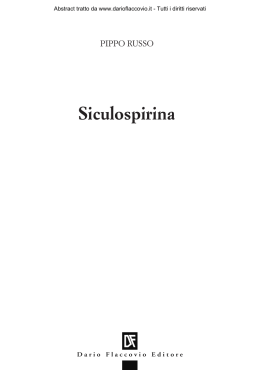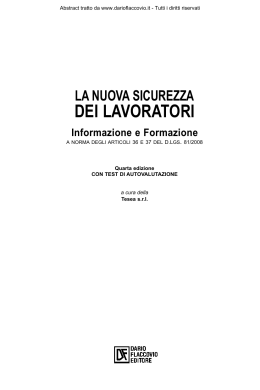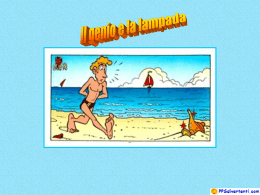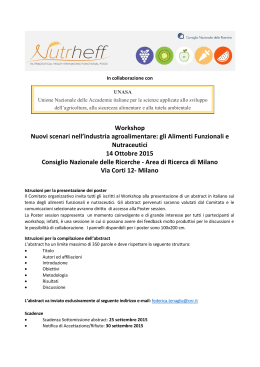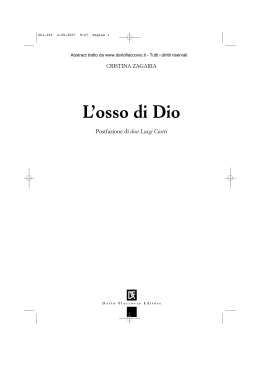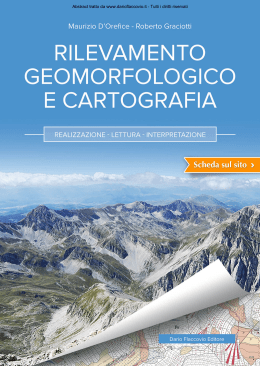Abstract tratto da www.darioflaccovio.it - Tutti i diritti riservati LAURA CAMPIGLIO CHI DÀ IL NOME AGLI URAGANI Dario Flaccovio Editore Abstract tratto da www.darioflaccovio.it - Tutti i diritti riservati Laura Campiglio CHI DÀ IL NOME ALI URAGANI ISBN 978-88-7758-921-7 Prima edizione: maggio 2010 © 2010 by Dario Flaccovio Editore s.r.l. - tel. 0916700686 www.darioflaccovio.it [email protected] Campiglio, Laura <1980-> Chi dà il nome agli uragani / Laura Campiglio. Palermo : D. Flaccovio, 2010. (Gialloteca ; 31) ISBN 978-88-7758-921-7 853.92 CDD-21 SBN Pal0226339 CIP - Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace” Abstract tratto da www.darioflaccovio.it - Tutti i diritti riservati CHI DÀ IL NOME AGLI URAGANI Abstract tratto da www.darioflaccovio.it - Tutti i diritti riservati Prima Parte Un mese L’ora migliore per fare il bucato sono le tre di notte. Grande insonne da lustri, da pochi giorni avevo scoperto una verità inconfutabile: l’unico modo di fronteggiare le notti bianche era annegarle in fondo all’oblò della lavatrice, in una qualunque lavanderia automatica aperta 24 ore su 24. Solo lì e solo a notte fonda l’odore del detersivo sapeva di catarsi, le lampade al neon diffondevano una luce senza tempo, il rumore della lavatrice suonava come la risacca di un mare lontano e il turbinio dei vestiti dietro l’oblò diventava un caleidoscopio ipnotico. In uno stato di veglia obbligata, quella pace era quanto di più vicino a un sonno ristoratore. L’altro vantaggio era che, trovandomi in terra straniera, il caffè della macchinetta era il migliore che offrisse il mercato. Rimestavo il mio con gesto meccanico (cos’era, il terzo o il quarto? Il quarto, probabilmente) quando nella girandola di vestiti inzuppati spuntò un lembo rosa lampone che si stampò contro il vetro e riprese a roteare. Lo sguardo appan- Abstract tratto da www.darioflaccovio.it - Tutti i diritti riservati nato dal sonno registrò quello sprazzo di colore con una stretta allo stomaco, regalandomi un ricordino della sera di cui avrei volentieri fatto a meno. Rosa lampone: era un reggiseno a balconcino, ormai tristemente orfano del lezioso slip coordinato e testimone, insieme al pezzo disperso, di una delle pagine più turpi della vita della sottoscritta. Che è piuttosto corta, ma non importa. «Mi è piaciuto, sai, quel tuo pezzo di costume sul gala del festival del cinema. L’ho trovato brillante, acuto, irriverente. Tipo quel passaggio, com’era? Delle signore in tailleur nero che sembrano, a seconda dell’età, standiste in fiera oppure… com’era?». «Tate svizzere». «Standiste in fiera o tate svizzere, sì. Geniale». Geniale, come no. Bisognava essere geni per tentare di fare cronaca, e farla bene, raccontando le cose come stavano, aggirando gli scogli dei poteri occulti e delle censure, e poi essere ricordata per settanta righe di gossip mondano. Ma in fondo avevo solo venticinque anni, di cui cinque passati a La Fazione, glorioso quotidiano locale il cui nome tutto diceva sulle velleità di informazione obiettiva e che, per ammissione degli stessi vertici, la gente sfogliava a partire dalla pagina dei necrologi. E si dà il caso mi trovassi nell’ufficio del direttore (proprio lui, non un misero caporedattore o uno scarso caposervizio. Il DIRETTORE, perbacco) di un molto importante e molto pomposo settimanale italiano. Il quale direttore, dopo avermi incrociata per caso a un aperitivo modaiolo e noioso come solo gli aperitivi modaioli milanesi possono essere, aveva giurato di trarmi dalle colonne del giornalino per farmi approdare su quelle del giornalone, 230 pagine patinate su cui il gotha del giornalismo nostrano faceva a pugni per mettere la firma. Quella che si dice un’occasione. 10 Abstract tratto da www.darioflaccovio.it - Tutti i diritti riservati «Sarcasmo e ironia, sarcasmo e ironia», continuava il direttore inarcando ammirato il sopraciglio sinistro, «doti che servirebbero anche qui, sai: la politica e le inchieste mattone vanno controbilanciate con il costume, il colore, la leggerezza…». Come dire, infiorettare le cose serie con un grazioso corollario di quisquilie, quale nobile compito. Ma in fondo non ero altro che una giovane pennivendola cui il direttore del giornalone offriva l’occasione di abbandonare la categoria dei giornalisti locali, i paria della carta stampata, per entrare nelle fila di quelli nazionali, che loro sì che sono bravi. E pazienza, dopotutto, se i pezzi di costume sono roba per casalinghe annoiate. Appunto: «I pezzi di costume fanno in trenta righe quel che un’inchiesta sociologica fa in trenta pagine», osservai compita. «È esatto», il direttore balzò sul suo posto in uno slancio di approvazione, «sono le evoluzioni del costume che fanno la storia. Il Sessantotto all’inizio non era che un fenomeno di colore a opera di quattro capelloni esaltati. E invece è stato un giro di boa». In fondo non aveva tutti i torti. «Mi sa che io e te andremo d’accordo», soggiunse, modulando la voce su un tono vagamente allusivo, «tu sei sprecata nella cronaca locale. Vieni a lavorare con me. Ti voglio in redazione anche a partire da domani. E a cena stasera». Eccola lì la fregatura: un invito a cena, un invito perentorio che suonava come un ordine. Con ogni probabilità il direttore era abituato a tenere sull’attenti una redazione intera che lo riveriva con sacro terrore, mica come il buon Pellagra, caporedattore de La Fazione, che si faceva le fotocopie da solo per non disturbare la segretaria e che mi cedeva il suo ufficio per guardare Beautiful in santa pace se gli spiegavo che forse sta11 Abstract tratto da www.darioflaccovio.it - Tutti i diritti riservati volta tra Ridge e Brooke era finita sul serio. L’antipatia latente per il direttore si fece all’improvviso più esplicita. «Mmm…», mugugnai fingendo di valutare la proposta, «e quale sarebbe l’ordine del giorno di questa cena?». «Oh, niente che riguardi il lavoro. Dopo il tramonto le colleghe molto belle non vanno annoiate con questioni redazionali», rispose inarcando all’inverosimile il sopracciglio sinistro e scoccando uno sguardo indagatore in zona quarto bottone della mia camicetta. I primi tre, in effetti, erano slacciati per permettere a un reggiseno a balconcino rosa lampone di occhieggiare dalla scollatura. Non per malizia, ma per pura estetica: a prescindere da ogni secondo fine, le tette sono tette. Chi le ha le mostri e chi non le ha le rimpianga, e questo è tutto. I guizzi imbizzarriti del sopracciglio del direttore, verosimilmente affetto da un tic che peggiorava in presenza di sbalzi ormonali, mi fecero all’improvviso ricordare di essere piuttosto bella, in effetti, decisamente tirata a lucido per l’occasione e senza dubbio oggetto delle lubriche attenzioni di questo tizio che, tenendo in pugno il mio destino professionale, era convinto di tenere anche le mie mutande. Non c’era dubbio: il direttore pensava che sarei andata a letto con lui, come da logoro copione della ragazza di belle speranze e desiderosa di fare carriera. «Senta, direttore», dissi esasperata, «tanto per essere chiari: cosa succede se non esco a cena con lei e, tanto per essere ancora più chiari, se non ci vengo neanche a letto, con lei?». Per nulla imbarazzato, il direttore mi guardò con il possesso sornione del gatto che sta per papparsi il topo: «Ne sarei molto rattristato», disse allargando le braccia, «e la mia curiosità giornalistica ne sarebbe frustrata. Sai, quel voler vedere cosa c’è sotto… E sotto la tua camicetta, nella fattispecie, mi sembra si intravedano scorci suggestivi». Scorci suggestivi. Buon dio. Era necessario distogliere il 12 Abstract tratto da www.darioflaccovio.it - Tutti i diritti riservati direttore da sogni e visioni mammarie e riportarlo alla dura realtà: «Quel che si intravede», dissi gelida, «è un balconcino rosa lampone. Taglia terza, coppa C, acquistato ieri e coordinato a uno slip invero piuttosto scomodo. E ora che ho soddisfatto la sua curiosità tolgo il disturbo, non prima di averle detto che lei è quel che si dice un uomo di merda». Tanto per essere chiari, appunto. Per nulla turbato, il direttore tentò di bloccare la mia uscita con un risolino che mi raggiunse alle spalle: «Beh, che modi! E te ne vai così, dopo avermi fornito una descrizione tanto invitante? Niente niente, neanche un ricordino?». Ma senti questa, un ricordino! Il direttore voleva scoparmi, e fin qui niente di strano, per poi archiviare l’episodio non come la punta di diamante del suo (triste, si supponeva) vissuto erotico, ma come un souvenir di seconda categoria. L’indignazione si fece bruciante. «Un ricordino, dice?», sibilai togliendomi gli slip da sotto il vestito con un gesto rapido e lanciandoli sulla scrivania, «eccolo qui, si tenga questi e li conservi per le sere d’inverno». A testa alta e senza mutande infilai la porta, conscia che un’uscita in grande stile vale più di qualsiasi entrata. Il giorno dopo consideravo con scoramento il mio futuro professionale e con perplessità il mio congedo dal direttore. Nelle mie intenzioni si era trattato di un gesto di massimo spregio, come quando le matrone romane si spogliavano nude di fronte agli schiavi a ribadirne l’inesistenza in quanto uomini e la riduzione a semplice oggetto. Ma il direttore o chi per lui avrebbero potuto interpretarlo come una bizza civettuola, un invito a un giochetto perverso, un rifiuto così plateale da preludere a un’altrettanto plateale resa. Senza contare che il coordinato rosa lampone, il quale per inciso mi era costato quanto un terzo di stipendio a La Fazione, era irrimediabilmente spaiato. 13 Abstract tratto da www.darioflaccovio.it - Tutti i diritti riservati Come temevo, per il direttore il lancio dello slip era stato come il lancio del guanto di sfida a una schermaglia amorosa, e il giorno successivo al fattaccio fui raggiunta da un orrido sms: Le tue mutandine sono state di ottima compagnia, ieri sera. Quando vieni a lanciarmi anche il reggiseno? Le vertebre cervicali mi si accartocciarono in un brivido di disgusto. Ma in quel momento ero già all’aeroporto, con il cuore e il passo leggeri come la valigia. Con un raro senso di liberazione feci quello che tutti sognano prima o poi di fare: presi il telefono e lo scagliai soddisfatta nel bidone della spazzatura. Poi mi diressi verso l’imbarco per Parigi. Il bucato notturno è meglio del Valium: dopo quella mezz’oretta passata a fissare la giostra dell’oblò e la botta di vita della centrifuga, l’asciugatrice dà il colpo di grazia. Per dieci minuti gli abiti fluttuano nel cestello sempre più leggeri, mentre l’aria calda e profumata intorpidisce le membra. A questo punto anche l’insonne più irriducibile, il più vigile tra i vigili, è irrimediabilmente rincoglionito, e le ultime energie gli bastano appena per fare su il suo fagottino e tornare a casa. Con le palpebre sempre più pesanti, raccolsi con un certo affetto il balconcino rosa lampone e gli altri panni ancora caldi, tuffai il naso tra le stoffe respirando a fondo l’odore di detersivo e uscii. Infilai un passo dietro l’altro come un automa, ma arrivata a destinazione neanche il sonno di piombo riuscì a evitarmi il tuffo al cuore che mi prendeva ogni volta che imboccavo la via di quella che ormai da un mese chiamavo casa. Rue Rollin – duecento metri di ciottoli nel quartiere latino – era esattamente quel che una viuzza parigina doveva essere. Una tavolozza che, anche nella luce tenue che precede l’alba, elencava le infinite qualità dei grigi di questa città: il tortora delle 14 Abstract tratto da www.darioflaccovio.it - Tutti i diritti riservati facciate, l’asfalto ferruginoso del pavé, i riflessi cangianti dei tetti di ardesia che certi giorni d’autunno erano l’esatto specchio del cielo. Solo a Parigi grigio voleva dire mille cose diverse. E forte di questa consapevolezza cromatica, al ritorno mi addormentai non appena toccai il letto. Per vivere a Parigi chiamandosi Linda Bastiglia ci voleva carattere. Il nom de famille che mi era capitato in sorte evocava, anzi citava alla lettera, il simbolo per eccellenza dell’assolutismo rovesciato con la Rivoluzione. Sicché stava simpatico solo quando si parlava di incendio e/o ceneri della: quel che si dice un nome difficile da portare. E nonostante – da irriducibile francofila e cultrice dello splatter – avessi per la Santissima Révolution il dovuto rispetto e parecchia simpatia, le celebrazioni del 14 luglio, con profusione di fuochi d’artificio nei cieli del dodicesimo arrondissement per ricordare il grande incendio della Bastiglia, mi facevano un certo effetto. Così come passare in place de la Bastille, dove mi sembrava che l’ombra dell’obelisco sorto sulle ceneri del mio cognome mi additasse come un indice accusatore. Ma nonostante l’evidente svantaggio anagrafico che mi segnava fin dalla nascita, quello per Parigi era stato un amore fulmineo, da quando a sedici anni, con uno zaino in spalla e pochissimi soldi in tasca, attraccai su un binario della Gare de Lyon e accettai incautamente un volantino che mi condusse dritta dritta in una bettola di ostello a Pigalle, nel quartiere a luci rosse. Fu la vacanza più bella della mia vita, nonostante prima di fare la doccia bisognasse aver cura di annegare tutti gli scarafaggi che la infestavano. Una buona abitudine, in fondo. La mia attuale ubicazione geografica testimoniava senza appello un imborghesimento dei costumi: dal quartiere a luci 15 Abstract tratto da www.darioflaccovio.it - Tutti i diritti riservati rosse al quartiere latino, a uno sputo dalla Sorbona, in una viuzza pedonale dove, se fossi vissuta in epoche diverse, avrei potuto avere come dirimpettaio Cartesio (dal 1645 al 1649, come recitava la targa del palazzo di fronte) e come vicino Hemingway (dal 1937 al 1939, come recitava quella del palazzo di fianco). Da qualche settimana vivevo in quaranta metri quadri – a essere ancora generosi – impregnati di secolar cultura, signori. La tizia che ci abitava, amica di un’amica dell’amica, aveva fatto sapere di partire a tempo indeterminato un mercoledì mattina di ottobre, proprio il giorno successivo al mio incontro-scontro con il direttore. Il mercoledì pomeriggio ero nell’ufficio di Pellagra a dargli il triste annuncio della mia imminente partenza e a imbastire senza premeditazione alcuna una giustificazione più o meno plausibile. Cercai le parole giuste per dirlo. Non le trovai. «Pellagra? Io me ne vado», annunciai asettica. «All’inaugurazione del torneo di pesca sportiva o al funerale del morto in motorino? Comunque, sei in ritardo per tutti e due». «No, Pellagra, vado all’aeroporto». Occhi al cielo e manata sulla scrivania: «Dio benedetto, e adesso che cazzo succede all’aeroporto?», chiese subodorando un sequestro di droga, un falso allarme terrorismo, lo sbarco di un esercito di ovulatori, cose così. Benché fosse da anni il redattore capo de La Fazione, a Pellagra i fuori programma non piacevano. Quando toccava cambiare la pagina verso le sei di sera e sostituire, che so, la polemica sul caro parcheggi con il pensionato in bici investito (il qual fatto, dato l’inevitabile spargimento di sangue, assurgeva al rango di cronaca nera) il nostro lanciava improperi contro il morto che aveva scelto un orario così disgraziato per andarsene e, al grido di se lavorassi in banca a quest’ora sarei già a casa, giurava che avrebbe cambiato mestiere di lì una settimana. Ma 16 Abstract tratto da www.darioflaccovio.it - Tutti i diritti riservati gli anni passavano e Pellagra restava: una colonna portante destinata a diventare una cariatide. «Cosa succede all’aeroporto?», riprese in tono lamentoso, «e perché io non ne so niente? Ecco, mi salta la cena anche stavolta». «Non credo», lo rassicurai, «succede solo che parto, e visto che la cerimonia di addio con le frecce tricolori è saltata non penso che la notizia meriti spazio in pagina». «Le frecce tricolori?», chiese Pellagra improvvisamente interessato. «Era uno scherzo. Scherzo. Battuta», sillabai. «Comunque, la notizia è: vado, sono già in ritardo, mi mancherete». Era vero, in fondo. «Ma perché te ne vai? Proprio adesso che inizia il torneo di pesca sportiva…». Se lo scopo era trattenermi, non poteva scegliere argomento peggiore. Della pesca sportiva, della polizia che ferma due ragazzini cannaioli, dell’assessore alla rava che le manda a dire a quello alla fava non me ne fregava niente, e neanche a lui. Ma dopo anni persi nel carosello della cronaca locale, le cose che contavano veramente diventavano proprio quelle lì, quelle che, fossimo stati ancora persone normali, avremmo liquidato con un francamente, me ne infischio. Era per questo che me ne andavo. E perché, quando hai appena tirato un paio di mutande (rosa lampone, non troverò mai più la stessa tinta, maledizione) in faccia a uno dei mostri sacri del giornalismo italiano, le possibilità di carriera diminuiscono sensibilmente. Il lancio della mutanda era un punto di non ritorno che valeva ben un biglietto di sola andata. Ma tutto questo a Pellagra non lo potevo spiegare. «Parto perché parto», argomentai con tautologica reticenza. Il che scatenò un’offensiva di domande. «Ma dove?». 17 Abstract tratto da www.darioflaccovio.it - Tutti i diritti riservati «A Parigi». «E a fare?». «A studiare». «Che cosa?». «Il da farsi». «Ma la pianti di dire cazzate?». «E tu di scriverle?». Pellagra sfoderò un sorriso da padre mancato, un misto di affetto e amarezza. Allargò le braccia: «Che dire allora, come vuoi. Però torna presto, che ci mancherai». «Dai Pellagra, sto solo via un po’», lo consolai, «vi leggerò su Internet, vi chiamo e vi mando dei pezzi dall’Eliseo per i trafiletti degli esteri». I trafiletti, sissignori. La politica estera a La Fazione la mettevano nei trafiletti. «Promesso?», lanciò prima che uscissi. «Giurato», gli sorrisi andandomene. È sempre così: gli addii sono conditi di malinconia e buone intenzioni, ma poi la realtà prende tutt’altra piega. Io, per esempio, mi ero sbarazzata del cellulare in zona check-in e partivo con l’idea di lasciar perdere tutto, La Fazione in primis e il giornalismo a ruota. Tutto quello che è seguito non lo volevo e non l’ho chiesto. È venuto, è successo, come succede la vita. Per esempio innamorarsi, forse, o mangiare viscide escargot, o riprendere a scrivere quel che non si può tacere, o lasciarsi trascinare in una spirale di shopping isterico o incontrare lei. Soprattutto incontrare lei: Lotte, Lotte la strega del bosco e la fata del lago, Lotte con gli occhi vacui e il sorriso dolente di vetri infranti. Non l’avevo cercata, Lotte. Mi era capitata, ero inciampata nella sua vita come un bambino che inciampa in un angolo ombroso del giardino. Ora ho un ginocchio sbucciato, e mi fa male. 18 Abstract tratto da www.darioflaccovio.it - Tutti i diritti riservati Chi scrive un giornale perde il gusto di leggere gli altri. Semmai, controlla la concorrenza: come ha titolato la tal testata o la tal altra, chi ha fatto lo scoop e chi ha preso il buco e via così. A Parigi ero ritornata a essere una lettrice, una di quelle che le cose le viene a sapere il giorno dopo e che, il giorno stesso, inganna l’attesa facendosi una vita sua. Una di quelle che la mattina passano dal giornalaio, comprano il giornale e si lamentano del giornale, così come del tempo e dei tempi che corrono. Ora si dà il caso che il giornalaio della rue Descartes si prestasse a questo gioco come nessuno. Monsieur Papelard, così si chiamava, era una curiosa creatura zoomorfa: un orso che guardava tutti in cagnesco, grugniva monosillabi ai clienti di suo gradimento e ruggiva insulti irripetibili a quelli che non gli andavano a genio. Quanto a me, lo trovavo adorabile, un esempio vivente di come il fatto di dare del voi anziché del lei ingentilisse anche il peggior turpiloquio. «Buongiorno, Monsieur Papelard. Di buon umore anche oggi, immagino», sorrisi melliflua al suo faccione accigliato. «Umpf… di buon umore sarete voi italiani, sarete. Guardate qui, Mademoiselle, il Corriere: in prima pagina una bella strage, un tizio che ha fatto fuori i due figli, il cane del vicino e il vicino stesso. E sapete cosa? Ha tagliato la corda, ha tagliato. Roba che uno dice: e chi se ne frega, ma no! Voi adesso andrete avanti a martellare per settimane. Mah… siete proprio un popolo latino, ci vuole solo il sangue per appassionarvi, ci vuole». «Perdonate Monsieur, siamo orribilmente gretti. Non come voi anime belle e spiriti elevati», affermai brandendo Le Monde che apriva con una bomba: i dati adrenalinici della vendita dei libri che, udite udite, avevano visto negli ultimi mesi un incremento dello 0,4 per cento. «Questi sì che sono brividi per i sostenitori dell’eccezione 19 Abstract tratto da www.darioflaccovio.it - Tutti i diritti riservati culturale francese», chiosai, «mentre noi siamo lì alle prese con le nostre storiacce di nera…». «Ah no no, Mademoiselle», si schermì Papelard, «guardate che per quanto mi riguarda questa storia dell’eccezione culturale francese è una stronzata buona per i lattanti e i coglioni. Questo è un pattume di paese marcio e porco, che eccezione e eccezione». Quando si scaldava, Papelard aveva un che di lombrosiano: sfoderava uno sguardo da maniaco omicida che saettava bagliori luciferini mentre il naso gli si imporporava di sdegno. Ma il culmine giunse quando una ragazzetta incauta osò chiedergli la brochure di Paris Plage, senza sapere che pronunciare le parole Paris Plage davanti a Papelard era come sventolare il drappo rosso sotto le narici fumanti di un toro. E infatti: «Il programma di Paris Plage potete mettervelo in culo, potete mettervelo», tuonò quello che fino a cinque minuti prima era un innocuo giornalaio, «uscite dal mio negozio, sciagurata che non siete altro! E che le sabbie marce di quella stronzissima spiaggia del cazzo vi si inghiottano, voi e tutti gli altri coglioni figli di papà!». La ragazzetta girò i tacchi in lacrime lasciando Papelard con le mani tremanti e il fiato corto. «Certo che voi sapete come fidelizzare il cliente, Monsieur», constatai ammirata. «Tornando a noi, fatemi vedere con cosa apre Libération…». «Libération?», ruggì Papelard in un rigurgito d’ira, «volete dire quel rotolo di carta da culo per porci borghesi bohémien e figli di papà marci, Mademoiselle?». «Proprio quello, Monsieur. Con cosa apre, dunque?». «Vediamo… ma senti qui la stronzata: Alla Sorbona è di nuovo maggio. È incredibile, Mademoiselle: quei porci ragazzetti dei miei coglioni l’hanno occupata ancora, l’hanno occupata». 20 Abstract tratto da www.darioflaccovio.it - Tutti i diritti riservati A Parigi, ogni anno, maggio tornava a intiepidire l’aria e profumare i giardini. Ma per i parigini di maggio ce n’era uno solo, unico come l’annata irripetibile dello champagne più pregiato. Sotto la tour Eiffel, il maggio per antonomasia era quello del ‘68: quello della fantasia al potere e del vietato vietare, delle manifestazioni oceaniche e delle cariche in piazza, della Sorbona occupata e delle ragazze liberate. Quello in cui si compì il miracolo e le strade di Parigi divennero spiaggia: al grido di sous le pavés la plage, sotto il pavé la spiaggia, gli studenti decisero che il posto migliore per i cubetti di porfido non erano le vie della capitale, ma le finestre della questura, e nel divellere il selciato scoprirono – magia magia – che sotto il manto di pavé covava non semplice terra, ma una signora spiaggia. Era quella la vera anima di Parigi: vacanziera, festaiola e casinara come Rimini e Riccione ad agosto. E allora alè, tutti al mare: tutti a occupare la Sorbona, a scendere in piazza gridando in coro, a correre via dalle cariche della polizia per finire a fare l’amore dietro il primo angolo disponibile, in piedi contro un muro, nel segreto di un androne. Per questo, per tutto questo, quando nel 2002 il sindaco socialista Bertrand Delanoë ebbe la malaugurata idea di creare sul lungosenna una spiaggia finta e tristemente istituzionale, buttando sugli argini quintalate di sabbia artificiale e conficcandoci una teoria di ombrelloni, i sessantottini gridarono allo scandalo. Perché per loro Paris plage era la profanazione di un simbolo, il vile tentativo di insabbiare la memoria storica della città e di quelli che, anni prima, la spiaggia se l’erano presa da soli. Dopo aver fatto storcere il naso agli allora benpensanti borghesi, scuotere il capo all’allora presidente della Repubblica Charles De Gaulle, brillare gli occhi dell’allora vivo e vegeto Jean-Paul Sartre, il maggio ’68 era diventato un’isti21 Abstract tratto da www.darioflaccovio.it - Tutti i diritti riservati tuzione: una specie di patrimonio nazionale che la Francia rivendicava in esclusiva e in competizione con gli Stati Uniti, una campagna militare al contrario, alla quale era uso comune vantarsi di aver partecipato. Il Sessantotto l’avevano fatto tutti: anche chi all’epoca aveva dieci anni o viveva in qualche campagna sperduta della Provenza millantava di esserci stato in qualche modo, anche per sbaglio, anche solo di striscio. In effetti, chi si era perso il maggio ’68 si era perso la festa del secolo: l’impressione, in fondo non erronea, che una manciata di settimane avrebbe cambiato il corso degli anni a venire, l’internazionalizzazione naturale del movimento, l’insperata realizzazione dell’asse tra studenti e operai, che con una raffica di scioperi generali paralizzarono la Francia, il rovesciamento dell’ordine costituito, il sesso libero e l’amore si vedrà. Intanto gli studenti enragés occupavano la Sorbona, salmodiavano il libretto rosso di Mao nelle aule e vociavano nel cortile sotto lo sguardo impassibile della statua di Victor Hugo che – oh, massimo spregio – qualcuno aveva sguerciato con una benda da pirata. Troppo bello per durare. Finirete tutti notai!, gridò un pomeriggio di sole lo scrittore reazionario Marcel Jouhandeau alla folla che manifestava sotto le sue finestre in boulevard Saint Michel. Come Cassandra, Jouhandeau fu odiato perché aveva ragione. Molti degli enragés diventarono davvero notai, altri medici o avvocati, altri giornalisti, altri più semplicemente giornalai. Per tutti, però, il Sessantotto era e restava roba loro: una nuova occupazione della Sorbona poteva essere al massimo il pietoso tentativo di imitare l’impresa epica di chi era stato tanto giovane e scafato da trovare la spiaggia a Parigi. Quella vera, non la stramaledetta Paris Plage. Questa era la storia del Sessantotto a Parigi. La mia, era tutt’altra cosa. 22
Scaricare