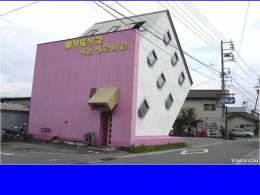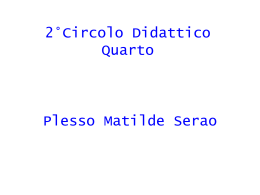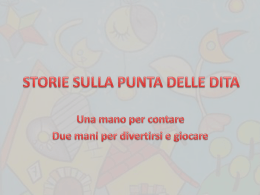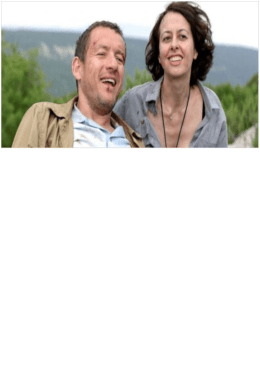Numero 6 giugno - luglio 2007 Dossier di questo numero: Fiabe di ieri e di oggi Editoriale di Francesca Pacini La tradizione dei simboli Intervista a Gianfranco Ersoch di Leonardo Leonardi Una madre da favola gli archetipi del femminile di Regina Crimilde Il segreto dei Nani il simbolismo di Biancaneve di Claudio Lanzi C’era una volta il suono la fiaba come respiro e ritmo di Seralisa Carbone Numero 6 giugno - luglio 2007 La sfida della mente conversazione con Carla de Gennaro sull’inconscio e la fiaba di Michela Gentili Le mani di Edward di Kusanagi Il rovescio della fiaba Tradizione e innovazione nell’opera di Gianni Rodari di Barbara Ronca Il logos e la fiaba di Stefano Petruccioli Quando la fiaba va al cinema di Stella Vordemann Sogno a occhi aperti di Fabio Fontana Numero 6 giugno - luglio 2007 Editoriale di Francesca Pacini «La caratteristica della buona fiaba, del tipo elevato ovvero completo, è che per quanto terribili siano gli avvenimenti, per quanto spaventose o fantastiche le avventure, essa è in grado di provocare nel bambino o nell’adulto che ascolta, nel momento in cui si verifica il “capovolgimento”, un’interruzione del respiro, un sobbalzo del cuore (…)» (Tolkien, Albero e Foglia) Il sobbalzo nel cuore. Non si tratta della meraviglia un po’ tonta dei bambini di Povia, quelli che fanno “oooooh” nelle sue canzoncine. È invece una meraviglia più sapiente, più antica. Ci ricorda un po’ i nani, i vecchi-bambini, dall’anima anziana e il cuore fanciullo, che estraggono cristalli dalla terre interiori, e che hanno bisogno di una Neve Bianca per dare senso e compimento al loro lavoro. Quel sobbalzo di cui parla Tolkien si gioca all’interno del cuore, liberato dal recinto che tiene prigioniero il moto sottile che evade le porose atmosfere della materia per farsi scintilla pulviscolare, esplodendo in cielo come una stella. Quel sobbalzo, oggi, diventa sempre più raro. Non c’è più un fuoco intorno al quale radunare la gente per raccontare storie e leggende. Era lì, sotto un manto stellato, agli occhi di una luna accesa dal sole nascosto, che la danza delle ombre disegnava i racconti che gli anziani trasmettevano da bocca a orecchio. Da bocca a orecchio, nei secoli, perché i figli dei figli dei figli mantenessero vive quelle storie nate con la prima aurora. Oggi il fuoco acceso nel bosco indica solo, nel migliore dei casi, un raduno di giovani scout. Nel peggiore, una mano criminale che ha volontariamente appiccato le fiamme. Lì, intorno a quel fuoco, tanto tempo fa le storie che cominciavano con il “C’era una volta” prendevano forma, vivevano, come Pinocchio, di vita propria, sfuggendo perfino ai loro demiurghi per diventare carne, respiro, parola. Oggi quelle fiabe sono quasi del tutto svanite, conservate attraverso i libri e qualche animazione in cui si sfilaccia la facoltà di immaginare. Il libro non svolge la stessa funzione. Lo sapeva bene Platone, che metteva in guardia l’uomo dall’uso della parola scritta che rischiava di incatenare i significati, strozzandoli per la mancanza di aria, di soffio vitale, quel soffio che si tramanda, appunto, quando una bocca trasmette qualcosa a un orecchio. È la stessa bocca della mamma che racconta la fiaba al suo bambino. Se la leggesse, quella fiaba perderebbe un po’ della sua magica polverina, come accade a Campanellino quando si indebolisce. Certo, è più facile scorrere il dito sulle pagine. Ma non è la stessa cosa. La voce, il suono, il racconto orale mantengono ancora oggi quello stesso mistero di allora. Solo che non ne siamo più consapevoli. Ma dovremmo ricordarcelo, se vogliamo accendere ancora le stelle nei cieli interiori. L’ho scoperto sulla mia pelle, con i miei nipotini. Come tanti bambini, hanno moltissimi giochi. Lui, un esercito di uomini ragno. Lei, regni interi di bambole e animaletti pelosi. Giocano un po’ fra di loro, il pomeriggio, poi vengono sistemati davanti a un comodo televisore, dove un comodo telecomando errerà in cerca di un comodo cartone animato. Ma quando apro un libro per leggere una fiaba, la festa dei sensi li fa sistemare, tutti eccitati, sulle mie gambe. Lo so, lo so che sono affamati di racconti. Così un giorno ho deciso di inventare le prime storie che mi venivano in mente. C’era la storia della principessina Trilli e del delfino coraggioso, per esempio. O quella di Buck e del suo orso custode. Raccontavo e vedevo le stelle esplodere nei loro occhi, come galassie pulsanti, affamate di vita. «Ancora, ancora, zia!». Ho dovuto ripeterle per parecchio tempo. Per 3 Numero 6 giugno - luglio 2007 giorni, mesi interi. A un certo punto avevo dimenticato la successione degli eventi (quando ti inventi di sana pianta una storia, non è detto che te la ricordi per sempre) ma loro no, se l’erano impressa con il marchio a fuoco. Sì, la memoria del fuoco agisce ancora oggi, danza, con le sue fiamme guizzanti, insieme all’oralità di racconti dispersi, che denunciano la vita frastagliata subita nei secoli, fatti prima di libri e poi di immagini animate, di televisori e computer, ma non ancora evasa da questa terra. Non ancora. I miei racconti non possedevano certo la sapienza e il vigore delle fiabe antiche, ma vivevano la vita magica dell’oralità. Quando, una sera, ho mostrato le stelle che come strade sterrate disegnavano curve nel cielo, si sono appassionati. Gliele ho narrate, poi ho appoggiato sulla falce lunare le storie della magia e delle fate, ho immaginato per loro mondi lontani e invisibili. Gli occhioni si sgranavano, avidi di quella conoscenza remota. Volevano ingoiare con le pupille quelle parole, come se avessero due grandi bocche ai confini del naso, due buchi scuri pronti a far propria la materia impalpabile di quei racconti. Eccola, la magia della fiaba. Viva, ancora oggi, in modi diversi. Tocca a noi, ricostruire quel fuoco per tutti i bambini di oggi e di domani. Dobbiamo cercare la legna, accomodarci con una coperta intorno alle spalle, soffiare sulla brace svegliando le fiamme sopite. Perché la tradizione orale non merita di essere seppellita per sempre. Ogni fiaba è rugiada del mattino per tutti i bambini. I cartoni animati e i film possono in qualche modo aiutare, ma non sono in grado di sostituire l’incanto della fiaba narrata. Incanto, incantamento, cantore. In questa epoca assediata dalla mancanza di tempo dobbiamo sforzarci per trovare lo spazio necessario al “sobbalzo del cuore”. La fiaba è una soglia sul nostro cosmo interiore, è porta e chiave, occasione e stupore. Non diventeremo mai esseri umani completi se non avremo imparato a conoscere il Bene e il Male. Dentro, non fuori di noi. E così se la strega ci spaventa piano piano ne riconosceremo la necessità affinché il Bene si compia. Sapremo che lei siamo noi, così come siamo anche la fata turchina. Le forze che ci compongono tessono le nostre trame psichiche e quelle spirituali. L’uomo antico ha usato il mito e la fiaba per farne la bussola della ricerca, l’orientamento che traccia un percorso preciso in cui si passa dall’ignoranza alla conoscenza, di noi stessi e del mondo che ci circonda. Anche se non ne siamo consapevoli, oggi usiamo ancora quei simboli traslocandoli al cinema e in televisione. Ma è l’uso cosciente che aiuta a uscire dalla grotta platonica per riconoscere le “vere” figure che crediamo di intercettare. Le fiabe non sono solo per i bambini. Sono per tutti. Ma se non le abbiamo toccate da piccoli, il recupero nell’età adulta sarà più impegnativo. Mi viene in mente una bellissima leggenda africana, che racconta l’importanza dei bambini e dei loro legami celesti. Quando sono piccoli, la tribù deve trattarli benissimo perché altrimenti il bambino, che vive ancora sospeso fra terra e cielo, potrebbe scegliere il cielo. Ogni bambino violato, maltrattato, offeso, non “scenderà” mai nella materia rimanendo come un albero spoglio e privo di linfa. Ecco, le fiabe sono la linfa che insegna al bambino la vita senza spezzare il filo di Arianna che lo lega ai cieli. Molte di loro sono andate disperse, però molte altre possono essere ancora conservate e trasmesse. Soprattutto, va conservata la suggestione di quel racconto che, da bocca a orecchio, che provoca il sobbalzo del cuore. Perché c’era una volta, sì. Ma c’è. E ci sarà. 4 Numero 6 giugno - luglio 2007 La tradizione e i simboli Le fiabe raccontano un percorso spirituale che gli antichi hanno in qualche modo uniformato attraverso l’uso consapevole di elementi simbolici, spesso comuni a più popoli. Oggi di quel percorso non si sa quasi più nulla. Il suo recupero, invece, è sempre fonte di meraviglia perché l’uomo si ri-conosce in quelle storie universali che parlano proprio di lui. Ne abbiamo parlato con Gianfranco Ersoch, che allo studio unisce una passione feconda... di Leonardo Leonardi [email protected] Il tempo delle fiabe sembra ormai lontano. Non il tempo di principi e maghi, casette nel bosco e creature fatate (quello è decisamente lontano), ma proprio il tempo della fiaba come forma letteraria, come racconto per addormentare i bambini, per esorcizzare le loro paure e quelle dei grandi, il tempo della fiaba come tradizione orale e momento di raccolta intorno a un’unica voce.In un periodo in cui nemmeno la Disney fa più appello alla tradizione popolare per produrre i suoi film, ora che il concetto di fiaba si fonde e si confonde con altri simili (favola, racconto, mito, parabola) e i suoi schemi più classici vengono presi a prestito da altre forme del narrare, vogliamo provare a fare un percorso a ritroso: ricercare le origini simboliche e allegoriche della fiaba. Perché alcuni modelli narrativi popolari, alcune storie e personaggi sono pressoché uguali nel folklore indo-europeo, in quello est-asiatico e in quello africano? Quali sono le verità che nella forma del racconto orale vengono rappresentate e rese accessibili anche ai bambini? Ne parliamo oggi con Gianfranco Ersoch, docente si simbolismo e di storia dell’ermetismo presso l’Accademia Tiberina di Roma, presidente dell’associazione Te Roma Sequor e socio fondatore e docente dell’Associazione Simmetria. Insieme a lui, cultore delle tradizioni arcaiche e massimo esperto dei miti e delle leggende popolari, cerchiamo di analizzare la valenza simbolica che caratterizza le fiabe, intese come riduzioni popolari di miti astrologici e religiosi. Le popolazioni primordiali hanno rappresentato nel racconto mitico una realtà pura, incontaminata e paradisiaca a cui tendono a ritornare, attraverso una serie di passaggi e trasformazioni, conflitti, abbandoni e ritrovamenti che simboleggiano un percorso interiore. Questo è un tratto comune che ritroviamo in quasi tutte le culture. Ci sono dunque, e quali possono essere, origini comuni delle tradizioni popolari in culture estremamente lontane tra loro? Non tutte le fiabe hanno questa valenza simbolica. Questo riguarda solo le fiabe di Magia, quelle che in inglese si chiamano Fairy Tales, caratterizzate da un intervento magico quasi sempre necessario allo sviluppo della storia e al conseguimento di un successo finale. Sono, peraltro, le più suggestive, come Cenerentola o Biancaneve. Gli studi di etnologia e antropologia culturale hanno messo in evidenza come queste fiabe, nella loro struttura, siano universali: noi possiamo trovare una ‘Cenerentola’ tra i Pellerossa, i Maori, le popolazioni Uralo-altaiche e così via, e ci si chiede allora il motivo di questa universalità. E’ una questione di diffusione? Ma che una fiaba mantenga inalterata la sua struttura attraverso un processo di diffusione che dura millenni e che coinvolge l’intero pianeta, attraversando culture e costumi completamente diversi è quantomeno singolare. Nel panorama delle diverse spiegazioni a questo fenomeno, le due tesi più diffuse sono quelle di un folklorista russo, Vladimir Propp, e uno storico delle religioni americano, Joseph Campbell; indipendentemente l’uno dall’altro e in momenti diversi, partendo anche da formazioni culturali differenti, propongono due spiegazioni oggi ritenute entrambe molto valide. Propp parte dalla sua impostazione legata al materialismo storico, e inscrive questo comune sviluppo dei folklori locali in un discorso di socialità: l’uomo è passato attraverso le stesse strutture sociali, e tale universalità della struttura spiega l’universalità della tradizione. Se però le tradizioni nascono in seno a una qualsivoglia società 5 Numero 6 giugno - luglio 2007 di pescatori e raccoglitori, nel momento del passaggio a stadi più avanzati (fino alla fase industriali), che senso ha questo tenace attaccamento alla fiaba, alla tradizione popolare e alla leggenda? Diverso è il discorso di Campbell, il cui modello di riferimento è la psicanalisi junghiana: le strutture presenti nella mente umana e nell’inconscio collettivo sono al di là del tempo e dello spazio, e pertanto sostanzialmente indifferenti ai cambiamenti sociali e storici a cui le popolazioni vanno incontro. Al di là di queste due tesi principali, esistono interpretazioni diverse, e sappiamo che alcune sono strettamente legate al rapporto con la religione. Ne vogliamo citare alcune che siano rappresentative? Alle teorie già esposte si aggiungono quelle di alcuni storici delle religioni come Mircea Eliade o Ananda Kentish Coomaraswamy, in cui la spiegazione psicologica a sua volta ne vela un’altra di tipo spirituale, con i due piani che corrono parallelamente. L’ipotesi dei due piani che corrono parallelamente ci restituisce l’immagine di una separazione tra piano psicologico e piano spirituale. Come si incontrano? Io ho trovato una spiegazione molto efficiente in Viktor Frankl, allievo di Freud e rettore dell’unversità di Vienna: lui sostenne l’ipotesi molto suggestiva secondo cui, come esiste un inconscio al di sotto della coscienza, un subconscio vero e proprio, esiste anche un inconscio al di sopra della coscienza, e lì c’è il contatto con la sfera divina dell’uomo, comunque la si voglia intendere. Quindi Frankl paragona il campo della mente a un piano e il campo dello spirito a un asse che attraversa il piano; il punto d’incontro, in una lettura bidimensionale, è il “cerchietto” formato dall’intersezione, se potessimo avere una lettura tridimensionale “vedremmo” l’asse spirituale. Qui si unisce la posizione di Coomaraswamy: se un mito ha un significato esistenziale, perenne, è chiaro che non cessa mai la sua attualità, che ne siamo coscienti o che ciò avvenga al di sotto, o al di sopra, della nostra coscienza. E ciò giustifica anche la sua autodifesa, la sua resistenza a tutte le trasformazioni che sono avvenute nei millenni: se è vero, come sostengono gli antropologi, che alcuni miti hanno un’origine risalente a 40.000 anni fa, il mantenere la struttura sostanzialmente invariata significa che qualcuno ‘dentro’ di noi ha un messaggio forte da trasmettere, e forse siamo noi ad essere troppo ‘duri’ da recepirlo. È per questo che, con l’avvento della civiltà industriale (e non prima), si è sentito il bisogno, come nel caso dei Fratelli Grimm, di scrivere le fiabe per fissarle, per evitare che si perdessero? Sì, la sensazione era che la tradizione andasse lentamente sbiadendo, nella memoria collettiva. E la nostra società occidentale è la prima che riesce a distruggere questo immenso bagaglio culturale, principalmente a causa di cartoni animati giapponesi e videogiochi, che peraltro stanno portando avanti la stessa opera anche nei confronti di una millenaria tradizione folklorica dell’Estremo Oriente. Il caso dei Fratelli Grimm, come del resto Calvino in Italia, è emblematico: quello dei Grimm è stato il primo tentativo di fare un lavoro filologico nei confronti della fiaba popolare. Significativo è, in questo senso, anche il lavoro di Andersen, che diversamente dai Grimm è un autore di fiabe, o di Perrault, che raccoglie le fiabe popolari rimaneggiandole in grande misura: queste operazioni sono sintomo di una necessità che, dalla fine del XVIII secolo, comincia a farsi sentire nella società europea, ovvero il bisogno di salvare la tradizione popolare dall’oblio in cui sta scivolando. Abbiano accennato alla fiaba come riduzione del mito astrologico-religioso. In questa la figura dell’eroe è sempre dipinta senza sfumature, come del resto quelle dei suoi alleati o antagonisti: i personaggi della fiaba sono buoni o cattivi, non c’è via di mezzo né complessità psicologica. E’ qui che compare il conflitto tra luce e ombra? E, in questa chiave, chi è l’eroe? L’eroe è il Sole. E’ una rappresentazione solare, e il ciclo solare è il ciclo della fiaba. Lo stesso sole, nel mito, è un significato, non un significante. Quando il sole comincia a morire lentamente, in autunno, il mondo cade nell’oscurità. L’eroe-sole affronta la sua caduta, fino ad arrivare al momento più buio, in cui riceve dei doni che gli permettono di tornare, altrettanto lentamente, alla vita. La fiaba parte sempre da una disgrazia iniziale, gli eventi precipitano fino al momento più oscuro per il protagonista. Da qui, tramite un aiuto, un dono, un alleato, comincia la risalita dell’eroe verso il suo successo. La morte-rinascita dell’eroe sole è particolarmente evidente in Biancaneve, se vogliamo. Queste favole sono ciò che resta di antichi miti in cui la religione è finita, si è trasformata; il mito dunque si trasforma in fiaba per uatodifendersi, per riuscire a conservare se stesso. Con una battuta, vorrei dire che la fiaba è un ‘mito in pensione’: quando i miti vanno in pensione si trasformano in fiaba. Possiamo dire che questo allontanamento della luce è rappresentato molto spesso, nella fiaba, dal viaggio, dall’esilio, dall’allontanamento dell’eroe? Spesso i protagonisti vengono scacciati, costretti a fuggire, rapiti o altro… Certo, è la nostra condizione esistenziale: noi non siamo ciò che vorremmo essere, ed è a questo che 6 Numero 6 giugno - luglio 2007 tendiamo costantemente. Passiamo attraverso vari processi di maturazione — fisica, psicologica e poi spirituale, o comunque interiore — e solo alla fine, come ‘premio’ per aver compiuto questo percorso, possiamo arrivare al successo nella nostra avventura, come l’eroe fiabesco. In questo passaggio si colloca anche la figura dell’aiutante, del maestro, della fata o di chiunque altro, comparendo come un deus ex machina, aiuti l’eroe a raggiungere il suo traguardo. Non è un caso che sia solo questo il momento della sua comparsa, è giusto? Naturalmente il deus ex machina compare per aiutare il protagonista solo quando lui (o lei) è pronto a riceverlo, cioè quando il suo percorso di maturazione è già avanzato: l’aiutante rappresenta la consapevolezza, la saggezza acquisita dall’eroe, e in generale le figure amiche, nella fiaba, rappresentano quelle nostre qualità che riusciamo a riconoscere e portare alla luce nel momento del bisogno più estremo. Il viaggio è sempre compiuto nel posto più lontano: dentro di sé. Fino al compimento di quel viaggio, noi (rappresentati dall’eroe) non abbiamo i mezzi (che, nella fiaba, sono gli alleati e i loro doni magici) per la nostra riuscita. A questa crescita dell’eroe, coronata dal successo finale, fa da contrappunto la fine, spesso tragica e violenta, dell’antagonista. Possiamo soffermarci su questo aspetto? Noi siamo abituati, in quest’epoca, a fiabe molto edulcorate, ma la tradizione classica del racconto popolare esige che il ‘cattivo’, alla fine, non solo paghi per la sua malvagità, ma lo faccia anche in modo estremamente violento. Questa è una violenza funzionale non solo (e non tanto) nell’economia della storia fiabesca, ma soprattutto nel suo ruolo educativo: il bambino si aspetta che il cattivo faccia una certa fine — e personalmente non ho mai incontrato un bambino traumatizzato da una fiaba classica—; non dobbiamo dimenticare che quel personaggio condannato a quella fine violenta è la parte oscura dell’eroe, e quindi di noi stessi: spesso è un parente molto vicino, a volte è un sosia, un impostore o un alter ego (che addirittura, spesso, viene scambiato per l’eroe stesso), ma in tutte le fiabe si può ritrovare la vicinanza e la complementarità tra luce e ombra nella coppia eroe-antagonista. 7 Numero 6 giugno - luglio 2007 Una madre da favola Nelle fiabe c’è sempre la divisione tra una madre buona e una madre cattiva, di cui la strega è l’estensione più estrema. A volte invece questa figura è del tutto assente. In ogni caso, è fondamentale nella vicenda dei protagonisti. Le declinazioni femminili di questa figura ci raccontano di un mondo simbolico in cui facciamo i conti con gli archetipi dell’origine... di Regina Crimilde Spesso nelle fiabe c’è una contrapposizione tra la figura di una madre buona e una madre cattiva. Come è facilmente comprensibile, in realtà siamo di fronte al tentativo di venire a patti con l’ambivalenza e il dualismo tipici di ogni essere umano, che però nella madre diventa particolarmente duro ad essere affrontato e accettato, in quanto essa rappresenta, contemporaneamente, anche l’unica certezza e sostenibilità per la vita infantile. Diventa quindi più facile separare nettamente le due facce della madre e inventarsi la matrigna. La madre buona si eclissa e lascia il campo alla madre cattiva? Ecco allora che ci si inventa la morte della vera madre e l’entrata in scena di una madre sostitutiva per la quale, non vincolata da legami di sangue alla prole, i sentimenti negativi verso i figliastri diventano plausibili. Come nel caso di Cenerentola - nella versione di Perrault - in cui la matrigna è sì negativa, ma opprime e asservisce la figliastra senza attentare alla sua vita. Quando si arriva a voler rappresentare il tentativo di figlicidio, allora anche la matrigna stessa si sdoppia, tanto grande è il tabù. La matrigna-la mamma Ci sono matrigne nelle fiabe: tante. Specialmente se paragonate alle poche (e scialbe) madri. La famiglia è spesso disequilibrata: nonni al posto di genitori; tanti orfani; padri vedovi, tutto tranne che inconsolabili e infatti, ahimé, spesso rimaritati male; sorelle e fratelli, anche in numero spropositato (al ché non si fa fatica a capire perché quelle povere madri siano morte); madrine e tutori. Ma madri poche. E spesso appena appena accennate: narrate quel tanto che basta a partorire il figlio o la figlia che poi sarà il protagonista. Come la mamma di Biancaneve la cui esitenza è ricordata solo per l’evento simbolico che sarà all’origine del nome della fanciulla. Si punge un dito cucendo alla finestra e vedendo il sangue cadere sul davanzale di legno, coperto di neve, proferisce il famoso voto: “ Se potessi avere una bambina dai capelli neri come l’ebano, dalle labbra rosse come il sangue e dalla pelle bianca come neve!”. All’origine di questa assenza delle madri nelle fiabe pare corrispondere un tabù ancestrale. Non è accettabile che la mamma possa essere “cattiva”. La sua faccia oscura viene esorcizzata dalla creazione di un suo alter, la matrigna. Questa assolve il ruolo femminile nella famiglia immaginaria e archetipa, e al tempo stesso si carica delle valenze crudeli senza per questo mettere in discussione la totale bontà che alla figura materna si deve e si vuole attribuire. 8 Numero 6 giugno - luglio 2007 Così, mentre l’autorità spetta comunque al padre, che quindi è assolto da accuse di severità, crudeltà, freddezza, proprio perché sono attributi che gli competono in quanto giudice e sovrano, la creazione della matrigna risolve il conflitto esistente tra ventre che genera (e quindi buono) e comportamenti malvagi. Ma questo fa anche pensare che questa crudeltà delle madri deve esserci sempre stata. E con una frequenza e un parossismo tale da doverla censurare ed escludere dalla elaborazione dell’inconscio collettivo che la è la fiaba. La matrigna di Biancaneve svela la sua doppia identità di donna e di strega ed è questa ultima ad operare direttamente le aggressioni fisiche. Così come nella paradigmatica fiaba di Hansel e Gretel, lo sdoppiamento è addirittura totale: due personaggi distinti. La matrigna diventa strumentale all’abbandono; ed è in seguito a questo abbandono che i due bambini finiscono nelle grinfie della strega cannibale. Le figure di madre sono aspesso assenti, o incolori. Come la regina madre della Bella Addormentata, che non sa evitare lo sdegno delle fate né contrastare l’avverarsi della profezia maligna. O la madre di Cappuccetto Rosso che espone la figlia ai pericoli del bosco senza saperle offrire altro che l’inefficace scudo della prudenza. Talvolta l’assenza della madre è definitiva e determinante per lo svolgersi della storia, gravida di prove difficili e tormenti per il protagonista: così nel caso di Biancaneve e di Cerentola, dove la morte della madre - assenza estrema - lascia spazio all’introdursi della matrigna. In Pinocchio la madre manca fin dall’inizio: la nascita stessa del burattino è una partenogenesi degna del mito greco. Solo che, nell’aureo mondo classico, senza genitori nascevano déi. Nel più prosaico mondo umano, senza genitori nascono mostri. E Pinocchio è l’esemplificazione del “mostro” moderno: reso rigido, sgraziato, informe, ribelle dalla mancanza di amore. Alla ricerca dell’unica fonte di amore che percepisce come possibile. Non Geppetto, che come ogni padre è una figura distante, portatore di sovrastrutture sociali imposte come valori (ordine, legalità, conformismo: il continuo richiamo ad essere buono e frequentare la scuola). Pinocchio identifica la madre nella evanescente e misteriosa Fata Turchina, che continuamente appare e scompare, muore e rinasce, lo blandisce e lo allontana. Allora si affacciò alla finestra una bella bambina, coi capelli turchini e il viso bianco come un’immagine di cera, gli occhi chiusi e le mani incrociate sul petto, la quale senza muovere punto le labbra, disse con una vocina che pareva venisse dall’altro mondo: - In questa casa non c’è nessuno. Sono tutti morti. - Aprimi almeno tu! - gridò Pinocchio piangendo e raccomandandosi. - Sono morta anch’io. Solo la presenza della madre nella sua vita, cercata e saltuariamente incontrata, attraverso peripezie infinite, opererà il miracolo di farlo uscire dalla sua condizione di “mostro”. La ricerca sarà lunga e faticosa, talvolta Pinocchio avrà paura di aver perso per sempre la madre: Lumachina bella: dove hai lasciato la mia buona Fata? che fa? mi ha perdonato? si ricorda sempre di me? mi vuol sempre bene? è molto lontana da qui? potrei andare a trovarla? Ma alla fine il ricongiungimento opererà il miracolo. Pinocchio potrà esclamare: Gli è tanto tempo che mi struggo di avere una mamma come tutti gli altri ragazzi!... Ci sono anche le mamme buone, per fortuna. Secondo l’interpretazione psicanalatica delle fiabe le relazioni familiari che esse rappresentano danno sfogo ai timori inconsci del bambino nell’affrontare e risolvere il complesso edipico. La simbologia delal madre-matrigna vorrebbe quindi incoraggiare il distacco dei figli dalle madri dipingendole come figure negative per facilitarne il processo. 9 Numero 6 giugno - luglio 2007 Al tempo stesso la strega che lo punisce e lo imprigiona (come in Hansel e Gretel) dà immagine proprio all’atteggiamento castrante e possessivo delal madre edipica. Ma nelle fiabe esistono anche figure materne positive, anche se spesso sono sostituti della madre vera (che è morta). Nella versione di Perault di Cenerentola incontriamo la più evidente e conosciuta di queste figure sostitutive, la fata madrina, che fa da contraltare alla matrigna, a sua volta figura sostitutiva della “madre cattiva. La fata madrina incarna un un principio provvidenziale di natura divina, che si fa garante della risoluzione della vicenda, attraverso magiche trasformazioni (zucche in carrozze, topi in cavalli, vestiti e scarpette di cristallo). Tutto ciò rimedia al danno e rende possibile, l’incontro con il principe, la crescita di Cenerentola da figlia a donna. Significativo è il fatto che in alcune versioni della fiaba il personaggio della fata madrina non c’è e la risoluzione del danno viene operata da un albero cresciuto sulla tomba della madre. O un uccello che assiste il principe nella sua ricerca di Cenerentola. La Fata come figura materna alternativa appare anche in Pinocchio, nel personaggio, appunto, della Fata Turchina che sviluppa le sue caratteristiche genitoriali solo nel corso del romanzo: all’inizio infatti viene presentata come una “bambina” e Pinocchio tende a considerarla una possibile sorella. Man mano che la narrazione cresce la buona fata diventa la madre mancante e Geppetto passa in secondo piano. Non dimentichiamo che Pinocchio è una fiaba sui generis, in quanto scritta da un ben preciso autore e non frutto di elaborazioni orali attraverso i secoli; inoltre anche Collodi stesso scrisse il romanzo a puntate, su richiesta di un editore e la narrazione sembra risentire di questo andamento episodico. il blog di regina Crimilde: http://blog.libero.it/ceraunavolta 10 Numero 6 giugno - luglio 2007 Il segreto dei Nani La fiaba di Biancaneve non è solo la storia di una fuga in un bosco e di un lieto fine. È anche un percorso denso di simboli, in cui nulla è casuale. Ci sono richiami perfino all’opera alchemica, che il genio di Disney certo non ignorava. Ma la sua origine è molto più antica... di Claudio Lanzi [email protected] La fiaba di Biancaneve è forse una delle più famose nel nostro occidente e anche una delle più antiche. Purtroppo dobbiamo la sua “forma” attuale, un po’ stereotipata, soprattutto alla versione cinematografica di Disney (verso il quale, comunque, dobbiamo levarci tanto di cappello per la genialità con cui ha raccolto e interpretato i messaggi più profondi di una delle fiabe più famose del mondo). In realtà esistono molte “varianti” sia nordiche che mediorientali, della storia di Biancaneve, in cui i personaggi cambiano nomi e ruoli, ma non la funzione simbolica. La storia è stata analizzata e scomposta in ogni modo, soprattutto alla luce della morfologia proposta da Propp e Campbell. Analisi, quest’ultima, rigidamente orientata in chiave meccanicistica e quindi collegata a degli schemi abbastanza rigidi, che tendono a individuare delle vere e proprie ”mappe” comportamentali alle quali deve soggiacere ogni storia eroica (compresi i racconti mitologici Omerici ed altri). Tale ipotesi è stata parzialmente contestata e smontata da Levi Strass e da altri ma, a proposito della strutturazione del racconto eroico, rinviamo al libretto “Il cinema dietro lo schermo” ed. Simmetria, dove viene effettuata un’analisi particolareggiata e divertente su come Holliwood riproponga costantemente il monomito di Campbell, al fine non dichiarato di costruire storie dentro reti “emozionali predefinite, tutte uguali a se stesse, al fine di assicurarsi facili successi di pubblico. Ma torniamo alla storia di Biancaneve, e vediamone velocemente i passaggi principali. Biancaneve è una fanciulla, poco più o poco meno che adolescente; ha una matrigna-strega che più cattiva non si può (le matrigne cattive sono un presupposto strategico per la partenza di molte fiabe) mentre del padre si sa ben poco. Sicuramente è un re o un grande signore ma non è comunque, per lo meno ufficialmente, parte attiva della storia. Forse è malato, o è morto, o è succube della matrigna. La matrigna possiede il terribile specchio “delle brame” che le dice costantemente e implacabilmente che lei non è la più bella del reame e che Biancaneve è più bella di lei. Mal sopportando questo confronto, la matrigna ordina ad un personaggio misterioso (un servo, un cacciatore, un guardiano, un contadino, un viandante, o chissà chi) di ucciderla. In genere c’è un primo tentativo che fallisce e poi un secondo, più spietato, in cui la matrigna chiede, come prova della morte, il cuore di Biancaneve. Ovviamente il cacciatore si commuove e organizza l’inganno a fin di bene: sacrifica un cerbiatto, o un altro animale, ne prende il cuore e lo porta dalla matrigna-strega (che inspiegabilmente sembra non accorgersi della sostituzione), mentre Biancaneve fugge nel bosco. Questa è la prima parte della storia. La seconda parte prevede la scoperta della casetta dei sette Nani, momentaneamente vuota, l’ingresso di Biancaneve nella casetta, l’addormentamento della fanciulla su tutti e sette i letti dei Nani che, per ospitarla, vengono avvicinati fra loro. Come sappiamo, al ritorno dei nani, celebri scavatori di pietre preziose, poco puliti, poco ordinati, c’è il fantastico incontro, lo stupore per la bellezza della fanciulla, la promessa di Biancaneve ai Nani di resta11 Numero 6 giugno - luglio 2007 re nella casetta e di non dare confidenza a nessuno, lo sviluppo di una grande amicizia fra i Nani e Biancaneve e infine l’impegno di Biancaneve a tenere ordinata la casa. A questo punto la matrigna-strega reinterroga lo specchio, scopre che Biancaneve è ancora viva e lo specchio le mostra il suo nascondiglio. La strega prepara la melaavvelenata (a metà) e la porta a Biancaneve. Biancaneve non riconosce la matrigna, morde la mela e muore (apparentemente). I Nani tornano, la trovano morta; pianto dei nani, la bara di cristallo, l’arrivo del principe azzurro, il bacio, il risveglio…e tutti vissero felici e contenti. I contenuti archetipici che animano questa formidabile struttura sono talmente tanti da costituire un intreccio sconfinato e affascinante. Alcuni apparati simbolici sono facilmente decifrabili, per lo meno in chiave psicologica; altri sono decisamente più criptici, così come avviene, del resto per tutte le fiabe del mondo, che trasferiscono nella tradizione popolare l’essenza dei racconti, base dei processi iniziatici e delle cosmogonie di ogni tradizione. Ogni sezione della fiaba di Biancaneve ha, ovviamente, un profondo richiamo alle dinamiche psichiche (che sono state quelle più indagate e che fanno godere a dismisura gli psichiatri di tutto il mondo: pensate, ad esempio, al formidabile pastrocchio edipico del quadrilatero padre-matrigna-cacciatore-Biancaneve) ma anche delle significative tracce alchemiche ed ermetiche che la ricollegano alla grande fiaba d’Amore e Psiche narrata da Apuleio (che, non per nulla era… un mago). C’è da dire che i bambini non studiano antropologia né psicologia. Eppure tale fiaba comunica meravigliosamente a livello inconscio, ed è da sempre straordinariamente amata. C’è l’avventura, il terrore, il cattivo, il buono, il sacrificio, il protettore, la sconfitta dei malvagi, il trionfo della giustizia, e tali messaggi arrivano alla mente senza particolari mediatori intellettuali. Qui ci soffermeremo solo su un particolare, tanto per mostrare, a chi non ne fosse già a conoscenza, la vastità dell’impianto scenico e le sue implicazioni mitiche. Parliamo dunque dei Sette Nani. E’ evidente come tale numero non sia casuale. I sette pianeti, le sette Virtù, i sette chakra, i sette colori dell’iride, i sette giorni della settimana, le sette note, il collegio romano dei septemviri, le sette stelle dell’Orsa, ecc. ecc., ci ricordano che siamo di fronte a un numero che è alla base di tutte le mitologie e di tutte le religiosità arcaiche. Dunque, a partire dal titolo, la fiaba unisce indissolubilmente la storia di Biancaneve a quella dei nani. L’una non può esistere senza gli altri. Biancaneve è perseguitata e arriva nella magica casetta dei Sette Nani per caso o, per usare un termine più appropriato, diremmo “per ventura”. L’incontro avviene dopo una lunga fuga (alcuni potrebbero dire da se stessa e dal suo Edipo, oppure che stava scoprendo la sua femminilità, come Cappuccetto Rosso ecc., ma qui tralasciamo gli aspetti psicologici). Quando arriva alla casa dei Nani è stanca, spossata da un viaggio pericoloso nel bosco dei suoi terrori, ma anche nella foresta dei suoi impulsi e delle sue intuizioni. È in fuga forse dal suo alter ego, madre usurpatrice che ha soggiogato il maschile paterno, che ha sovvertito l’ordine e la legittimità nel governo del regno, che vuole il suo cuore (indubbiamente tale “madre” non ce l’ha, ed usa fino a che può, come surrogato del cuore nel quale andare a trovare se stessa, uno specchio, altro oggetto magico che gioca un ruolo cardine in tutta la storia ma su cui non possiamo soffermarci). La casa dei Nani è piccola, non paragonabile davvero al castello da cui proviene Biancaneve, tanto è vero che lei c’entra appena. La fanciulla si incuriosisce delle dimensioni dei letti ma poi è troppo stanca per porsi altre domande e ci si abbandona sopra, avvicinandoli gli uni agli altri. Ora bisogna rendersi conto che, il suo stendersi sui letti accostati, posti orizzontalmente rispetto al suo corpo e il suo abbandonarsi al sonno, superando così le sue paure, ha un effetto potentemente evocativo. È una vera e propria incubazione, paragonabile forse a quella degli adepti dei misteri Orfici. Infatti, al suo risveglio, i sette proprietari dei letti le sono improvvisamente intorno, e la guardano stupiti. Dunque, se vogliamo vedere le cose da un punto di vista prevalentemente “magico”, il contatto con i “sette letti” dove riposano i Nani ha il potere di far apparire i “proprietari” dei letti medesimi, di estrarli dalle loro miniere. Il parallelo tra i centri sottili della cabala giudaico-cristiana e gli arcinoti chakra della tradizione induista è fin troppo facile. È evidente che al “risveglio” di Biancaneve anche i Nani sono “svegli” (nella fiaba si dice che hanno appena finito di scavare) e la scoperta reciproca lascia interdetti. Se ci rifacciamo al simbolismo proprio della tradizione ermetica rinascimentale, facilmente riscontrabile nell’iconologia dell’epoca, potremmo dire che il corpo di Biancaneve (che nelle fiabe originali non è vestita come una rubiconda educanda americana anni 30, ma è una splendida giovane coperta di pochi veli) ha scoperto di essere governato da sette pianeti, da sette metalli, ecc. Ed è evidente che lei se ne stupisca così come i Nani si stupiscono di essere collegati direttamente a quel corpo e che il loro lavoro ha portato… degli ottimi frutti. 12 Numero 6 giugno - luglio 2007 Sappiamo, soprattutto dalle tradizioni nordiche, che il popolo dei Nani è collegato sia alla Terra che a Vulcano, quindi sia alla nutrice primordiale (assai più generosa della perfida matrigna) e al dio del Fuoco primordiale, al grande forgiatore dei metalli primordiali. I Nani sono perciò degli scavatori di pietre preziose ma anche dei forgiatori di metalli. Potremmo dire che ognuno di loro è preposto ad un particolare tipo di pietre e di metallo. Il lavoro di “scavo”, sotto questo profilo, rifacendoci alla tradizione ermetica del Pimandro e alle elaborazioni di Lullo e di Agrippa, è un’opera che l’Anima “risvegliata” (brutta parola che apre a facilonerie new-age ma non ne abbiamo di migliori) esegue su se stessa, estraendo le “qualità” insite in ogni parte. In tale estrazione l’essere umano è paragonabile ad una miniera ma i metalli estratti vanno poi finemente lavorati per depurarli dalle scorie, raffinarli e impreziosirli. L’apparente assurdità del ruolo dei Nani nella fiaba è data dal fatto che non hanno relazioni col mondo esterno. Il loro lavoro sembra fine a se stesso. Infatti, vivono nella loro casetta in modo totalmente autonomo e non commerciano, né accumulano per loro stessi, le pietre che scavano. Oseremmo dire che sono chiusi in un vaso ermetico, apribile solo a determinate condizioni. Ma essi preparano lo straordinario dono di nozze a colui che saprà incontrarli e scoprirli. Ovviamente se Biancaneve non avesse un cuore puro non avrebbe mai trovato la casa dei Nani e questi non sarebbero mai diventati realmente “visibili”. Sotto questo profilo la storia ci propone un mondo che oggi definiremmo “tolkieniano”, dove il contatto con gli elementi naturali avviene proprio grazie alla assoluta assenza di malignità, di doppi fini, di strategie, da parte della protagonista. Biancaneve è un’anima algida, alla ricerca di se stessa e del suo calore. Non ha studiato… filosofia, non conosce quasi nulla del mondo. E’ semplicemente pura, vergine, ma prigioniera della sua matrigna. La prima operazione che fa è allontanarsene (per mezzo dell’enigmatico viandante-cacciatore-servo) che la induce a fuggire. Lo stesso nome “Bianca-neve” (che in altre versioni della fiaba è leggermente diverso) è collegato al concetto di purezza, di impalpabilità e di freschezza. Per questo lei trova la casa dei Nani. Non è dunque un caso ma una necessità metafisica. Anche la matrigna andrà nel bosco, novello fantasma del lato ombra di Biancaneve. Essa non si perde tra le ombre della foresta e non ne ha paura, ma il suo unico obiettivo apparente è distruggere la “bianca-neve” che dispone di un cuore e di una bellezza immacolata. E sarà proprio grazie a Biancaneve che ha inconsapevolmente reso visibile la casa dei Nani, e allo specchio magico che la riflette, che la strega giungerà a trovarla. Per cui la matrigna, avendo una immagine speculare della casa, cioè invertita rispetto all’ordine naturale, la vede solo come rifugio della sua antagonista e non ne comprende la funzione (se volessimo fare un parallelo con l’Alice di Carroll potremmo dire che la porta della casa dei Nani è, per alcuni versi, simile a quella da cui passa il Bianconiglio). Perciò la strega non potrà mai entrarci e, pur essendoci arrivata vicino, nel suo tentativo di distruggere la Purezza e di diventare, in tal modo, esteriormente la più bella, non sarà in grado di riconoscerne il valore. Ovviamente quando i Nani scoprono che Biancaneve è morta per essersi fatta tentare dalla mela (eh, queste mele, che ci perseguitano dall’inizio della Creazione!) ne piangono la perdita e le costruiscono la famosa bara nel cristallo. Insomma la proteggono e lasciano il corpo come mummificato e in attesa della rinascita definitiva. È evidente che la morte di Biancaneve ha una doppia valenza. Da una parte sembra la vittima ingenua di un inganno altrettanto ingenuo. Dall’altra soggiace ad una operazione necessaria. In realtà la strega fornisce il veleno che uccide ma, nello stesso tempo, tiene la “Bellezza” in animazione sospesa, che permetterà ai Nani di coagularla nella purezza del cristallo. Il Principe completerà l’opera e Biancaneve, ormai pronta per aver affrontato la morte, troverà la sua completezza nella congiunzione con l’amato. È chiaro che non si tratta di un colpo di fulmine tra due frollocconi di una soap opera, ma di una conseguenza incontrovertibile. Il Principe-principio (spirituale) arriva quando l’anima è pronta ad accoglierlo e non in altri momenti. Ora questa analisi veloce e superficiale non è assolutamente esaustiva, né dell’episodio estratto dalla fiaba né, tantomeno, del senso della fiaba stessa. Molto ci sarebbe da dire sui singoli personaggi e, in particolar modo sull’enigmatico cacciatore, sullo specchio, sulla casa, sulle pietre, e soprattutto sul Principe, deus ex machina, che appare per un solo istante ma che corona la storia con un apparente quanto improbabile lieto fine. Ma suscitare un minimo di curiosità è uno degli scopi di chi racconta le fiabe, e quindi anche del 13 Numero 6 giugno - luglio 2007 sottoscritto; per cui, se sarà possibile… ne parleremo ancora, un’altra volta. Stretta la foglia, lunga è la via…. approfondimenti: sull’’autore dell’articolo www.simmetria.org su Joseph Campbell, autore di studi sul mondo del mito e della leggenda http://it.wikipedia.org/wiki/Joseph_Campbell 14 Numero 6 giugno - luglio 2007 C’era una volta il suono La fiaba non è solo racconto ma anche esperienza sonora. Il bambino ascolta la voce della madre che introduce uno spazio magico che somma ritmo e racconto. E in cui lei parla anche di sé e dei suoi moti interiori. Purtroppo nell’era moderna questo filo diretto e invisibile - come quello di Arianna - si sta spezzando... di Seralisa Carbone [email protected] Le fiabe arrivano prima dei loro papà. Sentiamo parlare dei fratelli Grimm solo in età scolare, quando ci viene comunicata la necessità di imparare a dare un nome alle cose e, iniziandoci al concetto di “proprietà”, la maestra ci insegna ad attribuire una paternità a Cappuccetto Rosso. È il momento sacrale dell’ingresso definitivo della parola scritta nella nostra acerba coscienza culturale, quando una forma sconosciuta colonizza, fissa una nuova e irrinunciabile consapevolezza, un po’ come una sorta di verbo incarnato. Perché si sa, in principio era il verbo, e tutte le fiabe cominciano il loro cammino sul sentiero dell’oralità, correndo sulla lunghezza d’onda del suono per prendere vita con la voce della mamma, la prima voce che racconta il mondo e lo traduce in ritmo, respiro, enfasi. L’ascolto delle parole, il suono che sintetizza la voce materna in quella familiare musicalità che arresta il senso del tempo per catapultarci nello spazio-fiaba, rappresenta quello che potrebbe essere definito il nostro primo impatto con la coniugazione di forma e sostanza, il cui imprinting è così efficace da consentirci di reiterare questa piacevole esperienza con i nostri stessi figli, senza alcuna fatica. Se i molti studi sullo sviluppo del linguaggio hanno sottolineato l’importanza cruciale del condizionamento acustico nel bambino (durante il soggiorno uterino, galleggiamo cullati da suoni di acqua e parole lontane che sanno indicarci la direzione del benessere e, già nella prima settimana di vita, ogni neonato è capace di riconoscere la voce della propria mamma), non va dimenticato come l’uomo di tutti i tempi abbia insistito nel testimoniare la notevole affinità tra suono e percezione nella fase della crescita: nel pensiero platonico relativo al concetto di ethos, il suono, inteso sia come pratica vocale che strumentale, è considerato capace di agire sul carattere. La voce materna che racconta è, del resto, il primo momento formativo di sensibile importanza per il bambino. La parola, espressa nella sua valenza acustica dalla lettura, diventa strumento evocativo per il piccolo ascoltatore, il cui processo cognitivo è basato soprattutto su associazione, interiorizzazione e imitazione. La funzione sonora della fiaba si fa carico di responsabilità etiche di grande rilievo nei primi anni di sviluppo, poiché, caratterizzando personaggi, luoghi ed eventi attraverso un uso modulato del tono vocale, la voce materna è in grado di regolare, indirizzare, calibrare la percezione del bene e del male. Una perfida strega, se “intonata” con grazia e dolcezza, può sedurre la simpatia del bambino che, ammaliato come Ulisse dal canto delle sirene, manca all’appuntamento con la portata esemplare della narrazione fiabesca. «La voce della madre non gli parla solo di Cappuccetto Rosso o di Pollicino: gli parla di sé stessa così che il bambino è soprattutto interessato alla sostanza dell’espressione, alla voce materna, alle sue sfumature, ai volumi, le modulazioni, la sua musica che comunica tenerezza, che scioglie i nodi dell’inquietudine e fa svanire i fantasmi della paura…», scriveva Gianni Rodari nel 1971, quando la pubblicazione della Grammatica della fantasia aprì le porte a una maggiore sensibilità verso i condizionamenti di questo tipo di ascolto. Il suono della fiaba, del linguaggio materno così vicino e rassicurante, inizia il bambino a un percorso di conoscenza, evocando sensazioni trasversali che agiscono sulla sfera emotiva (incanto, sorpresa, paura), sui cinque sensi (impressioni visive, tattili, olfattive, gustative) e sullo stesso rapporto madre-figlio, per il contatto intimo, epidermico, sensuale, che viene a stabilirsi nel momento del racconto. Un aspetto, quest’ultimo, che ha saputo colpire ancora una volta il Rodari della Grammatica: «Mentre il fiume tranquillo della storia scorre tra i due, il bambino può finalmente godersi la madre a suo agio, osservare il suo viso in 15 Numero 6 giugno - luglio 2007 tutti i particolari, studiarne gli occhi, la bocca, la pelle… Per ascoltare, ascolta; ma si permette volentieri di distrarsi dall’ascolto – per esempio se conosce già la fiaba - e quindi deve solo controllare che essa si svolga regolarmente.» L’ascolto della fiaba realizza un autentico momento d’amore dello spirito – per trasmissione di conoscenza - e del corpo – per l’esaltazione dei sensi che ne consegue -, incastonato nell’esclusività del rapporto prezioso tra la madre e il suo piccolo. Un lusso di cui si gode da bambini e che, ormai adulti, possiamo rendere a nostra volta, traendone osmotico beneficio in un incanto senza tempo. La luce ovattata di una lampada predispone gli occhi e avvia il raccoglimento, un silenzio carico di attesa precede il racconto della sera. Come un rituale, la fiaba della buonanotte ha il suo microclima. E il suono della voce di mamma, che cullando racconta un’avventura sentita mille volte, ha un che di consolatorio, religioso, lenitivo, un’invocazione di pace che agisce da anestesia per l’inquietudine che non sa ancora addormentarsi da sola. Una fiaba ogni sera, una fiaba come una preghiera, prima di spegnere la luce. Un appuntamento che si fa rituale e veste la madre con i panni della sacerdotessa, custode di verità e meraviglia che intona le sfumature del bene e del male. I sensi si confondono, il respiro è più pesante, il dolce tono monocorde risuona. Non occorre aggiungere che vissero felici e contenti. La voce lieve della buonanotte ha rassicurato chi, al caldo di morbide coperte rimboccate, sta già sognando un lieto fine. 16 Numero 6 giugno - luglio 2007 La sfida della mente Le fiabe rappresentano un percorso psicologico in cui compaiono le scelte della psiche che nel processo di maturazione deve affrontare il difficile compito dell’integrazione del Bene con il Male. di Michela Gentili [email protected] Da bambini ci facevano compagnia. Ora che siamo cresciuti, possono aiutarci a capire chi siamo. Perché le favole rappresentano lo specchio del nostro inconscio. Per capire che cosa si nasconde dietro all’incantesimo del principe Ranocchio o perché la matrigna di Cenerentola ci fa ancora paura, abbiamo chiesto alla psicanalista Carla De Gennaro di spiegarci il valore simbolico di maghi, principi e matrigne. Un viaggio nel mondo della fantasia che diventa un percorso reale all’interno del nostra psiche. Ma le favole parlano davvero di noi? Sì, perché si inseriscono in un inconscio collettivo che è lo stesso per tutta l’umanità. Ogni storia individuale si radica su una psiche oggettiva, comune a tutti gli uomini e a tutte le epoche. Proprio su questo principio, composto da archetipi universali, si fondano le favole. Questo spiega la ricorrenza di personaggi, immagini e situazioni. Che struttura deve avere una favola per essere tale? Si compone essenzialmente di quattro fasi: l’esposizione, lo sviluppo, il culmine e lo scioglimento. L’esposizione è la contestualizzazione della favola che si svolge sempre in un luogo (un regno) e in un tempo (una volta) indefiniti perché la storia possa mantenere la sua validità e il suo valore archetipico al di là delle contingenze. Segue poi lo sviluppo della trama (una ragazza che non si vuole sposare, un principe che ha perso la fidanzata) che contiene sempre al suo interno un momento di svolta, detto culmine o peripezia (un mago che indica al protagonista il castello in cui è nascosta la principessa). La favola si conclude con lo scioglimento, una soluzione che di solito si attua con la formula “vissero felici e contenti”. Che cosa rappresenta questo percorso? È una metafora del processo di individuazione che ci aiuta a raggiungere la totalità della nostra psiche. Tutti i personaggi della fiaba rappresentano un aspetto dell’inconscio, sono figure archetipiche che devono essere integrate nella storia. Anche quelle negative? Certo. Questo processo verso la totalità include anche il Male che spesso è la forza motrice dell’evoluzione: costringe l’Io a crescere facendolo uscire da un paradiso terrestre illusorio. Le figure negative sono quindi uno strumento importante del processo di individuazione: l’incontro di Hansel e Gretel con la strega malvagia serve ai due protagonisti, che simboleggiano un Io immaturo, a crescere e consolidarsi. Un percorso completo presuppone un lieto fine che integri tutti gli elementi, compresi quelli malefici e diabolici. Per questo le favole finiscono sempre bene: quando il male viene reintegrato significa che è stata raggiunta la totalità della psiche. Perché c’è sempre un amore o un matrimonio che viene ostacolato? I protagonisti sono spesso una coppia che si è perduta, un uomo e una donna che devono ricongiungersi. Questo processo di ritrovamento rappresenta il nostro sforzo di integrare l’animus e l’anima, la parte maschile e femminile della nostra psiche. L’uomo, che è principalmente animus, cioè pensiero e razionalità, deve cercare di stabilire un rapporto positivo con la propria anima, che è fondamentalmente eros, 17 Numero 6 giugno - luglio 2007 sentimento. Al contrario, la donna anima dovrà cercare di far pace con la sua parte animus, composta di razionalità e discernimento. Per questo uno dei temi fondamentali è quello del matrimonio ostacolato: la coppia che deve ricongiungersi rappresenta queste due parti della nostra psiche. Spesso bisogna sciogliere un incantesimo. Che cosa significa? L’incantesimo simboleggia la perdita dell’Eden, della nostra natura incontaminata. Il principe Ranocchio e le fanciulle Cigno sono stati trasformati in animali perché la loro natura primordiale si è corrotta: l’Eden, in cui la psiche era completa, è scomparso e l’essere umano caduto sulla terra deve ritrovare la sua metà perduta. Così, bisognerà riconquistare la percezione originaria sciogliendo l’incantesimo: il bacio del principe sveglierà la Bella Addormentata e l’atto d’amore di una donna restituirà al Ranocchio le sembianze di un principe. Quando l’incantesimo finisce, l’animus e l’anima possono finalmente ricongiungersi. E i personaggi positivi che aiutano il protagonista che cosa rappresentano? La fata, il mago, il vecchio saggio e gli animali magici sono forze evolutive, elementi spirituali in senso psichico che avviano e promuovono il cambiamento. Trasformando la carrozza in zucca e regalandole un vestito per il ballo, la fata di Cenerentola interviene sul mondo psichico della fanciulla aiutandola metaforicamente a raggiungere il principe. Questi personaggi buoni rappresentano l’energia produttiva dell’inconscio che ci porta verso il Sé: sono spinte vitali e trasformative in grado di bilanciare le parti ombra che ostacolano il nostro cammino. Quali sono invece le figure negative e che ruolo hanno all’interno dell’inconscio? La più comune è la matrigna, che rappresenta un complesso materno negativo, cioè un cattivo rapporto con la madre. Solitamente ne è vittima la donna, difficilmente infatti nelle fiabe si trovano uomini maltrattati da una matrigna. Il rapporto con la madre è più conflittuale nella figlia, perché tra due figure dello stesso sesso si crea rivalità: per questo la matrigna è sempre gelosa e invidiosa. Ma nelle fiabe spesso appare anche una strega, che per la donna può rappresentare una parte ombra rimasta poco sviluppata oppure gli impulsi malvagi e repressi della psiche. Per l’uomo, invece, simboleggia un’immagine degradata e pericolosa di femminilità. Possiamo poi ritrovare l’archetipo dei genitori snaturati, come quelli di Pollicino che non possono sfamare tutti i figli e lo abbandonano nel bosco. In questo caso si tratta di un complesso negativo che comprende entrambi i genitori. Vi sono infine varie figure ombra che ostacolano il processo di reintegro della psiche, come il diavolo, lo stregone, il mago: rappresentano aspetti di cui abbiamo paura legati agli istinti, alle pulsioni, alla sessualità. Per completare il processo di individuazione del Sé, utte queste forze devono integrarsi in un lieto fine. È possibile, quindi, curarsi con una fiaba? Analizzando una favola preferita si può rintracciare il panorama interno di una persona. Con la tecnica dell’“amplificazione”, durante la terapia il paziente può imparare a ritrovare nelle favole i suoi comportamenti tipici. Non va dimenticato, però, che questo passaggio di livello può portare fuori strada: le favole possono rappresentare metaforicamente i problemi ma non devono mai costituire una scappatoia per eluderli. 18 Numero 6 giugno - luglio 2007 Le mani di Edward Edward Mani di Forbice è una straordinaria fiaba moderna in cui gli elementi tradizionali migrano sul grande schermo senza perdere nulla delle classiche suggestioni. Tim Burton racconta l’eterno tema della creatura diversa, orfana, straordinariamente sensibile. Dalla sua ferita, nasce anche il suo dono... di Kusanagi [email protected] “Don’t Judge a Book by His Cover” The Rocky Horror Picture Show Ci voleva il genio inconsueto, dolce e malinconico di Tim Burton, per raccontare la fantastica e triste storia dell’uomo dalle mani di forbice, creato un giorno da un anziano inventore che, un po’ dottor Frankenstein e un po’ Geppetto, decise di dar vita a una macchina, materializzando così il sogno di tramutare un robot in un essere vivente, dotato di pensiero e di coscienza di sé, ma soprattutto di un cuore e di un’anima, un cuore che lo avrebbe fatto soffrire come capita a tutti noi umani, ma capace anche di farlo gioire, e sorridere, e un’anima capace di fargli sentire di esser vivo perchè finalmente amato, perchè non più solo. Raccontato come una favola della buonanotte agli spettatori, la storia del film prende le sue mosse in un piccolo villaggio, mentre la neve scende copiosa dal cielo, e lo spunto narrativo da cui nasce è una di quelle innocenti domande che solo i bambini sanno porci, a cui noi adulti rispondiamo ricorrendo alla fantasia, perché la realtà è troppo piatta, e monotona, per esser rivelata a coloro che ancora ignorano, nella innocenza dell’età, quanto possa esser crudele ed arido il cuore degli uomini, soprattutto quelli ai quali l’età adulta ha portato via i sogni e il sorriso dell’infanzia. E così, magicamente, prende vita sotto i nostri occhi la fiaba di Edward Mani di Forbice, con una nonna dai capelli imbiancati che comincia a raccontare la sua storia, a fianco dell’enorme letto dove la ascolta la sua nipotina, sepolta sotto la sua enorme coperta, grande come può esserlo solo agli occhi di una bimba piccina piccina, per spiegarle il motivo per cui d’inverno nel suo villaggio cade la neve. La vicenda del pupazzo di carne e ossa, ma dalle mani di forbice, comincia in un sobborgo americano qualsiasi, molto simile a un piccolo villaggio da fiaba, abitato da persone qualsiasi che fanno lavori qualsiasi, ma con una singolare particolarità, e cioè quella di avere un sinistro castello gotico sulla collina in fondo alla strada, quasi come se fosse un’astronave atterrata lì dalla lontana Transilvania, proprio come la villa di Frank’n’furter di The Rocky Horror Picture Show, pellicola con cui Edward Scissorhands ha in comune sicuramente la tematica della diversità, e un protagonista “alieno” rispetto all’ambiente che lo circonda. Nella tranquilla cittadina con le case dai colori pastello, Peg, madre di famiglia nonché dimostratrice di prodotti di bellezza porta a porta, spinta un giorno dalla scarsità degli affari e dalla sua ingenua intraprendenza, si avventura fin dentro al tenebroso castello che, dapprima tetro ed abbandonato, si rivela pian piano come un luogo avvolto da un’atmosfera magica, con un giardino che pare animato dalle creature d’erba che lo abitano, vere e proprie sculture, frutto del talento di un artista sconosciuto. Ben presto, penetrata nel castello spettrale e in totale abbandono, fa un’incontro che cambierà la vita sua e di tutte le persone che le stanno intorno: conosce infatti l’unico abitante rimasto nel castello, una bizzarra creatura dal carnato pallido e dai capelli corvini, con uno sguardo da Pierrot triste, e con dei terribili cespi di forbici al posto delle mani, Edward. Lui le racconta la sua storia delle sue origini e di come sia stato creato da un anziano inventore, e di come 19 Numero 6 giugno - luglio 2007 la morte gli abbia impedito di completarlo dotandolo di un paio di mani come quelle di tutti. Mossa a compassione dalla solitudine della creatura e spinta da un’insopprimibile istinto materno, decide di accoglierlo nella sua casa, e di fare il possibile per toglierlo dalla sua triste condizione, cercando di farlo accettare dalla comunità del villaggio, subito curiosa nei confronti del nuovo arrivato dall’aspetto così insolito. Il nuovo arrivato, dopo un iniziale sospetto, anche grazie agli sforzi della padrona di casa viene accolto con interesse sempre crescente dalla piccola comunità del villaggio, per quell’elemento di novità e di insolito che spezza il consueto tran tran quotidiano dei mariti che partono per il lavoro alla mattina e delle casalinghe che passano il loro tempo tra shopping, il parrucchiere e le chiacchiere tra amiche. Interesse che cresce quando Edward mostra le doti che le sue inconsuete estremità gli consentono, inizialmente solo come abile e creativo giardiniere, poi come coiffeur per cani, per finire con il ruolo di raffinato parrucchiere per signora, al punto che nessuna delle signore può fare a meno di adottare il suo stile di pettinatura bizzarro e singolare. Ciò che da subito salta agli occhi è proprio la divisione tra ciò che la creatura Edward sa fare, ovvero la sua capacità creativa, e il suo aspetto esteriore mostruoso e deforme, come a voler sottolineare uno dei temi principali del racconto, e una delle sue morali: il valore delle azioni al di là delle parole e dell’inganno che spesso si nasconde dietro l’aspetto fisico, che non può essere preso come metro di giudizio per giudicare un qualsiasi essere vivente, nel bene ma soprattutto nel male. Come nella Bella e la Bestia, fiaba che riecheggia in quella di Tim Burton, il vero mostro è rappresentato dall’antagonista “umano” di Edward, nonché suo rivale in amore, che rappresenta il genere umano nel suo lato peggiore, e quindi in tutta la sua falsità, arroganza e violenza, mentre per contro la creatura è di animo gentile e sincero, fondamentalmente buono anche se certamente irrazionale e istintivo in alcune sue reazioni. I problemi per il nostro eroe sorgono proprio nel momento in cui, oltre che essere un oggetto curioso da ammirare o uno strumento da utilizzare per il proprio personale divertimento o piacere, comincia a mostrare di avere propri sentimenti e desideri, in particolare quando si rende conto di aver trovato il suo amore, e quindi idealmente la sua principessa, visto che di fiaba si tratta, ovvero Kim, la figlia adolescente di Peg. Lei dapprima non capisce i sentimenti di lui, abituata com’è a giudicare superficialmente, con gli occhi e non con il cuore, e a considerare l’amore come un sentimento giocoso, da non prendere troppo sul serio, un modo per sentirsi corteggiata ed essere al centro dell’attenzione, atteggiamento più che normale data la sua giovane età, e forse proprio il fatto di non esser più il centro dell’attenzione nella famiglia la indispettisce ancor di più nei confronti del nuovo arrivato. Ma poi impara ad apprezzarne la vera natura, andando al di là del suo aspetto esteriore, e riesce a vedere in lui la generosità di un animo nobile e gentile e la purezza di cuore, purezza degli innamorati che viene rappresentata in una delle scene più toccanti ed evocative del film, in cui per la prima volta Edward “crea” la neve: infatti, alla vigilia di Natale, mentre tutti si dedicano ad addobbare i giardini, Edward con il suo estro creativo concentra le sue lame su un blocco di ghiaccio, creando una scultura di un angelo con il volto della ragazza, e generando di conseguenza una pioggia di neve intorno a sé, una candida neve in cui Kim comincia a danzare, ispirata dalla magia del momento. Anche lei comincia così a comprendere quali sono i suoi veri sentimenti, e per il nostro eroe cominciano i guai, perchè in tal modo attira verso di sé l’odio del fidanzato di lei, Jim, si scontra con la sua malvagità e i suoi pregiudizi, e di conseguenza anche con quelli di tutti gli abitanti del villaggio, che gli voltano rapidamente le spalle per il suo aspetto esteriore “mostruoso” e per la sua fraintesa pericolosità, montata ad arte dal suo antagonista in amore. Amareggiato dalla sfiducia e dal pregiudizio delle persone attorno a lui, ad eccezione della famiglia che l’ha accolto, decide quindi di rifugiarsi di nuovo nel suo castello, luogo in cui però fatalmente gli eventi precipitano, perché nel tentativo di difendersi dall’assalto del fidanzato di lei, che l’ha seguito con il preciso intento di eliminare il “mostro”, Edward finisce per ucciderlo gettandolo dalla torre del castello. Quando la folla inferocita giunge al castello, in una scena che è un esplicito omaggio al mito di Frankenstein, il dramma si è già compiuto e il destino del nostro eroe è segnato: la solitudine diviene l’unica possibilità per continuare a vivere per Edward, un esilio reso sopportabile dal romantico e struggente ricordo della 20 Numero 6 giugno - luglio 2007 sua amata, che per placare l’ira della folla mostra un cespo di forbici, facendo loro credere che il “mostro” sia morto nel crollo del tetto. Profondamente significativo a nostro avviso è il fatto che lei scelga proprio di mostrare la parte anatomica di Edward che rappresenta la sua anomalia, perché simboleggia la percezione che hanno di lui le persone estranee, quelle che non lo comprendono o non vogliono comprenderlo, barricate dietro ai loro pregiudizi, riconducendo la complessità dei sentimenti e la profondità di una persona alla banalità di un mero tratto somatico. Proprio quelle forbici al posto delle mani che rappresentano efficacemente l’incapacità del protagonista di afferrare o possedere alcunché, siano esse cose o persone, caratteristica che permette al regista di mettere in evidenza il suo modo d’amare, il più puro, perché privo del desiderio di possedere l’altro, ma spinto solo da quello di donare se stesso. Al di là dei significati che vi si possano trovare, la magia della fiaba così magistralmente raccontata da Tim Burton ci restituisce intatto il fascino dei racconti attorno al focolare, e ha l’incanto delle storie che fanno restare a bocca aperta i bambini di fronte ai genitori o ai nonni mentre questi svelano loro strabilianti segreti e dischiudono mondi fantastici, e fa nascere in noi adulti che la ascoltiamo quello stupore fanciullesco che pensavamo dimenticato, che ci riporta indietro nel tempo, nel periodo in cui ancora credevamo a Babbo Natale, e in cui ogni nevicata era fonte di gioia e di meraviglia. Merito della riuscita della storia va certamente attribuito anche all’interpretazione di Johnny Depp, che nei panni del protagonista riesce, con una mimica facciale ispirata ai grandi del muto come Charlie Chaplin, ad esprimere pienamente la gamma dei sentimenti di Edward e a dare intensità e spessore al suo personaggio. Per le atmosfere della pellicola, oltre che alle scenografie ideate da Burton, bisogna ringraziare la partitura musicale di Danny Elfman, certamente una delle più ispirate del sodalizio con il regista (a cui si deve anche un’altro gioiello come Nightmare before Christmas), e che qui contribuisce in maniera decisiva ad impostare e a sottolineare il tono romantico, struggente e fiabesco del racconto. Vale la pena infine di spendere le ultime parole per ricordare la grandezza di un attore come Vincent Price, qui in una delle sue ultime apparizioni sul grande schermo, vero e proprio attore feticcio e fonte d’ispirazione per l’opera di Burton, che con pochi tratti e poche battute, con le sue espressioni sa donare vitalità e poesia al personaggio dell’inventore, silenzioso demiurgo di tutta la vicenda, creatore della singolare e gentile creatura nota al mondo come Edward Mani di Forbice. Kusanagi www.lavitaenientaltro.splinder.com Per approfondimenti sul film: http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=28546 http://www.cineblog.it/post/4125/cineblog-consiglia-edward-mani-di-forbice http://www.timburtonline.com/ http://it.wikipedia.org/wiki/Tim_Burton 21 Numero 6 giugno - luglio 2007 Il rovescio della fiaba Tradizione e innovazione nell’opera di Gianni Rodari Per lo scrittore di Favole al telefono la fiaba diventava utile stumento dell’utopia, non della conservazione. Ma allo stesso tempo, non riusciva a non sentire il fascino del mondo antico. Perché, malgrado applicazioni e interpretazioni, quel magico mondo ci parla da sempre. Anche quando ne usiamo un’immagine rovesciata, come accade, guarda caso, in uno specchio... di Barbara Ronca [email protected] La fiaba popolare è, assieme al romanzo, il genere letterario che maggiormente ha contribuito a formare l’immagine culturale dell’Europa moderna. È in particolare nell’Ottocento che vengono curate le più importanti raccolte di fiabe del vecchio continente, e lo studio della loro lingua e struttura è parte integrante del processo romantico di formazione del concetto di identità nazionale. La vera anima popolare (il volkgeist cercato dagli Schlegel, da Novalis, dai Grimm) si rispecchia in questo genere letterario, che diviene così, nelle parole di Herder, «un tesoro per il poeta e per il difensore del proprio popolo»; la fiaba ha quindi racchiusa in sé una travolgente forza di rivoluzione sociale, quando non politica. Quello della fiaba è un genere però, per così dire, sterile: proprio perché basato sulla tradizione folklorica e orale, può solo essere ascoltato e trascritto, certo non creato: una fiaba popolare smette di essere tale nel momento in cui non è più espressione della voce di un popolo ma di quella di un autore. Gianni Rodari (scrittore rivoluzionario del nostro Novecento che da subito si avvicina alle formule tipiche del racconto orale – esemplare in questo senso il ricorso ai dialetti, ai proverbi, la sperimentazione sul genere della filastrocca e, appunto, della fiaba) rende fecondo questo genere sterile; ne fa genere che si può creare, senza modificarne sostanzialmente le strutture linguistiche e stilistiche, ma rovesciandone, spesso, i contenuti; genere che influisce sull’attualità, sulla vita della gente comune, della cui voce, naturalmente, si nutre. Fin dai suoi esordi come giornalista di partito (negli anni ’50 Rodari lavora per diversi periodici del PC) è forte l’impegno politico che l’autore riversa nelle sue opere destinate ai ragazzi. («Sono soprattutto le cose da dire – dice Argilli nella sua minuziosa biografia rodariana – ciò che allora contava per lui»); stilisticamente, invece, l’autore “tentenna”, sperimentando la sua scrittura giorno per giorno, mescolando stili e generi letterari, non imponendosi canoni o regole. Non avendo ancora maturato una seria riflessione su cosa sia la letteratura ‘destinata ai bambini’, Rodari produce in questo periodo opere meno rifinite ma spesso socialmente molto più incisive di quelle che lo porteranno al successo negli anni ’60. Forse proprio per dar voce a questa passione civile, tra i tanti generi letterari in cui si cimenta, sviluppa una particolare predilezione per la fiaba: perché spiegare la società ai bambini richiede uno strumento che essi possano capire; e perché le sue fiabe, in un periodo di forte tensione morale e politica (come direttore del Pioniere Rodari fu anche scomunicato), possono affondare le radici nell’attualità e comunque vantare dei personaggi tipici delle vere märchen: definiti, senza sfumature; totalmente buoni o totalmente cattivi. Erano anni, come scrive Pino Boero (p.96), in cui ‘si poteva consegnare un messaggio di speranza solo attraverso posizioni politiche nette e precise (…) l’antagonista, il “cattivo” della letteratura giovanile tradizionale diventava il nemico di classe, il ricco, il padrone…. Per la prima volta in una fiaba ad essere crudele non è una strega, ma un ministro della guerra; il mondo del fantastico si popola di sirene di fabbriche, di pensionati e di palazzi di periferia, e i suoi eroi sono bambini i cui genitori fanno i fornai, gli spazzini, gli 22 Numero 6 giugno - luglio 2007 operai: eppure, rispetto alle fiabe dell’Ottocento, la sostanza non cambia. La fiaba torna alla sua originaria e fondamentale funzione di esaltare il ruolo degli umili e unificare tutto il popolo sotto un’unica bandiera culturale. Mantiene la sua struttura tipica (proppiana, direi) ma si colloca qui e ora, non in un passato mitico e atemporale. È lo stesso Rodari, dopo aver letto le Fiabe italiane di Calvino pubblicate da Einaudi nel 56, a sottolineare la fondamentale importanza che questo genere letterario ha nella formazione di una coscienza nazionale: riflettendo sul fatto che le maggiori raccolte di fiabe europee furono realizzate nell’Ottocento, Rodari si chiede: «Perché invece la grande raccolta di Calvino è arrivata solo (…) dopo la seconda guerra mondiale?’ La risposta è semplice: ‘...l’autore di questo libro è il popolo italiano’, ed è stato possibile sentire la sua voce ‘soltanto in un momento di grande unità nazionale, come è stato subito dopo la guerra, quando il popolo italiano è diventato protagonista della sua storia.» (G. Rodari, I 5 libri, p. 717). Il 1960 è per Rodari un momento fondamentale: entra a far parte della scuderia Einaudi, divenendone presto, insieme proprio a Calvino, la punta di diamante. Gli anni ‘60 sono per lui i più fecondi, letterariamente parlando: il suo pubblico si allarga, la sua fantasia si dispiega libera e raggiunge vaste fasce di popolazione prima precluse (cioè tutti quei ragazzi i cui genitori non leggevano giornali di partito). E sempre in questo periodo cresce il suo interesse per la fiaba, di cui scuote ridendo le fondamenta; e i cui personaggi, schemi, tic linguistici divengono strumento di una divertita rivoluzione – nelle Favole a rovescio della raccolta Filastrocche in cielo e in terra, ad esempio, «Biancaneve bastona sulla testa/ i nani della foresta,/ la Bella Addormentata non si addormenta/ il Principe sposa una brutta sorellastra…» – (p. 129). Con Favole al telefono, del ’62, si ritorna in carreggiata, lo scherzo si acquieta: non è un caso che la brevissima prefazione del libro inizi con la formula classica c’era una volta…, che ne fa un racconto a cornice, come la raccolta di fiabe per eccellenza, le Mille e una Notte, o come Il Cunto de li cunti di Basile. Anche nelle Favole rodariane i demoni notturni vengono cacciati dal raccontare, ma la moderna Sherazade è il ragionier Bianchi, di Varese, rappresentante di commercio. La narrazione, il cui destinatario non è un crudele sovrano ma la bambina del ragioniere, che non dorme senza aver ascoltato una storia, avviene per via tecnologica, ipermoderna: cioè, attraverso il telefono; ep»pure, le storie narrate sono tanto belline, dice Rodari, che anche le centraliniste, ogni sera, smettono di lavorare per ascoltarle: il fascino della fiaba è davvero senza tempo. Ma è pur sempre una fiaba moderna, mediata dall’ironia, quella di questa raccolta di racconti: essa si fa più giocosa (ci sono vecchine che contano gli starnuti, piovono confetti dal cielo, sorgono palazzi di gelato) ed entra nel quotidiano del lettore: il centro dell’azione non è più un reame lontano lontano, ma Busto Arsizio o Piombino; l’oggetto magico è il bastone di un vecchio, il viaggio di formazione dell’eroe è quello surreale (molto deve Rodari al surrealismo) di Giovannino Perdigiorno che cammina e cammina per andare a toccare il naso del re. Alcuni racconti (I capelli del gigante, La strada che non andava in nessun posto, Il re che doveva morire) riprendono con precisione lo schema tipico di alcune fiabe, trasportandolo su un terreno più conosciuto e quotidiano, ma mantenendo forti i temi del magico, del miracoloso; altre, come la divertente A sbagliare le storie, divengono semplice calembour linguistico, pretesto per ridere: in questo dialogo tra nonno e nipotina, infatti, lui narra una fiaba sbagliandone così grossolanamente la trama («C’era una volta una bambina che si chiamava Cappuccetto Giallo» «No, rosso!» «Ah, sì, Cappuccetto Rosso. La sua mamma la chiamò e le disse: senti, Cappuccetto Verde…» «ma no, Rosso!» «Ah, sì, Rosso. Vai dalla zia Diomira a portarle questa buccia di patata») che la bimba rinuncia alla narrazione. «E il nonno – conclude sorridendo Rodari – tornò a leggere il suo giornale». Dopo il 1969 la salute e lo stile di Rodari vanno peggiorando. La vena creativa che aveva raggiunto lo zenit negli anni 60 va affievolendosi. È mutato il paese, politicamente e socialmente, e con lui lo scrittore: «Rodari – dice ancora Argilli - non parte più lancia in resta». Forse per questo il rapporto con la fiaba si allenta. Nel ‘70, infatti, lo scrittore disse: «Le fiabe sono alleate dell’utopia, non della conservazione. E perciò (…) noi le difendiamo: perché crediamo nel valore educativo dell’utopia, passaggio obbligato dall’accettazio23 Numero 6 giugno - luglio 2007 ne passiva del mondo alla capacità di criticarlo, all’impegno per trasformarlo. Venuta meno la possibilità di quella trasformazione, anche la fiaba perde quindi il suo ruolo, il suo valore». Lamberto, barone protagonista del romanzo che da lui prende il titolo, nasce in questo momento di cedimento fisico, di nostalgia per il passato. In qualche modo questo libro è quasi un sunto dell’inesausta attività di Rodari di rottura verso i generi canonizzati. Con lui lo scrittore rompe definitivamente le regole della fiaba, a partire dall’irrinunciabile incipit c’era una volta…; qui addirittura l’eroe c’è due volte, e percorre a ritroso il passaggio obbligato del protagonista del racconto fiabesco: egli infatti è di solito un ragazzo, un giovanetto o una ragazza che, dopo molte avventure, diventano un principe o una principessa, si sposano e danno un gran pranzo. Questa favola, invece, comincia con un vecchio di novantaquattro anni che alla fine, dopo molte avventure, diventa un ragazzino di tredici anni’; si affaccia alla vita, quindi, per la seconda volta. Il romanzo, ambientato nelle regioni dell’infanzia dell’autore (è la prima volta che Rodari s’incaponisce perché i luoghi natii siano lo sfondo di una avventura da lui narrata) appare subito poco adatto ad un pubblico di bambini, e pare probabile che l’autore l’abbia scritto più per se stesso che per i ragazzi. Lamberto rappresenta la speranza di uno scrittore malato e stanco, che sempre ha usato la fiaba per narrare la realtà, di non morire, di acquistare forza dalla narrazione di una rinascita miracolosa come Lamberto la acquista dal sentir ripetere il suo nome. Se le fiabe sono, come dicevamo, le alleate dell’utopia, il sogno dell’esserci due volte, di tornare indietro alla giovinezza è l’ultimo regalo che questo genere fa ad un autore che lo ha sempre omaggiato. Rodari morirà il 14 aprile 1980, a soli sessant’anni. Il suo non è un lieto fine come quello delle fiabe, e la sua morte inaspettata riempie di sgomento i suoi amici e i tantissimi ammiratori, grandi e piccoli; sembrerà, col senno di poi, quasi profetico l’ultimo paragrafo di C’era due volte il Barone Lamberto, ma forse a rileggerlo vi si troverà coraggio e consolazione: ‘Non tutti saranno soddisfatti della conclusione della storia.’ recita infatti il brano, che ottimisticamente prosegue: ‘A questo però c’è rimedio. Ogni lettore scontento del finale, può cambiarlo a suo piacimento, aggiungendo al libro un capitolo o due. O anche tredici. Mai lasciarsi spaventare dalla parola FINE’. Anche qui, come in ogni fiaba che si rispetti, Rodari ci lascia una morale: quando si hanno le fiabe come alleati, sembra dirci, si può diventare capaci di non temere nemmeno la morte. Approfondimenti: http://www.giannirodari.it/ http://www.sbagliandosinventa.it/rodari_index.php http://www.indire.it/Rodari/ 24 Numero 6 giugno - luglio 2007 Il logos e la fiaba Per Platone la conoscenza fatica a procedere per trasmissione in quanto non è un possesso stabile. Ma ecco che il mito e la fiaba soccorrono il filosofo che vuole raccontare quella verità capace di sollevare il velo dell’ignoranza, tirando fuori l’uomo dalla caverna delle illusioni. Il segreto sta nella narrazione... di Stefano Petruccioli [email protected] «Sarebbe bello, Agatone, se la sapienza fosse fatta in modo da scorrere, se ci tocchiamo l’un l’altro, da chi di noi ne è più pieno a chi ne è più vuoto, così come nelle coppe l’acqua scorre attraverso il filo di lana, dalla più piena alla più vuota» (Simposio, 175 d). È dunque impossibile, secondo Platone, una trasmissione, un baratto di qualità tra un uomo e un altro. Ma, del resto, l’uomo è caratterizzato dall’inconsistenza della propria stessa natura, dalla mancanza di un’essenza stabile, dall’impossibilità di essere definito e descritto definitivamente, perché durante la propria esistenza cambia continuamente, costantemente (ibid. 207 d - 208 a). Non solo, dunque, non ci può essere una qualsiasi trasmissione o baratto, ma non c’è neanche un qualunque possesso: c’è, invece, il nulla che attraversa, come un brivido che sempre si rinnova, l’essere di ogni uomo. Anche la sapienza e tutte le conoscenze nascono e periscono, cambiano, non sono mai identiche, non sono, in definitiva, un possesso dell’uomo. La stessa sapienza di Socrate «vale poco, o addirittura è discutibile, simile ad un sogno» (ibid., 175 e). Platone, quindi, non può contrapporre a un falso sapere altrui un proprio sistema certo di conoscenze, un proprio solido possesso, bensì solo presentare una consapevolezza precisa del nulla, un’inquietudine, una tensione. Ma se non c’è un contenuto sapienziale posseduto e trasmissibile, insegnabile, se la conoscenza rimane, alla fine, inattingibile, cosa resta, allora, della filosofia? Che cos’è la filosofia? Il personaggio di Parmenide, nell’omonimo dialogo platonico, dovendo discutere delle più fondamentali questioni dell’essere, afferma che, apprestandosi a questo arduo compito, si prepara a «giocare questo gioco laborioso» (Parmenide, 137 b). La discussione filosofica sarebbe, quindi, un “gioco laborioso”, un gioco serio, e il dialogo che segue a questa affermazione «avviene veramente in forma di un gioco di domande e risposte. […] Il ragionamento viene capovolto, e poi ancora e ancora una volta. L’argomento va su e giù come una spola, e la saggezza assume forma nel movimento di un nobile gioco» (Johan Huizinga, Homo ludens, Einaudi, Torino, 2002, p. 176). La filosofia è, dunque, un gioco, un esercizio, un «allenamento» (Parmenide, 135 d). Quello che rimane è la filosofia come gioco vitale e inventivo, come divertente esercizio di cui i concetti della dialettica, eterogenei rispetto alla verità, incapaci di incatenarla e contenerla, sono gli strumenti inessenziali. Se il dialogo filosofico non è un processo che arriva alla verità, esso è, però, una via propedeutica per il suo eventuale momentaneo accoglimento: «Senza questo procedere peregrinando attraverso tutte le vie, è impossibile, imbattendosi nella verità, averne intendimento» (ibid, 136 e). Nella verità, dunque, ci si “imbatte”: il verbo greco qui utilizzato è entunchàno, che presenta, al suo interno, un richiamo alla parola tùke, cioè “caso”, “fortuna”. Per imbattersi nella verità, per incontrarla, è necessario seguire un pensiero di tipo “peregrino”, pronto a ricominciare sempre dall’inizio i propri percorsi, una “ragione errabonda”, un «ragionamento illegittimo» (Timeo, 52 b), bastardo, non un ordinato percorso di deduzioni e argomentazioni, ma uno affidato ai suggerimenti dell’immaginazione, alla creatività della narrazione di favole. Come Socrate afferma ragionando a proposito della natura dell’anima: «Definire quale essa sia, sarebbe una trattazione che assolutamente solo un dio potrebbe fare e anche lunga, ma parlarne secondo immagini è impresa più umana e più breve. Questo sia dunque il modo del nostro discorso» (Fedro, 246 a). Delle realtà ultime, più vere, quindi, l’uomo può parlare solo secondo immagini, può esprimerle solamente con delle parole e con un pensiero obliqui ed indiretti, che procedono per ammiccamenti, solo attraverso il racconto di belle favole. La conoscenza di ciò che diviene, del cosmo, della storia e della vita, può avere solo la forma di una storia narrata. Per fare filosofia serve, dunque, saper raccontare favole, miti; «serve un poeta e mitologo più austero e 25 Numero 6 giugno - luglio 2007 meno piacevole» (Repubblica, III, 398 a-b), certo, di quelli tradizionali, ma pur sempre un poeta e mitologo. «Se realmente non è utile agli dèi il falso, e lo è invece agli uomini come può esserlo un farmaco, è chiaro che l’uso di questo farmaco è riservato ai medici: non è cosa che competa a privati qualunque» (ibid., III, 389 b); allo stesso modo, narrare favole che siano utili compete al filosofo: poesia e favola accettabile è quella creata dal filosofo quando fa uso del mito, artificio indispensabile per parlare dell’essere, poiché la tecnica delle immagini, dei simboli, delle allegorie, la drammatizzazione che il mito introduce, sono ciò che permette di suggerirlo. «Rappresenta perciò un compito particolare il fatto che […] il modo mitico di narrare e la spiegazione teoretica […] siano tradotti in atto in un reciproco intreccio» (Hans Georg Gadamer, Studi platonici, 1, Marietti, Genova, 1998, p. 100). Mito e logos, favola e ragionamento, cioè, meritano un’uguale valutazione: né il mito è sottomesso al logos, né veicola una verità superiore che al logos risulta irraggiungibile (non si può propriamente parlare di un contenuto di verità maggiore del mito, di una sorta di irrazionalismo). Non c’è una subordinazione della favola al logos, essa non è un puro ornamento superfluo, ma esiste un intreccio saldo tra i due. «La capacità che hanno immagini e narrazioni di esporre uno stato di cose in maniera comprensiva e intuitiva, funge da contrappunto insostituibile all’analisi concettuale. A guardarlo in questo modo, il mito appare come una seconda via d’accesso alla realtà che, pur non potendo prescindere dal logos per quanto concerne il contenuto, presenta tuttavia nei suoi confronti un plus che non può essere sostituito in nessun altro modo» (Thomas A. Szlezák, Come leggere Platone, Rusconi, Milano, 1991, p. 143). Tra favola e logos esistono, dunque, dei nessi strutturali che non fanno della prima né un residuo di riflessione pre-filosofica, né una formulazione provvisoria, e neppure una forma di conoscenza di tipo mistico e quindi di carattere irrazionale. La mitologia, al contrario, è essa stessa una forma di logos, che si esprime mediante la favola, il racconto. Il mito, «ben lungi dall’essere un arbitrio, si fonda bene addentro nella natura dell’essere stesso e della conoscenza umana di questo essere» (Paul Friedländer, Platone, Bompiani, Milano, 2004, p. 237). Anche la narrazione di una favola è un pensiero, non è solo un rappresentare immagini ma è un pensare per immagini e raffigurazioni: è «un linguaggio di figure, che si organizza in un vero e proprio racconto analitico, che non port[a] alla certezza, ma che addirittura fond[a] un sapere dell’incertezza» (Franco Rella, Pensare per figure. Freud, Platone, Kafka, il postumano, Fazi Editore, Roma, 2004, p. 10), come si è visto. Che «non si tratt[i] affatto di un momento razionale e discorsivo e di un momento soprarazionale, intuitivo, mistico, ma dello stesso processo razionale» (Francesco Adorno, Platone, Laterza, Bari, 2002, p. 12), che esista una profonda affinità tra favola e logos, è sottolineato esplicitamente dallo stesso Platone: «un bel discorso, che tu, credo, riterrai un mito, ma io un ragionamento» (Gorgia, 523 a); e ancora: «probabilmente, questo, a te sembra un mito, di quei miti che narrano le vecchie, e non t’invita a pensare» (ibid., 527 a). E sempre lo stesso Platone definisce i suoi scritti favole e miti: in essi, egli si svaga dilettandosi «con le parole, fantasticando discorsi» (Fedro, 276 e) e fa «un racconto a mo’ di fiaba» (La Repubblica, II, 376 d), espone «a parole, come una favola» (ibid., VI, 501 e) le sue meditazioni. Si deve riflettere con la ragione e meditare attraverso i miti: «meditare e favoleggiare» (Fedone, 61 e), una sinergia e armonica simbiosi, perché «logos e mito sono la “sistole” e la “diastole” del cuore del pensiero platonico» (Giovanni Reale, Platone. Alla ricerca della sapienza segreta, BUR, Milano, 2004, p. 279). Così, le favole e i miti possono preludere come un gioco a un rigoroso e responsabile logos, possono guidare i sentieri in cui ci si imbatte nell’essere, nella verità, possono spostarsi al centro dell’opera e riempirla interamente come una fiaba raccontata che deve solo essere ascoltata, possono anche essere fonte di piacere letterario. Delle condizioni dei fondamenti non si può parlare che per immagini, narrativamente, descrittivamente e «solo ipoteticamente (miticamente) si può sostenere che le trame entro cui si articola e si svolge in unità il pensiero corrispondono alle stesse trame su cui in unità si articola il tutto, la “natura”» (Francesco Adorno, cit., p. 11). Questo rende necessarie le favole platoniche, e rende necessaria la loro molteplicità: non basta una sola favola. L’esperienza della verità che si ha non garantisce un possesso del sapere, non riempie l’esistenza degli uomini. Sono, perciò, necessarie ulteriori ricerche e fatiche, ulteriori narrazioni e racconti; si deve continuare a giocare il “gioco laborioso” della filosofia. L’impossibilità di un possesso stabile del sapere, di una contemplazione continuativa della verità, la cui luce è, ad un tempo, illuminante ed accecante, «apre e limita al tempo stesso l’esercizio della dialettica» (Jacques Derrida, La farmacia di Platone, Jaca Book, Milano, 1985, p. 150) e della mitologia filosofiche, essendo condizione di un discorso non solo sempre obliquo ed indiretto, ma anche sempre incompiuto, da continuare. Non potendo comunicare in maniera esplicita una qualche verità, non potendo, quindi, affrontare il problema della sapienza con una domanda diretta, ma dovendo narrare favole, il dialogo filosofico deve fondarsi su di una dialettica «sempre pronta a cominciare da qualsiasi domanda particolare: si può cominciare a parlare con qualsiasi parola» (Maurice Blanchot, L’infinito intrattenimento, Einaudi, Torino, 1977, p. 21), si può cominciare a raccontare in moltissimi modi. A questa passione per la domanda, per la ricerca, per la narrazione, va unita una critica a tutto ciò che si è potuto acquisire in precedenza, poiché non ci si deve “affezionare” troppo ai significanti, che non sono lo specifico della comunicazione filosofica, non essendo in grado di rappresentare né di significare la verità, ma solo strumenti e giocattoli intercambiabili. Tutto ciò, fa sì che il dialogo filosofico sia, in linea 26 Numero 6 giugno - luglio 2007 teorica, un “infinito intrattenimento”, la cui finitezza concreta è imputabile solo a fattori esterni: nessuno dei parlanti, infatti, può arrogarsi il diritto all’ultima parola, alla favola finale e definitiva, poiché nessun detto può esaurire l’argomento che, più che trattare, si sta “frequentando” nell’esercizio dialettico e narrativo, nessun detto può esprimere in maniera definitiva la verità cui, tuttavia, sempre si allude. Se esistesse, questa parola definitiva segnerebbe la fine del conversare, del raccontare, dello stare in comune. Essendo tale parola assente, la filosofia rimane un gioco serio ed infinito. Le favole continuano a essere raccontate. 27 Numero 6 giugno - luglio 2007 Quando la fiaba va al cinema I film non sono solo evasione o avventura. Spesso attingono a un mondo antico di cui conservano i sapienti tesori simbolici, anche se in modo inconsapevole. Quella dell’Eroe in lotta contro il Male è l’eterna narrazione della stessa esistenza. In cui - anche se sembra difficile riconoscerlo - l’unico vero nemico siamo sempre e solo noi stessi... di Stella Vordemann [email protected] Il cinema e le fiabe hanno qualcosa in comune? A prima vista si direbbe di no: in un caso si tratta di un’arte visuale, moderna, influenzata fortemente da fattori commerciali, che si fregia di un’autorialità. Nell’altro caso siamo di fronte a una forma di espressione orale (più raramente scritta), arcaica, dalle finalità pedagogiche, trasmessa in forma anonima di generazione in generazione. Differente è l’epoca e la mentalità che le hanno prodotte, diverso il pubblico d’elezione dell’uno e delle altre. Entrambi però hanno in comune una cosa importante: raccontano storie. È questo a far sì che il cinema si riallacci a una tradizione millenaria, connaturata al genere umano. L’uomo da sempre cerca di farsi una ragione della realtà in cui vive, e che a volte sembra incomprensibile, raccontando storie, cioè creando un resoconto semplificato degli eventi, che sintetizzi l’esperienza vissuta e le dia un senso compiuto. Wim Wenders ha descritto molto bene questa primordiale esigenza umana nel film Fino alla fine del Mondo: in una società minacciata da un disastro nucleare e dominata dal proliferare incontrollato delle immagini, inquinata dalla possibilità di filmare e fotografare tutto, di rendere visibili addirittura i sogni, una ragazza si ammala e rischia di impazzire. Verrà guarita solo quando il protagonista le racconterà la sua storia, dando un senso, e quindi un valore, al vissuto. La realtà, che a prima vista sembra un susseguirsi random di eventi, viene inserita in una griglia narrativa in tre atti, con punti focali (climax, punti di svolta dell’azione, catarsi) con un protagonista, l’eroe, che parte psicologicamente da un punto e arriva ad un altro, avendo imparato qualcosa. E il cinema fa proprio questo: prende un evento, un fatto di cronaca o un pezzo di storia e lo racconta dal punto di vista di un protagonista, nel quale ci identifichiamo. Ci fa capire che cosa significa avere quell’esperienza (che sia la guerra del Vietnam o una storia d’amore difficile), ci insegna qualcosa che prima non sapevamo su quel tema. Ci ammonisce sulle conseguenze di certi atteggiamenti e modi di pensare. La stessa cosa fanno le fiabe, in forma più crittata, più simbolica. Come nelle fiabe, il messaggio più elementare di ogni film è qualcosa come “l’amore vince su tutto, ma bisogna lottare”, ”a volte bisogna affrontare le proprie paure più recondite per poter ottenere quello che si vuole”, oppure “anche quando tutto sembra perduto, il coraggioso non perde la speranza e alla fine la sua ostinazione verrà premiata”, o ancora “può sembrare che i cattivi vincano, ma alla fine la lealtà e la bontà ricevono un premio su un altro piano”. Verità universali, semplici, eterne. Spesso più il film sembra semplificare la realtà, più ha successo. Perché? Perché il pubblico è stupido o ignorante? O piuttosto perché le verità semplici soddisfano un bisogno primario dell’essere umano, lo stesso che fa sorridere soddisfatti i bambini quando la strega di Biancaneve fa una brutta fine al termine della fiaba? Nell’originale dei Fratelli Grimm è costretta a ballare con ai piedi scarpe di ferro arroventate fino a cadere stecchita. Al giorno d’oggi le fiabe sono state purgate di questi elementi di “violenza grafica” perché turberebbe i bambini, i quali al contrario hanno una grande attrazione per la giustizia esemplare, perchè sanno ancora vedere attraverso il linguaggio simbolico e si rendono conto istintivamente che la punizione per chi ha turbato l’ordine delle cose, in un contesto metaforico, archetipico, deve essere emblematica. Come le fiabe prima dell’avvento della celluloide, il cinema attinge all’inconscio collettivo, creando storie di cui la gente sente il bisogno. E non solo perché ha bisogno di svagarsi, di divertirsi, ma innanzitutto perché ha bisogno di sentirsi raccontare la propria storia, come la ragazza del film di Wenders. Successi planetari come quelli della saga di Guerre Stellari e del Signore degli Anelli non si possono spiegare solo con la voglia di divertirsi. Non a caso questi film parlano della lotta del Bene contro il Male. La casa di produzione Weta Ltd., che ha realizzato gli effetti speciali per Il Signore Degli Anelli, usa delle 28 Numero 6 giugno - luglio 2007 apparecchiature per la creazione della realtà virtuale che sono più potenti di quelli della Nasa. Risorse enormi in termini di scienza e di creatività (e naturalmente anche in termini economici) non per andare sulla luna o per sparare razzi sulla Corea del Nord, ma per… raccontare una fiaba. Nel caso di Star Wars o del Signore degli Anelli è facile l’analogia con la fiaba perché il contesto è, per l’appunto, fantastico. Ma il cinema usa gli stilemi della fiaba anche per raccontare storie di attualità, ambientate nel presente. Tutti chiamiamo l’antagonista in un film “il cattivo”. E infatti, come nelle fiabe, il protagonista, l’Eroe, deve trovare sulla sua strada qualcuno che lo metta alla prova. Il cattivo, appunto, il Nemico, quello che ha il potenziale per annientarlo. Ma troverà anche qualcuno che gli darà una mano, che gli darà dei consigli, che gli insegnerà cose utili: il Mentore (tipo il maestro di arti marziali in Karate Kid, o un genitore, o un insegnante come Robin Williams in L’attimo Fuggente). Alcuni amici gli daranno una mano nei momenti difficili: gli Alleati; altri si frapporranno in alcuni momenti topici fra lui e il suo obiettivo: sono i Guardiani della Soglia (il nostro Eroe per risolvere il caso deve assolutamente entrare in quel night, ma sulla porta ci sono dei brutti ceffi che non hanno affatto l’aria amichevole). Alcuni personaggi sono poco chiari, sembrano amici, ma all’ultimo momento ti tradiscono. Lavorano per l’Eroe o contro di lui? Sono i Mutaforme, e nel cinema l’esempio migliore sono le Dark Ladies, donne misteriose e irresistibili (Sharon Stone in Basic Instinct, per citarne solo una). Il cinema è dunque popolato da archetipi che provengono dalle fiabe, anche quando sembra voler raccontare storie più moderne e ambigue. In qualsiasi genere, commedia romantica o film d’azione, film di guerra o western, fantascienza o dramma psicologico, lo schema fondamentale è sempre quello: l’eroe viene catapultato in un’ avventura, in un viaggio interiore o esteriore e deve superare degli ostacoli. A un certo punto sembra che non ce la farà mai, ma riesce a superare la difficoltà ed esce dall’altro lato con una maggiore consapevolezza. Se non riesce si tratta di una tragedia, una forma particolare di racconto la cui funzione è di ammonire sulle conseguenze di certi comportamenti. Il messaggio importante di ogni film e di ogni fiaba è che il nemico principale, quello che ci impedisce di ottenere quello che vogliamo, siamo noi stessi, sono i nostri atteggiamenti sbagliati, la mancanza di volontà, di coraggio, di perseveranza. Se superiamo il nemico che c’è in noi, supereremo anche quello esteriore. Il cinema, quello buono, anche quando a volte sembra fare tutt’altro, assolve oggi a una funzione che prima fu delle fiabe: trasmettere la conoscenza acquisita in millenni in forma di racconto, di metafora, cercando di veicolare in una forma di facile comprensione, contenuti altrimenti difficili da trasmettere. Il valore dell’amore, dell’amicizia, della sofferenza, del sacrificio, l’importanza della ricerca del benessere dei molti rispetto a quello dei pochi, questi sono i temi di molti film che a prima vista sembrano essere leggeri o sciocchi, ma che invece fanno arrivare il messaggio aggirando il filtro critico della ragione. 29 Numero 6 giugno - luglio 2007 Sogno a occhi aperti Cinema e fiaba condividono uno stesso destino: quello di proiettare”il pubblico” fuori della dimensione ordinaria. In questo senso, film come L’estate di Kikujiro introducono un’atmosfera sospesa in cui, ancora oggi, la realtà sembra dissolversi ai confini di altri regni... di Fabio Fontana Il cinema è il linguaggio dei sogni. Questa miracolosa invenzione è l’unica forma di trasmissione culturale in grado di coinvolgere tutti i nostri sensi a tal punto da trascinarli via - sull’ onda emotiva dei fotogrammi che scorrono - in una dimensione temporale sconosciuta, non necessariamente meno autentica di quella in cui ci troviamo ad esistere, ma in ogni caso sempre imprevedibile, inedita. Infatti, frequentemente il grande cinema sa parlare della vita più e meglio della vita stessa. Il cinema è il linguaggio dei sogni, e dei sogni ad occhi aperti, perché quando ci sediamo di fronte allo schermo, impazienti che la proiezione abbia inizio, accettiamo consapevolmente l’”inganno” della narrazione. L’artificio del doppio binario su cui scorrono realtà e invenzione, incontrandosi magicamente nel buio ovattato della sala. Ed è proprio questa convergenza, che sembra si interrompa bruscamente con i titoli di coda, a non finire mai, lasciando echi duraturi di sé negli angoli più raccolti della nostra coscienza, regalandoci per i giorni a venire, anche per quelli più duri, un’immagine illuminante, una frase e, perché no?, un viatico comportamentale. Spesso infatti al cinema ci si innamora delle proprie illusioni, si assorbe energia preziosa e rigenerante, si trae comunque spunto per la proiezione dei nostri io in carne e ossa nelle affollate platee della quotidianità. Insomma, dentro e fuori dal cinema si impara. Perciò anche il cinema scadente, quello più indifendibile e cialtrone, potrebbe possedere un valore. Un racconto esiste perché esiste una comunità di ascoltatori, un linguaggio è tale in virtù del fatto che qualcuno lo sa decodificare. A maggior ragione nella nostra epoca della cultura non mediata, dell’immagine dittatoriale e pervasiva, in cui ogni cosa è frenetica, meccanizzabile, in un certo senso già data, forse soltanto la celluloide sa come raccontare storie e come farsi autenticamente capire. La dimensione fiabesca è sempre stata una prerogativa dell’essere umano, a tutte le latitudini, in qualsiasi regione del pianeta, il “c’era una volta” porta con sé la certezza, o la speranza, del “ci sarà ancora”, la trasmissione simbolica del sapere si lega alla possibilità che un uditorio si riunisca nell’evento miracoloso dell’apprendimento. Gli esempi migliori, in tal senso, nascono quasi d’istinto, senza fronzoli o giri di parole aggiuntive, in semplicità assoluta. Prendete una piccola fiaba moderna come L’estate di Kikujiro di Takeshi Kitano, un piccolo, splendido ritratto del viaggio impossibile compiuto da un malvivente da quattro soldi e da un bambino paffuto alla ricerca della madre di quest’ultimo attraverso la campagna giapponese. Un’estate, un percorso di formazione per entrambi, tra minuscoli eventi, imponderabili ostacoli, giochi improvvisati sul crinale della propria inventiva, nel continuo contrapporsi di realtà e fantasia. E tutto intorno la quieta frenesia del paesaggio che muta, gli incontri che si susseguono, l’occhio paziente della telecamera che filma la loro storia e ce la offre in dono. E poi ci siamo noi, da qualche parte dispersi nel mondo, che stiamo assistendo alla proiezione, che fin dall’inizio abbiamo cominciato a riflettere, a giudicare, in una parola a crescere di pari passo con l’evoluzione della vicenda narrata. All’interno della nostra coscienza e un poco più oltre, avvinti alla forza inesausta del nostro sognarci. Proprio come accadeva migliaia di anni fa. 30 Numero 6 giugno - luglio 2007 Siamo nel “tempo degli uomini”, non c’è più una Terra di Mezzo se non quella che esiste nei nostri spazi interiori. Però, forse, i Silmaril - le pietre lucenti narrate da Tolkien - possiamo cercarli lo stesso. Trovarne qualche frammento per tentare di comporre il mosaico che collega i mondi antichi a quelli moderni. Cercando di capire dove risieda oggi la qualità dell’essere, o la sua assenza, annusando il profumo sottile delle cose che ci circondano. Ma è importante anche scovare i brogli e contraddizioni, e provare a non farsi travolgere da quegli anelli di potere (tanti, troppi) spesso camuffati, nascosti, che si giocano oggi i destini individuali e quelli collettivi. Navigare con ironia in mezzo alle tecnologie, alle informazioni; danzare la danza rapida dei consumi e dei fatti. Certo, sarà difficile inciampare – oggi - in uno smeraldo nascosto. Ma si scava, si scava. In fondo per cercare le pietre bisogna andare sottoterra. E sporcarsi le mani, frugare in mezzo a varie mondezze. Ma se si trovasse anche solo un frammento minuscolo, ne sarebbe valsa la pena. E se non dovessimo trovarlo va bene lo stesso. L’importante è cercare. L’uomo di oggi vive il conflitto tra passato e futuro, tradizioni e modernità. E tuttavia, tuttavia si può anche scegliere di non infilarsi negli -ismi. Si può evitare di appiccicarsi addosso un’etichetta. Modernista, tradizionalista, progressista, conservatore... La vera libertà di pensiero comporta molta solitudine, in un mondo che preferisce spesso infilare i piedi nelle pantofole di un pensiero fissato, ordinato secondo gli schemi politico-sociali ai quali aderisce e in cui ci si riconosce. Senza vedere al di là, senza capire che a volte “l’erba del vicino” è più verde davvero. Ma solo in quel contesto, magari, in quel momento. Perdere l’opportunità dell’istante, dell’idea “diversa” che cerca di vivere il presente del suo fiorire, prima ancora che la mente la riconosca come “amica” o “nemica” giudicandola in base all’appartenenza prima ancora che all’essenza. Silmarillon è un esperimento particolare perché si pone in modo libero e trasversale rispetto alle ideologie e agli schemi precotti. Cerca di essere senza “padroni”. Non è facile, in un mondo sempre più schierato che rifiuta il confronto con l’ambiguità, le intersezioni, le zone grigie fra il bianco e il nero. Noi andiamo avanti, grazie anche all’aiuto di blogger e amici che ci regalano gratuitamente i loro articoli. 31 Numero 6 giugno - luglio 2007 Infatti Silmarillon è scaricabile in PDF. Non costa nulla. Proseguiamo nel nostro impegno invitando chiunque, anche i nostri amici del Mulino di Amleto, a contribuire con articoli, recensioni, idee. Il web non è solo giungla, calderone, magma informe. É anche qualità, dono agli altri di ciò che si pensa o si sa. Noi sappiamo fare riviste che cercano di raccontare contenuti socio-culturali. O, quantomeno, ci proviamo. In questo spirito di offerta e di condivisione, speriamo che la nostra piccola comunità continui a fiorire. Un caro saluto a lettori e scrittori. Francesca Pacini 32 Numero 6 giugno - luglio 2007 Appunti di viaggio in celluloide Guida per riconoscere i tuoi santi, di Dito Montiel Quando il giovane Dito Montiel decise di abbandonare il quartiere della sua rabbiosa adolescenza, lo fece per inseguire un’idea di se stesso che potesse definirsi realmente inedita, nel bagliore della speranza di un riscatto umano e sociale mai conosciuto in passato. In quell’ultima, caldissima estate newyorkese di metà anni Ottanta, Dito capì che doveva fuggire dalla fragilità ingombrante di suo padre, dalla rassegnazione di sua madre, dall’amore goffo e smisurato dei suoi amici e della sua ragazza. E naturalmente dalla violenza e dalla morte, due frequentazioni assidue ed inevitabili per chiunque sia costretto a vivere nelle difficili realtà delle periferie statunitensi. Questa decisione sofferta e per nulla scontata porterà Dito a costruire la sua personalità di artista completo - musicista, scrittore e adesso, in seguito all’esordio cinematografico di cui ci stiamo occupando, anche regista - lontano da quella prigione claustrofobica di sangue e cemento. Salvo tornare a casa dopo circa vent’anni per l’aggravarsi delle condizioni di salute del padre e scoprire che nulla è cambiato dalla sua partenza. Nulla ma proprio nulla, soprattutto la forza dei sentimenti. Guida per riconoscere i tuoi santi forse non è il capolavoro acclamato dalla critica nei festival di mezzo mondo: c’è qualche velleitarismo inutile, mentre una certa discontinuità fa capolino nella sceneggiatura, spezzandone il ritmo. Sono dettagli, però, dal momento che si tratta pur sempre di un’opera prima, e di una testimonianza di assoluta sincerità. La pellicola è intrisa di quell’urgenza nel parlare di sé, di quella strana miscela di frenesia e di pudore che solo un racconto autenticamente autobiografico sa trasmettere. E contravvenendo alle regole canoniche del film di formazione, ormai davvero abusate, nell’attribuire un senso morale alla narrazione degli eventi ci fa capire che chi decide di restare, o non può fare diversamente, dopo tutto possiede uno spessore umano ben maggiore di chi invece se ne è andato per sempre. Perché al di là di tutte le considerazioni e le giustificazioni possibili dovute a delinquenza, miseria e degrado, qualsiasi fuga equivale ad un tradimento, mentre su di un balcone arrugginito e polveroso, in una poltrona ormai lisa, nell’abitacolo pieno di cartacce di una macchina rubata, persino nel parlatoio di un carcere di massima sicurezza, c’è ancora qualcuno rimasto indietro ad aspettare con fedeltà e dedizione. Ad aspettare che Dito tornasse. (Fabio Fontana) Avviso per il lettore: Accade che Fabio Fontana mi invia una recensione sul film di Ermanno Olmi. Film che ho visto e che ho criticato in un post pubblicato sul Mulino di Amleto. Che fare? Decido, eccezionalmente, di pubblicare entrambe le versioni. A voi la scelta. Francesca Pacini 33 Numero 6 giugno - luglio 2007 Centochiodi, di Ermanno Olmi Di Centochiodi avrete sicuramente già sentito parlare a sufficienza. Forse il film vi risulterà indigesto a prescindere, visto il trito e barboso sproloquio di cui è stato fatto oggetto su giornali, trasmissioni radio, dibattiti televisivi. Vorrei provare comunque a farvi cambiare idea .Va da sé che in questi tristissimi tempi italiani che ci sono capitati da vivere, in cui la sacralità ed il senso del divino sono stati sviliti a terreno di scontro tra gli opposti integralismi di quanti vorrebbero indire crociate missionarie vetero-cristiane e quanti all’opposto sono sempre più propensi a liquidare il concetto stesso di religione come tara mentale per ritardati, l’occasione che si presentava era alquanto ghiotta. Del resto basterebbe compiere un giro in libreria e fermarsi ad osservare, con un moto di tristezza, che interi scaffali sono occupati da libri e libelli pro e contro Gesù, per comprendere effettivamente a che livello di banalizzazione modaiola della questione si sia arrivati, grazie all’ineffabile operato di furbacchioni del calibro Dan Brown. Tornando all’ultima pellicola di Ermanno Olmi, bisogna aggiungere che persino il segretario del Partito dei Comunisti Italiani, Oliviero Diliberto, ha sentito l’insopprimibile esigenza politica di lanciarsi nella discussione, giudicando il lungometraggio diseducativo, in virtù della distruzione dei libri descritta nella pellicola. La netta presa di posizione del bibliofilo Diliberto ha innescato un conseguente, stucchevole botta e risposta polemico con Olmi sulle colonne del Corriere della Sera, di cui tutti sentivano l’urgente bisogno, credenti e non. Ora, per come la penso io, agli appassionati del bel cinema dovrebbe importare ben poco delle implicazioni metafisico-religiose di questa storia, incentrata sulla parabola di un giovane docente universitario di teologia che, spogliatosi degli orpelli barocchi della cultura ufficiale, decide di vivere il suo vangelo personale sulle sponde del Po. E non molto dovrebbe incidere, nella valutazione di gradimento complessiva dell’opera, l’idea che in fondo l’etica cristiana dell’ “ama il prossimo tuo come te stesso” sia un fondamento morale in grado di mettere d’accordo chiunque. I veri cinefili dovrebbero invece apprezzare il coraggio di un film sicuramente non facile, la sua intonazione alta e sentita, ma soprattutto la straordinaria vena lirica, dettata da un’ispirazione profonda, con cui Olmi riesce a tratteggiare il paesaggio ripariale del grande fiume, regalandoci lo spaccato di un ecosistema contemporaneo che non ha eguali nel cinema italiano degli ultimi anni. Perché se l’occhio del maestro lombardo sa posarsi sui tanti mali che affliggono la natura malata del crepuscolo post-industriale del Bel Paese – le sponde brulle e sabbiose, prosciugate dalla siccità, i pesci siluro infestanti che divorano le specie ittiche autoctone, l’ uso dei diserbanti, e degli insetticidi – altrettanto vivida e intensa è la bellezza che il mondo naturale sa opporre allo scempio e conservare in sè. Esattamente come il cuore pulito degli uomini “millenari” che popolano le sponde del corso d’acqua, peraltro quasi tutti attori non protagonisti, se si eccettua il bravo e sorprendente Gesù - Raz Degan (a modo suo un esordiente assoluto). Così facendo, Olmi rifugge da un facile qualunquismo ecologico, e non si dondola compiaciuto sul filo di un’apologia rurale ormai fuori tempo massimo, ma immerge, letteralmente, “il suo Cristo” sullo sfondo di un paesaggio delicato e fremente, che sa essere concreto e credibile pur mantenendo quell’alito di magia misteriosa che è proprio dell’ afflato poetico. In una pellicola che, più che all’“Albero degli zoccoli”e “Al segreto del bosco vecchio”, rimanda al “Mestiere delle armi”, dove prevalgono i sussurri alle urla e i toni sfumati alle tinte accese, il carattere ultraterreno della vicenda si definisce quindi lentamente come un alba rosata, o un’onda placida sul pelo dell’acqua. Con naturalezza. In un cinema come il nostro, dove si fa sempre più fatica a incontrare autori capaci di “leggere” il territorio italiano senza false remore ma con forza estetica e discrezione, “Centochiodi” appare perciò molto più che una lezione di stile. E purtroppo, sentite le recenti dichiarazioni di Ermanno Olmi, anche un canto di addio. (Fabio Fontana) Chiodo scaccia chiodo A volte l’aspettativa tira brutti scherzi. A volte le lodi eccessive tessono una rete ingannevole. Certamente Ermanno Olmi è un grande, lirico, intenso regista. E Centochiodi è un bel film. Forse, però, non è il capolavoro annunciato dal tam tam mediatico, quello che ha visto tutti, ma proprio tutti, inchinarsi davanti al maestro, incensando la sua opera con toni che rasentano la devozione. 34 Numero 6 giugno - luglio 2007 O forse, più semplicemente, la sottoscritta è un’imbecille perché non l’ha apprezzato così, questo film. Fatto sta che Centochiodi ruota intorno a un’idea a dire il vero non originalissima, quella dei libri che allontanano dalla conoscenza del mondo, dall’esperienza che solo l’attrito con la realtà può far scaturire. Lo racconta Elias Canetti nel suo magnifico Autodafè, tanto per fare un esempio. Il rapporto fra cultura e realtà ha sempre destato sommosse, scuole, schieramenti. Olmi, nel suo commiato dal cinema, lo riprende in chiave cristologica ponendo l’accento sulla differenza tra la sapienza delle religioni “lette” e la verità delle religioni “vissute”. Il Cristo moderno (che veste i panni di un improbabile Raz Degan) chiamato da tutti “il Professorino”, lascia il mondo dell’istruzione, delle scuole, dei libri di teologia dopo aver “crocifisso” un’intera biblioteca. Finisce per vivere sulle rive del Po, a contatto con un mondo in declino, quello struggente e verace delle microcomunità in cui ancora il danno delle metropoli non ha potuto corrompere l’anima, un mondo estraneo ai consumi mordi e fuggi, agli isterismi e agli individualismi. Un sentire ancora pulito, fresco come il bucato steso al sole. Sì, certo, le atmosfere sono rarefatte, olistiche, ma troppo di maniera. Lo sguardo sicuramente esperto di Olmi insiste sui dettagli, scava nei sorrisi, nei dialetti, nelle occasioni sociali della piccola folla che abita le rive del Po. Sembra quasi di sentire, bisbigliate negli spazi e nei gesti, le parole di Pasolini quando, negli Scritti Corsari, ammoniva sull’omologazione che di lì a poco avrebbe trasformato l’Italia in un paese soggetto alla deriva di una cultura moderna allo sbando, infettata dalla televisione, erosa dalle città che allungavano la loro ombra sulle campagne, trasformando l’innocente contadino in un proletario triste, posticcio, prigioniero nella gabbia della civiltà. Sì, le inquadrature di Olmi che esitano sui volti dei vecchi, sull’affresco di una chiacchierata costruita intorno a un bicchiere di vino, sulle mani che preparano il cibo, ci ricordano tanto il Pasolini che cercava “la verità” negli attori, nelle storie, nelle vite che raccontava. I dodici signori, incarnazione contemporanea degli apostoli di questo Cristo moderno (non manca neanche la Maddalena, che qui diventa la bella panettiera che si concerebbe a tutti ma che non riesce ad essere amata), sono la parte migliore del film. Un film che tuttavia rischia paradossalmente di sembrare artificioso proprio per l’insistenza nel voler raccontare la genuinità di quella vita remota, dal sapore antico, in cui si specchiano, ormai, solo i nostri vecchi, quelli delle campagne e dei mari. A tratti questo attardarsi esasperato sui dettagli di questo mondo “altro” assume quasi una valenza artificiosa. Insomma, si ha quasi la sensazione di qualcosa di “finto” malgrado la ricerca esasperata della semplicità. Il voler essere genuini a tutti i costi rischia di assomigliare a una versione sofisticata, intellettuale, del Mulino Bianco. Si rischia l’impopolarità, a criticare l’acclamato Centochiodi di Olmi. Ma va bene lo stesso. Perchè, seppur soggettiva, seppur singolare, seppur eccentrica in un coro entusiasta, questa sensazione rimane lo stesso. la sensazione che nel film si sfiori qualcosa ma non si scavi davvero. La frase che le recensioni hanno lodato di più è quella in cui Cristo-Degan dice che non c’è libro che possa sostituirsi a una tazza di caffé con un amico. Sì, benissimo, bellissima. Anche Martin Buber, una volta, scrisse qualcosa di simile. Scrisse che avrebbe cambiato tutta la sua biblioteca in cambio di una carezza. E poi? Al di là di alcune belle frasi, e di inquadrature certamente magnifiche, di atmosfere rurali, schiette, il film non si fregia del capolavoro. Almeno per la sottoscritta. Che rimane con alcune domande. Una su tutte: perché quando Cristo-Degan si spoglia della sua vecchia vita, getta gli abiti in acqua e molla l’auto sotto l’ombra di un ponte, si tiene la sua carta di credito e il suo portatile? Molto radical chic, questo Cristo moderno. (Francesca Pacini) 35 Numero 6 giugno - luglio 2007 Una retrospettiva su Manoel De Oliveira, Parole e Utopia. Quando si guarda un film di Manoel de Oliveira si pensa di non assistere a vero e proprio cinema. La posizione statica degli attori, l’allestimento della scena, la prevalenza del parlato sull’immagine come motore e snodo degli eventi, portano a ritenere teatrale la rappresentazione, e che il collocamento sullo schermo di quanto veduto sia un accidente, forse una stonatura. Ma difficilmente un’opera di De Oliveira sarebbe la stessa cosa “fuori” dal cinema. Perché è nel cinema che il suo ragionamento artistico si sviluppa, in una ricerca sull’immagine e sulla parola filmate, in una ricerca utopica (Parole e utopia è il titolo di un suo film del 2000) di un movimento e di un tempo del cinema, senza trovare altro che un gioco immobile, un dinamismo statico, la cui potenza di senso arriva solo attraverso il cinema. Non potrebbe attraverso il teatro, che è una forma già data, già limitata e canonizzata di espressione, dovendo già fare i conti col limite spaziale della scena, con un vedere che deve essere sempre uguale fino all’ultimo posto della platea, con la parola che arriva per l’impotenza dell’immagine. Ma attraverso un cinema imploso, che è teatro per non saper far valere la sua differenza dal teatro, che trova il limite come fine della sua ricerca. Perché ogni libertà del cinema finisce nella prigione per gli occhi del visibile, il nascosto ed il non nascosto si rivelano stare su uno stesso livello di importanza, ai fini di una comprensione ultima che è sempre negata. A niente dunque serve il cinema, con la sua possibilità di comprimere, espandere, “montare” e comporre movimento e tempo, se non a fissare ancora di più l’uomo nel suo esserci, nel suo essere nel teatro, limitato dal palcoscenico, dal guardare, dal guardarsi, dall’essere guardato. Ecco perché il cinema di De Oliveira è ovunque e in nessun luogo, nella storia e fuori dal tempo. L’impossibilità dunque del cinema di essere quello che è stato o ha tentato di essere, per rinascere da tale impossibilità più maturo, disincantato e beffardo. “Beffardo” è lo sguardo di De Oliveira. L’ordine, il rigore e l’intellettualismo dei suoi film sono posti per essere rinnegati subito, la realtà noiosa degli eventi che descrive diventa nel suo sguardo un divertissement surrealista, seguendo Bunuel ma in modo forse ancora più perverso, perché più educato, sottile. De Oliveira gioca con i sentimenti dei suoi protagonisti borghesi come con la fede dei devoti e teologi dei suoi film religiosi. In un approccio però di complicità, come se la finzione fosse il gioco a cui tutti sanno di giocare, perfino nei personaggi che perdono (veramente o per finta?) il “lume della ragione”. La finzione è la verità. E la verità è finzione in quanto non può che nascere ed essere nella parola, parola al di fuori della quale tutto è utopia, non luogo. È la parola, cinematografica e non teatrale, nel senso già detto, l’unico luogo. Luogo che non è mai “reale” perché è lontano dalle cose, sovrimpresso alle cose, artificiale ricreazione del reale. Luogo che a sua volta è prigione, prigione del senso, nella logica, nel sillogismo. I duelli verbali nei film sulla borghesia, come le dispute teologiche in un film come Parole e utopia, sugli ultimi anni di vita di Padre Vieira, sono giochi delle parti più che lotte per la vita. L’intellettualismo è lo stanco porto cui approda ogni ricerca della verità, sia essa sociale, psichica o escatologica. Intellettualismo che si manifesta nei paradossi, nei labirinti concettuali, nelle sortite cinico – borghesi piene di verità solo in quanto lì la verità si ferma e non riesce a trascendere, in vero amore, in vero odio, insomma in idea – realtà. Nei racconti di de Oliveira la fede in Dio si misura nel gioco della persuasione, ed è un gioco. L’innamoramento diventa puntello psicologico con cui ferire, attraverso la frase appuntita e sadica, da parte dell’uomo, o attraverso la pazzia simulata delle donne, per perdere l’uomo nella disperazione dell’incomprensione. Ma sempre per gioco, lugubre finché si vuole (i film di De Oliveira sono pieni di funerali). In attesa del suo prossimo film, alla Mostra di Venezia, sembra (si spera). (Parlardi) www.parlardi.splinder.com 36 Numero 6 giugno - luglio 2007 Il cinema di Wilder, che diventava ciò che (non) era. Trovare l’elemento identitario nel cinema di Billy Wilder significa fare i conti con la differenza. È un paradosso, un gioco banale, ma su di esso Wilder fondava il suo grande cinema. Ovvero, un cinema che è sempre ciò che non è, per mezzo di maschere che diventano visi e viceversa, che sono solo quel che sono per gli altri, e nulla più. E questo sia attraverso le commedie che i drammi, tanto per mezzo dei film, quanto per mezzo dei personaggi che li popolano. Perché anche il cinema per Wilder era una specie di maschera di sé, una propria proiezione da vendere costantemente, un vestito o meglio una seconda pelle. Il regista è quello che mostra di sé, attraverso i suoi film. Allo stesso modo, il personaggio è quello che appare. Un modo di far cinema dentro Hollywood, ma consapevole di cosa Hollywood sia, uno sfavillìo appicicato sopra il nulla. In quest’ottica i travestimenti e le finzioni, gli equivoci nei film di Wilder. Sempre basati sull’apparenza, da salvare per salvarsi. Wilder ha scelto Marylin Monroe per due delle sue più celebri commedie. Marylin come esaltazione suprema di Hollywood, come Hollywood in movimento davanti allo schermo, sovrimpressa sulla scena con la sua bellezza che è già mito vivente, già simbolo in sé e per sé, senza bisogno di qualcosa da simboleggiare. E nello stesso tempo come personaggio che incarna Hollywood come “morale”. Sia in A qualcuno piace caldo, che in Quando la moglie è in vacanza, è sempre pronta a credere nell’apparenza altrui, in un’ingenuità ineluttabile, leggera e realistica, consapevole di essere cinema e che tutto non può essere che cinema. Non sfuggono dalla regola, in un modo più sottile e forse perverso, neppure i personaggi di Shirley McLain, che in L’appartamento o in Irma la dolce si presta ai giochi trasformistici di Lemmon, disposta a credere ad ogni falsità quasi per salvarsi in un reale, per poter vivere in un vero della propria convinzione, quasi una resistenza contro l’inganno rivelato, contro il pericolo che cali la maschera, non solo di chi si ha di fronte, bensì la maschera del reale – cinematografico, o del reale che è cinematografico. Così l’estrema, divertente ma terribile verità di quel “nessuno è perfetto” che chiude A qualcuno piace caldo. Con Lemmon che sviscera una ad una tutte le falsità di cui si è ricoperto nel corso della storia, tentando di far valere un proprio io che sia altro rispetto ad un essere semplicemente per-altri, fino al far valere la propria differenza sessuale proclamandola, quasi fosse, in un’America puritana, veramente l’ultima differenza che fa la differenza, l’ultimo appiglio al proprio sé differente e al proprio corpo reale, anch’esso destinato a franare sulla superficialità della indifferenziata finzione hollywoodiana, con un sberleffo. Così, già prima, Wilder in film drammatici come Testimone d’accusa, con il lungo processo e le verità continuamente mascherate e smascherate, in cui la finzione diventa gioco crudele e consapevole, e chi finge è a sua volta “finto”, con l’ingenuità vitale di Marylin sostituita dal personaggio tragico della Dietrich. O in quello che forse resta il capolavoro hollywoodiano assoluto, Viale del tramonto. Con il personaggio della Swanson attaccato in modo morboso a ciò che non è, come aggrappata alla vita, a quella telecamera come ultima resistenza, diafana e sottile finzione, per non cadere nel baratro della morte che la circonda da ogni parte, e che addirittura, attraverso il celebre escamotage narrativo del film, la sta raccontando. (Parlardi) www.parlardi.splinder.com 37 Numero 6 giugno - luglio 2007 Fiaba-favola-fama La favola (fabula, in latino, come diminutivo metatetico di flaba-fabia) deriva da “parlare” (fari). Si parla di qualcosa quando questa lo merita infatti anche “fama” deriva dal latino fari. Molti attestano che sia fiaba che fama hanno il senso di “rendere palese”, evidente. E anche il sanscrito possiede il concetto di “palesare” attraverso questi due concetti uniti fra loro con bha-mi che vuol dire io splendo, oppure bhasami, che vuol dire io parlo. Ma anche il greco con phemi (parlo) o con phae (brillante) esprimono foneticamente gli stessi concetti. La Fama, per Greci e Romani, era figlia della Terra e rappresentava l’opinione pubblica, ma non nel senso che daremmo oggi alla parola opinione. Era un elemento fatale e geniale che rappresentava la potenza “sincera” di tutto ciò che avveniva sulla Terra. Essa era raffigurata come una donna piena di occhi, di bocche e di orecchie. Nelle Metamorfosi (XII), Ovidio dice che essa “è fatta di sonante bronzo, rimanda ogni voce e ripete ciò che ode”. Dunque la fiaba, nella sua accezione simbolica, rappresenta la quinta essenza del valore di una storia mitica, eroica, straordinaria. Tramanda lo straordinario, il memorabile quello che è degno di reputazione. Essa, nella accezione moderna, ci rimanda al racconto fantastico, per lo più destinato ai bambini. In realtà tutta la società arcaica vive di fiabe e di abili narratori. Ogni fiaba confina con la leggenda e non è, arcaicamente, un prodotto fantastico ma una estrapolazione poetica di miti solidissimi, reali e credibili fin nei dettagli, per la mente dell’uomo ancora pronto a comprenderle. rubrica a cura di Claudio Lanzi [email protected] www.simmetria.it 38 Numero 6 giugno - luglio 2007 Una sera, in un remoto college di provincia, dov’ero capitato in occasione di un giro di conferenze che si era prolungato oltre il previsto, proposi un piccolo quiz; su dieci definizioni del lettore, invitai gli studenti a scegliere quattro risposte che, messe assieme, indicassero i requisiti del buon lettore. Ho smarrito quell’elenco, ma, per quanto ricordo, le definizioni erano più o meno queste. Un buon lettore dovrebbe: 1. appartenere a un club del libro 2. identificarsi con l’eroe o l’eroina 3. concentrarsi sull’aspetto socio-economico 4. preferire una storia con azioni e dialoghi a una che non ne ha 5. aver visto il film tratto dal libro 6. essere un autore in erba 7. avere immaginazione 8. avere memoria 9. avere un dizionario 10. avere un certo senso artistico Gli studenti si mostrarono in massima parte favorevoli all’identificazione emotiva, all’azione e all’aspetto socioeconomico o storico. Ma, naturalmente, come voi avete intuito, il buon lettore è chi ha immaginazione, memoria, un dizionario e un certo senso artistico, quel senso che mi propongo di sviluppare in me e negli altri ogni volta che mi si presenta l’occasione. (Vladimir Nabokov, Lezioni di Letteratura) 39 Numero 6 giugno - luglio 2007 «La verità non è un segreto di pochi» Eppure Pensereste che lo fosse Dal modo in cui certi Bibliotecari E ambasciatori della cultura e Specialmente direttori di musei Si comportano Pensereste che fosse di loro Monopolio Dal modo in cui Si aggirano scuotendo Le teste altere Come se non andassero Mai al gabinetto O qualcosa di simile Ma se fossi in voi Non me la prenderei con loro Dicono che lo Spirituale è concepito meglio In termini astratti E inoltre Girare per i musei mi dà sempre La voglia di «sedermi» Mi sento sempre così Costipato In quelle alte altitudini (Ferlinghetti, Poesie) Sono le parole le vere colpevoli. Sono fra le cose più indisciplinate, più libere, più irresponsabili e più riluttanti a lasciarsi insegnare. Certo, possiamo sempre prenderle, suddividerle e metterle in ordine alfabetico nei dizionari. Ma le parole non vivono nei dizionari, vivono nella mente. Se ne volete una prova, pensate a quante volte, nei momenti di maggiore emozione, vi capita di non trovarne nessuna quando più ne avreste bisogno. Eppure il dizionario esiste; e lì, a vostra disposizione, ci sono mezzo milione di parole tutte in ordine alfabetico. Ma potete davvero usarle? No, perché le parole non vivono nei dizionari, vivono nella mente. (...) La questione è solo quella di trovare le parole giuste e di metterle nell’ordine giusto. Ma non possiamo farlo perché esse non vivono nei dizionari, vivono nella mente. E come vivono nella mente? Nei modi più strani, non molto diversamente dagli esseri umani; vagando qua e là, innamorandosi e accoppiandosi. È indubbio che siano molto meno limitate di noi dalle convenzioni e dai cerimoniali. Parole regali possono permettersi di accoppiarsi con le più comuni. Parole inglesi sposano parole francesi, tedesche, indiane, e di colore se gli salta in mente di farlo. (...) Per questo, imporre regole a tali impenitenti vagabonde è del tutto inutile. Le poche regole di grammatica e di ortografia esistenti sono le uniche restrizioni che potremmo imporre loro. Al massimo possiamo dire di loro - man mano che le spiamo dal profondo limite della caverna scura e male illuminata in cui vivono - che sembrano preferire la gente che sente e che pensa prima di usarle, ma non deve essere gente che sente e pensa a loro, ma a qualcosa di diverso. Perché sono molto sensibili, e si sentono facilmente a disagio. Non amano che si discuta della loro purezza o della loro impurità. (...) E non amano essere sollevate in punta di penna ed esaminate una per una. Restano sempre unite in frasi, in paragrafi, e a volte per intere pagine di fila. Odiano essere utili; odiano dover far soldi; odiano andare in giro a tenere conferenze. In breve, odiano qualsiasi cosa imponga loro un unico significato, o che le immobilizzi in un’unica posa, perché cambiare fa parte della loro natura. E forse è proprio questa la loro caratteristica più sorprendente: il bisogno di cambiare. Perché la verità che cercano di affermare ha tante facce. (...) E quando le parole vengono inchiodate a un unico significato, 40 Numero 6 giugno - luglio 2007 ripiegano le loro ali e muoiono. Senza dubbio a loro fa piacere che noi sentiamo e pensiamo prima di usarle; ma vogliono anche che noi ci concediamo una pausa, vogliono che diventiamo incoscienti, Il nostro inconscio è la loro privacy; la nostra ombra è la loro luce. (Virginia Woolf, Il mestiere delle parole - da Ore in Biblioteca e altri saggi) 248 Perchè mi hanno rinchiusa fuori dal cielo? Cantavo forse troppo forte? Ma - potrei usare un tono “in minore” timido come quello di un uccello! Non volessero gli angeli lasciarmi provare solamente un’altra volta vedi un po’ tu - se li ho disturbati ma - per favore - non chiudere la porta! Oh se fossi io quel gentiluomo dalla “veste bianca” e loro - la piccola mano a bussare di nuovo Potrei forse vietare l’accesso? 249 Notti selvagge! Notti selvagge! Fossi ora con te sarebbero notti selvagge la nostra estasi! Futili i venti a un cuore ormai in porto: non serve la bussola, non serve la mappa. Remare nell’Eden! Il mare! Potessi almeno stanotte ancorarmi in te! (Emily Dickinson - da Quel che sappiamo dell’amore) segnalato da Irene Polleggioni [email protected] Era una festa meravigliosa, su questo non potevano esserci dubbi. Come tutto luccicava, profumava, rumoreggiava! Non si poteva decidere se fosse più intenso il luccichio dei gioielli o quello delle decorazioni. La luce che diffondevano i lampadari giocava e danzava sulle candide schiene nude e i volti accuratamente dipinti delle signore, sulle nuche grassocce, sulle camice inamidate e sulle uniformi rigide degli uomini impettiti, sulle facce sudate degli inservienti che si aggiravano per le sale con le bevande. Profumavano i fiori sparsi un po’ ovunque nel padiglione; profumavano le essenze parigine di tutte quelle signore tedesche; profumavano i sigari degli industriali e la brillantina dei giovani slanciati nelle loro eleganti, aderenti divise da SS; profumavano i principi, le principesse, i capi della Polizia segreta di Stato, i direttori dei feuilletons, le dive del cinema, i professori universitari, che occupavano una cattedra di scienza della razza o della guerra, e i pochi banchieri ebrei, la cui ricchezza e le cui relazioni internazionali erano tanto potenti da permettere loro di prendere parte a una manifestazione così esclusiva. Si diffondevano folate di effluvi artificiali come a coprire un altro aroma, il puzzo stantio e dolciastro del sangue, che in realtà era amato e impregnava ormai l’intero paese, ma di cui si provava un po’ di vergogna in un’occasione tanto straordinaria e in presenza dei diplomatici stranieri. (Klaus Mann, Mephisto. Romanzo di una carriera) segnalato da Heraclitus www.aenigmata.splinder.com 41 Numero 6 giugno - luglio 2007 La rivoluzione spiegata alle commesse, Roberto Carvelli, Coniglio Editore Romanzo picaresco, ricco di personaggi strambi e teneri, La rivoluzione spiegata alle commesse fissa lo sguardo sulle storie di uomini e donne (ci affacciamo su queste pagine come se fossero finestre aperte sul quotidiano) che lottano per sopravvivere, per arrivare alla fine del mese, per trovare o tenersi un lavoro decente, una casa di due camere, un compagno o una compagna a cui dire buonanotte alla fine della giornata. Distrazioni, poche. Per chi vive a Torreverde, immaginaria borgata romana, simile ai quartieri periferici di tutte le città, il tempo passa lento e ci si ritrova al Bar Libano a chiacchierare di sport e di donne. Oppure di rivoluzione. Di strategie per il cambiamento. Ed è così che Bebo, commesso in una merceria, sensibile al fascino femminile ed ex studente ribelle, assieme ai suoi amici dai nomi improbabili (Stinchi Pirinchi, nonno Adinolfi, Zagalot, Nena…) decide, fomentato da impegnative letture di sinistra e dalle conversazioni filosofiche con il “maestro”, Doctor You, intellettuale introverso e romantico, di intraprendere una sgangherata marcia rivoluzionaria. Disorganizzazione e idee poco chiare, spirito di concretezza del tutto assente condurranno la rivoluzione al suo implodere. Saranno in grado questi sfortunati eroi di fare i conti con il fallimento? Il campionario di scritte sui muri, di modi di dire e di tipiche storielle frutto di fantasia, come quella che vuole i water di Torreverde intasati da coccodrilli o gli ufo visti atterrare sui campi di grano, è la scelta letteraria che soggiace alla composizione del libro per raccontare la periferia, e anche per questo il libro si rivela inventivo e brillante. Questo romanzo getta uno sguardo critico – e, per fortuna, ancora capace di ironia – sulla nostra società che più che offrire, riconoscere, tutelare sembra togliere, negare, offendere; uno sguardo allo stesso tempo distante e partecipe, che si posa sui sogni infranti delle famiglie, delle giovani coppie o di chi è rimasto solo, e ci dice che il precariato non è solo il tratto che rende tipico l’ambito occupazionale, oggi, ma finisce con l’essere segno distintivo delle identità e della contemporaneità; il “nomadismo sentimentale” di Bebo, ad esempio, non è un malinconico risvolto di questa precarietà che tocca persino la vita affettiva? Se, come recita la bandella del libro, che delinea la tendenza della collana, qualcosa dovete pur mettere nelle vostre nuove librerie Ikea, allora metteteci anche questo libro. Ma prima, ovviamente, leggetelo! Leggerlo è un atto dovuto, ché di commesse è pieno il mondo e anche dei loro sogni segreti di rivolta; ecco perché queste pagine meritano attenzione. Il sogno di libertà e di felicità dei numerosi personaggi che affollano il romanzo resta periferico, marginale, non riesce a diventare azione coerente, e manca l’obiettivo. In realtà, però, queste piccole formiche che hanno rotto le linee, e che disordinatamente annaspano, sembrano comunque voler dire che non tutte le rivoluzioni sono utopie o si svuotano di senso lungo la strada o hanno bisogno di gesti eclatanti. Molte si fanno ogni giorno, giorno dopo giorno. Nei posti di lavoro, dentro alle case, negli ospedali, nelle scuole. Se ci chiedessimo: “cosa resta, allora, dopo la rivoluzione?”, risponderemmo che, dopo la rivoluzione, ciò che resta è sempre e comunque la vita. A dispetto del titolo, questo libro c’entra poco sia con la rivoluzione che con le commesse. O meglio, pur raccontandoci di questo, a ben vedere, è della periferia che parla, della periferia come luogo non luogo, come luogo delle possibilità latenti o represse o semplicemente addomesticate. Periferia inesistente sulle cartine, quella di Torreverde (nome inventato eppure evocativo, che ricorda i nomi di altre borgate – vere 42 Numero 6 giugno - luglio 2007 – romane), e allo stesso tempo vivida, realistica, possibile. E qui si fanno strada altre riflessioni: sulla vivibilità degli spazi urbani, sul ripensamento dei confini, fisici e metafisici, tanto per cominciare. (Daniela D’Angelo) L’uomo che si innamorò della luna, Tom Spanbauer, Mondadori (Strade Blu) «Se voi siete il diavolo, allora non sono io a raccontare questa storia. È non-io, Out-in-the-Shed, Fuori-nella-Baracca. Questo è il nome che mi aveva dato lei senza neanche saperlo. […] Credevo di chiamarmi anche Ehi-tu e Vieni-un-po’-qui-ragazzino. Più o meno per i primi dieci anni di vita pensavo di essere quello che dicevano queste parole “tybo”. “Tybo” significa “uomo bianco” nella mia lingua. E la mia lingua è poche parole che ricordo ancora.» Ma il nome con cui si cresce non è per forza il nome con cui si è nati, e prima o poi i conti devono tornare. Gli Stati Uniti di fine Ottocento sono quelli dei cow-boys e degli indiani persi nelle riserve e nell’alcool, dei mormoni che hanno deciso che l’unica giustizia possibile è la loro, dei bordelli dove Ida Richilieu serve bottiglie e bottiglie di whisky, dove Alma Hatch riceve i suoi clienti nella stanza numero 11, dove un ragazzino mezzosangue viene violentato da Billy Blizzard e, dopo aver sepolto sua madre su Non-una-vera-montagna, trova il suo rifugio in una baracca e, avvolto in un boa di piume, regala whisky e piacere agli uomini di Excellent. Questa è la sua vita tybo, ma non basta. Un giorno Shed chiede ai suoi occhi, alle sue gambe e al suo cuore di aiutarlo a scoprire il significato del nome Bannock, o forse Soshone, che gli aveva dato sua madre: Duivichi-un-Dua. Inizia così il viaggio in cui scoprirà la sua gente, troverà il significato del suo nome, ma sopratutto incontrerà, amerà, riderà e piangerà per l’uomo che si innamorò della luna. Dopo aver scoperto la sua vera natura potrà tornare a Excellent: lui, Ida, Alma e Dellwood saranno una famiglia: potranno amarsi, bere, fumare e ridere, dovranno difendersi da chi ha già deciso della loro anima, conoscere e affrontare la verità, dovranno scoprire se stanno giocando una partita in cui il mazzo di carte è truccato e se poi è tanto importante vincere proprio quella mano. Questo è il romanzo che ha reso famoso Spanbauer negli Stati Uniti, soprattutto per la sua capacità minimalista di costruire azzardati percorsi spazio-temporali, in cui svolgere vicende dai contorni spregiudicati. In questo libro si scopre la sua abilità nel creare una storia con tecnica e ricchezza, sviluppando, per esempio, materiale “pericoloso” come l’amore incestuoso tra padre e figlio, senza perdersi, ma con la calma e la serenità di chi ha in mano l’unica chiave possibile e sa bene quante volte deve girare perché la storia funzioni. La sua scrittura è ferma, definita e sicura e proprio per questo prepara con cura il sentiero per il lettore, lo aspetta senza forzarlo ma sapendo bene che arriverà dove lui vuole. È con questi presupposti che Spanbauer ha fondato una delle più importanti scuole di scrittura creativa degli Stati Uniti, la “Dangerous Writing”, dove si è formato uno scrittore “pericoloso” come Chuck Palaniuk. Il romanzo di Shed è quindi una storia fatta di scatole chiuse che lui cerca di aprire lentamente, di mettere in cerchio rivolte verso il cielo per scrutarle e scoprire che le cose non stavano come avevo sempre creduto io, e cioè che io non facevo quel che pensavo di fare e che, alla fin fine, non ero assolutamente quello che pensavo di essere. (Silvana Cannas) 43 Numero 6 giugno - luglio 2007 La vita in comune, Letizia Muratori, Einaudi Stile Libero La vita in comune è un romanzo che non si dimentica. Sul serio. Racconta le tensione, i disfacimenti di una famiglia borghese attraverso un coro di voci narranti che, come negli antichi cori greci, evocano il fato disgregatore in cui la storia si compie. Ma ci sono anche speranza, cambiamento. Tutto scorre però attraverso il dolore. Il libro traccia un filo rosso che lega l’oggi agli anni Settanta, l’Italia all’Eritrea, passa attraverso gli snodi del lavoro, della guerriglia, dei problemi di fame e di sete. Tre protagonisti tessono le loro storie in questo unico canto che ha come denominatore comune la percezione del pericolo, quella che lega fra loro uomini, animali e piante. Così come l’arrivo di un temporale carica l’aria e viene fiutato dalle bestie inquiete, così “la vita in comune” somma ogni creatura nell’inquietudine del pericolo, quel pericolo che si fa vita. Solitudine e amore sono gli estremi di questo percorso (percorso che viene ben narrato nel libro proprio attraverso l’intreccio di queste storie, che si intercettano e a vicenda si compiono). La prosa di Letizia Muratori a tratti procede attraverso suggestioni e umori “umidi”, altre volte si fa secca, spietata, come il sole cocente di un mezzogiorno di agosto. Ancora una volta Einaudi Stile Libero fa propria la scelta di una scrittura moderna, graffiante, che si scosta felicemente dagli stereotipi narrativi che sembrano affollare le nostre librerie. Ben venga. (Alina Padawan) Wei Wei, La ragazza che leggeva il francese, e/o “I pochi brandelli di frase che all’epoca aveva cercato di farci entrare in testa erano bastati a farmi intravedere l’abisso tanto largo quanto profondo che separa una lingua alfabetica, formulata per l’orecchio, e la mia [il cinese] lingua, monisillabica e ideografica, elaborata per la vista..” [...] “Dopo la fonetica, la grammatica francese. Ma...come? Una tazza? Un bicchiere? Un piatto? Una scodella? La tavola è femminile e il letto maschile? Quando si tratta di animali e di esseri umani, posso capire. Un gatto non è una gatta, un ragazzo non è una ragazza, è evidente. Ma gli oggetti, le cose senza vita? È logico suddividerle in maschile e femminile? [...] Nella mia lingua, il cinese, l’aggettivo non varia mai, nemmeno se il sostantivo al quale è unito indica una sola donna o un miliardo di uomini!” Wei Wei è una ragazza cinese che sin da bambina sogna di studiare medicina, verrà, invece, portata a diventare un’interprete, e quindi a studiare il francese, la Cina ha bisogno di lei. Il libro è un viaggio attraverso la sua adolescenza e attraverso la scoperta non solo della lingua francese, ma di una cultura altra. Leggendo la storia di Wei Wei entriamo in contatto con la cultura cinese, con le sue regole, le sue tradizioni, le contraddizioni che esistono tra la vita in campagna e la vita in città, l’importanza del lavoro manuale. Ma è attraverso i romanzi francesi un nuovo mondo si presenta alla nostra protagonista. Leggendo questo romanzo sembra di sostare su di una soglia. Da una parte la Cina, la sua storia, la sua cultura e la sua lingua; dall’altra la Francia, anch’essa con la sua cultura, la sua storia e la sua lingua. Due mondi che però, da questo punto privilegiato di osservazione, non si scontrano. Ciò che emerge è solo uno sguardo curioso, a tratti divertito... (Simona Taborro) 44 Numero 6 giugno - luglio 2007 Da rileggere Diario di un gatto con gli stivali, Roberto Vecchioni, Einaudi E vissero felici e contenti… E se invece non fosse così? Ma siamo proprio sicuri che i finali delle fiabe siano necessariamente quelli che ci aspettiamo? A questi interrogativi cerca di dare una risposta il poliedrico Roberto Vecchioni, che nel suo libro Diario di un gatto con gli stivali si cimenta in una rivisitazione, in chiave moderna, delle fiabe più conosciute. La sua si presenta come una decostruzione della tradizionale struttura narrativa, in cui l’inserimento del senso del dubbio, applicato alle psicologie dei protagonisti delle storie, fa si che le maschere dei diversi personaggi diventino intercambiabili. In generale, le fiabe e le favole si dipanano secondo uno schema ben definito, che vuole trasmettere in chi legge un senso di sicurezza, infondere un messaggio positivo e, in un qualche modo, consolatorio. Il denominatore comune che unisce la totalità delle favole è infatti rappresentato da una morale di giustizia in cui, immancabilmente, il bene trionfa sul male: tutti possono vivere felici e contenti, anche il povero può fare fortuna e ogni personaggio ha di fronte a sé delle prove, che una volta superate gli permetteranno di ottenere una vita migliore. Del resto, l’articolazione della fiaba era stata teorizzata, agli inizi del secolo scorso, dallo studioso russo Vladimir Propp, il quale aveva individuato nelle cosiddette “funzioni” gli elementi costanti che si presentano nel testo fiabesco secondo un determinato ordine. Seguendo il sistema di Propp, si nota come i personaggi delle fiabe sono innumerevoli e diversi, ma le azioni che essi compiono rientrano in una gamma ben definita e si ripetono spesso. L’eroe protagonista si trova a dover affrontare mille peripezie, a dover lottare contro forze avverse e, soltanto alla fine, ottiene la giusta ricompensa per i suoi sforzi. Il lieto fine è assicurato e, a seconda dei casi, può essere rappresentato dalla conquista dell’amata, dallo scioglimento di un incantesimo o più semplicemente dalla disfatta del personaggio negativo. Questo ordine precostituito viene totalmente stravolto nel libro di Vecchioni, dove buoni e cattivi si scambiano i ruoli e niente è come sembra. L’ingenua Cappuccetto rosso lascia il passo a una presuntuosa e spregiudicata ragazza, Pollicino soffre di crisi d’identità così forti da pensare al suicidio, il gatto con gli stivali tiene un diario in cui annota tutti i suoi progetti malvagi e il principe azzurro di Biancaneve assomiglia sempre più a un uomo annoiato e non più innamorato della propria compagna. Attraverso il gusto del contrario l’autore fornisce al lettore una chiave insolita e dissacrante, ipotizzando quindi interpretazioni diverse da quelle tradizionali. E’ come se gli ingredienti delle fiabe venissero rimescolati e andassero a intaccare l’aspettativa ultima, ovvero una rassicurante conclusione. Le vie percorribili non sono dunque date aprioristicamente: si apre un nuovo ventaglio di possibilità e di finali imprevedibili come nella vita. Nel “Diario di un gatto con gli stivali” Roberto Vecchioni applica al genere favolistico il collegamento tra mondo reale e mondo fantastico, una delle costanti della sua produzione di cantautore. La classica cristallizzazione di situazioni viene trasfigurata in un prisma sfaccettato, per questo più reale e più umano, dove davvero niente è come appare. (Raffaella Sirena) 45 Numero 6 giugno - luglio 2007 Le intermittenze della morte, José Saramago, Einaudi Come Saramago ha indicato in molti commenti ai propri scritti, l’adesione del lettore all’ “assurdo” dei suoi romanzi implica l’allineamento a una schiacciante consequenzialità che, anche nel caso delle Intermittenze della morte, apre le prospettive dell’incontro letterario a una logica del possibile. Il tono sarcastico definisce gli strani accadimenti che travolgono un imprecisato Paese -niente ha nome nel mondo di Saramago-, vittima di una morte volubile che, prima, infligge l’eternità con uno sciopero di sette mesi e, in seconda battuta, riprende implacabile il suo esercizio di definizione della vita, decimando la popolazione e dandone preavviso epistolare. Ma qualcosa non funziona e una missiva inviata a un violoncellista che ‘deve morire’ torna per tre volte al mittente. La morte, allora, si fa bella, e prende le sembianze di una donna per spiare meglio la sua vittima ostinata, trasformando quello che credeva un banale intoppo in una variazione sul tema, un’avventura nuova, per lei che, come mai prima, si scopre stordita dal fascino imprevisto di sensazioni vitali e sconosciute. L’umanità, travolta dai giochi della morte, è descritta nella sua essenza sociale. Meglio un’esistenza senza fine o l’anteprima del trapasso? La seduzione dell’eternità è inizialmente molto forte, ma le istituzioni vanno in tilt e l’intero sistema rischia di essere ribaltato sotto il punto di vista politico, economico, ideologico: il potere non può gestire la vita eterna, né l’immortalità concede speranza di resurrezione ai credenti. Fede e ragione vacillano. Destabilizzata nei cardini della sopravvivenza, l’umanità di Saramago sembra incartata nelle proprie meccaniche, incapace di resistere alla follia, alla disperazione e alla rabbia. Uomini come tanti polli impazziti nell’aia, come un gregge di pecore senza cane da pastore. Come succede anche oltre le pagine di un libro. Ed è per questo che il lettore non sente la mancanza del nome di questo paese emblematico, né di quello dei protagonisti di una storia che esprime, attraverso l’assurdo, il loop che mai risparmia le miserie umane. Eppure, anche la morte diventa vittima inattesa di uno smarrimento che cambia le carte in tavola e rovescia gli abusi di potere, portando la vicenda in un altrove che intuiremo a libro chiuso. L’incontro con la musica, per la tragica signora, è il colpo al cuore che regala la coscienza di una umanità resa meno banale dalla sintesi balsamica dell’arte: «quello che impressionava la morte, era il fatto che le era parso di sentire in quei cinquantotto secondi di musica una trasposizione ritmica e melodica di una qualsivoglia vita umana, normale o straordinaria, per la sua tragica brevità, per la sua intensità disperata, e anche per via di quell’accordo finale che era come un punto di sospensione lasciato nell’aria, nel vago, come se, irrimediabilmente, fosse rimasto ancora qualcosa da dire». (Seralisa Carbone) 46 Numero 6 giugno - luglio 2007 Le Catilinarie, Amelie Nothomb, Voland ‘Fino a quando, Catilina, abuserai della nostra pazienza?’ Marco Tullio Cicerone, I Catilinaria Deve aver avuto in mente proprio questa domanda Amélie Nothomb, scrittrice cult belga ma francese d’adozione, quando ha pensato alla trama del suo romanzo Le Catilinarie, che nel titolo esplicitamente richiama le celebri orazioni ciceroniane. E deve averla ritenuta uno spunto narrativo più che una domanda retorica, visto che ha provato, nelle poco più di cento pagine del suo libro, a seguire il filo rosso di una delle risposte possibili. Il nucleo incandescente de Le Catilinarie è infatti Palamède Bernardin (rompiscatole ‘archetipico’, ‘mitologico’), colui che abusa dell’altrui pazienza fino alla fine, fino alle estreme conseguenze del suo sopruso. Perché questo fa, spesso, Amélie: scava nell’irrazionale mistero dell’umano, scova una scintilla, un’immagine, un segno, e lo segue implacabile fino alle sue (in)naturali evoluzioni. Storia sognante e surreale, Le Catilinarie si apre presentandoci i suoi protagonisti, Juliette ed Émile Hazel, coniugi sessantenni uniti fin dall’infanzia da un amore tenero e complice. Spinti da un ‘bisogno forsennato’, più ancora che un desiderio, di ‘lasciare quella perdita di tempo che è il mondo’, comprano una casa in campagna, ‘graziosa, invisibile, scalata da un glicine’. Forti di un amore che basta a se stesso, i due decidono di abbandonarsi lì ad un sereno isolamento, per tutto il tempo che resta loro da vivere. Ma qualcosa si insinua nella vita dei due coniugi, trascinandoli pian piano lontani dal loro idillio: il vicino, dottor Palamède Bernardin, che un giorno bussa alla loro porta, apparentemente per far la loro conoscenza. Accomodatosi su quella che diverrà la ‘sua’ poltrona, evidentemente contrariato per la presenza dei suoi ospiti, annoiato dai loro tentativi di conversazione, risponde laconicamente a monosillabi alle loro domande: eppure (è qui che Amélie introduce la deviazione dalla norma, l’insania che squarcia la banalità del quotidiano) non se ne va. Per due ore lunghe e penose, Émile e Juliette sono obbligati a cercare di intrattenere un uomo sgradevole e grottescamente obeso, il cui ostinato rifiuto di stabilire un contatto fa da assurdo contraltare alla sua ostinazione a voler rimanere nel loro salotto. Da quel giorno, ogni pomeriggio, con inesorabile puntualità, Palamède Bernardin bussa alla porta dei coniugi Hazel; le due interminabili ore del primo incontro si trasformano in un’inquietante routine, i cui risvolti ossessivi si fanno sempre più evidenti. L’unione indissolubile di Émile e Juliette si ribella al grottesco che Bernardine incarna alla perfezione; ma la guerra che li vede coinvolti li vuole perdenti. Proprio di guerra, ci dice la Nothomb, si tratta infatti (non è un caso che Bernardin esca spesso ‘vincitore’ dai suoi pomeriggi dai vicini); è una lotta animale, un ‘assedio (…) infernale e senza uscita’ in cui i monologhi di Émile e Juliette, che si oppongono coraggiosamente al silenzio di Bernardin, sono veri e propri fatti d’armi, tentativi di resistenza. Ma, se possibile, tutto questo non è ancora il peggio che Bernardin ha da offrire: il peggio è sua moglie, grassa, abnorme, deficiente; una ‘cisti’, come la definisce sarcasticamente Émile, voce narrante del testo; una ‘tumefazione’, un ‘mammifero’ che ingurgita il cibo con disgustoso godimento, una creatura primitiva e ributtante che ben si colloca nella galleria di personaggi eccessivi e paradossali che contrassegna le opere della Nothomb. Eppure l’autrice, il cui sguardo si posa gentile e spietato ad un tempo su queste vite mostruose, sembra strizzarci l’occhio; e dirci che lei preferisce la debordante primordialità di Bernadette Bernardin alla torva assenza di sentimenti del marito. Perché ‘la voluttà eleva’, come ci ricorda Émile, ‘qualunque ne sia la causa’; e l’incapacità di Bernardin di provare piacere ne fa un subumano, più di quanto possano l’orrendo corpo e la mente tarata di sua moglie. In un romanzo che si snoda fluido e piacevole fino al sorprendente epilogo dai risvolti macabri, spiccano le capacità linguistiche e stilistiche dell’autrice, che tutto usa con misura perfetta: la sua solida cultura, l’ironia intelligente, un certo gusto quasi punk per il raccapricciante. 47 Numero 6 giugno - luglio 2007 La totale assenza di barocchismi, di ridondanze, di eccessi, modella la materia rovente della trama in un testo di grande pulizia formale, ma anche di straordinaria intensità. Il linguaggio di Amélie si modula docile attorno agli eventi narrati; il suo rigore, la sua purezza, la tenue poesia di alcuni momenti (‘… era un inizio d’aprile come lo descrivono nei libri di scuola, con fiori leggeri come le eroine di maeterlinck…’) sembrano richiamare le origini giapponesi della scrittrice, nata a Kobe e a lungo vissuta nel paese del sol levante. Di lei, leggenda vivente, si raccontano storie di eccessi ed inquietudini; si dice che abbia scritto più libri di quanti anni abbia – 40 -, ma che li pubblichi centellinandoli, uno all’anno, per la sua piccola casa editrice francese Albin Michel, a cui è sempre fedele (come in Italia è fedele alla Voland). Forse proprio per la sua vita travagliata e fuori dall’ordinario Amélie riesce così bene a cogliere il fascino dell’umano - come quello del disumano. E riesce anche, come fa magistralmente con Le Catilinarie, ad immergersi lieve nell’assurdo del mondo, riemergendone con in mano una piccola perla letteraria. (Barbara Ronca) 48 Numero 6 giugno - luglio 2007 Tutte le fiabe sono uscite dalle profondità del sangue e della paura. (Franz Kafka, Conversazioni con Gustav Janouch) Favola: una storia dell’orrore per preparare i bambini ai giornali. (L. L. Levinson, The left-handed dictionary) L’immaginazione è più importante della conoscenza. (Albert Einstein) Ci sono crimini peggior del bruciare libri. Uno di questi è non leggerli. (Josif Brodsky) Un libro che non è degno d’essere letto due volte, non è neppure degno che si legga una. (J. K. Weber) Una notte d’amore è un libro letto in meno. (Honoré De Balzac) Il tempo di scambiarci poche parole, e mi precluse il regno mentale che lei sembrava disprezzare con tanta alterigia, e che porta un rosso nome viscerale: il cuore; - mi vietò anche l’antro di odori, di colori, il segreto asilo dove sicuramente scorazzava un possente arabesco di carne, una cifra di membra mescolate, monogramma simbolico dell’Inesorabile... In una parola, l’Inesorabile, io raduno il fascio di forze al quale non abbiamo saputo dare che il nome di «sensi». I sensi? Perché non il senso? Sarebbe pudico, e sufficiente. Il senso: cinque altri sottosensi si avventurano lontano da lui, che li richiama con uno scossone - proprio come dei nastri leggeri e urticanti, per metà erbe, per metà braccia, delegati da una creatura sottomarina... (Colette, Il puro e l’impuro) 49 Numero 6 giugno - luglio 2007 Quel che resta del giorn-ale Il mondo sta cambiando molto in fretta. Chi è grande non sconfiggerà più chi è piccolo, ma chi è veloce batterà quelli che sono lenti Rupert Murdoch Dobbiamo avere il coraggio di guardare in faccia la realtà. Il mondo sta cambiando, e il giornalismo tradizionale è in crisi. Non basta fare i gadget (l’edicola è ormai un bazar dove trovi di tutto, dallo scialle al rossetto, dal libro al dvd): i quotidiani sono attaccati al respiratore e se si stacca quel respiratore (i gadget, appunto) si collassa imemdiatamente. Decresce la pubblicità sulla carta stampata a favore della migrazione su internet, diminuisce il numero dei redattori (tagli drastici in Europa e in America, negli ultimi anni), aumenta la free press. Vittorio Sabadin ha scritto un libro prezioso, L’ultima copia del New York Times, in cui racconta i cambiamenti drastici che la stampa sta attraversando. E racconta le crisi, le resistenze. Ma non si può fermare il cambiamento. Dunque è meglio adeguarsi. Ho vissuto per quindici anni in mezzo alle riviste cartacee. Le ho costruite, insieme ad altri, numero su numero, timone su timone, pezzo su pezzo. Fino a pochissimi anni fa non riuscivo neanche a concepire l’idea che questo mezzo non fosse l’unica soluzione possibile per il giornalismo scritto. E invece oggi dirigo una rivista online, mi diverto a progettare inserti multimediali e soprattutto cerco di integrare gli aspetti tradizionali con quelli più moderni, attuali. Ho dovuto vincere le mie resistenze. Ma l’ho fatto. E ho capito che la carta stampata non sarà il futuro del giornalismo. Non sarà l’unico futuro, almeno. Certo, è bellissimo trovare conforto nella solidità della carta, nel suo odore, in quelle distese di parole che si possono toccare, sniffare, accartocciare. Eppure è anche necessario capire che il web potrà affiancargli un giornalismo efficace, magari diverso, sì, ma efficace. Specie se i quotidiani tradizionali continueranno a chiudere gli occhi, a voler proseguire una linea di fatto già sconfitta. Aprire il Corriere della Sera in metropolitana è come stendere un lenzuolo matrimoniale sul letto di una formica. Gli articoli culturali di Repubblica a volte fanno svenire anche il più erudito dei lettori. E poi la lontananza dalla gente. Tanta. Troppa. Mentre il giornalismo dovrebbe per sua natura essere vicino alle storie fatte di carne, di sangue, di sudore. Invece continua a ossequiare i padroni, cioè i gruppi politici ed economici che influenzano le linee editoriali con le loro brave pressioni. 50 Numero 6 giugno - luglio 2007 Ed ecco che nasce il citizen journalism, ecco che i blogger americani battono i giornalisti nel dare la notizia in tempo reale o nello scovare dettagli sconosciuti (spesso scomodi). Ci eravamo innamorati, tutti, di Tutti gli uomini del Presidente. Ma dobbiamo anche vedere cosa succede davvero, oggi. Dobbiamo vedere la debolezza delle redazioni, i bavagli e le parole schierate. Forse internet non è il nemico ma è invece carburante per un risveglio, una reazione. Di certo, così non si va avanti. Un po’ di pepe nel deretano certamente non guasta. Non bastano, però, le letteronze di Maria Latella che risponde ai lettori nella sua mezza paginetta, quando poi le cronache locali romane sono infestate da settagli su Provincie, regioni, imprenditorie e costruzioni. E la gente? Che succede davvero in città, oltre alle solite, drammatiche notizie di cronaca nera? Come respira la città? (O come soffoca, dati i livelli di inquinamento). Che si dice? Come si conciliano tutti i colori del mondo in una metropoli che continua a essere così provinciale? Quanti articoli si potrebbero fare. Ma non vanno bene. Non fanno gli interessi dei politici e degli imprenditori. Quelli della gente, oggi, sono minoritari. Il giornale è un luogo di potere i cui spazi sono contesi come jene con una carcassa. Dio mio, e se la carcassa fosse proprio quella del giornalismo? O meglio, di un certo tipo di giornalismo? Perché comunque la voglia di raccontare, l’urgenza della notizia, la voglia di dire e di scrivere cosa succede non moriranno. Ma cambieranno forma, probabilmente. Questo sì. E per fortuna. (Effepa) Qualcuno volò sul nido di Alda Sono una donna anziana, di 76 anni, malconcia, che ha subìto diversi interventi di cui l’ultimo all’anca e quindi faccio fatica a muovermi. Mi piacerebbe uscire, scendere le scale (non ho l’ascensore) e fare una passeggiata per le vie della città, bere un caffé al bar, sorretta dal mio bastone. Ma ho paura. Paura del mondo attorno perché è così spaventosamente cambiato. Io sono stata in manicomio per tanti anni, ma dopo la legge basaglia (legge 180 che ha fatto chiudere i manicomi) i matti sono in giro e hanno ragione di essere matti: c’è troppo odio in questa società. Un odio che ha devastato l’Italia e che rende le persone ignoranti, aride e cattive. Non c’è più amore per nessuno. E per assurdo affermo che mi sentivo più sicura in manicomio, anche se so che con questa mia affermazione urterò la sensibilità di molti: io vorrei che riaprissero i manicomi. Dico di più, vorrei ritornarci.Tra le mie quattro mura non mi sento sicura, ho dei vicini terribili, persone inqualificabili. Mi disturbano con il silenzio, se facessero rumore mi farebbe piacere, vorrei sentire le grida dei loro bambini, invece niente, silenzio tombale che mi porta a domandare “sarà in casa?”.Poi improvvisamente questo silenzio viene rotto da un rumore violento che ti fa sobbalzare perché non te l’aspettavi e se sei fragile di cuore può anche farti male. È una tortura morale. Madre Teresa di Calcutta diceva che c’è qualcosa di più grave dell’omicidio colposo: l’indifferenza, che può arrivare a uccidere un uomo. Ecco, i miei vicini mi trattano con indifferenza.Non parlano, non si rivelano, fanno comunella tra loro, 51 Numero 6 giugno - luglio 2007 continuano a vedermi come la donna che è stata in manicomio, una sorta di stigam impresso addosso, che mina la mia identità pesonale, per loro io sono ancora matta, E anche mia figlia lo è, per il solo fatto di essere nata da me. Ma i veri disturbati di mente sono loro. La gente odia la malattia mentale perché ha paura di essre uguale al malato di mente, molti non lo sanno che sono già uguali ai pazzi. E così li emarginano credendosi sani. I miei vicini di casa ricostruiscono la mia pazzia. Sparlano alle mie spalle perché la mia casa è disordinata, per loro vivo nella sporcizia, loro invece hanno case asettiche, perfette e impersonali ma non si rednono conto che vivono nella sporcizia morale. Il fatto che non mi rivolgano la parola è drammatico. (Alda Merini, testimonianza pubblicata su D - la Repubblica delle Donne) Già. Alda Merini non è una donna comoda. E non vuole esserlo. Tutt’altro. Ma un’anima sensibile come la sua, tutta pelle, esposta alle variazioni climatiche di un temperamento mutevole, incline alla malinconia e allo stesso tempo dotata di ali, le grandi ali dei folli (folli di saggezza, mi verrebbe da dire), deve fare i conti con la tristezza quotidiana di quel mondo patologico che noi chiamiamo normale. Normale perché dormiamo. Normale perché ci rifiutiamo di vedere le nostre miserie, le nostre patologie, le nostre nevrosi ormai elette a modello sociale. Sul piano psichico, la differenza tra il “sano” e il “malato”, diceva Freud, è solo una differenza quantitativa, non qualitativa. Quantitativa. Quindi il confine che separa (apparentemente) i due mondi risiede solo in un accumulo di peso, in un aumento della pressione. Interessante. Molto interessante. Siamo tutti potenzialmente folli. Non si tratta di un gene particolare (perlomeno finora neanche gli scienziati DNAdipendenti hanno isolato e indicato il cromosoma responsabile della follia). Non si tratta di una virata improvvisa verso territori a noi sconosciuti, in cui si aggirano allucinazioni e fantasmi. Noi, quei territori, li abbiamo già dentro. Esistono diversi gradi di follia. Ancora una volta, si tratta di gradi. Di un aumento della temperatura che fa bollire la coscienza, la trasforma in magma esplosivo, lava che cola travolgendo le barriere mentali. Ma i matti, spesso, sono saggi. Terribilmente saggi. Vedono cose che noi non vediamo. Sì. E tuttavia queste visioni non hanno solo a che fare con le deformazioni psichiche, le proiezioni, gli stati paranoici o allucinatori. A volte i matti vedono, semplicemente. Non guardano. Come diceva anche il Piccolo Principe di Saint Exupery, tra il guardare e il vedere esiste una differenza. C’è un libro bellissimo, Le libere donne di Magliano, in cui Mario Tobino ci regala un affresco umanissimo, perfino” sensato” (sì, c’è un “senso”, una direzione, anche nei matti, il loro caos a volte nasconde archietture precise, come accade con i frattali) del manicomio in cui lavora. La sua domanda è sempre attuale: «La pazzia è veramente una malattia? Non è soltanto una delle tante misteriose e divine manifestazioni dell’uomo, un’altra realtà dove le emozioni sono più sincere e non meno vive? I pazzi hanno le loro leggi come ogni altro essere umano e se qualcuno non li capisce non deve sentirsi superiore». Si sentono invece molto superiori, i vicini di Alda. Lei, la vecchia poetessa pazza, fa paura. E io mi domando se questo timore non scaturisca proprio dalla voglia di evitare il confronto con uno specchio evidente (in cui l’immagine si inverte, come in tutti gli specchi) che ci rimanda ll nostro reale disordine nascosto dietro le “pulizie” che ostentiamo. Dietro quella normalità in cui infiliamo i nostri disagi, le follie che tratteniamo nel pugno della mano, preferendo chiudere gli occhi e dormire. Forse le donne di Magliano sono davvero libere. E noi, noi prigionieri delle nostre paure, degli attaccamenti, dell’ incapacità di vedere la follia di una società che si ammala di indifferenza. Una società in cui il cuore si chiude, la mente si ottunde, la ragione sancisce il predominio relegando i fantasmi inconsci in soffitta, insieme al baule con i libri di Freud, insieme alle ombre che potrebbero urtare il magnifico profilo sociale e civile in cui ci illudiamo di vivere mentre forse stiamo invece morendo. Se solo avessimo più coraggio. Se solo decidessimo di guardare in faccia i nostri matti. Saremmo allora liberi. Come le donne di Magliano. Come Alda. Certo, un po’ picchiatelli. Ma liberi. (Alina Padawan) 52 Numero 6 giugno - luglio 2007 Visioni (senza commento) Terra madre In questo periodo assolato, difficile non fare il punto sulla situazione. Abitiamo una Terra che sta morendo. L’abbiamo violentata, sfruttata, devastata. Ne abbiamo scavato e percorso ogni solco, trasformando la sua carne, la sua umida terra, in catrame. Delle foreste abbiamo fatto carta per le nostre grafìe e legno per le nostre eco-abitazioni. I mari, i mari belli e avventurosi, ospitano oggi le scorie di fiumi sfiancati dalle immissioni di pesticidi e altre schifezze. Quegli stessi mari in cui l’uomo si è più volte perduto, cantando lo sguardo annegato nella vastità dei suoi specchi d’acqua. E in quegli stessi mari i ghiacciai, oggi, si stanno sciogliendo. Orsi polari, foche e balene non avranno più i loro banchi ghiacciati. La superficie solida si scioglierà costringendoli a stare a galla o a contendersi a morsi le superfici superstiti. Su quelle zattere improvvisate vedranno la deriva delle loro abitazioni inghiottite dal mare. Sulla terra le cose non saranno migliori. Alluvioni si alterneranno alla siccità, i tornadi saranno sempre più potenti, il Sole malato incendierà la Terra con i suoi bagliori di fuoco, non più protetti dalla coperta di ozono. Apocalisse? Purtroppo no. 53 Numero 6 giugno - luglio 2007 Realtà. Perché il futuro è qui. È adesso. Ma le notizie sull’agonia del nostro pianeta non bastano, con la loro evidenza, a far virare la coscienza dell’uomo. L’ultima riunione scientifica mondiale, pochi mesi fa, ha sfornato dati allarmanti, per due giorni televisioni e giornali hanno diffuso le notizie sui disastri imminenti (non ultimo quello relativo all’oro blu, alla carenza di acqua la cui minaccia avanza irrimediabilmente). Ma il giornale si butta via, la televisione si spegne, l’inerzia del quotidiano fatto di allegri consumi ci riporta al nostro beato menefreghismo. In più, questi giorni ho visto persone aggirarsi contente e abbronzate. Tutte scosciate, con l’ombelichino di fuori, esibivano i loro infradito nuovi di zecca. Ah, finalmente, non sopportavo il freddo (ma quale?) Che bello, è già estate! Magari domani vado al mare. Ma che giornata stupenda! Giornata stupenda? Sarò una Cassandra fuori dal coro, ma ho paura. Sono inquieta, come i miei gatti che di notte si lamentano senza trovare riposo, fiutando incerti questa strana atmosfera. Sento che la Terra sta morendo. Ne avverto gli spasmi, le ultime richieste febbrili. Le margherite sbocciate a febbraio mi stringevano il cuore. Stavano lì, poveri fiorellini in cerca dell’abbraccio del sole, ignari della loro temeraria presenza, del loro fragile aprirsi a un inverno capace, con una gelata improvvisa, di spezzarne il profumo. Soffro per ogni uccello che perde il senso della sua migrazione. Per ogni rondine scomparsa. Per ogni pianta ingannata dagli scherzi di una stagione impazzita. Assisto alle mutazioni di un tempo senza più bussola e direzione. Non basta un protocollo a Kyoto. Non bastano le buone intenzioni. La boa è stata doppiata, il punto di non ritorno raggiunto. Possiamo solo attenuare i danni, se ne siamo ancora capaci. Il futuro è già qui. Adesso. Sta nelle nostre mani. Gli indiani d’America non aravano la terra che doveva rimanere vergine, inviolata. Solo noi ne abbiamo fatto un luogo di abusi. C’è un libro uscito una decina d’anni fa, Ishmael, di Daniel Quinn, che nella sua struttura fiabesca racconta di un gorilla-guru che istruisce un allievo sul destino di un’umanità destinata a precipitare. Perché Caino non smette di uccidere Abele, perché l’uomo pensa che la Terra sia stata creata da lui. Il libro ha ispirato Instinct, film bellissimo, dolente, in cui si narra dei “lascia” – le antiche civiltà agricole e dei “prendi” – gli uomini moderni che tutto saccheggiano, procedendo come cavallette. Ecco, il “prendi” che è in noi non ha ancora imparato a mollare. Mollare la presa su una terra agonizzante, assetata, derubata dei suoi frutti. È nostra madre, la Terra. Lo è non solo simbolicamente. Se non iniziamo ora, non sarà più possibile cucire le sue ferite. Dobbiamo imparare a difenderla. Meglio pensarci sopra, piuttosto che correre spensierati verso una giornata di mare. (Lady Oscar) 54 Numero 6 giugno - luglio 2007 La dolce attesa Novità dall’Inghilterra. Con un nuovissimo kit fai da te presto si potrà conoscere il sesso del nascituro già dopo poche settimane di gravidanza. Mah. Ogni cosa diventa scommessa per una una previsione, un controllo, uno sfogo purulento di onnipotenza. A che cavolo serve sapere subito se avremo un bambino o una bambina? Per appendere un fiocchetto rosa oppure azzurro alla porta della nostra casetta? Per iniziare subito la sfilata di vestitini? (I neonati, loro, non vanno mica in giro con le gonnine o i pantaloni) O forse per il toto-nomi? Beh, alla faccia della pianificazione. Se andiamo avanti così, presto troveremo perfino il sesso degli angeli. Per quello dei bambini, a quanto pare, non c’è più scampo. Schedati da subito. Neanche un feto può più stare tranquillo, vivere in pace nelle acque materne, che subito arriva qualcuno e rompe le palle. Subito devono sapere, fare, disfare... Perlomeno piantiamola di chiamarla ancora “dolce attesa”. Di un’attesa, ormai, non c’è quasi più traccia... (effepa) 55 Numero 6 giugno - luglio 2007 La storia si fa attraverso il cibo. E il cibo attraversa la storia. Questo è il senso di www.atavolaconlastoria.com l’originale blog di Fabrizio Sette. Le tradizioni culinarie dell’uomo nell’età antica e medievale. Scoprirete che il “biscotto” altro non era che il pane degustato dai marinai del ‘300, cotto due volte per essere meglio conservato, che i Romani amavano l’antipasto ma poco apprezzavano la birra, e che il vino, alimento e parola, nacque nella regione tra il Mar Nero e il Caucaso Meridionale. Ricco di citazioni e frutto di appassionate ricerche è un blog per conoscere i gusti del presente attraverso la storia del passato. Per rimanere in termini culinari si consiglia il sito www.mangialibri.com. “Leggi come mangi” è il motto adottato da questa testata giornalistica tutta dedicata al mondo dell’editoria e diretta da David Frati. News e recensioni dedicate a libri e autori di ieri e di oggi. La rassegna stampa, il magazine, uno spazio ad hoc per i fumetti e un blog per essere sempre aggiornati perché come recita un articolo del manifesto Mangialibri “tutti i lettori meritano di essere informati”. Un sito di servizio, http://www.lavoricreativi.com/. Dall’art director al giornalista, dal web designer al fotografo. Offerte e richieste di persone la cui professione ideale è figlia della creatività. Un forum in cui trovare le risposte a tanti dubbi e in cui partecipare attivamente proponendo nuove discussioni. La newsletter per ricevere in tempo reale solo le proposte che fanno per voi. Realizzato da interno3.it, rappresenta un ottimo aiuto per districarsi meglio nell’odierna giungla del mondo del lavoro. E per chiudere sulla scia della creatività segnaliamo il blog100x100: 100 storie in 100 parole. Uno spazio online aperto a tutti dove poter inviare un racconto, firmato o non, che non superi il limite delle 100 parole. Una sfida, ma non una gara. Non si vince nulla, si vuole solo sottolineare quanto la comunicazione sia anche partecipazione da affrontare con l’aiuto della fantasia. Non solo prosa: per chi preferisce la poesia c’è lo spazio 100x100 versi. L’obiettivo è quello di raccogliere 100 racconti. Cosa accadrà dopo? Ora non è possibile saperlo, mancano ancora 51 passi per raggiungere il traguardo. (segnalati da Ettore Luttazi) 56
Scaricare