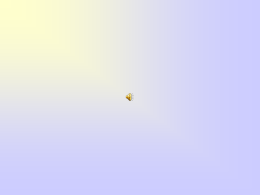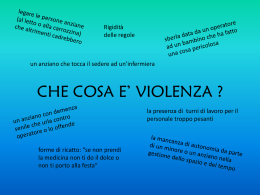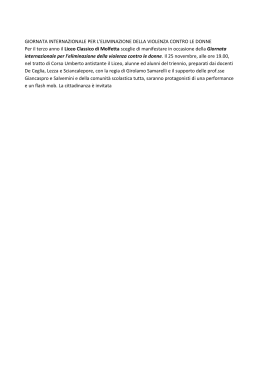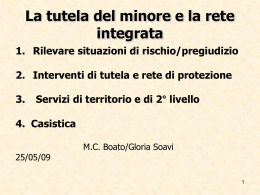Fare rivista dentro la crisi lunga della sinistra: due lettere dei tempi di «Inoltre» Tra il 1996 e il 2003 ho partecipato attivamente al gruppo promotore della rivista Inoltre, che continua ad uscire edita tuttora dalla Jaca Book. In quegli anni attorno a Inoltre confluirono vari intellettuali in rotta con la sinistra partitica (storica e nuova). Avevano, credo, la speranza di trovarvi un luogo capace di accogliere una ricerca politica e culturale non ingessata negli schemi delle burocrazie della sinistra. L’iniziale fervore di un’ampia fascia di potenziali collaboratori fu alimentato dall’alleanza stabilitasi tra una figura “storica” e anticonformista come Luciano Della Mea e Giuseppe Muraca, che da Catanzaro aveva anche lui tentato di fare rivista promuovendo Utopia concreta, presto bloccata dall’indisponibilità dell’editore Pullano. Vennero costituire tre redazioni: una del Centro Italia facente capo a Luciano Della Mea, una del Sud coordinata da Giuseppe Muraca e una del Nord affidata a me. E a Milano, nella fase di avvio, riuscii a far partecipare agli incontri redazionali che si tenevano mensilmente diversi insegnanti e ex militanti di nuova sinistra. Scegliemmo dei temi, discutemmo la possibilità di affrontarne altri in forme seminariali, valutammo i primi testi dei collaboratori che arrivavano numerosi. Purtroppo non vi fu neppure il tempo di consolidare il lavoro e delineare un chiaro progetto politico e culturale. Tra i fattori che, a mio parere, misero presto in crisi l’esperimento ci furono: - la diffidenza o l’imbarazzo di alcuni dei partecipanti, quasi tutti “di sinistra”, verso l’appoggio pur formalmente corretto venuto all’iniziativa dalla casa editrice milanese (la Jaca Book, se non più emanazione di Comunione e Liberazione, era comunque legata alle gerarchie ecclesiastiche); - il ribaltamento, già dal secondo numero, della scelta di avere una direzione collegiale e paritaria della rivista (L’”imposizione” infelice da parte di Luciano Della Mea e della Jaca Book di Ivan Della Mea come direttore responsabile portò all’uscita immediata di Giuseppe Muraca dalla direzione); l’abbandono dell’intenzione iniziale di consolidare le tre redazioni con un intenso lavoro di riflessione e discussione interna e di radicarne altre nelle città dove fosse stato possibile; l’impegno subito rislutato tiepido della Jaca Book nella distribuzione e promozione della rivista. Tra i vari tentativi di fare rivista negli anni Novanta questo è restato forse quasi sconosciuto, marginale e sotterraneo. Eppure ebbe il merito di raccogliere l’inquietudine di una diaspora di intellettuali di massa, che tuttora è in cerca non solo di riconoscimenti individuali, ma potrebbe dare energie per costruire nuove forme indipendenti di cooperazione intellettuale. Specialmente agli inizi di Inoltre ebbi modo con alcuni di loro di intrecciare scambi epistolari personali particolarmente intensi, anche se collaterali al lavoro della redazione. Data, infatti, l’eterogeneità delle provenienze politiche e culturali e delle attese, non c’era modo e tempo di discutere tutto negli incontri mensili. Di uno di questi scambi con Ezio Partesana, scaturito dal lungo articolo che riporto in appendice, pubblico la sua prima lettera e la mia risposta. Il perché il tutto appaia nella rubrica Nei dintorni di Franco Fortini, risulterà evidente dalla lettura. [E.A.] Ezio Partesana a Ennio Abate (Milano, 20 dicembre 1997) Caro Ennio, ho letto il tuo lavoro in questi giorni e ci sono delle cose che vorrei dirti; alcune riguardano l’aspetto obiettivo del tuo scritto, sono pubbliche e te le anticipo qui solo in parte, altre riguardano un confronto/battaglia tra di noi che è ora di cominciare a esplicitare. Mancano presupposti comuni o se ci sono, sono inespressi, così che forse il tono della lettera risulterà più acerbo di quanto vorrei. Tu prendilo per quel che è e non te ne offendere. Le obiezioni pubbliche si restringono a due essenziali. Ho qualche perplessità sull’interpretazione che offri del saggio di Benjamin sulla Gewalt, e sull’accostamento, anche se estemporaneo, tra Fortini e Negri. Per cominciare con Benjamin, lo scritto al quale fai riferimento è piuttosto acerbo, se non ricordo male dovrebbe essere degli anni immediatamente successivi alla prima guerra, 1918 o ‘19. Questo significa che appartiene in pieno al tempo in cui Benjamin studiava l’allegoria barocca, dava del Lei a Scholem e non aveva ancora sviluppato una critica della società borghese. Il che ovviamente non significa che allora il testo giovanile vada buttato via, piuttosto che per essere inteso vada collocato in quel contesto. In breve mi pare che la Gewalt della quale lì si parla sia da intendersi appunto come allegoria, meno di un concetto e più di un’immagine. Qualcosa di formalmente compiuto e racchiuso sotto cui si cela l’apparire di nuovi contenuti. Detto altrimenti, Benjamin, direi, considera in quello scritto il luogo comune della violenza per quanto di nuovo veicola nelle contraddizioni che acquieta. Non è quindi possibile utilizzarlo per una discussione con Türcke, la Arendt o altri che hanno di fronte a sé dimensioni effettuali della violenza, e di queste parlano. Bisognerebbe probabilmente intrecciare quello scritto con i Passagen e verificare come sia concepita lì la violenza, anche se mi rendo conto costituirebbe una mole di studio che richiede molto tempo. Assai più breve è dirti perché non mi piace l’accostamento tra Fortini e Negri. La definizione fortiniana del comunismo deriva direttamente da Marx (“... il movimento che abbatte lo stato di cose presente”) con un’accentuazione hegeliana del termine “movimento” (Bewegung è parola chiave della dialettica della Fenomenologia), mentre la determinazione di Negri e Hardt viene direttamente da Spinoza letto come protomaterialista del desiderio (il corpo, anche quello sociale, come materia del desiderio). A parte il fatto che credo i due si detestassero - Fortini e Negri intendo - non è affatto una questione filologica. Fortini aveva in mente la questione cruciale dell’anticipazione (“la lotta per il comunismo è già il comunismo”, cito a memoria), quel problema cioè che sorge quando si concepisce la lotta di liberazione sotto specie di un’abnegazione religiosa rimandando al futuro l’effettivo soddisfacimento. Così che nel frattempo qualsiasi durezza è non solo permessa ma addirittura giustificata. Negri a Hardt invece, e con loro quelli che ancora possiamo identificare con l’area dell’autonomia, sono convinti che l’autonomia del politico significhi, in un’epoca nella quale le forze materiali e mentali della produzione sarebbero in grado di assicurare ricchezza e tempo liberato a tutti, che sia sufficiente prendere individualmente posizione fuori dalla socializzazione ineguale per ritrovarsi ipso facto in una dimensione sociale non capitalista. L’esodo, appunto. Ma di questo avremo tempo di discutere insieme alla prossima riunione di redazione, se ci sarà da parte di tutti abbastanza pazienza e umiltà da non cominciare a protestare. Ho meditato a lungo prima di accendere il computer e scrivere. Perché sono così spesso in così profondo disaccordo con te? tanto da provare rabbia? Si parla e si scrive come se la dialettica marxista regnasse indiscussa nella cultura e finalmente ce ne si volesse liberare per un respiro più ampio, e invece di filosofia marxista non se ne vede l’ombra da vent’anni. È un quarto di secolo che gli intellettuali mettono tutto insieme: metafisica, logocentrismo, tecnica, dialettica e lotta di classe in un unico mito che soffocherebbe l’uomo, il pensiero e il progresso. Poi aggiungono che dialettica e marxismo sono stati confutati dall’89 (come Engels: la prova dell’esistenza del pudding è che me lo mangio) e che adesso finalmente non è più necessario farci i conti nella teoria, basta la prassi della vittoria del capitalismo. È questa la verifica dei nomi? Perché citare Hannah Arendt come punta di diamante della riflessione sulla violenza quando le stesse cose le scrisse Aristotele; che cos’è che rende così appetibile la Arendt se non il fatto che non fosse marxista, né dialettica? Davvero per non dover più studiare Hegel, Adorno, Marcuse, Horkheimer, Bloch e magari anche Lukàcs basta scrivere che la dialettica non è in grado di mostrare il che fare? Perché Heidegger e Derrida sì? Il che fare è un problema della teoria? Non si era detto che stava sul confine sempre percorso tra teoria e prassi? Non ci siamo. Capisco il bisogno di fare piazza pulita: si rischia di non avere nulla da dire, e cioè per un intellettuale che non sia accademico della frusta o pubblicitario di partito, niente da essere, nessuna identità, nessuna funzione sociale. Ma accidenti non si può fare così. La fatica di criticare Lenin o Adorno (o Lukàcs scriverebbe Fortini) è micidiale. Perché bisogna capire la realtà dei processi in atto. E bisogna capirla di quel capire che confina col fare, di quel leggere e scrivere che Fortini (per citare ancora un autore che abbiamo amato entrambi) alla biblioteca di Cologno Monzese elogiava nei manuali dei più svariati argomenti nonché sospetto, ma le mie conoscenza letterarie sono troppo brute per dirlo, anche in Manzoni. Perché abbandonarsi adesso a pensare la violenza - voglio scriverlo anche a costo di sembrarti uno sciocco - senza almeno ricordare quella che estrae e distribuisce valore, cioè tempo di vita? Hai deciso che ce ne sono altre più radicali? più originarie? D’accordo, ma per lo meno ce lo devi dire apertamente e, possibilmente spiegare. Tu dirai: non è vero. Te le mostro. Si scrive della violenza, ovvero di un concetto e una pratica. Sappiamo che concetti e cose intrattengono tra loro rapporti assai complessi. E va bene. Ma quei pensatori ai quali tu ti appoggi per parlare della violenza, o almeno per impostare il discorso, condividono tutti un’idea di che cosa sia la violenza della quale si parla, che è idealista. È un concetto giuridico-politico di violenza che essi adoperano, come se questa fosse l’origine. Si affrettano poi a dichiarare che l’Origine è un mito metafisico. Con il che, si suppone, il potere della parola dovrebbe trasformare un’origine in una non origine o, come elegantemente si esprimeva già Schelling, un Urgrund in un Abgrund. Ma non è vero. La società che è organizzata politicamente e giuridicamente è anche un corpo vivente che produce quel che consuma in modo sociale e, attraverso quello, riproduce se stessa. Chi ha deciso che in questo processo non ci sia violenza? Perché la Arendt e Negri e Hardt (che pure trovo bravissimo) non sono interessati a questo? E perché io devo far la parte del cretino che lo scrive a te come se tu non lo sapessi? Che cos’è che ti tiene così lontano da quelli che lottano per le solite cose: casa, salario, cittadinanza, salute, etc.? Siamo giunti per impotenza - e per crisi della funzione intellettuale - a fare a pezzi i riassunti da brutto manuale di liceo della nostra tradizione. Così non va Ennio. Che questo servizio lo rendano altri sulle pagine culturali di Repubblica è già abbastanza triste (se pensi che lo fondarono, quel quotidiano, per scavalcare in intelligenza il Corriere dove scrissero i Fortini, i Calvino, i Pasolini - a proposito: lui sulla violenza non ha detto proprio nulla? dobbiamo tirarlo fuori solo per le poesie, i festival del cinema e Valle Giulia? - ), che lo si faccia noi: impensabile. Ma tu dici: non è vero. Te lo mostro. La condizione postmoderna, scrivi. Dove è? Che cosa è? Il fallimento del blocco guidato dall’Unione sovietica per l’esodo di masse attraverso il muro di Berlino, dici. Ce ne siamo accorti solo allora? Non c’era stato nessun segno, nessuna frase e pratica politica prima a dire che quel percorso era sbagliato? E adesso per scrivere la nostra storia non abbiamo a disposizione niente di meglio di questa teoria degli opposti estremismi e dell’esodo? Non credi che potrebbe usarla anche Ferrara o Mieli o quell’altro imbecille che dirige i telegiornali su ItaliaUno? Oppure vogliamo finalmente discutere (grattarsi ognuno si gratti dove gli prude, in silenzio però e a casa sua) di come si produce la ricchezza che consumiamo, se davvero c’è così tanto lavoro morto disponibile (tecnologia e informatica) che non serve più sfruttare quello vivo, se davvero le transnazionali hanno fatto fuori l’imperialismo, se la produzione è sul serio così snella che si può translocarla dovunque, e via dicendo? Non si diventa più intelligenti facendo piazza pulita e si rende un cattivo servizio ai compagni. E credo anzi, al contrario, che se c’è qualcosa di utile oggi sia ripetere con ordine un’intera cultura teorica e pratica che stanno sotterrando come i soldati iracheni nel deserto. Tu mi dirai: questa non è una via politica. È vero. È molto meno. Una sopravvivenza invernale. Però noi siamo questo pochissimo, non altro. Ho smesso di avere pudore dei gruppi operai, precari, integrati in cassa, disoccupati, e quant’altro. Non mi danno alcun fastidio, o molto meno degli sproloqui fuori dalla storia e dalla società sul pensiero meridiano. C’è del lavoro concreto da fare, parziale quanto vuoi ma reale. E se invece vogliamo fare una rivista di riflessione, questa non si costruisce rinnovando lo stock delle merci culturali, anche perché così nuove poi non sono neppure..... Basta. Rileggo e sono perplesso. Mi dispiace dirti queste cose e non ho avuto l’intelligenza di distinguere quelle dirette a te da altre con le quali non c’entri per nulla. E sono anche stanco. Ci sono decine di tabelle che devo studiare e non ho ancora capito che cosa abbia a che fare la caduta delle borse est-asiatiche con la struttura produttiva di quei paesi. Facciamo così: tu leggi questa lettera e poi buttala - io ti chiamo dopo Natale e ci vedremo di persona. Ezio. Ennio Abate a Ezio Partesana (Cologno M. 13 genn. 1998) Caro Ezio, considero la tua del 20 dicembre un buon avvio per chiarire scelte personali (mie) e scelte del gruppo che si è andato aggregando tanto faticosamente attorno alla “scommessa” di INOLTRE. Non m’infastidiscono il tono baldanzosamente giovanile, il gusto per il termine polemico e tagliente, la propensione fino alla pignoleria filologica e filosofica di chi lavora ben più di me su testi, che io ho abbordato per condanna o abitudine da ladro di ciliege. Sì - lo so - anche questa è una maschera, ma non del tutto falsa; segnala agli altri (e ricorda a me stesso) il mio autodidattismo “pezzente”, solitario e convulso, ma pretende di suggerire: per favore, valutate le ciliege che ho rubato; non rimproveratemi di non aver scelto con cura gli alberi da cui coglierle. Erano quelli che avevo sottomano... Torno perciò a indossarla per passare in rassegna punto per punto le tue obiezioni al mio articolo (nei limiti del tempo che ho a disposizione e senza ricorrere ad altre letture o alla rilettura dei testi a cui mi sono riferito), ma evitando il “confronto/battaglia tra di noi” a cui sembri sollecitarmi. Mi sento, infatti, da molto tempo in un atteggiamento esplorativo, abbastanza solitario, pacato e fuori dalle scolastiche e vorrei sedimentarlo, superando nel lavoro stesso di lettura/riflessione/scrittura i dubbi e le obiezioni Alcune delle tue perplessità o rilevazioni di “contraddizioni” - quella ad es. dell’”accostamento tra Fortini e Negri” - sono già “mie” ( e mi pare di averlo dichiarato nel mio stesso scritto, in partenza). Ma non le drammatizzo come fai tu fino a “provare rabbia” per il nostro “profondo [?] disaccordo”. Perché? Semplicemente non vivo più come attuali o decisive queste perplessità o “contraddizioni”. Soprattutto sul piano della ricerca non stabilisco - per usare di più il tuo linguaggio - il confine amico/nemico dove lo metti tu. Sempre a proposito di Fortini-Negri, ti ho già detto che non so in quali termini “i due si detestassero”. Credo comunque all’interno di una comunanza quantomeno “anticapitalistica” e “umanistica” (se si vuole accentuare la “religiosità” di Fortini o il “materialismo” di Negri). E questo già mi potrebbe “bastare” - anzi mi è bastato - per frequentare - come ho fatto e sempre solitariamente (con i rischi e i meriti della ricerca solitaria) - i testi dell’uno e dell’altro. E, in proposito, mi vengono in mente i rapporti amore/odio fra Fortini e Cases o fra Fortini e Pasolini, non poi così dissimili (Vedi in particolare Attraverso Pasolini). Non mi voglio evitare (o non riesco a “superarlo”) questo “strabismo teorico” per il momento. In una certa misura e direi a partire dal ‘68-’69, per come ho vissuto e interpretato la contingenza storica in cui ci siamo venuti a trovare, l’ho ritenuto inevitabile e l’ho considerato verso la fine degli anni ‘70 persino profilattico (almeno per la mia mente) rispetto a modalità settarie, staliniste, paranoiche di condurre la ricerca in quella che tu definisci la “nostra tradizione”. Incoraggiamenti non scolastici in tale direzione ho trovato anche nei testi e nella vicenda intellettuale di Fortini. Ma anche se fossero mie “proiezioni”, non mi dissuaderebbe dall’insistere la tua distinzione - filologicamente corretta - fra “la definizione fortiniana di comunismo [che] deriva direttamente da Marx” e “la determinazione di Negri e Hardt [che] viene direttamente da Spinoza”. E non - qui davvero mi metti in un mucchio a cui non appartengo - per snobismo, gusto dell’oltrepassamento, “bisogno di far piazza pulita” o adesione alle mode culturali del momento, che imporrebbero di non studiare più “Hegel, Adorno, Marcuse, Horkheimer, Bloch e magari anche Lukàcs” ma Heidegger e Deridda. Ma proprio - come tu dici - “perché bisogna capire la realtà dei processi in atto” e non mi basta più “la nostra tradizione”. Che io non censuro affatto né demonizzo ( come invece tendi a fare tu per i pensatori dell’ esodo). Tra l’altro - a prova della mia impermeabilità a certe mode più diffuse fra gli accademici che nell’isolamento di Cologno - tengo a dirti che ho letto i testi di Negri - certo, non sempre capendo con quel “capire che confina col fare” (ma la ragione dello scollamento teoria-prassi non l’attribuirei solo ai testi letti e alla rappresentazione del reale lì tentata, ma ad una trasformazione imprevista e in parte indecifrabile del mondo attorno e dentro di noi...) - quando non era più in auge ma orami era finito in carcere per il 7 aprile; e ho trovato il tempo di accostarmi a Adorno, Lukàcs, Bloch proprio negli anni ‘80, quando già non li si leggeva più; e - infine - ho seguito pazientemente, ma sentendo fin dall’inizio la “debolezza” mascherata da “grinta intellettuale”, tutto lo sforzo di Preve per non mandare all’aria Marx fino ai suoi ultimi opuscoletti degli anni ‘90, pungenti sempre ma bloccati in un corpo a corpo troppo rancoroso e sospetto con “il mondo ex” (Matvejevic). Per me, dunque, ci troviamo in una situazione caratterizzata dal naufragio di quella che tu chiami “la nostra tradizione”. Essa non è neppure un tesoro sommerso che basti ripescare, magari sobbarcandosi “la fatica di criticare Lenin o Adorno (come mi pare tu voglia fare e che è un programma stimolante soprattutto però “per filosofi”...). Ripeto non basta (non = non serve, dimentichiamola, sputiamoci addosso!). Forse per questo nel mio tentativo di “pensare la violenza” non mi sono attenuto ai “classici”. Per stanchezza di una certa scolastica, lo riconosco. Ho cercato di “appoggiarmi” - senza premeditazione e seguendo il filo dei miei umori e pensieri e condizionamenti culturali e pratici - su certi pensatori e non altri. Senza chiedermi prima se erano idealisti o meno (Non ho - ti ripeto queste legittime e forse buone preoccupazioni “da filosofo” e te lo dico senza scherno alcuno...). Li ho trovati problematici, stimolanti, non liquidatori di alcuni punti fermi sulla violenza da me maturati. Sulla questione della violenza sono troppo problematico? Forse, ma direi che ce n’è bisogno (anche se gli intellettuali funzionari, non quelli critici, confondono il porre problemi con viltà o difesa di “privilegi”). Non ho poi presentato le mie esplorazioni di quelli che considero - fuori dalle scolastiche correnti “buoni pensatori della violenza” come il nuovo tesoro teorico che sostituisce quello “sommerso”. La mia attenzione ai pensatori dell’esodo è di cauta simpatia e non partigiana. Di chiaro so che mi sono posto il compito di rompere un certo tabù di diffidenza e di sufficienza verso le loro elaborazioni (quasi sempre condannate senza alcuna lettura). Non mi sembrano così propagandate in giro e - nella mia capoccia solitaria di periferico - le trovo ricche di spunti fecondi per accedere alla sfuggente realtà contemporanea , specie se confrontate con le stantie scolastiche partitiche. Né mi pare che almeno Negri e Hardt (per la Arendt - letta più con spirito documentario - ho espresso le mie riserve quasi “istintive”) siano così disinteressati al nesso lavoro-violenza. (Negri in particolare - per quel che ricordo del suo lavoro La forma Stato - ha sempre collegato costituzione materiale e costituzione formale-giuridica). Sono anni che c’incrociamo e non collaboriamo. E a impedirlo mi pare sia proprio quell’atteggiamento resistenziale (la nostra tradizione, la nostra storia, “noi siamo questo pochissimo”) che, pur richiamando pensatori o autori a me cari e che non voglio affatto di lasciar perdere, tende a partitizzarli, a museificarli un po’, a usarli come paletti pre-selettivi. Ora dovrai riconoscere anche tu che, se una tradizione è naufragata, non può essere solo per la cattiveria del Nemico o per la viltà dei chierici, specie se mi ricordi - e giustamente - che già ben prima dell’ Ottantanove c’erano segni, frasi e pratiche politiche che indicavano che “quel percorso [dell’Urss] era sbagliato”. Non credo perciò di rendere “un cattivo servizio ai compagni” (parola di cui non abuserei); e all’incontro possibile con quanti stanno ai margini (o fuori) quanto o più di me (compresi i “gruppi operai, precari, integrati in cassa integrazione, disoccupati, e quant’altro”) mi sento di andare solo con le carte in regola cioè aprendomi il varco verso di loro proprio con “una rivista di riflessione”, mediazione necessaria e solo in apparenza più “debole” di tante pratiche mediate da altri saperi più “forti”, cioè oggi più scolastici e partitizzati.... Un saluto affettuoso e pieno di stima Ennio Ennio Abate, Commento, novembre 2008 A me pare che le due lettere testimonino un diverso modo di atteggiarsi nei confronti della tradizione (comunismo, Fortini). Emerge anche la differenza tra una mentalità filosofica, quella di Ezio, fresco di studi e di tesi, e la mia più eclettica e inquieta. Certo l’accostamento tra Antonio Negri e Franco Fortini farebbe tuttora scandalizzare. Ma io ero consapevole delle distanze tra i due. Tuttora però credo che il vantaggio della mia posizione fosse quello di non fermarsi alla filologia. Il credito che davo e do a Negri è quello che darei ad uno che ha viaggiato in paesi mentali (Spinoza, Foucault, Deleuze) che io non ho avuto modo di visitare. Non significa approvare tutto il suo racconto, ma ascoltarlo con attenzione critica, magari confrontandolo proprio con quello di Fortini che aveva viaggiato in altri territori filosofici (Gramsci, Adorno, Lukács). Mi era e mi resta insopportabile il giudizio sprezzante sul lavoro di Negri. Quasi sempre ho avuto modo di verificare che non veniva dalla lettura dei suoi testi ma semplicemente dall’immagine pubblica che di lui hanno veicolato i mass mediai. E questo valeva anche per Fortini. In tanti ne parlavano con la stessa superficialità usata verso Negri. (Oggi poi non ne parlano neppure più, a riprova dello stile modaiolo, per cui si cita nella propria chiacchiera solo chi appare alla Tv o sui giornali). Ezio Partesana, Commento allo scambio di lettere con Ennio, novembre 2008 Ennio mi ha chiesto di pubblicare queste due lettere e volentieri per lui acconsento. Non sono mai stato capace di discutere senza arrabbiarmi, che fosse per voce o per iscritto, e l'età che mi separa da quelle missive non ha, purtroppo, migliorato la situazione. Per cui avanzo la preghiera a chi legge di perdonare il tono tragico e infantile di quanto scrissi allora all'incolpevole Ennio. Quale interesse possano avere quelle incaute riflessioni oggi non saprei. Se un punto riesco a vedere è, forse, solo nella convinzione che gli anni e il mondo debbano trasformare quella rabbia in lucidità (per citare il maestro Fortini), e se non a me almeno a altri. Un abbraccio a tutti i compagni, con affetto. Appendice Su alcuni buoni pensatori della violenza1 Ennio Abate Noi abbiamo fatto quello che abbiamo dovuto wo eine fremde Sprache herrscht secondo gli ordini di due ordini secondo due leggi (F.Fortini, Stammheim) In generale ... Molte domande si affollano alla mente, quando pronunciamo la parola violenza alla fine del '900, di questo «secolo breve» definito senza possibilità di facili smentite «il secolo più violento della storia dell'umanità». Provo a indicarne disordinatamente alcune. Come può essere riaffrontato senza troppi autoinganni questo tema in una Europa egoisticamente "protetta" dalle tragedie quotidiane che devastano certe regioni del mondo? e da una rivista di studio fatta da intellettuali di massa, che sono anch'essi prodotto sociale, comunque selezionato e in parte salvaguardato, di una storia (quanto riconosciuta?) di violenza subita/esercitata? Possiamo ancora fare affidamento sulle culture politiche che hanno fatto da sfondo alle lotte emancipative del secolo? o dobbiamo prendere atto che una condizione postmoderna più o meno realizzata ha cancellato, museificato o ridotto a rovine quelle nostre culture cristiano-borghesi e social-comuniste? Valgono perciò ancora le formule usate per definire la violenza in particolare dalle Scolastiche laiche "di sinistra": «continuazione della politica con altri mezzi» (Clausewitz), acceleratrice dello sviluppo economico (Engels), «levatrice della storia» (Marx)? E sono davvero più convincenti (o solo più rassicuranti?) le Scolastiche religiose in senso proprio, quelle invocanti la Pace, se e da tempo «la pace è la continuazione della guerra con altri mezzi» (cosicché il titolo del recente libretto di Marcos, La quarta guerra mondiale è cominciata, appare meno balzano di quanto possa sembrare a tanti distratti contemporanei)? E, insomma, è "la stessa di sempre" la violenza oggi in atto - visibile e devastante o sfuggente e quotidiana - se l'economia è globalizzata o si avvia ad esserlo? Possiamo ripeterci che - tutto sommato - la violenza resta comunque "marginale" rispetto ad altri 1 Pubblicato su «Inoltre», Jaca Book, primavera 1999. fenomeni "progressivi" che di solito qualificano una civiltà, un'epoca? Pensare la violenza Malgrado il tema della violenza sia stato e resti uno dei più chiacchierati, pensare la violenza oggi è indispensabile, anche se registriamo crescenti difficoltà nel farlo. Oltre alle chiacchiere, ci si affanna a ideologizzarla, a fissarla in descrizioni spettacolari e persino la "corretta informazione", invece che premessa di un'azione politica efficace, si disperde nel rumore di fondo o addirittura conferma e rafforza a volte la diffusa impotenza politica e la rassegnazione oggi prevalenti di fronte al disagio della civiltà. Molti dei modi più abituali e consolidati di discuterne, infatti, impediscono sia di pensare che di fare (di pensare bene per fare bene) e rianimano al massimo solidarietà e indignazione inerziali. Analisi scientifiche e prediche edificanti partoriscono aiuti "umanitari" (= elemosine) ai poveri del mondo. Appelli di protesta o richieste di grazia a sempre più impermeabili potenti sembrano sostituire le vere e efficaci pressioni e azioni divenute oggi impossibili; e prese di posizione simboliche non fanno che riecheggiare e attutire nell'opinione pubblica e privata gli scoppi delle bombe, le urla delle vittime, il furore dei combattenti armati. Le tragedie reali in ex-Jugoslavia, Ruanda e Burundi, Algeria, Perù o le efferatezze della normale cronaca quotidiana nelle metropoli e nei paesini più vengono comunicate in forme velocizzate e impeccabili e più si dissolvono. L'impotenza degli "uomini di buona volontà" e dei "democratici" è coperta da una delega implicita che permette la continuazione degli studi, degli affari, dei consumi. Invocare l'intervento USA-ONU (guerra del Golfo, Bosnia-Erzegovina), cioè del nuovo feticcio falsamente universalistico, dello Stato postmoderno che in sostanza quegli eventi di violenza produce, amministra e soffoca non è pensare la violenza, ma goderne gli utili. Aggrapparsi al residuale potere degli Stati nazionali o affidarsi a speranze secessioniste su base etnica significa voler solo la difesa della proprietà e dei poteri da violenze presunte o reali degli altri, gli esclusi, ai quali appunto non si desidera pensare, ma che si vogliono veder fluttuare televisivamente nel proprio immaginario di benestanti o di semigarantiti. I soprassalti di buona volontà o di democraticità svaniscono presto di fronte alle strette dei conflitti reali rimossi. Non più al bando le "utopie" ma simbolicamente praticabili ormai in CD-rom "per tutti", com'è capitato al "mitico '68", si accetta di scegliere in fondo fra l'esistente che c'è: o Stato postmoderno o Stato nazionale residuale o Bande mafiose o Sette New Age. Chi vuole scuotersi dalla solitudine, da questo torpore sociale, dai luoghi comuni, dalle rimozioni organizzate cosa può fare? L'avevano pur pensata prima di noi, no? Può rimettersi sulle tracce di alcuni buoni pensatori della violenza. Non è cosa dappoco oggi e non solo per una rivista. Pensare la violenza non è stata un'operazione inevitabilmente posticcia o neutrale e la vastità e complessità delle teorie prodotte non deve scoraggiare lo sforzo d'indagarle per cercarvi alcuni punti d'appoggio. Al minimo, otterremo un antidoto contro il cinismo del consumo simbolico di violenza spettacolarizzata e contro un certo pacifismo inerte, altrettanto orrendo. Non si ricaveranno automaticamente gli strumenti conoscitivi adatti per fronteggiare come desideriamo le tragedie in corso, ma uno spostamento dai luoghi comuni classisti, forcaioli, razzisti, sessuofobici è condizione indispensabile per guardarle senza veli ipocriti. Fra le “rovine” della Sinistra Ma quali sono oggi i buoni pensatori della violenza? Non lo so con certezza, ma ne ho scelto alcuni che mi sembrano rispondere a una sentita esigenza di far piazza pulita di un modo diffuso specialmente "a sinistra" di esorcizzare il problema della violenza - malgrado le apparenze - considerandolo "chiaro", "scontato" o, in anni più recenti, addirittura "superato". Comincerei perciò con un'affermazione di Fortini fatta proprio in occasione delle vicende di "violenza politica" dei nostri anni più "superati" (i '70). Essa colpiva già quando apparve, nel 1985: «se il terrorismo è stato vinto, i suoi vincitori non hanno convinto». In modo lapidario e pur dall'interno della cultura di Sinistra del secondo dopoguerra, Fortini constatava «la catastrofe ideologica tanto della sinistra "storica" quanto della "nuova"», rimasta succube della prima e dilaniata fra «progetti e azioni che si richiamavano a taluni aspetti della lotta terzinternazionalista o a modelli resistenziali, armati, bellici» e «atteggiamenti neolibertari, di fraternità immediatistica, da "espropri proletari" o da "occupazioni"». Questa catastrofe ideale e pratica si era svelata con più drammaticità proprio di fronte alla violenza che comporta l'uccisione del nemico. Osservava Fortini: «il cattolico collega coerentemente morale, religione e diritto e rimanda al Vangelo e alla dottrina della chiesa; mentre il comunista italiano di oggi si è preclusa la possibilità di rinviare, non solo ai testi e ai metodi marxisti, ma persino a tutta una parte della riflessione sullo stato e sulla violenza che è all' origine della borghesia». Era ormai divenuta "di sinistra" l'opinione che «qualsiasi azione violenta debba essere considerata politicamente erronea e giuridicamente perseguibile [e] che il metodo democratico [ridotto ad esclusione della violenza e principio di maggioranza] debba essere difeso e praticato sempre». Oggi, questa sua polemica contro l'«ottimismo radical-progressista» e l' «ideologia italiana» del defunto PCI e della Prima Repubblica è forse senza bersaglio. Ma, per farsi largo attraverso le nebbie ben più fitte dell'ideologia "normale" della Seconda Repubblica, resta la sua indicazione: pensare «la dimensione tragica dei conflitti fra gli uomini, la insolubilità dei dilemmi, se posti a livello giuridico o morale; la parte della violenza nella storia; la natura del potere economico e politico». Di politica si morì. Di privato si muore. Per pensare la violenza, dopo che in tanti abbiamo abbandonato delusi il terreno politico, bisogna ammettere che non basta ripartire dal proprio vissuto. Si parli del labirinto della Sofferenza o dei dintorni del palazzo fantasmagorico della Felicità, luoghi smarriti o trascurati dal Politico, resta l'insoddisfazione di ritrovarsi chiusi nelle serre spesso asfissianti dell'Estetico e dell'Immaginario. Certo, il pensiero che oggi si interroga (che arriva a interrogarsi, che gode del "privilegio" di potersi interrogare ... ) non imbocca automaticamente il varco che conduce al Reale e può chiudersi in un suo mondo cristallino, logico, altrettanto autoriferito rispetto a quello di chi parte dal proprio vissuto ed evita in apparenza le sofferenze o le felicità altrui, nominabili, avvicinabili, storiche. Né, dopo un secolo di psicoanalisi, è rimasto così tetragono e disincarnato da cavarsela dicendo: cos'è una pena amorosa di fronte alla tragedia degli albanesi? Riconosce, nei suoi filoni critici, che ci sono fenomeni ed esperienze incommensurabili sotto vari aspetti; sa che la sofferenza individuale non è annullata da quella collettiva, ma anche che i drammi sociali e politici di milioni di uomini e donne non sono sostituibili e surrogabili da quelli degli individui. Il pensiero critico non cela realtà e possibilità, cerca politiche e terapie. Vede quanto la felicità o sofferenza individuale è anche produzione del collettivo (e non di metafisici principi: Bene e Male ... ) e mostra come - schiacciando le minoranze, i diversi, le singolarità e ribadendo un'amministrazione gerarchica delle risorse, umiliante o mortifera per i molti – la felicità goduta dai privilegiati è vampiresca e mortifera. Volete confrontare la felicità ottenuta escludendo gli altri o goduta in mezzo ad una folla di poveracci o di idioti, e quella provata fra pari? L'ipotesi di una politica della Felicità, che spesso si agita nelle menti private per esorcizzare gli incubi della Politica pubblica e reale, resterà un feticcio ottimistico vanamente onorato in un vuoto astorico, a mezz'aria come in tutti gli Ideali. Non si scappa. Si deve attraversare il mondo (contemporaneo), costruendo nuove sensibilità, nuovi immaginari, ma anche nuovi concetti. L'ipotesi della politica della Felicità, per deprivatizzarsi, si deve confrontare direttamente con il pubblico, con certe situazioni emblematiche della violenza contemporanea: ex Jugoslavia, Algeria, Chiapas, Albania; e con le forme di violenza quotidiana: di camera, di strada, di luoghi di lavoro e di emarginazione, oggi ancora più sottili e nascoste. La violenza ridimensionata a strumento Hanna Arendt mi pare una buona pensatrice della violenza, anche se ne ha trattato soprattutto alla luce della crisi della civiltà occidentale e in un' ottica che privilegia il potere costituito rispetto al potere possibile. La Arendt non liquida la funzione positiva che il potere può avere nelle società umane, non lo demonizza, evita le soluzioni impolitiche. Afferma infatti che «il potere emerge ogni volta che la gente si unisce e agisce di concerto, [e] deriva la sua legittimazione dal fatto iniziale di trovarsi assieme». Quindi, esso per lei non è mai la semplice facciata della violenza («il guanto di velluto che nasconde il pugno di ferro»), che, considerata di per sé rischiosa, viene distinta dal potere (c'è una obbedienza consensuale alle leggi e un'«obbedienza indiscussa» ottenuta con un atto di violenza) e ricollocata in una funzione solo ancillare: di strumento, di mezzo, da usare cautamente, limitatamente, responsabilmente come un medicinale tossico. Harendt afferma, perciò, che la violenza può essere «giustificabile, ma non sarà mai legittimata» e che - qui è proprio una buona liberale! - «come tutti i mezzi, ha sempre bisogno di una guida e di una giustificazione per giungere al fine che persegue». La trova perciò razionale perlopiù se persegue obiettivi a breve termine, poiché «non sappiamo mai con un minimo di sicurezza le conseguenze ultime di quello che stiamo facendo». Se ne deve fare, dunque, un uso limitato e circoscritto (quasi solo per «drammatizzare le ingiustizie e ... sottoporle all'attenzione dell'opinione pubblica»), poiché «se gli obbiettivi non sono raggiunti rapidamente, il risultato non sarà la semplice sconfitta ma l'introduzione della pratica della violenza in tutto l'insieme della politica». La Arendt non arriva però al rifiuto assoluto della violenza come fanno molti pensatori impolitici e critica soprattutto quelle che considera «le mitologie della violenza» (presenti a suo avviso in Fanon, Mao, Sartre ... ). Insomma mira a fare della violenza un'«arma della riforma più che della rivoluzione». Insiste perciò fin troppo - e in un'ottica più esistenzialista che storica - sui «tratti più pericolosamente seducenti» della violenza, soprattutto quella collettiva che genera «forti sentimenti di fratellanza» ed è «condizione di ogni politica», intesa come «mezzo che ha consentito di sfuggire all'uguaglianza davanti alla morte per ottenere una distinzione che [assicuri] ,una certa dose di immortalità». Liquida perciò, senza troppe distinzioni, come biologistiche e organicistiche tutte le concezioni della violenza che vi vedono in varia misura una manifestazione della vita e della sua creatività. Violenza e potere non sono dunque per lei «fenomeni naturali ... manifestazioni di un processo vitale», «appartengono alla sfera politica delle cose umane» e solo la ripresa di un'effettiva «facoltà di agire nel mondo», un potere più umanizzato, esteso e razionale metterà fine all'esaltazione spesso astratta della violenza, mentre «ogni contrazione [monopolistica] del potere è un aperto invito alla violenza». Si potrebbe obbiettare che la distinzione fra potere e violenza non è così stabile e chiara come afferma la Arendt. (Perché è così facile, quando si sta perdendo il potere, veder emergere il dominio della «pura violenza» o del terrorismo? Perché potere e violenza sono così intercambiabili e la loro distinzione appare, malgrado tutto, teorica?) Ma le sottili e utili distinzioni concettuali della Arendt1 mirano ad un'assolutizzazione che mi pare liquidatoria di possibilità emancipative e liberatorie, diciamo pure, violente. Non le basta affermare, infatti, che «il potere e la violenza non sono la stessa cosa». Afferma in modo drastico che «il potere e la violenza sono opposti; dove l'una governa in modo assoluto, l'altro è assente». Perciò l'opposto della violenza non sarebbe la non violenza, ma il potere: e questo parrebbe esente dalla violenza. È questa contrapposizione, questa separazione del potere (statico e positivo) dalla violenza (dinamica e solo distruttiva) che non convince, anche se certo la Arendt non dice che «la violenza sia uguale al male».3 La Arendt afferma che «la violenza non può essere derivata dal suo opposto, che è il potere». E allora da dove sarebbe venuto il potere? Si è mai costituito un potere senza ricorso alla violenza? La violenza è sempre condannabile, destinata a essere "cieca", "folle", "distruttiva"? Sporgendosi fuori dalla Sinistra nello Stato postmoderno Degli spunti importanti per affrontare la questione della violenza mi sembrano presenti - e so quanto un'affermazione del genere cozza contro pregiudizi e ipocrisie" di sinistra" - nel libro di Hardt e Negri, Il lavoro di Dioniso, e in particolare nel capitolo Critica pratica della violenza. Perché? In primo luogo proprio per la fotografia lucida che àncora il discorso alla realtà contemporanea della quale vengono tratteggiati alcuni fondamentali aspetti: lo scarto fra ricchezza degli strumenti di analisi politica e incertezza sulla pratica politica possibile; il collasso della società civile e dei suoi tradizionali canali di resistenza collettiva; la dispersione della produzione di massa di fabbrica; la perdita di potere del movimento sindacale, ma anche della scuola e della stessa Chiesa. Per concludere: «Sul livello pratico, se guardiamo alle forme contemporanee della militanza, sembra che, con la scomparsa delle istituzioni tradizionali, l'orizzonte della pratica politica possibile si sia ristretto, tanto che oggi sembra che vi siano solo due poli di attività rimasti: la nonviolenza e il terrorismo. Posti di fronte a queste due opzioni, e riconoscendo il carattere suicida e controproducente del terrorismo, i militanti scelgono per la maggior parte la strada nonviolenta» (pp. 114,115) Secondo: per la critica coerente sia del pacifismo che del terrorismo: «Il rifiuto della violenza su cui esso [il potere] si fonda è troppo facilmente confuso con un rifiuto del potere tout court ... I militanti nonviolenti, che raramente sono essi stessi vittime, si mettono nella posizione di essere vittimizzati per rappresentare l'ingiusta sofferenza di chi non ha potere. Paradossalmente, queste azioni tentano di guadagnare consenso facendo leva sul potere morale della rappresentazione dell'impotenza. In questo senso, l'azione non violenta è l'immagine speculare del terrorismo. Anche il terrorismo opera per mezzo di gesti sinbolici, è anch'esso orientato verso la trasmissione di un messaggio per mezzo di una rappresentazione mediatica, ma l'azione terrorista cerca, al contrario, di rappresentare il suo potere e l'impotenza del nemico, lo Stato. Il piano della rappresentazione unisce l'azione nonviolenta e il terrorismo: sui suoi due poli opposti» (pp.116) Queste azioni «in genere una forma di protesta che punta alla penetrazione nei media» e che risultano quasi del tutto inutili «se private di una rilevazione da parte dei media» sono simboliche, non orientate verso il loro scopo diretto, «a differenza dello sciopero del movimento operaio, che metteva in campo una pressione diretta, economica e politica, sulla direzione d'impresa e sullo Stato riducendo realmente i profitti e mettendo in pericolo l'economia nazionale». Non si sfugge al simbolico? Questa riduzione al simbolico (che oggi è di moda esaltare come segno di "incivilimento", di "società trasparente", trascurandone però effetti e presupposti fondati comunque su meccanismi di coazione, meglio celati ma non scomparsi) è messa in luce con chiarezza anche da un altro buon pensatore della violenza, Cristopher Türcke. Egli ammette con amaro e prezioso rèalismo che «in un certo senso oggi ogni resistenza è puramente simbolica: ha un che di solo apparente» e mostra senza ipocrisie i limiti o l'inanità dei movimenti di lotta più o meno recenti: delle "barricate" («si gioca alle barricate»), dei sit-in antinucleare («è comunque chiaro a priori che non si impedirà in tal modo la costruzione dell' impianto di rigenerazione dell' uranio»), degli scontri di piazza («che il potere dello stato può permettersi fin quando sia a priori chiaro che le manifestazioni non raggiungeranno il loro scopo»), degli «scioperi ritualizzati». La lotta spostata sempre più esclusivamente sul terreno simbolico porta certo «il marchio del vano e del ridicolo» e può portare all'occultamento illusorio dei «veri rapporti di forza»: ci accomoda, cioè, in una politica dello struzzo ... I! simbolo è divenuto "un surrogato", la politica è diventata spettacolo. Sempre e solo rappresentare? Türke screma il campo della chiacchiera universale e infinita sul tema della violenza. La sua tesi di fondo è che «il rifiuto di ogni violenza è soltanto la sua ipocrita approvazione». La violenza è tabù: è praticata, restando tabù, come educazione («rinuncia all'istinto bruto») e come «rinuncia a pensare» per sopravvivere. Il suo attestarsi in una critica dell'«illusione della non violenza» all' ombra solenne di Adorno, smascheratore instancabile di «tutte le dimensioni della violenza in cui gli uomini dei paesi tecnicamente più progrediti sono impigliati», non è oggi posizione dappoco e permette di spazzar via cumuli di ipocrisia. Ma la sua «dialettica negativa», pur evitando quelle dichiarazioni di estraneità alla violenza, rischia di scivolare verso l'impolitico, da cui deriva (e lo fanno coerentemente Simone Weil e molti pensatori che qui non affronto) una morale ascetica che nega vita e potere. Il suo pensiero sembra paralizzato o in perenne attesa di fronte alla doppiezza irrisolta dello Stato moderno, che «garantisce i diritti fondamentali dell'uomo tanto quanto li sabota» o «realizza i diritti fondamentali dell'uomo in forma falsa»; oppure condannarsi a un continuo e indefinito smascheramento dell' «essenza antispirituale che c'è nello spirito della costituzione borghese», nel nome dei «diritti dello spirito contro l'antispirito». Türcke mi pare impigliato nel compito di dialettizzarsi col potere costituito e senza più speranza di "superamento". Infatti, dopo aver giustamente distrutto l'illusione che sia possibile l'assenza di violenza, pone il compito (abbastanza complicato) di distinguere tra violenza legittima e illegittima; oppure tra violenza evitabile e violenza inevitabile con lo scopo di liberarcene almeno in parte, riconoscendo che essa non può essere «mai completamente eliminata ... anche in un'unione di uomini liberi», poiché «ci sarebbe una completa assenza di violenza soltanto là dove cessasse del tutto la rinuncia all'istinto: nella conciliazione di spirito e natura». Rispetto a Türcke, la critica di Negri e Hardt alla nonviolenza mi pare più acuta, perché denuncia più apertamente il problema dell' ambiguo e oscuro rapporto che essa comunque intrattiene col potere costituito che, legittimato anche dal consenso dei non violenti, la violenza l’esercita. Per Negri e Hardt, la tradizione nonviolenta, con la sua innegabile componente religiosa (da Gandhi a Thomas Merton a Martin Luther King), la sua pretesa validità universale (specie in Gandhi, che la riteneva «giusta e dunque universalmente applicabile, in tutte le situazioni e lungo tutto il corso della vita di una persona») e la sua diffusione e popolarità specie negli Usa, mostra una debolezza teorica così formulabile: come, infatti, si può criticare la violenza ponendosene del tutto al di fuori, se «la complicità è una condizione della nostra esistenza sociale»? Violenza pensata dialetticamente. Violenza pensata fuori dalla dialettica. La posizione di Negri e Hardt, che rompe con la dialettica a cui ancora fa appello Türcke, mi sembra più adeguata ad una critica della condizione postmoderna. Non ritiene, infatti, che «tutte le pratiche e le teorie della modernità debbano essere considerate esaurite e invalidate», ma sceglie quella linea di pensiero, che «da MachiavelIi e Spinoza fino a Marx, e nel periodo contemporaneo da Nietzsche fino a Foucault e Deleuze» ha riaffermato «un terreno alternativo di critica sul quale si sono formate soggettività aperte alla democrazia radicale e al comunismo», un comunismo però non più definibile «soltanto in termini marxisti» e di cui si dirà più avanti. Essi mostrano un senso più preciso dell' azione politica possibile, forse proprio perché si rifanno alla tradizione materialista che - a differenza della Arendt prima nominata - ha sempre visto «l'esercizio del potere, che è l'essenza del mondo, come una forma di violenza» e, con Spinoza e Nietzsche, affermano che «la vita stessa implica violenza, e non avrebbe alcun senso porre qualsiasi nozione del bene, del giusto o del buono al di fuori del contesto dell' esercizio del nostro potere». Malgrado questi precisi riferimenti ad un'organica linea di pensiero, Negri e Hardt concordano con l'esigenza di ripensare la questione fuori dagli schemi prestabiliti. Indicano alla riflessione la traccia lasciata da Foucault e dalla sua anarcheologia: «imbastire una critica della violenza che non ritenga alcuna violenza necessariamente accettabile o inaccettabile, ma che piuttosto indaghi le diverse forme e istanze di violenza nelle nostre vite al fine di distinguerle», ma si richiamano anche - come ora vedremo - alla lezione di Benjamin. Una violenza che non è un mezzo esterno Le domande che Benjamin, un altro buon pensatore del nostro tema, si pone sono davvero radicali. Non solo vuole valutare se la violenza4 «sia mezzo a fini giusti o ingiusti», ma anche capire «se sia morale la violenza in generale come principio, anche come mezzo a fini giusti», arrivando a chiedersi se «mezzi legittimi da una parte, e fini giusti dall' altra [non siano] fra loro in contrasto irriducibile». Per lui, in contrasto con la Arendt e la tradizione machiavelliana, il fine giusto di per sé non giustifica la violenza come mezzo. Perciò mette in discussione anche la concezione giusnaturalistica (base ideologica al terrorismo della Rivoluzione francese, come ricorda); e respinge la concezione della violenza come «prodotto naturale, per così dire una materia prima, il cui impiego non solleva problemi di sorta, purché non si abusi ... a fini ingiusti» (concezione che residua - mi pare - nella posizione di Hardt e Negri. .. ). Non discute solo gli abusi e non vuole legittimare neppure gli usi (chirurgici, intelligenti, ecc.) della violenza. Né esita a polemizzare con la biologia darwiniana, che tende pur essa a considerare «insieme alla selezione naturale, solo la violenza come mezzo originario e solo adeguato a tutti i fini vitali della natura». Benjamin parte dal legame intimo tra la violenza e la legge e in proposito afferma che la violenza può avere due funzioni: creare o conservare diritto, manifestandosi storicamente come violenza legittima (riconosciuta e sancita dal potere) e violenza illegittima (non sanzionata e contrastata). Non dimentichiamo che egli parla in un contesto storico dove la classe operaia gli appariva «accanto agli Stati, il solo soggetto giuridico a cui spetti un diritto di violenza», per cui non ha remore "buoniste" nel sottolineare il carattere di «creazione giuridica» che la violenza ha sia nel caso dello sciopero sia in quello della guerra e persino nella «minaccia [del grande delinquente] di porre nuovo diritto, di fronte alla quale (e sia pur impotente) il popolo rabbrividisce ancora oggi, in casi di rilievo, come nei tempi mitici». Pertanto considera tranquillamente sullo stesso piano sia la violenza dei vari apparati dello Stato (1'esercito, la polizia, la magistratura e così via) sia quelle forme di violenza che si oppongono allo Stato e perseguono scopi differenti. Tenendo presente quanto lo Stato costituito teme la violenza "concorrenziale" alla sua (la violenza creatrice di diritto) ed è pronto a cancellarla, Benjamin svela la faciloneria mistificatrice dei pacifisti e la fragilità dell'anarchismo più "infantile", che - saltando la questione - si accontenta di dichiarare «esser lecito quel che piace»: un principio - egli osserva - che elimina tutta la riflessione storico-morale sul significato dell'agire umano; e che non comprende come, contro il diritto positivo e anche quando esso vuole conservare un ordine criticabile, non basti una contestazione fatta solo in nome di una "libertà" informe. Bisogna invece che si sia in grado di definire un ordine superiore di libertà.5 E per farlo, andando anche nella direzione della «critica della violenza che pone come di quella che conserva il diritto», Benjamin - ancora differentemente dalla Arendt - scava nell'origine stessa del diritto moderno, che è per lui appunto nella violenza, nel potere supremo: quello di vita e di morte. Nella polizia dello Stato moderno, infatti, ogni divisione fra «violenza che pone e violenza che conserva la legge» è stata soppressa. La polizia non risponde dei titoli per cui esercita violenza né si pone nuovi fini; non deve cioè "dimostrare" il diritto ad esercitare la sua violenza, né controllare che essa sia adeguata ai fini o ai nuovi fini che si pongono nella società in trasformazione. Alla fine della sua analisi, il diritto appare «in una luce morale così equivoca, che si affaccia spontaneamente la domanda se per comporre interessi umani in contrasto non vi siano altri mezzi che violenti». E fa l'esempio del contratto giuridico, che, anche se concluso pacificamente, implica in ultima istanza una possibile violenza, poiché «il potere che garantisce il contratto è a sua volta di origine violenta» o, in altri termini, «ogni compromesso, anche se liberamente accettato, ha essenzialmente un carattere coattivo». Oggi un pensatore così schietto, che non occulta la «presenza latente della violenza in un istituto giuridico» e smentisce i rappresentanti del potere che dichiarano di ripudiare "ogni violenza" quando più ne usano, può sembrare un incontentabile che pretenda la luna. Ma quanto appare corroborante per chi non si accontenta di aggregarsi ai cortei delle "mani pulite"! Le sue riflessioni inoltre non separano la Politica dai rapporti quotidiani e interpersonali, ma si affiancano all'esperienza e permettono di penetrarne e interpretare il vissuto quotidiano, correggendo lo strabismo del filosofo, attento alla teoria ma spesso cattivo pensatore dell'esperienza. Benjamin nel riconoscere la funzione costruttiva della violenza non si abbandona neppure al suo fascino. Sostiene che è «possibile il regolamento non violento di conflitti» e ricorre non per caso all'analisi dei rapporti quotidiani fra gli individui6, nei quali entra in gioco la tecnica: ad esempio «la conversazione, considerata come una tecnica di civile intesa», «la vera e propria sfera dell' intendersi, la lingua». Allo stesso tempo, fondandosi sempre sull' analogia (relativa) dei rapporti fra persone private con i rapporti politici, Benjamin considera alcune forme di violenza sociale, lo sciopero ad esempio, «a certe condizioni, come un mezzo puro» e difende l'idea di sciopero generale alla Sorel, considerandola una «concezione profonda, morale e schiettamente rivoluzionaria», proprio perché è «di per sé atta a ridurre l'impiego effettivo di violenza nelle rivoluzioni». La riflessione di Benjamin, dunque, tiene in debita considerazione l'obiettivo che oggi pare escluso da ogni teoria e discorso pubblico: il «riscatto dalla schiavitù di tutte le passate condizioni storiche di vita». Per lui una prospettiva «rivoluzionaria» o anche la semplice «soluzione dei compiti umani» (noi diremmo dei conflitti umani ... ), «rimane irrealizzabile se si esclude assolutamente e in linea di principio ogni e qualsiasi violenza». Il celestiale sogno di abolizione della violenza o l'impolitica rinuncia assoluta ad essa equivalgono per lui ad una accettazione mascherata o male avvertita dell'esistente nella sue forme ultraviolente considerate fisse e insuperabili (si pensi alla manzoniana svalutazione della storia7, ottocentesca e cattolico- romantica e alla postmoderna e laico-disincantata "fine della storia" .. .). Tuttavia Benjamin si chiede ancora se esistano «altre forme di violenza», se esista «una violenza di altro genere» che non sia più mezzo, strumentale rispetto a determinati fini, ma «manifestazione». Ne ritrova un'ambigua traccia nel mito, dove infatti la violenza non si presenta come strumento, ma come «semplice manifestazione degli dèi ... del loro essere». Deve però riconoscere che questa violenza mitica «si rivela profondamente identica ad ogni potere giuridico» che è, come si è detto, basato sulla violenza "tradizionale". Quindi anch' essa, trasferita nella storia, sarebbe carica di perniciosi risvolti. Cerca allora una sua antitesi e - questo è il punto fermo della sua analisi - la ritrova nella violenza divina, che annienta il diritto e distrugge anche i confini e i limiti "aristocratici" in cui quella mitica è trattenuta.8 Attestata dalla tradizione religiosa, ne ritrova tracce nella vita odierna «come violenza educativa», che può anche essere distruttiva, «ma lo è solo relativamente, in rapporto ai beni, al diritto, alla vita e simili, e mai assolutamente in rapporto alla vita del vivente», poiché in essa non è contemplata l'uccisione. La "scintilla" del pensiero benjaminiano nella condizione postmoderna Proprio a questo Benjamin si riallacciano - come anticipato - Hardt e Negri quando - pensando sia ai movimenti rivoluzionari che hanno usato la violenza per prendere il potere statale sia a quelli che hanno cercato di distruggere il potere dello Stato rifiutando qualsiasi rapporto con la legge - si chiedono se esista «una violenza che non sia un mezzo esterno al proprio fine». In lui ritrovano appunto un pensiero che non s'accontenta né della violenza che pone il diritto né di quella che lo conserva (la violenza amministrata) e indicazioni di una pratica politica alternativa che non si ingabbi in modo esclusivo nel piano tipico della Politica: quello simbolico della rappresentazione. In questa possibile pratica il potere non è qualcosa di esterno da raggiungere; ma è "dentro" la pratica stessa, che è perciò definita «costituente». Spinozianamente: la sua azione selvaggia distrugge e costituisce l'essere. Essa è pura e irrapresentabile ... è «esodo9 della moltitudine10 dalle costrizioni dell'ordine statale». È «la marcia di una comunità non rappresentabile». Il nodo è quello. Lo si vede stando nel pensiero dialettico o fuori. Le formulazioni di Hardt e Negri possono apparire oggi "astratte" e politicamente azzardate, ma mostrano con vigore i primi elementi di un paesaggio, in cui sono diventati evidenti «sia la crisi del capitalismo che la fine della transizione socialista». Questo bilancio epocale è comune a molti altri pensatori e in parecchi assume toni liquidatori o apocalittici. Quelli di Negri e Hardt sono spunti per ripensare la violenza dentro il mondo contemporaneo, nella nuova cornice dello Stato postmoderno e dall'interno degli attuali processi di trasformazione del lavoro, cercando di afferrarne i germi di comunismo, di democrazia radicale fuori dalle vulgate "di sinistra", spappolate ben prima della caduta del muro di Berlino o dell'Urss. Lo stesso Türcke - a riprova della prossimità di modi di pensare critici, che pur hanno diverse o contrapposte ascendenze - in un altro saggio del suo libretto, Su questo tacciono tutti (utile anche per orientarsi nel dibattito di revisione storica del nazismo e dello stalinismo), consegna alla riflessione collettiva lo stesso nodo storico della violenza del '90011. Hardt e Negri mi paiono comunque preferibili, perché più esplicitamente considerano la fine del secolo secondo una nuova visione comunista. Non è certo più il comunismo a cui molte generazioni di militanti anche "di sinistra" si erano accostati: un comunismo ideale, una forma, un fine, un processo necessario o inevitabile. Essi delineano un comunismo che non sorge da una transizione gradualistica («non vi è nulla - dicono i due studiosi - a cui transitare, vi è solo la forza del potere costituente»), ma che fiorisce solo e sempre nei nuovi processi di lotta.12 È «un comunismo senza memoria, senza ideologia», percepibile nell'esodo di massa che ha portato alla caduta del muro di Berlino, quando il proletariato si è mostrato non come «volontà di partecipazione» (dialetticamente, dunque), ma come capacità di separazione: «La sottrazione, la fuga, il rifiuto hanno fatto cadere il muro di Berlino. È stato uno sciopero sociale che ha rovesciato l'organizzazione burocratica e ha scosso le torri del Cremlino. Il regime è imploso, quando il suo centro si è svuotato e l'indipendenza proletaria ha preso le forme dell'esodo» Da questo punto di vista, il passato "di sinistra", il socialismo reale viene letto come un processo storico che ha portato il mondo dell'Est nel cuore dell'Ovest, per cui «Est e Ovest s'incontrano nella crisi attuale sul nuovo terreno dell'esodo, terreno da esplorare, spazio di possibile libertà» che va considerato perciò «una fondamentale realtà politica del presente», contenente in sé un'enorme energia creativa. Moltitudine al posto della classe? Siamo dunque, con Negri e Hardt, fuori dal pensiero dialettico della tradizione della sinistra, che forse abbiamo sentito in passato più "nostra". E, di conseguenza anche la violenza, nella loro ipotesi del venir meno della dialettica, non si prospetta più come fenomeno di lotta tra due classi, l'una che sta esaurendo la sua funzione storica e l'altra che ne assimila ed eredita i valori universali. Il conflitto sussiste, ma a confrontarsi sono «due processi indipendenti [del potere costituito e di quello costituente]». L'implosione dello Stato postmoderno13 [che] minaccerà di morte e distruzione il mondo intero» potrà essere neutralizzata esclusivamente dalla autonoma costruzione (che «si sviluppa all' ombra della morte») della democrazia ad opera non più di una classe, ma della moltitudine. Ma cos'è, dov'è questa moltitudine? è possibile davvero una politica senza rappresentazione? si chiederà scettico chi è cresciuto nella forma-partito e nella convinzione di un soggetto storico "di classe". Il problema, considerato secondo gli schemi consueti e consolidati della "sinistra", appare assurdo. Negri e Hardt stessi ne riecheggiano le difficoltà, quando si chiedono: «Com'è possibile ... abbandonare la concezione di un potere costituente che necessariamente si nega nel porre la Costituzione, e riconoscere invece un potere costituente che non produce più Costituzioni che se ne separano, ma piuttosto si pone esso stesso come costituzione?». E precisano che pensare dal punto di vista della moltitudine non significa «immaginarci dalla parte dei marginali o dei senza potere», perché finiremmo ancora «nel regno della rappresentazione, proponendo soluzioni simboliche», ma significa invece cogliere quanto la moltitudine sia da sempre centrale nella dinamica della produzione sociale e dotata di un potere qualitativamente diverso da quello dello Stato. La moltitudine per loro non è altro che il nome della democrazia. Ma una democrazia di eguali, fondata sulle capacità produttive dei suoi soggetti, sull'eguaglianza dei diritti e dei doveri. Si tratta di un «potere costituente ... che esclude qualsiasi trasferimento» (di sé) o ad un «fondamento trascendente» o ad una forma di «diritto naturale» o ad un qualsiasi «fine esterno a quello coscientemente definito dalla moltitudine nell'esperienza quotidiana». In chiusura provvisoriamente ... Alla fine di questa rassegna provo a fissare qualche conclusione, riprendendo le domande da cui sono partito, le quali in sostanza contenevano dubbi sia nei confronti del soggetto interrogante (intellettuali di massa) sia sulle culture di riferimento storiciste o religiose-pacifiste e sia sull' oggetto stesso della riflessione: la violenza, oscurato e deformato dai mutamenti più o meno epocali in atto. Sull'esigenza che l'intellettualità di massa ripensi - per via di faticosi tentativi e con gli strumenti "poveri" di cui dispone - il fenomeno della violenza, sottraendosi al silenzio impacciato, agli autoinganni impliciti nel vivere in una condizione di vita relativamente protetta, alle tentazioni nichiliste che hanno accompagnato il venir meno delle cosiddette Grandi Narrazioni o all'irrigidimento nostalgico, fideistico e difensivo verso questo o quel Simbolo forte, non ci piove. lo ho preferito cercare le basi per un "oltre" sul problema, poggiandomi su pochi, discutibilissimi e tra loro disomogenei pensatori; e selezionando e valorizzando le spinte "in fuoriuscita" dai limiti scolastici della Sinistra. Tutti i riferimenti scelti, comunque, hanno in comune, un'attenzione alla violenza che non s'illude di trovar rimedi o superamenti in un Assoluto o nella sua «negazione» magari eroica, autopunitiva, impolitica e astorica, ma si attesta sul principio del "Colpisci meno che puoi e sopporta meno che puoi", che cioè non rinunci a una energia reale (intravista, ma mal espressa purtroppo dal vitalismo biologistico), che è del singolo e della collettività, quando mirino ad umanizzarsi, a democratizzarsi a non lasciarsi spossessare dalle forme più positive di quella che chiamerei costruzione umana della violenza. (Gli esempi nella storia e nella vita quotidiana, strappando il velo del revisionismo storico che appiattisce oggi comunismo e fascismo, monarchie o democrazie, ci sono). Questo atteggiamento rifiuta, dunque, le culture della violenza ammesse e tollerate dai dominatori, che si accompagnano in genere proprio all'invito martellante di rinunciare a «quel tanto di natura violenta» che si ritrova comunque nei dominati e che, andrebbe difeso gelosamente e compreso nella sua potenzialità. E critica, in modo per me condivisibile, il pacifismo: quello più inerte e consolatorio, ma anche quello intimistico-privato-religiosizzante con la sua drammatizzazione tutta morale del «far torto o patirlo», o quello impolitico da zona grigia (e che vuol restare perennemente grigia). Infine, che la violenza oggi debba essere conosciuta come fenomeno non separabile dai processi della condizione postmoderna e della sua statualità, della globalizzaione economica e della quotidianità è un'aspirazione di ricerca che richiederà tempo ed energie. Cercansi dunque altri buoni pensatori che ci aiutino a promuoverla ... Note 1 Potere= agire di concerto; potenza= proprietà inerente al singolo; autorità= capacità di ottenere un riconoscimento non discutibile; violenza= strumento. 2 Cfr. AA.VV., Oltre la politica, Bruno Mondadori, Milano, 1996. 3. Anzi sostiene che «la violenza non è né bestiale né irrazionale». Sì, la violenza deriva spesso dalla rabbia e la rabbia può essere in effetti irrazionale e patologica, ma al pari di tante altre manifestazioni umane. Ma non c'è niente di disumano quando «gli uomini prendono la legge nelle proprie mani in nome della giustizia» e non è certo l'assenza delle emozioni a causare o promuovere la razionalità: «per poter reagire in modo ragionevole si deve prima di tutto essere commossi e l'opposto di emozionale non è il razionale .. ma l'incapacità a lasciarsi commuovere, in genere un fenomeno patologico, o il sentimentalismo, che è una perversione del sentimento». Né reagire violentemente contro l'ipocrisia o ad un uso menzognero della parola è indice di irrazionalità. 4 Il termine tedesco per "violenza" (Gewalt) significa anche "autorità" e "potere". 5 Ci sono in proposito precise sintonie con molti scritti di Fortini. 6 «I rapporti fra persone private ... offrono esempi a iosa. L'accordo non violento ha luogo ovunque la cultura dei sentimenti ha messo a disposizione degli uomini mezzi puri d'intesa. Ai mezzi legali e illegali di ogni genere, che sono pur sempre tutti insieme violenza, è lecito quindi opporre, come puri, i mezzi non violenti», [precisando che] «gentilezza d'animo, simpatia, amor di pace, fiducia e tutto quanto si potrebbe aggiungere ancora, sono la loro premessa soggettiva» [e che, però oggettivamente bisogna sapere che i] «mezzi puri non sono mai mezzi di soluzioni immediate, ma sempre di soluzioni mediate» 7 «loco a gentile/ad innocente opra non v'è: non resta/ che far torto, o patirlo. Una feroce/ forza il mondo possiede, e fa nomarsi/ dritto ... » (A. MANZONI, Adelchi, Scena ottava, vv. 40-43) 8 «la violenza mitica è violenza sanguinosa sulla nuda vita in nome della violenza; la pura violenza divina [si esercita] sopra ogni vita in nome del vivente. La prima esige sacrifici, la seconda li accetta». 9 Dell' esodo Paolo Virno ha dato questa definizione: «Chiamiamo Esodo la defezione di massa dallo Stato, l'alleanza tra general intellect e Azione politica, il transito verso la sfera pubblica dell'Intelletto. Il termine non indica affatto, quindi, una mesta strategia esistenziale, né l'uscita in punta di piedi da una porta secondaria, Né la ricerca di un interstizio che offra riparo. Al contrario, con "esodo" si intende un modello di azione a tutto tondo, capace di misurarsi con le "cose ultime" della politica moderna, insomma con i grandi temi articolati via via da Hobbes, Rousseau, Lenin, Schmitt ... Oggi, non diversamente da quanto avvenne nel Seicento sotto il pungolo delle guerre civili, va perimetrato daccapo un ambito degli affari comuni. Tale perimetrazione deve esibire l'occasione di libertà insita in quell'inedito intreccio tra Lavoro, Azione e Intelletto, che finora, invece, abbiamo soltanto patito» (P. VIRNO, Virtuosismo e rivoluzione, in «Luogo Comune», 1 , 1993, p.15) lO Sempre Virno ha così cercato di precisare il concetto di moltitudine: «Il contrasto politico decisivo è quello che oppone la Moltitudine al Popolo. Il concetto di "popolo", a detta di Hobbes (ma anche di larga parte della tradizione democratico-socialista) è strettamente correlato all' esistenza dello Stato, anzi, ne è un riverbero". Il popolo è un che di uno, che ha una volontà unica. Il popolo regna in ogni Stato" ... La Moltitudine, invece, rifugge dall'unità politica, recalcitra all'obbedienza, non consegue mai lo status di persona giuridica ... Essa è antistatale, ma, proprio per questo, anche antipopolare: "I cittadini, allorché si ribellano allo Stato, sono una moltitudine contro il popolo". Per gli apologeti seicenteschi del potere sovrano, "moltitudine" è un concetto-limite puramente negativo: rigurgito dello stato di natura nella società civile, detrito persistente e però informe, metafora della crisi possibile. Il pensiero liberale, poi, ha addomesticato l'inquietudine provocata dai "molti" mediante la dicotomia pubblico/privato: privata - nel senso letterale del termine: priva di volto e di voce, nonché in quello giurdico: estranea alla sfera degli affari comuni - è la Moltitudine. A sua volta, la teoria democratico-socialista ha brandito la coppia collettivo/individuale: mentre la collettività dei "produttori" (ultima incarnazione del Popolo) si immedesima con lo Stato ... la Moltitudine è confinata nel recinto dell' esperienza "individuale", ovvero è condannata all'impotenza. Questo destino di marginalità ha oggi fine. La Moltitudine, anziché costituire un antefatto "naturale", si presenta come un risultato storico, maturo punto di arrivo delle trasformazioni intervenute nel processo produttivo e nelle forme di vita. I Molti irrompono sulla scena, e vi restano da protagonisti assoluti, allorché si consuma la crisi della società del Lavoro.» (P. VIRNO, Virtuosismo e rivoluzione, in «Luogo Comune», 1, 1993, pp. 17-18). 11 «Alla formula di Horkheimer secondo cui 'il fascismo è la verità della società moderna' si potrebbe perciò aggiungere: 'e lo stalinismo è a sua volta questa verità, in modo specularmente inverso'. Esso è in certo senso più tragico del fascismo, perché prodotto da una rivoluzione che voleva spezzare quelle forze che infine ha invece aiutato solo a trovare uno sfogo alternativo. Ma entrambi, fascismo e stalinismo, portano il marchio indelebile dei modelli storici dei quali gli odierni misfatti mondiali sono le copie. Le copie non sono mai identiche ai loro modelli, e in questi limiti fascismo e stalinismo sono irripetibili: e però sono costantemente presenti. Il primo è sospeso come una spada di Damocle archetipica su ogni espansione e crisi capitalistica, il secondo su ogni rivoluzione proletaria. E questa è una rilevante diversità strutturale, nonostante tutta la somiglianza dei fenomeni. Il primo è il pericolo con cui ci minaccia l'organizzazione irrazionale della società: la minaccia dell'altro consiste nel tentare di organizzarla razionalmente. Ma di entrambi si può dire che sono un passato che non tramonta, poiché la storia, da allora, non fa più passi avanti, e i fondamenti sociali di allora non sono sostanzialmente mutati». 12 Può sembrare scandaloso per certa ex Nuova Sinistra accostare il nome di Fortini a quello di Negri, ma questa formula negriana mi pare proprio prossima alla definizione di Fortini: «Il combattimento per il comunismo è già il comunismo» (Fortini, Extrema ratio, pago 99]. Fortini la diede nel 1989 (anno fatidico per eltsiniani d'ogni risma!) e a pag. 41-43 di "Non solo oggi" (Editori Riuniti, Roma 1991), libro recuperabile forse solo fra i remainders, si può leggere anche: «Il comunismo in cammino (un altro non ne esiste) è dunque un percorso che passa anche attraverso errori e violenze tanto più avvertite come intollerabili quanto più chiara sia la consapevolezza di che cosa siano gli altri, di che cosa noi si sia e di quanta parte di noi costituisca anche gli altri. Comporterà che gli uomini siano usati come mezzi per un fine che nulla garantisce; invece che, come oggi avviene, per un fine che non è mai la loro vita. Ma che sia dalla lotta costretto ad usarli come mezzi mai potrà concedersi buona coscienza o scarico di responsabilità sulla necessità e la storia». 13 Per Negri lo Stato postmoderno rimuove qualsiasi dialettica sociale che possa far sorgere una società civile reale; pretende di presentarsi come democrazia perfetta, democrazia realizzata (la storia è finita); rimuove ogni dialettica fra costituzione materiale e costituzione formale; rende completo il divorzio del politico dal sociale (autonomia del politico dal sociale); considera obsoleta la rappresentanza politica (partiti, sindacati, gruppi d'interesse); sminuisce ogni "spazio sociale" e rafforza la tendenza al "mercato politico", che simulerà la rappresentanza (si ha cioè «il passaggio dalla rappresentanza democratica di massa alla produzione dei propri elettori da parte dei rappresentanti», attraverso la manipolazione mediatica della società); fa diventare fondamentale la passività del consenso. TESTI DI RIFERIMENTO - W. BENJAMIN, Per la critica della violenza, in "Angelus Novus", Einaudi, Torino, 1962 - C.TŰRCKE, Violenza e tabù, Garzanti, Milano, 1987 " M. HARDT, A. NEGRI, Il lavoro di Dioniso. Per la critica dello Stato postmoderno, Manifestolibri, Roma, 1995 - H. ARENDT, Sulla violenza, Guanda, Parma, 1996
Scarica