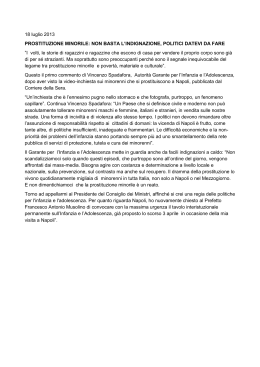CORSO DI SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA (GRUPPO ABELE) Il corso presenta interventi di: Luigi Ciotti (presidente del Gruppo Abele e di Libera, associazioni, nomi e numeri contro la mafia – segr.ciotti@ gruppoabele.org) Franco Floris (direttore di Animazione Sociale – animazionesociale@ gruppoabele.org ) Michele Gagliardo ( bububu.teen.con-percorsi con i giovani del Gruppo Abele – bububu.teen.con@ gruppoabele.org) Leopoldo Grosso (vicepresidente del Gruppo Abele- leopoldo.grosso@ gruppoabele.org) Pino Maranzano (responsabile dell’Aliseo realtà impegnata nel contrastare la diffusione dell’alcolismo – [email protected]) Paola Molinatto (collabora ad Animazione Sociale – animazionesociale@ gruppoabele.org ) Duccio Scatolero ( professore di Criminologia alla Facoltà di Psicologia di Torino e collaboratore di Spazi d’Intesa, realtà del Gruppo Abele che si occupa di gestione dei conflitti - ) Guido Tallone (Gruppo Abele , guidotallone@ gruppoabele.org) MODULO 3 FENOMENOLOGIA DELLA DEVIANZA: PERCORSI DI INCLUSIONE ED ESCLUSIONE INTRODUZIONE di Luigi Ciotti LEZIONE 1 Il processo di esclusione: la sofferenza grande domanda di Leopoldo Grosso Vivere e sopravvivere nell’Incittà: un “Drop in” frequentato da immigrati a Torino di Paola Molinatto LEZIONE 2 Minori stranieri in carcere: la scommessa di un patto per la legalità di Leopoldo Grosso Il rimpatrio dei minori stranieri di Leopoldo Grosso Allegato 1: Le scorciatoie della repressione di Paolo Vercellone Allegato 2: Ragazzi di (mala)vita di Franco Occhiogrosso Allegato 3: Dalla Scuola in carcere al carcere -scuola. Esperimenti al «San Michele» di Alessandria di Pietro Buffa LEZIONE 3 Etica e prostituzione: l’incontro possibile di Luigi Ciotti La relazione d'aiuto nel contesto "prostituzione" di Leopoldo Grosso 1 LEZIONE 4 La tossicodipendenza di Leopoldo Grosso La prevenzione attiva alle tossicodipendenze di Leopoldo Grosso L’insinuarsi dell’alcoldipendenza di Leopoldo Grosso Consumo, abuso e politossicodipendenza di Leopoldo Grosso La sottovalutazione del consumo di cocaina di Leopoldo Grosso LEZIONE 5 Le comunità per minori di Luigi Ciotti Allegato 1: LE COMUNITÀ PER MINORI: GOVERNARE IL PLURALE A cura di Luciano Tosco LEZIONE 6 Crescere in ambiente mafioso di Luigi Ciotti Allegato 1: Vittime assolute di R. Scifo I figli dei collaboratori di Luigi Ciotti Quel prete prendeva i ragazzi dalla strada di Luigi Ciotti Allegato 2: dai verbali della requisitoria finale del processo per l’assassinio di Pino Puglisi 14 aprile 1998 Allegato 3: Educazione a delinquere di Franco Occhiogrosso INTRODUZIONE di Luigi Ciotti Vorrei partire da una considerazione che mi sembra chiara e davanti agli occhi di tutti; stiamo vivendo in un momento di grande stagnazione e di ambiguità rispetto al problema della droga nel nostro paese. Credo che tutti abbiamo toccato con mano come, in questo momento, siano ridotti ed insufficienti la responsabilità e l'impegno da parte delle istituzioni riguardo le politiche sulle tossicodipendenze. Ma devo dire di più: c'è stagnazione, ambiguità, ritardo rispetto, più complessivamente, alle politiche rivolte al mondo della marginalità, del disagio, dell'esclusione sociale. L'Italia continua a restare l'unico paese in Europa che non ha un Dipartimento che si occupi di giovani con le adeguate attenzioni, con i necessari investimenti di risorse e strumenti. Di loro ci si "preoccupa" ma non ce ne si occupa veramente. L'Italia, al pari di quasi tutti i paesi industrializzati, è un paese dove l'esclusione sociale è in progressiva espansione, dove si approfondiscono povertà vecchie e nuove, nelle quali è sempre più facile entrare ma è sempre più difficile fuoriuscirne. Ormai, come testimoniano i dati e le ricerche della Commissione povertà e di altri autorevoli organismi, sono sempre più numerose le famiglie monoreddito che valicano la cosiddetta "linea di povertà"; cioè avere un lavoro non è più, di per sé, garanzia sufficiente per non essere, ufficialmente e a tutti gli effetti, poveri. Ma anche analizzando la povertà più "tradizionale" e più estrema, possiamo renderci conto di quanto si siano moltiplicati i volti del bisogno e di come questi si intreccino anche con la questione delle dipendenze e del disagio giovanile. Guardiamo il "popolo della strada". Chi di noi operava sulla strada anni fa, ricorda che negli anni '70 i cosiddetti "barboni" avevano un'età media di 65-70 anni; oggi l'età 2 media si è abbassata (il 30% dei senza fissa dimora ha tra i 18 e i 24 anni; un altro 30% è tra i 25 e i 34 anni). Ma, oltre al fatto anagrafico, sono mutate altre caratteristiche significative: è cresciuto il numero delle donne (sono circa il 25%); il 16,3% ha un titolo di studio superiore (il 13,9% ha un diploma, il 2,4% ha una laurea: rispettivamente il 39,1% e il 63,6% di questi ultimi sono stranieri); il 9,1 è sieropositivo e in Aids; il 29,1% è composto da alcolisti dichiarati; almeno il 15% è formato da persone tossicodipendenti; circa il 10% è rappresentato da ex ricoverati in ospedale psichiatrico. Solo il 15,9% vive sulla strada per propria scelta. Il 21,7% è stato cacciato dalla famiglia perché tossicodipendente o sieropositivo. Il 9,6% è stato abbandonato dalla famiglia in età evolutiva, il 6,3% è figlio di genitori a loro volta senza fissa dimora. Per il 43,5% la strada è stata una conseguenza della disoccupazione.Da questa sintetica "fotografia" ci accorgiamo che le dipendenze talvolta nascono dentro una realtà di povertà e, in altri casi, la producono a loro volta. Questo vale anche a dire che non si può ragionare di droghe senza misurarsi anche con i più generali contesti di bisogno e di esclusione. Le politiche relative alle tossicodipendenze vanno sempre saldate ad una serie di altri interventi. Per ragionare di politiche concrete, di risposte realistiche, innanzitutto bisogna togliere questo problema dall'astrattezza e anche dall'emotività e dalla strumentalizzazione. La questione droga entra ogni giorno nelle case di tutti con immagini di cronaca, con un certo tipo di disinformazione, di produzione di stereotipi e pregiudizi, che non corrispondono però alla realtà delle persone e del fenomeno. Immagini e stereotipi che poi diventano un cavallo da cavalcare o uno spauracchio da agitare e su cui speculare, com'è stato ai tempi della 162 per coagulare consenso sociale intorno alla filosofia punitiva che ne è stata alla base. Ebbene, io credo che il vero problema sia quello della verità; quella verità attenta, puntuale, scientifica che non ha sufficienti canali di diffusione. Io credo che bisogna creare un tavolo di riflessione, analisi e proposta, non solo degli addetti ai lavori, ma che sappia coinvolgere molte voci "dal di dentro", i nuovi volti del mondo giovanile, affinché possano portare dei contributi. Altra considerazione di fondo della quale sono estremamente convinto è il rapporto con la strada. La strada è per molti di noi il luogo di riferimento, dove siamo nati, dove abbiamo operato, dove sono cresciuti i nostri gruppi. La strada è stata il nostro punto di riferimento, simbolico ma anche operativo, e lo dovrebbe essere ancora di più, anche per le istituzioni e per i servizi pubblici. La strada chiede di leggere i cambiamenti e le trasformazioni; la strada chiede di mettere al centro la persona e i suoi bisogni fondamentali, dunque di mettere l'accento sulla riduzione delle sofferenze e sull'attenzione alle persone. L'abbandono, la deriva, l'esclusione, la segregazione, varie forme di marginalità, creano un danno che progredisce in due direzioni: la prima va verso la persona emarginata, che vede sempre più ristretti i propri spazi di sopravvivenza, percepisce gli altri sempre più in un contesto difficile come nemici e non solo, ma, lasciandosi travolgere dalle situazioni, dà sempre meno valore alla propria vita 3 ed è sempre più disposta a giocarsela per ben poco, esponendosi di più e con rischi di conseguenze devastanti. La seconda direzione va verso la società in cui il soggetto, la persona che fa fatica, si muove: il danno recato a se stessi e agli altri è un danno alto, soprattutto se misurato in relazione al poco utile ricavato dell'atto, soprattutto se misurato all'atto microdelinquenziale. E’ l'esasperazione di chi si aggrappa all'economia illegale della sopravvivenza, la storia dei nostri amici insomma, che per farsi, per sbattersi si aggrappano a questa economia illegale della sopravvivenza, capovolgendo le regole della razionalità di chi intende far profitti: non gran profitto con rischi minimi, come sarebbe la regola della razionalità, ma grandi rischi con minimi profitti, perché chi si sbatte sulla strada e chi vive sulla strada per sopravvivere si accolla rischi alti. Allo stesso modo il danno di chi ha avuto, per esempio, l'auto danneggiata per un furto di un oggetto all'interno dell'auto, ma è solo un esempio, è generalmente superiore al valore dell'oggetto di per sé, non solo a quanto viene venduto sul mercato della ricettazione. Ecco che allora il danno recato a sé e agli altri è un danno alto, se misurato in relazione al poco utile. C'è un terzo passaggio: il danno per sé e per gli altri non è solo economico-legale. La sicurezza riguarda anche la salute, per cui il danno è anche sanitario. Condizioni di vita decenti e la possibilità di cura per le persone tossicodipendenti, per gli amici che vengono da lontano, immigrati, irregolari, per chi è emarginato a vario titolo o non accede ai servizi, consentono al singolo di non ammalarsi e di non peggiorare. Ma costituiscono anche un investimento preventivo per la salute complessiva della popolazione e della gente, perché si diminuiscono le possibilità di contagio, d'infezione, si contiene la diffusione di malattie diverse. E' allora importante “prendersi cura”: curare le persone ai margini significa condurre più complessivamente una vantaggiosa politica di sanità pubblica. Un quarto passaggio. Sul piano dei costi sociali, dei costi dell'apparato giudiziario e della magistratura e di tutto quello che comporta, della sanità, l'investimento di risorse in servizi che contrastino l'emarginazione e tutelino la salute, rappresenta un risparmio economico da non sottovalutare. Bisogna avere il coraggio di fare queste scelte e conviene investire in questa direzione. Non è solo il considerare il costo di un carcere o di un ospedale rispetto ad una struttura di accoglienza, che è mediamente cinque, sei, sette volte inferiore. Certo, i conti li abbiamo fatti carta e penna alla mano con chi di questo se ne occupa e ne ha la responsabilità a livello nazionale. Oggi un ragazzino minore in carcere, ad esempio, costa quattro milioni al giorno; per gli adulti i parametri sono diversi, ma bisogna considerare anche il danno recato alle vittime dei reati, a chi subisce tutto questo, il carico degli operatori della giustizia, di tutti i diversi apparati. Conviene non essere miopi e credere e investire gradualmente in una direzione diversa, valorizzando le risorse, le capacità non utilizzate o mal utilizzate delle persone che sono in difficoltà, di un mondo marginale che cerca di sopravvivere in 4 lotta con gli altri e che, invece, può diventare protagonista di un processo attivo, e dove questo è stato fatto si sono ottenuti risultati concreti, che non sono fantasia, ma pratica, quotidianità. Ancora un quinto passaggio: sono necessarie politiche d'integrazione, cominciando dal sopperire ad alcuni bisogni materiali di base: un posto per dormire, per mangiare, dove lavare i propri vestiti, fino alla possibilità di un lavoro compatibile con la propria salute, ecc. Queste politiche sono il pilastro portante di una attività sociale che ha ricadute fondamentali sia sul piano del problema dell'opinione pubblica che su quello della sanità. E’ facile dirlo qui, ma provate a ripeterlo in alcune zone d'Italia, in alcune città. Parlare di riduzione del danno per qualcuno sembra parlare di morte, di resa, di cronicizzazione delle persone. Pensare ad altri progetti, altri percorsi, non esclude il resto. Ma quello che ci lega qui è la preoccupazione d'inventarci di tutto per fare in modo che nessuno resti un passo più indietro degli altri, per stanare, agganciare, accompagnare storie che hanno rotto i rapporti con i servizi o non li hanno mai avuti. Le comunità devono uscire dalla convinzione di essere il toccasana. Sono una realtà importante da sostenere, da incoraggiare. Ma è necessario anche aprire percorsi nuovi: la riduzione del danno l'abbiamo ribattezzata “la cura della vita”, perché vuol dire impegno per la vita. Certo, nessuno qui vuole semplificare, ma c'è da chiedersi che cosa si doveva, si poteva fare, perché le unità di strada, che lavorano seriamente, dove sono diventate operative hanno salvato vite e hanno aperto vie nuove per dare dignità, percorsi, futuro alle persone. Non è facile per nessuno e nessuno ha le ricette in tasca. Però, nessuno, in nome di partiti, di fazioni, di ideologie, di “guerre di religione”, può impedire una ricerca che ha come obiettivo dare speranza e vita alle persone. Invece, voi vedete che proprio tutte queste normative, decreti, leggi, vengono giocate si questi punti. C'è tanta gente che ha rinunciato rispetto a questo, che ha fatto una scelta di politica tiepida, mentre non si possono fare compromessi in questo ambito, perché c'è in gioco la vita delle persone. Gli interventi di strada consentono di contattare o di ricontattare le persone, significa rimetterle nel circuito dei servizi, rioffrire un'opportunità di relazione e di riferimenti, che non sono solo quelli materiali cui ho accennato prima, anche se c'è bisogno pure di quello. Questo che comincia sulla strada è il primo indicatore dell'integrazione; soprattutto, è un rimettere in gioco le risorse, le capacità di una persona, per quanto per molti siano ridotte, limitate. Il rafforzamento dell'autostima delle persone è possibile, come la valorizzazione delle conoscenze che ci sono dentro ciascuno di noi. E chi di noi ha avuto l'esperienza della strada diretta o indiretta sa che la strada aggiunge dei modi nuovi di “sapere”, che anche nella sua fatica è una risorsa, che tocca a noi fare in modo che diventi una risorsa, valorizzando le conoscenze non sfruttate. C'è un sesto passaggio che mi sta a cuore. Bisogna capire e fare capire che l'esclusione genera violenza. Mi ricordo che all'inizio del Gruppo Abele per tre anni 5 scelsi di dormire sui treni di Porta Nuova a Torino con chi aveva solo quella come casa: m'ha cambiato la vita. E me l'hanno cambiata il dormire d'inverno o d'estate sui treni, le retate, le etichette, i giudizi, le situazioni. Pur non giustificando questo modo di vivere, sia ben chiaro, mai: per me la legalità resta sempre un punto fermo. Ma bisogna anche far capire che è l'esclusione che genera violenza, perché io tante volte mi sono trovato a tirare la cinghia, a fare la fame, ad avere freddo. Non giustifico la violenza, ma a volte non se ne poteva più: c'era rabbia dentro rispetto a chi stava dall'altra parte, che semplificava e giudicava. La violenza a sua volta genera ulteriore esclusione, ci si ritira sempre di più, ci si esclude sempre di più. E' una spirale perversa in cui i timori, le paure, di una maggioranza d'inclusi che si sentono minacciati fanno scaturire reazioni che alla fine negano agli esclusi i diritti di cittadinanza. Io l’ho visto a Torino a San Salvario o a Porta Palazzo, ma tutti li abbiamo visti in altre zone. Qui c'è un problema di rispetto: il diritto alla sicurezza è un diritto sacrosanto che tutti hanno e, quindi, c’è bisogno di attenzione nei confronti dei cittadini, delle loro ansie e paure, quindi anche di una corretta informazione, un accompagnare le persone, formare i formatori perché li aiutino, per far superare le scorciatoie, i timori delle persone. Il diritto alla sicurezza è un diritto sacrosanto che impone un rispetto per tutti i cittadini. Però, poi nessuno deve utilizzare questo solo a sua misura; ed è un diritto che hanno ancora maggiormente in questo senso le persone più fragili, le persone più deboli, le persone che sono in maggiori difficoltà. L'investimento sulla sicurezza dei cittadini passa attraverso la garanzia di diritti di cittadinanza di tutti e nel creare opportunità, spazi, riferimento, ecc. Un altro piccolo punto: gli interventi di riduzione del danno hanno bisogno, secondo noi, di quattro direttive. La prima: il lavoro di strada, di cui ho già detto. L'istituzione che incontra ancor oggi più tossicodipendenti è il carcere: non sono i servizi, non sono le nostre comunità. Ecco che la prima direttiva di applicazione diventa il lavoro di strada, l'agganciare, l'accompagnare le persone. La seconda: una politica farmacologica che, insieme con l'offerta di opportunità sociali, come casa e lavoro, elimini il rapporto con la piazza e l'illegalità, consentendo strategie progressive d'integrazione. Ci vuole coraggio, ma anche che noi non siamo tiepidi nel trovare un modo per realizzare tutto questo. Terzo: ripari d'accoglienza e terapeutici che, a partire da una tensione e da un indispensabile approccio, in questo senso assistenziali, possano consentire di sviluppare relazioni, di fare uscire dall'isolamento la persona, d'innescare spinte riabilitative e di emancipazione dalle dipendenze. Quarto: la protezione della salute dall'overdose e dalla propagazione delle malattie infettive. 6 Tutto questo significa che le politiche di riduzione del danno, nel momento in cui riescono allo scopo dell’integrazione, hanno il duplice vantaggio di essere di aiuto alla persona in difficoltà, ma anche di proteggere la comunità sociale dai rischi e dai danni, e quindi svolgono un controllo sociale leggero e propositivo in questo senso; inoltre, credo che ci sia bisogno di formazione, di informazione attenta per far crescere il grado di conoscenza e di consapevolezza della gente, e di un grande investimento educativo del progetto complessivo che aiuti anche a scendere in profondità rispetto a tutto questo. In questo modo si intreccia la riduzione del danno con la prevenzione del danno, cioè si investono di responsabilità e di proposte le istituzioni locali, le agenzie educative, le reti di sostegno sul territorio, il sistema penale e carcerario, i centri sociali e terapeutici. L'esperienza "sul campo" del Gruppo Abele ci ha insegnato che i processi di emarginazione delle persone producono una loro minore responsabilizzazione. Più sei emarginato meno hai gli strumenti, le opportunità, la capacità di progettarti, di gestirti autonomamente. Occorre dunque rovesciare l'approccio punitivo del "fare toccare il fondo", del "creare terra bruciata", che tanti guasti, ingiustizie e sofferenze aggiuntive ha prodotto per tanti giovani, e valorizzare invece i percorsi di riassunzione di responsabilità all'interno di un recupero di dignità e di qualità della vita. Ancor prima di una scelta di astinenza. Perché la dignità e il rispetto delle persone, la tutela della loro salute, non può essere sottoposta a condizione, pur se l'obiettivo auspicabile è naturalmente quello di liberarsi da ogni tipo di dipendenza. È per questo che noi crediamo moltissimo al problema della riduzione del danno, anche a costo di critiche e incomprensioni. Contro quei facili moralismi e semplificazioni che, al di là delle grandi affermazioni di principio, non operano per dare dignità e qualità della vita alla gente. Le grandi e belle dichiarazioni di principio non servono, se poi si lascia tutto sulle spalle di chi è più fragile, di chi fa più fatica, di chi viene privato di diritti e, assieme, di parola, di responsabilità. Così intesa, la riduzione del danno può ridare autonomia alla persona e maggiore responsabilità alle istituzioni per quello che a loro compete. Si devono mettere insieme motivazioni, competenze, esperienze, servizi, sia nelle politiche carcerarie e penali, sia nella lotta contro l'esclusione sociale, oltre che nello specifico delle dipendenze. Si tratta, dunque, di mettere complessivamente in campo strumenti ed interventi sul piano culturale, educativo, economico, sociale, per ridurre l'area dell'esclusione e quella del disagio, per contrastare tutti quei processi di impoverimento materiale e spirituale che colpiscono fasce sempre più larghe di persone. Ci tengo a sottolineare questo aspetto perché le semplificazioni che sento fare in Italia sulla riduzione del danno non tengono conto di tutto ciò, delle evidenti implicazioni, delle necessarie sinergie. Riduzione del danno (e lo dobbiamo gridare con forza all'esterno) costituisce anche un contributo educativo. Ridurre i rischi non significa rinunciare ad educare, a informare, a camminare insieme. Certamente la nostra scelta è di accompagnare, non di portare, in un rapporto deresponsabilizzante di tutela, come qualcuno fa. Ridurre i danni non significa 7 rinunciare ad agire sul piano della prevenzione e della dissuasione. È uno strumento in più, non uno in meno. È una risorsa ulteriore per attivare momenti di crescita e di riflessione pedagogica. Punire è sempre più facile che non educare. Proibire è assai semplice, più oneroso è convincere, cioè vincere con, vincere assieme. La riduzione del danno va vista come integrata e integrabile con l'obiettivo di liberazione dalle sostanze: accompagnare, non portare; questa è una risposta carica di valenza etica. Riduzione del danno, per me si traduce in cura della vita, perché siamo chiamati ad aiutare tanta gente che vive nella strada a sopravvivere, perché un filo non si spezzi. Così possiamo educare ed educarci a vivere. Ancora una parola su un altro nodo: le comunità. Anche qui lo dico in senso propositivo e con profondo rispetto, ma anche con umiltà. Do sempre ai miei amici quattro chiavi da aggiungere a quelle di casa che la strada ci ha insegnato. La prima: siamo tutti chiamati ad incontrare le persone e ad affrontare i problemi e non viceversa. La seconda: siamo chiamati ad accompagnare, non a portare. La terza: non bastano le sole risposte tecniche se pure importanti, c’è bisogno di un faccia a faccia, di una relazione. La quarta: partire sempre dalle persone; non tanto dai loro problemi, di cui uno deve tenere conto, ma soprattutto dai loro bisogni. 8 LEZIONE 1 Il processo di esclusione: la sofferenza grande domanda di Leopoldo Grosso Inizierei da due premesse. La prima, la deriva marginale non è quasi mai un evento improvviso. Non è un fatto veloce, né un avvenimento a dimensione semplice. E’ invece un processo complesso, relativamente lungo, abbastanza lento. E il paradosso è che ci sarebbe tempo per prevenirlo. E’ il risultato, sempre, di un incrocio, di un’interazione in negativo tra processi sociali da una parte e vissuti relazionali dall’altra parte; tra situazioni oggettive ed impotenze soggettive. Quindi, oggettivazione e soggettivazione dell’emarginazione sono binari intrecciati. La difficoltà, infatti, nell’affrontarla e nel risolverla, è perché si ha a che fare con questo impasto: per cui non è sufficiente mutare la situazione oggettiva, come non basta fare un buon lavoro col soggetto. L’aiuto materiale, l’offerta di relazioni, la capacità di ridefinizione di sé e di usare l’aiuto proposto, sono i tre aspetti essenziali del percorso reintegrativo, riparativo, riabilitativo: se ne manca uno , o se i pesi specifici di ognuno di questi tre aspetti non sono ben dosati, il rischio di fallimento cresce. La seconda premessa riguarda la questione del dolore che ha molto a che fare con l’emarginazione. Diciamo che è un punto di diramazione. Fare i conti o meno può essere un punto di svolta. Già Freud indicava tre fronti di sofferenza per l’uomo: i fattori ambientali sfavorevoli (fame, freddo, carestia), il proprio corpo (che si ammala o con il quale non si va d’accordo), i rapporti con gli altri. La terza fonte, dice, è forse quella che genera il dolore più forte, più intenso. Il dolore però, in genere, offre una chance: interroga. Una caratteristica del dolore è quella di costringere la persona ad insistere sul perché. E’ domanda di senso. Il dolore apre l’interrogazione sul senso perché stravolge l’ordinario. La sofferenza può diventare il luogo di una grande domanda. Una domanda capace di escludere orizzonti impensabili ed impensati; e paradossalmente la sofferenza può rilanciare la vita. A volte si dice che il dolore rende migliori, fa crescere: è vero? Beh! Prima cautela: innanzitutto il dolore devasta. La devastazione, o meglio ancora, la rielaborazione dell’esperienza della devastazione, può aiutare, può trasformare, può aprire nuove possibilità. Quindi il dolore può anche aiutare, ma solo nel caso 1) che sia riconosciuto, che non sia negato; 2) che ci sia la possibilità nel frattempo, di intrecciare legami, per cui ci si accorge che si può ancora contare per qualcuno. Se ci sono queste due condizioni, c’è possibilità di andare oltre. Con l’emarginazione però c’è un problema. L’emarginazione quasi sempre non affronta, non si confronta col dolore, lo rifugge, o meglio, cerca in tutti i modi di anestetizzarlo: che vuol dire cercare non sentirlo, cercare di non provarlo e, soprattutto, non pensarlo. L’operazione che deve riuscire è non pensare il dolore. Quindi, rimuovere il dolore è la strada più affollata che l’emarginazione tenta di imboccare, ma che purtroppo non porta molto lontano perché in qualche modo bisogna stordirsi; però l’esperienza di stordimento 9 non è solo con la droga o il ricorso all’alcol, c’è anche l’uso improprio delle questioni che entrano in gioco: c’è l’attivarsi freneticamente, il fare tante cose pur di tentare, di non pensare a questo, e questo permette e facilita la rimozione. C’è anche il consumare: le esperienze di consumo sono speso esperienze di gratificazioni sostitutive; c’è il rischiare ( per provare più forte ancora) perché vivere al limite permette di non pensare la sofferenza ordinaria. Ci sono altre vie classiche: l’identificarsi con l’aggressore. Tra gli emarginati troviamo tante persone prepotenti, che quindi in qualche modo riproducono in piccola scala, qualche genere di prepotenza subita. Allora possiamo dire che l’emarginazione è la cronicizzazione di un disagio, di una difficoltà mai affrontata nel modo giusto, quasi mai neanche pensata. E’ un imbuto senza sbocco, è passività, è in qualche modo una pietrificazione dei vissuti. E’ il progressivo venire meno. Nel marciare lentamente verso il margine sociale, dove si è ancora emarginati, dove si spera ancora che avvenga quel qualcosa ben individuato e precisato che, però, non avviene. Nello slittamento del margine ad oltre il margine, al di là di esso, si comincia a sperare qualcosa di diverso, la speranza perde la sua individuazione, rimane solo l’attesa che avvenga qualche cosa per cambiare la situazione; quindi la speranza non è più individuata, è diventata qualcosa di più generico, di meno afferrabile, è più collegata al bisogno di non star male, che all’individuazione precisa di ciò di cui abbiamo bisogno per poter star meglio. Infine, nella stagnazione cronicizzata dell’emarginazione la speranza sbiadisce del tutto. Diventa prima luce fioca, poi viene meno e dà luogo a passività, a lasciarsi andare da una parte, o dal vicolo cieco della rabbia non finalizzata. E prima che la domanda si faccia muta, in genere incontriamo la pretesa. Chi sta male dimentica spesso il garbo e non pratica la riconoscenza (forse non l’ha mai imparata). Chi soffre si attende sempre qualcosa dagli altri, più spesso, pretende. E’ così che la domanda di aiuto è spesso aggressiva, potremmo dire che è come una sassata sul vetro. Capita come ai bambini, e non solo a loro, quando stanno male. Come vi dicono che stanno male? Facendovi star male, vi “passano” la sofferenza. Con chi ce la si prende? Con chi sta più vicino, con chi accudisce, con i familiari, con gli infermieri, con i volontari. Ma l’aggressività la rabbia, lo sfogo, a volte la cattiveria, sono però un segno di speranza, una prima bussola. Intanto, è un buttar fuori anziché un tenere dentro, è un attivarsi male, anziché passivizzarsi. Winnicot infatti ha definito la delinquenza giovanile come un segno di speranza perché c’è ancora vita, c’è ancora protesta, c’è ancora in qualche modo, pur distorto, richiesta di relazione. A volte invece la rabbia non c’è più, la ribellione scomposta e non finalizzata si esaurisce anch’essa. Che succede? L’aggressività è rimasta dentro: non viene più buttata fuori sull’altro, non permette più un movimento scomposto, comunque, di relazione ma l’aggressività fa una manovra ad U, automobilistica, e si dirige contro se stesso; e tutte le volte che l’aggressività si rivolge contro il soggetto, la soluzione è sempre la stessa, diventa depressione. Si rinuncia a combattere. I processi autodistruttivi a questo punto, 10 subiscono un’accelerazione e si saldano in maniera quasi definitiva, con i processi oggettivi dell’esclusione. Sul versante oggettivo, oggi ci dibattiamo tra povertà materiali (sette milioni di poveri in Italia, trecentomila ogni anno), culturali (i giovani ultras) e relazionali ( i contesti di solitudine, i “ghetti” di un noi senza confronto). All’interno di queste tre povertà, si evidenziano tre diversi insiemi di emarginati: i primi, gli emarginati per mancanza di autonomia ( non sono solo gli anziani, i disabili, le persone smarrite, ma anche alcuni pazienti psichiatrici cronicizzati); gli emarginati per mancanza di senso, che in qualche modo non trovano più se stessi; e infine, gli emarginati per mancanza di diritti ( per esempio le persone extracomunitarie, ma non solo). Questi tre “insiemi” assumono forme e configurazioni diverse, molto spesso s’incrociano, si sovrappongono, ma i processi sono simili anche se i binari che imboccano sono parzialmente diversi. Primo passaggio, è l’esperienza della delusione; secondo passaggio è una reattività inconcludente all’esperienza della delusione: non si costruisce un atteggiamento positivo, non si riesce a costruire, è qui che il disagio si cronicizza: rabbia, risentimento, rivendicazione; e infine il terzo passaggio, è in genere la passività e insieme ad essa, l’incalzare, in crescendo, della solitudine. L’emarginazione non fa molti distinguo cronologici. Picchia di più sulle età più deboli, ad esempio bambini: un solo “esempio”, le “carriere” scolastiche tutte prevedibili, ma assolutamente al momento stesso, quasi sempre imprevedibili dei minori di famiglie multiproblematiche, sono poi quelle che vanno ad affollare il carcere minorile e che non arrivano alla terza media. L’altra età su cui l’emarginazione picchia duro sono gli anziani, dove la dimensione principale è la solitudine, poiché non si conta più per qualcuno, dove molto spesso c’è l’impossibilità di fare qualcosa, dove viene a mancare uno scopo. Ma bambini e anziani “fondano” il loro stato marginale su un identico attore principale che è l’adulto, il quale rende difficile, problematica e sviata la vita di entrambi. L’adulto è il vero target preventivo. E’ l’adulto che dev’essere per primo preso in carico quando ci si occupa dell’emarginazione di bambini e degli anziani, dei non autosufficienti. E poi anche l’adulto è vittima di se stesso e si indebolisce: disoccupazione, alcol, malattie, equilibri personali che vanno in crisi. Oggi è in aumento l’emarginazione più pesante: i senza fissa dimora crescono; è caratteristico un nuovo furto d’uso che si diffonde in città, quello dell’automobile, ma non per farsi un giro come avveniva negli anni passati, ma per dormirci dentro al notte. Oggi per i senza fissa dimora, dove tra atteggiamento di rabbia e passività, il confine diventa labile, la politica di discriminazione o di accoglienza passa attraverso il diritto ad una residenza. Per far ottenere una residenza, anche se è solo formale, è una lotta con i comuni. E perché è importante? Perché permette di ottenere una carta d’identità e il libretto sanitario per esercitare certi diritti di cittadinanza. Ma in molti casi i comuni non lo fanno. Là dove c’è più emarginazione di questo tipo, c’è maggiore solitudine, c’è più disperazione e un minor senso di responsabilità per se stessi e gli altri. Quindi una 11 politica di rifiuto porta ad un’accoglienza di tutti gli aspetti negativi delle dinamiche marginali. VIVERE E SOPRAVVIVERE NELL ’INCITTÀ: Un «Drop in» frequentato da immigrati a Torino di Paola Molinatto Immaginate di dormire in una fabbrica abbandonata. Di essere soli. Di non capire bene la lingua. Di vagare per la città da mattina a sera. Alla ricerca di un lavoro, di cibo, di un posto in cui lavarvi, cambiarvi e lasciare le vostre cose. Immaginate di aver scelto la condizione di migrante, spinti da una scommessa sulla vita, e di essere al centro del guado. Immaginate, anche solo per un momento, i pensieri, la stanchezza, la determinazione e le emozioni degli abitanti invisibili delle nostre città. Un’Incittà è il tempo riunito, non soltanto nei nomi, nelle case e nelle statue, ma in quel che non si vede. Un’Incittà custodisce le gioie, i dolori, ogni sentimento, ne fa una rugiada che la veste e che tu percepisci senza poterla mostrare. Questo è un’Incittà, e questo era Saint-Pierre. La dolce, carezzandogli le dita, lo interrompeva gentilmente, Se questo è un’Incittà, qui è proprio così. Il mio Esternome le restituiva la carezza e in testa aveva un pensiero vizioso. (Patrick Chamoiseau) Alexandru, Mustafa, Mohammed, Abdel, Florian, Haddady e Slavko li ho incontrati in un pomeriggio di dicembre. A Torino, in un’ex fabbrica situata al numero 18 di via Pacini, quartiere Barriera di Milano. Parzialmente ristrutturato, l’edificio ospita un «Drop in» gestito dal Gruppo Abele e frequentato soprattutto da immigrati. Alexandru È la prima persona a dirsi disponibile per un’intervista. Mi dice che ha tempo e voglia di chiacchierare. Alexandru è un ragazzo alto e robusto. È di nazionalità rumena. Viene dalla Transilvania. Mi chiede: «Conosci Dracula?». Aggiunge che i rumeni dell’Ovest sono diversi dagli altri. «Noi siamo i migliori». Per arrivare in Italia ha pagato tre milioni. Ha viaggiato su un camion. Non ha incontrato difficoltà. Alexandru ha finito il liceo, dove ha studiato filologia e storia. È stato allevato dai nonni. I suoi genitori sono in Italia già da otto anni. Sono separati. Frequentano i dormitori cittadini. La sorella vive in Romania. Alexandru ha lavorato con una ditta di traslochi e ha anche accudito le pecore per un’azienda agricola. Non è in buoni rapporti con la famiglia. Attualmente vive in una casa abbandonata. È privo di documenti. Gli chiedo come immagina la sua vita tra qualche anno. Mi risponde: «In galera. Oppure sposato». Racconta che ha dei precedenti penali. È stato arrestato due volte. La prima volta per una rissa. In quel periodo faceva la guardia del corpo e il buttafuori. Inoltre aveva lavorato con persone che facevano dei prestiti. La seconda volta è stato arrestato per furto. Lui non c’entrava. L’hanno coinvolto. «Comunque in prigione non si stava male. Faceva caldo. Mi davano da mangiare. C’erano la doccia e la palestra». «Vorresti sposarti?». «Mi piacerebbe. Anche se non so se è un bene o un male. Vorrei anche dei bambini. Comunque se mi sposo è per sempre. Io non sono come mio padre». Alexandru parla volentieri. È affabile e polemico allo stesso tempo. Sembra sfogare una tensione a lungo trattenuta. Gli dico che ho la sensazione che lui sia molto 12 arrabbiato con la vita. Alexandru: «Se sono arrabbiato bevo. Ma non mi piace. Ho paura della mia forza». Poi aggiunge: «Più che arrabbiato sono confuso. Ho dentro tanta rabbia e tanta delusione. Vorrei cambiare il mondo». «Hai dei sogni?». «Io non sogno mai». Alexandru rimane con me tutto il pomeriggio. Interviene al momento giusto, mette a loro agio le persone, fa da traduttore. Mi è di grande aiuto. Mustafa Ha l’aria molto giovane. Mi dice che ha ventitré anni e che ha fatto le scuole medie. È emigrato dal Marocco per cercare lavoro. La famiglia è povera. Lui manda i soldi a casa. È a Torino da tre anni. Ha lavorato ai Mercati Generali. Ha anche tentato di mettersi in proprio, vendendo merci acquistate da connazionali a Porta Palazzo. I vigili gli hanno sequestrato tutto. Prima è stato in Spagna. È riuscito a lavorare con la frutta per quattro mesi. Poi è venuto via perché non c’erano possibilità di sopravvivenza. Chiedo a Mustafa com’è arrivato in Italia. Mi risponde così: «Sono passato dalla Turchia. Ci sono arrivato in volo direttamente dal Marocco. Ho attraversato la Grecia a piedi. Sono arrivato a Forlì nascosto in un container. Ho temuto di morire. Ero con dei kurdi. Avevamo cinque o sei bottiglie di acqua a testa. Sono finite presto. Siamo rimasti per tre giorni senza acqua e senza cibo. Faceva un caldo infernale. Eravano completamente disidratati. Eravamo terrorizzati. Non credevamo di uscirne vivi». «Quanto hai pagato?». «Sei milioni». Mustafa mi racconta che adesso vive in una fabbrica abbandonata con altre persone. «Era uno schifo. Abbiamo pulito». «Riuscite anche a cucinare?». «Sì. Ma adesso c’è il Ramadan». Chiedo a Mustafà quali siano i suoi progetti. Mi risponde che vuole rimanere in Italia. Probabilmente in Grecia avrebbe potuto trovare lavoro. Ma la Grecia non è l’Italia. Lui vuole vivere in Occidente. «Pensi di farcela?». «Posso resistere fino a Natale. Non di più. Purtroppo il lavoro lo trova solo chi ha degli amici». Gli chiedo di spiegarsi meglio. Mustafa non parla correntemente in italiano. Mohammed è un suo amico. Finora è rimasto ad ascoltare. È lui a parlare. «È semplice», mi dice. «Il lavoro vero lo si trova solo con il permesso di soggiorno. Per il lavoro nero ci vogliono gli amici. E gli amici vogliono un contributo, la metà della paga giornaliera». Lui ha paura della criminalità organizzata. Non vuole finire in un brutto giro. Neanche dai connazionali si può sperare in un aiuto. Mustafa. «E pensare che basterebbe poco. Con un milione potrei rimanere qui. E mantenere la mia famiglia. Con quella cifra in Marocco si vive come dei re». Prima di andarsene mi chiede se l’articolo che sto scrivendo può aiutarlo. Gli rispondo di no. Aggiungo che però penso che sia importante che si conoscano vicende come la sua. Ringrazio Mustafa e Mohammed del loro racconto. Ci salutiamo. Abdel Vive in Italia da sedici anni. È disegnatore industriale e tecnico navale. Parla in spagnolo e in francese perfettamente. Il suo italiano è scorrevole ed efficace. Ha studiato. La sua intenzione era di entrare in Polizia o in Marina. Non ci è riuscito. «La realtà – mi dice – è che i posti ci sono solo per i ricchi». Abdel è giunto in Italia nel 1984. È entrato legalmente. Non ha precedenti penali. Ha chiesto il permesso di soggiorno, ma senza successo. Lavorando in nero non è riuscito a dimostrare di essere sul territorio italiano fin da allora. «Ho fallito perché non avevo una prova». Aggiunge: «Gli italiani hanno bisogno di noi. Io ho due figli. So disegnare. Posso fare il fresatore. E invece ho paura di finire come un barbone». Gli chiedo della sua famiglia. Mi risponde che la moglie e i figli vivono in Marocco. Non li vede da quattro anni. Non va da loro per non dover rientrare clandestinamente in Italia. Spera in una sanatoria. Si mantiene lavorando 13 occasionalmente ai Mercati Generali. Gli è anche capitato di essere preso in prova per tre giorni come disegnatore da una ditta dell’indotto F IAT. «“Lavori bene, mi hanno detto”. E poi: “Hai il permesso di soggiorno?”. Alla fine non mi hanno preso». Abdel manda i soldi a casa. «Loro vivono dieci volte meglio di me. Io ho dormito qui una settimana. Da stasera torno in strada. Per affittare una casa occorre il permesso di soggiorno. Non se ne esce». Poi aggiunge: «È un dato di fatto. Gli italiani vogliono fare degli immigrati dei delinquenti. I pusher hanno bisogno di cavallini. E ci siamo noi». Gli chiedo se pensa ancora di trovare una soluzione. Mi risponde che è rimasto in Italia per questo. Se non dovesse riuscire, tenterà ancora in Spagna prima di tornare nel suo Paese. Riflette. Mi dice: «L’uomo è l’unico animale che si adatta a qualsiasi situazione. Un leone, portato al polo Nord, non sopravvive. L’uomo sì. Ovunque. Guardami. Ho perso venticinque chili in tre anni. Ma devo farcela». «Questo posto ti aiuta?». Risponde di sì. C’è la luce. Si fa la barba, una doccia. Può lavarsi i vestiti. Talvolta riesce anche a dormire. Abdel mi dice che viene al Drop in soprattutto per rilassarsi e per dimenticare. Ma anche: «Tra di noi dovremmo aiutarci. Questo posto deve diventare un’associazione di immigrati. Solo così cambierà qualcosa». Gli chiedo: «Sei cambiato?». Mi risponde: «È cambiato il modo di ragionare. Sono confuso. Ho la testa piena di pensieri. Fatico a prendere una decisione. Un minuto prima penso di andare in Spagna. Un minuto dopo sono a Biella, perché un amico mi ha detto che posso trovare un lavoro. Vado avanti a tentoni». Poi dice: «Io ho i miei ideali. Non voglio spacciare. Non voglio diventare così. Il mio sogno? I documenti a posto. Un lavoro. Un milione e due. Un milione e mezzo al mese. Cinquecentomila lire per l’affitto. Altrettanto per mangiare. Quello che rimane per il resto. Io e mia moglie che andiamo al supermercato. Lei potrebbe lavorare in una famiglia. Occuparsi degli anziani. Anche lei ha studiato». Gli domando se vuole dirmi ancora qualcosa. Abdel. «Sono come un naufrago in alto mare che sta cercando di salvarsi e ha già bevuto parecchi litri di acqua. È lì a metà. Con la testa né sopra né sotto l’acqua». Abdel rimane per qualche minuto. Poi ci saluta. Un amico è venuto a cercarlo. Forse ha trovato una macchina per questa notte. Florian È Alexandru a presentarmi Florian. Vuole che io parli con lui, che ascolti la sua storia. Florian ha un’espressione allegra sul viso. È palesemente di buon umore. Mi informa che la palestra del Drop in non è sufficientemente pulita e che le cyclette non funzionano. Aggiunge che è di nazionalità rumena. È in Italia da quattro mesi. Prima è stato in Turchia e in Jugoslavia. In quest’ultimo Paese gli è stato ritirato il passaporto, poiché il visto turistico era scaduto. È entrato in Italia dal confine orientale, passando per i boschi. A Gorizia le forze dell’ordine lo hanno sorpreso a dormire in un cassonetto dei rifiuti. Gli hanno consegnato il foglio di espulsione. Lui l’ha strappato e ha continuato il suo viaggio. È stato a Trieste, Venezia, Milano e Brescia, per non più di quindici giorni in ogni città. Ora è a Torino. Ha trovato una bicicletta con cui gira per le strade cittadine alla ricerca di un lavoro. «Come pensi di andare avanti?». Florian ha un diploma professionale da muratore. Suo padre era alcolizzato. Lui ha vissuto in orfanotrofio. Ha fatto il militare e si è trovato male. Nella vita gli è capitato spesso di essere picchiato. Per questo non sopporta di assistere a dei soprusi, specie se da parte di adulti nei confronti di ragazzi più giovani. «Dove dormi?». Non sono sicura di aver capito bene, ma credo che la descrizione di Florian corrisponda a una conduttura fognaria vicino al Po, a cui accede togliendosi scarpe e calze, per non bagnarsele. Ha delle coperte e finora non ha avuto freddo. «Come mangi?». «Questo non è un problema», risponde Florian. I suoi punti di riferimento sono la mensa di via Nizza, quella della Caritas presso la chiesa di Sant’Antonio e il Mac Donald’s. «Basta aspettare che buttino via i panini. Spesso sono ancora caldi. Non sono male». Alexandru lo interrompe. Vuole farmi capire che lui e Florian sono diversi. Lui, specie se è arrabbiato, tiene per se tutto quello che 14 trova. «Florian invece distribuisce i panini. È fatto così. Io no. Posso essere anche molto cattivo, se voglio. Dipende dagli altri». Chiedo a Florian che cosa pensa che gli accadrà. Risponde che vuole trovare un lavoro e farsi una vita qui, in Italia. «Non sono disperato», precisa. «Poco alla volta ce la farò». Aggiunge che la strada non gli fa paura, che sa cavarsela. Alexandru ne è convinto. «Florian è calmo. Parla bene con la gente. Vedrai. Ci riuscirà». «Come ti trovi al Drop in?». Ribadisce che è insoddisfatto della pulizia e dell’attrezzatura della palestra. Sostiene che gli operatori non se ne preoccupano. Gli faccio presente che si tratta di spazi autogestiti e che quindi potrebbe cercare una soluzione con le persone che utilizzano la palestra. Florian è d’accordo su questo punto, ma aggiunge che non tutti si comportano allo stesso modo. Sorride. Poi mi dice che gli operatori aiutano di più i marocchini. E che lui è disposto a pulire la palestra, se gli danno da dormire. Inoltre avrebbe bisogno di un dizionario. «C’è il corso di lingua, ma non posso migliorare il mio italiano stando con i marocchini che imparano l’alfabeto». Alexandru conferma la necessità di un dizionario e i limiti del corso di lingua. Florian e Alexandru convengono anche sull’importanza di poter disporre di alcuni pesi e di un attrezzo per boxare. Mimano alcuni pugni nell’aria. «Un punching ball?», chiedo. «Sì, ma anche un sacco, di quelli grossi». Florian: «Io non lavoro. Devo scaricare le mie energie». E poi: «Vieni. Ti faccio vedere la palestra». Haddady Entra nella stanza e chiede se può dire anche lui qualcosa. Si toglie il Montgomery beige e si informa del lavoro che stiamo facendo insieme. «Volete un caffé?», chiede con premura. Poi comincia a raccontare di sé. Viene dal Marocco. I suoi genitori sono anziani. Quando può manda loro del denaro. In città ha un fratello sposato, con una bambina e una casa molto piccola. Lui dorme dove capita. In macchina. Per la strada. Dipende. In francese aggiunge che è una vergogna. L’Italia fa parte del gruppo dei sette Paesi più potenti del mondo. Gli chiedo se riesce a lavorare. Risponde che ha un baccalaureato in lettere moderne. Venerdì e sabato ha lavorato ai Mercati Generali. Ha guadagnato centomila lire. «Guarda», aggiunge. Indica due ferite che ha sul volto. Una sul naso e una sullo zigomo. «Mi sono cadute addosso delle casse. Mi sono fatto male, ma non ho potuto dire niente. Vado avanti così». Poi Haddady racconta che ha vissuto in Francia. Che lì la situazione è diversa. Alterna frasi in francese e in italiano. A Parigi ha lavorato per la Croix Rouge e in una Boutique, uno «Sleep in» del 14° arrondissement. Si lamenta del fatto che qui, al Drop in, non ci sia un adeguato servizio di sostegno sul piano umano e psicologico. Mi dice che in Francia sono più organizzati. Ci sono molti operatori e persone come lui che li affiancano. Per Haddady è stata un’esperienza importante. Ha lavorato come «pari» nella Croix Rouge, dove lo hanno aiutato a disintossicarsi. Prima si faceva. Un po’ di tutto. Cocktail di farmaci, alcol, droga. Adesso ha smesso. «Anche per questo – mi dice – è importante avere una persona con cui parlare». «Ti senti solo?». «Vivi per strada. E questo significa che non puoi avere una donna. È peggio del carcere. Siamo liberi. Ma siamo ancora più soli. Per fare l’amore dobbiamo avere dei soldi. Ma quello non è amore, né affetto. Oppure ti masturbi. Senza una casa non esisti». «Che cosa significa dormire per strada? Che cosa sogni?». «Cauchemars, seulement. Tu comprend? Spesso non riesco a dormire. Oppure sogno di trovarmi di fronte a un muro o a degli ostacoli, che devo cercare di superare». «La strada ti ha cambiato?». «Sono sempre lo stesso. Forse un po’ più nervoso. Sono malato». Haddady è venuto in Italia per il permesso di soggiorno. Sono passati più di quindici mesi da quando ha presentato la domanda. Pensa di rimanere in Italia, eventualmente anche per poter fare ricorso. Adesso deve andare. Si scusa e ci saluta. 15 Slavko È arrivato in Italia nel mese di marzo di quest’anno. È di nazionalità serba. Ha un cappello da baseball e occhi pungenti. Si esprime con difficoltà in italiano. Viene dalla Voivodina. Con l’aiuto di Alexandru mi dice che ha combattuto nella Bosnia Erzegovina nel 1993 e nel 1994. Faceva parte di un reparto medicoinfermieristico dell’armata jugoslava. Gli chiedo che cosa abbia fatto successivamente e lui mi risponde che ha fatto la guerra per vivere. È stato allevato dai nonni e mi pare di capire che sia orfano dei genitori. Mi dice di essere stato profondamente choccato dal bombardamento N ATO. Gli chiedo com’è stato, come l’ha vissuto. Mi risponde così: «Dovevi essere lì per capire». Poi aggiunge: «In Bosnia è stato peggio». Con i suoi occhi ha visto i morti. E altre cose che non può raccontare a una donna. Anche dei bambini non può raccontarmi. Non è facile parlare con Slavko. Ogni sua frase sembra chiudere il discorso. Però continuiamo a chiacchierare. Alexandru si comporta come un traduttore professionista. È molto preciso nel riferirmi le parole di Slavko. Talvolta ne discute con lui, sono entrambi impegnati affinché io capisca bene quello che mi viene detto. Spesso mi domandano che cosa sto scrivendo nei miei appunti. In due occasioni mi chiedono di non scrivere ciò che hanno raccontato. Cerco di rassicurarli al riguardo. Alexandru mi dice che lui ha visto la guerra della strada. È un concetto che ripeterà più volte. Chiedo a Slavko dei suoi progetti. Vuole una vita normale, tranquilla. Se non adesso, almeno quando sarà vecchio. «Sei ottimista? Credi che ce la farai?». Mi risponde di sì. Sì, certo. Vuole un futuro. Una casa. Un lavoro. Se si comporta onestamente, vuole essere trattato bene anche dal datore di lavoro. Non vuole la carità. Solo casa e lavoro. In ogni caso, ce la farà. Da solo. «Gli operatori non possono aiutarci. Nessuno può farlo. Dobbiamo aiutarci da noi stessi». «Quanto potrai resistere?». «Aspetto di ottenere il permesso di soggiorno. Spero in una sanatoria. Se trovo una brava persona che mi aiuta rimango qui. Ho bisogno di una mano. Qui, al Drop in, c’è una piccola mano. Viceversa farò da me». «Hai degli amici? Qualcuno che possa aiutarti?». Risponde con il primo di una serie di secchi «No comment». Lo ringrazio per il suo contributo. Slavko vuole continuare. «Mi interessano le tue domande». Mi chiede: «Perché gli italiani si preoccupano tanto per gli animali e non per le persone? Se gli italiani ci riservassero lo stesso trattamento che rivolgono ai cani la nostra situazione migliorerebbe». Gli domando se è soprattutto amarezza quella che sente dentro. Risponde di no. «Come ti immagini tra qualche anno?». Ci pensa. Poi dice che vuole una legge che gli permetta di lavorare. Provo a insistere senza successo. Allora gli chiedo se pensa di trovare una compagna, di farsi una famiglia. Risponde: «Le donne italiane non guardano gli stranieri». No, non gli interessano. Loro (gli stranieri) non esistono per le italiane. Non hanno né una casa, né un lavoro, né una macchina. E poi, lui deve prima risolvere il suo problema. Dopo saprà rispondermi al riguardo. Dopo potrà dire a se stesso: «Sono un uomo. Sono fiero di me». «Adesso lo sei?». (Pausa.) «Ho fatto un grande passo in avanti, perché sono in Italia. Adesso devo farne un secondo». Non so come, ma a un certo punto parliamo di politica. Slavko sostiene che Berlusconi è un mafioso e un affarista. Mi offre un quadro della situazione politica italiana da fare invidia a quello di noti editorialisti. È analitico e preciso nelle sue affermazioni. Chiedo a lui e ad Alexandru che cosa pensano dei diritti politici per gli immigrati. «Vi interesserebbe votare?». Rispondono entrambi affermativamente, con sicurezza. Slavko aggiunge: «Mi importa quasi di più di quello che riuscirò a fare. Ho lasciato tutto. Sono qui. È anche il mio mondo». E poi: «Ho disertato dall’esercito jugoslavo quando sono stato richiamato per andare a combattere nel Kossovo. Credi che potrei chiedere asilo politico in Italia?». Con noi ora c’è anche Aldo, un operatore del Drop in. Conosce bene Slavko. Mi dice che stanno cercando di capire e di inquadrare la sua situazione dal punto di vista giuridico. Slavko mi chiede se posso aiutarlo. Se posso informarmi. Dice che ha paura. Ha paura di essere fermato e rimpatriato. Gli chiedo com’è arrivato in 16 Italia. Mi risponde che è passato attraverso il Montenegro. Di più non può dirmi. Risponde con una sequenza di «No comment» anche ad altre domande riguardanti l’esperienza militare e la diserzione. Discutiamo a lungo della sua situazione. Alla fine concordiamo con Slavko che occorre fare chiarezza su tre questioni: può essere espluso? che cosa rischia, una volta rimpatriato in Jugoslavia? può chiedere asilo politico? Stiliamo anche un breve elenco di enti e associazioni internazionali da contattare per una consulenza giuridica. Ci salutiamo. Slavko ci chiede di fare qualcosa. «Fate in fretta. Non posso aspettare». Fatti Tu dici: cos’è l’Incittà? È le posizioni che ti dà. Tu dici: cos’è l’Incittà? È la strozzatura dove le nostre storie si uniscono. E anche i Tempi. Le tenute si dissociavano. Le colline ci piantavano in una deriva immobile. L’Incittà mette in movimento, annoda, àncora, impasta e reimpasta a tutta velocità. Ma all’uscita non cadi in un culdisacco. Si ricomincia. Come? In un altro modo. Tu dici: cos’è l’Incittà? Non è un luogo di felicità. Non è un luogo di infelicità. È contenitore del destino. L’Incittà non è da prendere. È da capire. (Patrick Chamoiseau) Numeri. Cento, centotrenta, con qualche punta di centocinquanta persone al giorno. Questi numeri esprimono una media approssimativa dei passaggi giornalieri registrati nel corso dell’anno 2000 e fotografano l’attività del Drop in di via Pacini probabilmente meglio di qualsivoglia racconto o ragionamento. Per farsi un’idea di che cosa significhino è sufficiente salire al primo piano dell’ex fabbrica situata a fianco del Liceo Scientifico Einstein, in un’area caratterizzata dalla presenza di un ampio complesso di edilizia agevolata costruito alla fine degli anni Settanta. I locali, organizzati a mo’ di spina di pesce, intorno a un corridoio centrale, comprendono un locale-deposito per materiali di consumo e prevenzione, bagni e docce per donne e uomini, una lavanderia con due lavatrici e un’asciugatrice, due stanze adibite ad asilo notturno d’emergenza (rispettivamente con tre posti letto donne e sette posti letto uomini), una stanza per gli operatori in servizio nelle ore notturne, una palestra, una stanza utilizzata per il corso di italiano, due stanze adibite a incontri tematici e colloqui individuali o di gruppo, un bagno per gli operatori, una cucina. In testa, all’inizio del corridoio, c’è l’ufficio accoglienza; più avanti, sulla destra, un grande salone, arredato con divani, tavoli e sedie, un tavolo da ping-pong. È questo il cuore del Drop in. È qui che le persone sostano, riprendono fiato, bevono un caffé, chiedono informazioni o quant’altro. Solitamente c’è un gran via vai. In un pomeriggio qualsiasi è facile incontrare quaranta, cinquanta o sessanta persone, per lo più uomini, di provenienza slava o magrebina, nella maggior parte dei casi clandestini. Per il resto, una persona su tre è italiana, spesso con problemi di dipendenza; le donne sono invece relativamente poche, più o meno una su trenta. I dati raccolti nell’ultimo anno registrano una media di 5.130 passaggi mensili, con punte massime di 7.641 passaggi e punte minime di 2.757 passaggi, rispettivamente nei mesi di gennaio e settembre. La consistenza dei flussi di persone che frequentano il Drop in, secondo l’analisi fatta dagli operatori, sembra non essere influenzata significativamente da variabili stagionali (condizioni climatiche, offerte di lavoro) e invece determinata dal numero degli arresti e delle espulsioni effettuati periodicamente dalle forze dell’ordine. Tra le persone che frequentano il Drop in, in media una su quattro utilizza il servizio docce e lavanderia, mentre una su cinquanta impegna gli operatori in attività di counselling. Complessivamente i tossicodipendenti rappresentano circa il 10% delle persone che si recano al Drop in. Nel periodo considerato, accanto agli interventi di riduzione del danno, prevenzione, orientamento e sostegno, si sono svolte alcune attività: corsi di lingua italiana, laboratori teatrali e di creatività, cineforum, palestra. Tutti i venerdì 17 pomeriggio c’è un’assemblea aperta a tutti, che funge di incubatrice domande, i problemi e i tanti cul-de-sac in cui le persone si dibattono. per le Ipotesi. Il Drop in di via Pacini inizia la sua attività nel marzo del 1999. Il progetto, che il Gruppo Abele mette a punto partecipando e vincendo una gara d’appalto promossa dal Comune di Torino, prende le mosse da una domanda ricorrente. Già da un paio di anni responsabili e operatori del settore Accoglienza si interrogavano sul bacino di utenza raggiunto, trattato e preso in carico, con metodologie diverse, dagli interventi attivati e gestiti in città. Dall’osservatorio offerto da due agenzie operanti sul territorio cittadino – l’Ufficio persone senza fissa dimora del Comune di Torino e l’unità di strada attivata dall’ASL 4 in collaborazione con il Gruppo Abele – emergevano, rispettivamente, due dati. In primo luogo che l’80% degli ospiti dei dormitori comunali presentava problemi di tossicodipendenza. In secondo luogo che il 25% delle 3.000 persone contattate dal camper nel corso del 1998 era senza fissa dimora. Alcune proiezioni fatte in quel periodo stimavano in 300-400 il numero delle persone che ogni notte trovava rifugio in fabbricati industriali abbandonati o in altri luoghi di fortuna. Era dunque evidente che una parte consistente delle situazioni di emarginazione grave presenti sul territorio cittadino rimanesse al di fuori del circuito dei servizi socio-sanitari e quindi esclusa da politiche e interventi di sostegno e di riduzione del danno. L’idea di un centro diurno a bassa soglia per adulti in difficoltà, con annesso un ricovero notturno d’emergenza, nasceva dunque dall’ipotesi che fosse necessario diversificare ulteriormente le modalità di approccio ai problemi della tossicodipendenza; anche in considerazione del fatto che, solo a Torino, la popolazione tossicodipendente che non è mai entrata in contatto con i Servizi, o che ne ha interrotto il rapporto, è probabilmente stimabile in 5.000 unità. L’obiettivo prioritario dell’intervento è stato fin dall’inizio quello di «agganciare il sommerso», vale a dire le persone lontane dal circuito dei Servizi, che abitano la strada tutto il giorno, spesso in condizioni di disagio gravi, girando da una panchina all’altra, da un bar all’altro, da un vagone ferroviario all’altro, senza sapere dove andare. In questa prospettiva, nel 1998, il Gruppo Abele ha predisposto l’allestimento di alcuni locali all’interno dell’ex fabbrica, che in un’altra ala dell’edificio ospitava già un centro semiresidenziale e un centro crisi per percorsi drug free. Nel giro di pochi mesi, il centro a bassa soglia per adulti in difficoltà è entrato così a far parte dell’intero sistema di accoglienze del Gruppo, diventandone un elemento integrante, pur salvaguardando la propria autonomia e focalizzando l’attenzione su uno specifico target. Lo si è definito infatti «Drop in», che letteralmente vuol dire «salta dentro», ed è quindi un invito all’inclusione, in un tessuto urbano che, come accade altrove, favorisce l’esclusione dell’altro e la propensione lasciare fuori dalla porta i problemi, nonché, in senso stretto, le persone. Sorprese. Col tempo ci si è assuefatti all’idea che il lavoro sociale trovi la sua piena espressione nell’incessante sequenza di progetti e interventi attivati da instancabili operatori-ingegnieri (sociali) e/o operatori-urbanisti, per lo più animati da spirito salvifico e ossessionati da ansie di rinnovamento, bonifica e razionalizzazione (anche se di solito non le definiamo così). In questi casi è difficile che ci si confronti con eventi imprevisti. C’è un già-saputo che tende a uniformare e a standardizzare la realtà. Qualche volta accade che le cose vadano altrimenti. Qualche volta accade che si faccia sul serio. Così, se si parte con l’intento di navigare in mare aperto e di provare ad agganciare ciò ancora che non si conosce (anche se si immagina) è probabile che all’amo si trovino delle sorprese. E non sempre, come accade ai pescatori d’alto mare, le cose sono così (1) . semplici Analogamente, gli eventi inattesi che hanno caratterizzato l’esperienza del Drop in di via Pacini, sono stati sostanzialmente tre. Essi ruotano intorno ad alcune questioni che interrogano il senso stesso del lavoro 18 sociale e che sono efficacemente sintetizzate da almeno tre affermazioni ricorrenti tra gli operatori di via Pacini. «La strada ci ha invaso di immigrati». Immigrati più che tossicodipendenti. Tanti. Tantissimi. Con un carico di bisogni, domande e problemi tanto semplici quanto senza soluzione, come lo possono essere soltanto quelli che attengono alla sopravvivenza stessa dell’individuo. Persone spesso fornite di titoli di studio, capaci di parlare più lingue straniere, con competenze talvolta straordinarie relativamente alle capacità di adattamento e di sopravvivenza, che hanno girato mezzo mondo, e che tuttavia presentano quell’insieme di problematiche caratteristico di chi non possiede né casa, né lavoro, né documenti. I dati emersi dall’osservatorio di via Pacini hanno indotto gli operatori a modificare e ad aggiornare le mappe della geografia del disagio e dei percorsi di chi vive in strada. Tali mappe evidenziano tipologie di traiettorie e carriere di adulti in difficoltà, contrassegnate da esperienze e traumi di natura diversa – tossicodipendenza, alcolismo, disagio mentale, infezione da HIV , disoccupazione, invecchiamento, migrazione – e tuttavia accomunate dal fatto di consegnare le persone alla strada e alla sua logica liminare. «Qui non c’è un bel niente da rieducare». L’impatto è stato duro. Ha scompaginato le poche certezze che possono accompagnare il lavoro di chi ha scelto di stare a diretto contatto con la strada. Ha mandato a gambe all’aria ogni ragionevole aspettativa e previsione. A cominciare dalla consistenza della marea di persone che seguendo il tam tam della strada sono confluite al Drop in. Fin dall’inizio tutto è apparso inadeguato: risorse, forze, formazione. Ma è soprattutto rispetto a un modo tradizionale di intendere l’accoglienza che i conti proprio non sono tornati. Fine del modello educativo-terapeutico. Non è una novità. Chi lavora nei servizi a bassa soglia ne ha in genere una consapevolezza profonda. Ma è un dato di fatto che la cultura moralistica di cui sono spesso impregnate le politiche di welfare ci abbia abituato a pensare ai destinatari di interventi e politiche sociali con atteggiamenti alternativamente vittimizzanti o colpevolizzanti, a partire dai quali è difficile riconoscere nelle persone, a un tempo, condizioni di abilità e povertà e soprattutto lo status di attori e di soggetti agenti. Davvero la cosa migliore per un immigrato irregolare è di essere inserito nel circuito dei servizi? È necessariamente questa la via attraverso la quale si diventa «buoni cittadini»? «Migliorare la qualità della vita è poco?». Fare il caffé, caricare la lavatrice, stare con le persone, parlarci, riparlarci, provvedere a una medicazione, prestare ascolto, distribuire latte e biscotti, informazioni, materiale di prevenzione, discutere in assemblea, trovare un posto letto, seguire un gruppo di lavoro tematico, prendere in carico una persona, smistarne altre, contattare e ricontattare la «rete», attivare gli abitanti del quartiere, coordinare i volontari e gli operatori pari. La giornata di un operatore è fatta di cose come queste. La domanda è sempre la stessa: «Ha senso quello che facciamo?». Serve? Modifica le situazioni? Produce cambiamento? Che si tratti di domande che si sentono sulla propria pelle e non piuttosto di interrogativi puramente retorici o formali è evidente; basti pensare che nell’arco di un anno c’è stato un ricambio pressoché completo dell’équipe di via Pacini. Migliorare la qualità della vita e, in altri termini, minimizzare la sofferenza socialmente evitabile: questa è la scommessa. Esserci, e con una porta sempre aperta sulla strada. O K . E poi? È sufficiente? È poco? Produce solo frustrazioni (a noi e a loro)? In più, non c’è il rischio di ricadere nel paternalismo buonista o nella mensa per i poveri vecchio stampo? Interpretazioni C’era un vaevieni incessante, fra il Quartiere dei Miserabili e il cuore dell’Incittà. L’Incittà era l’oceano aperto. Il quartiere era il porto d’immatricolazione. Porto d’immatricolazione delle bisbocce, porto d’immatricolazione delle speranze in libertà, porto d’immatricolazione delle sventure, porto d’immatricolazione delle memorie che venivano portate da lontano. Ci tornavano per curarsi le ferite e trovare la forza di un assalto vigoroso all’Incittà. 19 (Patrick Chamoiseau) Le considerazioni e le riflessioni maturate tra gli operatori dell’équipe del Drop in sono ovviamente molte e approfondite. Ciò che le contraddistingue, a mio avviso, è innanzi tutto il fatto di indicare costantemente delle contraddizioni più che dei problemi e dei paradossi più che delle soluzioni. Esse delimitano, in questo senso, uno spazio aperto di «impossibilità» che è però anche il solo luogo, forse, nel quale ospitalità e responsabilità, intese come pratiche sia individuali sia collettive, possono provare a concretizzarsi. Tali impossibilità individuano infatti alcuni «tra», alcune terre-di-nessuno, alcuni terrain vague dell’intervento sociale e della stessa socialità, che sono altrettante buone ragioni per scegliere di provare a starci dentro e abitarle. Prima impossibilità. Essere un luogo di tregua e un porto di mare. Detto così può sembrare strano, ma in questo periodo una delle preoccupazioni degli operatori del Drop in consiste nel reperire qualche divano, con cui completare l’arredamento del salone. Il punto è che essere un luogo di tregua nella fatica dell’abitare la strada, concretamente, significa: essere un luogo che non obbliga a essere altro da se stessi, in cui non si chiedono prestazioni o performance di alcun tipo; essere un luogo in cui è possibile pensare, stare in silenzio, ascoltare, parlare (mentre la strada è rumore); essere un luogo in cui ricaricarsi emotivamente (trovando ascolto), riprendere le forze (mangiando qualcosa, riposando), ritrovare se stessi, la propria dignità (facendo una doccia, cambiandosi gli abiti). Da questo punto di vista, il divano e il caffé, lo shampoo e l’asciugamano, la siringa pulita e l’insulina sono micro interventi essenziali, che consentono di vivere un momento di sosta, di trovare una sospensione temporanea ai ritmi serrati e alla logica darwiniana della strada. Ma è anche vero il contrario. E cioè che il Drop in è un punto di incontro e di confluenza (di persone, informazioni, opportunità), un luogo di immatricolazione e di smistamento, da cui ripartire con nuove energie alla volta del proprio progetto migratorio. Insomma, un porto di mare, e quindi un luogo aperto, trafficato, animato, talvolta febbricitante. In cui è possibile trovare stimoli, orientamenti, in cui ci si sente accolti ma anche provocati e messi in discussione, nonché aiutati ad affermare la propria identità e i propri diritti, ad alzare la testa piuttosto che a pacificarsi con le tante umiliazioni subite. In questo senso il Drop in è anche un laboratorio naturalmente politico, che favorisce l’aggregazione degli individui e degli interessi, lo stabilirsi di alleanze tra gruppi e associazioni, e in cui riscoprire il senso della denuncia e la passione della proposta politica. Seconda impossibilità. Rispondere alla committenza della strada e alla commitenza istituzionale. «Ma noi da che parte stiamo?». Anche questa è una domanda molto seria, da parte degli operatori, e niente affatto scontata. Si può – si riesce? – essere un luogo intermedio, ma anche di traduzione e di traghettamento (nei due sensi ovviamente) di istanze, bisogni e linguaggi tra due rive opposte, quella delle istituzioni (i Servizi) e quella della strada (pur sapendo di appartenere alla prima)? È difficile rispondere, certo. Ma è altrettanto vero che gli operatori del Drop in sono consapevoli della loro inevitabile collocazione al centro del guado. E questo significa, inevitabilmente, fatica, tensione, crisi di identità. La committenza che viene dalle istituzioni parla spesso la langue de bois, alternativamente, del buonismo e del controllo sociale. La committenza che viene dalla strada, non senza qualche rischio di idealizzazione, parla invece la lingua dei problemi concreti di una persona adulta in difficoltà, che richiede interventi volti a un miglioramento concreto della qualità della vita, autovalutato e portato avanti in prima persona. Un esempio. (Anche se inadeguato a esprimere il senso profondo di questa contraddizione.) Fin dall’inizio dell’attività del Drop in si è scelto di raccogliere una mole anche consistente di dati relativamente ai flussi, alla popolazione di riferimento e alle tipologie di intervento (counselling, servizi docce e lavanderia, interventi di prevenzione e di riduzione del danno) che caratterizzano il servizio a bassa soglia diurno e notturno (per una sintesi, cfr. 20 le «finestre» di pp. 74-75). È evidente che tali dati siano degli indicatori significativi dei processi di emancipazione progettati e attivati, nonché un interessante elemento di valutazione utile alla ridefinizione degli obiettivi. Ma siamo davvero certi che quegli stessi dati non parlino in fondo anche di un’involontaria, ma probabilmente inevitabile, pratica di controllo sociale, volta a contenere il conflitto sociale connesso a situazioni di emarginazione grave e così fuzionale a «tener buone» le persone? Terza impossibilità. Scommettere sull’informalità dei rapporti e non rinunciare alla propria professionalià. Su questo punto la posizione degli operatori è molto chiara. È nel rapporto informale, nel dare credito e fiducia alle persone, nel valorizzare le abilità e le potenzialità, che si gioca gran parte del significato di un lavoro di questo tipo. Su questo punto tutti concordano. Anche se poi, nel concreto, bisogna riuscire a far funzionare questo modello d’intervento – in cui si lavora senza corazze professionali o di ruolo, senza scrivanie, spogliati di molte certezze, in balìa di mille domande – in una situazione in cui quasi quotidianamente ci si trova di fronte a cento persone adulte (prevalentemente uomini), di provenienza culturale diversa e in difficoltà. Alla prova dei fatti è inevitabile che le cose si complichino. «Che cosa significa “orientare” – si chiedono gli operatori – quando c’è una bocca da sfamare e un lavoro da trovare?». Da un lato, evidentemente, è forte la tentazione dell’aut aut tra militanza e professionalità, che si traduce spesso nel desiderio di condivisione e di stare dalla parte di chi vive una situazione che è probabilmente senza via di uscita. D’altro lato, l’esperienza maturata ha mostrato come, generalmente, riesce a trovare un equilibrio soddisfacente tra frustrazione e senso di onnipotenza chi mette in discussione radicalmente il senso del proprio essere animatore, educatore, psicologo o quant’altro, senza che tuttavia ne venga meno la formazione e l’identità professionale che, quando sia passata attraverso a un setaccio di questo tipo, inevitabilmente si rafforza e assume anche il senso di una scelta politica (di basagliana memoria). In sintesi: impossibilità di difendersi dietro a corazze professionali; impossibilità di aiutare davvero le persone in mancanza di un’équipe con competenze specifiche, socializzate e de-potenziate nei loro effetti di saperepotere. Quarta impossibilità. Lavorare senza patti terapeutici e fare del Drop in un luogo di sperimentazione di rapporti diversi da quelli della strada. Questo è un punto molto delicato. Le persone che vengono al Drop in sanno di essere accolte indipendentemente dal fatto di avere o meno il permesso di soggiorno, di fare o meno uso di sostanze, di avere alle spalle un percorso di emarginazione piuttosto che un altro, di progettare il proprio futuro nel modo A o nel modo B oppure di aver rinunciato ad averne uno (qualsiasi). Lavorare così non è semplice. Occorre innanzitutto fare i conti con l’episodicità dei contatti, con l’esiguità del tempo a disposizione, con l’impossibilità di misurare l’efficacia del proprio intervento. E poi imparare a misurarsi con il proprio senso di frustazione: «Come faccio a sapere quando aiuto e quando fallisco?». Anche se poi, anche al Drop in, come accade ovunque, le soddisfazioni ci sono. «Quando una persona mi dice che invece di trafficare con i telefonini scarica frutta a Porta Palazzo», «Quando mi rendo conto che, in fondo, la mia è una scelta egoistica: ciò che mi appassiona e mi incuriosisce è la realtà dell’incontro, che in posto come questo viene esaltata», come dicono gli operatori. Ma lavorare senza patti terapeutici significa davvero stabile relazioni non normative? Sì e no. Sì. Perché non si chiede alle persone l’adesione a un progetto o a uno stile di vita. No. Perché è importante sperimentare insieme relazioni diverse, offrendo opportunità, magari anche solo quella di togliersi per qualche ora dai rapporti incancreniti e dai «ciocchi» della strada. Per il resto, non ci sono né regole né patti da rispettare. Basta non farsi. Non spacciare. Non usare violenza. Solo le norme elementari della convivenza civile, per l’appunto. Il minimo, dunque. Anche per chi vive, letteralmente, ai confini della società? 21 Quinta impossibilità. Offrire semplici opportunità e lavorare per il cambiamento. Infine, è nell’improbabile intento di tenere insieme queste due opposte esigenze che si condensa il paradosso di un servizio a bassa e bassissima soglia come quello di via Pacini. Nello scegliere di accompagnare, con interventi puntuali e discreti (nel senso matematico del termine e non), le persone con i loro progetti e le loro speranze; nel perseguire testardamente l’obiettivo di migliorarne la qualità della vita senza tuttavia pretendere-chiedere-sperare un cambiamento negli stili di vita; nello scommettere sull’importanza di lavorare sui borderlands, con l’intento (solo apparentemente rinunciatario) non di affrancare le persone dalla realtà della strada, bensì di essere uno spazio aperto che con la strada e i suoi abitanti si confronta, dialoga e convive. Annotazioni La lingua creola non dice «la città» bensì «l’Incittà» [Lanvil, dal francese la ville, n.d.r.]: l’Incittà non indica una geografia urbana ben reperibile ma essenzialmente un contenuto, ovvero una sorta di progetto. E il progetto, qui, era: esistere. (Patrick Chamoiseau) Andando al Drop in, parlando con le persone che lo frequentano e con gli operatori, rivedendo gli appunti e ripensandoci, non ho potuto fare a meno di pensare a Texaco di Patrick Chamoiseau (2) ? Forse perché Texaco è una storia di conquista. La conquista di una città. Perché i suoi protagonisti assomigliano agli schiavi di oggi, gli immigrati. Con la differenza che i primi si andavano a prendere con la forza e i secondi (miracoli dell’innovazione!) vengono a frotte, spontaneamente, supplicando di lavorare. Perché l’Urbanista creolo e poeta che impara a dialogare e a confrontarsi con la realtà della bidonville e dei suoi abitanti mi pare che possa essere una buona metafora dell’operatore che sceglie di lavorare con persone che hanno sensibilità, abilità, traiettorie personali e destini comuni che chiedono innanzitutto di essere riconosciuti e valorizzati. Forse perché penso, in sostanza, che l’esperienza creola parli la lingua delle nostre società a venire. Ascoltando le ultime parole dell’anziana Dama d’improvviso ebbi un brivido: fra pochi anni più di metà dell’umanità affronterà in condizioni simili quel che lei chiama l’Incittà. (P. C.) (1) «D’improvviso la lenza si fece molle molle. Iréné masticava ingiurie quando un ricordo vecchio di dodici anni lo informò del pericolo. Subito attento attorcigliò la lenza a uno dei sedili e ingiunse a Joseph di tenersi forte. Una scossa formidabile elettrizzò il mondo. Il crine tintinnò come cristallo. Il gommone cominciò ad andare alla deriva più veloce di una goccia d’acqua su una piuma d’anatra. Joseph stupefatto frenava coi remi. Il tutto durò pochi secondi poi si fermò come aliseo che cade. Iréné ricominciò a tirar su la cosa, senza cedere, cauto, centimetro dopo centimetro. Per quattro ore non mollò un’unghia di centoventi metri di lenza. A momenti si immobilizzava e la lenza pronta a spezzarsi gli segava le palme ferree. Allora mormorava all’invisibile nemico: Sono io, sì; Iréné Stanislas, figlio di Ephiphanie di Morne l’Etoile e di Jackot mulatto bello ben fatto, maschio gozzuto... La lenza cedeva e Iréné tirava con la più rapida cautela. Punteggiava ogni nonnulla di filo guadagnato con un si sibilato nello sforzo e nell’esaltazione. Presto la lenza sbiancò annunciando gli ami. Joseph lasciò i remi pe r arpionare uno squalo chiaro, poi un secondo già soffocato e dal ventre aperto, poi un terzo che boccheggiava vigoroso, dovettero stordirlo, poi un quarto. Credo che Joseph diventò di sasso quando d’improvviso il blu si dissolse per l’apparire ancora in profondità di una massa smisurata». (P. C.) (2) Chamoiseau P., Texaco, Gallimard, Paris 1992, tr. it. Texaco, Einaudi, Torino 1994. Per informazioni: Carla Giachetto - Gruppo Abele - responsabile Drop in - via Pacini 18 10154 Torino - tel. (011) 2486221 - fax (011) 2450401. E-mail: [email protected] 22 LEZIONE 2 Minori stranieri in carcere: la scommessa di un patto per la legalità di Leopoldo Grosso Ineguaglianza e fallimento di una giustizia a “doppio binario” Negli istituti penali minorili del nord Italia, gli stranieri rappresentano una netta maggioranza sul totale dei detenuti. Molti di loro, sono recidivi nel carcere, con permanenze medie detentive di circa due mesi ogni volta. La misura a cui sono sottoposti con la restrizione è, generalmente, la custodia cautelare. La custodia in carcere è spesso conseguente al fallimento della misura cautelare in comunità, da cui i ragazzi si allontano dopo solo poche ore. Il sistema penale minorile segna un evidente empasse verso di loro: le misure alternative per chi è senza famiglia e senza riferimenti adulti attendibili, risultano impraticabili. Inoltre, sotto le spoglie di innumerevoli alias, i minori stessi appaiono difficilmente identificabili per quanto riguarda l’identità personale, la nazionalità di appartenenza e la stessa età anagrafica. La custodia cautelare in carcere si rivela l’unica misura di contenimento praticabile sul momento, benché fallimentare in prospettiva, nell’obiettivo di evitare la replicazione dei reati. Di fatto si assiste ad una vera e propria differenziazione di trattamento rispetto ai minori italiani, tanto che si configura una giustizia a doppio binario: misure alternative ed opportunità territoriali per i minori italiani, detenzione per i ragazzi stranieri. L’ineguaglianza di fatto di fronte alla legge si rivela anche inutile: il processo per i minori stranieri risulta molto spesso un rito celebrato a fantasmi, burocratico e dispendioso, poiché l’iter giudiziario ha tempi lunghi ed il minore nel frattempo, con la scadenza termini, è uscito dal carcere ed ha riguadagnato lo stato di clandestinità. Un penale totalmente separato e staccato dal sociale è oggi anacronistico per la realtà minorile, in quanto depotenzia ogni possibilità riabilitativa. E’ un involucro vuoto che rischia di alimentare contrapposizione e devianza anziché generare riparazione e reinserimento sociale. Sganciato dagli obiettivi della riparazione, dagli strumenti dell’accompagnamento relazionale, dall’offerta di opportunità in grado di modificare lo stile di vita del ragazzo, il sistema penale minorile fa un passo indietro di più di vent’anni, ritorna a essere quello che in passato è stato per i minori italiani e per i quali oggi la funzione può già definirsi residuale. La residualità del carcere minorile, come intervento estremo, non riguarda invece i minori stranieri, che, con la loro presenza massiccia, e con le loro modalità reattive, rischiano di restituire all’IPM non solo una funzione piena, ma anche modalità di gestione tradizionale, da tempo in disuso: le 23 pratiche dell’isolamento punitivo, del trasferimento in altri stabilimenti detentivi, dell’esclusione dalle attività di apprendimento e socializzazione,… Lo “zoccolo duro” dei minori stranieri recidivi: da clandestini a piccoli scippatori Sono soprattutto i minori stranieri maghrebini, in particolare nel nord-ovest d’Italia, a produrre comportamenti carcerari improntati sulla durezza, sulla sfida, sulla coesione del gruppo “contro”. La detenzione è messa in conto, tra i rischi del loro stile di vita. Viene considerata un incidente di percorso e costituisce solo una pausa forzata rispetto alla loro attività illecita; non mette in crisi né le loro scelte né la determinazione con cui perseguono il loro progetto. Ormai ai limiti della maggiore età, nell’impatto ripetuto con l’autorità giudiziaria modificano di volta in volta le loro generalità e posticipano la data di nascita. Esercitano tutta la resistenza possibile, finalizzata ad abbreviare la permanenza in carcere agendo comportamenti autodistruttivi (tagli alle braccia, scioperi della fame, ingestione di liquidi che ledono i tessuti interni,…) ed eterodistruttivi (vandalismi nelle celle, aggressioni, ribellioni di gruppo), rivolti al richiamo dell’autorità giudiziaria, per essere convocati dal giudice, nel tentativo di accorciare i tempi della scarcerazione. Talvolta negano il reato anche quando colti in flagranza, accusando le forze dell’ordine di errore, di aver teso la trappola, di persecuzione. La loro “durezza”, almeno apparente, si è forgiata in due esperienze precedenti. Sono prevalentemente piccoli spacciatori, con una veloce carriera che li ha portati a vendere prima hashish e poi eroina. Vengono considerati dall’organizzazione criminale che li arruola assai più affidabili, per l’attività di smercio al dettaglio, dei tossicodipendenti italiani. Più determinati, non avvolti dalla spirale della dipendenza, con un gran bisogno di denaro per sé e per la propria famiglia, fanno meno errori e garantiscono entrate sicure. La scelta di arruolarsi come pusher può essere precedente all’arrivo in Italia (“Pensavo di venire qui, spacciare per un anno, mettere da parte i soldi e tornare giù”), cullando ingenui sogni imprenditoriali; oppure successiva, a seguito di un periodo di emarginazione protratta quale clandestino per cui la scelta deviante rappresenta un tentativo paradossale di inclusione e di “realizzazione comunque” delle proprie speranze migratorie. Si entra in un’organizzazione, si fa parte di un gruppo, si esercita un ruolo, non si dipende più da nessuno, si hanno dei soldi. Non sono grandi guadagni. Le organizzazioni non lasciano spazi di autonomia. Oggi si è “salariati” del piccolo spaccio. La paga è di Lire 1.200.000 al mese, spese escluse. Sono le loro cupole a lucrare. Alcuni di loro, più problematici per storia personale, più sofferenti o maggiormente sbandati, non resisteranno né alla curiosità della droga prima, né al forte richiamo della sostanza dopo, e diverranno dipendenti. Allora, saranno scaricati dallo spaccio organizzato e “ripiegheranno” su attività più rischiose quali i furti e le rapine ai malcapitati. 24 Ciò che fa scuola, in Italia, è la cultura della sopravvivenza, la necessità di fare soldi, di realizzare in un modo o nell’altro il proprio progetto migratorio. C’è fretta ed il modello vincente è rappresentato dallo spaccio di sostanze stupefacenti. Si impone anche ai ragazzi più sprovveduti, consegnati dalle proprie famiglie in Marocco ad adulti che li usano in Italia nelle attività di ambulantariato di strada. Ci si socializza in fretta, in Italia, a questo modello: c’è una contaminazione veloce, nella vita di strada, tra storie diverse che rischiano di portare ad un unico terminale. Anche i ragazzi che vengono dalle campagne del Maghreb finiscono per apprendere presto le nuove modalità di adattamento, i “trucchi del mestiere”, le regole implicite ed esplicite dell’organizzazione a cui vengono affidati e le conseguenti nuove abitudini di vita. Coloro invece già in stato di emarginazione a Casablanca e nelle periferie delle grandi città del Marocco, sono addestrati e più scaltri nell’arrangiarsi e nel sopravvivere. L’”apprendistato” al porto, prima della partenza, costituisce un tirocinio lungo e “formativo”. Ciò che forgia è l’anticipazione del progetto migratorio, la sua “ruminazione” interiore, l’obiettivo ossessivo che condiziona tutto lo stile di vita. C’è chi passa tutte le notti al porto: sono gli aspiranti all’emigrazione, ragazzi e giovani tra i 15 e i 25 anni, i “boat people” del Maghreb. Le destinazioni sono più immaginarie e simboliche che reali. Non sanno bene a cosa vanno incontro. Vivono in una situazione protratta di esaltazione, in preda al sogno migratorio che annulla le distanze della geografia ed attenua i disagi quotidiani. Non si ascolta nessuno, non si dà retta a nessuno. Dopo un’attesa che può durare anni e che appare interminabile, c’è il giorno in cui va bene e partono in cinquanta. “Cosa farete se riuscirete a partire?” “Sarò salvo.” Ed in Maghreb non si muore di fame. La droga, in qualche modo c’è già, al di là delle sostanze di soccorso all’occorrenza: è la modalità con cui viene vissuta l’attesa pregnante. Nel frattempo, ci si aiuta col gruppo; nelle aggregazioni coesistono crisi di violenza e gesti di lealtà, tradimenti e solidarietà. Il gruppo aiuta a gestire il tempo indispensabile nell’attesa della seconda nascita. Il dopo, per molti di loro, è noto: clandestinità ed emarginazione, clandestinità e microdelinquenza, spaccio, consumo personale, incontro col penale e il carcere, ancora spaccio ed ancora carcere. Per qualcuno la dipendenza. La costruzione di un patto per l’inserimento nella legalità L’incontro con il penale, prima col CPA, poi con l’IPM, costituisce un tardivo momento di incontro con le istituzioni. Ciò significa che l’educativo di strada, i servizi a bassa soglia, operatori di madre lingua e mediatori culturali non sono riusciti ad intercettare prima i minori arrivati in Italia. Quando il contatto è più precoce, coi ragazzi ambulanti, con parcheggiatori e lavavetri abusivi, con coloro che ancora non hanno maturato o sperimentato a fondo una scelta delinquenziale, le istituzioni riescono a mostrare un volto 25 più amico, offrire opportunità: di percorsi di studio, di formazione e di lavoro ricorrendo all’istituto delle tutele civili. La convenzione di New York, a cui l’Italia ha aderito, prevede il diritto, per i minori, di poter restare, fino alla maggiore età, nel paese di emigrazione, anche se giunti clandestini. La difficoltà è materializzare tale diritto, produrre le necessarie risorse economiche ed umane per costruire utili percorsi di integrazione, per evitare che il ragazzo sia fagocitato dalla seduzione della criminalità e per ridurre l’insicurezza delle città. Intercettare precocemente il rischio, investire nella prevenzione, è scelta che qualifica le città più attente, che riescono a coniugare l’interessamento per lo sviluppo dei minori, indipendentemente dalla loro provenienza, con la lotta alla microcriminalità e all’arruolamento di facili e utili pedine da parte della delinquenza organizzata. Con questi ragazzi la Città deve cercare di costruire un patto, costituito da un utile e vicendevole offerta di opportunità e rispetto della legalità Se non c’è ancora carriera microdelinquenziale ed incontro con il penale, non c’è necessità in tal caso di arrivare alla definizione di un patto. Vicinanza relazionale, offerta di opportunità, la predisposizione di una tutela civile che faccia da riferimento per il percorso di integrazione, costituiscono in genere strumenti sufficienti per contrastare il rischio. La città compie un investimento sui ragazzi stranieri immigrati, esercitando un’attenzione educativa il cui beneficio sarà concretamente misurabile a distanza di qualche anno in termini di inserimento sociale pieno, di diffusione di una consapevolezza tra i giovani immigrati che è possibile la realizzazione del progetto migratorio nel rispetto della legalità, di disponibilità di manodopera qualificata sul mercato del lavoro. Quando invece si è già sperimentata l’immersione nel mondo dello spaccio, dei furti su commissione, della ricettazione o dello sfruttamento della prostituzione, allorché è già avvenuto il confronto con il penale, l’arresto in CPA o un periodo di custodia cautelare in IPM, si rende necessario un vero e proprio percorso di riconoscimento reciproco tra straniero ed istituzione giudiziaria, la rifondazione di una credibilità e la costruzione di una fiducia da parte di entrami fino alla stipulazione di un patto in cui, in cambio di ragionevoli opportunità offerte a sostegno di un reinserimento sociale nella realtà italiana si rinunci a comportamenti illegali. In questa situazione, non si tratta più di prevenire, ma di arrivare ad un accordo di reciproca convenienza, di cessazione delle ostilità, per perseguire un risultato vantaggioso per entrambe le parti. Ognuno deve rinunciare a qualcosa: la Magistratura all’applicazione del principio di autorità, quantomeno nella sua declinazione autoritaria, che richiede all’altro di adattarvisi, senza tenere conto delle difficoltà reali, e facendo ricorso alla forza per superare le resistenze (e già si è detto dell’inefficacia complessiva di tale approccio). Il minore straniero dovrà, per parte sua, rinunciare alle seduzioni dei comportamenti illegali, alle illusioni dei guadagni facili, ad uno stile di vita a cui si è abituato, spesso anche ad un ruolo sociale ed un’immagine di sé costruitasi man mano con la conduzione di attività illecite. 26 Il primo passo, come sempre avviene nella logica educativa coi minori, dev’essere compiuto dall’adulto, in questo caso dall’istituzione giudiziaria. E’ difficile venire incontro ad un ragazzo che rifiuta di farsi identificare, e dà costantemente false generalità, poiché viene a mancare il presupposto per una mediazione costruttiva: la fiducia che genera il riconoscimento. Tuttavia, in queste situazioni, di “accanimento” difensivo, in cui i ragazzi stranieri tentano disperatamente di proteggere quanto faticosamente “costruito” nel tempo (con l’accumulo del denaro per la partenza, le fatiche del viaggio e il duro impatto con la società italiana), l’acquisizione della reale identità è da considerarsi un punto di arrivo del percorso di incontro, un esito del patto che piano piano si costruisce. La fase iniziale è la più difficile: si tratta di raccogliere disponibilità, anche minime, per “sbloccare” una situazione apparentemente senza via d’uscita, con obiettivi ridotti, non risolutivi né definitivi, ma capaci di rimettere in movimento un rapporto che consenta progressivamente un investimento reciproco di una parte sull’altra. Il patto quindi non è il punto di partenza per una ridefinizione dei rapporti, ma già l’esito di un processo che ha consentito di ridurre le difese, guadagnare credibilità e riporre un prima fiducia in un rapporto che va ridefinendosi. Gli strumenti per la costruzione di un patto In ogni accordo, in ogni logica di mediazione educativa, nella negoziazione che si conduce con i minori per fare accettare e condividere un progetto od un percorso di cambiamento, sono necessari credibilità, fiducia, investimento affettivo, una relazione autentica che tenga conto del principio di realtà e del limite, ma che sappia anche venire incontro, assumersi il rischio dell’insuccesso, ed accettare una ragionevole percentuale di fallimenti. Magistrati, operatori sociali del carcere, dell’USM e dei servizi sociali territoriali concorrono tutti alla realizzazione della costruzione del patto. Al giudice toccherà la formalizzazione; egli siglerà in un’atmosfera di maggiore solennità e col peso della propria autorità le condizioni della “messa alla prova”. Ciò che è richiesto alle diverse squadre di operatori è la condivisione strategica delle linee progettuali per il reinserimento nella legalità, una congruenza di atteggiamenti e comportamenti senza la quale non si può fare molta strada, perché verrebbe a mancare la determinazione comune nel progetto che agli occhi del ragazzo significherebbe minor credibilità, minor garanzia, minor fiducia, maggiore possibilità di trarre vantaggi di corto respiro e a “effetto boomerang”, giocando sulle divisioni e con le manipolazioni. Già è difficile lavorare in squadra, ma lavorare bene tra squadre diverse lo è ancora di più. Lo strumento della formazione comune dovrebbe costituire un solido supporto per la comprensione delle linee strategico-progettuali dell’intervento, per una corretta ed efficace divisione dei compiti, per un coordinamento delle diverse azioni che ne determini e potenzi l’efficacia complessiva. A) Una comunità sperimentale per minori stranieri 27 La costruzione del patto comincia con un tempo per riflettere, per decidere. Ad oggi, tale tempo, quando c’è. non è finalizzato, ma è puro tempo di attesa, vuoto ed inutile, unicamente trascorso aspettando passivamente la scadenza termini: è il tempo della custodia cautelare in IPM. Il tentativo è di riuscire a rendere tale tempo più produttivo, utilizzando lo strumento della misura cautelare anziché della custodia (che oggi subentra al fallimento della prima, come dimostra la maggioranza dei provvedimenti detentivi per gli stranieri in IPM) ed affidando il minorenne ad una comunità per minori stranieri per la durata della misura cautelare stessa, che è mediamente di 45-60 giorni, a seconda della tipologia del reato commesso. Tale tempo in tale struttura dovrebbe consentire l’inizio di un percorso in cui il minore, sostenuto da un congruo impegno di risorse educative ed a stretto contatto con l’autorità giudiziaria, possa sperimentare l’opportunità di iniziare a costruire un inserimento sociale nella realtà italiana nel pieno rispetto della legalità. La scelta del percorso di comunità avviene in base ad un accordo tra minorenne e giudice, caratterizzato da condizioni chiare e conseguenze certe. E’ preparato dal lavoro delle assistenti sociali dell’USM e degli educatori dei Servizi Sociali del territorio nelle 96 ore massime di arresto al CPA, in cui vengono fatti percepire tutti i vantaggi dell’applicazione di tale misura rispetto alle altre soluzioni possibili. Tali vantaggi vengono successivamente valorizzati da un incontro vis-a-vis col giudice stesso per un’ulteriore rassicurazione sul significato del provvedimento che può, a sua volta, facilitare un successivo programma di messa alla prova in grado di evitare la probabile condanna. Il periodo successivo di messa alla prova può costituire l’inizio di un inserimento legale nella società italiana che può concludersi, in caso di successo, col rilascio del permesso di soggiorno. Durante il periodo della misura cautelare in comunità vengono predisposte le risorse per dare avvio ad una attività formativa e/o lavorativa esterna alla comunità. Le attività includono un dignitoso riconoscimento economico dell’impegno, anche finalizzato al creare i presupposti di una completa autonomia a percorso concluso. IL riscontro della concretizzazione delle opportunità assume indubbia importanza agli occhi del minore che conferisce maggiore credibilità al progetto. Inizialmente la comunità rappresenta un ambiente totalmente nuovo, estraneo e vissuto con diffidenza e ostilità, per le limitazioni poste alla libertà di movimento e per lo stile di vita che richiede. Per venire progressivamente a capo degli inevitabili atteggiamenti di chiusura difensiva o di sfida reiterata è necessario che nell’ambiente, nell’arredo, ma soprattutto nelle modalità del personale educativo sia assente ogni richiamo alla vita detentiva. Il minore non è obbligato ad aderire alla proposta del percorso di comunità; può recedere dalla scelta effettuata in un confronto con il giudice che gli sottoporrà le conseguenze della rinuncia alla misura cautelare in comunità. Ciò deve avvenire già al momento della scelta del percorso, con la descrizione netta delle alternative da parte del giudice. 28 S’impone successivamente, in caso di ricaduta nell’attività delinquenziale, una congruenza istituzionale rispetto alle conseguenze delle decisioni prese: sia come sostituzione di misura cautelare, sia come esiti processuali. E’ essenziale che il minore possa contare sulla certezza delle conseguenze, sia positive che negative, delle proprie scelte. La struttura residenziale si caratterizza ad esclusiva dimensione educativa. Compito degli educatori è creare un clima di fiducia e di impegno, che consente un progressivo coinvolgimento e un contestuale apprezzamento della scelta effettuata. Gli aspetti affettivi e relazionali, la qualità dei rapporti, la capacità di valorizzazione delle risorse, nonché di contenimento emotivo delle inevitabili crisi, debbono assumere priorità rispetto a norme e regolamenti, pur necessari per la convivenza interna. Per questo motivo, la comunità, sperimentale per soli maschi, deve poter operare con un numero ridotto di minori, fino ad un massimo di otto, consentendo dinamiche relazionali più vicine al modello familiare che non all’istituzione collegiale. La comunità è intesa soprattutto come spazio abitativo e come casa con i necessari locali per la vita in comune e per le attività ricreative anche all’aria aperta. Le attività formative, di apprendistato, corsi di lingue, possibilità di coltivare interessi personali si collocano soprattutto all’esterno in interazione con le risorse della città, in continuità e in progressione tra il periodo più protetto della misura cautelare e il periodo successivo. Sta al giudice, su proposta degli educatori, autorizzare, nelle differenti fasi dell’intervento, le attività esterne accessibili durante la misura cautelare in comunità. La comunità potrà sviluppare essa stessa iniziative al suo interno, con il contributo di disponibilità e competenze operanti nel territorio, valorizzando il protagonismo dei minori. A seconda delle situazioni individuali e soprattutto in una fase iniziale, i ragazzi vengono accompagnati nelle attività esterne, al fine di evitare le possibili interferenze con l’ambiente malavitoso di riferimento e disincentivare le tentazioni di allontanamento dovute a ricorrenti e repentini momenti di sconforto che possono portare il minore ad abbandonare il progetto. E’ necessario che il personale di riferimento in comunità sia costituito, al 50% da operatori etnici, in compresenza con educatori italiani. Per i ragazzi che oggi approdano all’IPM, spesso già recidivi, si ritiene essenziale il duplice riferimento. Entrambe le componenti agiscono a sostegno delle possibili dinamiche identificatorie, sia in riferimento alle radici culturali, alle nome interiorizzate e ai legami parentali col paese d’origine, sia rispetto alle aspettative nutrite nei confronti del mondo occidentale, che possono alimentare e spingere non verso una integrazione, ma ad una contrapposizione di modelli. Per consentire un’indispensabile individualizzazione dei rapporti personali, lo staff educativo non può essere in numero inferiore a quello dei ragazzi, con l’integrazione del volontariato qualificato, sia italiano che etnico a supporto delle varie iniziative che la comunità può intraprendere in particolare per il tempo libero. 29 La comunità si avvale di uno stretto raccordo tra il lavoro con il singolo e il lavoro con il gruppo, in una sapiente alternanza tra attività interne e attività esterne. L’individualizzazione del programma esterno che viene realizzato nell’ambito territoriale per ciascun minore è sostenuto da un lavoro di elaborazione personale all’interno della comunità. La riflessione è facilitata dal confronto tra pari che si misurano sulle difficoltà comuni incontrate nei diversi percorsi esterni. Insieme si conduce un lavoro di gruppo, ma al tempo stesso, si è anche gruppo di lavoro allorché, collettivamente, vengono autogestite molte funzioni della vita di comunità, dalla preparazione dei pasti alla pulizia dei locali alla lavanderia-stireria. L’accompagnamento educativo intensivo costituisce il principale strumento di contenimento e di controllo preventivo rispetto al rischio di abbandono della struttura. Altri accorgimenti possono contribuire a disincentivare l’allontanamento dalla comunità: la localizzazione della stessa, la tipologia dell’edificio, i vetri antisfondamento alle finestre, il controllo dell’ingresso, una qualche forma di controllo perimetrale, l’affiancamento nelle attività esterne, il rafforzamento delle presenze notturne. Tutto ciò dovrebbe rendere più disagevole l’uscita non autorizzata, tesa a eludere il confronto con gli operatori e l’autorità giudiziaria, e disincentivare tentativi di contatto da parte dell’ambiente esterno non desiderato. La comunità non è che l’avvio e l’inizio di un percorso. E’ forse il momento più delicato ed a rischio di fallimento, in quanto propone un impatto con un ambiente totalmente rivoluzionato rispetto al precedente in cui sono state modellate abitudini e stili di vita. Come momento maggiormente contenitivo non può superare il tempo della misura cautelare, dando successivamente luogo ad un proseguimento del percorso. B) Il proseguimento del percorso: strumenti giudiziari e sociali Il proseguimento del percorso avviene in strutture ancora guidate ma più agili e snelle della comunità, in grado di lasciare maggior spazio alle libertà, all’autonomia ed all’iniziativa del minore che, sperimentandosi in una nuova modalità di socializzazione personale nella legalità, deve poter condurre esperienze in proprio sul territorio, non solo lavorative e non sempre controllate. Il percorso prosegue quindi con un accompagnamento più leggero anche se debitamente sostenuto da un riferimento educativo e dalla puntualità delle verifiche. La garanzia di dare continuità al progetto iniziato con la misura cautelare nella comunità sperimentale e di rispettare il patto da parte delle Istituzioni significa che l’amministrazione locale deve farsi carico, dopo la cessazione della custodia cautelare, della disponibilità di posti in alloggi o strutture intermedie, quali luoghi di convivenza guidata da personale educativo, come anche del sostegno all’integrazione sociale e lavorativa (borse lavoro e non solo). In assenza, nell’insufficienza e nel mancato raccordo temporale nell’accesso a tali risorse, il percorso, pur iniziato con successo nella comunità 30 sperimentale, è destinato al fallimento. L’adolescente straniero vi leggerà il mancato rispetto del patto da parte dell’istituzione e non sarà in grado di tollerare il venire meno delle promesse né tantomeno comprenderà la logica delle lungaggini burocratiche ed i tempi delle collaborazioni interistituzionali. Allo stesso modo si rischia di andare incontro a fallimenti se l’unica risorsa attivata e disponibile, a seguito del periodo in misura cautelare, fosse un’altra comunità residenziale. Per evitare questo tipo di inciampi sui quali rischiano di naufragare tutti gli sforzi condotti, si rende necessaria una programmazione delle risorse territoriali contestuali al numero di inserimenti annui nella comunità sperimentale per la misura cautelare: otto minori ogni due mesi significa 48 ragazzi da gestire, per almeno un anno, sia sotto il profilo abitativo, lavorativo, che del necessario supporto educativo, prima che il progetto possa offrire riscontri sul piano del raggiungimento dell’autosufficienza e del rispetto della legalità. Per quanto riguarda gli strumenti giuridici, oltre alla misura cautelare, che ad oggi costituisce per i minori stranieri di prima immigrazione l’unico momento di contatto prolungato che consente un accompagnamento educativo e l’unica occasione per tentare di costruire un percorso di emersione nella legalità, un successivo istituto da utilizzare più ampiamente, anche per i minori stranieri è la “messa alla prova”. In genere, il minorenne straniero arrestato e posto in custodia cautelare esce in scadenza termini senza più comparire al processo che avviene in contumacia e si conclude con una condanna inefficace, vanificando qualsiasi opportunità di reinserimento sociale. Risulta pertanto indispensabile un raccordo tra tempi processuali e percorsi attuabili a seguito della misura cautelare nella comunità sperimentale. A tale scopo, la predisposizione di progetti di messa alla prova consente di inserire pienamente nel procedimento penale il patto proposto al minore, dando così continuità e rendendo utile ai fini del processo la misura cautelare. Per stare nei tempi brevi della misura cautelare, la messa alla prova dovrebbe essere disposta all’udienza preliminare, che andrebbe anticipata rispetto alla scadenza termini della misura cautelare. Ciò è possibile per le scarsissime esigenze probatorie che caratterizzano i procedimenti penali che traggono origine, nella grande maggioranza dei minori stranieri, da arresti in flagranza di reato. L’ostacolo a questa soluzione, per garantire la continuità del percorso educativo è rappresentato dalla eventualità che il minore neghi la sua responsabilità rispetto al reato, il che comporterebbe l’impossibilità di giungere al dibattimento prima della scadenza termini della misura cautelare. L’altra via percorribile è offerta dalla richiesta di giudizio immediato per i recidivi. Esso potrebbe costituire la seconda modalità con cui giungere, in via dibattimentale, all’attuazione di un percorso di messa alla prova, all’unica condizione che il minore accetti. Il vantaggio di tale soluzione è che si giunge, in tempi brevi, a dare al minore una risposta che non si caratterizza per l’assenza totale di 31 contenuto, come avviene nel corso di pena detentiva condizionalmente sospesa o di concessione del perdono giudiziale. Un terzo strumento giuridico indispensabile per la realizzazione del patto è il rilascio del permesso di soggiorno. La condanna penale, contenuta nei limiti del periodo già trascorso in custodia cautelare (oppure in misura cautelare in comunità), può consentire la concessione di un permesso di soggiorno per ragioni di protezione sociale ai sensi dell’art.18 comma VI, T. U. sull’immigrazione. Le proposte formulate durante la misura cautelare, che costituiscono il patto che si vuole realizzare col minore, potrebbero opportunamente costituire la “prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale” ai sensi dell’art.18, comma VI. Questo percorso appare molto utile perché consente, ai sensi dell’art.18, comma V, il mantenimento del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, e addirittura la sua concessione anche da maggiorenni, purché il reato sia stato commesso da minorenne. Infine, il permesso di soggiorno ai sensi dell’art.18 può trasformarsi in permesso di soggiorno per ragioni di studio o lavoro. Conclusioni La città di Torino deve confrontarsi oggi con circa 100.200 minori stranieri allo sbando, già noti all’autorità giudiziaria, con i quali le risposte sino ad oggi attuate sono risultate inefficaci. Gli strumenti utilizzati sono stati anonimi e burocratici: non hanno consentito né riconoscimento reciproco, né dialogo. Mancando di una logica progettuale, le varie risposte, istituzionali e penali sono inficiate da frammentazione e disarticolazione, che non solo non consentono di produrre efficacia alcuna, ma non vengono nemmeno capite. 32 Il rimpatrio dei minori stranieri di Leopoldo Grosso Sotto il profilo educativo e della promozione del minore, il rimpatrio può costituire una reale opportunità per il minore, adolescente o preadolescente, solo ad alcune condizioni, precise e verificate: * Allorché vengano individuate nel paese d’origine, e non solo come titolari di doveri e responsabilità giuridiche, ma come portatori di reali capacità educativa, coloro che si possono occupare del minore in oggetto. La verifica di tali capacità, allo stato attuale, è molto difficile. Generalmente il minore straniero che giunge in Italia come clandestino, viene affidato a parenti e conoscenti, talvolta “affidato” a connazionali all’insaputa del minore stesso, portatore comunque di un progetto immigratorio “indiretto”, in modo da badare economicamente a se stesso, o che la “famiglia” possa contare su alcune sue rimesse. È già capitato che, dopo il rimpatrio, lo stesso minore venisse di nuovo introdotto clandestinamente in Italia o, in vece sua, un fratello o un cugino. * Allorché, insieme alle reali capacità educative delle persone a cui viene affidato, vengono individuate le ipotesi progettuali per il suo reinserimento nel paese d’origine: scolarizzazione, formazione professionale, tirocinio pre-lavorativo… La definizione del progetto, rispetto al quale si impegnano le persone a cui viene affidato il minore, che a loro volta vengono supportate con le risorse economiche necessarie per realizzarlo, deve prevedere l’adesione volontaria e la partecipazione attiva da parte del minore stesso. # Un rimpatrio mirato, per costituire un risorsa per il minore e perché abbia successo, deve quindi ottemperare a condizioni: - l’individuazione di responsabilità educative reali e non solo formali nel paese d’origine; - la definizione di un progetto di reinserimento; - la disponibilità a sostenerlo economicamente nel breve-medio periodo; - l’adesione volontaria e la condivisione del progetto di rimpatrio da parte del minore; - la possibilità di verifica del percorso nel paese d’origine. # L’esperienza, benché frammentaria ed “impressionistica”, condotta fino ad oggi ci dimostra che, in mancanza di tali condizioni, il rimpatrio non è strumento utile alla promozione del minore, ma tende invece: - a ripristinare le condizioni di una situazione di sfruttamento e/o di marginalità preesistente; - ad essere solo una tappa per un nuovo rientro clandestino in Italia o altrove in Europa; 33 - a creare “addizionali” problemi di reinserimento nel proprio paese dopo un periodo significativo di “occidentalizzazione” e di conseguente interiorizzazione del progetto immigratorio. # In mancanza, oggi, di una verifica dell’esito dei progetti di rimpatrio già effettuati sarebbe opportuno creare le condizioni per un’adeguata sperimentazione di tale strumento. L’ambito della sperimentazione dovrebbe collocarsi all’interno di un accordo con le autorità locali che si occupano di minori sotto il profilo educativo, con l’aiuto di ONG nei paesi di rimpatrio che potrebbero monitorare e sostenere da vicino, anche economicamente, tali progetti, nonché condurre una verifica degli esiti nel tempo. # Il rimpatrio, a precise condizioni, può quindi costituire una tra le opportunità possibili per il minore in Italia, clandestino e reo. Il rimpatrio non costituisce invece opportunità, bensì danno allorché: - non è “mirato”, ma diventa misura giuridico amministrativa generalizzata, pur nell’ambito di accordi internazionali; - è mirato, ma non è affiancato da risorse umane ed economiche in grado di garantire la riuscita del progetto, nonché la sua verifica; - viene vissuto dal minore come una modalità punitiva per i propri atti devianti e per il proprio stato di clandestinità. Allegato 1: Le scorciatoie della repressione di Paolo Vercellone* Si parla ormai ufficialmente in Italia di abbassare a dodici anni la soglia dell’età punibile. Il ministro di Giustizia pare abbia dichiarato formalmente che è ora di finirla con una generalizzata forma di indulgenza verso i ragazzi delinquenti: la formula potrebbe essere “pietà l’è morta, facciamo anche noi tanti prigionieri”, ispirata com’è al modello d’Oltreoceano della “tolleranza zero”. È mia ferma opinione che questo modello deve essere rifiutato. Intanto perché è contrario a tutti gli strumenti internazionali fatti propri dall’Italia (la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, le cosiddette Regole minime di Pechino ONU per l’amministrazione della giustizia minorile del 1985, la raccomandazione 20/87 del Consiglio di Europa sulle risposte sociali alla delinquenza minorile) che coincidono nell’assegnare al sistema penale minorile lo scopo determinante della tutela del minore, nel ridurre al massimo la privazione della libertà individuale, nell’attribuire ai giudici la massima flessibilità nell’applicazione delle misure. Ma soprattutto per semplici ragioni di buon senso. Occorre partire da un postulato che certamente è condiviso dalla maggior parte dei cittadini, che cioè il diritto penale, nei confronti di tutti, ma soprattutto dei ragazzi, non deve essere uno strumento di vendetta. Il diritto penale come vendetta serve soltanto a dare il via ad una spirale di odio e di violenza, soprattutto quando, come è il caso nelle nostre società, ha come destinatari i membri di piccole o grandi minoranze, sociali o etniche. Conseguenze non previste Oggi, in un mondo con ben poche ideologie, sembra più logico parlare del diritto penale come uno strumento per evitare o ridurre le condotte che le nostre società hanno stabilito essere dannose e pericolose, definendole legislativamente come reati. Uno strumento, uno dei tanti a disposizione. Si tratta di vedere se ancora serve il diritto penale ora sancito per i minorenni. Vanno fatte alcune premesse. Per lo scopo di ridurre la criminalità minorile è minimo l’effetto di una “risposta giudiziaria” più dura. I picchi statistici sono in connessione di regola con grandi mutamenti sociali: soprattutto le grandi ondate migratorie. Decenni fa vi fu quella dal sud contadino alle città del nord. Ma ora non v’è più traccia di una rilevante criminalità minorile da immigrazione interna, 34 qualunque sia stata la posizione che allora assunsero i diversi Tribunali per i minorenni: semplicemente le famiglie immigrate e i loro figli si sono sistemate, l’opera di assistenza e l’aumento di una generalizzata prosperità economica hanno risolto i loro problemi. Adesso si è di fronte a quella di stranieri provenienti da nazioni povere e disperate: una gran parte se non la maggiore dei ragazzi arrestati sono appunto stranieri. È un problema grave ma che non può essere risolto dai giudici per i minorenni in Italia: riguarda tutto il mondo ricco, riguarda adulti e giovani, si rivela ora come un aspetto di un conflitto durissimo. Ogni ragazzo, quando più o meno lucidamente decide di commettere un reato, raramente mette in conto la possibilità di essere scoperto e poi punito. Pensa – come ognuno di noi ha fatto, basta ricordarsi com’eravamo da adolescenti – che le cose “brutte” come la morte e la prigione possono capitare soltanto agli altri. Il problema non riguarda però le “sciocchezze” che tanti ragazzi fanno almeno una volta nella vita, i cosiddetti “delitti di Topolino”, i Mickey Mouse crimes, per i quali è più che sufficiente il sistema attuale. Riguarda i colpevoli di gravissimi reati – esemplare l’omicidio – o a recidiva reiterata e soprattutto ragazzi di non facile recupero, o perché già introdotti nelle mafie o perché clandestini stranieri più o meno sfruttati da adulti. Per questi tipi di ragazzi e per questi tipi di reati non c’è bisogno di cambiare le leggi: la discrezionalità data dalla legge ai giudici per i minorenni consente loro di punire duramente con lunghe condanne alla reclusione. Tentati dalla durezza Bisogna invece sapere se è davvero meglio scegliere la via della punizione dura; e qui occorre fermarsi e ragionare, lasciando da parte quello che qualcuno chiama “buonismo” e riflettendo soltanto sulla utilità o meno di percorrere l’una o l’altra strada. Nei confronti dei delitti più gravi, e penso ai casi recentissimi di omicidi sconcertanti, apparentemente senza senso, commessi da ragazzi ed anche ragazze apparentemente non a rischio, il fatto che sia prevista e concretamente applicata una pena severa non serve a prevenire la commissione del reato. L’adolescente non è calcolatore a tal punto da determinarsi o no ad un delitto contro la persona in funzione della maggiore o minore durata della reclusione prevista da una norma che magari lui non conosce; né in funzione della notorietà di una “pena esemplare” irrogata nel passato per un reato analogo. Infliggere per questi casi lunghi anni di reclusione, come forse sarà inevitabile, serve soltanto a soddisfare li bisogno di vendetta, mascherato da ansia securitaria; ad eliminare dal nostro immaginario dei mostri che non devono somigliare ai nostri figli, metterli “dentro”, cioè fuori della nostra vita, e buttar via la chiave. Un giudice impegnato in uno di questi casi mi diceva qualche giorno fa: «Al tavolo dei decidenti oltre a noi è presente un fantasma, non l’opinione pubblica, ma il titolo del giornale dell’indomani». La prevenzione più efficace, se ce n’è una, sta in altri strumenti, in un maggior dialogo coi figli, nostri e di altri, ed anche in un atteggiamento più attento da parte dei mezzi di comunicazione di massa, inclini a enfatizzare i singoli episodi col risultato di stimolare condotte analoghe creando una aureola di attrazione sui protagonisti di episodi di violenza. Nei confronti di tutti i ragazzi, di qualunque categoria, la domanda non è punire o non punire. La commissione di un reato richiede sempre una risposta, nell’interesse dello stesso ragazzo, che deve essere messo in condizione di capire e di crescere, divenendo responsabile. Si tratta di individuare la punizione adatta, o se vogliamo, la punizione utile. Ora, sicuramente, punizione utile non è la privazione totale della libertà: lo sanno tutti che la prigione è scuola di delinquenza. Se davvero si vuole fare in modo che la punizione “serva”, cioè impedisca almeno la reiterazione dei reati, non si deve porre il ragazzo in condizione di passività, com’è appunto il bivaccare per più o meno tempo in prigione. Occorre una punizione che contenga un obbligo di impegnarsi, di essere attivi nel processo: si esemplifica con il procedimento di mediazione (è più faticoso incontrarsi col poliziotto cui si è fatta resistenza e comprendere le sue ragioni che farsi tre mesi di prigione rafforzando l’odio verso gli “sbirri”); con la probation, che richiede un impegno lungo, specialmente afflittivo se occorre permanere in comunità, rispettandone le regole, lavorando, andando a scuola, facendo tirocinio di libertà. Se proprio, per i casi più gravi, pare necessaria la risposta di detenzione, è serio non illudersi sulla funzione rieducativa di una reclusione di lunga durata. Maturità imprigionata Il ragazzo spesso accetta la punizione: sa di avere fatto male, ammette che a male si contrapponga male. Ma quando la punizione si prolunga nel tempo, più passa il tempo meno egli si riconosce in quel soggetto che meritava pena. Non senza ragione: a quell’età si cambia ogni giorno, si cresce fisicamente e psichicamente a volte con sbalorditive accelerazioni. Si aggiunga che i mutamenti più decisivi avvengono in occasione di eventi specialmente importanti: il primo amore, la prima morte di una persona cara, una bocciatura scolastica e certo la commissione stessa del delitto, il processo, la detenzione, sono esperienze tali da cambiare radicalmente la personalità del soggetto. Il non riconoscersi in colui che fu “giustamente” punito determina inevitabilmente la sensazione di essere, ora, ancora ingiustamente punito. Di qui la parabola tipica del comportamento del giovanissimo detenuto: ad una relativa accettazione subentrano, dopo un certo tempo, o una profonda depressione (frequenti i tentativi di suicidio) o una violentissima ribellione contro il meccanismo che lo trattiene lì dentro, 35 spesso con alternanza delle due reazioni. Nell’uno e nell’altro caso, quel ragazzo, quando uscirà, sarà diventato un uomo pericoloso. Anche nei confronti dei ragazzi immigrati è necessario insistere sul fatto che il diritto penale è certo uno strumento, ma non è il solo. Nessuno conosce la ricetta miracolosa, ma certamente non è quella di mettere in prigione un terzo di tutti i ragazzi e bambini immigrati. Anche qui non è il caso di richiamarsi a principi umanitari che pure dovrebbero essere ricordati in una nazione che fu di poveri che emigravano e da poco è diventata un paese che ha bisogno di poveri stranieri, né a ricordare che un bambino o un adolescente soli in un paese così diverso dal proprio hanno bisogno più di amici che di poliziotti. È sufficiente riflettere sul semplice rapporto costi-benefici: che senso ha creare delle scuole organizzate di criminalità per stranieri come sono inevitabilmente delle prigioni in cui i ragazzi tutto imparano salvo che il rispetto delle regole? La politica di condanne penali fin qui seguita non ha ottenuto altro effetto se non quello di aumentare il ricorso degli immigrati alla totale clandestinità, che è la loro migliore arma di difesa. A questo si aggiunga che tra breve si dovrà fare i conti con una seconda generazione di immigrati: bisogna evitare, dunque, che questa cresca nell’odio verso una nazione che ai loro genitori e ai loro fratelli maggiori ha riservato solo rigetto e prigione. Ci sono già abbastanza sospetti e odi reciproci tra italiani e stranieri (sia a Novi Ligure che a Modena i presunti colpevoli italiani avevano denunciato i soliti slavi), non aumentiamoli con una caccia al minorenne straniero. Allevati dalle mafie Infine c’e un fenomeno tutto italiano: i ragazzi della mafia. Non pare che l’accanimento penale su questi ragazzi porti a risultati degni di nota. Nelle regioni italiane dove la criminalità organizzata domina, i tribunali per i minorenni hanno quasi ovunque adottato la linea dura, giustificata dal fatto che là sono tanti i ragazzini che più o meno direttamente organizzati nelle varie mafie commettono delitti anche assai gravi, anche omicidi. Non si può permettere – dicono giudici e criminologi – che questi minorenni godano di impunità o quasi. Ma, stando a quello che si sa, il fenomeno non si riduce, anzi probabilmente aumenta. D’altronde si tratta di un fenomeno noto ai professionisti della materia: l’intervento giudiziario e quindi l’atteggiamento diffuso dei giudici per i minorenni non ha peso determinante nell’aumento o diminuzione della criminalità minorile, fino a quando la cultura criminale resterà dominante e di fatto vincente nel mondo degli adulti. Il fatto è che questa cultura criminale persiste ed anzi si aggrava e si estende, dando ai ragazzi la sensazione – se non addirittura la certezza – che è più conveniente stare da quella parte che non da quella del paese legale: le mafie pagano bene, danno sicurezza, status sociale, puniscono duramente i disertori. È comprensibile l’atteggiamento dei giudici per i minorenni di quelle regioni che debbono pur impostare una controind icazione facendo capire ai ragazzini che non sempre va tutto bene, che a stare con le mafie si può anche finire in prigione. È però necessario riprendere due strade che al momento sembrano abbandonate. Colpire e integrare La prima strada è quella di un’azione intelligente di repressione dura della delinquenza mafiosa. Non si può venire a patti con la mafia: uccidete di meno e fate pure i vostri affari. Solo colpendo i capi e i sottocapi con dure condanne, solo confiscando i loro beni, si può contribuire a ridurre il fascino di quei personaggi nei confronti dei ragazzini: ogni arresto di latitante famoso toglie un megafono all’attività promozionale delle mafie. La seconda strada è quella di una politica del Mezzogiorno organizzata e coordinata per dimostrare che è possibile bonificare la palude dalla quale nasce la malaria delle mafie. La richiesta di punire anche i bambini arruolati nella mafia nasce dalla mancanza, in quei territori, di risorse di tipo educativo, comunità, laboratori, centri di incontro: quelle risorse che in altri regioni, dove da decenni si fa prevenzione seria, hanno indotto – con successo – a rendere davvero residuale la privazione di libertà, così come esigono le regole di Pechino. Non è uno sforzo impossibile, dovrebbe essere una delle “grandi opere”, ben più utile del progettato ponte sullo Stretto di Messina. Il ministro di Giustizia e i suoi colleghi farebbero bene a pensare a questi obbiettivi, piuttosto che a quello di processare i dodicenni e di infliggere pene dure ai ragazzi, specie se non sono nostri figli. 36 *già presidente dell’Associazione internazionale dei giudici per la famiglia e per minorenni, docente di Diritto minorile all’Università di Torino. (pubblicato in Narcomafie novembre 2001) Allegato 2: Ragazzi di malavita di Franco Occhiogrosso Negli ultimi quindici anni la devianza minorile in Italia ha subito profonde trasformazioni. Sotto il profilo quantitativo, il numero dei ragazzi denunciati penalmente è più che raddoppiato; sotto il profilo qualitativo, ai cosiddetti “ragazzi della mafia” (cioè i minorenni coinvolti al Sud nella criminalità organizzata o che comunque ne hanno acquisito la subcultura) si contrappone nelle regioni centro-settentrionali la consistente e talora massiccia presenza di ragazzi stranieri che commettono reati. A questa non facile situazione si è di recente aggiunta quella costituita dall’emergere di una devianza con manifestazioni inedite, che vanno dal bullismo nelle scuole ad altre manifestazioni di una violenza tanto esasperata quanto immotivata. Essa presenta caratteristiche peculiari, differenti da quelle prospettate in precedenza: perciò, per distinguerla da quella tradizionale e quantitativamente molto più rilevante, viene correntemente definita con termini non tecnici quali “malessere del benessere” oppure “teppismo per noia”. Il reato come sintomo Un significativo aiuto all’analisi del fenomeno viene fornito dall’esame dei dati statistici. Tali dati, messi a disposizione dall’ufficio centrale per la Giustizia minorile del ministero della Giustizia, offrono indicazioni sulle denunce subite dai minorenni dal 1990 al 1998 e sugli arresti dal 1991 al 1999 e svolgono poi un’analisi più puntuale riguardo alle denunce del 1998 ed agli arresti del 1999. Bisogna però anche precisare che i dati statistici non consentono da soli di fare piena luce sull’andamento della devianza, ma vanno integrati da osservazioni e commenti che solo l’esperienza può consentire. Peraltro, prima di entrare nel merito dell’argomento, va detto che fino a qualche tempo fa la cultura giuridica minorile – traendo spunto dalla tradizionale ripartizione di competenze prevista dalla legge per l’intervento del giudice minorile – operava una distinzione tra devianza minorile e delinquenza minorile, in base alla quale la devianza riguardava i comportamenti irregolari che non comportano la consumazione di reati (come le fughe da casa, i tentativi di suicidio, l’assunzione di stupefacenti etc.), mentre la delinquenza si riferiva alle condotte che configurano reati. Negli ultimi anni tale distinzione è stata ritenuta superata e si è utilizzato il termine devianza per designare il fenomeno nel suo complesso. Si è inteso in tal modo realizzare un duplice obbiettivo. In primo luogo porre in evidenza che nelle condotte delinquenziali minorili, in quanto sintomo di un profondo disadattamento personale, è centrale non il reato, ma il soggetto e la sua condotta di vita. La più recente elaborazione dottrinaria minorile in linea con i più significativi documenti internazionali e con la giurisprudenza della Corte Costituzionale esige ormai una tale impostazione, come del resto dimostra la sostituzione del termine delinquenza con devianza. Va peraltro precisato che quando si parla di devianza minorile si fa quasi esclusivo riferimento ai comportamenti che costituiscono reato, sia perché sono più agevolmente disponibili e più ampiamente studiati, sia perché consentono anche di graduare l’andamento del fenomeno sulla base della diversa gravità dei reati. In secondo luogo, l’espressione devianza minorile intende porre in luce anche un secondo aspetto: quello per cui, a differenza di quanto accade nella delinquenza adulta, sia il minorenne autore del reato che la vittima del reato sono entrambi vittime, perché anche il reo minorenne è vittima della sua storia di vita, di una condizione minorile violentata, negletta e in ogni caso privata dei suoi diritti. Certo questa analisi non può legittimare il principio “tout comprendre, c’est tout pardonner”, né aprire la porta al permissivismo. Ma l’ottica secondo cui il problema della devianza deve essere affrontato non può che essere questa, se non si vuole innescare un processo a catena al termine del quale di “giustizia minorile” rimane assai poco. La svolta del 1986 I dati prospettati devono essere considerati con la necessaria cautela: da un lato è noto che esiste un numero oscuro e non quantificabile di reati che non vengono neppure denunziati, soprattutto quando gli autori sono dei ragazzini; dall’altro è altrettanto noto che per molti reati l’autore resta ignoto (ed una fetta di questi ignoti è costituita da minorenni). Malgrado ciò è possibile cogliere alcune chiare linee di tendenza. Le denunce degli anni ’91-’98 hanno un andamento sufficientemente stabile, essendo attestate costantemente su un numero oscillante tra le 41.000 e le 46.000 annue (vedi tabella 1 pag. 5 ndr.). Va ricordato però che nei cinque anni precedenti, tra il 1986 e il 1991, si è registrata una massiccia lievitazione del fenomeno e si è passati dai 19.728 denunziati del 1986 ai 44.977 del 1991, con una consistente crescita in ciascuno degli anni intermedi. Allargando poi la prospettiva e risalendo negli anni è agevole cogliere che in passato l’andamento della devianza non è stato affatto stabile: c’è stata dapprima una costante 37 diminuzione delle denunce (tanto che dai 33.000 ragazzi denunciati nel 1970 si era scesi sino ai 19.728 del 1986) poi una rapida risalita tra 1986 e 1991, e infine l’attuale livello, costante dall’inizio degli anni Novanta, di 40-45mila denunciati all’anno. In questi stessi anni la devianza femminile, in passato quasi inesistente, ha cominciato ad assumere un qualche rilievo, soprattutto nell’ambito delle minorenni straniere. Ciò è confermato anche dalle tabelle relative ai giovani arrestati (vedi tabelle 2A-2B pag. 5 ndr.), da cui si desume che il numero di ragazze italiane entrate negli ultimi anni in un C.P.A (centro di prima accoglienza, ossia piccola comunità collocata in una sede distinta dagli istituti penitenziari) ed in I.P.M. (istituto penale minorile) è esiguo, mentre quello delle straniere è molto più consistente. La devianza delle minorenni (esclusa quella delle nomadi zingare) ha per lo più carattere bagatellare e riguarda soprattutto furti in grandi magazzini o coinvolgimenti in conflitti familiari oppure in questioni di vicinato che danno luogo a querele per ingiurie e per diffamazione o a percosse e lesioni personali di scarsa entità. Se una minorenne è coinvolta in reati più gravi è quasi sempre perché legata sentimentalmente all’autore o a uno degli autori del reato. Del tutto diversi sono invece i casi riconducibili alla nuova forma di devianza designata con l’espressione “malessere del benessere”, nella quale la presenza delle ragazze è abbastanza significativ a. Indigena al sud straniera al nord Un altro dato evidente è la distribuzione non omogenea della devianza minorile: vi sono alcune regioni nelle quali il problema è rimasto del tutto irrilevante o quantomeno non ha superato limiti fisiologici (vedi tabella 3 ndr.). Le statistiche confermano anche che la devianza dei ragazzi stranieri si manifesta perlopiù nelle regioni centro-settentrionali, dove costituisce circa il 40% del totale delle denunce: nel 1998 in Toscana essa è stata addirittura prevalente ris petto a quella indigena (1571 denunce rispetto alle 1223 degli italiani, così come era avvenuto anche nel 1997). Il fenomeno si manifesta invece in misura molto modesta nell’Italia meridionale, in Sicilia e in Sardegna, dove non supera il 6% del totale. Tendono a diminuire le denunce di furto (dalle 22.259 del 1990 alle 15.559 nel 1998) e ad aumentare quelle relative agli altri reati. Un segno preoccupante è costituito dagli omicidi (consumati o tentati), che nell’ultimo decennio non sono mai stati inferiori al centinaio per anno, con un picco di 150 nel 1992. La devianza degli stranieri si esprime soprattutto nei reati di furto e di spaccio di sostanze stupefacenti. I reati contro la persona sono invece appannaggio quasi esclusivo della devianza italiana, a cui nel 1998 va attribuito circa il 94% dei casi. Indubbiamente la devianza minorile caratterizzata dalla consumazione di reati più gravi (estorsioni, porto illegale d’armi, rapine aggravate, omicidi consumati o tentati, associazione per delinquere) è quella meridionale. Ma è la sostanziale stabilità del fenomeno – attestatosi in questi ultimi dieci anni su livelli molto alti – ad essere preoccupante: significa che ci troviamo di fronte a una subcultura capace, in presenza di determinate condizioni economiche, sociali e culturali, di influenzare e di avviare all’illegalità ogni anno un numero più o meno simile di minorenni. *Presidente del Tribunale dei minori di Bari (pubblicato in Narcomafie giugno 2001) ALLEGATO 3: DALLA SCUOLA IN CARCERE AL CARCERE-SCUOLA Esperimenti al «San Michele» di Alessandria Pietro Buffa Un carcere-scuola vive sempre una profonda frattura quando prevale la logica dell’istituzione totale sulla logica formativa. Ma sostenere la centralità dell’attività didattica, affinché intorno a questa si definiscano ritmi e strutture della vita detentiva, è possibile solo se i vari operatori della casa di reclusione (docenti esterni, educatori penitenziari, polizia penitenziaria, magistrato di sorveglianza) partecipano attivamente e condividono il progetto educativo. 38 La Casa di reclusione «San Michele» di Alessandria è spesso denominata «carcerescuola», in realtà tale dicitura non è formalmente prevista da nessuna norma specifica. Rimane il fatto che la presenza da oltre quarant’anni di un corso scolastico quinquennale per la qualifica di geometra, associato ad alcuni corsi professionali, ha caratterizzato e caratterizza questo istituto di reclusione. Ogni anno decine di detenuti in Italia rispondono al bando nazionale per poter frequentare i corsi di Alessandria. Quando venni trasferito in questa sede, tra le varie sensazioni ed emozioni che accompagnano un trasferimento, sicuramente aleggiava la consapevolezza di andare a dirigere un istituto che si proponeva, nella sua storia, come «particolare». Ero affascinato dall’idea di poter lavorare in una situazione che consentisse la realizzazione di una concreta attività «trattamentale». Il presente contributo offre le riflessioni nate dalle personali percezioni in due anni di lavoro in questo contesto. È buona norma, nella vita in genere e in particolare nell’assumere un nuovo incarico, cercare di conoscere il nuovo contesto, comprenderlo prima di prendere qualsiasi decisione. Ecco perché alcune settimane trascorsero nel cercare di approfondire cosa significasse per l’istituto avere una scuola al proprio interno. Fui sorpreso nel constatare come tale presenza fosse meno pregnante di quello che mi aspettavo. La scuola non caratterizzava affatto l’istituto o, meglio, lo caratterizzava per le dinamiche che scatenava tra le varie componenti. Ritengo possibile tipizzare sinteticamente queste dinamiche partendo dall’individuazione dei gruppi maggiormente coinvolti. Ovviamente la sintesi sacrifica tutte le sfumature che la quotidianità propone e giunge a indicazioni di prevalenza. Partirei dal gruppo dei detenuti frequentanti i corsi. La prima istanza partita da questi era indirizzata alla direzione affinché tutelasse quello che essi ritenevano un diritto sacrosanto, ovvero, la fruizione di permessi premio ex articolo 30ter dell’Ordinamento penitenziario (O P ) a fronte del fatto di essere studenti e quindi di soddisfare uno dei requisiti previsti dalla norma, la «partecipazione all’attività trattamentale» all’interno dell’istituto (per inciso il secondo requisito è quello di non essere socialmente pericolosi). Altre richieste vertevano su istanze di minor conto, più strumentali all’allargamento degli spazi all’interno del contesto detentivo e, in questo, assumevano una connotazione assolutamente simile alle istanze che generalmente vengono avanzate in ogni istituto penitenziario. Nessuno dei detenuti, in quella prima fase, accennò al senso della scuola in carcere. Il gruppo dei docenti esterni appariva solidale con il gruppo dei detenutistudenti rispetto al tema dei permessi premio e critico nei confronti delle decisioni della magistratura di sorveglianza competente e degli spazi che l’organizzazione penitenziaria concedeva. Tra questi docenti, alcuni si occupavano, volontariamente, anche della gestione di alcune attività ricreative collaterali alle attività scolastiche. Il rapporto tra docenti e studenti si caratterizzava per umanità e solidarietà. Tra i suddetti gruppi e quello degli educatori penitenziari i rapporti non erano particolarmente buoni. Le rivendicazioni nei confronti di questi ultimi assumevano una connotazione stereotipata e ripetitiva. I detenuti accusavano gli educatori di essere «assenti» e «responsabili», attraverso gli atti del loro ufficio, dei rigetti sulle istanze di permesso premio da parte del magistrato di sorveglianza. I docenti sostenevano, con toni meno accesi, la tesi dell’«assenza» e della distanza dalla vita scolastica. Da parte loro gli educatori evidenziavano un certo scetticismo circa la serietà con la quale gli studenti affrontavano i corsi e il correlato atteggiamento di «comprensione» da parte dei docenti. Per altro verso rimarcavano la rigidità del magistrato di sorveglianza. Il gruppo della custodia, composto da appartenenti della polizia penitenziaria, esprimeva prevalentemente un atteggiamento scettico e critico sulle attività scolastiche e sui detenuti frequentanti (si sottolineava una loro presunta o obiettiva strutturazione criminale e una partecipazione strumentale). Critiche 39 venivano anche indirizzate all’area educativa, tacciata di essere «assente», e sui docenti esterni che venivano classificati come troppo «contigui» ai detenuti. Il magistrato di sorveglianza, a sua volta, sulla base della comparazione tra le risultanze scolastiche e la personalità dei detenuti — valutata attraverso le sentenze, gli atti dell’osservazione, i colloqui diretti — esprimeva un giudizio di «non credibilità» dell’attività scolastica nel suo complesso. In estrema sintesi si prospettò un sistema «carcere-scuola» particolarmente complesso, caratterizzato da un certo livello di conflittualità tra le varie componenti, dall’assenza di obiettivi e modalità condivise; un sistema bloccato sprovvisto di un progetto. È viceversa opinione di chi scrive che un carcere che si definisce «scuola» debba esprimere un progetto educativo e penale teso, quantomeno, al conferimento di competenze e conoscenze. Darsi un modello per comprendere e intervenire Tenterò di disegnare un modello per chiarire le dinamiche sommariamente descritte. Partiamo dal concetto di risorsa e vediamolo dal punto di vista del detenuto ristretto in un istituto penale. Egli, se sufficientemente dotato di risorse personali e sociali (e se riesce ad attivarle), può aspirare ad una pena più breve e migliore (Berzano, 1994). Indubbiamente la possibilità di frequentare corsi scolastici gli consente una certa considerazione da parte dell’amministrazione penitenziaria prima e della magistratura penitenziaria poi (Fassone, 1980; Buffa, 1997). Anche dal punto di vista dell’amministrazione penitenziaria la scuola rappresenta una risorsa importante perché permette di gestire più agevolmente le persone detenute che risultano meno reattive alla detenzione grazie all’impegno profuso nei corsi. In sostanza si creano le condizioni per una reciproca «funzionalità». Il mantenimento di un tale equilibrio, dando corpo a una logica specifica che è quella dell’istituzione totale (Goffman, 1968), può determinare il sacrificio di alcuni elementi, viceversa, fondamentali se si vuole uscire da questa logica per entrare in quella della scuola come elemento di acquisizione di competenze. La frequenza e l’impegno, da un lato, la pretesa del rispetto di questi presupposti, dall’altro, possono infatti essere sacrificati in nome di un reciproco inconsapevole accordo di quieto vivere. Tutto questo, nel caso in esame, rendeva il risultato finale non credibile agli occhi della magistratura di sorveglianza che, per questo, non attivava la premialità prevista dall’ordinamento penitenziario. I detenuti reagivano chiedendo a gran voce il riconoscimento di quello che — dopo una serie di passaggi inconsci, classici dello stato di soggezione istituzionale — veniva percepito come un «diritto» e non una possibilità vincolata a determinati requisiti. In questa querelle monotematica e acritica le altre componenti si coinvolgevano in qualità di «alleati» o «avversari». Gli insegnanti tendevano a difendere l’impegno dei detenuti-studenti, a giustificare certi loro atteggiamenti impropri (assenze, scarso impegno scolastico) prendendo spunto dalla condizione difficile di una persona soggetta a una pena detentiva, dalle presunte illogicità di una struttura che limita la vita di una persona. Per questo motivo le altre componenti percepivano i docenti come «estranei» alla logica penitenziaria. Sussisteva, peraltro, un rapporto equilibrato tra i vari operatori che difendevano le proprie posizioni. Nessuno, comunque, poneva in dubbio la funzione e l’«utilità» della risorsa scolastica. 40 Verso il cambiamento Proprio la magistratura di sorveglianza, rigida sulle sue percezioni e nelle sue decisioni, non concedendo sbocchi premiali alla mera frequenza scolastica, e quindi scompaginando l’equilibrio funzionale e totale descritto, è stato il punto di forza per la revisione di quello stesso sistema. Si iniziò con il dichiarare a tutte le componenti (magistratura di sorveglianza, detenuti, insegnanti, educatori, custodia) la centralità della scuola nell’istituto. Probabilmente molti presero tale affermazione come la solita dichiarazione iniziale di buoni propositi. In questa prima fase, ogni componente interna mise il direttore a conoscenza delle manchevolezze delle altre componenti, ma nessuno fornì indicazioni utili al riconoscimento del problema o, tantomeno, al suo superamento. Sul fronte interno si diede corso ad alcune scelte strategiche di fondo. Queste costituirono la prima fase del progetto — in quel momento non scritto né condiviso, come spesso succede nelle fasi iniziali degli interventi in campo sociale (Ambroset, 1992) — teso alla ridefinizione del ruolo della scuola all’interno dell’istituto. Si accorparono in sezioni omogenee tutti i frequentanti i corsi scolastici e di formazione. In questo modo si intese costituire un gruppo-scuola che potesse fruire delle condizioni minime per poter effettivamente studiare, anche durante il pomeriggio, nelle sezioni detentive. Contrariamente alle aspettative le resistenze da parte dei detenuti furono forti. Questo fu indice del prevalere delle logiche «di sezione» su quelle scolastiche. Gli insegnanti svolsero di loro sponte il ruolo di mediazione tra il gruppo di studenti che non volevano effettuare lo spostamento e la direzione. Da parte loro tutti gli operatori penitenziari appoggiarono l’iniziativa. Nel giro di pochi giorni lo spostamento fu effettuato a eccezione di qualche unità che preferì abbandonare i corsi. Seguì un periodo di richieste da parte dei detenuti-studenti, finalizzate al miglioramento della vivibilità all’interno delle sezioni omogenee. Pur con i tempi di una amministrazione pubblica si soddisfarono alcune richieste, soprattutto quelle che potevano aver attinenza al fattore studio. Si adottò la prassi di discutere collegialmente, per quanto possibile, gli argomenti o le ipotesi di lavoro riguardanti le attività scolastiche. In questo modo si consentiva lo scambio e il confronto su problemi concreti. Per esempio, si stabilì formalmente che la selezione dei vari candidati al primo corso venisse effettuata dall’ufficio educatori e dai rappresentanti della scuola. Parte del dibattito venne impiegato per analizzare il ruolo e le funzioni dei docenti nel contesto dell’istituto penitenziario. Il loro atteggiamento era quello di affermare l’indipendenza del loro ruolo e delle loro funzioni. Pur concordando sulla necessità di garantire e rispettare l’autonomia didattica, la direzione ribadì la necessità che l’attività scolastica costituisse parte integrante del trattamento penitenziario e, come tale, oggetto di valutazione da parte della direzione e, in seconda battuta del magistrato di sorveglianza. I docenti continuarono a sottolineare la loro contrarietà, motivando con il fatto che in tal modo le attività didattiche sarebbero state stravolte dalla commistione tra logica penitenziaria e logica scolastica. Le posizioni, pur non irrigidendosi, non sono mutate nel tempo. Si iniziarono a controllare mensilmente le presenze scolastiche, scoprendo un certo livello di assenteismo. Gli operatori penitenziari, nel loro complesso, utilizzarono tale argomentazione per sottolineare la scarsa adesione alle attività scolastiche e la strumentalità palese di una parte dei detenuti. Tale considerazione, in alcuni casi, veniva estesa alla generalità dei detenutistudenti. A seguito dei controlli, mensilmente, si inviò una lettera personale ai detenuti che risultavano particolarmente assenti, ammonendoli che ulteriori assenze avrebbero comportato l’espulsione dai corsi ai sensi dell’articolo 44 del 41 Regolamento di esecuzione. Tali missive vennero soprannominate ironicamente «avvisi di garanzia» e diedero corpo a proteste da parte degli interessati. Gli insegnanti riferirono di una loro attività di mediazione al fine di limitare la tensione. Grazie a una riorganizzazione dell’ufficio educatori, fu possibile individuare un educatore al quale venne affidato il compito di seguire le cosiddette «sezioni studenti» e i corsi scolastici. Questo costituì un elemento fondamentale nell’organizzazione. Gli agenti preposti al controllo del reparto aule costituirono un secondo importante punto di riferimento per avere indicazioni del clima scolastico. Nell’ottica di salvaguardare le attività didattiche si organizzò l’orario della palestra in modo da evitare che gli studenti optassero per tale attività in orario scolastico. Si calmierarono così le assenze o, quantomeno, si tolse un’opportunità di «svago» indebito. La credibilità A quel punto si ritenne fossero mature le condizioni per sviluppare un ragionamento più complessivo finalizzato alla stesura del progetto. Le componenti si erano già più volte confrontate e insieme avevano gestito dei cambiamenti. Insieme si concordò sulla necessità di dotarsi di un progetto univoco e aggregante le varie componenti che fosse in grado di far acquisire il crisma della credibilità al lavoro di tutti, evitando, nel contempo, di cadere in reciproche quanto inutili rivendicazioni. La credibilità, anzi, venne eletta a prospettiva progettuale e per far questo molto si insistette circa la necessità di dissociare la premialità dalla mera frequenza scolastica. Allo stesso tempo, però, maturò la consapevolezza e la necessità di dare prospettiva alle attività scolastiche, nel senso di inserirle in percorsi trattamentali articolati che, valutata la partecipazione dell’interessato, consentissero attività esterne al carcere. Alcune iniziative pratiche consentirono di sperimentare e dare corpo alle buone intenzioni. Nel periodo estivo, notoriamente vuoto di contenuti, si organizzò un ciclo di conferenze su temi di interesse generale scelti dagli stessi detenuti. L ’iniziativa, intitolata «Dall’atomo alle stelle», ebbe un notevole successo; vide la partecipazione di personaggi in vista della cultura alessandrina (che in questo modo entrarono in contatto con il carcere-scuola e le sue potenzialità) e suscitò un vero interesse da parte dei detenuti (che in quelle occasioni evitarono le solite rivendicazioni). Ma questa esperienza consentì soprattutto di continuare a sperimentare piccole forme di collaborazione interprofessionale. Si diede la possibilità a un gruppo di detenuti-studenti di progettare, a titolo di attività didattica, l’abbattimento delle barriere architettoniche in alcune vie e piazze cittadine. L ’iniziativa implicò l’uscita dall’istituto di un gruppo di queste persone in regime di articolo 21 O P per effettuare i rilievi topografici necessari. Al di là del significato sociale dell’iniziativa, questa ebbe un notevole rilievo per due ordini di motivi: da un lato, per un detenuto poter fruire, anche se temporaneamente, di una misura di quel genere significa poter vantare una certa considerazione spendibile nel suo iter penitenziario; dall’altro, la preparazione dell’uscita coinvolse gli insegnanti, delegati all’individuazione dei detenuti più preparati, la custodia che venne delegata all’organizzazione del controllo esterno e l’ufficio educatori che verificò con la custodia la fattibilità giuridica e di opportunità dell’iniziativa. In poche parole per l’ennesima volta si sperimentò un’integrazione su un progetto concreto. Effettuati i rilievi, venne confezionato all’interno dell’istituto il progetto, presentato successivamente al Comune di Alessandria. Il Comune, fatte le opportune verifiche, decise di approvarne la realizzazione impiegando detenuti ammessi al regime di lavoro all’esterno. 42 Tutte queste iniziative, il loro successo, il significato che a queste venne conferito dagli operatori e da almeno una parte dei detenuti-studenti coinvolti, le modifiche organizzative adottate, consacrarono il cambiamento del «clima». Il sistema «carcere-scuola» era finalmente sbloccato. Tutte le attività citate furono preventivamente comunicate e concordate con il magistrato di sorveglianza e seguivano una logica comune che era quella di attivare forme di premialità o di modificazione della vicenda penale solo dopo aver impegnato le persone in percorsi che testimoniassero con chiarezza l’impegno. Dare prospettiva all’attività didattica Tra l’altro in quel periodo, in alcuni casi, si comunicarono al magistrato anche i risultati scolastici. Questo determinò reazioni tra i detenuti e tra gli insegnanti. I primi opposero che i risultati scolastici non potevano costituire elemento di giudizio da parte del magistrato di sorveglianza per valutare la partecipazione al trattamento penitenziario. I secondi evidenziarono il rischio che le loro attività, in questo modo, fossero percepite dai detenuti come elementi del processo di valutazione delle istanze per la concessione dei benefici previsti dall’Ordinamento penitenziario. La posizione della direzione fu quella di ribadire che la valutazione della partecipazione al trattamento non poteva escludere i risultati scolastici, certo messi in relazione alle capacità individuali di base. Il timore degli insegnanti che questo determinasse un peggioramento della relazione tra docenti e studenti non è irreale, tuttavia è opinione di chi scrive che un’attività trattamentale svolta all’interno di un istituto penale non possa viversi quale «esterna» al contesto e alle sue logiche. Sull’argomento, per la verità, si ragionò molto senza giungere a un accordo. Al di là di questo si continuò a lavorare nell’ottica di dare prospettiva all’attività didattica interna studiando la possibilità di far frequentare a due corsisti dell’ultimo anno l’ultimo quadrimestre all’esterno, presso l’Istituto per geometri «Nervi» di Alessandria, cui fa capo la sezione distaccata presso la Casa di reclusione. Il progetto venne prima discusso all’interno attraverso le modalità già sperimentate, ovvero gli insegnanti indicarono i corsisti più meritevoli dal punto di vista didattico ma anche di «tenuta», gli educatori e la custodia indicarono invece la possibilità giuridica e l’opportunità della scelta. Seguì un lungo confronto all’esterno presso il consiglio d’istituto del «Nervi» che decise, non senza remore, di accettare la proposta del carcere. I risultati sono stati ottimi. L ’impegno dimostrato dai due studenti è stato notevole anche perché c’è stata in loro la consapevolezza che una tale modalità costituiva potenzialmente l’inizio di esperienze di ammissione all’esterno per motivi di studio per altri compagni di detenzione. Non solo infatti si pensò di riattivare l’iniziativa per l’anno scolastico successivo e per l’intero ultimo anno di corso, ma si ipotizzò anche di ammettere all’esterno alcuni detenuti già diplomati e iscritti ai corsi universitari con sede in Alessandria. Dopo mesi di lavoro, di progetti, di successi e discussioni fra operatori, si decise, a quel punto, di confrontarsi in plenaria con i detenuti-studenti. Fu una vera e propria prova del fuoco. Si discusse della necessità di essere un istituto credibile dal punto di vista della progettualità, delle iniziative, dei risultati, come gruppo integrato di lavoro. Il dibattito immediato, ma soprattutto quello intestino e meno palese, evidenziò una frattura nel gruppo dei detenuti-studenti. Difficile dire la proporzione numerica tra i convinti, gli scettici e i contrari all’impostazione trattamentale dell’istituto. Di certo la compattezza iniziale che tendeva a far prevalere un utilizzo strumentale delle opportunità formative era scomparsa. Alcuni affermarono «Questo carcere non fa per me» e chiesero il trasferimento ad altra sede, altri in 43 riunioni più limitate opposero ad alcuni compagni la richiesta di smettere di centrare tutto sul permesso invece di concentrarsi sugli impegni presi. Indicatori assolutamente spuri e imprecisi che però, collegati alle varie sensazioni degli operatori, confermavano un quadro di cambiamento. Da qui l’idea di formalizzare — dopo una lunga serie di contatti con l’Università del Piemonte Orientale interessata alla costituzione di corsi universitari all’interno dell’istituto, la presidenza dell’Istituto «Nervi», l’Ente di formazione professionale che opera in carcere e gli Stati Generali di Alessandria (che riuniscono tutte le espressioni civili, culturali ed economiche della città) — un progetto, denominato «Gutemberg», finalizzato alla conversione della Casa di reclusione «San Michele» in un istituto penale completamente dedicato ad attività formative. Questo, se concretizzato, consentirebbe di ritarare l’intera organizzazione sulle esigenze didattiche. Si pensi ai colloqui, alla fruizione dei pasti e delle ore ricreative che oggi, gioco forza, sono legate alla gestione delle due sezioni di cosiddetti «ozianti», ovvero di quei detenuti che non sono occupati in attività formative, e che oggi si sovrappongono poco funzionalmente alle attività scolastiche e trattamentali. Ma questo è il futuro. Conclusioni Dall’esperienza qui sinteticamente descritta possono essere evidenziati alcuni elementi che si ritengono centrali. Il binomio «carcere-scuola» non può non indicare un progetto di fondo. Fondamentali sono la condivisione e il riconoscimento tra tutti gli operatori coinvolti di obiettivi comuni e metodiche professionali, seppur diverse, orientate alla loro realizzazione. Sembra una banalità affermare questo ma la realtà, purtroppo, non sempre rende superflua tale dichiarazione. La condivisione deve scaturire da un approfondito confronto sulla condizione dell’uomo ristretto in carcere, dei suoi bisogni palesi, latenti e indotti. Oculate riflessioni devono essere condotte sul significato di risorsa che l’offerta formativa assume all’interno di un istituto di pena e sul fatto che un «carcere-scuola» per essere tale deve essere credibile, ovvero, deve poter costituire un servizio che metta realmente alla prova volontà e impegno dei detenuti-studenti. Solo in questo modo è possibile procedere a quella verifica della cosiddetta «partecipazione all’attività trattamentale» richiesta dall’Ordinamento penitenziario per poter modificare la vicenda detentiva (Canepa, Merlo, 1993). Trattamento e percorsi formativi non possono essere considerati elementi giustapposti, semmai i secondi sono parte integrante del primo. È necessario che tutti gli operatori, sia interni sia esterni, siano consapevoli di partecipare a un unico disegno. Chi entra in carcere per motivi professionali lavora con persone soggette a una pena che può modificarsi anche in relazione a quelle attività. È stato correttamente sottolineato che «la formazione entra nella vicenda delle persone recluse» (Soliani, 1998). Per chi sobbalzerà ritenendo di essere in presenza di un tentativo di riproporre l’addestramento coatto dei «corpi molli» di foucaultiana memoria (Foucault, 1976) si tranquillizzi: l’intento è, viceversa, di proporre un servizio penitenziario al quale volontariamente e consapevolmente le persone recluse possano aderire. L ’integrazione, più che attraverso proclami, si ottiene con la sperimentazione di iniziative concrete che vedano il contributo delle varie professionalità per raggiungere obiettivi precisi e limitati. È necessario curare le relazioni tra le varie componenti individuando passaggi e procedure, che siano poche, semplici e chiare, in modo da limitare i fisiologici conflitti di un gruppo di lavoro, che se non risolti possono creare pericolosi irrigidimenti. Tutti questi sforzi possono creare un’istituzione penitenziaria che, nel suo complesso, offre concretamente un servizio di formazione. Rispetto a questa opportunità i detenuti che faranno la scelta di fruire di questo servizio saranno 44 anche indotti a scegliere la via dell’impegno perché altro l’istituzione penitenziaria non potrà offrire. In tal senso è opportuno che il gruppo dei detenuti sia omogeneamente composto, in modo che le motivazioni iniziali si rinforzino attraverso la relazione con persone che hanno fatto le stesse scelte. Occorre anche dare dinamicità, prospettiva e riconoscimento all’impegno dimostrato prevedendo, per quanto possibile, un crescendo di attività correlate all’iter formativo, anche all’esterno della cinta muraria. È per tutti questi motivi che un carcere-scuola deve esserlo integralmente e la sua organizzazione deve essere centrata sulla formazione rispetto alle cui esigenze ruoti la restante parte della vita detentiva. BIBLIOGRAFIA Ambroset S., Postfazione, in Fattivamente, Atti del convegno «Carcere, lavoro e Progetto Ekotonos», San Vittore, Milano 1992. Berzano L. (a cura di), La pena del non lavoro, Franco Angeli, Milano 1994. Buffa P., Tra il dire e il fare: riflessioni sulla prassi applicativa dell’Ordinamento penitenziario, in «Questione Giustizia», 4, 1997, pp. 783-795. Canepa M., Merlo S., Manuale di diritto penitenziario, Giuffrè, Milano 1993. Fassone E., La pena detentiva in Italia dall’800 a oggi, Il Mulino, Bologna 1980. Foucault M., Sorvegliare e punire: nascita della prigione, Einaudi, Torino 1976. Goffman E., Asylum, Einaudi, Torino 1968. Soliani A., Prospettive di politica della formazione alla fine del secondo millennio, in Liberamente. Percorsi educativi negli istituti penali: idee e progetti, Atti del seminario «Ruolo e funzione dell’insegnante elementare negli istituti penali», Castiglione della Pescaia, 3-7 febbraio 1998. LEZIONE 3 Etica e prostituzione: l’incontro possibile di Luigi Ciotti Incontrare le persone e affrontare i problemi: informazione e formazione Perché il lavoro sociale non si riduca a sola questione tecnica (da delegare a esperti e specialisti competenti di frammenti) è necessario attrezzarci affinché la “strada”, laddove il fenomeno vive, possa essere ascoltata e conosciuta. Occorre fare dell’informazione e della formazione tasselli costitutivi e permanenti del lavoro sociale. Cercare strumenti per capire, per approfondire e per cogliere le diverse sfumature che compongono un fenomeno, diventa anzitutto un metodo. Nel “metodo” è già evidente il fatto che quando ci si avvicina alla “strada” si è alle prese con persone e non solo con problemi. Incontrare le persone per affrontare i problemi presenti in quel contesto assume, di conseguenza, la forza di uno stile che condiziona obbligatoriamente il procedere delle riflessioni e delle azioni. Da spazio geografico, la strada diventa così luogo antropologico, contesto che ci avvicina gli uni agli altri in una continuità che rompe le rigide separazioni di cui ci serviamo per difendere i recinti che ci siamo faticosamente costruiti per avvertirci diversi (e a volte migliori, quando non superiori) dagli altri, dagli ultimi della fila che stazionano dove noi passiamo. 45 Chi abita la “strada” non mi appare più – in questa prospettiva - come un estraneo che minaccia l’ordine in cui sono inserito, ma si presenta come un vicino di casa (più o meno silenzioso) che mi interroga con la sua sola presenza sul perché – nei pressi della mia abitazione – sono possibili così laceranti contraddizioni, povertà, fragilità e ingiustizie. Incontrare senza giudicare si presenta come l’unica difesa possibile perché pensare e operare il lavoro sociale siano liberati dai tortuosi pregiudizi che impoveriscono le nostre relazioni. È un'ecologia mentale che prima o poi contagia anche il cuore perché “non giudicare” (binomio evangelico che rischia di essere dimenticato anche all’interno delle nostre chiese) non riguarda solo l’“altro”, colui che è abituato a sentirsi definito da categorie che calpestano la dignità umana, ma anche la nostra libertà interiore. Non dimentichiamo, inoltre, che la prostituzione, di cui noi oggi prendiamo coscienza attraverso l’incontro con i volti delle ragazze nigeriane o provenienti dall'Est europeo non è un fenomeno nuovo. Se anche solo pensiamo alla storia del nostro Paese ci accorgiamo che la presenza della prostituzione è un affare di vecchia data che ha già in passato scosso l’opinione pubblica, provocato reazioni e sollecitato le più svariate risposte. (…) Torino negli anni della grande immigrazione: gli anni 1950-60. Pensiamo agli anni immediatamente successivi alla seconda Guerra mondiale, agli anni 1950-1960: sono i decenni del cosiddetto “miracolo economico”, di nuove massicce migrazioni dalle campagne verso le città, gli anni in cui il Sud Italia cerca lavoro e speranza nelle grandi aree urbane del Nord (la popolazione del capoluogo piemontese in quegli anni è passata da 719.300 persone del 1951 a 1.124.714 del 1967). Le grandi metropoli del Nord Italia non sempre sono pronte e preparate ad accogliere l’afflusso di un numero così elevato di persone. Di nuovo le famiglie immigrate sono costrette a vivere in condizioni estremamente precarie: se da una parte il mercato del lavoro in espansione è in grado di assorbire un elevato numero di persone, dall’altra esso non è in grado di garantire per tutti un impiego. Così, per molti, il grande viaggio verso il Nord termina amaramente nei vicoli del crimine o nella prostituzione. Anche la ricerca di una casa rappresenta un grave problema: i nuovi abitanti della città trovarono alloggio negli scantinati e nei solai del centro, negli edifici destinati a demolizione, in cascine abbandonate all’estrema periferia. Ovunque si verificarono atteggiamenti razzisti: ricordo i cartelli sui portoni dei condomini che riportavano la scritta “Non si affittano case ai meridionali”. Compaiono anche nuovi volti del fenomeno prostituzione: non sono pochi, ad esempio, i padri di famiglia che disoccupati o licenziati “imparano” a vendere il loro corpo per inseguire un po’ di benessere economico familiare. Drammi e sofferenze che mai nessuna ricerca sociologica riuscirà a raccontare fino in fondo. 46 Il problema della prostituzione assume, in questo contesto, non solo nuove forme, ma anche una visibilità diversa: di tipo moralistico e funzionale ad altre logiche. È il quotidiano di Torino, La Stampa, che fa scoppiare il problema della prostituzione come minaccia alla sicurezza urbana. Il quotidiano di Torino lancia un’offensiva contro la presenza di ragazze che si prostituiscono lungo le strade della città torinese. Si tratta di una vera e propria campagna realizzata anche per screditare quel faticoso percorso legislativo – noto come legge Merlin (febbraio 1958) – che depenalizzò il reato di esercizio della prostituzione in ambito privato superando quelle discriminazioni che rendevano le donne prostitute cittadine di serie B. La campagna de La Stampa non era uno sforzo per aggredire le cause della povertà che rendevano possibile il fenomeno prostituzione. Era più semplicemente un moralismo di facciata che contribuiva a nascondere le contraddizioni di fatto esistenti. Chi stonò in un coro troppo armonico fu il cardinale di Torino, padre Michele Pellegrino, che in una indimenticabile omelia tenuta nella notte di Natale del 1972 parlò del “Dio che venne ad abitare in mezzo a noi, ma i suoi non l’hanno accolto” e chiese alla città di lasciarsi interrogare dalla prostituzione come fenomeno di povertà, chiamandone quindi in causa anche le cause sociali e politiche e denunciando inoltre il rischio di calpestare soltanto la donna e di dimenticare, nella riflessione, il “cliente”. Non fu facile proporre alla città uno sguardo più completo, più umano e più aperto alla giustizia. Informazione e formazione – da sole – non erano sufficienti; così come non bastavano accoglienza e volontariato per scardinare meccanismi culturali e sociali radicati in pregiudizi e disuguaglianze insormontabili a livello di sole “buone opere volontarie”. Intrecciare cultura, cittadinanza attiva e politica era indispensabile per aggredire le cause delle ingiustizie nascoste nelle realtà della prostituzione. “Camminare insieme” divenne, molto presto, non solo il programma pastorale della Chiesa torinese di quegli anni, ma anche il percorso e la proposta perché realtà diverse potessero occuparsi della città. Il “nostro” tempo. Oggi il contesto sociale è nuovamente cambiato. Torino vive tensioni diverse e alcune delle vecchie povertà sono state superate mentre ne sono subentrate di nuove. Non sono cambiati però i bisogni delle persone. Questi ultimi sono sempre uguali: bisogni fisici fondamentali, bisogni affettivi, abitativi, di relazioni significative, di valorizzazioni delle proprie risorse, di senso… . Bisogni sempre uguali che diventano più urgenti e più laceranti se sono vissuti da persone che raggiungono la nostra città (il nostro continente e la nostra cultura) da terre lontane. Gli scenari dell’immigrazione stanno ridisegnando il mondo: dal sud del mondo e dall’est popoli interi si spostano alla ricerca di un futuro vivibile e nella speranza di scappare dalle tristi condizioni di fame e di miseria estrema cui sono sottoposte. Non sempre quel viaggio rappresenta un “nuovo” inizio. 47 Per molti la tragedia inizia prima dell’arrivo, a causa di “mercanti di speranza” che costruiscono costosissimi trasporti illegali nella più totale insicurezza e in condizioni disumane. Chi supera quel primo ostacolo deve però poi affrontare il dramma della clandestinità, della precarietà, dello sfruttamento, della salute min acciata da condizioni di vita precarie. Anche in questi nuovi contesti povertà, miseria e degrado sono elementi che si affacciano dentro il mondo della prostituzione. È vero: molte volte le ragazze che raggiungono clandestinamente il nostro territorio sanno che saranno indirizzate al mondo della prostituzione, ma ignorano completamente il modo e la violenza che segnerà il loro futuro. Rispettare ogni scelta per non abbandonare nessuno. Da una parte c’è il “piano” che interpella la scelta delle ragazze a proposito della prostituzione. Povertà e miseria condizionano pesantemente le scelte di queste persone, ma non sempre sono l’unico elemento che porta a prendere quella decisione. Rispettare scelte individuali è il vero scoglio che l’orizzonte della prostituzione ci fa incontrare quando questa è sganciata da meccanismi di violenza o di sfruttamento. Questo non significa smarrire i confini tra bene e male, coincide, al contrario, con la necessità iniziale di non condannare le persone e di farsi accogliere dalle persone in difficoltà. Alcune scelte possono anche non essere condivise, ma una presa di distanza dalla singola responsabilità individuale, non può diventare alibi per abbandonare la persona a se stessa, per condannarla oppure per arrivare alla conclusione che “in fondo quel trattamento disumano di chi trasforma una persona in merce, se lo sono voluto”. Individuare le vere responsabilità. Dall’altra parte c’è il piano di quanti si inseriscono su queste scelte individuali per lucrare economicamente e per sfruttare una condizione che non riscuote un consenso etico diffuso e che proprio per questo non è tutelata (tra questi vanno annoverati anche coloro che affittano loro alloggi a cifre esorbitanti perché sono prostitute e clandestine). Ciò che ne consegue è noto: chi si avventura con qualche consenso su queste strade, viene intercettato da organizzazioni criminali e ridotto a semplice “merce”. Se questi due livelli vengono mescolati, il rischio è gravissimo perché la silenziosa condanna della scelta individuale della ragazza si trasforma in una indifferenza colpevole che abbandona la ragazza a percorsi violenti, tragici e illegali considerati quasi come una punizione per devianze etiche inaccettate. La posta in gioco è alta. Il rischio è concentrare il nostro giudizio morale, quando la ragazza entra in un vero e proprio mercato della schiavitù, sulla sua scelta (e a questa sola condizione riservare il titolo di “vittima”), e di non prendere in considerazione i percorsi 48 più complessi e segnati da livelli di consapevolezza morale più o meno espliciti, per cui sofferenze, violenze, schiavitù o torture non possono dare luogo a vere e proprie “vittime”. Se questo avviene è perché si è passati – frettolosamente – dal piano del giudizio etico al livello sociale creando un cortocircuito che condanna senza ascoltare e senza sostenere. Tanta violenza e tanta brutalità appare spesso come un fenomeno da condannare a livello formale. Ma questo non basta. Se ci fermassimo qui noi contribuiremmo a favorire indirettamente quelle logiche che prima o poi espongono le vittime a quelle conseguenze. Farsi prossimo alle persone significa intanto accettarle per come sono, farsi accogliere da loro e poi offrire il nostro aiuto. Non dimentichiamo, per fare qualche esempio, che molte delle nostre amiche immigrate che, prostituendosi, hanno incontrato la morte per mano di brutali assassini, sono state spesso trasformate in vittime di serie B: cadaveri dimenticati in anonimi obitori e certamente non degne di tutte le attenzioni che sarebbero state riservate a un cittadino italiano senza “colpe”. Non confondere i piani è premessa di giustizia. Restare fermi su questioni di principio, può diventare una scorciatoia per percorsi fondamentalmente segnati dall’ingiustizia e dalla violenza. Quando si affrontano questioni etiche che vedono intrecciarsi il piano soggettivo e quello sociale, il primo dovere è quello di confrontarsi con una realtà complessa, senza subito tentare di addomesticarla alle proprie convinzioni. Questo non significa rinunciare ai propri riferimenti etici, ma operare la scelta in base alla quale la persona viene sempre prima di ogni teoria morale e prima delle cosiddette questioni di ordine pubblico. Abitare le nostre paure per imparare ad attraversarle e a superarle. Un secondo indicatore per le nostre riflessione etiche è dato dall’elemento “paura”. E’ elemento inevitabile dell’esperienza umana. Appare, molte volte, come dimensione negativa, come “dato” da allontanare perché sinonimo di fragilità, di debolezza o di mancanza di coraggio. In realtà le nostre paure non sono solo assenza di coraggio. Dentro la paura è presente quel sentimento di insicurezza che ci attraversa non appena la nostra vita incontra il “nuovo”, quanto è inatteso o quanto ci vede impreparati ad affrontarlo. Imparare ad ascoltare queste paure senza subito negarle o assecondarle in ansiose reazioni rigide o difensive, diventa compito che ci educa ad ascoltare anche la nostra sfera emotiva per inserirla nell’orizzonte dell’intelligenza. Anche questo è compito etico da non sottovalutare. Accompagnare il linguaggio emotivo lungo i sentieri della razionalità, vuol dire inventare, giorno dopo giorno, quell’intelligenza del cuore che crea unità tra ciò che pensiamo e quanto viviamo. Scoprirci inadeguati o impauriti dalla presenza di un altro effettivamente diverso dal nostro modo di essere e di fare, non è colpa morale. E’ semplicemente percorso possibile (“normale” potremmo dire se è ancora lecito usare 49 questo termine) che ci avverte della distanza da colmare se vogliamo avvicinarci all’altro ed incontrarlo. Il vero nodo non è dunque dato dalla “paura” (legittima, normale, fisiologica), ma da come utilizzeremo quei sentimenti e come risponderemo alla nostra sfera emotiva. Se quel “timore” ci schiaccia a terra, ci atterrisce rendendoci incapaci di reagire e completamente in balia di un simile stato d’animo, non prevarrà il desiderio di incontrare l’altro, ma il bisogno di allontanarlo, di scacciarlo e di eliminarlo. Se, al contrario, quel sentimento di insicurezza e di paura viene “abitato”, ascoltato, osservato, se si riesce nel tentativo del “dar parola” alle figure senza volto che generano paura, per coglierne la provenienza ed il perché di quella reazione, il nostro sentimento ci permette di rialzarci da terra e di non restare schiacciati o troppo piegati. Dove sussiste la paura, la “figura minacciosa” non prende un volto, non assume una parola e si resta prigionieri di un sentimento che blocca il vivere 1. Non dimentichiamo che se le nostre paure generate dalla “non conoscenza” producono rigidità e chiusure, le paure quasi simmetriche di chi è dall’altra parte _ esposto alla “strada” senza tutele e senza sicurezze _ rendono aggressivi e diffidenti di tutto ciò che e avvicina e circonda. Quante volte il mondo della prostituzione ha sollevato questi meccanismi di paura da abitare, da attraversare e da affrontare! Dare parola alla sessualità non è facile per nessuno. Se questa poi è vissuta in una logica commerciale che separa affettività da sessualità, i “fantasmi” si dilatano. E’ vero: l’esercizio della sessualità è fonte, molte volte, di gioie, piacere e intimità esclusiva, ma non possiamo negarci che proprio al fianco di queste emozioni possono convivere anche disagio, smarrimento, incomprensioni e fatiche (specie a livello maschile) che spesso non trovano luoghi in grado di dare a queste sofferenze accoglienza, possibilità di rielaborazione e accompagnamento. Senza dimenticare, tra l’altro, che per le nostre paure, non ha molta importanza se chi si prostituisce ha scelto quella attività, era a conoscenza che il suo disperato viaggio avrebbe incontrato quel mondo (non immaginando però le reali conseguenze di quel triste scambio) o se quasi mai chi si prostituisce finisce dentro a una rete criminale a noi nota come “tratta delle persone” che riduce la persona in schiavitù obbligandola a vendere il proprio corpo per arricchire organizzazioni criminali. La realtà drammatica nella quale precipitano queste persone oltrepassa le motivazioni della loro scelta. Non possiamo “filtrare” le richieste di aiuto in virtù dei nostri principi etici. Domandiamoci piuttosto come fare in modo che la dimensione morale non si riduca a percorso teorico che condanna prima e che rallenti poi il procedere della giustizia e della 1 Non a caso le prime parole con cui Gesù Risorto si lascia incontrare in una nuova e liberante relazione sono: “Non abbiate paura”. Per proporre una nuova modalità relazionale non più segnata dalla povertà di “paure” che negano incontro e comunicazione. 50 solidarietà. Il crinale è delicato. Un comportamento disordinato non può essere scambiato per bene morale, o anche solo normalizzato, ma tutto questo non ci deve irrigidire al punto da creare gerarchie, priorità o precedenze nel contesto del sostegno a chi subisce sofferenze, privazioni di libertà, sfruttamento ed esclusioni sociali. Non solo: se è vero che il contesto cambia radicalmente il criterio di valutazione etica, è altrettanto vero che nessuna condizione soggettiva può indebolire il dovere di prestare attenzione, di lasciarci interrogare e di avvicinare in termini culturali, sociali e politici chi è coinvolto nel mondo della prostituzione. Scegliere di prostituirsi o essere consapevoli che nel proprio “viaggio” si incontrerà l’esperienza della prostituzione non può diventare alibi per abbandonare storie personali a sé stesse o per giudizi moralistici che calpestano la dignità delle persone fino ad abbandonarle in una zona senza diritti e senza tutele. Lo stesso approccio vale in altre forme anche per il “cliente”, anche lui non deve essere giudicato a priori, ma accolto e accompagnato. Il difficile punto d’incontro tra diritto e morale. Il diritto non può incontrare terreni neutrali. Distinguere per non confondere è doveroso; se la distinzione, però, diventa vera e propria separazione per sostenere soltanto chi è stata costretta a prostituirsi ed abbandonare chi, con frammenti di libertà più o meno consapevoli, ha permesso all’esperienza di esistere, si creano condanne sociali che ci vedono in qualche modo complici. Il tutto, poi, può diventare pericolosa e insidiosa premessa per vuoti legislativi che prima o poi saranno colmati con interventi finalizzati a segregare, non a rispettare l’essere persona con piena titolarità di diritti. Non significa rendere lecito ciò che per l’impianto etico derivante dalla fede cristiana non può essere definito giusto. E’, più semplicemente, sforzo perché etica e diritto non si identifichino in una pericolosa unità. Se la legge si sostituisce alla coscienza, la nostra libertà è svuotata. Non possiamo chiedere al legislatore di costruire per legge l’intera rete di ciò che può essere definito lecito od illecito. Questo ultimo passaggio è di competenza dell’etica ed è responsabilità del soggetto. Fare in modo che il diritto si fermi sulla piattaforma del penultimo lasciando all’etica il compito di entrare nella sfera dell’ultimo e del “vincolante in coscienza”, è compito tanto difficile quanto urgente e necessario. Vuol dire, da una parte, creare le premesse per una reale e adulta educazione morale (rispettosa di tutte le libertà in gioco) e, dall’altra, chiedere al diritto di difendere chi vive atteggiamenti o comportamenti che la mia coscienza non approva, nel rispetto di tutte le libertà in gioco. Detto con altre parole: il diritto (e le tante forme di solidarietà pubblica e privata presenti sui sentieri della prostituzione) non può individuare nella “libertà” di chi si prostituisce uno spartiacque (etico, di aiuto e di supporto) per l’intervento. Prima del giudicare le coscienze, il diritto è chiamato a rimuovere le cause dell’ingiustizia e della povertà che di fatto indeboliscono le libertà delle persone nel loro 51 agire e nel loro inseguire speranza. Fare della prostituzione una questione individuale da condannare con categorie etiche, significa fermarsi alla superficie del fenomeno perché impauriti (e bloccati) dalla dimensione sociale di povertà, miseria, sfruttamento e ingiustizia presente in quel mondo. Dal punto di vista etico, però, l’interrogativo che emerge è il seguente: come impedire che lo stato di necessità condizioni così pesantemente la libertà da sentirsi quasi costretti a vendere se stessi per poter vivere? E si noti il cortocircuito che tale quesito lascia emergere: non solo la povertà materiale spinge verso soluzioni di questo tipo; anche la povertà di spirito (penso al mondo delle tossicodipendenze) o la logica del consumo fine a se stesso (portata alle sue estreme conseguenze) spinge in molti casi a vendere il proprio corpo con l’illusione di ri-trovare frammenti di libertà (esistenziale, relazionale, economica…). Sono le stesse paure che si incontrano quando si tenta di guardare il fenomeno della prostituzione dall’altro punto di vista: dalla parte dei cosiddetti clienti (con tutte le sfumature che questo termine chiede). Possono prevalere logiche di condanna, di giustificazione, di compromesso o di analisi caso per caso. Resta il fatto che anche in queste circostanze ci è chiesto di “fermare” i giudizi per tentare di ascoltare, di capire e di avvicinare queste realtà per incontrare la persona e, solo dopo, provare a valutare l’azione. Domandarsi perché le nostre relazioni affettive e sessuali diventano così povere al punto che diventa necessario – per alcuni – inseguire, costruire o illudersi di inventare nuove relazioni con il supporto del denaro, è domanda della quale non dobbiamo avere paura. Domandarsi perché il 70% dei clienti sono uomini sposati significa rimuovere finte sicurezze e aiutare, la coppia e la famiglia, a esprimere fatiche e incomprensioni spesso mute. Domandarsi perché gli uomini specialmente temono sempre di più il confronto e l’incontro con l’altro sesso, coincide con l’interrogarsi sulle relazioni per riscriverle: donne e uomini assieme. Se riusciamo a confrontarci su questi scomodi e difficili versanti, diventa evidente che interessarsi di prostituzione chiede di coinvolgersi – con laicità e rispetto - anche nei confronti del cliente. Convinti che anche queste persone possono – se lo vogliamo diventare destinatarie di una solidarietà adulta e rispettosa di tutte le componenti in gioco che con mille linguaggi chiedono aiuto. Come sempre succede quando ci si avventura verso una solidarietà “alta”, non ci si ferma al frammento, ma ci si coinvolge verso il tutto. La solidarietà così intesa assume dimensioni più complete e meno superficiali (meno moralistiche o meno assistenziali) per tenere insieme dimensioni diverse: - preparare l’avanzare della giustizia; 52 - attivare percorsi di informazione e formazione per costruire cultura e per contrastare quella volgarizzazione e diffusione di stereotipi sempre uguali e, purtroppo, superficiali; - spingersi sui sentieri della politica perché questa non consumi energie per nascondere, reprimere o allontanare le persone coinvolte nella prostituzione, ma perché ci si attrezzi – una volta per tutte – perché la povertà non diventi causa o premessa di comportamenti che non si vorrebbero scegliere; - non discriminare le persone su principi che possono, paradossalmente, schiacciare la dignità e la speranza di chi è in difficoltà (hai scelto o hai subito? Sei cliente occasionale o abituale? Sapevi a cosa andavi incontro o eri all’oscuro di tutto?…), ma confrontarsi con una laicità nuova e rinnovata perché alla richiesta di aiuto si risponda con la capacità di incontrare le persone e affrontare i problemi. L'attenzione alle parole Alcune parole sono ritornate. Con i “termini” abbiamo incontrato esperienze, storie, realtà e persone che in nessun modo possiamo ridurre a “solo problema” o a sola questione intellettuale. Perché anche questo è il fascino del linguaggio: portarci su terreni “nuovi” per proporci confronti e incontri che non sempre sappiamo programmare. Quando al vocabolo, però, si associa l’altro in carne ed ossa, la riflessione si rende obbligatoriamente più pacata, più seria e meno “gridata”. Anche i cosiddetti principi etici incontrano una nuova luce e una diversa prospettiva: non sono più astratti o validi anche se fuori della storia, ma obbligati ad entrare in meccanismi reali (e molto concreti) che spiegano la complessità senza ridurla in mortificante semplificazione. Alcuni di questi termini vale la pena provare a riprenderli. Perché la riflessione non si fermi e perché sempre più le parole restino saldate a pratiche rispettose delle verità in gioco e delle vite umane ad esse collegate. Solo a queste condizioni sarà possibile fare in modo che il nostro linguaggio diventi “ponte” verso le persone e le loro responsabilità, storie e fragilità senza mai costruire divisioni, separazioni o negazioni di speranza. Sarà questo il difficile compito verso il quale dobbiamo avanzare. Proviamo a riprendere alcune di queste parole. Cliente. Non può essere dimenticato dalle nostre riflessioni sul tema prostituzione. A volte è genericamente assolto (perché semplicemente partner di un contratto, dicono i più superficiali), altre volte è l’unico “mostro” che sorregge l’intera realtà della prostituzione. Come sempre gli estremi non si avvicinano alla complessità in questione. Se non serve assolvere, non ha nemmeno senso un semplice condannare che nega quanto sottende quelle pratiche. Non dimentichiamo che molte volte sono proprio i clienti che costruiscono, con le donne che si prostituiscono, premesse per percorsi di ritrovata speranza e per affetti 53 nuovi: liberati dalla logica commerciale di un sesso a pagamento. Fare in modo che dietro al “cliente” appaia la persona (con i suoi bisogni, la sua fragilità e la sua responsabilità) è cammino al quale non dovremmo sottrarci. Significa anche individuare quei percorsi formativi capaci di costruire quella maturazione affettiva e sessuale che non spinge ad inseguire prestazioni sessuali (e affettive) a pagamento. Vale per tutti: per le famiglie, per i contesti scolastici, per il mondo associativo, sportivo o del tempo libero, per le nostre chiese, per gli operatori dell’informazione ecc. Trafficanti. Anche a questo proposito sono necessarie parole chiare e senza ambiguità. Sono condotte da condannare senza sconti e con la massima chiarezza possibile. E’ reato non solo per la legge, ma anche per quel patrimonio etico che insieme ci siamo costruito. L’altro non può mai essere “piegato” al proprio uso e consumo, utilizzato come “merce” per lucrare su una attività che viene sfruttata e mantenuta sottomessa con ogni tipo di violenza. Rendere l’altro “schiavo” non è più categoria che interpella un’etica sessuale più o meno condivisibile. Siamo in presenza di crimini contro l’umanità che devono essere fermati con determinazione e progettualità internazionale. Le persone (donne e uomini)che si prostituiscono. Ci è chiesto di non confondere il piano dell’etica individuale con la realtà sociale che ne consegue. Non è sempre facile anche se rispettare scelte possibili non vuol dire condividerle e nemmeno rinunciare a chiedere il rispetto per le proprie idee, opinioni o stili di vita. Attenzione però a non dimenticare che le logiche che soggiacciono alla prostituzione sono presenti anche in altri contesti dove si tenta di dare prezzi (e monete) anche ad ogni dimensione dell’umano. Educati da un consumismo esteso all’infinito che tutto si può “comprare”, alcune volte si è tentati di acquistare anche carriere, successi, beni di natura diversa, titoli di studio, incarichi, stima o prestigio. Non solo: anche nell’atteggiamento di fede questa immaturità è possibile, quando ci si illude di meritare l’amore di Dio in cambio di una (presunta) correttezza morale spesa come moneta in grado di acquistare la salvezza che Dio ci offre gratuitamente. Un fenomeno, quello della “prostituzione”, che chiama dunque in causa una pluralità di elementi quali scelte etiche, squilibri internazionali, povertà, carenza di percorsi educativi, fragilità culturali, difficoltà a includere e comprendere il “diverso”, elementi tutti che dobbiamo imparare a gestire e ad affrontare. (tratto dall’introduzione dal libro M. Dal Prà L. Grosso La tratta degli esseri umani- L’evoluzione del fenomeno della prostituzione EGA 2002) 54 La relazione d'aiuto Leopoldo Grosso nel contesto "prostituzione" di La relazione di aiuto e le problematiche del rapporto, oltre alle difficoltà intrinseche devono fare i conti con i contesti e le situazioni contingenti in cui avvengono e si svolgono. I luoghi dell’incontro Le buone pratiche e i setting delle consultazioni tradizionali non ci sono molto d'aiuto; spesso non c'è a disposizione un ufficio apposito, un ambulatorio in cui le persone si prenotano, vengono, bussano e pongono domande. E’ più probabile che l'incontro avvenga nei luoghi in cui le persone esercitano o in situazioni di emergenza. In un'attività di "aggancio" tendenzialmente il luogo privilegiato dell'incontro è la strada. In questo caso, al contrario di un ambiente predisposto, chiuso e rassicurante, protetto da possibili interferenze esterne, il contesto del- l'incontro è esposto all'imprevisto, a pericoli esterni che interagiscono con la fragilità di una relazione che, con fatica, si tenta di costruire. Se il luogo d'incontro non è la strada, può essere il pronto soccorso di un ospedale o il carcere, posti dove le persone, al di là della loro situazione stanno vivendo una sofferenza aggiuntiva. In questi contesti e per il tipo di problematica di cui sono portatrici, le persone non sono sempre in grado di esporre una domanda chiara, che risulta in genere confusa e molto incerta. Difficilmente ci si confronta con atteggiamenti ben definiti; si tratta di svolgere un ruolo attivo nell'andare incontro a tali domande, e ci viene richiesto un comportamento in parte opposto a quello che abbiamo tradizionalmente imparato nella relazione di aiuto. Comunemente nella relazione di aiuto c'è un "cliente" che porta una domanda e il compito di chi aiuta è di cercare insieme una risposta idonea a tale domanda. Nei contesti in cui abbiamo scelto di muoverci non è così. Siamo noi che ci avviciniamo, che avanziamo piccole offerte, facciamo proposte minimali attorno alle quali si inizia a imbastire una relazione. E importante che con tali modalità la relazione sia sempre mediata da un aiuto materiale riuscire ad offrire un aiuto concreto che in qualche modo risponda al bisogno emergente del momento, consente di mostrare disponibilità e crea vicinanza. Un qualsiasi aiuto concreto, che può consistere nell'offerta di un riparo, di un medicinale, è utile nel generare domande aggiuntive. Dobbiamo evitare due tipi di errore. Il primo è di sviluppare un rapporto fondato unicamente sulle parole, sull'accompagnamento verbale delle persone. Le parole devono essere sostenute e supportate da una reale offerta materiale, perché l'opportunità effettiva che si mette a disposizione rende credibili le parole, rende più visibile e percepibile una disponibilità disinteressata. E’ essenziale offrire risposte concrete: è il "pretesto" su cui spesso si riesce ad instaurare una relazione, senza il quale è più difficile e si rende più incomprensibile l'intrusione. Molte di queste persone dovranno affidarsi a noi ma per potersi affidare a noi si devono fidare di noi. Il presupposto per affidarsi è fidarsi e l'atteggiamento di fiducia si ottiene con l'essere capaci di risposte concrete ai bisogni che emergono e alle necessità materiali che si evidenziano. La seconda questione che dobbiamo avere chiara nell'andare incontro alla problematica è che in genere la 55 persona che viene prostituita e la persona che si prostituisce rappresentano un continuum in cui non è sempre facile trovare la soluzione di continuità. Ciò pone un problema delicato: il problema della scelta della persona. La persona che viene prostituita non sceglie di farlo e si parla quindi di tratta. Ciò si colloca ad un polo di un continuum in cui si evidenziano situazioni di "moderna" schiavitù, che scivolano dal condizionamento espresso attraverso una coercizione, come l'utilizzo del noto rito voodoo per le nigeriane, etc... alle minacce per la vita delle ragazze e dei loro famigliari, come avviene in alcuni clan albanesi. Si osservano situazioni di estrema violenza e quindi di totale impedimento della libertà e situazioni in cui è difficile capire, nell'ambito della ambiguità della proposta emigratoria nei paesi occidentali, quale sia stata la possibilità di scelta delle ragazze, allettate da offerte di lavoro da parte di compatrioti, quali accompagnatrice nei locali notturni, mansioni in locali turistici e centri di bellezza. Il prostituirsi o l'essere prostituita si collocano lungo un continuum in cui è difficile dire fino a che punto c'è un consenso, o un imbroglio, o c'è un consenso estorto con diverse modalità. La scelta può diventare successiva, di comodo, perché ad dato un punto della vicenda si apprezzano alcuni vantaggi secondari. E’ importante essere consapevoli delle ambivalenze e delle ambiguità per evitare di immaginare unicamente una persona ridotta in schiavitù. Non è così. Se alcune situazioni sono veramente intollerabili e gridano vendetta, altre situazioni sono quantomeno più confuse, dove una visione unicamente dicotomica, quale vittimacarnefice, può risultare semplicistica e fuorviante. Non dobbiamo percepire la ragazza sulla strada solo e unicamente come la vittima. In una situazione di privazione e semi ambiguità che si crea intorno alla proposta del progetto emigratorio, e c’è sempre la speranza/delusione di approdare in un luogo in cui la propria vita cambia e migliora. Dietro ad ogni progetto emigratorio c'è sempre una speranza di emancipazione: dalla povertà, dalle condizioni di vita del luogo di provenienza, da una condizione femminile che molto spesso è opprimente e insopportabile. Una spinta fondamentale nella scelta di venire in occidente è dettata dal desiderio di emancipazione. Alcune intuiscono quale sarà il percorso e lo temono, altre ne sono consapevoli, altre vengono ingannate; nel complesso è un terreno molto magmatico in cui bisogna sempre differenziare situazione per situazione. Il resto del percorso avverrà nel rapporto con i clienti perché tramite l'interazione lavorativa con loro e non solo, cambia il tenore di vita, cambiano le abitudini radicalmente, oltre alla totale e indifesa esposizione alle sirene del consumismo occidentale. I proventi dell'attività di molte ragazze russe e ucraine vengono reinvestiti nell’acquisto di beni di consumo, dai cosmetici alle lavatrici, che vengono inviati ai loro paesi d'origine, con un'attività di rivendita che genera ulteriore business. I meccanismi sono complicati, i vissuti differenziati e si intrecciano con le culture d'origine e con il disegno criminale e mafioso delle organizzazioni, che ne approfittano. Lo sfruttamento non è sempre brutale, non si limita a prostituire la ragazza e a prendersene i proventi, ma a volte vi è un vero e proprio "contratto' in cui si consente alla ragazza di mandare alla famiglia alcune rimesse che possono garantire una vita migliore a chi è rimasto in patria e 56 consentire una buona reputazione e immagine nel paese d'origine. Perché questa digressione? Perché non dobbiamo fare l'errore di considerare la scelta di stare sulla strada come una scelta totalmente subita, dato che non è sempre così. Inizialmente può essere cosi, poi si può sviluppare "acculturazione" e produrre un certo consenso, che però è oscillante, maggiore o minore in certi periodi in rapporto alle vicende attraversate e ai rapporti che si riescono a ride- finire con la propria organizzazione di sfruttamento. E dato di base con cui si ha a che fare è l'ambivalenza rispetto a ciò che si fa; da una parte c'è repulsione e dall'altra ci si abitua e si produce, come per le sostanze stupefacenti, una certa assuefazione. Il dato di ripulsione e rifiuto viene progressivamente meno; si apprezzano sempre di più i vantaggi, (vestiti, conoscenze diverse, giri in cui si viene inseriti) e il discorso diventa molto individualizzato, persona per persona. Si vorrebbe fare qualcos'altro ma non è semplice. A volte capita di offrire loro un lavoro con l'opportunità di un guadagno di un milione e mezzo al mese e di sentirsi rispondere che è una cifra abitualmente “fatturata" in una giornata o due di lavoro sulla strada, ben poca cosa in termini di tenore di vita, in termini di possibilità di consumi e di invio di rimesse per il mantenimento della famiglia di origine. Ci troviamo davanti a paradossali contraddizioni, per cui non dobbiamo sottovalutare la grande attrazione che l'attività progressivamente esercita. E’ l'ambivalenza di fondo che farà si che alcuni percorsi di uscita non funzioneranno, perché alla fine prevarrà il richiamo del "giro" e di tutto ciò che consente di realizzare. Se l'organizzazione non esercita la forza bruta ma si avvale di condizionamenti più sottili riesce ad ottenere un'adesione più forte e convinta. Se siamo di fronte a una scelta che non è totalmente una scelta ma può diventare parzialmente una scelta, se essa è in molte situazioni governata dall'ambivalenza, noi non dobbiamo cadere in due fondamentali pregiudizi: il pensare che la ragazza sia una prostituta sempre prostituita e di conseguenza sempre vittima, induce a generare un atteggiamento sempre giustificazionista e impedirà di intravedere la resistenza al cambiamento e la necessità di differenziare strategie e anche obiettivi dell'intervento. Diversamente, percepita l'ambivalenza, cadere nel comportamento opposto, in un atteggiamento moralistico, di rifiuto e di con- danna. Occorre tenere una posizione di equilibrio, non scivolare nei due comportamenti opposti, non adottare una logica bianco e nero; occorre riconoscere le "complicità' per trattarle; occorre evitare il rifiuto e non cessare l'aiuto, se la ragazza non vuole "salvarsi". E importante riuscire a creare una distinzione tra morale e moralismo. Ciò non significa abdicare alle nostre valutazioni morali. Il moralismo è una morale a scartamento ridotto, una morale senza conoscenza, che tiene in gran conto i principi, ma non li articola con l'esperienza ulteriore della realtà e non fa uno sforzo di conoscenza, per cogliere tutti gli aspetti di una realtà in cui si cerca di tenere viva la tensione sui principi, pur a certe condizioni. Occorre evitare l'errore giustificazionista tout court e quello moralista. Sull'ambivalenza si lavora senza scandalizzarsi e senza tirarsi indietro, al di là della qualità delle scelte delle ragazze: scelte non libere, condizionate, scelte parzialmente condivise. Ciò determina il modo in cui noi ci posizioniamo di fronte al 57 problema e di fronte alle ragazze che hanno questo problema. Dobbiamo sempre chiederci qual è la nostra posizione sapendo che dev'essere nel nostro repertorio tollerare la confusione dei percorsi a zig zag, perché ciò che li genera è un'ambivalenza che si può chiarire e risolvere solo con il tempo. Occorre cercare di capire quali sono nelle ragazze gli atteggiamenti più tipici che ci troviamo ad affrontare. Alcuni atteggiamenti sono comuni a tutte, perché sono il risultato di una condizione comune. Il primo è la loro paura. L’atteggiamento sviluppato verso l'altro, verso il bianco in particolare, verso ciò che è straniero, per loro è combattuto: da una parte si intende il bianco come potenziale risorsa, ma lo si percepisce anche come pericolo. E primo problema che si pongono è capire se l'altro con cui si rapportano è una risorsa o un peri- colo. Devono essere aperte, ma anche guardinghe, andare incontro ma anche essere pronte alla difesa. Al di là di questo atteggiamento generale, le paure sono specifiche, ben precisate. La paura è il rapporto con la loro organizzazione. Se sono sulla strada e non riescono a tirar su i soldi che devono portare ogni mattina, la paura di non riuscire a raggiungere il fatturato richiesto è direttamente proporzionale alla prepotenza dell'organizzazione che le controlla. Là dove non c'è tolleranza ed elasticità e vengono utilizzati i metodi più violenti, la paura di venire picchiata e sfigurata esiste ed è reale. La seconda paura è quella di essere scoperta a trasgredire sulla strada le regole della organizzazione. Con i clienti spesso alzano il prezzo, vengono richieste prestazioni particolari e le ragazze hanno la possibilità di "fare la cresta" sul guadagno, ma se l'organizzazione le scopre le punisce severamente. La terza paura è quella del cliente. I clienti si articolano in una vasta gamma di tipologie. Quello sconosciuto e totalmente imprevedibile è quello che fa più paura. Un'altra paura riguarda le forze dell'ordine, che posso- no scoprire la loro identità clandestina e rimpatriarle. C'è un'ultima paura, banale ma non sottovalutabile, che è il freddo, soprattutto per le ragazze africane; l'arrivo del cliente è una buona occasione per salire sulla macchina e condurre la contrattazione al caldo. Gli interventi di strada con á camper che offre un riparo e bevande calde sono un piccolo aiuto materiale che facilita il rapporto. Si è di fronte a un coacervo di paure che le persone vivono e ci permettono di capire alcuni atteggiamenti. Non scordiamo che la paura genera aggressività. Un secondo atteggiamento tipico è quello della diffidenza, inevitabile in un primo periodo di conoscenza: c'è una distanza da colmare e nel momento in cui cerchiamo di avvicinarci, le ragazze ci guardano con sospetto; è questo il primo muro da superare per poter instaurare la relazione. Si capovolge il paradigma della relazione di aiuto- normalmente si instaura da una domanda che ci viene proposta, qui siamo noi che sollecitiamo l'incontro. Per riuscire a sgretolare il muro della diffidenza, 9 primo sistema per guadagnarsi la fiducia è di offrire un aiuto concreto facilmente fruibile: dai cinque minuti passati al caldo alla possibilità di fare una visita ginecologica. Ci troviamo di fronte a persone che nella loro vita non hanno sistematica- mente vissuto esperienze di rispetto. E’ importante che, nella nostra comunicazione nei loro confronti, sappiano cogliere questa dimensione profonda, che noi le rispettiamo comunque come persone, al 58 di là dell'attività che conducono. Noi non ci rapportiamo con quello che fanno ma ci rapportiamo con quello che sono. Non con 9 loro ruolo, ma con la persona. In un saggio intitolato "Stigma, l'identità negata', E. Goffman descrive quanto sia importante la prima immagine che una persona offre nel definire come ci si rapporta con lei, nel determinare la distanza relazionale che si costruisce. Goffman fa l'esempio di un cieco che attraversa la strada con un cane con tanto di bastone bianco; in quanto cieco evoca la percezione che le persone hanno di lui e le modalità con cui ci si rapporta: non con la persona, in realtà ma con la sua cecità. Solo se noi ne approfondiamo la conoscenza si scoprirà che sopperisce alla sua cecità con altre risorse: solitamente con una cultura molto ampia, con delle riflessioni profonde. In tal modo conosciamo una persona che non è solo cieca e nel frattempo definiamo in maniera diversa la nostra relazione con lui e la distanza diminuisce. Ruolo e aspetti esteriori definiscono il modo di relazionarsi. Dobbiamo essere capaci di andare oltre, non fermarci alle prime apparenze e tantomeno ai ruoli. Il rispetto è una modalità che ci fa guadagnare fiducia. Rispettare vuol dire non giudicare e accettare ciò che sta avvenendo nella situazione. Le ragazze in strada vanno riconosciute non per ciò che fanno, ma anche per quello che vorrebbero essere, per quello a cui aspirano. Il rispetto è comunicato non solo verbalmente, ma soprattutto dal non verbale: come le guardiamo, che distanza fisica teniamo. Rispettare non vuol dire essere troppo guardinghi, perché in questo modo non si è comunicativi in senso affettivo; è necessaria una certa vicinanza, ma non troppo perché può essere fraintesa e percepita come invadenza. Una comunicazione è rispettosa quando sa vedere la persona al di là del ruolo. La modalità del rispetto si concretizza nel caratterizzare la relazione nel momento in cui si offrono dei servizi. C'è sempre il rischio di organizzare dei servizi molto estesi e molto importanti, però anche molto routinari, in cui si perde l'elemento di umanità e quindi attenzione e rispetto; si rischia di diventare dei servizi "bancomat". qualcuno viene, suona il campanello e si eroga il servizio. Rispettare una persona, significa farle percepire che è importante per noi, riuscire a far passare un tipo di comunicazione: «guarda che io mi interesso a te, tu in realtà, al di là di quello che sta succedendo, sei importante per me". Questa comunicazione, anche se non arriva al primo incontro ma occorre tempo perché sia percepita, è fondamentale. Se la persona la coglie c'è la possibilità di costruire una relazione solida e di diventare punto di riferimento. Un altro problema con cui dobbiamo fare i conti è l'aggressività. Un’aggressività, indipendentemente da quanto ciascuno di noi se ne porta dentro, si apprende. Si impara molta aggressività stando sulla strada; fa parte delle leggi della sopravvivenza: bisogna difendere quei 10, 20, 50 metri di marciapiede dal- l'ingerenza della concorrenza; vuol dire reagire agli improperi che ti lanciano certe persone quando ti passano davanti in macchina. Bisogna difendersi e quindi bisogna imparare ad essere aggressivi. Chi non lo è, impara ad esserlo. La domanda di aiuto già è confusa, già è ambivalente, inoltre molto spesso è mal posta. Non è una domanda, ma è una pretesa. "tu mi devi dare questo". Occorre gestire l'aggressività. In psicologia si dice che l'aggressività o deriva da una situazione di frustrazione o è una maschera, un 59 comportamento che si apprende per- ché è funzionale a certe situazioni. Quando le persone stanno male, molto spesso usano l'aggressività per comunicare il loro malessere, come i bimbi che quando stanno male fanno star male i genitori, perché non sanno esprimersi: questo è un modo attraverso il quale si comunica, si contagia una sofferenza. Di fronte a queste domande/pretese è necessario per un verso difendersi, mettere uno scudo, ma per l'altro non è utile contro-aggredire. Le persone, 'dimenticando" la propria, percepiscono solo la nostra aggressività, si auto-identificano come vittime, per cui la contro-aggressione, anche solo sul piano personale, è contro-producente. Se l'aggressività è un pretesto per sfogare un malessere, per tenere su una maschera, non bisogna cercare di avere ragione sul contenuto espresso. E’ impresa vana. E’ più utile invece stare sulla relazione, spostando il discorso dal contenuto al rapporto che noi intratteniamo con le persone, e ragionare sulle ragioni di un buon rapporto. Non si deve cadere nella trappola di reagire sul con- tenuto o sul piano dell'aggressività; altrimenti avviene ciò che si definisce “escalation simmetrica": di fronte ad un'aggressività si risponde con un atteggiamento altrettanto aggressivo, l'altro reagisce ulteriormente e si crea la spirale negati- va. Un’aggressività deve essere gestita. In parte la dobbiamo assorbire (ma neanche troppo) e metabolizzare con un atteggiamento di mantenuta calma. Ciò non vuol dire che non ci si difende dall'aggressione, ma decisivi sono la modalità e il mantenimento di una possibilità comunicativa. Un altro atteggiamento con cui si deve fare i conti è la passività. Sorprendentemente queste ragazze non risultano molto intraprendenti. Al di là di ciò che hanno appreso, strettamente connesso alla loro attività, molte di loro non si sanno orientare, tendono molto a delegare la soluzione di problemi e si rinchiudono in un atteggiamento passivo, regressivo, anche se ovviamente non per tutte è così. Non bisogna assolutamente accorarsi la delega; non bisogna far nulla senza di loro; deve sempre essere stimolata una loro compartecipazione. Il segreto della relazione di aiuto è di non fare delle cose al posto di qualcun altro, ma di attivare l'altro, che accompagnato faccia la propria parte, perché ciò che ci chiede riguarda lui. Contrariamente si rischia di dar luogo ad opportunismi di ogni tipo, a sfruttamenti relazionali. Se il volontario che si attiva per far uscire una ragazza dal giro le trova un avvocato, un medico e fa tutto da sé senza l'attivazione della ragazza, si può anche sentire importante e realizzato, ma se la ragazza non prende coscienza di tutto ciò e non si attiva anche lei, non riuscirà ad usufruirne pienamente, né le apprezzerà fino in fondo, perché non se le è conquistate, non se le è guadagnate, non le ha portate avanti lei in prima persona. Questo è un atteggiamento sbagliato perché aumenta la passività delle persone, invece di attivarle, con un effetto paradossale: più noi facciamo, più ci richiedono cose da fare al posto loro. Si genera così una dipendenza relazionale. Devono pur imparare anche i meccanismi della nostra burocrazia e, finché non si attivano, non ci riusciranno mai. K. Lewin sosteneva che il mondo impari a conoscerlo solo se cominci a tenta- re di cambiarlo. Solo se ti dai da fare; il modo migliore per prevedere il futuro è contribuire a determinarlo. Attivandoci 60 apprendiamo e possiamo entrare di più in relazione; se invece delego, rimango all'interno di un atteggiamento di passività. E’ estremamente importante la differenza tra accompagnare le persone e portare le persone. Portare è come se le prendessimo di peso, spostandole e sostenendo noi tutto lo sforzo. Può capitare che loro non si rendano neanche conto di dove sono arrivate. Invece se noi le accompagniamo, le cose vengono fatte insieme. Condividere è difficile perché anche noi facciamo una fatica in più (i tempi si allungano, avremmo fatto prima da soli), ma è strumento educativo ed emancipatorio. Le culture delle persone prostituite sono molto diverse, ma un dato comune riscontrato è che molte di queste culture sono immerse in un atteggiamento fatalistico nei confronti della vita. Non sei tu che determini il tuo destino, ma è il tuo destino che determina te: ci si aspetta che gli avvenimenti accadano di per sé, che le cose arrivino, pensando il proprio ruolo come molto relativo. In occidente si è sviluppato un atteggiamento di attività e di protagonismo nei confronti dell'ambiente; da una concezione di tipo fatalistico, rispetto alla cui esasperazione si è anche critici, discende molta più passività. Il nostro compito è, cercando di stimolare il passaggio da un atteggiamento passivo ad uno attivo, far guadagnare maggior fiducia in se stesse, nelle persone che aiutiamo. Spesso ci accorgiamo che c'è poca fiducia in sé , pochissima sicurezza al di là degli atteggiamenti appresi nel loro ruolo, in cui sanno come devono comportarsi. Fuori dal ruolo predomina l'insicurezza. Due sono gli aspetti da far prevalere e che sono tra di loro correlati, la fiducia di sé e la funzione della costanza: una determinazione che sa mantenersi tale nel tempo. Per far questo è importante porsi dei micro obiettivi di percorso più raggiungibili, che non i grandi obiettivi della denuncia dello sfruttamento, dell'emancipazione dalla prostituzione e la costruzione di una nuova vita subito. Il concetto che ci deve guidare all'accompagnare, (e non nel portare), è quello della "frustrazione ottimale". Ciò significa che rispetto alle capacità di quella singola ragazza, dobbiamo porle un obiettivo in grado di essere raggiunto, con un po' di sforzo e con un po' di applicazione, mettendo molto del suo pur con il nostro aiuto. Se lei riesce a raggiungere questo obiettivo ne ha due vantaggi: è gratificata di per sé per il successo e si rende conto che può farcela da sola, interiorizzando un atteggiamento sulla propria capacità di attivazione. In questo unico percorso sviluppa in sé una funzione che molto spesso è carente, il tollerare le frustrazioni per raggiungere un obiettivo che richieda un qualche sforzo, contribuendo a costruire la dimensione della costanza. Se si sbaglia la scelta degli obiettivi, la ragazza non ce la fa, ci si sostituisce o la ragazza non regge la frustrazione dell'insuccesso e molla 'tutto, si demotiva e interiorizza, confermandola, una inadeguata immagine di sé stessa. Prima di porci degli obiettivi dobbiamo conoscere bene le persone, perché il rapporto e l'intervento non possono che essere individualizzati. E percorso stesso ha delle fasi che non sono generalizza- bili e quando vengono proposte in modo rigido vengono sconvolte dall’individualità di ogni singola ragazza. Un’individualizzazione del percorso è un criterio metodologico fondamentale. Non c'è ragazza prostituta o che si prostituisce che non porti dentro di sé un profondo senso di 61 colpa e un profondo senso di vergogna; anche quando apparentemente non sembra così, vergogna e colpa sono sempre presenti, pur rimosse o nazionalizzate. Un aiuto, su questo piano, può consistere nel cercare di portarle alla luce, anche se non sempre è facile né opportuno, perché non sempre ne vogliono parlare. Le aiutiamo soprattutto in maniera indiretta, attualizzando e concretizzando la scelta che stanno facendo. Nella rielaborazione noi siamo molto aiutati dalla scelta che le ragazze stanno conducendo, che è quella di uscire dal giro e dall'impegno che ci stanno mettendo. Ci sta "fare i conti con il passato", anche recente, se noi riusciamo a collocarlo dentro una storia che ripercorre tutto il progetto emigratorio, che riprende la loro condizione di vita nei paesi d'origine, che riprende le modalità con cui sono approdate in Italia e le modalità di esercizio della loro attività. Nel ripercorrere tutto questo percorso, ecco che possiamo finalmente concederci di essere un po' più giustificazionisti. Perché nei fatti c'è un percorso d'uscita e dobbiamo arrivare ad una riconciliazione con il passato, darne una spiegazione, consentirne una collocazione e rielaborazione. Devono essere in grado di “perdonarsi" in qualche modo il proprio passato se viene pesantemente vissuto con vergogna e colpa. In tutto questo l'attenzione prioritaria è nel rispetto dei tempi, senza forzarle a parlare o a raccontarsi. LEZIONE 4 La tossicodipendenza di Leopoldo Grosso Quando una famiglia “scopre” la tossicodipendenza del figlio si notano, in genere, due comportamenti contrapposti, entrambi disfunzionali alla situazione. Dal non voler vedere, al dramma (gli estremi si toccano). Se la realtà fa troppo male, se sembra accadere quello che non si sarebbe mai voluto che accadesse, i genitori tendono a non “vedere” i fatti, a interpretare in senso benigno i comportamenti del ragazzo, a credere acriticamente a tutte le sue spiegazioni. ~ il meccanismo di difesa di negazione della realta, troppo dolorosa da accettare, per cui ci si illude, chiudendosi gli occhi, che tutto vada nella direzione di sempre, che nulla eccessivamente perturbante sia successo. ~ cosi che spesso una madre quando, riassettando il giubbotto del figlio, vi trova in tasca una siringa, e chiede ansiosamente spiegazioni, si accontenta di risposte tipo: <<E di un mio amico che si fa, e siccome sua madre lo perquisisce quando rientra, mi ha chiesto di tenergliela>>. oppure: <<Tutti oggi hanno provato a farsi, ma cosa credi, io non sono stupido...>>. Il meccanismo di negazione della realta, se serve a salvaguardare il sistema di sicurezze dei genitori, non aiuta invece il figlio a rendersi pienamente conto dei suoi problemi, a compiere scelte diverse, a far ricorso a qualcuno che possa dargli una mano. Si protrarra inutilmente nel tempo un confronto che e necessario, invece, anticipare rispetto a una verita che solo episodi eclatanti quali l’intervento di Pronto Soccorso, l’arresto da parte delle forze 62 dell’ordine, la comparsa di una malattia, si svelera successivamente in tutta la sua durezza. Altre volte le famiglie reagiscono in senso opposto. L’uso di una droga da parte del figlio viene iperdrammatizzato, quasi senza fare distinzione alcuna tra le diverse sostanze e la loro differente pericolosita. Il comportamento di esasperazione assume modalita differenti a seconda che prevalgano, di volta in volta, la rabbia, la depressione, l’ira o il ricatto affettivo. Molto spesso il comportamento di disperazione e aggressivita si traduce nell’espulsione del figlio da casa, che rappresenta da una parte la punizione per il dolore arrecato, dall’altra una difesa da una situazione giudicata insostenibile sia per i componenti della famiglia, sia socialmente per l’esposizione al giudizio altrui. Imparare a convivere con il pro~3lema senza vergogna e senza sensi di colpa Dopo la prima fase di shock, la famiglia deve spesso fare i conti con altre due reazioni che, a poco a poco, rischiano di prendere il soprawento e di interferire negativamente con le scelte razionali e la tranquillita emotiva che, per quanto possibile, fungono da presupposti a un ruolo di aiuto. Sono i sentimenti di vergogna e di colpa. La vergogna e provata nei confronti dei parenti, degli amici, dei conoscenti, collegata all’esposizione di un fallimento familiare, rispetto al quale si temono giudizi, commenti maligni, rifiuti... La colpa e collegata all’idea, che si insinua immediatamente, di non essere stati bravi genitori, difficilmente capaci di tutelare il figlio da un pericolo da cui bisognava stare in guardia. La famiglia si colpevolizza e, al suo interno madre e padre spesso si rimandano l’un l’altro gli errori presunti, i reciproci sbagli educativi. Tra colpa e vergogna si apre una spirale negativa in cui la famiglia rischia di precipitare. La vergogna che si coglie nel dover sostenere lo sguardo degli altri si scarica nella colpevolizzazione tra i coniugi. Il risultato e il difficile raggiungimento di uno stato di tranquillita e di “tregua” sia all’interno della casa che fuori. Se si sta male in casa non ci si puo rifugiare fuori e viceversa. Ci si sente attanagliati dal problema, senza possibilita di luoghi in cui si e compresi, accettati, aiutati. Non a caso emergono fantasie di fuga, a volte realizzate. Sappiamo di una famiglia che si e addirittura trasferita all’estero, in una citta in cui no~ c’era alcuna persona e ne attivita ad attenderla, unicamente per cercare di liberarsi dai sensi di vergogna e di colpa e sperando che il figlio, cambiando completamente ambiente, potesse sradicarsi dalla dipendenza. Una proposta percorri1oile: lasciarsi aiutare Se la vergogna e la colpa non prendono il soprawento in maniera distruttiva, il dolore e la sua elaborazione possono portare ad atteggiamenti costruttivi. La famiglia puo contenere il dolore impegnandosi direttamente nel percorso riabilitativo accanto al figlio: favorendolo, accompagnandolo, ottenendo i primi risultati parziali quali la disassuefazione e la stabilizzazione dello stato di remissione. Per poter aiutare nel modo 63 piu opportuno, la famiglia deve essere ella stessa in grado di chiedere aiuto, superare il muro della vergogna, voler fare i conti con i propri sensi di colpa, colpe reali o presunte, mettersi in discussione e rendere in qualche misura visibile la propria difficolta. Bisogna quindi che compia due primi passi: − riconoscere la gravita del problema; − riconoscere la necessita di chiedere aiuto. Sara poi la competenza e la disponibilita degli specialisti (servizi per le tossicodipendenze, associazioni del privato-sociale) ad aiutare i genitori a non commettere sbagli, a non fare errori di precipitazione, ad assumere gli atteggiamenti piu idonei. Non bisogna illudersi che ci siano facili scorciatoie: che con una disintossicazione si risolva il problema, che basti chiudere la porta in faccia al figlio per fargli “toccare il fondo” al piu presto, affinche chieda aiuto. Ne i viaggi della speranza verso cliniche costose che compiono solo un intervento parziale, ne “sbatterli fuori casa” nella speranzaillusione che subito si rawedano e nel frattempo non capiti il peggio, aiutano le famiglie a superare le diffficolta. ~ piu utile un impegno costante, paziente, in cui ogni giorno si e disponibili al confronto, con atteggiamenti fermi, tenaci, ma anche flessibili, poiche ogni persona tossicodipendente e in parte simile, ma in parte anche diversa da un’altra nella stessa situazione, per cui gli interventi adeguati agli uni si rivelano ineffficaci o controproducenti agli altri. Quando il ‘gruppo” aiuta Il confronto settimanale con altre famiglie che hanno o hanno avuto la stessa diffficolta costituisce uno strumento utile per affrontare la situazione e contribuire a rendere i genitori un valido aiuto per il percorso riabilitativo del figlio. Nel gruppo tra famiglie si condividono le stesse sofferenze, si confrontano esperienze simili, si socializzano i diversi sforzi compiuti. Come una famiglia ha affrontato un problema, puo offrire un’indicazione. Quei genitori che possono affermare di avercela fatta consentono importanti iniezioni di speranza e di fiducia. Anche per chi, insieme al figlio, sta attraversando momenti drammatici, la vicinanza e la presenza di altri genitori si rivelano di conforto e di aiuto. ~ fondamentale, soprattutto all’inizio, quando si deve fare i conti con il convincere il figlio a farsi aiutare, attingere dall’esperienza delle altre famiglie non solo le conoscenze per meglio poter prevedere le conseguenze delle proprie scelte e dei propri atteggiamenti, ma soprattutto il sostegno psicologico e affettivo che fa sentire meno soli e meno impotenti. Far parte di gruppi di familiari per molti genitori rappresenta l’unico momento di reale comunicazione e di contatto con l’esterno. Le famiglie con un problema di tossicodipendenza che riguarda un figlio tendono a chiudersi, a evitare un difficile confronto con i parenti, a “tagliare” tutti i rapporti sociali, 64 perche vissuti ormai come “super~ui” oppure impregnati di vergogna, se non addirittura sfiorati dalla colpa, come “svago” oggi non piu meritato. La tossicodipendenza del figlio, che per molti genitori significa anche sostenere un peso economico non indifferente in quanto ricadono su di essi i diversi costi dell’esperienza della droga (non a caso molti genitori non consentono al figlio di mantenere la residenza formale presso il proprio nucleo), significa soprattutto isolamento relazionale e sociale. Le associazioni di familiari, in collegamento con le comunita e con i servizi pubblici, rappresentano un punto di riferimento importante, non solo come orientamento e sostegno nelle battaglie per l’emancipazione dallo stato di tossicodipendenza del figlio, ma anche per consentire la conservazione degli equilibri psicologici tra i genitori, un aiuto alle loro dinamiche relazionali, uno spazio di apertura e di confronto sistematico. La prevenzione attiva alle dipendenze Leopoldo Grosso Vorrei iniziare parlando dei concetto di bisogno: innanzi tutto dobbiamo fare una distinzione fra bisogno fisiologico e bisogno psichico. Normalmente parliamo del primo con un'accezione positiva: è contestuale all'epoca della vita, è uno stimolo, una molla verso il cambiamento. Solitamente il cambiamento", si impoverisce nel suo aspetto di risorsa nel momento in cui "si cronicizza, ed esistono dei chiari indicatori di impoverimento: I. le risorse che stanno intorno vengono a mancare, diventano inuùlizzabili; 2. la progressiva incapacità del soggetto di vedere e utilizzare queste risorse; 3. un indicatore più soggettivo, ma forse più pregnante: l'eclissi progressiva della speranza di cambiare, il cui correlato comportamentale è una sempre minore attivazione dei soggetto nel tentativo di cambiare. Questo processo comporta tre diversi atteggiamenú: a) " tento di cambiare agendo sulla situazione, per trasformarla". Si tratta di cercare di creare un contesto diverso come se questo magicamente comportasse un proprio cambiamento; b) "mi capiterà qualcosa che mi cambierà"; manca lo sforzo attivo di cambiare la situazione, ma si vive in attesa. Questo è l'atteggiamento, per esempio, della ragazza tossicodipendente che rimane incinta e ritiene che quell'evento le cambierà tutta la vita; e) l'ultimo atto: la constatazione che " non capita mai nulla e quindi tanto vale..."; è la nazionalizzazione dei comportamenti, il passaggio dall'atteggiamento passivo-fatalistico ad uno passivo-nichilista, per cui l'impossibilità di cambiare è teorizzata e nazionalizzata, e di conseguenza ci si adagia sui vantaggi minimali della situazione esistente. Questo ci porta a fare delle osservazioni: innanzi tutto notiamo che la cronicizzazione dei disagio ha degli elementi sia in senso oggettivo sia in senso soggettivo. Inoltre il disagio si mescola presto, pur con modalità differenti, all'uso di sostanze; questi due problemi (disagio cronicizzato e uso di sostanza) miscelati fra di loro, costituiscono un tutt'uno e vanno trattati insieme: non si possono ritenere prioritari l'uno o l'altro. Infine, possiamo osservare che anche nella cronicizzazione rimane un'enorme differenza delle situazioni di disagio, rispetto all'origine, agli sviluppi e ai quadri di consistenza. Il rischio che corriamo è quello di farci omologare ad un'unica 65 visione del disagio e di usare sempre gli stessi strumenti; pur rimanendo nel campo della dipendenza che comporta l'adeguamento totale della persona a certi modelli, noi dobbiamo fare questo sforzo a ritroso di differenziazione. La prevenzione secondaria agisce su un disagio già presente e volto verso la cronicizzazione. Io non affermo affatto che si debba rinunciare a questo tipo di intervento, ma ritengo che ci si debba prima interrogare su quale sia il materiale su cui lavorare: dobbiamo prevenire il rischio in cui un ragazzo può incorrere con più probabilità, o i rischi che sono in circolazione? Nel primo caso, prevenzione secondaria significa prendere in carico il ragazzo (dunque il singolo e il suo contesto); fare prevenzione primaria vuol dire invece prendere in carico il contesto sociale: sono entrambe necessarie, dobbiamo mettere in moto processi in entrambe le direzioni. Nella strutturazione del disagio possiamo tipologizzare (pur nei limiti che tutte le tipologie possiedono) tre percorsi, tre stili di vita che devono incrociarsi con fattori protettivi, per non sfociare nell'ingresso al consumo e alla dipendenza da sostanze. Il primo è quello tipico, classico, "lo zoccolo duro della successiva dipendenza": emarginazione e processo deviante; il secondo percorso è costituito dalla marginalità e dalla spirale dell'inconcludenza; il terzo è un percorso più difficile da riscontrare e da riconoscere (perché più raro e coinvolge utenti che non ci arrivano subito), ossia la compatibilità dell'uso di sostanze con il lavoro, la famiglia, una buona immagine sociale. Proviamo ad analizzare più approfonditamente i singoli percorsi citati: Prima tipologia: emarginazione e processo deviante. Questo è un percorso in genere già prevedibile e profetizzabile fin da quando i soggetti sono bambini, ma, paradossalmente, è anche quello sul quale è più difficile intervenire, sul quale i nostri strumenti non hanno successo, si infrangono. Sono stato riscontrati, a questo riguardo, quattro elementi ricorrenti: I. una famiglia multiproblematica 2. le difficoltà affettive che agiscono sul motore dell'apprendimento, cioè sulla capacità di attenzione e concentrazione, con conseguenti effetti sull'ingresso a scuola e sul percorso scolastico in genere. Questi bambini non si fermano mai, hanno difficoltà a soffermarsi, non perché incapaci di apprendere, ma per una serie di fattori, fra i quali il gap con cui arrivano già a scuola (per es., per quanto riguarda gli aspetti linguistici). Alle scuole elementari, con le tre maestre, il bambino riesce ancora ad adattarsi; non recupera sul piano dell'apprendimento, ma è contenuto il terzo passaggio: 3. la reazione compensativa del bambino, che diventa ragazzino, sul piano comportamentale: "Io non ho una identità scolastica di successo, cercherò di procurarmene una compensativa"; questa è la storia di tutti i ragazzini che la vecchia nosografia definiva "caratteriali". Questo passaggio, più contenuto durante la scuola dell'obbligo, avviene generalmente durante il cielo secondario, quando la capacità di bolding che esiste nella scuola primaria, con più insegnanti attente e coordinate, scompare, nonostante la buona volontà di molti insegnanti. Questo divorzio si consumerà durante la scuola media, e sarà consensuale: il bambino non andrà più a scuola, dove non si trova bene, mentre gli insegnanti e la classe in qualche modo "se ne liberano" (pensate a tutte le difficoltà che incontrano i progetti che combattono la dispersione scolastica). 4. 66 la reazione della scuola alle difficoltà che sono portate dal ragazzo, di fatto la messa alla prova della sua capacità di holding. Il seguito di questa storia è noto: dopo l'evasione scolastica vengono la strada, la micro- delinquenza, le bande di quartiere, l'avvicinamento alle sostanze che prima costituiscono una modalità per procurarsi i soldi, poi divengono oggetto di consurno e dipendenza, e tutti gli altri rischi (sanitari, sociali e giudiziari). Questi ragazzi dimostrano che la tossicodipendenza non è interclassista fino in fondo: chi più rischia, più paga. Dobbiamo allora prepararci accuratamente un programma di intervento preventivo. Le sue caratteristiche dovrebbero essere: a) la precocità; questa è importantissima, ma lo è altrettanto la modalità con cui l'intervento precoce avviene, ossia la segnalazione: deve essere intelligente, perché spesso le segnalazioni si riducono a richieste fatte dalla scuola, da un insegnante d'appoggio, o ad una certificazione medica. Agendo così non facciamo prevenzione, ma mettiamo una ipoteca pesante sul ragazzo, inserendolo in circuiti relazionali differenziati rispetto alla classe. Dunque, è importante che l'intervento sia precoce e che parta con le modalità giuste: bisogna fare un'analisi della domanda. b) una presa in carico "soft": non psicologica/psichiatrica, ma educativa, capace di avvalersi di competenze "psi-", ma in retrovia (altrimenti si passa all'etichettamento). Inoltre, la presa in carico deve essere in continuità con l'ambiente del ragazzo, e l'operatore deve operare un innesto dolce, accettato, accreditato agli occhi del ragazzo nel suo ambiente. Non si tratta di creare un nostro setting, ma di inserirci in quello del ragazzo. e) la continuità personale dell'operatore che attua l'intervento (si tratta di interventi lunghi, che vanno dalla scuola elementare fino ai 14-18 anni): è necessaria per evitare delle fratture nei passaggi fra servizi e operatori; su questi elementi micro si gioca talvolta la riuscita dell'intervento. Possiamo definire la continuità dell'intervento con un ternúne forte: "adozione di professionismo". Il problema principale, rispetto a questi percorsi, è riuscire a lavorare insieme tra squadre diverse, innescare delle collaborazioni forti fra assistenti sociali del territorio, preventori dei Ser.T, educativa territoriale, neuropsichiatria infantile: tutti questi sono referenti che fanno parte di squadre diverse, che talvolta rispondono a logiche diverse, che hanno funzioni diverse nel corso dell'intervento, il quale richiede una riprogrammazione, un monitoraggio e una valutazione continua. Il primo obiettivo che vogliamo raggiungere è che queste squadre si parlino e definiscano insieme un progetto competente; altrimenti questi ragazzi rimarranno i più prevedibili ma i meno "prevenibiii". Seconda tipologia: marginalità e spirale dell'inconcludenza. Un indicatore forte di questo percorso è ancora una volta il fallimento scolastico, che non avviene più alla scuola dell'obbligo, ma durante il biennio delle superiori: si tratta di una situazione di marginalità progressiva e non di emarginazione. Questo fallimento non avviene per le capacità del ragazzo, per un minore investimento della famiglia su un eventuale proseguimento degli studi superiori o per la ferita affettiva che diviene cognitiva (perché agisce sul motore dell'apprendimento), ma per il tratto più tipico delle situazioni di tossicodipendenza: la scarsa problematico . Gli studi superiori coinvolgono una serie di 67 microfattori del disagio: sono più faticosi, più lunghi, portano fuori casa, possono risultare inutili dai racconti di chi ha già finito, il confronto con il successo è più stringente, sono richieste maggiori capacità di tolleranza. Tutti questi fattori, cumulati, ci permettono di comprendere la curva dell'abbandono scolastico, che ha due picchi: il primo si verifica subito dopo le vacanze di Natale, perché un ragazzino capisce che a casa sta meglio ed ha tempo per riaprire la prospettiva lavorativa (che in realtà è molto più dura di quella scolastica); il secondo avviene immediatamente prima del termine ultimo per ritirarsi: è ovvio che un ragazzino si ritiri prima di vedere segnato in rosso sul tabellone “respinto", magari per la seconda volta. Può per esempio avvenire che il primo anno sia respinto, il secondo ritenti, poi molli tutto; oppure non abbia successo la trattativa con la famiglia, frequenti le scuole private di recupero anni scolastici, paghi, recuperi magari un paio di anni, poi... Sostanzialmente, gli anni che vanno dai 14 ai 18 (dalla terza media al servizio militare per i maschi) diventano gli anni dell'inconcludenza: non si ottiene un diplorna, non si riceve una formazione reale, non si ha un lavoro e non si porta a casa uno stipendio per avere la propria legittimità sociale, la propria "seconda pelle" sociale. Questi, che dovrebbero essere gli anni della formazione, sono anni decisivi: si sta sempre più fuori casa, anche perché in famiglia l'atmosfera diventa pesante ed i genitori non accettano che il ragazzo non lavori e si rivolga a loro per pagarsi gli svaghi serali. In questi ragazzi si struttura dentro un senso di diversità molto più sottile rispetto ai ragazzi della precedente tipologia, un senso di identità e un vissuto fallimentare, distorto (di cui l'insuccesso scolastico è il segno esteriore) che costituisce una minaccia permanente all'autostima e che progredisce verso tre atteggiamenti in successiva radicazione: a) opposizione per la famiglia b) omologazione nei confronti del gruppo dei pari e) compensazione verso le sostanze. Questi tre fattori soggettivi fanno da correlato a tre elementi oggettivi, di contesto, strutturali: a) la mancanza di un percorso formativo, anche alternativo al percorso scolastico classico b) l'assenza di un altro "contenitore" come l'ambiente di lavoro (che certamente ha aspetti positivi e negativi, ma in questo caso prevarrebbero quelli positivi) c) la progressiva ed oggettiva difficoltà a comunicare, con un padre che diventa sempre più insofferente a questa situazione e una madre che, secondo lo stereotipo classico, ha sempre maggiori difficoltà a mediare. In situazioni come queste, esistono due modalità di intervento. La prima agisce sulla spirale dell'inconcludenza, e richiede un collegwnento organico con la scuola, per riuscire ad offrire opportunità a chi "aderisce": tutte le ricerche sottolineano una forte sovrapposizione fra abbandono scolastico (anche alle scuole superiori) ed uso di sostanze. La seconda tipologia di intervento agisce invece sulla marcia di avvicinamento alle sostanze: nel percorso verso l'abuso e la dipendenza da sostanze, sono generalmente distinte quattro fasi: avvicinamento, luna di miele, stabilizzazione, dipendenza; qui siamo ancora nella fase di avvicinamento, nel pieno della prevenzione. Questa soluzione si è rivelata meno valida. Gli strumenti disponibili nel campo della prevenzione secondaria possono agire: - sul singolo, per cui è possibile un trattamento con caratteristiche più 68 informali e mediato dalla sua richiesta d'aiuto, dalla quale non dobbiamo allontanarci sulla famiglia (se il soggetto ci concede il passaporto d'accesso), in una forma più moderata della terapia familiare - sul gruppo, inserendo elementi di anticonfonnismo "nell'anticonformismo omologante" del gruppo. Nel libro "Jack Frusciante è uscito dal gruppo", per esempio, si cita una rock-band alternativa che ha successo, esce dai localini underground, inizia un tour nazionale, ma uno di loro non ci sta, lasciando tutti sbalorditi: la notizia è «Jack Frusciante è uscito dal gruppo!». Noi dovremmo riuscire a sbloccare certi processi di omologazione conforrnistica pesante presente in certe culture chiuse. Gli aspetti di prevenzione primaria sono tutta un'altra cosa:scuola, lavoro, occupazione. Il terzo percorso: la compatibilità. I ragazzi appartenenti a questa categoria vanno a scuola, hanno una immagine di "bravi ragazzi", la famiglia non sa niente dell'uso di sostanze, la fidanzata sa e non sa, spera che non sia... Questi soggetti riescono a rimanere nella clandestinità anche 3-4-5 anni (magari mandando l'amico a prendere la roba in piazza); tuttavia, se non ci fosse la dipendenza, il lavoro, i rapporti, ecc. non starebbero in piedi: la sostanza è funzionale all'equilibrio. In casi come questi, l'intervento è più tardivo, perché è possibile solo quando emergono le prime contraddizioni relative all'abuso di sostanze; questo avviene relativamente presto, perché la soglia di tolleranza per questi ragazzi è molto bassa. Un intervento, per essere efficace in casi come questi, deve prefiggersi tre obiettivi: 1 - lo stanamento (uno strumento pensato in realtà per le vittime dell'emarginazione: siringhe pulite, acqua distillata, preservativi, ecc.) 2- rimanere fedeli al tipo di richiesta dei ragazzi, che è quella di rientrare nella compatibilità, di un momento di tregua. 3- riuscire a passare da questa richiesta di tregua al bisogno della persona, con l'apertura di uno spazio per capire i bisogni, le contraddizioni, le difficoltà. Gli strumenti sono dunque l'out-reach (dobbiamo "stanare" queste persone), la mediazione farrnacologica, l'apertura di uno spazio relazionale. Le domande di prevenzione non sempre sono facili da interpretare: possono essere mute (non ci arrivano), aggressive (trasmesse non attraverso le parole ma con i comportamenti), o mediate da un terzo. Dobbiamo allora prestare molta attenzione per evitare alcuni errori, quali pensare che la domanda non esista quando essa è muta; aspettare (pur pensando che la domanda esista) che emerga da sola (nella tossícodipendenza il paradigma «se non c'è domanda non c'è aiuto» non è poi tanto vero, il problema è come farla emergere, come esplicitarla); aspettare che la domanda sia ben esposta (la domanda è sempre "sporca", questi soggetti ci portano in genere comportamenti auto- o etero- aggressivo ). Vorrei precisare un'altra importante questione. i termini della prevenzione sono "andare incontro", "mediare": mediare fra le culture, i desideri, i comportamenti; tra l'onnipotenza e l'irrealisticità di certi progetti e l'assoluta incapacità di concretizzare qualsiasi iniziativa. Si possono distinguere interventi diretti e interventi che avvengono in stretta collaborazione con gli alleati possibili, che chiamiamo indiretti. Gli interventi diretti devono avere le seguenti caratteristiche: - una bassa soglia una estrema vicinanza relazionale: se questa manca, l'intervento resta a bassa soglia, e 69 poiché non facciamo crescere una domanda, non possiamo portarlo a raggiungere una soglia più elevata.. Fondamentale è l'accoglienza e la prima dimensione dell'accoglienza è il rispetto. La riduzione del danno non è teorizzata per categorie di persone, né si fa per certi periodi, in certe situazioni, non esistono categorie di persone condannate per sempre alla riduzione del danno. Essa è utile quando permette di creare spazi di vicinanza relazionale. - capacità di creare spazi di protagonismo dell'utente: è questa tutta la tematica dell'empowerment, che significa passare da un atteggiamento passivo ad uno più attivo, con tutte le mediazioni del caso. Durante un intervento con un'unità di strada, i ragazzi ci hanno detto: "Noi ci facciamo tutto il giorno, ma vorremmo fare qualcos'altro". Questa affermazione sottende una richiesta: "Fateci fare qualcosa!". Se la tossicodipendenza è per definizione ambivalenza (voler continuare ad essere tossici e sperare di non esserlo più), esistono delle risorse che possono essere utilizzate: una di queste potrebbe essere la concessione di borse-lavoro, perlomeno con i soggetti che stanno tentando di uscire dalla tossicodipendenza con l'aiuto dei metadone; ciò che conta è approfondire degli strumenti per dare spazio a risorse di contrasto con la tossicodipendenza, che sono presenti anche in loro. Noi abbiamo cominciato con una attività banale: siamo andati per le strade con dei sacchi per raccogliere le siringhe sporche; in seguito è stato aperto il giornale di strada, poi sono state utilizzate le competenze dei ragazzi per capire meglio cosa succeda in strada, per fare dei volantini importanti sul Darkene, sulla pericolosità di certi miscugli, per i salvataggi dall'overdose; tutto questo lavoro è stato finalizzato al potenziamento ed allo sviluppo di atteggiamenti costruttivi. Abbiamo capito che non c'è un empowerinent pre-definito: esso deve mediare con le persone e i gruppi. Esiste un secondo tipo di intervento, che abbiamo chiamato "indiretto", e che agisce in stretta collaborazione con gli alleati "naturali": scuola, associazioni giovanili, adulti. L'ultima categoria descritta, in particolare, comprende un target fondamentale, costituito dai cosiddetti "operatori grezzi", ossia quegli adulti con i quali i ragazzi non scelgono di avere a che fare ma con i quali comunque interagiscono: il barista, il vigile, ecc.. (i mediatori dell'interfaccia adulta molto spesso danno una connotazione sociale adulta a questi ragazzi).Dovrebbe inoltre essere incentivato un selfhelp fra le famiglie che non hanno ancora problemi, ed i luoghi privilegiati per incentivarlo sono le scuole, in stretta alleanza con gli insegnanti interessati. Un ulteriore tipo di intervento possibile dovrebbe formare le persone a saper usufruire delle opportunità esistenti. Gli interventi in questo campo devono indirizzarsi al soggetto, al singolo, nelle forme possibili relativamente all'offerta di possibilità reali; se uno dei due elementi viene meno, l'intervento fallisce. Il lavoro con il singolo non è soltanto "psi-", ma si deve avvalere di altri strumenti e puntare, per esempio, a favorire la capacità di "influire su" ed a saper vedere le risorse esistenti. L’insinuarsi dell ‘alcoldipendenza di Leopoldo Grosso 70 L’emarginazione prodotta dalle situazioni di alcoldipendenza è insidiosa e progressiva. Chi, abitualmente forte bevitore, tende a lasciarsi andare e ha sempre piu bisogno di sostanze alcoliche non si rende conto di scivolare, lentamente, ma spesso inevitabilmente, nell’alcoldipendenza. Le “ragioni” del bere L’etilismo, anche se l’aumento di alcolisti giovani è aumentato in modo rilevante negli ultimi anni, è stato, ed è ancora prevalentemente, un fenomeno che riguarda le crisi di mezza eta. Una grave delusione sul lavoro (un licenziamento improwiso, un’aspettativa a lungo covata e poi andata drasticamente delusa...), una scontentezza sempre piu marcata e inquietante rispetto alla propria vita quotidiana (che sembra mancare di vere soddisfazioni, che non riesce a “volare” oltre il grigiore della routine, faticosa e sempre uguale a se stessa...), una delusione affettiva (un abbandono, un non ritrovarsi piu con il proprio coniuge,una relazione che non si realizza...), sono tutti elementi che, con prevalenze diverse, convergono a determinare la crisi, la voglia di lasciarsi andare, inversamente proporzionale alla capacita di superare gli ostacoli e venir fuori dal momento difficile. E’ tra i 30 e i 40 anni che l’alcoldipendenza spesso prende piede. Si innesta su un’abitudine al bere in genere gia ben consolidata. All’inizio non ci si accorge nè del rischio, nè dello stato di dipendenza. Anzi di fronte alle prove della realtà (incidenti, litigi, esami di laboratorio...) si tende ripetutamente a negare l’evidenza. E quando, a denti stretti, si è obbligati a riconoscere il dato di fatto, subentra l’illusione di voler risolvere il problema da soli, di non aver bisogno di aiuti. Le conseguenze del bere: in casa e sul posto di lavoro I familiari (la moglie/il marito, i figli, i genitori, gli altri parenti) vivono anch’essi, di riflesso, la situazione di alcoldipendenza. Altre volte il coniuge e uno dei genitori e talmente coinvolto nelle dinamiche relazionali con chi manifesta il sintomo della dipendenza che, nel gergo degli operatori che si occupano del problema, viene definito come “bevitore asciutto”, in contrapposizione, ma non in antagonismo, al “bevitore bagnato”, cioe a colui che abusa. Gli effetti protratti dell’abuso di alcol finiscono per avere conseguenze devastanti nei rapporti familiari. Dopo una fase in cui, generalmente invano, i familiari tentano di risolvere il problema facendo ricorso a ripetuti ricoveri nelle case di cura, subentra sfiducia, colpevolizzazione del coniuge che beve, un atteggiamento di progressiva indifferenza. Le conseguenze dell’etilismo, a medio termine, si fanno sentire anche sull’attivita lavorativa. Molti sono coloro che hanno perso il lavoro a causa del bere smodato o hanno usufruito di lunghi periodi di aspettativa non retribuita. La mancata prestazione lavorativa, la conseguente diminuzione di reddito, non puo non riflettersi a sua volta nelle relazioni familiari, aggravandole ulteriormente fino alla minaccia della rottura. Aiutarsi, lasciarsi aiutare, frequentare “il” gruppo. L’intervento piu valido è il lavoro di gruppo tra le famiglie che vivono il problema dell’alcoldipendenza. L’auto-mutuo-aiuto interfamiliare si esercita settimanalmente sia 71 nel momento della riunione, sia tra una riunione e l’altra sostenendosi reciprocamente quando si è in difficolta, sia promuovendo iniziative sul territorio con lo scopo di sensibilizzare le persone al problema e scuotere l’indifferenza della gente. Il lavoro di gruppo arresta la deriva marginale della famiglia, che non si sente piu sola e isolata, che relativizza il problema vivendolo sì con drammaticita, ma riaprendo le porte alla speranza del cambiamento. Quando vince l’alcol, la droga legale Alcune famiglie non ce la fanno. L’aggressivita, la depressione, l’egoismo apparente di chi è indifferente alla sofferenza degli altri, il subentrare delle malattie alcol-correlate, determinano a volte l’irreparabile rottura della solidarietà e dei legami intrafamiliari, lasciando la persona con gli irrisolti problemi di alcoldipendenza nelle mani degli specialisti, delle organizzazioni di volontariato, sola con se stessa. Spesso alla disoccupazione, all’isolamento e alla solitudine, apparentemente mascherate dalla frequentazione dei bar, si aggiunge anche il problema dell’abitazione a cui non si è piu in grado di provvedere, nè economicamente, nè materialmente. Sono le situazioni di emarginazione grave in cui il passo a trasformarsi in persone senza fissa dimora, è estremamente breve. Rispetto all’alcoldipendenza non si riscontra solo un’emarginazione della famiglia, un’emarginazione dentro la famiglia e dalla famiglia, ma spesso anche un’emarginazione da parte dei servizi e delle istituzioni. L’alcol, droga legale, non è pienamente assunto, nelle sue conseguenze, come problema di rilievo sul quale investire in termini di prevenzione, riabilitazione, riduzione del danno. L’intervento di prevenzione e riabilitazione degli stati di alcoldipendenza è ancora, spesso, terra di nessuno e zona di forte controversia tra i servizi (la psichiatria, gli ospedali, i servizi per le tossicodipendenze). Gli strumenti amministrativi, a sostegno degli interventi di cura e di riabilitazione, non sono ben definiti. Eppure l’alcol e la droga che in Italia, come in Europa, ha creato piu persone dipendenti, ha prodotto piu danni e mietuto piu vittime. L’emarginazione delle persone alcoldipendenti e delle loro famiglie è anche il risultato di una sottovalutazione storica del problema. Consumo, abuso e politossicodipendenza di Leopoldo Grosso Hashish, marijuana, anfetamine, cocaina, ecstasy, eroina, allucinogeni…. La geografia delle tante sostanze stupefacenti che, leggere o pesanti, naturali o sintetiche, legali o illegali, offrono piacere e sollievo è vasta e sparpagliata. Diverse sono inoltre le modalità di assunzione: le varie droghe possono essere inalate, fumate, masticate, bevute, mangiate, “sniffate”, iniettate. Ogni sostanza stupefacente è radicata, come madre e figlia al tempo stesso, all’interno di una specifica cultura. Intorno al valore d’uso attribuito a ciascuna droga vengono elaborati riferimenti esistenziali, modi di essere e di esprimersi, modalità di intendere i rapporti umani, percezioni della vita e del mondo. Tanto più pregnante è l’effetto attribuito alle sostanze, tanto più totalizzante è il significato che assume la cultura che la 72 circonda e viceversa. Si creano nicchie, annidate qui e là nei molti interstizi delle aree metropolitane, che intorno a un comportamento di consumo, creano codici, generano linguaggi, selezionano adepti. Diverse sono le sostanze, differenti le modalità di assunzione, variegate le configurazioni culturali da cui attingono e a cui conferiscono significato. Il primo compito, che compete a chi, a vario titolo impegnato nell’ambito educativo e preventivo, oppure dedito al sostegno e all’Aiuto di quei ragazzi che manifestano difficoltà, consiste nel rendersi conto della rilevanza delle differenze, di annoverare le tante diversità che si coniugano con i comportamenti di consumo, di abuso, di dipendenza. Le variazioni sono numerose e sempre significative. Chi è in discoteca con gli amici e “cala” nel corso della nottata due pastiglie di ecstasy, non è omologabile a chi, in uno stadio in uno stadio in una curva di ultras, si “scalda” con l’alcol e ingurgita anfetamine che lo caricano di aggressività. Chi si fa di coca, anche emozionalmente, vagheggiando di potenziare le proprie prestazioni sessuali, ha poco da spartire con chi, la stessa sera, sta da solo davanti al televisore con una bottiglia di whisky su tavolino. Nel tenere conto delle molte specificità e situazioni che si articolano intorno al consumo di droga, a volte vistose, più spesso sottili ma non meno importanti, significa incorrere nell’errore più grave e diffuso: la superficialità di “fare d’ogni erba un fascio”, comprendere l’intero fenomeno droga con un’unica chiave di lettura, con una sola modalità interpretativa. Le spiegazioni semplici a questioni complesse, ottengono effetti, all’apparenza, più rassicuranti; in realtà illusori e tendenzialmente generatori di ulteriori errori. Chi ancora accomuna, come spesso è accaduto in passato, un quindicenne che fuma hashish con un trentenne alle prese con la ritualità quotidiana della siringa e del buco in vena, o chi confonde consumatori occasionali con le persone politossicodipendenti, sotto l’unico appellativo di “drogato” e “tossico”, si aggrappa a una rappresentazione univoca e stereotipata della problematica, che se aiuta a fornire un’unica immagine a tutto campo del pericolo temuto, nell’illusione di riuscire meglio a controllarlo, in realtà nella dinamica sociale produce danni accertati. La semplificazione produce etichette che, quando vengono appiccicate, non aiutano né la comprensione dei fenomeni e tantomeno le persone a cui stanno strette e nelle quali si inducono comportamenti reattivi. “Etichettare” è comodo: non costa fatica e impegno di approfondimento, basta attingere nel “grande magazzino” delle interpretazioni sociali; contribuisce alla creazione di capri espiatori evitando di mettersi in discussione individualmente. Le ansie e le paure sono riposte in un pericolo fuori di noi, possibilmente ben individuato e definito, rispetto al quale salgono le richieste di controllo. Il cortocircuito delle semplificazioni circa la tossicodipendenza non è ininfluente rispetto ai tanti ragazzi che consumano sostanze. Quando lo sguardo altri diventa “pesante”, in 73 molti di coloro che fanno uso si creano difese, aumentano le barriere comunicative, si generano atteggiamenti controaggressivi. L’etichetta di “tossico” è penalizzante. Chi si sente tale tende a eclissare i propri comportamenti e, se ha bisogno, non chiede aiuto. Chi invece, a torto o a ragione, non ha tale percezione di sé, si sente frainteso, giudica a sua volta con altrettanta semplificazione il proprio interlocutore e si chiude al confronto. Soprattutto tra i consumatori, e in particolare tra i consumatori problematici, l’etichetta fornisce e rinforza processi si identità deviante, finendo per alimentare il protagonismo in negativo. La doverosa capacità di differenziare si costruisce tenendo conto dell’intreccio di almeno tre piani di analisi. In primo luogo le caratteristiche proprie di ogni sostanza, con gli effetti che produce (pur nella variabilità tra i singoli soggetti assunti) e con gli specifici aspetti di attrazione che conferiscono un valore simbolico d’uso, un vero e proprio valore aggiunto. In secondo luogo i comportamenti degli assuntori che si distinguono a loro volta in base a quantità ingerite, frequenza del consumo e modalità d’uso. In terzo luogo le motivazioni all’assunzione che incrociano propensioni personali, vicissitudini relazionali e situazioni contestuali. Ogni sostanza non è tossica allo stesso modo. Rispetto alla stessa eroina ricerche ed evidenze cliniche tendono a dimostrare che anche l’abuso protratto tende a non distruggere i neuroni e il danno eventuale è limitato ad aree cerebrali molto ben definite. L’alcol e i solventi utilizzati per le colle risultano droghe molto più cerebrolesive. Il concetto di tossicodipendenza è improprio, se ne discende che ogni sostanza stupefacente sia tossica e che sia nociva allo stesso modo. Improprio è il concetto di tossicodipendenza, se ne discende che ogni consumo divenga automaticamente compulsivo. Un compito fondamentale è pertanto distinguere tra consumo, abuso e dipendenza. - Per uso si intende un consumo di sostanze psicoattive che non comporta necessariamente n complicazioni, né danni, ma espone la persona a dei rischi diretti e a condotte a rischio. Per alcune sostanze emerge, nei comportamenti giovanili, un ampio uso controllato e limitato, che, come per l’alcol, se non sfocia in abuso, non viene percepito come nocivo. Questa definizione di consumo non è unanime ed è oggetto di intensa controversia culturale e politica, prima ancora che scientifica. - Per abuso si intende invece un consumo suscettibile di indurre danni di tipo fisico, relazionale, psicologico e sociale, sia per il soggetto stesso che per il suo ambiente. L’abuso è una modalità di utilizzo inadeguato di una sostanza, che conduce a un’alterazione significativa delle funzioni e a una sofferenza, quindi pregiudizievole per la salute propria e altrui. - Per dipendenza si intende, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, un comportamento recidivante e cronico, configurabile come vera e propria malattia, caratterizzato da: 74 - a) un desiderio prepotente e irrefrenabile (compulsivo) di utilizzare una sostanza psicoattiva; - b) incapacità o grande difficoltà nell’interrompere l’abitudine; - c) sindrome di astinenza fisiologica allorché la persona interrompe l’assunzione. La dipendenza implica un abbandono progressivo di altre fonti di gratificazione e di interesse a esclusivo vantaggio del rapporto con la sostanza che non viene interrotto nonostante il sopraggiungere di conseguenze evidentemente nocive. La sottovalutazione del consumo di cocaina di Leopoldo Grosso L’abbassamento del prezzo dello spaccio illegale al minuto, che ha reso la cocaina competitiva anche economicamente con l’eroina risponde a una aggiornata strategia del narcotraffico, sensibilissimo nel cogliere nuove propensioni al consumo di segmenti di giovani e meno giovani che tramite l’abbondanza dell’offerta vengono indirizzati verso le sostanze più convenienti al momento. Il consumo di cocaina oggi non riguarda solo alcune tipologie “tradizionali” di soggetti tra cui alcune culture malavitose, enti, ambienti d’arte e spettacolo, determinati ceti professionali ossessionati dal successo delle prestazioni, o tossicomani incalliti che alternano l’uso delle droghe con determinati effetti di mix (lo speedball). Il consumo di cocaina è diffuso oggi in quasi tutti gli strati sociali. Secondo l’OMS l’uso di cocaina sarebbe in aumento in tutto il mondo. Lo stupefacente si è rivelato la droga preferita da un numero crescente di persone con un minimo di agio economico nel Nord America e in Europa. Rispetto alla diffusione si valutano in 5.000.000 i consumatori nei soli USA, che diventerebbero 8.000.000 secondo le stime Ansa. La cocaina è droga d’ambiente, eccitante e di prestazione. Si afferma in Italia negli anni ’80, gli anni yuppies. Alla fine di quel decennio in Italia i consumatori erano stimati in 600.000, il doppio tra tossicomani e tossicofili da eroina. L’età media dei consumatori di cocaina è tradizionalmente superiore a quella dei consumatori di altre droghe: la classe di età più rappresentata è tra i 31-40 anni. Tuttavia negli anni ’90 si è assistito ad una progressiva diminuzione dell’età. Oggi l’età media del primo incontro con la cocaina è intorno ai 23 anni. Dati non confermati, utilizzabili solo come indizio, suggerirebbero un quadro in cui si registra una diminuzione dei consumatori occasionali a favore di un contemporaneo aumento di quelli abituali. Nell’inchiesta “Drugs” di Comunità Nuova emerge da parte degli studenti milanesi che la cocaina occupa il 3° posto dopo cannabis e alcol tra le droghe più usate. La cocaina dà dipendenza. Possiede un elevato potere di reclutamento: si stima che circa il 15% delle persone che iniziano a usare la sostanza a scopo ricreazionale sviluppano in seguito una dipendenza conclamata. L’area dei consumatori problematici è valutata intorno al 30% (200.000 persone). La gravità della dipendenza è correlata all’età di iniziazione e alla durata della cronicizzazione del consumo. 75 Ai Ser.T, da ormai più di qualche anno, si sono rivolti cocainisti “puri” e non solo più eroinomani con un uso secondario della cocaina. Nonostante la gravità dei danni psicofisici che l’abuso di cocaina produce e per la sua capacità di indurre dipendenza in un numero considerevole di consumatori, la diffusione del consumo di cocaina è stato ampiamente sottovalutata. Nella campagna di informazione e prevenzione la cocaina non ha ancora il posto che le spetta, per estensione del consumo, gravità dei danni d’abuso e rischi che comporta. A New York le autopsie hanno rivelato la presenza di cocaina in oltre il 18% di tutti gli incidenti automobilistici mortali. Un certo numero di infortuni e di ictus in età ancora giovane si spiegherebbe con l’uso protratto e con l’abuso di cocaina. Sul piano psichico l’uso cronico può provocare l’insorgenza di disturbi di tipo paranoide alterando l’equilibrio mentale. La cocaina libera l’aggressività, rompe i freni inibitori e non è casuale che il suo utilizzo si diffonda tra soldati e miliziani nei conflitti bellici. Tra i giovani è spesso concausa di risse, di prevaricazioni violente, sia individualmente che in gruppi. Il contesto di assunzione non è indifferente, poiché sottoculture violente, condizionamento di gruppo e stimolazione cocainica si alimentano e potenziano vicendevolmente. 76 LEZIONE 5 Le comunità per minori di Luigi Ciotti Uno dei diritti fondamentali di ogni minore è quello di avere una famiglia o comunque degli adulti significativi che si occupino di lui, in una casa che sente come sua. Avere una famiglia/casa è un obiettivo irrinunciabile per una “politica” per i minori e invece troppo spesso anche in Italia è un diritto negato. Per molti minori la famiglia di origine non c’è o non c’è la fa. Oppure la famiglia, per problemi, con percorsi distorsi scarica rabbia, delusione, rancori sui figli che vengono abusati, maltrattati. Oggi le case famiglia si ritrovano a dare risposta al posto della delega nei confronti degli istituti per i minori, gestiti sulla base di una realtà che negli anni ha rivelato la loro insufficienze in quanto: 1) collegi (50-100) troppo numerici 2) luoghi in cui, per il numero, prevale il rapporto con le regole, non con gli educatori 3) luoghi troppo chiusi verso l’“interno” e poco aperti esterno Allora le “case famiglia” si collocano tra una famiglia che non c’è e un istituto che è ormai superato. Rappresentano un passo in più correggendone i limiti: sono di piccole dimensioni, propongono un rapporto stabile, continuativo con adulti che sono motivati da passione e non solo dalla ricerca di un posto di lavoro. I rapporti con gli adulti sono sempre mediati dagli adulti di riferimento, il rapporto con l’esterno avviene come dovrebbe avvenire in ogni famiglia, quindi in un orizzonte di normalità e non di eccezionalità. Anche se chiaramente questo non significa che i problemi non esistano: quando un minore cambia famiglia non è mai senza difficoltà, senza lasciti, senza traumi. Se la famiglia “non sostiene” provoca sempre delusione, rabbia, protesta oppure colpevolizza, porta ad una svalutazione, ad una bassa stima di sé. In entrambi i casi ciò che viene a mancare è la fiducia nell’altro e in sé stesso. Il problema è che questa eredità non è lasciata fuori dalla porta di ingresso della nuova casa. Ogni nuova accoglienza è sempre in salita, non può che essere condizionata da ciò che il minore ha vissuto in precedenza. I nuovi “adulti” devono fare i conti con una sofferenza spesso mascherata. Se i minori stanno male il loro modo di comunicare il malessere è far stare mal chi si occupa di loro, creare problemi di rapporto. Sono quindi aggressivi, lanciano sfide, scappano, si fanno volutamente del male. In sostanza mettono alla prova, dopo una prima fase di annusamento del nuovo territorio (casa/famiglia) inizia il periodo più duro la cui richiesta nascosta è “Dimostrami che posso fidarmi di te”. All’adulto quindi è chiesta una grande pazienza, di essere fermo, saldo ma anche flessibile ed elastico, di conquistarsi il riconoscimento da parte del minore e la sua fiducia. La fiducia necessaria per poter chiedere aiuto. 77 Il percorso di crescita non è mai una linea retta , è fatto di sbalzi, discontinuità. Non bisogna mai illudersi, ma neanche farsi prendere dalla delusione. Affinare la capacità di sostenere e soprattutto la capacità di non deprimersi e di non abbandonare. I percorsi dei minori sono percorsi lunghi che devono passare attraverso lo sbagliare. Non c’è crescita ed educazione senza esercizio di libertà, l’uso della libertà è sempre un rischio, ma non usarla significa non crescere e rimanere dipendenti dagli altri, essere “bloccati” dalle paure e dai limiti. Bisogna saper “tollerare” che i ragazzi si prendano dei rischi, pur cercando di contenerli, reprimendo l’ansia che provoca la libertà. Allegato : LE COMUNITÀ PER MINORI: GOVERNARE IL PLURALE A cura di Luciano Tosco Definire tipologie di comunità, requisiti e standard di funzionamento, livelli di competenza è la premessa per uscire da una «cultura dell’emergenza» che fa pesare sulle comunità per minori interventi che andrebbero risolti diversamente. La strada da percorrere è verso interventi sempre più mirati e individualizzati, attraverso la costruzione e il potenziamento di reti sociali di supporto che favoriscano l’autonomia dei minori e grazie a una comunità locale responsabile, capace di farsi carico dei loro problemi. Il presente contributo completa la riflessione Le comunità per minori/1: leggere il plurale, pubblicata sul numero di ottobre della rivista. Sebbene non ci siano ricerche sistematiche sull’utenza delle comunità è impressione diffusa che gli inserimenti siano sempre più attivati con la logica dell’«ultima spiaggia». Si tratta o di emergenze che costringono all’inserimento residenziale come soluzione inevitabile o di un ultimo tentativo dopo anni di lavoro e di interventi che non sono riusciti. Oppure ancora di scelte residuali, perché non si sa cosa altro fare, pur riconoscendo che la comunità non potrà certo essere significativa per un’evoluzione della situazione. Tale logica risulta sostanzialmente diversa da quella di alcuni anni fa, quando la comunità era percepita come situazione transitoria per prevenire quelle situazioni che invece, oggi, portano agli inserimenti urgenti e alla necessità degli interventi residenziali. Si ritiene dunque che la presenza nelle comunità di un’utenza sempre più problematica sia certo dovuta a un aggravarsi delle situazioni di difficoltà ed emarginazione. Ma l’elemento fondamentale che caratterizza la richiesta e l’inserimento residenziale è dato dal cambiamento del ruolo della comunità da parte dei servizi socio-sanitari, della scuola, delle autorità di pubblica sicurezza e dell’autorità giudiziaria minorile. Tale cambiamento deriva certamente dalla sempre maggiore presenza di servizi di sostegno al nucleo familiare e al minore in particolare, dalla normativa vigente, dalla nuova teoria e pratica di lavoro sociale. Risultano in aumento gli inserimenti di preadolescenti e adolescenti border-line, senza diagnosi precisa, che hanno già ricevuto moltissimi servizi ma anche fallimenti assistenziali, compresi numerosi soggiorni in comunità. Aumenta la richiesta di inserimento di situazioni molto difficili, per le quali non c’è possibilità di rientro in famiglia o di autonomia personale anche dopo il compimento della maggiore età (ad esempio, minori con gravi disabilità abbandonati e non adottabili). Sempre maggiori sono gli inserimenti di minori abusati, mentre non si trovano strutture disponibili ad accogliere adolescenti con patologie relazionali ormai strutturate o dipendenti da sostanze stupefacenti. Molte comunità, poi, ospitano minori extracomunitari inseriti in ottemperanza ai compiti di protezione e tutela, ma i cui bisogni potrebbero essere soddisfatti con servizi e iniziative diverse, anche meno costose. Tra progetto e ultima spiaggia La comunità certo non è e non deve essere la prima risposta ai bisogni. L’aggravamento delle situazioni che vengono inserite nelle strutture residenziali 78 può essere considerato positivamente in quanto indica che i minori con le situazioni meno drammatiche, grazie ai servizi di supporto al nucleo, rimangono in famiglia oppure vengono collocati in affidamento. D’altra parte è legittima la richiesta degli operatori delle comunità di poter essere considerati come attori di cambiamento e non solo come «ultima spiaggia» quando non si sa più cosa fare e forse non c’è più nessuna speranza di cambiamento. In questa situazione non è sufficiente denunciare una presunta incompatibilità tra progettualità definita in una dimensione temporale e cultura dell’emergenza. Occorre forse accettare la sfida di trasformare anche l’ultima spiaggia in progettualità innovative. Ma ciò comporta numerosi aspetti di complessità. Bisogni e ambiti di intervento. Come già evidenziato, i bisogni sono sempre più di difficile soluzione, differenziati e richiedono risposte diversificate. Nel contempo, politiche sociali innovative impongono un preciso collegamento dei servizi con la comunità locale. Queste due esigenze, in teoria complementari, sono invece nella realtà operativa difficilmente conciliabili. Infatti, spesso, le comunità alloggio si caratterizzano per la loro valenza territoriale, ma non sono in grado di rispondere a molti dei bisogni di residenzialità del territorio; oppure per specificità di intervento per utenza con determinate situazioni e caratteristiche, ma hanno scarsi collegamenti con la zona in cui sono ubicate. Pertanto le tipologie di comunità di cui si è già trattato (educative, di tipo familiare) devono confrontarsi e considerare la variabile relativa agli ambiti di intervento. Tali ambiti si ritiene si connotino relativamente: all’accoglienza di minori di una determinata zona indipendentemente da bisogni e condizioni che hanno portato alla necessità di inserimento extrafamiliare (territorialità); all’accoglienza di minori con problematiche specifiche e comportamenti patologici già strutturati (terapeuticità); all’accoglienza anche di minori con problematiche specifiche, comportamenti devianti e patologici non ancora strutturati (specializzazione). Vediamo ora un po’ più nel dettaglio i diversi tipi di comunità. Comunità territoriali. Sono strutture che accolgono minori della loro zona e si connotano per un elevato livello di apertura con la rete e le risorse locali. Il cambiamento dei bisogni e dell’utenza impone riflessioni su questo tipo di modello (1). Comunità terapeutiche. Una parte dell’utenza che accede o per la quale è richiesto l’inserimento in comunità pone il problema di come attuare cambiamenti in situazioni molto problematiche. Infatti un significativo numero di minori presenta comportamenti e patologie relazionali o di rapporto con la sostanza già strutturate. In questo caso un «normale» progetto educativo non innesta cambiamenti significativi, in quanto gli stessi sono molto difficili e profondi, ma è necessario un ambiente più specificamente «terapeutico». Se questa analisi è condivisibile, occorre allora prevedere comunità educative «terapeutiche» per specifiche problematiche. Ciò pone alcune questioni, come per esempio: quali sono le problematiche di competenza di queste comunità? Quali gli standard e i requisiti? Chi è titolare della competenza di intervento (Asl, Comuni)? Chi decide gli inserimenti, con quali procedure e con quali garanzie per evitare accoglienze improprie e negative per lo sviluppo del minore? Comunità con tipologie di utenza e situazioni prevalenti. Le comunità terapeutiche devono essere utilizzate per situazioni molto particolari, a condizioni e con procedure definite. In caso contrario si favorirebbero risposte scorrette e processi di ulteriore «stigmatizzazione», con le relative deleterie conseguenze evolutive. Peraltro la complessità e la diversificazione delle situazioni e dei bisogni (si pensi, per esempio, agli abusi) richiede non certo strutture particolari, ma preparate e competenti su determinati aspetti. 79 Quali sono gli aspetti che necessitano di competenze specifiche (quelli generali li abbiamo già definiti) e quindi su quali si potrebbero «specializzare» le varie comunità? La permanenza oltre i diciotto anni. L’adolescenza e la mancanza di completa autonomia tende sempre più a prolungarsi e già attualmente si configura di gran lunga oltre i diciotto anni. Da questa condizione non sono certo esenti gli ospiti delle comunità, anzi spesso le difficoltà personali e familiari rendono ancor più difficile il raggiungimento dell’autonomia. Se è evidente come non sia possibile, in certi casi, dimettere una persona al raggiungimento della maggiore età, quale età anagrafica massima deve comportare comunque le dimissioni? Come già rilevato, alcuni minori entrano in comunità senza nessuna prospettiva di rientro in famiglia o di autonomia. Si può quindi prevedere che avranno bisogno di protezione e tutela anche residenziale per tutta la vita. Per questi casi può essere opportuno prevedere strutture di accoglienza che li ospitino anche dopo la maggiore età, quindi con utenza mista, derogando al principio della temporaneità nelle strutture residenziali per minori? Oppure occorre strutturare una rete di servizi articolata per strutture temporanee e strutture con compiti di cura e mantenimento delle abilità acquisite, per un’accoglienza a tempo indeterminato? Utenza mista minori e adulti. Nelle case famiglia, ma anche in altre strutture quali le comunità per madre e bambino (comprese quelle terapeutiche per pazienti psichiatrici e tossicodipendenti), è prevista la presenza di adulti, con problemi anche gravi, insieme ai minori. Per quanto riguarda le case famiglia, tale scelta deriva da una encomiabile opzione valoriale di solidarietà e accoglienza che, attuata nella struttura, può diventare anche un esempio «educativo» per gli ospiti. È legittimo però chiedersi quali debbano essere le condizioni e le garanzie perché la presenza di adulti con gravi problemi non sia di ostacolo allo sviluppo del minore ospite. Nelle comunità terapeutiche per adulti il bambino segue il genitore che lì si reca per curarsi. Anche qui occorre sempre chiedersi, caso per caso, se ciò sia importante al fine di non spezzare legami significativi o se il bambino vada semplicemente perché ciò è terapeutico per il genitore. Infatti non si può derogare al principio che il bambino è soggetto di diritti e non può essere strumento per nessuno, neanche per i propri genitori. Pertanto, anche in queste comunità, il minore deve avere le sue attenzioni e i suoi spazi e non semplicemente vivere in funzione dell’adulto. Comunità e non solo Le considerazioni precedenti richiamano due questioni generali relative all’utenza reale e potenziale delle comunità: da un lato problematiche sempre più difficili da affrontare e gestire, che richiedono competenze, capacità specifiche e comportano difficoltà per i percorsi di autonomia; dall’altro bisogni semplici di tipo primario e di inserimento sociale, cui si risponde con le comunità in quanto non esistono iniziative e servizi diversi e più idonei (ad esempio, adolescenti extracomunitari soli). Riguardo al primo aspetto, la maggiore problematicità dei minori inseriti, comporta difficoltà maggiori nella progettazione anche relativamente ai tempi di permanenza, alle dimissioni, all’acquisizione dell’autonomia (2). La media di permanenza nelle comunità è di circa due anni, ma questo dato non rende conto delle differenze tra periodi lunghi (in aumento) e pronti interventi che si «risolvono» in poco tempo (abbandono della comunità, ritorno in famiglia dopo una fuga, ecc.). L’aumento dei tempi di permanenza e la difficoltà ad attivare percorsi di autonomia (3) deriva certo dalla complessità dei casi, in particolare dalle situazioni familiari e dalle condizioni sempre più difficili per il rientro. A fronte di questa situazione, che quindi richiederebbe un notevole investimento nei confronti della famiglia di origine, nel momento in cui il minore viene inserito in 80 comunità quasi tutte le energie sono rivolte allo stesso e al suo percorso evolutivo. L’aumento dei tempi di permanenza e la difficoltà ad attivare percorsi di autonomia deriva però anche dalla carenza delle reti sociali. Se si vuole contrastare la tendenza a percepire e usare le comunità come contenitori per grandi emergenze, non basta rivendicare nuovi servizi (peraltro sempre meno possibili per la diminuzione delle risorse), ma occorre ragionare sullo spostamento dell’asse verso la competenza della comunità locale. Non basta che la struttura di accoglienza si ponga il problema di come far fronte alla richiesta, come dare autonomia ai ragazzi, come trovare casa e lavoro. Non basta che questo lo facciano gli altri servizi. La società in genere, nelle sue forme pubbliche e private, deve farsi carico di quei «pezzi» di problemi che i servizi non possono, ma debbono prendere su di sé. La presenza di una rete di opportunità diversificate per l’autonomia risulta essenziale: non si possono fare progetti standardizzati validi per tutti. Occorre, invece, poter costruire percorsi individualizzati all’interno di una rete di occasioni non solo istituzionali e pubbliche, ma anche prodotte dal privato, sia profit che dell’imprenditoria sociale, e dal volontariato, comprese le iniziative connesse a specifiche situazioni locali. Per quanto riguarda il secondo aspetto, e cioè quello dell’utilizzo «improprio» delle comunità per bisogni che potrebbero essere soddisfatti altrimenti e a costi più bassi, si ritiene si debbano sperimentare accoglienze diverse dalle comunità. Peraltro tali strutture servirebbero anche per favorire percorsi di autonomia dei minori ospiti di comunità (4). Nel caso di minori con un certo livello di autonomia, ma per i quali non è possibile il rientro in famiglia, si ritiene opportuno il ricorso a strutture di accoglienza diverse dalle tipologie di comunità fin qui descritte. Tale constatazione nasce dall’esperienza di tutela e protezione di minori soli extracomunitari ultraquindicenni con elevato livello di autonomia, derivata dalla cultura e storia personale, con bisogni primari di alloggio e secondari di inserimento sociale. Per questi ragazzi la comunità si è rivelata incompatibile e ha comportato o un’accentuata «reattività» nei confronti della struttura e degli operatori o un adattamento passivo e una regressione rispetto ai precedenti livelli di autonomia raggiunti. Inoltre, a fronte delle drammatiche condizioni di emarginazione, ai limiti delle possibilità di soddisfacimento dei bisogni primari, in cui si trovano molti di questi minori, ci si è chiesti se è meglio attivare interventi che permettano a molti di fruire di un minimo di condizioni dignitose, piuttosto che a pochissimi di ottenere il «tutto» di un’accoglienza in comunità. Infine, in una situazione di non rilevante possibilità di implementazione della spesa, le comunità non possono essere utilizzate per esigenze non coerenti con le proprie finalità e cioè per situazioni molto problematiche a livello sociorelazionale. I problemi della rete La costruzione e il potenziamento di «reti» che favoriscano l’autonomia dei minori portano necessariamente a interagire con i soggetti che a diverso titolo sono coinvolti nella relazione con il minore: la famiglia, la comunità locale, i servizi. Supporto alla famiglia. Questa funzione — finalizzata alla valorizzazione e al recupero delle competenze genitoriali relativamente al minore in comunità — è esercitata in modo alquanto insoddisfacente dai servizi per una serie di motivi che potrebbero essere così sintetizzati: carenza del personale dei servizi territoriali, in particolare assistenti sociali che, dati i carichi di lavoro, finiscono per «parcheggiare» i minori in comunità delegando tutte le competenze, compresa quella in oggetto, agli educatori; carenza culturale, derivata da un’idea della famiglia più come problema che come risorsa e da politiche sociali tradizionalmente mirate a intervenire su singoli membri e non a favore del nucleo nel suo complesso; 81 insufficienza, in gran parte conseguente a quanto sopra, di strumenti teorici e operativi e relativa formazione degli operatori per il recupero della genitorialità, delle sue risorse e competenze. Questi fattori favoriscono la tendenza, sempre presente nelle organizzazioni e quindi anche nelle comunità, all’autoreferenzialità, al sentirsi indispensabili e quindi al «tenersi» i minori perché se rientrano in famiglia peggiorano e quindi si perde tutto il lavoro fatto. Peraltro occorre interrogarsi se il rapporto con la famiglia, nel senso del recupero delle funzioni genitoriali (quasi come un criterio di divisione del lavoro), sia competenza dei servizi territoriali, mentre la comunità si deve occupare del minore. Certo non è semplice lavorare con la famiglia quando i minori arrivano in comunità con provvedimenti per abusi, maltrattamenti, ecc. Dove però gli educatori hanno posto come obiettivo questo impegno, i risultati spesso sono stati positivi. Occorre fare in modo che la famiglia non senta la comunità come antagonista. Gli educatori non sono i genitori buoni, e così non devono essere percepiti, ma dei professionisti che aiutano nelle competenze genitoriali. Spesso, però, gli educatori in questo percorso sono soli o perché gli altri attori hanno posizioni e progetti diversi o perché non si interessano (anche solo per i motivi di tempo sopra espressi). Allora la comunità diventa il solo luogo, anche per i genitori, in cui puoi essere ascoltato, per i tuoi problemi, in tempo reale. La comunità quindi si accolla da sola un compito non suo, con gli evidenti rischi di invasività che distolgono dai compiti cui deve assolvere. La comunità locale. Se è vero che le strutture residenziali non possono risolvere tutti i problemi, il ricorso alla comunità locale e ad altre istanze e organizzazioni sociali risulta alquanto problematico. In primo luogo relativamente agli operatori. Riconoscere la comunità come competente ad affrontare i problemi significa riconoscere che può avere rappresentazioni della realtà, obiettivi, idee di soluzioni e intervento anche diverse dalle proprie. Significa quindi fare un lavoro di rete che non sia strumentale e cioè non si può credere di essere i detentori del sapere sociale, pretendere di imporre il proprio punto di vista, voler ottenere ciò che si desidera. Implica una grande disponibilità, tutt’altro che scontata, a mettersi in gioco. In secondo luogo, spostare le competenze sulla comunità significa, da parte delle pubbliche amministrazioni, attuare azioni e volontà politiche di valorizzazione reale e non strumentale (ad esempio, utilizzo del volontariato e delle solidarietà sociali per un ritiro almeno parziale dalle responsabilità e/o per diminuire i costi dei servizi). In terzo luogo significa avere strumenti amministrativi e finanziari molto flessibili e «spostabili» in relazione ai bisogni e ai progetti (5). Quali e quanti sono i vincoli che contrastano la flessibilità? Come promuovere cultura e occasioni di accoglienza e solidarietà nella società come una funzione attinente alle responsabilità politiche, amministrative e tecniche delle pubbliche amministrazioni? Il valore aggiunto nei servizi formali. La presa in carico di «pezzi» dei problemi dei minori ospiti delle comunità dovrebbe far capo alla comunità locale, alle istanze e organizzazioni sociali, anche se questo «spostamento» di competenze risulta particolarmente problematico. Altrettanto complessa è la questione riguardante il «valore aggiunto» fornito, in un sistema di welfare mix, dal privato cui vengono affidati servizi formali. In altri termini, è possibile che «pezzi» dei problemi dei minori in comunità vengano assunti dall’organizzazione che gestisce la comunità stessa? Come? E quali? Oppure l’organizzazione affidataria di un servizio deve solo fornire le prestazioni professionali previste per lo stesso? 82 Di fronte alle difficoltà di presa in carico «sociale», oppure anche per scelta, le organizzazioni che gestiscono comunità cercano di rispondere ai problemi dei minori ospiti attraverso soluzioni «interne» all’organizzazione stessa. Tale impegno, necessario e positivo, deve però evitare il rischio di indurre dipendenza della persona dall’organizzazione. In caso contrario si finirebbe per ricreare lo spirito dell’istituto, anche se in forme diverse, cioè quello di un’organizzazione «mamma» che al suo interno tutto offre. Governare il plurale Come già accennato, le politiche sociali di welfare mix, in generale e nello specifico quelle rivolte alla tutela delle fasce più deboli, devono da un lato offrire servizi formali, dall’altro aiutare la comunità locale ad affrontare e se possibile risolvere i problemi che dalla stessa emergono. Per servizi formali si intendono prestazioni e interventi certi, continuativi, con standard definiti, gestiti da personale qualificato. Tali servizi sono pubblici in quanto di pubblico interesse, ma possono essere affidati in gestione al privato, in particolare alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e al terzo settore, ove ciò garantisca maggiore efficacia ed efficienza. Per quanto riguarda le comunità alloggio risulta evidente come la quasi totalità sia a gestione privata, il che comporta, data anche l’estrema eterogeneità e pluralità, una funzione di coordinamento e di governo da parte dell’ente pubblico. Tale funzione comporta competenze programmatorie, di allocazione delle risorse, di definizione degli standard, di verifica e valutazione di qualità. Risulta quindi evidente come le politiche delle istituzioni e degli enti pubblici influiscano in modo assolutamente significativo sulle comunità, sulla loro identità, struttura e crescita e quindi siano estremamente importanti e strategiche per orientare lo sviluppo delle stesse. In particolare risulta importante evidenziare due aspetti: il primo riguarda la definizione delle tipologie di comunità, dei requisiti e degli standard di funzionamento (6); il secondo è relativo alle forme di affidamento a terzi del servizio comunità da parte degli enti pubblici titolari della competenza. Si ritiene che le principali modalità debbano essere quelle dell’appalto e dell’accreditamento. Nel caso dell’appalto viene instaurato tra ente affidante ed ente gestore del servizio un rapporto reciprocamente vincolante per un tempo definito, normato da un capitolato su cui si basa il rapporto contrattuale. Si ritiene che questa forma sia utile per interventi specifici relativamente ai quali è prevedibile la costanza del bisogno e può essere utile per verificare interventi costanti per un certo periodo di tempo (ad esempio, comunità «territoriali» che accolgono minori di una circoscrizione cittadina e svolgono anche interventi di inserimento diurno). Oppure deve attuarsi quando occorre attivare servizi sperimentali, necessari e non presenti «sul mercato» (ad esempio, comunità per bambini da zero a tre anni). Oppure, ancora, quando occorre avere sempre disponibile il servizio (si pensi alla pronta accoglienza). L’accreditamento consiste invece nella disponibilità di una organizzazione a fornire parte di un servizio e nel riconoscimento dell’ente affidante. Le strutture pertanto vengono accreditate sulla base di determinati requisiti e standard. Nel momento in cui sia necessaria la prestazione (per esempio, l’inserimento residenziale di un minore), viene scelta, tra quelle accreditate, la struttura ritenuta più adatta. Non essendoci un rapporto esclusivo con un determinato ente pubblico, ne deriva la possibilità per il gestore di scegliere quali minori accogliere. È evidente quindi che l’accreditamento introduce, nel nostro caso, una situazione di «quasi mercato». Infatti, il mercato viene regolamentato da norme e standard, ma all’interno delle stesse si attua un rapporto di concorrenza non solo tra le varie strutture, ma anche tra gli enti pubblici titolari delle competenze. Gli enti tenderanno a scegliere le strutture più efficaci, efficienti e adatte a rispondere ai bisogni, mentre i gestori tenderanno 83 ad accogliere minori segnalati dagli enti che offrono loro maggiori garanzie. L’accreditamento risulta, nel caso delle comunità, più adeguato degli appalti per gli inserimenti a lungo termine di minori con specifici bisogni e caratteristiche, in quanto permette all’ente di scegliere in modo individualizzato e differenziato tra strutture presenti «sul mercato» senza esclusivo rapporto con l’ente stesso. Quanto detto sopra non esclude la gestione diretta della comunità da parte degli enti pubblici. Occorre però, a questo proposito, almeno nelle poche situazioni dove ancora esistono comunità per minori a gestione diretta, avviare una riflessione tra queste strutture e le altre. Finora ci si è limitati infatti a comparare i costibenefici tra le due forme, più che a individuare eventuali diverse peculiarità (7). Non si ritiene infatti che debbano configurarsi in modo identico a quelle private, quasi in un sistema di concorrenza peraltro difficile da sostenere, ma piuttosto che si debbano individuare specificità per le quali è opportuna una gestione pubblica. Per esempio, sperimentazioni, problematiche per le quali sono necessari rapporti delicati e complessi con altre istituzioni, quali abusi, procedimenti di adottabilità, ecc. Inoltre occorre chiedersi se l’assenza, di fatto, di comunità gestite dagli enti titolari delle competenze di protezione e tutela dei minori non possa essere considerata almeno inopportuna. È possibile infatti saper controllare e valutare senza alcuna diretta esperienza gestionale? Aspetti di complessità Le diverse modalità di gestione delle comunità pongono una serie di nodi problematici che vanno approfonditi. Livelli di competenza. Questa tematica è fondamentale se si vogliono attuare corrette politiche di accreditamento. Peraltro il Parlamento ha impegnato il Governo a definire criteri e linee guida. Tale impegno, al momento disatteso, richiede invece maggiore attenzione per permettere di avviare un riordino di tutta la materia a livello nazionale. Questa esigenza è comunque recepita dal disegno di legge di riforma dei Servizi sociali attualmente all’esame del Senato. Occorre pertanto, in primo luogo, decidere i livelli di competenza. Lo Stato deve fornire criteri, tipologie di strutture e standard generali onde evitare eccessive differenziazioni territoriali. Le Regioni invece devono individuare tipologie e standard più specifici. Una particolare attenzione deve essere rivolta al rapporto tra tipologie/standard e costi. Infatti, attualmente i costi sono molto diversificati e non sempre a quello più alto corrispondono maggiori prestazioni e qualità. Poiché nelle comunità spesso esistono disponibilità ad attività volontarie, permane il problema se si paga il servizio o il costo, e quanto quest’ultimo incide nella scelta dell’inserimento del minore in una struttura. Autorizzazione al funzionamento e accreditamento. Una seconda questione che si pone è quella di definire se autorizzazione al funzionamento e accreditamento si identifichino oppure no, e quindi se gli standard siano identici o diversi. Una prima posizione è quella di chi sostiene che l’autorizzazione al funzionamento sia un prerequisito per l’accreditamento e che quest’ultimo debba essere qualcosa di più della semplice autorizzazione ad aprire la struttura. In base a questa ipotesi l’autorizzazione al funzionamento si basa su standard minimi e abilita ad aprire la struttura. Con questa ci si può rivolgere al mercato privato (se esiste) e/o richiedere l’accreditamento e cioè la possibilità di essere fornitore dell’ente pubblico. Per esempio, se l’autorizzazione al funzionamento è data sulla base di un determinato rapporto tra operatori e utenti, l’accreditamento, fatto salvo questo rapporto, è concesso se il turnover non supera un determinato limite. Conseguenza di questa impostazione potrebbe essere il fatto che la Regione determina i criteri e gli standard di autorizzazione al funzionamento, mentre gli enti titolari delle competenze quelli di accreditamento e l’accreditamento stesso? In tal caso non sarebbero necessarie da parte delle Regioni provvedimenti particolarmente dettagliati e specifici. La seconda posizione identifica autorizzazione al funzionamento e accreditamento. In tal caso i provvedimenti di definizione degli standard dovrebbero essere 84 piuttosto dettagliati ed emanati dalle Regioni. L’accreditamento sarebbe di fatto, quindi, deciso dagli organi competenti a rilasciare l’autorizzazione al funzionamento. Accreditamento e scelta degli inserimenti. Entrambe queste posizioni non spiegano però i comportamenti tecnici e amministrativi necessari nel momento in cui i minori vengono inseriti nella struttura accreditata. Infatti, pur essendo accreditate varie strutture con identici requisiti, può essere più opportuno inserire quel minore in una di esse perché, per esempio, più preparata nei confronti di ragazze che hanno subito maltrattamenti in famiglia. La scelta quindi non è sulla qualità in astratto, ma sulla qualità relativamente allo specifico bisogno. Infatti, per un altro caso, potrebbe essere più utile un’altra struttura. Quali gli strumenti tecnici e quelli amministrativi per assumere in modo corretto e trasparente tali decisioni? Accreditamento e qualità. L’accreditamento come sistema di «quasi mercato» permette in quanto tale la qualità? Oppure, oltre alle «garanzie» della concorrenza, per l’applicazione della qualità occorre altro? Controllo e valutazione. Con il termine controllo si intende quel processo di verifica degli standard e degli adempimenti previsti. È evidente come il controllo non sia sufficiente soprattutto in servizi alla persona caratterizzati dalla fornitura di prodotti che non sono fini a se stessi, ma strumenti per il miglior benessere possibile del cliente. Pertanto la valutazione sposta l’accento dal controllo burocratico di adempimenti formali (pur necessario) alla qualità. Per qualità si intende un complesso multifattoriale che comprende efficacia, efficienza, definizione e controllo dei processi di produzione, analisi dei prodotti e dei risultati derivati dagli stessi, soddisfazione dei clienti e degli altri attori istituzionali e sociali. Non solo, ma la qualità comporta percorsi di autovalutazione attraverso, per esempio, veri e propri «manuali di qualità», momenti di eterovalutazione e confronti tra i due livelli. Occorre aspettare che lo Stato e le sue varie articolazioni istituzionali decidano i criteri di accreditamento e i requisiti di qualità? Oppure non è ora che gli enti gestori delle strutture residenziali non solo si autovalutino (cosa che forse ognuno fa al suo interno), ma portino a conoscenza i sistemi di autovalutazione e i risultati? E ancora, il confronto, attraverso la conoscenza reciproca e i processi di trasparenza, non è il sistema più opportuno per favorire il confronto culturale e passare da culture di singoli servizi a indicatori e percorsi condivisi? E i sistemi di accreditamento e qualità non possono non fondarsi su basi culturali comuni, se non vogliono semplicemente ridursi a meri adempimenti burocraticoamministrativi (8)? Conclusioni Le comunità per minori, a partire dagli anni Settanta, si sono sviluppate su tutto il territorio nazionale anche se in modo molto differenziato. Inoltre, varie leggi e provvedimenti nazionali le hanno legittimate come importanti componenti della rete dei servizi individuando però genericamente obiettivi, funzioni e nulla dicendo relativamente a tipologie e criteri per la definizione di requisiti e standard. Anche per i motivi di cui sopra (oltre che, naturalmente, per la diversità dei bisogni e le peculiarità delle singole organizzazioni di gestione) queste strutture si sono sempre più connotate in modo molto differenziato, con un insufficiente confronto tra loro e un significativo livello di autoreferenzialità. Oggi non si tratta sicuramente di scegliere un modello da preferire ad altri ma, proprio perché la diversità sia ricchezza e non caos, è necessario individuare alcuni «paletti» e «regole del gioco». A tale scopo si sono individuate le seguenti tematiche: 85 definizione di comunità, finalità, obiettivi, funzioni e requisiti generali; modelli di comunità e requisiti gestionali di ciascun modello; aspetti teorici, tecnici, organizzativi connessi alla situazione e ai bisogni dell’utenza reale e potenziale; rapporti tra enti pubblici titolari delle competenze ed enti gestori; riferimenti teorico-operativi nel lavoro educativo. Si è cercato di fornire prime risposte a queste tematiche attraverso approfondimenti, proposte, individuazione di ambiti di complessità. Le comunità per minori devono tutte avere finalità e obiettivi generali comuni, connessi ai compiti e al ruolo all’interno della rete dei servizi. Inoltre, comuni devono essere alcuni requisiti strutturali e gestionali. Si sono qui presentate specifiche proposte in proposito. Partendo da criteri e indirizzi omogenei le comunità si possono articolare in tipologie diverse in base a una serie di variabili, quali numero, tipo e professionalità degli operatori, rapporto operatori-utenti, presenza o meno di personale residente, tempi previsti di permanenza, organizzazione per turni o presenza stabile. In relazione a questa e ad altre variabili sono state individuate le seguenti tipologie: comunità educativa, comunità di pronto intervento, comunità di tipo familiare e casa famiglia. In particolare sono state evidenziate le differenze tra comunità educative e comunità di tipo familiare/case famiglia. Le prime si basano su un sistema organizzativo e sul lavoro professionale, le seconde su motivazioni valoriali e di scelta di vita. Ci si è chiesti se tali differenze siano soltanto di tipo «strutturale» e non incidano sulle scelte relative alla tipologia e alle condizioni dell’utenza da inserire. E ancora, come si collochino ciascuna all’interno delle politiche sociali di welfare mix e community care. Inoltre sono state affrontate altre tematiche relative a questa tipologia, quali l’opportunità di posti o di comunità di pronto intervento, l’opportunità di una divisione per fasce d’età, la permanenza oltre i diciotto anni, la presenza di utenza mista (minori e adulti). Le situazioni e le caratteristiche dei minori inseriti o per i quali si richiede l’inserimento interrogano le strutture residenziali su alcuni aspetti di complessità. Infatti, si riscontra una sempre maggiore presenza di minori con problematiche personali e familiari molto gravi, comprese situazioni con comportamenti patologici già strutturati. Al contrario, si riscontrano inserimenti di minori (in particolare adolescenti extracomunitari soli) che, per esigenze di protezione/tutela, vengono ospitati presso queste strutture pur non avendo necessità degli interventi delle stesse. Gli aspetti di complessità che ne derivano sono stati così identificati: la territorialità, intesa sempre meno come accoglienza di minori della zona e sempre più come collegamento in rete con le risorse del territorio; la terapeuticità, cioè la necessità di strutture specializzate per minori con specifiche patologie relazionali o dipendenze dalle sostanze ormai strutturate. Qui la questione riguarda quali problematiche siano di competenza di queste comunità, chi decida gli inserimenti e con quali procedure e garanzie, per evitare accoglienze improprie e negative per lo sviluppo del minore; la specializzazione, cioè l’accoglienza, in prevalenza, di minori con problematiche specifiche ma senza patologie già strutturate. In questo caso ci si chiede per quali aspetti e problematiche sia opportuno che le comunità differenzino le loro competenze; il rapporto con la famiglia di origine e la mancanza di una cultura e prassi operative di relazione con la stessa, miranti al recupero delle competenze genitoriali; l’utilizzo improprio delle comunità per minori con un elevato grado di autonomia e la conseguente necessità di sperimentare un diverso tipo di strutture residenziali, utili anche per la dimissione e l’autonomia progressiva dei minori già ospiti in comunità; 86 la carenza delle reti sociali di supporto. Occorre una maggiore presa in carico da parte della comunità locale dei bisogni dei minori presenti nelle comunità. Questa giusta istanza incontra molti ostacoli, quali comportamenti autoreferenziali degli operatori, posizioni di welfare residuale da parte di politici e amministratori pubblici, rigidità nell’utilizzo e nella riconversione delle risorse, comprese quelle finanziarie. Peraltro la rete è essenziale perché a situazioni e bisogni diversificati non possono corrispondere risposte uniche e standardizzate, ma una rete di opportunità che permetta percorsi individualizzati; il valore aggiunto dei servizi formali. I «pezzi» di problemi dei minori dovrebbero essere assunti, oltre che dalla comunità locale, anche dalle organizzazioni che gestiscono le comunità, le quali potrebbero fornire un «valore aggiunto» alle specifiche prestazioni previste per la gestione della struttura residenziale. Tale disponibilità, in sé positiva e auspicabile, può presentare dei rischi se si trasforma nell’unica risorsa che il minore ha a disposizione. Ciò infatti finirebbe per creare dipendenza dall’organizzazione che gestisce le comunità, riproducendo di fatto le dinamiche degli istituti tradizionali. Se, come il titolo dice, quello di comunità è un concetto plurale (tipologie, esperienze, ecc.), ne deriva la necessità di un governo della pluralità. Governare la pluralità significa in primo luogo definire tipologie di comunità, requisiti e standard di funzionamento, nonché i livelli di competenza nella determinazione ed esecuzione degli stessi. Secondo, significa definire le modalità (pur non escludendo la gestione diretta) di affidamento a terzi da parte degli enti pubblici titolari delle competenze. Sono state individuate come vie principali quelle dell’appalto e dell’accreditamento. Il sistema dell’accreditamento, quello che si prevede più diffuso per le comunità, implica la definizione del rapporto tra autorizzazione al funzionamento e accreditamento, nonché questioni relative alla valutazione di qualità. Infatti, la concorrenza che l’accreditamento introduce non può da sola garantire il rispetto di tale requisito. Molte delle questioni trattate in questo contributo rimangono quindi ancora aperte. Così come non è stata affrontata quella fondamentale dei modelli teorico-operativi nella gestione delle comunità. La speranza è che qualche «paletto» sia stato posto e l’augurio che il dibattito e il confronto continuino. (1) Per quanto riguarda la valenza territoriale, nell’esperienza torinese, per esempio, quasi tutte le comunità pubbliche o in convenzione si sono strutturate a livello circoscrizionale, cioè per accogliere minori di un territorio ben definito. Alcune poi hanno organizzato il proprio intervento in modo flessibile (con l’educativa territoriale o accogliendo minori sia a livello residenziale che diurno). Inoltre hanno investito molto nel lavoro di rete, non solo per i propri ospiti, ma anche a favore di minori della circoscrizione. In sostanza, si tratta di comunità aperte e collegate alla realtà locale. Nonostante l’indubbia validità dell’esperienza, tali strutture non sono però in grado di affrontare tutti i bisogni dei minori del loro territorio di riferimento. Per esempio, le emergenze, i pronti interventi, gli allontanamenti urgenti disposti dall’autorità giudiziaria; ma anche situazioni specifiche di esigenze di minori con gravissimi problemi relazionali, inseriti nel circuito penale, oppure che necessitano di un ambiente non cittadino o lontano dalle influenze negative di gruppi di coetanei, ecc. Il cambiamento di esigenze e tipologie di minori inseriti porta le comunità ad accogliere sempre meno minori della circoscrizione di riferimento e, quindi, a essere sempre meno territoriali in termini di utenza. Permane invece, e deve ulteriormente potenziarsi, la connotazione di territorialità relativamente alla rete di risorse e alle relazioni con le stesse. Peraltro la territorialità intesa in questa accezione dovrebbe essere requisito di ogni comunità. (2) A Roma, per esempio, è stato stilato un protocollo di intesa con l’autorità giudiziaria minorile, che definisce percorsi e tempi al fine di evitare il più possibile sia un’eccessiva permanenza nelle strutture (in particolare per i minori 87 da zero a tre anni), sia passaggi da una comunità all’altra per motivi prettamente anagrafici. (3) Una ricerca dell’Ufficio minori del Comune di Torino ha evidenziato la tendenza alla «cronicizzazione» del bisogno assistenziale. Infatti il numero di minori seguiti con interventi di educativa territoriale, centri diurni, affidamenti familiari, strutture residenziali, negli anni tende ad aumentare non a causa di un incremento delle situazioni nuove, ma per una diminuzione del numero di «dimissioni». Tale trend è confermato in parte anche per le comunità, dove la diminuzione di presenze nel 1997, rispetto all’anno precedente, è dovuta più a un decremento delle ammissioni che a un aumento delle dimissioni. (4) Queste considerazioni hanno portato a sperimentazioni di strutture residenziali diverse. Per esempio, a Reggio Emilia sono sorte unità semiautonome di convivenza guidata. A Torino (vedi anche Tosco L., Accoglienza residenziale con adolescenti extracomunitari, in «Animazione Sociale», 8/9, 1997) sono state avviate strutture di accoglienza per emergenze con funzione di filtro, case di ospitalità notturna per adolescenti ultrasedicenni, alloggi per convivenze con elevato livello di autogestione, iniziative a bassa soglia di accesso, quali mense, lavanderie, docce, posti letto, interventi di educativa di strada, progetti di «tutela civile» a gestione del volontariato. Queste sperimentazioni, finora utilizzate quasi esclusivamente a favore di minori extracomunitari, richiedono una riflessione circa l’opportunità di estensione, le condizioni e l’età per la loro fruizione. (5) Nel settore socio-assistenziale il Comune di Torino assegna alle circoscrizioni risorse di personale e di servizi, mentre è praticamente irrisorio il trasferimento di risorse finanziarie. Ciò comporta rigidità in caso di progetti innovativi. Per esempio, se un servizio locale trova le risorse per attivare sul suo territorio una convivenza guidata, chi paga l’affitto e le spese di gestione dell’alloggio? Al contrario, il Comune di Roma ha decentrato alle circoscrizioni il budget finanziario, ma le risorse di personale sono inferiori a quelle di Torino, pur essendo gli abitanti più del doppio. In questo caso i soldi ci sono ma mancano le risorse umane per pensare e fare progetti. Chi ha il personale per fare i progetti non ha i soldi per attuarli e chi ha i soldi non ha il personale per farli! (6) In mancanza di una normativa nazionale, le varie regioni hanno assunto provvedimenti anche piuttosto diversi. La Regione Lombardia ha individuato standard gestionali e strutturali piuttosto articolati e dettagliati. Tali standard definiscono l’autorizzazione al funzionamento che permette eventuali convenzionamenti da parte degli enti locali. La convenzione tipo generale con le specificazioni ulteriori per le singole tipologie (comunità di pronto intervento, di pronta accoglienza, per progetti a medio-lungo termine) è stata definita dalla Regione. Contestualmente è stato avviato un piano sia per il finanziamento di ristrutturazioni che per la riqualificazione professionale. La Regione Emilia Romagna ha deliberato una direttiva meno specifica di quella della Lombardia, in cui vengono definite tipologie e requisiti minimi in base ai quali è concessa l’autorizzazione al funzionamento. Le convenzioni tra ente pubblico ed ente gestore sono stipulate sulla base di elenchi di strutture «convenzionabili» decise dalla Regione. Le Regioni Lazio e Piemonte hanno assunto deliberazioni che normano i requisiti strutturali, mentre quelli gestionali sono piuttosto generici. Per quanto riguarda i capoluoghi di regione, Milano ha convenzioni con circa 350 strutture e contributi a strutture gestite dal volontariato. Il Comune di Roma non prevede contributi, ma ha convenzioni e inserimenti con pagamento «a retta». Il Comune di Torino gestisce direttamente sette comunità, quindici tramite appalto, e inserisce minori con il sistema «a retta» in una cinquantina di strutture. (7) Le comunità pubbliche risultano funzionanti solo a Torino, Trieste e Parma. Non risulta che se ne intendano aprire altre e nemmeno potenziarle dove già esistono. 88 (8) La Regione Lombardia ha definito i requisiti per l’autorizzazione al funzionamento in modo molto articolato, mentre l’Emilia Romagna, pur essendosi dotata di un provvedimento, è meno specifica. Piemonte e Lazio hanno assunto provvedimenti specifici relativamente agli standard strutturali, ma molto generali rispetto a quelli gestionali. Queste differenze sono connesse a scelte legate al periodo in cui i provvedimenti sono stati emessi, alla storia e alla cultura dei servizi di quel territorio, alla situazione delle strutture, alle risorse messe in campo per poter rispettare i criteri individuati. Le variabili che compongono le scelte di cui sopra sono tante e complesse, così da rendere essenziale, pur permanendo la competenza dell’ente pubblico, un’ampia consultazione con le forze sociali e con i gestori delle strutture. Tale concertazione è da assumere non solo in sede di istruttoria del provvedimento che definisce tipologie e standard, ma anche successivamente in sede di monitoraggio e verifica degli effetti del provvedimento. Inoltre è importante definire, contestualmente alle norme transitorie, e al fine di non rendere le stesse di fatto definitive, programmi di supporto per l’adeguamento agli standard decisi, quali progetti di riqualificazione del personale, prestiti agevolati per ristrutturazioni, ecc. LEZIONE 6 Minori ed organizzazioni criminali di Luigi Ciotti C’è un effetto dell’oppressione mafiosa su cui non ci si sofferma ancora a sufficienza. Ed è quello del furto di futuro a danno delle giovani generazioni. Bisogna tagliare alla radice le cause che sottintendono la scelta criminale e talvolta anche i destini personali e in questo la scuola ha un ruolo determinante. Circa il 90 % dei casi della dispersione nella scuola dell’obbligo avvengono nell’Italia meridionale, con una punta del 30 % in Sicilia. Il 76 % dei minori che vivono ai margini della legalità è analfabeta, o al massimo ha raggiunto la licenza elementare. E’ evidentissimo lo stretto rapporto tra criminalità minorile, tasso di scolarizzazione e condizione sociale. Lavoro, istruzione, informazione, salute, casa, servizi, qualità della vita sono i punti su cui lavorare, insieme, società civile ed istituzioni. Insieme, perché solo così si costruisce in maniera duratura, mentre troppo spesso purtroppo assistiamo ancora oggi a conflitti, a lacerazioni, all’interno spesso delle istituzioni. Conflitti che finiscono per creare sfiducia, disorientamento; conflitti che allontanano i cittadini dalla politica, che fanno riemergere il pessimismo. Arrestare i boss è importante ma sicuramente non sufficiente. La mafia è un parassita: un parassita che vive, si rafforza, si riproduce in un corpo malato, contribuendo a perpetuarne le patologie. Allora per estirparlo fino in fondo - e veramente - occorre non soltanto attaccare le manifestazioni del male, ma anche guarire il corpo, rigenerandone i tessuti. Occorre predisporre strumenti di intervento mirati, che diano ai cittadini la certezza di uno Stato, di una classe politica, sempre vigili, sempre compatti. Non di uno Stato, di una classe politica che sanno, provvisoriamente, scuotersi dall’endemico torpore che li caratterizza soltanto se pungolati da uno shock, da un trauma di una strage o di omicidi particolarmente gravi, appena commessi. Gli atti giudiziari, gli stessi certificati penali di moltissimi soggetti condannati per gravi reati legati alle attività della mafia tracciano il percorso di una sorta di apprendistato criminale, iniziatosi prima del compimento della maggiore età. Tragica riprova di questo controllo sui minori operato dalle cosche sono le feroci esecuzioni riferite da alcuni collaboratori di 89 giustizia e di cui sono stati vittime alcuni minorenni che a Palermo, come a Catania, non hanno rispettato le “regole” non scritte di Cosa Nostra ed hanno commesso reati senza l’assenso di chi, in una determinata zona, rappresentava l’autorità criminale. Dalla manovalanza del contrabbando di sigarette e dello spaccio di droga, ai reati contro il patrimonio, alle estorsioni, il minore viene usato ed addestrato dalla mafia. Assistiamo così ad una serie di passaggi dei ragazzi più “svegli”, più “capaci”, che dalla rapina con il coltello ai danni di un passante, chiamata nel loro gergo il “fermo”, giungono alla rapina classica e poi, se veramente “affidabili”, alla commissione di omicidi per conto della mafia. Questi ragazzi sono quelli che, con un’espressione sicuramente poco felice, oggi vengono denominati dalla stampa “baby-killers” minori la cui età anagrafica appare terribilmente sproporzionata rispetto alla gravità dei delitti di cui si sono resi colpevoli. Per questi il Malaspina, il carcere minorile di Palermo, è spesso una sorta di passaggio obbligato, di attestato di professionalità nel crimine, di cui fregiarsi all’esterno con i coetanei e, soprattutto, con quegli adulti ai cui occhi essi devono apparire sempre più bravi. Alcuni di quei minori omicidi, poi, fatto un salto di qualità diventano affiliati di rango dei clan mafiosi. Da qualche tempo a questa parte si sono moltiplicati gli studi anche sulla psicologia dei mafiosi. Per vedere quali sono le molle caratteriali, comportamentali, le esperienze, anche, di vita che possono aver portato qualcuno a questa scelta. Perché influiscono molto le compagnie. Frequentando i compagni, uno devia... Però, magari, ero più portato ad un altro tipo di compagnie... Io penso che, non dico chiunque, però una buona percentuale nell'infanzia si può deviare, anche se hanno dei meravigliosi genitori, se hanno dei genitori che non gli fanno mancare niente, che gli danno un'educazione: basta una cattiva compagnia, un coinvolgimento in un qualcosa... Io ho frequentato sempre gente più grande di me, più criminale di me. Forse questo ha influito. Perché io che ho vissuto in un certo ambiente degradato, logicamente... è stato facile per me incontrare delle male compagnie, trovare dei ragazzi, delle conoscenze, non di gente che magari andava a studiare o andava a lavorare - anche se ne ho avuti di questi amici così da ragazzino. Vede, un famigliare di un giudice frequenta un certo ambiente, il nipote, il fratello, il cugino, perché sono di famiglia. E allora se noi mettiamo poi che in Sicilia non c'è niente, che la Sicilia è abbandonata, già da ragazzini si vive sula strada. Sarà un'altra cultura, non lo so, però è così. E allora è così che si fanno le amicizie; è così che si inizia. Ma quando io, da ragazzino, una volta ho rubato una frutta, un'altra volta ho rubato... cioè sono cresciuto così, chi è che me lo va a dire di cambiare? Ormai le mie amicizie me le sono scelte, ormai le frequentazioni che io faccio già sono catalogate: io frequento delle persone che sono del mio stesso ambiente, e quando frequento persone che sono al di fuori del mio ambiente, io mi tramuto, faccio finta che sono in un ambiente pulito, sano. (..) Nessuno mi diceva: Nino, ma cosa stai facendo? Togliti da queste persone, non ti mettere in questi guai. 90 (…) Già c'erano delle persone che mi osservavano, a mia insaputa, che mi osservavano...Vieni guardato da ragazzino, poi si viene inseriti in un'organizzazione, piano piano, magari facendogli fare delle piccole cose. E poi, piano piano che si cresce, la gente vede, sempre in base all'ambiente dove si vive, dove si frequenta, e viene osservato; viene osservato... fino a quando gli viene fatta la proposta di far parte dell’organizzazione... Poi sono cresciuto, ormai avevo fatto la mia scelta, ormai ero dentro ad un meccanismo, forse inconsapevolmente, ma c'ero entrato... non me ne rendevo conto, ma c'ero entrato. (Da Vita da clan, di S. Lodato, edizione EGA) Allegato 1: da VITTIME ASSOLUTE di R. Scifo Alfio è un bel bambino, di quelli paffutelli che ti immagini leccarsi le dita sporche di cioccolato e conquistarsi con facilità le coccole dei parenti; poi incontro i suoi occhi, dolorosamente altrove. La madre è molto giovane, tesa, gli occhi cerchiati, ha in braccio una bimba di circa due anni, quasi adesa al volto della donna.La diffidenza nel darmi le informazioni necessarie alla stesura dell’anamnesi è evidente;è quasi sempre così in questo quartiere, devo ricordarmi che io rappresento le istituzioni e non sono stati loro a cercarmi. Devo chiedergli del padre di Alfio, la signora scoppia in lacrime, si riprende , la bimba si attacca sempre più, Alfio ha gli occhi puntati su di me ma non mi guarda: <<I bambini ci sono abituati, mi capita tutti i giorni di piangere, Alfio mi chiede di suo padre ed io non so cosa dirgli>>. Faccio giocare i bambini nell’altra stanza, Alfio è paziente con la sorellina che tiene d’occhio la mamma dalla porta semiaperta. Lupara bianca: così vengono definite le scomparse di affiliati all’organizzazione mafiosa di cui non si sa più nulla, il cadavere non verrà mai ritrovato. A mamma di Alfio si aggrappa alla speranza di una fuga precipitosa in qualche rifugio lontano; il coinvolgimento nelle attività criminose del marito viene riconosciuto dolorosamente ma è in secondo piano rispetto alle qualità di marito e di padre, qualità semplici, ovvie, mai idealizzate.Alfio mi racconta che a scuola le parole della maestra non le sente nemmeno, vorrebbe essere a casa accanto alla mamma ad aspettare, oppure a volte immagina papà che bussa alla porta della classe e lo porta via, al chiosco delle bevande dove si fermavano a bere insieme la bibita con lo sciroppo di mandarino; però, non potendo piangere una morte che non si vede e che non si può pensare, Alfio sogna di notte la verità, dolorosa ma non quanto il dubbio dell’abbandono. Avvenimenti drammatici di questo tipo ostacolano pesantemente quel processo mentale, descritto nella psicologia psicoanalitica, definito elaborazione del lutto. Il superamento dell’angoscia legata alla perdita della persona amata diventa a volte impossibile se l’evidenza dell’irreversibilità ella scomparsa non c’è; diventa quasi naturale aggrapparsi alla speranza e strutturare una forte negazione della morte dell’oggetto d’amore, soprattutto se quest’ultimo costituiva il principale modello identificatorio nel processo di costruzione della propria identità. Per sviluppare un concetto di sé, un’autoimmagine positiva, il bambino tende ad idealizzare la figura genitoriale identificatoria, isolandone anche i frammenti di affettività espressa. Una fredda e raziocinante critica della devianza sociale del genitore “mafioso” è possibile solo molto dopo, in genere non prima dell’adolescenza, ma senza intaccare troppo quegli aspetti positivi, forse in parte idealizzati, spesso sicuramente reali. Il dibattito scaturito da certe dichia razioni della figlia di Totò Riina, capro espiatorio massimo del male “mafioso”, con atteggiamenti pedagogici moraleggianti di molti intellettuali, mi hanno fatto ritornare in mente le tante storie, come quella del piccolo Alfio, di quelle che sono le vittime assolute dell’ambiente mafioso. Che tipo di aiuto potrò dare ad un bambino come Alfio? Credo ben poco. Intanto riconoscere il suo dramma e spronare la scuola a fare altrettanto, evitando ovviamente di spacciarlo per handicappato; fare in modo che i suoi occhi possano ricominciare a fissarsi nuovamente su quelli di qualcuno in grado di condividere il suo vissuto senza giudicarlo. Aiutare la madre a tirare fuori il proprio dolore senza il timore di doverlo nascondere come 91 una colpa, affinchè possa gradualmente essere in grado di contenere, dopo avere liberato le proprie, le angoscie dei figli guidandoli all’accettazione della realtà. Luca è un ragazzino violento; in classe, dicono le insegnanti della scuola media che frequenta, ha atteggiamenti da boss con i compagni che lo devono rispettare; non pretende granchè ma ogni minimo disturbo, scherzo o atteggiamento troppo confidenziale viene sistematicamente punito con esplosioni di violenza fisica. Blocco drasticamente sul nascere la esplicita richiesta delle insegnanti: certificazione di handicapinsegnante di sostegno, panacea per tutti i problemi della scuola, l’unica risposta possibile, la delega, lo scarico di responsabilità, il pragmatismo di chi la scuola la conosce e la vive tutti i giorni a differenza del medico, estraneo, tutto teoria e niente fatti. Il padre di Luca ha abbandonato moglie e figlio già da molti anni, si è trasferito al Nord, si fa vedere e sentire un paio di volte l’anno. La madre è riuscita a trovare lavoro con una cooperativa di servizi di pulizia per locali condominiali; sta fuori casa tutto il giorno. Luca aveva sostituito la figura paterna assente con uno zio materno, aveva venticinque anni quando lo hanno ammazzato. E’ stato Luca a trovare il cadavere, crivellato da colpi di pisto la, riverso in una pozza di sangue all’interno del suo garage in cui , spesso con l’aiuto del nipote, effettuava interventi di manutenzione della motocicletta. Sia la madre del ragazzo che Luca negano la probabile appartenenza della vittima alla criminalità organizzata, parlano di tragico errore di persona. Da allora, son passati ormai quattro anni, Luca non riesce più a dormire sereno la notte, spesso chiede alla madre di ospitarlo nel suo letto. A scuola mostra momenti di affabilità e gentilezza nei confronti di alcuni insegnanti che cercano con lui un dialogo alla pari, si chiude a riccio se percepisce atteggiamenti pregiudiziali, se intuisce l’etichettamento, non fa altro che confermare il ruolo che gli viene riconosciuto. Durante il pomeriggio è completamente solo da quando non c’è più lo zio ed è stato visto frequentare compagnie considerate nel quartiere dedite alla microcriminalità. La madre è molto preoccupata e sta cercando di trovare un lavoro che le permetta di essere presente in casa al pomeriggio. In ambulatorio Luca non mostra alcun atteggiamento tipico dei ragazzi che stanno organizzando una personalità “sociopatica”, è molto garbato, attento, riesce a criticare le proprie azioni, ad esprimere i propri vissuti, non mostra diffidenza nei confronti di chi lo ascolta senza giudicarlo. I suoi pensieri, le sue fantasie, le sue angosce sono tutte venate dalla costante della perdita. Perduto il padre, perduta in parte la madre (anch’essa vittima di abbandoni), perduto lo zio amato con l’irruzione drammatica di un persecutore misterioso e spietato che ha fatto scempio delle sue speranze. Le alternative per Luca erano la resa totale con la caduta nella depressione franca o la reazione evacuativa della rabbia interiore sotto forma di aggressività. Il meccanismo intrapsichico dell’identificazione con l’aggressore è ben conosciuto: è lo stesso che porta genitori che da bambini hanno subito violenze ad essere a loro volta violenti nonostante il ripudio razionale della stessa; tale dinamica si esprime anche su identità sociali, etniche o religiosi, per cui popoli vittime di persecuzioni si trasformano a loro volta in persecutori, la storia purtroppo ne è piena. Luca vede i propri compagni di scuola a volte in compagnia dei genitori, immagina comunque la loro presenza, la sua autoimmagine ne esce sistematicamente perdente, la rabbia è conseguente così come il dubbio: forse non è stato in grado di conquistarsi l’amore paterno, non è stato in grado di difendere lo zio, di fargli bastare la sua presenza. Luca fa un sogno: uccide con rabbia un uomo sconosciuto che però sa essere l’assassino di suo zio, con orrore riconosce nel cadavere il volto di suo padre, si sente disperatamente solo e si rende conto di essere anche lui un assassino. La situazione estrema vissuta dal ragazzo rende quasi inestricabili le fisiologiche angosce edipiche (la rivalità con la figura paterna che si è sottratta, spingendo il ragazzo a 92 pretendere il suo posto accanto alla madre) caricandole dell’ulteriore senso di colpa per la sostituzione affettiva del padre con lo zio. Però Luca non sta utilizzando un modello per lui positivo, come accade nel percorso classico di iniziazione criminale e mafiosa in particolare; Luca così facendo riesce a tirare fuori la rabbia e contemporaneamente a punirsi per le sue presunte colpe. Per questo quando entra in rapporto con qualcuno che riconosce il suo vero ruolo di vittima assoluta, è costretto ad abbandonare la parte del “cattivo”. Come fare però a cancellare dalla sua mente l’orrore che ha vissuto, a non pensare che ciò che è accaduto potrà accadere di nuovo, a recuperare speranze per il futuro e fiducia in se stesso? Quel prete prendeva i ragazzi dalla strada di Luigi Ciotti Al processo degli assassini di padre Pino Puglisi, quando gli è stato chiesto perché l’avevano ucciso, hanno risposto: ”Quel prete prendeva i ragazzi dalla strada, ci martellava con la sua parola, ci rompeva le scatole”. Auguro a tutti, come cittadini, come insegnanti, di essere capaci di rompere le scatole. E’ un’espressione che ci permette di capire con molta chiarezza che rompere le scatole significa andare contro corrente, significa amore di verità e giustizia per una società che fa emergere i diritti delle persone. Puglisi prendeva i ragazzi dalla strada perché è importante recuperare la strada in senso positivo. Cercava di far in modo che questi ragazzi abitassero il loro territorio. Le mafie hanno devastato il territorio, l’hanno occupato e lo controllano. Mentre la criminalità con tutti i suoi volti è preoccupata di controllare il territorio, Don Peppino nel suo quartiere di Brancaccio invece faceva abitare il territorio, faceva trovare i propri spazi ai ragazzi. Per questo alle 20,40 del 15 settembre 1993 un colpo di pistola ha ucciso don Puglisi, parroco della chiesa di San Gaetano, nel quartiere palermitano di Brancaccio. Un solo colpo: alla nuca, vile, preciso e definitivo. Un colpo solo per spegnere la vita di Padre Pino Puglisi, “tre P”, come lo chiamavano i ragazzi, non certo per minor rispetto, ma, all’opposto, per quel profondo affetto e quell’amichevole familiarità che quell’uomo buono e coraggioso, quel prete dallo sguardo un po’ triste e sorridente, aveva saputo conquistarsi tra i fedeli e la gente del quartiere. Un colpo solo per zittirlo, per fargli smettere di “invadere” il territorio organizzando centri sociali e di accoglienza, spazi e momenti di aggregazione, come quel centro “Padre Nostro” frequentato da tanti giovani o quel Comitato degli inquilini di via Hazon. Luoghi di incontro, veri e vivi, in cui si disputava di come migliorare la vita del quartiere, dei problemi da affrontare e delle attività da promuovere per risolverli, fossero questioni di chiesa o di scuola, di verde pubblico o di famiglie in difficoltà da sostenere. La pistola degli omicidi era silenziata, ma l’eco di quel colpo arriva forte anche ad anni di distanza. Un fragore che non cessa di ferire le orecchie, di rimbombare nei cuori e nelle coscienze di molti, nella società civile e forse anche in chi lo ha ucciso. Allegato 2: dai verbali della requisitoria finale del processo per l’assassinio di Pino Puglisi 14 aprile 1998 Il teste Porcaro Gregorio all’udienza dell’11 novembre 1997 ha confermato le dichiarazioni rese all’udienza (...). Aveva conosciuto padre Puglisi, quando aveva l’età di otto anni (...) gli aveva insegnato a dir messa e con lui aveva instaurato un duraturo rapporto. Don Puglisi era divenuto il suo padre spirituale ed il suo 93 contatto lo aveva portato a scegliere la via del sacerdozio. Nell’ottobre del 1992 era divenuto suo viceparroco. Col padre Puglisi aveva vissuto esperienze entusiasmanti nel quartiere Brancaccio: “il suo modo di lavorare fuori dall’ombra del campanile .... era un prete.....che appena arrivato in questo quartiere vedendo un po’ tutte le problematiche che aveva, un quartiere senza niente, senza servizi ....... ha cominciato a sensibilizzarsi, sicuramente anche a partire dalla storia dei bambini di questo quartiere che giocavano in mezzo alla strada oppure li vedeva rubare a destra o a sinistra, a rompere i vetri delle macchine, rubare degli stereo e cose varie... cominciò a rivolgersi soprattutto ai bambini, ma non solo a loro, alle ragazze, ai giovani, un po’ a tutta la gente ..... col suo modo di fare sorridente....” Era di carattere schivo e riservato, preferendo l’impegno quotidiano alle azioni spettacolari, ma per il suo attivismo che si esprimeva nell’organizzazione di visite ed incontri con le Istituzioni, nella partecipazione a cortei contro il prepotere criminale, nelle denunce del malaffare, si era esposto prima alle rappresaglie poi all’offensiva della mafia, aveva ricevuto minacce, avvertimenti, che aveva coraggiosamente denunciato ai fedeli nelle omelie domenicali. Era stata incendiata la porta di casa, era stato dato alle fiamme un furgone della ditta che si occupava del restauro della sua parrocchia, erano stati minacciati suoi collaboratori e suoi parrocchiani, ma tutto ciò non lo aveva distolto dalle sue occupazioni silenziose e quotidiane in favore della comunità: soltanto di fronte all’azione implacabile di una mano omicida, il suo spirito indomito di religioso impegnato sul piano etico e civile aveva dovuto soccombere, solo ed inerme. Don Porcaro ha ricordato che padre Puglisi dicendo “Chi usa lo strumento della paura è quasi un animale” cercava di sensibilizzare la popolazione e non solo quelli che erano venuti in chiesa, aggiungendo : “Siamo uniti e non lasciamoci schiacciare dalla paura”. (..) Raccoglieva i giovani dalla strada, tossicodipendenti, e sbandati, utilizzando per il loro recupero e lo svolgimento delle attività sociali luoghi che un tempo erano dominio di “cosa nostra” che li destinava all’esercizio di attività criminali. Aveva dato vita ad un gruppo di giovani volontari diventato presto punto di riferimento per tutti gli emarginati della zona ed aveva creato un centro di accoglienza, “Padre Nostro”, annesso alla chiesa di San Gaetano(..), per articolare cura al recupero dei bambini del quartiere Brancaccio che non frequentavano la scuola. Per rendere più incisiva tale opera, verso la fine del primo anno di parroccato aveva istituito dei corsi di scuola elementare e di scuola media, maturando l’idea di creare un centro di accoglienza. Tale idea si era concretizzata l’11 gennaio del 1991, allorché in occasione della visita dell’arcivescovo di Palermo nella parrocchia, tutti avevano reclamato a gran voce che venisse istituito nella zona un ordine di suore per dare assistenza ai malati, agli anziani e ai bambini. Padre Puglisi non aveva accettato che “in un quartiere, dove c’era un disagio sociale grandissimo, si potessero spendere anche 80 milioni per delle feste, ed entrò in contrasto con loro”. Nel gennaio 1993 i ragazzi della parrocchia, i più piccoli, gli adolescenti avevano organizzato un presepe vivente e la manifestazione si era svolta proprio nei locali dello scantinato di Via S. Ciro. Per l’occasione il presidente del Consiglio di Quartiere aveva invitato alcuni uomini politici della D.C. , che egli aveva pubblicamente ringraziato al termine dello spettacolo. Padre Puglisi aveva preso la parola, quasi rimproverando gli illustri ospiti con un tono molto duro; aveva detto loro: “Ecco se voi siete venuti qui per aggiustare questo quartiere siate i benvenuti, se no è meglio che non venite più, non vi fate vedere assolutamente!..... Noi abbiamo bisogno di fatti non solo di parole o di belle parole o di ringraziamento. (...) Qui c’è una situazione nel quartiere disagiato al massimo, senza una scuola media, gente disoccupata .... situazioni familiari assurde, promiscuità incredibile e voi venite qui a chiedere voti, ma perché, con quale faccia vi presentate qui!”(...) Tanto fulgore del coraggioso prete che con la sua infaticabile opera cercava di ridare dignità di “uomini liberi” a coloro che si erano persi nel sottobosco mafioso, non poteva essere ovviamente gradito ai “potenti” della zona che fiutavano il pericolo che il loro vivaio di giovani gregari potesse essere in qualche modo distrutto. (...) Il Graviano fece sapere che l’omicidio non doveva apparire come un omicidio di mafia bensì come l’opera di un tossicodipendente o di un rapinatore. (..) “Dalle rispettive autovetture siamo scesi io e lo Spatuzza. Quest’ultimo avvicinò il sacerdote gli prese il borsello e gli disse: “Padre, questa è una rapina”. Nel frattempo io posizionandomi dietro il sacerdote esplodevo un colpo di pistola alla nuca di quest’ultimo da brevissima distanza. Il sacerdote non si è reso conto di nulla in quanto con un sorriso si era rivolto allo Spatuzza profferendo le seguenti parole: “... Me lo aspettavo”. 94 I figli dei collaboratori di Luigi Ciotti I figli dei mafiosi che hanno scelto di collaborare con la giustizia, come anche i figli dei testimoni di giustizia, subiscono spesso bruscamente una rivoluzione nell’organizzazione della loro vita quotidiana. Questi ragazzi e bambini anche in tenera età, si trovano sradicati dal loro ambiente e sottoposti a protezione insieme ai propri genitori, o ad uno solo di essi. Si trovano, da un giorno all’altro, a non potere più utilizzare il proprio nome, a non capire la ragione per cui hanno dovuto abbandonare nonni, cugini, amici. Ci sono famiglie (con genitori anziani, mogli che non sapevano che il marito era in un’organizzazione criminale... ) che vengono sradicate e devono ricostruire sé stesse nell’arco di una notte; spesso queste famiglie pagano un prezzo ingiusto. E’ necessario affrontare la tutela di questi minori anche dal punto di vista psicologico, cercare che il minore non venga travolto dalle vicende in cui sono coinvolti i genitori, gli adulti. Non dobbiamo dimenticare neanche i cosiddetti “incolpevoli”, coloro che ad esempio hanno visto uccisi dalla mafia i propri parenti e crescono immersi in quella subcultura mafiosa dove la vendetta è una norma da rispettare, anche loro dovrebbero essere aiutati, invece nei loro confronti purtroppo gli interventi di prevenzione sono pochi ed isolati. Il rischio è che i bambini finiscano per pagare le colpe dei padri. Al 30 Giugno 1999 su un totale di 4207 familiari protetti, collaboratori e testimoni, i minorenni erano 1997, pari ad una percentuale del 47,5 %. Appaiono quindi evidenti la complessità e la specificità di alcuni problemi collegati al mondo minorile ed ai numerosi traumi che i minori sono costretti a subire nel corso della loro vita “blindata”. A cominciare dal trasferimento, quasi sempre all’improvviso, in una località “protetta”, ossia in un comune diverso e lontano da quello di abituale residenza e noto solo al Servizio Centrale di Protezione, in un contesto ambientale e culturale ben differente da quello di origine. E’ facile comprendere la delicatezza di tale intervento, se solo si pensa che ciò determina lo sradicamento di interi nuclei familiari dai luoghi che, magari fin dalla nascita, hanno rappresentato tutto il loro mondo. Si immagini quindi quali sofferenze psicologiche possono prodursi in un bambino che perde improvvisamente i propri punti di riferimento, quali la casa, la scuola, gli amici, i giochi, i nonni, e così via, ed è costretto a modificare radicalmente il modo di vivere la propria infanzia. Spesso poi le esigenze di riservatezza comportano la necessità di cambiare la località di protezione appena prescelta, aggravando ulteriormente i problemi dei minori. I problemi scolastici sono forse i più delicati tra quelli che quotidianamente si affrontano nell’attività di protezione dei minori familiari dei collaboratori. Sono 466 i minori che nel corrente anno scolastico sono stati trasferiti dal luogo d’origine ed iscritti a scuola con nominativo di copertura: di questi, 97, avendo meno di sei anni, frequentano l’asilo nido, 217 sono iscritti alla scuola elementare, 95, frequentano la scuola media e 57 sono iscritti alla scuola media superiore. Allegato 3: Educazione a delinquere di Franco Occhiogrosso Se la devianza dell’Italia centro -settentrionale è caratterizzata dalla massiccia presenza di ragazzi stranieri (circa il 40% del totale nel 1998), profondamente diversa è invece la situazione delle regioni meridionali, nelle quali l’incidenza dei giovani stranieri è decisamente modesta rispetto a quella dei ragazzi italiani. L’inquinamento mafioso dei minori italiani si manifesta 95 sia con il coinvolgimento diretto e strumentale nelle azioni dell’organizzazione criminale, compresi i reati più gravi (omicidi, estorsioni, rapine) sia con la trasmissione della subcultura della mafiosità, riscontrabile nel frequente uso delle armi anche da parte di minori non coinvolti nella criminalità organizzata o nel diverso atteggiamento che i ragazzi hanno nei rapporti sia con gli operatori sociali dei servizi che con il giudice minorile, con cui difficilmente accettano un colloquio autentico. Bilancio familiare? Ci pensano i figli È questo il frutto dell’esasperarsi del fenomeno mafioso, tradizionalmente presente in Sicilia, Campania e Calabria, e diffusosi a partire dalla fine degli Anni Ottanta anche altrove. La Sacra Corona Unita pugliese è quasi certamente un fenomeno indotto, nato quando le organizzazioni criminali siciliane, campane e calabresi, intuita la grande importanza che avrebbero assunto le coste pugliesi per i traffici illeciti, stabilirono intese con la malavita locale, favorendone lo sviluppo in senso mafioso. Il coinvolgimento di minorenni in tali organizzazioni non è generale. Alcune di esse (ad esempio Cosa Nostra siciliana) tradizionalmente ne diffidano; altre invece li impiegano come manovalanza soprattutto nel mercato della droga: talora hanno utilizzato i più “svegli” come baby killer, dopo averli cooptati nell’organizzazione con un apposito “battesimo del sangue”. Il coinvolgimento dei ragazzi è stato ottenuto offrendo loro per i servizi più elementari (ad esempio, segnalare l’arrivo della polizia nei luoghi dello spaccio) somme consistenti (in media circa 100mila lire al giorno, ossia 3 milioni al mese). Trattandosi di ragazzi che provengono da famiglie disagiate, entrate di tale entità sconvolgono spesso la gerarchia familiare: il figlio finisce per essere considerato il capo, proprio perché è l’unico a garantire una sopravvivenza decorosa, mentre il padre, quasi sempre disoccupato, perde ogni autorità. Un altro evidente indizio del coinvolgimento di ragazzi nelle organizzazioni criminali è la nomina di avvocati di fiducia, spesso professionisti di fama che difendono anche i componenti adulti del clan a cui è stato affiliato il minore. Per rendersi conto della gravità della situazione meridionale è peraltro sufficiente analizzare le statistiche dei minorenni italiani arrestati nel 1999 (vedi la tabella accanto). Risaltano le cifre della Campania (322 minorenni italiani arrestati), della Sicilia (456), della Puglia (332). Dati che, se confrontati con quelli delle regioni settentrionali, danno la misura delle profonde differenze tra le diverse realtà territoriali. Questo dato quantitativo, che pure è di tutta evidenza, va poi associato a quello non meno significativo della gravità dei delitti. La presenza dei baby killer, che nel 1991 era un dato appena emergente, è invece purtroppo divenuto un elemento stabile negli anni successivi. “Non sono Fatti miei…” Se è indubbiamente molto grave il fenomeno del deterioramento qualitativo della devianza minorile meridionale, certamente ancora più grave è il suo principale prodotto, la mafiosità. Con la mafiosità per la prima volta la criminalità minorile meridionale si fa portatrice di una subcultura che oppone un suo costume di vita ai principi del vivere civile. Essa si sostanzia nell’affermazione della fedeltà cieca ed indiscussa al clan e al suo capo, nell’omertà come regola generale di condotta, nella prevaricazione sui più deboli e nel sostegno per il più forte, nella sfiducia e nel rifiuto di ciò che viene dallo Stato o lo rappresenta. Gradualmente la mafiosità è passata dall’essere un modo di operare nell’illecito ad essere un costume sociale sempre più diffuso. Limitata in un primo tempo ai soli appartenenti ai clan, si è estesa poi ai fiancheggiatori e ad altre figure simili, fino a diventare “mafiosità senza mafia”, cioè un modo di essere, un costume sociale che non riguarda solo l’area connessa alla criminalità, ma la generalità dei cittadini. La sua diffusione non ha risparmiato nemmeno il mondo studentesco. Qualche anno fa un gruppo culturale di Molfetta (Bari), ha promosso un sondaggio tra gli studenti delle scuole medie della città per conoscere la reazione dei ragazzi ad un episodio accaduto l’anno precedente: l’omicidio del sindaco, uomo probo, da parte di un gestore di giochi per feste di paese, che aveva cercato di corromperlo. Dal sondaggio effettuato emergeva che, accanto alla gran parte degli studenti che considerava correttamente il fatto come un efferato delitto, vi era un gruppo minoritario (circa 500 studenti), che interpretava la vicenda come un regolamento di conti: se l’omicida aveva sparato, non poteva non esserci una ragione, un legame illecito che legava i due e che solo essi conoscevano. In sostanza, la probità e l’onestà del sindaco venivano negate alla radice. Questi studenti aggiungevano inoltre che essi mai sarebbero intervenuti a favore della vittima «perché non erano fatti loro». Nella sottocultura della mafiosità senza mafia il limite che separa la parola dall’azione è poi spesso impercettibile, come dimostra quanto accaduto l’anno scorso in una scuola professionale di Bari, dove un gruppo di studenti ha realizzato una sistematica azione di spaccio nella scuola, costringendo i compagni di classe a fare da corrieri. Col suo ingresso nel mondo studentesco, la mafiosità compie insomma un ulteriore salto di qualità, essendo la scuola uno dei pochi baluardi culturali in grado di diffondere i principi del vivere civile. Il malessere del benessere A partire dai primi Anni Novanta si è registrata in Italia una forma di devianza minorile del tutto sconosciuta in precedenza, caratterizzata dall’assenza di ogni coerenza tra causa ed evento; le condotte cioè sono tanto violente ed efferate quanto le 96 motivazioni inesistenti. Si va dal lancio assassino di pietre dai cavalcavia alla violazione di cimiteri, dal “bullismo” nelle scuole all’omicidio delle persone senza fissa dimora, dalle sevizie agli animali ai disordini provocati negli stadi da gruppi di ultras. Il fenomeno non è quantificabile, in quanto i reati che derivano da queste nuove forme di devianza sono catalogati in categorie statistiche generali e non in modo separato, ma è certo che esso esiste in ogni regione. In quest’area di problemi è stato collocato anche il fenomeno delle cosiddette baby gang, presenti soprattutto in Lombardia. Si tratta di reati che ogni volta risultano inspiegabili, feroci, senza movente. Come il recente omicidio di una suora commesso a Chiavenna (Torino) da alcune ragazzine, o l’ancora più recente omicidio di una bimba di otto anni commesso ad Andria (Bari) da cinque giovani appena maggiorenni. O ancora quello avvenuto qualche anno fa in Puglia a Castelluccio dei Sauri, dove due amiche hanno barbaramente ucciso una compagna di scuola, o quello accaduto in Piemonte, a Tortona, dove una donna fu uccisa da un sasso lanciato da un cavalcavia dell’autostrada. I protagonisti di questi fatti sono riconducibili talora ai modelli di una devianza “tradizionale” – quella in cui sono coinvolti ragazzi non scolarizzati, che vivono nelle periferie e fanno parte di famiglie molto povere – ma sempre più spesso si tratta di giovani di ceto sociale più elevato, membri di famiglie benestanti. Questo fenomeno rappresenta probabilmente solo un ampio spicchio di un più largo e profondo disagio giovanile, di cui si colgono varie spie nel consumo di droghe, nell’aumento di suicidi o tentativi di suicidi di minorenni, nelle morti del sabato sera, nell’ampia diffusione di disturbi psichici e psicosomatici (in particolare bulimia ed anoressia). Un disagio che si traduce in una violenza terribile contro gli altri o contro se stessi e che è l’altra faccia del benessere, quella abitualmente indicata come “il malessere del benessere”. In termini sociologici sono state date interessanti spiegazioni. Si è parlato della profonda modificazione dei valori e dei modelli durante gli Anni Ottanta, del diffondersi tra i giovani di una sorta di spirito di omologazione al posto della tradizionale contestazione sociale. Ma, mentre che si consolidava l’egemonia di questa nuova cultura, accanto all’aumento del benessere sono emerse le nuove forme di disagio innanzi indicate. Un fenomeno nuovo, che si caratterizza per l’ingresso nel mondo della devianza del ceto medio e delle donne, ma anche per le responsabilità degli adulti: si pensi ai gravi danni dell’espandersi dei comportamenti di abuso (non solo sessuale) su minori, o anche solo alla condizione di sofferenza dei bambini che divengono oggetto di contesa tra genitori separati (talmente diffusa da essere recentemente assurta a patologia psichiatrica con il nome di Parental alienation sindrom). Minori adultizzati In conclusione si può dire che il problema della devianza minorile italiana riguarda soprattutto le quattro regioni meridionali a rischio (Campania, Sicilia, Puglia, Calabria) dove il fenomeno presenta connotazioni patologiche connesse al deterioramento della qualità della vita, alla natura della devianza, alla carenza di risposte sociali. Altrove ha invece carattere fisiologico, connesso in gran parte al profondo cambiamento sociale che, al Nord e nel Centro Italia, sta trasformando la società monorazziale in società multietnica. La devianza minorile straniera riguarda soprattutto giovani zingari e africani. I primi – in virtù del nomadismo famigliare – sono presenti un po’ in tutta Italia e sono “specializzati” nei furti nelle abitazioni. I secondi sono spesso utilizzati come corrieri o piccoli spacciatori di droga, soprattutto al Nord e al Centro. Ma negli ultimi anni la devianza minorile straniera in Italia ha coinvolto adolescenti che provengono anche da altre parti del mondo (vedi la tabella accanto ndr.). Ci si è domandato se i ragazzi devianti, soprattutto al Sud, facciano parte della manovalanza del crimine, come è stato in passato, oppure se stiano incominciando a rivestire ruoli più importanti. In linea di massima sembra di no. Che i ragazzi stranieri siano sfruttati dagli adulti è indubbio. Lo conferma la “specializzazione” in alcuni tipi di delitti evidentemente indotti, come quelli, numerosi, che vedono protagoniste le bambine di famiglie nomadi. Ma lo stesso vale per i ragazzi italiani del Sud trovati in possesso di armi o di ingenti quantitativi di droga. Ci troviamo insomma di fronte ragazzi soggetti a precoci processi di adultizzazione, tali da indurre atteggiamenti e comportamenti delinquenziali non solo all’interno del gruppo dei pari – come avveniva in passato – ma anche verso tutti gli altri. In questi casi gli interventi di recupero devono essere mirati. Il rischio, altrimenti, è di rispondere con interventi adultizzati e una devianza adultizzata, con buona pace di una giustizia che intenda ancora definirsi “minorile”. (pubblicato nel n. 6 2001 di Narcomafie ) BIBLIOGRAFIA III MODULO − AA.VV., Annuario Sociale 2001, Feltrinelli − AA.VV., Droga ai due estremi della catena, EGA, 2000 − AA.VV., Scuola, famiglie e giudici di fronte al bullismo, in MINORI giustizia, n 2, 2000, Franco Angeli − AA.VV., Dipendenze antiche e nuove, in La professione sociale, ed CLUEB, n 2, 2000 97 − J. BALDARO VERDE, La sessualità tra piacere, colpa e vergogna, Edizioni Universitarie Romane, Roma, 2001 − A. BONOMI, Il distretto del piacere, Bollati Boringhieri, Torino, 2000 − M. CAMPEDELLI – L. PEPINO, Droga: le alternative possibili, EGA, 1997 − CARITAS, Immigrazione- dossier Statistico 2001, nuova anterem − CISS, Dietro le droghe, EGA, 1993 − M. DA PRA e L.GROSSO Prostitute, prostituite, clienti. Che fare? , EGA, 2002 − M. DA PRA, Prostituzione. Tratta delle persone.( in Pagine, n.1, Gruppo Abele) − D. GONIN, Il corpo incarcerato, EGA, 1994 − MARANGI – ROSSI, La mafia è cosa nostra, 10 film sull’onorata società, EGA 1993 − T. MATHIESEN, Perché il carcere?, EGA, 1996 − IL LAVORO DI STRADA , Quaderni di Animazione Sociale, 1995 − P.RIGLIANO, INdipendenze, EGA, 1998 − S. SCIFO, Vittime assolute, EGA, 1998 − F. SILVESTRI, Oltre la mafia, EGA , 2002 − Questa è la legge ….. Disposizioni legislative su prostituzione, immigrazione, minori (Pagine- il sociale da fare e da pensare, n. 2, 2001 Associazione Gruppo Abele) 98
Scaricare