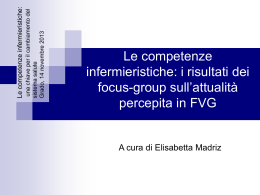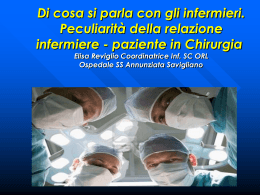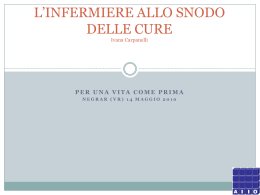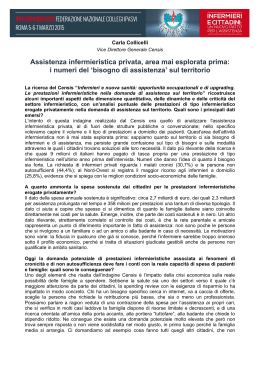Collegio di Torino IL CODICE DEONTOLOGICO: STRUMENTO DI LAVORO PER LA PRATICA QUOTIDIANA INFERMIERISTICA Atti del convegno – Torino 30 novembre – 1° dicembre 2009 Con il patrocinio M.A. Schirru (Presidente Collegio IPASVI di Torino) Benvenuti a tutti. Apriamo questo Convegno dal titolo “Il codice deontologico: strumento di lavoro per la pratica quotidiana infermieristica” nell’auspicio di sviluppare le basi per discutere, confrontarsi ed affrontare una realtà sanitaria e professionale sempre più complessa. È grazie al confronto che si può trovare un’unità d’intenti, così che la professione possa emergere in tutto il suo valore e la sua forza quale elemento fondamentale nella conduzione della Sanità e nel dare risposte di salute ai cittadini. Ringrazio l’azienda Ospedaliera San Giovanni Battista della città di Torino per averci ospitato. Tale ospitalità ha significato per l’azienda la variazione d’impegni già assunti per un corso che, tutto sommato, rispecchia quello odierno, ossia discutere e confrontarci circa il Codice deontologico. Ringrazio quindi per un simile sforzo, per aver rinviato i programmi a livello aziendale al fine di darci l’opportunità d’essere qui, insieme. Lascio la parola alle autorità, che daranno l’avvio ai lavori di questo pomeriggio. Inizierà la rappresentante di Cittadinanzattiva e del Tribunale del Malato, signora Elisabetta Sasso. Elisabetta Sasso (rappresentante Tribunale per i diritti del Malato – Cittadinanzattiva) Grazie e buongiorno a tutti. Sono qui in rappresentanza del Tribunale per i diritti del Malato‐ Cittadinanzattiva. Vi devo ringraziare innanzi tutto per l’invito. Vi porto il saluto di tutti i tribunali per il malato sparsi in Regione, i quali, quotidianamente, hanno dei rapporti con voi. Devo anche ringraziarvi per la collaborazione e la cooperazione che costantemente troviamo con le figure infermieristiche. Non vorrei fare un saluto troppo complimentoso nei confronti della vostra categoria, ma devo dire, anche per mia esperienza personale, che da sempre – chiariti alcuni punti fermi – la collaborazione con gli infermieri professionali è per noi un alleato prezioso nella tutela dei diritti del malato. Ricordo, una ventina d’anni fa, i primi incontri, qui alle Molinette, proprio con le Caposala e le infermiere. Ebbene, tali incontri hanno portato ad un nucleo di persone che collaborano con il Tribunale per i Diritti del Malato, all’analisi partecipata della qualità, all’audit civico che, fra l’altro, si sta svolgendo in questi giorni in tutta la Regione Piemonte, anche con la vostra collaborazione. Quindi, un particolare ringraziamento per l’attenzione – all’interno della vostra professione – che dedicate a quanto noi proponiamo. Mi complimento anche per la vostra attenzione nei confronti dell’etica e del Codice deontologico, termini che in questo periodo stanno perdendo di significato in molte situazioni. Voi invece continuate a rispettarli, e non può che farci piacere. È – quella di Cittadinanzattiva – una richiesta di continuare a collaborare insieme, soprattutto nella difesa della Sanità Pubblica, così come la intendiamo entrambi. Un augurio di buon lavoro e grazie ancora a tutti quanti. 2 Giuseppe Galanzino (Direttore Generale Azienda San Giovanni Battista) Vi ringrazio d’essere intervenuti a questa iniziativa. L’azienda Ospedaliera Universitaria Molinette mette volentieri a disposizione le sue strutture per convegni ed iniziative che, come scritto sul depliant, mettono al centro dell’attenzione il malato in quanto tale. Questa azienda si sta muovendo da tempo in tale direzione. Dopo la relazione introduttiva si terrà una Tavola rotonda sulle questioni religiose e culturali dei pazienti del Servizio Sanitario. Conosco personalmente uno dei partecipanti alla Tavola rotonda, ci siamo visti a Roma, perché l’azienda Molinette, da circa due anni, persegue un progetto sulle religioni. Dapprima un accordo con rappresentanti di una quindicina di religioni per permettere ai pazienti di far venire, quando sono ricoverati, il proprio ministro di culto. Questo accordo è stato stipulato anche grazie alla collaborazione dei cappellani dell’Ospedale Molinette. Inoltre, la scorsa primavera è stata inaugurata la “stanza del silenzio” in un’area dell’Ospedale verso via Genova, via Cherasco. Questa “stanza del silenzio” – aperta tutti i giorni dalle nove del mattino alla sera – è un luogo in cui i pazienti ed i loro parenti – credenti o meno – possono recarsi a meditare, a pregare, senza chiedere nessun particolare permesso. Abbiamo notato – da un registro posto all’esterno, naturalmente non vi è nessun controllo – che è discretamente frequentata, in particolare da seguaci di alcune religioni. Queste sono alcune delle iniziative che sono state assunte in un contesto in cui l’Ospedale Molinette ospita pazienti extracomunitari e/o di religioni diverse. Ritengo che gli infermieri saranno sempre più protagonisti del nostro Sistema Sanitario. Con l’introduzione del numero chiuso alla Facoltà di Medicina, gli attuali numeri dei medici – sto parlando di Molinette – saranno irripetibili. Do solo una cifra: alle Molinette abbiamo circa 950 medici dipendenti e 1.800 studenti che frequentano la Facoltà di Medicina, più 1.200 specializzandi. Non tutti fra i 1.800 studenti sono già laureati, naturalmente. Questi numeri, in particolare i 950 medici, sono numeri overdosati, nel senso che tra i grandi ospedali italiani le Molinette è l’azienda che ha il maggior numero di medici. Questo consente alle Molinette di essere quasi sempre in testa alla graduatoria nazionale in fatto di case‐mix, di media del peso del DRG prestato ai pazienti. Sarà impossibile riprodurre questo numero. I buoi in parte sono già scappati, nel senso che ogni tanto si sente qualcuno che afferma che bisogna abolire o allargare il numero chiuso. Credo che nei prossimi dieci anni ci sarà un po’ di rivoluzione copernicana nel settore dell’assistenza, nel senso che gli infermieri avranno sempre più importanza e dovranno, secondo me, cominciare, in qualche modo, ad occuparsi di cose che in questo momento spettano ai medici, perché il loro numero non sarà più quello. In questo ospedale l’età media del personale medico va dai 53 ai 58 anni, per cui fra dieci anni, se non prima, una larga parte di questi medici comincerà ad andare in pensione. Al di là delle parole ci stiamo già muovendo in una direzione di questo tipo: dal giugno di quest’anno, sulla base di un progetto cittadino, due aziende sanitarie di Torino – Molinette e ASL TO 2, quella di barriera di Milano – hanno preso in gestione delle strutture socio‐sanitarie. Le Molinette hanno preso in gestione i Poveri Vecchi, in Corso Unione Sovietica, la storica struttura di ricovero per i cittadini torinesi. Andremo progressivamente a farne una struttura di post ricovero. In questa struttura di post ricovero avrà larga preponderanza la parte relativa alle cure tutelari e, in minor misura che in ospedale, le cure sanitarie. Abbiamo previsto – in primavera dovremo aprire i primi due piani – un reparto di soli infermieri, una struttura a gestione infermieristica, dedicata, nel momento in cui faremo questa sperimentazione, al post ricovero. 3 Credo che la direzione giusta stia nell’assumere delle iniziative, nell’impiegare il vostro background culturale al fine di riunire le professionalità, superare le barriere e cercare finalmente di mettere il malato al centro dell’attenzione. È essenziale in un ospedale altamente specializzato come il nostro, perché in questo momento, o fino a questo momento, è il malato che gira all’interno dell’ospedale e non l’ospedale che si fa carico di andare dal malato e considerarlo una persona completa, anche con i suoi bisogni non solamente sanitari. Buon lavoro e grazie. Oscar Bertetto (Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari) Mi è particolarmente gradito essere presente all’inaugurazione di questo vostro Convegno perché l’Agenzia Regionale ha caratterizzato – in questi suoi tre anni di lavoro, che sono gli anni in cui sono andato a dirigerla – una presenza infermieristica attiva in tutti i gruppi di lavoro dell’Agenzia. Quando dico tutti i gruppi di lavoro non intendo soltanto nei percorsi diagnostico‐terapeutico‐assistenziali – dove era dato per scontato che fossero presenti gli infermieri a determinare parte di questi percorsi, sin dalla costruzione degli stessi – ma anche in quelli che vengono definiti progetti più strutturali della Sanità Regionale. Per cui, sono presenti gli infermieri nel gruppo che ha determinato le nuove regole dell’accreditamento delle strutture sanitarie e sono presenti gli infermieri a determinare questo accreditamento. E’ una vostra collega, un’infermiera, a dirigere il gruppo che sta portando il cittadino a compartecipare a momenti dell’accreditamento per processi come quello che stiamo portando avanti per la protesi d’anca. Nell’ambito del rinnovamento dell’informatizzazione del sistema, gli infermieri si stanno occupando di una ricerca clinica che sta paragonando cartelle infermieristiche informatizzate in uso in Europa: stiamo valutando quella spagnola, quella svizzera, quella tedesca in una ricerca che è tutta condotta esclusivamente da infermieri. Così come sono infermieri la maggioranza delle persone che in questo momento sta realizzando le interviste negli ospedali della nostra Regione e in seguito a livello territoriale, per valutare lo stato della “clinical governance” presente nelle nostre strutture sanitarie. Per entrare un po’ più nello specifico del tema di oggi – siccome non voglio caratterizzare gli interventi ai congressi come interventi formali di saluto, ma anche come assunzione di responsabilità dell’Agenzia nei confronti degli infermieri sulle tematiche che oggi andrete a discutere – voglio ricordare che il regolamento con cui abbiamo messo a punto il nuovo sistema di formazione ECM Regionale prevede, come provider, proprio i Collegi Infermieristici della Regione e li vede appunto come provider nella promozione di corsi, di congressi e di momenti di aggiornamento per quanto riguarda tutto il campo della deontologia e dell’etica, due argomenti che classicamente fanno parte dei compiti istituzionali dei Collegi Infermieristici. Accanto a ciò stiamo promuovendo – nuovamente con una forte componente di presenza infermieristica – la costruzione di spazi etici di discussione a livello delle aziende, che è uno dei punti del progetto del “Piano di Attività e Spesa” dell’A.Re.S.S. per il 2010. Spazi etici, perché noi riteniamo che debba essere data voce, all’interno delle strutture sanitarie, alle tematiche etiche che derivano dalla quotidianità del nostro lavoro e che non vengono affrontate dai Comitati etici aziendali che in qualche modo riservano la maggioranza dei loro interventi all’esame dei protocolli di ricerca. Sulla base del modello francese, promuoveremo, a livello delle nostre aziende, l’apertura di questi spazi etici di discussione. Un altro tema che sarà dibattuto nel vostro Convegno e che stiamo seguendo con particolare attenzione, è la promozione della ricerca in ambito infermieristico. Questo presuppone la presenza degli infermieri a livello dei Comitati etici, presuppone una diversa valutazione che i Comitati etici 4 devono fornire riguardo i protocolli di ricerca, ma significa anche promuovere momenti di ricerca a livello di attività quotidiana di lavoro, dove lavoro formazione e ricerca si intersecano. Penso, per esempio, alle comunità di pratica come modalità nuove per promuovere formazione e ricerca a livello regionale, un altro dei campi su cui credo che una vostra collaborazione sarà oltremodo necessaria. Altro tema discusso nel congresso – ed è un classico tema etico – riguarda l’equità di accesso ai servizi. Tutto il tema dell’equity audit e dell’attenzione all’equità di accesso in tutti i progetti che l’Agenzia va predisponendo è un tema su cui lavorare insieme. Ma tutto ciò, secondo me, non è possibile senza affrontare un discorso di fondo che io definisco di “empowerment organizzativo della figura infermieristica all’interno dei modelli organizzativi aziendali”. Ritengo sia giunto il momento di rivedere la riorganizzazione Aziendale per dare sostanziale voce al mondo infermieristico, ma questo lo si realizza non solo chiedendo a posteriori l’apporto infermieristico su progetti già elaborati, ma che i progetti futuri vengano definiti fin da subito con la presenza della vostra professionalità. Stiamo quindi promuovendo tutto ciò all’interno di un discorso più generale sull’empowerment che, naturalmente, tiene conto in primo luogo dell’empowerment individuale del cittadino ‐ punto di forza di tutto il sistema ‐ ma subito dopo valuta anche dell’importanza di promuovere l’empowerment organizzativo: la figura infermieristica non può che essere tenuta in particolare considerazione, come abbiamo già sentito dalle parole del Direttore Generale dell’Azienda che sta ospitando questo Congresso. Quattro grandi impegni sono di fronte a noi: il ruolo dell’infermiere nella ricerca; gli spazi etici di discussione all’interno dell’Azienda ed il ruolo dell’infermiere all’interno di questi spazi; il ruolo che può svolgere l’infermiere nell’equity audit e nel garantire l’equità di accesso alle prestazioni, il ruolo di una diversa organizzazione aziendale e quindi di empowerment organizzativo infermieristico, in particolare nei nuovi modelli di struttura ospedaliera che, anche quando esaminano nuovi percorsi come quello per intensità di cura, parlano ancora di intensità di cura e non di assistenza, causando quindi un ulteriore problema in un ospedale che viene valutato in base ai DRG prodotti. Abbiamo sentito il Dr. Galanzino parlare di case‐mix, ma il case‐mix tiene conto di una visione dell’assistenza ospedaliera che è ancora basata sull’intervento di tipo solo medico, mentre noi dobbiamo promuovere anche la valorizzazione delle tematiche di carattere infermieristico. È probabile quindi si debbano valutare anche nuove unità di misura delle prestazioni che vengono fornite dalle nostre strutture sanitarie, ed è proprio su queste novità che A.Re.S.S sviluppa il suo compito, ossia quello di percorrere strade innovative per valutare se possiamo valorizzare sempre più tutte le figure degli operatori del Sistema Sanitario Regionale Piemontese e, in particolare, data la giornata di oggi, quella infermieristica. Grazie. Mario Paleologo (Direttore S.I.T.R.A. delle Molinette) Ringrazio gli organizzatori di questo evento, la Presidente del Collegio IPASVI e la Presidente del CESPI per avermi invitato all’apertura dei lavori di questo importante e significativo Convegno. Ringrazio in particolare gli infermieri, i veri attori ed i veri protagonisti, in quanto sono sempre più consapevoli di come il rapido evolvere delle conoscenze richieda loro di risolvere problemi sempre più complessi. Così come si saranno accorti anche dell’evoluzione e della personalità dei soggetti, dei gruppi sociali e della cittadinanza di fronte ed in presenza di situazioni legate ai problemi della salute. Così anche della 5 trasformazione delle istituzioni che operano nel campo della salute che di conseguenza determinano, hanno determinato e determineranno sempre più la dilatazione e l’ampliamento delle funzioni dei ruoli degli stessi operatori coinvolti all’interno dei vari contesti assistenziali. Riporto quindi l’attenzione al titolo di questo evento: “Il Codice deontologico: strumento di lavoro per la pratica quotidiana infermieristica”. Titolo che, a mio parere, rappresenta o dovrebbe rappresentare, sia ai cittadini che alle istituzioni, la visione strategica attraverso la quale l’infermiere si ispira con maggiore competenza e rigore morale per approcciarsi più coerentemente all’evoluzione di concetti come la salute, il processo assistenziale, il cambiamento organizzativo. Mi auguro che questo evento accresca la consapevolezza di muovere decisi passi in direzione di un riequilibrio del rapporto tra professione e società e tra infermiere e persona assistita, consapevoli che ciò comporta un riesame del proprio ruolo professionale alla luce dei nuovi mutamenti, del modo di pensare alla vita umana e alla salute, dei concetti fondamentali della tradizione e della storia infermieristica, dell’assistenza infermieristica e degli impegni assunti nel tempo. Domandiamoci tutti: cos’è cambiato o cosa sta cambiando nell’assistenza infermieristica? O meglio: un’assistenza infermieristica autorevole, capace di fungere da guida all’attività professionale, cosa deve fare? Sono certo che nel corso di queste due giornate saranno date delle risposte chiare, esaustive, capaci di delineare il cammino che la professione deve compiere per arrivare al pieno riconoscimento nei diversi contesti assistenziali. Ma la domanda vuole porre in realtà l’attenzione su due aspetti. Il primo: emerge la necessità, almeno sul piano dialettico, di chiarire ulteriormente che la prassi e la teoria non sono in conflitto, anzi, si completano e si spiegano a vicenda nella figura stessa dell’infermiere che agisce in una data situazione assistenziale. La saggezza pratica consente all’infermiere di interpretare adeguatamente la complessità della situazione assistenziale con tutto se stesso, con la sua capacità, con la sua tecnica, con la sua umanità, e la teoria infermieristica lo aiuta ad erogare un’assistenza infermieristica misurabile, efficiente, efficace e soprattutto rispettosa delle irriducibili alterità del paziente. Quindi, è fondamentale aver chiaro che gli ideali conoscitivi e pratici di un tale sapere teorico non si fermano alla conoscenza dell’oggetto studiato, ma ne ricercano in profondità la comprensione e non si accontentano dell’applicazione neutrale di procedure tecniche ancorché massimamente accreditate, ma misurano l’adeguatezza della pianificazione attraverso una maggiore partecipazione della persona e attraverso la personalizzazione dell’assistenza. Il secondo aspetto: il timore della divisione tra generazioni, la fatica di tenere insieme l’identità. Le componenti professionali diverse per età, generazione e formazione fanno fatica a stare insieme. Attenzione: la grande forza degli infermieri sta proprio nei tanti cervelli che la compongono e nella capacità di stare insieme. Quelli della mia generazione hanno costruito la propria identità professionale sull’ideale di servizio, sulla capacità di anteporre ai propri bisogni quelli della persona assistita ed è in tal senso che oggi il nuovo Codice deontologico rafforza il principio secondo il quale intende l’assistenza infermieristica come servizio alla persona. È un servizio posto proprio in risposta ai bisogni della persona e al rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo, dei principi etici della professione, è condizione essenziale per l’assunzione della responsabilità delle cure infermieristiche, considerato che etica, umanizzazione e qualità sono i tre pilastri messi a fondamento della struttura organizzativa del sistema socio‐sanitario. La condivisione piena, vera, reale di un ideale di servizio può unire gli infermieri a garantire una legittimità del proprio ruolo nei diversi contesti assistenziali. Grazie e buon lavoro. 6 Maria Adele Schirru (Presidente Collegio IPASVI di Torino) Ringrazio le autorità per averci dato il saluto ed il loro contributo. Iniziamo così i lavori, richiamando, come ha detto il collega, il titolo di questo Convegno. Lui è convinto che da queste giornate emergeranno risposte esaustive. Lo spero anch’io. Il problema sta nel fatto che affrontiamo un argomento complesso e molto probabilmente non esistono verità assolute o ricette da trasmettere. È molto più probabile che da queste giornate emerga un metodo, la possibilità di trovare attimi di riflessione che vadano al di là dello stesso Convegno, ma che diventino la quotidianità nelle nostre unità operative. Cedo la parola, per la prima relazione, alla Presidente della Federazione Nazionale dei Collegi, Annalisa Silvestro. Due concetti chiave nell’azione professionale delle’infermiere: accontability, advocacy Annalisa Silvestro (Presidente Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI) Ringrazio gli ospiti e la Presidente per questo invito e per avermi dato la possibilità di continuare un percorso che alla fine toccherà tutte le province italiane. Come collettività professionale – oltre ad aver realizzato un grosso lavoro di confronto, dibattito e riflessione per elaborare il nostro nuovo Codice deontologico – proseguiamo su questo cammino per fare in modo che, con questo Codice deontologico, tutti gli infermieri possano avere un momento di incontro, di scambio di informazioni, di riflessioni per renderlo – come giustamente diceva la Presidente nel titolo del Convegno – uno strumento di lavoro, un qualcosa a cui gli infermieri possano sistematicamente riferirsi nel momento in cui svolgono le loro azioni assistenziali, che sono azioni sempre più complesse perché ormai, come veniva fra l’altro anche detto dal vostro Direttore dell’agenzia, quello che oggi viene chiesto agli infermieri – non soltanto dalle Direzioni generali delle organizzazioni o comunque da chi ha responsabilità gestionali, ma anche dai cittadini, dalla collettività nazionale – è di non essere solo dei professionisti sanitari in grado di dare risposte attraverso prestazioni, azioni, gesti affidabili, direi rigorosi da un punto di vista scientifico ed anche caldi nel modo di porsi nei confronti dell’assistito, ma anche di assumere delle posizioni a valenza più ampia di quella che forse fino a non molto tempo fa noi consideravamo come il cuore del nostro esercizio professionale. Sto parlando di posizioni più ampie ovverosia posizioni di sistema, non solo di Sistema Sanitario, perché da quel versante mi pare di poter dire – con alti e bassi, con punti di forza e di debolezza – che il nostro gruppo professionale comincia ad avere consapevolezza del ruolo che riveste all’interno del sistema, che genere di anello è diventato nell’ambito della catena dei servizi, quanto sia importante il ruolo che svolge e quanto sia fondamentale una sua sempre maggiore acculturazione tecnico‐scientifica e professionale per continuare a fornire queste risposte. Mi sento di affermare che iniziamo un po’ 7 tutti a riflettere, ad avere consapevolezza di noi stessi. Fino a non molti anni fa pensavamo che l’assistenza fosse parte della clinica e che quindi fosse preminente il processo diagnostico‐ terapeutico. Di conseguenza, ritenevamo che la formazione e l’attività degli infermieri fosse prevalentemente una formazione e un’attività che dovesse rendere gli infermieri in grado di essere un brillante, capace, eccellente collaboratore del medico nel dare corso alla verifica dell’ipotesi diagnostica e quindi nella definizione dei percorsi terapeutici. Adesso sono le richieste che ci provengono dagli assistiti, ma anche dai Direttori generali e da chi ha responsabilità gestionali. Ci stiamo rendendo conto che, in realtà, fino a non molto tempo fa siamo vissuti in una stereotipia d’impostazione che non ha molti agganci né con la realtà né con le richieste che ci vengono fatte né con i contenuti scientifici del lavoro che svolgiamo, sia come singoli professionisti che nell’ambito dell’equipe assistenziale. Ossia: è la clinica che fa parte dell’assistenza. A questo punto, se è così, ed io sono profondamente convinta che lo sia, il medico, quando imposta il processo diagnostico ed il processo terapeutico, se vuole essere un professionista tutto tondo – prestando quindi la dovuta attenzione al cittadino, all’alleanza col cittadino e alla progettualità rispetto ad obiettivi di salute che si vuole tutti insieme far raggiungere allo stesso – non può prescindere dall’impostazione assistenziale, altrimenti ci troveremo a continuare a portare avanti all’infinito quella scollatura che c’è nelle unità operative, perché non è mica tanto vero che medici ed infermieri sono così “embricati”, che lavorano in maniera così integrata. Non perché non lo vogliono fare, non perché non hanno compreso che questo è il metodo migliore per giungere agli obiettivi, ma perché partono da presupposti assistenziali – nell’assistenza metto anche la clinica – diversi. Hanno una lettura su base disciplinare diversa del problema, non riescono sempre ad integrarsi perché forse qualcuno parte dal presupposto di una superiorità intellettuale, culturale, decisionale, organizzativa e di processo che vorrei capire bene su cosa si basa. Allora, finché, come infermieri, non mettiamo in discussione tutto ciò, siamo in evidente difficoltà, tendiamo a frustrarci nelle nostre aspettative professionali, tendiamo a ritenere che l’organizzazione ci sia matrigna, tendiamo a pensare che non si tenga in debito conto le necessità che hanno gli infermieri per poter dare quel certo tipo di assistenza che viene richiesta ai cittadini. Di conseguenza, tutto questo si riverbera e si ripercuote sull’assistenza che noi prestiamo ai cittadini e quindi sui risultati di salute. Prima di ragionare insieme ai voi sulla suggestione che mi ha provocato il titolo della relazione che la vostra Presidente mi ha assegnato, volevo fare ancora due riflessioni rispetto all’intervento del direttore dell’ARES. Intervento direi ottimo, attento e di grande apertura. Però, nello stesso tempo, di un’apertura limitata. Si continua a dire che gli infermieri sono importanti perché fanno la rilevazione dei dati, le indagini, perché fanno tutta una serie di attività importanti. Guai se non ci fossero: è un inizio, è un proseguo estremamente positivo. Ma vorrei sentirmi dire dai Direttori dell’agenzia regionale, ma anche dai Direttori generali, che si comincia a coinvolgere gli infermieri non soltanto per questi importantissimi spazi di tipo etico e scientifico. La ricerca: bene, speriamo che i Comitati etici comincino a pensare che devono occuparsi unicamente delle ricerche, che hanno come Direttore scientifico un clinico, perché altrimenti andiamo poco avanti. Così come è importante anche parlare di equità, di accesso ai servizi e soprattutto di equità di risposta, ma sta qui il problema. Io vorrei sentirmi dire da questi direttori – che hanno un forte potere decisionale, che hanno la possibilità di orientare in un modo piuttosto che in un altro la realtà sanitaria di una Regione – che forse, per vedere se l’accesso al servizio è equo, ma soprattutto se è equa la distribuzione delle risorse per poi dare risposta a chi ha fatto accesso ai servizi, è il caso di iniziare a parlare anche con gli infermieri, non soltanto coinvolgendoli quando le decisioni di massima sono prese. Coinvolgendoli prima. Sono d’accordo con il vostro Direttore dell’agenzia quando dice che bisogna andare verso l’empowerment organizzativo. È da una vita che lo chiediamo, perché in un’azienda la parte 8 prevalente dei professionisti sanitari non è rappresentata dai medici, ma dagli infermieri. E allora, finché non li coinvolgiamo – per davvero, direttamente – sulla progettualità organizzativa perdiamo una grande opportunità, continuiamo a mantenere questo senso di distacco, alle volte di frustrazione, questo disagio e comunque, a lungo andare, questa forte sensazione interna del non riuscire – io infermiere – ad esprimermi professionalmente, a trasmettere quei contenuti di competenza, di valorialità, di attenzione che vorrei dare in quanto l’organizzazione mi mette in difficoltà. Quando si parla degli ospedali per intensità di cura è da un paio d’anni che noi infermieri, all’interno della rappresentanza professionale, stiamo dicendo che è molto limitato parlare di intensità di cura, a meno che non si prenda a termine di paragone il concetto che dietro la cura ci sia anche, e insieme, l’assistenza. Però è un concetto che noi non amiamo molto per il discorso che facevo prima. È da tempo che stiamo dicendo che gli ospedali vanno organizzati per complessità assistenziale, ovverosia sulla base della complessità che presenta l’assistito e soprattutto sulla base del consumo di risorsa professionale e infermieristica che quell’assistito richiede per avere la tal prestazione. Di conseguenza, avrò un’organizzazione che pone realmente al centro dell’operare la persona e allora, forse, comincerò a mettere in discussione il fatto che siamo ancora organizzati – nelle nostre strutture ospedaliere ed in parte nei nostri servizi territoriali – come lo eravamo alla fine degli anni ’60, quando è stata approvata la legge di riforma ospedaliera, la legge Mariotti, che ha organizzato gli ospedali dividendoli in varie tipologie. Quello che mi preme affermare è che tale legge ha organizzato gli ospedali nei reparti: maschile e femminile. In seguito i reparti sono stati chiamati in un altro modo. Li abbiamo chiamati unità operative semplici e complesse, prima c’erano i moduli, eccetera, eccetera. Adesso le unità operative semplici e complesse le abbiamo inserite dentro i dipartimenti. Abbiamo creato questa sovrastruttura che doveva avere l’obiettivo di concentrare molto l’attenzione sul cittadino, favorendogli la continuità assistenziale intra‐ ospedaliera, così da mettere a disposizione le competenze diversificate per il progetto di salute della persona. In realtà, si è rivelata una sovrastruttura che non ha inciso minimamente sull’organizzazione degli ospedali, tant’è che abbiamo ancora le nostre unità operative – lo dico frequentemente e lo ridico anche qui – che sembrano i castelli medievali dei reami delle nostre favole: il castello con la torre, la bandierina in cima, il fossato, gli alligatori, il ponte levatoio. Non è facilissimo entrare se il castellano non dà l’autorizzazione ed è praticamente impossibile uscire, potresti morire di fame lì dentro, perché non ti arrivano le risorse, perché chi le deve fornire le deve distribuire per tutti i castelli. Ognuno sta nel suo castello e quello che gli viene dato non è sufficiente per farlo funzionare a dovere. È un grosso problema, e se per caso qualcuno emigra in un altro castello ricomincia tutto daccapo, perché le notizie non passano, le informazioni non devono muoversi, soprattutto non vorremo mica disseminare competenze – ognuno ha le sue – e per cui il paziente di tipo chirurgico è assolutamente diverso da quello di tipo internistico. Non è quindi neppure possibile uno scambio di competenze, di capacità, anche per crescere, per integrarsi. Se fosse stato presente il dottor Bertetto avrei colto immediatamente la palla al balzo sull’empowerment organizzativo. Bene, cominciamo a lavorare. Cominciamo a dire che siamo disponibili ad andare in questa direzione. Poi vediamo come riusciamo a gestire la conflittualità che ne deriverà nel momento in cui dovremo andare a dire che, organizzandoci così, forse siamo in grado di superare le aggregazioni per disciplina clinica dei degenti, forse possiamo fare le aree. Io lavoro in un’azienda in cui stiamo tentando di realizzare questa cosa, dove non c’è più solo il nome del primario, ma c’è il nome dei primari i cui pazienti afferiscono a quell’area di degenza ospedaliera, perché il vero nome che viene messo a grandi lettere è quello del coordinatore infermieristico che si gestisce tutti i processi assistenziali e organizzativi, e quindi anche clinici che sono all’interno di quell’area. Quindi, da questo punto di vista, a me vanno benissimo queste 9 aperture e questi orientamenti, vorrei però che non fossero solo in determinate aree, ancorché importantissime, non vorrei essere fraintesa. Almeno in questa Regione le sento dire queste cose. Se facessi queste affermazioni in altre regioni mi guarderebbero con occhi stravolti, non capirebbero neppure di cosa stiamo parlando. E magari mi sentirei dire: “Sa, Presidente, noi in tutta la Regione abbiamo messo in percorso, lo faremo, un concorso per nominare come responsabile della struttura complessa un suo collega.” Oibò! Io dico: “Scusi, ma dov’è la grande novità?” “Beh, è una struttura complessa.” Al di là della struttura complessa, che mi pare una cosa normale, non ho capito perché noi non dovremmo ambire … non lo so, proprio non lo so … E su tutto il resto? Il nulla … Credo sia quindi molto importante confrontarsi su queste questioni, ma ritengo anche che dobbiamo fare un ragionamento più ampio, perché altrimenti continueremo ad autoconfinarci in certi spazi. Ieri l’altro è arrivato nel mio ufficio una e‐mail da parte del nostro servizio giuridico: “vi inviamo il bando di concorso per la posizione di direttore di una APS”, azienda per i servizi alla persona: nella Regione Emilia‐Romagna si va in quella direzione. Apro l’e‐mail per controllare i requisiti di accesso: laurea in medicina no, per fortuna, psicologia, pedagogia, sociologia, scienze infermieristiche no. Come mai? Forse non sanno neppure che esistono? Può darsi. Possiamo pensare che gli infermieri abbiano un titolo di formazione tale che permetta loro di andare in una certa direzione? Ho chiamato subito il Collegio e vedremo di capirci qualcosa. Altrimenti, ad esempio, l’impegno che mettiamo nei nostri percorsi formativi post based dove lo riempiamo? Sempre al nostro interno? Questa riflessione non era prevista, ma la voglio condividere con voi: è vero che noi stiamo prendendo velocità, che siamo impostati in una strada a quattro corsie. Verissimo. È vero che se cominciamo a ragionare come ipotizzavo adesso, anche per quanto riguarda l’organizzazione degli ospedali, siamo in grado di fare delle proposte di profonda revisione dei DRG, che in effetti non hanno più senso di essere per come si stanno impostando le cose. Volevo anche aggiungere – e poi ritorno sulla mia tematica, che è comunque correlata a quanto vi sto dicendo – che dobbiamo cominciare a nutrire la consapevolezza che quando ci viene detto – “avete le strade aperte, vi coinvolgeremo nei servizi sul territorio, vi daremo la possibilità di gestire dei reparti per conto vostro” – pur sottolineandone l’indubbia positività, non è una gentile concessione: è l’andamento demografico ed epidemiologico del nostro Paese che costringe, induce ad andare in quella direzione. Che senso ha continuare a tenere come figura preminente e centrale il medico quando la parte prevalente dei bisogni delle persone anziane con patologie cronico ‐ degenerative, con fragilità, con demenza non ha nulla di clinico, ma esprime un bisogno prevalentemente assistenziale? Dobbiamo quindi avere la consapevolezza che bisogna tenere conto di queste variazioni rilevanti, ma soprattutto dobbiamo anche tenere conto che abbiamo in buona parte compreso che non si può continuare a medicalizzare tutto, ma che bisogna cominciare a ragionare in maniera diversa e che bisogna quindi concretizzare anche quel mondo valoriale che ci viene spesso riconosciuto come un elemento a cui noi ci riferiamo sistematicamente, ma che non può essere solo un riferimento valoriale degli infermieri. Deve essere un riferimento valoriale dell’intera organizzazione, altrimenti diventa molto difficile dare sostanza e contenuto etico alle cose che facciamo dentro la nostra collettività, tenuto conto del fatto che noi svolgiamo una funzione molto importante: non solo quella di riportare al migliore equilibrio di salute possibile la persona di cui ci 10 occupiamo e a cui facciamo assistenza, ma anche accompagnare, sostenere, supportare questa persona quando la clinica può poco, mentre invece l’assistenza può ancora, e molto, in termini di ascolto, di accompagnamento e di attenzione alle mire. Tengo a ribadire che quanto ci è stato detto è molto importante, ma vi invito anche a riflettere su queste altre componenti che ritroverete nel Codice deontologico che abbiamo approvato all’inizio di quest’anno, e che si basa proprio su questi valori e su queste riflessioni e dà degli input molto importanti, io credo, ai professionisti infermieri. Ma dà degli input anche ai cittadini – che vorranno accostarsi alla lettura del nostro Codice – relativamente a ciò che possono aspettarsi dai professionisti infermieri presenti nella clinica, nella quotidianità operativa, ventiquattro ore al giorno per trecentosessantacinque giorni all’anno. Questo Codice dà anche degli input importanti per chi deve formare i futuri professionisti, chi deve “manutenerne" le competenze, che non sono solo di tipo tecnico‐scientifico, ma sono anche di tipo valoriale, e dà anche degli input a chi li deve poi gestire, organizzare, dirigere al fine di fare in modo che il contesto organizzativo in cui sono inseriti li faciliti e li sostenga nella loro attività assistenziale, nei processi che mettono in atto. Le due parole chiave che danno il “là” al titolo della relazione – “accontability” e “advocacy” – si sposano con quello che sto cercando, spero in maniera corretta, di trasmettervi. Perché responsabilità, lo ribadisco, non è solo la responsabilità che mi lega al mio assistito nel momento in cui concretizzo l’assistenza a lui diretta, ma è la responsabilità che mi lega anche a come mi impegno nell’ambiente assistenziale affinché vi sia tutto quello che serve al cittadino; inoltre, responsabilità per come io infermiere mi impegno perché anche gli altri componenti dell’equipe pongano al centro del loro operare quello che è il progetto di vita del cittadino. È una responsabilità, come dicevo prima, anche nelle scelte di politica sanitaria nazionale, non solo quelle che riguardano il Servizio Sanitario Nazionale, ma anche quelle che riguardano altri ambiti i quali tuttavia impattano sul Servizio Sanitario Nazionale ancorché regionalizzato. Porto un esempio: la professione non poteva non impegnarsi sulla riforma dell’università. I nostri futuri professionisti si formano lì. Le competenze si ridisegnano grazie ai modelli cognitivi che acquisiscono durante il percorso formativo. L’esperienza poi li arricchisce e ridelinea le competenze. L’università è la nostra agenzia professionalizzante di riferimento. Come potevamo non cogliere con grande preoccupazione quello che si stava profilando e che, anche se non del tutto scongiurato, pare giunto a positiva conclusione? Si voleva accorpare ad altri il nostro settore scientifico‐disciplinare. C’era stato un momento in cui pareva addirittura che venisse soppresso. I nostri professori in infermieristica avevano provato a condurre a buona ragione chi stava facendo queste riflessioni nel momento in cui si è visto che non si riusciva a far comprendere l’importanza di mantenere la specificità disciplinare infermieristica nella formazione degli infermieri. Lo ritengo un nonsenso. Si metteva in dubbio questo concetto. Perché? Perché, evidentemente, si partiva dal presupposto che, fondamentalmente, noi non abbiamo una disciplina perché il nostro punto di riferimento è la clinica, è la medicina. Di conseguenza, ci siamo coagulati attorno a questo fondamentale obiettivo: “noi vogliamo avere la nostra disciplina nei percorsi di formazione degli infermieri perché altrimenti non faremo assistenza infermieristica, non avremo infermieri che fanno assistenza infermieristica, ma avremo medici bonsai che fanno un misto tra la clinica e l’assistenza.” Il che non avrebbe portato a dei buoni risultati per i nostri assistiti e per i nostri cittadini. Ci siamo impegnati, abbiamo manifestato un forte dissenso, devo essere sincera, abbiamo anche un po’ minacciato – perché quando ci vuole ci vuole – e infatti pare che tutto si sia risolto. Aspettiamo, perché nella vita non si può mai dire, ma pare che la cosa sia rientrata. Questo esempio per dirvi che dobbiamo stare attenti, attenzionare, riflettere, guardare, leggere, confrontarci su quello che accade attorno a noi. Non dobbiamo rimanere chiusi nell’enclave ospedaliera o territoriale o di qualsiasi altra struttura in cui siamo inseriti. Dobbiamo guardare il mondo che ci circonda proprio per poter essere propositivi, attenti e riorientare le scelte politiche 11 che vanno poi ad impattare direttamente sulla nostra attività professionale e assistenziale. Dobbiamo stare attenti a quello che si decide nella finanziaria, dobbiamo stare attenti al patto Stato‐Regione quando riguarda la Sanità. Sono state erogate ulteriori risorse, ma non bastano, siamo sottodimensionati da questo punto di vista. E questo, secondo voi, non significa niente per l’assistenza infermieristica? Significa molto. Significa che, ad esempio, non riusciremo a garantire il turnover che serve nelle nostre realtà ospedaliere e territoriali. Di conseguenza, se avremo risorse contenute probabilmente dovremo fare delle riflessioni ulteriori per non diminuire lo standard assistenziale che ci siamo definiti e che abbiamo dato. Non possiamo pensare di non insistere con forza, perché quando si parla di qualità nelle aziende si parli delle lesioni da decubito, delle cadute, delle ferite, delle infezioni da cateterismo vescicale, perché anche questa è qualità all’assistito. Questo è dargli quello che serve, è evitare che vi siano danni iatrogeni perché noi o non lavoriamo su evidenza o con correttezza oppure siamo in numero troppo contenuto per riuscire ad attenzionare tutto ciò che l’assistito richiede. Se non facciamo questo è inutile che ci riempiamo la bocca sulla centralità della persona e sui valori a cui noi ci riferiamo nel fare assistenza. Questa è quotidianità operativa. Devono essere erogate le risorse, dobbiamo fare riflessioni su cos’è prioritario, dobbiamo cominciare ad analizzare quali sono le risposte che devono essere assolutamente date e le modalità attraverso cui darle. Dobbiamo spostarci sul territorio? Stupendo, bellissimo, poi però dobbiamo avere la possibilità, nel territorio, di poterle fare queste cose, di poter fare continuità dell’assistenza, perché il rischio è che ne derivi un danno e quindi un ulteriore aumento del carico di lavoro. Se sul territorio i nostri assistiti non trovano la risposta, cosa fanno? Vanno in Pronto Soccorso, che ha un iperafflusso costante. Poi c’è l’iperafflusso nelle Medicine, la carenza di risorse nelle Medicine e quindi siamo costretti a mettere in atto situazioni organizzative d’emergenza. E così gli infermieri si arrabbiano perché non riescono a lavorare come vorrebbero, e vorrebbero sparare al proprio dirigente infermieristico che non riesce a far passare il concetto che se non vengono date risorse la situazione diventa difficile. E avanti di questo passo. Vediamo di rompere questa difficoltà interna della comunicazione, cominciando a riflettere che non dobbiamo attendere che qualcuno decida per noi. Dobbiamo, lo dice il nostro Codice deontologico, ai diversi livelli di responsabilità, compensare le carenze organizzative quando sono frutto di eventi non prevedibili, non precedentemente pianificati. Ma quando le carenze continuano e si reiterano, forse dobbiamo cominciare a dire che in questo modo non riusciamo ad assolvere al nostro mandato assistenziale, che è quello di fare assistenza e soprattutto di farla in un certo modo. Quindi, responsabilità, non solo – ribadisco ancora – nella vostra quotidianità di professionisti. Voi siete il cuore della professione, il suo cuore sono i professionisti che fanno assistenza diretta alle persone. Il resto sono sovrastrutture necessarie, ma sono necessarie per far lavorare il professionista al meglio: la formazione, la gestione, l’organizzazione e quant’altro. Allora, responsabilità di tutti sui progetti, sulla progettualità e sui percorsi, perché in questo modo diamo concretezza al nostro Codice deontologico. Devo però fare una sottolineatura. La responsabilità: è un concetto su cui, secondo me, abbiamo molto riflettuto. Ebbene, dobbiamo rifletterci ancora e a più ampio raggio. Spesso mi capita di ascoltare i colleghi che associano al termine responsabilità autonomia, magari leggendo l’autonomia come la liberazione dalla costrizione mansionariale che abbiamo vissuto per tantissimo tempo. Ma la responsabilità legata all’autonomia significa la responsabilità di definire cosa fare, quando e come farlo – tenuto conto di altri elementi di analisi che ci provengono da altre famiglie professionali – rispetto a quello che serve all’assistito. Quindi, autonomia significa assumersi la responsabilità della decisione e non autonomia intesa come “faccio come mi pare meglio; però quando ho un problema chiamo il medico”. Autonomia significa chiamare il medico quando serve e assumersi la responsabilità della valutazione dell’analisi di quello che dobbiamo fare rispetto a degli obiettivi che devono essere 12 raggiunti e a degli esiti che devono essere verificati. Responsabilità quindi anche con questo tipo di lettura, collegata all’altro concetto che mi è stato detto di sviluppare, cioè quello della “advocacy”. Andiamo a vedere cosa si intende con questo termine. Normalmente si dice “accontability, advocacy”, “responsabilità, tutela”. “Advocacy”: “punto di riferimento”. L’infermiere che si imposta su questo concetto sta dicendo che vuole essere, che è un punto di riferimento. Direi che è un concetto che abbiamo più volte esplicitato. Ma il vocabolario dice anche: “un punto di appoggio”. Anche questo può essere corretto, quando diciamo che accompagniamo, che ascoltiamo, che dialoghiamo, che cerchiamo di far comprendere e cerchiamo di comprendere, che proviamo a trasmettere informazioni, a coinvolgere il nostro assistito nel progetto terapeutico, a farlo diventare agente terapeutico. Magari la cosa non è ancora così diffusa, però sì, è vero. L’altra definizione che mi ha colpito – consultando il vocabolario – è stata: “punto di appoggio morale”. Mi sono detta: quest’ultima definizione è molto più impegnativa, molto più difficile. Punto di appoggio morale. Il nostro assistito forse ha bisogno di un appoggio morale molto più competente e strutturato di quello che può essere il nostro, ma nell’infermiere può trovare comunque l’interlocutore per questo tipo di appoggio. Inoltre, l’infermiere può riconoscere di non essere in grado di dare tutto l’appoggio morale necessario e quindi coinvolge, chiama altri professionisti oppure – dato che sono qui davanti a noi – chiama i ministri di culto, se questo tipo di appoggio morale richiede un tale sostegno: la valenza spirituale e religiosa. Per cui mi sono detta: per noi forse diventa una sfida, ma diventa una sfida non soltanto nei termini che vi dicevo. Diventa una sfida anche in termini di accogliere valori e principi diversi dai nostri. Se il significato è anche quello di essere un punto di appoggio morale, e se ho a cuore il mio assistito, il suo processo di evoluzione, e se è veramente centrale quello che pensa, quello che sente, quello che l’assistito mi chiede, allora a questo punto devo avere anche la serenità e l’onestà intellettuale – per non dire morale – di dire che la mia morale, i miei valori non sono superiori a quelli di un altro. E che i valori, i principi di cui il mio assistito è portatore hanno pari dignità morale dei miei. Questo credo sia la parte più difficile del nostro essere infermieri, del nostro fare assistenza, specie quando siamo vicini ad assistiti che hanno un lungo percorso. Non a caso prima dicevo che l’andamento demografico ed epidemiologico della nostra società ci induce a pensare che saremo profondamente coinvolti in quella direzione. La persona anziana vede avvicinarsi il momento in cui deve cominciare a riflettere sul suo fine vita, perché è normale, è fisiologico. Tutti dobbiamo morire. E allora può aver bisogno di esprimere, di manifestare paure, timori, desideri. A questo punto apro una parentesi: volontà. Cosa vuole per sé questa persona, che concetto ha della dignità della vita, come pensa di essere aiutata, accolta, accompagnata, lenita in determinati momenti? Anche da questo punto di vista la nostra professione si assume un impegno grossissimo, se vuole essere punto di appoggio morale. Ed è proprio in questa logica che poco tempo fa è stato convocato un Consiglio Nazionale al quale sono state invitate le rappresentanze delle Associazioni infermieristiche per operare una riflessione corale su quale doveva o poteva essere la posizione che gli infermieri assumono rispetto all’attuale dibattito approdato in Parlamento sulle “volontà di fine vita”. Se vogliamo essere un punto di riferimento, un punto di appoggio – e soprattutto un punto di appoggio morale – una riflessione sull’orientamento era non solo opportuna, ma doverosa. Abbiamo analizzato, discusso, è stata definita una posizione, devo dire con un’omogeneità di valori, di pensieri e di esperienze che a me ha colpito molto, perché alla fine la 13 diversità emersa – se pur esistente – era minimale. Tutti convenivamo su come porsi, su come accogliere, su come rispettare. Tutti convenivamo che non volevamo accanimento terapeutico perché ne vediamo tanto nella nostra quotidianità operativa. Ci siamo detti che per noi infermieri più che analizzare, dibattere su cosa si debba togliere, dovremmo forse analizzare e dibattere su cosa non si debba mettere più. L’accanimento terapeutico fa soffrire, toglie dignità, non dà la possibilità di salutare, di concludere la propria vita, di dare messaggi coerenti con le aspettative dell’assistito. Abbiamo riflettuto, tutti insieme, convenendo che il nostro punto di riferimento sarà il nostro Codice deontologico. L’articolato del nostro Codice deontologico rispetto alla terminalità di vita e al fine vita dà degli orientamenti: questi sono i nostri orientamenti e noi ci radichiamo in essi. Questo è quello che io – Codice – ti suggerisco: riflettici, in relazione anche ai tuoi valori che devono però essere coerenti con quelli che esprime la professione. Ma se i tuoi valori, rispetto a quelli dell’assistito – che in coerenza con i suoi ti fa determinate richieste – sono tanto distanti da non potersi conciliare – malgrado l’aver parlato e dialogato – ebbene, noi chiediamo che venga data all’infermiere la possibilità di poter fare un passo indietro attraverso la “clausola di coscienza”, in modo da mantenere la serenità etico ‐deontologica dell’infermiere e la serenità dell’assistito. Al di là di questa riflessione, rimanendo nella logica di noi infermieri quale “punto di appoggio” – esprimeremo quindi alla collettività nazionale il nostro pensiero – abbiamo coerentemente affermato che il disegno di legge in discussione in Parlamento è distante dal nostro Codice deontologico. Noi riteniamo che non si possano imporre in questo modo alcune attività. E qui si apre un altro tipo di riflessione, di dibattito: abbiamo ben chiara la differenza tra l’aiutare a bere e a mangiare – anche sedendoci accanto alla persona e alimentandola col cucchiaino, l’abbiamo fatto tantissime volte e lo continueremo a fare – e l’inserire presidi sanitari per forzare l’alimentazione e l’idratazione. Il pronunciamento che faremo – pubblicamente – a breve verrà inviato a tutti i presidenti che si faranno premura – auspico – di renderlo noto a tutti i professionisti: esso ci pone in questa posizione. Noi diciamo: auspichiamo vi sia una modalità più mite per definire questa fase delicatissima della vita di una persona ed in questo ci riagganciamo comunque al nostro Codice deontologico. In conclusione: questo è un Codice deontologico che ci permette di fare le riflessioni che stiamo facendo. È un Codice che abbiamo voluto innovare – in maniera abbastanza importante – dopo dieci anni dal precedente. Pensiamo sia stata un’importante maturazione del nostro gruppo professionale, così come riteniamo che la nostra società, in dieci anni, abbia fatto un grosso percorso. Pensiamo quindi che si debbano dare agli infermieri dei punti di riferimento affinché possano non soltanto manifestare serenamente il loro modo di porsi dentro questi percorsi, ma possano anche, sulla base di queste riflessioni e di questi orientamenti, essere a loro volta attori protagonisti di ulteriori riflessioni che potranno portarci ad un’ulteriore rivisitazione del nostro Codice, in modo che riesca a dare agli infermieri – e di conseguenza ai cittadini – chiarezza di dove si vuole andare, sulla base di quali valori e con quale assunzione di responsabilità e di tutela. Grazie. 14 Una priorità in ambito regionale: l’applicazione sistematica e riflessiva del nuovo codice deontologico Maria Adele Schirru (Presidente Collegio IPASVI di Torino) Oggi gli infermieri si sentono frustrati e destabilizzati dai cambiamenti che intercorrono, in modo sempre più frenetico e percepiscono una vivace preoccupazione rispetto alla loro professionalità e alla loro possibilità di perseguire, nella realtà, la loro mission professionale. Tale percezione è diffusa, infatti tutti i sistemi sanitari e i professionisti si trovano oggi ad affrontare il problema di come garantire assistenza di elevata qualità a tutti i cittadini superando le disparità nelle condizioni di salute e dell’accessibilità alle cure, soprattutto da parte delle fasce di popolazione più svantaggiate e a rischio di esclusione sociale. Si tratta di problemi comuni che assumono un diverso grado di intensità a seconda dei diversi sistemi di protezione sanitaria. La scarsità delle risorse e la necessità di migliorare le performance dei sistemi sanitari pongono la questione dell’allocazione delle risorse e loro appropriato utilizzo. La sfida, dunque, è conciliare solidarietà – equità – accessibilità, valori Fondanti dei sistemi di tutela della salute, con obbiettivi di responsabilizzazione e razionalizzazione nell’impiego delle risorse. E’ di questa sfida che voglio parlare, di una sfida che richiede la capacità di mettere in gioco specifiche competenze radicate sul rispetto dei principi di giustizia sociale, solidarietà e impegno professionale. Giocare attivamente questa sfida significa quindi, per tutti gli operatori sanitari e per gli infermieri in particolare, individuare strategie di intervento capaci di orientare le scelte professionali in coerenza alla specifica competenza distintiva, riaffermando i principi e i valori fondanti la specifica professionalità Adottare scelte cioè che, in funzione della dinamicità e complessità del sistema di riferimento, esprimono i valori, la volontà e la competenza per orientare le politiche e lo sviluppo del Sistema Sanitario secondo quanto enunciato nell’articolo 47 del Codice Deontologico: l’infermiere ai diversi livelli di responsabilità, contribuisce ad orientare le politiche e lo sviluppo del Sistema Sanitario, al fine di garantire il rispetto dei diritti degli assistiti, l’utilizzo equo ed appropriato delle risorse e la valorizzazione del ruolo professionale. Scelte quindi che, evidenziano quali elementi chiave dell’azione professionale: • La persona al centro dell’attenzione professionale impegno assunto da parte dell’Infermiere professionista implicato sistematicamente in una lavoro di riflessione e proposizione per il • Miglioramento continuo delle risposte assistenziali ‐ qualità risultato perseguito misurabile in ragione del rispetto, non solo delle competenze cliniche e organizzative, ma anche della capacità di mantenere coerenza e congruenza con gli impegni assunti rispetto al cittadino. Un cittadino che desidera una • Eccellenza del processo assistenziale risultato atteso, auspicabile e perseguibile attraverso anche un processo di collaborazione tra i diversi membri del mondo professionale in 15 ragione dei ruoli ricoperti, nonché delle collaborazioni interprofessionali e interistituzionali. Una collaborazione che nasce e si sviluppa a partire dalla • Responsabilità quale processo assunto sia a livello di azione individuale sia di azione del gruppo professionale nel suo complesso. La responsabilità in questa accezione, non è solo quella normativa – istituzionale, per cui l’individuo “ FA” perché ha un obbligo formale, ma piuttosto quella per cui egli “FA” perché sa, perché condivide e soprattutto perché si è assunto un “impegno”. Questa più vera responsabilità è tale perché l’impegno assunto porta ragionevolmente a pensare cosa fare, come farlo e perché farlo. Una responsabilità quindi che si correla e si esprime attraverso • L’onesta intellettuale: ntesa come l’operare sempre nel rispetto del principio di “trasparenza”, comunicando le decisioni prese, fondando i rapporti sull’autorevolezza piuttosto che sull’autorità. • La condivisione e la partecipazione: intesa come la capacità di utilizzare e attivare i mezzi per accrescere la motivazione, facilitare il raggiungimento dei risultati, amplificare la fiducia. • L’impegno all’efficacia: in ragione di quel risultato percepito come utile dalla persona assistita e, contemporanemente, congruo nell’utilizzo delle risorse umane, tecnologiche e strumentali presenti • La coerenza: intesa come la capacità di avere una visione strategica complessiva delle problematiche per l’assunzione di modalità d’ azione funzionali e coerenti con le opzioni valoriali e teoriche effettuate. Una responsabilità che assume, quale “bussola” nella selva del quotidiano, il Codice deontologico, apparato radicolare ed espressivo della propria identità professionale. Un’identità professionale espressa nell’azione quotidiana, un’azione coerente anche letta nell’impianto strategico della Clinical Governance. Perché parlare a questo punto della Clinical Governance? Perché la nostra identità si muove e si concretizza anche in ragione delle logiche organizzative all’interno delle quali opera, ora, la nostra Regione, ha assunto tale modello come “il modello” attraverso il quale coniugare le necessità di razionalizzazione ed economizzazione degli interventi con gli aspetti di presa in carico del cittadino malato. Nella realizzazione di questo modello noi giochiamo un ruolo essenziale, di cui dobbiamo essere consapevoli e, attraverso l’espressione e l’azione dello stesso, siamo portatori e testimoni dei nostri valori e del nostro valore professionale. Vorrei pertanto presentare i pilastri sui quali poggia la strategia della Clinical Governance (prestazioni, qualità, cultura, unità d’intenti, infrastrutture, gestione dei rischi) correlandoli ad alcuni aspetti dell’impegno che noi, come professionisti infermieri, abbiamo assunto con il nostro codice deontologico. PRESTAZIONI: a fronte di un numero crescente di soggetti con poli‐ patologie, cronicità, disabilità disagio sociale, terminalità, è necessario passare da una logica basata sulla sola cura alla logica del prendersi cura. In tale ottica il solo accertamento medico e le prestazioni che ne seguono non sono più sufficienti. E’ necessario, fin dal primo contatto, attuare una valutazione multidimensionale e multi professionale per comprendere quali siano le prestazioni efficaci e quali inefficaci per un dato 16 utente con determinati particolari bisogni bio psico sociali. In questa logica è evidente l’importanza attribuita, all’interno del codice deontologico sia ai processi di autonomia professionali, sia alle interazioni quali componenti essenziali per una risposta ai bisogni (Articolo 14 ‐ L’infermiere riconosce che l’interazione fra professionisti e l'integrazione interprofessionale sono modalità fondamentali per far fronte ai bisogni dell’assistito.) Una risposta ai bisogni che vede il superamento della logica prestazionale verso una logica di accompagnamento nei percorsi, il superamento del luogo di cura istituzionale verso il luogo di cura come ambiente di vita della persona Scegliamo di lavorare sviluppando, nell’autonomia, le capacità di confronto e di collaborazione non solo tra professionisti ma inserendo nel team le persone portatrici di bisogni di assistenza QUALITA’: un moderno approccio per garantire la qualità è costituito dal “ evidence based” che si fonda sullo studio della letteratura e l’utilizzo delle linee guida. Questo approccio, certamente necessario, presenta però un rischio, quello di produrre una somma di prestazioni qualitativamente eccellenti ma non necessariamente utili. Una visione ampia della qualità deve invece prevedere che, innanzitutto, si attui ciò che è necessario. Chi comprerebbe un’auto con motore efficiente e potente ma priva di ruote? Spesso in sanità si rischia questo paradosso. Si praticano cure costosissime e poi non ci si prende cura del soggetto, rendendo vani gli sforzi fatti. Tale parodosso è tanto più quotidiano quanto è presente una logica organizzativa ancora ancorata alle discipline “primariali” e/o di struttura. E’ quindi necessario lavorare affinchè la logica organizzativa si orienti a logiche funzionali, anche in questo caso, basate sui percorsi e/o sui problemi di salute. All’interno del codice deontologico è emblematica la dichiarazione d’impegno in tal senso, basti citare da una parte l’articolo 12 nel quale è espressa la volontà di correlare obbligatoriamente lo sviluppo tecnologico e scientifico ai bisogni dell’assistito, (Articolo 12 L’infermiere riconosce il valore della ricerca, della sperimentazione clinica e assistenziale per l’evoluzione delle conoscenze e per i benefici sull’assistito) e, dall’altra, l’articolo 27 che sottolinea la responsabilità nel sostegno nei processi di continuità assistenziale e, pertanto, l’assunzione di una logica organizzativa basata su processi e su problemi. Articolo 27 (L'infermiere garantisce la continuità assistenziale anche contribuendo alla realizzazione di una rete di rapporti interprofessionali e di una efficace gestione degli strumenti informativi.) Scegliamo di lavorare sulla qualità misurata attraverso il beneficio percepito dai nostri referenti per eccellenza: le persone assistite CULTURA: per operare nei termini della Clinical Governance non è sufficiente poter disporre di una buona cultura professionale, tecnica e scientifica, che dovrebbe essere scontata. E’ necessario che le organizzazioni acquisiscano una cultura della partecipazione e della valorizzazione della singola risorsa umana a tutti i livelli. Un simile contesto, per altro, può favorire una generale propensione alla valorizzazione del ruolo dell’utente stesso e delle famiglie. Valorizzazione che richiede, come espresso in più articoli del Codice, un nuovo modo di relazionarsi con la persona assistita, con la famiglia, con la popolazione, sostenendo i processi di scelta e di sviluppo dell’empowement (art. 19, 20, 21, ecc) “ E' attraverso 17 relazioni organizzate che si assicura la partecipazione ‐ le relazioni come forme di partecipazione vanno viste anche come forme di prevenzione del contenzioso legale; come mezzi per combattere, attraverso il controllo sociale, i fenomeni di opportunismo professionale; per combattere le degenerazioni del conflitto di interesse e quindi come moralizzazione delle istituzioni sanitarie" (Cavicchi 2008 ‐ da Il pensiero debole in sanità) Scegliamo di stare dalla parte delle persone e del cittadino. UNITA’ D’INTENTI: Vi sono due modalità per raggiungere l’unità d’intenti, quella basata sul comando e quella basata sulla condivisione. La prima da garanzie sul breve periodo, ma alla lunga determina demotivazione e falsa adesione. Al contrario, varie componenti professionali che possono autonomamente e con maturità condividere gli obbiettivi, fornire il proprio contributo, comunicare in modo trasparente, possono sviluppare un unità d’intenti destinata a durare nel tempo. A proposito dell’unità d’intenti, si può qui affermare che la sfida, di cui abbiamo parlato all’inizio dell’intervento, può essere affrontata anche attraverso l’acquisizione della consapevolezza sul principio che la nostra condizione umana è una condizione plurale e non individuale. Prendendo, infatti, atto del “limite” di una responsabilità presente intorno al concetto di individuo, si creano le premesse per comprendere il significato che assume il Collegio Professionale. E’ appunto attraverso tale istituzione di rappresentanza che assume significato la partecipazione alla definizione delle politiche sanitarie e professionali. Parliamo, dunque, di un sistema professionale capace di interrogarsi sulle esigenze sociali e offrire risposte collettive attraverso progetti professionali. Un sistema professionale che sostiene l’essere riconoscibili a sé e agli altri attraverso pratiche confrontabili dalla somiglianza delle competenze espresse dal singolo con quelle di una “famiglia professionale”. L’essere appartenenti ad un gruppo “che non obbligatoriamente condivide le medesime finalità, ma condivide il cuore delle strategie usate per raggiungerle, ovvero le competenze a ciò deputate (Batini, 2009) Il nuovo soggetto della responsabilità diviene pertanto un noi non un io. E’ proprio questa condizione plurale che implica un nuovo concetto: quello della costruzione della responsabilità che implica i diversi livelli attraverso i quali la professione garantisce il proprio contributo sociale. Scegliamo di sviluppare la nostra comunità come luogo di raccordo, confronto, riflessione e sviluppo. INFRASTRUTTURE: L’utilizzo mirato ma crescente delle tecnologie informatiche diviene uno strumento di gestione per garantire l’accesso trasparente ai dati, nel rispetto della privacy, ma anche il rinforzo e il supporto per l’apprendimento pratico tramite la formazione a distanza. La formazione degli operatori ma soprattutto lo sviluppo di mentalità diviene fondamentale per garantire i tempi necessari per una pianificazione efficace attraverso risorse e strumenti indicabili e indicati nell’Atto Aziendale e nella Carta dei Servizi fruibili da tutti, operatori e cittadini. La capacità di coniugare gli aspetti essenziali della privacy, del segreto professionale con l’uso delle esperienze quotidiane come oggetti di formazione, di lavoro, di studio. Scegliamo la fiducia come luogo d’incontro di esigenze diverse e di rispetto comune. 18 GESTIONE DEI RISCHI: I concetti espressi dal risk management trovano nella clinical governance un’applicazione immediata con l’individuazione e la valutazione di procedure semplici, chiare, tese a rendere l’ambiente di lavoro sicuro per tutti, anche nel rispetto della legge 81/2008, con l’attiva partecipazione degli operatori e del personale altamente preparato e intrinsecamente motivato. Il codice all’articolo 29 sottolinea la nostra responsabilità nel “concorre a promuovere le migliori condizioni di sicurezza dell'assistito e dei familiari e lo sviluppo della cultura dell’imparare dall’errore” e contemporanemente evidenzia la nostra partecipazione attiva a tutte le “ iniziative per la gestione del rischio clinico” Scegliamo l’esplicito perché solo attraverso lo stesso possiamo riflettere e migliorare. E’ su questi fili “traccianti” che noi, come Collegio di Torino, abbiamo deciso di lavorare insieme, sviluppando un’ azione: a) Vicina ad ogni collega nell’operatività sul campo, nella problematicità della quotidianità: Come ? • I Consiglieri incontreranno i colleghi nelle diverse Aziende, pubbliche e private, del territorio torinese, in momenti di formazione/riflessione per una sensibilizzazione e confronto sulle possibilità nell’applicazione dei principi alla pratica quotidiana • Sarà presente un canale privilegiato per la comunicazione e condivisione dei problemi evidenziati nell’assistenza quotidiana. Questo canale sarà disponibile per tutti i colleghi interessati. b) Di supporto e di sviluppo di una competenza riflessiva ed operativa: Come? • Saranno organizzati eventi formativi con l’obiettivo di acquisire metodi e strumenti facilitati l’analisi e lo studio dei problemi in ambito etico e deontologico. • Ogni evento formativo sarà organizzato a partire dai problemi registrati nella realtà (segnalati, proposti, ecc.) Perché tale lavoro sia effettivamente vicino a tutti noi, abbiamo bisogno di una partecipazione attiva, dinamica e critica. Perché possa essere utilizzato come opportunità di crescita, di sviluppo, di serenità, di soddisfazione è necessario chiarezza nelle relazioni professionali privilegiando a volte posizioni conflittuali ma chiare, piuttosto che posizioni accomodanti ma fuorviere di stagnazione, di divisione, di implosione. Credo che ognuno di noi possa trovare la forza del proprio impegno nell’essenzialità del proprio “sentirsi infermiere”, un sentirsi che richiama al principio dell’ “aiutare gli altri, proteggerli, contribuire a conservare il loro ben‐essere, soddisfare i loro bisogni essenziale, cioè fare lavoro di cura, [che] genera in chi lo fa un senso di realizzazione perché si agisce là dove è in gioco l’essenziale (L. Mortari, 2006). Un senso di realizzazione che si completa e si sviluppa però anche nella cura di sé, nella cura del collega, nella cura di chi mi sta intorno perché, solo attraverso questa cura, potrò effettivamente spendermi nel confronto, nello scontro, nel dialogo, nella contrapposizione, nella dedizione alla mia disciplina intesa come arte filosofica dell’assistere “arte del pensiero, arte di convivenza, arte di dire no, arte della parola… “ attraverso anche un’educazione che ci guidi ad un’autodisciplina liberale, personale, interiore, generosa, indocile” (D. Demetrio) 19 1° SESSIONE: Capo I – art. 4: “ L’infermiere presta assistenza secondo principi di equità e giustizia, tenendo conto dei valori etici, religiosi e culturali, nonché del genere e delle condizioni sociali della persona. …. Valori etici, religiosi e culturali ‐ Lettura Magistrale Sandra BOMBARDI (Responsabile della Mediazione Interculturale Interaziendale – AOU e ASL di Ferrara) Nulla di importante al mondo è stato fatto senza passione. (G.W.F. Hegel) E’ con passione ed estrema umiltà che accetto la sfida intellettuale di essere qui con voi oggi e di introdurre e moderare una così ricca tavola rotonda. Sarà interessante comprendere, come le diverse visioni del mondo, in quanto diversi gli scenari e gli orizzonti di riferimento dei singoli membri della tavola rotonda, forniscono senso e significato a fatti di interesse comuni ‐ La Persona. Sarà altrettanto interessante comprendere la declinazione che ognuno degli invitati alla tavola rotonda farà di equità e giustizia tenendo conto dei valori etici, religiosi e culturali, nonché del genere e delle condizioni sociali della persona. Una riflessione riguardo la pratica quotidiana dell’infermieristica applicata in generale al codice deontologico ed in particolare art. 4 del Capo I, “ L’infermiere presta assistenza secondo principi di equità e giustizia, tenendo conto dei valori etici, religiosi e culturali, nonché del genere e delle condizioni sociali della persona, non può omettere le seguenti tre dimensioni: COSA fa l’Infermiere – presta assistenza ‐ Azione Infermieristica; L’infermiere per la persona e con la persona “secondo principi di equità e giustizia, tenendo conto dei valori etici, religiosi e culturali, nonché del genere e delle condizioni sociali della persona”. Prodotto dell’Infermieristica ‐ L’infermieristica dalla persona alla persona attraverso la ricerca; - COME avviene l’azione; - DOVE avviene l’azione, consapevoli dell’importanza e dell’influenza del valore culturale del contesto organizzativo (casa, servizi, ospedale …); L'uomo non è altro che la serie delle sue azioni. (G.W.F. Hegel) Cosa significa pensare, agire e dar origine ad etnografie infermieristiche guidate da valori etici, religiosi e culturali? I valori sono il “desiderabile”, esplicito o implicito, distintivo di un individuo o caratteristica di un gruppo, che influenza l’azione in grado di operarne una selezione tra i modi, i mezzi e i fini 20 disponibili in una specifica realtà sociale. Come afferma C. Kluckhohn, (sociologo e antropologo statunitense 1905‐1960), i valori comportano un dover essere. In questo senso i valori possiedono una dimensione normativa, una dimensione affettiva, una dimensione cognitiva, una dimensione selettiva, influenzando nettamente la capacità di scelta e l'orientamento dell’agire sociale. I valori sono la risposta ai bisogni più profondi dell'uomo, e in quanto tali sono sempre moderni, sono sempre necessari ‐ calati nei diversi contesti sociali ‐ per pensare e promuovere uno sviluppo vero in favore dell'uomo. Valori etici (intento razionale descrittivo e normativo di fondare la morale intesa come disciplina) e morali (indicare l'assieme di valori, norme e costumi di un individuo o di un determinato gruppo umano) determinano il comportamento dell'uomo, determinano “Il Senso” dell'esistere umano. Nei valori etici della persona vi è la ricerca dei criteri che consentono ad ogni individuo di gestire adeguatamente la propria libertà nel rispetto degli altri. Creano una cornice di riferimento, dei canoni e dei confini entro cui la libertà umana si può estendere ed esprimere. Alla base di ciascuna cornice valoriale etica sta la nozione di bene, di male, di virtù e della determinata visione dell'uomo e dei rapporti umani. La stessa visione dell’uomo e dei rispettivi rapporti umani ci portano a riflettere all’interno di una cornice spesso correlata ad una particolare religione, o comunque ad una ideologia fatta di specifici valori religiosi. Le persone, oggi più che mai, hanno bisogno di una ricomposizione attorno ad un progetto, a dei valori, a delle relazioni: la religione e la sua declinazione in appartenenza associativa, offrono esattamente questo genere di sostegno valoriale. Se ai valori religiosi, intimi e privati, si riconosce il ruolo di “fornire senso” rispetto ai grandi enigmi della vita e della morte, la sua influenza nel come declinare questi valori in un contesto di vita pubblica non è sempre chiara. Il valore dell’uomo come persona, il valore della cultura e gli stessi valori culturali sono il fondamento ed espressione del modo di essere persona tra le persone. La cultura in quanto prodotto relazionale, ed espressione di capacità e pratiche, è promotrice di sviluppo e miglioramento delle condizioni del vivere. Quello a cui si dovrebbe tendere, è ad una vivace e corale cultura dei valori: - Il valore della dignità e del rispetto per l’altro - Il valore della vita umana. - Il valore della libertà, in tutte le dimensioni e le attività umane: libertà di pensiero, di credo religioso, di parola, di proselitismo, di associazione, di autodeterminazione personale, economica e politica, di formare una famiglia, di educare i figli, ecc. Una cultura dei valori garante del bene comune, che attraversi una visione complessiva che dia ordine e significato e che sappia perseguire il "bene comune". In generale il lavoro, secondo le correnti di etica del lavoro, è autentico (in senso heideggeriano) solo se offre al soggetto la motivazione per esprimere la propria personalità in ciò che fa lavorando. Una cultura dei valori, ed esperienze organizzative di “Carta dei Valori”, presuppone l’autenticità dell’operatore offrendo all’infermiere motivazione al lavoro, pensato ed agita “secondo principi di equità e giustizia, tenendo conto dei valori etici, religiosi e culturali, nonché del genere e delle condizioni sociali della persona” La dimensione artistica dell’infermieristica produce senso, connessioni e legami con il proprio mondo, con il mondo delle pratiche e con il mondo dell’altro. 21 TAVOLA ROTONDA: tra richieste sconosciute, costrizioni e opportunità del quotidiano Moderatore ‐ Sandra Bombardi Diamo inizio a questa tavola rotonda. Invito pertanto al tavolo: Rosanna Cerri, Responsabile dell’Ufficio Qualità Percepita e Marketing AOU S. Giovanni Battista di Torino. Giuliana Galli: Componente del Comitato scientifico dell’Associazione Mamre Onlus Piero Montagna: Cappellano AO CTO di Torino. Alberto M. Somekh: Rabbino Capo Comunità Ebraica di Torino Paolo Ribet: Pastore Valdese ‐ Chiesa Evangelica Valdese di Torino. Gheorghe Vasilescu: Parroco della Chiesa Ortodossa Romena di Torino. Giorgio Villella: Responsabile Comitato di Coordinamento Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti‐ settore Eventi Hamid Zariate: Medico, Imam presso vari Centri Islamici. Ringrazio tutti gli intervenuti e vorrei cominciare questa riflessione di gruppo prendendo spunto dalla seguente riflessione di Mortari “L’essenza dell’aver cura è prendersi a cuore l’essenziale dell’uomo. È una pratica … di natura essenzialmente relazionale … che dischiude all’altro le possibilità dell’esserci … ed ha per fine la realizzazione di una vita buona … (Mortari, 2006). E’ quindi indispensabile interrogarsi sulla malattia, in quanto esperienza intima e culturalmente determinata: fatto personale che ha connotazioni diverse per ognuno di noi. La condizione di malattia si costituisce attraverso una rete di significati personali, culturali e sociali e (sickness), attraverso l’interpretazione e le rappresentazioni simboliche che i gruppi, ai quali apparteniamo, danno della stessa. Vorrei pertanto iniziare il confronto partendo da due domande guida: 22 Come sostenere e coniugare le varie condizioni ed espressioni della malattia: tra evento privato – intimo e rappresentazione pubblica? Quale accompagnamento nella sofferenza nel dolore e nella veglia? Suor Giuliana Galli (Componente del Comitato scientifico dell’Associazione Mamre Onlus) La condizione di malattia è spiegata e vissuta dagli esseri umani all’interno di spazi culturali, in una rete di abitudini tradizioni linguaggi, simboli condivisi a livello famiglia e sociale. Il momento attuale è ricco di significati assai differenziati riguardo all’interpretazione e al vissuto di malattia e di malato. Il Centro Mamre1 fa da specchio a questo fenomeno sociale. Ad esso affluiscono uomini e donne che la migrazione ha spaesato e resi, i più deboli, impotenti di fronte all’evento malattia. Il malato cerca una spiegazione per la sua condizione. Il più delle volte i risultati di esami, letti e interpretati dallo specialista‐medico, non vengono compresi dal malato che si aspetta non solo di sapere che cosa c’è ma “perché” le cose sono così. La spiegazione è cercata in ambito meta‐fisico, ontologico, religioso. Oggi l’esperienza religiosa è presente nella nostra società in modo assai variegato, la risposta ai “perché” esige attenzione e ascolto prima di azzardare spiegazioni, soprattutto se di tipo religioso, che rischiano di confondere e turbare più che portare pace al sofferente. Non è così scontato che la religione sia il tessuto connettivo della solidarietà umana. Le guerre più feroci sono state combattute in nome di Dio. “Got mit uns”, “Dio è con noi”: a suo tempo era il motto degli imperatori tedeschi, ed Hitler lo volle sulla bandiera della nazione da lui costruita e impresso sulla fibbia metallica dei cinturoni della Wehrmacht. Niente di meno spirituale e fraterno di questa terribile compagine! “In God we trust”, è scritto sulle banconote americane: “la nostra fiducia è in Dio”. I disastri finanziari di cui siamo stati testimoni ci dicono cosa stia testimoniando Dio su questi disastri: proprio nulla. Eppure, nonostante gli “errori” commessi anche a nome della religione essa ha molto da dire all’uomo. I profeti nell’Antico Testamento e Gesù nei Vangeli ammonivano non sono le espressioni verbali improntate a religione che ne esprimono il senso più profondo e vero. E’ la solidarietà fattiva frutto di convinzioni interiori ci permette di accostarci alla persona sofferente con atteggiamento corretto e pieno. Confrontati con i molti modi non scientifici di spiegare e vivere la malattia, portati da persone provenienti da altrove, dobbiamo aggiungere al nostro bagaglio di idee solidali, il senso di sorpresa e anche un po’ di spaesamento per il loro vissuto “diverso”. L’occidente con le sue invenzioni e scoperte tecnologiche, non è più il centro del mondo, è una parte: il resto è tanto, e questo “tanto” è qui. Le espressioni varie e molteplici di stili di vita giunte a noi ci obbligano ad allargare il modo di pensare la malattia “secondo noi” e di accostarci ai “nuovi giunti” con rispetto per il modo di pensare e di interpretare l’evento. Nonostante la diversità di impostazione culturale delle persone che fanno riferimento all’ospedale o agli specialisti di cura, per il credente vale il fondamento universale dell’essere umano appartenente ad una stessa famiglia che fa riferimento al Creatore: “E Dio disse: Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza […] Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò” (Gn 1,26‐27); L’essere umano come immagine di Dio è molto più ampio nelle sue espressioni di quanto noi possiamo averlo pensato: è sorprendente! 1 Il Centro Mamre cura l’integrazione di bambini nelle scuole con laboratori interculturali, promuove la formazione interculturale tra genitori e insegnanti, esercita azione clinica e di prevenzione e cura del disagio e dell’esclusione sociale. Il Centro si caratterizza per la sua impostazione etnopschica e etnopsichiatrica. 23 Non ci sono questioni filosofiche costruite, non c’è un senso di impedimento culturale alla stima, al rispetto, alla cura che si deve avere nei confronti della persona in quanto creata ad immagine e somiglianza di Dio. Per chi crede, naturalmente. Ma c’è un’altra espressione biblica e come tale religiosa, diremmo. L’espressione fortissima “E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” (Gv 1,14) addita l’essere umano spoglio da convinzioni ideologiche e da costruzioni filosofiche atte a distinguere e troppe volte ad escludere. “Carne umana” evidenzia il punto fondamento di ogni persona, punto di partenza di costruzioni culturali inclusive di molti significati e stili: questi vengono “dopo”, sono differenziazioni di una radice comune: l’umanità. Nell’accezione ampia della parola umanità lo “straniero” altro non è che una qualità aggiunta. E che qualità! Diverso per lingua, abitudini, credenze, di valori e interpretazione della malattia e della cura. E’ questo il punto d’incontro tra noi accomunati dalla stessa sostanza e dall’esperienza di sofferenza, dolore ed eventualmente, morte. L’accompagnamento all’esperienza di malattia esige, oggi più che mai, apertura, conoscenza, rispetto, accoglienza dell’altro, elementi di per se laici espressi da Erich Fromm nel suo libro “L’arte di amare”. Religiosi e laici: tutti; conosciamo l’impotenza che accompagna l’abbandono delle forze, lo smarrimento di fronte ad un verdetto clinico negativo riferito a noi stessi o a persone a noi care: è esperienza che colpisce l’individuo ma non si ferma lì, coinvolge la società, famiglia propria e la grande famiglia umana. Il paziente, generalmente, si aspetta una spiegazione immediata alla sua condizione. In alcuni casi questa è facile: una caduta, un incidente stradale, l’esito di una rissa, un virus…questo, tuttavia non basta. La ragione ultima è cercata altrove, nella rappresentazione simbolica degli accadimenti non di rado, la risposta è data facendo appello a giudizi morali non pertinenti come quelli dei discepoli di Gesù. “Presentandogli un uomo cieco dalla nascita essi così lo interpellano: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco?” (Gv 9, 2). La ragione è altra risponde Gesù, ed è che le opere di Dio vengano manifestate. L’opera di Dio è che ci amiamo nella modalità ampia del termine: con accoglienza, rispetto, conoscenza e cura. Rabbino capo Somekh (Rabbino Capo Comunità Ebraica di Torino) Direi sia opportuno distinguere tre punti sui quali desidero soffermarmi: il tema della sofferenza, il tema del dolore e il tema dell’evento. Ovviamente tratterò la cosa dal punto di vista della mia tradizione religiosa e comincerò col dire che esistono, a partire dalla Bibbia ebraica, due modalità, in un certo senso contrapposte, per cercare di penetrare il mistero della sofferenza umana. La prima è l’ipotesi per cui la sofferenza sia una punizione per cattive azioni commesse e l’altra, contrapposta, vede nella sofferenza un elemento di prova della persona che la subisce. La differenza è dal giorno alla notte. La punizione riguarda persone che non si sono comportate bene, mentre l’idea di prova riguarda i giusti, perché non ha nessun senso mettere alla prova dei malvagi, evidentemente. Come conciliare, all’atto pratico, queste due diverse interpretazioni senza urtare la suscettibilità di nessuno, come è giusto, cercando invece di fare di queste tematiche uno spunto di riflessione, di elevazione per tutti? Personalmente do un consiglio: il malato deve vedere se stesso nella prima prospettiva, cioè nella sofferenza come un elemento, una spinta al miglioramento di sé, ma chi assiste l’ammalato non deve assumere nei suoi confronti questo atteggiamento nella maniera più assoluta, deve invece 24 vedere nell’ammalato, nell’assistito, un giusto messo alla prova. Questo è stato l’errore degli amici di Giobbe nella Bibbia ebraica. Non è che l’ipotesi da essi ventilata – per cui la sofferenza in assoluto potrebbe essere una punizione – sia di per sé sbagliata o da scartare. Semplicemente essi si trovarono nella posizione sbagliata per poter fare tale affermazione. Quindi, quando si assiste un ammalato, dal punto di vista della sua sofferenza, lo si deve vedere, come dicevo, al pari di un giusto messo alla prova. Sarà lui stesso a dover elaborare la propria sofferenza in funzione del miglioramento di sé. Forse qualcosa di sbagliato potrebbe anche averlo fatto e, per la nostra sensibilità religiosa, l’idea della Teshuvah, cioè del “costante pentimento”, non è mai un’idea sbagliata o troppo tardiva. Il pentimento è uno dei fondamenti della vita morale delle persone, secondo l’ebraismo. Per quanto riguarda il tema del dolore, in questo forse abbiamo una visione diversa da quella che è stata per secoli la tradizione cattolica. Si sa che le pratiche anestesiologiche sono diffuse nella comunità occidentale da circa 150 anni. Credo che la prima anestesia sia stata fatta – nel senso moderno del termine – col cloroformio nel 1846. In realtà, l’anestesia o l’analgesia sono degli istituti biblici più antichi. La prima anestesia della storia è stata praticata dal buon Dio ad Adamo quando gli ha estratto la costola per creare Eva. È scritto: “Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò” (Gn 2,21). E questo permise l’intervento. C’è un illustre commentatore – rabbino e medico – vissuto fra Bologna e Roma nella prima metà del XVI secolo, Obadia Sforno, il quale, nel suo commento al Pentateuco, giunto a questo versetto ci spiega quali sono le ragioni dell’intervento divino che fece addormentare Adamo: la prima è levargli il dolore causato dall’intervento; la seconda è levargli la paura dell’intervento, e noi sappiamo che questo duplice aspetto – fisico e psicologico – è alla base della moderna anestesiologia. Quando mia moglie ha avuto uno dei nostri figli in un ospedale di Torino – premetto che lei, per fortuna, ha sempre avuto dei parti estremamente veloci – ciò che ci fece rimanere decisamente perplessi – lo denuncio perché ritengo di farlo – è vedere tante signore con travagli molto prolungati lasciate praticamente sole – senza alcun supporto, neppure psicologico – a girare nei corridoi, tenendosi il proprio duplice dolore, fisico e psicologico. Ritengo che questo sia contrario alla dignità della persona e che il dolore vada lenito, indipendentemente dal quadro generale della malattia di ciascuno. Credo sia un punto fondamentale, almeno secondo la nostra ottica religiosa. Per quanto riguarda il terzo tema, quello dell’evento, è preferibile che determinate esperienze, fondamentali per la propria vita – come appunto lo sono la sofferenza e il dolore – vengano vissute all’interno delle proprie pareti domestiche. Oggi non di rado si assiste ad un abbandono – talvolta anche da parte delle stesse famiglie – dei malati nelle strutture. Ciò è dovuto al fatto che la morte e la sofferenza estrema sono eventi sempre più lontani dalla nostra percezione quotidiana. Inoltre non sempre è possibile, come si vorrebbe, portare l’assistenza in luogo privato o addirittura a domicilio. Ci sono situazioni anche degenerative che richiedono evidentemente la struttura pubblica, la quale deve essere pronta a considerare ogni situazione, come si dice oggi, in modo olistico, tenendo presente la persona dell’assistito in ogni suo aspetto, complessivamente. Si è anche richiamata l’attenzione sul concetto della privacy, ossia del non fare del dolore di ciascuno un atto pubblico, perché questo può essere lesivo della dignità della persona. E ancora: si è richiamato l’importante concetto biblico secondo il quale ogni individuo è creato ad immagine e somiglianza della divinità. Questo è un punto che deve regolare le relazioni umane in genere. Siccome è stato citato uno dei testi fondamentali del filosofo Erich Fromm, “L’arte di amare”, vorrei citare un’altra sua opera dal titolo non meno importante: “Avere o essere”. Dobbiamo considerare il prossimo non per quello che ha, ma per quello che è. Grazie. 25 Imam, Hamid Zariate (Medico, Imam presso vari Centri Islamici) Buongiorno a tutti, sono un neolaureato in medicina ed imam in alcune moschee. Ho 26 anni e sono qui in Italia dal 1987. Una delle cose che ho maggiormente apprezzato in Italia è la grandissima disponibilità che ho sperimentato in ambito ospedaliero, sia come medico sia, soprattutto, come operatore sanitario. Negli anni in cui ho frequentato l’università ho fatto anche l’operatore sanitario per mantenermi negli studi. Quindi, so cosa vuol dire fare l’operatore sanitario: è faticoso. Di conseguenza, apprezzo il vostro lavoro. Indipendentemente da ciò, l’Islam ha naturalmente una sua visione della sofferenza, del dolore, dell’evento. Per l’Islam è una visione talmente ampia che, personalmente, non riuscirei a spiegarla in pochi minuti. Per quanto riguarda la sofferenza, l’Islam la concepisce all’incirca come la concepiscono le religioni monoteiste venute prima dell’Islam, cioè il cristianesimo e l’ebraismo. Mi piace riportare un detto del profeta che dice: “Immaginatevi la profezia come un’unica grande casa cui però, per essere completa, manca un mattone: io non sono altro che quel mattone”. In qualità di musulmano riconosco, come religioni divine – precedenti l’Islam – sia il cristianesimo che l’ebraismo. Non solo, ma addirittura riconosciamo come origine divina il messaggio di Budda stesso. Riprendo le parole dette dal rabbino riguardanti la sofferenza: è una punizione, un evento di prova o – altra cosa che aggiunge l’Islam – un modo tramite cui Iddio fa ritornare a sé, o meglio, fa ritornare sulla retta via la persona stessa. Nell’Islam queste due ultime voci sono le più significative: un evento di prova per il cosiddetto buono, ed un ritorno per colui che ha peccato. Uno che pecca – la fornicazione, ad esempio – può ammalarsi di una malattia venerea o di Aids. Ecco, in quel momento si rende conto di aver commesso un peccato, per mezzo del quale è stato punito. Tuttavia, quella stessa punizione è un modo tramite cui Iddio lo fa ritornare a sé per mezzo del pentimento. Per quanto riguarda il dolore, esso è un modo tramite il quale, nella visione islamica, Iddio perdona i peccati. Il profeta, infatti, diceva: “Qualsiasi tipo di dolore, sia esso fisico o psicologico, fosse anche dovuto al dolore provocato da una spina di rosa, tramite quello Iddio perdona il peccato.». Il dolore è dunque una purificazione, nella visione islamica, da qualsiasi tipo di peccato. L’evento. L’evento è qualcosa di talmente soggettivo – nel senso che il musulmano tende a viverlo come un momento della sua vita, un momento inevitabile – che, onestamente, non è facile da esprimere. Termino con due regole importanti che ben pochi conoscono, musulmani inclusi: nell’Islam qualsiasi necessità, sia essa un’urgenza, un’emergenza, fa cadere l’obbligo. Porto un esempio: qualcuno mi ha fatto notare che durante il Ramadan una persona non può né mangiare né bere dall’alba al tramonto; malgrado ciò, deve assumere una terapia. Beh, in questo caso, chi detta la legge non è più l’imam, ma il medico, nel senso che se quella tal terapia può essere suddivisa in più tempi o in dosi diverse lungo la giornata, deve deciderlo il medico. Il medico, in quel momento, diventa l’imam stesso, quindi è colui che detta la legge. Altro esempio: sono nel deserto, senza liquidi, col rischio di morire disidratato. In quel frangente l’unico liquido disponibile è a base alcolica, e nell’Islam gli alcolici sono proibiti. Per non morire disidratato, posso bere oppure no? In quel momento non solo posso bere – perché, come abbiamo detto, la necessità fa cadere il divieto –bensì ho l’obbligo di bere, perché nell’Islam vi è un’ulteriore regola molto importante, che è quella del non abbandonare noi stessi al male, al dolore. Quindi, se il non bere mi fa morire 26 disidratato, non devo abbandonare me stesso al dolore, al male, e quindi non solo l’obbligo decade, ma diventa un dovere da parte mia il bere per non morire. Queste sono alcune regole che aprono delle porte enormi circa un’idea piuttosto diffusa secondo la quale l’Islam sia una religione molto chiusa, limitata. Non è assolutamente così. Grazie. Cappellano Piero Montagna (Cappellano AO CTO di Torino) Che differenza c’è tra sofferenza e dolore? Gesù, nel Vangelo, ci rivolge un invito: “Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò” (Mt 11,28). Quando una persona soffre si trova ingarbugliata, con grandi interrogativi umani, psicologici e morali. La sofferenza è presente per qualsiasi ragione, come dicevano i relatori precedenti: può derivare dai sensi di colpa, dal sentirsi giustificati da Dio o abbandonati da Dio. La sofferenza la provo nella pelle. E quando la provo nella pelle devo dimostrare di combatterla in tanti modi. Chi mi ascolta, chi mi segue nella sofferenza? È un campo, quello infermieristico, molto impegnativo: lo vedo nel mondo ospedaliero dove opero, il CTO, e dove sono stato in passato. Ci vuole molta attenzione e molto amore nello stare accanto a chi soffre. La sofferenza non ha né risposte immediate né soluzioni immediate. Vi porto un paragone: al CTO è ricoverato un fratello in gravi condizioni. Questa mattina i medici mi hanno detto: “stiamo andando male”. Cosa provo dentro di me, quando mi dicono questo? Reagisci, ti fai coraggio, vai avanti, chiedi, ti informi, ma in ogni caso stai vicino a colui che soffre. Anche mio fratello ha bisogno di essere aiutato, come tutti i fratelli che voi seguite. Il dolore. Il dolore si esprime anche accompagnato dalla sofferenza tramite espressioni fisiche: ho male perché ho i calcoli ai reni, ho male perché mi sono ferito, ho male perché mi hanno picchiato. Il dolore è sollevato dalla vostra cura, dalle vostre mani tese, dal vostro amore. Lo percepisco al CTO, vedo con i miei occhi il personale all’altezza di questo compito. Sono contento di dirlo. Di fronte a queste situazioni di dolore, c’è qualcuno che mi dice, come ha detto Gesù al centurione: “Io verrò e lo curerò” (Mt 8,7). Sono presente e ti aiuto nel modo migliore. L’evento, tra privato o intimo. Sono situazioni sociali, perché il dolore e la sofferenza non appartengono unicamente al singolo, ma a tutta la società. E allora può essere un evento che colpisce. Un’alluvione, una malattia come l’influenza, ecc. diventano una collaborazione di azione sociale che mi porta a dire: lavoriamo assieme. Però, nel mio intimo non sono solo, come si diceva questa mattina, siamo in comunione, in condivisione, e allora ci facciamo dono. Grazie. 27 Pastore Paolo Ribet (Pastore Valdese ‐ Chiesa Evangelica Valdese di Torino) I temi che sono stati affrontati negli interventi precedenti sono belli, complessi, anche se difficili da affrontare in una Tavola rotonda in cui si deve definire, in pochi minuti, che cos’è il dolore. Mi limiterò quindi a fare alcune considerazioni. Ho ascoltato la seconda parte della relazione della dottoressa Silvestro e mi sono trovato in perfetta sintonia con tutto ciò che ha detto. In modo particolare quando ha paralato dell’infermiere come punto di appoggio morale. Credo che sia una bellissima definizione, in quanto si parla di tecnica nel lavoro dell’infermiere e dell’infermiera, ma considera anche l’aspetto, fondamentale, della cura. La cura non è soltanto cercare le medicine giuste, compiere i gesti giusti; ma orienta l’approccio nei confronti della persona ammalata. Quindi, pensare all’infermiere come punto di appoggio morale significa, a mio modo di vedere, cogliere uno degli aspetti fondamentali della malattia. La malattia è una dislocazione della persona, sotto molti punti di vista: dalla condizione di persona sana a quella di persona ammalata, per cui non tutti riescono ad accettare questa realtà e neanche riescono a capirla. Dall’altra parte, c’è anche una dislocazione fisica, nel senso che la persona ammalata, quando è grave, va in ospedale e quindi si trova in un ambiente che non è il suo, in un ambiente nel quale spesso, soprattutto se anziana, si sente disorientata: i ritmi cambiano, cambia la vita, cambiano i vicini, ti trovi a doverti confrontare non solo con il tuo dolore, ma anche con il dolore di chi ti sta accanto. E allora, forse, il dolore di chi ti sta accanto riesce a farti ancor più paura del tuo. Avere, in questa situazione in cui sei al di fuori della tua normalità, una persona che in qualche modo diventa anche il tuo punto di riferimento, il tuo punto d’appoggio, è importantissimo. Vorrei dire una cosa che probabilmente farà irritare qualcuno: credo che un elemento di cura fondamentale sia il tempo. Il tempo è forse la medicina più importante. So benissimo che il tempo è molto parcellizzato in un ospedale: devi fare tot cose in tot ore e devi riuscire a farle tutte, per cui i tempi sono compressi. Però … però il gesto nei confronti della persona ammalata richiede tempo, richiede, io direi, un ritmo umano. È chiaro, non è colpa dell’infermiere se deve correre, ma anche i ritmi dell’approccio devono – dovrebbero – essere misurati proprio sulla consapevolezza d’essere punto d’appoggio morale per la persona malata. Mi rendo conto che apro delle porte e poi non le chiudo, ma devo procedere … Il tema del dolore. È un tema terrificante. È stato ricordato già negli interventi di chi mi ha preceduto. E’ un tema che è presente nel libro biblico di Giobbe ed in modo, io credo, alquanto polemico perché si contrappone ad una lettura tradizionale del male come conseguenza meccanica del peccato del singolo. La storia è nota, ma cerco di sintetizzarla. Tre amici di Giobbe vanno da lui, che è stato colpito da molti mali, e gli dicono: “Dato che Dio benedice la persona buona, se tu sei stato colpito ne discende che hai fatto qualcosa che ha turbato Dio. Riconosci il tuo peccato e sarai salvato.” E la protesta di Giobbe sta nel dire: “No, io non ho fatto niente! Il male mi colpisce, ma io non ho peccato” . Alla fine Giobbe, nel suo sfogo, arriva addirittura a dire a Dio: “Se hai il coraggio vieni giù e dimmi in faccia che cosa ti ho fatto.” La cosa più bella del libro biblico è che Dio scende e glielo dice. O meglio, non gli dice che cosa ha fatto – perché non aveva fatto nulla di male, non aveva peccato (per usare un linguaggio 28 teologico) – ma gli pone dinanzi la totalità della creazione compiuta per amore di Dio. Nella creazione c’è un posto anche per il male. Il male, secondo la mentalità ebraica antica, è qui simboleggiato dal mare che cerca sempre di aggredire la terra. Però Dio dice: “Gli ho dato un limite che lui non oltrepasserà.” Lui ci prova, col moto eterno delle onde che assalgono la terra, ma non riuscirà a superare quel dato limite. Quindi, se voglio parlare del dolore, almeno dal punto di vista protestante, non lo vedrei né come prova né come mistica. Non lo vedrei neanche come elemento di salvezza, un elemento che ti porta verso la salvezza. Ricordo al riguardo una recente enciclica papale che si intitolava “Salvifici Doloris” – “la sofferenza salvifica”. Il dolore è – secondo il mio punto di vista – un elemento di contraddizione della nostra fede. È in contraddizione con la realtà buona della creazione di Dio. Lenire il dolore, dunque, è sempre un atto positivo perché permette alla persona malata di riacquistare quella parte di umanità che il dolore rischia di strapparle. Per questo intervenire con le cure palliative, con la cura appunto, è importante ed è una cosa terribilmente delicata, difficile e pesante da fare. Prima di venire a Torino ero pastore a Pinerolo. Posso testimoniare che l’équipe delle cure palliative a Pinerolo fa un lavoro splendido. Purtroppo si muore sempre più di cancro e tutte le persone che ultimamente sono state colpite da questa terribile malattia, che ho seguito nella malattia e di cui ho dovuto celebrare il funerale, mi hanno testimoniato quanto fosse importante la presenza dell’équipe delle cure palliative. Soprattutto, mi hanno testimoniato quanto grande fosse la loro disponibilità. Questo è importante, per la persona che viene colpita dal male. E allora, ecco che l’azione non si può rivolgere soltanto alla persona malata – moltiplicando la diagnostica, moltiplicando gli interventi di questo tipo – ma alla cura della persona e del suo contesto, in modo particolare della famiglia. Concludo dicendo che ritengo sia necessaria, nel momento della cura, la vicinanza, la presenza della comunità ecclesiale a cui la persona appartiene. Ho l’impressione che talvolta i pastori – quando vorrebbero andare a parlare fuori orario alla persona malata – siano accolti non sempre bene. Perché? Perché si stanno facendo le pulizie, la terapia, perché stanno distribuendo i pasti, ecc. Ma, d’altra parte, se il pastore va a trovare la persona nell’orario di ricevimento parenti, ci sono diverse persone in camera, e allora spiegatemi voi come si può fare “cura pastorale” alla persona con la stanza piena di gente. Ecco, credo sia importante anche questo aspetto, questa dimensione dell’accettare che ci siano persone che arrivano da fuori e che in qualche modo accompagnano a casa la persona malata. Grazie. Parroco Gheorghe Vasilescu (Parroco della Chiesa Ortodossa Romena di Torino) Sono lieto che il mio intervento sia tra gli ultimi della Tavola rotonda, poiché ho trovato ispirazione dagli interventi precedenti. Imposterò il discorso sulla sofferenza – e su chi presta attenzione ed amore alla persona nella sofferenza – dal punto di vista della Chiesa orientale, ortodossa, che pur avendo a Torino una grande comunità non ha strutture come quelle dei fratelli cattolici e valdesi. Ma anche i romeni hanno un’esperienza concreta legata soprattutto al personale assunto in queste strutture. Essi vengono a contatto con la sofferenza. La nostra comunità è sita in Via Cottolengo, pur nella differenza, ciò che ci accomuna 29 moltissimo nella vita è la sofferenza. Con la sofferenza dobbiamo confrontarci, prima o poi. Qualcuno dice che la sofferenza accompagna l’essere umano dalla nascita. Non sappiamo per quale motivo piangiamo, quando veniamo alla luce: qualcuno dice perché ci siamo abituati troppo bene, al calduccio nel pancione della mamma. La sofferenza aumenta anche nella fase finale dell’esistenza terrena, proprio perché non sappiamo cosa seguirà, sebbene la fede nei nostri testi sacri ed in ciò che ci insegna la Verità, il Libro della vita. Vorrei esprimere il punto di vista del mondo orientale sulla sofferenza non tanto misticamente, come vi aspettereste, ma facendomi aiutare e supportare da un testo che conoscete tutti, almeno quelli che hanno un minimo di confidenza con la Sacra Scrittura. Sto parlando del “buon samaritano”. Qui si può contemplare l’uomo di fronte all’uomo nella sofferenza. In questa parabola vediamo chiaramente l’uomo contro l’uomo. “Homo homini lupus”, dicevano i latini: “l’uomo è un lupo per l’uomo”. “Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gèrico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall’altra parte. Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre.». (Lc 10,30‐32) Qui vediamo, come ho detto, l’uomo accanto all’uomo, l’uomo accanto alla sofferenza. Talvolta l’infermiere si trincera in un’autocorazza fatta di autoconservazione. E forse dice: “meno male che non è capitato a me”; e quando il malato si comporta con un po’ di ostilità – magari provando invidia per chi è in salute e lui invece l’ha perduta – c’è il rischio di lasciarsi andare a pensieri del genere “certo che te la meriti questa malattia”. Lo dico in base alla mia esperienza, non volendo per questo tradire il segreto della confessione. Il Natale è una festa di gioia, ma anche di sofferenza, perché sappiamo benissimo che è una sofferenza non trovare un posto dove nascere ed essere da subito perseguitato. Ma proseguiamo nel racconto evangelico: “Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e n’ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui” (Lc 10,33‐34). Arriva uno straniero, un samaritano, che diventerà celebre nella sua espressione di bontà e di umanità: l’uomo per l’uomo. Il buon samaritano tira fuori due cose elementari: l’olio e il vino. Per gli ortodossi l’olio è il simbolo del Sacramento, noi diciamo Misteri, perché alla fin fine anche la sofferenza è un mistero. Tentiamo di dare delle spiegazioni filosofiche, morali, sociali, ma rimane un mistero. Quante volte interpelliamo Dio: perché la sofferenza? Gesù sulla croce pronuncia le parole del salmista: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” (Mt 27,46) Questo senso di abbandono che percepisce la persona sofferente si ricollega a quanto vi ho accennato poc’anzi, alla mia esperienza di sacerdote: molti tra i miei confratelli assistono i malati nelle cliniche, nelle case private dove sono assunti. Essi vengono da me e mi dicono: “Padre, non ho avuto pazienza con il vecchietto o con la vecchietta” Chiedo dunque loro di essere prossimo al fratello o alla sorella. Fatti prossimo. Loro mi domandano: “Cosa vuol dire farsi prossimo?” E così gli racconto la parabola del “buon samaritano” che tira fuori un unguento per lenire la sofferenza, e poi c’è anche il vino, simbolo dell’eucarestia. “Ringraziate – dico loro – il Signore che vi ha messo in questa situazione, in questa posizione.». I nostri anziani ci dicono che il medico, l’infermiere, tutto il personale sanitario, non sono professionisti, ma dei veri e propri missionari che hanno appunto una missione, un mandato 30 speciale, particolare. Tutti sappiamo che i medici fanno un giuramento, il giuramento di Ippocrate. Ritornando a chi deve assistere chi soffre, è importante avere pazienza: la mitezza, la bontà. Ai miei confratelli consiglio di andare dal malato o dall’anziano – ogni qualvolta si sveglia o vi chiama – col sorriso sulle labbra. Consiglio di dire qualcosa di simpatico, di scherzoso. Rendere queste persone ottimiste, mostrare che questa persona la si vuole sollevare, mostrare che non si è indifferenti nei suoi confronti. “Voi siete fortunati – dico a chi assiste – perché avete un doppio stipendio: uno ve lo dà la professione che svolgete, l’altro la missione che svolgete.». Gli insegnanti, i professori, i medici, i paramedici ed anche i sacerdoti hanno questo contatto diretto con l’animo umano. Vedere nel malato, nel sofferente parte della tua umanità che soffre, e sapere che tu non sei escluso. Nessuno di noi sa come finirà la propria vita: su un letto d’ospedale oppure a casa, seguito da qualche straniero che è lì per darci una mano, un bicchiere d’acqua, per alleviare la sofferenza ultima. Gesù non ci insegna come ha guarito i malati o come ha moltiplicato i pani nel deserto. Ci insegna questo: “… imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime” (Mt 11,29). La mitezza, la bontà, l’umiltà e la pazienza sono qualità che devono caratterizzare l’atteggiamento dell’infermiere e del medico di fronte al malato. Lo dico perché l’ho sperimentato direttamente e indirettamente: so cosa significa stare accanto e rendere felice una persona che non può essere felice nello stato di sofferenza in cui si trova. La sofferenza nel mondo non è frutto del caso. Tutto ciò che può darci la scienza per limitarla è bene accetto, perché nessuno, per quanto filosofo sia, patisce serenamente il mal di denti. Ciò non toglie, come ho detto, che la sofferenza ha un suo significato, un suo valore. Infatti, i cristiani seguono un uomo che il profeta Isaia anticipò: “Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire” (Is 53,3). Se quest’uomo – Gesù – l’ha assunta su di sé, vuol dire che ha un valore. Perciò è fondamentale scoprire che senso ha la sofferenza nella mia vita: perché a me e non ad un altro? Ricordo una carissima persona dalla nostra comunità, 96 anni d’età. Quando ha avuto una malattia mi ha detto: “Proprio a me, padre Giorgio, doveva capitare questa cosa?” “Non lo so, mamma Gianna, perché a me o a lei deve capitare una cosa del genere, però in questo caso dobbiamo avere proprio quell’atteggiamento di mitezza, di saggezza e di pazienza. C’è una preghiera ortodossa che recita: “ “Signore, donami la pazienza di Giobbe, la sapienza di Salomone e la mitezza di Davide.». Grazie. Giorgio Vilella (Responsabile Comitato di Coordinamento Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti‐ settore Eventi) Sono qui in nome dell’UAAR, l’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, un’associazione venuta alla ribalta quest’anno – gennaio – per la campagna pubblicitaria sugli autobus, successivamente per la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo la quale afferma che bisogna togliere i crocifissi dalle scuole. Tra l’altro, è un’azione che ho cominciato personalmente, quando ero Segretario dell’Associazione. Portiamo avanti altre iniziative, per questo la gente comincia a conoscerci. 31 Avevo preparato una relazione scritta con un titolo ed un sottotitolo che vi leggerò, ma, da come vanno avanti le cose, non mi atterrò al testo. Avevo comunque scritto questo: “l’Italia è uno stato laico secondo la Costituzione in vigore.». Il sottotitolo: “in uno Stato laico, nelle strutture pubbliche, devono valere uguali diritti per tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro religione o dalla mancanza di religione». Mi scuso per come ho concepito questa relazione. Io vengo da Padova, dove la situazione – relativamente alla laicità delle istituzioni e del sentire comune – è diversa rispetto al Piemonte. So che il Piemonte è la Regione italiana più laica, come lo è anche il suo quotidiano più diffuso, “La Stampa”. Inoltre, questo grande ospedale piemontese ha fatto la prima convenzione in Italia con la nostra Associazione per l’assistenza agli ammalati: l’assistenza laica‐ ospedaliera. È una curiosità personale, ma vorrei davvero sapere perché il Piemonte è così laico ed il Veneto non lo è per niente: forse dipende dal fatto che ci sono stati i valdesi e ne sono stati uccisi un centinaio nei secoli, bruciati vivi di solito, e allora forse le coscienze sono un po’ più tolleranti o forse dipende dall’influenza della cultura francese che si sente ai giorni nostri? In questi giorni in Regione Veneto è passata una delibera in base alla quale i sacerdoti cattolici saranno assunti dalle ASL per garantire ai malati, negli ospedali veneti, “l’esercizio di libertà religiosa, l’adempimento delle pratiche di culto e il soddisfacimento delle esigenze spirituali dei degenti cattolici e dei loro familiari, con contratto di livello D e alloggio”. Sono pagati come i capi infermieri, credo. Contestualmente, sono stati stanziati 2 milioni di euro per assumerli nelle ASL. È una delibera da Stato etico, che non rispetta il principio costituzionale dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, che fa dei cattolici dei cittadini speciali e di chi non è cattolico un suddito. Si assumono dei sacerdoti per l’accompagnamento spirituale dei degenti cattolici. Ma – chiediamoci – quanti sono i cattolici in Italia? In Piemonte, tra i bambini nati oggi, più del 50% non hanno i genitori sposati in chiesa o sono genitori che convivono e quindi non seguono le regole della Chiesa, oppure non sono sposati in chiesa, ma in municipio e quindi non seguono nuovamente le regole della Chiesa. Allora, se nella popolazione del Piemonte il 50% dei bambini appartiene a famiglie secolarizzate – fenomeno, quello della secolarizzazione, che si è già esteso in tutto il Nord Europa e sta correndo velocissimo anche nel Nord Italia e nel Centro, non nel Sud – vorrei sapere come si permette una Regione a fare una legge speciale per i cattolici. Anni fa la Regione Abruzzo aveva ricevuto numerose richieste dai cattolici per costruire nuove chiese. È stata quindi fatta una legge che stanziava diversi milioni per la loro costruzione. Credo abbiano fatto domanda anche i valdesi, ed è stata accolta. Poi l’avevano fatta i Testimoni di Geova. Risposta: “voi non avete l’intesa”. I Testimoni di Geova hanno fatto ricorso in Tribunale, il quale ha inoltrato il tutto alla Corte Costituzionale che ha obbligato l’Abruzzo a dare i fondi per la costruzione di una Congregazione dei Testimoni di Geova. La Costituzione italiana afferma che siamo tutti uguali. In questi giorni la Regione Veneto ha approvato la legge che vi ho appena detto. A proposito di ciò, è uscito un articolo sul “Corriere della Sera”, firmato da uno psicoterapeuta. Vi leggo un breve periodo così da esprimere il disagio che provano le persone che non hanno religione, quando sono in un ospedale pubblico: “E così con i miei soldi la Regione Veneto assumerà dei dipendenti non‐dipendenti – dipenderanno dal loro vescovo – ai quali darà anche vitto e alloggio perché possano venirmi a disturbare se sono ricoverato in ospedale. Dovrò, infatti, dire di no quando si presenteranno a chiedere se voglio una benedizione o un’assistenza religiosa, e se saranno discreti se ne andranno. Sennò mi chiederanno perché non li voglio, e da ricoverato sarò in una situazione di debolezza. Dovermi anche spiegare sarà antipatico. Se poi avessero anche voce in capitolo – questi sacerdoti assunti dalle ASL – nel processo terapeutico e in scelte etiche, sarei molto allarmato. […] Nel momento in cui si è visto quanto diversificate sono le posizioni degli italiani sui temi della bioetica, dell’assistenza ai malati terminali, sulla procreazione assistita, sull’interruzione di gravidanza, la scelta dell’assessore Sandri 32 [quello che ha fatto quell’ordinanza] non è solo inopportuna, ma costituisce una grave mancanza di rispetto nei riguardi dell’insieme dei cittadini.». Dunque, quale accompagnamento nella sofferenza per gli ammalati senza religione negli ospedali? Vogliamo che l’accompagnamento sia fatto nel rispetto di quello che pensano gli atei. Se ci sarà tempo vi racconterò quello che è successo a mia sorella, mancata tre settimane fa in un ospedale di Padova e così chiarirò perché voglio rispetto dagli ospedali. Io non ho nulla contro i religiosi che curano le anime dei propri fedeli. Non ho niente contro di chi crede, contro la vecchietta che muore quasi contenta perché si ricongiungerà a breve con suo marito. Non vado certo a dirle che non sono convinto che sia così. Benissimo. Però vorrei che ci fosse più rispetto per quelli che non hanno nessuna religione. Rosanna Cerri (Responsabile dell’Ufficio Qualità Percepita e Marketing AOU S. Giovanni Battista di Torino) Buongiorno. Rappresento l’Ufficio Qualità Percepita e Partecipata delle Molinette, che in questi anni ha cercato di implementare – e ha implementato con successo –alcuni progetti che colgono questi argomenti. Sono molto contenta perché per la prima volta che ho la possibilità di spiegare come è nata l’idea di far partecipare tutte le religioni all’assistenza e di conseguenza la creazione della “stanza del silenzio”. Quest’idea è nata nel 2004, quando con un Audit Civico ci siamo resi conto che non ottemperavamo ad un requisito: “Sono presenti nella vostra azienda servizi religiosi per non cattolici?” Il non poter rispondere a ciò ci ha fatto andare un po’ in crisi, e così abbiamo cominciato a cercar di capire come fare. Ci siamo interrogati su chi è l’infermiere. Abbiamo letto il precedente Codice deontologico, rivisto la Carta dei Diritti dell’Uomo, e la Costituzione per giungere alla conclusione che: “Se siamo uno Stato laico e i presupposti sono questi, anche le persone che non sono cattoliche hanno diritto ad avere un’assistenza religiosa.” Guardandoci attorno – era il 2004 – abbiamo notato come la nostra società fosse cambiata e come di conseguenza moltissimi migranti usufruissero dei servizi dell’azienda: il 2,8% del totale dei ricoveri era costituito da persone straniere. Anche questo dato ci ha fatto riflettere, perché queste persone lontane dalla loro famiglia, dalla loro cultura, dai loro affetti, vengono qui, in un paese straniero dove può capitare di ammalarsi, per loro la religione può essere l’unica forza, l’unico punto di ancoraggio con la propria cultura di origine. Tutto questo ha fatto nascere il “Progetto religioni”. È stato un lavoro molto lungo di cui si è occupato Mario Caserta. Fortunatamente, l’attuale Direttore Generale di questa azienda ha fatto proprio il progetto, altrimenti non l’avremmo mai portato a compimento. La conclusione di questo primo progetto è stata la firma di un protocollo d’intesa con tutti i religiosi interpellati. Di seguito la domanda è stata: il dialogo religioso serve? Come Ufficio abbiamo letto numerosi articoli. Da una review è emerso come non vi sono evidenze significative dell’influenza del dialogo col paziente e la preghiera sull’esito delle cure, ma neppure evidenze non significative. E allora perché no? Perché non costituire un luogo fisico da riservare alla preghiera. Quale luogo? E perché un luogo di comunicazione accessibile a tutti? In Europa 33 esistono diversi modelli: chiamati “stanza del silenzio” e “stanza interfedi”. Abbiamo optato per la “stanza del silenzio” perché, secondo noi, la “stanza interfedi” continua a dividere queste religioni, in quanto ognuna di esse può esercitare il proprio culto, ma separatamente. Il dialogo è fatto di silenzio ed è fatto di parola, abbiamo cominciato col silenzio quindi troviato un luogo – il luogo del silenzio – dove tutte le persone – credenti, non credenti, di tutte le religioni e culture – possono recarsi per riflettere, meditare, pregare. Ciò è necessario soprattutto in un ospedale come le Molinette perché questo luogo di cura non è un luogo di gioia –non c’è l’ostetricia– ma di ansia e sofferenza, dove a volte la malattia evolve e si va verso la morte. I parenti di persone appartenenti a fedi differenti dalla cattolica, sono soli davanti al lutto, non hanno un posto dove ritrovarsi, perché nelle nostre camere mortuarie c’è solo una cappella, ed è una cappella cattolica. Con questo non vogliamo annullare il fatto che vi sia la cappella cattolica, ma bisogna prestare un po’ più di attenzione anche agli altri. Se noi vogliamo accogliere gli altri, dobbiamo prestare loro attenzione. Da tutto questo è nata la “stanza del silenzio”, che per noi è solo un punto di inizio, perché vorremmo andare oltre: vorremmo arrivare ad una “stanza della parola”. Cioè, un luogo della parola dove le persone di diverse culture possano parlare di temi riguardanti l’etica, la salute,la malattia, la sofferenza. Questi temi accomunano tutte le culture, sono temi cari all’Uomo, sono temi che possono facilitare l’integrazione attraverso il dialogo interreligioso ed interculturale. E questo è il nostro desiderio futuro. Sandra Bombardi Vorrei chiedere ai componenti della Tavola rotonda – riguardo ad alcuni temi che sono stati affrontati – se vogliono intervenire e aggiungere altre riflessioni. DIBATTITO Cappellano Piero Montagna (Cappellano AO CTO di Torino) Proprio in merito al relatore che ha preceduto Rosanna Cerri, Giorgio Vilella, ritengo sia giusto e doveroso pensare alle diversità delle religioni e alle diversità delle culture ed anche ai ruoli che ci sono nella società e all’interno degli ospedali. Con il Concordato la religione cattolica prevale sul servizio ospedaliero e su altre realtà, ma non voglio entrare in merito a questo argomento. Comprendo le iniziative e i desideri che possono nascere per incontrare le altre fedi e le altre religioni. Però, per quanto riguarda il servizio in ospedale, per quanto riguarda me personalmente, 34 la diversità di fede che vedo in chi è ammalato – ma anche nell’infermiere, nel personale – è rispettata e su questo ci si incontra molto. Penso che questo non sia un aspetto d’urto, ma sia un aspetto da verificare, da confrontare con amore. Una sera, davanti al Pronto Soccorso, vedo una signora, sola. Vado spesso al Pronto Soccorso. Le domando: “Ha qualche problema?” Ovviamente un problema c’era. “Ho mio marito – mi dice – di là in rianimazione, ma io sono atea.». Ed io le rispondo: “Ma io le voglio bene così.” Poi ci pensa e dice: “Può dirmi qualcosa di mio marito, può andarlo a vedere?” Per farla breve, sono andato a chiedere come stava. Il giorno dopo entrambi mi domandano di chiamare un monaco buddista perché volevano sposarsi. Mi sono dato da fare e a Milano ho trovato una persona che li ha seguiti lungo tutto il mese di degenza in ospedale. È venuto un monaco da Milano. Penso stia ad ognuno di noi capire e andare incontro all’altro. Sandra Bombardi: Vorrei chiudere dando la parola ai diversi componenti della Tavola rotonda riguardo al tema delle religioni, dell’integrazione e quale rete di protezione e di senso può essere utile all’interno dell’organizzazione e del lavoro quotidiano dell’infermiere. Rabbino capo Somekh: Desidero intervenire brevemente sulla questione della “stanza del silenzio” in quanto ho seguito i lavori sin dall’inizio in qualità di membro del Comitato Interfedi della città di Torino, luogo iniziale dell’elaborazione di questo progetto. L’idea è stata proposta e sollevata dagli amici buddisti ed è stata rapidamente raccolta da tutti noi perché ci è parsa un’idea non inopportuna, un’idea importante. Voglio ricordare un versetto del Salmo 65: “Per te o Dio il silenzio è lode”. Il silenzio non è da identificarsi come una forma di assenza, ma è, a sua volta, una forma espressiva. L’idea è quindi condivisibile, purché sia rispettata da tutti nella sua essenza. Ci è giunta notizia che recentemente la “stanza del silenzio” è stata adoperata, almeno così ci risulta, per lodevoli iniziative che peraltro non erano silenziose. Ritengo sia opportuno trovare un accordo perché effettivamente questi progetti siano rispettati da tutti nella loro essenza. Riprendo un cenno fatto dal pastore Ribet a proposito della missione dei ministri di culto non cattolici nelle visite ospedaliere anche fuori orario. Mi sembra che sia assolutamente condivisibile l’osservazione che ha fatto a proposito della sovrapposizione con i parenti e con gli amici negli 35 orari canonici dell’ospedale. Operativamente dovrebbe essere rilasciato un lasciapassare anche ai ministri delle altre religioni perché possano svolgere il proprio compito accanto ai cappellani cattolici, tenendo conto che la percentuale di degenti appartenenti alle cosiddette minoranze sicuramente non richiede una presenza costante dei cappellani di altre religioni e quindi l’intralcio al traffico della normale operatività ospedaliera dovrebbe essere assolutamente limitato. Per quanto riguarda il tema delle religioni che ci vede qui riuniti oggi, credo sia un tema estremamente importante da sottolineare. Le religioni, lo abbiamo sentito, hanno diversa materia in comune, hanno diversi messaggi e significati che riguardano trasversalmente tutti i credi e che possono fornire quindi un supporto morale e spirituale all’esperienza personale anche degli stessi operatori sanitari. La dottoressa Bombardi prima parlava dell’importanza della figura dell’infermiere nella totalità della sua personalità, ma io vorrei fare un discorso parallelo a proposito degli assistiti. Esiste anche una componente specifica di ogni singola esperienza religiosa e quando, gentili infermieri ed infermiere, avete a che fare con un degente professante una certa religione – quale che sia non importa – ed esprimente delle esigenze in materia di osservanza religiosa, è evidente che siete costretti a calarvi nella personalità religiosa dell’individuo. Non si potranno confondere fra loro esperienze religiose diverse. Se una religione proibisce di mangiare determinati cibi o di bere acqua minerale gassata – come succede presso alcuni credi religiosi – e il degente in questione richiede un’attenzione di questo tipo, dovete abbandonare – in quel frangente – tutto il vostro pregresso culturale e calarvi interamente nella religiosità del paziente. Questo fa parte della considerazione olistica – di cui parlavo prima – della personalità del paziente dalla quale non si può prescindere. Tenete presente che le religioni non sono partiti politici che possono coalizzarsi. Ognuna esprime una propria verità e di questo fatto bisogna evidentemente tenerne conto e considerare il paziente che avete di fronte sullo sfondo della sua esperienza culturale e religiosa come unica davanti ai vostri occhi in quel momento. Grazie. Giorgio Vilella: Desidero scusarmi per come ho parlato nel mio intervento. Forse qualcuno vi ha percepito una vena di anticlericalismo. Nella mia Associazione c’è uno Statuto che potete andare a leggere su Internet: noi non ce l’abbiamo con nessuna religione, noi ce l’abbiamo con il nostro Stato che è clericale. Che la religione cattolica chieda di fare l’ora di religione nelle scuole pubbliche mi sta bene, è una richiesta legittima; però lo Stato doveva dire di “no” o di “sì” a tutte le religioni e all’ateismo. In Inghilterra, alle elementari, in certe classi non si fa religione, ma se si fa religione si fanno 6‐7 ore di religione cattolica, altrettante di religione protestante, buddismo, induismo e si dedicano delle ore per le associazioni come la nostra. Sono contento che in questo ospedale ci sia l’assistenza per tutte le persone. So che molte persone si troverebbero a disagio senza religione, come sbandate. Hanno bisogno della religione, e mi sta bene che ci siano le religioni che le accompagnano. Non ce l’ho con le religioni. Una volta ho sostenuto un dibattito con un sacerdote che affermava che non fossi ateo, ed io ribattevo che lo ero, e lui incalzava dicendo che non esistono gli atei, non esiste l’ateismo. “Lei è agnostico”: secondo lui io ero agnostico, infelice nell'attesa che lui mi convertisse. Mi mancava di rispetto. 36 Sono diventato ateo sessant’anni fa e ho ribadito questo concetto nel tempo. Non comprendo questa mancanza di rispetto nel riconoscere le mie idee. A me le religioni vanno tutte bene, però vorrei che lo Stato fosse laico. Proprio per questo vorrei parlare di un’esperienza personale. Tre settimane fa è morta mia sorella, 75 anni, professore universitario, una linguista piuttosto nota. Era diventata atea più o meno quando lo ero diventato io, sui 12‐15 anni. Il suo è stato un distacco sofferto dalla religione, fatto anche con rabbia perché, in quanto di sesso femminile, non sarebbe potuto diventare sacerdote, papa e quant’altro. Lungo tutta la sua vita aveva ribadito questo concetto. Sette anni fa ha avuto un tumore al seno, della peggior specie. Però è guarita, dopo cinque anni le hanno detto che aveva la stessa probabilità di vita di una persona sana della sua età. Dopo sei anni le diagnosticano un tumore al fegato. L’hanno aperta, hanno visto che non c’era niente da fare e l’hanno ricucita. Mia sorella era una donna determinata, ha sempre voluto sapere tutto, non ha mai dato il suo consenso se non era ben chiaro, voleva vedere le statistiche, eccetera. Le hanno detto che aveva tre o quattro mesi di vita. È tornata a casa, perché il tumore al fegato è asintomatico. Stava abbastanza bene e dopo sei mesi il medico curante l’ha fatta ricoverare in un hospice. Questo hospice è della ASL 16 di Padova, ma ha sede presso una struttura cattolica. Ci sono tre sacerdoti che fanno il giro degli ammalati e ce n’era uno che andava spesso da mia sorella e lei regolarmente lo allontanava, dicendo che aveva poco tempo da dedicare a lui e che preferiva pensare ai fatti suoi. Era visitata da tanti amici e colleghi. Il sacerdote insisteva, e una volta le ha detto che voleva essere presente al momento della sua morte, auspicando una conversione in extremis. Lei gli ha risposto: “Guardi, se anche mi dovessi convertire, se dovessi diventare pazza, diventerei buddista ma non cattolica.». In un’altra occasione le aveva detto: “Non è possibile che lei non creda, tutti devono credere, Dio c’è... E lei ha risposto: “Per me un adulto che crede in Dio è come un bambino di 14 anni che crede alla Befana.». Questo per dire con quale e quanta determinazione non gradisse la presenza del prete. Ad un certo momento non era più in grado di alzarsi dal letto. Ha chiesto che smettessero di alimentarla e di idratarla: le hanno detto che non era possibile. Era presente la figlia la quale ha controllato su Internet, scoprendo che la legge italiana in vigore dice che se una persona in piena coscienza decide di non alimentarsi nessuno la può alimentare con forza. Allora lo ha riferito alla madre e la madre le ha detto: “vai dai medici e digli come stanno le cose.». Inizialmente hanno fatto resistenza, quindi hanno accettato. È stata interrotta l’alimentazione e l’idratazione per via endovenosa. L’hanno addormentata e nel giro di due giorni è morta. Poco dopo è arrivato il solito sacerdote – quello che “voleva impossessarsi dell’anima di mia sorella” – ha trovato la figlia e le ha detto che avrebbe voluto benedire la salma. La figlia ha risposto di no: mia madre era orgogliosamente atea, tutti la conoscevano come atea, sarebbe stata un’offesa al suo ricordo, alla sua personalità. “No, vada via.” Il prete ha ribattuto: “Questa è casa mia e faccio quello che voglio. Appena ve ne andrete la benedirò.” I miei nipoti mi hanno chiamato piangendo. Sono corso lì e con il Direttore della struttura ho discusso con il sacerdote, il quale ha detto che scherzava. Ha ammesso di aver pronunciato quella frase, però ha aggiunto: “scherzavo”. 37 Sandra Bombardi: Volevo lasciare spazio al dibattito, alle domande. I temi affrontati alimentano curiosità, in quanto riguardano ambiti delicati e culturalmente determinanti, densi e suscettibili anche di punti di vista diversi. Partirei da un aspetto che ha sollevato il rabbino, ovvero l’aspetto delle religioni e come l’infermiere risponde anche all’espressione di credo dell’utente. Generalmente, al di là della religione, in quanto connotato di espressione – “sono di religione cristiana piuttosto che ebraica” e così via – noi più che altro rileviamo le necessità che esprime la persona e la sua religiosità, le quali attraversano diversi modelli del vivere e diverse funzionalità di vita delle persone, che passano dal momento della cura del corpo piuttosto che l’alimentazione, l’abbigliamento, ecc. Aspetti che nella vita di tutti i giorni, nel sociale, la religione va a regolamentare, regolamentano anche quella che è la vita delle persone. Quindi, noi infermieri ci avviciniamo al fine di comprendere come la religione attraversi il modello di vita, che potrà poi essere speculare al modello di cura nel momento in cui la persona esprime un bisogno di salute. Un aspetto importante che mi sembrava interessante è quello del contesto e del silenzio. Volevo appunto ringraziare i colleghi delle Molinette di Torino. Lo svedese Dag Hammarskjöld – Segretario delle Nazioni Unite dal 7 aprile del 1953 al 17 settembre del 1961 – aveva voluto, all’ingresso del Palazzo dell’Onu, una “stanza della quiete”. Era il 1954. Nel testo di presentazione ai visitatori aveva scritto: “Ciascuno di noi ha dentro di sé un centro di quiete avvolto nel silenzio. Questo palazzo, dedicato al lavoro e alla discussione, al servizio della pace, dovrà avere una stanza dedicata al silenzio e alla quiete.». Silenzio come ambiente ideale di un ascolto. Il silenzio ha anche un contesto che ci permette di ascoltarci. Un altro aspetto importante che mi sembra doveroso sottolineare e riprendere è il concetto del tempo. In uno dei primi corsi fatti a Ferrara – con la compresenza di ostetriche, medici, infermieri, assistenti sanitari – riguardante il tema del “ripensare i servizi per un’utenza che cambia” era emerso un aspetto interessante riguardante “i tempi della notte”. Durante la notte, dicevano le ostetriche, anche i parti più impegnativi alla fine comunque risultano migliori. L’ostetrica, di notte, è il più delle volte sola in sala travaglio e in sala parto, il medico di guardia si chiama solo nel momento espulsivo. In lavoro nei “tempi della notte” – pur nella complessità della solitudine dell’ostetrica di fronte alla donna – è migliore. Perché? Il silenzio, la penombra, si cammina più lentamente di notte, si entra nelle stanze bussando, parlando sottovoce, a fianco alla persona. Quindi, come poter trasferire i tempi della notte durante il giorno? Tempi fatti di tono basso, di luce, clima relazionale, vicinanza e dialogo con le persone. Come declinare durante il giorno i tempi della notte per fare in modo che ci sia anche questa dimensione di dilatazione temporale e quindi come prevedere il “prendere tempo”? 38 Un altro aspetto molto importante, che mi sembrava bello da ricordare, è stata un’esperienza che ho vissuto in Federazione sulle narrazioni nel cinquantenario. Prima Padre Vasilescu ricordava ciò che dice a chi è vicino ai malati: “Cercate di sorridere di fronte ai malati, di aver sempre questo atteggiamento positivo”. Ricordo un vecchio slogan di reclutamento, di sensibilizzazione alla professione infermieristica, ancora ai tempi delle scuole convitto. Questo slogan, molto carino, diceva: “Cerchiamo ragazzi seri ma che sappiano sorridere”. Un altro aspetto importante – da considerare – è l’uomo di fronte all’uomo nel momento in cui c’è la sofferenza, nel momento in cui c’è la condivisione del dolore. In ultima analisi, si è una persona di fronte ad un’altra persona ovvero una persona che accoglie un’altra persona. Si è una donna di fronte ad un’altra donna, ad esempio, quando si parlava dell’esperienza nel Centro di accoglienza femminile. Si tratta di essere donne di fronte ad altre donne, ci si impersona di fronte ad un’altra persona, e a quel punto penso vi sia l’identificazione con l’altro o con l’altra. Credo che tutto questo sia molto importante. Ora vorrei dare la parola al pubblico per le domande. Domanda I Intervento – (Infermiera: Claudia Contratto) Lavoro in ambito territoriale, al di fuori dell’ospedale. Tutti i giorni vediamo sempre più l’emergenza esplosa delle fragilità, le fragilità cliniche, le malattie croniche, le disabilità gravi, le malattie in fase avanzata ed esito infausto, sempre più spesso accompagnate dalle vulnerabilità sociali. Vediamo anche la solitudine, ma anche l’emarginazione, l’esclusione sociale vera e propria di persone o di gruppi. In un’ottica di infermieristica territoriale – oserei dire col modello che l’OMS ci dà di infermiere di famiglia – noi abbiamo un ruolo di attivatore di reti di supporto intorno alla persona‐famiglia che assistiamo e dietro a questa funzione ci sono dei valori professionali di cui sarebbe anche molto interessante discutere insieme. Molto interessante l’idea della “advocacy”. Attiviamo quindi reti di supporto sui bisogni di sostegno, di aiuto, di accompagnamento. Sono reti formali – penso ai servizi socio‐assistenziali – e sono reti di tipo informale, le reti amicali, di buon vicinato, il volontariato. Ora, io vorrei approfittare dell’occasione dei presenti alla Tavola rotonda per chiedere loro come fosse possibile attivare una collaborazione che permetta a noi – infermieri del territorio – di “utilizzare”, proporre alle famiglie che abbiamo in carico – nel pieno rispetto dei loro valori etici, culturali, religiosi – un sostegno di tipo religioso in quelle situazioni in cui la sofferenza, la malattia, il lutto sono vissute all’interno delle mura domestiche e di mura domestiche chiuse, di mura domestiche dove c’è solitudine. 39 Cappellano Piero Montagna (Cappellano AO CTO di Torino) Penso che ognuno di noi può rispondere con delicatezza a questa proposta. Le persone che soffrono chiedono aiuto in tutti i modi. Per quanto riguarda la fede – questa è la mia opinione, poi sentirete anche le altre risposte – non importa se cattolica o non cattolica, si potrebbe proporre l’indirizzo o i nomi dei loro responsabili del cammino di fede oppure chiedere aiuto ad un Centro, se c’è in zona, perché vengano incontro a queste famiglie e anche a voi perché li possiate aiutare. Pastore Paolo Ribet: Le comunità valdesi sono abbastanza piccole. Torino ha una chiesa di 1.500 membri dispersi in un’area molto grande. Uno dei momenti centrali e certamente più attesi e desiderati dalle persone è quella che si chiama la “visita pastorale”. Infatti, noi pastori abbiamo sempre la coscienza sporchissima su questo, perché non riusciamo a star dietro a tutti. È un momento importante – nella fase della malattia – l’incontro con il pastore o con la pastora, ma anche con dei gruppi di volontari che possono in qualche modo offrire questo supporto e questo legame. Prima ho terminato il mio intervento dicendo di permettere ai pastori – ai pastori di tutte le comunità – di entrare nei reparti per mantenere il legame con la famiglia. Ebbene, credo sia tanto più valido e più importante quando l’ammalato è a casa, perché lì la famiglia ha anche bisogno di un supporto direi fisico oltre che religioso, spirituale e psicologico. Imam, Hamid Zariate: Come musulmano sottoscrivo la proposta di Padre Piero, perché è una cosa che ho già detto in precedenza. So anche che l’ospedale ha un contatto diretto con un imam che ha partecipato alla costruzione, per così dire, della “stanza del silenzio”. Qua a Torino ci sono circa undici moschee o centri islamici. Io, per motivi di studio, abito a Novara, però assieme a me c’è anche il dottor Lafrà, musulmano, dottore in Scienze Islamiche. Anche lui ha fatto qualche volta da imam in alcune moschee e siamo lieti di lasciarvi i nostri recapiti per qualsiasi cosa, come ho fatto anche con altri vostri colleghi a Biella piuttosto che a Novara. Siamo a disposizione per qualsiasi cosa. 40 Rabbino capo Somekh: Questo mi sembra un intervento estremamente importante, anche perché ci porta al di fuori della struttura ospedaliera propriamente detta. In genere, per quello che riguarda i membri della mia comunità religiosa, essi sono in contatto diretto con noi. Ad ogni buon conto – suggerimento pratico‐operativo – siamo disponibili a redigere con l’ospedale un elenco delle comunità religiose con nominativi, indirizzi, indirizzi elettronici, numeri di telefono e tutto quel che serve, in maniera tale da poter dare seguito pratico a questa bellissima richiesta che ci è pervenuta. Giuliana Galli: Penso – rispetto alla richiesta che fa il Padre – alle parrocchie, alle Conferenze di San Vincenzo, al S.E.A. e insinuo un piccolo sospetto: l’attenzione al fatto che la persona che dovrà entrare in casa della persona malata sia ben accetta dalla stessa, perché molte volte c’è un certo senso di sospetto su chiunque debba entrare in casa, specie se è una persona non conosciuta. Rispetto a comunità non nostre, ci sono dei gruppi, come appunto ha detto l’imam: le moschee o anche le comunità. Relativamente alla comunità nigeriana c’è una comunità pentecostale. Oppure c’è “Fratia”, l’Associazione Promozione Sociale Culturale Italo‐ Romena. Parroco Gheorghe Vasilescu: A proposito della “stanza del silenzio”, questo concetto è molto caro al mondo orientale. I greci lo chiamano “esikia”. Già nel XII‐XIVº secolo nasce la corrente spirituale dell’esicasmo. Se la nostra esistenza terrena finisce con un silenzio, bisogna rispettarlo. Ricordo un passo dal testamento di uno scrittore romeno: “Non turbatemi il sonno con dei discorsi funebri”. Per questa ragione ho smesso di parlare, a parte il rivolgere qualche parola di consolazione se la persona è credente, ma noi siamo rispettosi di tutti, anche di chi non crede o respinge l’assistenza religiosa. Dare un consiglio, in questi casi, è facile e difficile allo stesso tempo. È facile per chi è abituato a dare consigli; un po’ più difficile per chi sta in contatto con la sofferenza, perché non è semplice portare insieme la croce altrui. Abbiamo già la nostra da portare, con grande difficoltà. 41 Malgrado ciò, e in forza di ciò, dobbiamo assumere l’atteggiamento di identificarci con la persona umana che si ha di fronte. Condivido con voi un altro pensiero, senza voler dare l’impressione d’essere un citomane: “Io sono anima dell’anima del mio genere e canto le gioie e piango le sofferenze.». È ciò che diceva San Paolo: “Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto” (Rm 12,15), in modo sincero, autentico. Questo si può osservare soprattutto nell’assistenza domestica alla quale si faceva – e io stesso facevo – riferimento. Noi siamo una comunità molto grande, ma con poche risorse. Tuttavia, nel campo della risposta spirituale, pur non avendo un’organizzazione in tal senso, siamo aperti e disponibili a chiunque si rivolga a noi. Quando è stata inaugurata la “stanza del silenzio” ho detto: “Sia benedetto il Signore, perché qui ognuno di noi, ogni credente di qualsiasi fede, di qualsiasi tradizione, può proiettare la sua ricchezza spirituale in questo spazio di silenzio e di ascolto”, perché il silenzio, come diceva il rabbino, non è assenza della parola. Infatti, nel concetto giovanneo “logos” rappresenta il Verbo incarnato. Grazie. Intervento ‐ (infermiera: Maddalena Galizio) Volevo esprimere un pensiero di grande apprezzamento e di ringraziamento per questa Tavola rotonda che ci avete offerto. Non penso accada spesso di vedere ministri di culto – incluso, giustamente, un rappresentante delle persone che non hanno fede – seduti ad un tavolo a parlare con noi, con la delicatezza ed il rispetto reciproco che ho percepito. Questo è quello che noi infermieri dobbiamo vivere ogni giorno. La nostra attenzione è centrata sul rispetto della persona come questa si manifesta nella sua interezza, ma anche nella sua umiltà, nella sua sofferenza, nelle sue difficoltà. La vostra vicendevole preoccupazione di non urtare nessuno è stata di grande esempio, e di questo vi ringrazio. Mi piacerebbe che gli infermieri – i curanti in genere – potessero ritrovarsi con chi può aiutarci a soddisfare il bisogno spirituale, questo bisogno che si manifesta nella solitudine, nell’angoscia, nella ricerca del significato di senso. Noi le viviamo tutti i giorni queste situazioni: a volte anche un banalissimo incidente – non c’è bisogno di avere una malattia grave – può sconvolgere l’equilibrio di una persona. Io penso che essere ammalati può risultare una grande opportunità di cambiamento per la persona stessa ed anche per le relazioni che fanno parte della nostra quotidianità. Grazie ancora, e di cuore, per quello che mi avete dato oggi. 42 Rabbino capo Somekh: Vorrei raccogliere in maniera operativa la proposta. Innanzi tutto ringrazio la signora, a nome di ognuno di noi, per le sue parole. Varrebbe la pena – nei limiti delle possibilità di tutti, naturalmente – organizzare dei seminari periodici su temi anche più specifici di quelli che sono stati affrontati oggi in modo necessariamente generico e generale, così da creare ed alimentare questa consapevolezza e questa sensibilità auspicata dalle infermiere. Siamo noi che dobbiamo ringraziare queste persone per la loro dedizione nella loro attività quotidiana al servizio della nostra società. Grazie. Sandra Bombardi: A questo punto chiamerei Annalisa Silvestro per le conclusioni. Ringrazio voi tutti per l’attenzione, per il coinvolgimento e ci vediamo domani mattina. Passo la parola ad Annalisa Silvestro. Annalisa Silvestro: L’intervento della collega Galizio è stato estremamente puntuale e corrisponde a ciò che pensavo di evidenziare in questo mio di chiusura. Innanzi tutto, prima di concludere, desidero sottolineare che a Torino – immagino in tutta la Regione Piemonte – avete una grande opportunità. Mi riferisco a ciò che è già stato sottolineato: rispetto ad altre Regioni ed aree del Paese una Tavola rotonda impostata così sarebbe non dico impossibile, ma molto difficile da realizzare, perché probabilmente non siamo ancora del tutto pronti a cercare questi confronti di fondamentale importanza. È stata una Tavola rotonda molto arricchente, come ci ha ricordato la collega Galizio: il rispetto reciproco, la capacità di ascoltarsi e anche di integrarsi. Inoltre – non so se interpreto il pensiero degli altri – questa Tavola mi ha dato l’oggettiva evidenza di quanto sia difficile per noi infermieri – una difficoltà che richiede impegno da parte nostra – riuscire ad accompagnare ed assistere i nostri assistiti nel pieno rispetto del loro modo di concepirsi e di concepire la vita, nel loro modo di stare dentro una situazione di disagio e di malattia nonché nel chiedere – non sempre in maniera esplicita – di essere aiutati e sostenuti. 43 In definitiva, un bell’esempio, e con gli esempi si impara, si apprende, si riflette molto di più che con tante parole. Possiamo quindi concludere, ringraziando innanzitutto il Collegio Infermieri di Torino che ci ha dato questa opportunità. Ringrazio sentitamente – a nome anche della Presidente provinciale – i relatori, i cui interventi sono stati ampiamente apprezzati. E il ringraziamento si estende a tutti i colleghi presenti: ognuno di noi ha potuto acquisire questi esempi e questi ulteriori elementi di riflessione professionale. Grazie ancora. 44 2° SESSIONE: Capo I – art. 4: “ L’infermiere presta assistenza secondo principi di equità e giustizia, tenendo conto dei valori etici, religiosi e culturali, nonché del genere e delle condizioni sociali della persona Maddalena Galizio (Dirigente del Dipartimento qualità, Policlinico Tor Vergata – Roma) Buongiorno a tutti. Desidero rivolgere – in questo inizio di mattinata – un pensiero di gratitudine per l’opportunità che abbiamo di stare insieme e di arricchirci attraverso il contributo di ognuno: penso a ciò che è emerso nella giornata di ieri, al notevole apporto offerto dai vari relatori. Saluto in modo particolare questo ospedale – che mi ha visto presente per tanti anni in qualità di infermiera – e la nostra Presidente. Iniziamo questa Seconda Sessione con la proiezione di un filmato dal titolo “Emigranti” di Franco Piavoli prodotto di Zefirofilm 45 Migranti comuni Grigie e sbiadite immagini, scorrono veloci, veloce come il treno corre la vita. Teste che ciondolano Volti solcati dal tempo trascorso Occhi chiusi per ricordare il passato. Silenzio Rime serrate a trattenere l'addio Emigrante... Un lento monologo un saluto che sfuma. Un diaframma separa il fuori dal dentro La fatica di corpi distesi. Solitudini... Corpi composti, corpi vicino, sentimenti al confino Tutto ovattato per sedare il proprio sentire Sguardo di speranza Occhi che cercano il nuovo mondo Vapore del respiro comune alla trasparenza di un finestrino Gocce: lacrime comuni. (silenzio - arrivo in stazione) 46 Migrante che approdi incredulo in un paese di sorte, di scelta o di fortuna Frenesia sui binari Speranza nel cuore Tristezza negli occhi (Silenzio- sul cartello di Basilea) Migranti chi attende all'approdo quei volti segnati? Sguardo sgomento sguardo spaesato sguardo in attesa ...di un cenno... ...di un segno... ...di vita... Ancora (Silenzio - dopo la partenza del primo treno) 47 Migrante non sai dove andrai vuoi salire ma scendi vuoi partire ma resti (quando ci sono persone frettolose sulla banchina) La dea della fortuna viaggia sulla strada ferrata Fremito annaspa il respiro, afferro una mano. Passi veloci e decisi accompagnano il coraggio a partire Salire sul treno Smarrirsi forse oltre il confino Oltrepassare come un intruso i bordi del proprio paese (Silenzio - quando si caricano le valigie) Mani che accompagnano che spingono che sostengono che tirano che salutano 48 (uscita dal treno dalla stazione di Milano) Il treno va lascia la bocca spalancata del luogo natìo, bocca spalancata e asciutta. (Silenzio - In sala d'attesa) Solitudini Speranze Emigranti per lavoro, per fuga, per salvare, per sognare, per studiare, per amare. Paesaggi dell'animo Paesaggi della sorte, della scelta, del coraggio, del dolore. Il pianto di un bimbo Una vita che nasce. (testo scritto da Cesarina Prandi, letto con voce fuori campo sul video Emigranti del 1963 di Franco Piavoli) 49 Creare le condizioni: responsabilità professionali e organizzative – Lettura magistrale Maddalena Galizio (Dirigente del Dipartimento qualità, Policlinico Tor Vergata – Roma) Il filmato è stato così emozionante che ha persino soffocato gli applausi. Personalmente ho sentito salire dentro me questa emozione. Grazie – mi rivolgo ai curatori di questo convegno – per averci offerto la possibilità di assistere a questa proiezione e grazie anche alla Presidente del CESPI, Cesarina Prandi, per aver accompagnato – con le parole di un’infermiera, con l’anima di un’infermiera – queste immagini. Ritengo sia il modo migliore per aprire una Sessione che ci conduce all’interno del nostro Codice deontologico, e precisamente all’art. 4 del Capo I: “L’infermiere presta assistenza secondo principi di equità e giustizia, tenendo conto dei valori etici, religiosi e culturali, nonché del genere e delle condizioni sociali della persona”. Chiamo al tavolo dei relatori la dottoressa Sandra Bombardi, responsabile dell’Ufficio Accoglienza e Mediazione dell’Azienda di Ferrara; la dottoressa Lorena Mantovani, assistente sanitaria, consigliere del Collegio di Torino, la quale si occupa dei Consultori; Mario Caserta, infermiere presso l’Ufficio Qualità Percepita dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni; infine, la dottoressa Carmen Cappitella, responsabile del Servizio Comfort del Policlinico Tor Vergata. Dopo aver visto il filmato possiamo introdurre la Sessione proprio con il volto dell’altro, il quale risulta essere un continuo appello a prenderci cura della sua esistenza. Il nostro è un trovarsi faccia a faccia con un volto che non è da scoprire, ma è un volto che ci richiama ad un rapporto di responsabilità. Come molti filosofi ci hanno insegnato, esiste l’etica dell’alterità, che è la responsabilità per l’altro, la quale viene ancor prima della necessità di conoscere l’altro. Il volto dell’altro deve consentire la manifestazione: l’altro si manifesta a noi – che siamo infermieri – per poter accogliere e cogliere tutto quanto servirà alla nostra funzione, talvolta anche solo di accoglienza, ascolto, accompagnamento. Il volto delle persone – lo abbiamo visto anche nel filmato – ci consegna il concetto di libertà e giustizia: nessuno vuole partire, nessuno vuole lasciare, nessuno vuole allontanarsi da quelle che sono le poche certezze che si possiedono – ma pur sempre certezze – ben radicate in ognuno di noi: la certezza della famiglia, del posto dove sei nato, dei luoghi a te familiari. Il concetto di libertà e giustizia. Giustizia perché devi partire in quanto non hai denaro, sei un perseguitato, ti torturano, non ti danno lavoro, non ti consentono di essere diverso. C’è una frase che voglio condividere con voi, tratta dal libro “Prendersi cura” di Marie Francoise Colliere: “La conoscenza dell’altro non avviene attraverso un amore sentimentale, ma attraverso un intelligente ascolto”. È così. Ciò che viene richiesto a noi infermieri è questa abilità di mettersi in contatto e di lasciare che le cose avvengano, cosa che è molto difficile per un infermiere, con la penuria di risorse che abbiamo, con la necessità di fare e con la costante gara contro il tempo. Come abbiamo visto ieri con la dottoressa Bombardi, la cura non è un qualcosa di esterno all’uomo, ma è un modo di essere fondamentale dell’uomo. In questo c’è la struttura delle persone, come il volere, il desiderare, l’agire. Dunque, come facciamo a creare le condizioni perché noi si possa operare in modo deontologico? Penso agli studenti, quando iniziano il tirocinio, alla prima volta in cui questo volto dell’altro viene verso di loro in una dimensione 50 diversa, con un significato diverso. Lo abbiamo accennato ieri: è molto difficile allineare gli obiettivi professionali – gli obiettivi legati ai valori – con gli obiettivi istituzionali. Ritengo che il management – soprattutto il management di una direzione – debba assolutamente trovare una strada per intervenire in questo allineamento. Tutto il Codice deontologico è un declinare di obiettivi. Ogni frase, ogni parola richiede la traduzione in obiettivi assistenziali per le aziende, per le strutture sanitarie. Il discorso finanziario – soprattutto quello – impedisce tutto ciò: è come se uno tirasse da una parte e l’altro dalla parte opposta. Orientare l’innovazione: dobbiamo uscire dagli schemi. Uscire dagli schemi è la cosa più difficile, perché gli schemi del passato sono rassicuranti. E ci sembra anche che contengano, in un certo qual modo, l’area della responsabilità. In realtà bisogna andare oltre, accettare idee innovative che consentano a noi di tradurci. Ritengo inoltre che dobbiamo aver cura che i nostri collaboratori contattino il valore intrinseco della propria persona, perché non credo che ci si possa occupare dell’altro – così come credo che non si possa vivere il Codice deontologico – se non si ha la percezione del proprio valore come persona e come professionista. È chiaro: un management ha bisogno di tutta una rete. I coordinatori sono le mie spalle, le mie braccia, le mie gambe, non potrei fare niente senza i coordinatori, poiché essi sono quotidianamente a contatto con i professionisti. Dovete prendervi cura delle persone con cui lavorate. Per fare ciò è importante, fra le altre virtù, sviluppare la capacità di ascolto. L’ascolto è fondamentale per l’innovazione. Se un professionista ti suggerisce un’idea che a primo acchito sembra assurda, ascoltala, perché è probabile che se ne possa trarre qualcosa di buono. Se quel professionista ha avuto il coraggio di proportela significa che ha fiducia nel fatto che tu saprai trarre da quell’idea il buono, il fattibile, il sostenibile. Bisogna creare dei gruppi di lavoro dove le persone trovino il proprio senso di appartenenza rispetto a ciò che fanno, avendo quindi la possibilità di contribuirvi. Lavoro quotidianamente con dei collaboratori che sono stufi d’essere dei meri esecutori, dove il lavoro più importante sembra quello di praticare le terapie che altri prescrivono. Il risultato è un allontanamento da quello che è il valore professionale. I gruppi di lavoro ti consentono di sperare, di sognare, di pensare che sia possibile, che qualcosa cambierà. Gli spazi di riflessione critica. Non è necessario un luogo fisico con scritto all’ingresso “spazio di riflessione”. La riflessione critica si fa anche alla macchinetta del caffè, se c’è qualcuno in grado di cogliere. Bisogna confrontarsi, perché da soli siamo tristi, siamo poveri, siamo dei ricercatori emigranti. Assieme agli altri troviamo la forza di andare avanti. Concludo sul discorso della cultura. Anche i relatori della prima giornata lo hanno sottolineato. La nostra cultura va arricchita dal sapere degli altri, abbiamo bisogno di attingere dal sapere di tutti, perché la nostra è una cultura aperta, una cultura al servizio della persona. Quindi, la formazione – quella invisibile che si fa tutti i giorni e quella strutturata – dev’essere una formazione che ci conduca a questa riflessione critica autonoma, costruendo – gradatamente – la nostra personalità, affinandoci nelle nostre capacità di ragionamento. Mi avvicino alla conclusione ritornando al discorso degli infermieri coordinatori. Uso un termine che non si utilizza: formazione umanistica. Non abbiamo mai impiegato questa parola in termini professionali così espliciti, ma in realtà abbiamo bisogno di scienze umane che ci aprano il cuore, perché la difficoltà quotidiana talvolta ce lo indurisce. Eppure, nella fatica quotidiana dobbiamo prendere coraggio e riesaminare le nostre modalità di lavoro. Poniamoci in discussione, prendiamo anche a carico noi stessi ed i nostri collaboratori, vinciamo i nostri limiti e le nostre resistenze. Vi lascio con questo obiettivo strategico, che fa parte della nostra filosofia e che è un obiettivo laico, come dicevamo ieri. È dedicato a tutti i curanti ed il Policlinico Tor Vergata include nei curanti anche gli amministrativi. Il nostro Direttore generale ritiene che quando si cura una pratica 51 vi sarà un beneficio nei confronti di chi è oggetto/soggetto di quella stessa pratica. Sono convinta che accompagnare i curanti nello spazio etico di ricerca – attraverso relazioni, responsabilità, comportamenti – conduce l’agire professionale verso due situazioni importanti: la testimonianza di valori che toccano la vita democratica nonché i processi innovativi che testimoniano la mediazione che deve esserci tra tutti noi che ci occupiamo dell’altro. Ed ora lascerei la parola ai nostri ospiti. 52 Differenze ed Equità, un Approccio Transculturale Sandra BOMBARDI (Responsabile della Mediazione Interculturale Interaziendale – AOU e ASL di Ferrara) Presentazione La riflessione che mi ritrovo a svolgere sull’organizzazione dei servizi e la nuova utenza che vi accede è oltremodo attuale, oggi più che mai, vista la complessità dell’attuale contesto sociale. La storia dell’uomo, è segnata da incontri e scontri fra popoli diversi nei quali la cultura è un prodotto in continuo divenire, un avanzare e un ritornare, un mescolare e distinguere, un predominare ed essere dominati. La quotidianità è costellata d’incontri che per la loro complessità epistemologica necessitano di attraversamenti in quanto, come disse lo stesso poeta americano Robert Frost, l’unico modo per superare il conflitto è attraversarlo. Lo stesso contatto e incontro con la persona straniera rappresenta una delle situazioni più evidenti in cui l’intreccio tra locale e globale non è solo questione teorica, ma si traduce in vissuti, esperienze e problemi specifici. Accarezzando con passione l’idea di un’accoglienza possibile nei servizi che si occupano di salute, questa non l’ho potuta scindere dalla inevitabile capacità d’ascolto necessaria negli operatori, situandola in uno spazio e in un tempo. Promuovere e favorire nei servizi e in ospedale accoglienza, facendosi carico delle possibilità multiple di “problem solving”, rimanda ad un’epistemologia della complessità in cui, come insegna Marianella Sclavi, hanno un ruolo centrale il paradosso, la circolarità delle comunicazioni, la polifonia, la comprensione dialogica, l’arte di ascoltare, la mediazione dei conflitti e l’umorismo. Accogliere nei servizi e complessità organizzativa L’azione dell’accogliere in ospedale deve garantire rassicurazione, orientamento, ottimizzazione dei tempi. Dedicare attenzione e ascolto agli aspetti dell’accoglienza in ospedale è segnale d’estremo rispetto per il cliente. Ricevere, ospitare, ascoltare, approvare, accettare, contenere. Questi sono solo alcuni dei termini con i quali le persone definiscono il termine accoglienza in ospedale. Il tema dell’accoglienza in ospedale è impossibile scinderlo dal concetto di umanizzazione, in tutte le sue implicazioni, che riguardano aspetti strutturali, ambientali, organizzativi, sociali e psicologici. Al processo di umanizzazione contribuiscono tutti gli operatori che a diverso titolo, con il lavoro d’ogni giorno contribuiscono a definire identità ai servizi ed allo stesso ospedale. Rendere l’ospedale “a misura d’uomo”, più umano significa tendere ad una cultura dell’accoglienza individuando la sua forza nello scambio, nella reciprocità e nel rapporto interpersonale. Il principio delle reciprocità consiste nell’avere rispetto per essere rispettati, come sostiene l’OMS, tutto si muove in base al criterio dell’interdipendenza. Nulla può essere realizzato da un unico soggetto, mentre tutto si realizza per la partecipazione necessaria e imprescindibile di più interpreti, essendovi oggi nei servizi per la salute e in ospedale livelli di relazione diversi e sempre più complessi. 53 La complessità delle attuali organizzazioni si presenta costellata da processi sempre più non lineari, dinamici, incerti e imprevedibili che ha reso sempre più difficile, se a volte impossibile, utilizzare le logiche del controllo della complessità (Beer 1972). Queste indicano che per comprendere e controllare la complessità ambientale il sistema aziendale deve cercare da un lato di ridurre la complessità, semplificarla e dall’altro deve aumentare le capacità di controllo e di regolazione. I servizi oggi, per un’utenza che cambia, meglio si leggono nel loro caos e nella loro complessità con modelli di ricerca di un nuovo ordine attraverso l’apprendimento (Nonaka 1988). In quanto, dal non equilibrio, dal caos può nascere spontaneamente un nuovo ordine, una nuova organizzazione attraverso un processo di auto‐rinnovamento che si esplica in 4 fasi: fase del caos, fase dell’amplificazione delle fluttuazioni‐contraddizioni, fase della cooperazione e fase nuovo ordine attraverso lo stesso apprendimento. Nelle organizzazioni, e in questo casi negli ospedali due sono gli elementi peculiari, di core sanitario, che connotano diversi gradi di complessità: complessità clinica e la complessità assistenziale. Oggi per le diverse provenienze geo‐culturalie e storie di salute e malattie dei nuovi utenti, un ulteriore elemento di complessità si è inserito trasversalmente in questo binomio; si tratta della complessità relazionale. Ci troviamo spettatori di una notevole “varietà” di senso, riguardo lo stesso problema di salute, in cui elevata è la differenziazione e maggiore è l’interdipendenza tra paradigmi, utili alla lettura e alla stessa risoluzione del problema di salute. In tutto questo, qualsiasi semplificazione comunicativa si voglia fare, che porterebbe inevitabilmente ad ignorare la possibile alterità dell’Altro, creerebbe una crisi nelle dinamiche comunicative, dell’accoglienza e reciproca convivenza. A questo punto una domanda è d’obbligo: come gli operatori dei servizi possono governare questa varietà? Interessante è la risposta di Ashby 1956, 1962: “Solo la varietà può distruggere la varietà. Un sistema per poter affrontare la complessità ambientale deve avere una varietà interna, ovvero gradi di libertà interna, coerente con la varietà esterna, ovvero coerente con i gradi di libertà esterna: - solo la varietà interna può distruggere la varietà esterna; - solo gradi di libertà interna possono distruggere gradi di libertà esterna; - solo la complessità interna può distruggere la complessità esterna”. Per creare le condizioni affinché si realizzi varietà interna è fondamentale un cambio d’approccio all’interno delle organizzazioni: dal presente approccio di tipo top‐down ad un approccio di tipo bottom‐up. L’approccio dal basso verso l’alto favorisce la produzione di conoscenza, è garanzia di intelligenza distribuita (capitale umano e capitale sociale) e implementa reti, crea relazione, reti di team auto‐organizzati. Il passaggio dal singolare al condiviso è favorito dalla determinazione a ottenere risultati appropriati per tutti, con la disponibilità a rinunciare a qualche personale vantaggio a favore del vantaggio comune. La sfida da cogliere, è quella di pensare ad uno spazio, fatto di relazioni umane, meno statico, che possa contenere la piena espressione del diritto alla diversità e che sappia fare della diversità una risorsa e che contestualmente la rappresenti come occasione di integrazione e di crescita delle persone. Dove integrazione non vuole avere il significato di cancellazione delle peculiarità ma corrisponde al concetto di inter‐azione, cioè di interscambio, di confronto, di reciprocità. 54 Nel corso della revisione della letteratura riguardo il processo d’accoglienza, riguardo l’ospitalità e il riconoscimento dell’altro, tre concettualizzazioni risultano, a mio parere, esemplificative, significative e paradigmatiche. La prima riflessione riguarda il concetto di rispetto elaborato dal sociologo americano, Richard Sennet (2004). Sennet presenta la modalità del “donare rispetto” come una performance situata nella relazione con l’altro che mette in scena, e rappresenta il riconoscimento reciproco. Donare amicizia, creatività, ascolto ed attenzione, fa guadagnare rispetto e per compiere questi gesti è necessario spendere tempo ed energie. Il rispetto è un qualcosa che si conquista continuamente, che permette un duplice riconoscimento fondato sulla condivisione dei diritti e fondato sul rispetto delle diversità. L’amore di sé e la stima di sé nascono dalla fiducia nelle proprie capacità personali, dalla percezione quotidiana che si è rispettati per quello che si è, e solo dal rispetto di sé può nascere il rispetto verso l’altro di cui accettiamo la diversità così come questi accetta la nostra. La mancanza di rispetto, precisa Sennet in apertura del suo testo, anche se meno aggressiva di un insulto diretto, può ferire in maniera altrettanto viva. La seconda riflessione, che ha contribuito alla costruzione della cornice teorica, riguarda il concetto d’identità e di comunità svolta da Zygmunt Bauman (2003). Riguardo l’identità, Barman riferisce che nel 1994, un manifesto, attaccato sui muri di Berlino, sbeffeggiava la fedeltà a schemi che non erano più in grado di rispecchiare la realtà del mondo: “Il tuo Cristo è un ebreo. La tua macchina è giapponese. La tua pizza è italiana. La tua democrazia greca. Il tuo caffè brasiliano. La tua vacanza turca. I tuoi numeri arabi. Il tuo alfabeto latino. Solo il tuo vicino è uno straniero”. La comunità, secondo il sociologo, è un luogo caldo, intimo e confortevole. È come un tetto sotto cui ci ripariamo, dove possiamo contare sulla benevolenza di tutti. Il privilegio di vivere in una comunità richiede un prezzo da pagare: l’assenza di comunità significa assenza di sicurezza, la presenza significa perdita di libertà. Da qui la continua tensione riguardo i presupposti di sicurezza e libertà ‐ comunità e individualità. Infine, il terzo contributo, riguarda il lavoro svolto da Martha C. Nussbaum (2001, 2002) attorno al concetto di capacità. Nussbaum si sofferma sull’importanza di garantire giustizia sociale e dignità umana. Il suo importante lavoro riguarda la necessità di valutare la qualità della vita delle persone partendo dalle seguenti domande: che cosa le persone sono in grado di fare ed essere in quella particolare società? Nussbaum si preoccupa in particolare della dignità degli esseri umani, delle modalità di riconoscimento, di valorizzazione e di quanto le persone siano libere di scegliere la propria vita nella concretezza delle loro condizioni particolari. Rispetto, comunità e capacità risultano essere le parole chiavi del riconoscimento dell’altro. Le stesse politiche per la salute, mettendo al centro il cittadino e rafforzando garanzie e diritti, permette il passaggio da un modello centrato sulla funzione di tutela – advocacy ‐ ad una funzione di valorizzazione delle capacità e delle abilità ‐ empowerment. Si tratta a questo punto di rendere protagoniste le persone del proprio progetto e del percorso individuale avvalendosi o imparando a valorizzare le reti formali e i propri mondi vitali. Quali competenze deve padroneggiare un operatore per prendere in carico l’utente e la relativa complessità della domanda d’aiuto? La maturata competenza cultura degli operatori e le abilità di ascolto attivo si presentano in questi casi espressione di meta‐competenze, o espressione di competenze complementari, in grado di realizzare significativi e sensibili progetti d’aiuto interculturali. 55 Il modello di Papadopoulos, Tilki e Taylor, illustrato nella seguente immagine, si pone l’obiettivo di sviluppare, negli operatori, competenza culturale attraverso un processo progressivo che si realizza in 4 fasi. Modello per sviluppare competenza culturale Papadopoulos Tilki Taylor (1998) Consapevolezza Culturale Competenza Culturale Sensibilità Culturale Conoscenza Culturale Middlesex University London www.mdx.ac.uk/www/rctsh Il modello permette il miglioramento dell’insegnamento dell’assistenza transculturale e si pone come guida per la strutturazione di specifici moduli didattici o corsi di perfezionamento. Inoltre, guida progetti di ricerca applica alla pratica assistenziale. La formazione transculturale pone dei presupposti fondamentali, basati sulla cultura di provenienza delle persone, e va intesa come presa di coscienza della propria identità, della “diversità” della quale ciascuno di noi è portatore (operatori e cittadini). Un progetto formativo che crea competenze culturali ha come base il rispetto per l’altro, il riconoscimento della reciprocità, della dignità della persona, della necessità di costruire un percorso condiviso, interculturale e mutabile, in relazione alle rispettive specificità culturali. Specificità culturali che non sono solo appannaggio delle sole persone straniere, ma appartengono a tutti gli esseri umani. L’abilità culturale maturata dagli operatori, porta a riscoprire la possibilità di non generalizzare il proprio sapere, ponendosi costantemente in dialogo e aprendosi all’apporto che l’utente e l’operatore possono dare, come risorsa, nel fornire risposte d’aiuto, adattando i modelli e gli strumenti di volta in volta necessari per cogliere i passaggi nella storia di una persona, che possono sembrare deboli dal punto di vista dell’organizzazione sanitaria, ma che possono essere punti forti e importanti per la persona. 56 La seconda meta‐competenza, o competenza complementare, riguarda le abilità di ascolto attivo possedute dagli operatori. Competenze di ascolto che si esplicitano attraverso: - la ricerca di senso interno alle diverse possibilità presenti nel pensiero della complessità; - il rispetto delle diverse logiche dell’altro; - la flessibilità riguardo alle pratiche “Un buon ascoltatore accoglie volentieri i paradossi del pensiero e della comunicazione. Affronta i dissensi come occasione per esercitarsi in un campo che lo appassiona: la gestione creativa dei conflitti”1. L’ascolto attivo permette di cogliere i sensi e i significati della domanda, al di là delle espressioni variamente usate dalla persona, per raggiungere il profondo malessere che l’ha causata e poter cercare insieme di ricondurre i comportamenti ad un livello di coerenza, tra quello che si fa e ciò che si pensa. Flessibilità, umorismo, coinvolgimento e distacco, ascolto attivo: un ambiente complesso in cui mancano queste competenze di base diventa “manicomiale” produce escalation dei conflitti e il cambiamento diventa turbolento e incontrollabile. L’ascolto attivo, guidata dalle parole di Sclavi, permette di esplorare con consapevolezza, emotiva e cognitiva le differenze, permette di utilizzare queste esplorazioni per costruire ponti, intrecciare dialoghi e produrre connessioni. Inoltre, permette la costruzione di una realtà sociale in un mondo complesso. Amore Dopo Amore Tempo verrà in cui, con esultanza, saluterai te stesso arrivato alla tua porta, nel tuo proprio specchio, e ognuno sorriderà al benvenuto dell’altro, e dirà: Siedi qui. Mangia. Amerai di nuovo lo straniero che era il tuo Io. Offri vino. Offri pane. Rendi il cuore a se stesso, allo straniero che ti ha amato per tutta la tua vita, che hai ignorato per un altro e che ti sa a memoria. Dallo scaffale tira giù le lettere d’amore, le fotografie, le note disperate, sbuccia via dallo specchio la tua immagine. Siediti. È festa: la tua vita è in tavola. Derek Walcott, Mappa del nuovo mondo, 1992 1 Sclavi M., Regola n.6 dell’Arte di ascoltare, in Arte di ascoltare e mondi possibili, Le Vespe, Milano, 2000, p.69 57 Consultori familiari e donne immigrate: uno strumento di lavoro. Nadia Lorena Mantovani (A.S. Coordinatore ASL TO 2 – Consigliere Collegio IPASVi di Torino) Al 1° gennaio 2008 la popolazione straniera residente in Piemonte ammontava a 310.5432 su una popolazione totale di 4.401.266 con un incidenza del 7,1%. La stima della Caritas è invece largamente maggiore, pari a 352.020 stranieri con permesso di soggiorno. Infatti, i dati in possesso dell’ISTAT sugli stranieri residenti provengono dall’anagrafe della popolazione residente dei comuni e si riferiscono alla quota straniera regolare più stabilizzata, inferiore, però al dato reale dei presenti con permesso di soggiorno. Al 1° gennaio 2008 i residenti stranieri a Torino erano 103.7953, cioè l’11,43% della popolazione cittadina totale. Il tasso di incremento dell’immigrazione nel capoluogo, negli ultimi dieci anni, è cresciuto in maniera esponenziale, considerando che nel 1998 gli stranieri residenti si assestavano a quota 29.225 con un’incidenza del 3,2% sulla popolazione totale. Da questi dati è possibile affermare che l’immigrazione in città ha subito un aumento percentuale del 357% nell’ultimo decennio. Ad oggi le comunità maggiormente rappresentate tra gli stranieri residenti sono quella Rumena, Marocchina, Peruviana, Cinese, Nigeriana. La struttura per età è sicuramente molto giovane: la classe d’età più consistente è quella 30‐34 anni. In questo panorama di popolazione in età fertile i consultori familiari hanno avuto ed hanno tuttora una funzione fondamentale nell’educazione sanitaria e promozione della salute riproduttiva. I consultori familiari sono servizi multidisciplinari in cui operano diverse figure professionali, medici infermieri, ostetriche, assistenti sanitarie, psicologi, mediatori culturali e assistenti sociali al fine di tutelare l’integrità psicofisica e relazionale dell’utente e favorire la continuità assistenziale. Sono punti di ascolto, di informazione e di primo intervento per rispondere ai bisogni, dubbi o disagi della donna, della coppia e dell’adolescente in riferimento alle problematiche della sessualità, della procreazione responsabile, della contraccezione, della gravidanza, della prevenzione delle patologie della sfera genitale femminile e delle malattie a trasmissione sessuale. In virtù di queste funzioni nel 2007 L’ASL TO2 ( ex ASL 3 e 4)è stata coinvolta dall’associazione Ideadonna Onlus di Torino (organizzazione specificatamente dedicata alle tematiche femminili relative alla migrazione) come partner del progetto “Getting better” “Getting better” è un audio‐video di educazione sanitaria e promozione della contraccezione rivolto alle persone di nazionalità nigeriana. La distribuzione gratuita è iniziata a giugno 2007 nei consultori familiari, ambulatori medici, realtà dell’associazionismo, esercizi commerciali maggiormente frequentati dalle destinatarie e dai destinatari dell’iniziativa; a fine 2008 le copie distribuite sono state 3300. Background del progetto 2 Dati estratti dal sito: http://demo.istat.it AA.VV., XI Rapporto dell’Osservatorio interistituzionale sugli stranieri di Torino, consultabile alla pagina: http://www.to.camcom.it/osservatoriostranieri 3 58 In seguito alla valutazione di alcuni dati quali la frequenza con cui le donne nigeriane abortiscono negli ospedali italiani e le stime sugli aborti o i tentativi di aborto al di fuori delle strutture sanitarie è stato definito il target di popolazione a cui rivolgere il progetto Dopo una prima fase di documentazione si è passati all’individuazione dei contenuti, dei problemi e dei modi per trattarli: il personale sanitario dei consultori è stato identificato come supervisore scientifico mentre le donne che hanno recitato che sono in parte mediatrici culturali, hanno argomentato riguardo le credenze tipiche della cultura nigeriana Sono stati realizzati quattro workshop. Le discussioni e i dibattiti si sono concentrati su argomenti definiti, quelli da trattare nell’audiovisivo e cioè: contraccezione, maternità, IVG e aborto clandestino. Argomenti che il gruppo di lavoro ha evidenziato come più importanti in merito ai comportamenti potenzialmente a rischio legati alla cultura di origine delle donne nigeriane. L’obiettivo generale del progetto “getting better” è il miglioramento delle condizioni di salute delle donne straniere, quindi, la riduzione del rischio di gravidanze indesiderate e la maternità consapevole. L’obiettivo specifico è stato la produzione di un audiovisivo di informazione inteso come uno strumento di mediazione interculturale capace di far avvicinare le donne ai servizi. I professionisti sanitari dei consultori hanno potuto evidenziare con questo lavoro il grande arricchimento della propria competenza interculturale consolidando il principio del confronto delle differenze e delle affinità esistenti tra le credenze, i valori e gli stili di vita: nell’ambito della presa in carico degli esseri umani nel SSN la conoscenza di questo principio è indispensabile per poter offrire un’assistenza sanitaria culturalmente congruente, utile e valida. Affinché si possa praticare un’assistenza significativa è estremamente importante scoprire e capire che ogni civiltà ha modi propri, locali o “emici”4 di vedere e conoscere la cultura a cui appartengono. Le idee e le credenze “emiche” sono spesso viste come “segreti” e può non esserci la volontà di condividerle con persone culturalmente estranee, come infermieri o medici, a meno che non si riponga fiducia in loro. E’ compito degli infermieri transculturali appropriarsi di questi elementi, stabilendo una relazione basata sulla fiducia. La conoscenza etica (esterna alla cultura), come per esempio le idee professionali di un infermiere, può essere diversa dalla visione “emica” e dalle esperienze individuali. Al fine di valutare e guidare il pensiero e le decisioni degli infermieri con gli assistiti sono importanti sia la conoscenza “emica” che quella “etica”. Il confronto con l’immigrato è ormai quotidiano e l’incontro con la persona straniera può e deve comportare una modifica nel modo di lavorare, di essere , di porsi: tutto ciò rappresenta una sfida professionale fondamentale nell’ambito dell’infermieristica che, per propria natura si focalizza sulla relazione con l’altro. 4 I termini “emic” ed “etic”, tradotti in italiano come emico ed etico, sono stati coniati dal linguista Kenneth L. Pike che li ha mutuati dalle parole “fonemico” e “fonetico”: il sistema fonetico è basato sulla suddivisione dei suoni in base alle differenze specifiche esistenti da linguaggio a linguaggio; il sistema fonetico è invece la descrizione dei suoni prodotti dagli organi della parola che sono comuni a tutti gli uomini. L’opposizione è stata introdotta in antropologia da Marvin Harris per distinguere il punto di vista interno ed esterno ad una data cultura, i concetti usati dalle persone che sono oggetto di studio e quelli usati da chi compie lo studio 59 Madeleine Leininger definisce la teoria infermieristica transculturale come: “…un insieme di concetti e di ipotesi infermieristiche in relazione tra loro che trattano diverse civiltà, prendono in esame comportamenti assistenziali di gruppo o individuali, valori e teorie basati sui loro bisogni culturali per poter offrire alle persone un’assistenza infermieristica efficace e soddisfacente; se quelle pratiche infermieristiche non riescono a riconoscere gli aspetti culturali dei bisogni umani, vi sarà un’assistenza meno efficace e vi saranno conseguenze sfavorevoli nei confronti dell’assistito”5 Le cure della spiritualità. L’assistenza religiosa in ospedale e la Stanza del silenzio Mario Caserta (Infermiere coordinatore – Ufficio qualità percepita e partecipata – SC URP – AOU “San Giovanni Battista” di Torino) All’ospedale Molinette i pazienti possono rivolgersi al personale infermieristico per convocare un ministro di culto della propria religione per ottenere conforto, confrontarsi o richiedere un supporto spirituale. Nella Stanza del silenzio, invece, tutti, credenti e non credenti, possono pensare, raccogliersi, pregare, consumare un dolore ed affrontare nel modo migliore possibile la malattia o il lutto. Il nostro tempo è caratterizzato fondamentalmente, ed in tutti i campi, dal pluralismo culturale, nonché dal pluralismo religioso. Tale pluralità, oltre ad essere una situazione non transitoria, ma stabile, poiché non sarà mai possibile che nel mondo si giunga a professare una sola fede, ha radici lontane nel tempo. Infatti, anche ai tempi in cui la società europea poteva chiamarsi societas christiana erano presenti altri culti (musulmani, ebrei, catari, ... ). In un simile contesto, come professionisti, possiamo rendere ragione della nostra fede, ma soprattutto siamo tenuti ad imparare a dialogare con le altre confessioni presenti, ad adottare una visione più ampia, pluralista. Pluralismo religioso, quindi, significa che nella società attuale non soltanto ci siano molte religioni “di fatto”, ma che possano esserci molte religioni “di diritto”, che vuol dire che di fronte alla legge hanno tutte il diritto di esistere, di predicare le proprie dottrine, di praticare i propri riti, di accedere a privilegi di vario tipo, di supportare spiritualmente le persone nei momenti difficili. Ed è in un contesto “difficile”, quale quello del ricovero ospedaliero, caratterizzato dalla sofferenza e spesso dal lutto, che assume importanza cruciale il “diritto” ad un rapporto con il divino anche attraverso l’intermediazione ed il conforto di un referente della propria religione. Sulla base di tali premesse all’ospedale Molinette si è dato avvio al Progetto “Culture e Religioni”. Il progetto “Culture e Religioni” Obiettivo prioritario del progetto era colmare l’assenza di un servizio religioso per i non cattolici. Lo strumento individuato, per semplicità ed economicità, è stato un elenco da distribuire ai reparti, contenente i recapiti dei referenti delle maggiori religioni contattabili dall’utenza. 5 Leininger M, Mc Farland M.R., Infermieristica transculturale, Ed. CEA, Milano, 2004 60 Data l’impossibilità di includere tutte le religioni nell’elenco si è reso necessario garantire la massima oggettività nella scelta delle religioni, ricorrendo a due criteri: il riconoscimento in qualità di “ente di culto” da parte dello Stato Italiano e la maggiore rappresentatività. Utilizzando i dati emersi dallo studio compiuto dal CESNUR (Centro Studi sulle Nuove Religioni), che nel 2006 ha censito il numero dei appartenenti alle varie minoranze religiose sul territorio nazionale, e fissato il cut‐off allo 0,05% (fedi che contano un numero di appartenenti superiore a 30.000 su tutto il territorio Italiano), risultavano incluse le confessioni indicate in figura 1 (con l’esclusione dei Testimoni di Geova che non hanno firmato l’intesa). Figura 1 ‐ RELIGIONI INCLUSE NEL “PROGETTO RELIGIONI” Superiori a 30.000 appartenenti sul territorio Italiano (0,05%) Induisti; 45.000 Ebrei; 36.500 Musulmani; 860.000 Buddhisti; 128.000 Ortodossi; 440.000 Protestanti; 513.000 Identificati i riferimenti religiosi nazionali (federazioni, associazioni e simili) avendo cura, nel caso fossero presenti più raggruppamenti, di scegliere sempre attraverso il criterio della maggiore rappresentatività, si è richiesto loro di indicare i ministri di culto locali (da indicare nella brochure definitiva) con cui è stata stipulata un’intesa che fissa vincoli e opportunità per le religioni e l’azienda ospedaliera. Redatta la brochure e distribuita nei reparti, i pazienti sono stati informati della possibilità di convocare i rappresentanti della propria fede attraverso l’affissione di appositi manifesti multilingue (figura 2) affissi in tutti i reparti e nei maggiori spazi aziendali. Le chiamate e gli interventi dei religiosi non sono mancati… 61 Figura 2: Manifesto multilingue La Stanza del Silenzio Sull’onda dell’entusiasmo e dei positivi feedback ricevuti dall’utenza e dagli operatori, nonché sulla spinta dei rappresentanti religiosi che richiedevano la possibilità di identificare spazi neutri per pensare, raccogliersi, pregare, consumare un dolore o per partecipare ad incontri e seminari si è avviata la progettazione di un locale dedicato ai credenti di tutte le religioni. Le tipologie di locale potevano essere due: la Stanza Interfedi (locale destinato alle diverse religioni in differenti orari della giornata) oppure la Stanza del Silenzio (spazio neutro da destinarsi contemporaneamente a tutte le religioni/fedi e anche agli atei nel comune denominatore del rispetto reciproco attraverso il silenzio). Per ragioni di praticità e di semplicità d’uso, e per privilegiare il massimo utilizzo evidenziando la visione laica dell’azienda ospedaliera, che garantisce pari opportunità a tutte le religioni/fedi/credenze, si è optato per la creazione della Stanza del Silenzio. Utilizzando un locale originariamente destinato a cappella cattolica, ma non più utilizzato in virtù della più grande chiesa ospedaliera, è stato richiesto ai rappresentanti religiosi, attraverso un questionario individuale (metodo Delphi), quali fossero i requisiti architettonici e funzionali necessari (colore delle pareti, arredi necessari, eventuali suggerimenti). La ristrutturazione, gestita dai servizi tecnici aziendali, è costata poche migliaia di euro, a dimostrazione che le cose si possono fare anche con pochi soldi. All’inaugurazione davanti alle centinaia di partecipanti si è presentato un locale affascinante: un cielo puntinato di stelle che accoglie i visitatori e li accompagna in uno spazio di 150 metri quadrati, con le pareti azzurre, alcune panche, un divano, uno spazio con tappeti per gli scalzi, uno scaffale con i libri sacri delle diverse religioni e nessuna simbologia o riferimenti a un culto particolare. “La sala è aperta a pazienti, famigliari e personale dell’ospedale. E’ un luogo che da’ la possibilità a chiunque, anche a chi non crede, di ritrovarsi nello spirito per meditare, dedicarsi alla preghiera in ogni sua forma o anche vivere il dolore ‐ ha spiegato il direttore generale delle Molinette, Giuseppe Galanzino ‐ è la stanza di tutti, non solo delle religioni.”. I commenti dei visitatori non sono mancati, nel “libro ospiti”, accanto a qualche nota polemica, si leggono numerosi incoraggiamenti: “… bravi!” oppure“… un grosso segno di civiltà” ed ancora 62 “ognuno vede Dio in modo differente, ma siamo tutti insieme nel silenzio e nel rispetto reciproco…” ed infine “…grazie per averci pensato, per essere vicini a chi soffre, a chi crede oppure no”. Alcune riflessioni… E' pensiero condiviso che il pluralismo religioso sia raggiungibile solo attraverso la cooperazione più che la competizione tra le varie fedi, ma tale risultato è possibile solo attraverso un rinnovamento sociale e teologico finalizzato al superamento (pratico, non teoretico: non c’è via di mezzo sul piano teoretico tra due dottrine incompatibili che non snaturi entrambe, e nella quale nessuna delle due sia più in grado di riconoscersi autenticamente) delle differenze che generano conflitto. Questi progetti non si sono posti obiettivi così ambiziosi ma sicuramente gettano le basi per un confronto interculturale, e soprattutto stimolano operatori ed utenti a superare le differenze e a considerare tutte le credenze con pari dignità. Considerato che la libertà di religione viene indebolita dal conferimento ad una specifica confessione di privilegi negati ad altre, l'unica via per un vero pluralismo teologico passa attraverso la condizione nella quale differenti fedi, professate in uno stesso spazio, godono degli stessi diritti di esercizio e di espressione pubblica. In quest'ottica, è evidente quanto il cardine dei progetti sia appunto la considerazione equa e paritetica di ogni religione mantenendo, come peraltro prevede il nostro codice deontologico, l'uomo al centro delle cure senza alcuna distinzione quali che siano le sue credenze o abitudini. Inoltre, le differenze culturali e religiose possono essere fonte di riflessione per operatori ed utenti, ad esempio creando dibattiti e/o incontri formativi in cui analizzare le diverse interpretazioni dei vissuti quotidiani (malattia, sofferenza, morte, ...) alla luce delle varie confessioni. E solo in tal modo le differenze teologiche ed ideologiche non sono un limite ma una preziosa risorsa. Bibliografia consigliata: A. Pangrazzi (2002) Salute malattia e morte nelle grandi religioni, edizioni Camilliane Il confort globale: tra accoglienza e personalizzazione dei servizi Carmen Cappitella (Responsabile progetto Confort—Servizio Confort Ospedaliero Policlinico Tor Vergata) Grazie, buongiorno a tutti. Sono molto emozionata perché la mia formazione è avvenuta in quest’azienda e vi ho lavorato per dieci anni. Tornare qui, oggi, a distanza di qualche anno, è estremamente emozionante. L’obiettivo della mia presentazione sta nel raccontarvi quella che è stata l’esperienza al Policlinico Tor Vergata – iniziata otto anni fa – sulla realizzazione di un servizio dedicato al comfort e all’accoglienza del paziente, in maniera estremamente ampia, con un respiro diverso da quello 63 iniziale. Siamo un Policlinico giovane, la nostra attività è cominciata circa dieci anni fa. Quali sono stati i presupposti grazie ai quali abbiamo iniziato a lavorare alla realizzazione di questo servizio? Desidero rispondere iniziando il mio intervento con un termine che spesso definisco paradossale: umanizzazione. Cosa c’è di più umano che un ospedale, dove ci sono delle persone che lavorano, che curano, che hanno bisogno dell’attenzione di qualcun altro? Siamo tornati a ripensare al significato reale di questa parola ed anche dalle relazioni che mi hanno preceduto – nonché dalla giornata di ieri – ho sentito forte il bisogno di ripensare all’umanizzazione delle cure. Questa mattina la collega citava M. F. Colliere ed il suo libro “Aiutare a vivere”. È un’opera che ho ripreso anch’io nella preparazione di questa mia relazione. Questo circolo di idee, di cultura infermieristica che torna – come diceva la dottoressa Galizio – è estremamente entusiasmante. In definitiva, cosa significa umanizzare? Innanzitutto pensare, ripensare agli spazi fisici, sociali e culturali dove il malato è il centro e la famiglia è una risorsa importante. Non dobbiamo dimenticarci dell’importanza che oggi riveste la famiglia. Naturalmente il personale è colui che mette a disposizione tutta la propria competenza, la propria autonomia, la propria responsabilità. Umanizzazione quindi come atto dovuto, perché la qualità delle prestazioni assistenziali passa inevitabilmente attraverso questa parola. E allora, la permanenza in una struttura di ricovero può essere un’occasione preziosa per fare educazione alla salute. Ieri pomeriggio abbiamo detto: a volte la malattia può diventare l’opportunità per ripensare le relazioni, quello che è il nostro stato di vita in questo momento. L’umanizzazione è pertanto l’occasione del ricovero come ripensamento a queste relazioni. L’intervento di cura non può essere riferito alla specifica malattia – eccoci al cuore del problema – ma dev’essere riferito alla vita della persona, alle scelte, ai vissuti, ai valori, a quello che è il proprio credo. Siamo partiti da quelli che erano i principi ispiratori del nuovo modello di ospedale: il decreto ministeriale del 2000. Eravamo alle soglie del nuovo millennio e c’era bisogno di ripensare quella che era l’assistenza erogata all’interno dei nostri ospedali. Ospedali con un alto contenuto tecnologico‐assistenziale, ma dove la parola umanizzazione e la parola accoglienza diventavano predominanti. Il prendersi cura può fornire un ulteriore significato, motivo e coraggio per affrontare anche quello che è l’aspetto curativo. Il prendersi cura viene prima della terapia. La clinica fa parte dell’umanizzazione e non viceversa, esattamente come l’assistenza. Mi piace questo concetto: la cura che può indicare l’azione che cura la debolezza, ma che può sviluppare la possibilità. Cura: rapporto come parola, gesto e realtà; quindi, è la risposta etica alla vulnerabilità umana Non voglio commentare oltremodo queste frasi perché ognuno di noi sarà in grado di trovarvi – all’interno del proprio vissuto e della propria cultura professionale – il significato più ampio. Nel 2002 abbiamo cominciato l’attività di organizzazione del “servizio comfort ospedaliero”, che intende promuovere e realizzare la filosofia innovativa del prendersi cura che diventa un valore complementare all’attività clinica e all’attività assistenziale. La nostra convinzione è che la persona che comincia un percorso all’interno del nostro ospedale deve impiegare le proprie energie sul proprio percorso di cura e non sull’adattamento all’ambiente. Quindi, l’ambiente deve diventare colui che accoglie, colui che accompagna e soprattutto che permette alla persona di non sprecare ulteriori energie per adattarsi al luogo stesso. Comfort ospedaliero inteso quindi come aspetto evoluto ed articolato dell’accoglienza all’interno delle aree sanitarie. Si vuole pertanto ridefinire e superare il vecchio concetto dei modelli alberghieri. Non vogliamo sentir parlare di servizio comfort che si occupa dei servizi alberghieri. No. La nostra è una visione diversa, è una visione globale che vuole abbracciare tutto il percorso di permanenza della persona in ospedale. Quindi, 64 realizzare tutte le funzioni di supporto e promuovere e sviluppare specifici ambiti progettuali. Ve ne presenterò alcuni, i quali sono parte integrante all’attività di cura e complementari alle attività sanitarie: ‐ valorizzare tutti gli aspetti del comfort ospedaliero, anche attraverso la gestione dei servizi alberghieri; ‐ garantire le condizioni ambientali di vita il più vicino possibile alle abitudini del vivere quotidiano; infatti, molte delle nostre attività riguardano proprio gli spazi fisici e l’ambiente; ‐ impiegare le risorse umane nei progetti di miglioramento e raggiungere la consapevolezza che misurare, verificare e valutare quelli che sono i risultati è alla base del percorso che continuiamo ad intraprendere. Ho parlato di cura dell’ambiente, ossia di organizzazione dell’ambiente fisico dove la persona si trova. Umanità del luogo non significa abbellimento. Umanità, abbiamo detto, è un termine‐ paradosso, e talvolta si rischia di generalizzare. Ogni uomo è diverso, è un portatore di cultura e di valori della propria società. Quindi, il comfort e l’ambiente devono accompagnare la persona. Sotto questa luce il rapporto tra i luoghi e il comportamento umano si infittiscono di preposizioni nuove e dove un tempo lo spazio conteneva, oggi invece deve condurre. L’ambiente. Lo abbiamo definito ambiente umano ed educatore, perché è stata esaltata un’architettura non convenzionale. Siamo, come già sottolineato, un ospedale giovane, per cui abbiamo avuto la possibilità di creare una struttura fisica‐architettonica diversa. L’ingresso al Policlinico è estremamente familiare. Le persone spesso ci dicono: “sembra di entrare in un centro commerciale”. Questo per via della galleria con vetrata, molto ampia, con i giardini laterali. L’uso del colore è stato molto importante: tutti colori pastello, colori in armonia, colori che ricordano la vita quotidiana, colori che troviamo all’interno delle nostre case. Per quanto riguarda le aree, abbiamo delle aree dedicate ai visitatori. Lo abbiamo già detto, lo ribadiamo: la famiglia ha un ruolo importante. L’ospedale non è un carcere e quando le persone vi entrano, in qualche modo noi stessi creiamo una muraglia tra chi è dentro e chi è fuori. Questo non lo vogliamo. Quindi, aree dedicate ai visitatori sul piano di degenza, che permettono di mantenere il contatto esterno. Le camere di degenza: si è privilegiato l’aspetto abitativo, la formazione e la comunicazione della cultura dell’abitare. Noi riteniamo che l’ambiente bello è garanzia di un buon lavoro per gli operatori e per tutti i cittadini. L’ambiente è di tutti, quindi a tutti sta il conservare il proprio patrimonio. Nelle aree dedicate tra le due degenze abbiamo una torre di nove piani. Su ogni piano ci sono due degenze e al centro quest’area visitatori, divisa in tre corpi: un corpo centrale, una sala privacy – che utilizziamo per gli incontri che richiedono una certa condizione di privacy, ad esempio con l’assistente sociale o la psicologa; oppure abbiamo dedicato un’area al culto, alla fede, non avendo uno spazio specifico centrale – ed infine l’area relax, dedicata alla famiglia, consentendo così ai familiari – soprattutto a quelli che vengono da fuori Regione – di poter sostare, riposare, garantendo la vicinanza fisica con i degenti. L’accoglienza: tutti noi in ospedale sperimentiamo un parziale disorientamento e desideriamo in qualche modo non sentirci esposti, avvicinare i propri confini, essere l’oggetto dell’attenzione di qualcuno e quindi essere tenuti all’interno di un palmo della mano. Tutti quanti, quando entriamo in un luogo nuovo, siamo disorientati. A maggior ragione se l’ingresso in questo luogo prevede un percorso di cura. Il malato deve trarre forza da se stesso e l’ambiente deve aiutarlo ad acquisire tale forza. Il malato è costretto a letto per buona parte del tempo, anche nei casi in cui non è 65 necessario. Da qui inizia la perdita dell’identità. È necessario realizzare – all’interno delle degenze – delle aree dedicate che permettano la socializzazione delle persone, che in qualche modo le facciano uscire dalla camera, per quanto possa essere bella, tecnologica, dotata di un aspetto abitativo. È quindi importante creare degli spazi di socializzazione: stare in compagnia, scambiarsi le esperienze, le informazioni. Gli orari dell’ospedale spesso hanno poco a che fare con la quotidianità. Gli orari di visita sono creati funzionalmente all’organizzazione, non per la famiglia. Noi abbiamo scelto di non avere un orario di visita prestabilito. All’inizio è stata una vera e propria rivoluzione culturale, soprattutto nei confronti degli operatori, ma col tempo ha consentito a tutti di comprendere come la famiglia diventava l’elemento strategico di cambiamento. Realizzare quindi la possibilità di una colazione non soltanto durante gli orari prestabiliti, ma consentirla nel soggiorno dei pazienti, perché possano accedere in qualsiasi momento della mattinata. “Luogo del secolo” dove ognuno ha la possibilità di separarsi dallo sguardo altrui. La nostra cappella ha dei richiami religiosi che ricordano il cattolicesimo, ma non vi sono simboli quali il crocifisso, proprio per permettere a tutti il raccoglimento, il silenzio. I luoghi della degenza permettono – anche nei momenti più importanti della propria privacy e della propria intimità – di poter accedere alle aree in maniera diversa. L’ospedale non è un albergo, non è una piscina, non è un Luna Park, però possiamo realizzare qualcosa di più protettivo attraverso la garanzia di un comfort diverso. Al Luna Park ci si distrae, noi invece vogliamo che le persone acquisiscano forza da se stesse, dall’ambiente e dunque si possano orientare. Qualità percepita. È uno degli aspetti importanti della nostra attività: capire – attraverso le analisi di soddisfazione del cliente – in quale direzione stiamo andando. Desidero citarvi alcuni dei nostri principali progetti, complementari a quelle che sono le attività cliniche: l’affettività delle cure ed il tocco‐massaggio sono progetti nati all’interno del nostro servizio o da iniziative del tutto personali di gruppi di colleghi, da noi appoggiate. Abbiamo un gruppo di infermieri che si organizza, si incontra, apprende tecniche di massaggio e di rilassamento e le somministra ai pazienti che lo desiderano. Il massaggio e l’affettività della cura possono creare rapporti intensi e profondi. È una tecnica che viene utilizzata moltissimo in ematologia. Il progetto “scrivere la cura”, partito recentemente, vede la parola come rimedio e come cura. A volte erigiamo delle dighe: sono una strategia a cui i sani ricorrono per difendersi dalla sinistra risonanza che suscita il lamento del malato. Si dà quindi la possibilità – non solo ai nostri clienti, ma anche agli operatori – di definire quelli che sono i propri sentimenti. Stiamo facendo strada alla “medicina narrativa”, che pone al centro della relazione terapeutica la costruzione di una trama narrativa dove si devono integrare l’oggettività biomedica e la soggettività dei vissuti, sia del paziente che delle persone che se ne prendono cura. Altro progetto – a cui tengo tantissimo, vi invito ad accedere al sito www.risponderealsilenzio.it e a rispondere all’appello che abbiamo lanciato come infermieri – è “rispondere al silenzio”. La Capitale – così come tutto il territorio – è stata spesso teatro di episodi di violenza sulle donne. I nostri Pronto Soccorso raccontano molte storie di questo tipo. Abbiamo creato un gruppo multidisciplinare all’interno dell’azienda al fine di costruire un percorso diverso per la donna che accede al Pronto Soccorso del nostro Policlinico a causa di violenze di qualsiasi natura. È un gruppo che si incontra ormai da un anno e mezzo. Nella “settimana della violenza” facciamo incontri formativi ai colleghi. Nel sito web da noi creato è presente un appello in cui chiediamo agli infermieri di aderire come categoria professionale per combattere questa grave problematica. “L’ospedale senza dolore”: è stato creato un comitato. Dolore significa cambiare attitudini e comportamenti degli operatori sanitari, perché il dolore deve diventare un evento non ineluttabile. Quindi, accompagnare, sostenere, alleviare, migliorare la qualità di vita. 66 Un altro progetto è il “gioco di squadra”: pensare il percorso di cura per i bambini attraverso il gioco, la formazione al personale, l’ambiente e la cura dei genitori. Il percorso è quello di alleviare in qualche modo le difficoltà dei piccoli utenti all’interno dell’azienda. Il “progetto NUR” è riferito alla funzione del “counselor interculturale”. La nostra è un’area con una forte presenza di persone provenienti dall’estero. Il “counselor interculturale” non è il “mediatore culturale”. È una situazione del tutto differente. Il “counselor” tratteggia il profilo dei due gruppi di appartenenza, sia dell’operatore che della persona che accede al servizio, in particolar modo al Pronto Soccorso. Il “counselor” deve rispondere alle aspettative e alle esigenze di comunicazione dell’operatore e deve domandare, accogliere e reinterpretare la diversità del paziente straniero. “Zaino di Babele” è l’ultimo progetto che vi presento: l’ospedale come crocevia di culture. È un incontro di formazione molto importante in cui i nostri “counselor” e psicologi invitano gli operatori che lo desiderano a provare ad indossare il burka per capire cosa sente, come vede e come vive la persona. Senza il coinvolgimento di tutti gli operatori non vi può essere reale miglioramento. Questa è la nostra radicata convinzione, per cui il percorso da fare è collettivo. Uno degli obiettivi principali del nostro servizio sta nel garantire il benessere degli operatori, ma questa è un’altra storia, che spero si affronterà in un altro momento, studiando il clima organizzativo dell’azienda. Siamo convinti che il mondo – anche questo terribile, intricato mondo di oggi – può essere conosciuto, interpretato, trasformato e messo al servizio dell’uomo, del suo benessere e della sua felicità. La lotta per questo obiettivo è una prova che può riempire degnamente una vita. Con questa riflessione e questo spunto vi ringrazio. 67 3° SESSIONE: Capo II – art. 8: “L’infermiere, nel caso di conflitti determinati da diverse visioni etiche, si impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo. Qualora vi fosse e persistesse una richiesta di attività in contrasto con i principi etici della professione e con i propri valori, si avvale della clausola di coscienza, facendosi garante delle prestazioni necessarie per l’incolumità e la vita dell’assistito”. Barbara Chiapusso (infermiere coordinatrice ASL TO 3 – Segretario Collegio IPASVi di Torino) Seconda Tavola rotonda di questo Convegno che vedrà coinvolto, come attivatore di riflessione, l’art. 8 del nostro Codice deontologico, che recita: “L’infermiere, nel caso di conflitti determinati da diverse visioni etiche, si impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo. Qualora vi fosse e persistesse una richiesta di attività in contrasto con i principi etici della professione e con i propri valori, si avvale della clausola di coscienza, facendosi garante delle prestazioni necessarie per l’incolumità e la vita dell’assistito.” Sicuramente sarà una Tavola rotonda impegnativa. Non per nulla avrete quindi la possibilità di leggere le domande che intendo rivolgere ai partecipanti sulle slides. Incomincerei – con grande piacere e con onore – invitando il professor Elvio Fassone che, attraverso la sua Lettura Magistrale, ci permetterà di addentrarci pienamente all’interno di questa Tavola rotonda. Obiezione di coscienza, clausola di coscienza e garanzia dell’assistenza – Lettura magistrale Elvio Fassone (Magistrato in quiescenza; Docente del corso di Dottorato in Sociologia del diritto ‐ Facoltà di Giurisprudenza) 1) la nozione di obiezione di coscienza Sotto un profilo filosofico‐morale l’obiezione di coscienza si configura come rifiuto di obbedienza ad una legge positiva in nome di una legge superiore. L’obiettore trasgredisce la legge degli uomini, o ne rifiuta l’osservanza, invocando il suo dovere di attenersi ad un comando che la trascende. Il modello classico di questo atteggiamento è rappresentato da Antigone, la quale ‐ professando obbedienza alle “leggi non scritte, inalterabili, fisse dagli dei: quelle che non oggi, non da ieri vivono, ma eterne: quelle che nessuno sa da quando comparvero” ‐ disobbedisce al divieto di Creonte di dare sepoltura al corpo del fratello ucciso. E la martirologia cristiana considera il primo obiettore di coscienza Massimiliano, che nel secondo secolo rifiutò di prestare servizio militare, poiché la sua fede gli vietava di portare le armi contro un altro uomo. 68 Il tratto comune a queste e ad altre numerose situazioni è il fatto che l’obiettore accetta la sanzione prevista a carico di chi non agisce in conformità del precetto. Egli non intende sottrarsi alle conseguenze previste per la sua disobbedienza, anzi cerca di dare ad esse il massimo risalto, per provocare una trasgressione diffusa, che porti alla cancellazione della legge positiva ritenuta ingiusta. Solo negli ultimi tempi l’obiezione di coscienza ha assunto anche una diversa intonazione, sotto il profilo giuridico. In questi casi circoscritti la sensibilità collettiva ha condotto alla legalizzazione dell’obiezione, cioè ad una autorizzazione a non osservare la legge positiva senza subire le conseguenze connesse all’inosservanza, ovvero subendone conseguenze molto miti. Si parla, in questi caso, di obiezione di coscienza legalmente riconosciuta. E’ evidente che un simile riconoscimento del primato della coscienza individuale deve essere usato dal legislatore con parsimonia e prudenza. Se si affidasse sempre al singolo la possibilità di invocare il suo personale giudizio, in nome dell’inviolabilità della coscienza, la legge verrebbe meno alla sua essenza, che è quella di esigere l’universale osservanza dei precetti legali. Tanto più in una moderna democrazia, nella quale si può presumere che una legge, per il fatto di promanare da un legislatore eletto liberamente da tutti i cittadini, sia conforme al sentire della maggioranza dei medesimi. 2) La normativa In effetti il legislatore ha legalizzato l’obiezione di coscienza in un numero molto limitato di casi. L’ha prevista a favore di chi rifiuta di prestare il servizio militare armato (legge 12 dicembre 1972, n. 772: peraltro questa legge conserva una sia pur lieve e diversa sanzione a carico dell’obiettore, rappresentata dalla maggior durata del servizio sostitutivo; essa prevede inoltre delle incompatibilità per chi detiene armi o ha compiuto reati di violenza). L’ha riconosciuta altresì al personale sanitario nel procedimento abortivo di cui alla legge 22 maggio 1978, n. 194, peraltro con due delimitazioni. Da un lato l’obiezione non esonera dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento. Dall’altro lato, “l’obiezione di coscienza non può essere invocata … quando, data la particolarità delle circostanze, il [loro] personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo”; e “si intende revocata se chi l’ha sollevata prenda parte a procedure o interventi per l’interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge” Ancora, l’obiezione di coscienza è riconosciuta dalla legge 12 ottobre 1993 n. 413, in materia di sperimentazioni sugli animali. Ed infine è riconosciuta dalla legge 19 febbraio 2004 n. 40, in tema di procreazione medicalmente assistita, la quale peraltro non esonera l’obiettore dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento. Non consta che vi siano altre situazioni legalizzate. Anzi, quando si è cercato di estenderne i confini invocando un’analogia di situazioni, la Corte Costituzionale ha opposto un rifiuto. E’ avvenuto quando il giudice tutelare, chiamato ad autorizzare la minore ad abortire secondo le procedure di cui alla citata legge n. 194 del 1978, ha chiesto che la legge gli riconosca il diritto all’obiezione di coscienza, che sarebbe garantita dagli articoli 2 (inviolabilità dei diritti fondamentali della persona, tra i quali quello di conformarsi alle proprie convinzioni profonde) e 19 (diritto di professare la propria fede religiosa). La Corte (con la sentenza del 25 maggio 1987, n. 196) ha dichiarato infondata l’eccezione osservando, quanto all’asserita disparità di trattamento rispetto al personale sanitario, che il giudice tutelare rimane esterno rispetto alla procedura di IVG, dovendo egli unicamente accertare il grado di maturità della minore; e quanto al diritto di conformarsi alla propria coscienza, la Corte 69 ha risposto che tale diritto va bilanciato con altri valori anch’essi di rango costituzionale, tra i quali, appunto, l’indefettibile esercizio della giurisdizione. Vi è stato, tuttavia, un ulteriore caso di obiezione di coscienza costruito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale: è accaduto a proposito del giuramento cui era chiamato il testimone nel giudizio penale e civile (le pronunce sono numerose: l’ultima è la n. 149 del 1995). La Corte ha preso le mosse dal principio di laicità, secondo il quale né lo Stato né la Chiesa possono utilizzare ciascuno il punto di vista dell’altro: la Chiesa non può pretendere di munire i suoi precetti morali della forza che promana dalla legge; lo Stato non può utilizzare la soggezione morale che deriva da una convinzione religiosa, al fine di rafforzare un proprio interesse, sia pure l’interesse istituzionale di ottenere dichiarazioni veritiere nei giudizi. In conseguenza, oggi, il testimone non “giura”, ma “si impegna” a dire la verità. Si tratta, quindi, di una situazione nella quale non è più necessario invocare il dettato della propria coscienza, nel caso specifico, poiché la stessa è già stata tutelata in via generale. 3) Conclusioni in tema di obiezione di coscienza In conclusione si può affermare che: a) le situazioni nelle quali l’obiezione di coscienza è riconosciuta sono soltanto quelle sancite espressamente da una disposizione di legge, e non è ammessa la creazione di altre situazioni per vie diverse da quella; b) anche là dove l’obiezione di coscienza è legalmente riconosciuta, l’esonero da una certa condotta viene meno quando ne conseguirebbe il pericolo per la vita di terzi, e c) il diritto all’esonero non si estende al di là delle attività strettamente involgenti il principio superiore invocato dall’obiettore. Non può, pertanto, essere invocata l’obiezione di coscienza, ad esempio, da parte del farmacista il quale si rifiuti di porre in vendita un determinato prodotto; né da parte del parlamentare il quale non accetti di votare in conformità della linea proclamata dal gruppo di appartenenza, su materie di particolare rilevanza (fermo restando, ovviamente, il suo diritto di votare secondo coscienza, una volta uscito dal gruppo); né da parte di un pubblico ufficiale che rifiuti di compiere o di ricevere un determinato atto, cui sia tenuto per legge. In tutti questi ed in consimili casi torna a valere la regola di Antigone: l’obiettore merita rispetto, se ed in quanto rivendichi il primato della propria coscienza, ma sia egli stesso, e non altri, a sopportare il prezzo della propria obiezione. Anche l’invito a praticare l’obiezione, che è accaduto di sentire da parte di autorità religiose, deve misurarsi con questa regola, che è conseguenza non eludibile del principio di laicità dello Stato. 4) I codici deontologici Il codice deontologico (in seguito: CD) è l’insieme delle regole etiche che un ceto professionale si dà per integrare la disciplina formale e legale che disciplina l’esercizio della professione. Poiché il diritto, per doverosa auto‐limitazione, rappresenta il minimo etico che disciplina un certo ambito di rapporti sociali, il CD è espressione della residua autonomia riconosciuta a quel gruppo sociale, e propone, di regola, un più alto livello di eticità nei comportamenti, dovuto alla sensibilità morale di quanti ne fanno parte. Il CD, in altri termini, si propone di far sì che la condotta dei professionisti cui si indirizza sia la più rispettosa possibile delle aspettative del cittadino che di quella attività deve servirsi, od alla quale deve sottostare. Conseguono alcuni corollari importanti. Il CD non può contenere disposizioni in contrasto con la legge positiva, altrimenti si autorizzerebbe un ceto professionale a farsi legislatore. Il CD vincola tutti gli esercenti quella professione, e può generare una loro responsabilità disciplinare in caso di inosservanza. Non può essere invocato a giustificazione di una violazione di legge, salvo che la stessa lo preveda facendo rinvio alle sue disposizioni. Può essere invocato per 70 rifiutare un’obbedienza gerarchica, quando l’ordine che sia esso stesso contrario alla legge od al CD Poiché il CD oggetto delle presenti riflessioni fa rinvio, in più parti, ai “diritti fondamentali dell’uomo” ed ai “principi etici della professione” (v. in particolare l’art. 5), è opportuno inquadrare il CD nella cornice normativa essenziale, al fine di dare un contenuto più concreto alle due locuzioni ora citate, nonché alla “clausola di coscienza”, che forma oggettoi specifico di queste riflessioni. 5) La Costituzione e le Convenzioni internazionali Nella materia che coinvolge il personale sanitario in genere, e l’infermiere in particolare, assumono rilevanza alcune disposizioni di rango costituzionale. La prima è l’art. 13 della Costituzione, il quale afferma il principio di portata generale, secondo il quale “la libertà personale è inviolabile”. La seconda è l’art. 32, il quale enuncia innanzi tutto il diritto dell’individuo alla salute ed alle cure, e quindi afferma il diritto all’autonomia del medesimo di fronte ai trattamenti sanitari (nei termini che saranno meglio esaminati più oltre). Queste disposizioni, illuminate entrambe dal principio generalissimo dell’art. 2 (“La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’individuo”) disegnano con chiarezza il principio di auto‐ determinazione dell’individuo. Accanto alla Costituzione, la materia riceve, poi, importanti indicazioni dalla Convenzione di Oviedo (propriamente “Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina”) stipulata a Oviedo il 4 aprile 1997. Essa garantisce ad ogni persona “il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti fondamentali” (art. 1); enuncia come regola generale che “Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato” (art. 5); e dispone che “i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento non è in grado di esprimere la sua volontà, saranno tenuti in considerazione” (art. 9). La Convenzione è stata ratificata dallo Stato italiano con legge 28 marzo 2001 n. 145, e quindi fa parte del nostro ordinamento giuridico. Per compiutezza della cornice, non si può non fare menzione del codice penale, che, sul punto, prevede i reati di lesione personale e di violenza privata, la cui anti‐giuridicità viene meno in presenza del consenso dell’interessato. 6) Il codice deontologico dell’infermiere Il CD in esame, varato nel gennaio del 2009, si differenzia in molte parti dall’omologo codice del maggio 1999. a) Nei primi tre articoli esso arricchisce il profilo professionale del professionista sanitario, e, ai fini che qui interessano, va ricordato come l’art. 3 ‐ che definisce la responsabilità dell’infermiere ‐ enuncia il principio generale secondo il quale lo stesso agisce “nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell’individuo”. Il dato rilevante è costituito dal fatto che i quattro beni elencati sono posti sul medesimo piano. Nulla è detto per il caso che due o più dei predetti valori entrino in contrasto tra di loro. b) Con il detto art. 3 si collega strettamente l’art. 5, il quale, riprende l’affermazione già presente nel testo del 1999, secondo la quale “il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e dei principi etici della professione è condizione essenziale per l’esercizio della professione infermieristica”. L’art. 5 non intende né elencare i diritti fondamentali, né costruire delle gerarchie tra di essi. Peraltro, data la subalternità del CD alla Costituzione ed alla legge, i diritti fondamentali vanno ricavati dalla cornice istituzionale delineata sopra. La coppia degli artt. 3 e 5, in sostanza, 71 finisce con l’effettuare un rinvio a quanto la scienza giuridico‐costituzionale ha elaborato in tema di diritti fondamentali della persona. c) L’art. 4, che nel testo del 1999 si limitava a chiedere all’infermiere di “[agire] tenendo conto dei valori religiosi, ideologici ed etici, nonché della cultura, etnia e sesso dell’individuo”, ora incornicia questo compito chiedendo all’infermiere di “presta[re] assistenza secondo equità e giustizia”, e di tenere conto “dei valori etici, religiosi, culturali, nonché del genere e delle condizioni sociali della persona” E’ significativo il fatto che è scomparso l’accenno ai “valori ideologici” ed all’“etnia” (fatto da valutarsi positivamente). Al posto della prima locuzione compaiono i “valori culturali”; al posto della seconda “le condizioni sociali”. Desta invece qualche perplessità il fatto che ieri il testo era tutto ‐ e giustamente ‐ centrato sul dovere di “tener conto” dei vari fattori elencati; vale a dire poneva il baricentro nelle esigenze della persona assistita, salva la considerazione che il “tener conto” non può essere inteso come un imperativo assoluto. Nel codice attuale, invece, questa priorità tendenziale deve misurarsi con dei vaghi e non ben definiti “principi di equità e di giustizia”. A giudizio di chi scrive, questa vaghezza, per la sua attitudine ad essere riempita da valutazioni soggettive molto labili, non può prevalere sui valori della persona enunciati dall’articolo stesso, dei quali l’infermiere deve “tenere conto”. Equità e giustizia possono soccorrere solo quando i predetti valori non sono coinvolti direttamente nella questione (ad esempio, nel riconoscere o meno una precedenza, nel praticare per giusti motivi un trattamento differenziato, nell’acconsentire ad un’abitudine o ad una credenza che non abbia controindicazioni, ecc.). d) Particolare attenzione meritano vari articoli del CD, che sottolineano concordemente il principio di autonomia dell’assistito. L’art. 7 afferma che “L’infermiere orienta la sua azione al bene dell’assistito …sostenendolo nel raggiungimento della maggiore autonomia possibile”. L’art. 25 stabilisce che “l’infermiere rispetta la consapevole ed esplicita volontà dell’assistito di non essere informato sul suo stato di salute …” L’art. 36 ‐ fondamentale nella disamina in oggetto ‐ dispone che “l’infermiere tutela la volontà dell’assistito di porre dei limiti agli interventi che non siano proporzionati alla sua condizione clinica e coerenti con la concezione da lui espressa della qualità della vita”. L’art. 37, non meno importante, afferma che “l’infermiere, quando l’assistito non è in grado di manifestare la propria volontà, tiene conto di quanto da lui chiaramente espresso in precedenza e documentato”. Vi è quindi un ricco contesto che soccorre nella disamina del punto nodale delle presenti riflessioni, costituito dall’art. 8. e) L’articolo 8 presenta notevoli innovazioni rispetto al CD del 1999. Esso si occupa di conflitti, che ieri erano “determinati da profonde diversità etiche”, oggi da “diverse visioni etiche”. I termini si prestano a riserve, poiché il parlare di “visioni etiche” è linguaggio piuttosto vago e meta‐giuridico. Ma quel che comunque va posto in rilievo è il fatto che si è voluto estendere l’area del conflitto coinvolgente la coscienza: ieri si richiedevano “profonde diversità”, oggi è sufficiente una “diversa visione”. Questa prima considerazione si lega con la modifica dell’ultima parte dell’articolo, perché ieri si consentiva all’infermiere di “avvale[rsi] dell’obiezione di coscienza”; oggi si è preso atto che l’obiezione di coscienza non può essere introdotta da un codice deontologico, né può essere invocata ad libitum del personale (cfr. il punto 3), e si è introdotta una nuova locuzione, prevedendo una “clausola di coscienza” . Si tratta di vedere quale praticabilità riveste tale clausola. 72 7) La clausola di coscienza Il punto di partenza, a giudizio di chi scrive, deve essere rappresentato dalla situazione che può fare insorgere la clausola di coscienza. Secondo il CD del 1999, l’infermiere doveva trovarsi di fronte ad una “volontà profondamente in contrasto con i principi etici della professione e con la coscienza personale”. Secondo il CD del 2009, deve trattarsi di una “richiesta di attività”, anch’essa in contrasto con i principi etici della professione e (è importante l’uso della congiunzione in luogo della disgiuntiva) “con i propri valori”. Poiché l’art. 8 ha avuto una laboriosa gestazione, si deve ritenere che il risultato finale non sia casuale. Con la nuova formulazione si è voluto ridurre la forza della richiesta, ampliandone l’area; si è attenuata l’entità del contrasto poiché è scomparso l’avverbio “profondamente”; e si è ampliato l’orizzonte valoriale invocabile, posto che alla “coscienza” si sostituiscono i “propri valori”. Riassumendo, sembra potersi dire che, da un lato, si è abbandonato il richiamo all’obiezione di coscienza, e dall’altro lato si è allargata l’area delle situazioni considerate. Si tratta allora di esaminare quale è la “richiesta” alla quale l’infermiere può non dare esecuzione, senza poter invocare una vera e propria obiezione di coscienza. Schematizzando si può prevedere che la richiesta provenga a) da un soggetto munito di un’autorità prevalente, b) dall’assistito, c) da una terza persona. 7.a) Richiesta proveniente da soggetto sovra‐ordinato Nel primo caso (questa “autorità prevalente” non deve necessariamente configurare una subordinazione gerarchica, ma è comunque tale che l’infermiere deve dare ad essa esecuzione), il CD non contiene nessuna disposizione che regoli le eventuali problematiche nascenti da questo tipo di subalternità, mentre abbiamo visto essere numerose le disposizioni che regolano il rapporto dell’infermiere con la volontà dell’assistito. Appare pertanto corretto rifarsi all’unico modello ricavabile in argomento, che è quello descritto dal testo unico delle disposizioni sul pubblico impiego: esso non si applica direttamente alla situazione in esame, ma offre comunque uno schema utilizzabile. L’art. 17 del predetto testo unico (d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3) stabilisce che “l’impiegato, al quale venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza, dichiarandone le ragioni. Se l’ordine è rinnovato per iscritto, l’impiegato ha il dovere di darvi esecuzione. L’impiegato non deve comunque eseguire l’ordine del superiore quando l’atto sia vietato dalla legge penale”. Poiché la norma non esige che l’ordine sia palesemente illegittimo, ma che l’impiegato lo ritenga tale, si può ravvisare un primo spazio per la clausola di coscienza. Se l’ordine entra in tensione con qualcuna delle disposizioni di cui si è fatta menzione, e segnatamente con gli artt. 36 e 37 del CD, l’infermiere ben può invocare la clausola di coscienza, poiché non si tratta di recuperare surrettiziamente un’obiezione di coscienza non prevista, ma di giustificare l’opinione (il “ritenga”) che la richiesta sia illegittima. Alla stessa stregua, la clausola può essere invocata quando la richiesta si traduca in un’ingiustificata e grave riduzione della garanzia di assistenza. Questo tuttavia non risolve il problema qualora l’ordine venga ribadito per iscritto (pur non trascurandosi che l’insistenza di fronte ad un’argomentata contestazione può avere conseguenze per colui che conferma l’ordine). La domanda si sposta allora sul secondo versante del “modello”, e cioè sulla valutazione se quell’ordine integri addirittura un illecito penale, e quindi giustifichi la non esecuzione. 73 7.b) Il consenso informato e l’auto‐determinazione La risposta è delicata e si deve procedere con molta prudenza. Tuttavia alcuni punti fermi possono essere proposti. La scienza medica ha progressivamente acquisito coscienza che gli operatori non dispongono più illimitatamente del paziente, siccome depositari di una conoscenza che egli non ha, e che ‐ secondo un precedente modo di pensare ‐ abilitava i depositari della scienza ad agire uti domini nei confronti del bisognoso di cure. L’asimmetria informativa oggi deve essere colmata attraverso il consenso informato, vale a dire attraverso una trasmissione delle conoscenze essenziali al caso, cosicché l’assistito possa esprimere una volontà consapevole (beninteso nel caso in cui egli sia in grado di farlo). Questa regola trova ormai un presidio formale nelle citate disposizioni della Costituzione e della Convenzione di Oviedo. In particolare, l’art. 32 Cost. offre sostegno al principio di auto‐determinazione dell’assistito. Il secondo comma della norma, infatti, si articola in tre disposizioni successive. Con la prima (“Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario”) si enuncia il principio, il quale, come si è anticipato, è un corollario specifico dell’inviolabilità della libertà personale, sancita dall’art. 13. Con la seconda proposizione (“… se non per disposizione di legge”) si introduce l’eccezione al principio, circoscrivendola sia in ordine allo strumento usato (la legge) sia in funzione dell’interesse che giustifica l’eccezione, e che deve essere un interesse generale: si può pensare alle vaccinazioni, alla quarantena, al trattamento della malattia mentale, e simili. Con la terza proposizione (“la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”) si introduce un secondo principio, rafforzativo del primo. Anche quando la legge e l’interesse generale legittimano un’invasione della sfera privata, deve essere fatto salvo il rispetto della persona: il trattamento, cioè, non deve essere troppo invasivo, non può violare il pudore senza adeguate cautele, non può protrarre la restrizione della libertà oltre lo stretto indispensabile, non può sacrificare la dignità dell’individuo. Alcuni ritengono che l’art. 32 debba avere altra lettura. La terza proposizione ‐ affermano ‐ funge in realtà da recupero e dilatazione della seconda: la legge, cioè, può giustificare il trattamento sanitario coatto non solo in funzione di un interesse generale, ma anche per opporsi al sacrificio della vita, sebbene questo sia chiesto e voluto dal titolare della medesima. Una simile volontà ‐ si afferma ‐ offenderebbe “il rispetto della persona”, il quale è un bene di cui l’individuo non può disporre. Di più: il primo comma dell’art. 32, nel considerare la salute come un interesse generale, fa sì che nessuno può obbligare l’individuo a ricorrere alle cure mediche, ma quando egli richiede un intervento di cura, perde la sovranità sia sulla gestione delle cure stesse, sia su se medesimo, perché gli autori delle cure sono tenuti in ogni caso e modo alla preservazione della sua vita sino a che la scienza lo rende possibile. A giudizio di chi scrive, queste tesi non hanno sostegno nella Costituzione, anzi da essa ricevono smentita. La terza proposizione della quale si è detto (la salvezza in ogni caso del rispetto della persona) non funge da restrizione del principio generale (l’auto‐determinazione), ma, al contrario, da restrizione dell’eccezione (l’intervento della legge). Proprio la progressione concettuale interna al comma, e proprio la ripresa della stessa parola (“la legge”) dimostra che il rapporto “principio ‐ deroga” viene confermato, attraverso un contenimento della deroga, e non attraverso una sua riduzione. Né il primo comma dell’art. 32 può trasformare un diritto in una soggezione, tanto più che questa soggezione è espressamente contemplata, e circoscritta, nel secondo comma. D’altronde il lessico della Costituzione è univoco: mentre in più articoli compare l’aggettivo “inviolabile” (e tra questi l’art. 13 che tutela la libertà personale) a significare che nessun estraneo 74 può offendere quel diritto, in nessuna norma compare l’aggettivo “indisponibile”, a significare che quel diritto è sottratto anche alla disponibilità del suo titolare. Dunque, se la condizione del singolo non ha riflessi sulla salute di altri, nessun trattamento sanitario può essere imposto o praticato al di fuori del suo consenso. Il dettato costituzionale, poi, è ribadito e precisato dalla ricordata Convenzione di Oviedo, la quale sancisce l’importanza del consenso informato e il primato della volontà della persona assistita. Si può allora ricavare un primo indirizzo in merito alla clausola di coscienza ed all’esecuzione o meno della “richiesta”. Il principio di auto‐determinazione dell’assistito comporta che ogni intervento sulla sua persona diventa illecito qualora non sia preceduto dal consenso: e si tratta di un illecito penale, poiché l’intervento non consentito può integrare, secondo i casi, i reati di lesioni o di violenza privata. Diversa è la situazione (e la si esamina solo di scorcio, per completezza) quando la richiesta, proveniente da soggetti sovra‐ordinati, non attiene ai principi fondamentali: ad esempio, quando essa si risolve in un de‐mansionamento dell’infermiere che non sia occasionale ma assiduo; o un utilizzo improprio delle sue competenze professionali; o quando si tratta di una richiesta di sovra‐ prestazioni in via sistematica, a causa di carenze organizzative. In tutti questi ed in simili casi non viene in considerazione la clausola di coscienza, poiché non si tratta di “diverse visioni etiche”, ma di un contenzioso attinente lo statuto di quel lavoratore, che potrà e dovrà essere risolto secondo le procedure ad esso dedicate. Diverso, invece, e pertinente alla materia in esame, è il caso di richieste non occasionali di azioni professionali da effettuarsi nell’impossibilità di garantire standard assistenziali adeguati: in questo caso la clausola di coscienza può essere invocata, perché non introduce una vera e propria “obiezione”, ma rende giustificato il rifiuto; anche se, a ben guardare, non sarebbe neppure necessario fare ricorso alla clausola di coscienza, poiché soccorre già il principio etico della “prudenza al fine di non nuocere”, ricavabile dall’art. 9; e soprattutto soccorre la liceità del rifiuto quando la richiesta può generare una responsabilità di tipo penale. In questa prospettiva trova risalto la “garanzia di assistenza” che costituisce il terzo elemento del trinomio oggetto delle presenti considerazioni. 8) La “richiesta di attività” proveniente dall’assistito Non meno delicato è il problema della opponibilità della clausola di coscienza quando la richiesta di attività provenga dall’assistito. L’art. 8 del CD considera una “richiesta di attività in contrasto con i principi etici della professione” (accantoniamo, per ora, i “propri valori”), e questi principi sono ricavabili dall’art. 5, subentrato all’art. 2 del precedente CD, il quale elenca dapprima “i diritti fondamentali dell’uomo” e subito dopo gli anzidetti “principi etici”. Ne segue che la richiesta dell’assistito ha un valore preminente quando attiene al rispetto dei propri diritti fondamentali. Ha ancora lo stesso valore prevalente quando attiene ai “principi etici” che siano coerenti, e non antagonisti, rispetto a quei diritti fondamentali. Non ha valore prevalente quando esorbiti da questi ambiti. Esemplificando, la richiesta dell’assistito non può essere inascoltata, attraverso la clausola di coscienza, quando attiene alla vita, alla libertà, o alla dignità della persona. Non ha, invece, valore prevalente quando è estranea a questo ambito: ad esempio la richiesta di un’alimentazione dannosa, o di una ambulazione sconsiderata, o di assunzione eccessiva di medicinale, o di visite fuori orario senza giusto motivo, o simili. E non ha valore prevalente nemmeno una richiesta che attenga alla sfera dei diritti di un’altra persona: ad esempio, il rifiuto di una trasfusione di sangue relativa al proprio figlio minore (con ciò si offre un principio di risposta anche in ordine alla terza situazione considerata in astratto, e cioè alla richiesta che provenga da un terzo). 75 9) I “propri valori” Ma gli interrogativi posti dall’art. 8 non sono esauriti. Se è abbastanza agevole trovare uno spazio alla clausola di coscienza quando la richiesta contrasta con i “principi etici della professione” (ed a maggior ragione con i diritti fondamentali della persona, tutelati da norme di rango superiore), più difficile è la risposta quando la richiesta sia in contrasto con i “valori” propri dell’infermiere. Per evitare che questa locuzione rappresenti un doppione della precedente, è giocoforza supporre che questi valori siano diversi da quelli assunti dal CD, e cioè siano valori personali, anziché oggettivi o universali. Anche la congiunzione “e”, che lega principi etici e valori propri, sembra voler dire che valori non rientranti fra quelli assunti dal CD non sono, di per sé, da prendere in considerazione. Se così è ‐ e la logica non consente altra interpretazione ‐ questa parte dell’art. 8 finisce con l’essere vuota di contenuto effettivo. In effetti, ricapitolando quanto sin qui detto, abbiamo visto (par. 3) che l’obiezione di coscienza non può essere invocata al di fuori dei casi espressamente considerati dalla legge; e la modifica apportata dal nuovo CD rispetto a quello del 1999 ne dimostra la consapevolezza. Abbiamo ritenuto, al contrario, che l’infermiere può utilmente invocare i “principi etici della professione”, e che tali principi gli offrono scudo contro le richieste che vanno contro tali principi. Non sembra ‐ a giudizio di chi scrive ‐ che vi sia spazio per dei “valori” soggettivi che non ricevano già copertura dai principi etici: ove si pensasse diversamente, si aprirebbe la strada non a ulteriori valori, ma a semplici convinzioni individuali, per quanto radicate e forti nel loro portatore. La grande ricchezza ed articolazione del CD rende difficile ipotizzare una richiesta “ingiusta” (definiamola in tal modo per brevità di linguaggio) alla quale non sia possibile opporre il rifiuto utilizzando il CD, senza necessità di ricorrere ad altre giustificazioni soggettive: la richiesta, ad esempio, di un trattamento sbrigativo o poco diligente nei confronti di una persona perché si tratta di un delinquente, o di un anziano, o di un nullatenente, o di un islamico, o di un rivoltoso, o simili, trova già ampio contrasto nei principi di equità e giustizia, contemplati nell’art. 4. Lo stesso può dirsi per una richiesta di eccessivo rigore (ad esempio in tema di visite) perché l’assistito è omosessuale o convivente o seguace di altra confessione religiosa. Ancora meno la clausola di coscienza può giustificare un rifiuto di esecuzione quando la richiesta attiene ad uno dei diritti fondamentali, in particolare nella delicata materia del fine vita. In questa materia, che richiede un supplemento di valutazione specifica, il CD enuncia dei principi di grande rilievo negli artt. 36 e 37, già ricordati: per cui, o la richiesta (di un terzo) va in direzione contraria alla volontà dell’assistito, ed in tal caso è sufficiente invocare i diritti fondamentali ed i principi etici contenuti nel CD; ovvero è l’infermiere che ritiene di non poter dare esecuzione alla volontà dell’assistito, ed allora i suoi “valori” personali non possono prevalere sull’obbligo professionale di rispettare “la concezione da lui [dall’assistito] espressa della qualità della vita”. 10) La “qualità della vita” L’art. 36 del CD, la cui disamina è indispensabile al fine di completare le valutazioni relative alla clausola di coscienza, risente dell’ampio dibattito che è in corso da tempo sulla “qualità della vita”, che espressamente richiama. I termini essenziali del dibattito sono noti, ma può essere utili richiamarli sinteticamente. Innanzi tutto, si sta affermando la consapevolezza che la morte non è un fatto istantaneo, ma un processo. L’essere umano non muore tutto nello stesso momento. Alcune sue parti possono necrotizzarsi prima che si verifichi la morte, quale oggi individuata nel momento in cui l’attività cerebrale è del tutto spenta; altre continuano a vivere dopo la medesima, come i capelli, le unghie ed altro ancora. 76 Dunque il momento della morte è convenzionale. E di riflesso è convenzionale la nozione di “vita” che la precede. Di qui la possibilità di nozioni diverse dell’essenza della vita. Secondo un certo orientamento di pensiero, la vita è sacra ed inviolabile a qualunque livello essa si esprima. La vita dell’essere umano è un investimento di Dio, e perciò va preservata sempre, in qualsiasi forma essa si manifesti. Essendo sacra, in quanto dono ab externo, la vita non è disponibile nemmeno dal suo titolare. Questa concezione intende la vita come “vita biologica” (per i Greci: “zoé”). E’ vita quella di un organismo che funziona, non importa a quale regime. Secondo un diverso orientamento, la vita è essenzialmente “relazione”. Prescindendo da un’ottica atea, ed anche accettando l’impostazione religiosa che vede nella vita un investimento di Dio, la vita umana è il culmine della creazione, e quindi non è solamente il funzionamento di un organismo, ma è lo specifico che lo distingue dagli altri organismi. La vita dell’uomo (e ovviamente della donna) è la narrazione della sua storia, del suo carattere, delle sue aspirazioni, dei suoi progetti, del suo sentire, delle sue relazioni. Si tratta non di una vita biologica, ma di una vita “biografica” (per i Greci: “bios”). Mentre per la precedente concezione è rilevante essere in vita, per questa è significativo avere una vita. Per conseguenza, la vita è inviolabile finché è storia. Dopo, essa rimane inviolabile dai terzi, ma diventa rinunciabile dal suo titolare. 11) Il diritto e le strategie di convivenza Il conflitto tra le due etiche non è componibile sul piano filosofico. “Sacralità” della vita e “qualità” della vita riflettono visioni del mondo irriducibili, postulati non dimostrabili e quindi inidonei a prevalere l’uno sull’altro. Entrambe le etiche assumono come valore primario la dignità suprema della vita. Ma divergono non appena scendono a specificare di quale vita si sta parlando. E la nozione di vita, come si è detto, è diventata convenzionale. Né una legge ordinaria, né tanto meno un codice deontologico hanno titolo per prendere posizione al riguardo. Compito del diritto, in ambiti relativi ai principi fondamentali dell’esistenza, non è quello di sancire il primato di una o di un’altra visione del mondo, ma quello di elaborare delle “strategie di convivenza”. Se nessuna di esse può dimostrare la propria preferibilità, il possibile punto di equilibrio non può risiedere che nell’affidare al singolo la scelta, e nel tutelarla contro ogni pretesa contraria. A chi afferma la sacralità della vita, quale che sia il regime al quale essa è ridotta, nessuno potrà imporre che quella vita non è degna di essere vissuta, e quindi può essere soppressa. A chi, viceversa, rifiuta una vita che non è più storia né relazione, ma solamente condizione vegetativa o intollerabilmente dolorosa, nessuno potrà imporre che quella vita deve essere comunque preservata anche contro il suo volere. Se il diritto non deve far propria alcuna etica e non deve essere servente di alcuna ideologia, allora il diritto può e deve accordare tutela all’unico bene non controvertibile, e cioè la libertà di opzione del singolo individuo tra le varie visioni etiche. Il codice deontologico, nel richiedere la tutela della volontà dell’assistito in merito alla concezione da lui espressa sulla qualità della vita, vuoi attualmente (art. 36), vuoi in precedenza (art. 37), mostra di uniformarsi a questa equilibrata saggezza. E assumendo questa linea a “principio etico” della professione, offre un’indicazione esauriente per risolvere i problemi che possono scaturire dalla clausola di coscienza in questa delicata materia. 77 Tavola rotonda: A garanzia dei valori personali degli attori: persona assistita, professionisti Barbara Chiapusso (infermiere coordinatrice ASL TO 3 – Segretario Collegio IPASVi di Torino) Grazie, professore. Sicuramente è riuscito a creare la piattaforma sulla quale adesso ragioneremo con i partecipanti alla Tavola rotonda. Ho cercato di riassumere quelli che sono i concetti importanti emersi durante la sua relazione, concetti che ora svilupperemo. In particolare la volontà dell’assistito, il primato dell’autodeterminazione o libertà e – come lei ha giustamente sottolineato – il conflitto e soprattutto le visioni delle due etiche, etica come sacralità della vita, etica come qualità della vita e quindi essere in vita e avere una vita. Di questo la ringrazio molto. Comincerei invitando – in mero ordine alfabetico – i partecipanti alla Tavola rotonda: la signorina Rosalia Buttà, coordinatrice infermieristica; il dottor Francesco Casile, operatore professionale dirigente; il dottor Ottavio Davini, direttore sanitario di questa Azienda; il dottor avvocato Dario Gamba, consulente legale del nostro Collegio infermieristico; il professor Maurizio Mori, direttore del master di bioetica dell’Università di Torino; la dottoressa Cinzia Sanserverino, tutor clinico e docente di infermieristica ed infine il professor don Giuseppe Zeppegno, direttore del master universitario in bioetica della Facoltà Teologica di Torino. Desidero focalizzare l’attenzione su un aspetto importante: nel momento in cui ci avviciniamo al tema dell’etica – e soprattutto ci avviciniamo al tema dell’etica della cura – cerchiamo in qualche modo di sfidare il dogmatismo della ragione. Noi siamo abituati, come esseri umani, a ragionare per semplificazione e cerchiamo sempre delle risposte univoche, delle regole che ci permettano di 78 poter così rispondere ai problemi che incontriamo nella pratica. In realtà, come è stato detto dal professor Fassone, oggi risposte intese come certezze non riusciremo a darne. Tanto è vero che l’obiettivo di questa Tavola rotonda è proprio quello di fissare un time‐out per ragionare su temi così complessi e poco inclini ad una soluzione definitiva, consentendoci di portare nelle nostre realtà operative i contenuti che emergeranno. Dunque, obiezione di coscienza. Nel momento in cui parliamo di obiezione di coscienza la nostra mente va alla legge 194 o anche legge meglio conosciuta come “interruzione volontaria di gravidanza”. Tutto ci sembra apparentemente chiaro e giuridicamente tutelato: abbiamo una legge che dice come dobbiamo comportarci. In realtà non sembrerebbe essere così e adesso lo chiederemo in modo particolare all’avvocato Gamba. Tanto è vero che, facendo riferimento all’art. 9 della legge 194 – in cui vengono suddivise le procedure e attività dirette a determinare l’interruzione di gravidanza da quelle assistenziali antecedenti e conseguenti all’intervento – cercheremo di capire, attraverso il suo intervento, quali siano oggi le interpretazioni più consolidate. Anche perché, durante la mia attività svolta in Collegio, non nascondo di aver ricevuto delle domande da parte di colleghi che chiedevano quando ci si possa avvalere dell’obiezione di coscienza e quando invece no. Quindi, interpretazione restrittiva o interpretazione estensiva? Dario Gamba (Avvocato, Consulente legale Collegio IPASVI di Torino) In effetti questo è un grosso problema. Esso nasce dal fatto che il diritto vivente su questo tema è abbastanza latitante, nel senso che è un tema che, per la sua complessità, lascerebbe intendere che ci siano centinaia di precedenti giudiziari. Trattasi del reato di chi si rifiuta di prestare assistenza ad un paziente che ne ha diritto in base al prima citato art. 32 della Costituzione: il paziente pretensivo chiede, autodeterminandosi, un servizio; ha il diritto ad abortire perché glielo consente la legge, un diritto costituzionalmente garantito perché si fa risalire all’art. 32 della Costituzione. L’operatore ha un altro diritto costituzionalmente garantito, che è quello di esprimere liberamente e di comportarsi di conseguenza in relazione al proprio modo di pensare e al proprio impianto ideologico. Ebbene, la contemperazione di questi due interessi è il problema giuridico generale e bisogna decidere, in termini calcistici, chi vince. La legge sull’obiezione di coscienza lo ha fatto, ma lo ha fatto in termini non esaustivi, forse perché quando il legislatore si occupa di un tema così pregnante subentra una sorta di remora. Noi abbiamo diverse leggi nel nostro ordinamento che hanno un incipit aperto, cioè lasciano al diritto vivente – ossia a ciò che accade in concreto – l’arduo compito di porre il punto, lo stato dell’arte. È evidente che tale punto cambi in modo estremamente repentino. Da un giorno all’altro, da un posto all’altro io posso ottenere un precedente giudiziario che mi sposta i termini del discorso. Questo relativismo assoluto lasciato da uno spazio normativo sicuramente non aiuta la certezza del diritto. Infatti, “gli atti necessariamente diretti a provocare l’interruzione volontaria di gravidanza” è la stessa dicitura che viene ripresa dalla legge sulla procreazione medicalmente assistita, legge molto più recente. Ma, anche in questo caso, il legislatore non se la sente di andare oltre. Riprende l’identica terminologia che aveva già creato vent’anni di dibattito e afferma: “si può obiettare agli atti che sono necessari e diretti a determinare la procreazione assistita”, rimandando al dibattito culturale e giuridico, rimandando, in sostanza, all’attività sul campo. Noi siamo, da questo punto di vista, appesi ad una sentenza. L’unico precedente 79 giudiziario che c’è stato in materia di individuazione di “quali siano gli atti ai quali si può obiettare oppure no”, ai sensi dell’art. 9 della legge sull’IVG, è stata una sentenza del 1983 del Pretore di Penne. È l’unico precedente giudiziario che abbiamo. Il Pretore di Penne dice: “giustissimo condannare – siamo in ambito penale – per omissione di atti d’ufficio, 328 del codice penale, un’infermiera che si è rifiutata di preparare il campo sterile per l’inserimento di una candeletta, quella dilatatoria, atto che si fa in vista dell’interruzione volontaria di gravidanza.” Questo è il Pretore di Penne, nel 1983. Poi più nulla. È lo stesso Pretore che aveva fatto la prima sentenza dove imponeva ad un’ ASL di somministrare la cura Di Bella. La cosa stupefacente è che poi non è successo più niente. È mai possibile che non si sia più ripresentato il problema e non sia stato portato nelle aule di giustizia? Perché questo è un reato perseguibile d’ufficio. Qualsiasi magistrato, qualsiasi PM che venga a conoscenza – tramite la Direzione sanitaria o per via di una lettera anonima – del fatto che qualcuno si è rifiutato di compiere quegli atti assistenziali di contorno che devono essere fatti nell’IVG – interpretando estensivamente la norma dell’art. 9 – deve esercitare l’azione penale e sottoporre il sanitario a processo. Non è successo più nulla, tranne che nel 1983. L’altro fronte che si sarebbe potuto aprire, ma che non si è aperto, è quello davanti al giudice del lavoro, perché è evidente che se sono inserito in un contesto lavorativo pubblicistico devo erogare il servizio. Se mi rifiuto di eseguire un ordine del superiore gerarchico vengo sottoposto immediatamente a procedimento disciplinare. Come mai non ci sono sentenze dei giudici del lavoro aditi da chi veniva ingiustamente licenziato, sanzionato disciplinarmente perché aveva interpretato troppo estensivamente questa norma sugli atti avverso i quali si può fare obiezione di coscienza? Anche questo è un mistero. Forse perché il problema è così scottante che nessuno se la sente di stressarlo fino alle estreme conseguenze, perché poi, dal punto di vista giuslavoristico, si trova il sostituto che risolve il problema. Dal punto di vista penalistico, se non è l’interessato a denunciare, ebbene, forse la Procura della Repubblica è impegnata in cose ritenute più importanti come le stragi, la mafia e quant’altro, e non ha la sensibilità di partire d’ufficio su una questione di questo tipo. Queste possono essere le ragioni che determinano questo diritto vivente così latitante. Ripeto: l’unico precedente che abbiamo è quello del Pretore di Penne che dice “il campo sterile va preparato”. E tutto il resto? Ci sono notizie di obiezione di coscienza esercitate sul prelievo di sangue finalizzato all’interruzione di gravidanza e tutta una serie di altri atti che sono di contorno, ma sono inequivocabilmente all’interno di un procedimento di IVG, così come la stessa preparazione del letto è all’interno di un procedimento di IVG. Che cos’è dunque assistenziale, prodromico e successivo? Che cos’è un atto diretto? Nessuno ce lo dice. Lo dobbiamo individuare al momento e sarà quel povero giudice che dovrà stabilire qual è l’equilibrio. Noi abbiamo un nocciolo, “ procedure e attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza” – IVG, procreazione medicalmente assistita – e poi abbiamo un contorno molto sfumato, di difficile individuazione. Si tratterà di porre – anche qui in termini un po’ calcistici, ma efficaci – il giusto equilibrio tra quei due interessi contrapposti: quello del paziente ad essere assistito e quello dell’operatore ad agire. E sarà probabilmente oggetto di future sentenze, sempre che il problema assurga a livello giudiziario. Comunque sia, oggi registriamo un vuoto abbastanza assoluto. 80 Barbara Chiapusso (infermiere coordinatrice ASL TO 3 – Segretario Collegio IPASVi di Torino) È come immaginavo, anche perché, per preparare i contenuti di questa Tavola rotonda, ho letto del materiale in merito. Sapevo che non ci sarebbe stata un’interpretazione univoca che, in qualche modo, ci avrebbe potuto aiutare nel dire “questo lo posso fare e questo non lo posso fare” e mi pare di capire che tu l’abbia confermato. Dario Gamba (Avvocato, Consulente legale Collegio IPASVI di Torino) Sì. In termini sanzionatori si può dire che laddove non c’è sanzione non c’è responsabilità, e quindi si potrebbe dire che è una zona commandos, dove comunque la scelta è una scelta personale, soggettiva, seguendo i propri valori ed il rischio concreto – da un punto di vista giudiziario – statisticamente è vicino allo zero. Non è certamente la mia un’istigazione a delinquere. È soltanto un registrare uno stato dell’arte tecnico‐pratico, tutto forense. Poi ci saranno sicuramente altri argomenti che emergeranno nel corso della Tavola rotonda. Barbara Chiapusso (infermiere coordinatrice ASL TO 3 – Segretario Collegio IPASVi di Torino) Vale la pena sottolineare come, pur essendo un terreno giuridicamente protetto, sia comunque un terreno friabile, nel senso che siamo partiti dall’obiezione proprio perché era giuridicamente tutelata, e in realtà risposte univoche non credo riusciremo a portarle a casa. Proprio perché non riusciamo a portare a casa un’interpretazione univoca da un punto di vista giuridico, do la parola al professor Zeppegno e al professor Mori. Quali possono essere le indicazioni che la disciplina dell’etica può fornirci per cercare di superare questi eventuali conflitti? Giuseppe Zeppegno (Direttore scientifico del Master Universitario in Bioetica della Facoltà Teologica) Sottolineo, in riferimento al precedente intervento, la difficoltà che l’art. 9 della legge 194 pone per gli obiettori di coscienza, in quanto può essere facile per un obiettore di coscienza dare assistenza conseguente all’intervento: in questo caso non c’è più il problema dell’aborto, ma di una donna che soffre e che quindi va aiutata. È molto più problematica invece la dimensione antecedente e in questo senso nel 1983 ci fu un altro 81 pronunciamento: è la sentenza 428 del Consiglio di Stato che affermò la possibilità da parte di operatori sanitari di non eseguire esami di sangue preordinati ad un intervento di interruzione di gravidanza. Però, come veniva giustamente detto, sono situazioni non sufficientemente legiferate e quindi lasciano sempre molto spazio all’interpretazione dei singoli giudici e spesso non si ricorre al giudice, in questi casi. C’è però un’esigenza che mi pare fondante e fondamentale, che deve coinvolgere tutti gli operatori sanitari ed è cioè quella di poter agire secondo coscienza. Cosa significa agire secondo coscienza? Significa avere la disponibilità nel poter fare riferimento al proprio mondo valoriale. Chi non fa riferimento al proprio mondo valoriale e agisce indipendentemente dalla sua coscienza, credo che rischi di perdere di dignità e di libertà. In questo senso mi pare particolarmente utile l’art. 8 del vostro recente Codice deontologico, perché lo considero attento alla situazione di conflitto che si può venire a generare. Il conflitto, se portato alle estreme conseguenze, rischia di provocare delle fratture estremamente gravi che possono essere molto dannose nel caso dell’interruzione di gravidanza per la donna che ha scelto questa strategia, ma anche per l’operatore sanitario. Ritengo sia importante portare alla vostra attenzione che il Comitato Nazionale per la Bioetica ci viene in soccorso con il pronunciamento sulla contraccezione di emergenza del 2004, là dove indica che l’operatore non favorevole a certe procedure deve comunque dialogare – così come dice l’art. 8 del vostro Codice – fornendo – dice il Comitato Nazionale per la Bioetica – “alla donna una informazione completa circa il ricorso ai prodotti in oggetto e ai loro possibili meccanismi di azione”. È un modo – mi pare utile – per interagire, per sostenere le proprie ragioni e per ascoltare, nel dialogo, le ragioni dell’altro. Questo è rispettoso della dignità personale dell’operatore e della persona che non condivide le idee espresse dalla coscienza dell’operatore. Certamente, in ogni struttura sanitaria abbiamo altre figure che possono interagire, a cui l’operatore che ha manifestato una “clausola di coscienza” può delegare l’assistenza della donna. Mi rendo conto che questo provochi comunque una frattura. Allora cito Giovanni Fornero che in un testo del 2005 intitolato Bioetica cattolica e bioetica laica segnala che nella società multietnica e multiculturale è difficile trovare sempre valori condivisibili. Le diverse opinioni non possono fare a meno di coesistere e dialogare, avvertendo il bisogno di un dialogo che non sia una giusta posizione di monologhi, ma, come aveva già sostenuto Scarpelli, un laboratorio in cui principi differenti possono infine confrontarsi senz’odio filosofico e teologico. Credo sia questa la strategia. L’etica non sempre aiuta a risolvere i conflitti, ma può attenuarli e trovare una soluzione dialogica, rispettosa delle alterità che sono in dialogo. Maurizio Mori (Direttore del Master di Bioetica dell’Università di Torino) Io la vedo un po’ diversamente, e mi scuso se non farò riferimento, volontariamente, né a codici né a sentenze né a comitati. Secondo me il problema di fondo è quello di prendere atto di due considerazioni: la prima è che il Codice deontologico, dal mio punto di vista, non è, come è stato detto prima, “il massimo etico espresso dalla professione”. Io direi che è una media bassa di ciò che è espresso dalla professione, perché l’etica non è racchiusa nel Codice deontologico. L’ideale morale è qualcosa di più, perché altrimenti i codici, se fossero già al massimo, non evolverebbero. Sono una media per mettere d’accordo una professione su quel che è l’etica professionale. Senz’altro il codice, in generale, è probabilmente più avanti di ciò che è il diritto – che vale per tutti – il quale, probabilmente, è sito un po’ più in basso. I codici si rifanno, giustamente, perché c’è una 82 evoluzione della medicina. Detto questo, oggi il problema di fondo è il seguente: noi stiamo vivendo la rivoluzione biomedica. Questo porta a dei cambiamenti straordinari nella medicina e, conseguentemente, porta, ad esempio, al nuovo ruolo che gli infermieri ricoprono nella medicina. Essi hanno acquisito una posizione nuova rispetto al passato e devono acquisirne consapevolezza così da agire in conseguenza di ciò. Invece noi continuiamo a ragionare come se fossero ancora gli infermieri di cent’anni fa. Questo discorso ci conduce ad un punto fondamentale sul piano etico, e cioè: qual è il valore primario nella medicina di oggi? Credo che il valore primario – su cui tutti noi dovremmo perseverare – sia il fornire e garantire i servizi al paziente. La medicina è fatta per garantire servizi ai pazienti, clienti, cittadini, chiamateli come volete, però a coloro che hanno delle esigenze e che richiedono la soluzione di tali esigenze. Se partiamo da questo punto di vista, credo che il problema della “clausola di coscienza” o dell’obiezione di coscienza sia una questione che assume carattere secondario, limitato eventualmente a pochi problemi, perché il cittadino che va in ospedale deve essere sicuro di trovarsi di fronte all’erogazione del servizio. Ora, noi abbiamo avuto, inizialmente, nel caso dell’aborto, un solo caso specifico. Si pensava fosse una piaga purulenta da tenere limitata e forse da isolare: si è data l’obiezione di coscienza. Tra l’altro, secondo me, l’obiezione di coscienza era probabilmente giusto concederla a chi si era già iscritto a Medicina ed era medico prima dell’introduzione dell’obiezione – trovandosi cambiata la legge rispetto alla sua iscrizione alla Facoltà –, ma in seguito non riesco più a comprenderla, perché quando una persona si iscrive a Medicina è consapevole del fatto che l’aborto è incluso tra le pratiche mediche. Pertanto, mi riesce oscuro il concetto che, chi oggi si iscrive a Medicina, debba avere questa sorta di privilegio. Comunque trattasi di legge ed io la accetto, ma la rimetterei in discussione. Il problema di fondo sta nel fatto che queste obiezioni di coscienza, che prima erano limitate ad un caso solo, oggi si stanno moltiplicando. Questo ingenera un problema, perché se l’operatore deve rispettare la propria coscienza a discapito dell’erogazione del pubblico servizio, allora dovremmo aprire un discorso per andare ad esaminare quanto queste coscienze siano effettivamente rispondenti e accettino un dialogo. Non amo la dizione “clausola di coscienza”, e ritengo che anche giuridicamente vi siano delle difficoltà ad accettarla. Sono del parere che chi ha degli ideali etici debba essere disposto all’obiezione civile, altrimenti è come chiedere uno sconto in base a proprie convinzioni che uno chiama “di coscienza”, ma chi ci dice che non siano tabù o superstizioni inveterate proprie dell’individuo? Se un Testimone di Geova diventasse medico od infermiere potrebbe dire: “voglio l’obiezione di coscienza sul problema della trasfusione di sangue”. Ciascuno potrebbe vantare le proprie questioni. Affermiamo di essere in grado di contenere le questioni razziali o di religione, ma, badate bene, è sufficiente che vi sia un gruppo ben organizzato che cominci a diffondere insistentemente determinate discriminazioni e si rischia di generare ulteriori obiezioni di coscienza. Il punto di fondo è questo: se una persona vuole difendere un alto valore morale, esiste la semplice disobbedienza civile, non serve l’obiezione di coscienza. La disobbedienza civile è un atto in cui si afferma: “io non faccio questo servizio e pago le conseguenze”. Non si riesce a comprendere perché uno dovrebbe avere degli sconti. Io credo che dal punto di vista etico questo sia molto più produttivo e porterebbe ad un reale dibattito che non la richiesta di alcuni gruppi organizzati alla ricerca dello scontro. Dico questo pensando alla legge oggi in discussione in Parlamento sulla questione dell’alimentazione o idratazione artificiale. Domani uno potrebbe metterci anche la ventilazione ed innumerevoli altre questioni. E, se è proprio vero che ciascuno deve rispondere solo alla propria coscienza, avremo ogni genere di obiezione, a seconda delle singole persone, gli arancioni, i buddisti, le obiezioni di tipo alimentare. In cucina potremmo avere chi obietta: “io non cucino i cibi con la carne” – ed io sarei favorevole, visto che credo che il vegetarianesimo sia un dovere morale – o potremmo trovarci di fronte le più svariate questioni. Mi rendo conto di sostenere degli argomenti che possono risultare controversi, ma credo sia giusto cominciare a riflettere anche su questi aspetti. Grazie. 83 Barbara Chiapusso (infermiere coordinatrice ASL TO 3 – Segretario Collegio IPASVi di Torino) Mi pare di aver capito che ci sono due posizioni che si integrano per alcuni versi e per altri invece si discostano. Questo ci permette di rivolgerci al dottor Davini, anche perché i precedenti relatori hanno affermato che il cittadino deve ricevere un servizio. Chi si iscrive alla Facoltà di Medicina dovrebbe sapere cosa andrà a fare, diceva il professor Mori, ed il professor Zeppegno puntualizzava che c’è anche la possibilità, viceversa, di delegare l’assistenza. Ritengo che lei, dottor Davini, grazie al suo campo d’azione, possa essere assunto, in questo momento, ad un ruolo un po’ più esterno di spettatore, e proprio da spettatore chiediamo – dal punto di vista istituzionale – quali meccanismi operativi possono essere messi in atto per facilitare la gestione di questi conflitti, che per il momento erano ancora focalizzati sull’obiezione di coscienza, anche se in realtà siamo già andati all’interno del concetto della “clausola di coscienza”. Ottavio Davini (Direttore Sanitario AOU S. Giovanni Battista di Torino) Innanzi tutto trovo che tutte le sollecitazioni siano arrivate dalla bellissima introduzione del professor Fassone, che ho apprezzato molto. Dai dubbi che le norme e la giurisprudenza trascinano nonché dalle diversità di opinioni del mondo eticistico, è curioso che alla fine io debba cercare di mediare il tutto. Tuttavia ci sta, nella misura in cui le istituzioni devono gestire i problemi nel concreto, quindi porsi di fronte ad un percorso di gestione di questo genere di problematiche. Ho apprezzato nelle considerazioni che faceva il professor Fassone una parola che ha usato nel dire come, secondo lui, bisognerebbe affrontare questi temi, ed è la parola umiltà. Tento di fare un’introduzione per dare una risposta che sia coerente, perché è evidente che molte questioni, da qualunque punto di vista noi le si analizzi – sia dal punto di vista etico, sia dal punto di vista filosofico, politico, giuridico, scientifico – non sono univoche nel senso che sussistono interpretazioni o opinioni differenti, molto articolate, ad esempio sul fine vita e inizio vita. Credo che questo sia da porre in relazione – mi riaggancio ad una considerazione che faceva il professor Mori sull’evoluzione dello scenario biomedico – ai cambiamenti all’interno della scienza e al fatto che le conoscenze aumentano e si moltiplicano. Secondo me è abbastanza chiaro – direi scontato – il concetto che l’etica non è immutabile, ma in qualche modo è figlia dell’evoluzione della società e dei tempi. Se pensate a ciò che era considerato etico qualche secolo fa probabilmente inorridireste. Basta far mente locale su alcuni episodi della nostra storia. Oggi c’è stata una grossa evoluzione, molte cose sono cambiate. Cito un paio di considerazioni di un libro letto di recente e che ho apprezzato. Si intitola “I due dogmi”, di Paolo Vineis e Roberto Satolli. Vineis è un professore di epidemiologia di Torino che lavora a Londra, e non è il suo primo libro sull’argomento. Egli sollecita una visione non integralista, sollecita fortemente al dialogo perché molte questioni sul tappeto sono – per dirla con un anglicismo – “fuzzy”, cioè indistinte, non ben determinabili. Un esempio: probabilmente molti di noi credono ancora che vi siano differenze genetiche tra le razze. La cosa non è vera, nel senso che analizzando il genoma si è scoperto che non ci sono differenze genetiche tra le razze. 84 Il concetto di morte, lo ha detto prima il professor Fassone, si è modificato enormemente nel corso degli anni. Possiamo discuterne, però abbiamo alcune certezze, seppur molte altre ci manchino. Tutto questo enorme evolvere del mondo scientifico, medico, sanitario e la sua applicazione nel contesto, nel quotidiano, deve, secondo me – sto appunto cercando di offrire una risposta istituzionale – impiegare lo strumento del dialogo, della comunicazione, dell’informazione, della formazione. Non penso che ci possano essere dei paletti piantati per terra che definiscono per tempo immemorabile quali sono le regole al di là delle quali non si può andare, perché le cose cambiano, e quello che noi scopriamo quotidianamente – e gli scenari che si aprono – modificano questo contesto. Su un concetto voglio e devo essere molto chiaro – non chiaro forse come il professor Mori, che ha lanciato una provocazione forte sul tema della laurea in medicina – ossia che il Servizio Sanitario Nazionale ha una sua missione che è figlia dell’art. 32 della Costituzione, dalla quale noi non possiamo derogare, e cioè: noi siamo qui per garantire l’assistenza ai cittadini che si presentano nelle nostre strutture, naturalmente nel contesto delle norme e delle regole – di carattere generale o di carattere specifico – che ci ha dato il Parlamento, per quanto riguarda i comportamenti nel concreto sui diversi atti professionali. Quindi è importantissimo – ci tornerò nel proseguo del dibattito – discutere, dialogare, così come è importante alzare il livello di compressione dei temi che spesso restano vincolati ad una contrapposizione ideologica preconcetta, mentre invece bisogna entrare nel merito. Però, è imprescindibile che quello che viene garantito dal Servizio Sanitario Nazionale faccia riferimento ai principi di solidarismo e di accesso universale e che quindi quelle regole non possano essere toccate, altrimenti andiamo a minare il senso ed il significato dell’art. 32. Credo che tra gli strumenti concreti dovremmo lavorare anche sulla possibilità di coinvolgere organismi od organi interni alle aziende su cui questo tipo di temi possono essere portati in quanto affini come, per esempio, il Comitato Etico o il prospettato Consiglio delle Professioni Sanitarie che più degli organi attuali, secondo me, potrebbe essere idoneo ad affrontare questi temi. Qualcuno ha già anche prospettato che i Dipartimenti comincino a diventare una sede di dibattito su questi argomenti. Barbara Chiapusso (infermiere coordinatrice ASL TO 3 – Segretario Collegio IPASVi di Torino) Premesso che è evidente che le osservazioni saranno diverse, è ovvio che i punti di vista saranno differenti su un tema così delicato, su un terreno così friabile. Proseguiamo ponendo la domanda nuovamente ai professori Mori e Zeppegno, perché è pur vero che il cittadino deve ricevere un servizio, ma è altrettanto vero che nel nostro operare quotidiano può accadere di trovarci di fronte ad un’alternativa, a volte lacerante, fra il comando della legge, che impone una determinata azione, e l’imperativo della nostra coscienza, rispondente a motivazioni religiose, ma anche etiche o ideologiche, secondo cui quella azione risulta inaccettabile: si crea un conflitto interiore. Ed ecco che arriviamo ad introdurre il concetto nuovo di “clausola di coscienza” per superare questo conflitto. La domanda spunto di riflessione che pongo ai due professori è appunto come si può conciliare il valore espresso da noi infermieri nell’art. 4 del Codice – che recita per l’appunto che “l’infermiere presta assistenza […] tenendo conto dei valori etici, religiosi e culturali […] della persona” – e l’imperativo della nostra coscienza, che verosimilmente può anche trovarsi di fronte a conflitti che non sono solo – e mi scuso per il solo – rispetto al tipo di alimentazione, ma che 85 appunto possono invece essere conflitti contrastanti con quello che è l’imperativo della nostra coscienza. Maurizio Mori (Direttore del Master di Bioetica dell’Università di Torino) Oggi tutti difendono la 194, ma io sono critico verso questa legge. Sono critico in molti settori, incluso il concedere l’obiezione di coscienza anche ai nuovi medici che si iscrivono a Medicina. Lo dico perché insegno filosofia, l’ho insegnata anche nelle Scuole Inferiori. Se nel mio programma di studi – mi riferisco a quando insegnavo all’Istituto Magistrale – c’era da insegnare Marx e Nietzsche, li insegnavo, anche se c’è chi può dire che sono autori da non insegnare. Non dimentichiamoci che in passato non erano previsti tra ciò che si doveva insegnare. Se si deve insegnare De Sade lo si insegno, e lo stesso vale per la filosofia di Hitler, perché Hitler ha scritto un libro, “Mein Kampf”, nel quale è presente tutta una filosofia – repellente fin che si vuole – ma che bisogna conoscere. Analogo discorso per quanto riguarda le altre questioni. Non è che se devo insegnare un certo tipo di programma posso dire: “io faccio il filosofo, però su queste cose faccio obiezione di coscienza”. No: se mi tocca farle le faccio. Detto questo, la mia più che una provocazione era un’osservazione sulla quale discutere, anche in prospettiva futura. Proviamo a pensare alla futura discussione di legge Calabrò. Il Presidente dell’Ordine dei medici di Bologna ha dichiarato pubblicamente al “Corriere della Sera” che se vincesse la posizione della Fnomceo – attualmente contraria alla legge Calabrò – ci sarebbe una sorta di scisma. Queste, in sintesi, le sue parole: “noi non stiamo più nell’Ordine dei medici perché ce ne andiamo”. Guardate che questo è quello che è capitato in Gran Bretagna con la Royal Medical Association, ed è capitato anche in Olanda. Quindi, queste avvisaglie dobbiamo prenderle in seria considerazione, non possiamo continuare a pensare di risolvere tutto tenendo insieme, pensando che il conflitto faccia male. Detto questo voglio rispondere alla domanda centrale. Credo che quello che vada fatto, come minimo, sia incentivare azioni come queste – se non più approfondite – di riflessione sull’etica, su cosa è effettivamente l’etica e cosa noi possiamo accettare come coscienza degli infermieri. Noi partiamo sempre dal presupposto che basta che uno senta profondamente qualche cosa e quella è l’etica. Ma in una situazione come è stata sottolineata prima dal dottor Davini – di rivoluzione della medicina, di grande cambiamento della medicina – noi dobbiamo renderci conto che il pericolo maggiore per l’etica sono i tabù, sono le cose ricevute quando eravamo bambini, sono le tradizioni. Se continuiamo a pensare che l’etica siano gli insegnamenti della nonna che diceva “esci con il velo” o “mi raccomando non uscire, le gonne le devi avere, i pantaloni non metterli che sono da maschi” e tutte queste altre questioni, se riteniamo che questa sia l’etica allora possiamo moltiplicare le “clausole di coscienza”. Ma noi dobbiamo mettere in discussione che cosa sia effettivamente l’etica, e anche su questo ci sono senz’altro opinioni diverse, alcune palesemente sbagliate. Io credo che, ad esempio, l’obiezione al preservativo sia profondamente sbagliata perché è un presidio legittimo per le persone. Se noi andassimo in questa direzione, allora la “clausola di coscienza” potrà esserci, ma sarà forse una questione residuale sulla quale possiamo eventualmente metterci a discutere. La mia osservazione di fondo è che dobbiamo tener conto del bilanciamento della coscienza dell’operatore, ma questa coscienza dell’operatore va profondamente coltivata e riveduta e, dall’altra parte, si deve dare peso – grande peso – alle esigenze dell’utente. Questo è il punto di 86 fondo, mentre ho l’impressione che talvolta vi sia uno sbilanciamento a favore dell’operatore: la sua coscienza non deve essere violata, dopodiché va bene tutto. Grazie. Giuseppe Zeppegno (Direttore scientifico del Master Universitario in Bioetica della Facoltà Teologica) Innanzi tutto mi pare doveroso ribadire che di fronte al conflitto troviamo due coscienze: quella del paziente – che è l’agente principale della gestione della sua salute, ha il dovere di custodirla, di promuoverla – e quella dell’operatore sanitario che è chiamato a collaborare con il paziente, naturalmente senza abdicare ai suoi valori. Come fare per superare questa frattura evidente? È il vostro stesso Codice deontologico a venirci in aiuto. Cito, ad esempio, l’art. 17, il quale aiuta l’operatore sanitario perché lo rende libero da pressioni esterne. In questo senso può, come dicevo già prima, recedere dall’alleanza precedentemente stabilita, sempre garantendo l’incolumità e la vita dell’assistito, come recita l’art. 8. Credo sia anche particolarmente utile la possibilità manifestata dall’art. 16 di chiedere una consulenza etica perché, evidentemente, si può poi stabilire, ragionando con competenze diverse, qual è la strategia più autentica per quel paziente. Mi pare opportuno, se prima ho parlato dell’inizio vita e dell’interruzione di gravidanza, accennare al fine vita. Notiamo prima di tutto che l’art. 38 vieta ogni forma di eutanasia attiva. Ritengo anche opportuno ricordare gli art. 34 e 35, laddove si invita a contrastare il dolore con la necessaria palliazione. E ancora: cito l’art. 36 che invita a valutare, in un dialogo confidente con il paziente, i rischi dovuti alla messa in opera di interventi non proporzionati od irrispettosi della sua qualità di vita. Mi pare che all’interno di questo quadro ci si possa muovere senza particolari difficoltà e credo che proprio voi, con questi articoli, abbiate messo dei paletti efficaci per evitare, già dal nascere, il conflitto. In questo ambito do atto che avete fatto un lavoro molto ricco. Barbara Chiapusso (infermiere coordinatrice ASL TO 3 – Segretario Collegio IPASVi di Torino) Forse il punto più caldo, più difficile è proprio questo: io infermiere mi faccio garante delle prestazioni necessarie per l’incolumità e la vita dell’assistito, quindi, come giustamente diceva lei ci sono due coscienze, due persone: l’assistito e l’infermiere. Se io, infermiere, mi rendo garante dell’erogazione delle prestazioni per la vita dell’assistito, come posso però appellarmi alla “clausola di coscienza”, se in essa scorgo principi in contrasto con i miei valori? Posso quindi utilizzare gli spunti importanti che voi avete fornito. È necessario incentivare riflessioni sull’etica e questo Convegno vorrebbe essere una sorta di “là” per il futuro. Sono in programma altri momenti di incontro e di riflessione sull’etica per quel che riguarda la professione infermieristica, il nostro agire quotidiano. Il professor Zeppegno parlava di consulenza etica. Secondo voi questo è forse il punto di incontro di queste due posizioni? Il punto d’incontro tra questo mio essere infermiere, che deve in qualche modo essere sempre garante delle prestazioni necessarie per l’incolumità e – dall’altra parte – questo appellarmi alla “clausola di coscienza” nel non voler appunto, per dei conflitti miei, erogare questo tipo di assistenza. 87 Giuseppe Zeppegno (Direttore scientifico del Master Universitario in Bioetica della Facoltà Teologica) Credo che quando il conflitto c’è e viene prospettato proprio come una rottura tra paziente e operatore sanitario, debba intervenire un discorso etico più ampio, perché evidentemente il conflitto non può rimanere tra i due, pena la sedimentazione. I Comitati etici, nelle strutture ospedaliere, a volte privilegiano la sperimentazione. Ci dovrebbe essere, a mio avviso, un altro tipo di Comitato che privilegi invece la bioetica clinica, cioè quella che si fa al letto del malato. In questo senso diventa utile costruire insieme qualcosa, valorizzando la diversità degli operatori, perché un problema ad oggi irrisolvibile tra i due soggetti può magari venir risolto diversamente con la collaborazione del Comitato etico. Maurizio Mori (Direttore del Master di Bioetica dell’Università di Torino) È giustissimo ciò che affermava sul Comitato etico, però anche dove funzionano i Comitati etici – non soltanto come da noi che funzionano unicamente sulla sperimentazione clinica –, intendo dove funzionano effettivamente per la consulenza etica, dobbiamo sottolineare che il compito del Comitato etico è meramente consultivo. La responsabilità è poi sempre personale – del medico o dell’infermiere – e quindi funzionano da setaccio di quelle che sono le coscienze. Questo può essere molto utile. Sono convinto che il problema stia tutto nell’incolumità e nella vita dell’assistito. Amo essere netto: quando si pensa è giusto pensare con pensieri forti, non deboli, riscaldati. Il problema è che il cosiddetto diritto alla vita vale nel contesto sociale generale – nel senso che uno non deve cagionare la mia morte con atti violenti – ma nei contesti sanitari la vita equivale alla salute, ovvero: zero di salute è la morte, non ci piove. Zero di salute è la morte. La salute può diminuire, e quando arriva a zero quella è la non‐vita. Chiamiamola non‐vita, morte. Prima c’è stata la bella lezione sulla “vita biografica” e sulla “vita biologica”, ma nel contesto sanitario vale il diritto alla salute. Ecco perché di fronte al Testimone di Geova che dice: “io non voglio la trasfusione”, il medico – nella tutela della salute – deve rispettare l’autodeterminazione e lo stesso deve fare l’infermiere. Gli infermieri non devono, come è già capitato, insistere affinché il paziente faccia la trasfusione – insistenza finalizzata alla tutela della sua vita – e poi alla fine lo stesso accetta pur di non continuare a sentire la tortura degli infermieri. Questa è la mia osservazione: privilegiare la coscienza dell’assistito. Non dimentichiamoci la forza dell’assistenza: l’assistenza è proprio il rispetto dei valori della persona, anche se io non li condivido. Quando uno studente viene da me e mi chiede una tesi su un tema che non mi interessa, io lo rispetto e gli dico: “va bene, mi aggiorno così che lei possa fare la tesi sul tema che ha scelto”. Non gli dico: “no, questo non rientra nei miei piani di studi e lei si arrangi”. Mi è capitato l’altro giorno: uno è venuto a chiedermi una tesi su temi bioetici che sono 88 un po’ distanti dai temi da me frequentati. Come insegnante – l’etica dell’insegnante – devo privilegiare gli interessi degli studenti. Credo che qualche cosa del genere dovrebbe essere fatto anche dagli operatori sanitari e dagli infermieri. Barbara Chiapusso (infermiere coordinatrice ASL TO 3 – Segretario Collegio IPASVi di Torino) Lo verificheremo adesso grazie al dottor Davini a cui chiedo se nel suo operare quotidiano ha raccolto richieste da parte degli infermieri riferite alla “clausola di coscienza”. Se sì, quale atteggiamento ha assunto, ovviamente come istituzione, e, in caso negativo, come si comporterebbe in una tale situazione? Ottavio Davini (Direttore Sanitario AOU S. Giovanni Battista di Torino) Direi che non abbiamo avuto, direttamente, segnalazioni in questo senso. Credo però che la cornice in cui mi sembra corretto inserire questo tipo di ipotesi deve essere quella di considerare la “clausola di coscienza” – come è emerso in modo abbastanza significativo all’interno di questo dibattito – nei suoi confini naturali, per la verità anche questi un po’ indistinti, al fine di evitare un’interpretazione troppo estensiva. Gli esempi di osservazione – non di provocazione – che ha fatto il professor Mori sono molto chiari. Si è portato l’esempio del Testimone di Geova, ma potremmo espanderci all’infinito, appellandoci in modo generico ad aspetti individuali ed interpretazioni soggettive della realtà. Lo dico con molta franchezza: nelle istituzioni si può misurare anche questo tipo di fenomeno, per evitare posizioni di tipo strumentale, nel senso che potrebbe anche venire comodo – in un certo contesto – cominciare ad ipotizzare che l’applicare o l’appellarsi alla “clausola di coscienza” consente di eliminarsi da una corvée particolare. Questo può essere un problema che già si vive in alcuni contesti – non in questo ospedale perché non abbiamo l’ostetricia – per l’applicazione della 194. Quello che possiamo dire è che, anche se non sono arrivati ai piani alti segnalazioni in relazione alla “clausola di coscienza”, abbiamo percepito che in alcune aree, in alcune situazioni poteva determinarsi un problema su questo tipo di linea. La sensazione è che spesso ci siano stati dei problemi di comunicazione e qualche segnale in questo senso lo avevamo avuto – dico questo perché è uno dei possibili esempi, sia strumentali che di applicazione iperestensiva – dal fatto che ci si potrebbe appellare alla “clausola di coscienza” per quel che riguarda le sperimentazioni cliniche, non quelle su animali, naturalmente. Questo è un argomento che è nitido, fortunatamente, nel senso che, nel caso di quest’azienda, il regolamento del Comitato etico interaziendale recita, in premessa: “La sperimentazione clinica costituisce uno dei compiti istituzionali dell’azienda ospedaliera San Giovanni Battista e del CTO, Comitato etico e interaziendale, le cui attività assistenziali, espletate da strutture complesse ospedaliere e universitarie, sono di riferimento regionale e nazionale.” 89 Cioè, la sperimentazione clinica è assolutamente connaturata alla Mission di un’azienda di questo tipo, a maggior ragione da quando dal 2007 questa azienda è un’azienda ospedaliera universitaria e quindi si potrebbe dire che se questo non è un argomento che ti appassiona, con cui non vuoi imbatterti, probabilmente ci sono altre realtà in cui puoi esercitare la tua professione senza porti questo problema. Potrebbe essere un approccio anche per altre questioni, ma certamente ritorneremo di nuovo ad avere una linea un po’ dura. Invece mi piacerebbe continuare con questa filosofia dialogante. Nel caso invece in cui – e su questo abbiamo fatto delle riflessioni – ci si trovasse veramente di fronte ad un’ipotesi di “clausola di coscienza”, la prima domanda da farsi, evidentemente, è se c’è una norma che regola quel contesto, quindi se in realtà non siamo nel contesto dell’obiezione, e le obiezioni di coscienza, abbiamo sentito, sono nitide, poche e abbastanza ben definite, con tutte le sfumature che ci ha presentato l’avvocato Gamba. Ritengo che il secondo aspetto che debba essere messo in evidenza è se esiste veramente un rilievo eticamente sensibile che sottenga a questa domanda di “clausola di coscienza” oppure se, come ho detto prima, possono essere altre le considerazioni, cioè se veramente sussiste un aspetto che coinvolge l’etica e l’interpretazione del rapporto tra il paziente e chi lo assiste od i propri valori esistenziali, cercando anche qui di considerare che questi devono essere però riconducibili e non possono essere generici o gonfiati. A me sembra che le considerazioni fatte dalla vostra Presidente IPASVI nel famoso commentario al Codice Deontologico – che ho letto – sono fondamentali e sono quelle che, come dire, definiscono, bilanciano e consentono anche di esprimere considerazioni sulla accoglibilità o sulla coerenza o meno di una “clausola di coscienza”, perché quando lei sottolinea come l’obiettivo sia di perseguire la centralità dell’assistito nei processi di cura – questo significa per l’infermiere riconoscere la dignità in ogni fase della malattia; non vado oltre perché il testo lo conoscete meglio di me – è chiaro che l’orientamento è prevalente verso l’autodeterminazione e la libertà di scelta del paziente. Quindi è evidente che questo diventa uno di quei grandi spartiacque, di quei grandi discrimini su cui gran parte del dibattito coinvolge non soltanto le categorie professionali – medici e infermieri – ma coinvolge spesso – sentendo anche degli sproloqui – il mondo politico. In realtà lo spartiacque diventa un po’ quello, cioè quanto pesa l’autodeterminazione, l’opinione dell’assistito rispetto alle convinzioni di chi lo assiste. Le considerazioni che sentivo sull’Ordine dei medici di Bologna personalmente mi trovano fortemente in disaccordo. E non è neppure chiaro dove potrebbero andare. Facendo un bilancio complessivo – anche in chiave interpretativa sul problema della “clausola di coscienza” – è importante comprendere qual è l’equilibrio e quanto ci si debba orientare sulla persona assistita e quanto sui nostri personali convincimenti. Credo che dalla Costituzione in avanti, attraverso tutte le norme e la giurisprudenza – secondo me abbastanza significativa – l’orientamento, fortunatamente, sia quello di privilegiare la soggettività. Grazie. Barbara Chiapusso (infermiere coordinatrice ASL TO 3 – Segretario Collegio IPASVi di Torino) A proposito di soggettività del paziente e di rispetto del paziente, riporto nuovamente il discorso dal punto di vista dell’infermiere, chiedendo all’avvocato Gamba qual è il valore giuridico di questa “clausola di coscienza” poco conosciuta, perché l’obiezione, ripeto, ha una tutela giuridica che invece la clausola non ha. 90 Insomma, io infermiere voglio esprimere il mio conflitto attraverso la “clausola di coscienza”: posso esprimere questo conflitto, come posso esprimere questo mio “no” per un conflitto etico? Questo solleverà sicuramente dei problemi, però vorrei capire se posso farlo, come posso farlo e quale valore giuridico ha questo mio farlo. Dario Gamba (Avvocato, Consulente legale Collegio IPASVI di Torino) Secondo me la “clausola di coscienza” ha una doppia lettura. È la lettura di una norma profondamente sovversiva, perché è una norma che, se la leggiamo bene, ha degli elementi antisistema, rivoluzionari. È una norma che dice, sostanzialmente, che se l’infermiere riceve una richiesta di attività – non chiarisce se da parte dell’ASL, quindi della pubblica utilità, o da parte del privato: immagino che pensi più al privato perché le richieste di attività dell’ASL, come dicevamo prima, hanno una natura di ordine di servizio e quindi sarebbe ancora più sovversivo dire che uno si può contrapporre – in contrasto con i principi etici della professione e con i propri valori, si avvale della “clausola di coscienza”. Ora, il testo precedente, per chi si ricorda il Codice deontologico, non diceva “con i propri valori”, ma “in contrasto con i principi della professione e la deontologia professionale o con la coscienza personale”. Coscienza personale è un termine sicuramente generale e trascendente. Si poteva pensare che ci fosse un livello dell’empireo, in cui la coscienza personale, espressione di valori generali, coincidesse con i principi generali dell’ordinamento giuridico e quindi con quelle norme fondamentali pregiuridiche che sono presenti anche nella Costituzione. Pertanto, si andava d’amore e d’accordo. Ma quando dice “con i propri valori” sta parlando dei valori individuali del singolo. Quindi, raccolgo la provocazione del dottor Davini su questa cosa. Mi sovviene mia nonna, piemontese. Quando le esponevamo delle questioni su cosa fare, su come comportarsi, come muoversi, ecc., lei, da buona piemontese, diceva: “ascolta me, fai quello che vuoi”. Mi sembra che qui l’approccio sia un po’ questo, ossia: “le cose in contrasto con i propri valori”. Se interpretata così è una norma fortemente antisistema, sovversiva al massimo. C’è da pensare invece che non sia questa l’interpretazione da dare, ma sia quell’altra, ovvero un’interpretazione più morbida, dove forse la norma deontologica e la norma giuridica non si considerano a vicenda, perché o io ipotizzo un ego ipertrofico da parte dello spirito del Codice deontologico oppure dico che lavoro in un campo diverso, metagiuridico, e forse questa è l’unica spiegazione possibile. Cioè, quando si dice “clausola di coscienza” si parla di un’obiezione a 360° che, secondo il principio di legalità, non è assolutamente consentita. Io eccepisco la “clausola di coscienza”, però poi aspetto la polizia, aspetto il cellulare che viene a prendermi e, come si diceva prima, come diceva il professor Mori, questa è obiezione civile. Va benissimo, questa è prevista, non si può dire consentita, perché da uomo di legge nulla che è vietato dalla legge è consentito, però io la faccio su un piano che è un piano metagiuridico. Questa è l’interpretazione che può consentirmi di accettare questo articolo nell’ordinamento. Voi, d’altronde, avete la prova del fatto che le perplessità del farmacista, che abbiamo sentito prima, sono le stesse del medico e dell’infermiere. Nel Codice deontologico del farmacista non è prevista la “clausola di coscienza”, però anche il farmacista si chiede: “come posso rifiutarmi di vendere la cosiddetta pillola del giorno dopo?” La norma sull’IVG no, perché quella al massimo l’art. 9 lo posso invocare sull’RU, l’altra pillola – quella che interviene su una gravidanza conclamata – e infatti quando si obietta non si eccepisce la “clausola di coscienza” sull’RU. Si 91 eccepisce l’art. 9 della legge sull’interruzione volontaria di gravidanza – per essere sicuri – altrimenti c’è il rischio del cellulare che ti aspetta. E allora il farmacista dice: “dove mi aggrappo per non vendere questa pillola?” In effetti è un problema aperto, nella stessa misura di chi ha la “clausola di coscienza”. La “clausola di coscienza”, naturalmente, non fa da scriminante, cioè non evita la punibilità di un eventuale reato. Questo dal punto di vista tecnico. D’altronde, il Codice deontologico ha una natura ben precisa. La Commissione per la bioetica lo ha codificato bene, ma d’altronde era nei principi dell’ordinamento. È un regolamento, quindi, è una norma, ma è una fonte secondaria che nella gerarchia delle fonti sta sotto le leggi e i decreti, ancor più sotto della Costituzione e dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico. Ha una natura regolamentare, anche se è un regolamento atipico, cioè un regolamento che ha una vocazione un po’ più ampia della mera regolamentazione di dettaglio. Su questo il Codice deontologico ha perso molte occasioni. Questo – in base allo spirito dei tempi – è ciò che oggi l’infermiere può fare, può obiettare. Altra norma che potrebbe essere estremamente irredentista è quella di quell’articolo che afferma che l’infermiere non compensa le carenze della struttura. Ma siamo nell’epoca di Brunetta! Voi provate a non compensare la carenza delle strutture, con le nuove tendenze organizzative del sistema, per chi è dipendente pubblico: rischiate il licenziamento e la denuncia penale. Quindi, se c’è un progetto brunettiano che prevede la compensazione delle carenze strutturali, voglio vedere come si fa ad invocare il Codice deontologico per dire: “non mi becco né il procedimento disciplinare né il procedimento penale”. Quella sentenza del Consiglio di Stato, prima giustamente citata, era una sentenza giuslavoristica, perché allora TAR e Consiglio di Stato facevano pubblico impiego, pertanto era il giudice del lavoro di allora. Quindi, probabilmente, era un dipendente che era stato portato davanti alla Commissione disciplina, sanzionato e poi era finito davanti al giudice. Sicuramente tutti quelli che lavorano nella Sanità e nell’infermieristica hanno provato un momento di grande euforia quando la legge 42 ha detto che il Codice deontologico diventava uno dei tre riferimenti di responsabilità e di ambito di attività dell’infermiere, ma questo non ha significato, tecnicamente – ci abbiamo pensato tanto, ci si è riflettuto a tutti i livelli – che finalmente il Codice deontologico, da norma regolamentare – quindi subprimaria – diventava legge. Perché non è un rinvio recettizio, per cui è diventato dello stesso valore. Certo, è stato recepito nell’ordinamento, ma come compagno di strada, nel senso che deve comunque rispettare, secondo il principio di legalità, i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico, le leggi e i decreti, quei decreti che hanno valore di legge e che stanno sopra, che sono prevalenti, gerarchicamente superiori. Diciamo quindi che è stato uno sdoganamento sub condicione. Ma figuriamoci se il legislatore, con il ruolo che riveste – che è quello di farsi rispettare, di garantire la legalità di un Paese – si sottopone a critiche a 360° su una norma regolamentare, su qualsiasi cosa che risponda a dei valori propri, individualistici del singolo operatore che in quel momento agisce. Sarebbe l’anarchia totale, il nichilismo completo. Il valore da attribuire ad una norma deontologica sta nel valore della norma deontologica stessa, naturalmente letta dal punto di vista della legalità. Ovviamente posso avere degli altri approcci. Posso sicuramente fare obiezione civile, posso sicuramente sottopormi alle inevitabili sanzioni che potranno derivare da una “clausola di coscienza” a 360°. Quindi, in base al principio di legalità, la “clausola di coscienza” non può mai consentirmi di sperare in una impunità quando mi pongo di traverso rispetto a quello che le norme giuridiche prevedono. Il problema è stabilire quali sono i limiti delle norme giuridiche e cosa prevedono, ma questo è un altro film. 92 Barbara Chiapusso (infermiere coordinatrice ASL TO 3 – Segretario Collegio IPASVi di Torino) Quindi è un po’ quella che era l’obiezione di coscienza, come diceva prima il professore: all’obiezione corrisponde un rifiuto e di conseguenza bisogna pagare, in qualche modo. Anche rispetto alla “clausola” mi pare d’aver capito – seppur quando parlano gli avvocati la terminologia non sia sempre di immediata comprensione – che sia necessario riflettere, che non sia poi questo strumento così formidabile, perché spesso sento che viene utilizzato in una certa maniera – “è possibile evitare di far questo perché posso avvalermi della clausola di coscienza” – e invece pare non sia così semplice e scevro di conseguenze. Dario Gamba (Avvocato, Consulente legale Collegio IPASVI di Torino) Non ci sono sconti. Barbara Chiapusso (infermiere coordinatrice ASL TO 3 – Segretario Collegio IPASVi di Torino) Bene. Torniamo a quanto già detto e volgiamo alla conclusione. Mi sembra che di contenuti ne siano emersi molti e vorrei soprattutto ci fosse anche la possibilità di fare delle domande. Premesso che le scelte della nostra coscienza sono veramente liberanti se fatte nella verità, e questo era un po’ quanto dicevate voi prima: che non sia un’etica quella del mercato, tabù, pregiudizi, tutto quello che è legato alle sensazioni del momento, e che non credo si possa definire etica, io chiedo a voi, professori Mori e Zeppegno, come posso capire quando è più il senso comune ad orientarmi nelle scelte, nelle valutazioni, piuttosto che un riferimento etico. Mi rendo conto che la domanda sia particolare. In realtà nasce da una riflessione, nel senso che spesso può accadere di provare un sentimento che ti fa dire “questo lo vorrei fare e quest’altro no”, e poi magari è solo senso comune, ma non è quello che mi guida realmente nella vita. 93 Maurizio Mori (Direttore del Master di Bioetica dell’Università di Torino) Mi è stata rivolta una domanda da cento milioni di euro, nel senso che – a ragione – è uno dei temi fondamentali. Mi limito a qualche provocazione per cercare di tracciare delle linee di riflessione. L’etica la prendiamo insieme al latte che si ciuccia da bambini, sta nel vento, e non sono sentimenti del momento, ma sono sentimenti profondi, quasi di seconda pelle, per cui certe mie affermazioni – vedo in sala qualche faccia scura – avranno turbato l’animo di qualcuno. E va bene, lo so. Il più grande pericolo, in un’epoca di grande cambiamento dell’etica, sono le tradizioni, perché continuare ad avvalersi di tradizioni passate senza rileggerle e reinterpretarle significa vivere come cent’anni fa in un mondo che è totalmente nuovo. Vivere come se non ci fosse il telefono, quando tutti abbiamo il cellulare. Questo, ad esempio, è quello che è capitato nella medicina. Si continua a rifarsi ad Ippocrate, con un’etica di 3000 anni fa, quando ormai tutto è cambiato nella medicina. Ippocrate è da dimenticare, perché noi dobbiamo rivedere i nostri sentimenti morali ed avere delle ragioni. Dopodiché, l’elaborazione di queste ragioni diventa difficile. L’ultima considerazione di fondo – così da comprendere dove sta la grande differenza fra la cosiddetta etica laica ed etica cattolica – è che l’etica cattolica parte dall’idea che ci sono dei divieti assoluti, cose che non si possono assolutamente fare per nessuna ragione. Assolutamente vuol dire che non ammettono eccezioni. Il papa Benedetto XVI, quando è andato in Africa e ha scandalizzato tanti dicendo che il preservativo non è la risposta all’Aids, suscitando problemi internazionali, ha detto semplicemente una cosa ovvia dal punto di vista cattolico, perché il divieto di contraccezione, il divieto di prevenzione, il divieto di fecondazione assistita, ecc., sono divieti assoluti che non ammettono eccezioni. Se avesse detto il contrario avrebbe sgretolato la propria etica. Questo può piacere o non piacere. Io, ovviamente, penso che invece non esistano divieti assoluti, che tutti i divieti debbano essere ricontrattati. La difficoltà nostra, il compito nostro è quello di ripensare un’etica nuova. Questa non è una cosa facile, non è un bruscolino, è una cosa complicata che bisogna fare con calma e mi pare che l’Ordine svolga delle ottime iniziative con questi incontri. Questa è la questione. In questo ci si rimette in gioco. Poi avremo gli elementi di compensazione, di dialogo, di compromesso, perché è giusto averli, è giusto cercare di arrivare a compromessi per litigare il meno possibile, anzi, per andare d’accordo, ma, detto questo, il problema di fondo è che non possiamo pensare d’aver tutti quanti ragione. Secondo me – lo dico con chiarezza – continuare a ripetere che ci sono degli assoluti è sbagliato. È una palla al piede che ci impedisce di librarci verso il futuro. Io la penso così, ciò non toglie che umanamente vado d’accordo con il professor Zeppegno, ma secondo me è profondamente sbagliato. Il nostro compito, nell’etica, è cercare di elaborare questo concetto. Non dire: “mia nonna mi ha insegnato queste cose qui, quindi questi sono i miei valori etici”, perché poi, alla fine, sono i valori della nonna, e quindi noi oggi diciamo che “le tagliatelle della nonna sono più buone” – ovverosia le tradizioni – e proprio per questo bisogna andare alla ricerca delle radici. Questo, secondo me, è solo conservatorismo da dimenticare. 94 Giuseppe Zeppegno (Direttore scientifico del Master Universitario in Bioetica della Facoltà Teologica) Non solo tra me e il professor Mori c’è il massimo rispetto umano, ma ci sono anche dei punti di convergenza. Uno qual è? In un precedente intervento il professor Mori ha parlato di tabù. Ora, se un operatore sanitario, e ogni uomo, in generale, esprimesse dei pareri semplicemente perché li ha sentiti dire o fanno parte di quella sfera di tabù che ha paura di contrastare, non agirebbe in coscienza e quindi perderebbe pienamente la sua dignità. Io credo che sia quindi indispensabile non seguire l’emozione del momento, non rincorrere i tabù, ma educare, formare la propria coscienza. In questo senso credo che la formazione della propria coscienza avvenga attraverso il confronto fra tutti gli uomini di buona volontà, nella ricerca costante del vero e del bene. Io sono convinto che nessuno di noi ha in tasca il vero ed il bene. E qui dissento da quanto precedentemente affermato dal Prof. Mori: credo che ci siano dei valori assoluti che però dobbiamo ricercare insieme, senza aver mai la certezza d’aver raggiunto la completezza della nostra conoscenza. Credo allora che per formare la coscienza sia necessario quello che stiamo facendo ora: convegni, riflessioni, magari anche a piccoli gruppi. Credo altrettanto necessario la ruminazione. Tutti noi ritorneremo a casa. Questo Convegno ci ha arricchiti, ma dobbiamo farci delle domande, chiederci cosa abbiamo capito, cosa abbiamo condiviso e non condiviso, cosa ci ha messo in discussione, perché non possiamo cercare sempre di sistemare le notizie che riceviamo in base ai nostri canoni già ben stabiliti. Cioè, c’è bisogno anche di una conversione della coscienza, così da arrivare a dire, in certi momenti della propria vita: “quella suggestione la ripenso” e così capisco che può diventare importante, può diventare un valore da acquisire. In ultima istanza, qual è la mia proposta? È la proposta di non camminare brancolando, guardando a vista. Ed è anche la proposta di non accettare il pensiero forte di chi ha tutte le certezze già ben incasellate, ma di muoverci secondo un’ottica di pensiero umile, cioè quella capacità di dire: “ho i miei vissuti, le mie convinzioni, ma le metto costantemente a confronto per cercare in tutti gli uomini che si relazionano con me ciò che veramente vale di più”. Io credo che il pensiero umile aiuti anche un operatore sanitario a non camminare su dei binari troppo rigidi, ma a cogliere le suggestioni e cercare, giorno dopo giorno, la verità e il bene. Cinzia Sanseverino (Tutor Clinico e Docente di infermieristica ‐ Presidente AIURO ‐ Componente Comitato Etico AOU di AL) Mi permetto di fare due considerazioni. Vi ho ascoltati con attenzione ed è sempre affascinante quando intervengono gli eticisti, laici e cattolici, questo volersi provocare che non è mai un provocare, questo dire che non esistono gli assoluti e poi, in realtà, gli assoluti esistono, da una parte e dall’altra. Ma voglio specificare cosa intendo. È stato affermato che bisogna fare attenzione al fatto che l’etica non è il detto della nonna, non è ciò che crediamo, ciò che ci è stato tramandato dalla nostra famiglia. Passiamo questo concetto. Sicuramente gli infermieri di questo sono ben consapevoli. Gli infermieri sono consapevoli che quando si avvalgono di quesiti etici e si pongono delle domande non sono le domande sul sentito 95 dire, su ciò che mi hanno insegnato, ma si pongono in ascolto dei valori della persona e dei propri valori che sono valori di coscienza professionali diretti sull’assistenza e su una domanda di sofferenza della persona. Su questo volevo essere un po’ più chiara e credo che i colleghi qui in sala si siano posti delle domande. Ascoltavo il professor Mori quando diceva: “vorrei che i medici non si iscrivessero alla Facoltà di Medicina, poi fanno obiezione perché si sa già che l’obiezione è presente” Sì, ha ragione, ma l’obiezione è talmente limitata su alcuni punti. Allora, da infermiera, mi pongo questa domanda: trent’anni fa, quando gli infermieri – ci sono dei colleghi in sala che si ricordano – hanno deciso di iscriversi alla scuola di infermieristica, lo hanno fatto perché ci credevano, perché volevano intraprendere questa professione. Ebbene, se trent’anni fa gli avessero detto che avrebbero partecipato ad una sperimentazione o che avrebbero dovuto somministrare una pastiglia che sarebbe diventata la famosa pastiglia per abortire, avrebbero comunque continuato a fare questo lavoro oppure avrebbero cambiato mestiere? Purtroppo la legislazione ci dà poco spazio, però non vorrei che passasse il messaggio che, siccome i giuristi ci dicono “attenzione”, noi non sappiamo più fino a che punto possiamo arrivare a protestare, a dire che la “clausola di coscienza” ci può in qualche modo tutelare. Continuiamo quindi a rimanere in ascolto dei nostri valori. Noi infermieri ci chiediamo continuamente: è giusto e fino a dove è giusto che io intervenga? È giusto continuare ad operare sulla persona, a violare quelli che sono i valori di quella persona? Purtroppo manca il collegamento, che è la comunicazione tra l’operatore, l’infermiere ed il medico, l’equipe stessa curante. È questo che viene a mancare. Mancando la comunicazione noi ci mettiamo in ascolto dei valori della persona e ci poniamo tantissime domande. Per quanto riguarda i corsi di etica, di bioetica, ben vengano, devono essere fatti, in misura sempre maggiore e a tutti gli operatori sanitari. E ancora: possiamo porre il quesito al Comitato etico, è vero, c’è una figura infermieristica che partecipa nei Comitati etici, possiamo avere un parere che non è vincolante, assolutamente non lo è, ma se non ne parliamo in equipe, anche con chi decide il progetto terapeutico – in quanto responsabile da un punto di vista legale, correggetemi il termine – ovverosia il medico, ebbene, se non ci mettiamo in ascolto tutti insieme non riusciremo a trovare la soluzione al problema. Non dimentichiamoci di continuare a metterci in discussione, di porci le nostre domande, e la “clausola di coscienza” ci dà anche la possibilità di farlo. Questo volevo dire. Grazie. Barbara Chiapusso (infermiere coordinatrice ASL TO 3 – Segretario Collegio IPASVi di Torino) Ti ringrazio, perché penso che in questo modo tu abbia risposto anche alla domanda sul Comitato etico, che sarebbe stata fatta fra poco. Proseguirei con la formazione. Francesco Casile. 96 Francesco Casile (Operatore Professionale Dirigente, Presidio Ospedaliero Maria Vittoria, Torino) La formazione assume un ruolo estremamente fondamentale per affrontare problemi etici, bioetici e relativi ai Codici deontologici. Questa mattina ho ascoltato attentamente i colleghi e la memoria mi ha rimandato, sentendo il dibattito sulla “clausola di coscienza”, ad un testo pubblicato all’inizio degli anni ’80 dal titolo “Dilemmi etici” (Uses editore), tradotto da due personaggi storici della nostra professione, Italia Riccelli e Rosetta Brignone, i quali recuperavano all’interno di questo libro una serie di casi presentati a livello internazionale dall’International Council of Nurses. Il testo cercava di porre delle domande rispetto a un caso, peraltro molto interessante. Si trattava giustappunto del caso di un’infermiera che andava a lavorare in un ospedale dove si facevano prestazioni di un certo tipo nei confronti delle donne e dei bambini, e non intendeva fare queste prestazioni. I curatori ponevano una serie di domande: l’infermiera sapeva che in quella situazione specifica si facevano quella serie di interventi? E se lo sapeva, perché l’infermiera è andata a lavorare in quel servizio e non ha chiesto di andare ad operare altrove? Sono già trent’anni che gli infermieri si pongono questi problemi di natura etica. Da una ricerca realizzata nel 2004 dal sottoscritto – con una serie di colleghi che collaborano con me –, ripetuta quest’anno per verificare se fosse cambiato qualcosa, abbiamo notato che nei corsi di laurea per infermieri c’è la presenza di corsi disciplinari sull’argomento dell’etica, della bioetica e della deontologia. Naturalmente lo studio del 2004 e quello del 2009 sono sovrapponibili perché la risposta dei coordinatori dei corsi di laurea era: “siamo in attesa di cambiare i programmi formativi e quindi non abbiamo fatto niente di diverso”. La cosa interessante che abbiamo riscontrato è questa: mentre al primo anno del corso di laurea è appannaggio della professione infermieristica l’insegnamento di alcuni argomenti che sono legati all’etica e alla deontologia, all’ultimo anno le carte si mescolano e quindi troviamo varie discipline. Quindi, ecco che ritorniamo a quello che prima diceva la collega Sanserverino, nel senso che al terzo anno noi troviamo – all’interno dei corsi di laurea per infermieri – il filosofo, il giurista, l’infermiere, il medico legale ed altri soggetti che interagiscono all’interno. Questo ci pone un problema: se è vero che nella formazione di base oggi abbiamo una presenza della formazione in questo ambito – la media è di 18 ore di insegnamento, che non è molto, ma comunque è già significativo – non basta che ci fermiamo all’interno della formazione di base, perché molto incide nella formazione continua. Volevo presentarvi un altro piccolo studio, sempre realizzato da questo gruppo. Abbiamo preso in esame un caso che è stato sottoposto agli studenti del terzo anno, alla fine del corso “Disciplina di infermieristica generale I” dell’Università di Torino: il caso specifico – con problematiche di natura etica – è quello di una paziente che arriva in neurochirurgia e viene lasciata su una barella; ai parenti viene chiesto di rimanere, altrimenti bisogna contenere. Pertanto c’è tutta una serie di problemi di tipo etico estremamente forti. L’identico caso è stato sottoposto ad un gruppo di infermieri in malattie infettive, scelti appositamente perché sono persone che fanno, ormai da anni, un corso annuale sulla prevenzione delle malattie infettive, all’interno del quale sono previste almeno due ore di etica e di bioetica. Questo per capire quale era la differenza fra gli studenti infermieri e gli infermieri. Vi posso dire che i risultati hanno confermato quello che è il 97 mio pensiero: che la manutenzione del cervello è importante. Mentre gli studenti infermieri davano delle risposte che erano quelle che mi sarei aspettato da colleghi infermieri di reparti che non fanno formazione in ambito etico – ovverosia trovare la soluzione più rapida, risolvere i problemi in maniera superficiale, eccessivamente accomodante –, gli infermieri, nonostante facciano due sole ore di formazione l’anno – da una decina d’anni – hanno dato risposte decisamente più centrate sulla risoluzione del problema etico. Credo che nella formazione post base, quindi nella formazione continua e permanente, ci debba essere costantemente una presenza di formazione che tenga conto di andare a discutere dei casi, perché se avessi fatto a me la domanda che hai fatto a Davini, ti avrei risposto: “sì, mi è capitato”, nel senso che nella mia azienda quest’anno abbiamo fatto 12 corsi di formazione sui Codici deontologici, ma era un corso di formazione fatto per le professioni sanitarie, quindi all’interno dell’aula c’erano presenti infermieri e anche professionisti di tutte le altre professioni sanitarie. Abbiamo fatto 4 corsi sulle problematiche etiche nella professione infermieristica e ostetrica, e un infermiere uscito dal corso il giorno dopo mi chiama e mi dice: “il medico vuole fare questa prestazione: io come mi devo comportare?”. La mia risposta è stata quella data in mattinata dal giurista: “se è palesemente illecita la fai, ma la discuti, se è illegale non la fai”, perché il problema di fondo è che molto spesso gli infermieri vengono a chiederti informazioni rispetto a questi ambiti dei quali, dentro le unità operative, si discute poco perché i problemi etici, nelle unità operative, sono delle cose che passano sempre in secondo piano o vengono visti più come problemi organizzativi che non come problemi etici. Il problema di fondo, che nasce anche nella formazione, è che molto spesso noi ci fermiamo sugli aspetti dell’etica del quotidiano, ma sugli aspetti della biotetica – e quindi sulla sperimentazione clinica piuttosto che su altri argomenti – poco ci confrontiamo. È chiaro che i Comitati etici su questo possono offrire delle consulenze, ma non possono dare delle risposte, tant’è che in un altro studio nazionale su 300 Comitati etici, solo l’11% dei Comitati etici discutono di problemi di natura etica che scaturiscono dalla professione. Barbara Chiapusso (infermiere coordinatrice ASL TO 3 – Segretario Collegio IPASVi di Torino) Infatti questa sarà per l’appunto la prossima riflessione. Ottavio Davini (Direttore Sanitario AOU S. Giovanni Battista di Torino) Su questo posso permettermi di essere sintetico. I Comitati etici hanno questa tra le loro potenzialità. Nel regolamento del nostro Comitato etico c’è, tra le sue funzioni, quella consultiva ed in particolare “per le strutture sanitarie, le direzioni generali, le direzioni sanitarie delle strutture afferenti al Comitato etico interaziendale al fine di ottimizzare i percorsi di buona pratica clinica e armonizzazione e, per il personale che lo richieda, in 98 relazione a questione etiche connesse con le attività scientifiche, assistenziali e didattiche, allo scopo di proteggere, promuovere i valori della persona umana”. Dopodiché, la maggior parte dei Comitati etici, questa è anche l’esperienza del nostro, lavorano prevalentemente sulle sperimentazioni cliniche – e va bene – perché presidiano un terreno importantissimo. Ritengo che da incontri come questo – e dalle riflessioni che è capitato di fare all’interno del Comitato etico – non si possa pensare – e lo dico con la chiarezza che posso usare in un contesto come questo – che queste tematiche si risolvano all’interno di una cerchia ristretta. È fondamentale che il dialogo – apprezzo il modello formativo appena citato – riesca ad espandersi e riesca ad offrire strumenti per affrontarlo, perché non possiamo minimamente pensare di affrontarlo alla garibaldina, sprovvisti di qualunque tipo di preparazione specifica. L’evoluzione – citata e richiamata più volte – della medicina ha cambiato e ha sensibilmente mutato gli scenari ed ha, per esempio, modificato il concetto di “naturale”. Quindi, tutte le nostre considerazioni etiche dovrebbero riflettere su questo: è cambiato moltissimo cosa è naturale e cosa non è naturale. Un teologo valdese in un suo libro ha scritto che “da tempo ormai la morte non è più un fatto naturale. Appena si varca la soglia di un ospedale si prende il commiato dalla natura.” Dobbiamo confrontarci con questo tipo di realtà. Dobbiamo essere coscienti che questo è il contesto e quindi attrezzarci con un percorso di formazione e di diffusione dei temi. Sono del parere che questa presa di coscienza collettiva non debba limitarsi agli operatori. Voglio citare un pensiero di un grande bioetico nord americano, Daniel Callahan, che, secondo me, ha centrato una delle questioni alla base di molte considerazioni che ci troveremo a sviluppare nel prossimo futuro sulla Sanità, sulla scienza medica, sulle professioni sanitarie, ma in un’ottica veramente ampia, e cioè: “Non è irragionevole dire che la medicina va dove va la società, che una trasformazione della medicina richiede idealmente una trasformazione della società giacchè le due cose non possono più essere tenute separate. Per ripensare gli scopi della medicina – e qui noi potremmo aggiungere: per pensare quali sono i modelli etici – occorre ripensare nello stesso tempo gli scopi e i valori della società e del substrato culturale della società.” Ho apprezzato moltissimo l’idea dell’etica che è nel vento, che si collega a quanto scritto da Callahan. Lo diceva anche Bob Dylan: “the answer is blowing in the wind…” Intervento (infermiera, Cinzia Sanserverino) Solo un’osservazione: far parte dei Comitati etici ci impone una maggiore visibilità. Sfido i presenti a dirmi se sanno chi sono i componenti del Comitato etico di questa azienda, così come di qualunque azienda. Una volta costituiti siamo poco visibili, e questa è una nostra pecca, me ne rendo conto. Perché fa parte del nostro regolamento, del regolamento di ogni Comitato, dove è scritto che ci facciamo promotori di formazione, ci facciamo promotori di giornate di aggiornamento su temi etici. Poi, in realtà, stiamo in carica 3 anni, ma questo non avviene. Mi assumo anch’io le mie colpe. Sicuramente, essendo maggiormente visibili e trasmettendo agli operatori nelle unità operative l’elenco dei componenti interni dell’azienda e del rappresentante infermieristico – parlo per gli infermieri – potrebbe aprirsi questo ponte di comunicazione che attualmente non c’è. 99 Barbara Chiapusso (infermiere coordinatrice ASL TO 3 – Segretario Collegio IPASVi di Torino) Concludiamo con il ruolo del coordinatore per sostenere il gruppo. Rosalia Buttà (Infermiere coordinatrice dell’assistenza, Oncologia ASL Bi) Il coordinatore, innanzi tutto, ha una responsabilità morale rispetto alle problematiche etiche che si vivono nel quotidiano. Ieri sentivamo la nostra Presidente parlare di ruolo di “advocacy” dell’infermiere nei confronti della persona assistita. Ecco, credo che lo stesso ruolo lo debba assumere il coordinatore nei confronti dei propri collaboratori perché aiutare, supportare i collaboratori a riconoscere prima di tutto i problemi etici e a dialogare, a confrontarsi per trovare una soluzione e dare quindi una risposta alle persone è una responsabilità molto grande, anche perché problemi non risolti causano delle conseguenze sul benessere lavorativo degli infermieri, oltre che non dare risposte adeguate alla persona assistita. Di conseguenza, il clima che viene a crearsi all’interno della propria struttura con i propri collaboratori diventa importante per favorire il dialogo, affinché questi problemi vengano esplicitati e ci possa essere un confronto. Altro elemento fondamentale che può favorire il coordinatore è quello della formazione, come già detto dal collega. La formazione permanente attraverso gruppi di lavoro ed il confronto può fornire un metodo, degli strumenti che possono servire ad affrontare queste situazioni, non basandosi soltanto su quello che è l’emotività, quello che è il coinvolgimento, quello che è il proprio punto di vista o quella che è la consuetudine di un reparto. Quindi, individuare un metodo che fornisca degli strumenti per affrontare questi problemi ritengo sia fondamentale, proprio per argomentare – anche razionalmente – delle scelte e delle convinzioni. Per ultimo, il confronto. Ritengo sia uno strumento del metodo, allargato. Ieri si diceva – così come in questa terza sessione, e ciò corrisponde alla realtà lavorativa quotidiana, tutti noi lo potremmo testimoniare – che i problemi oggigiorno sono molto complessi; quindi non è pensabile che un solo professionista possa risolvere un problema di una persona assistita, ma è necessario l’apporto ed il confronto multiprofessionale e multidisclipinare, al centro del quale, non dimentichiamolo, c’è sempre la persona assistita. Il rischio che noi operatori corriamo – nella pratica quotidiana – è quello di discutere molto fra di noi, anche in maniera approfondita, con tutte le migliori intenzioni, talvolta dimenticando la persona assistita, talvolta dimenticando di chiederle – a lei o ai suoi familiari, quando non è in grado di dare un apporto di volontà – qual è il suo desiderio, qual è il bene che vorrebbe per sé, qual è la risposta che dobbiamo aiutarlo a trovare. Ecco, credo che, in estrema sintesi, questo possa essere il ruolo del coordinatore. 100 Barbara Chiapusso (infermiere coordinatrice ASL TO 3 – Segretario Collegio IPASVi di Torino) Mi permetto di concedervi dieci minuti per un momento di dibattito con i nostri relatori. Colgo l’occasione per ringraziarli. A mio avviso è stato un dibattito molto interessante. Intervento (infermiera, Ada Masucci Docente incaricato di deontologia presso il corso di Laurea in Infermieristica dell’Università di Torino) Volevo ricordare una cosa molto importante. In un’occasione in cui si parlava del Codice deontologico, la nostra Presidente, Annalisa Silvestro, ha detto che il tempo dedicato all’elaborazione dell’articolo sull’obiezione di coscienza poteva essere quantificato in circa il 50% del tempo dedicato alla stesura di tutto il Codice. Questo la dice lunga sulle difficoltà, evidentemente anche sul dibattito, maturate all’interno del gruppo che ha elaborato il Codice. Tra l’altro ricordo che nella bozza del 2008 non c’era l’espressione “clausola” ma “obiezione di coscienza”. La mia domanda è questa: è emerso che nei codici deontologici, quando si parla di obiezione di coscienza, oggi l’orientamento è quello di rendere preminenti i diritti dell’assistito. Volevo ricordare che in altri codici deontologici – penso al codice degli infermieri canadesi e inglesi – questo orientamento era chiaramente esplicitato già nel 1985, se penso al Codice delle infermiere canadesi. Nelle versioni più recenti si arriva a dire chiaramente che il professionista deve comunque continuare a prestare assistenza al paziente fino a quando non si trova la soluzione organizzativa. E questo viene detto in maniera forte e chiara. La riflessione che ho fatto è stata questa e a voi pongo la domanda. Perché nei codici delle infermiere italiane degli ultimi 30 anni – il primo articolo sull’obiezione di coscienza lo si legge nel codice del ’77 – si è dovuti arrivare al 2009 per trovare un riferimento alla persona assistita? Ed il riferimento è in una forma che definirei piuttosto riduttiva, perché non dice che l’operatore deve continuare a prestare assistenza fino a quando si trova la soluzione, ma deve garantirla soltanto quando c’è il rischio della vita e dell’incolumità dell’assistito. Grazie. Dario Gamba (Avvocato, Consulente legale Collegio IPASVI di Torino) È una mia opinione e come tale deve rimanere. Secondo me l’autodeterminazione va bene per riempire i salotti, però poi nelle aule di giustizia non è passata, non sta passando perché la maggior parte delle sentenze penali di ultima generazione calpesta tranquillamente l’autodeterminazione in onore del valore sociale e benefico dell’attività sanitaria. Sempre più spesso vengono pronunciate delle 101 sentenze dove si assolvono i sanitari perché prescindono dall’interpello del paziente, dell’interessato, non lo coinvolgono nel processo di formazione del contratto sanitario, ma lo fanno a fin di bene, dimostrando che poi c’è stato comunque un risultato sanitario. In ragione di questa finalità e beneficialità poco importa che non si sia sentito il paziente. I codici deontologici sono figli dei loro tempi. Non si può pretendere che lancino – oltre una certa misura – il cuore oltre l’ostacolo, in quanto risiedono dentro l’ordinamento. Abbiamo visto come sono delicati i rapporti con la norma giuridica. D’altronde, sempre nello stesso Codice deontologico, quando esso parla del consenso del paziente e delle opinioni da lui espresse, nuovamente viene ribadita quella clausola che aveva fatto discutere quando era stata inserita nel Codice deontologico dei medici, dove si dice che il medico deve tener conto delle opinioni espresse dal paziente. Questo “tener conto” è quanto di più ambiguo ci sia, perché se uno fa una scelta di riconoscimento dell’autodeterminazione dice: “per me la volontà del paziente, che è controparte contrattuale e negoziatrice, rappresenta una volontà e quindi la devo rispettare”, che è ben diverso dal “tenerne conto”. Io posso “tener conto” del fatto che a lei non faccia piacere che io la strangoli; poi faccio un salto al di là del tavolo, la raggiungo e la strangolo ugualmente, perché ho “tenuto conto” di tutto quel che mi ha detto, ma penso che siano un sacco di fesserie. Questa ambiguità di fondo sull’autodeterminazione, presente nell’ordinamento giuridico, è un concetto che, man mano che si declina nel pratico, va sfumandosi. Questa è la mia impressione concreta, dal campo, dal diritto vivente. È un concetto molto ribadito. Più vado in su nei livelli, nei massimi principi lo ritrovo; più scendo nelle applicazioni pratiche meno lo ritrovo. E allora qui, probabilmente, il Codice deontologico fa il suo dovere, fa il regolamento, cioè non prende posizioni etiche così forti, malgrado le dichiarazioni di intenti, perché è una norma regolamentare, quindi non si prefigge di porre dei punti valoriali molto forti, ma lascia – lo abbiamo visto in diverse occasioni – che sia poi il rapporto di forza tra questi interessi contrapposti che si viene a realizzare, mi vien da dire nel mercato, ma sarebbe comunque riduttivo, meglio dire nel dibattito, nella dialettica tra le varie ideologie presenti, e lascia che il punto venga trovato lì, sul campo e non sulla carta della norma. Francesco Casile (Operatore Professionale Dirigente, Presidio Ospedaliero Maria Vittoria , Torino) È interessante la domanda di Ada Masucci, ma, come diceva giustamente l’avvocato Gamba, i codici sono figli dei loro tempi. Sicuramente l’art. 8 è un articolo molto discutibile, lo abbiamo discusso lungamente, continua a non trovarci d’accordo perché abbiamo una visione un po’ più liberale da questo punto di vista rispetto ai bisogni dell’utente, però teniamo conto che il Codice del ‘77 era un Codice fatto da soli 9 punti, ed erano delle mere enunciazioni che ognuno poteva interpretare a modo proprio, tant’è che il primo articolo io lo interpretai in maniera completamente diversa: non che sono contrario ad alcune prestazioni, anzi, sono favorevole. Perché quando il primo articolo diceva che l’infermiere lavora “per la vita”, era così generico dire “per la vita”: sacralità della vita o qualità della vita? Il mio punto di vista lo pongo sul tavolo come un punto di vista personale e come termine di discussione, di dibattito all’interno di questa assise. Però, teniamo conto che questo è l’ultimo Codice, che nasce dieci anni dopo il penultimo, quindi in tempi molto più ristretti rispetto ai codici precedenti: infatti il primo è del ‘60, il secondo del ’77, il terzo del ’99. Questo è il IV Codice deontologico che tiene conto di alcuni cambiamenti. Alcuni punti si potrebbero discutere, ma 102 teniamo comunque conto che è un Codice deontologico che fa riferimento a 360.000 professionisti con punti di vista che sono completamente diversi fra di loro. Sicuramente il dibattito è aperto. Credo sia la prima volta che il Codice deontologico degli infermieri viene discusso così lungamente fra gli stessi infermieri. Non era mai successa una cosa del genere, tant’è che questo Codice è rimasto nel sito della Federazione per alcuni mesi e ognuno poteva esprimere la sua opinione. Oggi noi esprimiamo le nostre opinioni e probabilmente fra 5 o 6 anni, quando si porrà il problema di modificare il Codice deontologico, troveremo sicuramente dei riferimenti diversi e su alcune parti riusciremo ad essere un po’ più avanti rispetto a quello che il Codice oggi ci dice. Naturalmente questa è solo la mia opinione. Barbara Chiapusso (infermiere coordinatrice ASL TO 3 – Segretario Collegio IPASVi di Torino) Ringrazio tutti i partecipanti per i contributi e le riflessioni fornite. 103 4° SESSIONE: Capo III – art. 12: “L’infermiere riconosce il valore della ricerca, della sperimentazione clinica e assistenziale per l’evoluzione delle conoscenze e per i benefici sull’assistito. M.A. Schirru (Presidente Collegio IPASVI di Torino) Senz’ombra di dubbio possiamo affermare che questo evento finisce in termini decisamente costruttivi. Tutti noi abbiamo assistito ad un susseguirsi di suggestioni e di input sui quali riflettere a lungo. Nel tempo che ci rimane affronteremo i temi della ricerca e della sperimentazione. Temi che vedono coinvolti gli infermieri, seppur marginalmente rispetto a quella che dovrebbe essere la logica che accompagna l’evoluzione dell’assistenza. Nelle relazioni a seguire sentiremo come nella nostra categoria vi siano ancora poche persone che si occupano di ricerca ed esse sono quelle che offrono a noi tutti gli strumenti per poter, operativamente, migliorare l’assistenza. Lascio quindi la parola al primo relatore, Valerio Dimonte, il quale affronterà il tema: “La ricerca in ambito infermieristico: quale beneficio per l’assistito?” 104 La ricerca in ambito infermieristico: quale beneficio per l’assistito Valerio Dimonte (Presidente Corso di Laurea in Infermieristica, Università degli Studi di Torino) Buon pomeriggio a tutti. Desidero sviluppare assieme a voi alcune riflessioni sull’aspetto della ricerca, tenendo conto che stiamo ragionando all’interno di un convegno sul Codice deontologico. L’obiettivo è quindi quello di individuare degli spunti di riflessione sul senso e sulla natura della ricerca in ambito infermieristico, nonché comprendere quali possono essere gli aspetti di potenzialità e di problematicità; non ultimo, come affrontarli, per offrire una risposta di tipo etico‐ deontologico al quesito: “quale beneficio per l’assistito?”. Espanderei la domanda: quale beneficio per l’assistito e per i suoi familiari o per quelle persone significative che ruotano attorno all’assistito? E ancora: quale beneficio per quelle due grandi categorie chiamate comunità – in senso generale – e Sistema Sanitario, in termini di un aumento generalizzato dello stato di salute o di un aumento della qualità dei servizi? Vi è un ulteriore aspetto da valutare: quale beneficio per l’infermiere e per la professione? Studiare quindi se stessi in quanto operatori che erogano una prestazione, proprio per via della particolarità di chi svolge questo genere di pratica professionale, che è appunto quella dell’assistenza infermieristica. Intendo sottolineare il fatto che è una prestazione strettamente a contatto con l’assistito: è un contatto col corpo, è un contatto fisico, è un contatto fatto di relazione. Non a caso esistono filoni di studio e di ricerca sugli infermieri finalizzati a tale aspetto, valutando gli infermieri non certo in senso corporativo – ovvero gli aspetti inerenti la sfera sindacale della categoria infermieristica – ma sul significato della relazione assistenziale e quali possono essere le ricadute sull’infermiere stesso. Questo è un aspetto decisamente interessante. Un altro aspetto generale – sempre di tipo etico e deontologico, ieri la Presidente Silvestro l’ha ben caratterizzato – sta nel passaggio che stiamo vivendo. Un passaggio radicale – dal punto di vista sociale e dell’organizzazione sanitaria – che riguarda la ridefinizione dei bisogni. Li conosciamo questi bisogni, ma non dobbiamo farli diventare una sorta di slogan. Quando diciamo che vi sono bisogni nuovi della popolazione intendiamo – come ieri è stato opportunamente sottolineato – che vi è una natura dei bisogni che richiede interventi di tipo professionale diversi da quelli di un tempo o complementari, che si integrano rispetto a quelli di un tempo. Questi bisogni non sono più unicamente di tipo medico, ma anche di tipo assistenziale‐ infermieristico, fisioterapico, dietistico e così via. Tutto questo è legato al discorso – trattato nella giornata di ieri – inerente a ciò che significa rispondere – con autonomia e responsabilità – a questi stessi bisogni. In sostanza, la capacità di prendere decisioni. L’autonomia non esiste senza la capacità di prendere decisioni. Questo cappello introduttivo per sottolineare come il prendere delle decisioni ha chiaramente a che fare con la ricerca e con i risultati della ricerca ed il loro utilizzo. Lo vedremo da un punto di vista deontologico, così come da ciò che la norma e il decreto delineano come Profilo professionale dell’infermiere e quindi quali sono i contorni, l’essenza dell’esercizio professionale infermieristico. Ritroviamo così due aspetti che sono strettamente legati: la ricerca e l’autoformazione. Domandiamoci il perché, non tanto in termini di norma, di regolamentazione, quanto in termini sostanziali. 105 Questo è il profilo rappresentato – sottoforma di figura – il quale sta a significare che il core del Profilo è chiaramente l’assistenza: assistenza di varia natura che risponde anche ai nuovi bisogni. Notate come è stato messo in risalto l’aspetto educativo così come quello relazionale. Il messaggio che sta dietro a questa norma – stiamo parlando del Profilo del 1994 – è che non è possibile operare una buona assistenza se nel frattempo non ci si aggiorna. Per praticare una buona assistenza devi essere aggiornato e per essere aggiornato devi accedere ai risultati che qualcun altro ha prodotto e che spesso sono i risultati della ricerca. Questi due aspetti sono complementari: uno non esclude l’altro. Oltre all’aggiornamento – quindi cercare di recuperare ciò che è già stato prodotto – un ulteriore aspetto – decisamente interessante – sta nel fatto che il Profilo consideri l’infermiere un autentico professionista laddove afferma che se ci sono domande senza risposta o con risposte dubbie, se ci sono problemi o bisogni delle persone assistite a cui non si riesce a dare risposte – perché non esiste ancora la conoscenza in materia – ebbene, quello è il momento in cui scatta la ricerca. Ci troviamo di fronte ad un aspetto che possiede anche una natura etica, nel senso che il dovere è quello di offrire risposte ai bisogni delle persone. Lo stesso Profilo afferma anche che laddove vi siano ambiti sconosciuti proprio là dev’essere presente il percorso che investe la ricerca. È interessante questo porre in relazione l’assistenza con gli aspetti organizzativi, gestionali, formativi, ed anche con gli aspetti della ricerca e dell’utilizzo dei risultati della ricerca attraverso l’autoformazione, in quanto strettamente intrecciati con l’assistenza. Dobbiamo operare una riflessione legata alla ricerca e al Profilo professionale, un Profilo che è stato emanato nel 1994, il quale rispecchia una situazione dove non esisteva un’articolazione formativa, tantomeno dal punto di vista assistenziale per livelli di complessità. Pertanto rispecchia ancora –anche se il Profilo prevede la formazione complementare – la concezione di un infermiere unico, ossia di un infermiere che pratica l’assistenza in tutti gli ambiti. Posto in questi termini parrebbe che l’infermiere dovrebbe essere in grado di portare avanti anche la ricerca. È un infermiere laureato, cioè un infermiere frutto di tre anni di formazione. Questo è un aspetto problematico che oggi possiamo porci in quanto, nel frattempo, sono emerse delle novità da un punto di vista normativo e dell’organizzazione dei percorsi di studio ed in parte anche dal punto di vista dell’esercizio professionale. Dobbiamo pertanto ragionare su più livelli, altrimenti rischiamo di commettere degli errori o di non risolvere dei problemi – ed anche questo è un errore – oppure ci aspettiamo che il livello di assistenza possa andar bene per tutti con una formazione triennale o – non ultimo – possiamo ritenere che con una formazione triennale si possano soddisfare tutte le esigenze che hanno a che fare con la ricerca. Commetteremmo un grave errore, pensando di fare ricerca senza effettivamente farla, per le ragioni che andremo ad analizzare. La Presidente del 106 Collegio di Torino aveva richiamato l’art. 12. Richiamerei anche l’art. 11, nel quale si riscontra una stretta connessione con il Profilo: l’infermiere deve operare sulla base di conoscenze validate e aggiornarsi di conseguenza. Ricordiamo anche l’art. 13 – quello della consulenza – seppur non sia così strettamente collegabile. In ogni caso, la consulenza parte certamente da un’esperienza, ma anche da una conoscenza approfondita ed inoltre parte dal fatto che questi colleghi – che hanno competenze tali da poter fare consulenza – possono sviluppare nuove conoscenze attraverso la ricerca. Questi sono gli aspetti generali che trasmettono il senso del perché dobbiamo interessarci di ricerca all’interno di questa professione che soltanto da pochi anni è stata definita formalmente con tutte le caratteristiche di una professione. Dobbiamo acquisire la consapevolezza che ormai vi sono tanti e tali problemi che non possono essere affrontati e risolti soltanto da una componente che – fino a pochi anni fa – è stata prevalente, ossia quella medica. È una componente che continua a rimanere fondamentale, ma oggi la natura dei bisogni ci porta a riconoscere che è necessario interessarsi anche di altri aspetti. Entriamo quindi nel merito degli stessi. È possibile che alcuni oggetti di interesse per la ricerca possono essere maggiormente considerati da alcune categorie di professionisti piuttosto che da altre. Cominciamo così ad introdurre aspetti di problematicità oppure aspetti che meritano una riflessione al fine di comprendere quali possono essere le risorse o le strategie necessarie per superare i problemi che si vogliono evidenziare. Essenzialmente dobbiamo considerare tutte le fasi che hanno a che fare con la ricerca. Iniziamo con la fase della scelta dell’oggetto: sembra la più banale, invece è una delle più difficili. La scelta dell’oggetto non significa soltanto definire chiaramente l’oggetto – l’obiettivo della ricerca – da un punto di vista tecnico, ma individuare con altrettanta chiarezza da dove scaturiscono le domande di ricerca. Questo è un aspetto che coinvolge tutti, non solo gli esperti della ricerca. Coinvolge tutto il mondo professionale che fa pratica, che deve imparare a porsi degli interrogativi a partire dalla quotidianità della pratica professionale così da far scaturire a sua volta domande che possono avere una risposta nelle conoscenze già esistenti, ma nella letteratura non sempre si individua una risposta. Proprio per questo è necessario avviare un percorso di ricerca. Altro aspetto non secondario: fare ricerca. Naturalmente essa richiede – e li vedremo – aspetti che possono essere problematici. Nella sua introduzione Maria Adele Schirru ha giustamente affermato che siamo ancora in una situazione dove c’è bisogno di sviluppo, c’è ancora molto da fare. Ma non solo: anche dove esistono dei risultati sussiste un altro aspetto altrettanto problematico che è quello dell’utilizzo dei risultati della pratica clinica. Rispetto alla scelta dell’oggetto desidero fare alcune riflessioni. Al nostro interno talvolta si apre un dibattito: “facciamo ricerca biomedica piuttosto che umanistica, più di tipo clinico piuttosto che di tipo assistenziale, seguiamo gli aspetti fisici piuttosto che gli aspetti dell’esperienza del vissuto del paziente, facciamo ricerca quantitativa piuttosto che qualitativa...” Ebbene, si può fare qualunque genere di ricerca. L’importante è chiedersi se siamo partiti dalla domanda giusta e la domanda giusta è sempre quella che riguarda il paziente. A volte possiamo occuparci maggiormente degli aspetti fisici, altre volte di quelli relazionali, educativi, ecc. Questa mia sottolineatura non è così banale come può apparire: talvolta giriamo attorno al problema perché ha a che fare con la natura stessa dell’assistenza infermieristica. A volte diciamo a noi stessi: “stiamo attenti a non replicare ricerche che sono di tipo medico o biomedico”. Certamente, ma la ricerca infermieristica è un’altra cosa. Tuttavia, prenderei con cautela questa affermazione, nel senso che sempre più i problemi delle persone assistite sono talmente complessi che richiedono uno studio integrato da parte di più discipline e da parte di più professioni. Diventa quindi difficile dire: “questa è una ricerca strettamente di assistenza infermieristica, questa è una ricerca strettamente di tipo medico”. Detto questo, c’è poi l’attenzione. L’attenzione che può cambiare, da parte degli infermieri rispetto ai medici, perché abbiamo esempi di ricerca condotti – mi riferisco al leader – da un 107 medico dove è presente la partecipazione degli infermieri; oppure possono esserci delle ricerche – caso decisamente più raro – dove la promozione è infermieristica e al loro interno partecipano anche dei medici. Rispetto a ciò, il riferimento dev’essere quello del Profilo. Abbiamo già detto quale dev’essere il riferimento chiave per scegliere un oggetto di ricerca: deve riferirsi ad un bisogno che al momento non ha una risposta, un bisogno della persona assistita, dei familiari o delle altre categorie precedentemente citate. La tipologia che troviamo nella letteratura scientifica di interesse infermieristico la possiamo trovare anche nella letteratura scientifica di area sanitaria. Abbiamo quindi situazioni che possono presentare delle analogie con aspetti più di tipo biomedico così come più di genere educativo. E ancora: aspetti che riguardano la situazione degli infermieri, la qualità di vita dei pazienti, aspetti educativi; non meno importante, l’efficacia di modelli organizzativi come ricaduta sulla qualità dell’assistenza e quindi come beneficio per le diverse popolazioni. Anche in Italia abbiamo uno sviluppo della ricerca, seppur limitato. Esiste una produzione e su questa mi soffermerò rispetto alle fonti e alla loro reperibilità. Un altro aspetto che richiede qualche riflessione e che pone delle problematicità da affrontare – in conclusione farò alcune proposte – è quello della gestione della ricerca, della progettazione, della valutazione, dell’attuazione dei risultati. In questo ambito abbiamo aspetti che riguardano le competenze tecnico‐metodologiche. Non si può fare ricerca senza competenze. Questo è un aspetto non certo secondario: proprio per questo ho voluto richiamare il Profilo, dove apprendiamo che un infermiere con la formazione triennale dovrebbe essere in grado di fare ricerca. È un’affermazione non del tutto condivisibile in quanto difficilmente possiamo pensare ad uno studente che, alla conclusione dei tre anni, possa essere in grado di progettare e gestire un percorso di ricerca. Accettabilità e adesione da parte di tutti i coinvolti. In un convegno etico‐deontologico l’oggetto della ricerca deve essere condiviso da quelli che sono i cosiddetti oggetti della ricerca e da chi fa la ricerca. Questo non soltanto per correttezza di informazione del coinvolgimento, ma perché c’è anche un problema di tipo etico nell’utilizzo delle risorse. Lo dico come formatore e come responsabile di un corso di laurea: facciamo e promuoviamo ricerche e indagini a qualunque livello non rendendoci conto che, attivando una qualunque di queste iniziative – le tesi fanno parte di quest’ambito – attiviamo anche un consumo di risorse, ed il consumo primo di risorse è la risorsa tempo dei malati, delle persone assistite a cui spesso chiediamo del tempo quando non di rado le ricerche non sono soltanto osservative, ma richiedono un’intervista, richiedono di andare ad indagare aspetti che non sono recuperabili dai dati della documentazione. Questo è un aspetto non indifferente. Così come richiediamo spesso del tempo anche ai colleghi infermieri o ad altri colleghi che devono utilizzare una parte del loro tempo per sviluppare anche questo tipo di attività. Questo non significa che la ricerca non deve essere svolta. Significa invece che bisogna prestare particolare attenzione a ciò che si fa, perché ciò che si fa deve essere anche utilizzabile e accettabile da parte di chi è coinvolto. Altro aspetto: è positivo partecipare a progetti di ricerca, si impara anche in questo modo. Nella maggior parte dei casi le ricerche – quelle che hanno anche un’attendibilità dal punto di vista dei risultati – in genere sono promosse da medici. Malgrado vi siano già delle esperienze in tal senso, bisogna sviluppare anche le ricerche promosse direttamente dagli infermieri. Non certo per rivendicazioni di tipo corporativo, ma per responsabilizzarsi maggiormente rispetto ad alcuni aspetti dell’assistenza. In questo modo si potrà sviluppare una maggiore sensibilità ed attenzione da parte della componente infermieristica piuttosto che da parte di altre componenti. Una delle questioni più importanti è quella delle risorse finanziarie ed economiche: non si fa ricerca senza soldi. La distribuzione dei finanziamenti segue delle regole in gran parte condivisibili: si erogano finanziamenti a chi dimostra d’essere in grado di svolgere una ricerca e quindi di 108 produrre dei risultati. Tuttavia, in una situazione dove si è al principio del cammino di ricerca, molto probabilmente bisogna pensare – anche su questo presenterò delle proposte – alla creazione di condizioni che aiutino questo genere di sviluppo. Precedentemente parlavo della formazione. Riprendo questo riferimento dai cosiddetti “Descrittori di Dublino” che sono all’interno della omogeneizzazione del sistema formativo post‐ secondario, quello che per noi corrisponde alle lauree magistrali e ai dottorati di ricerca. Questi “Descrittori di Dublino” rappresentano le competenze attese alla fine di un ciclo di studi, quindi alla fine dei tre cicli. Essi ci aiutano a ragionare: per quanto riguarda la ricerca, alla fine di un corso di laurea possiamo forse aspettarci che lo studente – il futuro professionista che andrà ad operare sul campo – sia in grado di utilizzare la letteratura? Valutando però che cosa? Forse il singolo articolo, cioè la singola ricerca? Forse no, perché bisogna avere competenze e conoscenze di ricerca approfondite. Tuttavia potrebbe essere in grado di riuscire a valutare la qualità dal punto di vista della tipologia degli articoli, se è una metanalisi piuttosto che un RCT, una revisione, un’esperienza. Inoltre, valutare la qualità delle fonti da cui l’articolo è stato recuperato, ovvero le riviste: quali riviste accreditate piuttosto che banche dati? Potrebbe, in sostanza, identificare dei quesiti. Lo abbiamo detto: è proprio del professionista il farsi le domande ed il partecipare a progetti di ricerca. Per quanto riguarda la laurea magistrale, oltre alle competenze prima elencate possiamo aggiungere che può esserci una responsabilità ed una competenza nel senso della diffusione dei risultati e della trasformazione degli stessi in pratica, cioè del loro impiego. Infine, è previsto il dottorato di ricerca dove si acquisiscono le competenze complete per essere in grado di gestire una ricerca dalla progettazione alla gestione, cosa veramente complessa. Dico tutto ciò perché questo è un sistema che si è sviluppato successivamente al Profilo professionale. Il nuovo sistema prevede questo insieme di cicli di studio. Esistono innumerevoli risultati di ricerca nel mondo – seppur la situazione italiana sia un po’ differente – ed essi sono recuperabili. Naturalmente bisogna sapere come poterli recuperare. Esistono banche dati – come molti di voi già sapranno – finalizzate, settoriali, nel campo sanitario, nel campo medico – tipo Medline – dove è presente anche la letteratura più specificamente infermieristica. In Medline ci sono più di 300 riviste indicizzate di tipo infermieristico così come esistono banche dati specificamente infermieristiche con oltre 1.000 riviste presenti nella banca dati Sinal. Le risorse quindi sono ampie, ma in genere la comunità scientifica le richiede con determinati criteri. Uno fra essi sta nel livello della rivista: dev’essere accreditata e seguire determinate regole per accettare gli articoli pubblicati nonché presentare i resoconti delle ricerche che sono state condotte. Altro criterio è quello dell’impact factor ossia quanto viene utilizzato quell’articolo, quanto viene citato, a dimostrazione del fatto che, probabilmente – sottolineo il “probabilmente” – tale articolo rappresenta un punto di riferimento molto importante. Esistono anche delle riviste infermieristiche – una trentina – che prevedono l’impact factor. Come potete vedere ve ne sono di diversa natura: riviste infermieristiche con tanto di impact factor che trattano di clinica, altre di tipo generalista, una si occupa di etica, il che vuol dire che anche il dibattito e la ricerca sull’etica 109 segue criteri che possono essere di tipo scientifico. Anche rispetto ad aspetti qualitativi si possono utilizzare criteri di natura scientifica. Presento solo un dato per dire qual è il livello di disponibilità: nell’Università degli Studi di Torino, così come in altre università italiane, abbiamo la possibilità di avere a disposizione molte riviste on‐line a full text, cioè a testo pieno. Questo supera un problema che avevano gli infermieri delle generazioni precedenti: l’accesso alle informazioni. Passiamo ora ad un ulteriore aspetto: l’utilizzo dei risultati, la produzione dei risultati. Questi risultati possono essere prodotti in Italia o all’estero: come facciamo a recuperarli e quali sono le difficoltà? Ormai attraverso le banche dati on‐line i risultati sono disponibili. L’accessibilità di questi risultati: ricerche dimostrano che se l’accessibilità non è direttamente sul posto di lavoro difficilmente si utilizzeranno i risultati recuperati dalle banche dati. Leggibilità dei risultati: significa che non sempre sono di immediata comprensione. Ci sono criteri scientifici che un infermiere potrebbe non essere in grado di valutare. Si presenta quindi la necessità di avere dei gruppi di supporto che aiutino a comprendere la validità scientifica degli articoli. Non secondario il problema della lingua: l’80‐90% dalla letteratura scientifica è in inglese. Trasferimento dei risultati nella pratica assistenziale: esistono delle raccomandazioni a livello internazionale sullo sviluppo di questa implementazione, ma è fondamentalmente partire da quesiti clinici pratici – questo è basilare – e riscontrare se la soluzione del problema è già presente nella letteratura; la si andrà quindi a recuperare e si formeranno dei gruppi. Ieri si parlava di “comunità di pratiche”, cioè dei gruppi che si incontrano su un dato problema e fanno una revisione di ciò che esiste relativamente alla problematica in questione, valutando gli studi e facendoli divenire pratica quotidiana. Questo funziona se diventa effettivamente pratica routinaria. Fatta una tantum non funziona. È una nostra caratteristica: facciamo un’esperienza, risulta positiva, siamo trasportati dall’entusiasmo del momento e poi la accantoniamo, non la trasferiamo nel quotidiano. Serve a ben poco, e qualora la volessimo riprendere, non essendoci appunto la routinarietà, diventa difficile gestirla. Richiamo un concetto di EBP per affermare che ciò che troviamo in letteratura non dev’essere inteso come una prescrizione, ma come un aiuto alla presa di decisione. Veniamo alle tre proposte che desidero presentare a conclusione della mia relazione: • come facilitare e promuovere i progetti di ricerca. In Regione Piemonte sono stati già previsti dei finanziamenti che aiutano – non soltanto a livello universitario, ma anche a livello del Servizio Sanitario – lo sviluppo delle ricerche. Dobbiamo chiederci se possiamo orientare – chiedere di orientare – anche i finanziamenti su tematiche specificamente clinico‐assistenziali, non agli infermieri, ma alle tematiche assistenziali‐infermieristiche. Naturalmente, tutti i soggetti coinvolti nei singoli progetti potranno accedere ai finanziamenti. Questo a livello regionale. In qualche azienda, forse tra le più importanti, potremmo chiedere se è possibile utilizzare una quota di finanziamento orientata a questo tipo di sviluppo. • le informazioni e le risorse esistono già, però le utilizziamo pochissimo perché non possiamo caricare sulle spalle dei singoli infermieri che lavorano nelle corsie anche questo carico morale ed etico dicendogli: “adesso devi anche aggiornarti e devi rispondere a tutti i quesiti e ai problemi che si presentano a livello assistenziale”. Non glielo si può chiedere. È quindi necessaria la presenza di gruppi di supporto che aiutino a recuperare le informazioni, a ragionarci sopra e a diffonderle all’interno delle singole aziende con dei centri o dei servizi deputati a tal fine. • il dottorato di ricerca. Senza lo sviluppo di queste competenze siamo in difficoltà perché altrimenti rimangono molti esercizi di ricerca. Esercizio di ricerca significa che tali ricerche possiedono alcune caratteristiche dell’autentica ricerca, ma i risultati non sono generalizzabili perché spesso le ricerche le facciamo noi ed i campioni sono decisamente limitati: con le risorse che abbiamo non siamo in grado di gestire delle ricerche in cui risultati possano essere estendibili 110 ad una popolazione più vasta. Non per niente – se ne parlerà anche nelle successive relazioni – sono molte le ricerche che nascono da lavori delle lauree specialistiche, delle lauree magistrali che però, per forza di cose, sono alquanto circoscritte. Ecco la nostra proposta: ci impegniamo come Università, ma credo che in questo anche il Collegio possa rivelarsi utile in termini di progettazione e di sostegno vero e proprio. L’intenzione sarebbe quella di partire, qui a Torino – entro un anno o due – con dei dottorati di ricerca che siano rivolti soprattutto ai giovani perché il futuro sono loro e quindi è giusto che si investa sul futuro. Grazie. L’Infermiere nei Comitati Etici Sanseverino Cinzia (Tutor Clinico e Docente di infermieristica ‐ Presidente AIURO ‐ Componente Comitato Etico AOU di AL) La mia relazione inizia prendendo spunto dall’art 12 del nostro nuovo Codice Deontologico: “ l’infermiere riconosce il valore della ricerca, della sperimentazione clinica e assistenziale per l’evoluzione delle conoscenze e per i benefici dell’assistito”, argomento di questa ultima, ma non meno importante, sessione; e se mi è permesso, aggiungerei una mia riflessione in merito. L’infermiere risponde ad ogni richiesta del paziente con competenza, pertinenza, responsabilità, cercando sempre di ottenere il “miglior bene possibile” per la persona. Se pensiamo al concetto che la Bioetica ha tra i suoi compiti quello di verificare la “liceità” dell’intervento “dell’uomo sull’uomo”, allora possiamo affermare con certezza che l’infermiere è un agente morale, proprio perché compie scelte continue di natura etica. Il binomio Bioetica e infermiere non può essere scisso, in quanto la rilevanza bioetica riguarda la professione infermieristica e degli operatori sanitari in genere, diverse questioni legate alla quotidianità dell’agire professionale. L’inserimento, o meglio il riconoscimento dell’importanza del professionista infermiere nei Comitati Etici, è una conquista “ relativamente recente”, dagli anni 90’, sino all’ultimo D.M. 12‐05‐ 2006 “Requisiti minimi per l’istituzione,l’organizzazione e il funzionamento del Comitati Etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali”. In effetti nel D.M. 18‐03‐19981, si legge: “ la composizione dei Comitati Etici deve globalmente garantire le qualifiche e l’esperienze necessarie a valutare gli aspetti etici e scientifico/metodologici degli studi preposti”. In tale decreto si evince per la prima volta l’importanza di altri membri con specifiche competenze, inserendo la figura dell’infermiere. Per l’infermiere vedersi riconosciuto come presenza importante in un C.E. è stato un punto di partenza e non di arrivo, in quanto non è solamente una presenza “fisica” ma può e deve dare un contributo concreto nelle ricerche medico/scientifiche. La formazione in ambito Etico/Bioetico diventa per l’infermiere un requisito fondamentale sin dal suo percorso formativo e necessario bagaglio, per un professionista completo in grado di poter essere componente di C.E., di porsi domande, consapevole di potersi avvalere di una consulenza Etica durante la sua pratica assistenziale, soprattutto quando emergono quesiti etici. Agli infermieri chiamati a far parte come membri componenti di Comitati Etici, si chiede giusta e adeguata preparazione per saper valutare un protocollo di sperimentazione clinica, o un caso clinico a forte rilevanza etica. Certamente una tale preparazione non è richiesta solo agli infermieri. Lo stesso CNB ha sottolineato in un suo documento l’importanza della formazione etica nel campo della biomedicina e della medicina clinica come presupposto e garanzia di un corretto esercizio professionale. 1 D.M. 12‐05‐2006 111 L’infermiere Assume un ruolo fondamentale in merito a tutto ciò che è inerente la sperimentazione clinica, per l’uomo, sull’uomo; ed è di fondamentale importanza, che conosca, per poter intervenire nell’analisi dei protocolli di sperimentazione clinica, i requisiti fondamentali di un protocollo di sperimentazione clinica secondo le Good Clinical Practice. E’ un documento che descrive: ¾ gli obiettivi; ¾ il disegno sperimentale; ¾ la metodologia; ¾ le considerazioni statistiche; ¾ l’organizzazione di una ricerca; ¾ i suoi eventuali successivi emendamenti ( descrizione scritta o chiarimento formale del protocollo). L’infermiera sarà in grado di conoscere le fasi dello sviluppo clinico, di valutare la validità scientifica del protocollo, ovvero la pertinenza, la validità , il valore. Sarà in grado di valutarlo in merito anche a chi fa che cosa e come reperirlo, stimare i rischi dovuti al prodotto di ricerca, stimare i rischi dovuti a procedure generali, stimare la fattibilità ed eventuali rischi/benefici per il soggetto dovuti alle procedure inclusa la rinuncia al miglior trattamento, solo fino a quando non dimostrata con certezza, endpoint primari e secondari, il disegno dello studio da eseguire, via di somministrazione del farmaco,criteri di inclusione ed esclusione, rischi e disagi, la durata attesa del progetto, criteri di interruzione e di ritiro del soggetto, gestione dati e conservazione,finanziamento e assicurazione, informazione e consenso. La riflessione che nasce, sull’importanza della figura infermieristica nei CE, è proprio inerente alla valutazione dei protocolli sperimentali. Se è ben integrata con i membri del CE, se di volta in volta valuta ed esprime consenso alla sperimentazione, il suo ruolo da infermiera non dovrebbe fermarsi qui; nel senso che l’infermiera tende a non andare oltre, non tende a cercare risposte. Spesso se vogliamo analizzare gli “aspetti economici della sperimentazione”, eventuali “incentivi”, riguardano praticamente la componente medica, anche se spesso i protocolli vedono coinvolta la componente infermieristica assistenziale. Ad esempio nella somministrazione dei farmaci sperimentali, rilevazione dei parametri vitali ovvero monitoraggio per eventuali eventi avversi da sperimentazione, registrazione e raccolta dati per lo sperimentatore…. I problemi che possono emergere, e che l’infermiera si trova ad affrontare insieme agli altri componenti del C.E., possono essere: ¾ elementi che possono influenzare il campione oggetto di studio, (influenzando l’attendibilità del risultato). ¾ valutazione dell’innovazione dell’eventuale terapia proposta versus una già esistente/tradizionale (comprese eventuali modalità per la sospensione di uno studio che si dimostri inadeguato nei risultati o addirittura dannoso). ¾ costo/beneficio; ¾ assicurazione, se presente; ¾ privacy, conservazione dei dati; ¾ correttezza e completezza delle informazioni; ¾ Consenso informato. A tal proposito, il professionista è consapevole che il consenso informato assume un ruolo fondamentale nella sperimentazione, è un momento etico in cui il soggetto assume delle responsabilità di fronte a sé stesso. Nel protocollo secondo le GCP ICH‐ Maggio 2004, recepite nel 112 nostro stato con D.L 200 del 6‐11‐072, nei principi da considerare inerenti al consenso informato si legge : “ in nessun caso il consenso del soggetto può implicare una rinuncia al diritto‐indisponibile ed inalienabile‐ alla vita e all’integrità personale, (fisica,psichica e morale). Le ricerche o sperimentazioni sull’essere umano non possono giustificare atti in se stessi contrari alla dignità della persona e alla legge morale, l’eventuale consenso dei soggetti non giustifica simili atti…..”. Purtroppo succede spesso, che gli stessi infermieri non sono a conoscenza della sperimentazione clinica che avviene nella loro Unità Operativa, per tale motivo mi ritrovo a chiedermi quanto potrei io, in quanto componente di C.E, e quanto i miei colleghi nei loro C.E di appartenenza, potrebbero essere incisivi e chiedere, con il consenso di tutti i membri e soprattutto del Presidente del CE, di parlare con lo sperimentatore e di coinvolgere l’intera equipe infermieristica, di citarla nelle pubblicazioni scientifica, di coinvolgerli anche per la distribuzione di eventuali incentivi. Coinvolgere gli infermieri nella sperimentazione clinica, in un progetto di ricerca, vuol dire avvalersi anche della rappresentante delle professioni infermieristiche, componente del CE, la quale potrebbe essere un valido supporto nel passaggio di informazioni, ottenendo così uno scambio comunicativo continuo anche per la valutazione in itinere della sperimentazione, e gli infermieri non sarebbero più solo esecutori di assistenza. Certamente, un altro passo fondamentale per la nostra professione è quella di diventare promotori stessi di studi sperimentali, in cui attraverso uno “ sguardo infermieristico” ne conseguirà comunque un protocollo multidisciplinare, in cui la ricerca attiva coinvolge competenze cliniche, specialistiche, metodologiche, statistiche,farmacologiche… Nel 1998 vennero pubblicate alcune linee guida dalla Research Society of the Royal of Nursing, con lo scopo di dare alcune semplici indicazioni agli infermieri con un ruolo di supervisori a ricerche sperimentali che si svolgono nelle loro Unità Operative3 : ¾ Essere d’accordo con delle precise linee‐guida prima dell’avvio della sperimentazione; ¾ Essere consapevoli dei principi etici che guidano la ricerca e accertarsi che essi siano condivisi da tutti coloro che vi partecipano; ¾ Accertarsi che tutti i ricercatori che partecipano alla ricerca conoscano e si attengano alle linee guida sull’integrità morale del ricercatore; ¾ Aiutare coloro che conducono la ricerca a esplicitare i dilemmi etici che emergono dal progetto stesso e a trovare le relative soluzioni; ¾ Assicurarsi che l’intento perseguito dalla ricerca sia formalmente presentabile ai Comitati Etici interni ed esterni; 2 Requisiti di un protocollo di sperimentazione clinica secondo la GCP ICH maggio 2004 tratto da A. Bignamini. Comitati etici. Storia e funzioni ‐ maggio 2004. Tratto da A. Spagnolo. 3 Christine M. Beerman. Nurse's role in bioethics. In AORN Standard Recommended Practices, and Guidelines. 1997. Ralph Pinnock, Ian Crosthwaite. The Ethics Committee within the hospital in Auckland (New Zealand): The first 7 years. The New Zeland Medical Journal – 5 Novembre 2004, vol 117 n°1205 McDaniel, Charlotte phD, STM . the Hospital etich committees and the nursing parteciaption . the Journal of nursing administration, da http:// www.ovidsp.it accesso il 10 nvembre 2009. F.D.Pilotto, I comitati di Bioetica e l’infermiere. Alpha Omega, VIII,n.2,2005‐ pp 263‐281. A cura della redazione, dossier, Infermieri e sperimentazioni cliniche. Assistenza Infermieristica e ricerca 2004, 23, 2 . A.Liberati. Editoriale. Una flebo di trasparenza per i Comitati. R&P 2004; 20: 89‐90 P.Culotta, I.Feroce, L.Callegaro. Recensione, Ricerca clinica. Dalla Good Clinical Practice alla buona Assistenza. Giornale Italiano di Farmacologia, 22, 1, 2008. Comitato Nazionale per la Bioetica, bioetica e formazione nel sistema sanitario, Presidenza del Consiglio dei Ministri,1991. Leavitt F.J. Education nurses for their future role in bioethics, in Nursing ethics 3/1 1996 39‐52. 113 ¾ Assicurarsi, prima di iniziare la ricerca, che il progetto di ricerca proposto sia stato approvato da tutti gli organi competenti; ¾ Assicurarsi, prima dell’inizio della ricerca, che ci sia stata l’approvazione da parte dei C.E locali, e di quelli coordinatori, (cioè dei Comitati del centro di riferimento di una sperimentazione multicentrica), quando il progetto coinvolge pazienti e clienti tutelati dal Servizio Sanitario Nazionale; ¾ Conformarsi alle linee guida riguardanti l’integrità morale del ricercatore; ¾ Fornire training, tutoraggio e una costruttiva valutazione dell’operato del ricercatore. Facendo un analisi della letteratura sull’infermiere nei Comitati Etici, ho trovato un interessante articolo tratto da “ the Journal of Nursing Amministration”, nel quale si parla dell’intervento degli infermieri nei CE ospedalieri. Attraverso una ricerca multidisciplinare si è analizzato lo scambio comunicativo fra i vari componenti i CE, e il contributo fornito dai vari professionisti che vi aderiscono. E’ stato scelto un campione di 4 CE ospedalieri di un'unica grande regione Inglese, fra gli 8 presenti e che avevano chiesto di far parte della ricerca. Sono stati scelti in base a questi 4 criteri: ¾ struttura del CE presente da almeno un anno; ¾ i Componenti non dovevano avere avuto altre esperienze nei CE; ¾ facilmente raggiungibili; ¾ composizione multidisciplinare. Totali dei componenti CE presi in esame 99. I dati sono stati raccolti da un ricercatore osservatore, che ha registrato tre sessioni di CE, per 9 mesi, ( riunioni di CE mensili, dalla durata media di 1h e 30’). Le conclusioni che si traggono dalla lettura è che gli infermieri che partecipano ai CE possono essere descritti per la maggior parte di sesso femminile, di età media di 45 anni, che ricoprono ruoli amministrativi e gestiscono la parte clinica assistenziale. Gli infermieri nei CE o sono eletti o hanno scelto autonomamente di parteciparvi ed il loro incarico e di circa 4 anni. Sono state analizzate le informazioni sulla comunicazione / informazione percepita e ricevuta. La comunicazione fra il Presidente e i componenti il CE è abbastanza equilibrata, ma parte sempre dal Presidente. Lo studio rivela che nonostante la partecipazione al CE da parte degli infermieri sia numerosa, vi è poca comunicazione, e vi sono molti studi che riportano che nonostante la loro partecipazione, la loro presenza non è una presenza “ attiva”. Il presidente del CE è quasi sempre un uomo, è sempre un medico. Emerge anche un altro dato interessante, la mancanza di informazioni sui componenti il CE, all’interno della stessa azienda, la loro poca preparazione in ambito etico, la quasi totale assenza di comunicazione fra il CE interno e tutti gli altri professionisti presenti in ospedale. La partecipazione dell’infermiera come componente membro del CE, potrebbe sicuramente essere più incisiva e pregnante se oltre alla valutazione dei protocolli sperimentali di ricerca clinica, potesse essere punto di riferimento per la consulenza etica. In effetti possiamo affermare che il ruolo dell’infermiera all’interno di un CE potrebbe essere così articolato: ¾ Conoscenza e aderenza ai “ valori” propri della professione e attenzione alla persona, riconoscendo il suo coinvolgimento etico nei problemi che emergono durante l’assistenza; ¾ esprimere eventuale disaccordo con le decisioni mediche se non inerenti al valore della persona; ¾ riconoscere i proprio valori e problemi e comprendere se siano centrati davvero su quelli del paziente; ¾ conoscere e rispettare la persona soprattutto sul concetto di solidarietà e ricerca del “ bene dell’uomo”; 114 ¾ partecipare sempre agli incontri del CE, sollecitare e promuovere eventuali discussioni etiche, partecipando anche alle riunioni infermieristiche e multidisciplinari; ¾ proporre soluzioni all’interno di un CE; ¾ aggiornarsi per migliorare i proprio sapere e l’autocoscienza; ¾ se è possibile, portare il dibattito etico anche al pubblico. Lo spessore etico dell’attività infermieristica è evidente, il contributo all’elaborazione etica è unico e insostituibile; il sapere esperienziale infermieristico porta raccolto in sé la storia del paziente, la sua sofferenza, il quesito etico che in ogni momento dell’assistenza può emergere. Tutto ciò avviene manifestandosi in un modo completamente differente rispetto a tutte le altre professioni, rendendo la professione infermieristica una delle più autorevoli espressioni della crescita morale che un gruppo di professionisti può sviluppare. Riflettere sull’agire, presupposto per la coerenza nell’azione Daniela Resta ( infermiere coordinatore – AOU S. Giovanni Battista di Torino – S.C. Geriatria e Malattie Metaboliche dell’Osso – sede IRV ) In sistemi complessi che si configurano per dare risposte a domande sempre più complesse, ciò che viene prodotto attraverso le continue interazioni degli elementi che li compongono, diviene l’elemento strategico e contemporaneamente flessibile che spinge costantemente i sistemi a interrogare se stessi. L’approccio riflessivo utilizza una conoscenza dei fenomeni processuale, circolare, basata su sistemi di retroazione continua tra soggetti, contesti, strumenti e considera la realtà una costruzione riflessiva che avviene attraverso tali relazioni, incluso l’intervento del professionista. Il professionista risponde alla complessità con una gestione selettiva delle informazioni disponibili, attraverso costruzione di deduzioni che gli consentono di osservare le cose senza interrompere il flusso dell’indagine in atto. Ciò diviene possibile in quanto egli ha costruito un repertorio di esempi, di immagini, di chiavi interpretative e di azioni che derivano dalla pratica. Nel cogliere il senso di una situazione la vede come un qualcosa che è già presente nel proprio repertorio di conoscenze ed esperienze. Ciò gli permette di considerare similitudini e differenze rispetto alla situazione consueta. La fenomenologia qui implicata è che ogni volta che si dice che qualcuno prende una decisione, quello che in realtà accade è che sta lavorando retrospettivamente. Quando ci si sente pronti a dichiarare che una decisione è stata presa, si ha a portata di mano un risultato che deve essere stato provocato da una scelta più antica. Decidere consiste nel localizzare, articolare, ratificare tale scelta più antica riportandola al presente. La storia recente è vista in retrospettiva, con in mano i risultati provvisori per vedere quale decisione potrebbe render conto di quel risultato. Quella decisione plausibile è la decisione che le persone annunciano. L’aspetto cruciale in tutto ciò è che una decisione è un atto di interpretazione e non un atto di scelta. Questo non sminuisce né banalizza in alcun modo l’atto della decisione. Quello che fa è suggerire un percorso diverso per giungere a decisioni migliori. L’infermiere è attivo rispetto all’assunzione di decisioni che riguardano la scelta e l’attuazione di azioni infermieristiche in risposta ai bisogni identificati. Le decisioni cliniche e i processi che le sostengono rappresentano un aspetto importante nella cura e nell’assistenza infermieristica. Sono 115 infatti le decisioni cliniche che determinano l’efficacia dei comportamenti sanitari e gli stessi esiti sulla salute dei pazienti.4 Ma su quali basi il professionista sanitario prende la sua decisione clinica? A partire dagli anni ’70, si è sempre più sviluppato il concetto di assistenza basata sulle prove di efficacia. La nascita dell’era dell’informazione, la rapidità con cui le informazioni e il loro flusso attraversano il mondo, hanno trasformato i processi decisionali dei professionisti della salute. Essi stessi hanno evidenziato la necessità di sostenere il processo decisionale attraverso l’utilizzo delle migliori prove di efficacia disponibili. L’Evidence Based Practice, fondando l’attività professionale sulla nozione di processo decisionale razionale5, consentirebbe, da una parte, all’utente di usufruire dell’intervento ragionevolmente più efficace e con i minori effetti collaterali (dimensione etica), e, dall’altra, al professionista di agire non solo sulla base di presupposti teorici o di esperienze personali (dimensione professionale) ma anche sulla base delle risorse disponibili ai trattamenti di provata efficacia (dimensione economica).6 Tuttavia, dati di letteratura internazionale e indagini locali indicano che molti professionisti, nel prendere decisioni, si riferiscono prevalentemente a quanto appreso durante la formazione di base o i corsi di formazione permanente, all’esperienza pregressa e al consiglio di colleghi o di esperti.7 Il ricorso a tale conoscenza empirica indica che, nel processo di decision‐making, gli infermieri ricorrono spesso a ”scorciatoie” metodologiche nei confronti delle informazioni disponibili. Essi utilizzano solo una parte delle informazioni a loro disposizione sul contesto di riferimento per elaborare decisioni, influenzando l’orientamento delle scelte con una forte impronta soggettiva. Le ricerche condotte nell’ambito della psicologia cognitiva dimostrano come i processi decisionali risultino condizionati dagli schemi cognitivi dei PAZIENTE decision makers, attraverso i quali essi costruiscono la loro rappresentazione COMPORTAMENTI del mondo ed il loro scenario di riferimento. Si pone dunque il esprimono INFERMIERE problema di analizzare tali schemi, Bisogno di allo scopo di cogliere più a fondo le assistenza leggono RAPPRESENTAZIONI relazioni tra i diversi fattori infermieristica MENTALI contingenti e soggettivi che contribuiscono alla strutturazione dei Assistenza infermieristica processi decisionali. Decisioni assistenziali I dati presentati nella relazione sono tratti da uno studio qualitativo che affronta il problema relativo alla pregnanza del concetto di bisogno di assistenza infermieristica nelle decisioni assistenziali. Scopo del lavoro era di descrivere le rappresentazioni mentali degli infermieri riguardo il concetto in esame e le correlazioni esistenti tra queste e le decisioni assistenziali, in modo da rendere evidenti i sistemi di credenze attraverso i quali vengono generate le decisioni e attribuito loro un significato. 4 Thompson C. Clinical experience as evidence in Evidence‐based Practice, Journal Advanced Nursing, 2003, 43 Esperienza clinica o prove di efficacia? Nursing Oggi 2004, 1 5 Hamer S. Collison G. Evidence Based Practice Assistenza basata su prove di efficacia, Mc Graw Hill, 2002, p.11 6 Gamberoni L. Marmo G. Bozzolan M. Loss C. Valentini O. Apprendimento clinico, riflessività e tutorato EdiSES, Napoli, 2009, p. 118 7 Gamberoni L. Marmo G. Bozzolan M. Loss C. Valentini O. op. citata, p. 119 116 Il concetto di bisogno di assistenza infermieristica rappresenta la prospettiva con cui viene considerata la persona assistita e l’elemento che giustifica l’interazione con quest’ultima. Tuttavia, il suo essere categoria astratta non permette agli infermieri la sua osservazione diretta, ma solo inferenze a partire dall’osservazione dei comportamenti delle persone assistite. Tale caratteristica comporta che, per poterlo possedere, maneggiare in diverse interpretazioni e traduzioni operative e per cogliere ciò che serve alle persone che si assistono, il concetto debba essere elaborato e “mentalmente rappresentato”. La pluralità di costrutti culturali, a volte molto diversi, rende ancora più difficoltosa la rappresentazione simbolica del concetto. Ci si trova in una situazione “paradossale” in quanto, alla grande abbondanza di idee e di concezioni teoriche non corrisponde una rappresentazione dell’oggetto circoscritta e realistica. E non solo perché sia difficile scegliere, ma perché, in tale abbondanza, è difficile vedere8. Ne consegue che lo spazio lasciato all’utilizzo delle rappresentazioni mentali personali nella comprensione della richiesta assistenziale è molto ampio, correndo il rischio che queste vengano costruite attraverso sistemi di rapporti e paradigmi di linguaggio attivati di volta in volta. Le rappresentazioni si costituiscono quali punti di contatto tra il soggetto e la realtà esterna. Il legame che unisce il soggetto alle proprie rappresentazioni è duplice: da un lato queste conducono l’interpretazione della realtà sulla base degli schemi cognitivi del soggetto, dall’altro, attraverso questi schemi, il soggetto costruisce la propria rappresentazione del mondo e lo scenario di riferimento9. Il legame fra rappresentazioni mentali e processi decisionali è stretto: conoscerlo e descriverlo significa poter cogliere ciò che dà forma all’azione, almeno quella intenzionale e consapevole. Lo studio è stato condotto seguendo il metodo Cognitive Mapping Approach che utilizza le mappe cognitive per rappresentare gli schemi cognitivi del decisore. L’acquisizione dei dati e l’estensione delle mappe è stata ottenuta seguendo le fasi del Documentary Coding Method: al campione di 14 infermieri, individuato secondo la tecnica di campionamento non probabilistico a palla di neve, è stata proposta la lettura di un caso assistenziale complesso e richiesto di rispondere a tre domande aperte. Il software T‐LAB® nella versione Pro.6.0.02 ha consentito di realizzare le analisi tematiche e comparative sui testi e di ricostruire le mappe cognitive su cui avviare l’analisi dei dati. Successivamente all’analisi dei testi, secondo il metodo e gli strumenti prima descritti, si è proceduto ad una loro attenta lettura allo scopo di estrarre le affermazioni significative dal loro contenuto. Questo ha permesso di raffinare ulteriormente le rappresentazioni ottenute attraverso le mappe cognitive e contestualizzare le dichiarazioni offerte dagli intervistati I risultati dello studio evidenziano una significativa variabilità nell’interpretazione della situazione assistenziale esposta nel caso tale da portare i decisori a scelte anche molto diverse tra loro in merito al caso in oggetto. Dal punto di vista dimensionale, la mappa ottenuta dall’analisi dei testi è composta da 202 unità lessicali; la frequenza con cui queste ricorrono nei testi hanno valori intercorrenti da 4 fino ad un massimo di 108. Le unità lessicali più frequenti risultano essere rispettivamente Paziente, Bisogno, Figlia, Infermiere. Queste quattro parole rappresentano i concetti con maggiore centralità cognitiva, ovvero quelli su cui poggiano i processi cognitivi degli intervistati. A partire dai testi ricavati dalle interviste è stato possibile disegnare una mappa concettuale complessiva, presentata nella figura seguente. 8 Olivetti Manoukian F. Produrre servizi. Lavorare con oggetti immateriali. op. citata, p. 69 Muzzi C. Ortolani C. Le mappe cognitive come strumento di analisi delle distanze cognitive nel processo decisionale. Rivista di Studi Organizzativi, Franco Angeli Editore, Milano, 2003 9 117 Lo spazio bi‐dimensionale è organizzato da due assi (X = orizzontale e Y = verticale) che, in analogia con le mappe topografiche, consentono di individuare i “punti cardinali” e quindi di orientarsi nell’interpretazione. A partire da questa prima lettura, i testi sembrano essere complessivamente organizzati dalle direttrici illustrate nel grafico alla pagina successiva. Interventi educativi Interventi Aree assistenziali Indagine diagnostica Competenze educative Per ognuna delle parole chiave sono state dettagliate le associazioni fra queste e i termini presenti all’interno dei testi. I risultati hanno prodotto rispettivi grafici dove il lemma selezionato è posto al centro e gli altri distribuiti intorno ad esso, ciascuno a una distanza proporzionale al suo grado di associazione. Di seguito viene presentato il diagramma delle associazioni relative al lemma “bisogno”. 118 Sulla stessa parola chiave si è avviata l’analisi delle sequenze a partire da una matrice in cui sono registrati tutti i termini predecessori e tutti i successori di una singola unità lessicale. Il valore della loro frequenza è stato trasformato in valori di probabilità e visualizzato in grafici, all’interno dei quali la distanza di un termine dal lemma centrale è proporzionale alla probabilità che hanno di precederlo o di succedergli. Nella figura che segue viene riportata la riproduzione grafica dell’analisi delle sequenze relativa al lemma “bisogno”: a sinistra, in blu, sono riconoscibili i termini predecessori mentre a destra, in rosso, i probabili successori. Se tra i termini predecessori del 0,050 CHIRURGICO lemma in oggetto sono presenti vocaboli relativi all’esercizio delle INFERMIERE PAZIENTE INFERMIERISTICO competenze infermieristiche CONSIDERARE RILEVARE 0,025 nell’ambito della valutazione, VALUTARE individuazione, rilevazione dei EVIDENZIARE FAMIGLIARE 1,6 0,4 0,8 1,2 2,0 bisogni, queste scompaiono del tutto INDIVIDUAZIONE BISOGNO se si considerano i termini successori, ASSISTENZA - 0,05 - 0,04 - 0,03 - 0,02 - 0,01 importanti per segnalare il livello di PAZIENTE interdipendenza del nodo centrale rispetto ai concetti espressi AUSILIO - 1,0 all’interno di un testo. In questo caso INESPRESSO assistiamo ad una desertificazione del SICUREZZA campo, nel quale non è presente - 2,0 alcun rimando al concetto di bisogno di assistenza infermieristica. L’assenza dei contenuti specifici professionali (presente anche nei diagrammi relativi ai termini “infermiere” e “paziente”) genera il rischio di concepire l’assistenza infermieristica quale assistenza non richiedente l’esclusivo contributo infermieristico. Le probabili cause di ciò sono da ricercarsi nel fatto che è praticamente assente la correlazione dei bisogni di assistenza infermieristica ai problemi di salute descritti nel caso, alle abitudini di vita del paziente e ai fattori che ne influenzano la contestualizzazione. Assenza, questa, che non permette di comprendere l’insieme della situazione di bisogno di quella persona, impedendone una lettura integrata tra il piano scientifico dato dalle evidenze e quello della comprensione. Un’ulteriore conseguenza della mancata contestualizzazione e collegamento con il problema di salute è la rappresentazione semplificatoria dell’assistenza infermieristica. Questa emerge dai dati raccolti come l’insieme di attività volte alla gestione del bisogno anziché delle decisioni prese in sua risposta. Il fatto che nessuno degli intervistati abbia dichiarato di assumere le proprie scelte anche alla luce delle evidenze scientifiche aggiornate, fa pensare che le relative rappresentazioni dei bisogni discendano soprattutto dalle sole conoscenze di senso comune piuttosto che dall’associazione di 119 queste con quelle derivate dalla riflessione sull’esperienza e pratica professionale e dall’elaborazione concettuale. I testi delle interviste e le mappe disegnate evidenziano le difficoltà incontrate dai soggetti nel definire il concetto di bisogno di assistenza infermieristica: per descriverlo, essi utilizzano dati legati alla pratica quotidiana, ovvero le azioni e le attività intraprese in sua risposta, invece che gli elementi professionalizzanti che lo contraddistinguono. In assenza del processo del ragionamento diagnostico, quale base per l’individuazione dei bisogni di assistenza infermieristica, sembra piuttosto che il percorso utilizzato per il loro riconoscimento avvenga a ritroso: poichè svolgo quell’azione, quell’azione mi riguarda e mi conduce al bisogno. In questa chiave, non essendo vincolata dalle regole metodologiche del processo assistenziale, l’individuazione dei bisogni e le decisioni assistenziali sono agite nella totale discrezionalità del singolo e basate su scelte di senso comune. In situazioni di questo tipo il processo decisionale di scelta avviene “nel corso di una carriera di azioni”, ovvero che, come afferma Garfinkel10, i suoi risultati sono resi sensati retrospettivamente al fine di sostenere la scelta operata. La rappresentazione del termine “infermiere” attraverso il grafico che riassume le unità lessicali a questo associate, disegna una figura di professionista in cui, in questa situazione assistenziale, sembra prevalere la componente tecnica dell’assistenza infermieristica, abbracciando un concetto di competenza che è prodotto di una logica tecnico‐strumentale. I dati emersi dallo studio, seppur bisognosi di successive indagini, hanno messo in evidenza che sembra non esistere, per gli infermieri, un concetto di bisogno di assistenza infermieristica definito, al quale riferirsi quando impegnati nelle scelte decisionali. Il metodo utilizzato nella conduzione dello studio ha permesso, attraverso l’estensione delle mappe cognitive quali rappresentazioni della parte del sistema di credenze di un individuo attivata dal problema in esame, di mettere in luce la varietà e le differenze nelle rappresentazioni del concetto e della distanza fra queste e quanto definito centrale per la professione infermieristica. Tale distanza si traduce nell’ancoraggio delle decisioni assistenziali piuttosto che ai paradigmi fondanti della disciplina infermieristica e a una visione sistemica in risposta alla complessità delle situazioni, ai rituali provenienti dalla pratica quotidiana e al senso comune. Inoltre, poiché le rappresentazioni mentali sono connotate culturalmente e socialmente, una rappresentazione mentale del concetto portante della professione infermieristica così sprovvista di elementi distintivi e un linguaggio utilizzato per descriverlo così vago e insufficiente dal punto di vista simbolico, intacca la capacità di rappresentazione di sé come professionista e, di conseguenza, la capacità di rappresentarsi agli altri come tale. Tuttavia sarebbe riduttivo considerare tali limiti come sola espressione dell’inadeguatezza dei singoli professionisti: questi ultimi sono piuttosto portatori degli effetti di un processo di professionalizzazione ancora giovane e per questo fragile. La centralità di concetti e paradigmi condivisi, l’utilizzo del ragionamento diagnostico come pratica quotidiana non sono obiettivi così lontani, ma occorre, per usare le parole di Olivetti Manoukian, “staccarsi da ciò che si deve, per investire su quello che si può perché quello che si può è quello che già c’è e che non è visto e valorizzato”. Quella che può apparire un’arretratezza può essere allora colta come un’opportunità e diventare un terreno di sperimentazione di un legame da costruire tra pratica, sviluppata e diffusa e ricerca. Per affrontare ciò sono necessari strumenti che superino la sola condivisione e la concordanza su concetti o paradigmi, per non cadere nell’equivoco descritto da Weick: “quando le persone concordano su un paradigma, è probabile che siano d’accordo sulla sua esistenza più che sulle sue 10 Garfinkel H. Studies in Ethnometodology. Prentice Hall. Englewood Cliffs. NJ. 1967 Disponibile al seguente indirizzo web: http://www.scienzepostmoderne.org/Libri/StudiesEthnomethodology.html (ultima consultazione 22/10/2009) 120 regole o sulla forma razionalizzata”11. Si tratta di ricostruire i determinismi e i modelli culturali interiorizzati che hanno strutturato i pensieri tanto da essere connaturati: per poter aprire e mobilitare delle possibilità di conoscenza che non siano solo attivazione di pensieri pre‐pensati, applicazione di saperi precostituiti e per poter dare agli elementi della realtà esterna dei significati che non siano solo quelli già acquisiti12. Un primo strumento che si delinea come utile a tale scopo deriva dal metodo impiegato in questo studio e si configura nelle mappe cognitive, che oggettivano le rappresentazioni mentali dei soggetti e contemporaneamente ne esplicitano i meccanismi sottostanti. Ma non si tratta solo della loro costruzione: il passo successivo necessario per sfruttare appieno il loro supporto è quello di condividerle. Questo permetterebbe di avviare il confronto sui punti di distanza cognitiva nelle percezioni dei diversi soggetti e passare, successivamente, alla loro ricomposizione. Il confronto tra le mappe e le diverse interazioni mentali che raffigurano, arricchisce i costrutti e i nessi causali che li legano e permette di affrontare le distinte visioni e costruzioni della realtà originate dal personale set di esperienze e dal ruolo professionale del soggetto. Quale può essere lo spazio dove tale confronto, così intenso, può avvenire? Quale luogo di incontro per i professionisti? Le Comunità di Pratica si presentano come lo strumento che offre le caratteristiche utili ai soggetti per interagire, collaborare, cooperare attraverso una forma di apprendimento mutuato, basato cioè sulla condivisione delle esperienze. I dati ricavati dal lavoro suggeriscono la possibilità di attivare Comunità di Pratica Infermieristiche dove i professionisti convergano le loro riflessioni su quegli elementi oggettivi che, offrendo la chiave di interpretazione delle rappresentazioni mentali, facilitino il passaggio dall’operatività alla concettualizzazione. Processo, quest’ultimo che porta a riflettere sul rapporto tra pensiero, linguaggio e cultura, in questo caso professionale. La possibilità di analizzare e condividere rappresentazioni mentali di concetti apre la possibilità di non essere parlati dalla cultura, ma di poter riflettere su di essa. La condivisione e diffusione di queste conoscenze anche nelle loro componenti tacite è fondamentale, perché un individuo è in grado di elaborare concetti solo se è consapevole di ciò che conosce. La spirale continua, così attivata, è possibile che alimenti costantemente la pratica riflessiva su cui attivare processi di apprendimento per i singoli professionisti, per la comunità professionale, per le organizzazioni, avviando nel tempo anche una trasformazione del linguaggio, via per una trasformazione comportamentale. La fatigue: comprendere per aiutare. Gianna Regis (Responsabile del progetto di Educazione Terapeutica, In collaborazione con tutto il gruppo Infermieristico S.O.C. Oncologia dell’Ospedale di Ivrea ASL TO4) Le parole chiave di questo lavoro sono “la fatigue nella persona assistita in ambito oncologico”, e “l’educazione terapeutica quale momento fondamentale dell’essere infermieri”. Come un intervento educativo effettuato dagli Infermieri, rivolto agli Utenti con patologia oncologica, può modificarne i comportamenti e quindi migliorarne la qualità di vita. 11 12 Weick K. Senso e significato nell’organizzazione. op. citata p. 129 Olivetti Manoukian F. Produrre servizi. Lavorare con oggetti immateriali. op. citata, p. 72 121 La CANCER RELATED FATIGUE è un malessere persistente, un soggettivo senso di stanchezza o di esaurimento correlato al cancro o ai suoi trattamenti, non proporzionale alle attività svolte e che interferisce con le normali attività quotidiane. E’ una condizione soggettiva spesso più invalidante del dolore, della nausea e della depressione, descritta dai Pazienti in vario modo utilizzando aggettivi come “affaticato, indebolito, esausto, spossato, sfiancato, stanco, intorpidito”. Alcuni Pazienti percepiscono la fatigue come un’ alterazione psicologica , ad esempio la perdita di concentrazione e di memoria o mancanza di volontà o del desiderio di compiere qualsiasi cosa. Dal 2000 la fatigue è riconosciuta a tutti gli effetti come una malattia correlata al cancro e non più considerata semplicemente come un insieme di sintomi che affliggono l’ esistenza e fiaccano la volontà del malato di tumore. Incidenza: E’ il più comune sintomo dei Pazienti oncologici: il 70‐80% ne è affetto. In corso di chemioterapia 80% In corso di radioterapia 80% A due anni dal trattamento 70% In fase terminale 80‐90% Cosa percepisce il Paziente: • Sensazioni fisiche: difficoltà a svolgere le quotidiane attività • Sensazioni di tipo emozionale: diminuite motivazioni e cambiamenti del tono dell’ umore • Sensazioni di tipo cognitivo: difficoltà a concentrarsi o a formulare pensieri compiutamente Destinatari del progetto educativo I destinatari di questo progetto sono tutti i Pazienti oncologici ( di qualsiasi età, sesso , e patologia) che afferiscono al Day‐Hospital del Centro Oncologico dell’Ospedale di Ivrea, ASL TO4, in trattamento chemioterapico. Analisi dei bisogni educativi dei destinatari Presso il Day‐Hospital oncologico di Ivrea, viene regolarmente distribuito a tutti i Pazienti il QuestionarioTIQ ( Therapy Impact Questionnaire), per la valutazione della qualità della vita e per rilevare i sintomi che maggiormente hanno afflitto i Pazienti. (ALLEGATO 1) Il TIQ E’ uno strumento multidimensionale, che considera 4 aree ritenute fondamentali nella valutazione della qualità della vita, per un totale di 36 item. Le domande tendono ad evidenziare le difficoltà o gli stati negativi subiti dai Pazienti tramite una scala verbale di tipo Likert con 4 possibili risposte ( no, un po’, molto ,moltissimo) . Il TIQ può essere utilizzato nei Pazienti Oncologici, sia nella ricerca che nella pratica clinica. Le 4 dimensioni che definiscono operativamente in questo strumento la qualità della vita sono: • effetti fisici concomitanti alla malattia e ai suoi trattamenti ( 24 item) stato funzionale ( 3 item) • effetti emotivi e cognitivi concomitanti ( 6 item) • interazione sociale( 2 item) Alle suddette aree si aggiunge un singolo item globale “ E’ stato fisicamente male?” 122 La somministrazione del TIQ avviene da parte del personale infermieristico preparato al suo utilizzo. Di facile compilazione in 5/10 minuti da parte del malato, o in caso di condizioni precarie di salute, da parte dell’ Operatore tramite intervista al malato. Presso il Day Hospital di Ivrea, sono stati analizzati alcuni Questionari TIQ : il campione analizzato comprendeva 32 Pazienti , di cui 16 affetti da carcinoma polmonare e 16 Pazienti affetti da carcinoma della mammella. Elaborando le risposte date alle domande presenti nel TIQ, è emerso che oltre l’80% dei Pazienti riferisce stanchezza, mentre sintomi quali il vomito vengono riferiti dal 31,25% dei Pazienti e l nausea è riferita dal 50% dei Pazienti. Da tali dati emerge che la fatigue è il problema più comune a questo tipo di Pazienti ed è quello da loro maggiormente sentito. E’ stata effettuata quindi una ricerca di dati che confermassero o meno quanto emerso dall’ analisi delle cartelle del campione preso in esame: la ricerca effettuata è stata fatta utilizzando materiale bibliografico e materiale disponibile on line. I dati provenienti dalla letteratura confermano che la fatigue è uno dei problemi maggiormente sentiti dai Pazienti oncologici e meno trattati. Obiettivi: OBIETTIVO DI DESTINATARI • miglioramento della qualità di vita • mantenimento del peso corporeo • potenziamento della forza e della funzione dell’ organismo • miglioramento dell’ immagine corporea • mantenimento della propria autonomia nello svolgimento delle funzioni inerenti la propria • persona ( cura di sé, igiene personale, cura dell’ abbigliamento,..) • mantenimento per il maggior tempo possibile dell’autonomia nella vita relazionale, sociale, lavorativa,…dei Pazienti oncologici OBIETTIVO DEI FORMATORI • sensibilizzazione e presa di coscienza dell’ importanza dell’educazione terapeutica in campo oncologico • apprendimento di informazioni sulla metodologia dell’ educazione all’adulto • apprendimento di informazioni sulla fatigue, e stimolo all’ insegnamento ai pazienti OBIETTIVO DELL’ AZIENDA • offerta di un servizio sanitario pubblico che comprenda l’ aspetto educativo per i pazienti e familiari • riduzione delle chiamate a Medici di Medicina Generale, Medici della Continuità assistenziale, Oncologi, per disturbi legati all’ astenia intensa, perdita di peso,., nei Pazienti Oncologici seguiti presso il Centro dell’ Ospedale di Ivrea. 123 Risorse: a. economiche • Costo della carta per la stampa dei questionari TIQ • Costo della carta colorata per la stampa dei diari e dei libretti informativi per i Pazienti • Utilizzo delle attrezzature informatiche della SOC di Oncologia b. umane • costo‐tempo per gli Operatori che partecipano al progetto per : • riunione di presentazione ( fuori orario di servizio) • riunione organizzativa prima dell’ inizio dell’ attuazione del progetto ( fuori orario di servizio) • 2 incontri formativi (in orario di servizio per i Docenti e fuori orario per i Discenti) • effettuazione colloqui individuali ( in orario di servizio) • riunioni bimestrali di verifica dell’ andamento del progetto ( fuori orario di servizio) e. logistiche • necessità di una sala per incontri formativi : Biblioteca ospedaliera o Studio medico utilizzato già regolarmente per i GIC o le riunioni di reparto • necessità di uno spazio in cui sia garantita la privacy per colloqui singoli con Pazienti e parenti f. di tempo • tempo di progettazione : tutta la fase progettuale che è stata svolta nei mesi da gennaio a maggio 2008 è stata effettuata non in orario di lavoro, ma dedicando tempo personale. Sono stati effettuati in orario di servizio i colloqui con i Responsabili e i vari professionisti interessati nel progetto , come pure la ricerca di dati on‐line. • tempo di attivazione : vedere cronoprogramma • tempo di valutazione : si presume che il tempo necessario per la fase di valutazione sia stimabile in circa 30 ore, comprensivo di revisione dei dati, compilazione delle schede di rilevazione dati, redazione del report conclusivo. Stakeholder: individuare i portatori di interesse e la modalità di coinvolgimento Medici Oncologi Centro formazione Ufficio Relazioni con il Pubblico Infermieri dei Distretti Personale dell’Hospice 124 attività Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. Gen. Stesura x progetto di base Verifica TIQ e x analisi dati Analisi x bibliografia Colloquio con x Direttore SOC Colloquio con x Responsabile Polo Onc. Riunione con x Infermieri Contatto con x gli Specialisti Predisposiz. x Libretto informativo Predisposiz. x diario Predisposiz. x Schede monitoraggio Incontri x formativi per gli Infermieri Riunione x organizzativa e avvio Inizio colloqui x con Utenti 1° verifica e x riprogettazione Analisi fattibilità: In un primo momento era stata valutata la possibilità di effettuare incontri comuni, con più Pazienti che avessero gli stessi bisogni, gli stessi interessi, lo stesso sviluppo di competenze. La fattibilità degli incontri di gruppo è stata valutata sia con gli Operatori, che con un campione ristretto di Pazienti, e tutti, hanno evidenziato la difficoltà di partecipazione a tali incontri, in quanto arrivano da lontano, alcuni non sono in grado di guidare autonomamente nel periodo in cui effettuano chemioterapia per cui dovrebbero ricorrere al supporto di un familiare ( …” mio figlio perde già tante ore di lavoro per accompagnarmi a fare le terapie , gli esami, le visite,…, che non voglio chiedere altro aiuto in questo periodo…magari più avanti…”). Si è scelto quindi, almeno in questa fase iniziale del progetto di utilizzare il metodo dell’ INSEGNAMENTO INDIVIDUALE. Pur consapevole che la ricchezza dello scambio di esperienze che avviene tra diversi Pazienti, all’interno di un gruppo, non si può riproporre nel rapporto a due ( Operatore sanitario‐Paziente), si è pensato che in questo momento, in questa situazione, sia il metodo educativo più efficace. Nel rapporto a due vengono integrati strettamente l’ insegnamento, la valutazione e il sostegno psicologico. Costituisce il metodo di elezione per l’ 125 educazione continua del Paziente. Permette anche di rivalutare i bisogni del Paziente, le sue competenze e di orientarle verso una attività pedagogica più appropriata. Insegnamento individuale VANTAGGI Personalizzazione Relazione privilegiata Possibilità di circoscrivere i bisogni specifici del Paziente Rispetto del ritmo del Paziente Miglior contatto Migliore conoscenza del Paziente Permette di affrontare il vissuto del Paziente SVANTAGGI Nessun confronto con gli altri Pazienti Assenza della dinamica di gruppo Rischio di insegnamento poco strutturato Richiede troppo tempo Rischio di influenza dell’ Operatore sul Paziente Rischio di incompatibilità con un Paziente “difficile” Stanchezza dovuta alla ripetizione Stesura piano operativo • Stesura del progetto di base Sulla base di quanto si sta apprendendo e discutendo con il gruppo del Corso di Educazione Terapeutica, si pensa a come stendere un progetto educativo, mirato a Pazienti oncologici e ai loro familiari, che abbia come obiettivo un cambiamento di comportamenti atti a migliorarne la qualità di vita. • Verifica dati questionario TIQ e rilevazione sintomo prevalente Vengono analizzati i dati ricavati dai questionari TIQ di 32 Pazienti, da cui si evidenzia che il sintomo più frequentemente segnalato è la fatigue. Si pensa quindi che tale valutazione sia meritevole di maggiore approfondimento, per capire se può essere utile investire delle risorse per fare un progetto educativo centrato sul miglioramento della fatigue, con conseguente miglioramento della qualità di vita del Paziente. • Analisi bibliografia inerente Si effettua una ricerca bibliografica ( sia su testi che on‐line) per confermare o meno la frequenza , l’ importanza della fatigue e il suo impatto sulla qualità di vita dei Pazienti oncologici. 126 • Colloquio con il Direttore della SOC di Oncologia per discussione del progetto Durante il colloquio con il Direttore della SOC di Oncologia, si presenta il progetto, gli obiettivi educativi, la necessità di coinvolgimento anche del Personale Medico sia nella fase di formazione del personale infermieristico, sia come coinvolgimento successivo, durante la parte operativa (presenza e supporto eventuale all’Infermiere durante i colloqui con i Pazienti,...) • Colloquio con il Responsabile di Polo e Direttore del Dipartimento Oncologico per discussione del progetto Il colloquio con il Responsabile di Polo e Direttore del Dipartimento Oncologico dell’ ASL TO4 ha l’ obiettivo di illustrare il progetto nel suo complesso, e richiederne l’ approvazione e eventuali critiche e/o suggerimenti. Si chiederà inoltre l’ autorizzazione per l’ utilizzo delle risorse umane, economiche e logistiche necessarie. • Riunione con gli Infermieri dell’Oncologia e condivisione del progetto Nella riunione, a cui sono invitati tutti gli Infermieri della SOC di Oncologia di Ivrea, viene illustrato il progetto nel suo complesso, soffermandosi maggiormente sugli obiettivi, sull’ importanza dell’ educazione terapeutica nella professione infermieristica, sull’ utilità di un’ impronta educativa in tutto ciò che i professionisti dell’ assistenza svolgono accanto a Pazienti oncologici e loro familiari. Si discute insieme delle fasi operative del progetto, dove è previsto il coinvolgimento di tutto il gruppo infermieristico. • Predisposizione del materiale per la discussione con i colleghi Infermieri dei concetti basilari dell’ educazione terapeutica. Tutti gli Infermieri, in quanto tali, hanno delle competenze in educazione terapeutica, ma si ritiene utile condividere con loro alcuni concetti che sono stati appresi durante il corso. Ciò è previsto durante il primo incontro formativo, che si terrà a settembre 2008, attraverso la distribuzione di materiale illustrativo precedentemente preparato e successiva discussione con il gruppo infermieristico. L’obiettivo è di sensibilizzare il gruppo all’acquisizione di competenze educative, e ad imparare a farlo in modo organizzato, continuo, e controllato. • Contatto con gli Specialisti del gruppo interdisciplinare di Educazione terapeutica Si prevede un colloquio individuale con i quattro Professionisti che si occuperanno della formazione degli Infermieri , con la presentazione del progetto globale, e con la discussione e condivisione degli argomenti da trattare. • Oncologo • Fisioterapista • Psicologa • Dietista • Predisposizione del libretto informativo da distribuire ai Pazienti Attraverso l’analisi della bibliografia, e lo studio di alcuni libretti informativi già costruiti, si tenta di predisporre un libretto semplice, facilmente riproducibile, e soprattutto di facile lettura da parte di Pazienti di ogni età, cultura,... La bozza di tale libretto verrà discussa con l’ equipe infermieristica, e verrà proposta a un piccolo campione di Pazienti, per avere un parere globale e soprattutto critiche e suggerimenti. 127 • Predisposizione del diario per i Pazienti Si ritiene utile l’utilizzo di un diario per far riflettere il Paziente sui momenti della giornata in cui ha più energie e quindi concentrare le attività più faticose in questi momenti. • Predisposizione schede di monitoraggio del progetto Si predispongono alcune schede per il monitoraggio e la valutazione del progetto. • Organizzazione di 2 incontri formativi per gli Infermieri Vengono coinvolti tutti gli infermieri della SOC di Oncologia dell’ Ospedale di Ivrea, che saranno parte attiva nel progetto. Il dettaglio operativo dei due incontri formativi, si trova all’ allegato 7. Il primo incontro è previsto con la responsabile del progetto, con l’ Oncologo e la Psicologa, mentre il secondo sarà con la dietista e la fisioterapista, da effettuare nella seconda metà del mese di settembre 2008. • Riunione organizzativa e avvio fase di attuazione del progetto La riunione organizzativa che si terrà subito prima dell’avvio della parte operativa del progetto ha l’obiettivo di discutere con il gruppo infermieristico tutti i dettagli operativi, e predisporre una sorta di “manuale” interno per permettere a tutti di trasmettere le stesse informazioni, con le stesse modalità, perseguendo gli stessi obiettivi. • Inizio colloqui individuali con i Pazienti e Parenti E’ la fase operativa vera e propria. Tutti i nuovi pazienti che accedono al servizio CAS – Centro Accoglienza e Servizi, per la presa in carico e che necessitano di un trattamento chemioterapico, vengono inseriti in questo progetto. Il primo colloquio è previsto durante la visita CAS, e prevede la somministrazione del libretto informativo. Durante il secondo colloquio ( al 1° ciclo di chemioterapia), verranno ripresi alcuni dei concetti già discussi durante la visita CAS, verrà consegnato il diario , e si spiegherà come compilare il questionario TIQ. • Organizzazione di incontri di gruppo rivolti a Pazienti e Parenti Si organizzeranno alcuni incontri di gruppo, rivolti a Pazienti e parenti, durante i quali, la responsabile del progetto, la Dietista, la Fisioterapista e la Psicologa daranno una serie di informazioni sulla fatigue, consigli alimentari, sull’ esercizio fisico, suggerimenti di tipo psicologico. • Monitoraggio strumenti per ricerca dati da monitorare Per monitorare l’andamento del progetto si prevedono i seguenti strumenti: o riunioni di equipe di verifica e monitoraggio da tenersi ogni 2 mesi , a partire da ottobre 2008 ( data inizio parte operativa progetto) o compilazione schede raccolta dati per la valutazione dello strumento colloquio o compilazione schede raccolta dati sull’uso del questionario TIQ 128 • Piano di valutazione: di processo Valutazione dello strumento COLLOQUIO Indicatore: numero di nuovi casi che hanno avuto il colloquio al primo ciclo di chemioterapia ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ numero totale nuovi casi di Pazienti che iniziano Chemioterapia nel DH di Ivrea Valutazione dello strumento QUESTIONARIO TIQ Indicatore: numero di TIQ compilati dai nuovi Utenti al 2° ciclo di chemioterapia ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ n° totale nuovi Utenti sottoposti a 2° ciclo di chemioterapia di risultato n° Utenti che hanno mantenuto il peso corporeo iniziale al termine della chemioterapia _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ n° Utenti sottoposti a chemioterapia L’ indice atteso è del 50 %: si prevede cioè che circa metà dei Pazienti che faranno chemioterapia, grazie alle informazioni ricevute, alla gestione corretta dell’ alimentazione possa mantenere il peso corporeo iniziale al termine della chemioterapia. • Attuazione Per monitorare tutta la fase di attuazione del progetto, verrà istituito una specie di “registro di classe”, su cui verranno annotate tutte le riunioni, gli incontri, i partecipanti, le criticità emerse durante le varie fasi dell’attuazione del progetto e le relative ipotesi di soluzione. • Riprogettazione / attuazione correttiva La riprogettazione verrà effettuata in tempi successivi, con l’ aiuto di tutto il gruppo infermieristico che partecipa al progetto, e sarà dettagliatamente descritta sul “registro di classe” del progetto . Dopo 6 mesi di fase di attuazione ( dal 1/10/08 al 31/3/09) si analizzano i primi risultati. Materiali e metodi di analisi • diario : 10 pagine, anonimo, con scopo di ricerca, ma anche per mantenere un “dialogo” con se stessi • questionario di verifica finale: somministrato a tutti i Pazienti telefonicamente , alla conclusione del percorso di chemioterapia • questionario di valutazione della tossicità da chemioterapia: viene utilizzato regolarmente in DH di Oncologia di Ivrea, per la valutazione dei più frequenti disturbi legati alla tossicità da Chemioterapia. 129 Risultati Nei primi 6 mesi di attuazione, sono stati arruolati 42 Pazienti , di cui : • 33 hanno completato tutte le fasi del programma • 5 in fase terminale di malattia • 1 non ha dato il consenso alla compilazione del questionario • 3 sono irreperibili • La maggior parte dei 33 sono di sesso femminile(23), con una fascia di età maggiormente rappresentata tra i 59 e i 68 anni Nei grafici A e B sono riassunti rispettivamente i dati relativi alle difficoltà incontrate nei vari ambiti e l’adesione ai consigli di chi ha avuto difficoltà nei singoli ambiti di interesse. Come si può vedere l’ambito in cui si sono registrate le maggiori difficoltà è stato quello dell’esercizio fisico in cui l’84,8% ha risposto di aver avuto difficoltà nello svolgere le solite attività di vita quotidiana. Di questi il 78,5% ha seguito i consigli ricevuti, mentre il restante 21,5% non li ha seguiti. Nell’ambito “dieta” invece difficoltà sono state incontrate dal 72,7% del gruppo, con l’87,5% di essi che dichiarano di aver seguito i consigli ricevuti e il 12,5% che invece dichiara di non averli seguiti. Difficoltà nel sonno sono state dichiarate dal 51% degli intervistati, di questi, hanno seguito i consigli nel 52,9% dei casi, mentre non li hanno seguiti nel 47,1% . Infine una percentuale minore di Pazienti che hanno registrato difficoltà si è avuta nell’ambito dell’ansia, dove solo il 45,4% dichiara di aver incontrato difficoltà e di questi il 46,7% ha seguito i consigli ricevuti, mentre il 53,5% non li ha seguiti. 90,00% 80,00% 70,00% Grafico A . 60,00% Difficoltà del 50,00% sì gruppo relative ai 40,00% no 4 ambiti. 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% esercizio dieta sonno ansia fisico 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% es er ci zi si a an nn o di et a so o fis ic o sì no Grafico B . Consigli seguiti relativi alle difficoltà riscontrate nei 4 ambiti. 130 Il giudizio del Paziente sull’utilità dei consigli ricevuti sulle strategie da mettere in pratica per affrontare la fatigue si differenzia per i vari ambiti che sono interessati. L’ambito relativo all’esercizio fisico è quello che ha registrato il maggior numero di giudizi positivi (N=22); anche nell’ambito della dieta un’alta percentuale degli intervistati (N=21) dichiara di aver trovato utili i consigli ricevuti. Nell’ambito del sonno e dell’ansia la percentuale di giudizi positivi sull’utilità dei consigli invece scende (N=9) (N=7). Frequenza dei consigli scelti tra quelli proposti nell’ambito dell’esercizio fisico consigli ambito dell’esercizio fisico sì no totale a. Svolgere un esercizio fisico semplice come Camminare b. Programmare la giornata inserendo un’attività leggera c. Trovare un buon equilibrio tra attività e riposo d. Altro 22 0 22 10 12 22 12 5 10 17 22 22 Frequenza dei consigli scelti tra quelli proposti nell’ambito della dieta Consigli ambito della dieta sì a. Mangiare poco ma spesso 20 b. Adottare un’adeguata igiene del cavo orale 20 c. Bere molto 18 d. Altro 10 no 1 1 3 11 totale 21 21 21 21 Frequenza dei consigli scelti tra quelli proposti nell’ambito del sonno Consigli ambito della sonno sì a. Svegliarsi tutte le mattine alla stessa ora 4 b. Dormire quanto basta 2 c. Evitare il consumo di sostanze eccitanti 7 d. Altro 6 no 5 7 2 3 totale 9 9 9 9 no 4 totale 7 2 3 5 7 7 7 Frequenza dei consigli scelti tra quelli proposti nell’ambito dell’ansia Consigli ambito dell’ansia sì a. Concentrarsi su ogni singola parte del corpo 3 b. Eseguire esercizi di respirazione C Ascoltare suoni registrati d. Altro 5 4 2 Attraverso il questionario finale è stata richiesta anche una valutazione da parte del Paziente del grado di utilità, chiarezza ed interesse percepiti relativamente all’informazione che fornita sia con l’opuscolo sia con i colloqui. Le informazioni sono state ritenute “molto” o “moltissimo” utili dal 63,6% dei Pazienti, percentuale che sale all’84,4% quando ne viene valutata la chiarezza. La valutazione positiva dell’interesse delle informazioni ricevute si colloca all’80,6%. 131 Grado di valutazione Per niente Poco Molto Moltissimo Totali Utilità 36,4% 48,5% 15,1 % 100 % Chiarezza 18,2 % 60,6 % 21,2 % 100 % Interesse 21,2 % 66,7 % 12,1 % 100 % Alla domanda diretta sui cambiamenti dei comportamenti sulla base delle informazioni ricevute, una maggioranza consistente del gruppo, pari al 78,8% dichiara di aver modificato i propri atteggiamenti nella vita quotidiana,. Solo il 21,2 % dichiara di non aver cambiato per nulla i propri comportamenti. Il grado di cambiamento introdotto varia da “un po’” nel 51,5% dei casi, a “molto” nel 21,2% fino a “moltissimo” nel 6,1%. Modifica dei comportamenti della vita quotidiana. no un po' molto moltissimo Bibliografia del progetto Marcello Tamburini .TIQ Therapy Impact Questionnaire . Strumenti di valutazione della qualità della vita. EDISES Milano 1993 Juith M. Wilkinson. Diagnosi infermieristiche con NOC e NIC. Casa Editrice Ambrosiana. Milano 2005 Anne Lacroix‐ Jean Philippe Assal Educazione terapeutica dei Pazienti. Nuovi approcci alla malattia cronica. Edizioni Minerva Medica. Torino 2005. Jean Francois d’Invernois. Remi Gagnayre Educare il Paziente. McGraw‐Hill Milano 2006 Anne Destrebecq. Stefano Terzoni. Management infermieristico. Carocci Faber 2007 Rapporto di un gruppo di lavoro OMS. Educazione terapeutica del Paziente.CESPI Torino 1998 Enrico Auteri. Management delle risorse umane. Edizione Guerini Milano 2004 Daniela Pittaluga, Loredana Sasso. Tra il dire e il fare. Sorbona 132 Il contatto pelle a pelle con la madre nei neonati da parto cesareo. Uno studio sperimentale Silvia Gouchon (Coordinatore Infermieristico – SS. Cure Domiciliari ‐ ASL TO3 – Pinerolo (TO) Giovanna Patrucco13, Amabile Picotto14, Marco Nangeroni15, Dario Gregori16 , Paola Di Giulio17 “Quando al mattino guardai la luce, subito sentii che non ero uno straniero in questo mondo” Tagore Quando si parla di contatto pelle a pelle o “skin to skin” ci si riferisce al posizionamento prono del neonato sul torace della madre al momento della nascita o comunque nelle prime ore dopo il parto. Già a partire dagli anni ’50 Bowlby1 comincia a parlare di processo di attaccamento tra il neonato e l’adulto. Poi, nel corso degli anni ’70 comincia a diffondersi la consapevolezza che i processi di attaccamento, e in particolare la relazione madre‐bambino, avvengono molto precocemente. Klaus e kennel nel 1982 pubblicano uno studio2 che analizza la nascita del legame tra i genitori e il bambino fin dai primi momenti di vita, considerati un “periodo sensibile” perché permette da un lato alla madre di essere sensibile e reattiva ai bisogni fisici e psicologici del bambino e al neonato di sopravivere e di adattarsi alla nuova realtà. E’ indubbio che uno dei principali meccanismi di adattamento che il neonato mette in atto alla nascita è proprio l’adattamento termico (passa dai 37 gradi ai 21‐24 gradi dell’ambiente esterno). Nel loro studio Klaus e Kennell hanno valutato il comportamento del neonato ed hanno verificato che il neonato, posto nelle condizioni di maggior benessere, protetto dal freddo, asciugato con teli tiepidi e soprattutto esposto al contato pelle a pelle con la madre, riceve gli stimoli che favoriscono la sua tranquillità e il suo benessere, facilitando l’adattamento alla vita extrauterina. L’efficacia del contatto pelle a pelle è stata ampiamente dimostrata e raccomandata nei neonati da parto spontaneo e nei prematuri per i suoi effetti sia sul controllo termico, che sull’allatamento, che sullo sviluppo della relazione madre‐bambino, quello che viene definito “bonding” e sullo sviluppo del neonato3. Nei neonati da parto spontaneo e nei prematuri questa è una procedura assistenziale abitualmente adottata. Tuttavia quando il parto avviene in sala operatoria, il contatto pelle a pelle tra mamma e neonato è poco praticato, per ragioni pratiche e di sicurezza. Persiste la preoccupazione che il neonato possa incorrere in una ipotermia. Obiettivo dello studio è quello di confrontare le temperature medie dei neonati da cesareo che praticano il contatto pelle a pelle (tenuti nudi a contatto con la pelle della mamma), rispetto al gruppo tradizionale (vestiti, nel letto con la mamma o nella culla), durante le due ore successive al rientro della mamma dalla sala operatoria. 13 ex‐Dirigente Responsabile SS Neonatologia – ASL TO 3 Pinerolo (TO) Coordinatore Infermieristico – SS Neonatologia ‐ ASL TO3 – Pinerolo (TO) 15 Dirigente Responsabile SS Neonatologia – ASL TO 3 Pinerolo (TO) 16 Professore università degli Studi di Torino 17 Professore Università degli Studi di Torino 14 133 Inoltre esiti secondari dello studio sono la valutazione dell’efficacia della prima poppata al seno, il momento del primo attacco, il pianto del neonato, l’allattamento alla dimissione e nei primi tre mesi di vita e il gradimento delle mamme sulla pratica del contatto pelle a pelle. E’ stato quindi disegnato uno studio di tipo sperimentale di non inferiorità (vuole dimostrare che il gruppo pelle a pelle non ha temperature significativamente inferiori rispetto al gruppo tradizionale). Il Campione è rappresentato da donne di nazionalità italiana, con parto cesareo elettivo, fuori travaglio, con anestesia locoregionale che partoriscono neonati fisiologici a termine con un apgar > a 7 ed un peso > a due kili e mezzo. La dimensione del campione è stata calcolata in 34 coppie mamma‐neonato per ogni livello di analisi, per avere una potenza dell’80% ed una significatività del 5%. Lo studio è stato approvato dal Comitato Etico Locale. E’ stato richiesto alle donne/coppie il consenso scritto dopo aver presentato loro lo studio. Le donne sono state randomizzate all’uno o all’altro braccio di studio utilizzando buste opachi contenenti l’allocazione, in base ad un elenco di numeri casuali generati dal computer, il giorno dell’intervento. Alle donne è stato comunicato il gruppo d appartenenza al rientro dalla sala operatoria. Sono stati raccolti i dati ed infine è stato valutato il gradimento da parte delle donne che hanno praticato il pelle a pelle somministrando loro un questionario con 7 domande a risposta chiusa su una scala di likert a 5 punti. Se è vero come abbiamo sentito dire oggi che il Codice deontologico è una sorta di manifesto dei valori che i professionisti eleggono a fondamento della pratica professioale e in quanto tale è il documento di identità che permette di capire e di definire chi è l’infermiere e in quali rapporti si pone con altri professionisti, qual è il contesto socio‐culturale in cui esercita possiamo affermare che nell’art. 12 (e nel precedente) viene riconosciuto un grande valore all’attività di ricerca4. E’ quindi importante che l’infermiere promuova e partecipi alla ricerca e che l’attività di ricerca venga condotta secondo principi etici. Se l’etica è il “luogo” (mentale, fisico, dialogico) dove riflettere sul “che fare”, su “cosa è giusto fare?” o meglio del “chi si è chiamati ad essere” vorrei condurre una riflessione sulla ricerca5 a partire dalla griglia che Spinsanti6 propone per l’analisi dei casi … provando ad applicarla anche allo studio. Spinsanti suggerisce di analizzare il comportamento su tre livelli: 1. il comportamento obbligato: ovvero se vi è rispetto del comportamento a cui siamo tenuti per obbligo di legge, per deontologia professionale, per regolamenti e normative (si propone di verificare quali conseguenze medico‐legali, penali o civilistiche o deontologiche possono derivare dal comportamento in questione); 2. il comportamento eticamente giustificabile: valuta se i comportamenti sono orientati da un lato alla difesa del minimo morale e dall’altra alla promozione del massimo morale. Secondo il principio di difesa del minimo morale valuta se il comportamento è orientato a : - evitare ciò che nuoce o danneggia il paziente (principio di non maleficità) - opporsi a discriminazioni e ingiustizie (principio di giustizia) Secondo la promozione del massimo morale il comportamento eticamente giustificabile prevede: - l’orientamento al bene del paziente (principio di beneficità) - il coinvolgimento del paziente nelle decisioni che lo riguardano (principio di autonomia) 3. il comportamento eccellente: rispetto al “quadrilatero della soddisfazione” (che contrappone giusta soddisfazione o giusta insoddisfazione alla ingiusta soddisfazione o ingiusta insoddisfazione) Spinsanti suggerisce di valutare se tutte le persone coinvolte (professionisti, 134 pazienti, familiari, autorità sanitarie) raggiungono la posizione della “giusta soddisfazione” (o almeno della “giusta insoddisfazione”). Utilizzare queste categorie per valutare uno studio significa condurre una riflessione critica a partire dai valori professionali condivisi. Innanzitutto si valuta il comportamento obbligato, con riferimento agli obblighi di legge, quali l’art. 32 della Costituzione (libertà di scelta), o all’art. 610 (reato di violenza privata) del codice penale, o alla normativa che ha riguardato la protezione dei soggetti partecipanti a studi clinici in Italia7 quali il DM 27 aprile 1992 “Disposizioni sulle documentazioni tecniche da presentare a corredo delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano, in attuazione della direttiva (CEE) n. 507/91” o DM 15 luglio 1997 che ha stabilito le Linee Guida di riferimento per l’istituzione e il funzionamento dei Comitati Etici, nonché ai requisiti che devono essere contenuti nel consenso informato (qualità della comunicazione e dell’informazione fornita, comprensione dell’informazione, libertà decisionale del paziente, capacità decisionale del paziente), o secondo quanto previsto all’art. 20 del codice deontologico 2009. Nel caso dello studio in questione questo è stato garantito richiedendo alle donne/coppie il consenso, informandole sullo studio e sottoponendo il protocollo di ricerca all’approvazione del Comitato Etico. In relazione al 2° livello: valutazione del comportamento eticamente giustificabile è importante rispondere ad alcuni interrogativi: - si è evitato di nuocere al paziente? ovvero … lo studio può nuocere al paziente? cosa prevedeva il protocollo di ricerca se si fosse evidenziato un rischio di ipotermia per i neonati esposti a skin to skin? Lo studio è disegnato allo scopo di minimizzare i rischi? (Principio di non maleficità) - ci si è opposti a discriminazioni e ingiustizie? Ovvero … dal diniego del consenso ne è conseguita qualche forma di discriminazione? … è stato adottato un comportamento diverso tra i soggetti coinvolti/esclusi dallo studio? Sono state trattate in modo diverso le donne assegnate ai due gruppi? (principio di giustizia) - lo studio è orientato al bene del paziente? … qual è l’oggetto della ricerca? … qual è l’obiettivo? … nel caso presentato lo studio si inscrive nelle pratiche human caring oriented ed è finalizzato a valutarne la sicurezza per il paziente … (principio di beneficità) - c’è stato il coinvolgimento del paziente nelle decisioni che lo riguardano? E’ stato presentato alla donna lo studio? Le donne erano libere di scegliere se partecipare allo studio? … potevano ritirare il consenso? se hanno dato il loro consenso e poi decidevano di non seguire il trattamento previsto (pelle a pelle o no) potevano scegliere il trattamento? Sono state informate sui rischi potenziali che potevano correre partecipando allo studio? Sono state prese le giuste misure per salvaguardare la riservatezza dei soggetti? E’ stata rispettata la confidenzialità dei dati? (principio di autonomia). Ed infine rispetto al 3° livello che comprende la valutazione del comportamento eccellente la riflessione può operarsi attorno al seguente interrogativo: gli operatori e le donne sono stati giustamente soddisfatti? …quale gradimento? Ho provato ad utilizzare questa chiave di lettura per valutare l’eticità di uno studio, probabilmente ce ne potrebbero essere altre … forse può non essere esaustiva … per esempio non ci siamo soffermati sull’eticità della scelta del disegno di studio, del tipo di ricerca, ma può essere uno strumento interessante per orientare il comportamento dell’infermiere coinvolto in un progetto di ricerca che deve muoversi tra due esigenze: da un lato il rigore scientifico e dall’altro l’interesse di ogni singolo paziente coinvolto nello studio. E per concludere riporto I risultati dello studio che hanno messo in evidenza che il neonato da parto cesareo esposto al contatto pelle a pelle entro un’ora dal parto non è a rischio di ipotermia 135 ma anche che i neonati esposti al pelle a pelle piangono di meno, si attaccano più precocemente al seno, assumono più latte materno esclusivo o prevalente sia alla dimissione che nei primi tre mesi ed è elevato il gradimento da parte delle mamme. Inoltre lo studio ha consentito di verificare la fattibilità della pratica e la sostenibilità anche sotto il profilo organizzativo. Quindi non resta che l’auspicio che la pratica del pelle a pelle possa essere estesa a tutti I neonati, anche a quelli nati da parto cesareo. “Il prototipo di tutto il prendersi cura del bambino è il tenere in braccio; il contenere in braccia umane” D. W. Winnicott BIBLIOGRAFIA 1 Boowlby J. Attaccamento e perdita, Bollati Boringheri, Torino, 1982 2 Klaus M H, Kennell J H Parent‐Infant bonding, Mosby, St. Louis, 1982 3 Anderson, G. C., Moore, E., Hepworth, J., & Bergman N. (2007). Early Skin to Skin Contact for mothers and their healthy newborn infants [review]. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 3. Art. No.: CD003519. DOI: 10.1002/14651858.CD003519.pub2 4 Silvestro A (a cura di) Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI. Commentario al codice deontologico dell’infermiere 2009, McGraw‐Hill, Milano, 2009 5 LoBiondo‐Wood G, Haber J, Palese A (ed. italiana a cura di) Metodologia della ricerca infermieristica, McGraw‐Hill, Milano, 2004 6 Spinsanti S Bioetica e nursing. Pensare, riflettere, agire, McGraw‐Hill, Milano, 2001 7 Scuderi L, Guidoni L, Rosmini F, Petrini C La normativa sulla protezione dei soggetti partecipanti a studi clinici in Italia: dagli anni Novanta al 2004 Ann Ist Super Sanità 2004; 40(4): 495‐507 La Ricerca per le Buone Pratiche in Pediatria: Testimonianze e Riflessioni Vagliano Liliana (Scuola di Dottorato in Scienze Biomediche ed Oncologia Umana – Indirizzo in Pediatria Sperimentale – XXIV Ciclo) La disciplina dell’Infermieristica Pediatrica, in maniera assimilabile alla Medicina Pediatrica, rappresenta una branca a se stante all’interno del Nursing. La ricerca delle buone pratiche implica, in tutti gli studi di ricerca, un’attenta considerazione delle questioni e degli standard etici. Gli infermieri e gli infermieri pediatrici, come tutti i professionisti che conducono ricerche, hanno la responsabilità professionale di assicurare che il disegno degli studi, siano essi di tipo qualitativo che quantitativo, rispetti i principi etici e protegga i diritti umani1. In Pediatria, oltre alle Good Clinical Practice e agli altri documenti che regolano l’attività di ricerca (come ad esempio l’Human Right Guidelines for Nurses in Clinical and Other research dell’American Nurses Association), è necessario tenere in considerazione anche i documenti che 136 tutelano i bambini, come la Convenzione sui Diritti dell’infanzia dell’ONU – UNICEF, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno 19912. L’articolo 12 del suddetto documento stabilisce che il punto di vista dei bambini/adolescenti debba essere preso in considerazione, anche in base al grado di maturità raggiunto. Naturalmente questo non vuol dire che la decisione venga trasferita completamente al bambino/adolescente, ma che ci sia una decisione condivisa dalla diade bambino – adolescente/famiglia ed equipe dei professionisti sanitari, ponendo attenzione a che il processo di inclusione del minore nella discussione e nella decisione non sia solo simbolico, con un impatto minimo sulla scelta finale. La comunità scientifica pediatrica sta riflettendo e lavorando per il riconoscimento, non solo formale, dell’autodeterminazione del bambino/adolescente, anche attraverso l’adozione di un modello condiviso di consenso e di comunicazione con il minore e la sua famiglia3. Nella pratica clinica e nella conduzione degli studi in Pediatria si aggiunge quindi un elemento ulteriore di difficoltà, oltre a quello di una maggior difficoltà a reperire la produzione di letteratura scientifica specifica4. Nonostante questi elementi, le ricerche infermieristiche effettuate in ambito neonatologico/pediatrico sono numerose e grazie anche alla “neonata” Società Italiana di Scienze Infermieristiche Pediatriche, la cultura della ricerca si sta diffondendo sempre più. In sede congressuale verranno presentate diversi filoni di ricerca infermieristica in ambito pediatrico e in particolare verrà presentata una ricerca descrittiva condotta presso l’AO Ospedale Infantile Regina Margherita – S. Anna di Torino sulla manipolazione dei farmaci in ambito pediatrico. Bibliografia 1. Rasero L. Considerazioni etiche nella ricerca infermieristica. Giornale Italiano di Scienze Infermieristiche 2006; 2 (II): 119 ‐ 21 2. ONU – UNICEF. Convenzione sui diritti dell’infanzia. G.U. 11 giugno 1991 3. Baston J. Healthcare decisions: a rewiew of Children’s involvement. Paed Nurs 2008; 20 (3): 24 – 26 4. Dall’Oglio I, Loreti A. La letteratura per l’Infermieristica Pediatrica. Giornale Italiano di Scienze Infermieristiche 2006; 3 : 114 – 20 La Gestione del Dolore in Pronto Soccorso. Valutazione dell’Efficacia di un Intervento di Miglioramento. Gavetti Dario (Centro Formazione Emergenza AO C.T.O. Torino) Frigerio SΩ. Di Guilio Pρ, Dimonte Vρ. Introduzione Il dolore è tra i sintomi più comuni riferito dai pazienti che accedono al servizio di Pronto Soccorso [PS]1. Diversi studi dimostrano che il 60‐70% dei pazienti prova dolore2,3 e in oltre la metà dei casi il dolore al momento del triage è di intensità moderata o grave4. I pochi studi che hanno analizzato le modalità di valutazione e gestione del dolore in questi reparti5 concordano nell’affermare che circa il 70% dei pazienti che ha dolore non riceve nessun ρ Università degli Studi di Torino 137 tipo di analgesia, o la riceve con notevole ritardo6,7. In particolare, meno della metà dei pazienti riceve un trattamento per il dolore durante il ricovero8 e il 60% dei pazienti dimessi ha dolore di intensità maggiore rispetto all’ammissione9. Tra le cause associate a questa mancanza sono descritte lo scarso utilizzo di strumenti per la misurazione e registrazione del dolore, la scarsa comunicazione tra il personale di assistenza, l’inadeguata formazione sulla valutazione e gestione del dolore e la diffusione di preconcetti tra gli infermieri sull’affidabilità nella stima del dolore da parte dei pazienti 8. Una delle componenti irrinunciabili nella gestione del dolore è la sua accurata misurazione2. Sono molte le variabili legate a questo aspetto, ma un particolare accento è posto sui metodi e strumenti utilizzabili. Una recente revisione della letteratura10 evidenzia come nel 95% dei casi il personale sanitario tende a sottostimare il dolore in fase di triage rispetto all’autovalutazione del paziente [p<0.001]. Il problema è diffuso, tanto che in uno studio11 si arriva a concludere che accettare l’autovalutazione del dolore effettuata dal paziente è il primo e più importante passo per il miglioramento della sua gestione in PS. Esistono diversi strumenti per l’autovalutazione del dolore negli adulti in pronto soccorso, ma quelli più utilizzati sono la Scala Visiva Analogica [VAS] e la Scala di valutazione Numerica [NRS] 12 . Nonostante numerosi studi di validazione abbiano dimostrato la validità ed attendibilità di questi strumenti nella misurazione del dolore negli adulti in PS12, 13, 14, poco è stata studiata la ricaduta della loro applicazione nell’attività quotidiana ed in particolare l’impatto del loro uso nel miglioramento della gestione del dolore. Uno studio retrospettivo1 con disegno pre‐post su 1000 pazienti [521 prima, 479 dopo] consecutivi di un pronto soccorso, ha valutato l’effetto dell’introduzione di una scala numerica per l’autovalutazione del dolore al triage su incidenza e tempo di somministrazione di analgesici, dimostrando una differenza significativa [p<0.001] sia nella somministrazione di analgesici che nella riduzione del tempo di attesa per la somministrazione. Stalnikowich et al., in un altro studio pre‐post6 su 140 pazienti, ha invece valutato l’efficacia di un pacchetto di interventi sulla riduzione della differenza di valutazione del dolore tra il personale sanitario e pazienti, e su incidenza e tempo di somministrazione degli analgesici. Oltre ad introdurre la scala, è stato formato il personale sul dolore ed introdotto un protocollo per il suo trattamento, dimostrando differenze statisticamente significative per ciascuno degli esiti misurati. Nel nostro paese, i dati su modalità e strumenti utilizzati per la gestione del dolore in PS sono carenti. Parte del problema è forse dovuto alla carenza di conoscenze sul dolore da parte del personale15. Le indagini condotte in altri contesti6,13,16 fanno ipotizzare che lo stesso problema possa essere presente anche tra gli operatori del PS. Uno studio pilota del 2007 sulle modalità di gestione del dolore condotto nel contesto ospite17 ha confermato i risultati di altri studi18: il dolore è sottovalutato, trattato con notevole ritardo o non trattato affatto, e l’oligoanalgesia rappresenta, anche in questo contesto, un problema importante. Questo studio si pone l’obiettivo di valutare l’efficacia dell’introduzione di una scala di valutazione del dolore nel migliorarne la qualità della gestione. Obiettivo dello studio Valutare l’efficacia dell’introduzione di una scala di autovalutazione del dolore nel ridurre l'intensità del dolore nei pazienti in dimissione dal PS, rispetto all’ingresso. Materiali e Metodi CONTESTO E POPOLAZIONE Pronto Soccorso della piccola traumatologia del Dipartimento di Emergenza ed Accettazione dell’ASO CTO ‐ Maria Adelaide della città di Torino. In questo reparto afferiscono in media 37.500 138 persone all’anno [dato 2006]. Vi prestano servizio 21 infermieri, 3 infermieri generici e 10 operatori di supporto all’assistenza. Gli infermieri hanno turni di servizio di 8 ore. Il personale medico è costituito da 41 ortopedici, ripartiti in 4 divisioni che ruotano ogni 24 h. Il turno di servizio di ciascuna coppia di ortopedici è di 12 h. Sono stati considerati arruolabili tutti i pazienti consecutivamente sottoposti a triage che avevano dolore all’accettazione e quelli senza dolore che avevano assunto analgesici subito prima dell’accesso in PS. Sono stati esclusi i pazienti che seguivano percorsi diversi da quelli standard [es. visite programmate], con codice rosso, trasferiti ad altro reparto dopo il triage, sottoposti a tutela giudiziaria, non in grado di comprendere la lingua italiana, con un alterato stato del sensorio. Sono stati anche esclusi i pazienti con meno di 18 anni non accompagnati da un genitore. Tutti i pazienti per i quali non è stato possibile completare la raccolta dati alla dimissione, sono stati esclusi dall’analisi. A tutti i pazienti è stato richiesto il consenso verbale all’intervista. MODALITA’ DI RACCOLTA DATI I dati sono stati raccolti in 9 giornate indice [GI], 5 nella fase pre, 4 nella post [fino al raggiungimento del numero di pazienti necessari], in turni di osservazione di circa 9 ore, tra Ottobre 2007 e Febbraio 2008. Le GI sono state scelte in modo da poter osservare il personale delle 4 divisioni ortopediche che a rotazione prestano servizio in PS. La raccolta dati è stata effettuata da due infermieri, di cui uno responsabile dello studio, entrambi dipendenti dell’ASO CTO‐Maria Adelaide ma esterni al PS. I pazienti sono stati intervistati utilizzando una scheda strutturata in due sezioni, sia al momento dell’accettazione [dati anagrafici, codice di triage, intensità del dolore, desiderio di ricevere un analgesico] che alla dimissione. Al paziente veniva richiesto di indicare su una scala NRS ad 11 punti l’intensità di dolore provata in quel momento, [0 nessun dolore e 10 il peggior dolore possibile]. Alla dimissione sono stati raccolti i dati sul dolore durante il ricovero, i principali trattamenti ortopedici e radiologici ricevuti, l’eventuale somministrazione di analgesia, e l’intensità del dolore, con la NRS. Le informazioni sulla diagnosi di dimissione sono state raccolte consultando il database delle cartelle cliniche di PS. E’ stata considerata leggera un’intensità di dolore 1‐4, moderata 5‐7, grave 8‐10. Al termine della prima fase, i dati raccolti sono stati presentati al personale infermieristico del reparto insieme alla proposta di adozione dei seguenti interventi di miglioramento: 1. introduzione di una NRS ad 11 punti per l’autovalutazione del dolore al momento dell’accettazione in triage, 2. segnalazione dell’intensità del dolore sulla cartella di triage, poi trasmessa alla sala visita, utilizzando un’etichetta adesiva colorata, 3. affissione di poster esplicativi, indirizzati al personale, delle nuove modalità adottate per la valutazione del dolore in tutte le sale visita del reparto, 4. diffusione dell’iniziativa a tutto il personale medico ed infermieristico dell’azienda tramite newsletter. Dopo 3 mesi dall’introduzione dei cambiamenti è stato rivalutato il dolore. I pazienti sono stati intervistati dall’infermiere che, come parte del triage, chiedeva loro di segnalare il proprio dolore utilizzando la NRS. I ricercatori hanno completato l’intervista in ingresso e valutato il dolore in dimissione ed i dati raccolti non venivano comunicati al personale in servizio. DIMENSIONI DEL CAMPIONE Per ottenere una differenza statisticamente significativa di 1.39 punti sulla differenza media tra dolore prima e dopo la dimissione, con una potenza del 90% ed una significatività del 5% è stato necessario arruolare 100 pazienti per fase. Ipotizzando di non riuscire a completare le interviste al 139 20% dei pazienti, ne sono stati arruolati 120. Il valore di 1.39 è stato preso come riferimento in quanto riconosciuto clinicamente rilevante per indicare una variazione del dolore2, 19. ANALISI DEI DATI L’elaborazione dei dati raccolti è avvenuta con il programma Excel di Microsoft Office. Per confrontare i risultati delle due fasi è stato utilizzato il test del chi quadro per la differenza tra proporzioni. Risultati Nella fase pre dei 172 pazienti consecutivamente giunti in PS durante le giornate di osservazione, sono risultati eleggibili 157 [10 non avevano dolore, 1 non ha dato il consenso all’intervista, 3 non capivano l’italiano, 1 paziente è stato escluso per il peggioramento delle condizioni cliniche]. Per 29 [18.5%] non è stato possibile completare l’intervista in dimissione. Dei 128 pazienti inclusi, 33 [25.8%] sono stati arruolati nella prima giornata, 32 [25%] nella seconda, 26 [20.3%] nella terza, 22 [17.2%] nella quarta, e 15 [11.7%] nella quinta. Dei 142 pazienti della fase post, sono risultati eleggibili 134 [6 non avevano dolore e 2 non hanno dato il consenso all’intervista]. Per 13 [9.7%] non è stato possibile completare l’intervista in dimissione; 29 [24%] sono stati arruolati nella prima giornata di osservazione, 30 [24.8%] nella seconda, 31 [25.6%] nella terza e 31 nella quarta. Vengono pertanto presentati i dati su 128 pazienti nella fase pre, e 121 nella post. La tabella 1 descrive le caratteristiche basali della popolazione. TABELLA 1. CARATTERISTICHE BASALI DELLA POPOLAZIONE CARATTERISTICHE SESSO ETÀ CODICI AL TRIAGE PRE MASCHI FEMMINE MEDIA [DS] RANGE BIANCHI VERDI GIALLI <=20 [RANGE 12‐20] ETÀ [ANNI] ANALGESIA A DOMICILIO DIAGNOSI ALLA DIMISSIONE POST N=128 21‐40 41‐70 71‐80 SI DISTORSIONE/DISTRAZIONE ALGIA DI NATURA NON TRAUMATICA [ANT] CONTUSIONE LOMBALGIA/SCIATALGIA FRATTURA/INFRAZIONE ALTRO % 56 43.8 72 56.2 46 [19] 12‐81 100 78.1 28 21.9 0 % p value 63 52.1 0.18 58 47.9 0.2 49 [19] 0.23 15‐91 87 72 0.27 32 26.4 0.40 2 1.6 N=121 17 13.3 3 2.5 <0.01 33 63 15 30 27 25.8 49.2 11.7 23.4 21.1 48 49 21 17 28 39.6 40.6 17.3 14.1 23.1 <0.05 0.14 0.21 0.06 0.70 36 28.1 31 25.7 0.67 17 14 13 21 13.3 11 10.1 16.4 22 11 13 16 18.2 9.1 10.7 13.2 0.29 0.62 0.88 0.48 I pazienti non differiscono, se non per una diversa distribuzione nelle due fasce di età più giovani, per le principali variabili. 140 Come si può osservare in tabella 2, quasi la metà dei pazienti, indipendentemente dal codice di accesso al pronto soccorso, e quindi dalla priorità di accesso in sala visita, ha dolore elevato [grave], che meriterebbe pertanto una sedazione. Nel periodo pre è maggiore il numero di pazienti con dolore leggero al triage [p=0.03], mentre le differenze per i pazienti con dolore moderato o grave non sono statisticamente significative [rispettivamente p 0.15 e 0.9]. TABELLA 2. INTENSITÀ DEL DOLORE AL TRIAGE CODICE AL TRIAGE BIANCO VERDE GIALLO TOTALI PRE NRO PTI POST INTENSITÀ DEL DOLORE n [%] NRO PTI INTENSITÀ DEL DOLORE n [%] N LEGGERA MODERATA GRAVE N LEGGERA MODERATA GRAVE 100 28 21 [21] 5 [17.9] 42 [42] 13 [46.4] 128 26 [20.3] 37 [37] 10 [35.7] 47 [36.7] 87 32 2 121 10 [11.5] 3 [9.4] / 13 [10.7] 44 [50.6] 10 [31.3] 1 55 [45.5] 33 [37.9] 19 [59.3] 1 53 [43.8] 55 [43] I dati riportati in tabella 3 evidenziano come le due popolazioni siano confrontabili per la durata del dolore. L’intensità del dolore non porta necessariamente il paziente a rivolgersi al PS entro le 24 ore: infatti tra i pazienti con dolore grave più di 1/3 [45.5% fase pre e 37.7% fase post] si rivolge al PS dopo due giorni dalla comparsa del dolore. In totale 53 pazienti sia nel pre [41.4%] che nel post [43.8%] si sono rivolti in PS dopo più di 2 giorni. In maggioranza erano pazienti con algia di natura non traumatica [37.7% nel pre, 39.6% nel post] e con lombalgia [19% nel pre, 17% nel post]. Nei restanti casi si trattava di pazienti con patologie di natura traumatica tra cui distorsioni [15.1% nel pre, 9.4% nel post], contusioni [1.9% nel pre, 9.4% nel post] fratture [5.6% rispettivamente nel pre e nel post ] ed altre patologie [21% nel pre, 19% nel post]. TABELLA 3. DURATA DEL DOLORE ED INTENSITÀ PRE N=128 DURATA DEL DOLORE LEGGERA < 24 H > 24 H > 2 GG POST N=121 INTENSITÀ DEL DOLORE MODERATA GRAVE LEGGERA INTENSITÀ DEL DOLORE MODERATA GRAVE n=26 [%] n=47 [%] n=55 [%] n=13 [%] n=55 [%] n=53 [%] p value 12 [46] 5 [20] 9 [34] 18 [39] 10 [21] 19 [40] 23 [42] 7 [12.5] 25 [45.5] 6 [46] 3 [23] 4 [31] 23 [42] 3[5.5] 29 [52.5] 22 [41.3] 11 [21] 20 [37.7] 0.9 0.48 0.71 La tabella 4 mostra la percentuale di pazienti che avrebbero voluto la somministrazione di analgesico al momento del triage. Ovviamente più elevato è il dolore maggiore il numero di pazienti che vorrebbe un analgesico. Più di 2/3 dei pazienti tra quelli con dolore moderato e grave vorrebbero ricevere un analgesico subito. La percentuale è elevata [intorno al 40%] anche tra i pazienti con dolore lieve. TABELLA 4. INTENSITÀ DEL DOLORE/ANALGESICO SUBITO INTENSITÀ DEL DOLORE LEGGERA MODERATA GRAVE n 26 47 55 PRE N=128 n analgesico subito [%] 11 [42] 31 [66] 46 [83.6] n 13 55 53 POST N=121 n analgesico subito [%] 5 [38.5] 32 [58.2] 38 [71.7] 141 Le patologie più dolorose sono le lombosciatalgie che causano dolore grave nel 73% dei casi, mentre le fratture nel 50%; le contusioni nel 42% mentre le distorsioni nel 36% dei pazienti. Come descritto in tabella 5, la differenza media dell’intensità di dolore prima e dopo l’introduzione della scala nei pazienti in dimissione non è statisticamente significativa [p=0.6]. Se si considerano solo i pazienti con dolore moderato e grave, la riduzione è di 1.4 punti e la differenza di intensità del dolore nelle due fasi tra pazienti con dolore moderato e pazienti con dolore grave è statisticamente significativa [rispettivamente p<0.001]. TABELLA 5. DIFFERENZA NELL’INTENSITÀ DI DOLORE FASE DEL PERCORSO INGRESSO DIMISSIONE Differenza [I‐D] Media PRE N=128 PAZIENTI POST N=121 PAZIENTI INTENSITÀ MEDIA DEL DOLORE INTENSITÀ MEDIA DEL DOLORE LEGGERO n=26 3.1 2.4 MODERATO n=47 6.1 5.7 GRAVE n=55 8.6 7.8 LEGGERO n=13 2.8 3.2 MODERATO n=55 6.4 5.2 GRAVE n=53 8.7 7.1 ‐0.7 ‐0.4 ‐0.8 +0.4 ‐1.2 ‐1.6 ‐0.6 ‐0.8 Durante la permanenza in PS hanno ricevuto analgesia 7 pazienti [5.5%] nella fase pre [3 con dolore grave, 3 moderato e 1 leggero], 16 dopo l’introduzione della scala [13.2%], p<0.03 [9 con dolore grave, 5 moderato e due leggero]. L’analgesia è stata somministrata dopo la prima visita [4 casi nel pre ed 11 nel post], prima del trattamento ortopedico [1 caso nel pre, 1 nel post], e subito prima della dimissione [2 casi nel pre, 4 nel post]. Il dolore alla dimissione è complessivamente diminuito in 37 pazienti su 128 [29%] nella fase pre, ed in 48 su 121 [39.6%] nella fase post [Tabella 6]. In particolare, tra i pazienti con dolore grave, ne sono stati dimessi con meno dolore il 26.8% nella fase pre e il 51.8% nella fase post, p<0.001]. Complessivamente però nella fase post tra i pazienti con dolore grave quasi il 50% viene dimesso con dolore invariato o addirittura aumentato. TABELLA 6. VARIAZIONE NELL’INTENSITÀ DI DOLORE DOLORE IN DIMISSIONE DIMINUITO INVARIATO O AUMENTATO PRE [N]= 128 PAZIENTI POST [N]= 121 PAZIENTI INTENSITÀ DEL DOLORE ALL’INGRESSO INTENSITÀ DEL DOLORE ALL’INGRESSO LEGGERO MODERATO LEGGERO MODERATO GRAVE DOLORE IN GRAVE DIMISSIONE n=26 [%] n=46 [%] n=56 [%] n=12 [%] n=55 [%] n=54 [%] 11 [42.3] 11 [24] 15 [26.8] Diminuito 0 20 [36.4] 28 [51.8] INVARIATO O 15 [57.7] 35 [76] 41 [73.2] 12 [100] 35 [63.6] 26 [48.2] AUMENTATO Discussione Il problema dell’oligoanalgesia nei pazienti che afferiscono al PS è diffuso: l’attenzione da parte del personale sanitario nel procurare un’appropriata analgesia è ancora insufficiente 2,3 e pochi sono ancora i dati disponibili1,4. Nella maggior parte dei casi si tratta di studi retrospettivi, su cartelle cliniche. Nonostante la disponibilità di scale di valutazione del dolore in PS, pochi studi ne hanno valutato l’efficacia nel miglioramento della sua gestione4. 142 I risultati di questo studio evidenziano che far misurare il dolore al paziente e comunicarlo all’equipe che lo prende in carico contribuisce ad avviare un trend, seppure lento, verso il miglioramento del suo controllo. Si tratta di interventi semplici, a basso costo, che non comportano un aumento del carico di lavoro degli operatori in triage. I pazienti nei due periodi dello studio sono confrontabili tra loro per le caratteristiche basali, e non sono cambiate le equipe né sono stati introdotti farmaci o tecniche analgesiche nuove. La differenza media dell’intensità di dolore in dimissione non è risultata statisticamente significativa anche se si è osservata una riduzione media del dolore di 1.4 punti nei pazienti con dolore moderato e grave. E’inoltre aumentato [anche se di poco], il numero di pazienti che hanno ricevuto un’analgesia. In altri lavori l’efficacia dell’introduzione di una scala per la misurazione del dolore è stata valutata assieme all’introduzione di un protocollo farmacologico per il suo trattamento5,6 documentando un aumento della proporzione di pazienti che hanno ricevuto analgesia. La sola introduzione della misurazione del dolore ha però prodotto risultati simili nei pazienti oncologici22: l’adozione della VAS e di altri 4 strumenti per migliorare la descrizione del tipo di dolore e della sua localizzazione, ha determinato l’aumento della prescrizione di analgesici e la diminuzione dell’intensità di dolore nei pazienti. In uno studio Nelson et all1 ha valutato su 1000 pazienti [521 prima, 479 dopo] l’introduzione di una scala di valutazione del dolore dimostrandone l’efficacia nell’aumentare la proporzione di pazienti che ricevevano analgesia in pronto soccorso. Gli operatori erano all’oscuro dell’obiettivo del lavoro e non avevano ricevuto nessuna formazione specifica. Nel nostro caso gli operatori conoscevano l’obiettivo del lavoro, ma non erano al corrente dei dati raccolti durante l’intervista [ad eccezione di quelli sull’intensità di dolore del paziente in triage]. Gli interventi adottati hanno probabilmente aumentato l’attenzione degli operatori al dolore. Durante lo studio, il Comitato aziendale Ospedale Senza Dolore ha organizzato un corso di formazione sulla gestione del dolore in ospedale, cui hanno partecipato solo 7 infermieri del reparto e, pur non potendolo escludere a priori, è poco probabile che questa iniziativa abbia influito in modo rilevante sul loro comportamento. Resta comunque difficile spiegare la riduzione ottenuta nella media del dolore in dimissione, dato che la prescrizione di analgesici è aumentata solo di poco. Non esistevano controindicazioni alla prescrizione di analgesici per i problemi presentati dai pazienti. Non esistendo protocolli di trattamento, la prescrizione di analgesici dipende dal medico ma sono state osservate tutte le equipe. Sono stati somministrati più analgesici rispetto alla prima fase, nei pazienti con dolore moderato [5 casi] e grave [9 casi] che sono quelli che ne fanno più richiesta anche in triage e nel secondo periodo sono [anche se di poco] aumentati i pazienti con contusione, evento traumatico doloroso che generalmente non viene trattato con farmaci ma con l’immobilizzazione dell’arto. Queste due variabili possono aver contribuito a determinare, nei pazienti con dolore moderato e grave la diminuzione dell’intensità del dolore, pur in assenza di un aumento importante del numero di pazienti a cui è stato somministrato un analgesico. Nello studio non era stato previsto di raccogliere dati sulle tecniche antalgiche utilizzate. In fase post inoltre i dati sull’intensità di dolore al triage sono stati raccolti dall’infermiere. Questo può aver determinato un aumento dei casi di sovrastima da parte dei pazienti [con l’aspettativa di accedere prima alla visita] che quando dimessi hanno forse riferito un’intensità di dolore molto inferiore aumentando lo scarto11. Il nostro studio pur essendo stato correttamente dimensionato ha il limite dei risultati riferiti ad un campione non molto numeroso. Inoltre non è stato condotto in cieco come l’esperienza di Nelson e questo non permette di escludere con certezza che gli operatori [a conoscenza dell’obiettivo dello studio] possano in qualche modo aver modificato il loro comportamento durante la presenza dei ricercatori nel servizio. 143 Quindi, i risultati di questo lavoro vanno interpretati con cautela. Inoltre, tra l’introduzione della scala e la valutazione dei suoi effetti sono intercorsi tre soli mesi ed i risultati osservati potrebbero essere determinati in parte dall’entusiasmo iniziale degli operatori. Sarebbe utile ripetere la stessa valutazione tra un anno, per verificare se il trend osservato si mantiene. La sola introduzione della scala e la comunicazione dei risultati agli operatori non è sufficiente a modificare in modo rilevante la situazione: l’aumento di pazienti che hanno ricevuto un’analgesia è inferiore al 10% del totale, e il 45% dei pazienti con dolore grave vengono dimessi con situazione invariata o dolore aumentato. Conclusioni Gli interventi per il miglioramento della gestione del dolore adottati in questo studio hanno comportato un aumento dell’attenzione al dolore, del numero di pazienti trattati con analgesici durante il ricovero, e una riduzione della media dei punteggi di dolore nei pazienti con dolore moderato e grave superiore rispetto al periodo precedente. Questi dati , confermano, assieme a quelli di altri studi1,2,20, come l’oligoanalgesia sia ancora un problema importante, sottolineando come, nonostante il miglioramento conseguito, ci sia ancora molto da lavorare per migliorare la gestione del dolore, considerato in letteratura il V segno vitale21. Bibliografia 1. Nelson Bret P, Cohen D, Lander O, Crawford N, Viccelio Asa W, Siger AJ. Mandated pain scales improve frequency of ED analgesic administration. American Journal of Medicine. 2004; 22(7): 582‐585. 2. Dawn B, Kendrick MD, Tania D, Strout RN. The minimum clinically significant difference in patient‐assigned numeric scores for pain. American Journal of Emergency Medicine. 2005; 23: 828‐ 832. 3. TCherny‐ Lessenot S, Karwowski‐ Souliè F, Lamarche‐Vadel A, Ginsburg C, Brunet F, Vidal‐Trecan G. Management and relief of pain in an ED from the adult patients perspective. Journal of Pain and Symptom Management. 2003; 25(6): 539‐546. 4. Johnston CC, Gagnon AJ, Fullerton L, et all. One week survey of pain intensity on admission to and discharge from the emergency department. A pilot study. Journal of Emergency Medicine 1998. 16: 377‐382. 5. Duchrame J, Barber C. A prospective blinded study on emergency pain assessment and therapy. The Journal of Emergency Medicine. 1995; 13(4): 571‐575. 6. Stalnikowicz R, Mahamid R, Kaspi S, Brezis M. Undertreatment of acute pain in the Emergency Department: a challenge. International Journal for Quality in Health Care. 2005; 17(2): 173‐176. 7. Karwowsky‐Souliè F, Lassenot‐Tcherny S, Lamarche‐Vadel A, Bineau S, Ginsburg C, Meyniard O, Mendoza B, Fodella P, Vidal‐Trecan G, Brunet F. Pain in an emergency department: an audit. European Journal of Emergency Medicine. 2006; 13: 218‐224. 8. Leininger Hogan S. Patient satisfaction with pain management in the ED. Top Emerg Med. 2005; 27(4): 284‐294. 9. Fidelia SJ, Tim J, Wolfe J et all. Adequacy of pain assessment and pain relief and correlation of patient satisfaction in 68 ED fast‐track patient . Journal of Emergency Nursing. 2001; 27(4): 327‐ 334. 10. Garbez R, Puntillo K. Acute musculoskeletal pain in the ED: a review of the literature and implications for the advanced practice nurse. AACN Clinical Issues. 2005; 16(3): 310‐319. 11. Puntillo K, Neighbor M, O’Neil N, Nixon R. Accuracy of emergency nurses in assessment of patient’s pain. Pain Management Nursing. 2003; 4(4): 171‐175. 144 12. Knox HT. Pain assessment instruments for use in the Emergency Department. Emergency Medicine Clinics of North America. 2005; 23: 285‐295. 13. Berthier F, Potel G, Leconte P, Touze MD, Baron D. Comparative study of methods of measuring acute pain intensity in an ED. American Journal of Emergency Medicine. 1998; 16(2): 132‐136. 14. Blettery B, Ebrahim L, Honnart D, Aube H. Pain scale in an Emergency care unit. Rèan. Urg. 1996; 5(6): 691‐697. 15. Catania G, Costantini M, Lambert A, Luzzani M, Marceca F, Tridello G, Boni L, Bernerdi M. Validazione di uno strumento che misura le conoscenze e gli atteggiamenti degli infermieri italiani sulla gestione del dolore. AIR. Assistenza Infermieristica e Ricerca. 2006; 25(3): 149‐155. 16. Tanabe P, Buschmann M. Emergency nurses knowledge of pain management principles. Journal of Emergency Nursing. 2000; 26(4): 299‐305. 17. Università degli Studi di Torino. Facoltà di Medicina e Chirurgia. Corso di Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche. Gavetti D. La gestione del dolore in Pronto Soccorso. Studio Pilota. 18. Ricard‐Hibon A, Ducassè JL, Ravaud P, Wood C, Viel E Chauvin M, Brunet F, Bleichner G. Quality control programme for acute pain management in emergency medicine: a national survey. European Journal of Emergency Medicine. 2004: 198‐203. 19. Fosnocht DE, Chapman CR, Swanson ER, Donaldson GW. Correlation of change in VAS with pain relief in the ED. The American Journal of Emergency Medicine. 2005; 23: 55‐59. 20.Campbell P, Dennie M, Dougherty K, Iwaskiw O, Rollo K. Implementation of an ED protocol for pain management at triage at a busy level I trauma center. Journal of Emergency Nursing. 2004; 30: 431‐8 21. Thomas SH, Andruszkiewicz LM. Ongoing visual analog score display improves ED pain care. The Journal of Emergency Medicine. 2004; 26(4): 389‐394. 22. Youn SC, Su Hyun K, Yun Suk K, et all. Change in patient’s satisfaction with pain control after using the Korean cancer pain assessment toll. Journal of Pain and Symptom Management. 2006; 31 (6); 553‐562. 145 Intervento dal pubblico (Piccin Nives): Sono una Caposala di questo ospedale. Credo che il tema affrontato dal collega – relativo alle sperimentazioni cliniche – sia un quesito molto importante che dovremmo porci per la necessità di svolgere una ricerca che non sia solo una ricerca per le industrie farmaceutiche – come effettivamente accade il più delle volte – ma perché sia una ricerca veramente utile e metodologicamente corretta. Se c’è un coinvolgimento di più persone nella valutazione del disegno della ricerca, delle finalità, degli obiettivi di quanto deve essere realizzato, probabilmente si svilupperà un maggiore senso di responsabilità ed una visione critica da parte di tutti nell’esatta valutazione delle finalità ultime del lavoro di ricerca, che non è un lavoro irrilevante in quanto coinvolge – in termini economici e di dispendio di energie – molti colleghi. Su questo punto auspicherei una partecipazione maggiore dei colleghi. Come lo vogliamo chiamare? Consenso informato per gli infermieri? Collaborazione informata? Contributo, coinvolgimento? Non saprei, ma ritengo sia importantissimo. Desidero rivolgere una domanda a Cinzia Sanseverino sulla gestione dei risultati della ricerca. Nelle valutazioni che vengono fatte all’interno dei Comitati etici è prevista anche una proprietà dei risultati della ricerca? Dico questo perché purtroppo diverse storie del passato – non certo positive – ci hanno insegnato che lasciare unicamente alle industrie farmaceutiche la proprietà dei risultati può far correre dei seri rischi a chi in seguito assume le terapie. Lasciatemi infine esprimere il mio ringraziamento a voi tutti. Complimenti, sia per l’interesse dei temi proposti sia per l’alto livello di significatività statistica presente nelle varie relazioni. Grazie ancora. Cinzia Sanseverino Ti ringrazio per la domanda. Attualmente ci sono delle direttive ben precise che obbligano le segreterie dei Comitati etici di farsi promotrici nel seguire gli studi che sono stati avallati dai Comitati etici. Quindi, alla fine dello studio e in itinere il Comitato etico può chiedere – se non è il Comitato etico aziendale che è il principale promotore dello studio, ma se è una ricerca multicentrica – al Comitato etico che è il promotore, che fa da referente a tutti gli altri Comitati, come sta proseguendo la sperimentazione. Un dato che viene a mancare, ce ne rendiamo conto, è quello relativo alla sospensione dello studio poiché si è appurato che è inefficace. Lì si perdono i dati. Però, sulla sperimentazione in itinere – nonché quando essa è conclusa – il dato c’è e lo sperimentatore deve riportarlo. 146 M.A. Schirru (Presidente Collegio IPASVI di Torino) Prima della conclusione vorrei fare una riflessione circa l’intervento del collega: il Collegio – grazie a questa iniziativa – ha dimostrato di volersi sentire coinvolto nei problemi dell’etica e della deontologia così come di voler divenire un punto di riferimento per tali problematiche. Sul tema della sperimentazione clinica meriterebbe pensare ad un incontro che valuti approfonditamente i suoi vari aspetti. Sarei grata se i presenti – o coloro ai quali parlerete di questa iniziativa – porteranno al Collegio i problemi inerenti questa tematica, evidenziando gli aspetti da chiarire e da approfondire. Il tutto potrà divenire oggetto di proposte a livello delle varie aziende per la specificità e le problematicità di quel contesto. È necessario approfondire – anche attraverso la programmazione di una giornata dedicata al tema – questi aspetti unitamente a tutte le tematiche inerenti la sperimentazione clinica, quali problemi essa pone agli infermieri e come gli infermieri possono farvi fronte. E ancora: come riusciamo a collaborare con altre figure professionali al fine di non portare avanti discorsi o percorsi paralleli. È necessario quindi avere una visione globale che ci mostri tutti gli attori che partecipano alla sperimentazione clinica. Questo potrebbe condurci a portare avanti delle iniziative assieme agli Ordini dei medici e alle Università. È stata più volte ribadita la necessità di trovare delle convergenze su problemi che – seppur su piani e competenze differenziate – toccano tutti e hanno un obiettivo unico ossia fare una sperimentazione che abbia un senso ed una finalità sola: produrre miglioramenti dal punto di vista terapeutico o assistenziale per i pazienti. Pertanto raccolgo questa proposta, siamo disponibili. Consentitemi alcune battute conclusive. Sono state due giornate intense. Non ho molto da aggiungere a quanto detto: le suggestioni e gli stimoli sono stati molti. Vorrei lasciarvi con un’unica suggestione: non avevamo certo la pretesa di offrirvi delle verità. Non esiste – lo abbiamo compreso dai vari interventi – un’unica verità. Esistono delle verità o possibili percorsi per trovare una verità che si contestualizza sullo specifico problema che quotidianamente ci troviamo ad affrontare. Ritengo che l’elemento di complessità sia emerso in tutta la sua forza. Abbiamo anche parlato di livelli di responsabilità. A questo proposito vorrei fare un’importante sottolineatura: chi ha livelli di responsabilità si responsabilizzi per davvero perché non possiamo pretendere – lo hanno detto chiaramente i colleghi – che gli infermieri che si occupano della clinica – i quali hanno diverse problematiche da affrontare – debbano avere anche una visione a 360° di quelle che sono le condizioni a livello aziendale o di contesto più allargato, la qual visione è di responsabilità di qualcun altro. Questa mattina ho apprezzato l’intervento della collega Caposala: ha dato alcuni spunti di riflessione su quale dovrebbe essere la competenza di chi guida dei gruppi. Attenzione: non ho detto “guidare” in termini di gerarchia perché è importante che il contenuto di responsabilità sia un contenuto di responsabilità diffuso. Partendo da questo presupposto ci troviamo di fronte a livelli di responsabilità differenziati. Lo sostenevo nella mia relazione di ieri, e lo ripeto: non esistono persone più importanti o meno importanti all’interno dell’organizzazione. Il problema è riuscire a porsi un obiettivo comune e che questo obiettivo – quantomeno nel contesto dell’unità operativa in cui operiamo ogni giorno – riesca ad avere un intento unico. E allora, è bene che chi ha la responsabilità se la assuma tutta. Non lo dico io, è confermato da dati di ricerca: nel nostro Paese il punto debole è costituito dalla leadership. Lo vediamo anche all’interno delle nostre organizzazioni: la leadership è debole. Rivolgo un invito, e lo rivolgo con forza: se nella clinica vogliamo far crescere gli infermieri si concedano i giusti spazi di 147 protezione – affinché, all’atto pratico, si possa operare una buona assistenza – e chi ricopre incarichi di responsabilità crei un sistema di protezione dalle bufere esterne che ci distolgono dalle varie situazioni. E ancora: chi ricopre incarichi dirigenziali cominci ad essere la voce vera della professione. Lo dico da dirigente infermieristica: non andiamo da nessuna parte se non abbiamo intenti unici. Dunque, non viviamoci come controparte. Viviamoci come appartenenti ad un gruppo professionale che ha sicuramente bisogno di crescere. Ai nostri dirigenti trasmettiamo i problemi, ma forniamogli anche delle suggestioni per risolverli, altrimenti è il solito gioco dello scaricabarile, del passarsi la palla l’uno con l’altro. Come Collegio invece vorremmo offrire il nostro contributo, costruendo una politica professionale che abbia un senso per chi lavora nelle unità operative ed ogni giorno fatica nell’affrontare la realtà quotidiana. Forniteci gli strumenti per potervi aiutare: segnalateci le vostre critiche ed anche i vostri ritorni positivi… ogni tanto le carezze fanno bene a tutti, ma soprattutto le carezze fatevele fare da questo Collegio. Grazie. Edizione a cura di: Associazione CESPI Via G. Botero n. 19 10122 TORINO Vietata la riproduzione anche parziale. Tutti i diritti riservati. 148
Scaricare