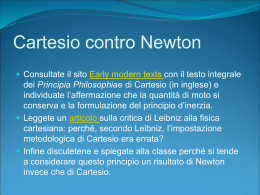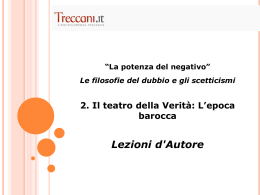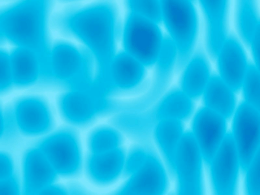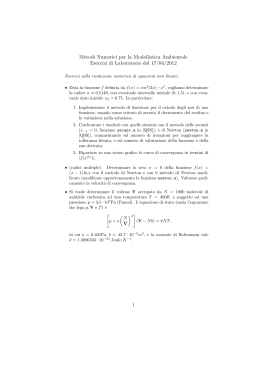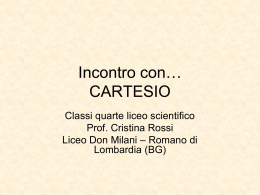Il mito dell’uomo macchina e la contestazione del meccanicismo in Inghilterra (secc. XVII-XVIII) Daniela Locatelli Questo lavoro mira a ricostruire e la nascita e la fortuna del paradigma meccanicistico, esemplare nel tema dell’uomo-macchina, in Francia, a cavallo tra i secoli XVII e XVIII. Mio scopo è, altresì, evidenziare come, per ragioni squisitamente teologiche, tale modello sia stato messo in crisi e sostanzialmente rifiutato nell’Inghilterra coeva, da Newton e dai suoi contemporanei. 1.1. Mersenne o la nascita del meccanicismo in Francia Nello stesso anno 1625, anno nel quale Cartesio andava progettando il Thaumantis regia ed esprimeva in pubblico la propria opinione sull’anima delle bestie, veniva edito a Parigi un lavoro dalle dimensioni notevoli di Padre Marin Mersenne, dal titolo La Vérité des Sciences. In tale opera, la quale può essere considerata vera e propria enciclopedia delle scienze, troviamo trattati che spaziano dalla taumatofisica, ossia scienza degli artifici atti a produrre meraviglie, definita come parte della Pneumatica, in cui ci si serve dell’aria e del vento, all’Idraulica, all’Automatofisica, che sembra far vivere le cose inanimate (fantasmi della tradizione alessandrina?), alla Neurospastica, alla quale fanno capo quegli artifici che si ottengono con l’argento vivo (pochi lustri dopo, il mercurio torricelliano ripreso da Boyle in Inghilterra). Proprio a partire da questo trattato, Mersenne sviluppa e perfeziona sempre meglio quell’opinione che ritiene gli animali meri meccanismi privi di anima e di ragione. A tale questione egli aveva già accennato in precedenza nelle Quaestiones in Genesim del 1623 ed in L’impieté des Deistes del 1624, ma solo ne La vérité des Sciences egli ne farà uno dei suoi argomenti preferiti. A causa delle notevoli dimensioni del trattato, che andava ben oltre le mille pagine, e risaputo che l’autore ne annunciò la vicina pubblicazione nel primo volume de L’impieté des Deistes, è possibile quindi pensare che La vérité des Sciences sia stata iniziata al più tardi nel 1623. In tale prospettiva, l’abbozzo cartesiano del Thaumantis regia del 1625 verrebbe ad essere di almeno un paio di anni posteriore all’opera compiuta di Mersenne. Si è da sempre sostenuto che Padre Mersenne abbia avuto un ruolo portante per diversi protagonisti della rivoluzione scientifica ed in particolare nei confronti di Cartesio, lo si è sempre visto come un suo comprimario, una sorta di onesto lavoratore capace di comprendere e divulgare correttamente le geniali trovate dell’amico e corrispondente. Per quel che si riferisce alla nascita del meccanicismo e in particolare all’idea dell’animale-macchina, siamo convinti che Mersenne, se proprio non ha preceduto del tutto Cartesio, non si è certamente limitato ad essere il divulgatore e l’esegeta delle opinioni cartesiane in merito. I due filosofi sono pervenuti agli stessi risultati, l’uno indipendentemente dall’altro, solo in seguito alla loro conoscenza: tale idea venne poi messa in comune, o meglio assegnata a Cartesio, favorito in questo anche dalla costituzionale umiltà del padre minimo.1 Verosimilmente, la loro collaborazione ebbe inizio intorno al 1625: è altresì vero che i due filosofi frequentarono lo stesso collegio gesuitico de La Flêche, ma la differenza di età, otto anni, che andava intercorrendo fra i due all’epoca della scuola, esclude che vi sia stato qualcosa di più di una conoscenza di vista. Caratterialmente essi si schierano agli opposti: al modesto, umile e disponibile Padre Mersenne, segretario della nascente repubblica letteraria, si oppone il superbo, egocentrico e pieno di sé Cartesio. 1 Cfr. P.A. ROSSI, Metamorfosi dell’idea di natura, Genova 1999, anche per le mie pagine che seguono. Tra due persone così è evidente che mai potrà esservi un rapporto paritetico, a meno che il primo non si adegui con paziente modestia alla boria dell’altro; la storia attribuisce a Mersenne il merito di essere stato per l’amico utile dal punto di vista logistico, mentre, ancora oggi, la storiografia filosofica descrive il religioso come una sorta di gregario di Cartesio: in tale prospettiva risulta quindi assai difficile rivalutare la figura di Mersenne come quella di uno dei padri fondatori del meccanicismo.2 A saper ben leggere Mersenne ci si accorge di quanto egli abbia, invece, saputo ascoltare, comprendere, rielaborare e dare culturalmente forma alle più interessanti idee del suo tempo: egli non si limitò a prendere nota delle teorie di Galileo, di Cartesio, di Pascal, di Hobbes, di Gassendi e di tantissimi altri ancora, egli si rese partecipe forte di tutta una serie di sue impostazioni originali che influirono in modo deciso sulla nascita della rivoluzione scientifica. Le Quaestiones celeberimae in Genesim, con l’aggiunta integrativa delle Observationes et emendationes ad Francisci Giorgi problemata, sono scritte contro gli atei, i deisti e le “divinatrices et magicas artes ceteraque portenta doctrinarum ejus generis”. Al fine di non incorrere nel pericolo di divulgare, confutandole, le “cattive filosofie” e le “false scienze”, egli le “impugna ed espugna”, inserendole nell’esegesi ortodossa delle Sacre Scritture. In verità, il testo biblico gli serve più che altro da pietra di paragone su cui saggiare le opinione dei naturalisti, in particolare di Campanella, Pomponazzi, Paracelso, dei maghi, degli astrologi e dei cabalisti come Pico della Mirandola e Gerolamo Cardano, e dei deisti, atei o sorςiers suoi contemporanei, come Vanini, Charron, Fludd. In realtà non è mai il testo sacro che gli serve da maglio demolitore del pensiero magico-naturalistico ed egli è sempre ben disposto a ricredersi in nome di una serena disamina condotta da ambedue le parti con lo strumento della ragione. Non è un caso, infatti, che Mersenne, in nome della stima intellettuale, distingua tra il Cardano astrologo e il grande matematico, tenda costantemente la mano a Campanella ed intrattenga rapporti d’amicizia con “eretici” quali Galileo e Hobbes. Laddove i naturalisti, gli atei e i libertini, i deisti e gli eretici hanno collaborato ad aprire nuove strade alla ragione, egli si fa loro difensore, ma quando sospetta in qualcuno un attacco contro la libertà dell’uomo, Mersenne abbandona la penna per la spada. La seconda opera mersenniana, L’impieté des Deistes, Athées et Libertins de ce temps, è dedicata, in particolare, alla confutazione dei Dialoghi bruniani, alla polemica contro l’astrologia divinatrice di Gerolamo Cardano e, più genericamente, alla demolizione della filosofia naturalistica con particolare riguardo alla teoria dell’Anima del Mondo: Dio, i cui progetti tutti tendono alla sua gloria, mi fece riconoscere, primo fra tutti in questo Regno, la nascita di questo monopolio di libertini e per effetto della sua misericordia e provvidenza, mi obbligò il mio zelo e il mio dovere a intenzionare i miei sforzi ad arrestare il corso ed a fermare il progresso di tale malaugurato progetto. Il controprogetto di Mersenne è quello di dimostrare che la ragione, sia essa teoretica che pratica, è lo strumento privilegiato che Dio ha dato all’uomo per comprendere qualcosa dei segreti della natura e dello spirito o, in altre parole, la costruzione della scienza positiva è intesa alla riconversione a Dio, mentre l’incredulità non può essere la condizione basilare della scienza, dato che sia la scienza sia la morale ci parlano di Dio. In queste opere giovanili, pervase da un ardente spirito polemico, Mersenne non se la prende, come dettava la moda del tempo, con la filosofia naturalistica di Aristotele, ma con le sue degenerazioni magico-naturalistiche dei secoli XV e XVI. A coloro che avevano elevato la sensibilità a forma di conoscenza e quindi l’animale all’intelligenza, onde poterne fare una della parti dell’Anima del Mondo, Mersenne mette in chiaro come non gli vada affatto a genio l’idea dell’unità e dell’unicità dell’Intelletto. Per tale ragione, nelle Quaestiones in Genesim, incomincia a mettere in dubbio la tesi dell’intelligenza delle bestie, convinto in tal modo di togliere parte degli argomenti ai naturalisti che avevano affermato che il Mondo ha una sola ed unica anima, la quale vegeta, sente e ragiona. 2 R. LENOBLE, Mersenne ou la naissance du mécanisme, Paris 1943. 2 A differenza di Cartesio, egli non parte dal dubbio, ma inizia a rilevare una prima certezza: ciò che mi fa riconoscere come io non è una qualche verità che posseggo, ma la consapevolezza di desiderare la verità che non posseggo. Mersenne non va a caccia di certezze universali, egli è convinto che nell’aldilà potremo rimanere stupiti di quanto il mondo sia diverso da quel che pensavamo: per lui è sufficiente conoscere le cose per quel tanto che ci sono proporzionate. La sua scienza non è mimesi dell’universale ma rilevamento di rapporti; la ragione non è intesa ad impadronirsi delle verità eterne, ma più semplicemente a tracciare un sistema di relazioni fra le cose tale da superare il mondo empirico e ridare proporzione a ciò che i sensi hanno sproporzionato. Sotto tale aspetto, Mersenne ha certamente contribuito in misura più incisiva di Cartesio alla creazione di quella svolta teoretica da cui la scienza esce affrancata dalla filosofia. In particolare la ragione, così tipica dell’essere umano e in maniera così assoluta assente negli animali, non è per Mersenne solo intelligenza ma, fondamentalmente, è libera volontà, massima perfezione dell’uomo, da esso condivisa solo con Dio e con gli Angeli, tanto che se la perdesse si ritroverebbe a non essere più uomo, perdendo allo stesso tempo l’humanité et la raison, et cessere d’estre capable de youyr de la felicité eternelle.. Ritorna qui la stessa tematica che aveva portato Cartesio alla negazione dell’anima alle bestie: l’uomo è il solo a condividere con i Puri Spiriti la libertà; essa è il marchio autentico della spiritualità, tanto che chi non possiede libera volontà non ha di conseguenza nemmeno l’anima. Quindi l’uomo, come animale che vuole liberamente, che desidera la verità, che anela all’immortalità della sua parte spirituale, ha un’anima unica, individuale, responsabile dell’agire e capace di scegliere; esso non è sottoposto ad alcun destino, la sua parte materiale deve rispettare sì le leggi naturali e sottomettersi alle regole che reggono il gioco fenomenico, ma la sua parte spirituale non ha nulla a che vedere con tutto ciò e, di conseguenza, il mondo fenomenico non ha alcuna influenza su di essa. Il corpo dell’uomo appartiene alla Natura ed è sottoposto alle sue leggi, ma l’uomo, come persona, appartiene ad un ordine incommensurabile con quello fisico, dato che egli è stato messo a parte della Grazia. La scena di questo mondo passerà così come la sua storia, ma la parola di Dio, il cammino dell’uomo verso la Verità, la sua grandezza di figlio divino, non passeranno. L’uomo inizia a capire quel che per lui conta, ciò per cui valga la pena giocare la propria vita, appartiene ad un ordine differente da quello naturale e, di conseguenza, non si rivolge ad esso per cercare le proprie radici, ma solo per convertirlo al piano della salvezza. Lo scienziato può, a questo punto, rompere con il “tabù del naturale”: egli ora sa che le sue opere materiali appartengono alla natura, mentre egli ha un destino storico che le trascende. Nel momento in cui la Natura perde la propria prerogativa di giustificare non solo il mondo materiale, ma anche l’uomo, allora essa può divenire una macchina. Nelle Quaestiones in Genesim Mersenne sostiene che l’uomo sia unione di anima e corpo e che esso possa essere definito solo con il ricorso ad ambedue i concetti. Nell’ambito della conoscenza, cioè in quell’ambito nel quale si cerca la certezza razionale dell’esperienza in sé, egli afferma che nessuna delle due può operare senza il supporto dell’altra. Se è vero che la ragione è la facoltà che stabilisce i rapporti fra i dati empirici, che da soli non parlano, è altresì vero che essa non può esercitarsi se non quando ha a che fare con la conoscenza sensibile, visto, ad esempio, che nel sonno la mente, privata delle sensazioni, rimane impotente. Ma se così fosse – gli obiettarono gli scettici – cioè se la conoscenza razionale facesse corpo unico con quella sensibile, così come mente e corpo fanno parte integrante dell’uomo, allora essa risentirebbe delle ben note inadeguatezze della percezione sensoriale, ossia agli errori dei sensi corrisponderebbero quelli della ragione. A Mersenne si pose il problema di far partecipare la conoscenza empirica della stessa conoscenza razionale: diversamente da Cartesio, che dichiarò di basare le sue uniche certezze sul Cogito, gli interessano più l’ottica e l’acustica rispetto alla metafisica, egli quindi ha bisogno sia dei sensi che della ragione. Contemporaneamente a Galilei, egli accertò la soggettività delle qualità delle qualità sensibili, dichiarando che nella percezione i 3 sensi non si limitano a registrare passivamente, ma integrando i dati a seconda del loro temperamento. In La verité des Sciences Mersenne aggiunse che “i diversi temperamenti dei sensi sono la ragione per cui gli oggetti ci sembrano diversi” o, meglio ancora “gli oggetti dei sensi ci sembrano diversi secondo le diverse disposizioni dell’organo”, ragion per cui sulla sola conoscenza sensibile non è 3 possibile costruire alcuna scienza che goda delle caratteristiche dell’oggettività e del rigore. Per istituire, quindi, una fisica senza far astrazione dei dati della psicologia, Mersenne rispose, ne L’impieté des Deistes, che questo sarebbe possibile se si matematizzassero natura e scienza. In definitiva, la soluzione è per Mersenne quella di dimostrare che la conoscenza sensibile, senza il conforto della ragione, non è conoscenza, ma pura registrazione di impressioni, e di conseguenza non può essere meccanizzata. L’idea, che cominciò a svolgersi fin dal 1623 nelle Quaestiones in Genesim, prese forma compiuta solo nel 1634, quindi, probabilmente, in concomitanza alla discussione del cartesiano Traité de l’homme, ma ciò non deve farci pensare ad un prestito di idee, piuttosto ad un prestito di argomentazione. Galileo, che aveva proposto l’idea di eliminazione delle nozioni qualitative dalla scienza, fece notare che, se oltre al moto e alla vegetazione, anche la sensazione è il risultato di un concorso di azioni puramente meccaniche, allora l’intera sfera delle attività animali avrebbe potuto essere meccanizzata e considerata analoga a quella di qualsiasi macchina. In tutto questo vortice di idee, che rappresentarono il perno motore della cultura moderna, l’idea dell’animale-macchina si trova in una posizione costantemente attivatrice. Nata in ambito etico e psicologico, essa ha generato una serie di concettualizzazioni dalle quali sortiranno la scienza e la filosofia meccanicistica.4 1.2. L’uomo-macchina nel Seicento: Cartesio e i cartesiani In apertura al suo Traité de l’homme, apparso postumo nel 1664, Cartesio scrive: je suppose que les Corps n’est autre chose qu’une statue ou machine de terre que Dieu forme tout exprés, pur la rendre la plus semblable à nous qu’il est possibile: en sorte que, non seulement luy donne au dehors la couleur et la figure de tous non membres, mais aussi qu’il met au dedans toutes les pieces qui sont requises pour faire qu’elle marche, qu’elle mange, qu’elle respire et enfin qu’elle imite toutes celles den nos fonctions qui peuvent estre imaginées proceder de la matière, et ne dependre que de la disposition des organes. Nous voyons des horloges, des fontaines artificielles, des moulins, et autres semblables machines, qui n’estant faites que par des hommes, ne laissent pas d’avoir la force de ce mouvoir d’elles mesmes en plusieurs diverses facons; et il me semble que ie ne sourais imaginer tant de sortes de monvements en celle-ci, que ie suppose estre faite des mains de Dieu, ny luy attribuer tant d’artifice, que vous n’ayez sujet de penser qu’il en eut avoir encore d’avantage5. Con queste parole si apre il manifesto dell’antropologia meccanicistica; esso, probabilmente, non ebbe sulla cultura del XVII secolo la presa che avrebbe avuto qualora fosse stato pubblicato, come l’autore sperava di fare, entro un unico grande discorso che inglobasse il Mondo delle cose materiali e quello dell’Uomo. Un sistema che rappresentasse, in definitiva, il sostituto meccanicistico dell’idea classica di Cosmo ed in cui uomo e natura avrebbero dovuto essere oggettivati sugli stessi concetti base di moto e di figura. Il porsi, in seguito, il problema della trascendenza dell’uomo rispetto alla natura corporea, impostarne i termini e le ipotesi di lavoro, avrebbe significato il 3 P.A. ROSSI, Metamorfosi dell’idea di natura, cit., pp. 70-71. Ivi. 5 R. CARTESIO, Traité de l’homme, in Oeuvres, ed. Adam-Tannery, XI, 119-215. 4 4 concepimento di quella scientia mirabilis che il “sogno mistico” del novembre 1619 gli aveva fatto intravedere6. Sta comunque di fatto che se l’idea unitaria di Cartesio non si compì che dopo la sua morte, egli ebbe modo di pubblicarne in vita, sia pur in forma di frammenti monografici, alcune parti e di accennare più volte alla sua concezione meccanicistica, sia nel Discours de la méthode sia nell’Epistolaire con Mersenne, il quale si premurava sempre di far circolare le idee dell’amico. La cultura scientifica dell’epoca, d’altra parte, era talmente pervasa e penetrata dall’interpretazione meccanicistica dei fenomeni fisici e biologici, che quando l’opera unitaria di Cartesio vide finalmente la luce, essa interessò e stupì soltanto l’ambiente filosofico, mentre i medici, che pur la lessero certamente con interesse, elogiandone la sintesi sistematica e la chiarezza espositiva, si stancarono ben presto delle pure “verosimiglianze” ivi contenute che, accanto alle fantasticherie e agli errori, la rendevano scientificamente approssimativa.7 In realtà il Traité de l’homme è un’opera che venne alla luce già morta, in un’epoca cioè in cui il meccanicismo biologico era già stato passato al vaglio dalle scuole di iatrofisica e iatrochimica ed aveva ricevuto più di una verifica sperimentale. Nel 1661, ossia un anno prima della pubblicazione in latino del De Homine, era uscito il De Pulmonibus del Malpighi, sintesi e unificazione della modellistica iatromeccanica e iatrochimica, in cui la macchina circolatoria di Harvey veniva completata e resa definitiva, chiudendo la catena del transito sanguigno con la scoperta della macchina alveolo-capillare in grado di svolgere la duplice azione, ossia quella miscelatoria, in cui l’ematosi si compie, e quella fermentativa, in cui hanno atto sia le termogenesi sia la fluidificazione sanguigna. Quando, l’anno successivo, viene pubblicata l’opera cartesiana, ricompare lo spettro del moto cardiaco per gonfiamento e sgonfiamento del viscere, che già aveva trovato spazio nella Quinta Parte del Discours de la mèthode, in maniera insolente peraltro, essendo questa teoria non altro che un residuo della fisiologia scolastica. Sta comunque di fatto che l’opera di Cartesio ebbe maggior fortuna dei suoi reali meriti: la medicina del XVIII secolo le riconoscerà la paternità della genesi della fisiologia meccanicista, allo stesso modo con cui a Cartesio verrà accreditata la nascita del meccanicismo in fisica, dimenticando Galileo, Gassendi, Huygens e padre Mersenne, così come ci si dimenticherà di Borelli, Sylvius e Malpighi quando si tratterà di stabilire la paternità della Weltanschauung meccanicista del vivente. La storia delle idee riconoscerà al De Homine il merito di essere stato il primo moderno trattato di fisiologia e la storia della scienza penserà anzitutto a Cartesio quando traccerà la storia della nascita del meccanicismo biologico. Solo il Seicento, il suo secolo, accolse tale opera con i giusti accorgimenti: Hobbes e Pascal la reputeranno, però a torto, filosoficamente irrilevante; Bellini, Malpighi e la scuola di iatrochimica la troveranno scientificamente opinabile. In realtà, Cartesio aveva scritto tale trattato dal 1632 e va quindi riconosciuto che se trentadue anni più tardi esso appariva scientificamente sorpassato, nel momento della sua stesura sarebbe stato dallo stesso punto di vista, interessante. La storia di quest’opera, delle sue traversie teoretiche e dei suoi dubbi umani, è narrata dallo stesso Cartesio a Mersenne: "il y a déjà 12 ou 13 ans que j’avais décrit toutes les fonctions du corp humain, ou de l’animal, mais le papier où ie les ai mises est si brouillé que i’aurais moi-meme beaucoup la peine à le lire; toutefois, je ne pus m’empecher, il y a 4 ou 5 ans, de le preter à un intime ami, lequelle en fit une copie, laquelle en a encore été transcrite depuis par deux autres, avec ma permission, mais sans que je les aie relues et corrigées. Et je les avais priés de ne le faire voir à personne, come aussi je ne l’ai jamais voulu faire voir à Regius, parce que je savais son humeur, et que, pensant faire imprimer nos opinions touchant cette matière, je ne desirais pas qu’un autre leur ôtat la grace de la nouveté. Mais il a eu, malgré moi, una copie de cet écrit, sans que je ne puissedeviner, en ancune facon, par quelle moyen il l’a eu et il en a tiré cette 6 Nella notte tra il 10 e l’11 novembre 1619 Cartesio, che allora aveva ventitre anni, trovò i “fondamenti di una scienza mirabile” e, un anno dopo, lo stesso giorno, iniziò “a capire i fondamenti di quella mirabile scoperta” (R. CARTESIO, Discorso sul metodo, a cura di LUCIA URBANI ULIVI, Milano 2002, p. 11). 7 P.A. ROSSI, Metamorfosi dell’idea di natura, cit., al quale mi rifaccio per la stesura di questo paragrafo. 5 belle piece du mouvement des muscles. Il en eut pu tirer beaucoup d’autres choses, pour grossir son livre..."8 Sia come sia, il De Homine esce troppo tardi per influenzare, più di quel tanto, la fisiologia meccanicista. Al contrario, il suo peso sarà molto rilevante nell’ambiente delle interpretazioni filosofiche del meccanicismo biologico e per la costruzione del dualismo antropologico. Quel che invece ebbe un determinante rilievo proprio per la genesi del pensiero biologico meccanicista fu l’impostazione che Cartesio diede, fin dai Principia Philosophiae (1644), al problema della naturalità artificiale. L’ampliamento del concetto di Natura, fino a fargli contenere l’ambito concettuale della macchina, rappresenta la condizione sufficiente per poter predicare la naturalità circa i prodotti della tecnica e la possibilità di utilizzare questi ultimi come modelli teorici in grado di dar ragione della struttura e dell’uso dei diversi organi che compongono il corpo umano. Il merito di quest’idea, o della sua dimostrazione, è senza dubbio di Cartesio, sebbene ciò faccia parte di quella “caduta di tabù del naturale”, segno dei profondi mutamenti culturali del secolo, che trovò le sue stesse radici nella nascita della scienza moderna, come abbandono del sapere di tipo filosofico. In definitiva, Cartesio rappresenta il momento della formalizzazione di un’idea che peraltro era implicita nelle condizioni stesse della nascita del concetto moderno di Natura. La nascita dell’antropologia meccanicistica del XVII secolo è legata alla caduta di quello che è chiamato “tabù del naturale”. Il tema dell’uomo-macchina, ovviamente, non può essere svolto se non dopo la comparsa dell’idea che l’opera dell’ingegno umano ha gli stessi diritti di “naturalità” dei prodotti della natura. Il pensiero classico aveva considerato la natura come la sollurs ars che la lezione ciceroniana nulla ars imitari solertiam naturae potest aveva codificato, con l’aggettivazione perfettiva di arte completa. Da questo derivò una plurisecolare rotta speculativa, la quale, avendo qualificato il prodotto della natura secondo la sua caratteristica di “forma primaria”, non aveva potuto considerare imperfetta ed incompleta un’attività imitativa in grado di agire solo sulla sfera dell’accidentale, dato che il prodotto della tecnica era qualificato secondo la sua caratteristica di essere “forma secondaria”. L’imperfetta imitazione del prodotto naturale da parte di quello artificiale non è legata quindi all’incompetenza dell’artigiano, ma è fondata su una necessità ontologica. Sta poi di fatto che, storicamente, è l’artificiale che viene spiegato in termini di naturalia e non l’opposto, cioè è l’universo del naturale che viene allargato fino ad includervi anche l’artificiale; Harvey, nel De generatione animalium, condanna la sviante prospettiva di chi considera il mondo con l’occhio fisso all’ambito della produzione tecnica, dato che è necessario invece capovolgere la prospettiva e giudicare gli artificialia assumendo come modello il mondo naturale9. Tant’è vero che il risultato dell’operazione di abbattimento della barriera tra arte e natura è espresso nella proposizione cartesiana “tutto ciò che è artificiale è di per ciò stesso naturale” e non dalla proposizione “tutto ciò che è naturale è di per se stesso artificiale”, che è il principio della sorçellerie. Ciò avrebbe implicato, infatti, una drastica riduzione dell’universo naturale, fino a farlo coincidere con quello artificiale; la prima strada tentata al riguardo è quella della filosofia naturalistica del XV-XVI secolo, dove la natura viene considerata come il prodotto della divina magia. La seconda strada è quella di fare dell’universo intero una macchina e di Dio il suo demiurgo. La visione di Dio come artigiano superiore, anche se fa la sua prima comparsa alla fine del XVII secolo, non è un’idea guida del pensiero teologico-naturalistico del Seicento. Erroneamente, si ritiene che a partire dal Seicento si inizino a considerare “naturali” i congegni meccanici. Per quel che riguarda l’esegesi dei testi a nostra disposizione, non vi è autore del XVII secolo tanto poco accorto da non vedere che di macchine in grado di realizzare o perlomeno di avvicinarsi alla perfezione dei prodotto naturali, non vi è alcuna traccia. Mersenne, a proposito scrive che 8 R. CARTESIO, Correspondence, a cura di C. Adam C. – G. Milhaud, Paris, 1936 (A Mersenne, 23 novembre 1646, VII, pp. 1-2). 9 W. HARVEY, De genaratione animalium, in Opera Omnia, Londra 1766, p. 385. 6 tuttavia non vi sarebbe tanta bellezza, né tanta industria quanta ve n’è nella composizione e nel movimento di un moscerino, che da solo racchiude e contiene più meraviglie di tutto ciò che l’arte degli uomini possa fare o rappresentare10, mentre Cartesio aggiunge: il che non sembrerà affatto strano a coloro i quali, sapendo quanti diversi automi e macchine semoventi può costruire l’industria umana con l’impiego di pochissimi pezzi in confronto alla grande quantità di ossa, muscoli, nervi, arterie, vene ed altre parti che compongono il corpo di ogni animale, considereranno questo corpo come una macchina che, essendo stata fatta dalle mani di Dio, è incomparabilmente meglio ordinata, ed ha in sé movimenti tanto più meravigliosi di quelli che mai gli uomini possono inventare11. Più tardi, Bossuet affermerà che non esiste genere di macchina che non si trovi nel corpo umano…(ma)…Nessuno scalpello, nessun tornio, nessun pennello può avvicinarsi alla sensibilità con cui la natura tornisce e arrotonda i suoi oggetti12. Questi sono tre autori nei quali il connubio arte-natura è già stato celebrato non solo con il rito baconiano, ma sostanzialmente con quello galileiano; in altre parole Mersenne, Cartesio e Bousset, pur avendo già raggiunto la piena consapevolezza della sostanziale non diversità fra naturale e artificiale, non reputano certamente discriminatoria la maggior perfezione del prodotto naturale nei confronti dei prodotto dell’umano ingegno, in ordine alla definizione del concetto di Natura. Infatti, ancor prima di Cartesio, Bacone aveva avvertito che “la natura supera infinitamente il senso e l’intelletto per la finezza delle sue operazioni…”13, mentre Galileo aveva rincarato: “non possiamo noi dire con ragione la fabbrica d’una statua ceder d’infinito intervallo alla formazione di un uomo vivo, anzi anco alla formazion di un vilissimo verme?”14. Vi è comunque un brano dei Principia Philosophiae in cui sembrerebbe possibile far affermare a Cartesio che, almeno per quel che lo riguarda, le cose sono andate esattamente in tal maniera: l’esempio di molti corpi costruiti dall’umano artificio mi è stato davvero utile; infatti non ho riconosciuto alcuna differenza tra le macchine che gli artigiani costruiscono ed i diversi corpi che la sola natura compone, se non per il fatto che mentre le azioni della macchina dipendono dal movimento di certe canne o molle, o altri congegni, le quali dato che debbono essere proporzionate alle mani di coloro che le costruiscono sono sempre tanto grandi che le loro forme e movimenti sono visibili, al contrario le canne e le molle che provocano le azioni dei corpi naturali sono generalmente troppo piccole per essere percepite dai nostri sensi15. Insomma, Cartesio afferma che, dopo aver confrontato le macchine con i corpi naturali, ci si accorge che, in via di principio, sono simili, restando, in via di fatto, la sola differenza della maggior complessità strutturale dei corpi naturali e della loro mirabile composizione di parti miniaturizzate. Sottoponendo il brano ad un’analisi poco più approfondita, si avverte chiaramente che Cartesio non sta affermando di aver raggiunto la consapevolezza che non vi sia differenza tra naturalia e artificialia, ma semplicemente che, dopo aver preso visione del lavoro degli artigiani, ciò gli è stato 10 M. MERSENNE, Harmonie universelle, Paris 1636, p. 231. R. CARTESIO, Discours de la Méthode, V, pp.195-197. Trad. L.U.Ulivi, Milano 2002. 12 B. BOSSUET, Traité de la connaissance de Dieu et de soi meme, Paris 1677, p. IV. 13 F. BACON, Novum Organum, in The Works of Francis Bacon, London 1857-1874, vol. I, p. 10. 14 G. GALILEI, Dialogo dei massimi sistemi, in Le Opere di Galileo Galilei, Ed. Naz., Firenze 1890-1909, vol. VII, pp. 11. 15 R. CARTESIO, Principia Philosophiae, ed. cit., II, 102. 11 7 utile per verificare un’idea che già si era fatto e formato seguendo il “metodo”, ossia l’idea che “ogni conoscenza che gli uomini possono avere della natura – scrive alcune righe prima del brano di cui sopra – è ricavata da ciò (ossia dai principi della geometria e della meccanica) dato che tutte le altre nozioni che si hanno delle cose sensibili sono confuse ed oscure”16. Difatti, a ben ricordare, è così che egli conclude: così come è certo che tutte le regole della meccanica fanno parte della fisica, allo stesso modo tutto ciò che è artificiale è di per ciò stesso naturale17. 1.3. L’uomo-macchina nel Settecento: La Mettrie e i materialisti Dopo aver studiato medicina prima a Parigi, poi a Leida, in Olanda, allievo dell’illustre Hermann Boerhaave, medico spinoziano sostenitore di un radicale meccanicismo fisiologico, Julian Offray de La Mettrie si colloca tra gli esponenti più radicali e lucreziani dell’Illuminismo francese. Ancora oggi conosciuto più come filosofo che come studioso di medicina, egli, grazie al proprio passato di medico militare, ebbe modo di poter osservare sulla sua stessa persona le conseguenze psichiche di una malattia organica: ciò gli permise di potersi fermamente convincere della stretta interdipendenza che intercorre tra anima e corpo, fino a ricondurre le cause dei processi psichici a modificazioni ed eventi di sola natura corporea. Tali attente osservazioni finirono con la radicalizzazione in senso fortemente materialista di quella che era stata la sua formazione originaria, incentrata su Locke e Newton, sviluppando anche linee di pensiero diffuse in ambiente inglese e rese successivamente pubbliche attraverso l’opera Histoire naturelle de l’âme, del 1745, in seguito Traité de l’âme, opera che attirò su La Mettrie ogni genere di persecuzione, sia da parte dei religiosi che dei politici. L’Olanda, al tempo libera e tollerante, non si rivelò affatto luogo sicuro, tanto che il nostro filosofo fu costretto a rifugiarsi a Berlino, sotto la protezione del grande Federico II di Prussia, considerato il sovrano protettore dei Lumi e monarca illuminato lui stesso, amico anche di Voltaire e Algarotti, Eulero, d’Alembert e Lagrange. Alla corte di Federico II il medico-filosofo rimase fino al 1751, anno della morte, libero di potersi finalmente dedicare ai suoi studi preferiti e scrivendo, in un arco di tempo assai breve, quelle opere che gli avrebbero aperto le porte del pensiero scientifico, dall’Homme machine del 1747 all’Homme-plante dell’anno successivo, da Anti-Sénèque del 1750 al Système d’Epicure del 1751, dalle Réflections philosophiques sur l’origine des animaux del 1750 a Les animaux plus que machines dello stesso anno, sino al meno conosciuto Discours préliminaire, appositamente scritto per l’edizione completa delle Oeuvres philosophiques, uscita a Berlino a cura dell’autore stesso proprio nel 1751, anno della scomparsa. L’anno seguente sarà proprio lo stesso sovrano, Federico II di Prussia, a volerne fortemente scrivere l’elogio accademico, pubblicato poi sulle pagine più che prestigiose della Histoire de l’Académie Royale de Berlin, istituzione della quale il medico e filosofo francese era stato figura d’elite. Se in un primo momento La Mettrie si presentò come un tenace e convinto fautore del meccanicismo cartesiano, in seguito ne respinse il dualismo ontologico tra res cogitans e res extensa, risolvendo la prima nella seconda, ossia il pensiero nella realtà: la differenza tra animale e uomo gli parve essere infatti solo di tipo quantitativo, e non qualitativo. All’interno della metafisica cartesiana tutto ciò che poteva essere attribuito all’anima poteva essere spiegato facendo ricorso al solo concetto di modificazione inerente alla materia. Lo stesso pensiero umano ne usciva come una sorta di prolungamento della sensazione che di fatto lo produce, comune a ogni animale e di carattere interamente materiale. Andando molto al di là del modello cartesiano di spiegazione fisica della realtà naturale, La Mettrie arrivò sino al punto di affermare che tutta la materia è senziente, anche per quei livelli che apparentemente paiono essere più inerti e bassi, andando così a sostenere 16 17 Ivi. Ivi. 8 l’ipotesi molto suggestiva dell’unità dell’intero universo, visto come una grande catena di esseri, gerarchicamente collocati dal più semplice fino al più complesso, in maniera cioè crescente. Nella sfera propria dell’etica, da vero seguace dell’epicureismo e dell’atomismo di ispirazione lucreziana, viva tra la fine del Seicento e la prima metà del Settecento, La Mettrie rifiutò fermamente ogni tipo di trascendenza, reputando quale unico vero fine dell’agire umano l’utilità sociale ed il piacere individuale, paradigmi etici in sé assai semplici e coerenti all’interno della sua ferrea epistemologia, in cui il secondo elemento, ossia il piacere, può essere condannato solo nella misura in cui si riveli nocivo per le altre persone. Al servizio della sua morale materialista La Mettrie elaborò tutta una minuziosa precettistica capace di studiare caso per caso le più diverse situazioni per consentire all’uomo di conseguire il massimo piacere possibile. Lo specchio di una vocazione marcatamente enciclopedica, non lontana da quella di Denis Diderot, che con il trascorrere degli anni declinò dall’originaria e controversa fedeltà a Newton, espressa negli scritti matematici, all’adesione fatalista a un materialismo ateo e privo di illusioni, che resta sempre e comunque una delle alternative possibili del pensiero umano. Diderot concepì un’opera, forse la sua filosofica più audace, Le rêve de d’Alembert (1769), come un lungo dialogo a quattro voci e suddiviso in tre tempi, attraverso il quale illustrò al lettore una visione fortemente meccanicistica e materialista dell’uomo come del mondo, secondo la quale non può esistere un io pensante distinto dalla materia, ma solo una materia sensibile da cui promana l’intera catena dell’essere e della conoscenza. Doveroso quindi ricordare in questa sede quanto sia vivo della gnoseologia di La Mettrie, ma anche di Condillac, nella provocazione intellettuale che identifica qui una comprensione in sé profondamente autentica del messaggio illuminista, quella per la quale non esistono domande che non possano essere formulate, né pensieri che non possano essere pensati. A differenza di Voltaire che, anche nei suoi momenti di maggiore pessimismo, non pose mai in dubbio l’esistenza di un ordine sovrannaturale, seppur incurante della felicità umana e collocato negli intermundia cui a noi è negato l’accesso, La Mettrie era tra quelli meno sicuri che fosse proprio così: lo si può leggere tra le pagine dell’Homme machine, in cui egli formulava la questione in maniera precisa, chiedendosi se la ragione dell’esistenza umana non coincidesse poi con l’esistenza stessa cui presiede. Forse solo il caso sta dietro il nostro essere nel mondo, in maniera però non precisata o precisabile. Un tema ripreso e ampliato, tre anni più tardi, nel Système d’Epicure, è quello in cui sono le leggi fisiche del movimento a produrre la realtà nel pensiero. È la natura a costruire, all’interno della macchina umana, una seconda macchina, che fa da serbatoio alle idee e altre ancora ne produce, sino alla conclusione, solo apparentemente paradossale, in virtù della quale la natura ha creato, senza pensare, una macchina pensante. Il medesimo problema venne posto da un altro naturalista francese, il Maupertius, matematico e geodeta newtoniano, nel suo Essai de cosmologie (1750), che fece incrinare le solide argomentazioni circa la dimostrazione a posteriori dell’esistenza di un creatore consapevole. Un interrogativo filosofico che più tardi sarebbe stato espresso in versi memorabili dal poeta e pittore inglese William Blake, in un clima già romantico. Un ventennio più tardi sarebbe toccato al barone d’Holbach, nelle pagine del suo Système de la nature, il compito di negare senza troppi giri di parole la finalità divina e il provvidenzialismo quali giustificazioni ultime dell’essere e dell’agire umani. La Provvidenza aveva seguito con ciò la strada dell’Artefice divino. Lo spettacolo della natura non poteva più impartire alcuna lezione metafisica: la natura non era più che un’onda passeggera nel grande oceano del tempo. La tendenza generale del pensiero scientifico contribuì, insieme ad una più pessimistica concezione della Provvidenza, ad imporre agli scrittori della metà del secolo una riluttante scelta fra un assoluto scetticismo e un rigoroso determinismo. La grande massa della popolazione dell’Europa occidentale continuava ad accettare la verità letterale della Bibbia e a credere nell’esistenza d’un ordine cristiano. Ma coloro che stavano all’avanguardia dei nuovi movimenti scientifici e intellettuali si erano ormai accorti che Mosè non era uno storico attendibile. Estraniatisi da una Chiesa che insisteva sulla verità letterale della Rivelazione, essi non trovavano più neppure nella religione naturale prove accettabili d’un ordine finalistico e provvidenziale. Solo 9 due posizioni sembravano poter resistere. Quella che, secondo Hume, negava la possibilità per l’uomo di giungere ad una conoscenza oggettiva di qualsiasi genere; e quella che, sull’esempio di d’Holbach, accettava l’idea d’un universo di materia in movimento, in cui tutto accadeva per necessità, e in cui la risposta ad ogni domanda stava nell’impossibilità di qualcosa di diverso. Accettando l’idea d’un universo statico, o d’un mondo dotato di movimento casuale, e non regolato su alcuno schema identificabile, la filosofia sembrava tornare al materialismo classico di Lucrezio e di Epicuro. Se le cose erano in uno stato di flusso disorganizzato, il prodotto del determinismo naturale non poteva essere che una successione di forme caleidoscopiche18. La Mettrie, in qualità di medico, era rimasto molto colpito dalla misura in cui i pensieri sono determinati dalle condizioni fisiche proprie di un uomo, che è macchina tra le macchine. Perfettamente al corrente delle acquisizioni più nuove su delirio e reazioni muscolari, queste presenti anche in animali morti, egli era orientato a leggere in codeste reazioni una nuova forma di movimento che fosse proprietà meccanica inerente alla totalità della materia, spiegando il complesso articolarsi delle varie attività umane in ragione di tale moto. Un materialismo quindi iatrofisico, che non escludeva necessariamente l’esistenza di Dio, se La Mettrie medesimo affermava in maniera esplicita di non discutere affatto la realtà di un Essere Supremo. La bilancia, al contrario, sembrava essere inclinata in suo favore. Dio non era comunque il più Grande artefice dell’universo cui avevano sacrificato sia newtoniani sia massoni del primo Illuminismo britannico, profeti di una teologia naturale posta a salvaguardia del cosmo. In realtà, La Mettrie aveva radicalizzato quelle amare conclusioni alle quali era giunta la scuola scozzese del London Merchant (1731) di Hume, percorrendo analoghi intendimenti espressi da Voltaire stesso in Micromégas (1753). Si è prima fatto cenno alla pretesa superiorità delle facoltà legate all’intuizione, non solo in campo morale. Anche come fonte del pensiero, egli assegnava al potere dell’immaginazione una velocità e un’audacia percettiva assai maggiori che non alla più lenta ragione umana. Sarebbe senza dubbio piuttosto difficile, alla luce di quanto scritto finora, veder cantare le mai esauste lodi dell’immaginazione dal precursore dei robot. Eppure è proprio questo che accade con La Mettrie. L’uomo macchina non si merita di affermare senza mezzi termini che l’immaginazione sia nettamente superiore alla ragione, quale fonte di idee, nelle scienze come nelle arti. Così scrive, in merito all’immaginazione, il padre degli automi: “È tramite il suo lusinghiero pennello che il gelido scheletro della ragione si ricopre di rosea carne vivente”; una suggestiva commistione , capace di evocare nell’anacronistica mente del moderno lettore temi e atmosfere legati al movimento cyberpunk. Teorie filosofiche nate dalle ricerche mediche quelle di La Mettrie, sempre e comunque incompatibili non solamente con il Genesi biblico, ma anche con qualsiasi altro genere di fede che faccia ricorso più o meno manifesto a un piano provvidenziale. Teorie che comunque non implicavano nemmeno il principio di una evoluzione organica di tipo continuo. A ben guardare, si tratta di una forma di naturalismo filosofico e scientifico che ha per fine il restituire la guida della condotta umana alla legge o forza operante in tutta le realtà naturale. Se nell’Histoire naturelle de l’âme, sua prima opera, La Mettrie si era ancora permesso qualche piccola concessione al tradizionale impianto metafisico di riferimento, nell’Homme machine sviluppa in tutta la sua coraggiosa coerenza la tesi materialisica dell’unica causalità corporea nell’uomo, presentandola quasi fosse una mera ipotesi basata sulla sola esperienza, per nulla contraddetta dalla presenza di facoltà di natura superiore: siamo molto oltre l’originario meccanicismo di Cartesio e della scuola francese del ‘600. L’uomo macchina di La Mettrie risulta essere, quindi, un robot così composito da non poterne scoprire l’intera strutturazione, se non analizzando uno alla volta gli organi meccanici che lo compongono. Ogni attività mentale è prodotta e determinata da movimenti corporei, nei quali agiscono e si rispecchiano i movimenti dell’intero universo. Il corpo stesso non è altro che un orologio, i cui umori sono orologiai e la macchina che costituisce il corpo umano è in assoluto la 18 N. HAMPSON, Storia e cultura dell’Illuminismo, trad. it. Bari 1976, pp. 98-99. 10 più perfetta di tutte, come una costruzione di neuro-ingegneria dietro la quale alcuni storici della cultura europea si sono illusi di veder aleggiare trionfante il fantasma dell’edonismo più libertino. Un puro mito letterario, che si trova in realtà sconfessato in La Mettrie fin dalla lettera dedicatoria dell’Homme machine, rivolta al grande fisiologo svizzero Albrecht von Haller, in cui si vede apertamente esaltato il fine piacere racchiuso nello studio, ritenuto dall’autore il solo autentico scopo dell’ attività scientifica. Scrittore inquieto e paradossale, La Mettrie frequentò il famoso Collegio d’Harcourt, dove studiò filosofia e storia naturale secondo l’impostazione cartesiana e seguì poi i corsi di medicina presso la facoltà parigina, sino a conseguire il diploma di dottore a Reims nel 1733. A seguito della parentesi olandese, fece ritorno nella natia Saint-Malo per esercitarvi la professione. Le Observations de médecine pratique (1743) costituiscono una sorta di bilancio di questa prima fase di attività, rivelando un notevole talento per l’osservazione concreta e sperimentale. Sei anni prima aveva fatto stampare anche un interessante Traité du vertige, cui era seguito nel 1739 il Nouveau traité des maladies vénériennes. La vera svolta di questi anni fu la traduzione di varie opere di Boerhaave, il grande maestro assiduamente frequentato a Leida. Uscirono così, a breve distanza tra loro, il Système sur les maladies vénériennes (1735), gli Aphorismes sur la connaissance et la cure des maladies (1738), il Traité de la matière médicale (1739), i due volumi di Institutions de médecine (1740), il Traité de la petite vérole (1740) e infine l’Abregé de la théorie chymique de la terre (1741). Opere importanti non solo perché contribuirono a far conoscere in Francia le più recenti conquiste della scuola iatromeccanica olandese, ma anche e soprattutto perché La Mettrie, nel volgere in francese i testi boerhaaviani, li integrò e li arricchì di note utili a inquadrare l’angolatura dalla quale li lesse uno dei massimi médecin-philosophes nella prima metà del XVIII secolo. La vita di La Mettrie iniziò a farsi tumultuosa nel momento in cui si trasferì nella capitale: medico personale del duca di Grammont e poi del reggimento delle guardie francesi, si trovò coinvolto nelle vicende della guerra di successione austriaca e fu presente, come chirurgo militare, alle battaglie di Dettingen (1743), Friburgo (1744) e Fontenoy (1745). Tornato a Parigi, frequentò Maupertuis e Fontenelle, nonché la Marchesa Du Châtelet. Il clamore delle proteste e delle condanne che incontrò la sua Histoire naturelle de l’âme lo costrinse a peregrinare tra gli ospedali militari di Lille e Bruxelles, Anversa e Worms. A gettare altra cenere sul fuoco provvide poi lo stesso La Mettrie, con la nota satira sui medici e la medicina del suo tempo contenuta in vari scritti, quali il Politique de Machiavel (1746), la Faculté vengée (1747), riedita poi con il titolo Les charlatans démasqués e l’Ouvrage de Pénelope (1748), tutti probabili frutti di esperienze e riflessioni di amaro carattere personale. Il medico e filosofo francese fu costretto alla fuga in Olanda, ove scrisse l’Homme machine, che iniziò a circolare anonimo nell’inverno del 1747, coraggiosamente fatto stampare da Elie de Luzac, giovane studioso e libraio pieno d’entusiasmo. La meritata pace arrivò, infine, presso la corte di Federico II, finalmente un milieu intellettualmente propizio e stimolante, come lo era stato anni prima la Leida di Boerhaave e dei newtoniani olandesi. Un anno prima dell’improvvisa scomparsa, avvenuta tra l’altro a soli quarantadue anni, La Mettrie redasse il Mèmoire sur la dyssentherie ed il Traité de l’asthme et de la dyssentherie, in cui faceva esplicito e gradito ritorno ad interessi medici mai realmente trascurati, un vero ed autentico motore della sua speculazione filosofica, peraltro mai pienamente affrancatasi dal modello cartesiano come dalle reminiscenze ippocratiche espresse, per la prima volta, nelle Lettres sur l’art de conserver la santé et de prolonger la vie (1738). Si trattava delle ultime prove da parte di un uomo che fu in vita tanto irritante quanto scomodo, solo in apparenza spensierato ma in realtà incline a tristezze e malinconie, come ebbe a osservare una volta Voltaire.19 Un sapere, il suo, di matrice schiettamente empirica, nato sulle pagine di Cartesio e sviluppatosi lungo il solco della grande tradizione iatrofisica anglo-olandese e italiana (Lancisi tra gli altri), ma 19 VOLTAIRE, Oeuvres complètes, XXXVII, Paris 1877, p. 320. 11 aperto anche a intelligenti confronti con altri modelli epistemologici, quali quelli rappresentati dai sistemi medici di Glisson e Stahl, Leibniz e Whytt, più attenti a fornire una spiegazione adeguata circa l’indubbio dinamismo operante nella realtà dei corpi viventi, senza con ciò rinviare necessariamente al postulato dei motori metafisici tradizionali. Non manca nel primo La Mettrie il recupero di un certo animismo, che il razionalismo del Seicento aveva posto in secondo piano nella nuova mappa del sapere, ridisegnata da Bacone e Locke in senso fortemente antiscolastico. A ciò si va ad aggiungere una parziale rivalutazione della storia naturale aristotelica, ricordata spesso con un rispetto e una stima realmente insospettabili. La stessa anima ha un’esistenza fisica indissolubilmente legata alla materia, anzi è essa stessa di natura materiale, pura estensione meccanica. La Mettrie desidera lumeggiare le forze operanti nell’organismo vivente, evitando l’uso delle ipotesi, screditate sia dal cartesianismo che dalla scuola empiristica. Il fenomenismo dell’uomo macchina è portato avanti con rara coscienza epistemica. Secondo Sergio Moravia, «a La Mettrie appare ora indispensabile che le forze agenti nel corpo vivente abbiano un’origine e una giustificazione reale e non più metafisica. Non per nulla è al medico, e non già al filosofo, che La Mettrie assegna l’onore e l’onere di studiare i segreti ressorts materiali che permettono, nell’uomo, l’esercizio delle funzioni vitali anche più complesse».20 Prese di posizione nelle quali si riflettono anche i forti echi sotterranei di quella letteratura clandestina, di stampo libertino e materialista, che lo storico sa particolarmente diffusa in gran parte dell’Europe savante nel primo Settecento. Non senza innegabili note di originalità, le stesse che lo portano a ipotizzare una nuova anima e un nuovo corpo, sino ad attribuire l’irritabilità halleriana non soltanto alle fibre muscolari, per concepirla quale sorgente del movimento. E’ lungo questa via che La Mettrie arriva a definire l’uomo alla stregua di un apparato meccanico, non solo in senso metaforico, come poteva ancora essere per la iatrofisica secentesca. Come ogni macchina, anche la macchina uomo è capace in linea teorica di un moto perpetuo, purché sia alimentata in modo regolare. Simile in questo a un pendolo, le sue parti componenti vengono sottoposte a una specie di oscillazione naturale, da rinnovarsi continuamente. La stessa vita dell’organismo corporeo si risolve nel movimento puramente meccanico di questo, non esclusa l’anima e le sue attività. L’uomo di La Mettrie è composto di solidi e di liquidi. L’illuminista francese parla di elasticità dei vasi, nei quali non esita a far scorrere, sia pure sotto una nuova veste, quei medesimi esprits animaux cui tanto aveva sacrificato la stessa tradizione di pensiero che egli va contribuendo a demolire. Paradossi dei quali la storia, non solo delle idee, è piena. La metodica lamettriana è strettamente fondata su presupposti euristici di tipo analogico e comparativo, particolarmente fortunati nell’età dei Lumi, con i quali viene tratteggiato «uno schema della natura profondamente unitario, non diverso da quello elaborato da altri savants e philosophes di indirizzo dinamicistico-vitalistico», come Cabanis e Laennec nel secondo Settecento.21 E’ attraverso il ricorso consapevole a segni e simboli che egli crea quell’universo culturale cui finisce per appartenere e che gli consente a sua volta di uscire dal proprio status di minorità naturale nei confronti delle altre specie animali, fino ad elaborare la propria civiltà, intesa qui quale spazio ideale di valori in cui riconoscersi. Talvolta, al fine di dévoiler analiticamente i concetti che va illustrando, lo stile intenso e appassionato di La Mettrie si fa addirittura violento, se non dissacratorio, la pars destruens dell’argomentare pare prendere decisamente il sopravvento sulla construens. Esiti preconizzati da mille messaggi lanciati più o meno tra le righe delle opere maggiori, secondo linee di sviluppo comuni anche al Telliamed, il noto roman philosophique circa le origini della vita pubblicato dal Maillet nel 1748, le cui conclusioni vengono consensualmente sottoscritte nelle pagine del Système d’Epicure. E quando i suggerimenti non paiono essere nuovi, lo è il modo attraverso il quale essi vengono rivissuti e interpretati.22 20 Introduzione a LA METTRIE, Opere filosofiche, trad. it. a cura di S. MORAVIA, Roma – Bari 1994, p. XIX. Ivi, p. XXVII. 22 D. ARECCO, L’uomo macchina di La Mettrie tra iatrofisica cartesiana ed enciclopedismo illuminista, in «Nuova Civiltà delle Macchine», III-IV, 2002, pp. 131-141. 21 12 2.1. Il meccanicismo inglese di Hobbes Il più sistematico, e se vogliamo anche geniale, tentativo di realizzare una politica come scienza, facendo leva sulle basi del meccanicismo galileiano e cartesiano, fu compiuto dal filosofo inglese Thomas Hobbes. Egli lavorò alla costruzione di un sistema materialistico-meccanicistico omnicomprensivo che, partendo da elementi più semplici, e procedendo per successive composizioni, fosse in grado di spiegare ogni fenomeno, da quelli fisici a quelli gnoseologici, da quelli etici e quelli politici. In tale maniera, la visione meccanicistica della natura, inaugurata da Galilei per quel che riguardava il mondo fisico ed estesa in seguito da Cartesio al mondo animale, veniva ora assunta da Hobbes quale spiegazione non solo filosofica, ma anche scientifica, di tutto il reale. Compito della filosofia, secondo Hobbes, è essenzialmente quello di procurare utilità all’uomo, ma questa non consiste, come sosteneva Bacone, solo nel dominio esercitato sulla natura, bensì nell’assicurare all’uomo la pace, intesa come garanzia di sopravvivenza fisica. Per conseguire tale scopo è la filosofia stessa a dover costruire scientificamente le regole del vivere umano, che si riassumono poi in realtà nella giustificazione dell’assolutismo politico, quale unica condizione per garantire all’uomo la concordia e la stabilità. L’unica scienza capace di fornire la basi a tale concezione politica è, per Hobbes, la meccanica, ossia la matematica applicata allo studio della natura. Solo ciò di cui tale scienza si occupa, i corpi materiali e i loro movimenti nello spazio, costituisce la vera realtà: tutto il resto, cioè le essenze immateriali, le qualità, i fini, è impressione puramente soggettiva e perciò non esiste. Anche Hobbes quindi, come già Bacone e Cartesio, fonda la propria filosofia su una concezione rigidamente meccanicistica della realtà, con la differenza che, per lui, tale filosofia è pratica anche per il suo oggetto, il mondo dell’etica e della politica. Sul meccanicismo egli fonda infatti la nuova scienza politica, inaugurando l’innovativa, e tipicamente moderna, concezione della politica come scienza23. È nell’opera inedita Elements of Law, del 1640, che Hobbes inserisce il primo abbozzo del De corpore, formulando così la prima versione del suo meccanicismo e sviluppando attraverso di esso il prodursi delle senzazioni, la formazione delle immagini, il manifestarsi del piacere e di quel dolore che, a sua volta, dà origine alle passioni. Si tratta di una riduzione audacemente materialistica di tutte quelle funzioni che, per consuetudine, venivano attribuite all’anima e che qui vengono ora interpretate in termini di movimento: tutto viene ricondotto alle sensazioni, le quali sono prodotte dal movimento dei corpi esterni, che si trasmette agli organi di senso. Tutti i fenomeni, quindi, sia esterni sia interni all’uomo, non sono altro che movimenti meccanici, connessi secondo rapporti di causa ed effetto. Hobbes intende in questo modo spiegare tutta la vita mentale dell’uomo, sia conoscitiva, sia affettiva e volitiva. Il nostro conoscere è in divenire, le immagini appaiono e scompaiono: ogni sensazione è un complesso di movimenti originati dalla pressione dei corpi esterni sui nostri organi di senso, pressione che produce un movimento trasmissibile dai nervi fino al cervello e al cuore. Il meccanicismo hobbesiano, come vedremo, sarà impugnato da Newton in ragione dei suoi aspetti materialistici, ‘colpevoli’ di lasciare aperta la porta all’ateismo. Una preoccupazione, nel tardo Seicento, non solo newtoniana, ma comune a pressoché tutti i teologi naturali di orientamento whig-latitudinario.24 2.2. I platonici di Cambridge: Henry More e Anne Conway I platonici di Cambridge furono un gruppo di pensatori inglesi del Seicento che gravitavano attorno all'università di Cambridge. Fra gli altri emergono le figure di Henry More (1614-1687) e 23 24 E. BERTI, Storia della filosofia dal Quattrocento al Settecento, Bari 1991, p. 94. D. ARECCO, I Fatti e le Idee. Scienza, religione e società nell’Inghilterra moderna, Genova 2007. 13 di Anne Conway (1630-1679), che si opposero fermamente alla nascente fisica sperimentale meccanicista per proporre una cosmologia spiritualista e riannodare i legami fra teologia, filosofia e scienza. More soprattutto fu molto attivo nel dibattito filosofico dell'epoca: ebbe una fitta corrispondenza con Cartesio, di cui inizialmente condivise il pensiero, ma col quale successivamente entrò in polemica. Si può quindi affermare che More sia mai stato “cartesiano”? Certamente no, se con quel termine si intende la rigida appartenenza a una scuola, o anche una elaborazione, entro certi limiti autonoma, che si svolga all’interno della scuola stessa25. Eppure, andando oltre la rigida attribuzione di etichette, vi è un periodo della vita intellettuale di More in cui egli più che mai si richiama a temi cartesiani, che integra ed inserisce nell’eclettica struttura del proprio pensiero, senza neanche preoccuparsi molto che la loro utilizzazione sia o meno consona allo “spirito” del sistema cartesiano. Tale periodo va, all’incirca, dagli anni dei poemi giovanili fino al 1665-’68: in questa accezione usiamo quindi per More il termine di “cartesiano”. Egli giustificava il proprio entusiasmo per la filosofia cartesiana soprattutto con la considerazione del giovamento che ne traeva la causa della religione, “sommo fine di ogni filosofia”. Che il sistema cartesiano potesse avere questa funzione era assunto allora ampiamente condiviso tra i platonici inglesi, ma forse tra di loro nessuno ne fu mai tanto convinto quanto More che, anche quando le sue simpatie verso Cartesio erano ormai smorzate, continuava a ribadire che il concetto di materia omogenea consentiva di inferirne l’esistenza di Dio e l’immaterialità e separabilità dal corpo dell’anima sostanziale. Nel giovane More il tentativo era quello di inquadrare la filosofia cartesiana entro una prospettiva che, attraverso successivi passaggi, la riallacciasse addirittura al sapere mosaico: in questo modo, chiaramente, egli non faceva che seguire quel noto procedimento attraverso il quale la religione giudaica prima, il cristianesimo poi, avevano potuto beneficiare del supporto razionale e collaudato della filosofia platonica. Non è un caso quindi che More stesso si professi platonico, così come lo era stato Marsilio Ficino, autore di una analoga operazione di recupero nei confronti del sapere ermetico durante il XV secolo. L’operazione di recupero della filosofia cartesiana, entro il gran corpo della filosofia perenne, benché More avesse molto chiara la paradossalità della cosa, trovava la propria giustificazione in tutta una serie di fattori, religiosi e culturali, non ultima proprio quella necessità di superare la profonda ostilità che gli ambienti conservatori nutrivano nei confronti di Cartesio, ostilità la cui forza verrà più tardi documentata dal ripensamento dello stesso More. Presupposto fondamentale, quindi, dal quale More muoveva, senza dubbio influenzato da quelle dottrine teosofico-ermetiche ben presenti nella cultura inglese del secolo, è che le verità espresse di volta in volta dalle filosofie storiche fossero già interamente note a Mosè. L’innovazione che More opera rispetto alla tradizione consiste nel privilegiare il filone fisico atomistico della filosofia pagana, come quello che più di ogni altro avrebbe tratto da Mosè le proprie dottrine; per fornire, a tal fine, un’ulteriore prova della sua erudizione filologica, il platonico inglese trasse dal Vossius la notizia secondo la quale, nei secoli precedenti la guerra di Troia, era vissuto un tale Moschus, autore primo della filosofia atomistica. Posto che il termine Moschus stia evidentemente per Mosche, nome con il quale in lingua ebraica era identificato proprio Mosè, More può tirare le conclusioni che tanto gli stanno care, richiamando in seguito tutti i rapporti possibili instaurabili tra Pitagora, Filolao, Democrito e Cartesio. Il platonico inglese, quindi, non è particolarmente interessato al metodo cartesiano e alla peculiare configurazione che vi assume la razionalità, neppure il cogito richiama la sua attenzione. Per lui la filosofia cartesiana è soprattutto una “fisica” che gli fornisce strumenti concettuali atti ad organizzare ed interpretare i fenomeni naturali, o a spiegare in termini razionali la cosmogonia biblica, mentre sullo sfondo prende forma il disegno del fine apologetico generale, ossia l’inferire, dall’ordine di una natura così spiegata, l’esistenza di Dio, con il correlato tradizionale 25 A. PACCHI, Cartesio in Inghilterra, Bari 1973. 14 dell’immortalità dell’anima. Ciò emerge in particolare nell’Antidotus adverus Atheismum e nell’ Immortalitatis Animae, dove l’assunzione e la discussione di tutta una serie di dottrine cartesiane presentano un carattere più sistematico; diversamente avviene nella Conjectura, opera in cui il ricorso a Cartesio si verifica caso per caso, ossia ogni qualvolta una singola dottrina si presti a chiarire questo o l’altro versetto, questo o quell’altro termine. Tuttavia, in generale, la prospettiva che risulta dagli scritti che intercorrono tra il 1649 e il 1662 mantiene una fondamentale unità nel tempo: in questa prima fase del proprio pensiero Henry More adotta i moduli del meccanicismo cartesiano, in polemica con la tradizionale spiegazione aristotelico-scolastica della realtà naturale. A un certo livello egli può quindi dirsi cartesiano, anche se già ritiene che la spiegazione meccanicistica non possa risalire alle ragioni ultime delle cose e, soprattutto, non possa coprire ogni ambito della ricerca naturale. Anche in questa fase cartesiana del suo pensiero, More ha sempre mantenuto un certo distacco critico nei riguardi del pensatore francese; la principale causa degli errori a lui imputati viene individuata da More nell’eccessivo amore per la necessità e certezza delle dimostrazioni matematiche, amore che spinse Cartesio a tentare di estendere la spiegazione meccanicistica all’intera sua filosofia. Questo può sembrare strano, visto che proprio il meccanicismo, o almeno quella che è la sua prospettiva “democritea”, sembra essere l’orientamento che nobilita la filosofia cartesiana, riallacciandola alla filosofia mosaica; inoltre, va considerato che tra le ragioni invocate esplicitamente da More per giustificare il suo entusiasmo per il cartesianesimo, egli fece riferimento proprio alla spiegazione in chiave meccanicistica della sensazione e all’interpretazione, meccanicistica anch’essa, dei fenomeni naturali. Non solo: More riprese pari pari da Cartesio la teoria cosmogonica, secondo la quale Dio non fece altro che imprimere alla materia indifferenziata una certa quantità di movimento vorticoso, affinché ne scaturisse, attraverso distinzioni e ricombinazioni di parti, l’intera varietà delle cose. Il fatto è che il platonico inglese, benché non si stanchi di esaltare questo tipo di scienza che va ricercando le cause corporee connettendo materia e movimento, in un discorso deduttivo la cui necessità riflette la stessa struttura necessaria delle leggi attribuite loro da Dio, non è disposto ad applicare tale strumento interpretativo cartesiano all’universalità dello scibile naturale, rivelando un interesse piuttosto scarso verso la rigorosa estensione della spiegazione meccanicistica a tutti i fenomeni, compresi quelli organici, secondo l’orientamento peculiare della filosofia alla quale si ispirava. Newton lo avrebbe seguito lungo questa strada. Tra gli scritti di maggiore rilievo, in cui More affronta il problema della dimostrazione dell’esistenza di Dio e dell’immortalità dell’anima, in questa fase ancora cartesiana del suo pensiero, si possono annoverare l’Antidotus adversus Atheismum e l’Immortalitatis Animae26. In entrambi More fa sovente ricorso a Cartesio, ma ne utilizza temi e dottrine senza accettare in blocco il sistema cartesiano, ignorando soprattutto la giustificazione fondamentale data dal pensatore francese alla sua gnoseologia attraverso il cogito, che costituisce la dimostrazione della verità delle idee chiare e distinte, al di là della fondazione della loro certezza sull’evidenza e prima di ritrovare nella veracità divina una garanzia definitiva e generale della validità del sapere umano. Questa rigorosa, e discussa, impostazione gnoseologica sembra sfuggire al platonico inglese, il quale, non avendo seguito Cartesio sul suo terreno, si troverà in difficoltà ad accettare le dimostrazioni a priori dell’esistenza di Dio, tranne la prova ontologica, volgendo invece tutto il proprio interesse al meccanicismo cartesiano, che gli sembrava potesse fornire validi appoggi alle prove a posteriori. Ecco perché egli accoglie con tanto entusiasmo Cartesio ed i concetti cardine della visione meccanicistica della realtà naturale, pur riservandosi di porre in luce un ulteriore intervento divino, anch’esso comunque di carattere meccanico, ancorché mediato da un’azione spirituale, nella complessa produzione dei fenomeni della natura organica. 26 Titoli completi: Antidotus adversus Atheismus: sive ad naturales mentis humanae facultates provocatio an non sit Deus e Immortalitatis Animae quatenus ex Cognitione Naturae Rationisque Lumine est demonstrabilis. 15 Lo scarso interesse legato, invece, alla soluzione cartesiana del problema della fondazione del sapere si riflette innanzitutto nel fatto che nell’opera dell’inglese non vi sia alcun accenno al tema del cogito ergo sum, se non per una questione in un certo senso secondaria rispetto alla funzione primaria dell’argomento, ossia per la distinzione dell’anima dal corpo; anche in questo caso More attribuisce scarso peso alla dimostrazione cartesiana, negando al pensatore francese la validità della deduzione necessaria dell’esistenza di una sostanza incorporea, chiaramente distinta dall’estensione, dalla constatazione dell’esistenza di una funzione pensante. Chiaro è ciò che a More preme di più: egli conduce la discussione su questo tema in difesa della dottrina dell’estensione spirituale, messa in pericolo dalla rigorosa distinzione cartesiana; ciò nondimeno, è un fatto che, dell’intero discorso cartesiano relativo al cogito, il platonico inglese richiami solo questo elemento, trascurando invece il momento dell’autofondazione del pensiero, perché è molto meno sensibile a quest’ultimo problema e alla sua soluzione. Una riprova di questa impostazione la si può trovare in una lettera scritta intorno al 1650 dallo stesso More ad Anne Finch, la futura Lady Conway, per rispondere ad alcuni quesiti posti dalla gentildonna, che andava allora istruendosi nella filosofia cartesiana27. Una delle questioni poste dalla Conway recitava all’incirca in questo modo: se è vero quel che afferma Cartesio nell’articolo quattro dei Principia, che non abbiamo segnali per distinguere il sonno dalla veglia, non è possibile alcuna conoscenza vera. Nella risposta, More, lungi dal richiamarsi al cogito, incomincia col minimizzare la portata dell’affermazione cartesiana, dettata secondo lui dalla preoccupazione di mettere meglio in luce l’eccellenza del suo metodo, per poi concludere con un rimando all’articolo trenta dei medesimi Principia, in cui la garanzia di Dio sanziona il retto uso “della facoltà naturale che Egli ci ha dato, di discernere quel che è vero o falso, nel sonno e nella veglia”. More si rivela, con la sua vivissima curiosità, il suo entusiastico trasporto verso le questioni naturali, dai macroscopici fenomeni ciclici celesti alle irripetibili variazioni e alle microscopiche strutture degli esseri viventi, un uomo del suo tempo, partecipe di quell’esaltazione generale che in Inghilterra portava, proprio in quegli anni, alla fondazione della Royal Society, coronamento di un ideale baconiano perseguito per decenni dai “virtuosi”, seguaci ossequienti di un metodo di ricerca estremamente aderente al dato sperimentale. More, che con questi “virtuosi” intrattenne eccellenti rapporti, si distingueva però da essi per il suo atteggiamento verso la natura, instancabilmente interrogata: egli cercava di inquadrare i fenomeni naturali entro una prospettiva che troppo impregnata di misticismo speculativo da platonismo rinascimentale, compromesso inoltre da interessi cabalistico-teosofici, sentendo poi la presenza del divino nella natura con una partecipazione emotiva tale da richiamare aspetti metafisici. Nella bellezza dei fiori, nell’efficacia curativa di decine di piante meticolosamente elencate, nell’eleganza di forme e nell’istinto degli animali, nella funzionalità degli organi del corpo umano, More ravvisa i molteplici segni della provvidenza divina, inseriti in una visione finalistica generale, nella quale l’opera di Dio interviene attraverso un’infinita variazione di grado, realizzando un’integrazione continua con lo spirituale e il meccanico, che fa qui pensare a Leibniz. Ciò che va accomunando due pensatori tanto diversi alla matrice comune del neoplatonismo, è proprio la determinazione di una scala gerarchica degli esseri naturali, configurata da More come una discesa, che parte dall’uomo “culmine della creazione”, il cui principio è la ragione nella sua massima sottigliezza e riflessione, attraverso la spiritualità-razionalità sempre meno perfetta degli animali e delle piante, ai fenomeni della natura inorganica, fino ai moti e alle mutazioni dei minerali e dei metalli, in cui sopravvive, benché estremamente oscurata, “un’ultima e remotissima ombra” della natura divina. Ed è proprio a causa di questa estrema rarefazione in loro del principio “vitale” che i fenomeni della natura inorganica possono essere riconsiderati da un punto di vista meccanicistico, il che consente a More di introdurre il discorso cartesiano. Caratteristica del platonico inglese è la ricerca costante di equilibrio tra l’interpretazione vitalistica e la spiegazione meccanicistica dei fatti naturali, in una tensione che più tardi nel tempo 27 Si tratta di una delle tre lettere scritte da More alla Conway escluse dalla raccolta della Nicolson, Conway Letters, London 1930, a causa del loro contenuto strettamente filosofico. 16 si risolverà a totale favore del vitalismo; in questa fase, invece, More propende ancora per la meccanica, per cui l’intervento divino viene visto piuttosto come una continua correzione del moto da Dio stesso originariamente impresso alla materia, una specie di continuo miracolo meccanico, in parziale deroga alla regolarità di leggi meccaniche ugualmente stabilite da Dio, che raffina la propria azione quanto più la complessità dell’opera lo richieda. Si può nuovamente pensare a Newton, che in gioventù approfondì la lettura di Cartesio e fu amico di More; due cose, crediamo, collegabili. È a questo punto che il cartesianesimo, secondo More, inizia a peccare di eccessiva fiducia nella possibilità della matematica di risolvere tutti i problemi: Cartesio, come l’inglese osserva nell’Epistola ad V.C., ha il merito di aver fornito una chiara spiegazione delle cause immediate di quasi tutti i fenomeni sensibili da lui trattati in chiave meccanicistica; ma si tratta pur sempre di neppure la millesima parte dei fenomeni naturali; gli altri sono troppo complessi per poter essere stati prodotti mediante leggi tanto semplici. Senza contare che, se Dio avesse creato l’universo ricorrendo ad una azione puramente meccanica, avrebbe dato prova di scarsa sapienza: perché More ritiene che Dio si dimostri più sapiente intervenendo in modo continuo a correggere e raffrenare quei movimenti che seguendo una determinazione puramente meccanica, sviano dai suoi disegni, piuttosto che calcolando sin dall’origine un sistema materiale retto da leggi necessarie, strutturate in modo da produrre il mondo naturale in tutta la sua bellezza. Quale sia poi lo strumento in grado di assicurare la mediazione tra Dio e il mondo dei corpi in movimento, risulta a tale stadio abbastanza nebuloso: nell’epistola di cui sopra More accenna ad un principio più divino e santo del moto materiale, ad un non meglio determinato Spirito, nozione ancora vaga che si preciserà più tardi nel concetto di spirito plastico di matrice cudworthiana. Tutto sommato non aveva torto More nel definirsi, in quel periodo, cartesiano: in fondo egli ne aveva assorbito l’interpretazione meccanicistica della realtà naturale, cioè di quell’aspetto forse più inquietante della nuova filosofia agli occhi di conservatori e teologi; certo, egli si fermava dubbioso di fronte alla meravigliosa complessità di struttura e di funzione degli organismi viventi, ma va anche ricordato che il meccanicismo cartesiano ed hobbesiano era ben lungi dal fornire interpretazioni esaurienti in proposito, al di là di certi schemi esplicativi più generici che generali, di qualche esemplificazione particolare e di una ammirevole quanto cieca fiducia nelle capacità della ragione e nella grande macchina. La differente tensione speculativa tra More e Cartesio era comunque già emersa fin dai primi contatti tra loro, quando un More giovane ed entusiasta, dopo aver letto con estrema attenzione ed ammirazione il Discours, la Dioptrique e i Principia, aveva mosso a Cartesio una serie di quesiti e obiezioni che denunciavano in lui la presenza di un orientamento filosofico già ampiamente meditato e articolato, ma anche densamente personale, pur se sviluppatosi all’interno di una scuola non certo insensibile al richiamo rassicurante della tradizione. Il platonico inglese apprezzava in Cartesio un ingegno straordinariamente lucido e un pensiero rigoroso, ma gli sfuggiva l’impossibilità dell’adattamento, del compromesso, della distinzione sottile che concilia e soffoca le divergenze. Così, quando More insiste sul fatto che anche gli spiriti sono forniti di estensione, la risposta di Cartesio segna con estrema decisione la serietà di un metodo che non ammette confusioni compromissorie: il filosofo francese non è abituato a discutere sui nomi; se qualcuno vuol sostenere che Dio sia in qualche modo esteso, in ragione dell’attributo dell’ubiquità, faccia pure. Ma egli nega che si possa ritrovare, sia in Dio che negli angeli, nella nostra mente e in qualsiasi altra sostanza che non sia corpo, una vera estensione, quale viene comunemente da tutti concepita. Va detto che, tra i contemporanei, pochi compresero Cartesio fino in fondo, intendendo così bene la portata innovatrice del suo discorso, la rottura con il passato ed il rigore dell’impostazione metodica e speculativa, ma certo More, col suo bagaglio di credenze e pregiudizi, alle prese con un inestricabile groviglio di razionalità e teosofia, misticismo cabalistico e filosofia naturale, sembra meno degli altri adatto a comunicare con l’autore del Discours: egli mescola con indifferenza i suoi ingredienti, sostiene tesi fantasiose seppur ancor lecite nel suo secolo, come quella secondo la quale 17 gli spiriti, sia buoni sia malvagi, sono dotati di sensibilità e involucro corporeo, discettando a lungo sul tipo di veicolo da assegnare ad angeli e demoni; eppure cerca il dialogo con un pensatore come Cartesio, il quale, implacabilmente, gli taglia ogni argomentazione, sottolineando la propria determinazione a non dar mai luogo a congetture, a non occuparsi di questioni intorno alle quali non abbia certam rationem. Nonostante tutto, il platonico inglese assorbì largamente dal cartesianesimo alcuni caratteri, quali appunto la ricerca di un’espressione rigorosa del pensiero, l’interesse per un’interpretazione meccanicistica dei fenomeni naturali e delle funzioni dei corpi animati. Quando però la consapevolezza della contraddizione si fece strada in lui, More fu costretto a rompere decisamente con il cartesianesimo, iniziando quella che va considerata come una vera e propria seconda fase del suo pensiero. Alla fine della sua vita, per More dire meccanicismo cartesiano era quasi come spalancare le porte al materialismo di Hobbes e all’ateismo. Una lezione ripresa da Newton. Si ritiene che dall’opera di Anne Conway, Leibniz abbia attinto riguardo all’uso e al significato del termine monade. Marjorie Hope Nicholson affermò in seguito che Leibniz attinse ben più di questo: sull’influenza effettiva delle idee della Conway sul sistema filosofica leibniziano, la critica è tuttora piuttosto divisa: ciò che è certo è che Leibniz ne conobbe direttamente il contenuto; del resto egli stesso riconosce esplicitamente una vicinanza di pensiero con la Conway.28 L’opuscolo cui si fa riferimento, The Principles of the Most Ancient and Modern Philosophy, comparve per la prima volta ad Amsterdam nel 1690 in traduzione latina, ripubblicato in inglese due anni dopo. Solo da pochi anni si registra un accurato interesse nei confronti della filosofia di Anne Conway, rivalutando e sottolineando l’importanza della valenza biografia nello studio del pensiero femminile. Le lettere tra la Conway e i suoi grandi corrispondenti ci delineano la particolare atmosfera nella quale si muovevano gli intellettuali anglosassoni nel clima dei settarismi religiosi e delle nuove proposte scientifiche e filosofiche, che infiammavano la vita politica e sociale dell’Inghilterra al tempo della Restaurazione. Uno di questi corrispondenti fu Henry More con il quale ella intrattenne un’amicizia intellettuale che durò per circa trent’anni anni: iniziata nel 1650 continuò fino alla morte di lei nel 1679. Gli argomenti trattati non sono solo filosofici; si trovano infatti riferimenti ai membri del circolo neoplatonico di Cudworth, all’ambiente dalla Royal Society di Boyle, Glanvill e Newton, dettagli sulle cure mediche prestate alla donna da William Harvey, sulle pratiche guaritrici di Valentine Greatrakes e Francis van Helmont: tutto ciò ci consente di ampliare il nostro sguardo sia sulle consuetudini intellettuali della molto variegata cerchia di persone che per un motivo o per l’altro circondavano la Viscontessa, sia di cogliere alcuni dettagli della vicenda biografica di Henry More negli anni in cui andava costruendo la sua metafisica spiritualistica, anti-meccanicistica e anticartesiana. Quaccherismo, familismo, behmenismo, cabalismo, spinozismo e cartesianesimo sono gli argomenti più ricorrenti, così come le interpretazioni millenaristiche, che andavano interessando More e che – anche tramite quest’ultimo – segnarono Newton. Possiamo così seguire l’intrecciarsi delle relazioni di More con gli ambienti cabalistici tedeschi, vederlo affinare i suoi studi intorno alle prospettive millenaristiche, seguirlo negli scambi di opinioni, di testi ebraici e cabalistici con van Rosenroth e van Helmont, il quale prolungò, invogliato anche dell’insistenza di More e del visconte di Conway, il suo soggiorno in Inghilterra di otto lunghi anni, molti dei quali passati nella residenza dei Conway stessi, nella quale sembra avesse trasferito il proprio laboratorio alchemico. L’intensità degli interessi millenaristici di More, che si misura tra le altre cose con la tendenza ad una cristianizzazione dell’ebraismo (due temi poi newtoniani), viene tenuta tuttavia ben distinta da 28 Cfr. G. MOCCHI, Contiguità filosofiche, Catanzaro 1999, anche per le mie pagine che seguono. 18 quell’entusiasmo che contagia l’Europa delle sette e degli scismi. Ma forse è proprio essa la chiave di volta che consente alla cosmologia spiritualistica di Anne Conway di arrivare a poter costruire una teodicea in termini neoplatonici e cabalistici, proprio superando il dualismo che continua a permanere nella metafisica moreana (la quale, sotto questo aspetto, non riesce del tutto a liberarsi del fantasma di Cartesio). Molto discussi nelle lettere che i due si scambiarono sono proprio i due aspetti di antisettarismo e spiritualismo cabalistico che condurranno Lady Conway su posizioni nettamente più radicali: rifiutando la lettura apocalittica degli eventi del tempo, proposta dal suo maestro More (e sostanzialmente condivisa da Newton), abbraccerà la causa quacchera fino in fondo, decidendo di non dover rendere conto a nessuno delle proprie scelte. Il bersaglio comune è comunque lo stesso: il rischio di una deriva materialistica, se non atea, rappresentata dal meccanicismo cartesiano. Anne Finch, sposata Conway, conosceva il latino e forse anche il greco e l’ebraico. Forse attraverso gli studi compiuti dal suo fratellastro prediletto, John, a Cambridge, riuscì a definire i propri interessi nel campo filosofico, evidenti nelle prime lettere che scrisse a Henry More, che presto ne divenne il maestro e tradusse per lei i Principia di Cartesio, in seguito al quale Anne iniziò a porsi non una ma una lunga serie di domande. La stretta relazione di More con Anne continuò anche dopo il matrimonio di lei con Edward Conway e si sviluppò quasi come una sorta di terapia, dal momento che, per lei, la filosofia era forse l’unico sollievo alle atroci emicranie che la perseguitarono per la vita intera. Forse, proprio l’aver approfondito i temi teologici suggeriti dalla prospettiva cabalistica, in cui il problema del male metafisico si intreccia o spesso si identifica con quello del dolore nel mondo e del male morale, costituì per lei una sorta di antidoto intellettuale, ma anche religioso, per cercare di comprendere ed accettare le ragioni della sua così intensa sofferenza: tutti i dolori e le sofferenze stimolano la vita degli spiriti esistenti in ogni cosa che soffre. Come noi vediamo dalla nostra costante esperienza e come la ragione ci insegna, ciò deve accadere necessariamente perché attraverso i dolori e le sofferenze qualsiasi grossezza o densità sia contratta dallo spirito o dal corpo sia diminuita, e così lo spirito imprigionato in una tale grossezza o densità sia libero e diventi sempre più spirituale di conseguenza più attivo ed effettivo mediante i dolori. 29 Questa valutazione filosofica del dolore come parte integrante del processo di purificazione è forse una delle caratteristiche più tipiche del pensiero di Anne. È altresì probabile che la prospettiva filosofica di More, che capovolge le indicazioni materialistiche di Cartesio, in favore di una dimensione decisamente centrale dello spirito anche nella prospettiva cosmologica, abbia potuto rispondere ad un quesito sempre presente nelle lettere della Conway: come è possibile che se mente e corpo, spirito e materia, sono separati, come il dualismo cartesiano prevede - e in parte anche quello moreano - possano interagire tra loro? Come è possibile che l’anima soffra così tanto per le pene del corpo? Nonostante essa sia unita al corpo essa non ha corporeità né natura corporea, perché allora sarà ferita e dorrà anche l’anima quando il corpo è ferito, nonostante siano di natura diversa? Se l’anima può penetrare così facilmente nel corpo, come può una cosa corporea ledere anche essa?30 Anne Conway aveva anche una importante relazione intellettuale con il suocero, grande collezionista di oltre tremila libri nella propria casa di Londra e di altri novemilanovecento in quella di Portmore. Anche suo marito Edward era uomo di ampie letture e condivise gli interessi filosofici di sua moglie - lui stesso era stato allievo di More, che gli dedicò l’Immortality of the Soul – e per quanto non nascondesse la propria avversione verso il quaccherismo, non ostacolò mai Anne nella sua definitiva adesione alla setta, da lei maturata anche attraverso il suo sempre maggiore 29 30 A. CONWAY, Principles, ed. Lopston, London 1982, VII, pp.105. Ivi, VIII, pp.128. 19 approfondimento per i temi cabalistici che andavano sviluppando i suoi amici più intimi, primo fra tutti van Helmont, che ebbe una parte non di poco conto nella composizione dell’opera cabalistica più importante del momento, la Kabbala denudata. Proprio a questo testo Lady Conway farà riferimento costante nella costruzione della sua visione filosofica. Helmont, si sa, sarebbe stato anche tra le letture di Newton.31 Nel 1650 dunque Anne Conway e Henry More, che a quel tempo era uno dei divulgatori più entusiasti della filosofia cartesiana in Inghilterra, iniziano a corrispondere proprio intorno a questa. Come cristiano impegnato, More era conscio dei pericoli che si celavano nel dualismo cartesiano e nella prospettiva meccanicistica, per la quale tutte le interazioni fisiche potevano spiegarsi in termini puramente meccanici come un risultato della materia in movimento. La reazione di More si indirizza soprattutto verso ciò che gli sembra più temibile, ossia che la teoria cartesiana aprisse alla duplice minaccia di ateismo e materialismo, cosa che egli denuncia con preoccupazione nei vari studi dedicati proprio all’analisi della prospettiva cartesiana. Curioso è il fatto che la corrispondenza tra Cartesio e More ebbe termine poco prima di iniziare quella con Anne Finch, alla quale More dedicò il suo Antidote against Atheism, iniziando così a informarla sui caratteri della nuova filosofia. More, che era certamente un maestro attento e rigoroso, non le propose la lettura delle Meditazioni o del Discours, ma quella dei Principia, anche perché colpito dalla sua singolare velocità e dalla semplicità di comprensione. Nelle prime lettere si caratterizza il ruolo esclusivamente didattico di More, ma nel tempo il carattere della loro relazione cambia e il soggetto della loro corrispondenza si allarga ad altre aree, portando la Viscontessa a scelte intellettuali più autonome. Lo sviluppo e i caratteri del pensiero di Lady Conway non ci vengono forniti solo dalle lettere: l’opuscolo postumo, quello comparso per la prima volta ad Amsterdam nel 1690, può infatti valere come una testimonianza della sua metafisica e della sua posizione critica nei confronti della filosofia meccanica. Tra i temi presenti nell’opera di Anne Conway sono, in questo frangente, di particolare interesse quei capitoli riferiti alla sua metafisica monista, che si pone come radicalmente antitetica sia a quella cartesiana sia alla hobbesiana, intervenendo con un suo specifico punto di vista nel dibattito tra meccanicisti e spiritualisti. La sua personale critica al cartesianesimo parte proprio dalla concezione di quest’ultimo del corpo come “mera massa morta, che non solo è carente di vita e di percezione di qualsiasi tipo ma che ne è anche incapace in tutta l’eternità”.32 Ed è proprio la negazione di qualsiasi principio vitale nella materia che non consente alla spiegazione cartesiana della natura – che, alla pari di More, considera eccellente e ingegnosa – di riconoscere la presenza nella natura di “molte operazioni che sono più che meramente meccaniche”. La natura stessa “non è un semplice corpo organico simile ad un orologio in cui non vi è un principio vitale di movimento”, al contrario, essa è un corpo vitale, dotato di percezione, “molto più sublime di un mero meccanismo o movimento meccanico”.33 Ancor più da rigettare è Hobbes, per la sua riduzione di Dio a materia, poiché ciò implica una confusione tra l’essenza di Dio e quella delle creature, le medesima che opera Spinoza. Newton sarà d’accordo, pienamente. La seconda fondamentale differenza tra la filosofia della Conway e quella di Cartesio e Hobbes è che, per entrambi, la materia, o corpo, ha solo estensione e impenetrabilità: essi dunque fanno riferimento solo agli attributi della materia; ma in tal modo “essi, non hanno proceduto al di là della scorza o guscio, non sono mai giunti al nocciolo, essi hanno solo toccato la superficie senza discenderne il centro”.34 Dunque, essi non sono giunti a riconoscere gli attributi più nobili di quella sostanza che essi chiamano materia, cioè “spirito o vita e luce”, nei quali sono da comprendere “la capacità di ogni tipo di sentire, percezione e cognizione,oltre che amore, e ogni virtù e potere, gioia 31 P. HARRISON, Isaac Newton’s Library, Cambridge 1978, ad indicem. CONWAY, cit., IX, 2, 135. 33 Ivi, 136. 34 Ivi, 139. 32 20 e godimento che le più nobili creatura hanno o possono avere, così come anche la più vile e la più spregevole”.35 Ora, tali attributi consentono a qualsiasi creatura di tramutarsi dallo stato attuale, ma è necessario operare una duplice distinzione: la prima riguarda queste capacità e la figura e l’estensione, la seconda riguarda l’azione vitale e il movimento locale o meccanico: questa capacità di acquisire le sopramenzionate perfezioni è comunque un attributo diverso dalla vita e dalla percezione, e queste sono comunque diverse dall’estensione e dalla figura; questa azione vitale è chiaramente differente dal movimento locale o meccanico, nonostante non sia separata o separabile da esso, e comunque esso è usto come suo strumento, almeno in ogni rapporto con le altre creature.36 Vita e figura, sostiene Anne, sono distinti attributi dell’unica sostanza. Il cambiamento di figura, il movimento locale e meccanico, che è altro dalla caratteristica vitale, non può agire senza una qualche vitalità. Straordinaria la vicinanza con il Newton dei manoscritti alchemici. Allo stesso modo, per Anne Conway le operazioni vitali o azioni hanno luogo con strumenti corporei: ho detto che vita e figura sono attributi differenti di un’unica sostanza, e così come uno e medesimo corpo può cambiarsi in un qualsiasi tipo di figura, e così come una figura più perfetta può comprenderne una inferiore, così, per la stessa ragione, uno e medesimo corpo può mutare da un livello di vita ad uno più perfetto, che sempre ne comprende in sé uno inferiore. […] la figura e la vita sono distinti da non incompatibili attributi di un’unica e medesima sostanza. La figura serve alle operazioni della vita. Così come noi vediamo nei corpi degli umani e dei bruti in che modo la figura degli occhi serva alla visione, la figura delle orecchie all’udito, la figura della bocca, dei denti e della lingua al linguaggio, la figura della mano e delle dita al lavoro, e la figura dei piedi alla deambulazione, così anche le figure di tutti gli altri rimanenti membri danno il loro uso e contributo grandemente alle operazioni vitali che gli spiriti preformano in questi membri. […] Di conseguenza, figura e vita coesistono in un’unica sostanza o corpo, laddove la figura è strumento della vita, senza la quale nessuna operazione vitale potrebbe essere compiuta.37 La fatale debolezza della spiegazione materialistica è che cerca di definire come funzioni vitali il risultato del movimento locale e meccanico; sono esse due operazioni distinte: allo stesso modo il movimento locale e meccanico, cioè il trasporto del corpo da un posto ad un altro, è un modo o operazione distinta dall’azione o operazione della vita benché esse siano inseparabili. 38 Qualsiasi operazione vitale, come la visione per esempio, non avviene senza movimento locale, che è il suo strumento: senza la luce, che penetra l’occhio, l’atto della visione non si compie. Se dunque l’azione vitale è ben “più nobile e divina” nel suo modo di operare di quanto lo sia il moto locale, essi si incontrano in un’unica sostanza e agiscono insieme. Ciò tuttavia non deve far ritenere che il senso o la percezione derivino da un movimento locale o meccanico: il movimento vitale o azione avviene quando una cosa ne utilizza un’altra come uno strumento di cui si serve per eccitare un’azione vitale nel soggetto o nel percepiente. E questo movimento locale può trasmettersi attraverso vari corpi, per quanto siano distanti, con i quali essi siano uniti senza nessun nuovo movimento di corpo o di materia.39 Per comprendere come ciò accada, occorre distinguere due caratteristiche di ogni creatura, ossia l’estensione materiale e quella virtuale: 35 Ivi. Ivi. 37 Ivi, 139-140. 38 Ivi, 140. 39 Ivi, 141. 36 21 così noi possiamo distinguere tra estensione materiale e virtuale, avendo ogni creatura questa duplice estensione. L’estensione materiale è quella che la materia corpo o sostanza ha in sé, ma senza movimento e azione. Questa estensione, propriamente parlando, non è né più grande né più piccola poiché rimane sempre la stessa. L’estensione virtuale è il movimento o l’azione che ha una creatura data immediatamente da Dio o ricevuta immediatamente da qualche creatura compagna.40 Ogni movimento che procede dalla natura interna di una creatura, non da qualche fonte estranea, è vitale: questo io chiamo un movimento di vita, che non è soltanto locale e meccanico come gli altri, ma ha in sé una vita, e una virtù vitale, e questa è l’estensione materiale di una creatura.41 Allora il movimento che si comunica da un corpo ad un altro avverrà in virtù di una sorta di atto creativo: come Dio e Cristo soltanto possono creare la sostanza di qualsiasi cosa, allora nessuna creatura può creare o dare l’essere a qualche sostanza, se non come strumento, come una creatura dà esistenza al movimento o all’azione vitale, non da se stessa, ma solo in subordinazione a Dio come suo strumento. Nello stesso modo il movimento in una creatura può produrre movimento in un’altra. E ciò è tutto quello che una creatura può fare per muovere se stessa o una sua creatura compagna, cioè come strumento di Dio. 42 Dunque, nei corpi non va riconosciuto solo l’attributo della quantità e della figura, ma anche la presenza della vita e in ciò è possibile riconoscere un movimento prodotto dall’esterno ed una trasmissione di un movimento o azione vitale. Qui la somiglianza con quanto dirà un giorno Leibniz è davvero notevole. È evidente che Anne Conway propone una visione ancora più radicalmente spiritualista di quella di More, per quel che riguarda l’idea di estensione. Per More, infatti, qualsiasi cosa, se esiste, è estesa, ed evidentemente è Dio ad essere assolutamente esteso, non certo la materia. Ed è dalle caratteristiche della materia, dalla sua impenetrabilità per esempio, che è possibile definire la coesistenza di più spiriti nello stesso luogo e la loro reciproca penetrabilità, cosa che ai corpi non è possibile. Da qui More individuerà una gerarchia di spiriti mediani che intervengono nella piramide delle creature. Ad alcuni di essi spetta anche il compito di agire come un principio plastico in grado di far incarnare le anime nei corpi. Man mano che More si addentrerà nella disamina delle caratteristiche essenziali che distinguono la materia dallo spirito, giungerà ad affermare che lo spirito, oltre ad essere esteso, possiede una specifica qualità, la spissitudo essentialis. Tale attributo dello spirito sarà poi ancora di più spiegato e articolato all’interno della nozione di spazio infinito in un’opera della maturità, ossia l’Enchiridion metaphysicum. Questa spissitudo essentialis consente allo spirito di autodilatarsi, di autocontrarsi e di spingersi in qualsivoglia spazio, anche in quello interiore degli esseri umani. Anne Conway si spinge più in là, riconoscendo una “presenza intrinseca” divina in ogni sostanza creata: si può osservare qui un tipo di spiritualità divina o di sottigliezza in ogni movimento e in ogni azione di vita di cui nessuna sostanza creata o corpo è capace, cioè attraverso una presenza intrinseca, che, come sopra è stato provato, non compete a nessuna sostanza creata, e compete ad ogni movimento e azione qualsiasi. Infatti il movimento o azione non è una certa materia o sostanza, ma un suo modo di essere. E quindi la presenza intrinseca è nel soggetto stesso, così che il movimento possa passare da corpo a corpo anche alla più grande distanza se si trova un medio adatto, che lo trasmetta.43 40 Ivi, 142. Ivi. 42 Ivi, 143. 43 Ivi, 141. 41 22 I bersagli sono quelli di sempre: Descartes, Hobbes, Spinoza e i deisti. Cattivi maestri e a un tempo cattivi compagni. Anne Conway non solo si dichiara anticartesiana e antihobbesiana44, ma rigetta con veemenza il dualismo cartesiano, sia per le implicazioni meccaniciste, sia soprattutto perché, escludendo qualsivoglia presenza vitale e spirituale nella materia non corporea, elimina radicalmente il presupposto monista, per cui tra spirito e materia esiste una differenza soltanto modale e non essenziale45. Alla base della sua veduta monista, la Conway pone una teologia fondata su un’ipotesi emanazionista di stampo neoplatonico, che coniuga nei termini previsti dalla versione cabalistica curata da von Rosenroth e van Helmont. La creazione si modula a partire da quegli attributi divini che sono comunicabili alle creature mediante un essere intermedio, ossia Cristo, che possiede sia gli attributi del Creatore che quelli delle creature. Le qualità delle sostanza non sono quindi riferibili alle caratteristiche delle cose create, cioè spirito e materia, ma alla presenza maggiore o minore nelle cose stesse di quegli attributi divini che sono comunicabili alle creature. Dunque il maggiore o minore grado di bontà e perfezione presente nelle cose create farà loro acquisire un minor o maggior grado di partecipazione al principio divino creativo, che è “Spirito luce e vita infinitamente sapiente, buono giusto valido onniscente onnipresente e onnipotente Creatore”46. La sostanza divina, che è principio creativo “senza né forma né immagine, o figura qualchessia”, pur essendo distinta dalle sue creature, “però da esse non è separata o divisa, ma intimamente connessa e in tutte presente”.47 E proprio secondo l’Idea presente in Dio, allo stesso tempo sua immagine e suo verbo, dunque sua stessa essenza, che ogni cosa è stata creata. Anche la sapienza e la volontà divina sono un tutt’uno con la sua essenza: costituiscono cioè “i distinti modi o proprietà di un’unica e medesima sostanza”. 2.3. Newton e i suoi seguaci Isaac Newton si trova oggi al secondo posto nella classifica dei cento uomini che hanno cambiato il mondo, dopo Maometto e prima di Gesù48; tale posizione è giustificata dai contributi impareggiabili che egli diede alla scienza, princípi che hanno dato forma al mondo moderno oltre che al suo stile di pensiero scientifico. Newton fu prima di tutto un uomo schivo, lontano dal mondo. Gran parte della sua vita la trascorse a studiare ed a condurre i propri esperimenti in completa solitudine. Fu un anticonformista, rifuggì la semplice vita di campagna e rifiutò di prendere i voti, preferendo autoisolarsi all’università di Cambridge. Aderì all’arianesimo in un momento in cui, se lo si fosse venuto a sapere, la sua carriera sarebbe naufragata. Un unitarianesimo sociniano, il suo, tutto sommato non dissimile da quello di altri uomini colti del suo tempo (l’amico Locke, il fedele seguace Samuel Clarke, tra gli altri). In gran segreto, coltivò anche studi di alchimia e di storia sacra. La postuma Chronology – apparsa l’anno dopo la sua morte, nel 1728 – ne costituisce il solo esempio a stampa. Sir Isaac fu un alchimista. Passò parecchio del proprio tempo a studiare la cronologia della Bibbia, esaminando profezie, indagando sulla magia, cercando di rivelarne i segreti ermetici: quella 44 “Nessuno ci obietti che questa filosofia altro non sia che cartesianesimo o hobbesismo sotto nuova veste. Per primo, la filosofia cartesiana dice che il corpo è mera massa morta, che non solo è carente di vita e di percezione di qualsiasi tipo ma che ne è anche incapace in tutta l’eternità. Questo grande errore deve essere imputato anche a tutti quelli che dicono che lo spirito e il corpo sono cose tra loro contrarie e non convertibili l’uno nell’altro, negando così al corpo ogni vita e perfezione, cosa che è completamente contraria al fondamento della nostra filosofia . In questo senso è lontanissima dall’essere un cartesianesimo in una nuova veste, tanto che essa può più realmente dirsi ant-icartesiana, relativamente ai suoi principi fondamentali” (Principles, IX, 2. 135-136). 45 Ivi, 136. 46 Ivi, I, 1-5, 63. 47 Dio “in sé non ha né tenebra né corporeità, e quindi né forma né immagine, o figura qualchessia” (ibidem). 48 M. HART, The 100, London 1993. Trad. it. Gli uomini che hanno cambiato il mondo, Roma 1997. In M. WHITE, Newton, L’ultimo mago, pp.7, trad. it. I.BLUM ed E. DIANA, Milano 2001. 23 che si è rivelata a noi nel corso dei secoli è l’immagine di un genio che cercava la conoscenza in tutto ciò in cui s’imbatteva, un uomo spinto a indagare su tutti gli aspetti della vita. Una avidità di conoscenza, la sua, tanto esagerata da portarlo addirittura all’autolesionismo, all’esaurimento (come nell’anno nero 1693, in cui ruppe con Locke e si allontanò da tutti). Nella sua indagine alchemica Newton si convinse che essa avrebbe potuto offrirgli una via verso l’unificazione del sapere: se alla base dell’occulto fosse esistito un principio, allora quel principio poteva essere il collante in grado di unificare i principi fondamentali in una sintesi organica e razionale, capace di armonizzare ogni branca del sapere. Newton lavorò sperimentalmente alla trasmutazione dei metalli e ai segreti dell’arte, alle distillazioni: pratiche di laboratorio che riconsegnarono la Grande Opera alla scienza e alla tecnica. Come gli alchimisti alessandrini, Newton si rese conto di quanto fosse importante controllare la quantità di calore applicata a una sostanza nel corso dei processi alchemici. Come tutti gli alchimisti europei, anche Newton era motivato dalla convinzione che la saggezza alchemica avesse origine nella tradizione ermetica, derivante dal nome del dio Hermes; in più, alla figura mitica di Ermete Trismegisto venivano attribuiti importanti scritti sull’alchimia; naturalmente, era anche nell’interesse degli alchimisti favorire l’idea che la propria arte avesse origini così antiche e misteriose, giacché ciò poteva giustificare la loro malcelata presunzione di fondo. In Newton, le origini cui riportare la nascita storica dell’alchimia erano ad ogni buon conto quelle mosaiche. Del resto, egli era un biblista e in tale veste si muoveva. Per un certo periodo di tempo, in Inghilterra, l’alchimia era stata dichiarata illegale, da Enrico IV per la precisione: il fatto che essa fosse più o meno tollerata dipendeva dal sovrano in carica, ad esempio re Enrico VIII ed Elisabetta I furono molto coinvolti dagli alchimisti e attribuirono alla cultura di questi ultimi gran peso a corte. Ad influenzare le idee di Newton fu un infatti un medico di fama, il dottor John Dee, il maggior mago dell’età elisabettiana, l’alchimista che ricevette anche le attenzioni della regina Elisabetta I: i due condivisero l’interesse per la filosofia di una società esoterica denominata “Rosacroce”: l’opinione di Newton sulla mistica rosa-crociana non era peraltro positiva; a suo avviso, l’antica alchimia era stata corrotta da troppi maghi moderni e se ne doveva ora restaurare la purezza originaria, in maniera quantitativa.49 Quando Newton divenne studioso dell’alchimia, i rosacrociani avevano già fatto il loro tempo: ciò nondimeno essi influirono non poco sugli studi e sulle ricerche alchemiche di Newton. Tra i testi della sua biblioteca è l’opera in sei volumi di Elias Ashmole, Theatrum chemicum britannicum, nella quale figurano, tra i vari alchimisti, anche il medico Paracelso e il più importante seguace della tradizione ermetica, Cornelio Agrippa. Uomini fuorviati da sogni impossibili, convinti che il processo alchemico fosse una rappresentazione microcosmica della creazione. Medici, nel caso di Paracelso. Newton era semplicemente attratto dall’alchimia e da molti suoi scritti emerge chiara la convinzione che gli antichi avessero un tempo posseduto tale conoscenza e che essa si fosse dissipata nelle filosofie arcane. Inoltre era preoccupato che qualcun altro prima di lui potesse giungere alla scoperta della pietra filosofale. In superficie l’alchimia è una disciplina con una forte componente pratica e forse fu proprio grazie ad essa se in seguito si poterono mettere a punto le tecniche di purificazione necessarie alla produzione di farmaci. Newton mise mano ai suoi studi di chimica e di alchimia intorno al 1667 e compilò anche un glossario comprendente circa 7.000 parole, accompagnate da breve definizione. Molti i suoi manoscritti sull’arte spargirica. Iniziò a raccogliere il materiale per allestire il proprio laboratorio e si introdusse anche in una cerchia di alchimisti e commercianti di libri specializzati, con una fitta rete in Europa. 49 N. GUICCIARDINI, Matematica e alchimia in Newton, in «Nuova Civiltà delle Macchine», III, 2000, pp. 26-41. 24 Mentore in questo nuovo campo di studi, che Newton sapeva bene di dover tenere segreto, fu Robert Boyle, aristocratico inglese che da giovane viaggiò a lungo per l’Europa e fu anche in Italia, dove conobbe l’opera di Galileo. Tornato in Inghilterra si dilettò con l’alchimia a tempo perso, compiendo vari esperimenti pseudo-scientifici. Trasferitosi ad Oxford, nel 1654 mise a punto alcuni esperimenti con una pompa ad aria progettata e costruita appositamente per lui da Robert Hooke, e nel frattempo diede anche vita all’Invisible College, la Royal Society nella sua forma primigenia. Si incontrarono nel 1675 e un anno dopo iniziarono anche una corrispondenza, quando Newton si interessò ad una pubblicazione del Boyle, Della reazione del mercurio con l’oro. A metà del XVII secolo gli alchimisti si erano raccolti intorno a Samuel Hartlib, giunto dalla Prussia polacca e subito inseritosi nella rete di maghi e alchimisti londinesi, fino a formare un gruppo, il così detto Hartlib Circle: esso intendeva offrire all’alchimia una base razionale, sposando la tradizione alchemica alla costruzione intellettuale della filosofia meccanicistica. Del gruppo faceva parte Boyle, ma ad introdurre Newton nella cerchia fu probabilmente Henry More, che, quando non si trovava a Cambridge, passava il proprio tempo a discutere di filosofia con Anne Conway. Per tutti loro il meccanicismo, nella sua vulgata cartesiana, era una frontiera molto pericolosa e il materialismo di Hobbes stava a dimostrarlo. Una lezione raccolta dai Boyle Lecturers tra fine Seicento e inizio Settecento – Richard Bentley in testa – interessati ad usare la scienza non per insidiare o offendere la fede, ma per difenderla e nobilitarla agli occhi di Dio. Nel caso specifico di Newton non si poteva accettare, ad esempio, l’idea del nostro pianeta come organismo autoregolantesi, il quale non avrebbe bisogno di essere sorretto e guidato dalla mano divina. Non si poteva a suo avviso fondare la spiegazione di ogni cosa solo su materia e movimento. In tal senso, il meccanicismo poteva funzionare solo come un ideale orientativo, come un modello in sé ipotetico atto a impostare una ricerca che alla fine lo avrebbe oltrepassato. Resta evidente qui l’influenza su Newton di More e dei platonici di Cambridge. Il Dio di Newton è parte dell’universo da Lui creato intervenendo – ciclicamente – in esso come per accordare una macchina imperfetta, un orologio che altrimenti tenderebbe a fermarsi.50 Il primo passo di Newton fu quello di iniziare a tenere un taccuino di appunti relativo alle attività che svolgeva il laboratorio: i primi esperimenti risalgono al 1669 e hanno a che fare con la natura dei metalli. Per l’alchimista il mercurio era il più importante di tutti i reagenti, in quanto, per tradizione, una sostanza denominata mercurio filosofale era il mezzo con il quale i metalli potevano essere trasmutati. Il mercurio era considerato la prima materia dei metalli, ossia lo spirito santo dell’alchimia, l’anima che doveva essere liberata dai metalli morti e inerti attraverso la trasmutazione. Non c’è da stupirsi quindi se i primi esperimenti compiuti da Newton implicassero il tentativo di produrre questo mercurio filosofale: le istruzioni di Boyle comportavano la soluzione del mercurio in acido nitrico, seguita dalla graduale aggiunta da limatura di piombo. Newton abbandonò presto i consigli di Boyle e passò ai propri esperimenti, usando ora come materiale di partenza l’antimonio, elemento che si ricava da un minerale naturale, l’antimonite: l’interesse degli alchimisti per tale sostanza derivavano dal fatto che essa, se purificata, sembrava avere affinità con l’oro, formando con esso una sorta di amalgama chiamato regulus, una sorta do composto cristallino; in particolare, quello ottenuto trattando l’antimonio del ferro produceva una configurazione cristallina stellata che venne chiamata Regolo di Marte. Newton descrisse il proprio metodo per produrre questo regulus in uno dei suoi primi saggi sulla prassi alchemica, anche se si rendeva conto che fosse solo un piccolo passo verso la tanto agognata pietra filosofale. Nel 1670, Newton iniziò poi le proprie lezioni al Trinity College di ottica, materia 50 Si veda, su questi argomenti, D. KUBRIN, Newton and the Cyclical Cosmos. Providence and the Mechanical Philosophy, in «Journal of the History of Ideas», XXVIII, 1967, pp. 325-346, nonché il saggio di G.B. DEASON, La teologia riformata e la concezione meccanicistica della natura, in Dio e natura. Saggi sul rapporto tra cristianesimo e scienza, a cura di D.C. LINDBERG, tr. it. Firenze 1994, pp. 195-226. 25 di studio con la quale il suo predecessore, Isaac Barrow, aveva concluso l’anno precedente, ma alla seconda lezione, e per quasi tutti i successivi diciassette anni, avrebbe parlato ad un’aula vuota. Era troppo grande per essere capito e l’ateneo cantabrigense troppo decaduto per offrirgli allievi degni di ascoltarlo. Crediamo che fu anche questo a spingerlo verso altre speculazioni, di segno esoterico e religioso, in grado come detto di imbrigliare e di esorcizzare gli aspetti più pericolosi dell’eredità di Cartesio, i cui scritti spinsero Newton a studiare l’ottica,51 e del meccanicismo. Come professore, il suo primo sforzo scientifico fu questo ritorno all’ottica, infatti già a metà degli anni Sessanta aveva dimostrato che la luce bianca era composta di molti colori che potevano essere separati da un prisma, ottenendo luce rossa a un estremo dello spettro e luce blu all’altro. La memoria inviata alla Royal Society sul finire del 1671, la sua pubblicazione nei primi mesi del 1672, le successive dispute con Hooke durate sino al 1675 sono storia nota. Newton trattò i fenomeni ottici con l’intento di dimostrare che la luce bianca è composta da tutto lo spettro dei colori e che il prisma scindeva la luce solare “pura” in quei colori perché rifrangeva in misura diversa le varie componenti dello spettro. In Of colours, del 1666 egli poté affermare, dopo aver fatto passare la luce rifratta da un prisma attraverso un secondo prisma, che i raggi esclusivamente rossi rifratti dal secondo prisma non davano altro colore che il rosso e così con il blu. Questa dimostrazione andava contro una comune credenza di allora, secondo la quale la natura della luce sarebbe stata modificata o alterata nel passaggio attraverso un mezzo come il vetro. Conclusioni alle quali Newton pervenne anche sulla scia dei propri studi alchemici. Una cosa simile si può dire per l’altro suo capolavoro scientifico. Le origini dei Principia mathematica possono farsi risalire all’incontro tra Edmund Halley, il grande astronomo, e Newton, avvenuto nel 1682 a Cambridge. L’astronomia ellittica di Keplero, ricalcolati i moti celesti, portò Newton a formulare la meccanica gravitazionale, mentre altri spunti gli vennero dalla cometa di Halley. In ogni caso, il sole centrale di cui parla Newton (lui, un copernicano convinto) era anche una rappresentazione del fuoco che ardeva al centro del pritaneo negli antichi culti. Un ulteriore richiamo ermetico, che ispirò in questo caso acquisizioni di tipo squisitamente scientifico. Un discorso simile può farsi anche per le queries dell’Opticks (1706). Venuto successivamente meno anche il ruolo dell’etere, Newton iniziò a dare sempre più peso a quell’idea alchimistica dei principi attivi, concetto già antico e assai radicato nella tradizione ermetica. Anche i principi attivi dell’alchimista era una sorta di spirito operante in natura: lo stesso Newton arrivò a percepire la gravità come una forza agente a distanza, resa proprio possibile da qualche principio attivo. Il concetto di spirito cominciò a fondersi con la concezione di Newton della gravità. Il bersaglio restava sempre e comunque l’ideale meccanicistico, con tutte le sue ricadute sul piano religioso. In questo senso, l’amico Locke – membro come Newton del partito liberale in parlamento, nel biennio 1689-1690 – non fece altro che sottoscrivere l’impostazione spiritualista newtoniana. Da Hobbes, infatti, Locke era lontano tanto sul piano politico (in quanto avversava l’assolutismo) quanto su quello filosofico (poiché, al pari di Newton e basandosi su di lui, respingeva esiti di tipo materialistico).52 51 52 M. MAMIANI, Isaac Newton filosofo della natura, Firenze 1976. M. WHITE, Newton. L’ultimo mago, tr. it. Milano 2001. 26 Appendice Il Cyberpunk 1. Il movimento non-movimento Caratteristica che spesso accomuna le tendenze culturali dell’ultimo trentennio dello scorso secolo, in particolare quelle nate dalla letteratura, è quella che esse non diventino mai un vero e proprio movimento, non si strutturino, non riconoscano capiscuola: ognuno rivendica la propria originalità e autonomia.53 Così, anche per il cyberpunk, è difficile identificare tutti i punti di riferimento e gli esponenti di questo possibile movimento, giacché gli stessi protagonisti spesso non accettano nemmeno la definizione stessa di “movimento cyberpunk”. Ma, in sostanza cosa è il cyberpunk? Della letteratura di genere ci dà una interessante definizione la rivista italiana Decoder quando afferma di poterla delineare come la fantascienza radicale degli anni Novanta, una corrente che in pochi anni andò svecchiando e ribaltando gli schemi dell’ormai vetusta fantascienza classica, quella in stile Asimov per intenderci. Il caposcuola del cyberpunk viene comunque identificato all’unanimità in William Gibson, autore nel 1984 di Neuromancer, la cui traduzione italiana dal titolo in Neuromante non contribuì a rendere il gioco di parole dell’originale: neuromancer, infatti, contiene riferimenti al cervello o meglio al sistema nervoso, neuro, e allo stesso tempo ad aspetti occulti che richiamano il negromante. Inoltre il neologismo neuromancer evoca nel suono una sorta di “nuovo romantico”, alludendo quindi a un nuovo romanticismo cibernetico. È lo stesso Gibson a fornirci una convincente illustrazione del cyberpunk letterario, definendolo come nuova corrente nella scena della fantascienza degli anni Settanta: esso si è inserito in una tendenza di vecchio stampo, post-Tolkien, popolata di unicorni e sirene e un’altra di tipo militarista, fatta di astronavi ed eroi tradizionali. Gibson può essere quindi considerato in qualche misura uno scrittore di genere, inserito nei canoni della fantascienza. Gli autori cyberpunk, per altro, dichiarano esplicitamente di avere come “padri spirituali” e numi nella letteratura a loro precedente soprattutto autori che vengono considerati di fantascienza, in particolare Philip K. Dick e James G. Ballard. A questi e a un’altra serie di scrittori di fantascienza, che costituiscono lo sfondo del movimento cyberpunk, vanno affiancati almeno William Burroughs e Thomas Pynchon, scrittori che in Italia hanno avuto risonanza inferiore al ruolo giocato nel rinnovamento della letteratura anglosassone. Il 1984 è allora la data di nascita del cyberpunk. In breve il movimento incomincia a seminare proseliti nel mondo del cinema, della musica, dell’arte, dei fumetti. Ma quali sono gli aspetti che lo resero interessante persino dal punto di vista politico? Innanzitutto il fatto che nonostante esso fosse nato nella letteratura di fantascienza, il cyberpunk parlasse al presente, anzi, addirittura fosse proiettato in un futuro prossimo: le storie da esso descritte delineano perfettamente, o quasi, il mondo in cui noi oggi viviamo. Un mondo tecnologicizzato, in cui sempre maggiore è la presenza del computer. Il cyberpunk andava dilatando l’esistente, fino a farlo apparire mostruoso, rendendo sempre più evidenti i tratti principali di una realtà, tratti che potrebbero invece sfuggire alla descrizione realista. Ma la vera innovazione sta nel suo modo di guardare al futuro, un modo diverso da molta letteratura di fantascienza tradizionale: i protagonisti cyberpunk non sono i potenti del futuro o gli eroi classici delle vicende di azione fantascientifiche, al contrario, essi sono perdenti, sbandati, vinti, emarginati, folli. E pirati, pirati del computer, i cosiddetti hacker. Il punto di partenza dell’immaginario cyberpunk è infatti radicato nella realtà in cui noi oggi viviamo. Esistono gli hacker così come esiste uno scenario tecnologico che muta anche antropologicamente l’essere umano. Il personaggio cyberpunk è un mutante iperattrezzato alla 53 F. GIOVANNINI, Cyberpunk e splatterpunk, Roma 2001. 27 sopravvivenza nel nuovo habitat, decisamente superiore al vecchio sapiens sapiens, si muove alla conquista dei propri obiettivi contro tutto e contro tutti, solitario e nichilista, senza alcuna verità da tramandare e senza alcuna da cercare, intento solo alla soddisfazione delle proprie necessità. 2. La macchina Uno dei punti fondamentali di questo mondo futuro del cyberpunk sta nell’intreccio tra l’uomo e la macchina: solo chi è capace di usare le macchine si afferma e ha la possibilità di sopravvivere, superando anche le rigidità e i confini in cui il sistema dominante di questo futuro vorrebbe tenere i cittadini delle metropoli ipertecnologicizzate. Nella futura società descritta dal cyberpunk il rapporto tra l’uomo e la macchina è spinto fino alle sue estreme conseguenze. I pirati, gli hacker, coloro che vivono ai margini, sono tra coloro che più pienamente si ritrovano legati alle nuove macchine, ai computer, a tutti gli scenari avveniristici che lo scenario degli autori propone. Un intero filone della fantascienza classica parla di robot, descrive le visioni di questi ultimi o i loro conflitti con gli umani. Il cyberpunk parla invece di un universo molto più simile al nostro, in cui le macchine non si sono rese autonome, al contrario, si sono mescolate, incardinate, nella carne degli uomini. Le macchine si tramutano in vere e proprie estensioni del corpo, creando continuità tra l’uomo e lo strumento tecnologico, diventando vere e proprie protesi del corpo stesso: i personaggi dell’ideologia cyberpunk non si collegano al computer battendo le dita su di una tastiera, ma addirittura inserendo cavi dentro il proprio organismo, fino ad entrare, così, “dentro” la macchina. La realtà del cyberpunk è ipermateriale, è disvelamento delle possibilità inaudite della materia, compresa quella di cui è fatto l’uomo, non attraverso un atto produttivo, ma mediante un atto comunicativo e conoscitivo, legato alla tecnologia informatica54. La realtà del cyberpunk, attenzione, non è dunque solo virtuale, è un mondo diverso, chiamato cyberspazio: totalmente svincolato dalle esigenze del sistema produttivo, esso è un luogo al quale non si accede tramite la sola ragione, ma con l’intera sfera sensoriale, luogo dove alla conoscenza viene restituito il suo valore originario di esperienza dell’ignoto. Qui è come se le macchine fossero un’altra realtà, dotata di una sfera sensitiva peculiare, esseri trascendentali in virtù dei quali l’uomo agisce su se stesso e sul mondo, è mosso a conoscere e a conoscersi, a compiere riti alla ricerca di una ignota dimensione situata al di là della realtà visibile a occhio nudo. La macchina è quindi regno del metafisico che, combinandosi con le possibilità umane, viene amplificato e dotato di nuovi poteri, quello dei media per citarne uno. L’eroe cyberpunk non è solo un avventuriero cinico e disincantato: viaggiare nel cyberspazio consente anche un’esperienza mistica55. William Gibson ha spesso descritto gli stati di conoscenza totale raggiunti dai suoi personaggi durante le permanenze nello spazio virtuale. Entrare nel computer, avvicinarsi alla matrice, è come entrare in un luogo in cui non ci sono né vita né morte. Non a caso, tra i personaggi reali che costituiscono una sorta di “culto” per il movimento cyberpunk vi sono i vati della psichedelia, tra cui Timothy Leary, capo a suo tempo degli hippy americani come teorico dell’LSD, poi divenuto in seguito esponente del movimento cibernetico all’americana. Leary ha fondato una sua società, con lo scopo di diffondere nuovi giochi elettronici e nuove consolle per videogame, proponendo allo stesso tempo una riflessione filosoficoesistenziale sul nuovo mondo nel quale ci si sta addentrando. 3. Non solo letteratura Se finora ci siamo soffermati solo sugli scrittori e sui loro personaggi cibernetici, è doveroso ricordare che il “fenomeno” cyberpunk coinvolse l’intero panorama comunicativo. Per il cinema 54 55 P. PARDO, Il cyberpunk, Milano 2001. F. GIOVANNINI, Cyberpunk e splatterpunk, cit. 28 quindi, nonostante le difficoltà ad indicare pellicole pienamente etichettabili, è interessante ricordare alcuni titoli fondamentali per il genere, dalla trilogia di Alien, a cui diede vita nel 1979 Ridley Scott, a Blade Runner, capolavoro del 1982 dello stesso regista, ai più recenti Terminator degli anni ‘80/’90 di James Cameron. Anche per il teatro è qui doveroso annoverare tra gli altri il più citato gruppo teatrale cyberpunk, i Mutoid Waste Company, di provenienza londinese, che inscena spettacoli all’aperto utilizzando rottami e materiali di recupero, senza poi dimenticare la troupe catalana della Fura dels Baus, dove attori stuntman manovrano oggetti e meccanismi cyberpunk. Terminiamo con la musica. All’immaginario cyberpunk apparteneva una serie di dischi risalente agli anni Sessanta, d’area psichedelia. Se da molti è ritenuto troppo ardito citare Stg. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, l’album lisergico pubblicato dai The Beatles nel 1967, altri si ritengono invece d’accordo nel menzionare l’opera prima dei Pink Floyd, anch’essa del 1967, nata dalla mente psichedelica di Syd Barrett, ossia The Piper At The Gates Of Dawn, a cui fecero seguito altri album ritenuti cyber, da A Saucerful Of Secrets a Ummagumma. Altre suggestioni vennero dall’elettronica anni Settanta-primi Ottanta: qui vanno menzionati almeno i tedeschi Kraftwerk e il loro epigono pop-post punk Gary Numan (“uomo-nuovo”, calato nella nuova dimensione futurista): rimane impossibile dimenticare i loro scenari squadrati e geometrici, freddi e intellettuali. Quella citata da William Gibson è invece la futura musica dub-reggae, mentre si diffonde nel frattempo l’uso di definire cyberpunk la cosiddetta techno-house nordeuropea, l’hip-pop e, infine, l’elettronica, o musica prodotta da campionatori e tecnologie digitali. Vanno ascoltati senz’altro i padri indiretti di tali filoni musicali, ossia i Cabaret Voltaire e i Clock DVA, provenienti entrambi dall’industriale Sheffield e alfieri entrambi della new wave più sperimentale. 29
Scaricare