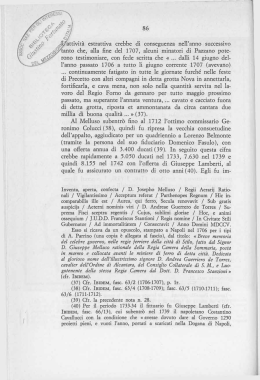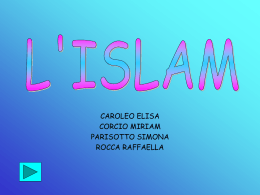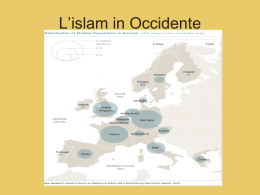Teologia e realtà umana. Immagini storiche e idee politiche L’islam moderno e contemporaneo, in tutte le sue tendenze, si ispira a una visione della storia che privilegia l’inizio rispetto alla fine, il passato rispetto all’avvenire. Si tratta di un’utopia, un’utopia all’indietro che si nutre di retrospettiva, l’utopia del cominciamento ideale. Si noti che essa non appartiene solo alla cultura islamica ma è piuttosto frequente nella storia. L'Europa, per esempio, l'ha conosciuta con i nazionalismi del XIX secolo: anche allora, per dare forma a un’identità di sé, si costruì un passato mitico e ideale. Come? Grazie alla lettura orientata dei testi storici. La quale distorce la realtà storica attraverso l’interpretazione. Per quanto riguarda i musulmani, all'inizio della storia, come parte inalienabile dell'utopia, c'è la rivelazione: il Profeta fondò una nuova comunità e creò una società nuova. Di qui, l’idea di ricostruire oggi quella società. In realtà, leggendo la Sunna, si nota che all'inizio la figura del Profeta non venne letta come figura di potere e di governo, come un semplice legislatore, ma anche e di più come il modello del perfetto comportamento secondo religione, dunque una figura etica – specialmente di ritualità - e di moralità. In campo politico, furono piuttosto le figure dei primi califfi a tracciare le direttive d’orientamento per l’avvenire: grazie alle campagne militari oltre i confini della penisola arabica, e alle vittorie che ottennero sui due grandi imperi del mondo antico, ma anche attraverso i disordini interni. All’epoca dei primi califfi (632-661) la comunità accantonò la meditazione sull'escatologia su cui verte la rivelazione coranica specialmente nel periodo meccano, e si impegnò a definire un modo di governo strutturato, e a elaborare un concetto di “Stato”. Venendo ora all'utopia dell'inizio ideale, le fonti storiche ci dicono che all’epoca dei primi successori del Profeta la giovane comunità non si volgeva all’indietro ma guardava davanti a sé sulla scena storica. La sensazione d’aver perduto qualcosa, d’aver raggiunto una rottura che segnava la fine di un'età dell'oro si fece strada a poco a poco e prese forma definitiva nella formulazione del concetto dei quattro “califfi ben guidati”, al-ḫ ulafāʼ al-rāšidūn. Tale concetto è attestato solo alla fine IX d.C. (dopo la prima metà del III secolo dell'egira); Aḥ mad ibn Ḥ anbal (di cui si dirà meglio in seguito) fu tra i primi a difenderlo. Evidentemente, quest'idea impiegò lungo tempo prima di fare la propria comparsa, almeno due secoli. Come si diceva, le utopie si nutrono di rappresentazioni storiche e la rappresentazione della storia è selettiva, contiene sempre un fattore arbitrario. In effetti, tre dei primi quattro califfi furono assassinati; tutti fuorché il primo, Abū Bakr. Il caso più grave fu quello di ‘Uṯ mān, il terzo. Infatti, dall’assassinio di ‘Umar, compiuto da uno schiavo, forse persiano, di nome Luʾluʾa, si presero le distanze affermando che il suo artefice non era un musulmano e dunque questo califfo era morto da martire; identico fu il caso di ‘Alī: chi lo aveva ucciso non era un davvero un miscredente ma era comunque un eretico, uno kharigita. ‘Uṯ mān, al contrario, venne ucciso da veri credenti. E per di più ‘Alī, il suo successore, fu sospettato d’essere coinvolto o almeno di averne approfittato; ne derivò il primo scisma, la prima guerra civile, la prima fitna (ftn significa “fascinazione” o “tentazione” primma che “discordia” o “rivolta”) che sfociò nella scissione tra sunniti e sciiti. L’unità della comunità era distrutta: i sostenitori di ‘Uṯ mān divennero i futuri sunniti, e i sostenitori di ‘Alī i futuri sciiti. Lo scisma tra sunniti e sciiti continua fino a oggi e i vari tentativi di riallaciare l'unità primigenia, di ecumenismo, iniziarono presto ma fallirono tutti; diedero origine a scuole di pensiero (firaq, “sétte”, pl. di firqa, “porzione”, “divisione”), che accompagnano la storia delle due grandi confessioni. Questi episodi di frattura vennero accolti con stupore oltre che dolore. Infatti, il Corano attribuisce la divisione agli infedeli e soprattutto ai cristiani che si erano demoliti l’un l’altro a forza di dispute teologiche; secondo il Libro, l’Islam aveva al contrario ricostituito l’antica comunità abramitica che si reggeva sulla rivelazione primordiale, questa ricostruzione dell'unità primigenia era, sempre secondo il Corano stesso, un segno della misericordia divina. E allora perché la discordia tra le fila dei musulmani? Perché la divisione e lo spargimento di sangue? L'idea che prese piede è che la discordia e lo spardigento di sangue fossero una punizione divina, perché si era contravvenuto al divino comandamento; dunque, per riscattare la comunità, il colpevole andava individuato e punito. Iniziarono così le giustificazioni e le accuse reciproche, e nacque la storiografia; ci si chiese come procedere da buoni musulmani, e nacque la teoria politica; gli avvenimenti vennero giudicati sempre a partire da criteri religiosi, e nacque la teologia: le fonti antiche non parlano di cattiva condotta ma di peccato o disubbidienza a Dio. Ma tacciare di peccato e disubbidienza la prima generazione di musulmani costituisce un problema. Notiamo che quanti si erano uccisi gli uni gli altri erano dei Compagni del Profeta, le stesse persone che le generazioni posteriori avrebbero assunto a modello perché testimoni della rivelazione, vicini al Profeta. Nella fattispecie della discordia tra i due califfi ‘Uṯ mān e ‘Alī, entrambi sono nel numero dei cosiddetti al-‘ašara al-mubaššara (“i Dieci Promessi”), le dieci persone che avevano ricevuto dal Profeta la promessa certa del paradiso secondo un detto ripreso dal tradizionista “canonico” al-Tirmiḏ ī, m. 892 (Sunan, nn. 37473748). Come si giunse alla credenza in un'età dell'oro? Come prese forma l'utopia dell'inizio ideale? La prima soluzione adottata dai dotti della prima ora fu l'affermazione del criterio detto irğāʼ o “sospensione del giudizio”; un principio di ordine politico che venne applicato appunto alla discordia tra i due califfi ‘Uṯ mān e ‘Alī: non era possibile conoscere chi dei due avesse “peccato”, dunque la soluzione era demandata a Dio e all'aldilà. Si trattò di un appello alla moderazione politica che presto si convertì in dottrina teologica, la dottrina dell’ irğāʼ: nessuno deve dubitare della fede di un correligionario perché solo a Dio spetta decidere chi andrà punito e chi sfuggirà al castigo e, quanto al mondo terreno, tutti i musulmani sono uniti grazie all’Islam nella umma. Tra ‘Uṯ mān e ‘Alī, dunque, non era noto chi avesse avuto torto e il giudizio era sospeso. Questa soluzione, tuttavia, lasciava aperta comunque una questione importantissima. Il Corano (24,6, sura della Luce) considera il caso dell’uomo che accusi la moglie di adulterio senza poter produrre quattro testimoni: egli dovrà pronunciare quattro giuramenti per confermare quanto afferma, e un quinto per chiamare su di sé la maledizione divina nel caso in cui abbia mentito; e la donna messa in stato d’accusa dovrà compiere lo stesso per difendere il proprio onore. I giuristi precisano che come esito di questo confronto il matrimonio andrà sciolto e i due coniugi non potranno più risposarsi. Questo rituale di divorzio è chiamato li‘ân. In questo caso, il giudizio sulla colpevolezza è sospeso perché la testimonianza di entrambi i coniugi non è accolta come veridica: vale a dire che l'uno o l'altro dei due mente sebbene non sia noto quale dei due. Rigettare la testimonianza di entrambi coloro che si accusano l'un l'altro diverrà un principio della giurisprdenza islamica. Questa situazione, in nome dell'analogia, ricorda il caso di ‘Uṯ mān e ‘Alī e dei loro sostenitori. E anche le due importanti battaglie che videro protagonisti dei Compagni del Profeta. Innanzitutto la battaglia detta “del Cammello”, in seguito al cammello che portava il palanchino di ‘Ā’iša, intenzionata a prendere vendetta su ‘Alī per l’assassinio di ‘Uṯ mān insieme ai Compagni Ṭ alḥ a e Zubayr, avvenuta nel 35/656. E la battaglia di Ṣ iffīn, un toponimo, che oppose le truppe irachene di ‘Alī all’esercito del governatore di Siria, Mu‘āwiya, futuro iniziatore della dinastia omayyade, nel 37/657. Coloro che si erano affrontati in quei periodi di crisi erano anch’essi dei Compagni, e anche la loro veridicità nella testimonianza era in discussione. Ma perché ci si diede pensiero della testimonianza di persone defunte da due o tre generazioni? Il motivo sta nelle tradizioni profetiche che quelle persone avevano trasmesso. Accogliere l'idea di una colpevolezza dei musulmani di prima generazione, gli interlocutori del Profeta, significava invalidare l'intero apparato della Sunna, che quelle stesse persone avevano tramandato. Occorreva dunque trovare un'altra soluzione, che andasse oltre la sospensione del giudizio. Tale soluzione fu, nuovamente, di ordine legale e prese forma in un noto adagio a contenuto giuridico, formulato appunto in quel periodo, cioè kullu muğtahid muṣ īb, “chiunque formuli un’opinione ragionevole ha ragione”. Si affermò infatti l'idea che tutti i responsabili di quelle prime battaglie avessero obbedito al proprio iğtihād, cioè lo “sforzo” di ordine intellettivo volto alla personale interpretazione e soluzione delle questioni giuridiche non definite dalla letteratura canonica. Questo modello sarà accolto, con qualche eventuale modifica, sia dai giuristi (hanafiti e malikiti) sia dai teologi (specialmente al-Aš‘arī e molti della sua scuola). Tornando alla dottrina dei quattro califfi bendiretti, all’inizio si riconoscevano solo tre califfi che non erano gli stessi ovunque: a Medina e Bassora, Abū Bakr, ‘Umar e ‘Uṯ mān; a Kūfa Abū Bakr, ‘Umar e ‘Alī. Alla fine del II secolo (tra l'VIII e il IX d.C.), alcuni tradizionisti di Kufa fecero una concessione: Abū Bakr, ‘Umar e ‘Alī ma anche, sebbene con qualche riserva, ‘Uṯ mān; infatti, quest’ultimo apparteneva pur sempre ai Compagni e per di più agli al-‘ašara al-mubaššara. A quel punto si ristabilì la sequenza storica, si invertì il posto di ‘Alī e ‘Uṯ mān, elevando infine quest'ultimo allo stesso rango degli altri. Così inizia la glorificazione dei quattro “califfi bendiretti”, nel IX secolo. Le fonti mostrano con chiarezza che in questo periodo formativo tutti condividevano la necessità di venire a capo del passato e di focalizzare l’attenzione su altri temi, le questioni inerenti il funzionamento dello Stato. I quesiti erano molti: chi sarebbe stato il califfo? andava eletto? e come si doveva procedere? una volta avuto un califfo, sarebbe stato possibile sottrargli il potere già conferito? è possibile deporre un califfo? infine, il potere governativo, dunque lo Stato, era una necessità assoluta? teologi e giuristi discussero questi temi ampiamente e fin dal principio. Si consideri che l'esempio dei califfi bendiretti non era affatto uniforme in materia di assunzione del potere. Abū Bakr era stato nominato per acclamazione, un’acclamazione non concertata (“all'improvviso”, faltatan, come dicono le fonti); ‘Umar era stato designato dal suo predecessore; ‘Uṯ mān venne eletto da un'assemblea di sei persone, un comitato elettorale di cui lui stesso era membro; ‘Alī era stato confermato nelle sue funzioni di califfo dalla bay‘a, un giuramento di fedeltà che peraltro non fu unanime, prestato dai capi della comunità. Il principio che il potere dovesse appartenere alla famiglia del Profeta non poteva dirsi categorico: Omayyadi e gli Abbasidi appartennero a quella famiglia, ma non così Abū Bakr e ‘Umar. Una sola convinzione accomunava tutti, l'idea che il potere fosse un’eredità di Dio e un Suo dono ai giusti ovvero ai pii (cfr. ṣ āliḥ ūn specialmente in Cor. 21,105: “Già abbiamo scritto nei Salmi, dopo che venne il Monito, che i Miei servi giusti erediteranno la terra”, sura dei Profeti. In altri termini, se è vero che il capo era un prescelto, la sua eccellenza non era un'elezione nel senso di atto altrui ma una qualifica che costui possedeva, cioè la sua condizione di ṣ āliḥ , il suo possesso di ṣ ulḥ cioè un “buono stato” che è insieme “virtuosità” e “pietà devozionale”, qualità intrinseca e comportamento. I sostenitori dell'uno o dell'altro candidato discutevano in termini teologici sulla rispettiva eccellenza dei vari candidati al califfato comparandoli tra loro; e per stabilire dei criteri stesero dei cataloghi di virtù, definendo con esattezza ciascuna virtù e riportando nelle loro opere esempi autorevoli, a partire dal Profeta e dai Compagni, qualità e comportamenti necessari o almeno auspicabili in un sovrano. Il sostrato di ogni dibattito era – allora come ora - la capacità di realizzare il vero Islam: il capo della comunità, per necessità un ṣ āliḥ , è chi sa comandare il bene e rifiutare o impedire il male (cfr. al-amr bi-al-ma‘rūf wa al-nahy ‘an al-munkar). E' un principio affermato dal Corano, dove questa espressione compare ripetutamente, ad esempio nella terza sura: “Voi siete la migliore Comunità mai suscitata tra gli uomini: promuovete il bene, proibite il male, credete in Dio” (3,110; cfr. 3,104 e 114 e 7,157). Nel versetto in questione, il bene è ciò che è conosciuto e riconosciuto come parte della Legge (e dunque del messaggio coranico, cfr. ma‘rūf), mentre il male è il suo opposto, cioè quanto è negato o non riconosciuto dalla Legge (cfr. munkar). Ma l'uno e l'altro si prestano a differenti interpretazioni; è dunque questione di esegesi. Una volta definiti in senso ampio il bene come l'Islam e il male come la miscredenza e/o la disubbidienza a Dio e dunque alla Legge, come si fa a ordinare il bene? con la spada (bi-al-sayf), con l’esortazione (bi-allisān) o semplicemente con la disapprovazione interiore (bi-al-qalb)? e chi ha il diritto di agire? in altri termini, come dev'essere il capo (imām) della comunità islamica (umma)? Inoltre: il capo è necessario? oppure la comunità necessita di costui solo nell'emergenza, ad esempio in guerra? è possibile che i credenti semplicemente si attengano al Corano, una Scrittura che offre istruzioni sufficienti a costruire una società rigorosa? ma quest'ultima posizione implica però che i credenti interpretino personalmente il Corano, che leggano alla sua luce le emergenze storiche, e naturalmente, che tutti lo facciano allo stesso modo; è possibile? Le risposte a queste domande sono sempre state divergenti. E questa divergenza, di antica datazione, nata all'esordio dell'Islam, è la base su cui poggia l'ampia varietà di dottrine e di movimenti religiosi e politici della nostra contemporaneità. Bibliografia J. Van Ess, L'alba della teologia musulmana (a cura di I. Zilio-Grandi), Einaudi, Torino 2008. Integralismo Parlare di integralismo, nel caso dell'Islam, è una mera tautologia; non a caso integralismo con i suoi derivati è un concetto di origine e impiego occidentale. Infatti, l'Islam è sempre e comunque integralista perché, per sua definizione, integra gli aspetti mondani a quelli religiosi. I musulmani hanno sempre collegato i precetti religiosi all'ordinamento della società, dello Stato e in definitiva del potere, secondo l'eloquente espressione dīn wa dunyā, “religione e mondo”. Per un credente musulmano, riservare l'espressione della propria fede alla sfera intima della propria coscienza, al “foro interiore”, senza modellare su di essa il mondo esterno è “miscredenza”, cioè negazione dell'unicità di Dio o kufr. L'unica eccezione ammessa per separare i due aspetti della propria fede è quando il musulmano si trovi in una condizione di grave e imminente pericolo per sé o la propria fede, quindi in ambiente ostile, come nel caso di un paese non islamico dove i musulmani sono minoranza discriminata. In questo caso è legittimo il ricorso alla taqiyya, la dissimulazione della fede e delle sue cerimonialità liturgiche: fenomeno particolarmente sviluppatosi nello sciismo qualora circondato da forte maggioranza sunnita. Radicalismo, Islam radicale, fondamentalismo, Islam militante In ultima analisi sono tutti sinonimi. I musulmani parlano di islām uṣ ūlī per dire l'Islam radicale ovvero fondamentalista nel senso di ritorno alle “radici” o fondamenti dottrinali della fede islamica, gli uṣ ūl, con ciò intendendo il Corano e la Sunna). Dunque, islām uṣ ūlī è un'espressione da accogliersi prima di tutto in senso dottrinale; è come dire che per la mancanza di una Chiesa docente - il singolo fedele è autorizzato a dare un'interpretazione personale dei testi sacri andando da sé alle radici della religione, sebbene in stretta connessione con la tradizione ininterrotta delle “scienze religiose” ovvero con quattordici secoli di lavoro esegetico. Per questo l'Islam “radicale” o “fondamentalista” che dir si voglia ha dato negli ultimi decenni un forte impulso alla re-interpretazione della tradizione scritturaria. Si può parlare in questo anche di Islam militante, dove militante non ha necessariamente un senso bellico ma quello della partecipazione individuale attiva (a un movimento che sia culturale, politico o altro; cfr. l'etimologia di miles, “uno dei mille”). Poiché nella mentalità islamica la società e il potere sono costituzionalmente inscindibili dalla religione, l'interpretazione personale del Canone avrà anche un risvolto politico: se ciascun fedele ha il diritto di andare da sé alle radici della religione significa, sotto il profilo della dottrina politica, che ciascuno ha il diritto di giudicare alla luce delle fonti l'operato dei detentori del potere, di valutare se essi si possano definire ṣ āliḥ ūn, “giusti e pii”, e in caso contrario, eventualmente, di destituirli. I movimenti contemporanei di questo tipo si distinguono per la volontà di ripudiare e rovesciare il potere costituito nel mondo islamico qualora esso sia giudicato “empio” o kāfir, perché aperto a una modernità considerata estranea e antagonistica rispetto ai valori dell'Islam. Salafismo Si intende una scuola di pensiero nata in constesto sunnita, in particolare in Egitto, nella seconda metà del '900. L'idea di salafismo è sia di ordine storico sia di ordine teologico. Questa scuola prende infatti il nome dalla locuzione araba al-salaf al-ṣ āliḥ che dice collettivamente “gli antichi o gli antenati (salaf) pii e giusti (ṣ āliḥ )” e identifica le prime tre generazioni di musulmani vissute tra il VII e l'VIII secolo d.C., cioè i Ṣ aḥ āba o “Compagni” del Profeta, coloro che lo videro o udirono personalmente; i Tābiʼūn o “Seguaci”, la generazione successiva a quella del Profeta; e i Tābiʼ al-Tābiʼīn o “Seguenti ai Seguaci”, la terza generazione. Tutti costoro vengono considerati dai salafiti modelli di condotta secondo religione. Sotto il profilo teoretico, il salafismo va definito come un movimento riformatore o riformista perché insegue la riforma dell'Islam contro l'innovazione (al-bidʼa) ovvero il sedimento dottrinale, successivo all'epoca degli “antichi pii e giusti”, che lo avrebbe alterato e corrotto; al tempo stesso il salafismo è un movimento conservatore, perché mira al ripristino di valori antecedenti, al ritorno delle condizioni morali e etiche in cui agì il Profeta insieme ai primi convertiti. Riformisti e conservatori a un tempo, i salafiti sono altresì fondamentalisti o radicali poiché promuovono una nuova e più autentica interpretazione (iğtihād) del Corano e della Sunna e dunque dell'Islam; per questo i salafiti usano per se stessi anche il termine islāmiyyūn (lett. “Islamici”), espressione non del tutto equivalente a muslimūn (“Musulmani”), ampiamente privilegiata dai mass media occidentali. Occorre sottolineare che non si tratta affatto di un rifiuto generalizzato della modernità. Salafiyya e modernità (ḥ adāṯ a) non sono concetti necessariamente antitetici; lo sono occasionalmente, in contingenze particolari. In effetti il salafismo nacque come risposta islamica alla cultura occidentale e si affermò in reazione al diffondersi della cultura europea nelle aree geografiche dell'Islam, ma non in necessaria opposizione. L'obbiettivo dei salafiti non è mai stato quello di contrastare la modernità ma di rivelare le radici della modernità all'interno dell'Islam. E questa definizione di intenti consente di collocare il salafismo anche tra i movimenti progressisti. Riformare l'Islam re-inserendolo nell'attualità storica: fu questo l'obbiettivo dichiarato dei due massimi rappresentanti del salafismo: Rašīd Riḍ ā, di origine siriana m. 1935, che, in linea con la scuola hanbalita, denunciò gli eccessi del sufismo, la stagnazione intellettuale delle élites intellettuali e il ritardo della cultura specie nel campo delle scienze e della tecnologia; e il suo maestro, l'egiziano Muḥ ammad ʾAbduh, teologo, giurista e filosofo m. 1905, tra i fondatori del movimento culturale e politico conosciuto come iṣ lāḥ , un termine che va di pari passo con salafiyya e che dice “riformismo” nel senso di rettifica, riparazione, riaggiustamento; si consideri l'etimologia della parola, che significa propriamente “rendere ṣ āliḥ ”, “causare o produrre ṣ ulḥ ”. A proposito di progressismo, si osservi che nella percezione islamica attuale (cfr. http://ar.wikipedia.org/wiki) l'espressione al-iṣ lāḥ al-islāmī è considerata sinonima di al-islām al-taqaddumī (“Islam progressista”) e di al-tağdīd al-islāmī (“rinnovamento islamico”); e viene intesa appunto come “una rilettura (fahm ğadīd) dell'Islam tornando alla comprensione e alla spiegazione (ʼan ṭ arīq iʼādat fahm wa tafsīr) del Corano e della Sunna e impiegando strumenti intellettuali e tradizionali (ādāt fiqhiyya wa taqlīdiyya) come fecero i musulmani delle prime generazioni”. Salafismo e wahhabismo Trattandosi di modernità, l'impiego attuale del termine salafismo resta tuttavia ambiguo. Ai suoi inizi, infatti, con Muḥ ammad ʾAbduh, Rašīd Riḍ ā e anche l'iraniano Ğamāl al-Dīn al-Afġānī (m. 1897), il movimento salafita era decisamente aperto al confronto con l'Occidente non-musulmano; basta pensare alla celebre “fatwā del Transvaal” rilasciata da Muhammad ʾAbduh nel 1903 in seguito alla richiesta di un musulmano di origine indiana che risiedeva lì; il responso suscitò la forte opposizione di alcuni ambienti islamici perché postulava la liceità di cibarsi di carni non macellate secondo la normativa islamica. Ma nella seconda metà del XX secolo viene a rappresentare un sinonimo di wahhabismo. Questa trasformazione non deve sorprendere visto che lo scopo del wahhabismo come quello del salafismo è affrancare il mondo islamico dalla sudditanza, psicologica, culturale e politica, nei confronti dell'Occidente, adottando l'esempio delle prime generazioni di musulmani. I due movimenti divergono però per metodo e per strumenti. Bibiografia M. Campanini, Il pensiero islamico contemporaneo, Il Mulino, Bologna 2005. Idem, L'alternativa islamica. Aperture e chiusure del radicalismo, Bruno Mondadori, Milano 2012. Alle origini del wahhabismo: Aḥ mad ibn Ḥanbal Aḥ mad ibn Ḥ anbal, m. 855 d.C., visse in una Baghdad pervasa di fermenti eretici e dominata dalla scuola teologica mu‘tazilita (i “razionalisti” dell'Islam), in un’epoca in cui le neonate scuole giuridiche non rappresentavano ancora dei punti di riferimento solidi. Giurista indipendente o muğtahid (cfr. iğtihād), sostenne un rigoroso ritorno alle fonti, cioè al Corano e alla Sunna, contro le innovazioni in dottrina e nei costumi. Rimproverò ai suoi colleghi di aver perso di vista la rivelazione coranica e l'esempio profetico, e nel suo pensiero il primato del Canone scritturario (il Corano e la Sunna, sui quali si fonda la Legge religiosa o šarīʼa) è indiscutibile. Difese sempre la Sunna contro il principio giuridico dell'istiḥ sān, il “ritenere buono ed equo”, caro agli hanafiti, e contro l’iğmāʼ, il consenso dei dotti, che sentì come espedienti volti ad aggirare l'insegnamento di Muhammad. La sua opera maggiore è infatti il Musnad, un'imponente raccolta di tradizioni ordinata secondo i nomi dei referenti di tradizioni (cfr. isnād) tuttora di grande prestigio accanto ai Sei Libri. Ibn Ḥ anbal fu dunque un teologo e un giurista di matrice tradizionalista (cioè non razionale, non dialettica). In qualità di teologo, Ibn Ḥ anbal promosse un accostamento al Libro di tipo letteralista: credere in Dio significa credere alla descrizione che Dio ha fatto di Se stesso nel Suo libro, considerando realtà non solo gli attributi divini, come la saggezza, la potenza e così via, ma anche le espressioni che invocano la divina corporeità, come la mano di Dio o il Suo Trono; di conseguenza, rifiutò sia l'esegesi allegorica (ta’wīl ) del Corano e delle tradizioni, allora in voga tra i mu'taziliti, sia la teologia negativa (taʼṭ īl); sia, anche, ogno convizione circa l'antropomorfismo divino (tağsīm): promosse infatti la dottrina teologica cosiddetta balkafiyya secondo la quale si deve credere in Dio senza interrogarsi sulle cose divine, cioè senza chiedersi come (bi-lā kayf), lasciando interamente a Dio l'intelligenza del Suo mistero. E' questa una posizione decisamente fideistica. Contro i mu'taziliti, Ibn Ḥ anbal predicò la dottrina del Corano increato (il Corano è la parola di Dio non creata, kalām Allah ghayr maḫ lūq), intendendo con “Corano” le sue lettere alfabetiche, le espressioni e i contenuti. Per quanto riguarda la Sunna, il suo lavoro nel Musnad è assai rigoroso e distingue tra le tradizioni perfettamente autentiche o “sane” dal punto di vista della trasmissione (ṣ aḥ īḥ ) e quelle che beneficiano solo di una “presunzione d’autenticità” nel senso che nulla le smentisce. Osservante della Sunna profetica, Ibn Ḥ anbal rifiuta l’iğmāʼ nella più comune accezione di consenso dei giuristi ma ammette l’iğmāʼ inteso come “consultazioni dei Compagni e dei Seguaci” i quali, avendo avuto la possibilità di comprendere il Corano meglio delle generazioni posteriori, debbono considerarsi esempi della condotta secondo religione. Però, non ritenne il consenso di Compagni e Seguaci una radice o un fondamento (aṣ l, cfr. il plurale uṣ ūl) della religione al pari del Corano e della Sunna perché possibile veicolo di errore, dal momento che una comunità ignara del Canone scritturario potrebbe concordare su un errore. Sebbene accolga nel Musnad il celebre detto profetico che fonda il consenso comunitario1, lo intende evidentemente in senso ristretto; quanto al caso di un disaccordo dei Compagni o dei Seguaci, di una divergenza nelle loro testimonianze e opinioni, l'autore ammette la possibilità che ci si distacchi dal loro esempio ma sempre richiamandosi al Corano e alla Sunna. Ibn Ḥ anbal condanna l'iğtihād inteso come esercizio libero della propria opinione personale o ra’y, e lo ammette solo se condotto rigidamente sulle fonti canoniche; il compito del giureconsulto (muftī) è applicarsi personalmente (cfr. iğtihād) per ricavare dalle due autentiche fonti del diritto le prescrizion da applicarsi alle contingenze. Dunque, non è corretto affermare che Ibn Ḥ anbal rifiuta il ragionamento analogico o qiyās; è invece corretto affermare che ne restringe il campo d'azione2. Un aspetto notevole del suo pensiero riguarda la dottrina politica: a questo proposito, Ibn Ḥ anbal sostenne l'inclusione del ğihād tra i doveri del musulmano, quasi fosse un sesto “pilastro”. Affermò di non conoscere nulla di meglio per il credente, dopo gli obblighi di legge, del ğihād3; infatti riporta nel Musnad dal Profeta che il ğihād è il sostegno dell'Islam e il culmine della sua sommità4, là dove ğihād significa adoperarsi per l'affermazione dell'Islam ma non necessariamente in senso bellico (con il proprio denaro, con l'esortazione verbale, etc.). Da Ibn Ḥ anbal prende il nome lo hanbalismo, una delle quattro scuole giuridico-religiose del sunnismo. Questa scuola di pensiero, conformemente al fondatore, afferma recisamente il primato delle due fonti autentiche dell'Islam, il Corano e la Sunna; e, nella loro interpretazione, si oppone a qualunque invasività della ragione umana ritenendola arbitraria e possibile fonte di errore. Ibn Taymiyya Giurista e teologo siriano, visse per lo più a Damasco, dove insegnò; arrestato molte volte per le sue espressioni di intransigenza, morì in carcerenel 1328. La figura di Ibn Taymiyya rappresenta bene la tendenza hanbalita, la quale investe la teologia e la giurisprudenza ma è anche un’attitudine etica oltre che una precisa posizione politica; è forse il più notevole e influente tra gli studiosi di scuola hanbalista, specialmente per la rilevanza politica del suo pensiero. Sulle orme di Ibn Ḥ anbal, anche Ibn Taymiyya promuove l'affermazione di un Islam autentico e puro: le fonti della Legge sono soltanto il Corano e la Sunna e quel che se ne trae grazie a un qiyās rigoroso (cfr. fondamentalismo o radicalismo), insieme all'esempio delle prime generazioni di musulmani, nel suo caso fino alla fase omayyade (cfr. salafismo). 1 2 Infatti, come fece poi Ibn Taymiyya, ammise il ragionamento analogico solo se concepito nel modo sguente: si ricerca nei sacri testi la causa fondante (‘illa) di un dato precetto (ḥ ukm), e quindi, per analogia, si estende quel precetto a tutti i frangenti che condividono la stessa causa. 3 4 Se questo esempio costituisce, insieme al Corano, un insegnamento infallibile, qualsiasi deviazione o modifica, qualsiasi elemento allogeno ed estraneova accolto come una perniciosa innovazione (bidʼa), da proibire e perseguire come fonte di allontanamento dalla verità. Testimone della difficile situazione politica seguente il crollo del califfato abbaside (la presa di Bagdad da parte delle armate mongole avvenne nel 1258) con la disgregazione della dār al-islām (“la dimora dell'Islam”), Ibn Taymiyya predicò un monismo politico-sociale che riflette il principio teologico del tawḥ īd (unità e unicità di Dio), combatté ogni forma di pluralismo come fonte di corruzione, e vide come unica difesa l'aggregazione sociale forte, fondata sui valori etico-religiosi dell'Islam. Il suo richiamo al ğihād contro i Mongoli partiva dall'idea che essi, pur convertiti all'Islam e sunniti, non fossero veri musulmani perché applicavano leggi concepite dall'uomo anziché la sola Legge religiosa; in tal modo, la loro condizione era assimilabile a quella degli arabi nella fase storica detta ğāhiliyya o “ignoranza del Libro”; pertanto affermò che “ogni gruppo di musulmani che trasgredisca alla Legge islamica [...] deve essere combattuto, sebbene continui a professare formalmente la religione”. Occorre dunque applicare l'obbligo del ğihād, inteso non come collettivo (farḍ al-kifāya) ma come dovere del singolo musulmano (farḍ al-ʼayn). Il testo più celebre di Ibn Taymiyya è “La condotta secondo la Legge”, al-Siyāsa alšar‘iyya, uno speculum principum in cui l’arte del buon governo, ovvero l’adeguamento della prassi politica e giuridica alle fonti scritturarie e ai principi sciaraitici, prevede la legittimità della ribellione contro il principe ingiusto. Il compito di sorvegliare sulla corretta applicazione della legge divina spetta ai teologi-giuristi, gli ʼulamāʼ. In estrema sintesi, secondo il pensiero di Ibn Taymiyya un governo può dirsi islamico solo se promuove la šarīʼa e sostiene il relativo l’impegno degli ʼulamāʼ. Questa teoria costituì il caposaldo della predicazione di Ibn ʾAbd al-Wahhāb, ed ebbe come riflesso notevolissimo l’identificazione, da parte dei wahhabiti, della dinastia al-Saʾūd come legittima depositaria del governo islamico. Bibliografia H. Laoust, Essai sur les doctrines sociales et politiques de […] b. Taymiyya, Institut Français d’Archéologie Orientale, Le Caire 1939. Idem, La profession de foi d’Ibn Taymiyya, la Wāsiṭ iyya, Geuthner, Paris 1986 (testo arabo in fine, pp. 1-27). Idem, Ibn Taymiyya, in Encyclopédie de l'Islam, 1a ed., III, pp. 976-79. C. Bori, Ibn Taymiyya: una vita esemplare. Analisi delle fonti classiche della sua biografia, supplemento monografico della «RSO», Roma 2003. I. Zilio-Grandi, Temi e figure dell'apologia musulmana, in C. D'Ancona (a cura di), Storia della filosofia nell'Islam medievale, vol. I, Einaudi, Torino 2005, pp. 137-179. Ibn ʿAbd al-Wahhāb Ibn ʾAbd al-Wahhāb (m. nei pressi di Riad nel 1792) è un teologo hanbalita, seguace delle dottrine di Ibn Taymiyya (m. 1328) e del suo discepolo Ibn Qayyim al-Jawziyya (m. 1350). E' ispiratore del movimento di pensiero detto wahhabismo, a sua volta debitore dell'insegnamento di Ibn Taymiyya. Ibn ʾAbd al-Wahhāb dedicò la propria esistenza alla purificazione della religione islamica tramite il ritorno al messaggio primigenio dell'Islam rappresentato dall'insegnamento e dalla condotta degli “antichi pii e giusti” (al-salaf al-ṣ āliḥ ) e il rigetto di ogni elemento che costituisca innovazione eretica (bidʼa), là dove “innovazione” qualifica ogni convincimento e ogni atto che non siano fondati sul Corano, sulla Sunna o sull'esplicito consenso dei Compagni e dei Seguaci. Quindi, è corretto definirlo radicale o fondamentalista, e anche salafita. Nella sua vasta opera, nella quale spicca il Kitāb al-tawḥ īd, “Il libro dell'unicità divina”, Muḥ ammad ibn ʾAbd al-Wahhāb dichiarò eretiche molte pratiche religiose non originarie, introdotte successivamente alle prime generazioni. Innanzitutto, l'eccessiva venerazione dei santi fondatori da parte delle confraternite mistiche, che reputò una forma di politeismo o shirk: il musulmano non deve cercare l'intercessione di altre creature, limitate e mortali, la cui “amicizia” (ḫ ulla) con Dio” terminò con la loro morte; sulla stessa linea, avversò la pratica di festeggiare la nascita del Profeta (mawlid al-nabī). Oltre a questo, condannò tra l'altro l’uso del rosario (masbaḥ a), la costruzione di minareti e l’abitudine di decorare le moschee. Riprendendo la nota divisione islamica del mondo in dār al-islām (dimora dell'Islam e per derivazione luogo di pace), e dār al-ḥ arb (dimora della guerra), Ibn ʾAbd al-Wahhāb estende quest'ultima nozione ai paesi islamici che non applicano la Legge religiosa; e a chi vi risiede e voglia vivere da autentico musulmano, raccomanda la hiğra o “emigrazione”. Inoltre, condanna aspramente ogni forma di divisione all'interno della umma; il disordine sociale (fitna), primo passo verso la decadenza dei valori morali e religiosi, va combattuto con lo strumento del ğihād (inteso evidentemente anche in accezione bellica). Ibn ʾAbd al-Wahhāb è considerato da alcuni un importante riformista, un restauratore della religione; all'inverso, è fortemente criticato da altri come legalista, traditore dei valori più profondi dell'Islam. Wahhabismo Questo movimento, sunnita e hanbalita, si ispira all'insegnamento di Ibn Taymiyya attraverso la mediazione di Muḥ ammad ibn ʾAbd al-Wahhāb. Dopo che quest'ultimo ebbe convertito alla propria visione dell'Islam Muhammad ibn Saʾūd, fondatore della dinastia saudita (nel 1744 si giurarono fedeltà reciproca, con l'intento di realizzare una comune azione per la riforma dei costumi che entrambi giudicavano non più conformi all'Islam autentico), il wahhabismo si imporrà come dottrina ufficiale alla fondazione del Regno (1932). Trovò così attuazione larga parte dell’insegnamento politico di Ibn Taymiyya; lo dimostra l’organizzazione amministrativa del Paese, espressa dalla legge fondamentale (qānūn asāsī) del 1926 e dallo statuto fondamentale (niẓ ām asāsī) del 1992. La collocazione del wahhabismo all'interno della linea hanbalita ne definisce già per grandi linee il contenuto dogmatico: restrizione dei margini di operatività della dottrina, vincolata alle sole due fonti scritturarie (Corano e Sunna); esclusione dei risultati prodotti dalla dottrina successiva alle prime generazioni; rifiuto di ogni forma di iğtihād che si discosti da un qiyās direttamente condotto sulle fonti scritturarie. Sotto il profilo teologico, la dottrina wahhabita procede dalla rigida affermazione dell'unicità di Dio (tawḥ īd), in aperta opposizione a tutte le forme riconducibili al politeismo (širk). Il pensiero wahhabita postula che molti musulmani ignorino i contenuti della propria religione e siano con ciò assimilabili ai politeisti preislamici (cfr. ğāhiliyya; un'idea che sarà ampiamente ripresa da Sayyid Quṭ b, m. 1966); infatti, ogni atto di venerazione islamica – non generalizzata - rivolto ad altri che a Dio macchia il proprio autore di negazione dell'unicità di Dio (kufr). Di consegunza, molti di coloro che si professano musulmani non lo sono affatto, perché, nella loro relazione con Dio, si affidano a intermediari (oltre al culto dei santi, è manifestazione di politeismo rolgers in preghiera a un profeta o a un angelo). Su queste basi, i wahhabiti si definiscono anche ahl al-tawḥ īd, “unicisti” o “gente che professa l’unità e l'unicità di Dio” (muwaḥ ḥ idūn). Ma va da sé che ogni credente musulmano si professa muwaḥ ḥ id. Gihadismo Questo termine, nato alla fine degli anni '80, si applica in generale a qualsiasi movimento politico estremista il cui principale obiettivo sia quello di sostenere il ğihād (in questo caso “guerra santa”) contro i “miscredenti” o kāfirūn intesi nel senso ampio di Ibn ʾAbd alWahhāb e, prima, di Ibn Taymiyya, siano occupanti o siano autoctoni, in vista del cambiamento e del rovesciamento dei regimi, e senza escludere il ricorso ad azioni terroristiche. Secondo i gihadisti, il ğihād è un pilastro o rukn; è pertanto un dovere individuale (farḍ al-ʼayn) e non collettivo (farḍ al-kifāya). Wasaṭ iyya Con wasaṭ iyya, “medietà” o “centrismo”, si indica un movimento specialmente rappresentato dall'egiziano Yūsuf al-Qaraḍ āwī, che si presenta come indipendente, nonché critica nei confronti del movimento di Fratellanza islamica. La wasaṭ iyya è così denominata perché nei propri intenti persegue la via mediana tra due estremi che sono il salafismo spinto di chi vorrebbe ricreare in toto la società musulmana dei primi secoli, e il secolarismo (‘ilmaniyya o ‘almaniyya) di chi persegue un’imitazione acritica dell’Occidente (esistono alcuni partiti politici, in Egitto, Giordania e Iraq che si appellano a questa visione, almeno nel nome). Il punto di vista centrista mira invece a una forma civica di governo islamico che testimoni nel dibattito pubblico la vocazione democratica dell’Islam e che smentisca l’idea di Islam come religione della guerra (idea diffusa dopo l’11/9), ispiratrice di regimi oppressivi. L'idea “centrista” vanta una lunga storia nel contesto islamico. E' più volte attestata nel Corano (ad esempio 2,143: “Così facemmo di voi una ummatan wasaṭ an, una “comunità del giusto mezzo”) e quindi ampiamente ripresa nel corso della storia (anche dagli hanbaliti e da Ibn Taymiyya). La premessa della wasaṭ iyya contemporanea è che la religione predica la medietà (wasaṭ è un alto valore islamico) e che la stessa natura umana tende alla moderazione5; pertanto è categoricamente negato l'uso della violenza, incompatibile con gli obbiettivi fondamentali. Il compito della wasaṭ iyya è duplice: da una parte favorire una più profonda conoscenza e comprensione dell’Islam, dall’altra apportare i necessari cambiamenti affinché si realizzi una società autenticamente islamica e inoltre forte e indipendente e, non ultimo, tollerante. In effetti, questo movimento si definisce inclusivo e aperto al mondo, in grado di opporre soluzioni moderate alle sfide della modernità grazie all'attività di un’adeguata leadership intellettuale che sia di guida (taršīd) a tutti i musulmani (cfr. il ruolo degli ʼulamāʼ nella dottrina hanbalita). Alcuni studiosi collocano questo movimento nella più vasta corrente ideologica detta al-ṣ aḥ wa al-islāmiyya (“risveglio islamico”), nel senso di ritorno alla veglia e allo stato vigile e cosciente (cfr. la radice ṣ ḥ w) dopo la naqṣ a, il periodo buio a sua volta successivo al “Rinascimento” o nahḍ a. Nonostante l’apparente somiglianza tra i concetti di nahḍ a (che vuol dire a sua volta destarsi, alzarsi dal letto) e ṣ aḥ wa, quest’ultima si caratterizzerebbe per una maggiore concretezza che la rende non più un sentimento o una pulsione ma un movimento attivo, una ḥ araka islāmiyya (il “movimento islamico”). 5 Yūsuf al-Qaraḍ āwī L'egiziano Yūsuf al-Qaraḍ āwī (n. 1926) è tra i fondatori del movimento detto della “via mediana” (al-wasaṭ iyya). Occupa una posizione importante nell'Islam contemporaneo, sia sotto il profilo intellettuale (è autore di quasi 200 pubblicazioni in ogni campo del pensiero islamico), sia per il ruolo direttivo presso istituzioni internazionali (ad esempio, è presidente della “International Union of Muslim Scholars”, e direttore del Mağlis al-ūrūbiyy li-al-iftāʼ wa al-buḥ ūṯ ovvero “European Council for Fatwa and Research” (nato a Londra nel 1997, ora a Dublino) anche accademiche (ad esempio, è membro dell' “Oxford Centre for Islamic Studies”). La sua notorietà è rafforzata dalla partecipazione mediatica: promotore del notissimo sito web “Islam-online”, tiene un programma settimanale sul canale satellitare alJazeera, Al-šarī‘a wa al-ḥ ayāh, “La šarī‘a e la vita”, seguito da oltre 60 milioni di spettatori. Secondo alcuni osservatori, Yūsuf al-Qaraḍ āwī si sarebbe formato tra i Fratelli musulmani e occuperebbe attualmente tra le loro fila la posizione di ideologo o “leader spirituale”; questo ruolo, tuttavia, è stato più volte e pubblicamente smentito da al-Qaraḍ āwī, che si dichiara indipendente da movimenti politici e scuole giuridiche. Questo pensatore può essere definito un riformista e un progressista, perché sulla necessità del rinnovamento o tağdīd e della modernizzazione; la modernità è un valore positivo che non coincide affatto con la laicità o la secolarizzazione, con l'attribuzione di un ruolo secondario alla fede; essa va però accolta con “medietà”: i musulmani “non devono rifiutare tutto ciò che è nuovo né approvare tutto ciò che viene dall'Occidente, ma accogliere ciò che è nuovo e buono per la società islamica, preservando ciò che è vecchio e utile”. Al tempo stesso, al-Qaraḍ āwī è salafita, perché si richiama all'età più antica che definisce l’epoca in cui i musulmani “sapevano dare spiegazioni semplici, riducendo al minimo il conflitto nella comunità”. Nell'appello agli “antichi pii e giusti”, dunque, al-Qaraḍ āwī persegue segnatamente la semplificazione dottrinale e sociale; e ritiene che il primo compito degli ‘ulamāʼ contemporanei sia ridurre e arginare la pluralità delle visioni e delle interpretazioni perché “l’Islam è comunque Islam” e prevede alcune certezze irrinunciabili (qaṭ ‘iyyāt) “base ferma di ogni variazione ermeneutica nonché del cambiamento sociale”. Re-islamizzazione, dunque, ma ammettendo che l'applicazione della Legge divina ha a volte fallito, non per inadeguatezza della Legge religiosa come sistema legale ma per l'umana fallacità nella sua interpretazione e nel suo impiego. Al-Qaradawi riconosce l’estremismo legalista come un problema dell'Islam attuale e si appella agli ʼulamāʼ affinché guidino soprattutto i giovani; muove però parole di critica anche contro le facili accuse di “estremismo” a chi non le merita, per cattiva comprensione dei fenomeni analizzati. Tra i molti testi e interventi che al-Qaraḍ āwī dedica alla corrente mediana, quello intitolato “Parole sul centrismo islamico e sulle sue caratteristiche” (Kalimāt fī al-wasaṭ iyya alislāmiyya wa ma‘ālimi-hā (“La medietà islamica e le sue caratteristiche”) si apre con alcune definizioni di wasaṭ iyya: è “una delle principali caratteristiche dell'Islam, [...] sinonimo di equilibrio e moderazione; […] è la capacità di mediare e bilanciare le parti contrapposte, cosicché […] nessuna delle due prenda più di quel che deve e può, né abbia il sopravvento sulla parte opposta, né le nuoccia in alcun modo […]. Tra i contenuti di wasaṭ iyya, l'autore propone la giustizia, la rettitudine (lontano dall’inclinazione e dalla deviazione), la prova del bene (“la perla più bella è al centro del collana”, “il leader del popolo sta in mezzo e i seguaci gli stanno attorno”), la sicurezza (“gli estremi sono esposti al pericolo mentre il centro è protetto e custodito da quel che lo circonda”), la prova della forza (“non vedi che i ragazzi sono il momento di di forza, tra la debolezza dell’infanzia e quella dell’invecchiamento?”), il centro dell’unione ovvero il punto di incontro (“le estremità si moltiplicano all’infinito, ma è sempre uno il punto mediano e il centro […] sul piano materiale, sul piano intellettuale e sul piano morale”). Va infine la dichiarata apertura di al-Qaraḍ āwī al dialogo con l'occidente, nonostante egli muova aspre critiche al pensiero e alla condotta occidentali. Presenta infatti il dialogo come un dovere religioso e un tratto fondamentale della cultura musulmana; e critica i correligionari che lo rifuggono nel timore di contaminazioni e corruzione. Tale timore deriva da un’immagine distorta dell'altro, ed è proprio questo il primo ostacolo da superare grazie a un dialogo tanto religioso quanto politico-istituzionale, il cui obbiettivo è triplice: contrastare la tendenza materialistica che rifiuta Dio e si oppone al messaggio divino; affermare le convergenze tra le due religioni; purificare le relazioni dal sentimento di ostilità generato dalla memoria delle crociate e del colonialismo, e, nella contemporaneità, dall’imperialismo. A fronte della fama nel contesto arabofono - anche occidentale - il divario linguistico rende la figura di al-Qaraḍ āwī e in generale i contenuti della sua predicazione quasi sconosciuti ad altri contesti (è ripreso in lingue europee dallo svizzero Tariq Ramadan, ma per lo più senza essere nominato). Bibliografia Peskes E., Ende W., Wahhabiya, in E.I.2, Brill, Leiden 2003, Vol. XI, pp. 44-52; Ibn Taymiyya, Il buon governo dell’islam, trad., intr. e note di G.M. Piccinelli, Fondazione Ferni Noja Noseda, Bologna 2001; I.M. Lapidus, Storia delle società islamiche, vol. III. I popoli musulmani, Einaudi, Torino, 2000; M. Campanini, Storia del Medio Oriente, Il Mulino 2006; Idem, Islam e politica, Il Mulino, 1999; Fuller Graham E., Lesser Ian O., Geopolitica dell’Islam: I Paesi Musulmani, il Fondamentalismo, l’Occidente, Donzelli, Roma 1996; al-Qaradawi Y, Islamic Law in the Modern World, Wami House International, Riyad, 2000; idem, Why we Must Live by the Sharia, Wami House International, Riyad, 2000; idem, Priorities of the Islamic Movement, Press Syndacate of Awakening Publications, USA, 2002; R.W. Baker, Islam Without Fear: Egypt and the New Islamists, Harvard University Press, 2006; Hatina M., Identity Politics in the Middle East, Liberal Thought and Islamic Challenges in Egypt, Tauris Academic Studies, London, 2007; A. Boubekeur, O. Roy (eds.), Whatever Happened to the Islamists? Salafis, Heavy Metal Muslims, and the Lure of Consumerist Islam, Columbia University Press, Washington 2012. Il “diritto delle minoranze” e Tariq Ramadan L’esigenza di regolare la situazione del musulmano che vive in territorio non islamico è avvertita sempre di più a partire dagli anni Settanta, quando molti musulmani emigrati precedentemente verso i paesi del Vecchio continente, cui si sono aggiunti quelli di più recente immigrazione, hanno fatto dell’Europa l’orizzonte definitivo della propria esistenza, trasformandosi di fatto in una vera e propria minoranza. La costituzione di una comunità islamica “permanente” nello spazio europeo occidentale ha innescato una serie di trasformazioni che riguardano anche il diritto, sia quello dei paesi europei sia quello islamico. Diritto europeo. Per quanto concerne il primo, si è trattato, e si tratta, di valutare la richiesta islamica di accogliere alcune regole proprie della cultura giuridica islamica (alimentazione, abbigliamento, famiglia etc.; tale riconoscimento sarebbe elemento indispensabile per l'osservanza dei dettami previsti dalla religione di appartenenza. I giuristi europei, in particolare gli ecclesiasticisti (rapporto tra Stato e religione), hanno iniziato a predisporre, nel rispetto dei principi giuridici inderogabili del patrimonio normativo nazionale, comunitario e internazionale, alcuni strumenti che consentano di inserire nei rispettivi ordinamenti giuridici norme attraverso cui soddisfare le esigenze del nuovo soggetto. Un processo quest’ultimo la cui importanza risulta evidente se si considera che le richieste avanzate dai musulmani finiranno, col tempo, con l’assumere uno spazio sempre maggiore nel dibattito politico nazionale ed europeo, soprattutto in presenza di molti musulmani autoctoni, e quindi, specialmente nei paesi che adottano il modello dello ius soli, cittadini, dunque elettori (elettorato attivo e passivo) Diritto islamico. Per quanto riguarda il diritto islamico, invece, il fattore decisivo è la sempre più pressante richiesta di “normatività” proveniente dalle prime generazioni di musulmani autoctoni, cioè dai figli degli immigrati, che lamentano scarsa considerazione da parte della giurisprudenza islamica. In effetti, quest’ultima si è limitata, fino a poco tempo fa, a estendere ai musulmani europei l’applicazione di regole elaborate durante l’epoca medievale e moderna, senza tener conto delle mutate circostanze. La “normativa” elaborata dai giuristi dell’età medievale e moderna presenta, infatti, il carattere dell’“eccezionalità”, nel senso che essa aveva per oggetto un fenomeno, quello della presenza islamica nella cosiddetta “dimora della guerra” la quale, per il suo carattere sporadico e quasi sempre temporaneo, veniva considerato straordinario e dunque tale da non occasionare l’elaborazione di una disciplina giuridica organica, preferendo invece risolvere le fattispecie a esso connesse attraverso l’emissione di singole e circostanziate fatàwà (o responsi giuridici rilasciati a un'autorità riconosciuta), nelle quali, peraltro, i giuristi, proprio in virtù della straordinarietà della situazione, anziché sforzarsi di formulare delle risposte ad hoc, spesso erano soliti ricorrere all’istituto della darùra (necessità), ossia a quello strumento giuridico che consente in caso di estremo bisogno di derogare alla normale applicazione delle regole6. Ma, partire dalla seconda metà del Novecento, la presenza islamica in Occidente ha perso la natura di fenomeno sporadico e temporaneo per acquisire gradualmente quella dell’irreversibilità. La presenza permanente e massiccia di milioni di musulmani richiede effettivamente l’elaborazione di nuove regole. In particolare, va considerato un rinnovato interesse per la pratica religiosa da parte dei giovani 6 Il ricorso al principio giuridico secondo cui «la necessità legittima ciò che normalmente è vietato» è stato avallato anche da molti giuristi contemporanei che hanno sottolineato come i presupposti per l’applicazione della darùra risultino particolarmente frequenti nei casi che riguardano i musulmani che vivono in un contesto migratorio, quindi non islamico. musulmani europei, e quindi la rivendicazione di un ruolo attivo nel panorama sociale e intellettuale europeo, con la nascita di associazioni islamiche che hanno iniziato a chiedere insistentemente agli ulema del mondo islamico e a quelli che vivono in Europa, risposte esplicite ai loro interrogativi. Per soddisfare queste richieste, a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, si è avviato un confronto che sta portando a delineare quell’insieme di prescrizioni che consentirà ai cittadini europei di fede islamica, ma anche a quei musulmani che non sono legati da alcun rapporto di cittadinanza con lo Stato europeo nel quale vivono, di restare fedeli al messaggio di Allah. In questo contesto, ad esempio, è nato a Londra nel 1997 – successivamente, però, ha stabilito la propria sede a Dublino – il “Consiglio europeo per le fatàwà e le ricerche”. Questi nuovi sviluppi hanno determinato, negli ultimi dieci anni, la nascita del fiqh al-’aqalliyyàt o “diritto delle minoranze islamiche”, un’espressione che indica quella branca del diritto islamico che regola la condizione dei musulmani che vivono in un contesto non islamico, ossia in un contesto nel quale la maggioranza della popolazione appartiene a una fede religiosa diversa dalla propria e nel quale viene applicato un sistema giuridico non islamico. Questa nuova disciplina si propone, dunque, di determinare, nel corso del tempo, il superamento dello stato di anomia nel quale versano i seguaci di Allah che risiedono in Occidente. Il primo a utilizzare l’espressione fiqh al-’aqalliyyàt fu, nel 1994, al-‘Alawànì, presidente del North America Fiqh Council, che la adoperò in occasione dell’emanazione di un responso giuridico, sollecitato da un gruppo di musulmani residenti negli USA, sul tema della partecipazione alla vita politica statunitense, da alcuni considerata come una forma di sottomissione a un sistema secolarizzato non islamico. In quella occasione egli fece osservare che gli obblighi che i musulmani sono chiamati a rispettare variano a seconda del contesto nel quale essi si trovano. In particolare, se i seguaci di Allah vivono in un paese nel quale rappresentano una minoranza della popolazione, allora il dovere di rispettare il diritto islamico riguarderà solo quelle regole che non siano in contrasto con il sistema giuridico dello Stato nel quale essi vivono. Il fiqh al-’aqalliyyàt prevede quindi regole destinate non a tutti i musulmani, ma solo a coloro che si trovano in condizioni particolari. Da questo punto di vista, vale la pena sottolineare che negli ultimi anni sono stati pubblicati studi che hanno posto al centro dell’attenzione la compatibilità tra le disposizioni del diritto islamico e quelle delle singole legislazioni nazionali o al massimo di quella europea. La necessità di elaborare una giurisprudenza che si prefigga di declinare i principi immutabili della šarì‘a alla luce del particolare contesto nel quale si trovano i musulmani che vivono in Occidente ha destato l’interesse di alcuni giuristi e intellettuali musulmani. Tra di essi un ruolo di primo piano è svolto da Tariq Ramadan. Tariq Ramadan: profilo biografico Tariq Ramadan è un cittadino svizzero di fede islamica. È nato a Ginevra il 26 agosto del 1962, ed è nipote Hasan Al-Bannà’, colui al quale generalmente si attribuisce la fondazione del movimento dei “Fratelli musulmani”. Ramadan si definisce un intellettuale che studia le scienze islamiche nel tentativo di offrire una risposta ai problemi che i musulmani incontrano in Occidente. Il suo obiettivo - dichiara - non è quello di diffondere l’islam, bensì aiutare i musulmani europei e americani a vivere in mezzo agli altri senza rinunciare alla propria identità. Ramadan sostiene, infatti, che in Europa i musulmani hanno definito la propria identità sulla base del tipo di relazioni che hanno instaurato con l’ambiente circostante – il quale per lo più ravvisa nella presenza islamica un problema – un ambiente che è stato da alcuni completamente accettato e da altri assolutamente rifiutato. 1. Nel primo caso, i seguaci di Allh si sono trasformati in «musulmani senza islam», ossia hanno eliminato dalla dimensione pubblica della propria vita quotidiana tutto ciò che potesse richiamare l’islam, relegando quest’ultimo esclusivamente alla sfera privata. Questi musulmani hanno individuato nella privatizzazione della fede la strategia più efficace per integrarsi nella società europea. 2. Nel secondo caso, invece, essi hanno assunto l’atteggiamento di chi vive in «Europa come se si trovasse fuori dall’Europa». In sostanza, questi musulmani hanno ritenuto che l’unico modo per rimanere fedeli alla religione di appartenenza e per proteggersi dalle spinte assimilazioniste provenienti dalla società europea fosse quello di riprodurre nel Vecchio continente le modalità con le quali l’islam viene vissuto nei paesi d’origine; una convinzione che nella pratica si è tradotta nell’esaltazione della vita comunitaria e nella quasi totale assenza di rapporti con la società del paese nel quale si vive. Ramadan ritiene che entrambi questi atteggiamenti siano da respingere. Dissolversi all’interno della società europea equivale, in effetti, a sostenere implicitamente che i musulmani in quanto tali non sono in grado di apportare nulla alla società europea, ignorando il contributo che, invece, essi potrebbero rendere sul piano della “maggiore spiritualità, del senso della giustizia, della fraternità e del maggior impegno a favore della solidarietà”. Ma anche la seconda posizione è inaccettabile perché non si può immaginare un qualche futuro per i musulmani in Europa se essi rifiutano ogni rapporto con l’ambiente circostante e se non sviluppano una dialettica grazie alla quale potranno essere, dare e ricevere. Occorre, quindi, secondo lo studioso svizzero, trovare una “terza via”. Partendo dal presupposto che l’islam è unico ma che la sua manifestazione mondana è per natura plurale, in quanto legata al luogo e al momento storico nei quali esso si realizza, Ramadan sottolinea la necessità di creare - analogamente a quanto già avvenuto in Africa e in Asia - un Islam europeo, un modo per mantenere viva la fede e restare fedeli agli insegnamenti coranici e profetici pur trovandosi in Europa, in una nuova situazione storica, sociale e politica. A tal fine è necessario tornare all’essenza dei principi islamici, avviare cioè un’opera di emancipazione dalle modalità storiche. Sarà solo dopo aver restituito ai principi islamici la loro configurazione originaria che si potrà poi procedere a interpretarli e calarli nella cultura occidentale. L'autointegrazione del diritto islamico. Secondo Ramadan la nascita dell’islam europeo è subordinata all’accettazione del principio dell’autointegrazione del diritto islamico, inteso come un sistema completo in grado di fornire una risposta per tutti i casi che sorgono nella vita reale. “Di’: O mio Dio! Padrone del Regno! Tu dai il Regno a chi vuoi, e strappi il Regno a chi vuoi, esalti chi Tu vuoi, umili chi Tu vuoi: in mano Tua è il Bene, e Tu sei potente su tutte le cose” (3, 26). Il contenuto di questo versetto coranico è indicativo della differenza esistente, in tema di titolarità del potere sovrano, fra i sistemi giuridici occidentali, per i quali la sovranità appartiene al popolo, e il diritto islamico, che, invece, riconosce la potestà suprema solo ed esclusivamente a Dio. L’attribuzione della sovranità a soggetti diversi ha come corollario un differente modo di intendere il concetto di legislazione. Infatti, i sistemi occidentali prevedono la creazione di norme giuridiche realizzate da un gruppo ristretto di uomini, che, per il tramite di elezioni, sono all’uopo scelti dal popolo, il quale popolo, di conseguenza, rappresenta la fonte di legittimazione del loro operato. Per il diritto islamico, invece, la legislazione coincide con la volontà stessa di Dio, resa manifesta attraverso il suo Profeta. In questo caso, quindi, le regole che disciplinano la vita delle persone hanno un’origine divina, sono state cioè emanate, direttamente (Corano) o indirettamente (Sunna, “tradizione profetica”), da Dio, e in quanto tali rivendicano ubbidienza assoluta. All’uomo rimane, perciò, un margine di manovra abbastanza ristretto. Egli dispone, in effetti, di un diritto di legiferare relativo, che consiste esclusivamente nell’estrarre le disposizioni “normative” contenute all’interno del Corano e della Sunna. Nella maggior parte dei casiquesta operazione si risolve «in una forma di ijtihàd», ossia in uno sforzo interpretativo attraverso cui si cerca di rendere applicabili tali intidazioni ei variegati contesti della vita quotidiana. In alcuni casi, poi, questo sforzo interpretativo assume i toni dell’integrazione, nel senso che esso deve far fronte a dei casi particolari per i quali non vi è alcuna indicazione all’interno del Corano e della Sunna; occorre dunque integrare, cioè aggiungere contenuti nuovi. Questa premessa - osserva Ramadan - è indispensabile per chiarire la confusione che vige spesso, in tema di diritto islamico, tra lo spirito delle ingiunzioni che sono tratte dal Corano e dalla Sunna e l’applicazione pratica di queste disposizioni che, nel corso dei secoli, è stata proposta dai giuristi. È indispensabile cioè, chiarire la differenza fra ciò che nel diritto islamico è considerato assoluto e immutabile, ossia la šarì‘a, e il fiqh, che, invece, fa della flessibilità e della dinamicità i suoi caratteri più rappresentativi. La šarì‘a, infatti, va intesa come quel complesso di principi e insegnamenti giuridici che possono essere ricavati dall’analisi, condotta alla luce dell’esempio del Profeta (Sunna), dei versetti prescrittivi (àyàt al-ahkàm, al-àyàt al-muHkamàt) contenuti all’interno del Corano. I principi e gli insegnamenti così ricavati rappresentano, poiché discendono dal volere divino, la dimensione assoluta e immutabile della “via rivelata”, valida quindi per tutti i tempi e tutti i luoghi. La šarì‘a consiste, di conseguenza, in una serie di linee guida, di direttive, di principi ispiratori che non vanno confusi con il contenuto letterale dei versetti giuridici da cui scaturiscono; questi ultimi, infatti, sono da considerarsi come «réponses a des situations spécifiques auxquelles devait faire face la communauté des fidèles autour du Prophète, [cioè] une réponse relative à l’événement historiquement daté». Del resto, non potrebbe essere altrimenti: le prescrizioni giuridiche specifiche racchiuse nel Corano e nella Sunna sono numericamente così limitate da rendere impossibile l’eventualità di far fronte, sulla base del loro enunciato, a tutte quelle situazioni che, nel corso del tempo, necessitano, all’interno della società, di essere regolate. Per essere fedele al suo compito, cioè conservare il legame tra la componente assoluta e immutabile del diritto e la relatività delle circostanze, delle epoche, delle culture, il fiqh, che è frutto di un’elaborazione umana e razionale, deve essere dinamico, in costante elaborazione, essere cioè al passo con l’evoluzione dei tempi: la sua caratteristica principale, infatti, è quella di essere suscettibile di cambiamenti e adattamenti. Differenza tra 'ibàdàt e mu'àmalàt. I giuristi possono formulare delle “risposte islamiche”, ossia emettere dei responsi (fatàwà) nel quadro della šarì‘a, solo per quei problemi, vecchi e nuovi, che rientrano nel campo delle mu‘àmalàt, vale a dire nel campo delle relazioni sociali; mentre nulla potranno stabilire per le ‘ibàdàt, cioè per le pratiche di culto, dal momento che queste ultime sono state determinate e fissate una volta e per tutte e devono essere applicate così come sono state rivelate al Profeta e da lui insegnate e spiegate. Questa metodologia ha trovato un’applicazione pratica nell’appello internazionale per una moratoria immediata delle punizioni corporali, della lapidazione e della pena di morte nei paesi islamici, lanciato da Ramadan il 30 marzo 2005, l’analisi del quale risulterà, quindi, particolarmente utile. Il diritto penale islamico prevede, sulla base di specifiche prescrizioni contenute all’interno di alcuni versetti e detti profetici, l’applicazione di una serie di pene che hanno sia una funzione sanzionatoria, cioè punire coloro che abbiano posto in essere atti che l’islam considera reprensibili, sia una funzione preventiva, cioè costituire un deterrente che scoraggi la realizzazione di comportamenti illeciti. In sostanza, tali pene costituiscono, secondo il giudizio unanime dei giuristi, i mezzi per realizzare, garantire e preservare i grandi obiettivi del messaggio islamico, cioè la religione, la vita, la ragione, la filiazione e la proprietà, a difesa dei quali sono previsti, rispettivamente, la guerra difensiva, il taglione, il divieto di bere vino, il divieto di rapporti sessuali illeciti e, infine, quello relativo al furto. Questi/e mezzi/pene dovranno essere sempre attuati/e in maniera “giusta”, ovvero nel rispetto delle condizioni al verificarsi delle quali ne è subor- dinata l’applicazione, e alla luce del contesto sociopolitico nel quale avvengono i fatti passibili di essere puniti; un’attuazione delle pene che non tenga conto di questi criteri costituirà, nel primo caso, una violazione della šarì‘a, nel secondo caso, una potenziale ingiustizia e, dunque, un tradimento degli insegnamenti islamici. Con riferimento a quest’ultimo punto, Ramadan cita il precedente del califfo ‘Umar ibn al-Khattab il quale decise, durante un periodo di forte carestia, di sospendere l’applicazione della pena che il Corano prevede in caso di furto. Tale misura fu, infatti, adottata nella convinzione che un’attuazione sic et simpliciter della pena avrebbe potuto configurare una situazione per la quale si sarebbe finiti col punire delle persone il cui ladrocinio era riconducibile esclusivamente al tentativo di sopravvivere alla situazione di estrema povertà nella quale versavano e che era causata dalla carestia in atto. La sospensione (ta‘lìq) della pena fu decretata da ‘Umar anche in un’altra occasione: un uomo si rivolse al califfo affinché facesse punire un suo dipendente che lo aveva derubato; interrogato da ‘Umar sull’accaduto, il lavoratore riconobbe le proprie responsabilità, ma dichiarò di esserne stato indotto dalla circostanza che il suo datore di lavoro non gli dava il necessario per vivere; a quel punto il califfo non solo non fece punire il lavoratore, ma intimò al suo datore di lavoro di fornire al proprio dipendente i necessari mezzi di sussistenza, altrimenti sarebbe stato lui a essere punito. È evidente, quindi, come ‘Umar ibn al-Khattab ritenesse che l’applicazione delle pene dovesse essere funzionale al perseguimento dei intenti della sharì'a e non a una mera aderenza alla lettera dei testi che contengono le prescrizioni relative alle pene stesse. È questa la logica a partire dalla quale prende le mosse l’appello internazionale lanciato da Ramadan. La definizione dell’occidente: da “dimora della guerra” a “dimora della testimonianza” L’altro elemento nel quale Ramadan ravvisa un presupposto indispensabile per la nascita dell’islam europeo è rappresentato dalla necessità di rivisitare in chiave critica l’apparato cognitivo elaborato dai giuristi musulmani vissuti durante i primi tre secoli dell’islam in merito alla classificazione dei territori; un apparato cognitivo al quale molti giuristi, attualmente, continuano, pedissequamente e acriticamente, a fare riferimento, senza tenere in debita considerazione che si tratta di nozioni definite per descrivere una realtà geopolitica molto diversa da quella attuale, la quale, invece, richiede, per meglio essere compresa, la costruzione di un nuovo bagaglio concettuale che la rappresenti maggiormente. I giuristi classici hanno suddiviso il mondo in due distinte e giustapposte entità territoriali ossia la “dimora dell'Islam” e la “dimora della guerra”. L’inclusione di uno spazio geografico all’interno dell’una o dell’altra categoria avveniva dopo aver verificato che in esso fossero rispettati alcuni parametri: che l’Islam fosse la religione professata dalla maggioranza della popolazione che abitava il territorio da classificare, che i governanti di quest’ultimo aderissero all’islam, e che il sistema giuridico applicato nella regione fosse quello islamico. Ramadan sottolinea che i due concetti non traggono origine né dal Corano né, tanto meno, dalla Sunna. Invece, rappresentano il tentativo, operato dagli antichi giuristi, di descrivere ai musulmani il quadro geopolitico allora esistente, raffigurato come un mondo diviso in due blocchi chiusi e antitetici; una descrizione umana, quindi, che, in quanto tale, risente del contesto e del momento storico nel quale è stata formulata; e che non può rappresentare la situazione attuale, nella quale si moltiplicano le occasioni d’interazione, di confronto, di reciproca apertura. In effetti, per queste ragioni, il paesaggio politico ed economico del mondo viene sempre più illustrato ricorrendo ad altri concetti, presi a prestito dalla sociologia dello sviluppo, che rimandano a un’immagine del mondo visto come un blocco unico all’interno del quale è possibile riconoscere un centro – rappresentato dall’Occidente – e una periferia – rappresentata dal resto del mondo. Alla luce di queste considerazioni occorre, secondo Ramadan, ritornare alle fonti (Corano e Sunna) produrre una nuova definizione del territorio occidentale che meglio si presti a descrivere la realtà nella quale ci troviamo oggi; una nuova definizione che lo studioso svizzero individua nella nozione di “Dimora dell’Invito”. La nozione di dar ad-da‘wa è stata elaborata alla fine degli anni ottanta del secolo scorso, più precisamente nel 1987, da un intellettuale molto stimato all’interno della umma, ovvero Faysal Mawlawì, libenese sunnita (ex leader del partito politico noto come al-jamà'a al-islàmiyya). Il punto di partenza da cui Mawlawì prende le mosse per articolare questa nuova denominazione è la similitudine tra la situazione dei musulmani in Occidente e quella vissuta dai loro fratelli di fede durante il periodo meccano, ai quali veniva richiesto non solo di credere, ma anche, e proprio perché si trovavano in una situazione di minoranza e in un contesto che non accettava la nuova rivelazione (perché il messaggio divino minava in qualche modo lo status quo, l’ordine precostituito), di invitare i popoli e le tribù a Dio, presentando e spiegando la loro religione. Allo stesso modo, i musulmani che vivono in Occidente, proprio perché si trovano in un contesto dove rappresentano una minoranza e dove vengono percepiti essenzialmente come un problema, devono assumersi la responsabilità di testimoniare la loro fede, di invitare le persone che li circondano a Dio. Questo significa che non solo i musulmani possono vivere nei paesi occidentali, ma anche che essi hanno la responsabilità sociale di testimoniare in questi paesi il messaggio divino, nella speranza che un numero sempre maggiore di persone abbracci l’islam e che quindi i musul mani si trasformino nella maggioranza della popolazione, creando così il presupposto per la totale applicazione del diritto islamico. Da Dimora dell'Invito Dimora della Testimonianza. Quest’ultima puntualizzazione, benché di fondamentale importanza, viene omessa da Ramadan che, però, sembra cogliere appieno le conseguenze negative che potrebbero da essa derivare. Egli, infatti, afferma che se da‘wa costituisce il termine con il quale i musulmani indicano l’idea di presentare e spiegare il messaggio dell’islam ai non musulmani, esso viene spesso inteso come uno strumento attraverso cui fare proselitismo e indurre alla conversione. Per questa ragione è più appropriato, secondo Ramadan, sostituire questo concetto con quello di šahàda (testimonianza. Dunque, l'occidente come dàr al-shahàda). Infatti, nel momento in cui il musulmano pronuncia la professione di fede, egli attesta non solo l’unicità di Dio e che Muhammad è il suo inviato, ma anche la propria fede in Dio. Credere significa agire di conseguenza, coerentemente con gli insegnamenti e le prescrizioni dell’islam, essere testimoni di ciò che si è e dei propri valori, a prescindere dal luogo nel quale ci si trova. A maggior ragione nell’Occidente, perché da un lato esso rappresenta, come si è visto, il centro, la testa dell’intero sistema mondiale, dall’altro perché esso rappresenta il luogo dove spesso ci si dimentica del Creatore, al punto di negarne l’esistenza, e dove tutto si basa su una logica esclusivamente economica, della produttività e del consumismo. Ricordare Dio e la spiritualità alle persone che li circondano e affermare, nell’ambito delle relazioni sociali, i valori, la morale, la giustizia e la solidarietà, costituiscono, quindi, dei doveri dei musulmani che legittimano, da un punto di vista religioso, la loro presenza in Occidente. In Occidente, molti elementi essenziali per la realizzione dell’identità islamica (libertà di coscienza, libertà di culto, libertà di espressione, sicurezza e partecipazione alla vita sociale) sono già riconosciuti dalle legislazioni: i musulmani sono liberi di praticare la loro religione (tutte le pratiche di culto e una parte delle relazioni sociali), liberi di parlare dell’islam e di organizzare diversi tipi di attività religiose, sociali e culturali, liberi di istituire delle associazioni e di partecipare, a diversi livelli, alla vita sociale. Restano, tuttavia, almeno due problemi da risolvere, ossia: come conservare, in una società secolarizzata caratterizzata dalla neutralità dello spazio pubblico, il dinamismo della vita spirituale e di conseguenza, come garantire la trasmissione del sapere islamico; occorre risolvere il rapporto tra il diritto dei paesi europei e quello islamico: i musulmani che sono venuti in Europa, come lavoratori, studenti, rifugiati o per ricongiungersi alle loro famiglie hanno, tacitamente o esplicitamente, riconosciuto il carattere obbligatorio della Costituzione o delle leggi del paese in cui si apprestavano a entrare e poi a vivere. Firmando un contratto di lavoro o chiedendo un visto, essi accettano l’autorità della Costituzione, delle leggi e dello Stato. Lo stesso vale per le seconde generazioni e quelle successive che, essendo cittadini, sono naturalmente legati alla legislazione dello Stato, e su di loro ricadono i termini dell’accordo già accettato in precedenza dai loro genitori. Per i musulmani, quindi, il rispetto delle leggi locali dovrebbe essere – secono Ramadan - la diretta conseguenza del patto (visto, contratto di lavoro, cittadinanza) stitpulato con le istituzioni del Paese in cui si trovano; tale accordo, in virtù dello stesso diritto islamico, non può essere violato perché il Corano recita: “Rispettate il patto perché in verità vi sarà chiesto di darne conto” (17, 34). I musulmani, inoltre, dovranno evitare, fra le attività che le legislazioni locali ammettono, ma non impongono, di partecipare a quelle che sono in contraddizione con la loro religione. Si pensi, ad esempio, al vino. Il consumo di questa bevanda è, infatti, lasciato all’arbitrio dei singoli, i quali, pertanto, potranno scegliere liberamente se berne o meno (difatti le restrizioni previste non riguardano la scelta di bere o non bere il vino, ma, semmai, la quantità che se ne può assumere quando, ad esempio, ci si accinge a guidare); va da sé che in questo caso, e in tutti quelli analoghi, caratterizzati dalla mancanza di ogni tipo di imposizione, i musulmani hanno la libertà di operare delle scelte che siano in linea con i dettami della propria religione, una libertà che, nel caso del vino, si traduce nell’astenersi dal consumo. Il problema nasce, invece, quando i musulmani sono chiamati a compiere obbligatoriamente delle attività che sono in evidente contraddizione con il proprio sistema giuridico: si pensi ad esempio all’assicurazione obbligatoria contro terzi (quella delle autovetture) che, essendo caratterizzata dall’incertezza di una delle due prestazioni, viola il principio di diritto islamico secondo cui non vi debbono essere dubbi sulle obbligazioni assunte dalle parti. Ogni qualvolta ci si troverà dinnanzi a una situazione del genere (matrimonio, eredità, divieto di interesse), i giuristi musulmani dovranno quindi realizzare uno studio specifico per determinare, con la formulazione di un parere giuridico circostanziato, i possibili adattamenti del fiqh che permettano al musulmano di soddisfare contemporaneamente le esigenze connesse alla sua fede ma anche al suo essere cittadino. L’originalità del lavoro di Ramadan consiste non tanto nella produzione di concetti e idee originali, quanto piuttosto nella sistematizzazione della riflessione avviata da altri autori prima di lui sul tema della presenza islamica in Occidente, una riflessione che, diversamente dall’opera di Ramadan, non ha ricevuto alcuna attenzione e non è stata fonte di alcun dibattito. E questo perché si trattava o di testi scritti in arabo, lingua inaccessibile alla maggior parte di coloro che si interessano a Ramadan, o perché si trattava di autori che non hanno ricercato la visibilità massmediatica di cui, invece, è stato ed è protagonista il professore svizzero. Questa circostanza spinge a ritenere che Ramadan sia più da ascrivere alla categoria dei divulgatori che a quella dei ricercatori. A confortare questa tesi ci sono i testi prodotti dallo studioso svizzero, i quali, fatta qualche debita eccezione (come ad esempio il testo sul riformismo islamico, che costituisce la sua tesi di dottorato), si caratterizzano per il fatto di essere l’uno la mera riproduzione sistematica dell’altro, contribuendo in tal modo a spiegare come egli abbia fatto, nel giro di pochissimi anni, a dare alle stampe, secondo quanto viene riportato sul sito ufficiale, venti libri e settecento articoli. Il principale merito di Ramadan consiste nell’aver contribuito a diffondere, soprattutto fra i giovani, una serie di idee alla luce delle quali risulta evidente che esistono all’interno del quadro islamico degli spazi di manovra, gestendo i quali potrebbe essere possibile per i seguaci di Allah individuare delle soluzioni che consentano di combinare la fedeltà all’islam con il rispetto delle istituzioni e dei principi sui quali si reggono le democrazie occidentali. Ramadan ha, quindi, il merito di aver portato fuori dall’accademia i risultati di molte ricerche e di averli resi fruibili a un numero sempre maggiore di musulmani e non solo. Bibliografia C. De Angelo, I musulmani in europa nella prospettiva islamica, in I. Zilio-Grandi (a cura di), Il dialogo delle leggi, Marsilio, Venezia 2006, pp. 132-159. Per un Islam europeo fondato sulla condivisione dei valori, cfr. I. Zilio-Grandi, The Gratitude of man and the gratitude of God. Notes on šukr in traditional Islamic thought, in “Islamochristiana” 38(2012). Il presente saggio intende offrire un contributo allo studio della gratitudine o šukr nella tradizione islamica, partendo dall'impiego coranico della radice škr (specialmente il derivato šakūr), osservando i suoi contenuti esplicitati dalla lessicografia antica (Ibn Manẓ ūr), richiamando la presenza di tali contenuti nel pensiero tradizionale (Ibn Abī al-Dunyā e al-Harāʾiṭ ī) e proponendo qualche confronto con la riflessione teologica (Abū Ḥ āmid al-Ġazālī e Ibn Qayyim al-Ǧ awziyya). Alla luce della letteratura consultata, la gratitudine risulta un nodo cruciale della fede, un caposaldo dell'etica islamica consapevolmente realizzata, nonché un grande elemento di raccordo tra la prassi di Dio e il dovere dell'uomo, sia per la consonanza tra la riconoscenza umana a Dio e il gradimento divino nei confronti del credente, sia per la stretta connessione tra la gratitudine dovuta a Dio e quella dovuta al fratello benefattore. L’uomo appare infine come una creatura dotata di conoscenza la cui più alta vocazione è, appunto, quella della gratitudine. Premessa In seguito a numerose affermazioni coraniche continuamente ribadite dalla letteratura di Tradizione, l'assoluta alterità dello statuto divino rispetto a quello umano è un assunto fondamentale della dottrina islamica: se Dio è il Creatore unico, ogni uomo è una Sua creatura tra le altre; se Dio è il Re (malik) o il Padrone (mālik), l'uomo è inesorabilmente Suo servo e Sua proprietà. Accade però, sempre seguendo la letteratura canonica, che un modo d'essere o d'agire della divinità si trovi a coincidere con una capacità o un'attitudine dell'uomo, ed è cosa che balza all'occhio scorrendo i “Bellissimi Nomi”. Alcuni sono evidentemente prerogativa di Dio ma altri, in numero cospicuo, si schiudono a una lettura di senso antropologico e segnano altrettante virtù del fedele, pratiche consolidate o qualità in forza delle quali costui si comporta rettamente. E a volte, perfino, richiamano la condizione necessaria del musulmano, com'è il caso del Nome mu’min (cfr. īmān, “fede”), o i suoi doveri legali, com'è il caso di šahīd (cfr. šahāda, “Testimonianza di fede”). Sono quei “Nomi equivoci” (asmā’ mutašābiha) o “condivisi” (muštaraka) che formano l'oggetto della riflessione di al-Ġazālī (m. 505/1111) nell'opera intitolata Al-maqṣ ad al-asnā e dedicata appunto al significato dei Nomi: sebbene immersi nella differenza (iḫ tilāf), i Nomi divini si prestano al ragionamento analogico (qiyās)7. Così suggeriscono un campo di intersezione tra la sfera divina e quella umana, delineano una tensione comune, e infine valgono a fondare un'etica religiosa. 1. Šakūr, Nome di Dio, nome dell'uomo virtuoso Tra i più bei Nomi di Dio c'è šakūr, una forma intensiva, che viene a significare “molto Riconoscente” o “molto Grato”. E' incluso in tutte le liste principali 8 ed è derivato letteralmente dal Libro dove compare a partire dal tardo periodo di Mecca. Questo Nome è citato nelle sure del Cfr. Abū Ḥ āmid al-Ghazālī, Al-Maqṣ ad al-Asnā fī Sharḥ Asmā’ Allāh al-Ḥ usnā, Arabic Text, edited with Introduction by Fadlou A. Shehadi, Dār el-Mashreq, Beirut, 1971 soprattutto 47-59. 8 Nella lista in al-Tirmiḏ ī sull'autorità di Abū Hurayra figura al 36° posto (cfr. Maqṣ ad, 63); in Ibn Māǧ a al 42°; in al-Ḥ ākim al-Nisābūrī, da Abū Hurayra da Ibn Sīrīn, al 31°. 7 Creatore (35,34), della Consultazione (42,23) e del Reciproco Inganno (64,17); nei primi due casi la “gratitudine” (šukr) di Dio si accosta alla Sua indulgenza, maġfira o ġafr (nell'espressione šakūr ġafūr), nel terzo alla Sua mitezza o mansuetudine, ḥ ilm (cfr. šakūr ḥ alīm). Allo stesso tempo, šakūr è epiteto di Noè nella sura del Viaggio Notturno (cfr. ‘abd šakūr, 17,3) e qualifica in generale il credente pio nelle sure di Abramo (14,5), di Luqmān (31,31), dei Sabā’ (34,19) e, nuovamente, della Consultazione (42,33); in tutti e quattro gli ultimi casi, la buona attitudine allo šukr va di pari passo con la costanza o fermezza d'intento del musulmano, cioè ṣ abr (cfr. ṣ abbār šakūr)9. Qualche autore inserisce tra i Nomi anche šākir10, “Riconoscente” o “Grato”, a sua volta attestato nel Corano, e in tutto l'arco cronologico della predicazione. Questa voce è riferita anche al credente nelle sure dell'Ape (16,121) e dell'Uomo (76,3)11; quanto a Dio, compare nelle sure della Vacca (2,158) e delle Donne (4,147) dove è accostata al Nome ‘alīm, avvicinando in tal modo Gratitudine e Sapienza. La ricorrenza della sura delle Donne è particolarmente rilevante, perché la gratitudine di Dio è correlata alla gratitudine dell'uomo: “Perché Dio vi tormenterebbe se Gli siete grati (šakartum) e se credete in lui? Dio è grato e sapiente (šākir ‘alīm)”12. La voce che l'erudito medievale Ibn Manẓ ūr (m. 711/1312-3) dedica alla radice verbale škr nel dizionario dal titolo Lisān al-‘arab, La lingua degli Arabi13, si presta a introdurre l'argomento sia per la nitidezza delle spiegazioni sia perché riprende, com'è di regola in quest'opera, le ricorrenze più notevoli nella letteratura canonica dell'Islam. Perciò è utile ripercorrerla a grandi linee. Nelle prime righe l'autore definisce in generale lo šukr – con il sinonimo šukūr – come “il riconoscimento (‘irfān) e l'aperta ammissione (našr) del beneficio ricevuto”. È dunque gratitudine ma con un'accezione dichiarativa e divulgativa, e per di più fisica e tangibile visto che, osserva ancora Ibn Manẓ ūr, “proviene necessariamente dalla mano (lā yakūnu illā ‘an al-yad)”, a differenza della lode o ḥ amd che “proviene dalla mano o da altro”14 nel senso ovvio che dev'essere anzitutto verbale15. La prima forma di applicazione è la gratitudine dell'uomo a Dio. Ibn Manẓ ūr scrive che l'uomo šakūr è chi abbonda in šukr e porta immediatamente l'esempio coranico di Noè, il servo “molto grato” (cfr. 17,3) salvato dal diluvio come pagamento (cfr. aǧ r in 26,109)16 per i vani A proposito della possibile coincidenza di un Nome con una virtù del credente, lo ḥ ilm qualifica nel Corano, oltre a Dio, anche Abramo e Šu‘ayb (cfr. rispettivamente 11,75 e 87) e inoltre il figlio che Abramo si apprestava a offrire in sacrificio (37,101); quanto al ṣ abr del musulmano, appartiene in forma sublime a Dio essendo appunto alṣ abūr il Suo penultimo Nome. 10 Come al-Ḥ ākim al-Nisābūrī che lo posiziona all'87° posto. 11 Si aggiungano le ricorrenze del plurale šākirīn, sempre riferito all'umanità, in 3,144 e 145; 6,53 e 63; 7,17,144 e 189; 10,22; 39,66. 12 Sulla questione dello šukr, divino e umano, cfr. A. Giese, Shukr, 1. As a religious and mystical concept, in “Encyclopaedia of Islam”, 2a ed., vol. IX, 515-517, specialmente costruito sulla dottrina di al-Ġazālī, a sua volta da rinomati compendi sufi (al-Qušayrī e al-Makkī); A. K. Reinhart, ukr, 2. As a factor in public life and in the principles of law, ibidem, 517, dedicato anche allo šukr al-mun‘īm o “gratitudine per il benefattore”, tra i principi del diritto islamico; L. Sanneh, Gratitude and Ingratitude, in “Encyclopaedia of the Qur’ān”, a sua volta dedicato in parte ad al-Ġazālī, Brill, Leiden-Boston vol. II (2002), 370-373; più generale M. Ayoub, Thanksgiving and Praise in the Qur’ān and in Muslim Piety, in “Islamochristiana” 15(1989), 1-10. Una prospettiva particolare in R. Tottoli, The Thanksgiving Prostration (sujūd al-shukr) in Muslim Traditions, in “Bulletin of the School of Oriental and African Studies” 61,2 (1998), 309–313. Per una recente visione islamica spirituale, veda la voce sulla gratitudine in M. Fethullah Gülen, Key Concepts in the Practice of Sufism, 1. Emerald Hills of the Heart, Somerset (New Jersey) 2006 (1a ed. 1998, ed. or. turca 1994), 94-97. 13 Consultato nell'edizione Dār al-ma‘ārif, Beirut 2010 (6 voll.); cfr. IV, 2305-2308. 14 Identico al-Zabīdī (m. 1205/1790), Tāǧ al-ʼarūs, Dār al-hidāya, Riad s.d. (40 voll.), XII, 224. 15 Lisān, 2305. E' un'opinione che Ibn Manẓ ūr riprende dal più antico Ṯ aʾlab (m. 291/904) autore del Kitāb alfaṣ īḥ , contro altri grammatici convinti della perfetta sinonimia dei due termini. La maggiore estensione di ḥ amd sarebbe attestata dal detto profetico: “La lode sta a capo della gratitudine (al-ḥ amd raʼs al-šukr), un servo che non loda Dio non Gli è grato (mā šakara Allāh ʼabd lā yaḥ madu-hu)” perché – spiega Ibn Manẓ ūr – nella lode stanno l'ammissione manifesta (iẓ hār) e la celebrazione (išāda) della grazia ricevuta. Cfr. ibidem, 987, s.v. ḥ amd. Comunque ammette che ḥ amd e šukr sono vicini tra loro (mutaqāribāni) e ricorda che anche ḥ amīd è Nome divino. Cfr. Tāǧ : “Lo šukr riguarda le membra del corpo, il ḥ amd riguarda la lingua”, 226. 16 Sull'accezione concreta ed eventualmente pecuniaria della ricompensa detta aǧ r, cfr. Lisān, I, 31 (“Al-aǧ r al9 appelli al suo popolo. Il Lisān procede con un ricorso alla Sunna. Videro che il Profeta si applicava assiduamente alle pratiche devozionali (‘ibāda) e gli chiesero: “Fai così, anche se Dio ti ha già perdonato le colpe del passato e del futuro?” “E allora – rispose, siano su di lui la preghiera e la pace - non devo essere un servo molto riconoscente (šakūr)?!”. E' un detto molto noto, trasmesso in varianti di diversa estensione (per lo più sull'autorità di al-Muġīra ibn Šu‘ba), che fanno leva sulla macerazione corporale di Muhammad durante la preghiera e attestano bene la valenza di atto anche fisicamente eseguito, implicita nella gratitudine umana al Signore17. Ibn Manẓ ūr illustra poi il lemma šakūr in riferimento a Dio18, cioè quando è Sua ṣ ifa o “descrizione”: ha presente la sura del Creatore quando recita che “Dio pagherà loro quel che è loro dovuto (uǧ ūra-hum) e moltiplicherà per loro la Sua grazia (ni‘ma) […] (35,30)” perché spiega che ogni piccola opera del servo cresce e prospera presso il creatore, il quale la ripaga oltre misura. E precisa che lo šukr di Dio per l'uomo è la remissione delle colpe (maġfira), remissione ampia perché šakūr è in forma intensiva, mentre lo šukr dell'uomo è operare “attraverso gli atti devozionali (ṭ a‘āt), attraverso l'adempimento dei doveri di servitù (‘ibādāt)”. In tutta coerenza porta quindi l'esempio coranico della Famiglia di Davide, che Dio esortò ad agire per Lui quale manifestazione sensibile di gratitudine (cfr. a‘malū […] šukran) e che, anziché molto, corrispose poco a quell'esortazione (cfr. qalīl min ʼibādī al-šakūr, 34,13). A questo punto l'autore del Lisān riprende con attenzione la differenza tra šukr, “gratitudine”, e “ḥ amd”, lode, e osserva che ḥ amd è più ampio e inclusivo di šukr, perché si dice che qualcuno è meritevole di ḥ amd per le buone qualità (ṣ ifāt ğamīla) e il buon operato (ma‘rūf) insieme, mentre si dice meritevole di šukr per il buon operato soltanto. Inoltre - spiega - šukr significa contraccambiare il bene ricevuto (muqābalat al-ni‘ma) con la parola, l'azione e l'intenzione – gli elementi costitutivi delle ‘ibādāt – nonché elogiare (ṯ anā’) chi è fonte del beneficio (mun‘im) facendo di tutto per agire in sua ubbidienza (ṭ ā‘a). E così, nuovamente, colloca lo šukr nella zona della prassi19. 2. Lo šukr, prassi di Dio, dovere dell'uomo Quel che Ibn Manẓ ūr ha spiegato fino a qui è che lo šukr umano a Dio è un'espressione materiale di gratitudine – un “fare per Dio”, ‘amal li-llāh, “gratifica” più che gratitudine - seguente un beneficio ricevuto. Ma, in modo più indiretto, ha rilevato una valenza pragmatica anche nello šukr che arriva dal Signore, visto che ha richiamato Noè il quale ebbe da Dio un donativo tangibile (aǧ r). L'aspetto concreto della gratitudine, di Dio o dell'uomo, è cosa su cui l'autore del Lisān tornerà nelle righe successive20 quando scriverà che šukr deriva dall'espressione šakarat al-ibil, applicata ai “cammelli che ingrassano al pascolo”; e che šakira o miškār è l'animale da latte che, foraggiato, produce latte in abbondanza e più copiosamente di prima; e che proprio šakūr - Nome divino, epiteto del buon credente - si dice del quadrupede a cui basta poco foraggio e addirittura con quel poco ingrassa, “come se ringraziasse anche se il beneficio che riceve è poco; la sua gratitudine sta nel manifestarsi della crescita (ẓ uhūr al-namāʼ), nel manifestarsi del foraggio assimilato”21. ǧ azāʼ ʼalā al-ʼamal”) e, simile, al-Fayrūz’ābādī (m. 817/1415), Al-qāmūs al-muḥ īṭ , Mu’assasat al-risāla, 6a ed. Cairo 1419/1998, 342. 17 Cfr. al-Bukhārī, Ṣ aḥ īḥ , kitāb tafsīr al-Qurʼān, tafsīr sūrat al-Fatḥ , n. 4486; simile da ʾĀʾiša, ibidem, n. 4487; a proposito del carattere fisico dello šukr umano, kitāb al-ǧ umʼa, n. 1069, sempre da al-Muġīra: “Il Profeta stava in piedi per pregare finché i piedi o le gambe gli si gonfiavano. Glielo fecero notare e gli chiesero [...]”; kitāb alrifāq, n. 6019, dallo stesso garante: “Il Profeta pregava finché i suoi piedi si gonfiavano o si tumefacevano; gli chiesero [...]”. Cfr. Muslim, Ṣ aḥ īḥ , kitāb ṣ ifāt al-qiyāma, n. 5051 e 5052; Ibn Māǧ a, Sunan, kitāb iqāmat al-ṣ alāt, n. 1409. 18 L'autore tace invece il Nome šākir. 19 Lisān, ibidem. Diverso il Tāǧ , cfr. ancora 226, che distingue šukr del cuore, della lingua e delle membra del corpo: il primo è assoggettarsi e sottomettersi ( ḫ uḍ ūʼ wa istikāna), il secondo elogiare e dichiarare riconoscenza (ṯ anāʼ wa iʼtirāf), il terzo compiere atti di obbedienza e subordinazione ( ṭ āʼa wa inqiyād). 20 Lisān, 2305-2306. 21 Oppure che aškara šukran si dice dei quadrupedi che ingrassano e le cui mammelle si riempiono di latte; o che l'erba è maškara quando è foraggio buono per gli animali da latte; o che zamān al-šakira è quando l'animale da latte festeggia la primavera; o che il cielo istaškara quando piove molto e l'effetto sulla natura è ridondante... Cfr. Lisān, Sono esempi di viva fisicità, visto che la forma esplicita della gratitudine è il nutrimento alimentare. Al tempo stesso parlano di una scarsità ripagata con l'abbondanza, e pertanto affermano che un necessario costitutivo dello šukr è l'aggiunta, cioè l'aumento (ziyāda) o la moltiplicazione (muḍ āʼafa) del corrispettivo. Ibn Manẓ ūr sa bene che tale è anzitutto – sia detto con il dovuto rispetto per la cultura religiosa in esame – il modo consueto della gratitudine di Dio, che “accresce” (yazīdu, cfr. 17,4) e “raddoppia” (yuḍ āʼifu), in questo mondo e nell'aldilà, “raddoppia la Sua grazia a chi vuole” come recita la sura della Vacca (2,261), “se c’è un’azione buona la raddoppierà e nella Sua grazia la ricompenserà enormemente” com'è detto nella sura delle Donne (4,40)22. Così, la definizione di šukr si è perfezionata: è una concreta espressione di gratitudine, un beneficio seguente un beneficio ricevuto; ed è una risposta aumentativa, una reazione magnificante23. Proprio sull'accrescimento - illimitato quello di Dio, limitato quello dell'uomo - poggia il commento di al-Ġazālī al Nome šakūr nell'opera ricordata sopra: esso significa che Dio “compensa con molti gradi le piccole azioni d'ubbidienza (ṭ ā‘āt) e ripaga l'operato (‘amal) di giorni finiti con un'infinita beatitudine nell'aldilà”. “Si dice che ha mostrato gratitudine per una buona azione di chi la corrisponde con un'azione due volte buona – scrive ancora al-Ġazālī, - […] e se riflettiamo sull'aumento (ziyāda) che sta nel corrispettivo, allora l'unico Grato in assoluto (šakūr muṭ laq) è Dio; infatti, ciò che Egli aggiunge è senza restrizione e limite, perché non c'è nulla oltre la beatitudine del paradiso”24. Dal momento che šukr, come si è visto, ha anche senso dichiarativo e significa “elogio” (ṯ anā’), il Nome šakūr deve implicare l'elogio di Dio verso i meritevoli. E su questo punto il commento di al-Ġazālī esprime chiaramente l'intersezione tra il divino e l'umano suggerita da certi Nomi Bellissimi, nonché una circolarità di senso. Il grande teologo nota che l'elogio di Dio, sebbene rivolto alle azioni dei servi, è comunque diretto a Sé, perché le azioni umane sono create da Lui, mentre l'elogio umano per un beneficio ricevuto non può che essere diretto ad altri. E in effetti anche lo šukr umano a Dio proviene da Lui stesso, che è l'Unico a consentirlo; è una grazia ulteriore (niʼma uḫ rā) che si aggiunge alla grazia per cui l'uomo esprime gratitudine. L'elogio dell'uomo a Dio è insufficiente – continua l'autore - perché sfugge alle capacità creaturali; ed è più povero delle opere di ubbidienza (ṭ āʼāt). Al-Ġazālī conclude che l'ottima espressione di gratitudine al Signore è operare in ubbidienza di Lui25. Non è distante la riflessione del dotto ḥ anbalita Ibn Qayyim al-Ǧ awziyya (751/1350) nell'opera dal titolo L'Equipaggiamento dei pazienti, la provvista dei grati (‘Uddat al-ṣ ābirīn wa ḏ aḫ īrat alšākirīn)26. Anche questo autore, che pure indugia, come vuole il titolo dell'opera, sulla sostanza e i modi dello šukr umano27, non dimentica di avvicinare quest'ultimo allo šukr di Dio28; e a sua volta rileva la giunzione o l'interconnessione che sottende Sua gratitudine una faccenda diversa. Come già al-Ġazālī, nota che Dio merita d'essere chiamato Grato più d'ogni altro; Egli è “il Grato in tutta verità (al-šakūr ‘alā al-ḥ aqīqa)” perché “contraccambia quel che gli è offerto in gratitudine (mā yuškaru la-hu) […] e ripaga la buona azione con un'azione dieci volte migliore”. Di conseguenza, “la creatura che Egli ama (yuḥ ibbu) di più è quella contraddistinta dalla gratitudine”: “Dio è Bello e 2036. Molto ridotto a questo proposito il Tāǧ , cfr. 227. 22 Cfr. anche 2,245; 30,39; 57,11. 23 Non si può non considerare che, se tutti i benefici, l'uno via l'altro, richiedono d'essere seguiti da benefici maggiori, l'idea di šukr è estremamente felice, perché rimanda a una continua dilatazione del bene. 24 Maqṣ ad, 114. 25 Ibidem, 115. 26 Dār al-turāṯ , Medina, 3a ed. 1409/1989 (segnalo che il lavoro di “traduzione abbreviata” di Nasiruddin alKhattab, Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Patience and Gratitude, “Towards Islamic Psycology”, parte 1, Ta-Ha Publishers, London 1997, conserva poco dell'originale nella parte sulla gratitudine). Per una contestualizzazione di quest'opera, e in generale sul pensiero dello studioso ḥ anbalita, rimando alla corposa raccolta di saggi curata da C. Bori e L. Holzman, A Scholar in the Shadow. Essays in the Legal and Theological Thought of Ibn Qayyim al-Ǧ awziyyah, numero monografico di “Oriente Moderno”, 90/1 (2010). 27 Cfr. ad esempio l'intero cap. XX, dedicato alla controversa precellenza della gratitudine o della pazienza l'una sull'altra, 111-147. 28 Ibidem 280-283 (all'interno del cap. XXVI). ama la bellezza29, è Sapiente e ama i sapienti, è Clemente e ama i clementi, è Grato e ama chi è grato [...]30. 3. Lā yaškuru Allāh man lā yaškuru al-nās Nel corso delle sue meditazioni sul Nome šakūr, al-Ġazālī31 ricordava un detto profetico trasmesso da più Compagni, incluso nell'Adab al-mufrad di al-Buḫ ārī32 e continuamente ripreso dalla letteratura successiva: lā yaškuru Allāh man lā yaškuru al-nās. E poiché questo detto presenta un'ambiguità di lettura, conviene tornare a Ibn Manẓ ūr che ne discute la sintassi e, di seguito, il senso. L'ambiguità – spiega l'autore del Lisān – sta nella diversa terminazione di Allāh in questa occorrenza: se il Nome è al nominativo (Allāhu), soggetto della frase, vuol dire che Dio non accoglie (lā yaqbalu) la gratitudine che l'uomo Gli offre per i benefici provenienti da Lui, se l'uomo non è grato agli altri per i benefici che gli vengono da loro e se rifiuta (yakfuru) di ammetterli; “questo in virtù della connessione (ittiṣ āl) tra le due cose”33. Se invece il Nome si intende in accusativo (Allāha), il detto si spiega altrimenti: “chi ha natura e costume (ṭ ab‘, ‘āda) tali, da negare (kufrān) il bene ricevuto dagli altri e omettere la gratitudine per loro, costui ha il costume di negare il bene ricevuto da Dio (kufr ni‘mat Allāh) e di omettere la gratitudine a Lui34; “è come dire: chi non ama (yuḥ ibbu) me, non ama te, l'amore (maḥ abba) di te è connesso (maqrūna) all'amore di me”35. La differenza di lettura non è di poco conto. In un caso – là dove Dio non è grato all'uomo che non è grato al fratello - lo šukr divino si trova discutibilmente subordinato a quello tra le creature, con un antropocentrismo quanto meno anomalo nel contesto islamico; nell'altro caso – là dove l'uomo che non è grato al fratello non è grato nemmeno a Dio - lo šukr è tutto creaturale e lascia cadere la gratitudine da parte del Creatore. Comunque sia, quel che importa acquisire è che, nelle pieghe della lingua e tra le sottigliezze grammaticali del detto profetico in questione, l'azione di gratitudine si rivela un grande elemento di raccordo tra la prassi del Creatore e l'operato che le Sue creature devono, a Lui e per Lui: lo šukr è un processo connettivo, possibilmente ininterrotto, un momento alto di contiguità e, dobbiamo aggiungere, di reciproco amore (cfr. la ripetuta ricorrenza della radice ḥ bb). Restiamo per il momento a Ibn Manẓ ūr. La dignità religiosa dello šukr insieme alla felicità dei suoi contenuti si riflette infine e più che mai nella definizione che l'autore dà a contrario, logicamente derivata dal discorso che precede. Scrive che “la gratitudine è l'opposto dell'ingratitudine” oppure “della negazione/empietà” (al-šukrān ḫ ilāf al-kufrān)36; e in tal modo insegna che šukr è un sinonimo di Islam37. Il suo appunto è luogo comune. Riflette la simile contrapposizione tra šukr e kufr (o kufrān) attestata varie volte nel Corano38 e richiama una versione 29 Fino a qui il celebre detto del Profeta. Ibidem, 282-283. 31 Cfr. Maqṣ ad, 115. 32 Dār al-bašāʾir al-islāmiyya, ed. Muḥ ammad Fuʾād al-Bāqī, Beirut 3a ed. 1409/1989, 85 (bāb man lā yaškuru al-nās). Cfr. anche Abū Dāwud, Sunan, kitāb al-adab, bāb šukr al-ma‘rūf, n. 4180, da Abū Hurayra. 33 Simile interconnessione compare in un altro detto celeberrimo: man lā yarḥ amu lā yurḥ amu, (“chi non ha misericordia non trova misericordia”), riportato anche nella versione leggermente più ampia, lā yarḥ amu Allāh man lā yarḥ amu al-nās, cfr. Maqṣ ad, 47-48, da Abū Sa‘īd. Entrambe le versioni presenterebbero una pari ambiguità di lettura, non fosse per l'insensatezza dei contenuti eventuali (la misericordia umana nei confronti di Dio). 34 Il detto, normalmente inteso in questa accezione, rappresenta un “incentivo morale” al ringraziamento degli altri. Sulla sua rilevanza anche nella contemporaneità, cfr. M. Piamenta, The Muslim Conception of God and Human Welfare. As Reflected in Everyday Arabic Speech, Brill, Leiden 1983, 20. 35 Lisān, 2305. 36 Lisān, ibidem. 37 Nel senso, appunto, di “corrispondere a Dio il dovuto” (cfr. il rapporto etimologico tra dīn, “religione” e dayn “debito”). L'empietà è il suo contrario, cioè “the denial of what is rightfully owed to God”, cfr. L. Sanneh, Gratitude and Ingratitude, 370. 38 Per esempio nella sura della Formica dove è detto: “Chi è grato (man šakara) lo è a proprio vantaggio, e chi è ingrato (o “miscredente”, man kafara) nessun danno può arrecare al Signore [...]”, 27,40). 30 estesa del detto profetico appena analizzato - lā yaškuru Allāh man lā yaškuru al-nās – la quale recita: “Raccontare i benefici ricevuti vuol dire essere grati (šukr) e tacerli vuol dire empietà (kufr), chi non è grato del poco non è grato del molto, chi non è grato agli altri non è grato a Dio, l'insieme è benedizione (al-ğamāʼa raḥ ma) mentre la porzione è castigo (al-firqa ʾaḏ āb)”. Questa lezione ampia è attestata innumerevoli volte nel Musnad di Ibn Ḥ anbal (m. 241/855), e, più o meno completa nelle sue parti, è ripresa da molti. La cita nella sua interezza, per esempio, un contemporaneo di Ibn Ḥ anbal, un autore tanto precoce quanto fecondo sull'argomento della condotta morale39, Ibn Abī al-Dunyā (m. 281/894) di Baghdad, in un opuscolo intitolato La gratitudine a Dio (Al-šukr li-llāh)40. E la riprende qualche decennio dopo Abū Bakr al-Harāʾiṭ ī (m. 326/939-40) in un'opera piuttosto simile alla precedente e intitolata L'Eccellenza della gratitudine a Dio per i suoi benefici (Faḍ īlat al-šukr li-llāh ‘alā ni‘ami-hi)41. Questi due lavori sono i più noti della classicità islamica sul presente argomento, insieme al Libro della pazienza e della gratitudine (Kitāb al-ṣ abr wa'l-šukr) di al-Ġazālī42 e al già citato Equipaggiamento dei pazienti, la provvista dei grati di Ibn Qayyim. C'è però qualche differenza evidente. Le opere di al-Ġazālī e Ibn Qayyim sono dedicate congiuntamente a gratitudine e pazienza, nel rispetto di alcuni passi coranici e del detto profetico: “La pazienza è metà della fede (īmān), la gratitudine è metà della fede, la certezza (yaqīn) è la fede tutta intera”43; e il loro contenuto è discorsivo sebbene costruito sul canone. Invece La gratitudine a Dio di Ibn Abī al-Dunyā e L'Eccellenza della gratitudine a Dio per i suoi benefici di al-Harāʾiṭ ī vertono sostanzialmente sul solo šukr, e il loro contenuto è interamente tradizionale. In entrambe, l'umana gratitudine al Signore è esemplificata per via di detti profetici sporadicamente sostenuti da citazioni coraniche, aneddoti o versi poetici che vedono protagonisti alcuni messaggeri pre-islamici, dotti e pii della prima età islamica e persone qualsiasi del cui esempio si è serbata la memoria. Poiché l'intero materiale è giustapposto e privo di commento44, ciascuna delle due piccole opere appare infine come una selezione operata da un autore, un'antologia che certo non risponde a criteri assoluti. Nondimeno esse si prestano a esemplificare la più antica letteratura tradizionistica sul tema della gratitudine. 4. Ibn Abī al-Dunyā e la gratitudine a Dio Leggendo il lavoro di Ibn Abī al-Dunyā – come quello di al-Harāʾiṭ ī - si nota subito che la sovrapposizione dello šukr umano a quello divino è evitata, e che è data per scontata l'unilateralità 39 Come ricorda L. T. Librande, Ibn Abī al-Dunyā. Certainty and Morality, in “Studia Islamica” 100/101 (2005), pp. 5-42 (questo lavoro verte sul Kitāb al-yaqīn). 40 Ed. Muḥ ammad Basyūnī Zaġlūl, Muʾassasat al-kutub al-ṯ aqāfiyya, Beirut, 1a ed. 1413/1994, 31 (n. 63), da Nuʾmān ibn Bašīr. Questo testo è brevemente considerato da A. K. Reinhart in uno studio dal titolo Before Revelation. The Boundaries of Muslim Moral Thought, State University of New York Press 1995 (vedi 119) che però, per l'argomento dello šukr, considera specialmente la discussione dello šukr al-munʼim presso i teologi dialettici (alĞuwaynī, al-Ġazālī e al-Shahrastānī, cfr. 106-120). 41 Titolo completo: Faḍ īlat al-šukr li-llāh ‘alā ni‘ami-hi wa mā yaǧ ibu min al-šukr li-al-mun‘im ‘alay-hi wa mā fī ḏ ālika min al-ṯ awāb, ed. Muḥ ammad Muṭ ī‘ al-Ḥ āfiẓ , Dār al-fikr, Damasco 1402/1982. Cfr. ancora Reinhart, nuovamente in Before Revelation, 118-119. 42 Si tratta del capitolo XXXII dell'Iḥ yāʼ, oggetto di una recente traduzione corredata da introduzione e annotazione scientifica, alle quali si rimanda: H. T. Littlejohn, Al-Ghazālī on Patience and Thankfulness. Kitāb al-ṣ abr wa'l-shukr - Book XXXII - of The Revival of the Religious Sciences. Iḥ yāʼ ʼulūm al-dīn, The Islamic Texts Society, Cambridge (UK), 2010. Il capitolo è diviso in due parti e la seconda, dedicata appunto alla gratitudine, si divide a sua volta in tre sezioni: 1. sulla sostanza dello šukr (63-118), 2. sua applicazione (119-188), 3. rapporto tra pazienza e gratitudine (189-224). Sulla tripartizione dello šukr in conoscenza o ‘ilm, “condizione [ottimale]” o ḥ āl e azione o ‘amal proposta altrove da al-Ġazālī cfr. anche Giese, ukr, 516. 43 Riportato anche da Ibn Abī al-Dunyā, Al-šukr, 30 (n. 57) da al-Muġīra. Cfr. ad esempio al-Ṭ abarī, Ğāmi‘ albayān, 30 voll., Beirut 1412/1992 (rist. an. della 1a ed. 1323h), vol. XXII, 53 (comm. a Cor. 31,31). 44 Per Ibn Abī al-Dunyā è cosa consueta; cfr. J.A. Bellamy, The Makārim al-Akhlāq by Ibn Abī'l-Dunyā (A Preliminary Study), in “The Muslim World”, 53(1963), 106-119, dove l'autore segnala il Makārim al-aḫ lāq (dedicato alle virtù, tra le primissime opere arabe sull'argomento, ed. Mağdī Fatḥ ī al-Sayyid Ibrāhīm, Maktabat al-Sāʾī, Būlāq s.d.) come eccezione alla regola. della gratitudine45; quando si tratta del comportamento di Dio non si parla mai di šukr o gratitudine ma di niʼma, “grazia” o “dono”, e niʼam, “benefici”. D'altra parte l'autore non ha alcuna intenzione di inserirsi nel dibattito teologico sui Nomi - il loro rapporto con l'essenza di Dio o l'eventuale somiglianza con le virtù umane - che pure non fu estraneo ai contemporanei di Baghdad. Il suo scopo è istruire sulla sostanza e le modalità della condotta buona, qui come altrove: cos'è, nella vita vissuta, lo šukr? quali sono i suoi modi, i suoi tempi? come essere certi di avere corrisposto a Dio il dovuto? Cosa significa šukr nella pratica è presto detto. È lodare Dio, dichiarare al-ḥ amdu li-llāh46, continuamente47 e soprattutto per l'avvento del Profeta e dell'Islam perché, come affermò l'omayyade ʾAbd al-Malik ibn Marwān (m. 86/705), nessun discorso di gratitudine è più dolce ed eloquente di “sia lode a Dio per averci beneficato e guidato sulla via della Religione”48. Alla domanda “per cosa essere grati?” la risposta è ampia, anzi assoluta, perché ogni cosa è grazia, il cibo e le bevande49, gli abiti nuovi50, il corpo di cui l'uomo è dotato, le mani e i piedi, gli occhi51, la lingua52, il volto53, la respirazione54. Merita gratitudine anche la capacità d'essere grati. Come cantò il poeta gnomico Maḥ mūd al-Warrāq (m. ca. 225/840), “se la mia gratitudine per la grazia di Dio è a sua volta una grazia (niʼma), per una grazia simile dovrò essere grato./ Nel succedersi dei giorni, nell'esistenza che perdura, la gratitudine è raggiunta solo per favore Suo (illā bi-faḍ li-hi)”55. Quando Mosè chiede a Dio quale sia la migliore gratitudine, Dio risponde: “Essere grato in ogni caso (ʼalā kull ḥ āl)”56; e infatti occorre formulare sempre la propria gratitudine a Dio perché l'intero tempo della vita è dono, ogni momento, felice o infelice. Per comprenderlo, “guardate chi sta peggio (man huwa taḥ ta-hu) e non guardate chi sta meglio (man huwa fawqa-hu)”, come consigliò il Profeta57. Infatti dotto è colui che non sa (lā yadrī) se la grazia stia in ciò che gli capita di bene o in ciò che non gli capita di male58. Anche nel libro di Ibn Abī al-Dunyā compaiono riferimenti occasionali alla pazienza o ṣ abr. Il che è ovvio e inevitabile perché, molto semplicemente, l'insieme di pazienza e gratitudine è richiesta a tutti i fedeli, qualunque sia il loro credo, dalle vicende alterne della vita. Da parte dell'Islam, un detto profetico ricordato nella Gratitudine a Dio riassume in un lampo l'etica della virtù secondo questa religione: “Chi è afflitto porti pazienza, chi riceve doni sia grato, chi patisce 45 A parte, forse, un unico caso ambiguo. Dio ispira a Mosè: “Ricordami molto affinché tu possa meritare la gratitudine (ḥ attā tastawǧ iba al-šukr) e completare l'aumento [di grazia] (wa tastakmila al-mazīd)”, Al-šukr, 64 (n. 161). 46 Ibidem, 42 (nn. 102-104). 47 Ibidem, 23-24 (n. 39) da ʾAbd Allāh ibn Salām: Mosè chiede al Signore qual è la forma della gratitudine che più Gli conviene. Rispose: “Che la tua lingua non smetta di ricordare Me”. Cfr. 21 (n. 33). 48 Ibidem, 13 (n. 10, cfr. n. 9), da Ḥ asan al-Baṣ rī: Il Profeta - Dio preghi per lui e gli dia pace - udì un uomo che diceva: “Sia lode a Dio per l'Islam”. “Tu sei grato per un beneficio immenso” (niʼma ʼaẓ īma), - osservò. Cfr. ibidem, 23 (n. 38, da Abū Ṭ alḥ a): Il Profeta incontrò un uomo che lo salutò. “Come stai?” - gli chiese il Profeta. Rispose: “A te lodo Dio e a Dio lodo te”. Il Profeta pregò per lui […]; cfr. anche 63 (n. 158). 49 Ibidem, 15 (n. 15) da Abū Hurayra; cfr. 33-34 (nn. 69-72), 66-67 (nn. 166 e 167) e 78 (n. 203, riferito a Noè e al suo epiteto di ʼabd šakūr in Cor. 17,3). 50 Ibidem, 26 (n. 48), 34-35 (nn. 74 e 75), 97-98 (nn. 40-41). 51 Cfr. Cor. 16,78: “Dio vi ha fatto uscire dal ventre di vostra madre impotenti e ignoranti e vi ha dato l’udito, vi ha dato la vista e il cuore perché un giorno lo poteste ringraziare”. 52 Ibidem, 41-42 (nn. 100 e 101). 53 Ibidem, 59-60 (n. 146) da Anas ibn Mālik: “Quando il Profeta si guardava allo specchio diceva: Sia lode a Dio che mi ha fatto regolare e proporzionato (sawā-nī, ʼaddala-nī), che ha reso nobile e bello il mio volto [...]”; simile 69 (n. 173). 54 Ibidem, 50-51 (n. 117) da Abū Ayyūb al-Qurašī: “Chiese Davide: Signore, qual è il dono più piccolo che mi hai fatto? Disse: Respira! Respirò, ed Egli disse: Ecco il dono più piccolo che ti ho fatto”. 55 Ibidem, 36 (n. 82), cfr. 49 (n. 110). 56 Ibidem, 60 (n. 147). 57 Ibidem, 38-39 (n. 90) da Abū Hurayra; cfr. 77 (n. 200). Cfr. Ibn Ḥ anbal, Musnad, kitāb musnad al-anṣ ār, n. 20908, da Abū Ḏ arr al-Ġifārī. 58 Va in questo senso l'osservazione di un credente della prima ora, Ṣ āliḥ ibn Mismār (m. ante 50h), ibidem, 7677 (n. 199); cfr. 73 (n. 190). un torto perdoni e chi fa un torto chieda perdono”59. Se la pazienza è necessaria, la gratitudine è necessaria ugualmente a chi vuole evitare la disgrazia: “Dio provvede la Sua grazia a chi vuole, e a chi non è grato la rovescia in castigo”, disse Ḥ asan al-Baṣ rī (m. 110/728)60. Pertanto la grazia va incatenata o messa in ceppi (cfr. qayyada) con lo strumento della gratitudine, come suggerì un altro califfo omayyade, ʾUmar ibn ʾAbd al-ʾAzīz (m. 101/720)61. La plasticità dello šukr è fuori discussione, e anche il suo senso apotropaico. Venendo ora alla distinzione tra il comportamento di Dio e quello dell'uomo nel materiale proposto da Ibn Abī al-Dunyā, essa spicca nei racconti sulla quantità impareggiabile della grazia divina; ad esempio è riportata questa esclamazione del profeta Davide, una grande figura coranica della riconoscenza (cfr. 7,144): “Dio mio, se tutti i capelli che ho in testa avessero due lingue, e ogni lingua, notte e giorno, cantasse le Tue lodi, non avrei ripagato uno solo dei Tuoi benefici (niʼam)”62. Ma – insegna tra le righe questa silloge - l'abbondanza dei benefici divini non deve avvilire il fedele che sa di non poterli ricambiare. Un detto di Sulaymān al-Taymī (m. 143 h) è esplicito: “Dio ha beneficato (anʼama) i servi a misura Sua e ha richiesto loro la gratitudine secondo la loro capacità”63. Le rassicurazioni sono continue, ed è ripetutamente illustrata l'abitudine di Dio che compensa oltremodo ogni piccola azione del servo64. ʾAlī ibn Abī Ṭ ālib (m. 40/661) disse che “la grazia è legata alla gratitudine, la gratitudine ha a che fare con l'accrescimento (mazīd) e le due cose procedono insieme (maqrūnāni fī qarnin)”65; ed è altrettanto eloquente questa conversazione sulla grazia inesauribile tra Abū ʾAqīl (m. 12 h) e tale Bakr ibn ʾAbd Allāh, dove la gratitudine umana è ridotta alla formula proferita. Il primo dichiarò: “Ogni volta che il servo dice al-ḥ amdu li-llāh, gli spetta un beneficio”. L'altro chiese: “E come ripaga quel beneficio?” “Dicendo nuovamente al-ḥ amdu li-llāh – rispose, - dopodiché gli arriva un altro beneficio. I doni di Dio non hanno fine”66. Simile concatenazione di lodi umane e doni divini figura nella densa preghiera, significativa soprattutto nel finale, che Ḥ asan al-Baṣ rī formulava prima di darsi all'attività esegetica: “Sia lode a Dio nostro Signore, Dio sia lode a Te, che ci hai creato, beneficato e guidato sulla via, che ci hai insegnato, salvato e sollevato dalle avversità, sia lode a Te per l'Islam e il Corano, sia lode a Te per la nostra famiglia, il nostro denaro e la salute ritrovata, a Te che ci hai dato – davvero! - ogni cosa che Ti abbiamo chiesto […]. Tu sia lodato per ogni Tuo dono vecchio e nuovo, segreto e risaputo, particolare e generale, nel vivo e nel morto, nel presente e nell'assente, sia lode a Te perché Tu sia soddisfatto (ḥ atta tarḍ ā), sia lode a Te quando sarai soddisfatto (iḏ a raḍ ayta)”67. Ma i luoghi di maggiore interesse didascalico nel lavoro di Ibn Abī al-Dunyā restano quelli sui profeti. Un esempio è il dialogo tra Dio e Mosè, una figura che il Corano cita nel contesto della gratitudine (cfr. 34,13): “Signore, – disse Mosè - cosa può fare Adamo per ripagare in gratitudine (an yuʼaddiya šukran) quello che hai fatto per lui? Lo hai creato con la Tua mano, hai soffiato in lui del Tuo spirito, gli hai dato asilo nel Giardino e hai fatto prosternare gli angeli davanti a lui”. “Mosè, – rispose il Signore - lui seppe (ʼalima) che tutto questo gli veniva da Me, per questo Mi lodò, e tanto bastò a ripagarmi (kāna […] šukran) di quello che avevo fatto per lui”68. Il detto che Man ibtalā fa-ṣ abara wa uʼṭ iya fa-šakara wa ẓ ulima fa-ġafara wa ẓ alama fa-istaġfara, ibidem, 65-66 (n. 164) da Saḫ bara (cfr. 31, n. 64, e 66, n. 164). Cfr. ad esempio al-Ṭ abarī, Ğāmi‘, vol. XIII, 123 (comm. a Cor. 14,5): “Com'è buono il servo che pazienta quando è afflitto (iḏ ā ibtalā ṣ abara) ed è grato quando riceve (iḏ ā uʼṭ iya šakara)”. 60 Ibidem, 16 (n. 17); cfr. 30 (n. 60) e 36 (nn. 80-81). In altri termini, non c'è rifugio da Dio se non in Dio, come afferma il Corano stesso (9,118); vedi anche Ibn Qayyim attorno all'espressione “mi rifugio in Te da Te” (aʼūḏ u bi-ka min-ka), ‘Uddat al-ṣ ābirīn, 279, nel contesto della riflessione sui Nomi ṣ abūr e šakūr (cap. XXVI). 61 Ibidem, 19 (n. 27); cfr. 32 (n. 66). 62 Ibidem, 18 (n. 25) da Ḥ asan al-Baṣ rī. 63 Ibidem, 12 (n. 8). La traduzione non segue l'edizione, che invece porta qadyuri-him. 64 Ad esempio, compare due volte Cor. 14,7 (“Se Mi sarete grati aumenterò per voi la Mia grazia […])”, cfr. ibidem, 11 (n. 3) e 29 (n. 56). 65 Ibidem, 16 (n.18). 66 Ibidem, 12 (n. 7); cfr. 41 (n. 98). 67 Ibidem, 13 (n. 11). 68 Ibidem, 14 (n. 12) da Ḥ asan al-Baṣ rī. 59 precede richiama un'idea ormai familiare, cioè l'andirivieni dei doni che Dio e l'uomo si indirizzano a vicenda, l'offerta reciproca e in qualche modo sempre compensativa che forma la sostanza della gratitudine: se Dio colma l'uomo di grazia e benefici (niʼma, niʼam), ebbene, l'uomo può offrire in grato contraccambio la propria esistenza, la propria presenza fisica nel mondo, fonte di appagamento per il Signore purché sia sostenuta dall'umana consapevolezza (ʼilm) di sé e delle proprie offerte scarse contro la ridondanza dei doni ricevuti. E' chiaro in questo senso un racconto che vede ancora protagonista Davide, racconto fondato contemporaneamente sullo scambio reciproco dei doni e sulla conoscenza quale forma sufficiente di gratitudine: “Signore – disse Davide, - come esserti grato se ottengo d'esserti grato solo per Tua grazia”? Dio gli ispirò: “Non sai (taʼlamu) che i doni che hai ti vengono da Me?” “Certo” - rispose. “E Io lo accetto quale gratitudine che viene da te (innī arḍ ā šukran min-ka)”, disse Dio69. Proprio il re e profeta Davide che Dio beneficò con l'abilità metallurgica – nulla di più concreto, - Davide che nel Libro dell'Islam incarna il servo dimentico del Signore ma che, dotato di scienza (ʼilm), si accorse della sua pochezza e pentito si prosternò (cfr. specialmente 34,10-11 e 38,24)70 funziona nel lavoro di Ibn Abī al-Dunyā come figura di ammonimento, e di consolazione per il credente maldestro. Sviluppando il tema coranico degli uccelli che pregavano con lui (cfr. 21,79 e 38,19), La gratitudine a Dio narra che mentre egli si trovava nel tempio gli passò accanto un uccellino raro (durra); Davide lo osservava, meditava sulle sue forme e si meravigliava, quando l'uccellino parlò: “Ti meravigli, Davide? Eppure la mia gratitudine a Dio per il Suo favore (faḍ l) a me è maggiore della tua per il Suo favore a te”71. Secondo un altro racconto, Davide si illudeva (ẓ anna) che nessuno al mondo lodasse Dio meglio di lui. Mentre era seduto nel tempio, a fianco lo stagno, discese un angelo che gli chiese se capiva il gracidio della rana. Davide fece attenzione e si accorse che l'elogio della rana era migliore del suo. “E allora Davide, - gli chiese l'angelo, - hai capito le parole della rana?” “Sì” – rispose. “E cos'ha detto?” “Ha detto: Sia gloria a Te, nella Tua lode sta il sommo grado della sapienza (muntahā al-ʼilm)”72. Dunque, se è vero che nel materiale di tradizione selezionato da Ibn Abī al-Dunyā manca il richiamo manifesto allo šukr di Dio per l'uomo – richiamo chiaro nel Corano, ripreso dalle opere lessicografiche e meditato da alcuni ingegni sottili - è anche vero che una divina gratitudine nel senso proprio di šukr cioè benefica attività che risponde a un beneficio ricevuto, accrescendolo, occhieggia qua e là attraverso l'idea, già coranica73, di soddisfazione o accettazione da parte di Dio (al-riḍ ā, riḍ wān)74; soddisfazione, specialmente, per la conoscenza o ʼilm che l'uomo sa manifestare a Lui. 5. Al-Harāʼiṭ ī e la gratitudine come dovere sociale 69 Ibidem, 11-12 (n. 5) ancora da Abū al-Ǧ ald; con uno scambio di personaggi (Mosè al posto di Davide) questo racconto compare quasi negli stessi termini anche nel Kitāb al-ṣ abr wa'l-šukr di al-Ġazālī; vedi anche Giese, ukr, 516. Cfr. 12 (n. 6) da Abū al-Ǧ ald: “Signore – disse Mosè, - come esserti grato se il mio operato intero non può ripagare il più piccolo dei Tuoi doni?” Dio gli ispirò: “Mosè, adesso mi sei grato (alʼāna šakarta-nī)” 70 Vale la pena di ricordare in questo contesto il rapporto che lega Davide alla cosiddetta “prosternazione del ringraziamento” o sağdat al-šukr, da effettuarsi, seguendo l'esempio di Muhammad, ad ogni buona notizia ricevuta; come ricorda tra gli altri al-Nisāʾī, Sunan, kitāb al-masāğid, n.118, da Ibn ‘Abbās, commentando la prosternazione richiesta dalla sura Ṣ ād (Cor. 38) il Profeta disse: “Davide la eseguì in segno di pentimento (sağada-hā […] tawba), noi la eseguiamo in segno di gratitudine (nasğidu-hā šukran)”. 71 Ibidem, 22 (n. 35, da Ṣ adaqa ibn Sufyān). Il passo riecheggia, però con tutt'altri toni, il corposo racconto sulla tentazione di Davide già citato nel Tafsīr di Muqātil ibn Sulaymān (m. 150/767), cfr. Dār al-kutub al-‘ilmiyya (3 voll.), ed. Aḥ mad Farīd, Beirut 1424/2003, III,116 (comm. a Cor. 38,24), poi variamente ripreso da altri, ad es. al-Ṭ abarī da al-Suddī, Ḥ asan al-Baṣ rī e Wahb ibn Munabbih, cfr. Ğāmi‘, vol. XXIII, 95 (sempre su 38,24): Davide promette al Signore di eguagliare la pietà di Abramo e Mosè; mentre prega, un uccello variopinto gli vola accanto; cerca di afferrarlo e nota una donna al bagno; la desidera e quindi trova il modo di eliminare il marito di lei per poterla sposare. 72 Ibidem (n. 36) da Anas ibn Mālik. 73 Cfr. per esempio 39,7: “Se invece avete gratitudine per Lui, Egli la accetterà da voi”. 74 Sull'entità del possibile appagamento di Dio, cfr. un altro racconto su Davide, ibidem, 22-23 (n. 37) da Sufyān ibn Saʾīd. Esclamò: “Sia resa lode a Dio come conviene al Suo nobile volto, il mio Signore, sia esaltata la sua gloria”. Dio gli ispirò: “Davide, hai seguito l'esempio (tabaʼta) degli angeli. Al-Harāʾiṭ ī dedica la parte finale della sua opera sulla gratitudine a Dio alla gratitudine che gli uomini si devono l'un l'altro75 e così, sebbene in extremis, insegna la stretta correlazione tra le due cose76. Il suo criterio può riassumersi così: proprio perché è un modo di Dio, lo šukr dev'essere un modo dell'uomo virtuoso, non solo verso Dio ma anche e contestualmente verso il fratello. Dopo aver citato a sua volta “lā yaškuru Allāh man lā yaškuru al-nās” e averne notato l'ambiguità di lettura, questo autore mostra di propendere per il senso tutto umano del detto in questione perché riporta subito, sempre dal Profeta, che “gli uomini più grati a Dio (aškaru al-nās li-llāh) sono quelli più grati agli uomini (aškaru-hum li-al-nās)”77. E in tal modo inaugura un percorso sulla gratitudine come dovere sociale. Secondo il materiale raccolto da al-Harāʾiṭ ī, “il contrassegno della gratitudine dell'uomo (ʼalāmat šukr al-marʼ) è divulgare la propria gratitudine (iʼlān al-šukr)”78. Per converso, “il peggior discorso è quello che nega il beneficio ricevuto (taǧ dīf)”79. E mettere gli altri a conoscenza del bene ricevuto da qualcuno è già un corrispettivo adeguato per quel bene: “Chi riceve un beneficio (maʼrūf) lo contraccambi e, se non può farlo, lo menzioni agli altri (ḏ akara-hu), poiché insegnò il Profeta - fare memoria di un beneficio significa essere grati per esso”80. Secondo un detto non troppo dissimile, “quando ricevete un beneficio contraccambiatelo al benefattore e se non potete invocate Dio per lui fino a quando saprete (ḥ attā taʼlamū) che glielo avete contraccambiato”81, cioè, in altre parole, fino a quando Dio vi darà conoscenza (ʼilm) di avere accolto la vostra supplica e di avere ripagato il fratello in vece vostra. Arguto, e sulla stessa linea, è il seguente motto di Fuḍ ayl ibn ʾIyāḍ (m. 187/803): “Ci sono due cose. La prima non la venderei per nulla al mondo, ed è che gli altri mi dicano: Hai fatto bene (aḥ santa), perché se dai a qualcuno mille dīnār e quello ti dice: Hai fatto bene, che Dio ti ripaghi in bene ( ǧ azā-ka Allāh ḫ ayran), costui ti ha dato più di quello che ha preso. La seconda non la comprerei per nulla al mondo, ed è che gli altri mi dicano: Hai fatto male”82. In questi racconti, è come se la gratitudine dell'uomo e quella di Dio si confondessero in un unico gesto, visto che il ringraziamento dell'uomo al benefattore suscita l'azione benefica di Dio la quale, beninteso, è aumentativa per natura. Tra i molti aneddoti ripresi da al-Harāʾiṭ ī a tale proposito, c'è il consiglio di Ǧ aʾfar al-Ṣ ādiq (m. 148/765) a un amico: “Sii grato a chi ti benefica e benefica chi ti è grato; il beneficio ringraziato non si consuma, mentre, se non si è grati, esso non perdurerà; la gratitudine aumenta il bene e tiene al riparo dai mutamenti della sorte (cfr. amān min al-ġiyar)”83. Si ritrova così, tradotta in regola dei rapporti umani, la circolarità dello šukr, quella concatenazione dei doni che già caratterizzava la gratitudine tra l'uomo e Dio84. Come si è osservato sopra, lodare Dio per i Suoi doni dichiarando “al-ḥ amdu li-llāh” è un'alta forma della gratitudine creaturale. E quel che il credente deve a Dio lo deve, mutatis mutandis, anche al fratello benefattore. Un distico composto dallo stesso al-Harāʾiṭ ī recita: “Se mai un nobile (māǧ id) potesse fare a meno d'essere ringraziato (cfr. šukr) per la magnificenza dei suoi possedimenti o l'altitudine della sua condizione,/ Dio non avrebbe ordinato ai Suoi servi d'essere grati a Lui dicendo: siate grati a Me, voi due, uomini e ǧ inn (cfr. ayyuhā al-ṯ aqalāni)”85. Faḍ īlat al-šukr, 61-69 (faṣ l: mā yağibu ‘alā al-nās min al-šukr li-l-mun‘im ‘alay-hi) e 70-71 (faṣ l: mā ḏ ikru-hu min kufr al-ṣ anī‘a). 75 Quattro secoli dopo sarà seguito molto da vicino dal giurista ḥ anbalita Ibn Mufliḥ (m. 763/1361), Al-ādāb alšar‘iyya, ed. Šu‘ayb al-Arnaʾūṭ e ‘Umar al-Qayyān, 3 voll., Muʾassasat al-risāla, Beirut 3a ed. 1419/, cfr. soprattutto I, 330-335 (faṣ l man lam yaškur al-nās lā yaškuru Allāh). 77 Faḍ īlat al-šukr, 61 (n. 79), da Ašʾaṯ ibn Qays; Al-ādāb, 331, dallo stesso garante. 78 Ibidem, 63 (n. 84) nei versi di Muḥ riz ibn al-Faḍ l. 79 Ibidem, 70-71 (n. 105), un'opinione del Seguace, ebreo convertito, Kaʾb al-Aḥ bār (m. 32h). 80 Ibidem, 62-63 (n. 83) da ʾĀʾiša; cfr. 65 (n. 92) e 80 (n. 103); Al-ādāb, 331-332. 81 Ibidem, 63 (n. 85), da Ibn ʾUmar; cfr. “chi riceve un beneficio e non ha trovato altro da dare in cambio che invocazione ed elogio, ha contraccambiato”, ibidem, 64 (n. 86) da ʾĀʾiša; cfr. anche 65 (n. 89). 82 Ibidem, 68 (n. 99). Cfr. Al-ādāb, 331: “Il più bell'elogio è dire: Dio ti ripaghi in bene ( ǧ azā-ka Allāh ḫ ayran)”. . 83 Ibidem, 66-67 (n. 94). 84 Sullo scambio reciproco e continuo della gratitudine, cfr. il detto di Ǧ aʾfar al-Ṣ ādiq taciuto da al-Harāʾiṭ ī ma ricordato da Ibn Mufliḥ : “Per me, nulla è più dolce di una mano a cui ne segue un'altra”, Al-ādāb, 335. 85 Ibidem, 65 (n. 91). Per l'espressione ayyuhā al-ṯ aqalāni, lett. “voi due che avete peso”, applicata alle due 76 La stessa coincidenza di šukr e Islam - e del loro contrario, l'ingratitudine/empietà (kufr, kufrān) già considerata nella sua applicazione allo šukr dell'uomo verso Dio, ricompare ora, nel resoconto tradizionale di al-Harāʾiṭ ī, per lo šukr dell'uomo al fratello: “Chi riceve un beneficio e non trova altro da corrispondere che l'elogio (ṯ anāʼ) – spiegò il Compagno Ṭ alḥ a ibn ʾUbayd Allāh (m. 36/656), - allora elogi, e sarà stato grato; invece sarà stato ingrato (o empio, kafara) se avrà taciuto quel beneficio”86. Un altro esempio è offerto dalle seguenti parole del Profeta: “Vi sono dei servi ai quali, nel giorno della resurrezione, Dio non rivolgerà la parola”. “Chi sono?” - chiesero. Rispose: “Chi rinnega (tabarraʼa) i propri genitori […], chi rinnega il proprio figlio, e chi riceve un beneficio da altri e poi disconosce (kafara) il loro beneficio e li rinnega87. Un'ultima ma non meno rilevante forma della gratitudine creaturale figura in un racconto della celebre Asmāʾ bint Yazīd ibn al-Sakan (m. 30h), “la predicatrice delle donne” (ḫ aṭ ībat alnisāʼ) nella primissima era islamica: “L'Inviato di Dio passò da noi, e c'erano con me delle donne […]; io ero sposata, e loro delle concubine. Quando lo videro, si sedettero stringendosi l'una all'altra. Disse: Guardati tu, figlia di Sakan, e guardatevi voi dal rinnegare il benefattore. Chiesi: Per mio padre e mia madre, cosa significa rinnegare il benefattore (kufr al-munʼim)? Rispose: Poniamo che un uomo venga da voi e, con il suo denaro, liberi una di voi dalla sua condizione, e che lei, grazie a lui, si procuri un marito, e poi, per questo, si adiri con lui e dica: Lo giuro su Dio, da te non ho ricevuto beneficio alcuno! Guardatevi dunque dal rinnegare il benefattore”88. Conclusioni Riassumiamo e concludiamo. Il Corano insiste sull'alterità del divino e tuttavia istituisce una palese correlazione tra la gratitudine del credente a Dio e quella di Dio al credente, applicando in entrambi i casi il medesimo lessico, cioè i derivati della radice škr, ivi compresa la voce intensiva šakūr. Il ricorso alla lessicografia antica consente di specificare i contenuti della radice in questione, e di distinguere šukr o “gratitudine” da ḥ amd o “lode”: nella gratitudine si contano contemporaneamente l'aspetto materiale (cfr. “[...] illā ‘an al-yad”), la componente dichiarativa e divulgativa (cfr. ṯ anā’ e našr) e il carattere incrementativo (cfr. ziyāda, muḍ āʼafa), mentre la lode è anzitutto verbale. Tali contenuti figurano nel pensiero tradizionale - qui specialmente esemplificato dal lavoro di Ibn Abī al-Dunyā e di al-Harāʾiṭ ī – con qualche scelta di campo. In primo luogo, nella palese volontà di distanziare la prassi divina da quella umana, la radice škr è applicata solo alla gratitudine dell'uomo, risposta modesta ai sovrabbondanti doni di Dio (niʼma, niʼam), mentre la gratitudine divina è trasformata in un più astratto “gradimento”, compiacimento o appagata accettazione (al-riḍ ā, riḍ wān). Non così accade nella riflessione teologica - qui esemplificata dalle figure di al-Ġazālī e Ibn Qayyim - che invece continua a legare l'operato umano a quello divino, insiste sulla gratitudine quale elemento di raccordo tra il creatore e il credente virtuoso, e così raccoglie le allusioni coraniche a un circolare andirivieni della gratitudine. In secondo luogo la letteratura tradizionistica, conformemente al proprio carattere soprattutto operativo, si concentra sull'aspetto pragmatico della gratitudine, facendo coincidere lo šukr con l'atto devozionale nella sua esecuzione anche fisica (ṭ āʼa, ʼibāda) e per lo più identificando gratitudine e lode (ḥ amd). Quanto allo šukr che gli uomini si devono l'un l'altro, esso è presentato come parte integrante dell'obbligo religioso di servitù, un'estensione tutta terrena della gratitudine dovuta a Dio; cosicché lodare ed elogiare il fratello per ogni beneficio proveniente da costui equivale comunque a ringraziare il Signore per i Suoi doni innumerevoli. Si tratti di Dio o del fratello benefattore, la tradizione sottolinea nondimeno l'elemento cognitivo (cfr. l'impiego frequente della radice ʼlm) e insegna che la gratitudine poggia sulla piena consapevolezza della gratifica ottenuta. Secondo l'insegnamento del pensiero tradizionale islamico, dunque, il credente virtuoso è chi, sapendo bene specie responsabili delle loro azioni, cfr. Cor. 55,31. 86 Ibidem, 65 (n. 88). Ibn Mufliḥ aggiunge: “Quanto a chi si fa bello di un beneficio che non ha ricevuto, costui è come chi veste due abiti menzogneri”, Al-ādāb, 332. 87 Ibidem, 70 (n. 102), da Anas; cfr. 70 (n. 104); cfr. Al-ādāb, 333. 88 Ibidem, 71 (n. 106); cfr. Al-ādāb, sempre 333, tutto costruito sull'ingratitudine al marito. il debito contratto con Dio, vi corrisponde anche, davanti a Dio, saldando i debiti con la società umana. Cos'è il potere, di chi è? Prendiamo avvio, come sempre occorre fare in questo contesto culturale, dalla scrittura sacra dei musulmani la “Recitazione araba”, il Corano. Se formuliamo le domande fondamentali a proposito del potere, e cioè: che cos'è il potere, e di chi è il potere, troviamo una risposta immediata già nelle parole di apertura di questo Libro, nella prima sura o capitolo, detta Fātiḥ a, l'Esordio. Questa sura recita: Nel nome di Dio, il clemente, il compassionevole. Sia lodato Dio, il signore dei mondi, il clemente, il compassionevole, Re del giorno del giudizio. Te adoriamo, Te chiamiamo in aiuto. Guidaci alla diritta via, la via di quelli che hai colmato di grazia, non quelli che ti fanno adirare, non quelli che errano. Il potere è dunque, categoricamente, di Dio, il quale è “il signore dei mondi”, ha autorità e potestà su ogni comunità creata, e su un tempo – il giorno del giudizio - che non è semplicemente un punto cronologico finale ma la definitiva resa dei conti, un tempo che riassume e ricapitola l'intera vicenda creaturale. A questo potere sull'intera storia del creato sta di fronte, corrisponde l'adorazione delle creature – ricordiamo: “Te adoriamo” - là dove questa adorazione è ubbidienza e atto devozionale (‘ibāda in arabo), nonché riconoscimento del sostegno che Dio offre, riconoscimento del divino intervento salvifico – ricordiamo: “Te chiamiamo in aiuto”. Questo supremo Re “del giorno del giudizio” - o, secondo un'altra lettura possibile, supremo Padrone – si configura non come despota o tiranno ma come l'unico possibile dispensatore di grazia, l'unica guida al bene, l'unica via al ravvedimento per la collettività e per il singolo; ricordiamo: “Guidaci alla diritta via”. E poiché è fonte di grazia – e di clemenza e di misericordia - Dio è oggetto di lode da parte delle creature; ricordiamo “Sia lodato Dio, il signore dei mondi”. L'insegnamento è dunque il seguente: il potere appartiene a Dio, e il riconoscimento di questa sua autorità comporta la salvezza dall'errore e dalla perdizione. E' un'idea di potere che ricorda molto il senso dell'espressione latina potis esse (da cui deriva l'italiano potere), che dice, appunto, capacità e sovranità ma anche cura, anche protezione dal male. Potremmo pensare anche a un altro termine latino etimologicamente prossimo all'italiano potere, cioè pater, che dice “padrone e il protettore della casa”, “colui che nutre la famiglia”, non fosse che l'idea di un Dio-padre è del tutto estranea alla mentalità islamica. Questa stessa idea di potere, che accorpa alla divinità la regalità e insieme la custodia, il dominio del creato e insieme la sua cura compassionevole, compare anche in un altro versetto, quello celeberrimo sui Nomi di Dio. E' la sura del Raduno: Egli è Dio, non c’è altro dio che Lui, conosce il mistero e il visibile, è il Clemente, il Compassionevole. Egli è Dio, non c’è altro dio che Lui, il Re, il Santo, la Pace, il Fedele, il Custode, il Potente, il Dominatore […] il Creatore, il Plasmatore, il Forgiatore. Egli ha i Bellissimi Nomi e ogni cosa nei cieli e sulla terra celebra le Sue lodi […] (59, 22-24). Sul rapporto tra il potere di Dio e il bene che procede dall'esercizio di questo potere e che solo questo potere consente, è altrettanto indicativo un altro versetto, nella terza sura: Di’: “O mio Dio! Padrone del Regno (mālik al-mulk)! Tu dai il Regno a chi vuoi, e strappi il Regno a chi vuoi, esalti chi Tu vuoi, umilii chi Tu vuoi: in mano Tua è il Bene (ḫ ayr), e Tu sei sopra le cose potente (qadīr)!” (3,26). Riassumendo, secondo il Corano e il pensiero islamico in generale, Dio è Re e Padrone (malik o mālik) perché governa, sostiene e custodisce il creato. L'ambito semantico, in arabo, è quello di mulk: regno, potestà, autorità, capacità di proteggere e di beneficare. Dobbiamo aggiungere ora che, essendosi Dio manifestato attraverso una Parola, il Corano appunto, riconoscere l'autorità divina e ubbidire a Dio significa ubbidire al Corano. Come si trasmette il potere Si è già parlato di califfato. Ma, a proposito della trasmissione del potere, il Corano risponde prima di tutto attraverso la figura di Adamo il primo uomo, che Dio creò perché fosse il Suo “califfo”, ḫ alīfa, letteralmente qualcuno “viene dopo” e che “fa le veci”; Dio chiese agli angeli che si prosternassero davanti alla neonata creatura e tutti ubbidirono tranne uno, Satana. A commento di questo segmento di storia sacra possiamo affermare che il potere è oggetto di diretta trasmissione da parte di chi lo detiene, visto che è Dio che ha nominato Adamo Suo califfo e gli ha donato autorità nel governare il mondo; e possiamo affermare anche, nella fattispecie, che il potere è una sorta di eredità, un dono divino. Chi non riconosce, chi non testimonia personalmente questo potere, nel caso di Adamo Satana, è sì un ribelle nella comunità, è sì un eversivo in senso sociale, ma è anche, e prima ancora, un eversivo sotto l'aspetto religioso, è non-islamico. E a margine di questo, osserviamo che, secondo il pensiero islamico, Satana è il contrario del musulmano, non il contrario di Dio; su questo potremmo ritornare. Passando alle definizioni, se il potere divino sul mondo è detto mulk, invece questo potere delegato, derivato da Dio, potere transitivo e tutto terreno di cui l'uomo è possibilmente depositario è detto nell'arabo coranico sulṭ ān. Il Corano attribuisce volentieri il sultan al profeta Mosè; in senso negativo, come abuso di potere, sulṭ ān è riferito più di una volta (14,22; 15,41) proprio a Satana. Il patto con Dio Abbiamo detto fino a qui che il potere (mulk) – cioè la guida al bene - è di Dio; e che Dio delega il potere, in una forma terrena detta sulṭ ān, a un suo vicario o luogotenente al quale è dovuta ubbidienza. Si è detto anche che il riconoscimento dell'autorità divina si dà attraverso l'adesione al Corano. Su questi medesimi temi, occorre segnalare un'altra idea coranica, quella del patto di Dio. Nella sura del Limbo, il Corano afferma che Dio stipulò un patto pre-eterno con l’intera umanità pensata come un'unica comunità di credenti. E' detto: Ricorda quando il tuo Signore prese dai lombi dei figli di Adamo i loro discendenti e li fece testimoniare contro se stessi: “Non sono Io il vostro Signore?” Risposero: “Sì, ne siamo testimoni”. Facemmo questo perché nel giorno della resurrezione non possiate dire: “Non ci siamo accorti di nulla” (7,172-173). A questo patto con l'umanità, che riconosce il dominio di Dio e il suo governo (questo il senso dell'arabo rabb che dice “Signore” in questo passo - si accosta un altro patto preeterno, che Dio stipulò con i profeti (mīṯ āq). Nella terza sura è detto: Ricorda quando Dio strinse un patto con i profeti: “Vi ho dato parte del Libro e della sapienza e poi vi sarà un messaggero inviato a confermare (cfr. ṣ addaqa) la rivelazione che possedete, dunque credete in lui e dategli sostegno. Confermate e accettate il Mio patto a questa condizione?” Ed essi risposero: “Lo confermiamo”. E Dio disse: “Testimoniate, e Io testimonierò insieme a voi” (3,81). Come abbiamo sentito, Dio stipula questo patto con i profeti in generale, dunque con tutti i suoi emissari di verità, i quali individualmente attestano, testimoniano, professano (cfr. šahāda) non soltanto la loro sudditanza al Signore, ma anche la loro perenne adesione a quell'ultimo messaggero – Muhammad – che confermerà le Scritture dei profeti suoi predecessori; lo farà con una Scrittura ultimativa che è il Corano stesso. E' come dire che dopo Adamo, considerato dalla tradizione il primo profeta dell'umanità, i detentori del potere per grazia di Dio sono i profeti, là dove, si noti, il potere dei profeti si regge su una delega rilevuta da Dio che ha la forma di una Scrittura Sacra; ricordiamo: “Vi ho dato parte del Libro [...]”. Cosicché ciascun profeta è un eletto da Dio, e la manifestazione terrena, la prova, l'incarnazione della suo statuto di eletto è proprio la parte di Libro che ciascun profeta ha ricevuto e possiede. E' un'idea molto forte di Libro, ed è proprio attorno al possesso del Libro che ruota il possesso lecito dell'autorità sugli altri. Il potere temporale si regge sul Libro, e spetta a chi conosce, divulga e fa rispettare la volontà di Dio. Fino a quell'ultimo Profeta, Muhammad, la cui Recitazione in arabo ricapitola, conferma e restaura in un unico Corano tutte le parti del Libro, cioè tutta la legittima autorità, di chi lo ha preceduto. Un Islam “laico”? E' una contraddizione in termini visto che l'Islam, in senso proprio, si intende come recisamente laico: se “laico” è il contrario di ecclesiastico e l'Islam – ameno quello sunnita - non conosce chiesa, e non conosce magistero. Alcuni intellettuali hanno però pensato a una politica senza Islam, relegando sostanzialmente l'Islam al privato o al coiddetto “foro interiore”. Tra i classici, certamente il tunisino Ibn Khaldun (m. 1406), che, basandosi sull'osservazione della storia, teorizzò una sociologia politica fondata sulla ciclicica alternanza di beduini e sedentari. Tra i moderni ‘Alī ‘Abd al-Rāziq (m. 1966) che nell'opera dal titolo L’Islam e i fondamenti del potere (Cairo 1925) avviò il discorso sulla possibile laicità dell’Islam, a suo avviso possibile in quanto intrinseca ai fondamenti della religione musulmana. Si tratta dunque della più celebre e riuscita teorizzazione dello stato laico nei paesi islamici. La sua teoria è però in evidente contrasto con le dottrine islamiche fondamentali e invece prossima agli assunti secolaristi occidentali (mai posti, però, a modello esplicito). Il peso dottrinario del pensiero di ‘Alī ‘Abd al-Rāziq è continuamente confermato dagli intellettuali arabi e dagli studiosi occidentali i quali trovano in L’Islam e i fondamenti del potere un’opera chiave nell’interpretazione del secolo appena concluso. Del resto, la forza riformatrice delle tesi contenute in L’Islam e i fondamenti del potere, tesi destabilizzanti per il sistema dottrinario e politico in una critica fase di evoluzione (caduta del califfato, colonizzazione, riforme istituzionali), si comprende bene alla luce delle polemiche successive: il cosiddetto “affare ‘Alī ‘Abd al-Rāziq” ebbe come risultato immediato l’espulsione dell’autore dal corpo insegnante dell’università di al-Azhar (la massima università islamica) e dal corpo dei giuristi, e come effetto ultimo una grave crisi politica in Egitto. La sovversione al potere divino: la figura di Iblis-Satana Come vedremo, nella figura satanica così come il Corano la attesta ricompaiono elementi già noti alle elaborazioni dei monoteismi precedenti, canoniche o apocrife; si tratta a volte quasi di una ripetizione. E' vero che dal punto di vista ebraico o cristiano, queste ed altre riedizioni di elementi tratti dalle Scritture ebraica e cristiana possono apparire a prima vista dei tentativi maldestri di copiatura; si deve però tenere presente che, dal punto di vista islamico, queste riedizioni sono invece sentite come una ripresa, da parte dello stesso Dio, di parole già dette ad altri popoli in altri tempi, parole che vengono ripetute in un senso nuovo e più vero, non solo parole successive nel tempo ma anche più corrette rispetto alle precedenti. Infatti, dal punto di vista islamico, le parole contenute e tramandate dal Corano derivano direttamente da Dio, non sono mediate da autori ispirati. Anche nel caso delle vicende di Satana, si tratta dunque di una storia già narrata da Dio, ma narrata, nel Corano, più correttamente. La figura diabolica fa una sua prima significativa comparsa nel Corano (“prima” in senso logico e non cronologico) con il nome di Iblìs (termine derivato probabilmente da diàbolos), in due racconti paralleli, l’uno contenuto nella settima sura del Corano, o sura del Limbo, coranica; e l’altro nella sura di al-Hijr, la quindicesima. E’ la scena primordiale: il Signore ha creato l’uomo a partire da argilla o da fango. Seguendo la Sua volontà, enunciata in precedenza agli angeli, ha creato qualcuno che che sarà sulla terra, il Suo vicario, il Suo luogotenente; qualcuno che sarà, in terminologia arabo-islamica, il Suo califfo. Chiede quindi agli angeli di prosternarsi di fronte a questa creatura e tutti ubbidiscono; unico tra tutti, l’angelo Iblìs rifiuta. Si recita appunto nella sura del Limbo che «si prosterarono tutti eccetto Iblìs» (Corano 7,11). La motivazione del rifiuto di Iblìs è subito resa nota nella stessa sura: «disse Iddio: ‘Che cosa ti ha impedito di prostrarti, quando Io te l’ho ordinato?’ Rispose: ‘Io sono migliore di lui, Tu hai creato me di fuoco e lui di fango’» (Corano 7,12; cfr. 38,76). La motivazione di Iblìs viene ribadita nella sura di al-Hijr: «Gli chiese Iddio: ‘Iblìs, che cosa hai tu che non ti prostri con gli adoranti in adorazione?’ Rispose: ‘Non sarà mai che io adori un uomo, che Tu hai creato da argilla secca, presa da fango nero impastato’» (Corano 15,32-33). Si noterà subito che la disubbidienza dell’angelo è effetto di un ragionamento, Iblìs ha messo a punto un sillogismo: l’angelo disubbidisce dato che il fuoco è migliore del fango, dato che egli è stato creato da fuoco e l’uomo da fango, e dunque egli è migliore dell’uomo. «Io sono migliore di lui», dichiara infatti l’angelo, spiegando così la sua disubbidienza (cfr. nuovamente Corano 7,12). Il percorso seguito da Iblìs nella sua disubbidienza ci illumina alcuni aspetti fondamentali della figura diabolica secondo il Corano, sui quali vorrei insistere. 1) Il primo aspetto è, naturalmente, la capacità di ragionamento; l’angelo mette a frutto una data conoscenza di cui è dotato, nella fattispecie una conoscenza circa la propria origine, cioè il fuoco, e circa l’origine dell’uomo, cioè il fango; e, inoltre, circa la sostanza e il valore di fuoco e di fangoagli occhi di Dio. Iblìs mette a confronto le due cose, le equipara, mette a punto un’analogia, e ne trae una nuova conoscenza, che è la superiorità dell’uno sull’altro. In tal modo, grazie alla sua conoscenza e alla sua capacità analogica, Iblìs formula un giudizio sull’ordine di Dio, ordine che discute e che, pertanto, non esegue. 2) Una domanda importante a questo punto è la seguente: Iblìs è il solo a conoscere, a conoscere se stesso e le altre creature? Ed è il solo capace di trarre da queste conoscenze delle conoscenze nuove, giovandosi dell'impiego dell'analogia? Oppure, al contrario, la sua conoscenza circa la sostanza e il valore delle cose create è condivisa dai suoi simili, condivisa dalle altre creature angeliche, anch’esse capaci di formulare giudizi sull’operato di Dio? La risposta corretta è quest’ultima: la conoscenza di Iblìs è una conoscenza condivisa. Basti pensare a un episodio riportato nella seconda sura, la sura della Vacca, dove Dio comunica agli angeli la volontà di creare l’uomo, e gli angeli sanno già che l’uomo porterà la corruzione sulla terra e spargerà il sangue; e dsanno invece d'essere, a differenza dell'uomo, pii, votati all’ubbidienza e santi per intrinseca costituzione; per questo chiedono a Dio ragione del Suo progetto. All’annuncio del progetto divino di creazione dell’uomo, gli angeli rispondono: «Vuoi mettere sulla terra chi vi porterà la corruzione e spargerà il sangue, mentre noi cantiamo le Tue lodi ed esaltiamo la Tua santità?» (Corano 2,30). E Dio risponde: Io so ciò che voi non sapete. In definitiva, ciò che distingue Iblìs dai suoi simili non è la conoscenza delle cose, che è conoscenza legittima, conoscenza buona, rivelata da Dio e dunque un Suo dono; e a ben vedere non è neppure il ragionamento attraverso il quale, utilizzando quella conoscenza, produce conoscenze nuove. Ciò che distingue Iblìs è precisamente il fatto di non sottomettere il proprio giudizio alla Volontà del Signore. Sia Iblìs sia il gruppo degli angeli ragionano attorno al progetto divino sul mondo, sia l’uno sia gli altri discutono razionalmente la divina volontà; però la figura diabolica è appunto diabolica in quanto non sottomette la propria ragione alla divina volontà, non accetta in modo pacificato il progetto divino sul mondo perché antepone alla volontà del Creatore la propria ragione creaturale. In questo senso, Iblìs incarna la situazione anti-islamica per eccellenza, letteralmente contraddice l’Islam, cioè contraddice la sottomissione pacificata alla Volontà di Dio. In definitiva, il Corano non chiede di non ragionare sulle cose, ma appunto di non opporsi all’operato di Dio, e di conformarsi comunque, di accettare comunque, senza opporsi ai motivi e agli esiti della Sua Volontà, nonostante la facoltà intellettiva di cui la creatura è dotata. L'insegnamento è il seguente: la ragione è lecita e buona però si deve arrestare a un dato punto, e questo punto è la Volontà del Creatore, è l’ordine che Dio impartisce. 3) Il terzo aspetto notevole nel brano dedicato alla genesi della figura diabolica è l’attenzione a sé, dunque la capacità di autoriflessione, capacità di autoriflessione che condurrà Iblìs all’autoconsapevolezza. Il male incarnato da Iblìs nasce dunque non solo dall’uso autonomo della ragione come motivo di disubbidienza, ma anche dal fatto che Iblìs ha rivolto la propria facoltà razionale verso se stesso. L’angelo ha guardato a se stesso e a un’altra creatura, anziché guardare al comandamento divino. Ed è proprio nell’attenzione a se stessi, a se stessi e non a Dio, che va individuato un aspetto eminentemente anticoranico e, di conseguenza, eminentemente anti-islamico. Per illustrare meglio questo punto cruciale, a costo di lasciare per un attimo la figura di Iblìs, parliamo della formulazione islamica della cosiddetta regola d’oro, l’invito ad amare gli altri come se stessi: ama il fratello come te stesso. E' l’alto comandamento etico che pone a misura della relazione con l’altro la medesima relazione che ciascuno intrattiene con se stesso, un caposaldo dell’insegnamento evangelico. Ricordiamo che l’intera predicazione coranica è, al contrario, radicalmente in linea con il comandamento espresso invece nel Deuteronomio: “Ama il Signore, tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutto te stesso, con tutte le tue forze.” E’ un dato di fatto che la letteratura religiosa islamica storpia la formulazione cristiana della regola d’oro e sostituisce “ama tuo fratello come te stesso” con “ama per tuo fratello ciò che ami per te stesso”. Dunque, la dottrina musulmana non chiama l’uomo a dirigere il proprio amore direttamente verso l’altra creatura, e tantomeno presuppone un amore verso se stessi; l’oggetto dell’amore sta oltre l’uomo che ama e oltre l’uomo per cui si ama; si tratta invece di estendere il numero di coloro che beneficiano e traggono vantaggio dall’amore e non di estendere il destinatario dell’amore. Il destinatario dell’amore è e resta Uno e Unico, è Dio, o eventualmente, per estensione, l’Islam come religione e il Profeta di questa religione, Muhammad. 4) Veniamo a un quarto elemento significativo della figura diabolica nel Corano: nel momento in cui riflette su se stesso, nel momento in cui guarda a se stesso invece di guardare a Dio e alla Sua volontà, Iblìs pecca di superbia. E’ detto chiaramente nella sura Sàd, la trentottesima, che l’angelo «si riempì di superbia e rifiutò» (Corano 38,74). Superbia che, nella lingua araba utilizzata dal Corano e generalmente nell'arabo classico, equivale precisamente a un ingrandimento, a un aumento delle proprie dimensioni. “Facendosi grande”, Iblìs diviene grande, e sembra addirittura insinuare il dubbio in Dio; si recita infatti, nella stessa sura Sàd , che Dio «gli disse: ‘Iblìs! Che cosa ti ha impedito di prostrarti a quel che Io ho creato con la Mia mano? Ti sei sollevato in superbia o sei davvero così alto?’» (Corano 38,75; cfr. Cor. 2,34 e 7,13)..A questo punto è evidente che la conoscenza dell’angelo, conoscenza che, elaborata dalla ragione, lo ha condotto all’autoconsapevolezza, lo ha anche sollevato a dimensioni abnormi, dimensioni che lo hanno avvicinato pericolosamente alle dimensioni della figura divina. Nel dialogo tra Iblìs e Dio così come il Corano lo riferisce, Iblìs parla con Dio da pari a pari; sta di fronte a Lui e non è affatto sottomesso, non parla dal basso, non si trova in una posizione inferiore. Il Corano presenta Iblìs come una figura fortemente vicina alla figura di Dio stesso. E un elemento che subito vedremo meglio. 5) Il pensiero che ha generato la superbia dell’angelo lo ha posto fuori dalla comunità: «si prostrarono gli angeli, tutti quanti insieme eccetto Iblìs» (Corano 15,30-31, cfr. 2,34; 7,11; 17,61; 18,50; 20,116; 38,73). Quest’angelo è un isolato, è un’eccezione, ha introdotto nel creato l’individualità della creatura. Ma l'individualità spetta solo a Dio, che appunto è “l’Uno e l’Unico”; si pensi, a titolo di esempio, alla formula della professione di fede islamica: “Non c’è Dio eccetto Dio”. Al contrario, la condizione creaturale è eminentemente molteplice e plurale. Riassumendo: Iblìs abusa della conoscenza ricevuta, ragiona sulla volontà di Dio e vi si oppone scientemente, e in tal modo è divenuto grande; per di più, è uno solo che sta di fronte a Uno solo, è uno solo che parla con Uno solo. La figura di Iblìs nel Corano si propone dunque come una figura che sta attentando all’unicità di Dio. Iblìs rappresenta il peccato dell’autolatria, l'sdorazione di se stesso; ma prima ancora rappresenta il peccato di chi nega l’unità e l’unicità di Dio. In breve, rappresenta il peccato di chi nega il monoteismo. Ecco perché la punizione inflitta da Dio all’angelo non sarà soltanto l’allontanamento dal Giardino paradisiaco, non sarà soltanto il cambiamento del suo nome, da Iblìs a Shaytàn, ma sarà anche il rimpicciolimento. Secondo il Corano, infatti, Dio ridurrà drasticamente le abnormi dimensioni di Iblìs: «Esci da qui, che tu sei reietto», «e disse Iddio: ‘Fuori di qui, esci da qui spregiato e reietto’», «vattene di qui. Non ti è lecito, qui, fare il superbo (ovvero ingrandirti). Fuori. Tu sei ormai un essere spregevole (ovvero, letteralmente, sei tra i piccoli» (Corano 15,34-75. Cfr. 7,13 e 18, e 38,77). 6) Per avviare alla conclusione questa traccia indicativa a proposito della figura del diavolo nel Corano, c’è ancora un elemento notevole che riguarda l’azione tentatrice nei confronti dell’uomo. Innanzitutto il tempo della tentazione. Nella sura del Limbo è contenuto un nuovo dialogo tra Dio e l’angelo, l’angelo oramai punito non solo con l’allontanamento ma anche con il rimpicciolimento. «Disse Iblìs: ‘Lasciami attendere fino al giorno in cui gli uomini saranno risuscitati’. Rispose il Signore: ‘Ebbene, ti sia concesso d’attendere fino a quel giorno’». Lo stesso dialogo compare, con lievi modifiche, nella sura di al-Hijr: «‘Concedimi, Gli chiese, d’attendere fino al giorno in cui saranno risuscitati i morti’. Rispose: ‘E sia, ti sia concesso d’attendere fino al dì del Termine Chiaro’» (Corano 7,14-15 e 15,36-38. Cfr. 17,62 e 38,79-81). Il tempo della tentazione, che dura fino al giorno del giudizio, è la storia del mondo. L’angelo sa che in questo tempo può dispiegare la sua forza: «costui sarebbe quello che hai onorato sopra di me?Dammi tempo fino al dì della Resurrezione e io annienterò tutta la sua progenie, salvo pochi», si legge nella diciassettesima sura, la sura del Viaggio Notturno (Corano 17,62, cfr. 38,83) . Dio concederà a Iblìs l’uso e l’abuso della storia del mondo, e inoltre, cosa più interessante, accoglierà la proposta di Iblìs come una proposta corretta. Secondo la sura Sàd, «disse Iblìs: ‘Per la Tua potenza! Io tutti li sedurrò salvo quelli di loro che sono i Tuoi servi puri.’ Disse Iddio: ‘Questa è giusta sentenza, e giusta sentenza io pronuncio, riempirò l’Inferno di te e di quelli tra loro che ti seguiranno, tutti insieme’ (Corano 38,82-85). La sura di al-Hijr insiste: «disse ancora Iblìs: ‘Signore [...] io farò bella ai loro occhi ogni turpitudine sulla terra, e ingannerò loro tutti eccetto i Tuoi servi puri’. Rispose: ‘Questa è una Via per me retta. In verità sui Miei servi tu non avrai potere alcuno eccetto su quei traviati che ti seguiranno’» (Corano 15,39-42). Dio accoglie le parole di Iblìs ritenendole «giusta sentenza», equiparandole alla parola di verità che Egli stesso pronuncia: «e giusta sentenza io pronuncio». Dio afferma inoltre di ritenere la via dell’inganno minacciata dall’angelo una via diritta (si ricordi: ‘Questa è una Via per me retta’), espressione che il Corano impiega abitualmente in riferimento alla Via percorsa dal buon credente, il servo che segue la via della legge rivelata; pensiamo alla prima sura, dove è detto:«guidaci per la retta via» (Corano 1,6). Questo comporta un forte avvicinamento della tentazione alla verità e alla legge, o addirittura identifica il traviamento diabolico con la giustizia, l’azione tentatrice con la via diritta. Ciò non deve stupire: quel che il Libro dell’Islam suggerisce in questi passi è appunto che la minaccia di Iblìs e il male che egli è in procinto di compiere rispondono al disegno di Dio, cioè rispondono all’autorità di Dio in questo male. E in quanto conformi al disegno divino, sono corretti. Nella sura del Limbo l’angelo esplicitamente attribuisce a Dio la responsabilità della propria trasgressione e anche la responsabilità del futuro traviamento degli uomini: «poiché Tu mi hai fatto errare - dice Iblìs a Dio - io mi apposterò sulla Tua via diritta» (Corano 7,16); dunque Iblìs ingannerà l’uomo perché a sua volta è stato vittima dell’inganno di Dio. Le parole di Satana non sono semplicemente parole di vendetta. La sua posizione è una posizione mediana, una posizione di transizione, di passaggio: l’origine del traviamento, di Iblìs stesso e, di conseguenza, anche l'origine del traviamento degli uomini, resta sempre Dio stesso. Lo ribadisce appunto la sura di al-Hijr, la quindicesima: «disse ancora Iblìs: ‘Signore, poiché Tu mi hai fatto errare [...], io farò errare loro tutti eccetto i Tuoi servi puri» (Corano 15,39). In definitiva, Iblìs compirà contro gli uomini quel che il Signore ha compiuto contro di lui; Dio lo riconosce - «questa è giusta sentenza» - e, non solo non si oppone, ma anche esorta all’azione: «Conturba con la tua voce quelli fra loro che potrai, e piomba loro addosso con i tuoi cavalieri e i tuoi fanti, e assòciati a loro nei beni e nei figli, e fa’ loro promesse! Ma non promette Satana che inganno», come si legge nella sura Tà-Hà (Corano 17,16). Prima di passare alle principali soluzioni proposte dalla letteratura religiosa successiva, dobbiamo insistere su qualcosa che a questo punto è forse prevedibile; cioè che, quando si afferma che il Corano è nella visione islamica Parola letterale di Dio, significa precisamente che tutte le parole contenute nel Corano sono da considerarsi parole di Dio, anche le parole pronunciate da altri. E’ sempre Dio che ha parlato, perfino quando parlava Iblìs il futuro Satana. E si tratta sempre di azioni di Dio, anche quando si afferma che altri agiscono. Sono molti i commentatori coranici che insistono su questo punto. La grande letteratura esegetica islamica non fa che riprendere e sviluppare i temi coranici già esaminati. 1) Innanzitutto lo svilimento della figura di Iblìs. Iblìs è presentato volta a volta come borioso, patetico o grottesco. Si rileva in particolare lo svilimento della conoscenza di Iblìs, e conseguentemente lo svilimento del suo ragionamento. Tra i molti teologi che insistono su questo punto citiamo Tabari (m. 310/923), autore di un monumentale commentario dal titolo La raccolta delle dichiarazioni. Questo autore insiste sull’ignoranza di Iblìs. Ricorda che l’angelo comparò il fuoco al fango e trovò giustamente superiore il fuoco, ma utilizzò un numero insufficiente di dati: non mise in conto che l’uomo era stato creato dalla mano di Dio e riempito di Spirito, e che possedeva la buona disposizione del Signore nei suoi confronti; secondo Tabarì, il percorso logico di Iblìs fu dunque scorretto e privo di rigore, perché la superiorità di Adamo si fondava su elementi diversi dalla materia della sua costituzione. Citiamo anche Qurtubì (m. 671/1272), “il Cordovano” autore di un celebre commentario dal titolo La raccolta delle sentenze; anch'egli insiste sull’ignoranza dell’angelo e inoltre sull’ingannevolezza del ragionamento creaturale: secondo questo autore Iblìs sbagliò perché confidò troppo nel suo giudizio e non considerò che il fango, contro ogni apparenza, è in realtà superiore al fuoco: infatti il fango è peso e immobilità, calma e lentezza, temperanza, pazienza e vita, mentre il fuoco è leggerezza, mobilità, violenza, incostanza, agitazione; e se il fango non procura dolore o pena invece il fuoco è doloroso, è la pena che Dio infligge ai Suoi nemici, perciò nell’inferno c’è fuoco e non fango; inoltre il fango non necessita del fuoco mentre il fuoco necessita di un luogo dove prodursi e questo luogo è la terra del suolo. 2) Naturalmente nella letteratura esegetica lo svilimento di Iblìs procede di pari passo con l’annullamento della sua individualità, di quella sua unicità che lo avvicinava all’Uno e Unico: sulla base di molti racconti, la gran parte presi a prestito da altre tradizioni religiose, i commentatori, quasi senza eccezione, ricordano ad esempio che Iblìs non fu l’unico angelo a disubbidire a Dio. Richiamano, tra le altre, la storia dei due angeli Hàrùt e Màrùt, che Dio inviò sulla terra per vedere se si comportavano meglio degli uomini e che invece si macchiarono di ogni colpa ivi compreso l'assassinio. 3) Un altro punto su cui ritorna molto l’esegesi è l’incorporazione dell’ operato di Iblìs all’operato divino, il che ribadisce un’idea di creazione in senso forte: Dio crea tutto e agisce tutto; tutto accade esclusivamente in base alla Sua volontà liberissima e incondizionata. Lo illumina con chiarezza il grande Fakhr al-Dìn al-Ràzì (m. 606/1209), che nelle sue Chiavi dell’Arcano riassume così le grandi questioni precedenti: “dal momento che la rovina di Iblìs derivò dall’analogia, Dio non è causa immediata di errore ma sua origine, causa prima: per ogni cosa che si muove deve esserci qualcosa che la fa muovere e per ogni cosa che è in quiete deve esserci qualcosa che la tiene in quiete; dunque se qualcuno erra deve esserci qualcuno che lo fa errare”. Secondo Ràzì, nel caso di Iblìs le possibilità sono tre: chi lo portò all’errore fu lui stesso, oppure fu un’altra creatura, oppure fu Dio. La prima possibilità è falsa, perché la creatura dotata di intelletto non sceglie l’errore sapendo che è errore; anche la seconda è falsa, perché comporta il circolo vizioso giacché spiega la disubbidienza presupponendola. Di conseguenza quella vera è l’ultima, e chi fece errare Iblìs fu Dio. Naturalmente, l’esegesi insiste sulla anche sulla funzione strettamente strumentale di Iblìs - che oramai è caduto ed è divenuto Satana - quanto si tratta della tentazione dell’uomo. Satana è un servo tra i molti servi di Dio, e viene descritto precisamente come un utensile nelle mani dell’Onnipotente. Ancora Tabarì dichiara che la cacciata dei progenitori dal Giardino va sì attribuita a Satana, perché Satana ne fornì il motivo in quanto intermediario; ma Satana è privo di capacità causativa autonoma, è una causa intermedia, una tra le infinite cause seconde; chi li cacciò resta pur sempre Dio. Anche il mistico Qashànì (m. 731/1330) insiste sull’unica Volontà che sta a monte del peccato dei progenitori: “certo fu Dio che lo volle, perché, se Dio non avesse voluto, Iblìs non avrebbe potuto ingannarli”. L’andaluso Qurtubì si sofferma in particolare sulla debolezza di Satana, il quale non sa allontanare qualcuno dal luogo in cui risiede, ma può solo sospingerlo e indirizzarlo; pertanto quel che compì sull’uomo non fu uno spostamento violento e rapido ma solo “un’induzione allo scivolamento”. L’istanza monoteista è molto decisa nella letteratura di commento al Corano. Perciò non deve meravigliare se alcuni racconti sorvolano del tutto sull'intermediazione del Tentatore e insistono direttamente sul rapporto tra Dio e uomo. Citiamo uno scambio di battute appunto tra Adamo e Dio, rammentato ancora da Tabarì: “disse Adamo: ‘Signore, la mia colpa fu scritta da Te a mio carico prima di crearmi, oppure io stesso la inaugurai da me’? Rispose Iddio: ‘Fu scritta da Me a tuo carico prima di crearti’. Disse Adamo: ‘Se Tu l’hai scritta a mio carico prima di crearmi, allora perdonami.’ E Dio lo perdonò [...].” Infatti, secondo il Corano, Adamo fu perdonato, e la tradizione, per le parole che Dio gli donò, ne fece il primo profeta nella storia dell’umanità. 3) Concludiamo ricordando una lettura particolarissima della figura satanica, lettura assai diffusa in ambiente mistico. Nonostante essa appaia del tutto eterodossa rispetto alle soluzioni più consuete all’esegesi, tuttavia merita di essere menzionata per la posizione radicale che esprime, posizione spregiudicata e provocatoria ma di grande fascino intellettuale. E’ la posizione che rinviene in Iblìs non la figura di colui che nega l’Unicità di Dio o dell’autolatra, cioè la posizione di chi fa un dio di se stesso, ma, tutto al contrario, la figura del perfetto monoteista. Questo tipo di interpretazione parte dall’idea già vista di Satana come servo di Dio: che attua necessariamente il disegno divino come ogni altra creatura, Satana che parla le parole di Dio e agisce le azioni di Dio. Spingendo però questa idea alle più stringenti conseguenze, Iblìs diviene il servo migliore, perché, rifiutando di prosternarsi a Adamo, non fa che dichiarare che nessuno eccetto Dio è degno di ricevere una prosternazione ovvero un atto di adorazione; e lo dichiara a costo della propria eterna sventura. Iblìs diviene così una figura tragica di eccezionale grandezza: per non cadere nel peccato di idolatria, per non tradire la professione di monoteismo, si trova costretto a disubbidire a un ordine divino e a meritare la divina maledizione. Posto di fronte all’alternativa - farsi idolatra associando altri a Dio oppure disubbidire - Iblìs sceglie il male per così dire minore, anche se questo gli comporterà la caduta e la disgrazia. Questa interpretazione, molto diffisa, venne resa celebre attraverso l’opera in persiano di Rumì (m. 1273), e anche, ben prima di Rumì, attraverso l’opera in arabo di Hallàj, “il martire mistico” dell’Islam come lo chiama il suo grande biografo Louis Massignon; quell’Hallàj che passò alla storia come il-pazzo-di-Dio e che fu giustiziato a Baghdad nel 922 d.C. perché aveva spinto all’estremo l’affermazione monoteistica fino a teorizzare l’Unicità dell’Esistenza. Hallàj dedicò alla disubbidienza di Iblìs un opuscolo dal titolo Tà Sìn dell’eternità dove esemplifica attraverso Satana la figura del perfetto monoteista e, di più, la figura del perfetto amante di Dio. Disubbidire all’ordine contingente di Dio significa, nella splendida ipotesi di Hallàj, ubbidire pienamente a una primordiale vocazione d’amore per Dio, un amore che esprime appieno l’Unicità di Dio in quanto unifica tutto: Creatore e creatura, Inventore e cosa inventata, Maestro e discepolo; è un tutto-amore che nullifica ogni cosa eccetto Dio stesso. Secondo Hallàj, questa vocazione al monoteismo d’amore, questa “follia d’amore”, altro non è che il monoteismo vero, al più alto grado; cosicché, come appunto ricorda Hallàj, “non vi fu, tra gli abitanti del cielo, chi fosse monoteista come Satana”. Concludiamo allora questa esposizione citando alcune parti significative della piccola opera di Hallàj, e in particolare una parafrasi, anzi una riscrittura, del dialogo coranico tra Iblìs e Dio, che l’autore propone: “Gli disse Iddio: ‘Prosternati davanti ad Adamo!’ Rispose: ‘Mai mi prosternerò ad altri che a Te!’ Gli disse Iddio: ‘Anche se Io scaglierò su di te la Mia maledizione?’ Rispose: ‘La tua maledizione non mi nuocerà! VolerTi dichiarare Santo è la mia follia, volerTi roteare attorno è la mia illusione [...] Solo per proclamarti Santo io nego il Tuo ordine, la mia mente vuole continuare a essere folle di te. E chi è Adamo? Senza di Te, nulla! E chi sono io, Satana, per differenziarlo da Te? [...] Per me non potrà esserci allontanamento da Te perché ora so che allontanamento e avvicinamento sono una cosa sola. E se Tu mi abbandoni, il Tuo abbandono mi sarà vicino e mi terrà compagnia; e poi, come può esservi abbandono se amarsi è ritrovarsi? Sia gloria a Te! Io rimetto questo pio servo che io sono, che non si prosterna ad altri che a Te, alla Tua provvidenza, e alla Tua Essenza.’ [...] Gli disse Iddio: ‘Non ti prosternerai dunque, o tu, umiliato?’ Rispose: ‘Di’ piuttosto: o tu, amante!, perché ogni amante è un umiliato.’ Gli disse Iddio: ‘E’ mia la scelta, non tua’. Rispose: ‘La mia scelta è tua, come ogni altra scelta, Tu sei il mio Inventore! Ed è Tua la verità. E in verità, mia vocazione prima è amarTi [...]. Dunque, Non biasimarmi, [...] Maestro, e ricompensami piuttosto, perché io sono un servo solitario. E voi tutti sappiate che sono un martire dell’amore.”
Scarica