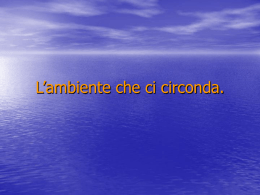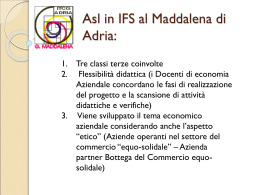Indice Frontespizio Colophon Prefazione di Emmanuel Carrère EPEPE FerencKarinthy Epepe PrefazionediEmmanuel Carrère TraduzionediLaura Sgarioto AdelphieBook TITOLOORIGINALE: Epepe LaPrefazioneètradotta daPiaCigalaFulgosi Quest’operaèprotetta dallaleggesuldiritto d’autore Èvietataogni duplicazione, ancheparziale,non autorizzata Incopertina:W.T.Benda, copertinaperlarivista «Woman’sHome Companion»(gennaio 1936). ©BLUELANTERN STUDIO/CORBIS Primaedizionedigitale 2015 ©1999,2005ÉDITIONSDENOËL ©2015ADELPHIEDIZIONIS.P.A. MILANO www.adelphi.it ISBN978-88-459-7662-9 PREFAZIONE DIEMMANUELCARRÈRE Laprecedenteedizione diquestolibromièstata mandata nell’autunno 2000 da Olivier Rubinstein,ildirettoredi Denoël, con un laconico biglietto di accompagnamento: «Dovrebbepiacerti».Non sapevo ancora che la prima mossa di Olivier, appena si insedia a capo di una casa editrice, è quella di recuperare i diritti di Epepe per inserirlo nel suo nuovo catalogo, nella speranza difarneungiornoillibro di culto che è palesemente destinato a essere. Quello che non sapeva lui è quanto questoromanzocascasse afagioloperme.Quando l’ho letto, infatti, stavo girando un documentario su un ungherese uscito di senno di cui penso non sia fuori luogo raccontarequilastoria. Nel 1944 András Toma, che al momento del suo ritorno i giornali diBudapesthannounpo’ impropriamente presentatocomel’ultimo prigionierodellaseconda guerra mondiale, aveva diciannove anni. Trascinato dalla Wehrmacht nella sua disfatta, catturato dall’Armata Rossa in Polonia, fu trasferito da un campo di prigionia all’altro, sempre più a est, poi, probabilmente inseguitoaunaccessodi follia, internato nell’ospedale psichiatrico di una piccola cittadina russa chiamata Kotel’nič. Vi sarebbe rimasto per cinquantacinqueanni. Ho consultato la sua cartella clinica, dove il regolamento imponeva di registrare, ogni due settimane,unanotasulle condizioni del paziente. La successione di queste millecinquecento note circa, per la maggior parte brevissime, è la cronaca di una lenta e inesorabiledistruzione. András Toma non era un prigioniero politico, ma un prigioniero di guerra, cittadino di un paese ormai amico, e a guerra finita non c’era alcuna ragione di trattenerlo in Unione Sovietica. Il punto è che non parlava russo, ma ungherese, e nessuno intorno a lui capiva l’ungherese. Inoltre – e questo non solo ha complicato ulteriormentelecosema suggerisce che senza essere necessariamente pazzo non avesse una grande capacità di adattamento–luinonha mai tentato di parlare russo, di racimolare qualche parola che gli avrebbe permesso di esprimersi e probabilmenteditornare a casa, e d’altra parte nessuno ha cercato di parlargli in una lingua abborracciata, o a gesti, insomma di escogitare unmodopercomunicare con lui. Che due persone prive di una lingua comune non riescano a comprendersi di primo acchitoènormale,main teoria con un pizzico di buona volontà finiscono pertrovareunterrenodi intesa. Al personale dell’ospedale deve essere mancato quel pizzico di buona volontà, e ad András Toma non tanto l’ostinazione quanto la flessibilità e forse l’intelligenza: fatto sta che la reciproca incomprensione del primo contatto è durata, assolutamente immutata, per cinquantacinque anni. Per cinquantacinque anni quest’uomo ha borbottato tra sé nella sualingua,circondatoda persone che ne parlavano un’altra, che lui non ha mai potuto o voluto capire. Ogni quindici giorni i medici annotavanosobriamente nella sua cartella: «Parla ungherese». Era diventatounsintomo. András Toma è stato ritrovato, in modo del tutto casuale, nell’autunno del 2000. Una giornalista locale seguiva il giubileo dell’ospedale, il primario ha presentato agli astanti il decano dei pazienti: «Un bravo vecchio, molto tranquillo, parla solo ungherese,ahahah!».La giornalista, scaltra, ha fiutatolabellastoriaeha scritto un articolo sul tema: «Vi è nella nostra città l’ultimo prigioniero della seconda guerra mondiale». L’articolo è statoripreso,ilconsolato ungherese si è occupato della cosa e ha organizzato il rimpatrio di András Toma; che si chiamasse davvero András Toma, a dir la verità, non era affatto certo,poichéilsuonome era stato prima mal declinato, poi trasposto in russo e in ultimo storpiato nella trascrizione.L’incertezza sullasuaidentitàhareso ancor più romanzesco il suo ritorno al paese natale, che ha fatto notizia sui giornali di Budapest. Alla fine della guerrasonosparitimolti ungheresi, e il loro ricordo è stato rimosso, tanto più che l’Ungheria era alleata con la Germania. Di quei fantasmi non si parlava, ed ecco che a un tratto uno di loro si ripresenta. Per quanto possa sembrare strano, decine di famiglie hanno rivendicato una parentela con lui: era il fratello Janos, lo zio Geza, il cugino Ferenc. L’esercito ungherese ha svolto delle indagini, e alla fine è riuscito a identificare la vera famiglia, che ha accettato di riprenderlo con sé. András è quindi tornato,asettantacinque anni, nel paesino da cui se n’era andato a diciannove. Io ho assistito al suo ritorno. Era uno spettro, un Kaspar Hauser con i capelli bianchi. Si rifiutavadicrederechesi trovava in Ungheria, poichélaggiùgliavevano dettochel’Ungherianon esisteva più: cancellata dalla carta. Era diffidente, sospettava unatrappola. Nessuno lo capiva. La sua lingua non era più l’ungheresemaunasorta di dialetto privato, autistico, quello di un monologo interiore rimuginato per tutta la durata dell’esilio. Sopravvivevano alcuni brandellidifrasi,incuisi parlava della traversata del Dnepr, di un lungo viaggiointrenonelquale quasi tutti i suoi compagni erano morti, della terra troppo ghiacciata perché si potesse seppellirli, di stivali che gli avevano rubatoedellasuagamba amputata che pretendeva che gli restituissero. Si riconosceva anche il nome di Hitler che lui chiamava«HitlerAdolf», all’ungherese, mettendo il cognome davanti al nome. Secondo lui quell’Hitler Adolf era un furbacchione,edifronte a questo giudizio, più volte ripetuto, è calato il gelo. Non so se leggerete questa prefazione prima odopoillibro.Selastate leggendo dopo, non ho bisogno di spiegare il perché del racconto che ho appena fatto. Se prima, non penso di rovinarvi il piacere riassumendo la trama di Epepe – in ogni modo è poco probabile che affrontiate il libro completamente vergini: qualcuno ve ne ha parlato, o vi siete fatti sedurre dalla quarta di copertina. È la storia di unuomochesiritrovain un paese di cui non capisce la lingua, e il racconto giorno per giorno della sua sopravvivenza in quelle condizioni. C’è però una grande differenza tra András Toma e Budai, il protagonista del romanzo di Ferenc Karinthy.Ilprimoeraun contadino semianalfabeta che parlava soltanto la sua linguamaternaeche,per una resistenza psichica difficile da spiegare ma sotto gli occhi di tutti, si è rivelato incapace di acquisire foss’anche i minimi rudimenti di un’altra, da cui pure dipendeva la sua salvezza. Il secondo è tutto l’opposto: un linguista di professione, che padroneggia decine di lingue e dotato di un’eccezionale facoltà di analisi. Ci sentiamo tutti a disagio quando i personaggi di un romanzo si comportano come degli idioti, pensiamo che al loro posto faremmo meglio, ma non possiamo pensare niente del genere riguardo a Budai: sfidato sul suo terreno, hapiùstrumentiedèpiù abile della stragrande maggioranza di noi, il che non gli impedisce di incorrere in un fallimentodopol’altro.È unodeipuntidiforzadel libro che il protagonista sia così industrioso, così combattivo, che esplori in modo esaustivo tutte lepossibilitàdicavarsela – ovvero di capire qualcosa,anchesolouna parola,dellalinguachesi parla attorno a lui – e che,nonostanteiprodigi di metodo che mette in campo, l’oggetto del suo studio gli rimanga così ostinatamenteoscuro. Un’altra grande differenzatraidueèche lastoriadiAndrásToma è vera, mentre quella di Budai si svolge non soltanto nella finzione, ma in un universo parallelo, un paese di fantasia che sfugge alle leggi del realismo almeno quanto le isole dovefinisceilGulliverdi Swift. Il libro non è molto lontano, va detto, da quei deprimenti film d’animazione dei paesi dell’Est, tanto in voga negli anni Sessanta e Settanta,incuisivedeva un omino con la bombetta aggirarsi fra moltitudini dallo sguardo vacuo in una metropoli tentacolare dove tutte le vie si assomigliavano. Quei film avrebbero dovuto illustrare l’angoscia dell’uomo moderno, la disumanizzazione delle città, e nel dibattito che seguiva c’era sempre qualcuno che pronunciava con gravità l’aggettivo «kafkiano». A sottrarre Epepe a questo cliché sono la precisione e il rigore con cui sono riferiti i tentativi di evasione di Budai, e l’esultanza che si intuisce nell’autore a mano a mano che strutturalastoriaesfida il lettore a coglierlo in fallo. Per trovare qualcosa che ricordi questa esultanza non bisogna cercare negli epigoni di Kafka, ma piuttosto nel meraviglioso film di Harold Ramis, Ricomincio da capo. Stesso soggetto da incubo, privo di qualunque giustificazionerazionale: unuomobloccatoinuno squallido paesino rivive senza fine la stessa giornata. Stesso modo esaustivo, quasi matematico di esplorare tutte le conseguenze del postulato. Stessa ebbrezza narrativa. La differenza è che gli sceneggiatori di Ricomincio da capo, nutriti a un tempo di fiabe e di convenzioni hollywoodiane, si traggono d’impiccio facendo trionfare l’amore,mentreilpovero Budai perde Epepe, di cui, colmo di sventura, nonènemmenosicurosi chiami Epepe – né Bebe, néDiedie,néEtietie... Strano libro, comunque, se nel tentativo di collocarlo ricorro da una parte a una delle storie vere più disperate di cui sia mai venuto a conoscenza, dall’altra a una commediafantasticaalla Frank Capra. Strano libro, che stona nella produzione del suo autore al punto che si è tentati di chiedersi: «Ma che gli è preso?». Di questaproduzione,perla verità, il lettore francese conosce assai poco, poichésonostatitradotti solo altri due racconti: Automne à Budapest è una rievocazione sottile e relativamente audace della rivoluzione del 1956 e della sua repressione a opera dei carri armati russi; L’Âge d’or è una commedia agra sugli amori di un giovane dongiovanni ebreo, nascosto in un edificio di Budapest nel dicembre del 1944, mentre i sovietici assediano la città e il partito filonazista delle Crocifrecciateviimpone ilterrore.1Aquell’epoca, come ho appreso dalla figlia e traduttrice Judith, lo stesso Ferenc Karinthyavevadisertato e si era imboscato in un ospedale di Budapest dove, per giustificare quasi un anno di permanenza, subì non meno di quattro operazioni del tutto immotivate ma innocue: tonsille, appendice, adenoidi ... la quarta Judith non ricorda più quale sia. Dal padre Frigyes Karinthy, uno dei più famosi scrittori ungheresi fra le due guerre, Ferenc aveva ereditatounavisionedel mondo umoristica e distaccata, che bilanciavalaserietàdella sua attività sportiva. Campione di nuoto e di pallanuoto da giovane, è stato poi allenatore di uno dei più importanti club dell’Ungheria, e infine arbitro internazionale, cosa che, oltre agli impegni letterari, lo ha fatto viaggiare in tutto il mondo. Ha condotto giochi radiofonici, pubblicato decine di romanzi e pièce teatrali, tutti di ispirazione realistica. Comunista fino al 1956, si è poi astenuto da qualunque presa di posizione politica limitandosi a un ruolo di osservatore ironico. Non voleva a nessuncostoesiliarsidal suo paese, e soprattutto dallasualingua–benché come Budai ne parlasse molte altre. È morto nel 1992elesueopere,come quelle di suo padre, per quanto in misura minore, continuano a essere lette in Ungheria. Eccoilpocochesodilui, e onestamente, se al ritorno da un viaggio in Giappone non avesse scritto Epepe, non avrei alcun motivo di saperlo. MahascrittoEpepe. L’hoappenarilettoper scrivere questa prefazione e mi accorgo che è la seconda volta. Intendo: che lo rileggo, perciòèlaterzavoltache loleggo.Nonsonomoltii libri che si leggono tre volte in cinque anni. Mi sono divertito, per i cinque che sono appena passati, a stilare la mia lista: Ethan Frome di Edith Wharton, Preghiera per Černobil’ di Svetlana Aleksievicč, AusterlitzdiW.G.Sebald, Autobiographie de mon père di Pierre Pachet, Morire dentro di Robert Silverberg. Questi libri hanno in comune una tonalità cupa e anche desolata. I due americani, Wharton e Silverberg, raccontano storie di solitudine strazianti ma senza riflesso nella storia collettiva. Gli europei, invece, descrivono più o meno direttamente gli esperimenti sul genere umano che sono stati condotti su grande scala nell’Europa del secolo scorso. Il romanzo di Ferenc Karinthy rientra nella narrativa pura, ammesso che una cosa simile esista: narrativa da orologiaio, ludica, chiusa sul proprio risultato. Ma anch’esso affonda le sue radici in ciò che Georges Perec chiamava«l’histoireavec une grande hache».2 Sonostatolìlìperbarare, diecirighesopra,nelfare l’elenco delle mie riletture recenti, per includervi dei libri che non ho letto tre volte negliultimicinqueanni, ma che avevo voglia di nominare come si ha vogliadinominarequelli che si amano. Pensavo a W o il ricordo d’infanzia, e all’improvviso penso, e mi pare assolutamente certo,cheaPerecsarebbe piaciutodamattiEpepe. 1. Presso Adelphi è in corso la traduzione del secondo[N.d.T.]. 2. Hache al maschile significa «acca», al femminile «ascia, scure» [N.d.T.]. EPEPE Aripensarciinseguito, non può che essere andata così: nella confusione dello scalo Budai deve aver sbagliato uscita, è salito suunvolodirettoaltrove e per qualche motivo l’equivoco è sfuggito anche al personale dell’aeroporto. A posteriorinonsièpotuto neppure chiarire verso doveeperquantotempo abbia volato, perché non appena i motori hanno cominciato a girare lui ha reclinato lo schienale e si è assopito. Era esausto per la mancanza di riposo dei giorni precedenti, aveva sbrigato una gran mole di lavoro, fra cui la relazioneperilcongresso di linguistica a Helsinki, doveeradiretto.Durante il volo lo avevano svegliato una volta sola per servirgli il pranzo, poi si era riaddormentato, forse per dieci minuti, forse dieci ore, forse più. Oltretutto era senza orologio, perché aveva intenzione di comprarsene uno là e al ritorno non voleva presentarsi alla dogana condueorologi;cosìnon aveva la minima idea di quanto fosse lontano da casa. Si accorse di non essereaHelsinkisolopiù tardi, quando arrivò in città; all’inizio ignorava dove si trovasse. All’aeroportoeranosaliti sul pullman, faceva freddo, era già buio, una sera o notte di vento, e lui era ancora insonnolito. Il veicolo fermò varie volte, molti scesero; Budai era già stato a Helsinki, ma ora scrutava invano l’oscurità alla ricerca di qualche palazzo noto o del mare. A una fermata scesero tutti, e il conducente fece cenno anche a lui. Si ritrovò sotto una tettoia, all’ingresso di un albergo, circondato da una folla di persone che tiravano da ogni parte trascinandolo via dai suoi compagni di viaggio, e gli ci volle un po’perliberarsidaquella calca. Un grasso usciere in pelliccia e con un berrettobordatod’orogli rivolse un solerte saluto militareespinselaporta avetri,maquandoBudai gli parlò in finlandese quello non parve capire, rispose in una lingua sconosciuta, gli indicò la hall e non ci fu tempo per altri chiarimenti perché tutti premevano perentrare. Anche alla reception dell’albergo c’erano molte persone in attesa. Budaidovettemettersiin coda e quando finalmente si trovò davanti al portiere, un uomo con i capelli grigi in uniforme scura, alle sue spalle una famiglia chiassosa e carica di bagagli, composta da padre, madre e tre bimbetti agitati, cominciòapressarlocon impazienza e perfino a urtarlo: a quel punto successe tutto rapidamente, quasi suo malgrado.Parlòdinuovo in finlandese, ma il portiere non lo capiva, alloraprovòininglese,in francese, in tedesco, in russo, senza successo: il portiere rispose in un’altra lingua, che Budai non aveva mai sentito. Mostrò il passaporto, il portiere lo prese, sicuramente per registrareisuoidati,egli diede una chiave attaccata a una sfera d’ottone. Tra le pagine del passaporto Budai aveva infilato un assegno di viaggio in dollari,lasuadiariaperil soggiorno, il portiere prese anche quello, girò la manovella di una calcolatrice manuale e, lettoilrisultato,compilò in fretta un piccolo modulo già timbrato, un titolodicreditoinvaluta locale, accompagnando i suoi gesti con un fiume di parole. Budai cercò di protestare perché non aveva intenzione di cambiare l’assegno, ma non riuscì a farsi capire, e alle sue spalle la numerosa e strepitante famigliaglistavasempre più addosso, sventolando fogli in un crescendo di strilli infantili, mentre il portiere gli indicava di andareallacassa;fucosì che, vedendo che era inutile insistere, lasciò loro il posto e si diresse versolosportello. Anche lì c’era una lungacodacheavanzava a passo di lumaca; si mise in fila, sempre più infastidito,poichéoragli sarebbe toccato sistemare quella situazione assurda. Le rapide frasi del cassiere glisuonaronoestranee,e non ebbe il tempo di spiegarsi neanche qui – inognicasononavrebbe saputochecosaspiegare, einchelingua.Ricevette un fascio di grandi banconote nuove di zecca, qualcuna più piccola e sgualcita e una mezza manciata di spiccioli; si ficcò il tutto in tasca senza badarci troppo.Eraunafaccenda seccante e al tempo stesso ridicola, e cominciò a riflettere su cosa potesse essere realmente successo. ForseHelsinkinonaveva accordato all’aereo il permesso di atterrare a causa del cattivo tempo ederanofinitiinun’altra città? Ma in quel caso gli avrebbero consegnato il bagaglio, mentre lui aveva con sé soltanto la borsa che aveva sistemato nella cappelliera. A ben vedere, l’unica cosa che poteva essere accaduta è che al momento dello scalo fosse salito sull’aereo sbagliato e, se era andata così, la sua valigia era approdata senza di lui a Helsinki come indicava il biglietto, ma – si accorse in quell’istante – non aveva più neppure il biglietto, lì per lì non ricordava se qualcuno gliel’avesse ritirato, all’aeroporto o altrove. Aveva lasciato a casa, in un cassetto, la carta d’identità e le altre tessere, e si ritrovava privo di qualsiasi documento. Eppure era la cosa che meno lo inquietava, in qualche modo tutto si sarebbe risolto, l’essenziale era arrivare a Helsinki. Ma prima doveva spiegare a qualcunodadoveveniva e come fosse capitato là, e bisognava trovarlo, questo qualcuno, per esempio alla sede locale della compagnia aerea e, certo, anche questa andava trovata. Davanti alla reception la fila era addirittura più lunga, e lui non aveva voglia di rifarelacoda;tantomeno agli altri sportelli, che non riusciva a capire a cosafosserodedicatiese potevano servire per chiarimenti e informazioni. C’erano sì delle targhette qua e là, sui lunghi banconi, ma erano indecifrabili, scritte in lettere mai viste, come le parole che accompagnavano le immagini e i manifesti appesialleparetioititoli dellerivisteedeigiornali in vendita. Non poté esaminarli perché la hall era completamente invasa da una moltitudineondeggiante e tumultuosa: se solo tentava di fermarsi veniva spinto e trascinato via. Perciò preferì rimandare a più tardi, avrebbe risolto le cosealtelefono,dallasua stanza. Sullasferadellachiave ricevuta alla reception eraincisoilnumero921, così immaginò che la camera fosse al nono piano. In fondo alla hall trovò gli ascensori: ne erano in funzione tre su ottoedavantiaciascuno stazionava un folto gruppodipersone.Budai aveva pensato di salire a piedi, ma dopo essersi guardato intorno in cerca delle scale, senza vederle, aveva deciso di non abbandonare il suo postonellacoda.Civolle un quarto d’ora perché arrivasse il suo turno e quando salirono erano così tanti che stavano pigiati uno addosso all’altro. A manovrare l’ascensore era una ragazza alta e bionda, in uniforme blu, che di frequente si rivolgeva ai passeggeri in quella incomprensibile lingua, probabilmente per chiedere dove scendevano, quindi fermavalacabinaaquasi tutti i piani. L’ascensore erapresod’assalto,enon appena si svuotava risucchiava una nuova ondata di passeggeri. Vicino alla ragazza, sulla parete della cabina, girava un piccolo ventilatore, e a Budai venne da chiedersi come fosse possibile lavorare in una gabbia chiusa e soffocante, con tutta quella gente, magari per ore, per un intero turno dilavoro.Masiaffrettòa scacciare quel pensiero: non era affar suo, se ne sarebbe andato al più presto da quel posto, il giorno stesso, si augurava, o al massimo l’indomani mattina. Prima del nono piano fece un segno per scendere, e insieme a parecchi passeggeri sgusciò fuori dalla cabina: lo spazio lasciato libero fu immediatamente riempito da nuove persone. Nei corridoi, invece,mentrecercavala suacameranonincontrò nessuno: si incamminò in varie direzioni, vagando, contando i numeri avanti e indietro in cerca della 921, ma c’erasempreunangoloo un corridoio a interrompere la sequenza di porte. Per ben due volte ripassò dagli ascensori, e alla fine se la trovò davanti, in fondo a un remoto corridoiolaterale. La camera era minuscola, ma l’arredamento era moderno e confortevole, con un divano, un armadio, uno scrittoio provvisto di telefono e abat-jour, un comodino con una lampada da lettura. Nella angusta stanza da bagno c’erano una doccia, un lavandino,l’acquafredda ecalda,ilwater,specchi, asciugamani. Benché in entrambi i locali ci fosse un piacevole tepore, non si vedevano caloriferi, dovevano essere incassati nelle pareti. Alle finestre c’erano tapparelle e tende di stoffa, e fuori, di fronte all’albergo, si vedeva un edificio simile, alto e largo, punteggiato di finestre illuminate e buie. Un unico quadro campeggiava su una parete, un dipinto a olio protetto dal vetro: raffigurava un pendio innevato con due abeti e cerbiatti saltellanti sullo sfondo. Accanto alla porta c’era un foglio in una cornicetta, forse le tariffe o il regolamento dell’albergo, scritto negli stessicarattericheaveva visto giù al pianterreno. Non riconobbe il tipo di alfabeto, ma certamente non corrispondeva a nessuno di quelli che conosceva: non era né latino né greco, non era cirillico, né arabo o ebraico,enonsitrattava neppure di caratteri giapponesi, cinesi o armeni – un tempo, all’università, aveva avuto modo di studiare qualcosa anche di quelle lingue. Qua e là, però, disseminati in quella scrittura totalmente sconosciuta, spiccavano dei numeri arabi. Allora cercò il denaro ricevuto in cambio dell’assegno; con le scritte non approdò a nulla, ma sotto i soliti paesaggi o ritratti riconobbe i numeri: diciotto biglietti da 10 nuovi fiammanti, qualchealtroda1eda2, e monete di diverso valore. Ma era troppo stanco e intorpidito per proseguire nell’indagine di quella faccenda, e anchesporcoperillungo viaggio. Prese l’occorrenteperlavarsie, già che c’era, tirò fuori metà delle cose che aveva nella borsa. Per fortuna, per evitare che la valigia superasse i venti chili, lui e sua moglie avevano stipato parecchia roba in quella borsa di tela con la cerniera lampo: biancheria, pigiama, pantofole, il nécessaire, un paio di scarpe, un pullover, due bottiglie di vino da regalare e altre cose... Strano che all’arrivo in aeroporto non avesse pensato alla valigia; è pur vero che non ne aveva avuto modo, tra la fretta, il sonno e la confusione di quando li avevano caricati sul pullman. O forse aveva creduto che la valigia fosse nel bagagliaio. Si fece una doccia, si rase davanti allo specchio, indossò della biancheria pulita; quella usata la lavò subito, com’era sua abitudine, e la appese ad asciugare sui rubinetti e sul braccio della doccia. Poi si mise allo scrittoio e fece qualche tentativo al telefono: in camera non eradisponibileunelenco nénientedelgenere,così compose dei numeri a caso, più volte, finché non trovò qualcuno all’altro capo del filo. Risposero in molti, voci maschiliefemminili,ma in qualunque lingua parlasse e per quanto ripetesse e perfino urlasse la parola informazione tutti si esprimevanonellastessa incomprensibile maniera, una sequenza di suoni chioccianti e apparentemente inarticolati: ebebe o pepepe, etete o cose simili; il suo orecchio fine, addestrato a cogliere le varianti e le sfumature più sottili, non riusciva a distinguere altro che un borbottio gracchiante. Alla fine sbatté giù la cornetta con un risolino nervoso, seccato di non aver concluso nulla. E per giunta era affamato, chissà quante ore erano che non mangiava. Si vestì, chiuse la stanza e scesedabasso. L’ascensorista questa volta era una donna anziana, non la ragazza bionda, o forse era un’altracabina,esempre stracarica. Nell’atrio, dietroalbanconevideun nuovo portiere al posto diquellocoicapelligrigi, ma la fila in attesa non era diminuita. Neppure questo portiere capì Budai, né Budai capì lui; era inconcepibile che in un albergo così grande impiegassero personale così incompetente, che non sapeva parlare nessuna delle lingue più diffuse nel mondo. Le persone cominciarono a rumoreggiare, dal fondo della coda gli gridarono qualcosa, gesticolavano, gli indicavano di mettersi alla fine del serpente umano perché li aveva superati: confuso, Budai posò la chiave sul bancone e si allontanò. Nella hall la folla non si era diradata, e tra urti e spintoni si aprì un varco fino alla porta a vetri. Il grasso usciere in cappotto di pelliccia e berretto con il nastro dorato accennò anche stavolta il saluto militare. Fuori, il marciapiede era gremito diunamoltitudinechesi spandeva e turbinava in ogni direzione. Tutti andavano di fretta, trottando, sgomitando per fendere la calca e malmenandosi; una vecchinacolfazzolettoin testa che si trascinava accantoaluiglisferròun calcio alla caviglia, e fu colpito più volte sulla schiena e sul fianco. Sullacarreggiataiveicoli avanzavano in colonne dense, frenando e ripartendo di scatto, tantocheeraimpossibile attraversare, in un ingorgo generale con nervosieincessanticolpi diclacson:videunagran varietà di automobili e camion, furgoni da trasporto, filobus e autobus, ma non riconobbe nessuna marca o modello, nemmeno stranieri. Doveva essere l’ora di punta, e da qualsiasi partetentassediaggirare la baraonda, prima a destra, poi a sinistra dell’uscitadell’albergo,si trovava davanti sempre la stessa congestione. Allora svoltò in una traversa: anche lì il marciapiede era invaso di persone e la strada bloccata da fiumi di macchine. Riuscì a farsi largo con fatica. Certo, non voleva nemmeno allontanarsi troppo, perché temeva di perdersi e non ritrovare lastradaperl’albergo. In alto sfolgoravano insegne luminose e la maggiorpartedeinegozi era ancora aperta. Vendevanoditutto,nelle vetrinec’eranoarticolidi ogni tipo: abiti, scarpe, stoviglie, fiori, elettrodomestici,tappeti, mobili, biciclette, profumi, articoli di plastica... queste le cose chevidesolopassando.E ovunque una marea di clienti, le code si snodavano dentro i negozi e spesso si prolungavano fino in strada. Particolarmente assediate erano due gastronomie che Budai superò in quel breve tragitto, e con un grosso sforzo: sul marciapiede la calca era quasi impenetrabile, chi restavafuoridalnegozio si assembrava all’ingresso disponendosi in colonne compatte. Riuscire a comprare qualcosa gli parve un’impresa disperata. La fame però lo tormentava, e fu con sollievo che scorse un ristorante poco più in là, dietroallegrandivetrine videtavoliapparecchiati, clientichemangiavanoe camerieri in giacca bianca. Purtroppo c’era la coda anche lì, e molto lenta, perché lasciavano entrare la clientela col contagocce, tante persone quante ne uscivano. Con discrezione, si mise a osservare quelli che stavano in fila insieme a lui. Ce n’erano sia bianchicheditantealtre razze: due ragazzi neri come il carbone e coi capelli crespi, più avanti una donna dalla pelle gialla con gli occhi a mandorla in compagnia della sua bambina, dei tipi alti dall’aspetto germanico, un uomo grasso, mediterraneo, con il viso lucido di sudore,inuncappottodi cammello, malesi con la pelle scura, facce dai lineamenti arabi o semitici, una ragazza lentigginosa coi capelli ramati in pullover blu e munita di racchetta da tennis: sarebbe stato difficile individuare una razza o un colore predominante, per lo meno là, davanti al ristorante. Dopo quaranta minuti buoni di attesa finalmente lo fecero entrare; consegnò il soprabito al guardaroba e in cambio gli diedero un numero. I tavoli erano tutti occupati, e impiegò parecchio a trovare un posto in fondoallasala.Domandò in inglese il permesso di sedersi, ma nessuno lo capì:alzaronolosguardo daipiatticonespressione vacua, poi continuarono rapidiamangiare.Anche lì avevano tutti fretta. Passò un’altra mezz’ora prima che arrivasse il cameriere, certo, era pur vero che lo chiamavano da ogni parte e non era mai libero. Sparecchiò sotto il naso di Budai, tolse piatti e bicchieri usati e li sostituì con un coperto pulito, poi gli mise davanti il menu e Budai non riuscì a decifrarne neppure una lettera.Cercòdispiegarlo all’anzianocamerierema questi si strinse nelle spalle,farfugliòqualcosa di incomprensibile e se ne andò, richiamato altrove; Budai si rivolse di nuovo ai suoi compagni di tavolo, parlò loro in sei o otto lingue, ma senza il minimo risultato, non davano nessun segno di capire e a malapena gli badavano. Era sempre più nervoso, aveva lo stomaco stretto dalla fame e dalla tensione, e sul tavolo non c’era nemmenounpo’dipane. Il cameriere tornò dopo una ventina di minuti, portando al suo vicino una bella porzione di pollo arrosto con un ricco contorno, e benché Budai tentasse di comunicare a gesti che voleva proprio la stessa cosa quello si allontanò, senza lasciar intendere se aveva recepito l’ordinazione oppure no. Nel frattempo nuovi clienti presero il posto dei precedenti, il cameriere rispuntò all’altro capo del tavolo, sparecchiò, servì pietanze e alcuni pagarono il conto: di Budai non si curò e si diresserapidamenteaun altro tavolo. Budai gli fece pss pss e si sbracciò finché quello non tornò, mafusolopergracchiare qualcosa fra lo stizzito e l’indignato, scandendo con foga le parole; se domandasse pazienza o dicesse che non poteva occuparsi di lui, era impossibile capirlo. Budai ormai faticava a dominarsi, si agitava sulla sedia, non sapeva più cosa fare, doveva aspettare o che altro? Quando il cameriere riapparve continuando a ignorarlo anche questa volta, picchiò la mano sultavolo,spostòlasedia con un calcio e si allontanò esasperato. Al guardaroba c’era la coda per ritirare il soprabito perché il viavai era aumentato, e Budai avrebbe voluto prenderli a spintoni dalla rabbia. Pagò l’addetto con una monetina: il vecchio doveva esserne soddisfatto perché borbottò qualcosa che sembravaungrazie. Già, ma non aveva ancora mangiato, ormai non riusciva a pensare ad altro. Per strada proseguì sgomitando nella ressa che non diminuiva, si fece largo con le mani e coi piedi fino a quando, a prezzo dicalciepugni,quasidei corpo a corpo per guadagnare qualche metro, dopo una lunga ricerca, più o meno ottocento metri oltre il ristorante si imbatté in quella che pareva una tavola calda. Il locale era gremito di persone in fila,echissàperchecosa; si mise in fondo a una coda qualsiasi. Procedevano piuttosto lentamente; solo più avanti scoprì che il serpente umano faceva capo a una cassa dove si pagava, veniva rilasciato uno scontrino e di lì la coda proseguiva nella vasta sala fino al bancone dal lato opposto, dove distribuivano i piatti. Quando arrivò alla cassa la donna in camice azzurro lo guardò in attesa: Budai precipitò nell’imbarazzo e non riuscì a proferire alcun suono, ma tanto qualsiasi cosa avesse detto non sarebbe stato capito. La cassiera lo redarguìinquellalingua sconosciuta,einrisposta lui balbettò qualche parolainspagnolo,senza sapere perché. Ma le persone dietro di lui avevanogiàcominciatoa rumoreggiare, brontolandoperiltempo che ci metteva, facendo tintinnare le monete nella mano, lo incalzaronoelospinsero via:auntrattosiritrovò oltre la cassa e senza lo scontrino. Il cliente successivo era già davanti alla donna in camice azzurro, era impossibile rientrare nella fila, erano troppo ammassati, e comunque non gliel’avrebbero permesso, avrebbe dovuto rimettersi al terminedelserpente.Era assurdo rimanere in coda senza scontrino, non l’avrebbero servito, ma non aveva altra scelta, e si lasciò portare dal flusso. E quando alla fine arrivò al bancone, dove ognuno consegnava il foglietto ricevuto alla cassa al personalecolcappelloda cuoco e otteneva in cambio cibo e bevande, solo lui gesticolava a mani vuote, tentando inutilmente di spiegarsi. Senza scontrino non gli diedero retta, gli fecero passare sopra la testa e sotto il naso piatti pieni di arrosti e di pasticci: a quelpuntopestòipiedie tirò un pugno nell’aria – chi gli garantiva che dopo un’altra fila ce l’avrebbefatta? Si trascinò in strada, abbacchiato e avvilito, e aveva ormai perso ogni speranza di cenare quando all’angolo scorse una vecchietta che vendevacaldarroste,con appena tre o quattro persone che aspettavano attorno al braciere di ghisa. Impiegò mezzo minutoperarrivarci,ma anchequinonglivalsero la sua professione di linguista e la sua conoscenza più o meno buona di almeno venti lingue; per farsi capire dovettericorrereaisegni come un sordomuto. Comprò tutte le castagne, una quarantina, non ne aveva mai prese così tante. Pagò con una banconota di piccolo taglio e la vecchietta gli diede perfino il resto. Le mangiò subito, roventi, intanto che camminava, le divorò avidamente, scottandosi la lingua, e mentre mangiava gli vennero le lacrime agli occhi, provò pietà per sé stesso, si sentiva così sperduto ed estraneo in quella città. Via, via: era il suo unico pensiero, tornare in albergo, prendere il bagaglio e andarsene, al più presto, in aereo, in treno, con qualsiasi mezzo, pur di non rimanere in quel posto un giorno, un’ora dipiù. L’usciere gli spinse la porta a vetri; al banco della reception c’era un altro tizio. Al termine dell’immancabile fila Budai non riuscì a spiegarsi neanche stavolta,invanoindicava la sua chiave appesa fra le altre, il portiere si limitava a scuotere la testa con aria un po’ annoiata.Allorascrisseil numero della sua stanza su un foglietto e così ottenne la chiave della 921. A manovrare l’ascensore c’era di nuovo la ragazza alta e bionda in divisa blu, lui la salutò con un cenno del capo, ma lei non lo vide nemmeno, fissava conariaassenteeassorta oltre la sua testa, poi lo spazio fra loro si riempì di persone e lui poté rivederla solo per un attimo,quandouscì. In camera scoprì di avere il corpo pieno di lividi ed escoriazioni, se li era procurati nella mischia, in strada, e inoltre gli era piombata addosso una grande stanchezza; con un lieve senso di allarme constatò che non aveva ancora concluso un bel niente. Nel luogo da cui proveniva e in quello di destinazione,acasasuae a Helsinki, forse non immaginavano proprio dove fosse finito. Ma la vera assurdità era che neppure lui ne sapeva di più: al momento non aveva la minima idea di come ripartire, da che partecominciare,conchi parlare, quale prassi seguire... Fu assalito da una sensazione sinistra, unoscurosensodicolpa, il sospetto di aver tralasciato qualcosa, di non aver fatto quel che andava fatto, ma erano pensieri senza risposta. Inpredaall’ansiasibuttò di nuovo sul telefono ostinandosi a comporre numeri a caso: doveva essere notte fonda ormai, all’altro capo del filo si sentiva squillare ma risposero solo poche vociassonnate,esempre in quella lingua singolare, esotica, inintelligibile, una sorta dibalbettioinarticolato. Per via della sua professione Budai aveva un acuto senso della lingua: il suo campo era l’etimologia, lo studio dell’origine delle parole. Nel corso del suo lavoro si era occupato delle lingue più disparate: senza contare l’ungherese e il finlandese, naturalmente, tra le lingue ugrofinniche aveva studiato il vogulo el’ostiaco,poiconosceva il turco, qualcosa di arabo e di persiano, nonché il paleoslavo, il russo,ilceco,loslovacco, ilpolacco,ilserbocroato. Ma la parlata di quel luogo non ricordava nessuna di queste, e nemmeno il sanscrito, l’hindi, il greco antico o moderno; e non poteva essere una lingua germanica, poiché Budai sapeva il tedesco, l’ingleseeancheunpo’di olandese. Conosceva il latino, il francese, l’italiano e lo spagnolo, masticava il portoghese, il romeno, il ladino, e avevanozionidiebraico, armeno, cinese e giapponese. La maggior parte, ovviamente, le conosceva soltanto per iscritto, avendole studiate sui libri quando si era occupato dell’origine di certe parole, ma era abbastanza per rendersi conto che quell’idioma non somigliava a nessunadiesse,eperciò, in base al solo orecchio, non era in grado di comprendere a quale gruppo linguistico appartenessero quegli edede,ghiaghiaghia–così suonavano all’incirca. Andò a staccare il testo incorniciato accanto alla porta, e alla scrivania, alla luce della lampada, loesaminòconmaggiore attenzione. Ma non venne a capo di nulla, non aveva mai visto caratteri del genere, tentò di leggerli in un senso e nell’altro, invano. Non capì neppure se si trattava di una scrittura alfabetica, comelelingueeuropee,o sillabica, come il giapponese, o di ideogrammi, come il cinese,odiunascrittura consonantica, come le antiche scritture semitiche o l’aramaico; di nuovo, non riuscì a farsi una ragione dei numeri arabi presenti nel testo. Ma ormai era talmente esausto che il suo cervello non ragionava più e preferì rinviare all’indomani ogni chiarimento; si spogliòesicoricò. Aveva l’abitudine di leggere una mezz’ora prima di dormire, e si accorse di non avere nulla: i libri, gli appunti, la relazione per il congresso, era tutto nell’altra valigia, quella grande. Si rialzò, svuotò la borsa, ma niente; si stizzì per non aver preso almeno un giornale o una rivista sull’aereo. Si rigirò a lungo nel letto, senzaaddormentarsi,poi decisediaprireunadelle bottiglie di vino rosso cheavevaportato.Provò a cavare il tappo con la lama del coltellino tascabile, ma ottenne solo di sminuzzarlo in pezzi che spinse dentro labottiglia.Nonpotendo richiuderla finì per berla tuttaapiccolisorsi,enei fumi di un’ebbrezza senzapensierisprofondò finalmentenelsonno. Il mattino dopo si svegliò intontito e con il malditesta;iltempoera grigio ma non pioveva. Dalla finestra chiusa guardò giù in strada, perfinodalnonopianosi vedevalafollainbasso,il flussoneroecontinuodi veicoli e pedoni. Si sentiva lo stomaco fuori posto, aveva bevuto troppovino,esispazzolò i denti a lungo per eliminare il sapore sgradevole che aveva in bocca. Fece una doccia, strofinandosi il viso e la fronte sotto il getto d’acqua caldissima, si asciugò energicamente dallatestaaipiedi,conil grande telo di spugna, finoadarrossarelapelle. In una tasca laterale della borsa scovò un panino al salame che gli era sfuggito: l’aveva certo messo lì sua moglie, per il viaggio. Poteva mangiarlo per colazione,magariconun tè, ma non c’era traccia di un campanello per chiamare la cameriera o un inserviente. Forse bisognava usare il telefono, ma avrebbe dovuto sapere quale numerocomporreecosa chiedere, insomma, si sarebbe ritrovato nella stessa situazione della sera prima... Di colpo fu preso dall’impazienza e da una lucida voglia di agire: basta, quell’assurdità era durata fin troppo, lui aveva affari urgenti da sbrigare a Helsinki, a breve sarebbe iniziato il congressointernazionale di linguistica e, sia pur con ritardo, doveva arrivarci e tenere la sua relazione. Riempì di nuovo la borsa, la lasciò pronta sul portavaligie e si decise a scendere per chiarire una volta per tutte quella faccenda e ripartire. Agli ascensori c’erano sempre lunghe file d’attesa, e a giudicare dalle lucine sulle bottoniere stavano funzionandotuttieotto; evidentemente al mattino il viavai era moltointenso.Budainon trovò le scale, o per lo meno non le vide dopo i corridoi, così si rassegnò a mettersi in coda, nella fila più esterna. Gli ascensori però arrivavano di rado, per interi minuti non si sentivacheillorofruscio dietroleportechiuse,su e giù. E quando uno si fermava ci entravano solo in quattro o cinque, perché le cabine si erano già riempite ai piani superiori – a quell’ora scendevano tutti. Il gruppochesisfoltivapiù lentamenteeraproprioil suo, da dieci minuti non si aprivano le porte automatiche; temendo che l’ascensore avesse sospeso il servizio, passò nella coda accanto. Ed ecco che l’altra fila si mosse, mentre la sua si bloccò,elepochevoltein cui l’ascensore si fermavalafrecciaaccesa erasemprequellarivolta verso l’alto; c’era da impazzire. Quando approdò al pianterreno Budai era ricoperto di sudore, per la calca e la rabbiarepressa. Nella hall c’era lo stesso affollamento del giorno prima, forse di più: capannelli di gente, persone in fila, altri che cercavano di attraversare la sala sgomitando; non era chiaro se fossero tutti ospiti dell’albergo o altrimenti che cosa ci facessero lì. Iniziò ad aprirsi un varco nella ressa fino alla reception, e gli occorse un sacco di tempo, forse una mezz’ora, prima di trovarsi al cospetto del portiere di turno. Era nuovo, non l’aveva mai visto, ma al pari degli altri non capiva Budai e rispondeva con lo stesso incomprensibile cicaleccio. Budai non riuscìpiùadominarsi,fu colto da un accesso di collera e, rosso in viso, picchiando la mano sul banconepreseaurlarein varielingue: «Skandal, ein Skandal!... C’est un scandale, comprenezvous...?». Gridòtuttoquelchegli veniva in mente, protestava che gli restituissero il passaporto e il biglietto aereo,volevaparlarecon il direttore, pretendeva che chiamassero un interprete; si abbandonò alle minacce, ripeteva pass, passport, passaporto; la scenata attirò l’attenzione e molti gli si assieparono intorno. Il portiere allargava le braccia perplesso,alloraBudaisi sporse sopra il bancone, afferrò l’anziano impiegato per le spalle e cominciò a scuoterlo, a urlargli in faccia. Senza costrutto, dato che questi non capiva una parola, né gli altri testimoni della scena davano il minimo segno di intendere. Erano lì ad aspettare il loro turno e, ormai spazientiti, premevano, ognuno interessato al proprio caso;tuttofinìinniente, come una bolla di sapone, il portiere si riaggiustò la giacca e Budai si perse d’animo, imbarazzato.Sitrattenne ancora un momento, cercando con lo sguardo lo schedario o l’armadietto dove potevano essere custoditiipassaporti,ma non c’era modo di oltrepassare il bancone per raggiungere l’ufficio della reception; provò ancheunpo’divergogna perilputiferiocheaveva scatenato, non era davvero nel suo stile. Si rese conto che sarebbe stato penoso e soprattutto inutile esasperare la situazione, e dopotutto neanche quelli alle sue spalle potevano restare là in eterno.Così,dopoessersi asciugato il collo e la fronte, e essersi soffiato il naso, cedette e in silenzio, docilmente, si lasciò spingere via, ancora una volta senza averconclusoniente. Nella hall c’erano dei grandi tavoli rotondi circondati da poltrone; una si era appena liberata.Andòasedersie chiuse gli occhi. Magari tuttoquestononeravero e lui si trovava già a Helsinki, o ancora nel suo paese, non si era mossodacasa.Oppuresi trovava là, ma ormai eranovenutiasaperedel suoinconveniente,dilìa poco sarebbero arrivati, si sarebbero scusati, gli avrebbero spiegato; ogni cosasisarebbechiaritae sistemata. Forse era questione di pochi minuti, bastava contare fino a sessanta, al massimo fino a cento... Ma quando riaprì gli occhi vide la hall dell’albergo e quella massa di gente in movimento, le scritte e i manifesti turistici illeggibili, i paesaggi e le gigantografie alle pareti esullecolonne,igiornali dai titoli misteriosi e indecifrabili, uomini, donne, vecchi e giovani, persone di ogni tipo e natura. In quell’istante gli passò davanti uno strano corteo dall’aspetto esotico, una specie di delegazione di sacerdoti, vegliardi barbuti, per la maggior parte di pelle scura, vestiti con un lungo caffettano nero, il copricapo viola, cinture colorateallavitaegrosse catene d’oro al collo: la folla si apriva con rispettoalloropassaggio mentre incedevano maestosi uno dietro l’altro. Si sforzò di mantenere la calma: urla e strepiti non conducevano a nulla, questo era chiaro. Provò a riorganizzare i suoi pensieri: innanzitutto doveva recuperare il passaporto, questa era la cosa più urgente, e naturalmente anche il biglietto aereo, senza il quale non sarebbepotutoandarené a Helsinki né, dopo il congresso, rientrare in patria. Con i documenti inmanosisarebbepreso iltempodiscopriredove si trovava, come c’era finito,dichieralacolpa, in che modo era stato catapultato in quella stupida avventura e così via... Ma prima di tutto dovevametterequalcosa sotto i denti, poiché aveva fatto una magra colazione e lo stomaco glielo chiedeva con prepotenza,naturaleche poi fosse nervoso. Non era possibile che all’interno dell’albergo non ci fosse un ristorante o qualcosa di simile.Decisedicercarlo. Affrontò la bolgia e fece il giro della sala d’ingresso, che era vastissima, cento o centocinquanta metri di lunghezza e la metà in larghezza. Da un lato della sala si vendevano souvenir e altri oggetti: si mise a osservare le bambole, le statuine, i cofanetti dipinti, braccialetti, spille e altre cianfrusaglie, le macchinefotografichedi marca sconosciuta, i binocoli da teatro. Prese un portachiavi da un ripiano di vetro, c’era il disegno di un bastione o di una torre con una scritta, probabilmente si trattava di un monumento caratteristico della città: edificio ignoto, scritta indecifrabile. Ciò nonostante decise che, prima di andarsene, se ne sarebbe comprato uno, in ricordo di quell’assurda storia, della notte trascorsa in quelposto. Non riuscì però a trovare il ristorante, pur avendo perlustrato con attenzione tutta la hall e perfino chiesto indicazioni a un signore, ripetendo le parole restaurant e buffet; siccome quello si limitava a guardarlo con ariaottusaBudaimimòil gesto di mangiare, portando la mano alla bocca. Allora l’uomo, un tizio allampanato col naso adunco, sembrò capire e alzando la voce, unavoceaspra,glichiese qualcosa che suonava come: «Patiaghiaghiabbu? Vevetereplibobo...?». Ma può anche darsi chedicessetutt’altro–in quella città articolavano le parole in una maniera così strana che a Budai riusciva impossibile scriverle, benché conoscesse alla perfezione e usasse regolarmente l’alfabeto fonetico con cui i linguisti annotano i più vari tipi di suoni e le più sottili sfumature di pronuncia. Il tizio berciava con tono sgradevole e quasi provocatorio, ora l’aveva pure afferrato per il bavero della giacca e indicava in alto, non era chiaro verso che cosa. Budai avrebbe voluto andarsene, ma quello non lo mollava, lo tratteneva gesticolando senza smettere di fare quei versi chioccianti, tanto che alla fine Budai dovette divincolarsi con laforza. Fucongrandesorpresa che più tardi scoprì una scalinata all’angolo opposto della hall: una larga scala con la balaustra di marmo, ricoperta da una passatoia rossa, che salivaalpianorialzato,o primo piano, e conduceva a un corridoio. In fondo al corridoio c’era un’ampia porta a vetri, ma entrambiibattentierano stati staccati e appoggiati al muro; al di là della porta, si apriva un vasto locale con il soffitto a volta, ingombrodiimpalcature sullequalisimuovevano su e giù alcuni imbianchini,lanciandosi grida. Al centro, per quanto poté scorgere tra i ponteggi, sembrava esserci una statua o una fontana ricoperta da un telo, da un lato un enorme bancone e, dietro, una pedana con un pianoforte protetto da un drappo; in un angolo, accatastati, tavoli e sedie in gran quantità;eingiroschizzi di pittura, e malta e calcinaccisulpavimento. Non c’era alcun dubbio, era il ristorante, temporaneamente chiuso per i lavori di imbiancatura. Adesso capì che cosa cercava di dirgliiltizioallampanato e perché indicava con insistenza verso l’alto. Uno degli operai, con la tuta sporca, il secchio in mano e un cappellino di carta in testa, passò accanto alla porta: Budai tentòdichiedereanchea lui, a gesti, dove poteva trovare da mangiare. L’uomo strizzò gli occhi, mormorò qualcosa di incomprensibile, scosse la testa e disegnò con il braccio un ampio arco che forse voleva dire: da nessuna parte in tutto l’albergo. Era davvero il colmo della sfortuna: dopo l’infeliceescursionedella sera prima il solo pensiero di uscire in strada gli ripugnava. Ma mangiare bisognava, calcolòchedovevaessere quasi mezzogiorno; in mancanza dell’orologio era il suo stomaco a segnare il tempo, e lo faceva senza tregua... Si ripromise di mantenere la calma, non importa doveoquantoglisarebbe toccato aspettare. In genere gli aerei partono lamattinapresto,quindi ormai il volo mattutino per Helsinki era perso. Voleva mangiare a sazietà, almeno una volta, ed era disposto a dedicare a quello scopo l’intera mattinata; poi si sarebbe informato sui volipomeridianioserali. Tornòapassolentogiù nella hall e, dopo aver pazientemente atteso in coda davanti all’ascensore, si fece portarealnonopianoper prendere il soprabito. Benché la notte prima avesse trovato senza difficoltà la sua stanza, questavoltasismarrìper i corridoi e vagò in ogni direzione finché non si imbatténella921.Eradi fronte alla porta quando sentìsquillareiltelefono, girò in fretta la chiave nella serratura, si precipitòdentro.Nonera nemmeno entrato che l’apparecchio tacque e, sollevata la cornetta, udì il solito ronzio, che sembrava il tubare di un piccione... Si domandò chi poteva essere a chiamarlo:forseavevano scoperto cosa era successo, si erano messi a cercarlo e l’avevano rintracciato, e adesso stavanogiàprocedendoa farlo rientrare? Sedette sulletto,immobile,nella speranza che ricominciasse a suonare, poi si innervosì, si coprì la testa di pugni, con rabbia: perché non era tornato mezzo minuto prima?Iltelefonotaceva, Budai lo fissò a lungo pregando che squillasse, ma la fame non gli dava pace; uscì dalla stanza, rientrò, guardò l’apparecchio per qualche minuto, e poi si deciseauscire. Allareceptionsilimitò a consegnare la chiave sulbanco,infilandositra le persone; un’operazione semplice, che pareva consentita. Per strada il traffico non era affatto diverso rispetto alla sera precedente, si trovò in mezzo alla stessa quantità esorbitante di veicoli e pedoni, tra clacson,ressaeurti:non riusciva a spiegarsi dove sidirigevanotutticosìdi fretta a quell’ora, tornavano dal lavoro oppure ci stavano andando, e in ogni caso, chi era tutta quella gente, da dove veniva quella piena inarrestabile di esseri umani?... Nessuno si curava di lui, non lo degnavano di un’occhiata, ma se si distraeva per un istante, se solo si fermava a guardarsi intorno, veniva immediatamente preso a spintoni e faticava a rimanere in piedi. Capì che se voleva ottenerequalcosainquel luogo doveva ricorrere anche lui alla forza, alle spallate e alle gomitate. Masiaffrettòascacciare unpensierocosìsubdolo: da quel posto lui non voleva proprio niente, se nonmangiareasazietàe andarsene al più presto, adieu,finedellastoria. Il tempo era nuvoloso e freddo, quasi si gelava, e soffiava un vento fastidiosoetenace;alzòil bavero del cappotto e si calcò il cappello sulla fronte. Si avviò nella direzione opposta a quelladelgiornoprimae decise, già che era capitato lì, di osservare ciò che lo circondava. Lungo la strada vide palazzi vecchi e nuovi, grattacieliebassecasette a un piano, baracche di legno, casermoni di quattro o sei piani dalle facciate scrostate, e poi una torre di vetro e cemento armato, che si slanciavaversoilcielo,e poco dopo un’altra uguale, in costruzione: non aveva punti di riferimento, non sapeva se quello era il centro città o la periferia. Guardòlastradaconpiù attenzione, e nel traffico tumultuoso che somigliavaaunfiumein piena individuò tre tipi di autobus, alcuni verdi, alcuni rossi e altri bianchiemarroni,eoltre a questi dei filobus con un numero – 8, 11, 37 e 137 –, ma non poteva averealcunaideadelloro percorso. Vide anche dei taxi, o per lo meno lo sembravano, tante auto grigie con una striscia rossa sulla fiancata, il tassametro e una bandierina pieghevole di fronte al conducente. Provò a fare un segno con la mano, senza nessun esito: erano pressoché tutti occupati, ma gli autisti non gli badavano nemmeno se erano liberi, forse la corsaeragiàprenotata.È verocheisuoicenninon erano particolarmente convinti, quasi temesse che anche in quella situazione sarebbe stato inutile cercare di spiegare, esprimersi a gesti; tanto non l’avrebbero capito, e del resto neppure lui aveva chiaro dove voleva andare. Non lontano dall’albergo il traffico si riversava in una piazzetta, al centro della qualeun’ampiascalacon il corrimano giallo si infilava al di sotto del livello stradale, gremita dipersonechesalivanoe scendevano.Ilcoloreela forma del corrimano gli sembrarono familiari: forse la sera prima, sul pullman che l’aveva portatoincittà,neaveva visti di simili. Quando scattò il verde al semaforo, una marea scura di passanti lo trascinò verso il centro dellapiazzaedilìgiùper le scale. Proprio come pensava, era una stazione della metropolitana: un grandeatrioovaledacui si diramavano tanti corridoi, con frecce dipintesuimuriecartelli grandiepiccoli–perlui, alsolito,incomprensibili – a indicare le varie direzioni. I passeggeri che uscivano o cambiavano treno si incrociavano con quelli che scendevano nell’atrio, imbottigliandosi in una calca vorticosa e quasi impenetrabile. Dalla parte opposta le scale mobili che portavano al livello più basso inghiottivano e rigurgitavano senza sosta flussi di folla: in quellaressaformicolante Budai stentava a tenersi in piedi. Ciò nonostante provò a farsi strada, aveva scorto un’enorme mappa sulla sinistra e cercò di raggiungerla. Invece rimase imprigionato nella correntedirettaallescale mobili, che lo strappò verso l’altro capo dell’atrio, ma lui non aveva nessuna intenzionedisaliresuun treno,noninquellacittà. Però era impossibile resistere a un tale esercito, o passarci in mezzo, e solo a prezzo di un vero contrasto, a forza di ginocchiate e pugni, e restituendo spintoni, riuscì a liberarsi e portarsi ai margini del flusso, dove l’impetodellamarciaera rallentato dalla corrente contraria. La mappa incollata su una lastra di vetro rappresentava la rete metropolitana, con le stazioni,icollegamentie le linee in diversi colori; era uno schema piuttosto intricato di raggi e cerchi concentrici. Sotto c’era una serie di pulsanti, presumibilmente corrispondenti alle fermate: schiacciandone uno, sulla mappa si illuminava il percorso. Attese il proprio turno, perché anche qui aspettavanoinmolti,poi provòapremereunpo’a casaccio. La prima destinazione che scelse era raggiungibile con una sola linea, per la seconda bisognava cambiaredueotrevolte; ma sulla mappa c’erano solo le stazioni della metropolitana,nonlevie e le piazze in superficie, la città vera e propria, e Budai non riusciva a orientarsi. E anche se fosse stato in grado di leggere i nomi sui pulsanti non gli sarebbe stato di nessun aiuto, perché non avrebbe saputo collocarli in quel nulla ignoto e sordo. La fermataincuisitrovava era segnata con un cerchietto rosso, ed era anche un po’ più sporca delle altre perché tutti ci appoggiavano il dito sopra. Budai non capì la scritta, ma notò che si trovava in basso a sinistra sulla cartina, all’intersezione tra un raggio e una linea circolare, più o meno a metà strada fra il centro e la periferia, dunque in uno dei quartieri a sud- ovest della città. Sempre che segnassero anche loroilnordinalto. Tornòinstrada:apoca distanza dal metrò stavano costruendo un grattacielo altissimo. Piegando il collo di lato, Budai si mise a contarne i piani: erano arrivati al sessantaquattresimo,ma lo scheletro d’acciaio svettava ancora più alto. Sulle impalcature brulicavano come formiche nere nugoli di operai, i montacarichi portavano su e giù uomini, materiali, elementi prefabbricati, enormi pannelli di cemento armato... Le proporzioni dell’edificio e le dimensioni del cantiere oltre che impressionarlo lo spaventarono, come se questo potesse crollargli in testa da un momento all’altro e seppellirlo per sempre. In ogni modo, non era certo uscito per starsene lì a bocca aperta; entrò nel primo negoziodialimentariche vide e si mise pazientemente in coda, come gli altri clienti. E quando i commessi non capironoquelchediceva non si arrese, e non si lasciò spinger via finché non ebbero preso e pesato tutto ciò che indicava. Gli toccò fare code diverse, per i salumi, per il burro e il formaggio, per il pane e un’altra dalla parte oppostaperilpescefritto di cui gli era venuta voglia. In cambio ottenne solo scontrini, con i quali dovette andare di nuovo in coda alla cassa. Pagò senza avere idea di quanto stesse spendendo, ritirò il resto, e tornò in fila ai banchi della merce: l’intera procedura durò circaun’oraemezzo. All’ingresso dell’albergo stazionava semprel’uomoobesocon ilberrettodallafettuccia dorata: ma questo quando dorme, si chiese Budaipassando.Ottenne la chiave nello stesso modo della sera prima, scrivendo «921» su un foglietto che poi si infilò nella tasca del cappotto, per le future evenienze. Agli ascensori si fermò unmomentoaosservare in quale cabina fosse l’ascensoristabionda;era in quella centrale, e fu lì che Budai entrò. La ragazza stava leggendo, non staccava gli occhi dallibroneanchementre schiacciava i bottoni dei piani richiesti. Sollevò lo sguardo solo quando Budai, non sapendo come comunicarle che voleva scendere al nono piano,lesfioròilbraccio. Lei lo fissò per un breve istante, con l’aria un po’ stranita, come chi si risveglia da un sonno profondo, poi le porte automatiche si aprirono, eranoarrivati. Durantelasuaassenza avevano rassettato e pulitolacamera,erifatto il letto. Trovò il pigiama sotto la coperta e le pantofole dentro al comodino. Questo suscitò in lui un vago allarme: lo consideravanouncliente stabile? Scacciò quel pensierosciocco:nonera micaaffaredelpersonale di servizio, che cosa potevano mai saperne... Aprì il sacchetto, affettò ilpaneconilcoltellinoe, smanioso, si preparò un sandwich. Tutto aveva un gusto insolito, dolciastro, i salumi, il pane, il cetriolo, perfino il pesce, un sapore diverso da quelli che conosceva. Incartò con curagliavanzielidepose fuori dalla finestra. Aveva finalmente mangiato, a sazietà, mancava solo il caffè di finepasto.Manonaveva nessuna voglia di uscire e di mettersi in cerca di un caffè. Si sarebbe invece riposato un po’, soddisfatto di essere riuscito a sfamarsi nonostante le difficoltà. Lanciò via le scarpe e si sdraiòsulcopriletto. Siaddormentòperdue o tre minuti al massimo per svegliarsi di soprassalto in preda a un’inquietudine angosciosa, con il cuore ingola.Eraun’assurdità, una follia starsene là sdraiato mentre a Helsinki c’era il congresso di linguistica, dove era previsto il suo intervento già il primo o ilsecondogiorno;magari era stato eletto in qualche commissione e i suoi colleghi non si spiegavano la sua assenza.Checifacevalui qui, e che cos’era questo qui,doveera,inchecittà, paese, continente, in quale dannata parte del mondo era finito? Provò a ripercorrere ancora una volta tutta quella vicenda senza senso, fidando nella sua capacità di ragionamento, quell’attitudine deduttiva sviluppata in anni di lavoro scientifico, e non ultimo anche nella sua esperienza di viaggiatore, poiché aveva visitato molti paesi sin da quando era studente. Ma per quanto ripassasse nella mente gli eventi delle ultime ventiquattr’ore, anche a ritroso, non gli riuscì di individuare in quale circostanza avrebbe dovuto agire diversamente, dove o a chi avrebbe potuto rivolgersi. Non dubitava che l’equivoco all’origine di tutto si sarebbe chiarito, e a quel punto lui sarebbe potuto ripartire subito, tuttavia ebbe un attimo di smarrimento: senza amici né conoscenti, privo di documenti, abbandonatoinunacittà sconosciuta di cui ignorava perfino il nome, dove non capiva quel che dicevano e nessuno capiva lui, nonostante tutte le lingue che parlava, in quella inarrestabile e inestricabile massa umana, che non si diradava mai, non aveva ancora incontrato nessuno con cui scambiaredueparole. Cercò di raccogliere le poche idee che si era fatto di quella città. Doveva essere una grande città, questo sembrava assodato, una metropoli, uno di quei centri urbani di livello mondiale dove non era mai stato. Per il momento non intuiva nemmeno in quale parte del globo potesse trovarsi,inchedirezione e soprattutto quanto lontano da casa. Rifletté su quest’ultimo dato, perché avrebbe potuto pensarci la sera precedenteeosservarela crescitadellabarbadopo il viaggio in aereo, durante il quale aveva dormito tutto il tempo: perfarsiun’ideadelleore trascorse e così calcolare la distanza in linea d’aria. Ma la sera del suo arrivo, quando si era fatto la barba non ci aveva badato, doveva essereunpo’intontito,e oranonriuscivaaffattoa ricordarsi quant’era lunga... Era una città densamentepopolata,su questo non c’era dubbio, una densità maggiore di ogni altro luogo che avesse mai visitato, ma era difficile stabilire quale razza o gruppo etnico fosse prevalente. Il tratto più notevole, però, era che la gente non parlava le lingue straniere, per lo meno quelle a lui note; perfino in un albergo enorme come il suo parlavano soltantonellalorolingua materna. E questa suonava completamente estranea alle sue orecchie,diversadatutte le altre, puro e semplice grammelot, come del resto il loro sistema di scrittura, un insieme di scarabocchivacuieprivi di senso. Le condizioni meteorologiche non sembravano fornire alcun indizio: il tempo era secco, freddo, invernale, proprio come febbraio dalle sue parti. Nemmeno i cibi che vendevano nei negozi rivelavano molto del clima locale, erano alimenti che si trovano ovunque – carni, salumi, formaggi, mele, limoni, arance, banane, scatolame, conserve di frutta sciroppata, succhi di frutta, caffè, dolci, pesci di mare; potevano essere benissimo prodotti d’importazione. Neppure la moda differiva dai canoni del mondo civilizzato, gli abiti di boutique si distinguevano da quelli dei grandi magazzini solo per la qualità, e gli altri articoli rispecchiavano gli standard internazionali; tutto questo valeva ben poco per formarsi un’idea, era un’equazione di sole incognite. Che fare? Le autorità locali e l’amministrazione dell’albergo forse ignoravano che fosse capitato lì per errore, senza volerlo, altrimenti gli avrebbero già restituito il passaporto e... Ecco un’altra cosa incomprensibile, un mistero assoluto, il passaporto: perché lo tenevano loro, e dove, se si usa restituirlo al cliente dopo le formalità dellaregistrazione?Eche fine aveva fatto il portiere dai capelli grigi che gliel’aveva preso il primo giorno?, non l’avevapiùvisto;dov’era finito il suo biglietto aereo, dove poteva reclamare, e in quale lingua avrebbe dovuto spiegaretuttociò?Provò disagio ripensando alla penosa scenata della mattina, alla sua insulsa e inutile stizza – e tuttavianonpotevamica lasciare le cose come stavano... Quanto sarebbe rimasto lì, senza farniente,alnonopiano di un albergo sconosciuto di una città sconosciuta? Passò in rassegna, con ordine, i luoghi dove avrebbe potuto recarsi per ottenere aiuto. Alla direzione? All’ufficio informazioni? Da un interprete, in un’agenzia diviaggi,allacompagnia aerea, le idee gli attraversavanolamente, ma dove erano quei posti, a chi avrebbe chiesto indicazioni in quella ressa mostruosa in cui tutti avevano fretta e si rifiutavano di ascoltare oppure reagivano blaterando in modo astruso? Probabilmente in banca o negli uffici pubblici parlavano altre lingue, ma dove erano, come riconoscere anche solo l’edificio senza saper leggere le insegne? E se avessevolutorivolgersia un’ambasciata, la sua o quella di un altro paese? Come l’avrebbe individuata, da che cosa avrebbe capito che ce l’aveva davanti? Dallo stemma sul portone? Doveva tenere gli occhi ben aperti: se avesse perlustrato la città in maniera sistematica, muovendosi con attenzione e stando sempreall’erta,l’avrebbe trovata per forza. Ma soprattutto là, nell’albergo stesso, era inverosimile che in un hotel così frequentato noncifossenessunocon cui riuscire a intendersi. Eragiuntoilmomentodi darsi da fare, doveva vincere il suo riserbo, il suo impaccio, scuotersi dal torpore fisico e mentale per tirarsi finalmente fuori da quella stupida disavventura. Per prima cosa prese un foglio dal quadernetto – ne teneva sempre uno in tasca per annotare quello che gli passava per la mente – e scrisse poche righe in inglese per spiegare da dove veniva, dove era diretto e così via, pregando la direzione di agire urgentemente per aiutarlo a ripartire, o di mandargli una persona competente con la quale poter chiarire la faccenda. Dopo aver firmato aggiunse «camera 921», come avrebbe fatto un detenuto in cella, e gli venne da sorridere. Poi tradusse il tutto in francese e in russo; intendeva consegnare il foglio alla reception dove, logicamente, l’avrebbero passato a chi di dovere, qualcuno che conosceva per forza almeno una delle tre lingueeavrebbepresole misurenecessarie. Sollevò di nuovo il ricevitore e provò a formare dei numeri che, a intuito, potevano essere quelli di pubblica utilità: 0, 00, 01, 02, 11, 111, 09, 99 e così via, senza nessun risultato, oppure, per tutta risposta, l’immancabile cicaleccio.Erafuribondo, noncapivaperchénonci fosse un elenco telefonico nella stanza, non riusciva a farsene una ragione, cominciò a schiacciare esasperato il tastoperinterromperela linea, a sbatacchiare il telefono, urlando: «Pronto!... Hallo!», e alla finebuttògiùlacornetta contaleviolenzacheper poco non la fracassò... Decise di procurarsi un elenco a qualunque costo, non importa dove o come. Si rivestì in frettaeuscì. Giù alla reception provò a superare le personeinattesa:riuscìa consegnare al portiere la chiave,estavaperdargli anche i foglietti quando gli altri iniziarono a rumoreggiare, lo ostacolarono e gli fecero segno di andare alla fine della coda. Così fu costretto a mettersi pazientemente in fila e una volta dinanzi al portiere gli schiaffò in mano il testo trilingue. Questisirigiròifoglietti tra le mani sbattendo le palpebre, farfugliò qualcosa che suonava come una domanda, ma Budai tagliò corto e si defilò mescolandosi alla folla. Camminò su e giù nella hall dell’albergo, alla ricerca di un telefono pubblico. Non ce n’erano, o non ne trovò, ma in compenso gli venne in mente che quelmattinoerapassato accanto a una cabina telefonica. Uscì, si lasciò trascinare dal fiume di follaebenprestolavide, non proprio dove ricordava ma all’angolo successivo. Era davvero una cabina telefonica, ma ovviamente era occupata, e accerchiata di persone in attesa. Gli parve un’impresa senza speranza quella di aspettare il proprio turno e sotto gli occhi di tutti staccare l’elenco fissato alla cabina e portarselo via – anzi, gli elenchi, c’erano più volumi, grossi e pesanti. Ma non si arrese, insistette a girare per le strade e a cercare, come se la sua vita intera dipendesse dal fatto di procurarsi un elenco telefonico; scese di nuovo nella metropolitana. Sì, si ricordava bene, lungo una parete erano allineate una decina di cabine: ma anche qui erano occupate e da ognuna partivano lunghe code di cui, nella ressa dell’atrio, non si vedeva la fine. Rinunciò a mettersi in fila ma decise, già che c’era, di andareastudiaremeglio la mappa della rete sotterranea.Nonriuscìa capirci molto di più, ma senefeceunoschizzosul taccuino: segnò la stazione in cui si trovava, quella col cerchietto rosso, ne ricopiò perfino il nome, disegnando una per una le strane lettere – per ritrovare la strada nel casosifossesmarritoper lacittà. Quando tornò in superficie era ormai buio, i lampioni erano accesi;eraaquell’orache il pullman l’aveva portato in città il giorno precedente. Così erano trascorse ventiquattr’ore. Non gliene importava granché in quel momento, mentre era intento a procedere in mezzo alla calca, inquieto: ormai aveva imparato ad avanzare a testa bassa, a spingere, a lottare per aprirsi il passaggio nella corrente deipedoni,propriocome facevano tutti... Il cantiere del grattacielo era in pieno fermento, sottolalucedeiriflettori gli operai lavoravano, non meno numerosi che di giorno. Più avanti notò una tavola calda che ancora non aveva visto, e vi gettò un’occhiata dentro. Era un self-service, i clienti prendevano a un bancone i piatti pronti che desideravano, e alla fine pagavano alla cassa quel che c’era sul vassoio; e l’affollamento non era maggiore che altrove. Budai se ne rallegrò, era la prima sorpresa piacevole che gli capitava, ed entrò. Si servì di tutto, zuppa, uova farcite, arrosto con un contorno, formaggio e dolce, in preda a una vaga apprensione – chissàquandoavrebbedi nuovo avuto l’occasione di poter mangiare a sazietà. Si versò anche delcaffèdalbeccucciodi un distributore. Alla cassapagòconunpugno dispiccioli,lasciandoche la cassiera prendesse l’importo necessario, poi si appoggiò a un tavolo alto lì vicino e divorò tutto. Ancora quello strano sapore dolciastro, come se avessero zuccheratoicibi,perfino lacarneeleuova. Fuoridallatavolacalda si imbatté in una cabina telefonica vuota. Sul vetro era incollato un foglio con una scritta, presumibilmente diceva che l’apparecchio era guasto, ma le porte non eranochiuseeall’interno c’erano dei voluminosi elenchi, protetti da astucci metallici incernierati alla struttura. Cercò di studiarecomesmontarli; era già pronto ad allentare le viti con il coltellino tascabile quandosiaccorsecheun uomo in divisa grigia lo stava osservando. Indossava una mantellina corta e un berretto: era senz’altro un poliziotto. Budai si rese conto di non aver con sé nessun documento d’identità, e di sicuro non era in grado di spiegare che cosa stesse combinando là dentro. Cominciò a sfogliare il volume, fingendo di cercare un numeroounindirizzo;il poliziotto non si muoveva, lo fissava, con aria diffidente. Decise di cambiare strategia, uscì dalla cabina e gli si rivolse direttamente. Provò in tedesco, in inglese, in italiano e in altre lingue, anche se annaspava, non sapeva benecosachiedere,quali informazioni: l’ambasciata,l’ufficiodel turismo, o che altro genere di aiuto? In ogni modo il poliziotto annuì e puntò il dito verso di lui: «Cetence glubglubb? Guluglulubb?». Dissepiùomenocosìe estrasse un libretto con la copertina nera, lo compulsò a lungo girandorapidolepagine, quindi cominciò a spiegare gesticolando in più direzioni. Parlò parecchio,concalma,poi indicò da qualche parte alle sue spalle, ripetendo in tono pedante alcune frasi, per non essere frainteso – Budai non avevalaminimaideadel luogo verso il quale l’altro lo stava scrupolosamente indirizzando. Infine il poliziottogliagitòildito sotto il naso, come a chiedergli se fosse tutto chiaro: «Turubu scetiekitiovovo?». Sconfortato, Budai riuscìsoloadallargarele braccia; il poliziotto fece il saluto militare e se ne andò. Budai rinunciò a ulteriori tentativi; era anche in pensiero per la nota che aveva lasciato in albergo, a quell’ora probabilmente era già arrivatanellemanidichi di dovere, forse si stavano dando da fare, magari lo stavano cercando e non lo trovavano: si affrettò sulla strada dell’hotel. Stavolta, eccezionalmente, era ancora in servizio il portiere a cui aveva consegnato i foglietti, lo vide da lontano, dal fondo della fila. L’uomo, dall’aria malaticcia e scontrosa, gli gettò uno sguardo assente, e quando Budai gli mostrò ilbigliettoconilnumero della stanza si limitò a consegnargli meccanicamente la chiave, senza altre comunicazioni. Budai allungò il collo per vedere se c’era qualcosa nello scomparto della 921, ma era vuoto, e il portiere glielo sottolineò con le palme delle mani aperte. Budai rimase interdetto,provòafargli capirecheaspettavauna risposta, un avviso, una notizia, doveva esserci un qualche messaggio per lui, ma quello scuoteva la testa borbottando e passò al cliente successivo. Naturalmente era possibile che il messaggio fosse in camera, o fuori dalla porta, magari gli avevano lasciato scritto il nome del luogo o della persona a cui rivolgersi per sistemare le cose. Stava per dirigersi verso l’ascensore quando notò sul bancone un grosso volume, di sicuro un elenco telefonico. Il portiere era voltato dall’altra parte: lo stesso Budai si meravigliò di come ebbe il coraggio di prenderlo e portarselo via sotto gli occhi di tuttaquellagente.Fuun gesto d’impulso, dettato dall’imperativo di procurarsi un elenco a tutti i costi, in fondo era quella la ragione per cui era uscito; la sua mano agì da sola: si mise il volume sotto il braccio e siallontanòtranquillo. Al nono piano però non c’era niente sulla portadellasuastanza,né sulla maniglia, né per terra, né infilato nello spiraglio o altrove; per ben due volte controllò che fosse proprio la 921. E anche in camera non c’era nessuna nota, non un rigo sul tavolo, niente, Budai perlustrò ogni angolo. Non sapeva che cosa pensare: la sua richiesta non era stata inoltrata o dovevano ancora cominciare a occuparsene? Possibile che gli toccasse passare un’altra notte in quell’albergo? In tal caso sarebbe arrivato al congresso di Helsinki nellasecondagiornata,e nonprimadellasessione pomeridiana – ciò lo innervosì al punto che gli salì il sangue alla testa, ma preferì scacciare quei pensieri. Inoltre, era distrutto dagli andirivieni della serata, era fradicio di sudore e sentiva un impellente bisogno di farsi una doccia. E avrebbe dovuto, con sua grandevergogna,disfare di nuovo il bagaglio per prendereilnécessaireeil detersivo per lavare, come d’abitudine, la biancheriausata. Dopo essersi un po’ rinfrescato si mise comodo, in pigiama e pantofole, e si sedette alla scrivania con il volumetrafugato.Eraun libro rilegato di colore marrone, sulla copertina spiccavano tre righe di diversa lunghezza in lettere chiare, di varie dimensioni: i caratteri erano quelli già visti altrove. Aprendolo, nella prima pagina c’era un elenco di venti o venticinque parole, o gruppi di parole, in grassetto e con un numeroaccanto:dicerto i numeri di pubblica utilità. Seguivano sette pagineditestofittissimo quasi senza interruzioni, probabilmente norme e regolamenti del servizio di telecomunicazioni, e poi alcune tabelle che forse indicavano le tariffe. Erano ottocentomille pagine di grande formato, su cinque colonne, stampate a caratteri talmente minuscoli che Budai dovevastrizzaregliocchi perriuscirealeggerli.Gli parvedipoterdesumere, solo in base all’impostazione tipografica, che i nomi non erano in ordine alfabetico, ma raggruppati sotto un titoletto per categorie professionali o commerciali – una sfilza sterminata di parole e numeri,titoletti,parolee numeri. Non soltanto all’inizio, ma anche procedendonelvolume,i numeri non erano di uguale lunghezza: ce n’erano di due, tre o quattro cifre, altri di cinqueosei,altridisette o otto, in modo casuale però, senza apparente criterio. Provò a comporre qualcuno dei numeri in grassetto, che aveva individuato come probabili numeri utili, ma con scarso successo: il telefono non prendeva la linea, oppure dava un segnale intermittente di occupato, oppure squillava a vuoto, e se qualcuno finalmente rispondeva si esprimeva in quel modo incomprensibile, per quanto lui tentasse ogni volta di parlare una linguadiversa. Non aveva senso continuare, dovette ammetterlo; preferì concentrarsisulvolume. Benché non si fosse mai occupato di storia della scrittura, ricordava ancora dai tempi degli studi come Champollion avesse decifrato i geroglificieGrotefendla scrittura cuneiforme nelle incisioni in antico persiano, e come di recente fosse stato svelato il mistero delle iscrizioni maya e delle tavoletteligneedell’Isola diPasqua.Inquesticasii ricercatori disponevano di testi bilingui o trilingui,comelasteledi Rosetta o i reperti di Persepoli, o delle trascrizioni di studiosi precedenti, magari vaghe e imprecise, ma pur sempre decifrabili con un po’ di fatica, pazienzaefeliceingegno. Il metodo era quasi sempre lo stesso: sulla base di alcune considerazioni si ipotizzava che certi segni, o gruppi di segni, corrispondessero a determinate parole o nomi, dunque a gruppi fonetici noti, e in seguito, sostituendo questi gruppi a singoli elementi nel testo, si deduceva progressivamente il significato degli altri segni, fino a dipanare l’intero sistema di scrittura studiato. Eppure, nonostante l’impiego dei mezzi più sofisticati, quanti avevano fallito nell’impresa, e quante volte! E se avevano ottenuto qualche risultato era stato al prezzo di decenni di ingrata fatica. Al giorno d’oggi,invece,afacilitare il compito degli studiosi ci sono potenti calcolatori elettronici in grado di elaborare un’enormemassadidati. Ma lui, lì, in quella stanza, che cosa poteva maifare,dasolo,senzail benché minimo aiuto, di fronte alla scrittura sconosciuta di una lingua sconosciuta? Da qualeipotesipartire,con che cosa confrontarla senza disporre, per ora, di alcun punto di riferimento per capire il significato da attribuire almeno a una stringa di caratteri? Che cosa sostituireachecosa?Ein che punto...? Ciò nondimenoincominciòa trascrivere i segni dell’elenco: ricopiò uno per uno, sull’ultima pagina del volume, che era bianca, ogni nuovo carattere che incontrò nel testo. Questa attività silenziosa, dal ritmo piuttosto simile a quello della raccolta di dati nel suolavoro,apocoapoco lo rasserenò, calmò la sua agitazione e, almeno per il momento, lo riconciliò con la situazione in cui si trovava; assorto in quel compito preciso e circoscritto, quasi si scordò di dov’era e come c’era finito. Alla tavola caldasierasaziato,enon pensò neanche agli avanzi che aveva messo fuori dalla finestra; stappò invece l’altra bottigliadivino. Continuava a rimuginare, chiedendosi che razza di alfabeto aveva davanti: erano segni molto semplici, due o tre tratti per ogni carattere, come le rune dell’antico germanico o l’antichissima scrittura cuneiforme sumerica – maluinoneracertocosì sciocco da pensare che fossero imparentati con sistemi di lingue estinte datempo.Notòl’assenza di segni diacritici e del maiuscolo, quantomeno in quel libro: i caratteri avevano tutti la stessa dimensione. A un tratto si rese conto di averne ricopiati oltre cento, e continuava a trovarne; sorseggiando il vino rosso, si fermò a riflettere,domandandosi checosapotevadedurne. Che si trattasse di una scrittura logografica, dove ogni segno rappresenta una singola parola, e per questo eranocosìtanti?Odiuna scrittura sillabica, come nell’antichità quella cretese e cipriota? Oppure aveva una struttura composita, come i geroglifici egizi, che indicano più elementi ciascuno – parole, gruppi di suoni e singoli fonemi? Magari – glivenneinmenteanche questo – era un catalogo di segni fonetici variamente combinati, come quelli che stilano i linguisti per classificare le più sottili sfumature di pronuncia? Oppure disponevano di tantissimisuoni,ognuno con una sua funzione distintiva? Domande, domande, e nemmeno una risposta... Nel frattempo, quasi senza accorgersene, si era bevuto l’intera bottiglia. Il mattino dopo non era in grado di ricordare quando e in che modo si eraaddormentato. Al risveglio il tempo era grigio come il giorno precedente. Aveva la testa annebbiata, la nausea e si sentiva in colpa per aver bevuto troppoun’altravolta;era in collera con sé stesso, come chi è venuto meno a una promessa. Non osava pensare a quegli ultimi due giorni, lo assaliva solo un bruciante senso di fallimento; l’unica cosa che ormai sapeva con assoluta chiarezza e lucidità era di essere arrivato al limite. Nella doccia aprì il rubinetto dell’acqua fredda, rabbrividì e starnutì sotto il getto gelido. Era una follia, un delirio, un incubo dal quale doveva risvegliarsi: non poteva piùandareavanticosì! Si vestì, si preparò un sandwich con gli avanzi del giorno prima e elaborò un piano: era talmente ovvio e semplice che si meravigliò di non averci pensato prima. Se gli impiegati di quell’albergo erano un branco di incapaci con cui non si riusciva a scambiareunaparola,se mancava perfino il punto informazioni o lo tenevano nascosto, doveva semplicemente cercare un luogo dedicato ai turisti. Alla stazione dei treni, per esempio,odegliautobus, all’aeroporto, agli uffici di qualche compagnia aerea, al porto, marittimo o fluviale, se ce n’era uno da quelle parti. Doveva salire su untaxiefarcapireinun modo qualsiasi dove voleva andare, tutto qui. Poi ci avrebbe pensato l’autista, e una volta sul luogo avrebbe di sicuro trovato la persona adatta... Tutto questo gli pareva ora così chiaro e semplice:stavaquasiper rifare la borsa e portarla con sé per non esser più costretto a tornare in albergo, ma poi preferì lasciarla lì, c’era pur sempre il conto da pagare, altrimenti non gli avrebbero permesso di andarsene, e poi doveva riprendersi il passaporto, sarebbe ripassato per forza. Avrebbe fatto il bagaglio a cose risolte, in un paio diminuti. Nell’ascensore c’era di nuovo la ragazza bionda inuniformeblu.Conaria piacevolmente distratta Budai posò a lungo lo sguardo su di lei. Notò ancora una volta quanto fossesnellaeslanciata,e com’erano delicati i tratti del suo viso ovale; oggi non leggeva, lo sguardostancoeassente era perso nel vuoto – chissà quante corse aveva già fatto su e giù quella mattina. Solo quando arrivarono al pianterrenolaragazzalo vide, e da una piccola luceneisuoiocchiBudai capì che l’aveva riconosciuto.Lesorrisee la salutò con un lieve cenno del capo: era moltoimprobabilechela rivedesse ancora. Non si nascose che un po’ gli dispiaceva, ma era l’unica cosa che avrebbe rimpiantodiquellacittà. Quella mattina tutto appariva diverso, se n’era già accorto in ascensore ed ebbe la stessa sensazione anche nella hall, difficile spiegare come e perché. L’atrio era affollato di persone, ma non c’era il violento pigia pigia degli altri giorni: nel gigantesco salone il flusso sembrava più lento e pigro, rilassato, come se tutti se la prendessero comoda. Il negozio dei souvenir era chiuso, la vetrina era sgombraebloccatadaun lucchetto. Era chiusa l’edicola, sullo sportello dellacassaeracalatauna saracinesca metallica, e dietro il lungo bancone, dove di solito si affaccendava un gran numero di persone, ora ciondolavano soltanto due o tre impiegate, ed era chiusa la maggior parte delle porte degli uffici. In effetti, era partito di venerdì e dunque era domenica, essendo passate due notti: a quanto pareva, era festivo anche lì. Soltanto alla reception il numero di persone era invariato: fu preso dallo sconforto vedendo la lunghezzadellacoda,ma attesequietoilsuoturno per restituire la chiave. Lo scomparto 921 era vuoto,eormaisisarebbe stupitodelcontrario. Il bancone per una volta era libero, le tre impiegate del turno festivo si limitavano a chiacchierare. Budai colse l’occasione: si avvicinò,restòlìdavanti per un po’, poi, siccome loro non gli badavano, cominciò a bussare sul piano. Quelle non reagirono,eluibussòpiù forte finché finalmente una si accostò. Provò a parlarle in varie lingue: la donna lo fissava perplessa e indignata come se fosse matto. Allora Budai tirò fuori il quadernetto e, con un tratto piuttosto goffo, disegnò una locomotiva, poi un aereo, e con le braccia mimò il gesto di volare, sforzandosi di esprimere cosa intendeva e dove voleva andare. Ma l’impiegata, una donna di mezza età dal colorito giallognolo e i capelli raccolti in uno chignon, lo assalì berciando con una tirata incomprensibile e stridula, uno sproloquio che Budai interpretò come: «Che vergogna, che indecenza, neanche di domenica si può stare in pace!» – ma ovviamente poteva aver detto tutt’altro. Budai capì che con le parole non avrebbe risolto nulla: con audace determinazione estrasse dalla tasca una banconota di grosso taglio e la poggiò sul bancone davanti alla donna. Quest’ultima continuò a sbraitare ancora un po’, ma prese il denaro e andò in un ufficio sul retro: l’aveva accettato, forse c’era speranza che fosse disposta ad aiutarlo. Tornò in fretta, e con un’altra ramanzina consegnò a Budai nove banconote di taglio minore, contandole una per una, più una manciatadispiccioli–gli aveva semplicemente cambiato il pezzo da dieci – poi girò i tacchi e lopiantòinasso. Uscito dall’albergo la folla gli sembrò più fluida e il traffico, sebbene intenso, un po’ menofrenetico.Sispinse sul bordo del marciapiede e alzò la mano per fermare tutti i taxi che passavano. Ma eranopochi,nespuntava uno ogni tanto ed era occupato, anzi stipato di persone una sull’altra, fino a otto o dieci passeggeri tra uomini, donne, bambini, anziane signore. E quelli vuoti avevano la bandierina abbassata, oppure transitavano sulla corsia più lontana e non sarebbero riusciti a spostarsi. Infine ne vide uno che arrivava con tutta calma, era anche libero,mainvanogridòe si sbracciò, scese con un piede sulla carreggiata, l’autista non rallentò, non lo guardò, e l’avrebbe pure travolto se non si fosse scansato in tempo. Quando rinvennedallospavento, quello era ormai lontano... Tornò con fatica all’ingresso dell’albergo,dovestavail grasso usciere in pelliccia. Budai si rivolse a lui in varie lingue e scandendobeneleparole nel tentativo di spiegare che aveva bisogno di un taxi o di una stazione di taxi, doveva per forza essercene una nelle vicinanze, e usava testardamente la parola che suona identica in ognipartedelmondo: «Taxi...!Taxi,taxi...?!». Quello si limitò a strizzaregliocchietticon un’espressione ebete sulla faccia pingue e portando la mano alla visiera spinse la porta a vetri per farlo entrare. Budai gli andò vicino, propriosottoilnaso,egli urlò in faccia cosa voleva, al che l’usciere borbottòqualcosacome: «Kiripidu labadaraparaciara... patarasciara...». E ripeté il saluto militare, e spinse la porta, come un pupazzo amollacapacediduesoli gesti.Nelfrattempoaltre persone si erano assiepate attorno all’ingresso. Budai non intendeva bloccare il passaggio e temeva di noncontrollarsi,eracosì infuriato che avrebbe schiaffeggiato quel babbeo: si allontanò verso la carreggiata. Riprese a sbracciarsi, ma non otteneva nulla, e cominciò a dubitare che le auto grigie con la striscia rossa sulla fiancata fossero davvero taxi... Stava per lasciar perdere quando una vetturacheavevavistoil suo cenno incerto si fermò accanto a lui. Il conducente si sporse dal finestrino e gli parlò con la bocca piena, e Budai interpretò che gli domandassedovevoleva andare. Senza indugio glielomostrò,aprendole braccia come ali, poi mimòilmovimentodelle bielle di una locomotiva e aggiunse perfino il fischio del treno. L’autista scosse la testa, ridendo, ma non era chiarosefosseunnoose non capiva. Intanto le macchine dietro suonavano e davano gas ai motori, la fila di auto si allungava perché era impossibilepassarenella corsia di fianco per superare. Budai, preoccupatodiperderela sua unica opportunità, prese una banconota di grosso taglio e la porse all’autista. L’autista rispose qualcosa che, a giudicare dal tono, spiegava il suo rifiuto, era prenotato o aveva terminato il turno e stava rientrando. I clacson ormai strepitavano tutti insieme, con insofferenza: l’autista riaccese il motore e ingranò la marcia. Disperato, Budai tirò fuori un altro pezzo da dieci e infilò la mano nell’auto, che si mosse proprio allora: le banconote caddero nel taxi. Budai non riuscì a rincorrerlo nel traffico intenso. Per un paio di minuti restò come paralizzato dall’ennesimo insuccesso – o forse non era un insuccesso, forse quella che lui vedeva come una catena di sfortune in quella città era la norma. Quanto meno per uno come lui, un forestiero che non parlavalalingua...Infine siriscosseesifeceforza: infondo,potevaarrivare a una stazione ferroviaria anche senza taxi.Glispiacevasoloper i soldi, quei due pezzi da dieci,nonsapevaquanto valesseroma,daquelche aveva visto finora, sembrava una bella somma. Seinegozieranoquasi tutti chiusi, compresi gli alimentari, il metrò era affollato come nei giorni feriali; lungo la strada verso la piazzetta circolare aveva escogitato un modo per arrivare a destinazione. Sifecestradafralagente fino alla grande cartina sul muro, che per il momento rappresentava l’unico punto fermo cui aggrapparsi e che ora l’avrebbe aiutato a orientarsi. Cercò i collegamenti, gli interscambi tra le linee, le fermate cerchiate in rosso, presumibilmente le più importanti. Si sa cheinqualunquegrande città del mondo la metropolitana è collegata alla rete ferroviaria; immaginò che i nomi in corrispondenza delle stazioni dei treni presentassero un terminericorrente,come per esempio a Parigi la Gare de l’Est, la Gare du Nord, la Gare de Lyon, eccetera. Mentre osservava la cartina veniva costantemente spintonato, e più di una volta fu addirittura cacciato via, ma riuscì sempreariconquistareil suo posto. Con gran faticaindividuòscrittedi due o tre parole nelle qualil’ultimacoincideva, non perfettamente, certo, ma poteva trattarsi di piccole differenze grammaticali. Le annotò tutte, riproducendo con cura i segni sconosciuti: la prima stazione su cui cadde la sua scelta era la più vicina, e si raggiungeva con la linea gialla. Dovettemettersiinfila allacassapercomprareil biglietto–pagavanotutti conunamoneta–epoisi diresse verso le scale mobili davanti alle quali la folla s’ingrossava. Di sottovidelamoltitudine incanalarsi in un dedalo di corridoi, tra manifesti e cartelloni affissi da ogni parte, svolte, incroci, sbocchi, e poi ancora scale, giù e poi di nuovosu;freccecolorate indicavano le direzioni, pannelli luminosi con scritte blu, verdi, rosse, nere e gialle. Budai seguiva quest’ultimo colore, ma a un tratto non lo vide più, il flusso umano lo aveva trascinatooltreedovette vagare per un buon quarto d’ora prima di ripescarlo. Si sforzò di prestare più attenzione, si mantenne vigile, gli altricoloricominciarono a scemare finché non restò che il giallo e si ritrovò finalmente sulla banchina, in mezzo a un frenetico andirivieni, investito dalla corrente d’aria provocata dai convogli in corsa nel tunnel. Adesso doveva solo cercare di non prendere la direzione sbagliata: tirò fuori il quadernettosucuiaveva ricopiato il nome della stazione e lo confrontò con quelli sotto le due frecce. Il treno sbucò dalla galleria. I passeggeri lo presero d’assalto scontrandosi con quelli che scendevano, generando il caos e mulinelli di persone vicino alle porte, che riuscirono a chiudersi dopo il fischio di un capotreno dalla pelle scura. Budai si infilò per un soffio. Dentro faceva un gran caldo ed erano schiacciati uno contro l’altro; avrebbe voluto chiedere indicazioni a qualcuno,aiutandosicon gesti o disegni – ma non poteva muovere le braccia, e la gente spintonava, una lotta di posizioni, chi voleva scendere premeva verso leporteelospaziolibero veniva subito riempito. Budai non aveva timore diperderelasuafermata perché lo schema della linea era appeso in vari punti del vagone. Riconobbe con facilità il nome formato da tre parole e contò quante fermate mancavano prima di scendere da quel convoglio, che sfrecciava come un lampo e poi frenava così bruscamente che i passeggeri cadevano gli unisuglialtri. Quando scese si ritrovò in un complicatissimo intrico di corridoi, scarpinò per un bel pezzo, si smarrì, poicapìchelefrecceper l’uscita erano bianche e più grandi delle altre, infinesalìsuscalemobili di una lunghezza infinita... Sbucò in una grandepiazza;ilcieloera plumbeo,copertodauna coltre impenetrabile di nubi, e cadeva una pioviggine silenziosa e gelida.Lafollaeradensa come ovunque, pensò non appena vi si immerse, senza darsi una meta precisa. Doveva essere finito in un mercato o in una fiera: sulle bancarelle e perfino sul selciato si vendeva di tutto, i commercianti urlavano a squarciagola, musica e altoparlanti al massimo volume. C’era soprattutto roba di secondamano,gliparve, mentre avanzava adagio intorno alla piazza, trasportato dal flusso: mobili, lampadari, abiti, pellicce consunte, vasellame, tappeti, cianfrusaglie, oggetti d’antiquariato, prodotti difettosi o di scarto, giocattoli, palloni, grossi tagli di gommapiuma, tubi di ogni colore e diametro arrotolati e impilati, pneumatici, canne da giardino, lastre di vetro. Dentro a una tenda di tela cerata si sentiva gracchiare un grammofono e sul banchetto era accatastata una pila di dischi;Budaisifecelargo per avvicinarsi, nella speranzadiascoltareuna qualche melodia conosciuta, o di scorgere una copertina leggibile: avrebbepotutoessereun punto di partenza, una chiaveperscioglierealtri enigmi. Ma rovistò invanotraidischi–altri curiosi frugavano insieme a lui nella tenda –evidesoltantolesolite lettere e scritte misteriose. Nel frattempo dal megafono veniva un gran baccano, e come se non bastasse proprio alle sue spalle qualcuno si mise a suonare una trombetta: era un grassone con una casaccadamarinaio,che sembrava un cuoco di bordo cinese: emetteva solo due note, stridenti, sempre le stesse – era insopportabile, Budai preferì lasciar perdere i dischieseneandò. Si vendeva anche vaporoso e candido zucchero filato, si arrostivano piccole salsicce speziate che sfrigolavano nel loro grasso, ma erano così tantiinfilacherinunciò. Banchi di sementi, piante da fiore e terriccio, più in là animali vivi, conigli, colombi dalle zampe piumate, canarini, pappagallini, perfino tartarughe, e poi una speciedigrossalucertola crestata ricoperta di squame che se ne stava immobile nella sua gabbia, con lo sguardo vitreo, rigida come fosse impagliata. Un uomo gigantesco con la faccia rossa, e mani e piedi enormi (simile agli indigeni della Patagonia nelle descrizioni degli esploratori), con una consunta giacca a quadretti dal bavero di velluto, era intento a dimostrare le virtù di uno smacchiatore: versava inchiostro, olio, succodipomodorosuun paio di pantaloni chiari, poi faceva sparire ogni traccia con il suo liquido miracoloso, senza smettere di blaterare in ungergotuttosuo.Piùin là stava un pescivendolo col grembiule insanguinato, il quale, avendovistoinBudaiun potenziale cliente solo perché aveva gettato un vago sguardo al suo banco, lo tirò per il cappotto e voleva affibbiargli a tutti i costi uno smisurato merluzzo o chissà che cosa: picchiavalamannaiasul banco, passava la lama del coltello sulla pelle sottile del pesce per mostrarne la freschezza, glielo muoveva sotto il naso, gesticolava, insisteva, a momenti glielosbattevainfaccia... Ad altri venditori fu inveceBudaiarivolgersi, dapprimainvarielingue orientali, poi slave, e ancora in inglese, olandese, spagnolo e portoghese. Ma anche qui, di volta in volta, gli davano risposte incomprensibili oppure lo fissavano con aria ottusa, lo ignoravano o addirittura lo allontanavanocomeuno scocciatore, forse scambiandolo per un mendicante. Budai ripiombò nell’imbarazzo enellosmarrimento. Di stazioni ferroviarie neanche l’ombra. Aveva guardato in tutte le direzioni. Aveva notato un ampio edificio grigio in ferro e vetro ma mentre si avvicinava si accorse che era un mercato coperto, ed era chiuso. Agli ingressi laterali erano in corso le operazioni di carico e scarico:lemerciinarrivo scorrevano su nastri trasportatori, casse vuote e pile di sacchi venivanolanciatedentro ai furgoni, elevatori spostavano balle e container pesanti, facchini caricavano botti,damigiane,blocchi di ghiaccio e di strutto, mezzene di maiale congelate. A un certo punto arrivò un camion pienodicassediverdura – erano porri, o qualcosa delgenere–enesceseun corpulento autista con un giubbotto blu. Vide Budaifermosullarampa. Loafferròperunbraccio, lo tirò verso il camion e indicandoilpianaledisse qualcosacome: «Dümücie brüdimrüciüre!Klütt!...». Queltiziol’avevapreso per uno scaricatore. Un equivoco che l’avrebbe anche divertito, ma lui non era là per divertirsi: arrancandoinmezzoalla folla tornò verso la metropolitana. Doveva continuarelasuaricerca, verificando la serie di fermate dove poteva esserci una stazione ferroviaria. Questa volta doveva prendere la linea viola e poi la verde. I vagoni erano affollati come sulla gialla; provò a fare un piccolo censimento, un esame antropologico dei compagni di viaggio per individuare il colore della pelle, il tipo e la forma del viso più diffusi. Durante il breve tragitto osservò una quantità di sfumature, dal nero carbone al bianco latte passando per il bruno, ma i tipi puri – notò – erano piuttosto rari, troppo pochi per indicare in maniera inequivocabile che ci si trovasse in Europa, in Africa o nell’Asia orientale; benché anche in quei continenti esistessero zone con una popolazione multietnica, per esempio le città portuali.Aognimodo,la maggior parte degli abitanti di quella città doveva essere un incrociodirazze:comela giovane donna – occhi a mandorladagiapponese, capelli biondissimi e labbra negroidi – che era scesa insieme a lui, talmente carica di sacchetti della spesa da finirgli addosso mentre le porte si richiudevano. Budaicolsel’occasionee, dopo un vano tentativo verbale, mimò a gesti la locomotiva per farle capire dove voleva andare. La donna sorrise come se avesse indovinato, disse qualcosa, indicò a destra e a sinistra, poi si avviò infrettaincoraggiandolo a seguirla con un cenno del capo. Budai ebbe finalmentelasensazione di essere sulla strada giusta, si avviò dietro alla donna attento a non staccarsi mai da lei, e lei stessaditantointantosi girava per mostrargli con la testa la direzione. L’uscita–segnalatadalle grandi frecce bianche – non era distante, il corridoio sbucava in un atrio a forma di stella, stavano per arrivare quando un’enorme ondata umana lì investì. Appena si riprese, si accorse che quell’urto irresistibile li aveva strappati l’uno lontano dall’altro; Budai cercò con tutte le sue forze di riavvicinarsi a lei, ma invano. La testa bionda riemerse per pochi attimialcunimetridopo, dove la marea l’aveva trascinata, per poi sparire definitivamente nel turbine dei passeggeri in movimento. Budai la attese in superficie per un po’, ma non la vide più uscire dalla metropolitana. Si diresse verso sinistra, come gli aveva indicato la donna. Questa parte della città sembrava diversa da quanto aveva visto finora, aveva un aspetto più antico, un’atmosfera più intima, le strade strette ma sempre popolose;potevaessereil centro storico, se ne avevano uno. Passò davantiaunsegmentodi muro antico incorporato in una struttura più moderna, con un’iscrizione in alto: doveva trattarsi di un monumento, forse delle vecchie mura cittadine. Anche da queste parti i negozi erano chiusi. Svoltò in un vicolo tortuoso, con gli edifici vetusti dalle facciate scrostate, la strada sporca, piena di immondizie e bucce di frutta; gatti randagi si aggiravano tra le gambe dei passanti e sgusciavano dentro e fuori da androni maleodoranti. Ricominciò a piovigginare; muri tagliafuoco si ergevano ciechi, grigi e umidi nel nulla. Giunse in una piazza; al centro c’era una fontana con la statua di un elefante che spruzzava un getto d’acquadallaproboscide. Intorno girava il traffico delle auto, incessante e denso,comesescorresse dall’inizio dei tempi e dovessedurareineterno. Dalla piazza se ne apriva un’altra ugualmente movimentata,iveicolivi confluivano passando sotto un grande arco, sormontato da un alto torrionecoronatodauna balaustra, con le feritoie eunacupolaincima.Gli sembrò familiare, ma non sapeva perché; lo osservò da ogni lato e a untrattoloriconobbe:lo aveva visto nella hall dell’albergo,alnegoziodi souvenir, sul portachiavi. Non era facile stabilirne l’epoca e lo stile: la parte con le finestre a sesto acuto si sarebbe detta gotica, mentre la cupola emisferica pareva piuttosto orientaleggiante, moresca. Era probabilmente stato costruito a scopo difensivo, e le opere di quel genere si assomigliano tutte – specie agli occhi di profanicomeBudai–con i loro volumi massicci, gli enormi blocchi di pietra grezza, il loro austero scopo pratico: le fortificazioni romane, le torri di guardia medioevali, perfino la GrandeMuragliacinese. Ma di stazioni ferroviarie non c’era traccia. Eppure almeno gliufficidellecompagnie aeree avrebbero dovuto essere in quel quartiere, intuiva,esefosserostati chiusi li avrebbe riconosciuti dalle vetrine: modellini di aeroplani, cartine, borse con il simbolo della compagnia. Anche la Postacentraleegliuffici pubblici sono di solito nel centro storico delle città–maluivedevasolo piazzeestrade,palazzidi varie dimensioni, negozi chiusi, saracinesche abbassate, veicoli e persone, strade e piazze. Ormai cominciava a dubitare di essere davvero nel centro storico; oppure qui la città vecchia non coincideva con il centro amministrativo, come nel caso della City a Londra? O forse esisteva da qualche parte un quartiere ancora più antico? Oppure c’erano diversi centri storici? A chi e come avrebbe potutochiederlo? Si infilò di nuovo nel metrò verso la stazione successiva fra quelle annotate. Si ritrovò a vagare tra edifici anonimi e insignificanti: ricominciò a piovere, e quando smetteva una pesante coltre di nubi incombeva sui tetti. Poi capitòinunparco,anche quello sovraffollato, con bambini che giocavano suiprationellesabbiere, facevano navigare barchette a vela, si dondolavano sull’altalena; donne con lecarrozzine,caniliberie al guinzaglio, e tutte le panchine occupate, con lunghe code per sedersi. Si comprò una ciambella salata e delle salsiccette arrostite,epranzòcosì:il profumo era eccellente, ma anche queste avevano un sapore dolciastro e stucchevole... E se la parola che ricorreva nei nomi delle fermate, che lui aveva supposto significasse stazione, avesse voluto dire semplicementevia,viale, piazza, porta o cose del genere? O fosse soltanto un attributo come vecchio e nuovo? O magari si trattava di un personaggio famoso, un condottiero o un poeta a cui avevano intitolato vari luoghi? O chissà, forse era il nome stesso dellacittà? Alla tappa successiva scese dal metrò insieme alla maggioranza dei passeggeri, il convoglio quasi si svuotò. Si riversarono in massa verso uno stadio, vide la grigia costruzione di cemento ergersi in tutta la sua grandezza come un gigantesco transatlantico, e già da lontano udiva il rimbombo del pubblico. Il tempo si era schiarito, e nel cielo del primo pomeriggio si incrociavano scie di aeroplani. Budai comprò il biglietto come tutti gli altri,siunìallaschieradi coloro che entravano e salìintribunadallescale posteriori, fino alla fila piùalta.L’arenaeralarga centinaia di metri e pullulava di una quantitàindescrivibiledi spettatori, e continuavano ad arrivarne:ipostiasedere erano tutti occupati già da un pezzo, ma in alto, nei posti in piedi la folla si gonfiava, c’era quasi da aver paura che l’enorme edificio crollasse sotto il loro peso. Guardando in basso era pressoché impossibile distinguere ilconfinetrailcampodi gioco e gli spettatori, ovunque era pieno di persone: sull’erba brulicavano almeno due o trecento giocatori che correvano dappertutto, con dieci o quindici colori di maglie. Il pubblico gridava scatenato, accanto a Budaiuntiziosmilzocon un berretto giallo e una ispida faccia da gatto urlava a squarciagola agitando il pugno. Budai noncapivanientediquel che stava succedendo, osservava tutto quel movimento laggiù sforzandosi di indovinare le regole del gioco, ma non riusciva nemmeno a contare quante erano le squadre. Il terreno rettangolare era diviso in aree più piccoledalineebianchee rosse,eincampoc’erano almeno otto palle che i giocatori colpivano di mano e di piede, con i pugni o di testa, buttandole da una parte all’altra, oppure le tenevano sotto il braccio mentre discutevano animatamente tra loro. Porte o reti non se ne vedevano; il campo invece era recintato lungo tutto il perimetro da una rete metallica, che in alcuni punti era alta quattro o cinque metri e altrove arrivava alle spalle dei giocatori, ed era proprio lì che la mischia sembrava più vivace e i partecipanti si assiepavano in un muro compatto. Auntrattounodiloro, con la palla in mano, tentò di scavalcare la recinzione, evidentemente con lo scopo di abbandonare il campo.Icompagnisene accorsero e si gettarono contro di lui, che aveva già la gamba sinistra oltre la rete, ma quelli lo afferrarono per la destra e lo tirarono giù; dalla tribuna si levò un ruggito sinistro. Il fuggitivo cercò di liberarsi, ma gli altri erano in troppi, non mollavanolapresaealla fine riuscirono a trascinarlo sul campo: si rotolò sull’erba, perse la palla, e a quel punto lo lasciarono in pace, senza fargli male. Subito dopo, dal lato opposto, dove la recinzione era più alta, un nero spilungone in maglia a righe si staccò dagli altri e svelto come una scimmia si arrampicò su per la rete, e stava per farcela, sembrava. Allora accorsero tutti, compreso quello che era stato tirato giù poco prima, e si slanciarono verso il nero, lo afferrarono, gli si aggrapparonoallegambe mentre quello scalciava come un disperato, e finirono per trascinarlo giù. L’arena era in tumulto, rimbombavano cori di incitamento e insulti – benché Budai nonriuscisseacapireper chi tifassero gli spettatori. Quando un giocatore tentava di abbandonare il campo pareva riscuotere l’approvazione generale, ma appena gli altri si buttavano al suo inseguimentoilpubblico passava dalla parte degli inseguitori aizzandoli con passione e furia spietata. Il più sollecito a riacchiappare i fuggitivi era un ragazzotto dall’aria spavalda, tarchiato e muscoloso – erastatoluiaprenderela palla allo spilungone nero. Scattò all’improvviso e in men che non si dica era in cima alla recinzione: prima che i giocatori se ne rendessero conto aveva scavalcato e si stava calando fino a terra. Gli altri cercarono di trattenerlo attraverso la rete e riuscirono ad afferrarlo bloccandolo contro la recinzione. Ma il piccoletto non si arrese, si dibatté finché non sgusciò fuori dalla maglia, che restò là impigliata mentre lui piombòaterra.Poibalzò in piedi e salutando felice con la mano corse palleggiando negli spogliatoiesparìproprio sotto il settore dove sedeva Budai. I giocatori lo guardarono da dietro la rete, come chiusi in gabbia.Ilpubblicointero era sollevato, la tensione si liberò in applausi, risate e allegro brusio, e la massa di persone, finora salda come un unico agglomerato, cominciò a sciogliersi in lente ondate... Anche Budai si avviò verso l’uscita, il cuore aperto a una gioia lieve e inebriante: si sentiva pieno di fiducia e serenità. Dopo vagò ancora per la città: di nuovo arrivò la sera, i lampioni si accesero tutti in una volta, in lontananza brillavano delle lettere rosse e blu in cima a un grattacielo. Doveva essere finito nella zona dei club o qualcosa del genere, la musica di bar, taverne e locali notturni invadeva le strade, suonata dal vivo o registrata; e poi insegne luminose, vetrine con esposte foto di artisti, ballerine e spogliarelliste. Il solito sciame di persone in un sensoenell’altro,perfino qualche passo di danza sul marciapiede, una stria turbinosa in mezzo al flusso infinito dei passanti, bianchi, orientali, neri, ragazze dallapelleolivastracome zingare con fiori tra i capelli, soldati. Era colpito dalla grande quantità delle divise: poliziotti coi manganelli siaggiravanonellacalca, comeneavevavistigiàal mercato, al parco e attorno allo stadio. Controllori dei mezzi pubblici, sia uomini che donne, vigili del fuoco col casco rosso (sempre che lo fossero), postini o ferrovieri in uniforme blu, e i bambini e le bambine spesso portavano una sorta di divisa, una giacchetta verde con pantaloni o gonnadellastessastoffa. Ma le più comuni erano normali tute da lavoro marroni, di tela robusta, senza alcun distintivo, indossate da uomini e donne. Semplicemente per praticità? Oppure erano membri di una qualcheorganizzazione? Quellaserasirespirava aria di festa: gente a passeggio per le strade, venditori ambulanti o banditorieintornoaloro capannelli di persone e una gran ressa. Anche a Budai venne voglia di spendere i soldi che aveva in tasca, decise di comprare e consumare tutto quello che gli capitava a tiro; riteneva di poterselo concedere, come minimo. Da uno strillone comprò il giornale con l’intenzione di studiarlo una volta in albergo,poiaunchiosco si mise in coda per una crêpe: le preparava un giovanotto in giacca bianca,cappellodipaglia e papillon, una faccia ambrata da indiano che luccicava di sudore. Preseanchedabere:aun lungo bancone vendevano una bevanda sciropposa dal sapore mielato e stucchevole che non dissetava, e ne ordinò parecchi bicchieri... A un angolo di strada c’era un tizio con un pullover logoro e sdrucito che urlava e sbraitava mentre avvolgeva delle catene intorno a un compagno, un povero disgraziato con la gobba, e poi passava con un piattino fragliastanti.Pocodopo arrotolò il compare nella carta da pacchi, lo legò stretto con uno spago robusto finché perse ogni forma umana: sembrava una mummia o un pacco postale; per finire lo infilò in un grosso sacco e con altro spago strinse l’imboccatura in cima. A quel punto soffiò in un fischietto e l’altro cominciò, per quanto gli fosse possibile dentro a quell’involucro, a muovere le spalle e i piedi. Il numero consisteva nel suo tentativo di liberarsi da solo, senza alcun aiuto esterno, ma pareva impossibile, così incatenato e impacchettatodallatesta ai piedi. Ma quell’ometto striminzito si agitava sempre di più, per far uscire un arto o almeno un dito, e dal sacco ora spuntava la sagoma di un ginocchio, ora di un gomito. Nel frattempo emetteva suoni gutturali, mentre il tizio con il pullover illustrava in tono entusiastico le varie fasi del numero e passava di nuovo con il piattino. Il sacco crollò a terra: il gobbetto si contorceva e si rotolava sul selciato, stava lottando strenuamente all’interno, si dava da farecontuttelesueforze e la sua inventiva, brontolava e sbuffava furiosamente, si dimenava e rimbalzava come in preda alle convulsioni. A un tratto lo spago che chiudeva il sacco si allentò, nell’apertura apparve dapprima un ditino sottile, poi la mano e infine il braccio. Da quel punto in poi si liberò piuttosto in fretta, tirandofuoriinsequenza la testa, le spalle e la gobba. Un minuto più tardi si scrollò di dosso involucro e catene e fece un inchino: aveva una faccia storta e lentigginosa, batteva confuso le palpebre. Gli astanti applaudirono e versarono soldi nel piattino. Budai aveva sete e bevve ancora: quello sciroppo dolciastro dovevaesserealcolicoea pocoapocoglidiedealla testa, si sentiva annebbiato e con uno strano formicolio nel corpo. Percepiva tutto in modo chiaro, anzi, più vivido, ma come dall’alto,senzaprendervi parte. Adesso tutta quella situazione gli sembrava di poca importanza, non ci faceva molto caso, stava in un angolo remoto del suo cervello: in fin dei conti non era colpa sua se le cose erano andate così, non aveva mica sceltoluidifinireinquel posto, che venissero a cercarlo... In quel momentogliinteressava di più l’atmosfera animata della sera, la miriade di piccoli eventi sul marciapiede e nelle strade, abbandonarsi a quella chiassosa e variopinta allegria popolare. C’erano molti ubriachi che barcollavano,cantavano, con un cappellino di carta in testa, sparavano con pistole giocattolo e lanciavano stelle filanti. Brillo com’era si sentiva quasi uno di loro, gli sarebbe piaciuto fare parte di qualcosa, di qualsiasi cosa. Si unì a una rumorosa comitiva di adolescenti un po’ bulli che sfottevano chiunque incontrassero, scherzavano, si spintonavanol’unl’altro, giocavano alla cavallina, spruzzavano l’acqua alle ragazze con delle cannucce. Tra risate e schiamazzisvoltaronoin una traversa; Budai li seguì. Eraunvicolopiuttosto strano, con case strette strette, alcune non più larghedell’aperturadelle braccia, dipinte a colori vivaci, verde, rosso, arancione, addirittura a scacchi. Le finestre, soprattutto al primo piano, erano molto grandi, quasi quanto la casa,edietroaognunadi esse c’era una donna: truccate pesantemente, in abiti da sera dalle profondescollatureoche lasciavano scoperte le spalle e parte del seno. Strizzavano l’occhio agli uomini di passaggio invitandoli a entrare; Budai capì subito in che tipodizonaeracapitato. E sebbene non frequentasse luoghi simili da quando era studente, provandone unacertarepulsione–di norma evitava quel genere di strade –, d’un tratto intravide la possibilità di un incontro: finalmente sarebbe potuto restare a tu per tu con qualcuno, scambiare una parola, domandare e forse avere risposte, o almeno provare a spiegare, trovare ascolto... Al pensiero si emozionò al punto che cominciò a sudare;entrònellaprima taverna e si mise in fila per un bicchiere, per farsi coraggio e vincere la sua naturale timidezza. Al pari dei colori delle case, le donne dietro alle finestre erano tutte diverse: bionde dalla pelle lattea, minuscole orientali con gli occhi a mandorla e uno chignon fermatodalpettinecome le geishe giapponesi, bellezze color dell’ebano con una massiccia collana d’argento al collo. Ne vide una in abito di tulle bianco, avevalunghecigliascure sul viso madreperlaceo e un sorriso da madonna agli angoli della bocca: non adescava nessuno, se ne stava seduta a guardare la strada, e fu questo che attirò l’attenzione di Budai. Passò più volte sotto la sua finestra, lei lo notò marimaseimpassibile,si limitò a seguirlo con lo sguardo radioso e un sorriso pudico e beato... Con repentina decisione Budaisuonòallaporta,il cuore in gola come uno scolaro che sta per fare una marachella; un ronzio segnalò che potevaentrare. Si ritrovò in un atrio semibuio, a un tavolino sedeva una donna anziana.Quandolepassò accanto lei gli diede un pezzetto di carta con scritto il numero 174. Budai non capì, glielo restituì con aria interrogativa, ma la donna gracchiò qualcosa scocciata e indicò una scala. Lui salì al primo piano, dove c’era un vecchietto calvo e rinsecchito, con la faccia rossa e rugosa come una mela al forno. Gli chiese il numero, lo bucò con una pinza, poi strappò unbigliettodaunblocco: datochenonsicapivano l’unl’altro,civolleunpo’ prima che fosse chiaro che bisognava pagare sull’unghiaconunpezzo da 10. A Budai sembrò parecchio, chissà se comprendeva solo l’ingresso o anche qualcos’altro, era già pentitodiessereentrato. Fu immesso in una sala rotonda sulla quale si aprivano quattro porte. Lungo la parete circolare erano disposte sedie e panche dove sedevano venti o venticinque uomini, in attesacomedaldentista, enonc’eranopostiliberi. Un altoparlante diffondeva le note di un valzer, e i clienti conversavanoeridevano traloro.Budairinunciòa ricorrere al linguaggio dei segni, tanto era inutile, e poi si vergognava un po’ di trovarsi lì, come spiegarlo? Ci avrebbe provato dopo, da solo con la ragazza... Di tanto in tanto si apriva una porta e spuntava una donna discinta, che faceva una giravolta sollevando l’orlo dell’abito;aquelpuntosi alzava il cliente di turno – erano al numero 148 – e sparivano insieme nella stanza. Ma c’era anche chi passava la manoperaspettarneuna che gli piacesse di più, e alloratoccavaalnumero successivo. Poco per voltaavevavistol’intero assortimento, ma purtroppo quella con il visodamadonnanonera comparsa: che fosse soltantouncampioneda esposizione? In ogni caso gli affari andavano a gonfie vele, le porte si aprivano e si chiudevano in continuazione: le donne si ritiravano in camera col cliente per dieci o quindici minuti, in qualche caso anche meno, ed erano sempre in arrivo nuovi avventori.Perviadiquel fitto andirivieni l’aria della sala era viziata, molti fumavano e non pareva ci fosse modo di ventilare l’ambiente: afrorimaschilimescolati a fumo di sigaretta, a fragranze dozzinali e a un vago odore di disinfettante o insetticida. Budai trovò una sedia libera ma non andòmeglio:gligiravala testa e si sentiva lo stomaco sottosopra, aveva bevuto troppo intruglio alcolico. Desiderava solo andarsene, ma temeva cheavrebberimpiantodi essere fuggito come un codardo e di aver sciupato l’occasione; gli dispiaceva anche per i soldi. Decise che non avrebbefattoildifficilee si sarebbe accontentato dellaprimachecapitava, chiunque fosse. Tanto con tutto quel commercio gli era passata qualsiasi voglia giàdaunpezzo. Arrivò finalmente la chiamata del 174: comparveunaragazzona robusta dai capelli rossicci e dalla pelle scura o abbronzata. Budaisialzòelaseguìin silenzio nello stanzino. Chiusero la porta, ma si sentivano lo stesso la musica,ilchiacchiericcio e le risate dei clienti in attesa. La donna indossava una leggera camicetta bianca e un’ampia gonna verde mare, sotto la quale per un attimo si intravidero le floride cosce nude, e un paio di sandali. Cominciò subito a spogliarsi: si era già sfilata la camicetta dalla testa quando Budai la fermò alzando il dito. Iniziò a parlarle in più lingue, indicando prima sé stesso, poi lei, e fece un largo gesto delle braccia tutt’intorno, infine aprì le mani con ariainterrogativa:voleva saperecomesichiamava la città, in che paese si trovava, cose così. La ragazzanondovevaaver capito, perché con voce profonda e ruvida da fumatricereplicòperben due volte con una domanda,fissandolocon le sopracciglia inarcate. Allora Budai tirò fuori il quadernino e disegnò goffamentel’Europa,con le tre penisole meridionali e i fiumi principali: in riva al Danubio segnò la sua città natale, da dove proveniva, ne ripeté più volte il nome scandendo bene le sillabe mentre si picchiava l’indice sul petto. La ragazza guardò il disegno, pensosa, e intanto gli fece cenno di mettersi a suo agio, lui stava ancora lì in piedi con il cappotto addosso. Budai si tolse solo il cappottoeloappoggiòsu una sedia: prese a gironzolare impacciato per l’angusto stanzino e la donna lo invitò a sedersi accanto a lei sul sofà rivestito di pelle. Non gli metteva fretta e non si mostrava impaziente, anche se là fuori – a giudicare dal baccano, dalle voci e dal rumore di sedie spostate – i clienti non diminuivano e il volume della musica era sempre più alto. Fra tutti quanti doveva averla toccata la solitudine di quel forestiero, nonostante non lo capisse, e forse aveva intuito che era un cliente diverso dagli altri. Budai staccò il foglio dal quadernetto e glielo porse insieme alla matita, come a dirle di fare un disegno simile. La donna fraintese il gesto, piegò il foglietto e lo ripose in una scatola metallica che teneva sotto il letto. Allora Budaiprovòachiederleil suonome,poitentòconi numeri da uno a dieci, aiutandosi con le dita: uno, due, tre... Ma non erachiaroseafferrava,le risposte che dava erano lunghe e parlava lentamente, scoppiando ogni tanto in una risata amara: era impossibile comprendere quel che diceva.Ladonnaestrasse di nuovo la scatola e gli mostrò varie cianfrusaglie: spille, nastri, fermagli, vecchie lettere, fotografie, un binocolo da teatro, un anello, biglie colorate, una perla di vetro; forse erano i suoi ricordi e i suoi segreti. E parlava, parlava con voce profondaeroca;richiuse la scatola e poi la riaprì, ripetendo più volte qualcosacome: «Tevebevedere acipacitapp! Acipacitapp?... Buturü gebeceacipacitapp?...». Questo acipacitapp lo diceva in continuazione; a un tratto prese dalla scatola una vecchia scarpinainfantileeisuoi occhi si riempirono di lacrime. Budai non sapevacosaimmaginare. Era sua, di quando era bambina?Odisuofiglio? E dov’era adesso suo figlio?... La ragazza stringeva a sé quella scarpina con tanta passione che era impossibile non provare penaperlei:lepassòuna mano sui capelli, che erano soffici e rossi, e carichi di elettricità, tanto che a sfiorarli emettevano quasi scintille, le accarezzò la fronteeilcollo.Ladonna gliafferròlamanoesela portò al viso, alla bocca, inumidendoladilacrime; lui ne fu imbarazzato, ma di colpo la sua rigidità si sciolse come neve al sole... Dalla sala d’attesa si udì un nervoso scalpiccio di passi: doveva essersi trattenutooltreiltempo. Qualcuno bussò alla porta. Budai si sentì a disagio: gli dava fastidio che gli mettessero premura, ma avrebbe anchevolutoliberarsida quella situazione. La ragazza però lo tratteneva, aggrappata a lui, inginocchiata ai suoi piediconlatestasulsuo grembo. Budai tentò di sollevarla ma cadde anche lui in ginocchio accanto a lei; restarono così, a metà strada tra il pavimento e il sofà, in una posizione goffa e innaturale, ma abbracciati come un corposolo. Da fuori cominciarono a vociare e a battere i pugni sulla porta: bisognava sbrigarsi. La donna lo baciò sulla boccaamo’dicommiato e lui la abbracciò di nuovo...Levoltòlespalle infilandosi il cappotto; dopo una breve esitazione posò con qualche impaccio una banconota da 10 sulla sedia. Lei non lo guardava, intenta a sistemarsi la pettinatura allospecchio,enondisse una parola. Budai uscì dalla porta sul retro, passando per una scala di servizio che puzzava dipipìdigatto. Ilvicolosbucavainun ampio spiazzo dove girava una spettacolare ruota panoramica sfavillante di luci, e intorno pullulavano mille attrazioni, giochi, tiroasegno,autoscontri, la nave dei pirati, le giostre: un lunapark. Anche le gigantesche montagne russe erano illuminate, echeggiavanostrilli,urla gioiose, squilli di trombette, scoppiettii; e sciami di folla dappertutto. C’erano scivoli, un tunnel della paura, lancio degli anelli e punching ball, numeri di prestigiatori, acrobati e giocolieri, mangiaspade e mangiafuoco, un contorsionista che incrociava le gambe dietro il collo, e una donnacannone,cheperò stava seduta immobile su una pedana, prigioniera del suo peso, enormeeinertecomeun idolopolinesiano. Si potevano affittare delle barchette, naturalmente dopo un’attesa interminabile; ormai Budai non si curava più del tempo, non gli importava che ore fossero. Gli diedero una barchetta monoposto, una lenta corrente lo trascinò dentro un tunnel a forma di grotta. La musica era assordante, una specie di barcarola sentimentale,eovunque, perfino sull’acqua, ondeggiavano lanterne colorate dalla luce soffusa. Su entrambi i laticastelliinminiatura, cascate, chiuse, centrali elettriche, ponti e cose delgenere:nientediche, un’attrazione piuttosto ordinaria.Eppureperlui fu la gioia più grande e inattesa di tutta la giornata, forse la prima daquandoeraarrivatoin quelluogo... D’estate aveva l’abitudine di andare in canoa sul Danubio. Partivalamattinapresto e risaliva la corrente lungo la riva tortuosa e fitta di alberi e cespugli. Tra isolotti e secche, l’acquanonformavamai uno specchio perfettamente liscio, ma era increspata sulla superficie da ondine scintillanti, a tratti più mosse; anche con la bonaccia il fiume era vivo e dotato di un proprio respiro. Spesso approdava su una piccola isola senza nome e si riposava: nei periodi di piena il Danubio la sommergeva, i ciuffi d’erba e le alghe trascinate dalla corrente restavano impigliati nei tronchi dei salici e nei cespugli, e poi quando il fiume si abbassava di nuovo si seccavano e sembrava che gli alberi avessero la barba. L’isola era tagliata a metà da una stretta laguna navigabile, dove lui si infilava con la snella e agile imbarcazione sotto le fronde degli alberi e l’intrico di liane. Non aveva mai incontrato nessuno da quelle parti, al massimo qualche uccello selvatico che volava via al suo passaggio.Allafocedella laguna c’era una breve rapida, il fiume accelerava all’improvviso e l’acqua diventava trasparente, rivelandoillettosassoso: eraquicheglipiacevadi più fare il bagno, nella corrente, sentire sulla lingua e sulla pelle il sapore fresco e tenero dell’acqua dolce. Un mattinodimaggioaveva visto delle anatre selvatiche davanti alla spiaggia sabbiosa, era rimasto immobile a osservarle da dietro un cespuglio senza che si accorgessero di lui: la madre stava insegnando ai piccoli a nuotare, a tuffarsieapescare... In preda a un’ebbrezza lieveecaricadiricordisi avviò per tornare in albergo. Si era segnato sul quaderno il nome della sua stazione, ma in compenso non sapeva dove prendere la metropolitana: l’ultima fermata a cui era sceso eraormaitroppolontana e non sarebbe stato capace di ritrovarla, e invano si guardava intorno in cerca delle tipiche scale gialle. Cominciò a chiedere, fermava i passanti che gli venivano incontro, sperando che capissero almeno il gesto, e indicava in basso, verso ilselciato.Unadonnadai lineamenti tartari, che indossava quella tuta marrone, sembrò finalmente intuire: con aria rassicurante gli fece segno di seguirlo, lo prese addirittura sottobraccio, e due isolati più in là lo condusse in un bagno pubblicosotterraneo. Temette di essersi smarritopersempreedi non ritrovare più l’albergo – ormai era tardi, doveva essere mezzanotte passata –, quando gli venne un’idea: osservare il flussodellafolla,dov’era più denso e in che direzione andava, individuare insomma una corrente principale. E quella si sforzò di seguire,standoattendoa non allontanarsene mai: il corteo attorno a lui divenne via via sempre più compatto, girato l’angolo si unì a una vasta fiumana di gente chedopopochecentinaia di metri entrò in una costruzione rotonda dal tetto piatto: erano le scalecheconducevanoal metrò. Qui gli fu facile orientarsi; sulla mappa cercò il suo percorso, i colori delle linee e dove cambiare. Uscitoinsuperficieera nellapiazzettadacuiera partito al mattino. Nei pressi c’era il grattacielo in costruzione che aveva ammirato il giorno precedente. Contò di nuovo i piani: arrivò a sessantacinque, eppure si ricordava benissimo che erano sessantaquattro.Licontò un’altra volta: sessantacinque, ed era già allestita la struttura di ferro del sessantaseiesimo: l’avevano tirato su in un giorno, non c’erano dubbi... Davanti all’albergo il grasso usciere portò la mano alla visiera e diede una spinta alla porta sbattendo le palpebre. Budai cominciava seriamenteapensareche non fosse un essere umano in carne e ossa, ma un robot in divisa programmato per compiere quei due o tre movimenti.Futentatodi toccarlo per vedere di che cosa fosse fatto, ma poi si trattenne: chissà, poteva prendere la scossa... Mentre era in coda per la chiave, si ricordò vagamente della lettera lasciataperladirezioneil giorno prima: avrebbe trovato una risposta nel suo scomparto? O magari era finalmente saltato fuori il passaporto? Ma poi vide che non c’era niente e che il portiere era cambiato ancora, e gli passò qualsiasi voglia di mettersi a discutere e ricominciaredacapocon una scenata inutile. Ritirò in silenzio la chiave e andò a fare la filaperl’ascensore. Non si aspettava l’ascensorista bionda perché l’aveva già incontrata al mattino; si meravigliò di vedersela davantiall’aperturadelle porte. Aveva l’aria esausta,ilvisoarrossato, lesichiudevanogliocchi quando schiacciava i pulsanti con le lunghe dita dalle unghie ben curate – possibile che stesse lavorando fin dal mattino?Oeratornataa casa per poi riprendere servizio la sera? Dove poteva abitare, nell’albergo o presso la sua famiglia? Aveva una famiglia, un marito?... Nellacabinal’ariaerapiù soffocante del solito, e si accorsecheilventilatore era guasto. Salendo aveva cercato di trovarsi proprio accanto a lei: la peluria chiara delle tempie era imperlata di minuscole gocce di sudore. L’alcol aveva allentato i freni inibitori di Budai: con il giornale cominciòafareventosul collo e la fronte della ragazza. Lei si voltò lentamente, con aria più sorpresacheseccata,uno sguardo stanco ma curioso, e disse anche qualcosa, con una breve risatina: per la prima volta Budai la vide sorridere. Si sentì assalire da un misto di fiacchezza e tenerezza, dall’improvviso desideriodistarlevicino, di riposare al suo fianco... Sì, mentre osservava lei e sé stesso, aveva solo il desiderio di sdraiarsi e dormirle accanto, nello stesso letto, aspettare che la ragazza prendesse sonno, ascoltare il suo respiro, sentire il battito dellesueveneattraverso la pelle sottile dei polsi; questo l’avrebbe appagato totalmente. Quandogiunseroalnono piano fu la donna ad avvertirlo che era arrivato. Quindi si ricordava di lui, non le era del tutto indifferente. Anche questa volta la stanza era stata riordinata, e il letto rifatto. Però era scomparso l’elenco telefonico: il personale delle pulizie doveva averlonotatoeritirato,e cosìeranoandatiperduti gli appunti che aveva annotato alla fine del volume. Gli restava il giornale per ricominciaredacapo,ma non ne aveva nessuna voglia. La stanchezza gli appesantiva le membra, aveva camminato ore e ore, vagando qua e là, e aveva sprecato un’altra intera giornata – confessò a sé stesso con un misto di derisione e sgomento – senza progredire di una virgola. In preda a uno stato febbrile, passando da un senso di disgusto per il proprio fallimento a un torpore etilico venato di apatia, si svestì, si fece una doccia e si coricò, ma non spense l’abat-jour. Il problema era lui, il suo carattere alieno da ogni forma di invadenza e prevaricazione: se ne rese conto con grande lucidità, nonostante il sonno e la sbornia. Se nonfossestatocapacedi vincere la sua irresoluta modestia, il suo timore di esser di peso, non si sarebbe mai tirato fuori daquellasituazione,non sarebbe nemmeno riuscito a dare notizie di sé, e nessuno sarebbe venuto a cercarlo. Doveva battersi da solo, non c’era altra via d’uscita: doveva cambiare radicalmente, solo così avrebbe potuto ritrovarelasuavitavera, lasuapersona. Dallarabbiapicchiòun pugno sul comodino con una tale violenza che la lastra di vetro andò in pezzi e si ferì la mano. Prese a sanguinare; si fasciò prima con il fazzoletto, poi con un asciugamano, ma anche questosiintrisesubitodi sangue. Odiava quella città, la odiava profondamente perché gli riservava solo sconfitte e ferite, lo costringevaarinnegaree acambiarelasuanatura, e perché lo teneva prigioniero, non lo lasciava andare, e ogni volta che provava a fuggire lo ghermiva e lo tiravaindietro. Faceva un sogno ricorrente. Era a Helsinki, la città sul mare che conosceva da tempo, camminava per le strade linde, e da qualsiasi punto partisse – la cattedrale, il teatro dell’Opera,ilmercatodel pesce, lo stadio olimpico –, arrivava sempre al mare. Gli piaceva quel sogno, guardare l’orizzontechediventava via via più blu dietro la schiera di case bianche e marroni: era perfino capace di evocarlo in modo vivido, di richiamarlo dal fondo dei ricordi più remoti, nell’incoscienza lieve e chiaroscurata del primo sonno o del risveglio. Intanto, il congresso di linguistica di Helsinki doveva essere ormai finito, era previsto che durasse tre o quattro giorni, a seconda del numero di interventi nella discussione. Da quandoeralì,invece,per quanto frugasse nella memoria, di acqua non ne aveva vista affatto, nemmeno un fiume, o un lago: soltanto in quel lunapark, dove aveva affittato la barca, o ai giardini pubblici, la vasca in cui i bambini giocavano con le barchetteavela. Laferitaallamanonon guariva, gli faceva male, un dolore continuo e pulsante, aveva cambiato la fasciatura più volte usando un fazzoletto pulito. Decise che non avrebbe più bevuto, aveva esagerato: doveva restare sobrio e lucido, senza perdere la testa, e le sere seguenti riuscì a controllarsi. Si sforzò di mantenere per qualchegiornounasorta di routine. Mangiava al mattino e al pomeriggio, disolitoallatavolacalda vicino al grattacielo in costruzione, e il resto della giornata girovagavanellestradeo si spostava in metropolitana. In un paio di occasioni non restituì la chiave per risparmiarsi la fila al ritorno. Ma poi ci ripensò;senelfrattempo l’avessero cercato si sarebbe soltanto creata confusionesudovefosse finito. Peraltro, continuava a non avere notizie del suo passaporto e il portiere dai capelli grigi che gliel’aveva preso la primaseranonsierapiù visto. I dettagli delle mosse successive lo tennero così occupato da permettergli di non pensare troppo alla situazione in sé; e forse era proprio quello che voleva, accantonare l’idea per un poco... Preparò diverse copie di un avviso in sei lingue, che affisse in vari punti dell’albergo – nei corridoi, in ascensore, nellahall,eperfinofuori dall’ingresso principale: invitava chiunque era in grado di leggere e capire lesueparoleadandarloa cercare nella stanza 921 e, nel caso non ci fosse stato, a lasciargli un messaggio nella sua casella alla reception; aggiunse la promessa di una lauta ricompensa. Poisimiseabussarealle camerevicine:ilpiùdelle volte non gli rispose nessuno,forseerasoloil momento sbagliato, gli ospitieranofuori,oforse dava dei colpetti troppo discreti. Dove c’era qualcuno, invece, capì di aver disturbato: dietro una porta si udì berciare un’aggressiva voce femminile, dietro un’altra invece, che Budai aprì dopo aver ricevuto un’incomprensibile risposta, due giovanotti dalla carnagione olivastra, in pigiama, si allontanarono bruscamente uno dall’altro:ilpiùbasso,un tiziosmilzoeocchialuto, sgusciò fuori di corsa, infilò il corridoio e scomparve dietro un angolo. La porta successiva non era chiusa: Budai sbirciò dallospiraglio,entròcon cautela e fu investito da untanfodiporcilechelo fece arretrare per un istante.Nellastanzanon c’era nessuno, soltanto gabbie piene di grassi conigli d’angora sistemate da ogni parte, per terra, sulle sedie, sul portavaligie,incimaagli armadi, perfino sotto il letto e nel bagno, dentro la doccia, sulla tazza del water; conigli chiusi nelle loro gabbie a rosicchiare e zampettare nei loro escrementi, in unfetoreinsopportabile, zigandoinsulsamente. Glivenneun’altraidea: verso sera uscì e si mise davanti all’ingresso dell’albergo ad aspettare il pullman che li aveva condotti lì dall’aeroporto. Ma non avrebbesaputodireache ora erano arrivati, né di checoloreerailpullman, e anche se lui era stato l’ultimo a scendere non potevagiurarechequello fosseilcapolinea,perché il pullman era ripartito dopo pochi istanti. Così si limitò a tenere la posizionenellabolgiadel marciapiede, lottando e sgomitando per non essere trascinato via mentre cercava di identificareunmezzofra tutti quelli che passavanoneltraffico–e se il volo con cui era arrivato non fosse stato giornaliero? Eppure quell’uscita non fu del tutto inutile, perché proprio allora, al passaggio di un poliziotto armato di manganello, lo folgorò l’idea più importante e clamorosa che avesse finora concepito: era di una semplicità così geniale, di un’efficacia cosìinfallibilecheesultò tra sé per esserci arrivato. Se per un motivo qualsiasi si fosse fatto portare alla polizia, l’avrebbero interrogato e, non capendo la sua lingua, sarebbero stati costretti a trovare un interprete, al quale finalmente avrebbe potuto raccontare cosa gli era successo... Tornò di corsa nella sua stanza per riflettere con calma sul modo migliore per farsi arrestare. Poteva provocare una rissa, attaccar briga con un passante, spaccare una vetrina o una cabina telefonica con un mattone; bucare le gomme a un’automobile al semaforo, oppure rompere il semaforo, accendere un fuoco di giornali e cartacce in un parco o un luogo pubblico. Non riusciva però a vincere la resistenza che provava verso simili atti vandalici, e inoltre temeva una reazione ostile da parte dei passanti, che avrebbero potuto malmenarlo prima dell’arrivo della polizia. Nella città vecchia aveva visto una fontana con un elefante di pietra: e se fosse andato a farci il bagno? Forse sarebbe bastato anche spogliarsi in mezzoallastrada–mail suo senso del decoro si ribellava a una cosa del genere. E se avesse finto un malore, un attacco di epilessia, contorcendosi sul selciato con in bocca un pezzo di sapone schiumante,comefanno gliimpostori? Non aveva ancora deciso, ma uscì di nuovo in strada e si piazzò davanti all’albergo, in attesa di un’ispirazione momentanea. Non dovette aspettare molto: sul marciapiede scorse un agente di polizia mescolato tra la folla. Budai tirò un respiro profondo,loraggiunsedi buona lena e, scegliendo ilmetodopiùimmediato – non prima di aver abbandonato e ripreso l’idea per ben tre volte –, gli sferrò un gran pugno in pieno petto. Il poliziotto credette che gliel’avesse dato involontariamente, per gli urti della folla, e si scansò per lasciarlo passare. Ma Budai non si arrese, anzi si infiammò nelpropositoecongesto audace gli fece volar via il berretto, mettendo a nudo una fronte bassa, arrossata e lucida, e i capelli cortissimi. A quel punto il poliziotto non ebbe più dubbi, soffiò furioso nel fischietto e assestò sulla testa dell’aggressore una tale manganellata che Budai vide tutto nero; al secondo colpo perse i sensi... ... Si risvegliò in un abitacolo chiuso e in movimento, deboli raggi di luce filtravano da piccoli finestrini a sbarre: si trovava di sicuro in un cellulare della polizia. La testa gli ronzava, sulla fronte sentì due bernoccoli doloranti grossi come noci, ma fu pervaso da un profondo senso di soddisfazione per aver raggiunto lo scopo – o per lo meno era sulla buonastrada...Iltragitto durò parecchio, circa mezz’ora; Budai si rannicchiòsullapancadi legno, stordito dalla botta. Fuori cominciò a piovere, ascoltava il rumore delle gocce sul tetto del furgone: il ticchettio lo fece assopire. Si svegliò di colpo quando il cellulare si fermò e il portello posteriore venne spalancato. Apparvero due poliziotti – nessuno di loro era quello aggredito – e gli indicarono di scendere. Si trovò in un ampio cortile recintato da muri grigi e affollato da un gran numero di uomini in divisa e in borghese; Budai venne scortato dentro l’edificio, dove imboccarono un lungo corridoio con un intenso viavai di gente. Seguì docile i due poliziotti, senza provare a attaccar discorso, tanto era inutile, e poi fra poco avrebbe avuto un’occasione migliore per parlare con qualcuno, di questo era ormai certo. Faceva molto caldo, l’aria era pesanteeumidacomein una serra, si sudava e le finestre erano tutte chiuse. Lo condussero in una specie di ufficio: dietro a un tavolo ricoperto di feltro verde e macchiato d’inchiostro sedeva un grasso ufficiale dal coloritolivido,conibaffi spioventi, che faticava a tenere aperti gli occhi, due fessure dal taglio obliquo; ciò nondimeno stava mangiando, e affettava un tocco di pancetta dall’odore un po’ rancido su un pezzo di carta bisunta e appiccicosa, da cui sgocciolava il grasso, scioltodalcaldo.Anchelì l’afa era insopportabile, Budai si domandava perché tenessero il riscaldamento acceso, come facessero a resistere, a sopportare quella temperatura assurda. L’ufficiale guardò i presenti con aria insonnolita, asciugandosi la bocca e lafaccialucidadisudore con un fazzoletto a quadretti; i poliziotti abbozzarono un pigro salutomilitare,equelloa sinistra balbettò qualcosa a mo’ di rapporto, presumibilmenteriferìil reato per il quale Budai era stato fermato. Il comandante annuì, sospirando rumorosamente come se anchequestoglicostasse fatica,epuntòsudiluilo sguardo apatico degli occhietti grigiastri, asciugandosileditaunte sul feltro del tavolo, poi gliruggìqualcosaintono interrogativo. Budai credette che fossefinalmentearrivato ilsuomomentoeavanzò diunpasso–masubitosi bloccò. Ora sì che aveva bisogno del passaporto: era una sorta di immunità,unaprovaeal tempo stesso un appello, avrebbe sostituito lunghe spiegazioni, glielo poteva sventolare sotto il naso e tutto sarebbe andato liscio, avrebbero saputo che fare di lui... E invece per l’ennesima volta fu costretto a spiegarsi a gesti e in più lingue: indicava sé stesso, ripeteva il suo nome, la nazionalità, la città di residenza, e chiedeva un interprete.Nellosguardo dell’ufficiale di polizia non apparve il minimo barlume d’intelletto; certo, quel caldo soffocanteavevafiaccato lo stesso Budai, e incrinato la sua iniziale determinazione e, per giunta, si accorse che la benda era insanguinata, la ferita alla mano si era riaperta, chissà se per il calore o la colluttazione con il poliziotto. Nel frattempo l’ufficiale avevafinitolapancettae ora era alle prese con un pezzo di formaggio mezzo sciolto, molle e maleodorante: rimase a contemplarlo per qualche istante, poi cominciò a mangiarlo a piccoli bocconi. Il telefono accanto a lui iniziò a suonare; dopo unalungaseriedisquilli l’ufficiale allungò svogliato una mano e sollevò la cornetta. Rispondeva a monosillabi, con il minimo sforzo, in quell’idioma straniero sconosciuto, di tanto in tanto emetteva un rutto esiasciugavailcolloela faccia con il fazzoletto. Quando l’ufficiale riagganciò,Budairitrovò unpo’dienergia:picchiò il pugno sul tavolo e pretese che lo interrogassero, che gli dessero il modo di provare la sua identità e di difendersi, di giustificare il suo comportamento e così via... Con tutta calma l’ufficiale si alzò, andò versodiluie,prendendo lo slancio con la stessa flemma, gli assestò uno schiaffo, dopo di che tornò a sedersi, ansante, e continuò imperturbato a mangiare. Aveva il palmodellamanosoffice e carnoso ma, si intuiva, avvezzo a mollare ceffoni. Budai sentì distintamente tutt’e cinqueleditaeperfinoil grosso anello a sigillo: rimasetalmenteattonito per quel colpo inatteso – quello precedente, la manganellata, in fondo l’aveva previsto – che ammutolì, paralizzato. Senza opporre alcuna resistenza si lasciò ammanettare e consegnare a un altro agente in divisa, il quale gli tolse la cravatta, la cinturaelestringhedelle scarpe e lo scortò fuori dall’ufficio di quel comandante obeso e sornione che puzzava di formaggio e di sudore e che probabilmente era l’equivalente di un prefettodipolizia. Fu condotto per una serie infinita di corridoi, affollatissimi, fino a una grande porta a sbarre dove fu preso in consegna da uno spilungone nero. Quest’ultimo indossava la tuta marrone che aveva già visto, e alla cinturaavevaunpesante mazzo di chiavi: doveva essere un secondino o una guardia carceraria. L’agente che gli affidò Budai di certo gli riferì che era ubriaco: lo spilungone nero scoppiò a ridere scoprendo le gengive rosse e i denti sani e bianchissimi, quindi gli diede un’amichevole pacca sulla spalla, gli tolse le manette e lo fece camminare davanti a sé; dietro una svolta del corridoio comparve un’infilata di celle, tante massicce porte di ferro tutteuguali.Ilsecondino nero si fermò, ne aprì una con la chiave, rise, gli gridò qualcosa, gesticolando, e lo spinse dentro. Poi richiuse la porta con uno schianto così violento che rimbombò in tutto il corridoio. Era una cella per due, illuminata da una lampadina che pendeva dal soffitto. L’altro giaciglioeraoccupatoda un tizio che dormiva voltato verso la parete e chenonsimossequando Budaientrò.Anchequiil riscaldamento era intollerabile, l’aria umida e soffocante, il calorifero emetteva dei crepitii ma non c’era nessuna manopola per regolarlo. Da quando era arrivato in quel posto a Budai doleva la testa, non riusciva a pensare ad altro, e poi perché faceva quel caldo torrido?, sarebbe bastato lasciar entrare un po’ d’aria, ma non c’erano finestre. Si sdraiò sul tavolaccio con addosso i vestitielescarpe,chiuse gli occhi e aspettò che il dolore lancinante al craniosicalmasse. Si assopì, il colpo in testa doveva averlo intontito; al risveglio si accorse che il suo compagno di cella era seduto sul giaciglio, e lo fissava. Sembrava ubriaco, probabilmente era dentro per una sbronza o chissà quale altro disturbo della quiete pubblica: era un uomo barbuto di mezz’età, con un aspetto da straccione, gli abiti sudici e logori, la faccia ricoperta di cicatrici e macchie violacee, lo sguardo annacquato. Quando vide che Budai era sveglio gli puntò il dito contro e con voce profonda e rauca, esalando un fiato alcolico,glidisse: «Chlombrattibratt?». Suonava come una domanda e in quella circostanza poteva significare:«Chisei?».La determinazione di Budai peròsieraindebolita,eil malditestanonglidava pace,così,anzichéperder tempo nelle solite inutili spiegazioni, rispose istintivamenteripetendo quelcheavevasentito: «Chlombrattibratt?». Iltiziobarbutogrugnì, alzò le spalle e iniziò a frugarsiaddosso.Cercòa lungo, borbottando, svuotò le tasche bucate, poi infilò le mani nella fodera e tirò fuori una quantitàdicianfrusaglie: unfazzolettosporco,una crosta di pane secco, dei fiammiferi, un mozzicone di matita, chiodievitiarrugginitee alla fine una sigaretta tutta storta dalla quale era uscita buona parte del tabacco: gliela mostrò e gliene offrì metà. Budai fece di no con le mani per dare a intendere che non fumava... Forse la domanda di poco prima voleva dire: «Hai una sigaretta?», o magari: «Vuoi una sigaretta?». Ricominciò per l’ennesima volta a parlargli in varie lingue, in tedesco, in olandese, in polacco, in portoghese, addirittura in turco e in persiano, perfino in greco antico, ma quello non gli dava retta e a un certo punto lointerruppe: «Scerederebe toghig hodovee gürübülü pracc... Antapracc, vara ledebedime kariciarapracc...». «Che cosa? Che cosa vuoi?!» esclamò Budai nella propria lingua, scandendo bene ogni parola come se quello potesse comprendere. «Dimmi che cosa vuoi...!». Il barbuto lo fissò per unpo’conilsuosguardo velatoeassente,siaccese la sigaretta, aspirò profondamente, poi soffiò fuori il fumo e riprese a parlare. Con l’aiuto dei gesti e della mimica facciale Budai riprovò a spiegargli che luierastraniero,chenon lo capiva, ma era impossibile interromperequelfiume in piena, l’uomo parlava incessantemente, incurante di essere ascoltato o meno. Doveva aver cominciato una storia piuttosto lunga, la voce forte e cavernosa prese un tono epico,sifermavasoloper tirare qualche boccata: fumò la sigaretta fino a bruciarsi le dita, poi la buttò per terra e la schiacciò. E parlando si infervorava,facevaampi gesti e riempiva il discorso di esclamazioni a effetto, si schiariva la gola, sbuffava, rideva sguaiatamente, schioccava la lingua con aria sognante, all’improvviso saliva di tono, si adombrava, ammiccava come a dire: «Capisce cosa intendo, no?».Budaiprovòaaprir bocca, ma l’altro lo zittì conungestodeciso: «Durung!...». E continuò a raccontare, a declamare la sua interminabile tirata,nonstavazittoun secondo, Budai aveva ormai le vertigini, gli tornò anche il mal di testa...Eppure,rinchiuso là dentro, aveva finalmente un’occasione che non gli si era mai presentata: farsi dire dal suo compagno di cella dove si trovavano, in quale paese, e di lì poi carpirgli in un modo o nell’altro – ci sarebbe riuscito di sicuro – le parole del suo idioma, peravereuniniziodacui partire... Tentò a più riprese di fermare il barbuto, buttò giù dei disegni sul taccuino, contòsulledita,indicòsé stesso e poi l’altro con occhi interrogativi, poi, perdendo la pazienza, si miseagridargliaddosso, ma niente: non c’era verso di farlo tacere, era inarrestabile, parlava, parlava,parlava... Sembrava anzi arrivato a un momento cruciale: levò in alto la mano sinistra come se imprecasse, fu invaso da una sorta di fervore, abbassò gli occhi, tacque per un istante e quindi scoppiò in una risata teatrale.Poifececennoa Budai di avvicinarsi e ascoltare: la sua voce passò al canto. Aveva una robusta voce di basso e intonò una melodia sconosciuta, una specie di aria d’opera, un pezzo serio, di un certo spessore. Da comeportavalavoce,da cometenevaemodulava i suoni, si intuiva che le notevoli qualità vocali erano state educate, ma la vita depravata e vagabonda, l’alcol e il fumol’avevanorovinata, rendendola opaca e roca... Sembrava tutto preso dall’esibizione, inebriatodalcantochesi spiegava libero. L’aria culminava in un passaggio virtuosistico, una serie di scale che salivanoperpoiscendere lentamente verso il grave, sempre più in basso,eancora,equando parevachefossearrivato all’ultima nota, eccone un’altra più profonda, al limite delle possibilità fisiologiche, per concludereconunsuono finalecupoeprolungato. Budai non sapeva se applaudire oppure no. Allafinediun’esibizione canora di tale entità, il barbuto era visibilmente estenuato; cercò un’altra sigaretta, non diede il benché minimo segno di reagire a nessuna domanda, rimase a fissare il vuoto con una faccia grigia e cerea, fumando, poi si sdraiò sul tavolaccio e si voltò verso la parete... Il caldo non accennava a diminuire, sembrava perfino che avessero alzatoilriscaldamento,e l’aria non circolava: Budai aveva la camicia fradicia, si era tolto il cappotto e la giacca e li aveva deposti accanto a sé. La situazione era assurda, il caldo era intollerabile anche in maniche di camicia, il calorifero continuava a emettere insopportabili scoppiettii – in preda a un’improvvisa collera Budai cominciò a tempestare di pugni la porta di ferro: voleva essere tirato fuori di lì, pretendeva che lo interrogassero, con un interprete,nonpotevano più tenerlo rinchiuso in unacellatorridainsieme auncantante,unmalato dimente. Fece baccano finché nonsiaprìlospioncinoe apparveilvisonerodella guardia, che si mise a ridere, come a dire: «Guarda questi due balordi ubriachi». Ma appena Budai lo assalì di domande – con che diritto lo trattavano a quel modo? –, quello ruggì con rabbia e richiuse di scatto lo spioncino; e non ricomparve,neanchepiù tardi, quando Budai riprese a picchiare sulla porta. Il suo compagno di cella o parlava, o dormiva; aveva parlato così a lungo che poteva avergli raccontato tutta la sua vita. Era evidente chenongliimportavase l’altro stava a sentire o meno. Budai aveva pensato addirittura che fosse sordo, vista la totale indifferenza alle domande. Volle accertarsene, e mentre quello sproloquiava provò a picchiettare la penna contro il calorifero: il barbuto drizzò la testa e si girò a guardare – dunque ci sentiva –, e poi ricominciò tranquillo a blaterare... Budai era entrato in quel luogo che era quasi sera,enonmangiavafin dal mattino. L’ora del pasto doveva essere già passata, e nulla faceva supporre che gli avrebberodatoqualcosa. Il suo compagno di cella sembrava anzi prepararsi per la notte, sedette sul bugliolo abbassandosi i calzoni senza vergogna, e senza smettere di parlare. Pareva avercela con qualcuno, batteva il piede per terra, iroso, e agitava minacciosamente il pugno, con un’espressione piena di odio e di amarezza. Pian piano si calmò, quindi si infuriò di nuovo, diede un paio di schiaffi nel vuoto e girò le spalle, comeseavessesistemato i conti col nemico; poi si pulì la mano sui pantaloni e sputò in terra. Budai stentava ad addormentarsi sul giaciglio duro, lo tenevano sveglio il caldo tremendo, la fame e il senso di impotenza. Quando riuscì finalmente ad assopirsi, madido di sudore, ebbe l’impressione che il tizio gli si fosse avvicinato e continuasse a blaterare, gesticolandogli in faccia, col fiato che sapeva d’acquavite. Ma forse stava sognando. Faceva uncaldoterribileeaveva malditesta,elamanogli doleva. Alla mattina il secondinoportòdelcibo: due pezzi di pane nero e una gavetta piena di brodaglia simile a caffè. Il barbuto ne bevve un po’, poi la passò a Budai, cherifiutòconungesto... Poco dopo riapparve la guardia e gli indicò di seguirlo. Percorsero gli stessi corridoi della sera precedente, fino allo stesso ufficiale grasso dalla faccia violacea. Stava mangiando – stavolta un pezzo d’anguria troppo matura,esputavaisemi tutto attorno – e la stanza era afosa e maleodorante, come se non avessero mai aperto la finestra. A Budai vennero restituiti gli oggetti ritirati il giorno prima, e l’ufficiale, dopo aver finito l’anguria, essersi pulito i denti con uno stecchino e asciugato la bocca e i baffi con un fazzoletto a quadretti,gliurlò: «Goroghetutunepetecc! Viripij?». Budai restò imbambolato davanti al tavolo macchiato d’inchiostro. Che altro avrebbe potuto fare? Quello lo guardava con i suoi occhietti obliqui, aveva la stessa aria sonnolenta e annoiata, il respirocorto,lepalpebre che quasi gli si chiudevano. Poi gli mostrò entrambe le mani,aperte,unavoltae poi un’altra volta. Budai non capiva che cosa volessedalui.Iltelefono squillò anche ora, l’ufficiale sollevò la cornetta e rispose con voce strascicata, prendendo dei documenti da un cassetto e grattandosi il collo tozzo e arrossato. Quando ebbe finito – e non fu cosa da poco – alzò verso Budai uno sguardo che diceva: «E questo che ci fa ancora qui?».Restòcosìqualche momento, con la faccia torpida e bisunta, poi scrisse «20» su un pezzo di carta e glielo allungò. Budai continuava a non capire, al che l’ufficiale tiròfuoriilportafogli,ne estrasse due banconote da 10 e gliele sventolò sotto il naso. A quel punto finalmente ci arrivò, era improbabile che gliele stesse offrendo: doveva pagare una multa che ammontavaa20unitàdi quella valuta; ecco cosa aveva inteso l’ufficiale mostrandogli per due voltelemaniaperte. Non aveva voglia di discutere, era contento di aver capito, e se si fosse messo a protestare avrebbero potuto commutare la multa in giorni di reclusione, ci mancava solo quello. Estrasse dunque dalla tascaduebigliettida10e li posò sul feltro verde del tavolo: la sua riserva di denaro si stava assottigliando. Non gli rilasciarono alcuna ricevuta,dovettefirmare su un grosso libro e l’ufficiale–conleunghie sudicie–gliindicòinche punto. E con questo la faccenda in sostanza era chiusa. Esitante, azzardò ancoraqualchetentativo – si era pur fatto arrestareconunoscopo– ma nessuno gli diede retta. Il secondino nero era sparito, l’ufficiale obeso era di nuovo al telefono e aveva tirato fuori dal cassetto un tegame azzurro con una specie di stufato freddo: lo annusò un po’, poi si diede a mangiarlo di buonalena.Infilandosiil cucchiaio in bocca produceva uno sgradevole risucchio, rivoli di sugo gli colavano lungo i baffi spioventi che lui poi ripuliva con il fazzoletto... Budai temette che se avesse insistito si sarebbe preso un altro ceffone. E cominciavaapatirel’aria afosa e viziata che riempiva tutti i locali di quell’enorme edificio – alla fin fine provò sollievo quando venne scortato all’aperto e poté respirare a pieni polmoni. Giunse alla fermata della metropolitana con il metodo già sperimentato, seguire il flusso principale della folla. Cercò sulla mappa la stazione in cui si trovava, segnata da un cerchietto rosso in alto a destra, e individuò con facilità il percorso per la sua fermata nei pressi dell’albergo... Uscito in superficie lanciò un’occhiataalgrattacielo in costruzione: anche quel giorno si lavorava alacremente e i montacarichi andavano su e giù. Per pura curiosità ricontò i piani, ce n’erano due in più, sessantasette... Fece colazione alla tavola calda. Mentre sorseggiava il tè troppo dolce, si rese conto con sgomentodiaverfattola coda per ogni singola cosa senza quasi accorgersi: ci stava prendendo l’abitudine. Eppure era proprio quello a cui non doveva mai abituarsi, lo sentì in maniera molto forte e chiara e il cuore cominciò a battergli all’impazzata. Accettare la situazione, anche in modo inconsapevole, avrebbe significato rassegnarsi, arrendersi, perdere la sola cosa che gli dava speranza: la certezzadiesserediverso dagli altri abitanti, di essere uno straniero, capitato lì per errore e del tutto estraneo a quel luogo – ed evidentemente non potevano costringerlo a rimanerci. Tornò di corsa in albergo: stavolta non solo immaginava o confidava che ci fosse qualcosa per lui, ma ne era sicuro... Fu quasi felice di rivedere all’ingresso il babbeo in pelliccia, che gli sorrise battendo le palpebre, facendoilsalutomilitare e spingendo la porta a vetri; ma notò che l’avvisoinpiùlingueche avevaaffissoprimadella disavventura poliziesca erasparito. Mentre era in fondo alla coda per la chiave – di turno c’era un nuovo portiere, un giovanotto biondo dalla faccia liscia che sembrava un ragazzino –, scorse da lontano l’angolo di un pezzo di carta che sporgeva dalla casella 921,unaletteraounodi quei foglietti usati negli alberghi per scrivere messaggi, da lì non poteva vedere bene. Fu preso da un’eccitazione tale che le sue dita cominciarono a danzare confrenesiasulbancone della reception: la coda nonglieramaisembrata così insopportabile. Era la risposta della direzione?, oppure un riscontro dell’avviso affisso in giro per l’albergo? O forse era arrivata una telefonata per lui, la compagnia aerea l’aveva rintracciato, qualcuno l’aveva cercato da casa o daHelsinki?Sì,perchéin quella città non era riuscito a ottenere l’attenzione di nessuno, alla polizia non gli avevanochiestoneppure come si chiamava... All’improvviso scoppiò a piangere, mentre avanzava lentissimo la gola e il petto erano scossi dai sussulti; temeva di dare nell’occhioefeceappello a tutte le sue forze per contenerel’emozione. Giunto dinanzi al giovane portiere gli mostrò il numero della stanza che teneva sempre in tasca. Questi annuì cortese, staccò dal gancio la chiave della 921 e nel contempo estrasse quel qualcosa dalla casella. Era un foglietto piegato in quattro,eilgiovanottolo aprì sul bancone aggiungendo qualche parola inintelligibile: era una specie di modulo diviso in caselle in cui erano stati scritti a penna dei numeri. Con gestirapidiemeccaniciil portiere prese la calcolatrice e girò un paio di volte la manovella, forse per controllare le somme, con una penna a sfera annotò velocemente il totale, lo sottolineò con due tratti, poi fece un grosso scarabocchio e, pronunciando in tono disinvolto quella che suonava come una frase dirito,loporseaBudai... A quel punto non ebbe piùdubbi,sitrattavadel conto dell’albergo, e si accorsecheeratrascorsa una settimana esatta dal suoarrivo.Forseiclienti che si fermavano erano tenuti a pagare la stanza ognisettegiorni. Nell’immediato quello chelolasciòsenzaparole fu il totale: 35,80, ecco cosa c’era scritto in fondo al foglio; sottraendolo a quanto aveva ancora in tasca gli restava pochissimo, più o meno una cifra analoga. È vero che da quando gli avevano cambiatol’assegnoaveva spesoadestraeamanca conunacertaleggerezza, come se fossero stati soldidelmonopoli,senza pensare che sarebbero finiti... Il portiere gli indicò lo sportello accanto, era là che avrebbe dovuto pagare, era la stessa cassa dove all’arrivo gli avevano dato le diciotto banconote da 10, nuove di zecca. Ora col cuore pesante ne consegnò quattro – dopo una coda di almeno mezz’ora, naturalmente –, e con amara ironia constatò che nell’arco di una settimana aveva sperperato buona parte del suo assegno senza sapere neanche in quale valuta. Si ficcò il conto in tasca, e intanto che aspettava l’ascensore controllò di nuovo quantoglirimaneva.Tre biglietti da 10, alcuni taglipiùpiccolida1eda 2, come poté leggere su quei pezzi di carta sgualcita e sbiadita, e un po’ di spiccioli. Erano pochi soldi, una somma pericolosamente misera: non osava immaginare che cosa sarebbe successo quando li avesse finiti, ma non poteva fare a meno di pensarci. Con la testa in fiamme, sommando e moltiplicando cercò di calcolare per quanti giorni sarebbero bastati, e rifletté sul modo di far economia, fermo restando che bisognava pur mangiare. Magari rinunciare a tutti i suoi giri per la città, risparmiare sui trasporti pubblici... Ma come doveva ridursi, tappato in camera ad aspettare l’arrivo delle truppe di soccorso? Il suo cervello, ormai innescato, continuava a lavorare: ora all’improvviso, mentre l’ascensore lo portava al nonopiano,glivenivano mille idee, una migliore dell’altra, anche se tardive e vane, su come arrivare allo scopo o almeno provarci, se solo non avesse dovuto lesinare ogni centesimo... Per esempio avrebbepotutomostrare a qualcuno un biglietto da 10 in una mano e il disegno di un aereo nell’altra, fargli capire a gesti che cercava quella cosa lì, l’aeroporto o gli uffici di una compagnia aerea, sventolargli la banconota davanti agli occhiinsiemealdisegno, e pagarlo solo se lo avesse condotto là. Oppure poteva adescare in metropolitana un passeggero che gli fosse sembratoadatto,unoun po’ male in arnese, passargli la banconota sotto il naso come una pannocchia di granturco davanti al muso di un maiale, e imitando il fischio della locomotiva farsi portare verso una stazione ferroviaria. Una proposta esplicita dello stesso genere poteva persuadereunimpiegato dell’albergoaprocurargli una macchina o un taxi, poi ci avrebbe pensato l’autista ad accompagnarlo dove voleva, aggiungendo ovviamente il prezzo per la corsa; sì, con un tassista se la sentiva di provarci ed era certo di farcela. Queste possibilità gli balenavano nella mente, unadopol’altra,masullo sfondorestavauntimore agghiacciante: a chi si sarebbe rivolto se non avesse concluso nulla e nel frattempo fossero finiti i soldi? In quale aiuto poteva mai sperare? A quanto aveva sperimentato finora, per la gente del posto lui avrebbe anche potuto creparedifame. Nella sua camera era tutto uguale a come l’aveva lasciato, avevano soltanto cambiato le lenzuola, gli asciugamanielatovaglia di tela sul tavolo: evidentementedavanola biancheria pulita ogni settimana. Budai guardò in strada dalla finestra e vide la fiumana di folla che serpeggiava interminabile. A Helsinki il congresso doveva essere finito da un pezzo, i partecipanti erano tutti ritornati a casa, anche i più lontani...Sisvestì,tiròle tende,sisdraiòsullettoe si mise sotto le coperte. Un minuto più tardi sentì che il suo corpo si irrigidiva, il tronco e gli arti erano bloccati, come instatod’ipnosi,nonera in grado di sollevarsi e nemmeno di voltarsi sul fianco, non riusciva assolutamente a muoversi.Manonvoleva muoversi, sarebbe rimasto lì con gli occhi chiusi per un tempo indefinito, senza alzarsi neanche per bere, disteso, senza pensare a niente, per ore o anche pergiorni,perl’eternità. La sua famiglia si aspettava che tornasse quattro, cinque, al massimo sei giorni dopo la sua partenza: avrebbe dovuto essere a casa già da un pezzo. Chissà che cosaavevanopensatodel fatto che non avesse scritto, telefonato, mandato un telegramma, che non avesse più dato alcun segno di vita. Quando avevano cominciato a cercarlo, e a partire da dove? Da Helsinki? La segreteria organizzativa del congresso di linguistica doveva aver segnalato che lui non si era mai fatto vivo, che l’avevano atteso inutilmente. Forse si erano rivolti alla compagnia aerea? O uno dopo l’altro ai probabili aeroporti di scalo dai quali poteva esser transitato per sbaglio? Chissà quali strade avevano tentato, in preda a un’angoscia crescente: dov’era finito, era pensabile che fosse sparito in quel modo, senza lasciare traccia? Come si spiegavano questo mistero i parenti, gli amici, i colleghi, e soprattutto sua moglie, come doveva sentirsi? E suofiglio,unbambinodi pochi anni, e il cane?... Immaginare il loro smarrimento, l’agitazione, i tentativi via via più disperati, le ansiose congetture, il timore di un incidente – questi pensieri gli davano un dolore quasi fisico,chesisommavaal suo senso di impotenza: era intollerabile, molto peggio della sua condizione, ogni volta che queste idee lo assalivano si sforzava di scacciarle. Non avrebbe saputo dire per quanto tempo fosse rimasto a letto, forse per due o tre notti. Durante tutte quelle ore non era comparso nessuno, nessuno aveva telefonato o bussato alla porta; lui per lo meno non aveva sentito nulla, enoneranovenutiafare lepulizie.Sierasvegliato bruscamente e aveva visto che era mattina, la luce filtrava grigia dalla finestra, un’altra giornata fosca e plumbea: da quando era capitatolìavevascortoil solesìenounpaiod’ore. Si riscosse, andò in bagno a farsi una doccia e la barba. Diede un’occhiata al conto che sieraficcatointascagiù alla cassa: purtroppo i numerieranoscrittisolo in cifre, non in lettere. E pensare che avrebbe potuto essere un buon punto di partenza per capire la grafia delle cifre. Se l’avesse appurato, avrebbe tentatodiascoltaredalla viva voce degli abitanti la forma fonetica dei numeri, magari estorcendola con domande astute, e così, per gradi, sarebbe riuscito a decifrare primalascritturaepoila lingua; naturalmente tutto questo avrebbe richiesto parecchio tempo. E comunque sarebbe dovuto partire dauntestoconinumeri scritti sia in cifre che in lettere; e non era il caso di quel modulo... Perciò preferì mettere da parte ilcontoerimandareaun altro momento la riflessione. Nell’immediato aveva compiti più seri e importanti a cui dedicarsi, e per concentrarsi in tali riflessioni lasciò la sua stanza solo per mangiare: andava alla tavola calda che già conosceva oppure, per risparmiare,compravaal negozio generi poco costosi come pane, pancetta,cetrioliesimili. Macomunquenonaveva appetito, benché fosse a digiuno da giorni, assorbito com’era da un indefesso lavorio mentale: non aveva perso la fiducia nella propria intelligenza, ed era convinto che se avesse esaminato con ordine tutto quello che gli era successo – dall’inizio, dal momento incuierascesodall’aereo per salire sul pullman che l’aveva portato in città – qualcosa sarebbe per forza venuto fuori, proprio come una somma in fondo a una lungacolonnadinumeri. Stava seduto alla scrivania e riempiva fogli di disegnini e appunti, col sistema che usava a casa quando era alle prese con qualche complesso problema linguistico: accostava e confrontava i foglietti dove aveva annotato, come per gioco, diverse forme lessicali e relative varianti, fino a quando, presto o tardi, all’improvviso i dati si disponevano secondo un ordine chiaro ed evidente. Certo, quando succedeva... Credeva nella sua intuizione, nella prontezza del suo ingegno,nellacapacitàdi approfondimento, nel suo estro, dote indispensabile per la ricerca scientifica, e forse anche nella fortuna, che durante la sua carriera l’aveva finora assistito, riusciva aportareaterminetutto quel che intraprendeva. Era abituato a ragionare con metodo, era il suo mestiere, era così che si guadagnava da vivere. Anche ora, mentre tracciava figure e appunti sul taccuino – attività che metteva istantaneamente in moto la sua immaginazione –, provava quasi lo stesso piacere che si prova nel risolvere un problema di logica: affrontare la miriade di misteri di quella città con la sola forza dell’intelletto. Raccolse tutte le esperienze che gli erano capitate e le inserì nel suocervellocomedatiin uncomputer,aspettando che le elaborasse e producesseistruzioni. Giunse a una conclusione sostanziale, per quanto penosa e amara: per prima cosa doveva sapere con precisione dov’era, se voleva andarsene di lì, altrimenti ritrovare la strada di casa era fuori questione. Non era possibile evitare o rovesciare quest’ordine di priorità, una cosa seguival’altra.Chissà,se no, quanto tempo avrebbe dovuto aspettarel’aiutodelcaso: gliimprovvisatitentativi difugaeranofallitienon c’eranessunagaranziadi un miglior esito in futuro.Qualechefosseil luogonelqualeildestino lo aveva scaraventato, si persuase che lasciarlo nonerafacile. Non che fosse diminuita l’urgenza, ma forse era stata proprio la fretta il suo errore più grave, scappare a gambe levate senza aver chiaro sequellazonadelmondo comparisse sulle carte geografiche, o se invece nonfosseinunterritorio sconosciuto, e lui il primo esploratore fra i suoi simili. Perché in tal caso non poteva squagliarsela, doveva farsi carico dei compiti fondamentali di un esploratore: determinare laposizionegeograficadi quella città, scoprirne il paese e continente, chi erano gli abitanti, che lingua parlavano e così via, in modo da poterne dare notizia una volta tornatoacasa. E,fral’altro,sitrovava sulla Terra o su un altro pianeta? Nell’èra delle missioni spaziali e della fantascienzaladomanda non suonava così assurda. Riflettendoci a mente fredda, però, scelse la prima ipotesi. Accanto a molti altri segni, a testimoniarla erano la vegetazione tipicamenteterrestreche aveva osservato nei parchi – gli alberi, l’erba, i fiori –, e le specie animali che gli era capitato di incontrare: cani, gatti, piccioni, passeri, insetti, i conigli d’angora della stanza dell’albergo, i pesci al mercato e i canarini, i pappagalli, le tartarughe alla fiera degli animali vivi, a parte quella lucertola a sei zampe di cui non aveva mai sentitoparlare.L’odoree la consistenza dell’aria non erano diversi da quelli del suo luogo d’origine. E, naturalmente, a indicare che fossero sulla Terra era soprattutto la presenzadiesseriumani, per giunta con una densità senza confronti, e di case, strade, alberghi, trasporti pubblici, veicoli, metropolitana: tutto era identicoomoltosimilea quel che si trova in qualsiasi grande città. Il modo di vivere in generale,iritmi,inegozi, i ristoranti, il cibo, l’economia basata sul denaro,ilfattostessoche gli avessero cambiato l’assegno di viaggio; i numeri arabi e l’uso del sistema decimale. La scansione del tempo in settimane, la pausa domenicale, eccetera, eccetera. Stelle non ne aveva viste, il cielo era quasi sempre coperto, ma per fortuna la sera successiva si schiarì per qualche ora. Budai non sapeva molto di astronomia, era in grado di riconoscere solo qualche costellazione, le Pleiadi, Orione e l’Orsa Maggiore e, a partire da quest’ultima, sin da piccoloavevaimparatoa individuare la stella polare. Si mise d’impegno a cercare proprioquesteeletrovò, dunque doveva essere nell’emisfero settentrionale: non ne sapeva molto, appunto, ma era sicuro che in quellomeridionalel’Orsa Maggiore non era visibile... Ma se era sulla Terra, a che grado di latitudine e longitudine si trovava? In vita sua non si era mai occupato di queste cose, forse avevalettodicoordinate geografiche solo nei romanziperragazzienei resoconti di viaggio. Si sforzò di ricordare come si faceva a stabilirle, e provò anche ad arrivarci da solo: se avesse messo a confronto il mezzogiorno locale, cioè quando il sole è più alto, con l’ora del suo paese – semprecheavesseavuto consél’orologioenonlo avesse spostato sull’ora locale –, dallo scarto si poteva calcolare la longitudine: bisognava dividere le 24 ore per 360 gradi, ogni differenza di quattro minuti equivaleva a un grado, e così avrebbe saputoaqualedistanzaa estoaovestsitrovavada casa. Ma era senza orologio, e non poteva farci niente. In assenza di qualsiasi strumento, determinarelalatitudine di quel luogo era una questione di pura speculazione e avrebbe potuto arrivarci solo a prezzo di estenuanti calcoli mentali. Il sistema più rapido era misurare l’angolo tra la stella polare, che è allineata all’asse terrestre, e l’orizzonte. Ma ci voleva un sestante o un teodolite, e dove procurarseli? A occhio nudopotevastimaresolo approssimativamente l’altezza della fioca stella polare–semprechefosse quella – e gli sembrava più o meno la stessa che dalle sue parti: doveva quindi trovarsi sul medesimo parallelo, o non lontano, ma dove? In Europa? In Asia? In America? O in un continente ancora sconosciuto? Aveva considerato spesso il clima sgradevole o la composizione multietnica della popolazione, ma non ne ricavava indizi utili. Il loromododivestirenon erapernullainsolito,era paragonabile a quello che si vede nelle grandi città europee, forse appena più grigio e austeroeconunmaggior numero di uniformi. Gli venne in mente la guardia nera alla polizia, che aveva la stessa tuta indossata da molti: che fossero tutti, fra uomini e donne, dei secondini o delleguardiecarcerarie? Intanto, andando su e giù in ascensore, aveva visto spesso la ragazza bionda.Cercavadicapire i suoi turni, ma finiva per confondersi: a volte era lì nelle ore che lui prevedeva, a volte no, altre volte ancora, quando le porte automatiche si aprivano conilloroforteronzio,se la trovava davanti inaspettatamente.Ormai si salutavano, e da certi piccoli segni si intuiva che anche Budai aveva colpitolasuaattenzione. In un paio di occasioni, mentre lui si apprestava a scendere, la ragazza gli aveva anche rivolto la parola: in risposta lui le aveva sorriso timidamente stringendosinellespalle, come a dire che non capiva, ma non c’era stato il tempo di aggiungere altro e quelli che uscivano l’avevano trascinatofuori. Ma la volta successiva, al nono piano, la donna gli posò la mano sul braccio e lo trattenne; Budai finalmente capì che voleva invitarlo da qualche parte. Restò nella cabina, che via via chesalivasisvuotavadei passeggeri, mentre i numeri dei piani si accendevano uno dopo l’altro sulla tabella luminosa sopra le porte. Il diciottesimo era l’ultimo, e nell’ascensore erano rimasti solo loro due.Laragazzaaprìegli fececennodiscendere. Era un piano diverso, senza stanze. C’erano enormi serbatoi verniciati di bianco e tubi di tutte le dimensioni, l’impianto diriscaldamento,ilvano motori dell’ascensore, pulegge e cavi. E anche una specie di bar o ristorante che al momento era chiuso – forse lo aprivano nella stagioneestiva–conuna terrazza panoramica affacciata sulla città, per quanto poté vedere dalla porta a vetri chiusa da unlucchetto. La ragazza si accese una sigaretta e gliene offrì una. Budai le fece capire che non fumava. Da come aspirava avidamente il fumo e lo espirava sembrava una fumatrice accanita, e in ascensore ovviamente non poteva fumare. Nel frattempo gli sorrise, come a scusarsi: ora era fresca e riposata, i tratti del viso erano distesi e non mostravano traccia di stanchezza, aveva un modo di fare spigliato e sereno,unapettinaturae un trucco perfetti. Non cercò di forzare la conversazione, doveva essersiormaiaccortache era inutile, buttò lì qualche parola con voce morbida,qualcosacome: «Jejee tlehuatlan... Muulatlalaalli?». Escoppiòinunarisata sommessa, lenta e melodiosa, soffiando uno sbuffo di fumo, con la schiena appoggiata a uno dei serbatoi. Dalla cabina aperta si udì un trillo, stavano chiamando l’ascensore dai piani inferiori, ma la cosalilasciòindifferenti. Budai si picchiò il dito sul petto, ripeté il suo nome un paio di volte, poi indicò la ragazza con aria interrogativa. Lei rise di nuovo e rispose con una parola di due sillabe. Lui non era sicuro di aver capito e domandò: «Pepe?Tete?». Ma avrebbe anche potutoessereBebe,Veve, Ghieghie, Dede o chissà che altro ancora, l’aveva detto articolando i suoni in maniera così strana, e quando lo ripeteva suonava diverso, a volte sembrava addirittura di tre sillabe, qualcosa come Edede, Bebebe. Ma forse declinava il nome, oppure aggiungeva un articolo...Aquelpuntoil campanello suonava con insistenza, ai piani inferioridovevanoessere in tanti ad aspettare l’ascensore. La donna spense la sigaretta, la breve pausa era finita. Budai rientrò con lei nella cabina, che tornò a riempirsimanmanoche scendeva: nuovi passeggeri si infilarono tradiloro,einbreveluie la ragazza non si videro più. Soltanto al nono piano,primadiscendere, intercettò il suo sguardo e si scambiarono un’occhiatad’intesa. Era elettrizzato: per quanto esile, era pur sempre un legame, un rapporto, il primo da quandoeralì–sel’avesse mantenuto e coltivato, poteva diventare il filo d’Arianna di quel gigantesco e popoloso labirinto... Magari stava facendo una scoperta dalla portata universale, e un giorno, alla fine, avrebbe visto con altri occhi quella situazione. Magari era il primo a essere arrivato in quel luogo. O forse no, era tuttaunasuaillusione. In ogni modo, era ora di affrontare il compito che si era dato: innanzitutto farsi un’idea delle dimensioni della città. La mattina dopo uscì di buon’ora, salìsuuntrenoqualsiasi inmetropolitanaearrivò fino al capolinea, dove il vagone si svuotò completamente. Sulla banchina si fermò un momento a pensare alla direzione da prendere in superficie: avrebbe puntato verso la periferia, allontanandosi dal centro. Si sforzò di memorizzareilsensodei binari per orientarsi, gli sembrava la cosa più logica, ma i sottopassaggi della stazione si rivelarono tortuosi, un intrico di corridoi, scale, svolte e sbocchi: quando fu in stradanonsapevapiùda che parte andare, così si incamminò a caso, nell’ignoto. Tracciò sul taccuino uno schizzo degli incroci e degli edifici più caratteristici chesilasciavaallespalle, peraiutarsialritorno. Erauntipicoquartiere diperiferia,lunghimuri, recinzioni, ciminiere, gasometri, strade larghe e sporche, tetre case di mattoni; lontano contro il cielo grigio la sagoma scuraeimponentediuna grandefabbrica,coltetto dentato come una sega, un’ariapienadifuliggine e acre odore di fumo. Qua e là spacci di alimentari, rigattieri, negozidiarticolivaricon levetrinepienedimerce piuttosto scadente. E ovunque la marea dei passanti era densa come altrove... Forse aveva sbagliato direzione? Oppure la metropolitana non raggiungeva i confini della città? O la città era cresciuta a dismisura? Come dovevano sentirsi gli abitanti, nati in mezzo a quel caos? Non si rendevano conto che la follainondavaeintasava tutto,liobbligavaastare perennemente in fila, a sprecare un mucchio di tempo, come riuscivano atollerareunaqualitàdi vita così infima? O non sapevano immaginare niente di diverso, a loro sembrava naturale, ci avevano fatto l’abitudine? Ma ci si potevamaiabituare? Le strade erano piene diveicolianchelìeBudai provòaleggereletarghe, ma non fece nessun progresso: lettere indecifrabili si alternavano a tre, quattro, cinque cifre, e non c’era nessuna sigla internazionale che permettesse di risalire al nome del paese. Se avesse saputo guidare avrebbe cercato di procurarsiunamacchina – senza giri di parole, di rubarla – per poi inventarsi qualcosa. Ma non era capace... e tantomeno di rubare; e poi senza una cartina non sarebbe andato lontano,inqueldedalodi vie e piazze, in quel traffico da ora di punta. Gli venne in mente di aver visto un negozio di biciclette,manonavevai soldi per comprarne una e del resto non sarebbe mai riuscito a usarla senzaperdersi... Di stazioni ferroviarie non c’era traccia, e neppure di ponti ferroviari o terrapieni dovesupporredeibinari. Cercò invano un aeroporto; ogni tanto si sentiva in alto il rombo di un aereo ma non si capiva da che parte atterrassero o decollassero. Se la città fosse stata sul mare, avrebbe camminato lungolacostaallaricerca di un porto, e lì avrebbe trovato delle navi, una barca: avrebbe issato le vele con una rotta qualsiasi, perché il mare è una porta spalancata, unaviaversoogniluogo. Non si era imbattuto nemmeno in un fiume, inuncanale,inuncorso d’acqua qualsiasi che in teoria – se lo avesse seguito–l’avrebbeprima o poi condotto al mare, dove doveva sfociare. Aveva visto solo dei bacini artificiali, nei terreni fra un edificio e l’altro, pieni d’acqua stagnante,sporcaenera, simili alle cisterne costruite nel suo paese durante la guerra; e un laghetto ornamentale senza canale di scolo nel parco che aveva attraversato un giorno, sulla cui superficie galleggiavano cartacce, bottiglievuoteemacchie oleose. Ricominciòafermarei passanti chiedendo da che parte fosse il mare, mimando con le mani il moto delle onde o muovendo le braccia come un nuotatore. Ripeteva la parola più volte, ora in una lingua, orainun’altra,perfinoin greco: «Thalassa!Thalassa!». Naturalmente non lo capivano e se ne andavano per la loro strada,indaffarati,senza tempo da perdere con i suoi grattacapi. Dopo vari tentativi Budai si perse d’animo e smise di domandare, era avvilito, inibito dagli insuccessi, sentiva un nodo alla lingua. Ma continuò a camminare nella folla che non diminuiva, per un istinto più forte di ogni intenzione cosciente: aveva deciso che non avrebbe abbandonato la partita, doveva arrivare fino in fondo, con tutte le sue forze, quale che fosse il risultato. Sulle strade calò una nebbia fredda e pungente, a tratti così fitta che non riusciva a vedereaduemetridasé. Iveicoliavevanoaccesoi fari,procedevanoapasso d’uomo, gli ingorghi erano accompagnati da un concerto di clacson e urla, i motori si ingolfavano. Ora Budai faceva molta attenzione ai punti di riferimento per orientarsi al ritorno. La nebbia si diradò per unattimoegliapparveil conoditelabiancadiun tendone da circo: non lo interessava in quel momento, non sapeva chefarsene,epassòoltre nella caligine grigioviola. Più avanti intravide un portale tutto illuminato: cosa potevamaiessere...? A un tratto si accorse che le macchine erano scomparse, c’erano invece tante lucine fioche e tremolanti. Luccicavano misteriose nella penombra lattescente: erano stelle? O fuochi fatui? In quella foschia fitta e soffice, privadiprospettiva,non riusciva a stabilire a che distanza fossero. E solo dopo essere inciampato più volte in cumuli di terraesagomedimarmo e pietra, si rese conto di essere in un cimitero, e quelle fiammelle erano candele e lumini, che stavano sulle tombe oppure in mano ai visitatori. Questi ultimi gremivano i viottoli di pietriscooccupandoogni palmo di terra fra i tumuli e i mausolei: Budai si chiese se per caso fosse il giorno dei morti, ammesso che lo celebrassero da quelle parti. Oppure era capitato in un corteo funebre, magari di qualcuno abbastanza famoso da radunare una simile moltitudine? O in quella città era normale checifosselafollaanche alcimitero?...Dalontano arrivava una musica d’organo o di uno strumento simile, una melodia grave e solenne che pareva accompagnata da canti lenti, strascicati: era impossibile stabilire da dove proveniva, se dall’altoodasottoterra.I monumenti funebri, per quanto si poteva intravederenellanebbia, erano di varie forme e dimensioni, con fiori e vasi, talvolta con una statua o il ritratto del defunto. Non erano moltodiversidaquellidi tutti i cimiteri, ma non c’erano croci, per lo meno su quelli che osservò da vicino: le iscrizioni sulle lapidi erano incise con quei caratteri simili a rune. Non poté fermarsi a studiarle perché veniva continuamente spinto via dal torrente umano, che sembrava seguire unadirezioneprincipale; alla fine si ritrovò fuori dalcimiterocosìcomeci era capitato, cioè senza accorgersene. La nebbia si era un po’ diradata: gli apparve un quartiere operaio, tante casette tristi, tutte uguali, con l’intonaco scrostato, dai tetti mancava qualche tegola, in piccole aiole crescevano sparuti cespugli di erbe aromatiche. Poi un alto muro di cinta, un portone di pietra assediato da centinaia di persone:noneraunafila questa volta, ma un assembramento rumoroso e disordinato dove tutti spingevano per entrare. Budai si chiese che diamine stesse succedendo: la curiosità lo attirò verso quel raduno chiassoso e in un attimo alle sue spalle si era ammassato un mare di gente, e anche volendo non poteva più tornare indietro. L’ingresso era troppo stretto, e le persone continuavano a spingereeadaumentare. A un certo punto erano cosìcompressicheBudai temette di finire schiacciato o calpestato: quando fu finalmente dentro, gli sembrò di esserepassatoattraverso untritacarne. Dovevaesserecapitato inunozoo,omeglio,uno zoo di scimmie, perché non c’erano altre specie dianimali.Soloscimmie, tante gabbie piene di scimmie. E centinaia di visitatori, ogni recinto era circondato da nugoli di persone che contemplavano a bocca apertaesgomitavanoper guardare più da vicino: in gran parte bambini, ma anche parecchi adulti. Erano esposte le specie più disparate di primati, per quanto poté concludere in base alle sue scarse nozioni di zoologia: lemuri, scimpanzé, babbuini, enormi gorilla e minuscoli uistitì, cercopitechi, gibboni, macachi. La cosa più sorprendente era che, per quanto numerose, quellebestiemostravano personalità distinte, bastava osservarle per unpo’eognunarivelava un carattere unico e inconfondibile: il modo di correre, di arrampicarsi su e giù, di mangiucchiare con aria irrequieta; sbucciavano la frutta, giocavano, si grattavano o si spulciavano beate l’un l’altra facendo le facce più diverse, facce fiere o devote, affabili o spaventose, pietose o arroganti; squittivano, strillavano, chiacchieravano, gracchiavano, ridacchiavano, si eccitavano e si annoiavano, si amavano e si odiavano, si picchiavano o si accoppiavano, o se ne stavano accovacciate in un angolo con aria afflitta,sognandolibertà eforeste. C’erano avvisi in ogni luogo e le reti delle gabbie erano piene di scritte, più o meno lunghe. Quanto a Budai, avrebbe preferito che fossero poche e brevi, perché allora si sarebbe trattato inequivocabilmente del nome della specie, seguito dal nome latino, come si usa negli zoo. Certo, si trovava sempre davantiicaratterichelui non riusciva a leggere, ma questa volta avrebbe avuto un punto di partenza per decifrare quella scrittura: conoscendo il nome latino del babbuino – casualmente se lo ricordava, papio – era possibile scoprire i segni corrispondenti a quei suoni, e sostituendoli in altre parole un po’ alla volta avrebbe decifrato l’interoalfabeto...Sì,mai cartelli erano così tanti che potevano indicare ogni sorta di cose: il divieto di dar da mangiare agli animali, notizieedatisullaspecie in questione, la distribuzione geografica, perfino il marchio di fabbrica della gabbia, cose generiche come «Vietatogettarerifiuti»o «Vietato fumare»... Sembrava impossibile pescare da una tale marea di scritte quella riferita al nome della scimmiadietrolesbarre, figurarsi poi il nome latino, sempreché lo usassero. C’era una fila lunghissima anche davanti alla porta dipinta di verde dei servizi igienici, due colonne distinte per gli uominieperledonne:se la sorbì fino in fondo, non aveva alternative... Piùtardi,daunviadotto, che per chissà quale ragione faceva passare una strada al di sopra di un’altra, scorse in lontananza uno stabilimentobalneare.Vi erano diverse piscine, grandiepiccole,affollate dibagnantinonostanteil clima invernale; nell’acqua non c’era quasi lo spazio per muoversi, la gente si tuffava vociando e schizzando,altristavano appesi a grappoli al trampolino. Per quanto poté,attraversoilvapore che si condensava nell’aria fredda, perlustrò con lo sguardo tutta l’area dello stabilimento in cerca di condotte o canali di smaltimentoperleacque reflue, ma non vide niente del genere; dedusse che le tubature eranosotterranee. Il paesaggio della periferia diventava più desolato, le case si diradavano e si alternavano a terreni incolti e a prati; però il traffico stradale rimaneva pressoché lo stesso. La nebbia era svanita, l’aria era fredda e secca, e per qualche minuto fece la sua comparsa nel cielo sporco il disco rossastro enitidodelsole.Quaelà erano sparse baracche di cartone incatramato o ricavate da carcasse di autobus, e lontano la lunga sagoma color ruggine di una discarica di detriti chiudeva l’orizzonte. A un certo punto si creò un ingorgo di pedoni e macchine, la massa era così compatta chetuttisifermavano,si riuscivaapenetrarvisolo a forza di spallate nella ressa; evidentemente un ostacolo ostruiva la strada. Budai non si lasciò scoraggiare, riteneva di avere affari piùurgentideglialtriesi fece largo a spintoni, ormai aveva imparato chenonc’eraaltromodo di cavarsela. Così, dopo diecioquindiciminutidi mischia e botte, arrivò a vedere ciò che impediva ilpassaggio. Dei bovini stavano attraversando la carreggiata, un’intera mandria sfilava lentamente, muggendo, guidataacolpidifrustae con l’aiuto di cani da alcuni mandriani in stivali di gomma, giacca di pelle o di velluto a coste, cappello a tesa largaobasco–unaviadi mezzotracowboyebulli di periferia... Budai agì d’impulso e seguì i bovini sul terreno erboso, lasciando la strada asfaltata e confondendosi con i mandriani, anche se il suo abbigliamento era diverso dal loro. E non sapeva il perché di quel gesto,nonsichiesedove stava andando, voleva solo uscire dalla città. Nessuno gli domandò che cosa ci facesse con loro; la mandria avanzava disordinatamente e sollevando nuvole di polvere, ogni tanto qualchetoroimbestialito tentava di fuggire e creava un gran subbuglio,finchéicanie ibovari,unendoleforze, non lo riprendevano con grida selvagge e nervosi latrati. Attraversarono una distesa sabbiosa, oltrepassarono una segheria dove si tagliava il legname in mezzo a sibili assordanti, e poi entrarono in una zona abitata, gli zoccoli degli animali scalpitavano sul selciato con un rombo sordo. Poi guidarono quel branco di bestiame verso un terreno recintato e da lì in un edificio dalle volte immensechesorgevasul lato opposto. Budai si buttò in avanti, un po’ per curiosità, un po’ portato dal suo stesso slancio: si accorse che le bestie erano entrate quasi tutte nel vasto capannone a pilastri, ma non vide la testa della mandria, che doveva aver raggiunto una zona più in là nell’edificio. Uomini e bovini riempivano tutto lo spazio, oltre ai mandrianic’eranooperai in grembiule di tela che si affaccendavano: i muggiti e le grida erano sempre più sinistri e ogni suono rimbombava fra le pareti nude, nell’aria aleggiavano odoricaldienauseanti:si trovava al mattatoio, nonc’eranodubbi. Quell’orda rumorosa e scomposta di bestie e uomini confluiva in una grande sala rischiarata da lucernari, dove il pavimento era rosso e scivoloso per il sangue. Gli animali dovevano intuire il destino che li attendeva, forse per l’odore del sangue, si impennavano e pestavano disperatamente gli zoccoli,dilìnonavevano alcuna via di scampo, e da dietro spingevano nuovicapi.Quandoerail suo turno, l’animale veniva circondato all’improvviso da un gruppo di nerboruti garzoni,unoloafferrava per le corna, un altro lo tenevaconunacordaelo immobilizzava con le zampe divaricate. Allora quello con la scure lo colpiva da dietro sulla nuca:lezampecedevano e la povera bestia crollava sul pavimento. Una volta a terra, lo colpivano anche sulla fronte, ma doveva restare vivo ancora parecchio tempo perché, riversosuunfiancosulle piastrelle, si agitava e scalciava scuotendo la testa, anche dopo che gli avevano ficcato un coltello nella gola per dissanguarlo, e il suo sguardotristedamartire diventava vitreo, con una lentezza esasperante. Budai non tollerava quella vista, non voleva più guardare, ma ovunque si girasse giacevano animali moribondi, dieci, venti, trenta, che poi venivano trascinati via per essere scuoiatietagliatiapezzi, e di seguito toccava ad altrialloroposto,sottoi colpi della scure, e quando anche questi erano stati abbattuti, eccone ancora, senza fine,comesearrivassero lì tutti i bovini del mondo... Indietro non poteva tornare perché la mandria che rifluiva nella sala lo avrebbe travolto e schiacciato, poteva solo andare oltre, in avanti, dentro la carneficina, inciampandoininteriora e pelli, in frattaglie e pezzi di carcasse, in mezzo al sangue fumante, a macellai coi vestiti insanguinati e a muri sporchi di sangue, fra i pilastri: sentiva che senonfosseuscitoalpiù prestosarebbesvenuto. Quando finalmente si portò fuori dal capannone, si ritrovò nell’angolo di un cortile sul quale si aprivano delle officine di lavorazione: si preparavanoinsaccati,le macchinemacinavanola carne e la riducevano in poltiglia. Ormai lontano dalla scure, da quello sterminiodimassachesi trasformava a poco a poco nella routine della produzione su larga scala, non riusciva ancora a liberarsi dalle immagini che aveva visto là dentro. Le ginocchiaglitremavano, e le forze lo stavano abbandonando al punto chedovettetenersiauna grata per non crollare a terra... Dopo quella violenta commozione, sopraffatto da un disperato senso di solitudine, cercò conforto evocando l’immaginedellaragazza dell’ascensore mentre fumava all’ultimo piano dell’albergo: la sentiva molto vicina, provava il bisogno quasi vitale di aggrapparsi a lei, anche solocolpensiero.Eppure nonsarebbestatocapace di raccontarle quell’esperienza da incubo, dato che non riuscivano a capirsi al livello più elementare; non sapeva nemmeno con quale nome pensarla: Bebe, Tetete, Epepe? Uscì dal cortile del mattatoio passando dal cancello posteriore e proseguìilsuocammino lungo un fossato. Osservò la superficie dell’acqua, vi galleggiavano delle foglie morte, immobili: acqua ferma e fangosa nel suo letto, odore di marcio. Poi, in maniera piuttosto sorprendente, il paesaggio ritornò urbano:ricomparverogli edifici, all’angolo di una strada svettava un grattacielo rotondo dalle lineemoderne.All’uscita del metrò si era incamminato nella direzione sbagliata o aveva girato in cerchio e stava tornando indietro, verso i quartieri centrali dai quali era partito? Oppure quella era una città diversa? E sorgeva cosìvicinoall’altra? Davanti a un negozio di scarpe un giovane paralitico in sedia a rotellesuonavailviolino – ma forse questa scena risaliva a un’altra volta chesieraavventuratoai confinidellacittà,ledue giornate ormai si confondevano nella sua memoria. Aperta per terra giaceva la custodia delviolino,conattaccato un cartello. Budai stavolta provò a intuire quelchec’erascrittocon l’aiuto della situazione, del contesto. Dovevano essere parole toccanti, perché i passanti, che anche qui riempivano le strade, gettavano spesso degli spiccioli nella custodia, facendoli cadere anche tutt’intorno, e parecchie personesieranofermate in circolo ad ascoltare il musicista, bloccando il passaggio. Il ragazzo suonava discretamente, maneggiava lo strumentoconunacerta abilità, di sicuro aveva studiato musica, forse c’era scritto questo sul cartello. Suonava una strana melodia, molto semplice, commovente, densa e pura, carica di nostalgia, o almeno così parveaBudai;nonaveva frettadiproseguireilsuo cammino e si unì agli astanti. Il ragazzo eseguiva sempre la stessa aria, ricominciandola ogni volta; aveva le cosce atrofizzate, e i suoi piccoli piedi striminziti, nelle scarpe minuscole, pendevano inerti dalla sedia; il viso un po’ gonfio, la fronte incorniciata dai riccioli, chinosulsuostrumento, tirava l’arco traendone quella sola melodia, ignaro di tutto, incurante, lo sguardo vuoto puntato sulle corde – o forse era cieco...? Visto l’effetto che esercitava sugli ascoltatori e le copiose offerte, Budai immaginò chesulcartelloilgiovane invalido informasse il pubblico che aveva intrapreso la carriera di musicista ed era stato costretto a interrompere glistudiperlapovertà.E benché si trattasse solo della sua supposizione – che tra l’altro, quand’anche l’avesse indovinata, poteva comunque essere una subdola messinscena, unodeisolititrucchiper abbindolare gli ingenui –,Budainefucomunque colpito e commosso. Certo,erainunostatodi profonda prostrazione, abbandonato a sé stesso da chissà quanti giorni, sempre più solo in una giungla sterminata di pietra, cemento e mattoni,inmezzoaisuoi innumerevoli abitanti... Sebbene avesse deciso di badare al centesimo e di spendere il minimo indispensabile, ora lanciò anche lui una monetinaalviolinista. E poi tirò avanti per la suastrada.Glisembròdi entrare di nuovo in un quartiere del centro storico: le strade erano diventatepiùstrette,agli incrocic’eranoisemafori pedonali, ogni tanto un palazzo antico mostrava la patina dei secoli, e vi erano resti di mura e fortificazioni come quelle già viste in precedenza. Era stanco per il gran camminare, ma non trovò né un parco né una panchina sucuisedersi. Mentre cercava un postoperriposare,scorse un edificio con una copertura di acciaio e vetro, con una torre e una cupola, e quattro grandi orologi sulla maestosa facciata che segnavano il tempo all’unisono; all’interno intravide una sala enorme e profonda, e fiotti di gente che entrava e usciva dall’ingressoprincipalee da quelli laterali. La formadell’edificiogliera familiare, ne aveva visti di simili in tutto il mondo. Budai lo osservò con il cuore in gola per l’emozione: che fosse finalmente una stazione ferroviaria?... Ma una volta entrato in quello spazio immenso, una speciedihangardivetro e acciaio, non vide né binari né vagoni né locomotive,eilviavaiei rumori erano di tutt’altro genere. Eppure l’edificio visto da fuori, nelle linee generali e, a osservare bene, persino nella pianta, aveva tutte le caratteristiche di una stazione, tanto che si sentì di concludere che era proprio quella la sua destinazione originaria, e poi dovevano averlo convertitoadaltro.Ache cosa, lo ignorava; quel vasto atrio gremito di persone sembrava una sala d’aspetto. Da lì, divisi da file di colonne, si diramavano corridoi a destra e a sinistra, e gruppi di persone in attesa, in silenzio o bisbiglianti, si concentravano soprattutto in prossimità delle porte d’entrata; posti a sedere, però,noncen’erano. Altre porte a vetri si aprivano su locali più piccoli, e con qualche spallataegomitataBudai riuscì ad avvicinarsi e sbirciare dentro. Un uomo vestito di scuro sedevaauntavoloposto sopra una pedana, e di fronte a lui il pubblico assisteva in file di panche. In un angolo laterale c’era una specie di pulpito dal quale parlavaun’altrapersona: nella prima stanza era occupato da una donna di colore dalla capigliatura lanosa, in tailleur blu; in quella successiva, da un uomo alto e atletico nell’uniforme di tela marrone. Sulle prime Budai credette di essere capitato in una scuola o in un’università, dove quelli sul pulpito rispondevano a un’interrogazione, in cattedra c’era il professore, e tutti gli altrieranostudenti–ma alloraperchésitenevano addosso il cappotto, e soprattutto perché veniva tollerato quel continuo viavai? Ma era troppo stanco per rifletterci:aprìlaportadi una stanza a caso, nell’ultimafiladipanche c’era un posto libero e andòasedersi. Dal pulpito un ometto basso dall’aspetto insignificante stava cercando di spiegare qualcosa: sbatteva le palpebre, farfugliava e incespicava, si confondeva, si vedeva che non era abituato a parlareinpubblico.Ogni tantounuomovestitodi scuro nella prima fila gli faceva delle domande, così come quello seduto al tavolo sulla pedana. A quel punto Budai capì dov’era finito: era un tribunale, e molto probabilmente vi si discutevano le cause civili, a giudicare dal contesto e dall’atmosfera. E quello che aveva preso per un insegnante era naturalmente il giudice, l’individuo che faceva le domande era un avvocato o qualcosa del genere,quellosulpulpito poteva essere invece il querelato,ilquerelanteo untestimonechiamatoa deporre. Non riuscì però a capire l’oggetto della questione, dato che il dibattimento si svolgeva nellalorolinguaastrusa. È vero che non vi prestò molta attenzione; camminava dal primo mattino, anzi da giorni, quella marcia continua lo aveva spossato, faticava a tenere gli occhi aperti e per un po’ siassopì. Si svegliò di soprassalto quando la donnaaccantoaluidisse qualcosa ad alta voce verso lo scranno del giudice,chesovrastavail pubblico, di certo in risposta a quanto aveva appenasentito.Ladonna doveva essere lì già da prima, soltanto che lui non l’aveva notata: portavaocchialispessi,e anche le palpebre erano spesse e arrossate, come se avesse pianto molto. Per il resto era piuttosto attraente, non sembrava avere più di trent’anni, portava un cappello verde sui capelli biondi raccolti nello chignon, aveva labbra ben disegnate che suggerivano una certa sensualità dietro alla concitazione del momento, e un corpo dalleformepiene,sodee desiderabili che si intuivanosottoilvestito. Era evidentemente irritata da quel che balbettava l’ometto che sbatteva le palpebre, era rossa in viso, teneva la bocca socchiusa, pronta a interromperlo – era forse suo marito? Era un’udienzadidivorzio? Aunanuovadomanda dell’avvocato l’ometto rispose con una sola parola, in maniera straordinariamente pronta; a quel punto scoppiò un putiferio. Il pubblico tuonava, nella prima fila un’anziana virago balzò in piedi agitando minacciosa un ombrello, altri si misero a gridare a squarciagola, il giudice suonava una campanella senza riuscire a frenare quell’uragano di passioni: la vicina di Budai proruppe in singhiozzi, un signore con i capelli grigi e i favoriti alla Francesco Giuseppe si rivolse al giudice indicando la donna piangente. Spuntarono degli uscieri chetentaronodicalmare gli animi e far tornare le persone ai loro posti, la campanella del giudice trillava senza posa. Allora la donna col cappello verde – senza dubbiounadellepartiin causa – sgusciò fuori dalla fila di panche, si slanciò verso il pulpito e si gettò sull’uomo che stava deponendo. Questi tentò goffamente di togliersela di dosso, la donna vacillò, poi emise un lamento di dolore – il caos era totale. Il più impaurito sembrava l’ometto insignificante, che sbatteva atterrito le palpebre: tese la mano verso la donna con uno sguardo tenero e apprensivo del tutto inaspettato, visto quel che era appena successo... Per una volta, eccezionalmente, Budai non si sforzò affatto di comprendere che cosa stesse accadendo. Non ci avrebbe capito granché neanche se avesse parlatolalorolingua:era una faccenda privata, senza speranza né soluzione, che gli era del tutto estranea, lui non c’entrava e non voleva saperne. Così si alzò e uscì dalla stanza, passando in mezzo al gruppetto di gente assiepata davanti alla porta. In strada, si voltò a guardare la singolare facciata dell’edificio e gli venne in mente che, se davvero era stata una stazione,lealtrestazioni della città dovevano trovarsi lungo quello stesso viale circolare, o almeno una parte, come a Mosca – e magari tra queste ce n’era qualcuna che non era stata convertita ad altri scopi. Le probabilità erano senza dubbio esigue, ma ne bastava una soltanto, ealmomentononaveva idee migliori: a ogni modo, si avviò nella direzione che riteneva più plausibile. Ma la via finiva perpendicolare a una stradina, e lui si guardòperplessoprimaa destra e poi a sinistra: adesso da che parte doveva andare? Aveva senso sforzarsi di individuare uno schema?Forselestazioni erano disseminate per la città senza seguire un criterio e uno se le trovava davanti nei puntipiùdisparati,come a Berlino, Parigi, Londra. O forse c’era una stazione centrale che smistava la maggior parte del traffico ferroviario, come ad Amsterdam, Francoforte e Roma. O al massimo due,comeaNewYorkla Grand Central e la PennsylvaniaStation. In una piazza, stretta fra le case, si elevava sopra ai tetti una chiesa alta e imponente. Sembrava un’antica cattedrale, un monumento storico, anche se i numerosi campanili, la cupola gigantesca, gli archi e le volte a tutto sesto, le colonne, le cornici, i fregi, le statue, i pilastri, le decorazioni in pietra e le volute le davano un aspetto a dir poco eclettico: era arduo stabilirne l’epoca, probabilmente era stata costruita nel corso di vari secoli, come spesso le cattedrali. Di fronte all’ingresso principale le persone aspettavano in fila per due, formando una coda lunghissima che costeggiava una navata laterale per poi svoltare e sparire dietro la chiesa... Già che era arrivato fin là, si disse, valeva la pena dedicarvi un po’ di tempo: raggiunse il fondo della codaesiunìaglialtri. La piazza era piena di piccioni che zampettavano e svolazzavano in folti stormi. Erano sfacciati e invadenti: quando avvistavano qualcuno condellebricioledipane non si limitavano ad avvicinarsi, ma andavano a beccarle direttamentedallemani, siposavanosullespallee sulla testa, tubando e frullando, sollevandosi in volo come nuvole grigie, spargendo piume e escrementi. Budai, in coda, provò ad attaccare discorso con un’anziana signora con un logoro collo di pelliccia che, come altri, dava da mangiareagliuccelli,ma forse le si rivolse troppo discretamente,oppurela donna era un po’ sorda, fattostachenonreagìin alcun modo: continuava a gettare le briciole, tubava per attirare i piccioni e lasciava che le si posassero dappertutto... Non si capiva neanche se ad attirare quella folla immensa fosse la devozione religiosa o la curiosità di visitare una chiesaimportante. Dopo un bel po’ – ormai non ci faceva più caso,avevapersoilsenso del tempo – arrivò finalmente all’ingresso, dove sperava di trovare qualche opuscolo illustrativo,comeèd’uso in luoghi simili. Ma appena varcati i battenti del portone il disciplinato corteo ebbe un’improvvisa accelerazione, perché tutti si lanciavano sui banchetti dei venditori che riempivano l’ingresso. Da quel che riuscì a distinguere al di làdellaressa,vendevano oli, unguenti, una poltiglia o pasta dall’aria sospetta, arredi sacri o comunque accessori da cerimonie, e poi candele e incensi, ma niente guide. Le persone si muovevano spingendosi e quasi calpestandosi l’un l’altro, e chi era riuscito ad arraffare un vasetto o una boccetta proseguiva a forza di ginocchiate e gomitate, con il bottino stretto al petto.Lamitevecchietta che poco prima dava da mangiare ai piccioni adesso assestava calci tremendi a chi le capitava a tiro, il logoro collo di pelliccia le era scivolato sulle spalle e sventolava come un vessillodibattaglia. Lo spazio interno, talmente ampio da non poter essere abbracciato con un solo sguardo e articolato in modo caotico, era invaso dai fedeli e dal loro mormorio salmodiante. Varie liturgie si svolgevanoinpiùluoghi contemporaneamente, o almeno così sembrava dalle frotte di persone che qua e là si stringevano attorno a uomini in tonaca e zucchetto – di certo sacerdoti – intenti a recitare o cantare qualcosa a voce alta. Le pareti erano quasi interamente ricoperte di affreschi, immagini, dipinti e mosaici, e intorno erano statue, stucchi, rilievi, pulpiti sovrastati da baldacchini, edicole, nicchie, archi e volte, decorazioni e intagli a merletti, dorature, smalti, avorio, vetrate multicolori,pavimentidi marmo intarsiato, spessi tappeti e pesanti lampadari in ferro battuto: il tutto era di una ricchezza e abbondanza così strabiliante che era impossibile coglierne i dettagli. Budai tentò di individuare uno stile in quell’intreccio sfolgorante, ma – forse perché non se ne intendeva molto – non seppe riconoscere né il romanico, né il rinascimentale, né il barocco, né altro, pur riconoscendo degli elementidiognuno.Così, su due piedi, non riuscì neppure a capire a quale religione o mitologia si riferissero le immagini, lestatueeledecorazioni: figurediuominiedonne, giovaniedecrepiti,perlo piùinabitiantichi,conil saio o una specie di tonaca, rappresentati in gruppi, scene di caccia, cervi e caprioli, cani, leoni, uomini armati di picche e archi e un cavaliere in armatura che lottava con un serpente. Pur avendo poca familiarità con l’iconografia, poteva però escludere che fosse un luogo di culto cristiano o ebraico, poichénonc’eranoaltari, crociostellediDavide,o musulmano, perché il Coranovietalestatue.Se fosse capitato in una sortadipagodaorientale l’avrebbe capito dalla caratteristica figura del Buddha seduto o di Šiva dalle molte braccia... Naturalmente queste erano osservazioni che procedevano per esclusione, e poteva darsi benissimo che si trattasse di templi d’altrogenere.Anchequi le iscrizioni sui muri e altrove erano in quella speciedialfabetorunico, ma i caratteri avevano un aspetto più arcaico e qualchesvolazzoinpiù– forse la loro lingua liturgica stava alla linguavivacomeillatino all’italiano o l’antico slavo ecclesiastico al russo? La cerimonia era bizzarra e selvaggia; Budai si avvicinò a uno dei gruppi più folti, in prossimità dell’ingresso. Fu allora che si accorse che, non lontano, sopra un tavolo coperto da un drappo scuro, giaceva immobile una donna corpulenta, davvero enorme, vestita con eleganzaecircondatadai fiori: era morta. Aveva unvisograssoecolorito, forse l’avevano truccata, un collo pingue col doppiomento,eanchele mani, accanto al corpo, erano paffute e piene di fossette,carichedianelli d’oro affondati nelle pieghe delle dita. Gli astanti, che chiaramente eranolìperdarel’ultimo saluto alla defunta, le voltavano invece le spalle, guardando verso il sacerdote: questi, reggendo un grosso recipiente metallico, quasi una teiera, appeso a delle rumorose catene, all’improvviso cominciò a gridare qualcosa in tono dolente. Allora anche tra i fedeli si levarono gemiti e guaiti, molti si gettarono sul pavimento, sbattendo la fronte così forte da temere che si rompesserolatesta.Enel frattempo non smettevano di lamentarsieiloropianti salivano e riecheggiavanotralealte volte, mescolandosi alle litanie provenienti da altre zone della chiesa. Alcuni avevano gli occhi pieni di lacrime, una donna esile con un foulard nero in testa si sentì male, le gambe le cedettero e dovettero accompagnarla fuori fendendolafolla. Ragazzi in cotta rossa sistemarono delle candele accese intorno alla defunta, ma l’assembleacontinuavaa non curarsi di lei. Tenevano gli occhi fissi sul sacerdote, che alzò e spalancòlebraccia,tanto che le ampie maniche dell’abito talare gli scivolarono fino ai gomiti, poi chiuse gli occhiconun’espressione estatica, quasi voluttuosa, e declamò delle parole con voce metallica, ripetendole per due volte. O forse non erano uguali, ma solo simili, due versi in rima che suonavano pressappococosì: Zöhömöö,pröhödöö Türidümi mödölnöö...! Queste parole produssero sull’uditorio l’effetto di una eccitazionesenzafreni,e anche coloro che fino a quel momento erano rimasti in silenzio cominciarono a singhiozzare,agridare,si prosternarono a terra finendo uno sull’altro, poiché non c’era spazio pertutti.Unvecchioalto e secco si strappò di dosso prima il cappotto, poiglialtrivestiti,ilgilè, la camicia, i pantaloni, gli stivali, restando in lunghi mutandoni a quadretti:avevailtorace ricoperto di un folto vellocanutoeroteavagli occhiinpredaaunafolle frenesia. Anche altri si spogliarono, nonostante il freddo, persino donne e ragazze, come ossesse, quasi a offrire la loro nudità... In Budai, stranamente, lo spettacolo non suscitò indignazione né stupore, ma piuttosto si sentì contagiato dall’ebbrezza di quella devozione: provò il desiderio di gettarsisulpavimentodi marmoinsiemeaglialtri, di togliersi le scarpe e di allentare colletto e cravatta. Era come stordito, invaso da una gioia estatica, felice di trovarsi là e di potersi donare agli altri, di fondersi nella grande comunitàdeicredenti. Accesero l’incenso, e il sacerdote sollevò il turibolo e lo fece oscillare. Allora tutti quanti, come a un segnale, si precipitarono in avanti verso di lui. Benché vinti dall’estasi mistica si disposero comunque in fila per due.Alcunitentavanodi sorpassareperesserepiù vicini, ma quelli in fila non lo permettevano e li ricacciavano indietro: si scatenò una vera rissa per i posti. Un signore obeso con la bombetta e il bastone da passeggio finì letteralmente calpestato, gli camminarono sopra nonostante agitasse le braccia ed emettesse flebili strilli come un maialinodalatte. Lo scopo di tutta la baraonda era arrivare al sacerdote, prostrarsi ai suoi piedi e baciargli la scarpa che fuoriusciva dall’abito talare. Era una scarpina di vernice nera che un tempo doveva esserstatalucida,maora era diventata opaca a causa del contatto di tutte quelle labbra. Quando arrivò il suo turno, Budai si chinò come gli altri ma la sfiorò appena, provandone ribrezzo. Si rivolse al sacerdote prima in latino e in greco, bisbigliando veloce per sfruttare al massimo il brevissimo tempo a sua disposizione, quindi in ebraicoeinanticoslavo, lingue usate nei riti religiosi e presumibilmente note agli studiosi di teologia. Il sacerdote rimase immobile, sul volto scultoreo dalla carnagione bronzea non comparvealcunsegnodi comprensione. Agitò il turibolo che teneva ancora alzato sopra la sua testa; Budai venne spinto via malamente dal fedele dietro di lui, una specie di cinese con la testa rasata e i baffi spioventi, e dovette cedergli il posto per permettereanchealuidi baciare la scarpa di vernicenera. La cerimonia si concluse così; l’assemblea si sciolse e lui si allontanò, sospinto dalla densa corrente dei visitatori. Era stanco e non aveva abbastanza energia per provare a chiedere informazioni a qualcuno, si lasciò trascinare. Il flusso umanosidividevaindue davanti a una scala a chiocciola che portava verso l’alto con una leggera pendenza. Scelse questa via e iniziò a salire,sempregirandoin tondo.Prestoglivenneil fiatone e gli si indolenzirono le gambe, ma gli altri camminavano così in fretta che volente o nolente dovette stare al loro passo, mosso anche dallacuriositàdiscoprire dovestavanoandando. Dopo un bel pezzo, e chissà quanti giri, all’improvviso il percorsomutòdirezione. Svoltarono in un ballatoio circolare intorno a un immenso vano coperto da un soffitto a forma di campana: erano arrivati sotto la cupola della chiesa. Dalla balaustra si potevagettarelosguardo verso il basso, sulla moltitudine che formicolava ottanta o centometrisottodiloro: vista da lì era solo una massa nerastra anonima e impersonale, carne viva che ondeggiava lenta. Ma si provava una vertigine ancora più intensaaguardareinsu, nella cavità della cupola, seguendo i costoloni curvi fino alla cima, che sembravacosìaltadafar venire il batticuore: la sommitàdellacupolaera quasialtrettantolontana cheilsuolo. Bisognava fare tutto il giro del ballatoio, seguendo le frecce disegnate. Poi si varcava una porta, e di qui si salivano altre scale, moltopiùstretteeripide della precedente, che si arrampicavano all’interno della struttura a guscio della cupola. Poi anche queste terminavano e si proseguiva su semplici scale a pioli, anguste passerelle e di nuovo ripide scalette sempre più faticose e che richiedevano quasi un’agilità da acrobata. Ma non poteva più tornare giù, perché c’era gentedietrodilui,ealtri ancora, in fila indiana, senza fine, sin dove arrivavailsuosguardo. Eranoormaivicinialla cima, gli sembrava, e in effetti l’ultima scaletta verticale l’aveva condotto in un piccolo locale circondato da tante finestrine. Doveva trattarsi di quella struttura cilindrica costruita sulla sommità delle cupole per consentire l’ingresso della luce nello spazio sottostanteche,aquanto ricordava, in gergo architettonico si chiama lanterna.Sopradiessasi elevava una minuscola calotta di vetro, il punto piùaltodellachiesa.Una scaletta di ferro portava lassù,eallafine,unoper volta, ci si poteva sporgere con il busto. La scomodità era ampiamente compensata dalla vista che si godeva: tutto intorno si allargava il panorama dell’intera città. Stavacalandolasera:il cielo si tingeva di color nero inchiostro, ma era difficilediresequellache gravava sopra i tetti fosseunanebbiadifumo e fuliggine o una nuvola caricadipioggia.Lacittà si estendeva a perdita d’occhio in tutte le direzioni: ovunque ci si voltasse non se ne vedevano i confini. Non c’erano altro che case e isolati, vie, piazze, torri, quartieri antichi e moderni, caseggiati logori e fatiscenti e grattacieli nuovi fiammanti rivestiti di marmo candido, viali e vicoli, fabbriche, officine, gasometri, e il gigantesco capannone del mattatoio, che riconobbe anche da lontano. E camini, camini dappertutto, cometantegoledidrago verso il cielo che sputavano fumo bianco, nero, giallo e violaceo. E ilventolorimescolavain cumuli sporchi e ne soffiava alcuni filamenti anche attorno al suo punto d’osservazione; era un vento freddo e furioso che ululava cingendo d’assedio la cupola, tanto che la struttura cigolava e gemeva sotto le sue raffiche e la sommità oscillava sensibilmente. Si infilava anche nella piccolagabbiadivetroin cui stava appollaiato Budai,ilqualetremavae batteva i denti ma restava lì, incapace di staccarsi da quella visioneincantevole. Però, per quanto spaziasseconlosguardo, nonvedevanébinari,né stazioni; l’oscurità, inoltre, si infittiva e andavacancellandoogni dettaglio. E non scoprì neppure fiumi, ponti o litorali, per quanto aguzzassegliocchi.Forse soltanto lo specchio di un bacino idrico – ci era passato accanto strada facendo – luccicò per qualche istante, riflettendo un raggio di soletardivoederrante,e poi scomparve tra i veli del crepuscolo... Solo allora cercò quei terreni incolticheavevacreduto ai margini della città e che aveva attraversato a piedi. Li colse all’ultimo momento, prima che svanisseronelnulla:una striscia sottile di uno spento colore brunoverdastro, in mezzo a due quartieri densamenteedificati,sia da una parte che dall’altra. Ma non capiva che cosa dividevano da che cosa, se era davvero una linea di separazione topografica...Dunqueera allo stesso punto di prima: era arrivato in un’altra città o era semprelastessa? Aognimodo,decisedi desistere. Non tanto per la stanchezza, se fosse stato per quello avrebbe proseguito; aveva una notevole resistenza fisica, a casa era solito temprare il corpo con vari sport, ed era abituato a non risparmiarsi fatiche se si prefiggevaunoscopo.Ma sapeva che da quella chiesa ce l’avrebbe fatta a ritrovare la strada per l’albergo, da qualsiasi altro luogo più lontano inveceno,specieorache era calato il buio: non sarebbe riuscito a tenere a mente o segnare sul taccuino tutti i punti di riferimento. E poi, se davvero quella era un’altra città, che garanzia o speranze aveva, lì, di orientarsi meglio? La lingua, l’alfabeto e tutto il resto erano sconosciuti tanto quanto nella prima, e simile il numero dei passantieilloromododi fare frettoloso, sgomitante e cinico. Avrebbe dovuto ricominciare tutto da capo, raccapezzarsi, imparare i percorsi dei mezzi pubblici e come soddisfare i suoi bisogni primari:ilsobrioeparco stile di vita che aveva faticosamente instaurato sarebbe andato perduto. E non aveva uno straccio di postodoveposareilcapo –perché,sevifossestato costretto, a chi e in che maniera avrebbe potuto chiedere alloggio per la notte, dove mai l’avrebberoaccolto? Le luci si accesero, isolatoperisolato,strada perstrada;apocoapoco emersedalblugrigiastro il panorama serale della città. Non se ne vedevano i confini da nessuna parte: in lontananza, là dove le linee dei lampioni e gli ammassi di luci convergevano in un unico chiarore, nebbie luminose e vie lattee ne lasciavano intuire un seguito, così come lo spazio concentra in un’unica scia la miriade di stelle distanti milioni di anni luce nella volta celeste... Per tutta la sua esistenza Budai aveva vissuto in città, per lui eral’unicacornicedivita compatibile con il suo lavoro,lesueabitudini,i suoi svaghi, e aveva sempre subìto il fascino delle grandi metropoli del mondo. E sebbene le proporzioni di quella città lo atterrissero, e di fatto lo tenessero prigioniero, non poteva negarne l’imponente bellezza. Da lassù sentì quasidiamarla. Daquandoeraarrivato Budai era entrato in possesso di alcuni testi che potevano servire per lo studio del sistema di scritturainusodaquelle parti. Innanzitutto il foglio appeso nella sua camera, che sembrava un regolamento e che aveva già esaminato. Poi c’era il giornale comprato la prima domenica nel quartiere deidivertimenti,chenon avevapiùpresoinmano. Ma ora decise di concentrare la sua attenzione sul conto dell’albergo, trattandosi dell’unico scritto di cui intuisse almeno vagamente il contenuto. Aveva già appurato che le varie voci erano state compilate solo in cifre, senza nessuna lettera, e tuttavia riteneva valesse la pena di occuparsene piùafondo. In cima al modulo, in mezzo ad altri segni illeggibili, spiccava il numero 921. Era chiaramente l’intestazione principale, essendo lui l’occupante diquellacamera;mache ilrestofosseilsuonome, ammesso che lo sapessero, era un’ipotesi impossibile da confermare o confutare, al pari di tutte le speculazioni precedenti. Provò ad analizzare i costi addebitati, per la somma finale di 35,80. La spesa maggiore era naturalmente il prezzo dellastanza,allaqualesi aggiungevano altre voci, forse le telefonate, il riscaldamento,oletasse, o chissà. Cercò invano importi di una certa entità: il più alto era 5,40, poi un 2,70, un 3,80 e cifre simili. Eppure da qualche parte doveva esserci una moltiplicazione, la tariffa giornaliera per sette, dato che gli avevano consegnato il conto una settimana dopo il suo arrivo. Ma non ritrovò un’operazione del genere, pur avendo rilettotuttoecontrollato lesommepiùvolte. Allorapensòdicercare sulfoglioladata,inaltoe in basso: niente. Gli sembrava impossibile che il conto non riportasse una data – forse era scritta in lettere?Perchémai,forse si usava così?... Poi gli venne un’altra idea, e passòinrassegnatuttele voci lasciate in bianco. Dedusse che si trattava di servizi di cui non aveva usufruito, e che non gli erano stati addebitati: colazione, lavanderia, stiratura e così via. In mancanza di altri criteri, provò a indovinare il tipo di servizio dalla lunghezza della dicitura, naturalmenteallaciecae senza successo, poiché avrebbe dovuto almeno saperecomesuonavanoi termini. Fu allora che notò la brevità delle parole:unpaiodilettere, o poco più. Forse aveva davanti delle abbreviazioni? Se era così, probabilmente si trattava di abbreviazioni correnti, note a tutti, comequellesullebollette dellaluceedeltelefono– ma in questo caso il suo compito diventava enormemente difficile, pernondireimpossibile. Riprese in considerazione il giornale, lo guardò, lo rigirò fra le mani per vedere che cosa poteva cavarne.Feceunastrana e spiacevole scoperta. Finoadalloraavevaletto da sinistra a destra e dall’alto in basso, come in latino e nei sistemi di scrittura europei. Così sembravano suggerire il conto, il regolamento dell’albergo e pure l’elenco telefonico sottrattoallareception,e poi sparito dalla sua camera. Ma ora gli sorgeva un dubbio. E questo perché in cima alla prima pagina c’era una specie di testata, un titolo più grande e in grassetto, ma ce n’era una anche in fondo all’ultimo foglio, e identica. Da dove bisognava cominciare? Da davanti, dall’alto? O da dietro e dal basso? O forse da una parte all’altra come nel greco antico, nella cosiddetta scrittura bustrofedica, dove si legge da destra a sinistra e poi a ritroso, specularmente, da sinistraadestra?Oppure era soltanto quel giornale a essere scritto in una lingua con caratteridiversi?Ricopiò alcune lettere, scelte qua e là fra tutti i testi che possedeva: fin dalle prime trovò delle corrispondenze. Era sempre più disorientato... E neanche sulgiornalec’eraladata, per lo meno non in numeri, lo esaminò in lungoeinlargo;pernon parlare del nome della città o del luogo di stampa del giornale: dove andarli a cercare, nella testata, appena sotto, o al di sopra? Doveva essere proprio lì, sarebbe stata la cosa più logica – ma poi quale testata, quella davanti o quelladietro? Allora gli venne l’idea diprendereildenaroche gli era rimasto in tasca e dispose con ordine le banconote secondo il taglio. Vi erano raffigurati personaggi sconosciuti, paesaggi o scorci di edifici ignoti, figure allegoriche, elementi ornamentali... Come su tutte le banconote. Anche le immagini sulle monete non erano molto dissimilidaquelleinuso ovunque: teste femminili, spighe di grano, fiori, uccelli. Provò a cercare sui biglietti il numero espresso in lettere, dato che doveva esserci. Ma c’erano scritte di ogni genere, di varia grandezza e forma, e copie di firme scarabocchiate. Poteva trattarsi di molte cose: il nome della banca o dell’istituto, quello dello Stato, la legge che ne regolava l’emissione e la circolazione. Forse la consueta formula che stabiliva la somma pagabile al portatore e che la falsificazione era punita a norma di legge, quelgeneredicosechevi vengono stampate – in ognicaso,eratroppoper riuscireaorientarsi. Un’analisi delle monete forse era più promettente: di solito – almenoneipaesidov’era stato finora – oltre alla cifra c’era solo il nome della valuta locale e quellodelpaesediconio. Fece tintinnare gli spiccioli nella mano: eranopezzida50,da20e da 10. Su ogni moneta unascrittacorrevalungo il bordo, senza interruzioni. Non solo non riuscì a decifrare il nome della valuta, ma neppure dove iniziavano ofinivanoqueisegni. Così non era giunto a nulla: brancolava nel buio a occhi bendati... Doveva rimettersi a copiareicaratteriditutti i testi? E a cosa sarebbe arrivato?Erainutile,non disponeva di documenti sufficienti, o meglio, gli mancava un punto da cui cominciare, un criterio–ilbandolodella matassa. Quello che ci volevaeraundizionario, o almeno uno scritto bilingue. Aveva bisogno di una libreria,efinoraneisuoi giri per la città non ne aveva mai incrociate. In realtà, si ricordava vagamente di averne vista una alle spalle del grattacielo in costruzione – era diventato più alto, nel frattempo, adesso contava sessantanove piani... Le stradine di quel quartiere erano particolarmente strette, con un traffico e una ressa eccezionali perfino per la media della città, nella calca di fronte a certi negozi si metteva quasi a rischio la vita. Dovevaessercapitatonel pieno dei saldi di fine stagione, e in effetti, pensò,erapartitodacasa a metà febbraio, il periodoeraquellogiusto, a fine inverno. I commercianti gridavano sul marciapiede, fuori dai negozi, offrendo a prezzi stracciati abiti, maglioni, biancheria intima: i clienti li accerchiavanoformando capannelliimpenetrabili, passandosi i capi di mano in mano, li prendevano e li ributtavano alla rinfusa nelle casse, e tutti contrattavano, nella confusione generale. Alcuni negozi traboccanti di clienti avevano abbassato la saracinesca per non farne entrare più, ma le personesiammassavano lo stesso, urlando verso l’interno aggrappate alla serranda e, appena questa si alzava per pochi secondi per far uscire qualcuno, un nuovo fiotto di gente riusciva a infilarsi dentro. Montagne di scarpe, pantofole di feltro e calze, e decine di altri articoli: tutto in offerta. Un venditore di caramelle cieco cantilenava senza posa unafilastroccastridulae stonata. Nellalibreriac’erauna baraonda simile: c’era chi frugava fra i libri impilati per terra o sui tavoli, chi tirava giù i volumi dagli scaffali e li sparpagliava sul pavimento sollevando nuvole di polvere, chi si arrampicava sulle scalette per raggiungere lemensoleinalto;perun bel pezzo Budai non fu neppure in grado di individuare il libraio. Nella mischia, tentò di rivolgersi a qualcuno e dovette gridargli nelle orecchie,mailfrastuono era tale che non gli badavano, tutti presi dalla lettura e dalla sceltadeilibri.Dopoaver scrutato a lungo, la sua attenzione fu attratta da un grassone in fondo al negozioconuncamicedi cotonina, la faccia coperta di macchie epatiche,ilnasogrossoe le labbra carnose, un tiziosguaiatoepetulante che freneticamente rimetteva a posto i libri, li impacchettava e li legava con lo spago, si accalorava nelle contrattazioni, ora togliendo, ora aggiungendone uno, come se fossero patate o pomodori. In quella situazione Budai non aveva modo di spiegarsi o di chiedere, e neppure di farsi capire a gesti; riuscì a ad arrivare fino al tizio con le macchie epatiche e fece un tentativo, ma erano così in tanti a parlare contemporaneamente, a spingere e a gesticolare che la sua voce si perse nelbaccanogenerale. Allora cominciò a passare in rassegna gli scaffali,nellasperanzadi incappare in un dizionario, un’edizione col testo a fronte, una guidaturistica,oalmeno un libro scritto in una lingua straniera che conosceva, così da mostrarloalnegoziantee fargli capire che gli serviva un vocabolario. Ma, per quanto frugasse, trovava solo libri in quei caratteri simili a rune; perlopiùvolumiantichi, di varia forma e rilegatura, alcuni malridotti, altri quasi nuovi, intonsi. Provò a verificare il senso della scrittura,sedasinistraa destra o al contrario, come aveva sospettato osservando il giornale. Ma sfogliandoli in fretta non riuscì ad arrivare a una conclusione, prima gli parve che fosse in un modo, poi nell’altro, alcunisembravanoavere due copertine, sul fronte e sul verso, oppure la copertina davanti e il frontespizioinfondo. I libri erano in offerta, e il prezzo dietro al volume era stato cancellato con un tratto d’inchiostro e accanto c’era quello scontato. Ma erano comunque spaventosamente alti, quantomeno per le sue tasche:andavanodai3o 4earrivavanofinoai10, 15 e 25 – non li aveva nemmeno, quei soldi. Spulciò dappertutto per più di un’ora, e gli passarono fra le mani libri d’ogni genere. Raccolte di poesie, volumi con l’aspetto di romanzi, edizioni pregiateperintenditorie copie rilegate o in brossura di serie ad alta tiratura, opere scientificheetecnichesu carta lucida delle discipline più disparate, eperfinotesidilaureain chimica e matematica, piene di formule e derivate – forse avrebbe potuto ricavare qualche risultato dalle parti di testo, se solo non fosse stato così miseramente estraneo a quelle materie. C’erano intere annate di riviste dal contenuto incomprensibile, rilegate, cataloghi ricoperti di numeri con un’infinità di note e tabelle che illustravano chissà cosa, raccolte di disegni e caricature di facce mai viste, con in calce firme indecifrabili e pochi versi, una specie di programma teatrale con le foto di un’attrice sconosciuta che posava con vari costumi, e inoltre fiabe per l’infanzia, se mai lo erano, probabili libri scolastici e un sacco di altre cose... Ma non ne trovò neppure uno che fosse scritto in una lingua diversa, anche solo in parte. In mancanza di meglio avrebbe potuto bastargli anche una grammatica, ma non la scovò tra le migliaia e migliaia di volumidiquelnegozio. Tutto questo era abbastanza avvilente e snervante, e per giunta schiacciato e spintonato in un baccano assordante.Certo,sesolo avesse potuto spiegare a qualcuno che gli serviva un dizionario... ma in quella baraonda non sarebbe mai riuscito ad avere l’attenzione del libraio, assediato da una torma di clienti spazientitiegesticolanti: ci provò comunque, ma neanche stavolta quello glidiederetta.Avendone fin sopra i capelli di quellabolgia,eritenendo disperato ogni ulteriore tentativo, alla fine si scelse un libro da solo. Primadiandarsenecolse perunistantelosguardo del tizio in camice di cotonina,glielomostròe pagò. Si sarebbe detta una raccolta di novelle, vista l’impostazione tipografica e la presenza di molti dialoghi. In quelle pagine, a differenzachealtrove,la scrittura procedeva inequivocabilmente da sinistra a destra e dall’alto in basso, come dicevanolaposizionedei titoli e l’inizio e la fine dei racconti. Era un volumetto smilzo, dal prezzo relativamente modesto: 3,50. Sulla copertina c’era un paesaggio esotico dai colori blu e verde pastello, un golfo, le palme, un grappolo di casette bianco gesso addossate sul fianco di una collina, con i tetti attaccati uno all’altro – forse quel libro lo aveva colpito anche per l’azzurro saturo e l’orizzontesconfinatodel mare. Sul bordo ripiegato della copertina, il cosiddetto risvolto, c’era una fotografia, certamente dell’autore: un uomo sulla quarantina in piedi davanti a uno steccato, con un pullover a collo alto, una postura disinvoltaespontanea,il viso pieno, i capelli cortissimi; teneva gli occhi socchiusi, con uno sguardo stanco o annoiato e sulle labbra una strana smorfia leggermente beffarda, come se cercasse di reprimere uno sbadiglio. La faccia gli era familiare, ma non ricordava dove potesse averlo visto. A ogni modo, il suo aspetto e lo stile suggerivano che fosse un autore contemporaneo, che scriveva della vita di tutti i giorni – la sua scelta era caduta sul volume proprio per quello. Non gli sarebbe statodigrandeutilitàun testo in una lingua arcaica o poetica, aulica, oppure in un gergo tecnico-scientifico tipico di certe discipline, o in una prosa di carattere astratto e trattatistico. A lui serviva la lingua corrente, quella parlata dalla gente per la strada al giorno d’oggi, nella quale avrebbe dovuto addentrarsi parola per parola: stando alla sua ipotesi, e secondo ogni probabilità,queiracconti erano scritti in una linguadelgenere. Al ritorno in albergo, passò davanti ai negozi di souvenir nell’atrio e diede un’occhiata più attenta alle cartine sullo scaffale di vetro. Ce n’erano molte e tutte diverse, così tante che all’improvviso fu vinto dall’esitazione e non seppe più quale prendere. Ne aprì una a caso, pensando naturalmente che rappresentasse la città. Ma non riuscì a orientarsiinquell’intrico in miniatura di vie e piazze che ricopriva la superficie della carta: i limiti dell’insediamento urbano non comparivano, o forse si trattava solo di una parte, il centro, magari un quartiere. Non erano segnati binari ferroviari, rappresentati per convenzione da sottili lineenere;nelrettangolo dellacartinanonc’erano nemmeno corsi d’acqua, solo piccole macchioline azzurre sparse qua e là: forse dei laghetti ornamentali, o quei bacini artificiali di raccolta che aveva visto in giro. Nell’angolo in bassoadestrasisnodava una striscia azzurra lunga e stretta, che finiva fuori dal bordo della carta; ma a risalire le anse tortuose in direzione contraria la striscia a un certo punto si interrompeva, spariva nel nulla, infrangendo l’improvvisa speranza di Budai che potesse trattarsi di un fiume. Tutt’al più, anche se nulla lo provava, ne era solo una diramazione morta: anzi, magari un fosso, come quello che aveva seguito dalle parti delmattatoio. Avrebbe voluto individuare l’albergo, sulla cartina, o confrontarla con la mappa delle stazioni in metropolitana.Farlocosì a occhio era difficile: l’unanonglieraneppure chiaro come andasse tenuta, quale fosse il versogiusto,el’altranon gli si era fissata abbastanza bene nella memoria. Certo, aveva scritto sul taccuino il nome della fermata vicino all’albergo, ma lì non lo ritrovava. Per di più,sulfogliopieghevole che teneva fra le mani non sembrava segnalato il metrò: non c’erano linee continue o tratteggiate per indicare la rete sotterranea, né cerchietti semplici o doppi, vuoti o pieni o tagliati da una lineetta perlestazioni.Ricordava che su alcune cartine le fermate della metropolitanaeranouna semplice M maiuscola – sì, ma quale lettera corrispondeva qui alla M? O forse quella rappresentata era una zonadellacittàdovenon passava la metropolitana? E se non fosse stata neppure la cartina di quella città? Madiqualealtra,allora? La voltò per guardare che cosa c’era scritto dietro. Conteneva molto testo, in caratteri di vari colori e dimensioni; così a una prima occhiata non si riusciva a individuare la parola principale, ossia il nome dellalocalità.Ineffettile scritte più grandi potevano significare di tutto: per esempio «nuova», «aggiornata», «cartina», o meglio «istituto cartografico», il nome di una casa editrice, indirizzo, via e numero civico, o perfino «benvenuti, vi auguriamo un piacevole soggiorno», o «felice anno nuovo» e un mucchiodialtrecoseche di solito si stampano sul retro delle cartine. Poteva anche trattarsi di pubblicità, marche di birra, vermut, cioccolata ochissàchealtro,oppure nomi di ristoranti, alberghi... La cartina stessa era ricoperta di scritte minuscole, per tutta la lunghezza delle vie e in ogni punto immaginabile, parole frammiste a numeretti misteriosi: solo con una lente d’ingrandimento sarebbe riuscito a spulciarle, ma ne fu talmente atterrito che preferìlasciarperdere. Si rivolse invece alla negoziante e cercò di chiederle a gesti di mostrarglisullapiantina il nome della città e il punto esatto dell’albergo, se c’era, o altrimenti di dargli la cartina giusta. Ma il comportamento di quell’uomo che frugava tra le cartine e chiedeva informazioni, mentre tutti gli altri clienti aspettavano al banco, doveva aver infastidito la donna: non gli diede ascolto e lo liquidò con una frase seccata. Ma Budai continuava a insistere e faceva tintinnare le monete per saperequantocostassela piantina,efinalmentelei scrisse12suunpezzodi carta. Lui girò i tacchi all’istante,brontolandoe imprecando contro chi aveva la faccia tosta di venderlaaquelprezzo. Più tardi, a mente fredda, si chiese se una cartina gli sarebbe stata davvero utile. Senza neanche essere certi di avere fra le mani la mappa della città, e comunque, di quale quartiere? Non era forse uno studio del tutto inutile,chenonl’avrebbe avvicinato d’un passo all’obiettivo? Non c’era un metodo più diretto, più efficace?... Se ne tornò dunque nella sua stanza per dedicarsi, con serietà e impegno, a un’indagine sulla lingua e sulla scrittura locali che si attenesse ai princìpi della scienza moderna e alla sua preparazione accademica, servendosi di tutti i mezzi e le possibilità a disposizione. Purtroppo,comeaveva più volte rimpianto da che era arrivato in quel luogo, non si era mai occupato di storia dei sistemi di scrittura, e tantomeno di crittografia,essendouno specialista di studi etimologici, ovvero dell’origine delle parole. Però, scavando nella memoria, si ricordò che nelle letture giovanili ci si imbatteva in ingegnosedecifrazionidi codici segreti, per esempio nei romanzi di Verne. In Mathias Sandorfciriuscivanocon l’ausiliodiunagriglia,in Viaggio al centro della Terra invece modificando l’ordine delle righe secondo un certo criterio. Aveva anchesentitodirechein tempi più recenti, durante le due guerre mondiali,iservizisegreti avevano elaborato dei sistemi perfetti per decrittare i messaggi cifratidelnemico,grazie a metodi matematici e statistici: in pratica qualsiasi codice, anche il piùelaborato,puòessere violato. Quei crittografi però,unavoltatrovatala chiave, ristabilivano la versione originale di un messaggioredattoinuna lingua nota, e solo in seguito trasformato e camuffato. Budai invece si trovava di fronte alla scrittura sconosciuta di una lingua sconosciuta: non l’avrebbe capita neanchesefosseriuscito aleggerla. È vero che l’ingegno e la pazienza degli archeologi, al di là dei casi già citati, avevano risoltoancheproblemidi questo genere quando potevano contare su un reperto multilingue. Bastava pensare alle due grandi prodezze in questo campo del ventesimo secolo, la decodificazione dei caratteri cuneiformi degli Ittiti e quella della cosiddetta «lineare B» cretese, due sistemi di scrittura pressoché sconosciutidipopolifino allora sconosciuti. Eppure il punto di partenza fu proprio quel quasi, il piccolo impulso necessario a muovere i primi passi. Nelle tavole d’argilla degli Ittiti un buon numero di segni si potevano identificare con ideogrammi babilonesi già noti in precedenza. E anche colui che decifrò la lineare B, l’inglese Ventris, poté sfruttare l’affinità, evidente in base ad alcune corrispondenze, tra questa e il sillabario cipriota. Dunque da una cosaderivòl’altrael’aver svelato il significato di pochi segni sillabici permise, grazie a varie speculazioni e ipotesi combinatorie, di individuare i successivi. Inoltre, gli studiosi avevano buoni motivi persupporrecheneitesti ricorressero alcuni nomi propri, come succedeva nelle tavolette cretesi con i nomi delle antiche città di Cnosso e Amnisos; quest’ipotesi contribuì in misura decisivaallorosuccesso. A rendere molto difficile il compito di Budai era il fatto di non saper leggere nemmeno unodiqueisegni,dinon avereilminimopuntodi riferimento: con quale sistema di scrittura poteva confrontare quello locale? – naturalmente non conosceva a memoria le scritture cuneiformi, in granparteormaiestinte, né le aveva mai studiate approfonditamente. L’altro problema era che non poteva formulare ipotesi, non avendo un appiglio,unaparolaoun nome da cercare, una traccia da seguire, sia purvaga.Eppuredoveva esserci,daqualcheparte. Per comprendere la natura di un sistema di scrittura,unbuonpunto di partenza può essere il numero dei segni impiegati. Ce ne sono moltissimi nei sistemi che fissano parole intere e concetti, come nel cinese,peresempio,dove si dice che superino i cinquantamila. Nelle scritture sillabiche, naturalmente, ne bastano molti meno: i geroglificicretesiacuisi accennava sopra sono ottantanove, la scrittura cipriota ha quarantaquattrosegni,il giapponese moderno centoquaranta. Un numero inferiore di segni indica senza dubbio una scrittura alfabetica, come quelle dei moderni popoli europei: l’inglese ne ha ventisei, come il francese, il russo trentadue,ecosìvia. Si mise dunque a ricopiare,comegiàaveva fatto una volta, i caratteri dei testi stampati che aveva a disposizione. Superò ben presto i cento e nulla indicava che fossero finiti...Sitrattavaquindi diunsillabario?Igruppi di segni gli sembravano troppo lunghi perché fosse una scrittura sillabica. Allora erano logogrammi? Proseguì nellavoro,madiventava sempre più difficile suddividere i caratteri e raffrontarli. Un dubbio lo assalì: e se avesse scrittopiùdiunavoltalo stessosegno? Al duecentotrentasettesimo aveva ormai perso la speranza di arrivare alla fine, e lasciò perdere. Si cimentò con un altro metodo: scegliendo caratteri a caso e improvvisando dei calcolitentòditrovarele lettere più ricorrenti e le più rare, partendo dalla considerazione che le vocali, essendo molte meno delle consonanti, in genere sono più frequenti.Peresempio,è stato calcolato che in ungherese le lettere più frequentisonolaeelaa, e poi t, s, n e l, e le più rare x, q e w – in altre lingue naturalmente la proporzione è diversa. Il ragionamento però avevasensosesitrattava di una scrittura alfabetica,enonsillabica – dove ogni segno corrisponde a un nesso di consonante e vocale: in tal caso era fatica inutileesprecata. Allora si domandò se quella lingua avesse gli articoli, come il greco anticoel’arabo,l’ebraico, l’inglese, il tedesco, l’italiano, lo spagnolo, e così via. Perché, se sì, poteva essere un buon avvio. Anzi, in un testo scritto li avrebbe individuati più facilmente che non nel parlato, dove spesso l’articolo si fonde con il sostantivo. Per esempio, quando la ragazza dell’ascensore gli aveva detto il suo nome, lassù al diciottesimo piano, la seconda volta gli era parso più lungo. Forse l’articoloerae,pe o te? E come si scriveva? Se l’avesse trovato, sarebbero state le prime letterecheeraingradodi leggere, sia pur in manieraapprossimativa. Perciòdecisedicercare parolette brevissime, uguali o almeno somiglianti, all’inizio di righe abbastanza lunghe o di frasi e paragrafi. Ma invanosfogliòilgiornale e il libro che si era appena procurato, quasi nonnetrovò,eseriuscìa mettere insieme alcune parole identiche queste erano di cinque o sei lettere: che prove aveva che si trattasse di articoli? Stranamente, invece, trovava delle particelle di due segni identici alla fine di ogni paragrafo e in fondo ai capitoli, o novelle, del volume.Allorasiricordò che in rumeno, in bulgaro, in albanese e in mordvino l’articolo non precede il sostantivo ma lo segue – che fosse così anche in quella lingua? Oppure non c’erano articoli – come in latino, in finlandese, nelle lingueslaveeincinese– e quella paroletta finale serviva a chiudere il contenuto dell’enunciato, come in latino dixi o l’augh nei romanzi sugli Indiani d’America? Se in una lingua esistonoleparolesìeno, allora è chiaro che il no ricorrerà relativamente spesso. Lo stesso dicasi per il che, il ma e la congiunzione e, benché quest’ultima possa trovarsinellafraseanche comeparticellaenclitica, attaccata alla parola che la precede, come il -que del latino. Una volta aveva letto una ricerca sui sostantivi più ricorrenti nella lingua ungherese: grande, popolo, casa, appartamento, paese e così via. Erano gli stessi anche qui? E se sì, come poteva pescarli in quel mare di testi, cosa l’avrebbe aiutato a identificarli? E se si fosse inoltrato in quella giungla a partire dagli elementi sintattici?Aquelloscopo avrebbedovutoricercare gruppidisegnisimilima non proprio identici. Per esempio, se erano uguali all’iniziomadiversinella terminazione, si poteva supporre che fossero forme flesse della stessa parola. Trascorse un’intera giornata a cercare di articolare gruppi del genere: li aveva disposti per bene in colonne, per poi poterli confrontare. Aveva trovato per lo più parole in cui coincidevano soltanto i primi due o tre segni. Certo, non poteva escludere che fosse una casuale allitterazione di vocaboli affatto diversi, come porta e porto, o in inglesesix e sister. Ma se invece si fosse trattato della stessa radice, come sperava, che cosa poteva celare quella terminazione variabile? Flessione del nome o del verbo,desinenze,suffissi derivativi, postposizioni? O la distinzione del genere maschile e femminile, come in francese directeur e directrice? Quelchecredevafossela radice della parola poteva anche essere un prefisso verbale, o la prima parte di un composto, o un mucchio d’altrecose. Quando, al contrario, era uguale l’ultimo membrodellaparola–ne trovò diversi esempi nel suo paziente lavoro di spigolatura –, si poteva immaginare che si trattasse di vocaboli dotati dello stesso suffisso. Come in ungherese szobában, házban, városban oppure szobának, háznak, városnak;3 e ce ne sarebbero potuti essere ancora tanti, a seconda di quante desinenze possedevaquellalingua– ma di nuovo, a quale caso corrispondevano, e come si pronunciavano? Esenonsifossetrattato di suffissi, ma di semplice assonanza o rima,allostessomododi piatto e gatto, oppure stabilimento, pentimento e bastimento? Quella parte finale avrebbe anche potuto essere una base verbale preceduta da un prefisso, come ad esempio in predire, disdire e contraddire e molti altri, come nelle trentaepassalingueche bene o male conosceva. La questione restava ancora una volta la stessa: come fare a orientarsi e capirci qualcosa? Lavorare così era inutile, uno sforzo sterile, un susseguirsi di congetture e nessuna certezza. Perdersi in ipotesi, speculazioni teoriche, giochi di pazienza logici e sostituzioni non sarebbe servito a fare dei passi avanti, se non alla velocitàdiunalumaca.E se pure, con un lavoro immane, grazie a calcoli statistici e probabilistici, a prezzo di una quantità enorme di energia, con disagio e fatica fosse riuscito a decifrare quell’alfabeto e a stabilire il valore fonetico di tutti i segni – cosa dalla quale era lontanissimo, non avendone individuato nemmeno uno –, da ciò non sarebbe affatto conseguita la comprensione di quella lingua. La scrittura degli Etruschi, per esempio, non ha più misteri per noi, sappiamo leggerla compiutamente; ma la loro lingua, nonostante i tentativi delle menti migliori e l’aiuto dei più moderni strumenti scientifici, resta ancora sconosciuta, con l’eccezione di qualche decina di parole e di un paio di formule grammaticali. Perfino la sua parentela genetica è oscura e controversa – forse anche l’epepe parlato da quelle parti era un idioma isolato e senza affiliazioni, come l’etrusco, il basco e un paio di lingue africane e caucasiche? Ciò nondimeno lui si trovava in una situazione ben più favorevole di coloro che lavorano alla ricostruzione di una lingua morta. Essi dispongono solo di documenti scritti, e perciò sono costretti a ricorrere a metodi indiretti, complicati, speculativi, che comportano tanti infruttuosi esperimenti. Lui invece poteva contaresullalinguaviva, sulla sinfonia a mille vocicherisuonavaperle strade, nelle piazze, in albergo, in metropolitana: non doveva far altro che prestarvi attenzione e isolarelevariemelodiee note – ad annotare la partitura ci avrebbe pensato dopo. Mise dunquedaparte,almeno per il momento, il giornaleeglialtritesti,e si risolse a tenere da allora in avanti le orecchiebenaperte. In teoria avrebbe potuto imparare la lingua da chiunque, da un qualsiasi abitante della città, carpendogli piano piano le parole, le regole e così via, se solo questo chiunque gli avessededicatounpo’di tempoepazienza.Maera proprio ciò che mancava ai locali, un minimo di cortesiaedisponibilitàin quellafrettaperpetua,in quella ressa continua; sarebbe bastata una persona con cui spiegarsi, che degnasse d’attenzione il suo gesticolare da sordomuto almeno una volta, con calma. Da quando era arrivato non avevaancorastabilitoun contatto umano con nessuno. Ma no, forse conqualcunosì... Scrissesubitoinumeri da 1 a 10 su una pagina del taccuino e corse a cercare Pepe agli ascensori, la invitò a salireall’ultimopiano,le mostrò il foglio e indicò il numero 1. La risposta della ragazza non fu chiara, probabilmente non capiva che cosa volesse, rideva, si accese una sigaretta, si strinse nelle spalle, e mormorò con voce flautata qualcosacome: «Tuulli ulumulu alaulp tleplé...». Non poteva essere il nome di un numerale. Budai non si arrese, sollevò il pollice, indicò l’1 anche su una banconota, insistendo. Stavolta Bebe rispose in maniera più breve, con unmonosillabo: «Dütt!». Allora lui le domandò il 2, il 3, il 4 e così via, annotando le risposte in alfabeto fonetico. Arrivò fino al 10, ma nel frattempo il campanello aveva cominciato a suonare,aipianidisotto dovevano essere in tanti ad aspettare l’ascensore. Perverificareleindicòdi nuovo l’1, ma stavolta la ragazzadissequalcosadi completamentediverso: «Sümülükada». Budai era confuso: qual era il nome dell’1, questooquellodiprima? Il campanello trillava sempre più imperativo, la donna spense la sigaretta, gli fece segno che le dispiaceva ma doveva veramente andare.Maluisentivadi non poter rimandare ancora a chissà quando, cercò di far capire alla ragazza che l’avrebbe aspettata lì e la pregò di tornare al più presto. Edede si arrestò, pensierosa.Budaidoveva avere un’aria talmente disperata da superare l’abisso linguistico che li separava. Annuì seria, battendolecigliabionde, come a dire che sì, sarebbetornata. Passòunamezz’oraela ragazza riapparve tra le porte automatiche dell’ascensore. Budai riprese a domandarle i numeri, ma non era soddisfatto del risultato: soltanto due o tre termini suonavano ugualiosimiliaquellidi prima. Certo, dalle risposte di Tete era difficile isolare il numeraleveroeproprio, perchéleinonsilimitava adireunaparolasola,eil resto poteva significare ditutto.Cosecome:bene, va bene, sì, prego, ho capito, aspetta, tel’hogià detto, o altre particelle discorsive che si usano parlando. O forse in questa lingua dicevano in più modi lo stesso numero? Come in altre lingue per lo 0: nulla, zero,niente,eccetera? Dopo quella volta iniziò a fare la posta presso gli ascensori in attesa di veder spuntare Dedede – non era ancora riuscito a capire esattamente il suo nome pur avendoglielo chiesto innumerevoli volte – per proseguire con lei le lezioni di lingua. Naturalmente la ragazza doveva lavorare, portare su e giù il flusso ininterrotto di passeggeri, e di sicuro era sorvegliata, controllavano se era in servizio.Soltantodirado e per brevi momenti riuscivanoarimanereda soli, su al diciottesimo piano, mentre da sotto non smettevano di suonare in maniera piuttosto snervante. A volte Budai restava con lei nell’ascensore, non avendo nient’altro da fare, andava su e giù nella cabina che si riempiva,sisvuotavaesi riempiva di nuovo, mescolato agli altri passeggeri. La donna intanto era impegnata a manovrare l’ascensore, rispondeva al telefono, forse per ricevere istruzioni, e solo ogni tanto era libera di lanciargli uno sguardo d’intesa,comeadirgli:so che sei lì, non mi sono scordata di te... Nell’ascensore sovraffollato il piccolo ventilatore non bastava a garantire un buon ricambio d’aria. Era ancheperquestaragione che Budai non vedeva l’ora delle loro brevi pause, per respirare un po’ d’aria fresca e provare a imparare qualcos’altrodalei. La ragazza, stranamente, non mise in dubbio neppure per un attimo il ruolo di insegnante che Budai le aveva assegnato, e anzi loassunsedibuongrado e con zelo, come se fosse un suo dovere o un’ambizione. Quando arrivavano all’ultimo piano, si accendeva una sigaretta, espirava il fumo e si disponeva ad ascoltare, pronta a rispondere alle sue domande. Certo, neppure per lei doveva essere facile capire sulla base di gesti e scarabocchi cosa volesse sapere quell’ospite che parlava una lingua sconosciuta. Forse sentiva fino a che punto quell’uomo avesse bisogno di lei e del suo aiuto – o forse nutriva verso di lui un’altra inclinazione? Eppure più di una volta Budai la cercò senza trovarla, non era ancora riuscito a stabilire né a farsi spiegare i suoi turni, semprecheneavesse.In quei momenti la vita gli apparivavuotaeprivadi senso, si sentiva smarrito, un pesce fuori dall’acqua. Per ora non aveva alcuna intenzione di rivolgersi a qualcun altro, pensava che si sarebbesoltantoconfuso e avrebbe rimesso in questione quel pochissimo che credeva diaverimparato.Eforse gli sembrava una forma diinfedeltàneiconfronti di Dede, che era sempre così gentile e paziente conlui. Inoltre non si illudeva dipoterfermarelagente per la strada con i suoi problemi grammaticali, ormai l’aveva capito. C’erano parecchi ubriachi,inparticolarela sera, dappertutto: per le strade,inmetropolitana, nell’atrio dell’albergo, uomini e donne, barcollavano, vociavano, cantavano, litigavano, vomitavano, si azzuffavano: con loro non aveva molte speranze... Aveva paura soprattuttodisera,lasua camera gli pareva una cella carceraria, si sentiva imprigionato; se almeno avesse avuto qualcosa da leggere, in una qualsiasi delle tante lingue che conosceva! Non sempre aveva l’energia di buttarsi in quei rebus indecifrabili, sentiva la mancanza di un po’ di nutrimento spirituale, di evasione, temeva quasi di impazzire. E non osava neppure allontanarsi dall’albergo, nel caso riapparisse la ragazza: in certe giornate era capitatocheleilavorasse sia al mattino, sia di notte. Però Budai non reggeva più a stare nella suastanzaconlemaniin mano, era agitato, tormentato dalla smania di darsi da fare, di seguirepiste,diandaree venire,perilterroreche, sefosserimastoinattivo, nessuno avrebbe mosso unditopersalvarlo. Scese a gettare uno sguardonellahall,dacui poteva tener d’occhio gli ascensori. Il gigantesco atrioerariempitodauna folla enorme che, a quanto pareva, non diminuiva neanche a nottefonda:lepersonesi appisolavano sulle poltrone oppure si trascinavano qua e là mezzo addormentate. Davanti alla reception c’eraunalungafila,dove figuravano molti nuovi arrivati con le loro valigie.Notòperlaprima volta che si vedevano solo bagagli in entrata, mai in uscita – dove andavano a finire le valigie di chi partiva? E se avesse provato a seguirne le tracce?... O forse passavano da un altro ingresso? Ma dove poteva essere, questo ingresso? Oppure qui la gente arrivava di continuo, e nessuno partivamai? S’imbatté di nuovo nella delegazione di sacerdoti dall’aspetto esotico che aveva incontratoilgiornodopo il suo arrivo. Il piccolo e variopinto gruppo di vegliardi barbuti dalla pelle scura e lucida, vestiti di lunghi caffettani, adorni di catene e copricapi, sfilò in maestoso silenzio tra la folla che si apriva deferente al suo passaggio – non portavano nessun segno osimbolocherivelassela loro identità, la loro provenienzaoreligione. Decise di fare un giro, superò il grasso usciere che lo salutò come sempre, portando la mano alla visiera. Si limitò ad andare al grattacielo in costruzione per vedere a che piano fossero arrivati. Vi stavano lavorando a pieno regime, schiere di manovali brulicavano sui muri, le fiamme ossidriche scintillavano, imontacarichiandavano suegiù,sottoiriflettori; strano però, dall’ultima voltacheavevacontatoi piani l’edificio era cresciuto solo di uno – ora ne aveva settanta –, eppure erano passati parecchigiorni. Di notte la vita scorreva con la stessa intensità. Le uscite della metropolitana rigurgitavano e inghiottivano gente senza posa, le schiere di quelli che tornavano a casa stanchi dal lavoro e quelli che invece si avviavano con la faccia gonfia di sonno verso i lontani quartieri industriali, per il turno dell’alba. Altri erano in giro senza meta, si raccoglievanoagliangoli dellestradeonellepiazze ingaggiando discussioni senza fine, forse su un evento sportivo, oppure aspettavanoigiornalidel mattino. Nei bar si vendeva quella bevanda alcolica dal sapore sciropposo di cui si era già ubriacato una volta. Gli avrebbe fatto piacere cedere all’alcol, alla levità e all’incoscienza dell’ebbrezza, ma mantenne il suo proposito, e poi gli spiaceva sprecare così i pochi soldi che gli restavano. In lontananza, in alto, scorsedinuovolelettere rosse e blu che lampeggiavano; chissà che cosa reclamizzavano... Da un locale sotterraneo, che finoaquelmomentonon aveva notato, proveniva un ritmo martellante di batteria, musica mista a frastuono. Sbirciò all’interno, per pura curiosità: la grande sala era strapiena, forse era un locale da ballo, anche setrailfumo,ilbaccano e la folla che occupava ogni angolo possibile e immaginabile, non poté individuare una pista, perché la gente ballava anche fra i tavoli, al bar, lungo i muri e perfino sulle scale d’ingresso. Naturalmente erano in maggioranza giovani, abbigliati nello stile sgargiante o provocatoriamente stracciato che in tutto il mondo è la divisa della gioventù. Le coppie di ballo non erano solo di sesso opposto, ma anche di ragazze con ragazze, e ragazziconragazzi.Madi vere e proprie coppie ne vide poche, per lo più ognunoballavacontutti e per conto suo, in un turbinio generale, in un fracasso assordante. Inoltre, le differenze di genere erano poco marcate, parecchi ragazzi sfoggiavano lunghe capigliature di foggiafemminile,etrale ragazze molte indossavano i pantaloni. Sembrava poi che ogni razza presente sulla Terra vi fosse rappresentata; si dimenavano e si contorcevano a ritmo di danza mescolandosi in un intrico caotico di bracciaegambe. Non vide però musicisti, la musica era registrataeamplificataa livelli insopportabili. I pezzi si susseguivano senza interruzioni, tutti uguali, almeno alle sue orecchie; puro ritmo, nientemelodia,unritmo spezzato, sincopato, insinuante, impudico... Ma era soprattutto il volume a infastidire Budai, che si sentiva quasiscoppiarelatestae non si capacitava di come gli altri riuscissero a resistere in quel baccanoincessante. Stava per andarsene quandoinfondoallasala ci fu un improvviso disordine, una specie di tumulto. Che cosa stesse succedendo di preciso non gli fu chiaro per qualche secondo, ebbe l’impressione di uno scarto,diunmovimento sfasatorispettoaltempo dellamusica.Poicapìche erascoppiataunarissa,e a poco a poco cominciarono anche a delinearsi i due fronti, bianchi contro neri. Quale ne fosse la causa eraimpossibilecapirlo,e fu una sua mera congettura, del tutto privadifondamento,che potesse avere a che fare con una biondina slavata, il cui viso apatico e beffardo era apparso per un attimo dietroaicontendenti. Inmenchenonsidica, i litiganti erano già stati separati. Da chissà dove eranosaltatifuorideitizi in divisa, con la solita tuta marrone. Col fischietto tra i denti, disposti a cordone, avevano formato una barriera vivente tra le due fazioni: i litiganti non smettevano di minacciarsi e insultarsi, digrignando i denti, da una parte e dall’altra del muro di agenti in uniforme, con una furia che non accennava a placarsi... Budai fu incuriosito dalle loro urla,eritennecheanche da queste potesse trarre qualche dato utile. Nel caos e nel frastuono – perché nel frattempo la musicanoneracessata– sentì che i rivali, agitando i pugni, si gridavano qualcosa come: «Durumba!... Udurumbunda!». Naturalmente poteva significare un sacco di cose: carogna, fetente, bastardo, stai attento, vieni qui, ti ammazzo, ti spacco la faccia e altre gentilezze del genere. Budaiselescrisse,aogni buon conto, insieme agli altri appunti, in alfabeto fonetico, aggiungendovi interpretazionipossibili. Fu allora che uno dei bianchi, un tizio tarchiato in pullover, si sporse oltre la catena umanadiuominiintuta marrone e, prima che potessero trattenerlo, colpìconunabottigliadi birra la fronte di uno nero allampanato che si sbracciava davanti a lui. Si udì un rumore secco: sieraspaccatoilvetro?o si era rotto il cranio? Quello che aveva ricevutoilcolpovacillòe rivoli di sangue rosso scuro cominciarono a scenderglilungolafaccia nerissima. Gli agenti di sicurezza, o quel che erano, fischiarono nervosamente mentre tenevano a distanza i rivali. Ma un altro giovanotto nero accanto al ferito estrasse il coltelloaserramanico:si accovacciò di scatto, passò sotto la catena di braccia e vibrando un colpo rapido come un fulmine trafisse all’addome il tizio con il pullover... Questi si guardò attorno con aria stupita, senza rendersi pienamente conto di cosa era successo. Si premette la mano alla vita, là dove era penetrata la lama, e con grande lentezza si piegò inavanti,conlosguardo di chi non riusciva a credere che fosse capitato a lui, proprio a lui; quando rimase immobile tra le braccia dei suoi amici aveva ancora quello stupore fissonegliocchi. Fuoriululòunasirena, forse l’ambulanza o una volante della polizia. In mezzo alla confusione balenò di nuovo per un attimo la chioma bionda della ragazza, poi i poliziotti irruppero nel locale, scendendo gli scalini a suon di manganellate... Budai non ci teneva a rinnovare la loro conoscenza e prudentementeselafilò. Era sconvolto dalla vicenda a cui aveva assistito, ma non si era scordato del suo impegnoconEpepe.Non voleva assentarsi troppo alungo,nelfrattempolei poteva essere riapparsa; ritornòversol’albergo. Non trovando la ragazzanell’ascensore,si ritirònellasuastanzaesi rimise a fare tentativi al telefono.Avevaannotato alcuni numeri che rispondevano anche di notte, riconosceva perfino le voci delle persone che chiamava. Eraun’esperienzastrana, quasi onirica, quella di conversareconqualcuno e non capire una parola: ormai li chiamava spesso, gli piaceva. In realtà nutriva anche la speranza che l’interlocutore dicesse il proprio numero, come spesso accade quando si chiama quello sbagliato. Certo, da quelle frasi rapide era pressoché impossibile afferrare le risposte che cercava, ma anche così, senza trarne nessuna utilità, gli faceva bene dire «Pronto?», porre domande, sentire che c’era qualcuno all’altro capodelfilo,chelostava ascoltando, immaginare com’era fatto... Cosa strana, tra i suoi interlocutori telefonici c’erachinonriattaccava, anzi, si tratteneva a lungo a parlare, e per quanto la conversazione fosse inutile reggeva quel gioco assurdo – che razza di perversione, eh? O forse era solo noia, e mancanza di un passatempomigliore? Una volta, mentre stava per cominciare il giro delle chiamate, l’apparecchio prese a squillare. Ne fu così sorpreso, e perfino spaventato, che non osava sollevare il ricevitore. E quando finalmente si decise a risponderenonsapevain chelinguafarlo,astento riuscì a mormorare un esitante: «Hallo»... Era una voce femminile, e parlavainfretta,comese avesse poco tempo; aveva pronunciato la penultima sillaba salendo di tono, quindi doveva aver concluso conunadomanda.Budai, cheintantosieraripreso, cercò di dire in inglese, in francese, in russo e in cinese che non aveva capito. Allora la donna ripeté la stessa frase articolando piano ogni parola, il che naturalmente non gli fu d’aiuto. Budai provò in altre lingue, una dopo l’altra, così come gli venivano, ma la donna non lo lasciò finire, scoppiò in una lieve risataeriattaccò. Chi era, che cos’era successo? L’avevano finalmente trovato? Lo stavano cercando da casa? Magari erano sulle suetraccegiàdaqualche tempo? La compagnia aerea si era resa conto dell’errore e l’aveva rintracciato? O forse qualcuno aveva letto il suoavviso?Laletteraper la direzione era stata recapitata? Ma allora avrebbero dovuto sapere che non parlava la loro lingua, l’aveva scritto ben chiaro. E perché si limitavano a telefonargli? O era solo una donna che aveva sbagliatonumero? Poi all’improvviso gli venne in mente che doveva essere Bebe! Com’è che non ci era arrivatosubito!Macerto, quante volte in ascensore lei gli aveva visto in mano la chiave con il numero di stanza: perché non avrebbe potuto fargli uno squillo? E se era lei, di sicuro voleva dirgli che erainalbergo,cheaveva preso servizio, che lo aspettava... Infatti si aprirono le porte di una cabina, ed eccola. Lei strizzò gli occhi sorridendo. Stavolta davvero non vedeval’oradirestareda solo con lei lassù al diciottesimopiano:cercò in ogni modo possibile, mimando una cornetta all’orecchio e il gesto di comporre un numero, di farle capire che aveva colto il messaggio ed era venutodalei...Ancheora la donna, mentre manovrava l’ascensore, di tanto in tanto gli sorrideva, ma con un velo di misteriosa riservatezza. E Budai fu assalito da un nuovo dubbio: come doveva interpretare il comportamento di Veve, complice intimità o nient’altro che la sua consuetagentilezza? Quando furono al diciottesimo piano, Budai per prima cosa le chiese il suo numero di telefono. Le porse il taccuino perché lo scrivesse, fece il gesto di comporre il numero, imitò lo squillo, esortandola in tutti i modi.Maleisilimitavaa alzare le spalle e a fumare, non capiva – oppure non voleva capire, non desiderava dargli il suo numero? O forse non aveva il telefono? In effetti, dove abitava, e con chi? Era sposata o ancora nubile? Viveva con la sua famiglia o da sola?... In realtà non sapeva nulla dilei,maaesseresinceri, non gliene importava molto. Il motivo principale per cui aveva bisogno di quella donna prescindeva dai rapporti che potevano legarla ad altri; bastava che le lasciassero il tempo di dedicarsi a lui. Ma forse neppure questo era importante, dato che i minuti che Etete trascorreva lassù al diciottesimopianoerano sottratti all’orario di lavoro.Quantoalui,non poteva permettersi il lusso di sprecare la sua attenzione, non poteva lasciarsi sfuggire l’unico filo che il caso gli aveva messo tra le mani. Per il momento, Budai teneva allaragazzaperun’unica ragione, a cui tutto il resto era subordinato: era la sua insegnante di lingua. Erano ancora ai numeri.Immaginòchele risposte della donna alla stessa domanda suonassero sempre diverse perché mescolava i numeri cardinalicongliordinali. Potevano non somigliarsiaffatto,come uno e due rispetto a primo e secondo, o in inglese one, two e first, second...Alterminediun lavoro lungo e faticoso, condotto con enorme pazienza, dopo aver chiestolestessecosefino allo sfinimento, era giunto – in maniera molto approssimativa e conqualcheincertezzadi pronuncia – a mettere insieme i numeri da 1 a 10,elisapevaanchedire. Eccoli:1=dütt,2= klooz ogrooz,3= tösh,oanche baar, 4 = gedirim, 5 = baar o tösh (stranamente, il 3 e il 5 sembravano intercambiabili, o forse sololuinoneracapacedi distinguerli),6=kus,7= rododod, 8 = hodod, 9 = dohodod,10=ezrez. Così, nel loro insieme, non gli ricordavano i numerali di nessuna linguavivaomorta,alui nota.Certo,conunpo’di fantasia il gedirim (4) poteva essere assimilato al russo četyre, il kus (6) al kuusi del finlandese, l’ezrez (10) all’ashr dell’arabo.Masitrattava probabilmente di coincidenze fortuite. Era sorprendente la singolare assonanza tra il 7, l’8 e il 9, ma poteva ancheavercapitomale. In generale quel che rendeva il compito particolarmente difficile era l’indefinitezza dei suoni che udiva. Eppure nel corso del suo lavoro aveva maturato una certa pratica nel riconoscere con precisione le sfumature fonetiche. Soltanto che nella lingua degli abitantidiquellacittàvi erano modalità articolatorie così bizzarre come non ne aveva mai udite altrove. Formavano le parole in maniera strana, opaca, confusa, senza seguire le regole di pronuncia condivise, per lo meno nei paesi civilizzati. Parlavano con voce ingolata, emettendo suoni gutturali, ma non al modo dei cinesi, dei giapponesi,degliarabi:le vocali erano mormorate e di colore variabile, le consonanti rauche e biascicate, accompagnate talvolta da suoni occlusivi simili a schiocchi di lingua. Quest’ultima caratteristica ricordava i click delle lingue degli Ottentotti e dei Boscimani dell’Africa meridionale, mentre la frequenza del nesso tl l’azteco centroamericano. L’abbondanza di ö e ü sembrava invece indicare una parentela con la famiglia linguistica turca... Ma tuttequesteeranovaghe impressioni,troppopoco perorientarsi.Secondole stime degli studiosi le lingue del mondo erano quasi tremila: a quale di esse poteva assimilare la lingua che parlavano in quel luogo, sulla base di cosìpochielementi? Ilpassosuccessivofuil tentativo di rintracciare le forme allocutive nel discorso, non solo in quello di Tjetje: stava sempre in ascolto, con le orecchie tese, ma per quantosisforzasseriuscì a cogliere un’unica forma, che suonava all’incirca come klött o klütt, sempre che avesse capito bene. Gli tornò in mente che al mercato coperto, durante la sua primagrandeescursione incittà,ilcamionistache l’avevascambiatoperun facchino si era rivolto a lui proprio con quella parola, come a chiamarlo: «Ehi, lei!»... Sembrava essere la sola forma allocutiva esistente, in luogo delle tante in uso altrove: tu, lei, voi, signore, signora, signorina, vossignoria, vostra grazia, zio, zia, compagno, collega e così via.Ilchenonerad’aiuto allasuaindagine.Perché se c’era un’unica forma che andava bene per tutti, uomini e donne, bambinieanziani,allora dal punto di vista di Budaiilsuointeresseera pari a zero: non sapeva che farsene, non lo portava da nessuna parte. La stessa cosa valeva perilsaluto:parasciarao paratecera,oqualcosadel genere; all’ingresso dell’albergo, per esempio,ilgrassousciere col nastro dorato glielo diceva sempre mentre spingevalaportaavetri: lo diceva al mattino o alla sera, di giorno o di notte, quando arrivava e quando andava via, senza differenze. Ecco dunque un altro dato poco analizzabile, linguisticamente non classificabile, un elemento lessicale che non poteva essere diviso in parti. L’unica utilità era che ora sapeva come cisisaluta,nulladipiù. Poi si mise a caccia delle espressioni di cortesia come prego, mi scusi, si accomodi, eccetera. Gli venne in mente che avrebbe potuto elicitarle in qualche modo. Se per esempio si fosse fatto urtaresulmarciapiede,o gentilmente avesse cedutoilpassosullescale in metropolitana, il passante probabilmente avrebbe mormorato qualcosa come scusi, oppure grazie... Ma con i pronomi personali non era riuscito a cavare un ragnodalbuco,edireche aveva passato parecchio tempoacercarelaforma delcorrispettivodiio,tu, luiolei.Avevatentatoin mille modi, con i gesti e con un sacco di domande, di sentirlo dalla bocca di Dedede, ma la ragazza non sembrava afferrare nella maniera più assoluta. Non faceva che scuotere la testa, mentre soffiava fuori il fumo con aria passiva, e non serviva insistere. Che motivo poteva esserci dietro quella ritrosia, quando per altre cose si mostrava così disponibile e sagace? A Budai venne in mente che quella lingua non avesse pronomi personali. Si poteva immaginare, teoricamente, che comunicassero in una specie di linguaggio infantile che impiegava solo la terza persona, come i bambini piccoli quando parlano di sé: Giovanni mangia, il bimbo cammina. Alcuni popoli primitivi si esprimevano proprio in questo modo. Ma erano compatibiliigrattacielie una coniugazione da età dellapietra? Non aveva mai pensatofinoachepunto le situazioni potessero essere equivoche, e quanto fosse difficile determinare una e una solareazione;oranefece l’amara esperienza. Alla stessa domanda, formulata a parole o mimando, riceveva risposteotroppolunghe, quindi non interpretabili, o sempre diverse; oppure dei gesti – ma anche quelli, quante cose potevano comunicare! Per dire di noinEuropaoccidentale scuotono la testa, i greci la gettano all’indietro, mentre i bulgari annuiscono, e per chiamare qualcuno allontanano da sé le braccia. Si dice che presso gli eschimesi strofinarsi il naso l’uno conl’altroequivalgaaun bacio, e così via – chi gli avrebbe spiegato che cosa significano i vari gestidaquelleparti? Ilsuocervelloperòera costantemente attivo ed escogitavasemprenuovi sistemi. Tra essi quello che finora si era rivelato il più efficace: cercare le scritte il cui significato fosse inequivocabile. Per esempiolaparoladipinta sulla parte anteriore dei taxi, alla quale non potevano darsi molte alternative. Oppure quella che si leggeva sulle rampe gialle delle stazioni del metrò: qualunquefosseilsuono nella lingua locale, era incontestabile che indicasse la metropolitana.Lascritta sopra l’ingresso dell’albergo, illuminata la sera, era già meno certa,potevaesserehotel ma anche il suo nome proprio, Palace, Royal, Park o altro... Lui l’aveva annotato comunque, per oravolevaraccoglierneil più possibile e poi far leggeretuttoaPepe. Quando un ascensore non funzionava e sulla porta era affisso un cartello era quasi sicuro chesignificasseguasto.E così pure sulle cabine telefonichefuoriservizio – come quella da cui avevaprovatoasottrarre l’elencotelefonico,prima che arrivasse il poliziotto. Oppure la breve comunicazione sulla vetrina dei negozi chiusi, evidentemente chiuso... Oltre a queste, aveva ricopiato le stringhe di lettere viste su alcuni locali: trattoria (o ristorante, osteria, mensa?), tavola calda (o self-service, bistrot?), e tintoria (lavanderia, lavasecco?). I negozi sembravano un buon terreno di caccia, per la possibilità di confrontare l’insegna coniprodotti,all’interno e in vetrina. In tal modo aveva raccolto le parole fiori, ferramenta, legna e carbone (o forse combustibili), tappeti, mobili, stoviglie, vetri, lampadari, strumenti musicali, tessuti, abiti (o confezioni), merceria, giocattoli, articoli sportivi, eccetera. Ovvio, anche qui c’era un margine di errore. Sull’insegna di un’attività commerciale poteva esserci il nome del proprietario, l’indirizzo o una parola simbolicaogenerica–ad esempio Arcobaleno (negozio di tessuti o tappeti), Cristalli (vetri, stoviglie, lampadari), Arredamenti, Articoli per la casa, Tessili e un mucchio di altre cose, comecapitavaovunque. Nei negozi di alimentari la vetrina era molto istruttiva per lui. Se un articolo aveva vicino una targhetta che recava il prezzo accompagnato da una scritta, c’era ragione di supporre che questa fosse il nome. Gli interessavano soprattutto generi come arance, limoni, banane, zucchero,caffè,tè,cacao, cioccolata,ossiaprodotti il cui nome era simile in molte parti del mondo – sarebbe stato interessante e rivelatore scoprire la versione locale di queste parole migranti... Certo, poi pensò che nemmeno questo criterio era infallibile, poiché le parole sulle targhette potevano significare anche prezzo imbattibile, prima qualità, specialità, qualità extra, autentico, dolcissimo, appena tostato, offerta speciale, solooggi,scontiinvernali, liquidazione, o qualsiasi altro richiamo usato dai commercianti per promuovere la loro merce. Le copiò dunque sul taccuino con un punto interrogativo accanto alla presunta interpretazione. Durante i suoi giri per la città aveva annotato parecchie scritte di cui aveva dedotto il significato: guardaroba, cassa, acqua potabile (o acqua non potabile), vietatol’ingresso,fermata d’autobus, attenzione, vernice fresca, vietato camminare sull’erba, lavori in corso sulla carreggiata, passaggio pedoni sul lato opposto (sarebbe stato un bel colpo,seciavessepreso), alta tensione oppure chi tocca i fili muore e altre cosedelgenere. Raggiunto un numero sufficiente di casi simili, aveva intenzione di chiedere a Ebebe di leggergli quelle parole a voce alta, una per una. Ma la prima volta che ci provò la ragazza era nervosa, di pessimo umore, non voleva neppure salire con lui al diciottesimo piano. Doveva esserle successo qualcosadispiacevole,in ascensore lo ignorava visibilmente, voltava la testa dall’altra parte, schiacciavaibottonicon aria apatica. Budai però non rinunciò, andò su e giù pazientemente e attese finché la ragazza non decise di prendersi una breve pausa per fumare.Madopoqualche boccata, non appena le rivolselaparola,gliocchi arrossatilesiriempirono di lacrime, tirò fuori un fazzolettino sgualcito e cominciòapiangere. Budai la guardò turbato e perplesso: come poteva consolarla senza sapere chi o che cosa la faceva soffrire? E poioranonavevatempo peroccuparsidiquesto,e neppureavrebbedovuto, pensava. Bisognava che fosse freddo e determinato, anzi, egoista e spietato, era la sua unica opportunità. Alla ragazza doveva dedicare solo l’attenzione sufficiente a mantenere la loro conoscenza,tuttoilresto non era che uno spreco di energia. E se da parte di lei ci fosse stato dell’altro nei suoi confronti, ebbene sì, lui avrebbedovutosfruttare anche questo a proprio vantaggio. Così non mollò la presa, caparbiamente: tanto insistette che alla fine la donna, accantonato il suo misterioso malumore, si mise di nuovo a disposizione e cominciò a leggere a voce alta l’elenco che lui le sottopose... Forse per la prima volta da quando era finito in quella città, Budai ebbe la sensazione di aver raggiunto un qualche risultato grazie alle sue capacità logiche e alla sua costanza. A dimostrarlo erano diversi segnali, a partire dalla mimica e dai gesti diTete:avevaindovinato gran parte delle parole annotate, si era mosso nellagiustadirezione.Gli ridiede un po’ di fiducia vedere che quella sua lotta solitaria non era stata vana. Proseguì con raddoppiato zelo, sfruttando ogni spunto, provava quasi godimento mentre annotava la maniera in cui la ragazza pronunciava le varie stringhe di lettere, e poi le ripeteva subito per tenerle nell’orecchio e sullalingua. Rimase invece deluso dalle parole migranti, perchénessunaavevaun suono riconoscibile. Taxi, autobus, metrò, hotel, buffet, arancia, banana, cacao, eccetera, erano nomi completamente diversi. Questo provava che il paese – cioè i loro linguisti, le scuole, la stampa – difendeva con un rigoroso purismo la lingua nazionale dagli influssistranieri.Oppure che era un luogo talmente isolato dagli altri popoli e lingue del mondo che non ne risentival’influenza? Aveva messo insieme un glossario di circa trenta o quaranta espressioni, corredate di pronuncia, significato presunto, e probabili alternative nei casi dubbi: era lui stesso stupito di come gli era riuscito bene. Si sentiva elettrizzato, in camera sistemò le sue schede in ordine fischiettando allegramente, e la sera si concesse in via eccezionale un bicchiere di quella bevanda alcolica dolciastra. Decisecheperunpo’non avrebbe cercato altro materiale, ma si sarebbe sforzatodielaborarequel cheavevaraccoltofinoa quelmomento. La mattina dopo però, quando provò a convincere la ragazza a scomporre le parole in segni, ovvero in suoni, o quantomeno le espressioni più estese in parole singole, con sua gransorpresalacosanon ingranava:sibloccavano, ricominciavano da capo, siinceppavanodinuovo. Appena ricontrollava i valori fonetici, le varie lettere suonavano diverse,piùlungheopiù brevi, oppure irriconoscibili. E non è che a furia di domande ottenesse risposte più coerenti, anzi, il quadro si faceva sempre più confuso e imbrogliato. Forse la pronuncia di ogni segno cambiava in funzione del contesto, a seconda che si trovasse isolato o all’interno di una parola? Come in inglese e in francese? E inversamente: poteva darsi che uno stesso suono fosse restituito da varielettere? Queste analogie, del resto, avevano valore se si trattava di una scrittura di tipo alfabeticoenonsillabico – ecco, di nuovo questo problema –, e men che meno logografico, come in cinese, dove il segno corrisponde a un concetto compiuto; per quanto quest’ultima ipotesi gli sembrasse poco verosimile, i carattericinesieranopiù iconografici e complessi di quelli, e soprattutto esprimevano in maniera molto concisa una quantità di informazioni... Ma nel caso di una scrittura sillabica,avrebbedovuto seguire un approccio di lavoro totalmente diverso, poiché la sillaba è in genere composta da una vocale e da una consonantee,sepercaso fosse riuscito a individuare, diciamo, la sillaba pe, non avrebbe potuto scinderla in p ed e. Perché in un tale sistema di scrittura, per definizione, accanto a pe anche pi, po, pu dispongono di un segno autonomo, così come i nessime,re,de,eccetera, dunque il suono cercato sarebbe stato celato ogni voltainaltrisegni.Eper giunta avrebbero anche potuto esserci sillabe di quattroocinquelettere– dove era il filo per dipanarequell’intrico? Se nella lettura dei singoli caratteri non aveva fatto grandi progressi, almeno conosceva la forma scritta e la pronuncia approssimativadialcune espressioni. Peccato che fossero in gran parte termini di frequenza occasionale, non il genereutileaorientarsie a cavarsela nel quotidiano. E soprattuttoeranotroppo pochi,nonsarebberomai bastati per partire e tornare a casa. Doveva proseguire nella raccolta di parole in ambiti semprenuovi. Cominciò a osservare i nomi delle vie, strano che non ci avesse pensato prima. Sembrava una città ordinata, le targhe toponomastiche erano appese agli angoli delle strade, ben visibili, secondo un modello preciso: rettangolari, gialle, a caratteri neri. Budai cercò l’elemento comune, la parola o gruppo di segni che potesse significare viale, corso, via, circonvallazione, passeggiata, passaggio, lungofiume o cose del genere. Per quanti appunti prendesse, però, non trovava alcuna corrispondenza: forse erano specifiche omesse, ritenute superflue? O forse usavano denominazioni a sé stanti, come Strand o Piccadilly a Londra, Broadway e Bowery a New York, Rond-Point a Parigi, Graben a Vienna, il Körönd o il vecchio Oktogon a Budapest? Ma queste erano delle eccezioni, possibile che in questa città fossero la norma? Ottenne risultati di poco migliori con le pubblicità; c’erano tantissimi cartelloni in metropolitana, lungo le scale,neicorridoienegli atri sotterranei, ma anche per le strade, alcuni erano di dimensioni gigantesche, ricoprivanointerepareti. Moltidiessiliconosceva fino alla nausea: l’uomo biondo dalla faccia rossa che beveva birra, con la schiuma che gli colava giù per il mento, la grassa cuoca nera che sollevava in alto il suo mestolo ammiccando e facendo balenare la candida dentatura, il cavaliere in armatura con l’ombrello aperto sopralatesta,lafamiglia numerosa i cui membri, seduti in cerchio, immergevano i piedi nudi in un catino comune, e così via; non vedeva mai articoli e prodotti diffusi in altre parti del mondo. Era difficile riuscire a distinguereilnomedella marca da quello del prodotto. Leggendo Ship Soda non sapeva quale fosse Ship e quale Soda. Ciò nonostante riuscì a scoprire alcune parole nuove: detersivo, pneumatico, lassativo, cartine per sigarette, tosaerba, dado da brodo. Non che fossero particolarmente utili sul pianopratico. Molto spesso i simboli grafici sostituivano le scritte, ne trovava dappertutto: frecce, indici tesi, disegni stilizzati, silhouette. In albergo sulle porte dei bagni era rappresentata una vasca o una doccia, sulle toilette una testa maschile o femminile, oppure una scarpa da uomoodadonna.Anche sulle cabine telefoniche nonc’eranoscritte,mail disegnodiuntelefono.Il divietodifumareerauna pipa fumante tagliata da una riga rossa, in maniera simile ad altri divieti. Anche i cartelli stradali funzionavano piùomenocomeintutto il mondo, e il labirinto della metropolitana era organizzato alla stessa maniera: informazioni e orientamento si basavano soprattutto su frecce e colori. I segnali ingeneraleeranostatidi grandeaiutoaBudai,che senzaconoscerelalingua era riuscito a orientarsi in tante situazioni e a crearsi un certo tipo di vita, sia pur limitata a poche attività. D’altra parte, però, sostituendosialleparole, gli impedivano di impararle. Poi gli tornò in mente cheilgiornoincuisiera spinto verso i confini della città, aveva intravisto in lontananza un portale illuminato nella nebbia, ma in quel momento aveva fretta e aveva tirato dritto, non si era avvicinato... Se fossestatouncinema?E la prima domenica, nel quartiere dei divertimenti dove si era aggirato fino all’alba – ormai i suoi ricordi erano vaghi –, c’erano solo locali di varietà o forse anche dei cinema...? Allora non gli interessava, ma ora non smetteva di pensarci. Meditò se tornare fin là, se ne valeva la pena e la spesa. Ormai gli erano rimasti pochissimi soldi, gli dispiaceva spenderli perfino per il metrò – nonosavapensareacosa sarebbesuccessoquando fosserofiniti!–,emagari non era una pista così promettente. Aveva avuto tante di quelle delusioni da quando era capitato in quella città, perché rischiarne un’altra? Meglio lasciar cadere l’idea, dimenticarla come se nonglifossemaivenuta, cancellarla... Ma non riusciva a scacciare quel pensiero, che continuava a lavorare tenacemente dentro di lui, indomabile: e se stesse trascurando una possibilità? Gli si annidò nel cervello come un’ossessione: se non avesse fatto di tutto, se non avesse seguito fino in fondo ogni minimo barlume di speranza, se anche solo una volta avesse desistito significava che si era arreso a quella condizione, che aveva rinunciato a lottare, insomma che aveva accettato di non andarsene mai più di lì. Non si trattava del cinema in sé o della sua utilità,quantodiandarci per non avere niente da rimproverarsi. Decise di dedicarvi un’intera giornata, dal mattino presto a notte inoltrata. Arrivò fino al capolinea del metrò e da lì proseguì a piedi nella stessa direzione della volta precedente. Passò accantoallungomurodi pietra, ai gasometri, rivide la fabbrica con il profilo dei tetti a forma di sega, i bacini di raccolta idrica – non avrebbe mai creduto che sarebbetornatosuquella strada! Apparve il tendonebiancodelcirco: il portale che sembrava uncinemadovevaessere nei paraggi, per fortuna era vicino alla stazione del metrò. Ora non c’era nebbia, non sarebbe stato illuminato, ma Budai non aveva dimenticato come arrivarci, e infatti poco dopo lo vide sul lato opposto della gigantesca piazza, brulicante di folla. Non era un cinema, erano dei grandi magazzini. Un edificio enorme, come lo sono ovunque, di diciotto o venti piani, e dai numerosi ingressi la genteentravaeuscivain continuazione.Eppure,a giudicaredallevetrineal pianterreno, la scelta non era più varia che altrove: confezioni un po’fuorimoda,daltaglio goffo, articoli per la casa e prodotti in serie dalla fattura piuttosto scadente, merce dozzinale che si sarebbe potuta trovare anche sulle bancarelle di un mercato... Ma lui non voleva comprare niente, non aveva soldi, non entrònemmeno,giròsui tacchi e se ne andò. Restava ancora il quartiere dei divertimenti, e con un piccolo sforzo di memoria riuscì a ricostruire il percorso in metropolitana per arrivarci – in genere aveva un buon senso dell’orientamento, quando era stato in un postosapevatornarci. Era un giorno feriale, malafollaerafittacome la volta precedente. Mentre calava il buio cominciarono ad accendersi ovunque scritte luminose, dai bar edalleosterievenivauna musica assordante, gli ubriachi barcollavano sui marciapiedi, gridando, soffiando in trombette di carta. Ritrovò l’angusto vicolo dove aveva fatto visita a quella casa: la donna in tullebiancodallelunghe ciglia e dal viso di madreperla sorrideva anche ora dalla finestra con il suo pudico sguardo da madonna... Budai ripensò con un pizzico di nostalgia ai giorni in cui poteva permettersiquellecose,e anche un giro in barca, unbicchiere,unacrêpe. Benché di cinema non ci fosse traccia, non era dispiaciuto di essere tornatolì.Eracosìsolo,e più tempo passava in quella città sovrappopolata più si sentivaabbandonatoasé stesso. Il semplice fatto diritrovareunpostoche conosceva creava una sorta di legame, un minuscolo punto di riferimentoinunoceano di estraneità. La ruota gigante, la nave dei pirati, il tiro a segno, la donna cannone. Non riusciva ancora a capire: davveroquinonavevano i cinema oppure era lui che non sapeva vederli? Ma questa cosa non gli pareva più così importante, o forse era passatainsecondopiano nellasuaattenzione. Adesso era tutto preso dal suo stato d’animo mutevole. Ora la folla fluttuante di cui lui stesso faceva parte non gli era affatto sgradita, gli sembrava sopportabile, anzi piacevole. Soprattutto il senso di leggerezza, l’unico ma tutt’altro che trascurabilevantaggiodi quella permanenza: il nondoverrendereconto di nulla a nessuno. Ci si poteva anche abituare a una vita complicata, fattadicontinueattesee code, in cui bisognava sgomitare nella ressa; avrebbe finito per non accorgersene più, l’avrebbe considerata una cosa naturale, come tutti gli altri. Queste idee, naturalmente, nascevano dall’umore del momento, un temporaneo stato di grazia, una sorta di ottundimento della coscienza che altrimenti lo tormentava. E sotto quellapiccolascintilladi serenitàc’eraforseanche Epepep, l’allettante certezza che quel giorno stesso, o al più tardi l’indomani, l’avrebbe di nuovoincontrata. Unattimodopoinvece siabbattevaancorasudi lui l’amarezza, la disperazione. No e poi no, non avrebbe mai potuto abituarsi a quella vita: i cibi, le bevande, il sapore dell’aria – fuligginosa, dolciastra, quasi granulosa, greve e soffocante come se fosse povera d’ossigeno –, la ressa perenne, il dover procedere a spallate, gomitate e pedate, la calca, il ritmo folle e intollerabile. Budai amava gli spazi vasti e assolati dove lo sguardo poteva correre libero, come le piazze italiane – che se ne faceva di quel cumulo di mattoni e cemento sempre sovraffollato, che aveva l’aspetto di un’unica gigantesca periferia urbana?... E poi provava unanostalgiasemprepiù acutadisuamoglie,della famiglia, del lavoro, del suo ambiente, di casa sua. Che sforzo scacciare il pensiero più penoso, che non gli dava tregua: come si erano spiegati la sua scomparsa, svanito senza lasciare traccia o unsegnodivita? Gli venivano in mente delle cose tremende: il suo cervello girava a vuoto, producendo un incalzare di domande senza risposta. Per esempio: e se non fosse finito lì per errore, come aveva finora creduto? Se al momento dello scalo non fosse stato lui a sbagliare aereo, ma qualcuno l’avesse dirottato, in altre parole, rapito? Forse sull’aereo gli avevano messo del sonnifero nel pranzo perché non si rendesse conto della durata del volo... E da allora lo trattenevano in quel luogo, impedendogli di tornare a casa. Ma chi erano, e per quale ragione,eachescopo?E perchépropriolui?Achi dava fastidio? Che cosa aveva fatto di male, e a chi? Eppure sarebbe stata una situazione più sopportabile. Rabbia, malevolenza, odio: una relazione con due poli. Alla collera si può rispondereconlacollera, la si può accettare, identificando l’avversario, e lottare, combatterlo, dunque anche sconfiggerlo. Ma se a confinarlo là erano l’indifferenza e la paralizzante noncuranza di chiunque – cosa che sembrava più verosimile –, allora come tirarsi fuori da quelle sabbie mobilisenzanienteacui aggrapparsi, niente su cuipuntareipiedi? L’importante era non perderelatesta,cosìsolo com’era, non arrendersi al disordine, alla massa caotica.Incertimomenti era assalito dalla paura che la sua mente abbandonasse quella lotta disperata e sprofondasse nella babelechelacircondava, o in una malinconia grigiastra e incerta. Eppure non aveva altre armi che la sua lucidità, l’unico faro che poteva puntaresuquell’incuboa occhiaperti. Riassumendo le sue incessanti speculazioni, ecco a che cosa era giunto con gli strumenti a sua disposizione: conosceva il significato approssimativo di qualche espressione della lingua parlata, i numeri da uno a dieci, una maniera di interpellare e una di salutare. Inoltre, il senso e la forma fonetica di varie stringhe di lettere, in base alla pronuncia di Deded–dovevanoessere nomi di prodotti in commercio –, e due o tre frasi più lunghe. Era in grado di leggere solo parole intere e falliva ognivoltachetentavadi scomporle in unità linguistiche minori. Non conosceva ancora il valorefoneticodinessun segno né, inversamente, i caratteri che rappresentavano i vari suoni; per finire, non aveva ancora capito che tipo di scrittura impiegassero da quelle parti. Erano risultati di una pochezza disarmante, insufficienti non soltanto a ricostruire uno straccio di sistema, ma perfino a comporre una frase di senso compiuto. E quando provò a usare le parole che credeva di aver decifrato, per esempio per chiedere dov’era una tavola calda o una stazione della metropolitana, sperimentò con delusione che lo capivanoastentooppure lo fraintendevano. Le aveva forse pronunciate male? C’era poco da stupirsi, data la stranezza del loro modo di articolare i suoni... Un’altravoltaperò,inun sottopassaggio della metropolitana dove era scoppiatounimprovviso tafferuglio, Budai ebbe l’impressione che le persone urlassero e blaterassero parole vuote, e che nessuno stesse a sentire nessuno. Forse nemmeno gli abitanti si capivano l’un l’altro, forse in quella città si parlavano dei dialettidiversi,operfino linguediverse?Nellasua mente sovreccitata balenò il dubbio assurdo cheavesserotantelingue quantierano. 3Inungherese-ban/-ben è il suffisso inessivo, mentre -nak/-nek è il dativo. Negli esempi citati:«nellastanza,nella casa, nella città» e «alla stanza, alla casa, alla città»[N.d.T.]. Intanto, il venerdì successivo trovò il conto settimanale nella casella della 921. Il portiere – un’altra faccia nuova, ma quanti erano? – fece le somme e stavolta il risultato fu di 33,10. Appena un po’ meno del precedente. Budai lo ritirò annuendo in silenzio, ma non andò allacassaasaldarlo.Non aveva abbastanza soldi: quel che gli rimaneva in tascanonerasufficiente, anche se nell’ultima settimana aveva speso moltomenodiprima. Che cosa sarebbe successo, ora? Quando avrebbero reagito, e soprattutto come? Forse poteva venirne fuori qualcosa di buono, per esempio se lo avessero convocato in direzione per avere delle spiegazioni: finalmente interpellato, avrebbe potuto parlare, chiedere un interprete... Oppure non sarebbe successo niente, non si sarebbe fatto vivo nessuno? Fino a quando avrebbero tollerato che alloggiasse lìsenzapagare,unavolta che l’amministrazione l’avessescoperto?Inogni modo i soldi stavano finendo, inesorabilmente.Contòe ricontò il denaro che aveva in tasca: il suo patrimonio ammontava a 9,75. Ecco quanto gli restava dei 200 e rotti ricevuti in cambio del suoassegnodiviaggio. In preda al panico, si lanciò in calcoli febbrili: se la prima settimana, oltre all’alloggio, aveva speso circa 130, e la seconda, pur avendo stretto i cordoni della borsa, 26, con il rimanente, limitandosi all’indispensabile, avrebbe potuto tirare avanti solo qualche giorno. Che ne sarebbe stato di lui se non fosse intervenuta una svolta nel suo destino? Doveva procurarsi del denaro, madove,come? E poiché le disgrazie non vengono mai sole, cominciò anche a fargli male un dente. Era un molare superiore: all’inizio aveva cominciato subdolamente, una fitta momentanea, credeva fosse solo la sua immaginazione, provò a non farci caso. Poi il doloreesploseintuttala sua violenza e divenne lancinante,lamascellasi infiammò e gli si gonfiò la faccia. Era inutile illudersi che sarebbe passato, il tormento era ormai insopportabile e non aveva medicinali o calmanti, la piccola farmacia da viaggio che sua moglie gli aveva preparato era nell’altra valigia,quellasmarrita. In albergo aveva tentato invano di far capire il problema al personale, non gli avevano dato retta o gli avevanorispostoilsolito blablabla. Disperato, nellamorsadelsupplizio e non sapendo più che cosa fare si precipitò in strada. Proprio in quel momento un taxi libero rallentava per fermarsi al semaforo rosso. Budai spalancò la portiera e senza chiedere o dire niente saltò a bordo. All’autista che si era voltatoversodiluitentò di spiegare dove voleva essere portato: si premette la mano sulla facciagonfia,poimimòil gesto di estrarre un dente. L’autista sembrò afferrare, non replicò nulla, schiacciò l’acceleratore: era un giovanotto dai tratti mongoli, l’aria impassibile, il berretto a visiera. Ma appena girarono l’angolo si ritrovarono bloccatineltraffico.Non si andava né avanti né indietro, la carreggiata era invasa dalle auto imbottigliate. Restarono fermi nello stesso posto per interi minuti, poi la filadimacchinesimosse lentamente e si arrestò dopo qualche metro. Avanzavano con una lentezza snervante, intollerabile: doveva esserci un incrocio o un semaforo che impediva altrafficodifluire,come una chiusa. E il tassametro scattava, ancheconl’autoferma,e non si vedeva alcuna speranza di liberarsi dall’ingorgo... Budai non ce la faceva più, apostrofò l’autista in tono pressante, e siccome questi nemmeno si era voltato gli picchiettò la spalla, indicandosi di nuovo la faccia gonfia. Ma l’autista era imperturbabile, non lo degnava della minima attenzione, e nulla confermava che avesse capitolasuarichiesta. Quando guardò il tassametro vide con terrore la cifra 8, e poco dopo 8,40 e poi 8,80 e così via, e l’auto si muoveva appena, il motore girava prevalentemente a vuoto. In pochi minuti il prezzodellacorsasuperò i 10, non li aveva neppure in tasca, e magari erano previsti anche dei supplementi... Era nervosissimo, il mal di denti era quasi insopportabile: prigioniero in quel taxi accerchiato dalle macchine, si pentì di esserci salito, gli venne voglia di spaccarlo a pugni. O di spronare l’autista a buttarsi a tutta velocità contro il grosso camion che sbarrava loro la strada, che esplodessero pure riducendosiauncumulo di lamiere contorte, purché succedesse qualcosa! Ma oltre alla rabbia, a consigliargli la fuga era anche la parte lucida dellasuamente:checosa sarebbe successo al momento di pagare la corsa? Uno scandalo? Sarebbe arrivata la polizia? Rabbrividì al solo pensiero di dover affrontare una situazionedelgenerenel suostato,amenoche...A menoche,approfittando di un momento di distrazione dell’autista, mentre ingranava la marcia ma l’auto si muoveva a passo d’uomo... Budai aprì di scatto la portiera e si proiettò fuori dalla vettura. Inciampò nel bordo del marciapiede, ma non si fece male. Per unattimovidegliocchia mandorla dell’autista che si voltò a guardarlo, poi il taxi scomparve nel traffico: anche lui si perse nella massa dei pedoni. Era una zona sconosciuta, anche se si trovava appena dietro l’albergo. E la prima persona che fermò, alla quale mostrò a gesti che aveva mal di denti, sembròcapirealvolo:gli indicò un vicino complesso di edifici piuttosto alti con la facciata giallo pallido. A giudicare dall’aspetto esterno avrebbe potuto essere un ospedale, una clinica o un istituto di cura, dietro il corpo principale si estendevano altre ali e padiglioni, e dall’ampio passaggioavoltaentrava e usciva una gran folla. Vide perfino una specie di ambulanza che sbucò daunaltroingresso,una vettura bianca, chiusa, a sirene spiegate... Quindi l’autistadaitrattiasiatici l’aveva portato nel posto giusto? Povero ragazzo, ci avrebbe rimesso di tasca sua i soldi della corsa,propriolui,l’unico che gli fosse mai stato d’aiuto... Qui tutti capivano il suolinguaggiodeisegni, e venne subito indirizzato verso il reparto odontoiatrico. Nel corridoio degli ambulatori, come peraltro immaginava, c’era una quantità infinita di gente in attesa, in piedi o seduta sulle panche, e perfino accovacciata o sdraiata sulpavimento,molticon la faccia fasciata o incerottata, con l’ovatta che usciva dalla bocca. E i pazienti venivano chiamati con una lentezza esasperante, di sicuro per ordine di arrivo, e perciò scoppiavano ogni tanto alterchi e risse. Davanti alla porta dove Budai aveva trovato posto c’erano almeno trenta persone prima di lui. Ma non aveva scelta, e doveva pure essere contento di essere arrivatolà. Passò un sacco di tempo,Budaisudavaper il dolore. Aveva rinunciatodaunpezzoa contare le ore, quando finalmente toccò a lui e allora gli eventi accelerarono improvvisamente. Non appena entrò nell’ambulatorio, fu circondato da uomini e donne in camice bianco ed ebbe giusto il tempo di indicare il dente che gli faceva male. Allora uno di loro lo sbatté su una sedia, l’altro gli rovesciò la testa all’indietro, il terzo gli iniettòunliquidofreddo e dolciastro nella gengiva. Il quarto, un tipo tarchiato e nerboruto in scarpe di gomma con la suola bianca, come quelle dei lottatori, gli infilò in bocca una pinza scintillante. Una fitta acuta, uno schianto secco: il tizio levò in alto ilmonconeinsanguinato e glielo mostrò, poi lo gettò nel secchio vicino alla sedia, dove Budai sputò il mezzo bicchiere d’acqua che gli diedero persciacquarsilabocca. Gli chiesero qualcosa, forseilsuonome,eluilo disse, e diede anche l’indirizzo di casa, senza immaginare come li potevano capire e scrivere, e soprattutto a che serviva. Non bisognavapagareniente, o comunque nessuno gli domandò dei soldi. Il paziente successivo era giàpronto,enonappena Budai si alzò dalla sedia quello vi si sedette, e dietro se ne accodò un altro... Per uscire non tornò sui suoi passi, cambiò strada per disattenzione,oforseper il sollievo di essersi lasciatoallespallequella faccenda.Sismarrìlungo corridoi tortuosi, rampe di scale, ovunque affollamento e caratteristico odore d’ospedale, e poi ancora, unodopol’altro,corridoi tortuosi o che attraversavano cortili coperti da tettoie di vetro: a quanto sembrava, le varie parti di quel complesso ospedaliero erano state affastellate l’una sull’altra in diverse periodi. Poi a un tratto sbucò in una sala enorme. Doveva trovarsi nel reparto di ostetricia, davanti a lui erano allineate centinaia e centinaia di culle di neonatiinfascebianche. I neonati, proprio come la popolazione adulta dellacittà,eranoditutte lerazzeumane,dallapiù chiaraallapiùscura,con ogni colore di pelle, ogni tipo e forma di viso. E nonriempivanosolouna sala, ma anche quella dopo, e quella dopo ancora, neonati e neonati, bianchi, neri, bruni, gialli, e se non ci stavano nelle corsie eranoneicorridoi,lungo le pareti. A volte giacevano insieme due o tremarmocchi,chissàse erano gemelli o dividevano il lettino per mancanza di spazio? E anche i padiglioni successivi erano pieni zeppi di bebè, e così di seguito,comesetuttociò non avesse mai fine, e nelfrattempoinfermiere vestite di bianco sbucavano dalle sale parto o chissà da dove con portantine a rotelle cariche di neonati, a decine, a ventine, che strillavanofuriosierossi come gamberi, oppure assopiti, spossati dalla fatica di venire al mondo... A Budai piacevano i bambini, in genere si inteneriva a guardarli, però non ne aveva mai visti tanti tutti insieme, era confuso e turbato da quello spettacolo. Ebbe l’impulso di scappare, iniziò a cercare l’uscita o quantomeno un reparto senza neonati, con un’impazienza crescente che sentiva trasformarsi in angoscia: che cosa sarebbe successo in quella città quando quei piccolifosserocresciutie si fossero aggiunti alla moltitudine? Tornato in albergo, nell’ascensore si imbatté in Bebe. La ragazza notò immediatamente la sua faccia gonfia e con lo sguardoglifececapiredi non scendere. Quando furono al diciottesimo piano Budai tentò di spiegarlechegliavevano cavatoundente,eaprìla bocca per mostrarle quale. Veved era vicinissima e i suoi capelli biondi gli sfioravano la fronte, sentiva la pelle e il respiro della ragazza: in seguito non fu più in gradodiricostruirecome fosse andata, e in fondo che importanza aveva ormai, se fosse stato lui ad accarezzarla e a baciarla, oppure lei a porgere con tenero abbandonoprimailviso, poilabocca.Lelabbradi Budai erano ancora gonfie e intorpidite per l’iniezione, o per la gengiva ferita, erano rigide e goffe, non sentiva quasi nulla, doveva essere anche un po’ intontito, annebbiato. E poi il campanello cominciò a trillare, chiamavano l’ascensore, bisognava scendere: la cabina si riempì rapidamente di gente, e a poco a poco quel che era successo lassù sembrò loro sempre più lontano e irreale. Ma il problema del denaro era ancora da risolvere.Dovevacercare di lavorare, gli serviva unmestierequalsiasiper guadagnaredeisoldi,ma dove, da chi? Non riusciva a ottenere informazioni ben più semplici. E poi non era più capace di fare domande alla gente, era una cosa più forte di lui, difficile da contrastare. Quel chiudersi in sé stesso era conseguenza delle innumerevoli frustrazioni e delusioni che aveva subìto, una formadiautodifesadella sua psiche. Era sempre più impacciato e timido, e quasi non osava rivolgere la parola ai passanti, a chiunque: ammutoliva e si bloccava. Forse, dato il suo temperamento, era l’unico modo in cui sapevareagire. Alloraglisovvenneche un lavoro gliel’avevano proposto, al mercato coperto, la prima domenica, quell’autista che voleva fargli scaricare la verdura dal camion... Si vestì con gli indumenti più scadenti del suo misero guardaroba, delle due paia di scarpe scelse quelle ormai sformate dallelunghecamminate, indossò il pullover che aveva nella borsa da viaggioesiavviò. Ci mise parecchio tempo a ritrovare il mercato. Scese alla fermata giusta, in metropolitana, ma attraversò per ben due volte l’enorme piazza prima di essere sicuro chefosselastessa:eraun giorno feriale, l’area era sgombradaibaracchinie dai banchi di vendita, il selciato era spazzato e pulito, e al centro si vedeva la statua di un soldato ferito: era un monumento ai caduti? Dedusse che il mercato delle pulci si teneva solo la domenica e nei giorni festivi... C’era invece un bel movimento nel mercato coperto sotto la struttura di vetro e acciaio dall’altro lato della piazza. La parte anteriore era presa d’assalto da chi voleva fare acquisti, mentre sulla rampa laterale si svolgevano intense operazioni di carico e scarico, con un gran lavorio di gru, nastri trasportatori e manodopera umana. Tanti scaricatori indaffarati attorno ai camion,figurimalvestiti che trasportavano all’interno balle, blocchi dighiaccioecanestri. Non fu difficile mescolarsi a loro, si formavano delle bande occasionali che si facevano assegnare questo o quel carico. Bastò stare attento all’arrivo del primo camion di merce, avvicinarsi, voltarsi di spalle e già gli avevano messo un sacco sulla schiena. Doveva essere pieno di patate o cipolle, non era particolarmente pesante; lo portò dentro, seguendo gli altri, lo buttò in un mucchio sopra una gigantesca pesa,poitornòindietroa prenderne un altro. Non gli chiesero nessun documento, e dopo un paiodidomande,quando fuchiarochenoncapiva la lingua, non gli rivolsero nemmeno più la parola. Non che ci fosse molto da dire: quel che doveva fare era chiaro senza bisogno di tanti discorsi. E neppure gli altri scaricatori gli badarono, avevano il loro daffare, e non sembravano neppure conoscersitraloro. Budainonavevapaura del lavoro fisico; da giovane, quando era studente borsista all’estero e spesso in bolletta, gli era capitato di lavorare per intere nottate alle Halles di Parigi o al mercato di CoventGardenaLondra. E aveva ancora un fisico robustoesano,glifaceva piacere il movimento. L’unicacosacheglidava fastidio era che i sacchi gli sporcavano le mani e il pullover: ci misero circa un’ora e mezzo a portare tutto il carico sulla pesa. Allora il camionista li pagò, e ficcò in mano a tutti quantiunabanconotada 1. Poi gli fecero portare dentro delle mezzene di maiale, era merce refrigerata, gelida e umida, la sentiva fredda sulla schiena e le palme delle mani gli diventarono unte e bagnate. Quindi procedetteascaricareda un furgone delle voluminose gabbie con dentro grassi conigli d’angora,comequelliche avevavistoinunastanza dell’albergo. In tutta la giornata guadagnò otto banconoteda1equalche spicciolo. Provava una piacevole stanchezza e anche un pizzico d’orgoglioall’ideache,se necessario, era capace di mantenersi con il lavoro delle sue braccia. Però non vedeva l’ora di tornare nella sua stanza dabagnoefarsiunabella docciacalda. Da allora in poi, tutte le volte che andò al mercato coperto, a qualsiasi ora, trovò sempre da lavorare. E nessunomaivollesapere chi fosse. Notò che alcuni scaricatori del turnodinottealtermine del lavoro non se ne andavano, restavano nelle mescite aperte nei pressi dell’edificio. Altri si mettevano a dormire inmezzoalleballe,sopra sacchi vuoti o in un angolotranquillo,dentro casse di grandi dimensioni. Dovevano essere vagabondi, gente senza fissa dimora, avevano vestiti sporchi, un aspetto trasandato: ecco, si era ridotto come unodiloro. Un giorno, tornando dal mercato, scese in metropolitana sulla lunga scala mobile, accanto alla quale saliva in senso contrario il flusso interminabile di chi ne usciva. A un tratto, con un certo ritardo, vide sull’altra scala un uomo con in mano una rivista ungherese. Non c’era alcundubbio,noneraun abbaglio, era un numero del vecchio settimanale «Színházi Élet»,4 il titolo si leggeva benissimo. Anche l’attrice fotografata in copertina gli sembrò familiare: in costume da bagno a righe,stavainpiedisulla scalettadellapiscinacon leondedeibagniGellért, bionda e snella, con la mano sinistra alzata in un saluto... Era una cosa talmente sorprendente e imprevista: prima che Budai se ne rendesse pienamente conto, il tizio con la rivista, un uomo di una certa età, dai capelli grigi, con gli occhialieunlodenverde piuttosto liso, era già passato oltre sulle scale mobili ed era ormai alle sue spalle. Così, su due piedi, non gli venne niente da dirgli, e col respiro spezzato gli gridò: «Mi scusi... Dico a lei, signore...!». Ma le scale mobili ronzavano e cigolavano cosìrumorosamente,ein quel tunnel obliquo e rimbombante, gremito di passeggeri, c’era un tale baccano che il signore in loden di certo non lo sentì. Allora Budai, atterrito all’idea di perderlo di vista per sempre, gli urlò di nuovo: «Ehilà, guardi da questaparte...!». L’uomosivoltò,conlo sguardo di chi si sente chiamare dall’aldilà. Allungò la mano verso Budai, da lontano, con gesto incerto, forse nel dubbio che fosse un miraggio: «Ma allora anche vossignoria...?». Il resto fu coperto dal rumore circostante e dalla distanza sempre maggiore tra di loro. Budai tentò di risalire peravvicinarsialsignore in loden, ma le scale mobili procedevano piuttostovelocementeei passeggeri dietro di lui formavano una barriera impenetrabile, anzi, alcuni scendevano i gradini per la fretta di arrivare ai binari: non avevaalcunasperanzadi raggiungerlo, non c’era lo spazio, né il tempo. Disperato gridò ancora verso quella macchia verdastra che si allontanava sempre più inaltoesiperdevaormai nellafolla: «Miaspettialla...». Ma lì per lì non gli venneinmenteunluogo in quell’intrico di corridoi e sottopassaggi della metropolitana. Se almenogliavessechiesto l’indirizzo, o gli avesse dato il suo mentre passavano uno accanto all’altro! Ma non sapeva il nome dell’albergo, e neanche la via... Intanto la figura dello sconosciuto era stata completamente risucchiata dal gorgo del metrò. Budai non riusciva a darsi pace, provò a mettersi nei panni dell’altro: che avrebbe fatto se qualcuno l’avesseinterpellatocosì, dovel’avrebbeaspettato? Il posto più ovvio era in cima alle scale mobili. Soltanto che non era facilearrivarcidadovesi trovava. In fondo c’era un divisorio a separare una scala mobile dall’altra, e poi il percorso veniva incanalato da varie barriere, passando per corridoi tortuosi, incroci e nuove svolte e deviazioni. E quando, dopo aver vagato a lungo, vide la scala mobile, non era più sicurochefosselastessa. Dove terminava ne cominciava un’altra, e dopo un’altra ancora; qual era dunque la fine delle scale mobili? Ed erano tutte stipate di genteinmezzoallaquale il suo sguardo cercò invano il signore in loden. Ovviamente non sipotéfermare,lamassa lotrascinòvia. Eseilsignoreinloden, ragionando come lui, l’avesse atteso in fondo allescalemobili?Ritornò indietro, facendosi largo afatica,finoall’altezzain cui aveva incrociato il tizio in loden: avrebbe fatto meglio a saltare dall’altra parte in quell’istante, a scavalcare il corrimano di gomma che separava una scala dall’altra, perché non ci aveva pensato sul momento?... Non lo trovò, di sotto, neanche giù sulla banchina percorsa dal rimbombo dei vagoni e dalla corrente d’aria. Potevadarsicheiltiziolo stesse aspettando su in strada? Ma a quale uscita?Perchécen’erano otto o dieci... Vagò ancora in su e in giù per illabirintodellastazione, alungoeinvano:l’uomo che stava cercando non emerse più dall’inesauribile marea umana che riempiva uniformemente ogni spazio. Nel turbamento dell’emozione,nonseppe decidere se quell’incontro fosse un segno positivo o negativo. Anche se non era riuscito a parlargli, a stabilire un contatto, lo rassicurava, nell’isolamento totale che lo aveva afflitto finora, scoprire di non essere il solo straniero proveniente dal suo paese. Poteva sperare di incontrarlo di nuovo, lui o un altro compatriota, oppure uno straniero di un’altra nazionalità: la prossima volta le circostanze sarebbero state meno sfortunate, e finalmente lui avrebbe chiarito tutte le questioniinsospeso. D’altra parte, però, se provava ad analizzare quella strana scena, c’erano degli elementi inquietanti.Apartiredal fatto che lo sconosciuto avesseinmano«Színházi Élet».Larivista,aquanto ricordava Budai, aveva cessato le pubblicazioni una trentina d’anni prima. Quel signore viveva lì da così tanto tempo? E se sì, vi si era stabilitodisuavolontào ci era finito per errore anche lui? E come ci era arrivato, con quale mezzo di trasporto? Si era portato dietro la rivista per leggerla in viaggio, magari proprio il numero della settimana, e da quel giorno la conservava?... Questo poteva spiegare lo stupore incredulo del suo sguardo quando si era voltato verso di lui, reagendo al suo grido come se avesse sentito una voce dall’oltretomba. E anche quel «vossignoria», una forma allocutiva antiquatacheormainon usavapiùnessuno.Epoi perché «anche vossignoria»? Perché quella parola che sembrava accomunarli in uno stesso destino? Si riferiva soltanto al fatto che erano connazionali, oppure – era questo che piùtemeva–quell’uomo, proprio come lui, non riuscivaadandarseneda trent’anni,oforsepiù? Per giorni non poté darsipace,sitormentava per l’occasione perduta, si colpevolizzava e rimuginava in continuazione: avrebbe dovuto comportarsi diversamente? E come l’assassino che torna sul luogo del delitto, andò ancora molte volte in quella stazione del metrò, vagando per ore, nella speranza che il signore in loden ripassasse di lì – magari faceva parte del suo tragitto abituale. E sebbene non riuscisse a incontrarlo, da allora in poi coltivò il segreto sospetto che nella moltitudine che invadeva le strade e la metropolitana si aggirasse qualcuno con cui scambiare una parola... forse più di uno – ma come avrebbero fattoariconoscersi? Illavoroalmercatoele ronde nella stazione della metropolitana finirono per dare un ordine alle sue giornate. In genere mangiava alla solita tavola calda e poi tornava a piedi in albergo. Passava sempre accantoalgrattacielo.Da quando aveva cominciato a contarne i piani ne avevano costruiti otto, ora erano al settantaduesimo: ma qual era l’altezza progettata? In albergo andava sempre a cercare Pepepe agli ascensori, e dopoaverlaincontrata,o se non la trovava in servizio, non gli restava che ritirarsi in camera. Malvolentieri,perchéera là che si sentiva più solo e abbandonato, e il tempo sembrava non passaremai. La stanza era sempre pulitaeinordine,illetto rifatto, e una volta la settimanacambiavanole lenzuola, la tovaglia, gli asciugamani e il telo da bagno. Ma non era mai riuscito a sorprendere chi si occupava di tutto questo: quando rimaneva in camera, e talvoltapergiorni,nonsi facevano vivi. Una mattina, per pura curiosità, finse di uscire e si appostò dietro l’angolo del corridoio, ma per l’intera mattina non comparve nessuno. Altre volte, invece, era sceso brevemente alla reception e quand’era risalito, dopo un quarto d’ora, aveva trovato la stanzarassettata. La cosa che gli mancava di più era la lettura, la parola scritta: acasapassavametàdella sua vita in biblioteca, in mezzo ai libri, talvolta fino a diciotto ore al giorno – gli dispiaceva rinunciare a quell’abitudine. In preda all’astinenza riprese in mano la raccolta di novelle che aveva comprato al negozio di libri usati. La sfogliò ancora una volta, senza capirci un’acca; osservò la copertina, il golfo con l’acquaazzurra,lepalme, le casette di un bianco abbagliante sul fianco della collina. Poi guardò la foto dell’autore sul risvolto di copertina, l’uomo in pullover dal viso pieno e con i capelli a spazzola: gli occhi socchiusi, la sua espressione annoiata e un po’ beffarda gli parveroancorafamiliari. Sidomandòdovepotesse averlo visto... A chi assomigliava, chi gli ricordava, che cosa lo attraeva in lui? L’ironia? Quell’ariapigraevigileal tempo stesso? Finché una sera, dopo una dura giornata di lavoro al mercato, guardandosi allo specchio del bagno mentre cercava di reprimere uno sbadiglio, all’improvviso capì: assomigliava a lui. Era per questo che gli era simpatico e aveva scelto proprio quello tra le migliaia di volumi? Era questo che gli era piaciuto, la propria faccia? E così si ripresentava alla sua mente la più angosciante delle domande: che ne era dei suoi familiari? Perché il tempo non si era certo fermato, a casa: stavano bene, erano in buona salute,eranovivi?Esesì, in che modo potevano aver reagito alla sconcertanteassurditàdi nonaverel’ombradiuna notiziadatresettimane? Invanosisforzavadinon pensarci, questa ossessione torturava il suo sistema nervoso. Se avesse almeno potuto avvertirli, mandare un sia pur breve messaggio, farsaperecheeraancora vivo–chissàdove... Finora non aveva mai visto un ufficio postale, danessunaparte;eppure doveva esserci. Forse ci era passato davanti senza accorgersene? Niente cassette delle lettere,ancheseleaveva cercate nella hall dell’albergo. Lì aveva tentato di spiegare alle commesse dei vari negozi che voleva un francobollo, non vedendone esposti, ma dalle risposte e dai gesti non era chiaro se non capissero o lo inviassero altrove–sì,madove? Allora gli venne un’altra idea: piegò a formadiletteraunfoglio di carta e scrisse l’indirizzo della moglie. Naturalmente, era piuttosto turbato e commosso mentre lo scriveva, la solitudine l’aveva reso fragile e incapace di dominare le proprie emozioni. Adesso però si sforzò di contenersi e portò la lettera di prova giù alla reception.Laconsegnòal portiere di turno, che peròsilimitòaguardarla e a rigirarla tra le mani, probabilmente senza riconoscere i caratteri latini.Oforsenonsapeva chefarne,nonspettavaa lui, non volle ritirarla, e gliela restituì con una breve frase di cortesia. Credendo che si riferisse alla mancanza del francobollo, Budai prese del denaro, lo fece tintinnare, come a chiedergli quanto costava, e posò sul banconeunamanciatadi spiccioli, fissandolo con sguardo interrogativo per capire se bastavano. Il portiere, un uomo di una certa età, dall’aria distinta, dovette fraintenderloepensarea un tentativo di corruzione: in preda a un’improvvisa stizza, esclamò sdegnato qualcosa e allontanò da sé il denaro. Distolse lo sguardo da Budai e si rivolse ostentatamente alclientesuccessivo. Nonostante l’insuccesso, meditò se non fosse comunque il caso di scrivere una lettera a sua moglie. L’avrebbe lasciata sul bancone della reception, quando in servizio ci sarebbe stato qualcun altro, con accanto dei soldi, una somma sensata per l’affrancatura, e poi si sarebbe allontanato in fretta. Nella remota eventualità che fosse arrivata, dal timbro postale sarebbero potuti risalire alla provenienza... Però temporeggiava e rimandava il momento, non riusciva a prendere in mano la penna, non avevaanimo.Oforse,più semplicemente, non trovava le parole per spiegare quello che gli era successo. No, per quanto ci girasse intorno, era incapace di metterloperiscritto. Tornò nella sua stanza e si attaccò al telefono. Formò i numeri alla cieca, senza guardare il disco dei numeri, e chiamòisuoiconoscenti sconosciuti: non gli importava che gli addebitassero le chiamate il venerdì successivo, tanto ormai era in debito. Se qualcuno gli rispondeva, scandiva al microfono sempre la stessa cosa, andòavantiperoreeore, sforzandosi di non perdere la pazienza: il nome della sua città natale e il numero di telefono di casa sua, questo ormai era capace di dirlo nella lingua locale, sei semplici cifre di base. E lo faceva nella convinzione che prima o poi avrebbe azzeccato unalineaperlechiamate internazionali, o magari un numero pubblico dal quale avrebbero inoltrato la sua telefonata; non doveva far altro che ripetere ostinatamente la sua filastrocca.Magridòfino a diventare rauco, in risposta non ottenne altro che il solito ciangottio, voci ora maschili, ora femminili, ora infantili, ora senili, ma nessun segno che comprendessero quel che diceva. Passò così tuttalaserata:allafinelo assalì una rabbia impotente, sbatté giù la cornetta, schiumante di collera maledisse la propria sorte e prese a pugni la parete, tanto che dalla stanza accanto bussarono in risposta. Che sventura tremenda gli era capitata! Perché proprio a lui? Perché era successo proprio a lui? Perché, perché, perché, perché? Poi, quando si fu calmato un poco, si immerse per l’ennesima volta nella contemplazione del dipinto a olio sopra la scrivania,quelpaesaggio innevatocongliabetiei caprioli sullo sfondo che correvano aggraziati. Ne conosceva fino alla nausea ogni dettaglio, ma era il suo unico sguardo possibile su una natura libera, un mondo aldilàdiquellacittàche lo imprigionava. Sempre che esistesse, quel mondo, e non solo nella suaimmaginazione. 4.«Vitateatrale»[N.d.T.]. Finoranonerariuscito afarsidiredaBebequali erano i suoi turni di servizio, dove andava dopo il lavoro, il suo numeroditelefono,dove abitava, dove poteva trovarla e così via. Pur mostrandosi molto sveglia in altre circostanze, la ragazza non sembrava capire queste domande, oppure le lasciava cadere deliberatamente. Budai non ottenne grandi risultati nemmeno quandoprovòaspiarla:o era nell’ascensore, o non era nell’ascensore, ma non la vide mai arrivare in albergo né andarsene, e non la incontrò da nessun’altra parte dell’edificio. Però si sentiva abbastanza in confidenza per chiederle diportarlo,adesempio,a una stazione o a un aeroporto. Ma alla prima occasione in cui, al diciottesimo piano, Budai toccò questo argomento, mostrandole dei disegni di mezzi di trasporto, Etete non manifestò nessuna disponibilità ad aiutarlo, anzi,siintristìegliocchi le si riempirono di lacrime... Forse la addolorava che lui volesseandarsene?Cercò di consolarla, accarezzandola, ma la sua timidezza rese il gestoimpacciato,eallora si limitò a stringerle il gomito non sapendo che altro fare. Senza la comprensione linguistica l’abisso tra di loroeratroppoprofondo, perquantodesiderassero entrambi colmarlo. E in quel momento qualcuno chiamò l’ascensore, non c’era mai abbastanza tempo, un po’ di quiete senzainterruzione. Quellaserastessanella stanza di Budai venne a mancarelaluce.Accadde subito dopo che si era fattoladoccia,mentresi preparava ad andare a dormire. Aprì la porta e diede un’occhiata nel corridoio, poi fuori dalla finestra: era buio dappertutto, anche i lampioni erano spenti, solo i fari delle auto fendevano il vuoto nero. Dovevaesserciunguasto nella fornitura di elettricità di tutta la zona, perché non si vedevanolucineppurein lontananza. La cosa non lo turbò più di tanto: conosceva bene la sua stanza, si orientava a tentoni,ecomunquenon aveva niente da leggere. Si infilò a letto, anche se nonavevasonno. Poco dopo udì bussare delicatamenteallaporta. Aguzzò l’orecchio pensando di essersi sbagliato, e lo sentì di nuovo; con prudenza qualcuno abbassò la maniglia ed entrò – quando era uscito a guardare nel corridoio, evidentemente aveva dimenticato di girare la chiave. Quel qualcuno si chiuselaportaallespalle e si fermò, respirando piano. Solo allora Budai siresecontocheinrealtà la stava aspettando. Forse per questo non aveva chiuso a chiave e, benché fosse stanco, era ancora sveglio ed eccitato. In effetti, pur senza formulare un pensiero compiuto, qualche angolo del suo cervello doveva aver calcolatochesemancava la corrente neanche l’ascensore poteva funzionare... Per avere una conferma, e prima che lei potesse parlare, chiese: «Bebebe?». La ragazza rispose con un risolino timido, che rivelò il suo leggero disagio, com’era naturale. Questo non le impedì di correggere la sua pronuncia imperfetta: «Diedie...». Ma poteva anche essere Dede, Tjetjetje, Tete e perfino Cece, ancoranonerariuscitoa chiarire l’esatto valore fonetico delle varie consonanti. La ragazza era rimasta accanto alla porta, senza avanzare. Certo, era comprensibile ilsuoimbarazzoperaver preso l’iniziativa di entrare nella sua stanza. Nonostante la stranezza della situazione Budai ebbe la sensibilità di notarlo:sialzòdallettoe le si avvicinò brancolando nel buio. Indossava l’unico pigiamacheaveva,eche lavavaregolarmente,ma tanto al buio non si vedevano. Procedendo a tentoni, andò a sbattere contro di lei e la sua mano toccò il seno della donna. Ripiegò immediatamente il braccio teso, per non farle credere che volesse approfittare della situazione...Maaltempo stesso fu pervaso da un grande turbamento nel sentire attraverso il vestitoilcaloredelcorpo diPepe:avevailsenoalto e sodo come quello di una ragazzina, e gli sembrò di percepire anche il battito del suo cuore. Si avvicinarono al letto, non avrebbero potuto mettersi altrove in quella minuscola stanzad’albergo.Quando si sedette di fianco a lui la donna si accese una sigaretta, e il suo viso balenò nell’oscurità: a Budaiparveleggermente estraneo, la pettinatura era diversa, i capelli più lisci del solito. Lei si voltò dall’altra parte, senza guardarlo. Spense la fiamma, forse le sembrava più appropriato restare nell’oscurità. Da quel momento in poi l’unica luce fu la brace intermittente della sigaretta, che lasciava intravedereappenaisuoi lineamenti. A poco a poco la stanza si riempì difumo. Ma la ragazza non finì la sigaretta. Si liberò degli abiti e corse nel bagno con addosso solo le calze. Budai la udì muoversi in cerca del rubinetto, poi sentì scorrere l’acqua. Si alzò per chiudere a chiave la portaesirimisealetto. Edede sapeva di sapone e di acqua di colonia quando si sdraiò accanto a lui sotto le coperte, aveva la pelle fredda per la doccia, tremava leggermente. Budai cercò di scaldarla, le prese i piedi gelidi tra le cosce e la abbracciò. E poi fece tutto quello che un uomo deve fare, guidato dalle proprie pulsioni e abitudini. Veve non oppose resistenza, né si fece pregare, ma si lasciò andare molto lentamente e non del tutto. Non mostrava un grande coinvolgimento, sembrava che per lei fosse più importante compiacere Budai. Dal canto suo, lui sentiva il bisogno della partecipazione della compagna e non amava un piacere solitario. E finìinfretta,nonriuscìa trattenersi: aveva passato troppo tempo in solitudine. Sivergognavaunpo’a giacere di fianco a lei al buio. Fu la ragazza a rompere il silenzio, si sollevò a sedere sul letto e gli domandò qualcosa: stranamente, lui indovinò che gli stava chiedendo se poteva fumare, se non gli dava fastidio. Quando fece scattare l’accendino si coprì con il lenzuolo: la imbarazzava ancora mostrarsinudadavantia lui. E poi si mise a parlare sottovoce, esitante, facendo delle pause, bloccandosi; ogni tanto scuoteva la cenere della sigarettanelportacenere che Budai aveva preso dalla scrivania. Poi divenne via via più sicura, forse aveva cominciato una storia piuttosto lunga che voleva raccontargli da tempo, oppure gli stava parlando di sé, della sua vita. E pensare che, se c’era qualcuno che doveva sapere quanto poco lui capisse, quella era proprio lei. Budai tentava di indovinare qualcosa dal tono della voce, dal ritmo del discorso, dalle inflessioni, ma non era certo facile... Il racconto si fece animato e sofferto,maleinonperse mai quella soavità che le era naturale. E aveva appena spento la sigaretta che le sue dita nervose ne accesero un’altra: l’argomento dovevatoccarlamoltoda vicino. Poteva darsi che stesse parlando di qualcuno. Ma di chi? Chi poteva turbarla così? E perché aveva deciso di parlarne proprio in quell’occasione? Forse si trattavadisuomarito? ABudaivenneun’idea: cercònelbuiolemanidi Epepe, prima la destra, poi la sinistra, e tastò le dita affusolate alla ricerca di una fede o di qualcosa del genere. Naturalmente non c’era, l’avrebbe già notata. La donna però dovette comprendere, accese l’accendino e alla luce della fiamma prese un anello dalla borsetta sul comodino. Aquelpuntoanchelui chiese un po’ di luce e, per quanto lo permettesse quel debole chiarore, esaminò l’anellorigirandolofrale dita. Sembrava d’oro, la forma era quella di una fede, nessuna incisione all’interno. L’esterno era decorato da sottili righe blu: avrebbe potuto essere una fede matrimoniale, ricordava vagamente di averne viste di simili, più moderne. Ma se lo era davvero, perché la tenevanellaborsetta? O forse era proprio questa la chiave del suo strano comportamento? La sua paziente sollecitudine nel rispondere a tante domande, ma non a quelle che la riguardavano, su dove abitava e la sua situazione familiare? Ecco la spiegazione: un matrimoniofallitodicui non voleva parlare? Era questo il motivo per cui non ne portava il simboloaldito? In seguito provò a interpretare le parole della donna in questa luce,edeccochedicolpo tutto divenne chiaro. Gli parve di riuscire a seguirequelchediceva,o perlomenol’essenziale:i dettagli, si sa, non contano... Era uno sfogo su quanto fosse intollerabilelavitaacasa sua, la convivenza con tutta quella gente: parenti vari, zii e zie e i due figli del primo matrimonio del marito. E anche coinquilini e subaffittuari, e perfino gente che occupava solo un posto letto per la notte e di cui non riuscivano a liberarsi, vecchi invalidi e malati, nevrotici urlanti e ubriaconi sudici e intrattabili, donne dalla vita equivoca, provviste anch’esse di marmocchi, tuttistipatiinunpiccolo appartamento. Una caciara perenne, strilli, baruffe, mai un minuto di tranquillità; non potevano però andare a vivere in un’altra casa, l’intero stabile era sovraffollato, come dappertutto, alloggi migliori non ce n’erano senonaprezziproibitivi o tramite conoscenze speciali, e poi come facevano a lasciare quei poveri vecchi? In quell’ambiente infernale anche il loro rapporto si era deteriorato, era inevitabile, suo marito beveva, trovava sollievo solo nell’alcol, era diventato più rude: si erano allontanati, di fatto era come se non vivessero più insieme. Lei stessa cercava ogni occasioneperevadereda casa, in confronto a quel manicomio perfino il brutto e vecchio ascensore dall’aria viziata era un paradiso... Ecco perché non portava la fede nuziale e finora non aveva mai voluto parlaredisé,eancheora si vergognava a raccontare certe cose del marito. Ma ci teneva a fargli capire perché era venutadaluiquellasera, non voleva che Budai la credesse una donna leggera in cerca di facili avventure. E poi doveva pur raccontarlo a qualcuno. Sempre che fosse questo che stava raccontando, e non tutt’altro. Intantoavevariempito lastanzadifumoe,dopo essersi sfogata, sembrava anche un po’ più calma. Quando tese la mano nel buio per prendere un’altra sigaretta, urtò il bicchier d’acqua preparato per la notte. Riuscì ad afferrarlo al volo ma si sbilanciò, e sarebbe caduta giù dal letto se Budai non l’avesse trattenuta, ma nella manovra l’acqua schizzò addossoaentrambi.Bebe scoppiò a ridere, e la sua risatalocontagiò,unriso incontenibile: sghignazzavano uno sopra l’altro. E nessuno dei due riusciva a smettere, e se anche si fosse calmato, l’altro avrebbe ricominciato, e ridevano e si rotolavano sul letto, per poco la donna non cadde di nuovo e questo li fece ridereancoradipiù. ABudaitornòinmente un ricordo d’infanzia, un’attrazione del parco dei divertimenti del Városliget che si chiamava «Giù dal letto!». Grasse signore prosperose giacevano in camiciadanottedipizzo in mezzo ai guanciali e alle trapunte, e se il giocatore riusciva a colpire il bersaglio con unapalladipezza,illetto si ribaltava e il pingue donnonerotolavagambe all’aria tra le risate del pubblico. Non riusciva a scacciare quella buffa immagine che alimentavalasuailarità; desiderò condividerla con Vedede e istintivamente lo fece. Lei lo ascoltava rannicchiata tra le sue braccia, annuiva ridacchiando,emettendo piccoliversidiassenso,e alla fine rise insieme a lui, con una tale spontaneità da far crederecheavessecapito tutto. Elui,ormaitrascinato, finìperraccontarlecome era capitato lì, le descrisse nei dettagli l’imbarco sull’aereo, quando aveva perso il bagaglio,inchemodogli avevano sottratto il passaporto e così via. E anchealtrecosecheman mano gli venivano in mente, senza un criterio preciso: l’episodio del suoarresto,lavistadalla cupola dell’enorme chiesa in cima alla quale si era arrampicato, e quella volta che si era imbattuto in un suo connazionale in metropolitana... Poi le parlòdicasasua:delsuo cane, un bassotto vecchio e saggio che d’inverno in giardino si aprivaunpassaggionella neve e poi nel bianco si vedevano muoversi due puntini, la punta del naso e della coda. E di quando andava a sciare sui Tatra o sui Mátra, e preferiva avventurarsi da solo fuori pista, serpeggiando in dolce pendenza nel folto dei boschi, dove il silenzio erapiùdenso,etuttoera verdeebiancoesoffice,e sulla neve le orme fresche dei cervi. E sul ciglio del pendio si sentiva attratto e risucchiato dall’abisso, e che gioia provava nel lanciarsi con gli sci ai piedi,nellasciarsiandare all’ebbrezza del vuoto, all’estasidelprecipitare... La donna lo ascoltava in silenzio complice, stretta a lui nel letto. A un tratto Budai si interruppe e alzò di scattolatesta: «Matucapisci?». «Gapisci»risposelei. «Capisci?». «Gapisci». «No,noncapisci!». «Gapisci» ripeté lei ancora. «Non è vero, stai mentendo!»scattòBudai, semprepiùirritato. «Gapisci». «Ma non puoi capire! Perché fai finta di capire senoncapisci?». «Gapisci» insisteva cocciutaDebebe. Budai fu colto da un’improvvisa collera, afferrò la donna per le spalleepreseascuoterla violentemente,urlando: «Non hai capito una parola di quello che ho detto!». «Gapisci». «Bugiarda!». «Gapisci». «Bada,tu...». Era travolto dalla propria brutalità, gli si annebbiò il cervello: col palmo della mano le schiaffeggiòilmento.Ma Pepep non smise di ripeterelastessaparola: «Gapisci,gapisci». Lui non sapeva più quel che faceva, aveva perso il controllo: la scuoteva, la spingeva, la colpiva dove capitava, al viso,sulcollo,sullanuca, sul petto. Lei non si difese, sollevò soltanto un braccio per proteggersi gli occhi, e nel buio si sentiva il suo pianto sommesso. Ma la sua passività aveva l’effetto di eccitare la collera di Budai, che ormai si dimenava come unossesso:laafferròper icapelli,lapreseapugni, in uno stato di accecamento totale, in preda a una rabbia irrazionale, dimentico di ognialtracosaalmondo, voleva solo vendicarsi, vendicarsi... Poi di colpo le crollò addosso, sfinito, ansimante, con il cuore che gli batteva all’impazzata, affranto. La abbracciò, si strinse a lei, le baciò le mani, pieno di vergogna la imploròesupplicò: «Perdonami, sono un pazzo! Perdonami, ti prego, ho perso la testa! Sono un pazzo, un pazzo...». Ceteceavevaancoragli occhipienidilacrimeeil viso arrossato per i colpi ricevuti. Budai avrebbe dato metà della sua vita per farsi perdonare da lei; la abbracciò, la accarezzò e la baciò su tutto il corpo, quindi si mise in ginocchio accanto al letto, posò la testa sul suo grembo, mormorando parole dolci con voce soffocata. La donna aveva la pelle ardente, mani asciutte e caldissime mentre gli carezzava la testa passandogli le dita tra i capelli,poiloattiròasé. StavoltaEbebesilasciò andare completamente: fu tenera e sollecita, e si comportò come non si era mai comportata con nessuno, neppure col marito, si capiva dal suo modo di fare. Adesso raggiunse insieme a lui l’apice dell’amplesso. La cosa più importante non furono quei brevi minuti, ma la fusione perfetta che seppero creare i loro corpi, tutto il resto aveva cessato di esistere, spazio e tempo avevano contorni sfumati,c’eranosololoro due al mondo. Ci furono attimi in cui la mente infervorata di Budai fu tentatadaunadomanda: se tutto quel che gli era successo finora era il prezzo da pagare per questo incontro, non ne eraforsevalsalapena? E a quel punto, come epilogo,tornòlaluce,ela lampadasulcomodinosi riaccese. Dopo la lunga oscurità quella debole lampadina li abbagliò: la donnastrizzògliocchi,si voltòefusubitoinpiedi. Certo, se c’era la corrente, anche l’ascensoreavevaripreso afunzionareeleidoveva tornare in servizio. Si rivestì in fretta, accendendosi un’altra sigaretta. Budai, ancora sul letto, la osservò avidamente mentre si infilava le minuscole mutandine,elecalze,esi allacciava il reggicalze – ora era così innamorato di lei, la guardava estasiato con la tremenda e felice consapevolezza di non poter più vivere senza di lei. Avrebbe desiderato farleunregalo,oalmeno offrirle qualcosa, ma in camera non aveva nient’altro che poche fette di un salame scadente e una crosta di paneseccosuldavanzale dellafinestra.Laragazza non accettò niente, si aggiustò rapidamente i capelli, si passò il rossetto sulle labbra, si lisciò l’uniforme blu e lo salutò. Si accordarono a parole e a gesti che l’indomani lei sarebbe tornata a trovarlo alla stessa ora... Lasciò la sigaretta accesa sul bordodelportacenere,la stanza era satura di fumo,maBudainonaprì lafinestra,nemmenopiù tardi. Il mattino dopo, quando si svegliò, il suo primo pensiero fu contarequantomancava all’appuntamento di quella sera. Stavolta intendeva accoglierla come si deve, e scese a fare la spesa. Aveva un po’ di soldi in tasca, nei giorni precedenti aveva lavorato parecchio al mercato; passò l’intera mattinata in coda nei negozi di alimentari. Comprò formaggio, arrosto freddo, pesce marinato, uova sode, insalata, pane fresco, burro, pasticcini, e due bottiglie di quella bevanda alcolica che si trovava dappertutto, non potendo offrire alla suaospitenéuntènéun caffè. Quando ritornò, vide che avevano fatto le pulizie,apertolafinestra perdareariaallastanzae cambiatolelenzuola.Era di nuovo venerdì, un’altra settimana era trascorsa; la terza da quando era arrivato – a lui, naturalmente, sembrava un tempo molto più lungo. Ci sarebbe stato un nuovo conto nella sua casella, magari sommato al precedente?... Aveva ancora parecchie ore da aspettare: la sera prima Bebe era venuta piuttosto tardi a bussare alla sua porta, intorno a mezzanotte, ma senza orologio non poteva esserne certo. Era così impaziente che non riusciva a star seduto: uscì di nuovo, col pretesto di andare a cercare un regalo per la suabella. In ascensore non l’aveva vista: non era di servizio quel giorno? Forsecominciavadopo,o magari era il suo giorno libero e sarebbe venuta solo la sera, per lui? Alla reception non c’era niente nella casella 921, forsenelpomeriggio...Si avventuròperlestradine dietro l’albergo, dove non era stato quasi mai. Meditava su che cosa comprarle come ricordo: un braccialetto, una collana, un gingillo? Oppure un portasigarette, un accendino? In ogni caso, qualcosa che potesse tenere sempre con sé, su disé. Poco lontano, con sua grande sorpresa, scoprì una pista di pattinaggio su ghiaccio. Era uno spazio piuttosto piccolo, qualche metro sotto il livello della piazza circostante, e si poteva guardare dall’alto, come facevano in molti dalle ringhiere. La pista era gremita di pattinatori che,curiosamente,erano quasi tutti anziani: attempate signore sovrappeso o rinsecchite e signori calvi e panciuti che scivolavano, volteggiavano e piroettavano al suono di una musica lenta. Era un’immagine così surreale: flirtavano e si tenevano a braccetto, alcuni muovevano passi di danza in mezzo alla folla:Budainonproseguì per la sua strada, si fermò ad ascoltare la musica e ad ammirare quella popolosa corrente che fluiva in cerchio sul ghiaccio, tutti quei vecchi che barcollavano con grazia, e pian piano cominciò anche lui a dondolare a tempo di valzer... Si rese conto di essersi lasciato sfuggire l’occasione migliore che gli fosse mai capitata; quella notte aveva finalmente avuto l’opportunità e tutto il tempo per farsi capire e per chiedere di essere accompagnato – ma dove? a una stazione? all’aeroporto? all’ambasciata?, che importava dove, bastava che riuscisse a ripartire verso qualsiasi luogo conosciuto. Certo, a sollevare l’argomento proprio con Etete, e proprio in quella circostanza, non si sarebbe mostrato molto sensibile, considerato comeavevareagitodopo il breve accenno su al diciottesimopiano,eche era venuta a trovarlo in camera sua in seguito a quell’episodio... Quella sera, però, in un modo o nell’altro, doveva spiegarglielo, vincere la sua resistenza con tenerezza e intelligenza, non poteva più rimandare! In tutto ciò la cosa più assurdaerachel’avrebbe aiutato ad andarsene proprio l’unica persona che lo tratteneva lì. In effetti, al momento non aveva le idee molto chiare: voleva andarsene oppure no? Cercò di rifletterci ma non riusciva a ragionare, era troppo preso dall’emozione dell’attesa... Per dare un taglio a queste vane elucubrazioni,deciseche avrebbechiestoaDededi condurlo, questa era la cosa più importante, e poi, una volta imparata la strada, avrebbe scelto con calma il momento giustoperpartire. Nel frattempo era divorato dall’impazienza: e se avesse capito male e lei fosse arrivata prima? Magari era addirittura già passata. Tornò di corsa in albergo, le avrebbe comprato qualcosa lì, nei negozi della hall. Prima, però, voleva fare un salto in camera, e quindi, come tutte le altre volte, si mise in coda per la chiave. Ma quando arrivò al bancone e, come d’abitudine, mostrò il foglietto con il numero 921, il portiere si voltò a guardare, poi allargò le braccia per fargli capire che non c’era. E davvero la chiave non era lì: la casella era vuota e la chiave non era appesa al gancio. Una cosa simile non era mai accaduta – l’avevano forse messa per sbaglio in un’altra casella?Ol’avevapresail personale per le pulizie? Sarebbe stata la prima volta, e comunque quel giorno erano già venuti. Nonsiarreseemostròdi nuovoilpezzettodicarta al portiere dai capelli grigi in uniforme scura, che gli sembrava una faccia nota. Certo, di portieri ne aveva visti talmentetanticheormai glisiconfondevanonella memoria.Esefossestato quellocheeradiservizio la primissima sera, quandol’autobusl’aveva portato in città dall’aeroporto e l’aveva scaricato davanti all’albergo? Chiunque fosse, trattò Budai con una certa freddezza, e scosse la testa borbottando,comeadire che non poteva farci nulla. Di fronte all’insistenza di Budai tirò fuori un grosso registro, lo sfogliò, cercò un rigo, annuì e picchiandoci sopra con l’indice glielo mostrò – come se servisse a qualcosa! –, poi richiuse di scatto il librone e passò a occuparsi del cliente successivo, il quale scalpitava, avendo osservato con malcelata irritazione la lunga disputa. A quel punto Budai, perplesso e in preda a uno sgradevole presentimento, salì al nono piano e proseguì nei corridoi verso la sua stanza. La porta era chiusa ma appoggiò con cautela l’orecchio e gli sembrò di sentire dei rumori. Dopo esser rimastolàdavantiperun po’,nonsapendochefare bussò e poi aprì leggermente la porta. Nello spiraglio apparve una donna di mezz’età con un fazzoletto in testa, che lo guardò e richiusesubitolaporta... Budai controllò il numero della stanza, casomai avesse sbagliato; no, era la sua, la 921. L’avevano data a qualcun altro. E quella mattina avevano cambiato le lenzuola per loro. In quell’istante fu solo un dettaglio a preoccuparlo: che ne era statodellesuecose.Quel po’ di biancheria che aveva, e la borsa di tela, l’unico bagaglio con cui era arrivato in quella città... Bussò nuovamente, ma stavolta non risposero, e quando abbassò la manigliarisultòchiusaa chiave. Non si scoraggiò e cominciò a tempestare la porta di calci e pugni finché non riaprirono. Apparveunuomosmilzo dalla faccia giallastra e coperta di macchie, in camicia e bretelle, inviperito, che si mise a strillareconvoceacutae femminea e stava per richiudere d’un colpo la porta quando Budai infilò il piede e si spinse dentroaforza. La prima cosa che lo colpìful’odore,unodore greve e penetrante aleggiava nell’aria. Poi il numero di persone che aveva invaso quella stanza minuscola: oltre ai due già menzionati c’era una vecchia in un angolo che borbottava qualcosa, sembrava una preghiera,edeibambini, quattro, cinque o sei – non riuscì a veder bene nella penombra, la tapparella era abbassata a metà –, alcuni dormivano sul letto, accantounacarrozzina,e sultavoloeraappoggiato un porte-enfant di vimini. Come se non bastasse, due gatti spelacchiati e spaventosamente grassi, dal sudicio pelo tigrato, correvano qua e là, saltando dal davanzale della finestra alle sedie e in cima all’armadio. E coniglid’angorachiusiin gabbie, come quelli che aveva già visto, il tanfo doveva venire da lì: inconcepibile che in un albergo si tollerassero cose del genere... Per il resto, avevano cambiato tutta la disposizione dei mobili, non sembrava nemmeno la stessa stanza: il letto era stato spinto contro l’altra parete, l’abat-jour era privo di paralume, al centro c’era un recinto per bambini, biancheria stesa ad asciugare sulle spalliere delle sedie, e carabattoled’ognigenere sparseovunque:coperte, pacchi, biberon, vasi da notte. I nuovi occupanti si misero a inveire contro di lui, con voci querule e chioccianti, tentando di spingerlo fuori. Budai cercò con lo sguardo le suecose,mainvano,non vide i suoi vestiti, né il pigiama, né la borsa, né gli appunti lasciati sulla scrivania. Diede un’occhiata anche nel bagno, i suoi articoli da toilette erano spariti, e ora sopra la vasca c’erano dei fili carichi di pannolini e mutandine appena lavati. A quel punto si lasciò sbattere fuori, persino i bambini lo spingevano strillando; làdentro,nonpotevapiù tornarci. Non ne aveva neanchevoglia,nonsela sentiva di disturbare o far cacciare quella famiglia evidentemente bisognosa. Se li avevano sistemati lì, non li avrebbero mandati via perfareunfavorealui. E va bene, ma adesso dove avrebbe alloggiato? In preda alla disperazione tornò a cercare Epepe agli ascensori, ma non c’era. Scese di nuovo al pianterreno,sifecelargo attraverso la folla che riempiva la hall, si sorbì la coda per arrivare alla reception: tentò di spiegare il suo problema e, indicando le chiavi appese, insisteva per farsi dare un’altra stanza. Ma il portiere si stancòdellesuelagnanze e richieste, oltre che di doversi occupare così a lungo della stessa persona, e tagliò corto passando al cliente successivo.InvanoBudai si ostinò, il portiere continuavaaignorarlo. A quel punto provò a rivolgersi altrove, ai banchi dedicati ad altri servizi indicati da altrettante targhette. Purtroppo non ottenne risultati migliori, perché le impiegate che vi lavoravano, non afferrando quel che diceva, dopo un po’ smettevano di ascoltarlo e lo piantavano in asso. Ritornò dunque alla reception, e dopo un’altrafilachelomisea dura prova nel corpo e nello spirito, stavolta si sforzò di far capire che, se era diventato una persona tanto sgradita, almeno gli restituissero il bagaglio, e lui si sarebbe cercato un alloggio altrove; e soprattutto il passaporto, altrimenti non lo avrebbero accettato da nessuna parte. Sorprendentemente, il portiere sembrò afferrarelaquestione,gli chiese il foglietto con il numero della stanza e tirò fuori una voluminosa cartella. Vi rovistò dentro, poi gli sventolò davanti al naso due documenti pinzati conunagraffetta,listese sul bancone, e con un tono pedante, da predicozzo, blaterò qualcosadeltipo: «Tuluplubru klött apalapala groz paratléba... Klött, klött, klött...!». Budai capì l’espressione klött, che secondo le sue osservazioni equivaleva all’allocutivo «lei», «signore»;invecegroz,se non si ingannava, era il numerale 2. Esaminò i pezzi di carta sul bancone: riconobbe subito il primo, si trattava della copia carbone del conto del venerdì precedente che non aveva ancora saldato. L’altro era un modulo uguale, con caselle e scritte simili, solo il totale differiva di poco – stavolta era minore, 31,20 –, e doveva essere quello dell’ultimasettimana. Sulla base di tutto questo, le parole appena udite potevano voler dire, pressappoco: «Prima deve pagare questi due conti, lei, sì, dicopropriolei!...».E,nei fatti, significava che trattenevano bagaglio e passaporto per restituirglieli quando avesse saldato – sempre cheilportierenonavesse dettotutt’altro. Budai, naturalmente, non aveva tutti quei soldi,ildenarocheaveva in tasca non ci si avvicinava neanche; dopo le spese mattutine, gli era rimasta una manciata di spiccioli. Gli venne in mente all’improvviso che avrebbe perso anche l’incontro fissato con Devebe per quella sera. Eccociòcheloagitavain quelmomento:ladonna, convinta di passare la serata insieme a lui, bussava alla 921 e restava inorridita alla vistadeinuovioccupanti della stanza. E non poteva neppure lasciarle un messaggio... Era un pensiero insopportabile, lofacevausciredisenno, era la cosa che lo addoloravapiùdituttoil resto: si sentì montare il sangue alla testa, gli si offuscò la ragione, gli venne voglia di spaccare tutto, di picchiare, di uccidere. Ormai non gli importava più di niente, in un accesso di collera cominciò a pestare i piedi, a ruggire, a sbraitare, e pur sapendo che nessuno l’avrebbe capito, esplose, gridando la sua incontenibile indignazione nella sua lingua: «Che porcheria... questaèlapeggioredelle porcherie! Siete dei farabutti, dal primo all’ultimo...deglisporchi farabutti,porci!». Scoppiò uno scandalo, unparapiglia,eattornoa luisiformòuncerchiodi curiosi. Arrivò il grasso usciere in pelliccia e berretto col nastro dorato–dovevanoaverlo chiamato dall’ingresso –, lo afferrò per un braccio e lo trascinò attraverso l’atrio gremito di persone. Quando giunsero alla porta, l’usciere la fece girare e gli indicò di levarsi di torno. Siccome Budai nonsimuoveva,conuno spintoneloscaraventòin strada, e da dietro gli assestò forse anche una pedata. Come paralizzato, stordito, Budai brancolò a lungo sul marciapiede. Poitornòinséqueltanto che bastava per rimettersi in sesto. Gli eravolatoviailcappello, lo ritrovò, il cappotto si era aperto e si erano staccati due bottoni, la manica si era scucita. Non riusciva a pensare a niente, si lasciò trascinare dalla folla. Si ritrovò alla pista di pattinaggio che aveva scoperto nel pomeriggio: stavascendendolaserae i lampioni ad arco erano accesi, i pattinatori giravano in tondo sotto una luce forte, eccessiva come il volume della musica... Poi passò vicino al grattacielo, e neanche stavolta poté trattenersi dal contare i piani: erano arrivati al settantacinquesimo, era cresciutoditrepiani. Dappertutto vide sporcizia e rifiuti: era sempre stato così e lui nonsen’eramaiaccorto? Inquelmomentoilvento turbinava e sollevava l’immondizia tutto intorno; doveva aver travolto anche un chiosco di giornali, sulla carreggiatasvolazzavano migliaia di fogli di giornale... Fu colpito dallaquantitàdianziani: zoppi, invalidi, paraplegici avanzavano claudicando con i loro bastoni, fra ondate di folla che si abbattevano sulle loro teste sommergendoli e stritolandoli. Fragili vecchine simili a uccelli malati e spauriti si muovevano in quell’ambiente ostile trascinando i loro corpi gracili, tentavano di attraversare la strada o di salire sugli autobus carichi di passeggeri, perennemente spintonate e schiacciate nella calca: che cosa mai le tratteneva lì? Perché nonandavanoaviverein paesaggi più ameni, in ambienti e località più ospitali? O forse non avevano nessun altro posto dove andare?... Poi c’erano degli strani dementi pieni di tic che gesticolavanoefacevano smorfie, che parlavano e borbottavano da soli, e altri che vagavano per le stradedandoinsmaniee lanciandourlatremende, pazzi che correvano minacciando i passanti conuncoltelloedaiquali era meglio scappare. E, ancora, mendicanti che balbettavano scuotendo il barattolo delle elemosine, idioti farfuglianti, paralitici e mutilati, minorati che strisciavano gattoni – e tutti quanti avevano voglia di vivere, raggomitolati e pressati l’uno sull’altro, spalmati ovunque per la città, ingombrandoogniluogo con le loro innumerevoli vite... Un pensiero errante si infilò nella mente di Budai: e se l’avessero cacciato dall’albergo a causadiBebe?Nonperil conto non pagato, no, tutt’altro: avevano scoperto la loro relazione, dopo che la donna era stata da lui. Erano inflessibili, non tanto per un divieto morale o religioso, o perché fosse inaccettabile un rapportoconiclienti,no, c’era una ragione più profonda ed estremamente pratica: dalla loro unione amorosa sarebbe potuto nascere un bambino, un nuovoessereumanoche avrebbe contribuito alla crescita di una popolazione esorbitante... Forse era colpevole del reato più grave ai danni della società, il tentativo di incrementodelladensità demografica? Era buio; nel cielo apparvero delle luci, bianche, rosse, viola e verdi. Luci fisse, lampeggianti, rotanti, fluttuanti, tremule, scintillanti, che passavano lentamente o guizzavano via all’improvviso, che si accendevano senza ragione e altrettanto misteriosamente si spegnevano. Che cos’erano? Stelle? Aerei? Luci di segnalazione per gliaereiincimaatorrie grattacieli? Razzi, astronavi?... Ma ora non ce la faceva a pensarci, ormai era sera e questo gli ricordò che si avvicinava l’ora dell’appuntamento con Petebe; ritornò dunque dicorsainalbergo. Mal’usciere,chefinora lo aveva sempre accolto garbatamente accennando il saluto militare e aprendogli la porta, stavolta, non appenalovide,glisiparò davanti sbarrandogli il passaggio con la sua mole imponente. Cosicché non era un pupazzo o un robot, come Budai aveva sospettato all’inizio: l’aveva riconosciuto, si ricordavadellasuafaccia e dello scandalo di quel pomeriggio. Eppure anche adesso, mentre alzava il braccio per bloccarlo, i suoi gesti erano rigidi e meccanici, la faccia stupida e inespressiva, con gli occhietti strizzati, come quandoloaccoglievacon cortesia. Budai si limitò a farsi da parte, senza allontanarsi troppo. Dove sarebbe potuto andare? Per quanto il comportamento di quell’idiota obeso lo umiliasse, non aveva altra scelta o possibilità se non riprovarci. Escogitòunpiano:attese che arrivasse un gruppo abbastanza numeroso di persone e che l’usciere aprisse loro la porta salutandoli con due dita alla visiera. Con circospezione si intrufolòinmezzoaloro, come se facesse parte dellacompagnia.Manon riuscì a eludere la vigilanza dell’uomo: costui fece passare tutti glialtri,maquandofula voltadiBudaisifrappose conlamassaenormedel suocorpo.Enessunaltro tentativo ebbe successo: l’usciere era sempre all’erta.Laterzaoquarta volta si lanciò verso la porta con tale violenza che finirono uno contro l’altro, e poiché nessuno dei due cedeva, ingaggiarono una vera e propria colluttazione. Budai non era un tipo gracile, credeva di poter avere ragione di quell’ammasso di lardo. Solo che questi si rivelò sorprendentemente tenace, e inoltre aveva il vantaggio di puntarsi contro lo stipite della porta.Nessunoriuscivaa prevalere sull’altro, tenevano entrambi la posizione senza muoversi di un centimetro. In pratica questo significava la sconfittadiBudai,poiché era lui a voler passare la soglia; alla fine fu costretto a battere in ritirata. Però l’albergo non aveva altri ingressi? Magari anche Tjetje passava dall’entrata riservata al personale. Si avviò e svoltò al primo angolo: se avesse esplorato con attenzione tutto l’isolato l’avrebbe trovata per forza. Sì, ma l’hotel era stretto fra edifici di varie dimensioni, a destra e a sinistra e, a quanto sembrava, anche da dietro, e le vie erano tortuose e lo allontanavano dalla direzione che voleva prendere,epocopiùinlà dei lavori stradali gli impedirono di passare. In breve era già disorientato, era partito per fare il giro dell’albergo e forse era finito da tutt’altra parte... A un tratto si ritrovò presso la pista di pattinaggio: era già la terza volta in quella giornata. Stavano per chiudere, o meglio, era loro intenzione, ma i pattinatorinonvolevano andarsene. I dipendenti li spingevano verso le scale con l’aiuto dei larghi spazzoloni che usavano per pulire il ghiaccio, ma la gente sciamava nuovamente indietro infilandosi fra unoel’altro,constrillae risate trionfanti, invadendo di nuovo la pista, e così bisognava ricominciaredacapo. Era una scena divertente, e Budai sarebbe rimasto volentieri a guardarla, ma l’inquietudine lo attanagliava: chissà, mentre lui indugiava lì, magari Deded stava varcando l’ingresso principale!... Aveva anche fame, non mangiava niente dal mattino – che fine avevano fatto i sacchetti pienidiciboperlaserata che aveva messo sul davanzale della finestra? Quando era entrato di forza nella stanza 921 si era dimenticato di prenderli, e ora lo rimpiangeva amaramente.Lafamiglia numerosa si era mangiata tutta quella roba? Oppure l’avevano divorataiduegattacci? Se fosse andato a comprare qualcosa alla tavola calda o in un negozio, avrebbe perso altro tempo in code, e temeva di mancare l’arrivo della donna. Preferì ignorare i morsi della fame e tornare sui suoi passi fino all’ingresso principale dell’albergo. In quel momento,daunagrande automobile nera stava scendendoladelegazione sacerdotale dall’aspetto esotico che aveva ammiratogiàaltrevolte. L’usciere si tolse il berretto e fece un inchino in segno di riverenza al passaggio dei vegliardi barbuti col cappuccio viola e le catene d’oro al collo. Budaiprovòamescolarsi anche a loro, contando su un momentaneo calo dell’attenzione da parte del grassone imbecille. Ma questi lo vide comunque,lobloccòelo respinse: era impossibile raggirarlo. Ma quell’usciere era sempre in servizio? A guardarlo meglio, Budai non era più sicuro che fosse lo stesso di prima. Se anche fosse stato un altro, però, assomigliava in maniera impressionante a quello precedente, non solo per la pelliccia e il berretto piatto col nastro dorato, maancheperquelmodo di sbattere le palpebre e strizzare gli occhi come un ebete, per la faccia gonfia e insignificante, per lo sguardo vacuo e stolidodatroglodita. Passò il tempo, forse ore,enonaccaddenulla, tranne che a un certo punto cominciò a piovere; Budai si riparò sotto la tettoia dell’ingresso. L’usciere non sembrò infastidito, non gli badava neppure. Ebede però non arrivò, non si fece viva: c’era ancora qualche remota speranza che venisse?... Se la sua ipotesi era giusta, cioè che lui era sgraditoall’albergoperla loro relazione, lo stesso doveva valere per la sua partner, sua complice! Era possibile che anche lei fosse stata cacciata, ossia licenziata dal suo posto di ascensorista? Se le cose stavano così, poteva rimanere lì ad aspettarla finché voleva, tantoerainutile. Moriva di fame, era esausto, estenuato dalle preoccupazioni e dagli avanti e indietro di quella giornata, aveva la testa vuota; non si reggeva più in piedi, e si appoggiò contro un muro. Però si sforzò di riscuotersi: che poteva fare? C’era qualcosa che non aveva ancora tentato? Ecco, avrebbe potuto distogliere l’attenzione dell’usciere. Come fanno i bambini, quando indicano alle spalledelloroavversario per farlo voltare, oppure lanciano un oggetto. Ma con quale stratagemma avrebbe potuto distrarre l’inavvicinabile piantone? Non sarebbe bastato gettargli ai piedi un oggetto insignificante, come un sassolino o un pezzetto di carta appallottolato: quel tizio era troppo sospettoso per cadere in un tranello così banale... Doveva sacrificare qualcosa,esseredisposto a rischiare, questo l’aveva ormai imparato: in quella città non si otteneva nulla gratuitamente! Sospirando amaramente, afferrò dunquelemonetechegli restavano in tasca, e in un momento di relativa calma, quando non passavanessuno,conun gesto morbido del braccio le lanciò sul marciapiede davanti all’usciere. Gli spiccioli caddero sul selciato con un tintinnio squillante e senzaspargersitroppoin giro. Le sue previsioni si rivelaronoesatte:l’uomo aguzzò le orecchie e si chinò a guardare. Era quello il momento che Budai aspettava per passargli velocemente accanto, o meglio alle spalle, e introdursi nell’edificio senza essere notato. Era quasi arrivato alla porta, e si sentiva già dentro, quando un folto gruppocominciòauscire – perché si entrava e si uscivadallastessaporta, una soluzione piuttosto singolare e tutt’altro che pratica per un albergo frequentato come quello... Erano tanti giovanotti, alti e longilinei, alcuni di pelle scura, con una tuta da ginnastica rosso vivo, che vociavano in maniera inintelligibile, ridendo e scherzando: dovevano essere degli atleti, come quelli che aveva visto nell’enorme stadio. Procedevano compatti uno dietro l’altro, era impossibile muoversi in direzione contraria per entrare, e quando furono usciti tutti, saranno stati venti o venticinque, il corpulentocerberostava di nuovo all’erta, vigile come un cane da guardia. Allora Budai, stizzito e deluso, iniziò a raccoglierelemoneteper tentare di nuovo il trucco. Ma l’usciere posò il suo enorme scarpone proprio dove ne erano cadute di più, e Budai potéprenderesoloquelle sparse intorno. Credeva che il tizio stesse scherzando, ma provò inutilmente a spostargli il piede, lo esortò a toglierlo da lì, ma quello non si muoveva. La rabbiadiBudaisiscatenò contro quell’imbecille: radunòlaforzadicuiera capace e gli sferrò un calcio alla caviglia. Per tutta risposta l’usciere soffiò forte in un fischiettoeluiseladiede agambe. All’angolo successivo, dove si fermò brevemente per riprenderefiato,sichiese perché si fosse spaventato così tanto. Il suono del fischietto doveva avergli ricordato la sua disavventura con la polizia, e non aveva nessuna voglia di cacciarsi in situazioni simili; ed era anche plausibile che, vistosi aggredito, quell’idiota avesse fischiato per chiamare un poliziotto. Comunque fossero andate le cose, fu soddisfatto di avergli mollatounbelcalcio,era il minimo che si meritasse, e almeno lui aveva potuto sfogare la sua collera... Aveva un sonno tremendo, si sentiva malfermo sulle gambe,eraaffamatoegli sembrava un’impresa disperata riuscire a varcare la soglia dell’albergoquellasera.E seanchecifosseriuscito, nonavrebbemairiavuto la sua stanza né gliene avrebbero data un’altra per riposare. Si sarebbe dovuto aggirare per i corridoi o sedersi nell’atrio. Trovò aperta l’abituale tavolacalda,dovedivorò in fretta un paio di sandwich. E adesso? Che fare,doveandare?Finoa quel giorno aveva avuto un minimo di agio, un buco dignitoso dove rintanarsi, e lavarsi, riposarsi, rimettersi in ordine. Ma adesso, senza le sue cose, e dopo aver perduto buona parte dei suoi ultimi soldi sotto la suola dell’usciere, dove poteva andare? Se pure avessescovatounhotel– sebbene in quell’istante non sapeva nemmeno dove cercarlo – non l’avrebberomaiaccettato senza passaporto e documenti. E Djedje, come avrebbe fatto a rivedereEdjedje? La pioggia non cessava; in breve si ritrovò bagnato fradicio: cappello, cappotto, scarpe. Si ritrovò alla stazione della metropolitana, guidato forse dal suo istinto, e scese di corsa per ripararsi dall’acquazzone. Era la stradachefacevasempre per andare a scaricare al mercato. Quando fu ai binari, più per abitudine che altro, salì sul treno diretto là, era troppo debole e intontito per pensareaun’altraidea. Al mercato coperto, lo scarico delle merci sulla rampa laterale si svolgeva anche di notte. Ma stavolta Budai non intendeva lavorare, voleva solo un giaciglio per sdraiarsi, un riparo, proprio come i vagabondi che si rannicchiavano in un angolodopoillavoroole bevuteinosteria...Trovò presto un cantuccio relativamente comodo. Sul fondo, alla fine della rampa,doveilviavaiera minore, dietro a una gran catasta di casse vuote c’era lo spazio sufficiente per una persona, e non l’avrebbe visto nessuno. Sul pavimento di cemento erano stati gettati alcuni vecchi sacchi: l’angolino dovevaesseregiàservito aqualcuno.Sisdraiòcosì com’era, con gli abiti zuppi addosso, si coprì con il cappotto fradicio che sapeva di pioggia, radunòunmucchiettodi stracci sotto la testa, vincendo l’istintivo ribrezzo per quelle condizioni prive di ogni igiene. Era esausto, non ebbeneancheiltempodi girarsi che cadde in un sonnoprofondo. Si svegliò con il corpo bollente, battendo i denti; non del tutto, però,rimaseinunostato di dormiveglia. Era buio, dafuorifiltravanoleluci artificiali, i rumori dello scarico, il rombo dei camion, il cigolio del nastro trasportatore, non sapeva dire però se era la stessa notte o quella successiva. Aveva la febbre alta, senza dubbio: doveva aver preso un raffreddore, oppure un’influenza, tutte quelle ore ad aspettare fuori dall’albergo sotto la pioggia. Tremava di freddo, forse aveva la polmonite. Non era mai caduto così in basso da quando era arrivato lì. Era completamente abbandonato, senza un medico e senza farmaci: in quello stato non ce l’avrebbefattaneppurea trascinarsi fino alla clinica dove gli avevano cavatoildente.Nascosto in quell’angolo nessuno l’avrebbe aiutato, certo, maalmenololasciavano inpace,ederaquelloche desiderava: come un animale voleva solo rintanarsi, lui e i suoi mali. Si ripiegò su sé stesso, i suoi pensieri erravano stentati sul fondo della coscienza. Eraprostratonelcorpoe nello spirito, madido di sudore, divorato dalla febbre. In quella condizione vegetativa le sue funzioni vitali e fisiologicheeranoridotte al minimo, e non era un male, non potendo soddisfarle. Non aveva fame, ma non avrebbe saputo come procurarsi del cibo. Un tè gli avrebbe dato sollievo, si sentivalagolaseccaeun cattivo sapore in bocca, ma non era in grado di trovarlo, e allora meglio non pensarci... Aveva anchealtribisognimolto meno gradevoli, e ormai impellenti. Quando veniva a lavorare, aveva scoperto che dietro al mercatoc’eraunalatrina sudicia, tuttavia alcuni preferivano usare il muro esterno dell’edificio, insozzandolo.Madoveva alzarsi e arrivarci, ed era un’impresa al di sopra delle sue forze. Però non voleva farsela addosso, non avrebbe mai potuto: una cosa del genere, finché avesse avuto un barlume di lucidità, era impensabile. Solopersollevarsiebbe bisogno di una lunga preparazione: per interi quarti d’ora si spronò ad alzarsi, ma poi rinunciava, sconfitto. Dopo essersi dato più volte la spinta, lentamente si drizzò a sedere ma ebbe un tale capogiro che dovette coricarsi di nuovo, e svenne,sprofondandoin una nebbia rosso scuro. Quando tornò in sé, ricominciò, penando e imprecando: non poteva accettareilfallimento.Se si fosse arreso ora, si disse,eratuttoperduto. Decise di alzarsi, a costo di sputare l’anima, maledisse la propria debolezza, e alla fine riuscì a tirarsi in piedi, e se ci riuscì fu solo grazie alla sua ostinazione. Avanzòafatica,tastando il muro come un cieco, lottando per ogni metro e sentendosi mancare a ogni passo: in quei momenti per non cadere aterrasireggevaaquello che trovava. Era costretto a fermarsi, appoggiato a una balla o a una cassa, e dopo qualche minuto era in grado di proseguire. Per quel breve tragitto di andata e ritorno gli ci vollepiùdiun’ora,ealla fine era completamente stremato: quando crollò di nuovo sul suo misero giaciglio aveva consumatoognienergia. Si dibatté in un dormiveglia confuso, al confine tra sogno e coscienza: i due piani si mescolavano e a volte si fondevano, indistinguibili. All’improvviso gli parve divederedeirattichegli passavanosuipiedi,elui nonneavevapaura.Maa posteriori non riuscì a capire se fosse successo davvero, il che non era affatto improbabile in quel luogo, o fosse stato solo uno scherzo della suaimmaginazione.Fece moltisogni,ancheperla febbre.Sognòvarievolte che incontrava finalmentequalcunocon cui parlare, cambiavano solo la persona, l’occasione, le circostanze. L’uomo che compariva più spesso e in diverse situazioni era l’ungherese in loden incontrato in metrò. Poi faceva a botte con il grasso usciere dell’albergo, e scivolava sul ghiaccio coi pattinatori, ogni tanto ruzzolando goffamente. E viaggiava in aereo, in treno, in nave, e andava addirittura a cavallo, anche se non aveva mai praticato questo sport: trottava su un terreno umido e sabbioso, lasciandosi dietro una lungafiladiimpronte. E gli avvenimenti più recenti vissuti in quella città si mescolavano con i ricordi di casa sua. A questopunto,qualunque ricerca sarebbe stata inutile, non l’avrebbero più trovato, ormai non aveva un alloggio, un recapito, era diventato un vagabondo senza dimora: chi avrebbe potuto sapere dove si trovava?... La sua disgraziavistaattraverso occhi altrui, ecco l’unica cosa per la quale ancora sicommuoveva–simise perfino a piangere, tutto solo, nascosto dietro alle casse, sul cumulo di vecchi sacchi. Quel destino sarebbe stato un po’piùtollerabilesenon avesse avuto la famiglia, illavoro,gliamici,ilsuo cane. Gli mancava soprattutto sua moglie, com’era naturale, era questo il sentimento più forte e profondo; aveva vissuto così a lungo al suo fianco, lei era come una parte del suo io, e il pensiero della sua sofferenza gli dava un dolore insopportabile. Se avesse potuto, avrebbe chiesto a un chirurgo di tagliargli via quel pezzo dicuore. No,nondovevastarelì a compiangersi, gli era chiaro anche tra i fumi della febbre. Commiserarsi non serviva a nulla, anche perché, al di fuori di lui stesso, nessuno si sarebbe dispiaciuto per lui: era solo uno svantaggio, un intralcio ulteriore... E per forza di cose arrivò pure a considerarelapossibilità più estrema, quella che in sostanza giaceva in fondo a ogni suo pensiero. In quelle condizioni non avrebbe dovuto fare quasi nulla, forse solo lasciarsi andare, farsi scivolare fraleditaqueltenuefilo a cui ancora si aggrappavaegiàsarebbe sprofondato nella beatitudinedelnulla:per lui al momento era davvero la scelta più facile... Ma la rimandò, e rimandò anche il momento in cui ci avrebbe riflettuto seriamente: c’era tempo per pensarci, quest’ultima via d’uscita sarebbe sempre stata disponibile. Ora quell’idea gli ripugnava, non tanto in sé stessa, quanto perché significavaunafuga,una ritirata ingloriosa. Pur nella miseria e nell’infernotorbidodella malattia, dentro di lui era rimasta una sola passione: la caparbietà. Quell’indefinibile accanirsi, quell’inspiegabile furia, quella resistenza che gli impediva di arrendersi, di uscire vinto da quella lotta.Quandostringevai dentieimprecava,anche nei momenti più strazianti della crisi, si stava battendo per mantenere vivo almeno un frammento di coscienza, per non arrendersi per nessuna ragione al mondo a quella insensata oscurità. Era una specie di puntiglio, di senso dell’onore, di assurda e forse ridicola fedeltà ai suoi propositi, o di alleanza con sé stesso, dato che non poteva contaresunessunaltro. Poi gli apparve in sogno anche Pepe, in situazioni diverse ma sempre cariche di angosciaesensodicolpa: non riusciva a perdonarsi di averla picchiataquellasera.Era un pensiero che lo inseguiva come un’ossessione: era per questo che la donna non si era più fatta viva? Forse in un secondo momento aveva provato rancore verso di lui?... Comunque fosse, non poteva finire così, doveva rimediare, farsi perdonare, cercare di spiegarle,dirlechesiera pentito. Tra le altre, una ragione per guarire in fretta era che bisognava tornare in albergo, cercare Bebebe: senza di lei non poteva vivere in quel luogo, e nemmeno andarsene. Non aveva la minima idea di quanto tempo avesse languito in quel misero nascondiglio, aveva perso la cognizione del tempo, confondevailgiornocon la notte. Quando si alzò per trascinarsi fino alla latrina, vide che il mercato era deserto, i chioschi, i negozi e i banchi erano chiusi, con le saracinesche abbassate, con le sbarre bloccate da lucchetti, benché ai lati dell’edificio operai, macchine e gru continuassero a lavorare con gran frastuono. Dunque era di nuovo domenica,comelaprima volta che era stato lì. E siccome era stato cacciato dall’albergo di venerdì, aveva passato duenottialmercato. Si sentiva un poco meglio, la febbre gli era calata. Per due o tre giorni ancora non lasciò il suo cantuccio, era troppodeboleperfarlo,e pian piano iniziò a riprendersi. Gli era pure tornato l’appetito, ma le uniche cose commestibilicheavevaa portata di mano erano delle mele mezze marce probabilmentecaduteda qualche cassa. Tentò di rosicchiare le parti sane, erano piuttosto disgustose, ma era comunque meglio di niente. E dopo tutto quel tempo sentì anche il bisognodilavarsi.Sialzò e vagò a lungo, in preda allevertigini,allaricerca dell’acqua, e finalmente all’angolo opposto della rampa scoprì un rubinetto. Una lunga coda di gente aspettava, provvista di gavette, bottiglieeperfinosecchi. Si unì a loro e si domandò chi potevano essere: commercianti, clienti o scaricatori a giornata? E la fila si allungava dietro di lui, cosicché quando arrivò al rubinetto ebbe soltantoiltempodibere, in mancanza di un recipiente bevve con le maniacoppa,sisciacquò la bocca e si ritrovò più in là, spinto oltre dalla mera presenza di chi gli stavaallespalle. Preferì ritornarci la sera tardi, quando i negozi erano chiusi e l’attività del mercato era limitata al carico della merce dai magazzini laterale e posteriore e allosgomberodellecasse e degli imballaggi vuoti, come sempre, giorno e notte. Stavolta c’era davvero poca gente in coda davanti al rubinetto, soltanto quattro o cinque ubriachi barcollanti, e dopo una breve attesa Budai poté restare solo e indisturbato. Il getto dell’acqua era più debole e non aveva neppure sapone, ma si prese il piacere di rinfrescarsi le mani, la faccia e il collo, mise la testa sotto il getto gelido per raffreddare la fronte sofferenteesciacquarsii capelli. Si sarebbe lavato volentieri anche le parti intime,maachesarebbe valso se poi doveva rimettersi la biancheria sporcaesudata? Col passare dei giorni si ristabilì, e siccome doveva mangiare e vivere,ripresealavorare. Per fortuna c’era sempre qualcosa da scaricare, in sostanza era lui a decidere quando e quanto lavorare, a seconda dell’umore e delle sue forze. Quando trasportavano generi alimentari, poteva sottrarne un po’, lo facevano anche i suoi compagni, nessuno riusciva a controllare: carote, cipolle, frutta, verdure crude, e a volte, quando il magazziniere era distratto, rubava dei pezzi di salsiccia e di ciccioli di maiale. E se aveva bisogno d’altro, se lo comprava subito coi soldi guadagnati, lì al mercato. La sua vita era cambiata radicalmente rispetto a prima, e una volta superata la malattia, gli sembrò ancora più tremenda e insopportabile. Le poche cose che ancora venivano da casa sua eranorimasteinalbergo, compresi i suoi articoli da toilette. Per prima cosa dovette procurarsi sapone, spazzolino da denti e dentifricio, che eranoinvenditaancheal mercato. Il dentifricio era dolce come la maggior parte dei cibi di quel luogo. Non comprò invece l’occorrente per radersi, costava troppo e servivano tante cose, lamette,rasoio,pennello, sapone o crema – e poi perché, per chi? Non era mai stato da un barbiere in quella città, non ci aveva pensato: gli era cresciutaunpo’dibarba, aveva i capelli arruffati, leunghiedimaniepiedi eranocresciuteesierano indurite. I suoi abiti si erano strappati e non aveva ago e filo, aveva persoparecchibottoni,si erano rotte le stringhe dellescarpe,ilcappottoe lagiaccasieranoscuciti, bucati e sporcati in vari punti, poiché li teneva sempre addosso, quando dormiva e lavorava. Una volta che si era un po’ allontanato dal mercato si vide riflesso in una vetrina e faticò a riconoscersi in quel vagabondo barbuto e straccione. La cosa che più lo spaventò furono gli occhi, lo sguardo sconvolto, spossato, cupo e torbido in quel volto giallo, patito ed emaciato da cavernicolo... Soffriva soprattutto di non potersi cambiare, di non avere della biancheria pulita da mettersi addosso. E ancheseavesseavutoun cambio, dove poteva lavare quella sporca, dove farla asciugare, e comunque dove tenerla? Gli articoli di abbigliamentocostavano uno sproposito, come aveva notato nelle vetrine di quei grandi magazzini di periferia che aveva scambiato per un cinema. Non gli bastavano i soldi, per racimolarli c’era da sgobbare parecchio: doveva rimandare l’acquisto. E fino ad allora non poteva fare altrochepensareallasua persona senza tener conto dei propri abiti – anzi, ancora meglio, dellasuapelle,dituttoil suocorpotrasandato. Si era inselvatichito, e ora anche la nostalgia di casa si era attenuata. Non teneva più neppure ilcontodiquantotempo era passato dal suo arrivo in città. A casa si ricordavano ancora di lui? Oppure lo avevano dato per disperso, cancellato, forse perfino rimosso? La casa, quella di un tempo, era diventata un ricordo sempre più vago e nebuloso; l’unica cosa invariata era l’imperativo di andarsene da lì. Dove e con quale mezzo non gli importava, l’essenziale eraandarevia,via,via. Non appena cominciò asentirsimeglio,preseil metrò per tornare all’albergo. Era quasi certochenonl’avrebbero lasciato entrare, e infatti così fu. Il grasso usciere in uniforme gli bloccò l’ingressoanchestavolta, alzando il braccio in segno di divieto: del resto, perché mai avrebbe dovuto fare entrare un pezzente simile, un losco figuro magari dedito all’accattonaggio o ad attività anche peggiori? O forse quell’idiota si ricordava di lui dall’ultimavolta,quando lo aveva sbattuto fuori dall’albergo e gli aveva impeditoinognimododi rientrarvi?... Ma anche Budai era più fiacco, menocombattivodiquel giorno, e si fece bastare un paio di incerti tentativi. L’usciere stava all’erta e gli sbarrava automaticamente il passaggio appena lo vedeva. E nel frattempo borbottava qualcosa sottoilsuonasocarnoso, come rivolto a lui. Budai si avvicinò per sentire meglio e gli sembrò di coglierequantosegue: «Parataciara... Kiripi laba parascera... parataciara...». Ovvero era la stessa frase che il tizio aveva detto tempo addietro allorché Budai gli aveva chiesto informazioni sui taxi; durante le sue analisi linguistiche, più tardi, l’aveva interpretata come un saluto. Si era forse sbagliato? Non era plausibile che nel respingerlo l’usciere usasse una formula di benvenuto... Oppure poteva darsi che quella locuzione avesse un doppiosignificatoechea secondadellecircostanze volessedire«Benvenuto» o «Va’ all’inferno»... Come in latino, ad esempio,l’aggettivoaltus che può significare sia «alto» che «profondo», e sacer sia «sacro» che «maledetto», il perfetto contrario l’uno dell’altro? L’albergo, visto da fuori, gli apparve come un paradiso perduto. Fu con profonda nostalgia che rievocò – anche se ormai ci riusciva solo a fatica – i giorni in cui disponeva di una stanza tutta per sé, di un letto conlenzuolaecoperte,di una scrivania, di un bagno con lavandino e doccia. E vedeva Edede tutti i giorni... Chissà se adesso si trovava là dentro e andava su e giù in ascensore, schiacciandoitasti?Sela loro relazione era stata scoperta,cometemeva,e davvero era considerata unreatograve,alloraera inutile cercarla in albergo, la ritorsione doveva aver colpito anchelei.Delresto,orasi sarebbe vergognato di farsi vedere in quelle condizioni. Le sue energie erano poche, la mente arida e spenta, quel giorno non aveva nessuna voglia di ricominciare i giochini tentati la volta precedente con il grassone. Si aggirò ancora qualche minuto intorno all’ingresso, ma la situazione non era mutatanéluifuingrado di escogitare altri stratagemmi. Al momento non era neppure certo di voler entrare a tutti i costi. Dopounpo’,senzaaverlo deciso veramente, si incamminò verso la stazione della metropolitana. Il grattacielo in costruzione era più alto di due piani dall’ultimo giornochecierapassato accanto:eranoarrivatial settantasettesimo. Tra i facchini del mercato era ormai in grado di riconoscerne qualcuno; non desiderava approfondirne la conoscenza.Ecomunque c’era un ricambio piuttosto intenso, vedeva sempre facce nuove, e lo colpiva il fatto che i neri fossero più numerosi che altrove. Verso sera, ma anche a qualunque ora, chi come lui era senza dimora veniva a cercare un posto dove coricarsi, sulle balle, su mucchi di carbone o perfino accanto al muro, spesso in evidente stato di ubriachezza. Ogni tanto unpoliziottopassavaper la rampa di carico e faceva sloggiare quelli che trovava, ma il covo di Budai non venne mai scoperto. Poi, quando la polizia se ne andava, tutti tornavano a sdraiarsi nel luogo che occupavanoprima. Dopo il lavoro, aveva iniziato a bazzicare la mescita nella via accanto. L’aveva inserita fra le sue abitudini: faceva parte della sua routine,moltopiùdiuna camicia pulita, anche perché non poteva procurarsela. Date le sue finanze fu costretto a scegliere se mettere da parte i soldi per la biancheria oppure berseli, e riflettendo a mente lucida optò per la seconda ipotesi: senza alcol la sua situazione era semplicemente intollerabile. In genere l’osteria era strapiena, sebbene servissero solo due o tre tipi di bevande. Lui non riusciva a cogliere differenzesostanzialitra di esse: il solito liquore sciropposo, dal gusto un po’ stucchevole che si trovava dappertutto e che, per sua esperienza, aveva un grado alcolico piuttosto elevato. Nel locale sudicio, dall’aria viziata, pieno di fumo e di rumore si incontrava soprattutto chi viveva intorno al mercato, scaricatori occasionali e gente della malavita, oltre ad alcune donne alcolizzate, dall’aspetto equivoco e sfiorito. Di solito gli avventori trascorrevano ore intere albanco,conilbicchiere in mano, immersi in lunghi discorsi, anche se Budai nutriva il sospetto che neppure loro si capisseroenonfacessero altro che parlare da soli tra i fumi dell’alcol. A volte la discussione trascendeva e scoppiavano improvvisi alterchi, furibonde polemiche che minacciavano di degenerare in risse. In quei casi il gestore, un nero dalle spalle larghe, con la testa rasata, in grembiule verde, accompagnava i disturbatori all’uscita, oppurelisbattevafuori. Budai si divertiva a stare a osservare quel che accadeva nella bettola, quantomeno era un modo di passare il tempo. Rimaneva lì a berefinchéglibastavano i soldi, o fino a quando nonsistordiva,isensisi ottundevano, i pensieri diventavano nebulosi, per tornarsene poi nella sua tana e crollare addormentato. Il mattino dopo si svegliava in preda ai postumi della sbornia, col mal di testa, un sapore disgustoso in boccaeunfortebruciore di stomaco; ciò nonostante la sera dopo era di nuovo là alla taverna. Isuoinerviperòerano sempre più logorati, viveva in un continuo stato di tensione, come carico di energia elettrica. A volte, era sufficiente un gesto irrilevante o anche solo l’aspetto sgradevole di qualcuno perché Budai sentisse montare una furia cieca e improvvisa: era consapevole di quanto fosse una collera inutile e assurda, eppure nonriuscivaasoffocarla. Glisiannebbiavalavista, provava un odio violento, insultava il malcapitato e lo malediceva,immaginava di picchiarlo e di prenderlo a calci, di gonfiargli la faccia di schiaffi. Un giorno al mercato, per esempio, notòunbelragazzoaltoe sottile, dalla pelle ambrata, vestito come un damerino, con delle catenelle al collo e al polso, che, a giudicare dal movimento ritmico della mandibola, stava masticandounagomma. La sola vista di quel bellimbusto dalle ossa sottili, in camicia sportiva, assorto a masticarelasuagomma, scatenò in Budai un tale accessodiirache,senon avesse temuto le conseguenze del suo gesto, l’avrebbe preso a pugniinfaccia,l’avrebbe massacrato di botte. E, ancora qualche giorno più tardi, appena il pensiero gli riandava a quel ragazzo stava male dallarabbia. A suscitare la sua colleraeranosoprattutto ivecchi,imalati,ideboli: si rendeva conto di quantociòfosseingiusto e perverso, ma non riusciva a dominarsi. Un giorno trovò occupato il suo giaciglio dietro le casse:cidormivauntizio gracile e deforme, dai capelli grigi, poco più alto di un bambino, con un paio di pantaloni di tela blu tutti macchiati. Budai si sentì montare il sangue alla testa e con il respiro strozzato agguantò e scaraventò via quell’inerme relitto umano che non tentò neppure di difendersi... Più tardi, assalito dal rimorso, partì alla ricerca dell’uomo per rimediare al suo gesto offrendogli un bicchiere, maquelloerascomparso senza lasciare traccia, come tutti gli altri che avevaincontrato. E ora, ovunque andasse, attraversava di propositolastradaconil rosso, buttava per terra l’immondizia, calpestava le aiole recintate nei parchi e in generale tendeva a infrangere quanti più divieti possibile, per un istintivo senso di ribellione: le regole e le leggi locali non lo riguardavano,quellanon era casa sua, lui era uno straniero, un nemico. E quando qualcuno lo spingeva nella calca, il chesuccedevaspesso,lui restituiva subdolamente calci e pugni, e se non ci riuscivatornavaindietro ad accanirsi sul colpevole, non si dava pace finché non si era vendicato. Danneggiava, rovinava o spaccava tutto quello che gli capitava a tiro: in un’occasione capitò davanti a una cabina telefonica isolata e strappòviailricevitore,e poi rovesciava i cassonetti fuori dai portoni per spargere in giro la spazzatura, quandoerabuiolanciava sassi contro le finestre per rompere i vetri o prendeva di mira i lampionistradali. E però non aveva smesso di perlustrare la città:partivadalmercato coperto e si avventurava in direzioni sempre nuove. Non aveva perduto la speranza di scorgere da qualche parte una stazione ferroviaria, la posta, una banca, gli uffici di una compagnia aerea, un’agenzia di viaggi, un punto informazioni, di imbattersi in un suo connazionale, come l’uomo in loden con la copia di «Színházi Élet», o in chiunque fosse in grado di scambiare qualche parola in una delle numerose lingue che conosceva... Ogni tanto tutto questo gli sembrava talmente vicino e possibile che non si sarebbe stupito che accadesse girato l’angolo. Altre volte, invece, in preda alla disperazione, era pronto a fare un compromesso: avrebbe accettato di restare lì ancora per un anno o due, ma anche cinque o dieci, a condizione di avere la certezza di tornare a casa. Voleva qualcosa da aspettare, voleva misurare i giorni, le settimane, i mesi che mancavano. Oppure da lì non c’era ritorno? Era quella l’ultima stazione, l’ultima Thule degli antichi a cui doveva approdare ovunque stesse andando, che fosseHelsinkioqualsiasi altroluogo,edoveprima o poi tutti sarebbero arrivati? Laprimaveraarrivòda un giorno all’altro. Al mattino, quando Budai aprì gli occhi, una lama di luce obliqua e tagliente penetrava nel suo rifugio. In quella cittàiltempoerasempre stato uguale, grigio e nuvoloso, e sulle prime Budai credette che fosse una lampadina, e solo a poco a poco, col cuore in festa, si rese conto che era un caldo raggio di sole. Nell’aria si respirava una specie di strana eccitazione. I cani randagi che si aggiravano sempre intorno al mercato quel mattino erano più irrequieti del solito, correvano, abbaiavano, mugolavano, guaivano, si azzuffavano per un osso. La tiepida luce del sole si spandeva sulla rampa, lo scarico delle merci era sospeso. In lontananza si udiva una musicaditamburi,piatti etrombe. Attratto dal frastuono della banda, Budai lo seguìebenprestoarrivò a un ampio viale dal qualeeragiàpassatopiù volte nel corso delle sue camminate. Adesso però era molto più affollato del solito: i marciapiedi erano invasi dai curiosi, mentre sulla carreggiata un corteo senza fine scorreva come un fiume inpiena. Eranobambini,maschi efemmine,scolariconla giacca impermeabile e altre divise variopinte, facevano roteare bacchette e volteggiare piume colorate; con la pelle bianca, gialla, nera ocaffellatte,sfilavanoin drappelli omogenei oppure misti. Alcuni a passo di danza, altri su pattini a rotelle, o facendorimbalzarepalle, agitando palloncini. E reggevano bandiere, cartelli, striscioni con scritteincomprensibili,e immaginiedisegniilcui significato sfuggiva totalmente a Budai: erano stemmi, emblemi composti di vari elementi, caricature, pecore e volpi con testa umana, uccelli, una scimmia che brandiva uno scacciamosche, una vecchiachecadevadaun albero, un grassone sul ghiacciochecedevasotto il suo peso, un neonato dal viso rugoso che veniva rapato... Che cosa raffiguravano quei disegni? Chi prendevano di mira? Poi vennero delle tamburine, una squadra di ragazze in scintillanti abiti argentati, ognuna con il suo tamburo, e trombettiericonlastessa uniforme scura dei controllori della metropolitana. E un’intera banda di vigili del fuoco, giovanotti col casco rosso seguiti a passo d’uomo dalle autopompe con a bordo il corpo al completo e la scalaeretta. Passarono uomini a cavallo,poinecroforicon gli stivaloni e i colletti neri,seguitidarombanti motociclisti che indossavano quella tuta intera che portavano in molti – Budai si domandò per l’ennesima volta che tipo di associazionepotessemai essere. E camion carichi di bambini che sventolavano bandierine strillando con le vocette acute. Dietro di loro veniva trainato su un rimorchio un gigantesco cilindro verniciato di grigio, lungo circa una quarantina di metri, alla cui vista il pubblico cominciò a mormorare, mentreBudaisichiedeva che cosa diavolo fosse: unabomba,unsiluro,un razzo, una navicella spaziale? E poi di nuovo musicisti, percussionisti con strumenti simili a xilofonievibrafoni,cori, e il flusso del corteo che ognitantorallentavaper poi ripartire. Quindi passò,dasola,unadonna di mezz’età un po’ grassoccia, con un abito giallo sgargiante e un cappello in tinta ornato di fiori, e fu accolta da uno scroscio di applausi e un gran vocio mentre procedeva sorridendo e ringraziandoadestraea sinistra. Infermiere in camice bianco spingevano paralitici e invalidisusediearotelle, alcuni malati zoppicavano reggendosi a stampelle o bastoni, e altri ancora erano trasportatiinbarella. E poi sfilarono un’infinità di categorie, una più bizzarra dell’altra: sportivi, ciclisti,sollevatoridipesi dalla muscolatura possente, acrobati, pagliacci, gente in maschera – anche se questi ultimi sembravano una componente piuttosto esiguadiquellafesta,ma forse il corteo confluiva da percorsi diversi... Il gruppo più numeroso era anche il più sconcertante:detenutiin divisa a righe, ammanettati, a testa china, scortati ai lati dalle guardie in tuta marrone, la stessa dei motociclisti. Questa strana processione sembrava senza fine, dietro agli uomini avanzavano più lentamente delle donne, sempre vestite da prigioniere, poi dei bambini, alcuni molto piccoli, ragazzini e ragazzine di otto-dieci anni, tutti in abiti da detenuto e con le manette ai polsi. Erano dei veri carcerati? Compresi i bambini? E dove li stavano portando? O era tutta una messinscena, uno scherzo, o magari una manifestazione, una dimostrazione – ma contro che cosa? Le guardieeranoarmatema ridevano allegramente, salutavano con la mano gli spettatori, e questi rispondevano. Un tramestio in lontananza preannunciò lo spettacolo successivo: stormi di uccelli svolazzavano e volteggiavano sopra il viale. Soltanto dopo un bel pezzo si vide che cos’era:uncamioncarico digabbieaccatastateuna sull’altra, che venivano aperte una dopo l’altra, liberandogliuccelli.Non erano colombe, assomigliavano piuttosto a storni, si libravano con un gran frullar d’ali, in fitti nugoli, cinguettando, fischiettando e garrendo felici per la libertà ritrovata,siposavanosui fili elettrici con strilli acuti, e poi all’improvviso spiccavano il volo verso il cielo azzurro e infinito... Questa fu l’attrazione che riscosse più successo, venne accoltaovunquedagrida di giubilo, e anche Budai l’ammirò incantato, con il cuore rapito, e attese con ansia quel che sarebbevenutodopo. Ma da quel momento in poi la sfilata cambiò aspetto. Quattro vegliardi barbuti vestiti di scuro procedevano a passolentoesolennecon ariatetra,edietrodiloro, in formazioni ormai scomposte, una quantità sterminata e schiamazzante di gente comune, un flusso colorato e turbinante, come se fosse il seguito dei vecchi saggi della città. Alla processione si unirono anche gli spettatori che erano sui marciapiedi, ingrossandola a dismisura. Budai venne trascinatodallafolla,ma si sarebbe unito comunque, spontaneamente. La moltitudine si gonfiava sempre più e scorrevaormaiquasiper inerzia, non se ne scorgevano né l’inizio né la fine, e probabilmente non era l’unico a non sapere dove stava andando e perché. Qua e là sopra le teste ondeggiavano le bandiere e i cartelli, si sentivanogridareslogan, a tratti si alzavano dei cori per cantare o declamare qualcosa. Accanto a Budai un demagogo in pullover, con la pelle scura come uno zingaro e madido di sudore, urlava in un cono di cartone contribuendo allo strepito generale. Poco oltre un gruppetto di donne sia giovani che mature ridacchiavano scherzando fra loro. Presero a stuzzicare ancheBudai,unaragazza gli fece il solletico sul collo con un ciuffo di piume colorate. A tratti ondate di rabbia attraversavano la folla comeraffichedivento. La tumultuosa e caotica marea umana sfociò in una grande piazzarotondagiàinvasa dalla folla, confluita da altre direzioni. Al centro c’eraunafontanaconun elefante di pietra: dalla proboscidedovevauscire il getto d’acqua, ma ora era spenta; la statua gli era familiare, l’aveva vista durante una delle sue prime passeggiate per la città. Sul piedistallo, appoggiato a una zanna dell’elefante, stava un giovane alto con i capelli lunghi. Indossava una camicia nera abbottonata fino al colloearringavalafolla: a giudicare dai gesti cadenzati e dalle rime che si riconoscevano nelle sue parole, stava declamando una poesia. L’assemblea lo ascoltava mormorando e ondeggiandolievemente, ogni tanto si levavano grida di approvazione, e alcuniripetevanoconlui deiversichesembravano un ritornello – ammesso che l’interpretazione di Budai fosse vicina al vero. Il ragazzo con la camicia nera si accalorava sempre più, a un tratto sferrò un pugno nell’aria e infine puntò il dito al cielo con gliocchichiusi...Quando ebbe terminato, tutti applaudirono gridando e lui saltò giù dal piedistallo. Ma al suo posto venne subitoissatounaltro,un uomo anziano smilzo e gracile, con i baffi bianchi e radi capelli grigi. Tremava visibilmente, era malfermo sulle gambe e sorretto da altri due, gli zigomi pronunciati e la fronte sporgente si arrossarono appena iniziò a leggere qualcosa da un foglio, la voce flebile si spezzava per l’emozione. La piazza ammutolì, tutti ascoltavano commossi quell’uomo che pareva godere della stima generale. E solo quando faceva una pausa e alzava lo sguardo si levavano voci di condivisa indignazione: si sarebbe detto che stavaleggendoipuntidi unprogramma,unaserie di rivendicazioni o proteste. Quel discorso davanti a un pubblico così vasto doveva turbarlo al punto che a tratti perdeva la voce, ormai non riusciva più neanche a sussurrare, tossì a più riprese in un fazzoletto, con il viso in fiamme, e alla fine lo aiutaronoascendere. Il nero bassino in gilè, bombetta e giacca a quadri che si arrampicò sulla statua dopo di lui pronunciò in tutto sei o ottoparole;conclusecon una smorfia beffarda e picchiandoilpalmodella mano sulla proboscide dell’elefante. Doveva aver detto qualcosa di moltospiritoso,perchéil pubblico esplose in una risata generale. Non volevano lasciarlo scendere, e il nero li ringraziò per l’ovazione con inchini in tutte le direzioni e nuove smorfiebuffe,chefecero ridereancheBudai,tanto comicaeralascena. Prese il suo posto un tizio occhialuto dal viso molle e glabro. Non appena cominciò a parlare fu travolto da fischi e urla di sdegno: aspettòchesicalmassero un po’ e proseguì. Probabilmente stava tentandodidarequalche spiegazione, la folla lo scherniva e cercava di zittirlo,mailtiziocongli occhiali insisteva e li invitava almeno ad ascoltare. Arrivò quasi a supplicarli, ma così non ottenne altro che di irritarli di più. Lo insultavano, lo minacciavano con i pugni alzati, gli lanciarono addosso bottiglie vuote: le sue parole vennero sommerse dal frastuono e dai fischi. Anche Budai era esasperato dall’untuosa insistenza del tizio e gridò a gola spiegata: «Tiratelo giù! Basta!... Machevuolequestoqua? Fuori dai piedi, che vada aldiavolo!». Allafinealcuniragazzi lo spinsero giù dal piedistallo e lo cacciarono: doveva considerarsifortunatodi essererimastoilleso. Seguirono molti altri oratori, tra cui la donna grassoccia col vestito giallo che Budai aveva giànotatonelcorteo.Ora reggeva un canestro pieno di distintivi o coccardeelilanciavaalla folla.Lagenteannaspava e faceva letteralmente a botte per acchiapparli; Budaieratroppolontano per prenderli, da quella distanza vide soltanto che erano degli affarini neriapallinirossiorossi a pallini neri, come le coccinelle. La donna se ne appuntò uno al petto e la folla riunita nella piazza andò in visibilio, si levarono grida di giubilo, tutti urlavano evviva,pestavanoipiedi sul selciato. E cominciarono a cantare incoro. Poi a salire sul piedistallo fu un sacerdote con la veste liturgica e la mitra, simileaquellocheaveva visto nella chiesa con la cupola. Srotolò una bandiera rossa e nera, come i distintivi, a strisce però, con al centro un uccello stilizzato ad ali aperte – uno storno? –, era grandissima,dasolonon riusciva a reggerla e due chierici lo aiutarono ad aprirla. Il sacerdote mormorò una breve formula, poi gli diedero un turibolo e lui lo agitò verso la bandiera, e in una nuvola di fumo bianco la benedisse o la consacrò... La gente lo osservavaconcommossa devozione. Molti avevano le lacrime agli occhi, e chi riusciva andava a baciare l’orlo della bandiera, pregava in ginocchio o addirittura si prostrava davantiaessa. Si sentirono delle sirene in arrivo, da più lati contemporaneamente. Ambulanze? Pompieri? Polizia? A quel suono la gigantesca adunata si riscosse e cominciò a disperdersi in ogni direzione,versolestrade adiacenti. Il ramo del corteo che aveva trascinatoconséBudaisi infilòsottol’ampiaporta di un vicino bastione merlatodovescorrevano le auto. Al passaggio dei manifestanti i negozi chiudevano uno dopo l’altro, abbassando di schianto le saracinesche. Lacircolazioneeraormai paralizzata,gliautobuse lemacchineaccostavano al marciapiede, i passeggeri scendevano e si univano alla folla. Da lontano giungevano rintocchidicampaneeil suono continuo di una sirena come quello che nelle fabbriche segna la finedelturnodilavoro. Siritrovòneipressidel grattacielo del quale contava i piani. Adesso non gli passò neppure per la testa di farlo. All’avvicinarsi della folla, gli operai scesero dall’edificio con i montacarichiocalandosi dalle impalcature, le gru e le macchine si fermarono, l’altissima struttura d’acciaio e di cemento si svuotò. Così com’erano, con le tute macchiate di vernice o col berretto di carta in testa, gli uomini del cantiere si unirono agli altri ingrossando la moltitudineondosa–ma checos’era,unosciopero generale? Suimuricominciarono ad apparire dei manifesti, ancora umidi, con titoli a caratteri cubitali,edifronteaessi si formavano capannelli dipersonecheleggevano e discutevano con foga. La corrente della folla risucchiava tutti, quelli che uscivano dalle case per unirsi agli altri e la gentechesbucavaafiotti dalle scale gialle del metrò. Da un altoparlante una voce gracchiò in maniera concitata, come per dare istruzioni urgenti. La cosa non piacque ai manifestanti, che si misero a protestare, si bloccarono indignati e a un tratto scoppiò un tafferuglio. Come se non bastasse, una fiumana che veniva da una via laterale incrociò quella principale, si crearono vortici e ingorghi, le due ali si mescolarono, si ammassarono e si pigiarono nel caos. E dall’altoilmegafononon smettevadigracchiare. Il cuore di Budai cessò dibattereperunistante: sulmarciapiededifronte gli sembrò di vedere Epepe. Fu solo un secondo, o forse meno, nella folla apparvero la testabiondael’uniforme blu... Oppure erano stati il colore dei capelli e il vestito a trarlo in inganno, e il pensiero che fosse lei era solo il frutto della sua immaginazione? Perché nonavevafattointempo ad apparire che era già scomparsa, e Budai impiegò tutte le sue energie per andare in quella direzione ma non la rivide più, né una donnachelesomigliava; certo,potevaanchedarsi che nel frattempo lei e quelli intorno fossero statispintiavanti. Eppure la delusione non lo scoraggiò, non aveva affatto perduto la speranza che il caso li avrebbe fatti incontrare dinuovoinquelturbinio caotico. Anzi, quell’episodio gli infuse sicurezzaevogliad’agire, desiderava davvero partecipare alle cose che stavano accadendo, voleva andare dove andavano tutti gli altri, condividerne il destino, fare sua la loro causa e lanciarsi anima e corpo inquell’avventura. Decise di imparare le canzoni. La più ripetuta eraunamarciadalritmo serrato, l’aveva sentita talmente tante volte che ormai aveva nella memoria non solo la melodia ma anche le parole, per come era riuscito a distinguerle nei cori, e faceva pressappococosì: Cetectopadebette Etekglöchrifefee Bügiütignemelaga Pecice...! Laparolafinaleveniva urlata in modo secco, come un colpo, con rabbia o allegria. Ripetevano questo canto in continuazione, e in maniera martellante – era una provocazione, una minaccia, o fino a quel momento era una canzone proibita? Il più esaltato era un ragazzo ossuto con una folta zazzera:ognivoltachela canzone finiva lui la ricominciava da capo, dava l’attacco con le sue lunghe braccia e quelli attorno gli andavano dietro. Erano come inebriatidalcantoedalla loro voce, e tutti, compreso Budai, condividevano la stessa sensazione: stavano facendo qualcosa di grande e di importante. Questa euforica certezza si diffondeva tra di loro, la certezza che uniti, tutti insieme, erano più forti,chenessunopoteva fermarli, si sentivano invincibili – e questo li riempiva di una gioia selvaggia, gli estranei si abbracciavano e si baciavano,danzavano,si scatenavano, quasi volteggiavano a mezz’aria. A fianco di Budai una ragazza in un abito argentato, con la pelle ambrata e i capelli neri crespi come la lana suonava il tamburo: doveva far parte del gruppoditamburineche prima sfilava in ordine nel corteo, formato da ragazze vestite tutte uguali, che poi si era sciolto e mescolato agli altri. Non aveva più di quindici anni e batteva sul tamburo con una foga instancabile, sul viso le si leggeva un entusiasmo che rasentava l’estasi, e mentrealzavalosguardo verso un vago punto lontano mostrava il biancodegliocchi.Budai non poté reprimere il pensiero che quella ragazzina, se fosse giunto il momento, avrebbe sacrificato la propria vita senza esitazione. Lì vicino avevano innalzato una barricata. Avevano divelto la pavimentazione stradale, portato dei mobili dalle case vicine, perfino credenze e pianoforti, e sparso sabbia e ghiaia: avevano costruito uno sbarramentoaltoelargo, in cima al quale era piantataunabandiera. All’angolosuccessivoil passaggio nella traversa era sbarrato da uomini con la solita uniforme di tela: una schiera di soldati armati. La folla scorreva accanto a loro, un gruppo di giovani donne però si fermò a stuzzicarli. Si avvicinarono applaudendo e muovendo passi di danza,sordealleurladel comandante che ordinava loro di star lontano, appuntarono fiori ai berretti dei ragazzi, e quando questi imbracciarono i fucili ne infilarono anche nelle canne. Si aggiunsero altre donne, offrirono ai soldati sigarette e prodigarono abbracci, pacche sulle spalle e strette di mano, sorridendo e vociando. Con tutte queste manifestazioni di amicizia, nel giro di due minuti l’intera pattuglia venne disarmata. La strada bloccata si aprì e lamoltitudine,compreso Budai,visiriversò.Anzi, gran parte del drappello militareappenascioltosi unì al corteo, gli uomini in tuta ridevano e cantavano insieme agli altri. Qua e là, si vedevano alcuni civili con in spalla i fucili sottrattiaimilitari. Poi giunsero in una viuzza stretta dove una folla rumorosa occupava la carreggiata. Erano concentrati davanti alla facciatagrigiaeanonima di un grande edificio di quattro piani, le cui finestreeranogremitedi curiosi, e anche le case dirimpetto, più basse, brulicavano di persone come un formicaio. Budai si spinse fin sotto il palazzo grigio: il portoneerachiuso,coni pesanti battenti di ferro sprangati. Davanti, un mezzo cingolato da combattimento impediva il passaggio con la sua massa d’acciaio. Non capiva bene che cosa stava succedendo: entrò in una delle basse casedifronte.L’androne, le scale e i ballatoi sul cortile interno erano affollati, e nessuno gli chiese dove stava andando. Salì indisturbato fino all’ultimo piano, spinse una porta socchiusa ed entrò in un appartamento che si affacciava sulla strada. La stanza era stipata di gente,erachiarochenon tutti abitavano lì, anzi, i veri occupanti dell’appartamento forse non erano neppure presenti. Arrivò sul balcone e si sporse a guardare, in basso ondeggiava una folla densa e torpida; da lì vedeva bene anche le case accanto, tutte straripantidipersone. Di fronte, al primo piano dell’edificio grigio, dei tecnici stavano installando un altoparlanteallafinestra, con la tromba rivolta verso la strada. In basso la folla si era un po’ sedata ma li osservava con tangibile sospetto, gridando ogni tanto qualche frase di ironico incoraggiamento. Un ronzio e uno sfrigolio indicarono che l’altoparlante era acceso, e l’apparecchio cominciò afischiareeagracchiare. Quando i rumori d’interferenzacessarono, una voce femminile rapida e agguerrita scandì qualcosa, poi seguìunapausa,qualche secondo di silenzio pesante, e infine un colpo di gong. Dopo di che una voce maschile più profonda e cavernosa, lenta e solenne,annunciò: «Cetencia...». Questa prima parola suscitò delusione: venne accolta da un coro irritato di fischi e buu. Accanto a lui, la ragazza nera alta e snella agitò furiosa il pugno dal balcone.Lavocediprima ripeté in tono un po’ più incerto: «Cetencio...». Non poté proseguire per l’ondata di protesta che esplose con forza elementare. Un mattone volò verso l’edificio grigio, lanciato con ogni probabilità dalla casa dove si trovava Budai: colpì il muro, si frantumò nell’impatto e cadde a terra in pezzi. Il secondomattonefinìsul davanzale della finestra, il terzo invece centrò in pieno la tromba dell’altoparlante, che tacque. Tutte le finestre intorno si svuotarono, i curiosi si ritrassero all’interno. Davanti al portone il carro armato accese il motore rombando, fece un mezzo giro sui cingoli e dalla torretta d’acciaio uscì minaccioso il cannone. I pedoni arretrarono, ma non troppo, restarono nei pressi del veicolo corazzato tuonando contro l’equipaggio invisibile,lamanoalzata come in un giuramento. Poi ricominciarono a cantarequellamarcia: Cetectopadebette Etekglöchrifefee... Illanciodimattoninel frattempo non era cessato, e quando Budai, spinto dall’inquietudine, corsegiùdallescale,vide nel cortile dei grandi mucchi di mattoni, che servivano da munizioni: una catena umana se li passava di mano in mano fino agli appartamenti che davanosullastrada. Uscendo dalla casa, notò all’angolo alcuni camion che trasportavano uomini in uniforme. Arrivavano pianissimo, suonando il clacson, cercando di incunearsi in mezzo alla folla che non voleva aprire loro il passaggio. Un uomo alto e dal portamento fiero saltò sul tetto della cabina del primo veicolo: doveva essereunufficiale,anche se indossava la tuta senza mostrine come tutti. La sua voce dal timbro metallico giunse lontano, sovrastando il frastuonogenerale.Disse pochefrasibrevi,intono militaresco, accompagnate da gesti delle braccia duri e decisi: presumibilmente stava ordinando ai disturbatori di disperdersi. Ma fu investito da urla di contestazionedapartedi una folla sempre più ostile e inquieta, e gli tiraronoaddossoperfino un mattone. Sebbene l’avessero mancato di poco l’ufficiale non mostrò alcuna paura, gettò uno sguardo di disprezzo nella direzione da cui era partito il lancio e scese dalla cabina con aria che non prometteva niente di buono. Gliuominiinuniforme saltarono giù dai camion, formarono un cordone da una parte all’altra della strada e cominciarono a respingere la massa. Il loro numero però era talmente esiguo in confronto a quello dei manifestanti che con la sola forza fisica non ce l’avrebbero mai fatta, neanche caricandoli. Allora provarono a disperderli con gli idranti, dirigendo a ventaglio il getto d’acqua: quelli in prima linea, inzuppati, si spostavano indietro fradici e gocciolanti. Ma un mattone ben assestato colpì la mano del soldato che impugnava l’idrante e danneggiòlapuntadella bocchetta. Imilitaririsposerocon dei fumogeni, che si rivelaronopiùefficaci:la gente si disperse e si ritirò, poi si mise a correre per sfuggire alle nuvole bianche che esplodevano qua e là. Budai era abbastanza lontanodanonsubiregli effetti del fumo, ma venne travolto dal fuggi fuggigenerale.Svicolòin una traversa e corse lungolarecinzionediun parco,finoall’angolo. Mentre riprendeva fiato, notò una saracinesca abbassata a metàsottolaqualemolti siinfilavano.Sichinòper sbirciare dentro, per curiosità, quindi vi entrò: dei gradini illuminati da nude lampadine conducevano a un tiepido seminterrato in cui aleggiava un vago odore dicanapa.Dovevaessere il deposito di un negozio dicordeeteloni:lungole paretiimbiancateacalce erano allineate pile alte fino al soffitto di sacchi ripiegati, rotoli di tela, corde, sugli scaffali tantissimirocchettitutti ugualidispagoenastro... Epoivideunmucchiodi gente: uomini, donne, ragazzi; sulle prime Budai non capì che cosa stavano facendo. Volevano portarsi via la merce? A che scopo si eranoraccoltilì? A sinistra si apriva un locale più piccolo, anch’esso pieno di persone. Dovette alzarsi in punta di piedi per vedere al di sopra delle teste che cosa facevano. Un uomo in giacca di pelle, con una faccia lunga e giallastra e baffi spioventi, prendeva dei mitra da una cassa e li distribuiva:dicevapoche parole a ognuno, gli stringeva la mano e gli consegnava l’arma. Alcuni indossavano uniformi, quelle che Budai aveva già visto: controllori, ragazzi e ragazze in giacca impermeabile verde, le solite giubbe di tela, perfino un vigile del fuoco. Gli altri erano comunque in tenuta da combattimento, un bizzarro misto di abiti civili e militari, stivali, giacche di feltro con l’interno di pelle di pecora, impermeabili mimetici, bandoliere e cinture portamunizioni, colbacchioberrettirigidi da poliziotto. C’erano addirittura due uomini rapati a zero in divisa a righe da galeotto, come quelli che avevano sfilatolamattina–erano due di loro, o manifestanti travestiti? Oeranoduecondannati? E condannati per cosa? Per reati comuni? O prigionieri politici? Eranoevasi? A quanto sembrava, Budaieracapitatoinuna delle basi della sommossa che era scoppiata nella zona o forse nell’intera città; tutto l’andirivieni sembrava confermare questa ipotesi. Più tardi arrivòanchedabere,una piccola botte fu fatta rotolare pian piano sui gradini. Fu accolta da risate e grida di gioia e presa d’assalto. La stapparono e ne versaronoilcontenutoin gavette e bottiglie, che poi passavano di mano in mano. Anche Budai bevve un sorso: questo nonerailsolitointruglio dolciastro servito nelle bettole, ma vera acquavite di vinaccia, cosìfortechedavasubito allatesta. Conl’arrivodellabotte sceseroaltrepersone,tra cui una strana ragazza dall’aspetto deforme e armata di mitra. Teneva la schiena curva, o forse era gobba, il collo incassato nelle spalle, aveva la fronte bassa, la facciapiattacomequella di una scimmia, un’espressione ebete e una luce opaca negli occhi mentre si aggirava guardinga per il seminterrato. Non bevevainsiemeaglialtri, non parlava e non rideva,misuravaillocale con un passo lento e felpato, un’aria misteriosa, squadrava tutti in modo ambiguo, come a caccia di qualcuno, o come se fosse finalmente il suo momento, ora che aveva un’arma a disposizione – ma da dove era saltata fuoriquella? Nel bel mezzo dell’allegrabevutafeceil suo ingresso, quasi inavvertito, un giovane biondo. Per meglio dire, la sua presenza si notò a scoppio ritardato perché uno dopo l’altro ammutolirono al suo cospetto. Si fermò sui gradini senza dir nulla, immobile, e guardava in basso strizzando gli occhimentresiabituava alla penombra. Doveva avere circa venticinque anni, aveva le labbra sottili ed esangui e gli occhi grigio-azzurri, comeilghiaccio;portava un vecchio berretto sciupato, gli anfibi, una tuta verdastra con una cintura portamunizioni, la mano destra era posata sul fodero della pistola. Quando il silenzio fu totale si inoltròinmezzoaglialtri e sempre senza dire una parolastrappòlagavetta a un ragazzo che stava per bere. L’acquavite si versò sul pavimento, quello fece per riprenderelasuagavetta ma il nuovo venuto gli diedeunoschiaffo. Questo era un giovane robusto e armato, ma non tentò di restituire l’offesa né di difendersi. Nessuno mosse un dito, molti arretrarono e perfino la ragazza dal viso scimmiesco si irrigidì... Il biondo si strinse la cintura in vita eruppeilsilenzio.Parlòa voce bassa, in tono distaccato, e scandiva con una tale chiarezza che per una volta Budai riuscìadistinguerequasi tutto, e suonava all’incircacosì: «Deperetj glütt udjurumba?» – e si voltò attorno con aria interrogativa. Gli altri non lo guardarono, la maggior parte abbassò gli occhi. «Begec alaulp atipatitjapp?»proseguì,e poi ripeté: «Atipatitjapp?... Atipatitjapp?...». L’uomo coi baffi e il viso giallastro in giacca di pelle che distribuiva i mitra cercò di interloquire, ma il biondo gli fece cenno di tacere e con la stessa noncuranza, come di sfuggita, gli disse: «Je duruntj...». Parlò per due o tre minuti, in tono monocorde; gli ascoltatori, disposti intorno a lui, parevano sempre più convinti, lo ascoltavano senza fiatare. Finì con una domanda, alzando appena il tono di voce sull’ultimasillaba: «Eleedje kurupudu dibadi?... Dibadi, aka teresce mutju lolo dibadi?». «Dibadi! Dibadi!...» gridarono tutti insieme conentusiasmo. Nessuno pensò più all’acquavite e uscirono in strada. In quel momento passavano dei carri armati, con un frastuono assordante: erano aperti, carichi di uomini in uniforme. Quelli del magazzino si riversarono nella carreggiata, circondarono i blindati e vi si arrampicarono, con il ragazzo biondo in testa.Siripetélascenadi poco prima: cominciò una discussione animata, i civili si rivolgevano ai militari, gesticolando. Questi ultimi sembravano molto turbati da quell’assaltospontaneo,i carri si fermarono e dall’interno sbucarono altri soldati con l’elmetto. Uno di loro si tolse un auricolare dall’orecchio – doveva essere il comandante –, alzò il braccio per chiedere silenzio e domandò qualcosa. Gli risposero in cento agitando i berretti, e lui scesenellatorretta.Dopo qualche istante riemerse conlatestaedissesolo: «Budjurim». Scoppiarono grida di gioia, tutti acclamarono il comandante. Spuntò una bandiera, anch’essa a bande rosse e nere, e tra evviva e applausi venne issata sul primo carro della colonna. Poi si mossero, i cingoli scricchiolarono,popoloe carri avanzarono insieme nella stessa direzione,cheeraancora il palazzo grigio, ma stavolta il retro dell’edificio. Trovarono una gran folla, i militari non dovevano essere riusciti a sgomberare la zona oppure la gente era ritornata. E anche da questo lato alle finestre si affacciavano tanti curiosi,unmistodicivili e militari, com’era nelle strade. Budai cercò di non perdere di vista il giovane biondo, seguendocongliocchila tuta verdastra. La ragazza gobba armata di mitra, invece, non si staccava da Budai, lo tallonava con il suo passosilenzioso. A quel punto si sentirono degli spari, qualche colpo isolato e poi raffiche. Da dove si trovava Budai non si capiva se avessero cominciatodall’internoo dall’esterno del palazzo. Forse dall’edificio avevanosparatodeicolpi di avvertimento e gli assedianti avevano rispostocontirimirati,o viceversa. Ma ormai non faceva molta differenza: c’eranocosìtantearmiin giro e il clima era così rovente che prima o poi le cose sarebbero inevitabilmente precipitate. Dovevano esserci dei tiratori anche sui tetti. Poi al crepitio acuto degli spari si mescolò una linea di basso di esplosioni più gravi e cupe: erano i cannonideicarriarmati. Un pezzo di muro grigio si staccò e cadde sul selciato, lasciando un ampiobucorotondo. Dall’interno risposero con raffiche di mitragliatrice che piovvero come grandine pertuttal’ampiezzadella strada. Si scatenarono il panico e il caos, la moltitudinesisparpagliò di colpo, tutti fuggivano terrorizzati cercando riparo dove potevano, nei portoni dei palazzi, dietro le auto in sosta, i cassonetti dell’immondizia, le colonne per le affissioni, oppure si gettavano proni davanti ai negozi chiusi. Quando la carreggiata fu deserta, parecchi giacevano a terra, immobili, oppure strisciavano tra i lamenti. Una donna ferita piangeva e implorava aiuto. Dall’altopartìunanuova raffica. Il piccolo gruppo al quale Budai si era unito cercòrifugiotraipilastri anneritidalfuocodiuna casa in rovina. Budai tremavaintuttoilcorpo, ribollivadirabbiadentro di sé, provava un impotente desiderio di vendetta, sentiva l’odio salirgli in gola simile a un conato di vomito, urlavainsiemeaglialtrie malediceva il nemico invisibile, li chiamava assassini, assassini sanguinari. Ma alla raffica successiva fu assalito da un tale terrore che si precipitò come un pazzo dentro quella casa e, attraverso un dedalo di muri fuligginosi, cercò disperatamente un’uscita posteriore da cuifuggireilpiùlontano possibile e non sentire piùilcrepitiodellearmi. I resti della casa testimoniavano una catastrofe precedente, non era stato un semplice incendio perché l’intonaco nudo e affumicato era scheggiato dai proiettili; doveva essere stata colpita dalle bombe, dall’artiglieria, da un combattimento ravvicinato, e alla fine erastataincendiata–ma in che occasione? Che cosa era successo? Un assedio, una guerra, una rivoluzione? E chi aveva combattuto,controchi,e quando,achescopo? Aveva quasi trovato il modo di uscire: doveva solo scendere alcuni gradini e dopo un corridoio a cielo aperto sarebbestatofuori.Main quel momento sentì una voce e qualcuno lo trattenneperilcappotto. Sivoltòsobbalzando.Era ilgiovanebiondo,chegli fececennodiavvicinarsi. Budai si bloccò, non capiva dove lo stava chiamando e perché. Il giovane gli tese un revolver, poi, vedendo che non reagiva, glielo schiaffò in mano... All’improvviso fu assalito dalla vergogna: quel gelido sguardo grigio-azzurro gli aveva letto nel pensiero. Avrebbe voluto spiegarsi, ma come poteva, e poi non c’era nemmeno il tempo. Così guardò la pistola, soppesandola, e annuì conariaimbarazzata,per dire che sì, va bene, era conloro. Giunserofurtivamente fino alla strada che costeggiava il palazzo grigio, a sinistra della facciata principale. Sull’altro lato della strada c’era una costruzione più moderna, rotonda, di colore chiaro, una specie di torre, e corsero in quella direzione. Una rampa larga quattro o cinque metri si avvolgevaaspiraleverso l’alto, per dieci o dodici piani:eraunparcheggio, unastrutturamodernae leggera in grado di contenere un gran numero di automobili. Nonsimuovevanessuna macchinaalmomento,la struttura era presidiata da uomini armati come loro,egliscontriafuoco si erano ormai estesi a tutta la zona. Sparavano dadovepotevano,dietro il parapetto della rampa, leauto,qualunquepunto offrisseprotezione. Salirono lungo il lato interno della rampa, tenendosi più indietro rispettoallepostazionidi tiro, poi infilarono delle scale. I combattenti si erano impadroniti del parcheggio, avevano depositidimunizioni,un serviziodicollegamento, avevano appeso in giro cartelli scritti a mano e frecce, e perfino organizzato un locale di pronto soccorso per i feriti. Il ragazzo in tuta verde, dopo veloci scambi di parole con altre persone, li guidò all’ultimo piano, e poi più su, in una specie di sottotetto a volte multiple dal quale si aprivano delle piccole bocchette d’aerazione verso la strada. Da quell’altezza si poteva mirareversoilbasso,sul tetto del palazzo di fronte. La ragazza taciturna dal muso scimmiescosiaccovacciò subito presso una delle aperture e cominciò a farefuoco. Del gruppetto facevano parte anche il ragazzo che si era preso lo schiaffo, il baffuto in giacca di pelle, il vigile del fuoco con l’elmetto rosso e uno dei detenuti. Alla piccola squadra improvvisata si erano uniti alcuni militari passati dalla parte degli insorti e una decina di civili armati di fucili o mitra che dovevano essersiaggregatilungola strada.Traloroc’erauna donna, una nera robusta di una certa età, senz’armi, con un gran sorriso allegro stampato sulla faccia larga... Il comandante, su questo non c’era dubbio, era il biondo in tuta: dirigeva la squadra con naturale autorevolezza e indicava aognunoisuoicompiti. Rimasero in quel sottotetto tutto il pomeriggio e la sera, a spararesulpalazzogrigio di fronte. Budai non avevanessunapraticadi armi da fuoco, e così gli mostrarono come funzionava il revolver e come si ricaricava, ma anche dopo le spiegazioni sparò alla cieca,senzaconvinzione. Le finestre di fronte si eranospopolate,maogni tanto riappariva qualcunoperprenderela mira.Sicapivacheerano tantissimi e di etnie diverse, esattamente come i combattenti dell’altro fronte: dunque ilconflittononparevadi naturarazziale. Accaddero ancora molte cose quella sera, era difficile non mescolarle insieme. Spararono,siriposarono, ripresero a sparare dandosi il cambio alle varieaperture.Qualcuno portò da mangiare, una specie di zuppa di carne speziata ma dolciastra, e del pane nero da caserma. Uno dei loro, un ragazzo in giacca impermeabile, venne feritoecaddeall’indietro sbiancando all’improvviso. Non gridò, ma dalle labbra serrate e dallo sguardo convulso si capiva quanto stava soffrendo; lo portarono via in barella. Budai riuscì anche a dormireunpaiod’ore,in un giaciglio approntato in un angolo del sottotetto, sopra dei trucioli di plastica. La ragazza dall’aria balorda gli rimase appiccicata, ancheinquell’occasione. Non gli parlò – non la sentì mai dire una parola,chefossedavvero muta? –, si limitò a fissarlo con un’espressione ottusa, con insistenza, sdraiata su un fianco con il gomitopuntatoaterra,e senza abbandonare il mitra:checosavolevada lui? Budai sentiva una strana inquietudine, anche nel dormiveglia, un torbido senso di colpa: perché si trovava lì, che cosa ci facevano insieme, che cosa poteva maiaveredaspartirecon una mentecatta del genere...? Poi gli sembrò di tenerla tra le braccia, di stringerla con cruda e turpe libidine, malgrado lo sgradevole puzzo di sudore della ragazza e in mezzo al fragore incessante della battaglia. E aveva paura che il giovane in tuta verde lo punisse, che cosa sarebbe successo se li avesse sorpresi in quell’angolo buio? – certo, forse tutto questo erasoloilfruttodellasua immaginazione, una proiezione dei suoi istinti sconvolti e degenerati. Più tardi un boato enorme scosse il sottotetto, come se fosse cadutaunabombaouna granata – o era un’allucinazione? Quest’ultima, come poté constatare, non se l’era inventata: alle prime luci dell’alba, quando abbandonarono il parcheggio, vide che nei muri si erano aperte enormi crepe, e la maggior parte delle auto era andata distrutta. Il palazzo grigio di fronte aveva subìto danni ancorapiùgravi,aiquali avevano contribuito i cannonideicarriarmati: la facciata era attraversatadaunampio squarcio, uno degli angoli era completamente crollato, e numerose lesioni ancora fumanti lo deturpavano. La sua squadra si recò all’ingresso principale delpalazzoassediato:era evidente che gli attacchi dei ribelli ormai si concentravanolì.Ilcarro armato che proteggeva l’ingressodelpalazzoera bruciato, con la torretta piegata da un lato e i cingoli divelti. I più audaci lo usavano come copertura e vi si appostavano dietro per sparare; poi, con sforzi immani e voci di incitamento, riuscirono a smuovere quella pesantemassad’acciaioe la spinsero come ariete contro il portone sprangato e crivellato di colpi, bloccato dall’interno con puntelli esacchidisabbia. Non cedette facilmente: il gigante corazzato ci sbatté contro dieci o quindici volte, tra le urla d’incoraggiamento generale, ma i pesanti battenti di ferro si incurvavano per poi tornare com’erano. Lanciarono delle bombe amano,locolpironocon raffiche che produssero un gran fumo e un rumore assordante, e finalmentefecerosaltare icardini.Quandolanube di polvere da sparo si dissolse, bastò un’altra spintaeilportonecrollò. Con grida di trionfo la moltitudinesiaffollòper entrare, esortando quelli delle prime file nella speranza di trovare via liberadentroilpalazzo. Ma il passaggio nell’androneerasbarrato da ranghi serrati di uomini in uniforme, la stessa da una parte e dall’altra – o forse c’era effettivamente una differenzanellelorotute o in certi dettagli che lui non riusciva a notare? Come videro le mitragliatrici e i fucili d’assalto gli attaccanti si bloccarono. Budai non era fra i primi, ma si trovava abbastanza vicino per avere una buona visione del campo. Dall’interno una voce rauca e quasi soffocata intimò qualcosa, di sicuro l’ultimo avvertimento. Ma il fronte degli attaccanti non avrebbe potuto retrocedere nemmeno se avesse voluto, poiché alle loro spalle c’era un’orda di gente che spingeva per entrare: a breve sarebbero inevitabilmente finiti addossoaidifensori... Un fuoco di fila. Urla, ruggiti, caos. E ordini strillati, quasi cantati. E poiunaltrofuocodifila, che passò rasente l’orecchio di Budai. Ma era troppo tardi per fermare l’avanzata, la genteeracomeunfiume in piena, una corrente inarrestabile che travolgeva e calpestava tuttoetutti,feriti,morti, difensoriarmati:alterzo ordine di fuoco, un’ondata umana crollò nell’androne... Il ragazzo biondovicinoalui,tutto infervorato e arruffato, fendeva con la rivoltella in pugno il turbine di corpi mentre con la mano sinistra faceva cenno ai compagni, li chiamava a gran voce, ma nel boato del combattimento si vedeva solo il movimento delle labbra. Budai lo seguiva in una nebbia rossa, in preda a una sorta di ebbrezza nella quale non aveva più paura di niente, abbandonandosi al piacere sconosciuto dell’assalto,conunasola certezza: dovevano passare. Accanto a lui la ragazza gobba dal muso scimmiesco si portò la manoallaspallaecadde, ma Budai non si curò di lei, si buttò in avanti nella calca, assalì gli uomini armati di fucili, lottando corpo a corpo e urlando insieme agli altri, con una voce strana, che non aveva mai sentito uscire dalla propriagola. Di colpo ci fu un cedimento in avanti e si ritrovarono nel piccolo cortiledipietra.Avevano sfondato le linee. Quando si voltò a guardare, l’androne era completamente invaso dalla folla densa e nera che era dietro di loro: a una simile superiorità di numero non era possibile resistere. I difensori erano scomparsi, la moltitudine vittoriosa correvainebriatasuegiù per l’edificio. C’era una scala in un angolo del cortile, Budai salì di corsaalprimopiano,poi al secondo, eccitato e curioso di vedere quel che avrebbero trovato, ora che avevano finalmente raggiunto l’obiettivo. Ma non c’erano che corridoi e porte, stanze arredate come uffici, e gli occupanti stavano già frugando ovunque, mettevano tutto a soqquadro, rovesciavano le suppellettili e sparpagliavano i documenti, il pavimento era ricoperto di carte. Il palazzo pullulava di gente, in divisa e in borghese, con o senza armi, alcuni erano feriti e bendati, e lui non distinguevapiùfrachisi trovava già dentro e chi era venuto da fuori, e comunque che cos’era quel palazzo, e perché avevano dovuto occuparlo? Un uomo venne condotto con violenza lungo il corridoio. Era scortato da due figuri armati di mitra, i molti che lo seguivano e quelli che incontrava al suo passaggio cercavano di afferrarlo,diprenderloa calci, a pugni, lo insultavanopienid’odio, lo minacciavano, gli uomini col mitra faticavano a difenderlo. Era alto, dal portamento marziale, con la tuta a brandelli, la testa e la camicia insanguinate, e si proteggeva gli occhi con il braccio piegato. Una ragazzina esile e bionda, con lunghi capelli d’angelo, si fece agilmente largo attraverso il cerchio di persone che lo circondava e gli sputò in faccia. Avevano fatto altri prigionieri e ora li stavano portando giù all’ingresso. Una donna veniva trascinata per i capelli: si dibatteva, lottava con le unghie e coi denti. Quando la costrinsero a inginocchiarsi, lei aprì le braccia,simiseagridare e a piangere, come a chiedere pietà. Le strapparono di dosso la gonna, poi le mutandine rosa, e così mezza nuda la trascinarono giù dai gradini. In quel tumulto anche Budai si ritrovò sotto l’androne, dove erano in corso la vendetta selvaggiaeiregolamenti diconti:unodopol’altro, uomini e donne, già malmenati e incapaci di reggersi in piedi, venivano condotti a forza all’ingresso del palazzo e dati in pasto a una folla assetata di sangue e pronta a linciarli. Quello che Budai non capiva era in base a che cosa scegliessero uno o l’altro in quel caos generale. È vero che la maggior parte aveva la tuta di tela, ma quella la portavano anche parecchi tra i giustizieri del popolo; non riusciva a venire a capo della questione della divisa. Furono consegnati dei civili, delle donne, e poi ancoraun’interasquadra di uomini in uniforme – era evidente che nella scelta interveniva anche ilcaso,oltrechelarabbia del momento, accuse sommarie e una cieca isteriacollettiva. Ed era come se la composizione dei partecipanti fosse cambiata: non vedeva più in giro quelli con cui avevacombattuto.Erano invece comparsi dei figuri loschi che dirigevano le operazioni e si distinguevano per la loroferocia.Peresempio, un uomo barbuto con l’aria da farabutto, una faccia piena di cicatrici che gli sembrava stranamente familiare, voleva impiccare un prigioniero. Il malcapitato era in fin di vita, l’avevano mezzo spogliato, gli avevano tolto gli stivali, legato le caviglie e l’avevano appesoatestaingiùaun lampionenellastrada,di fronte al portone, tra ingiurie, sghignazzi e deliranti grida di incitamento. Alcuni uomini armati si stavano però indignando, erano evidentemente contrari, avrebbero voluto staccare il corpo dalla corda. Un ragazzo dall’aria assennata, probabilmente uno studente, tentava di dissuadere le persone intorno a lui dal commettere altri assassini, mentre faceva scudocolsuocorpoadue nere di mezz’età, forse due donne delle pulizie. Con scarso successo, perché la marmaglia inferocitalofischiavaeil barbuto dalla faccia sfregiata lo scostò ruggendo: «Durung!». In quell’istante Budai lo riconobbe: era il suo compagnodicella,quella specie di cantante lirico fallito che per tutta la notte non aveva fatto altro che parlare; o quantomeno gli somigliava parecchio... Eraunaveracanaglia,un caporione, provava un piacere perverso nel compiere violenze: con una spranga di ferro colpì alla nuca un soldato prigioniero. L’uomo si accasciò a terra e lui gli si buttò sopra, gli puntò le ginocchia sul petto e lo trafisse ripetutamente con il coltello a serramanico, affondandolo nel collo e nei genitali, mentre la vittimascalciavaancora. Poi portarono della benzina,glielaversarono addosso e gli diedero fuoco: il corpo arse fino ad annerirsi completamente, emanando un odore di carnebruciata.Questafu una delle tante atrocità checommisero. Nel frattempo era tornatoilgiovanebiondo intutaverde.Insiemead altri quattro o cinque compagni si era presentato fuori dall’edificio, come se qualcuno l’avesse chiamato. Quando apparve, i fanatici sanguinarisifermarono, non era chiaro se perché lo consideravano il loro capo o perché la sua mera presenza incuteva un timore reverenziale... Siavvicinòaiprigionieri, che subivano con rassegnazione la loro sorte, scacciò la marmaglia che li circondava, sferrò anche un calcio nel sedere al barbuto,chefinìcolnaso per terra suscitando lo scherno generale. Tra i prigionieri scelse quelli indivisaerivolseloroun secco comando: lentamente, controvoglia, gli obbedirono. Li mandò verso il muro, la folla si ritrasseeammutolì. Iprigionierieranouna dozzina, gironzolavano impacciati sul marciapiede;moltierano già feriti, con un braccio appeso al collo, la fronte o la testa fasciate. Un uomo di mezz’età con i capelli brizzolati, elegante malgrado la divisa strappata, sostenuto da un vicino, fumava quieto la sua sigaretta e osservava senza paura la folla inferocita. Il giovane biondo li esaminò con sguardo freddo e inespressivo, serrando le labbra.Dopounpo’disse loro qualcosa con voce sommessa, e quelli alzarono tutti le braccia. Poi chiese il mitra a uno dei suoi compagni, lo soppesò, se lo girò tra le mani, sbirciò perfino dentro la canna. I prigionieri in uniforme stavano lì con le braccia alzate. Sui loro volti non si leggeva paura, ma piuttosto incertezza, imbarazzo, quasi non sapessero come comportarsi in una situazione così strana. Uno di loro si soffiò il naso con una mano, tenendol’altraalzata. Il biondo si voltò di fianco e aprì il fuoco tenendo il mitra all’altezza della vita. Scaricò su di loro una lunga raffica, spostando l’arma da destra a sinistra. Gli uomini crollarono l’uno sull’altro, molti caddero di peso, qualcuno rantolava fra scatti convulsi. L’uomo dai capelli brizzolati fece in tempo ad aspirare l’ultima boccata e a gettarelasigaretta,poisi piegò in ginocchio sul selciato come di sua volontà, lo sguardo torpido, quasi annoiato, e prima di accasciarsi mise il braccio sotto la testa. All’estremità del gruppo ce n’erano due che gemevano ancora, agitati dai sussulti. Con gli occhi socchiusi, il ragazzo in tuta verde sparò un’altra raffica in quella direzione. Poi non simossepiùnulla. Quella stessa mattina Budai assisté ad altre tre esecuzioni del genere. All’ultima non fu nemmeno scosso, riuscì ad assistervi dall’inizio alla fine senza provare nessuna emozione. Se fosse esistito un Dio, pensò stancamente, lo avrebbe pregato di non lasciare che la pietà si spegnesse mai nel suo cuore. Era esausto, aveva fame. Vagò per le strade affollate: la moltitudine era ancora più densa del solito, e la gente, in spasmodica attesa di nuovi eventi, si riuniva in capannelli a discutere animatamente o si assiepava attorno a improvvisati oratori. Il cieloerasolcatodaaerei, e da lontano proveniva un fragore incessante e cupo, come se la città fosse già sotto assedio. Ogni tanto passavano rombando dei camion carichidiuominiarmati. Nellestradesicantava,si distribuivano volantini, e quando appariva uno strillone con i giornali freschi di stampa veniva letteralmente preso d’assalto. I muri erano tappezzati di avvisi, non solo manifesti, anche fogli scritti a mano, e in molti si fermavano a leggerli, aggiungendovi commenti o affiggendonealtri. Più avanti vide un’altra zona che aveva subìto danni gravissimi, gli edifici erano in parte crollati, nelle strade giacevano alti cumuli di macerie, qua e là le rovine annerite fumavano ancora: quel quartiere doveva essere stato teatro di scontri violenti. Molti abbandonavano le propriecaseconfagottie pacchi, famiglie rimaste senza casa tiravano carrette cariche delle poche masserizie scampate alla distruzione. Un folle vestito di stracci, con i capelli lunghi e la barba da profeta, camminava inmezzoallacarreggiata roteando gli occhi e agitando le braccia, urlando ossessivamente lastessaimprecazione: «Tohoree! Muharee!... Tohoree,muharee!...». Budai sentiva una nausea indefinibile, aveva lo stomaco stretto in una morsa. Credeva fosselafame,maquando riuscìametterequalcosa sottoidenti–compròda unambulanteunaspecie di polenta da due soldi a base di farina di mais o simili – , il senso di disgustononsiattenuò. Nel pomeriggio arrivò la pioggia, un abbondante acquazzone primaverile. E quel rombo che si udiva in sottofondo si avvicinò, divenne all’improvviso più forte, spaventoso. La gente fu sopraffatta da uno strano terrore, tutti correvano, si addossavano ai muri, si infilavano negli androni e nei negozi scassinati man mano che il frastuono cresceva; gemevano, inveivano, le donne strillavano e piangevano impaurite. Poco più in là, sul muro di un edificio, avevano teso fra due finestre un’enorme bandiera rossa e nera con l’emblema dell’uccello. Budai e alcuni altri passanti si rifugiarono nel negozio di stoviglie all’angolo,edallavetrina spaccata si disposero a osservare quel che stava persuccedere. Arrivarono nuove truppe a bordo di carri armati, mezzi corazzati, motociclette, pezzi di artiglieria pesante. Portavano un’uniforme diversa: una tenuta chiara,quasibianca,eun casco mimetico. Due carri armati si fermarono proprio all’altezza del negozio, dei soldati sporsero la testafuoridallatorretta, si fecero dei segnali, si gridarono qualcosa gli uniaglialtri;perBudaila loro parlata era sempre un blaterare incomprensibile. Illorobreveconfronto produsse il seguente risultato:preserodimira la grande bandiera sul palazzo di fronte e senza tanti preamboli spararono. Si levò un nuvolone di fumo e polvere e crollò un bel pezzo di muro. Il colpo successivofecetremarei muri al punto che nel negozio di stoviglie i piatti, i vassoi, i vasi e i bicchieri caddero dagli scaffali e andarono in pezzi. Budai corse fuori a rotta di collo. Aveva ricominciato a piovere a dirotto, in meno di un minuto si ritrovò bagnato fradicio. Attraversò una zona dove non era mai stato: sembrava un quartiere operaio, un’infilata di caseggiatienormietetri, orrendi casermoni con innumerevoli e minuscolefinestre,ealla fineunapiazzalastricata di forma ovale, contornata dalle case. Le truppe motorizzate erano già là, giunte da un’altra strada, e la piazza era gremita di gente nonostante la pioggia. Solo in un secondo momento si accorse che erano tutte donne,vecchieegiovani, madri e bambine, sotto tantissimi ombrelli, e quandosimescolòaloro, per almeno dieci volte credettedivedereBebe. Le donne si avvicinarono ai soldati parlando tutte insieme e gesticolando. Ma quelli nonrisposero,nemmeno uno aprì bocca, rigidi come statue guardavano la pioggia con visi impenetrabili, le gocce ticchettavano sui loro elmetti. A Budai non era chiaro se tacessero perché parlavano un’altra lingua e non capivano, oppure per il divieto di parlare... Alla fine le donne si misero a cantare la marcia ben nota: Cetectopadebette Etekglöchrifefee Bügiütignemelaga Pecice...! L’ultima parola la gridarono in tono di sfida, con esasperazione, quasiavolerlagettarein facciaaisoldatiindivisa bianca;questiultiminon reagirono neppure ora. Nel frattempo la composizione della folla cominciò lentamente a modificarsi: a poco a poco arrivarono gli uomini. Si avvicinavano ai carri armati con aria apparentemente innocente, come se volessero solo curiosare, maBudainotòchealcuni nascondevanodellearmi sotto i cappotti. Si scambiavano sguardi d’intesaesimescolavano alla folla sempre più numerosi. Le donne a quel punto, come seguendo un piano prestabilito, si ritirarono concautela. Iniziò tutto con un fischio: all’improvviso la piazza riecheggiò di urla selvagge, di battaglia. Estratte le armi, gli uomini aprirono il fuoco sui carri armati, lanciarono bombe a mano e bottiglie esplosive piene di una sostanza strana, probabilmente fabbricate in casa. Nel contempo nuovi rinforzi usciti dai caseggiati si lanciarono nel combattimento con una dotazione analoga a quella degli altri: adesso erano in diverse centinaia ad attaccare i soldati. Disposti in formazioni singolari correvano a zigzag, cambiavano improvvisamente direzione, si gettavano a terra proni, poi si alzavano di scatto per scagliare le bombe e di nuovo si appiattivano sulselciato. Ma stavolta non ottennero un gran risultato. I carristi scomparvero dentro le torrette corazzate, i cannoni tuonarono, e la fanteria motorizzata reagì all’attacco impiegando armi automatiche a fuoco continuo. I ranghi degli attaccanti si ruppero, e ben presto decine di feriti si contorcevano sulla piazza. I carri armatisimiseroinmoto con un’agilità imprevista, e puntarono versoilfoltodellafolla:i cingoli schiacciarono senza pietà chiunque trovassero sulla loro strada, come mostruosi tritacarne: urla, frastuono rimbombante, la pioggia scorreva sporca e rossa sul selciato. Budai vide tutto questo da una certa distanza, ma fu travolto dall’angoscia, da una paurainfernaledimorire e, mentre si lanciava a perdifiato passando in mezzo a vivi e morti aveva la sensazione di essere inseguito da un carroarmatocheeralìlì per raggiungerlo e stritolarlo sotto il suo corpo d’acciaio. Aveva ancoralapistolaintasca, avrebbe voluto liberarsene, ma non osava gettarla via per nonattirarel’attenzione. Dall’altro lato della piazza ovale scorse un piccolo padiglione giallo con le colonne, sotto cui si riparavano in molti, e sidiresselà. Tutti si disperdevano, gli sconfitti scappavano soprattutto nelle case circostanti. E continuavano a sparare, dalle finestre e dalle aperture dei tetti, non volevano arrendersi. Allora i soldati con l’elmettosceserodailoro mezzi, li inseguirono fin dentro i palazzi, su per i piani: la battaglia proseguì nelle case tra spari e lampi di esplosioni,semprepiùsu fino ai sottotetti. E il drammagiunseallafine: un corpo precipitò dall’alto e cadde sul lastricatoumidoconuno schianto agghiacciante; poi un altro e un altro ancora,certigridavanoe scalciavanonell’aria,edi nuovocorpi,molticorpi, cadevano l’uno sull’altro e giacevano in pozze di sangueepioggia. Era una vista insopportabile: Budai si fecelargocontuttelesue forze verso l’interno del padiglione. Fu allora che si accorse che quella piccola edicola gialla era una stazione della metropolitana. Nell’atrio sotterraneo riuscì a gettare di nascosto la pistola in un cestino dei rifiuti. Una gran quantità di persone, in piedi o sedute per terra, riempiva le scale, i corridoi e le banchine, e la circolazione dei treni era sospesa. Si sentiva solo una voce atona gracchiare senza interruzione all’altoparlante. Faceva un caldo asfissiante, l’ariaeraumidapertutte quellepersonefradiciedi pioggia, e lui aveva riposato pochissimo negliultimiduegiorni:si rannicchiò in un angolo esiaddormentò. Sisvegliòbruscamente allo stesso suono col quale si era assopito: il gracchiare lontano e instancabile dell’altoparlante. Là sotto non c’era differenza tra il giorno e la notte, il viavai era immutato, la gente vagava nei corridoi oppure dormiva. Si trascinò fino in superficie, le porte del padiglione giallo erano state chiuse con una spranga di ferro, non si poteva né entrare né uscire, dei soldati in divisa bianca armati di fucile piantonavano l’ingresso. Attraverso la grata, nella luce fioca – eral’albaoilcrepuscolo? –, si vedeva solo che la piazza ovale e le strade intorno erano deserte, e che ogni angolo era presidiato dalle guardie: doveva esserci il coprifuoco. Decise di tornaregiùadormire. Quando si svegliò di nuovo,capìdaunrombo sotterraneo che la circolazione era ripresa, e sentì il familiare spostamento d’aria. La via verso l’esterno era di nuovo aperta: fuori il tempo era soleggiato e ventoso e il traffico di pedoni e veicoli movimentato come sempre. I morti erano spariti, e le tracce dei combattimenti celate da ponteggi e frettolose imbiancature. Budai si mescolò alla folla sul marciapiede e si diresse al negozio di stoviglie dove si era rifugiato: le vetrine erano state chiuse con assi di legno malavenditaeraripresa, anche se l’assortimento, così gli parve, era più scarso di prima. Sulla facciata di fronte, dove era stata cannoneggiata la bandiera, il buco era schermato con del canniccio. Il cambiamento era ancora più vistoso nel quartieredistruttodacui avevavistoandarsenegli abitanti rimasti senza casa. Le rovine erano state demolite e le macerie rimosse, il terreno era stato spianato e sembrava un normale spazio edificabile. Là dove erano state erette le barricate, non solo le avevanosgomberate,ma avevanoperfinoriparato il lastricato divelto. Più oltre, sul grattacielo in costruzione che aveva tante volte ammirato, e dal quale erano scesi gli operai per unirsi allo sciopero, fervevano di nuovo i lavori: adesso erano arrivati all’ottantunesimopiano. Tornò nella strada del palazzo grigio – per espugnarlo si era combattuto una notte intera. Aveva subìto danni troppo gravi per essere riparati in poche ore, ma era impacchettato dai ponteggi, come se dovesse essere restaurato, e le tracce dell’assedio erano invisibili; davanti al portone il relitto del carro armato era scomparso... Se Budai non avesse partecipato in prima persona agli eventi, dall’aspetto attuale della città non avrebbe potuto intuire nulla di quanto era successo. Di fianco al palazzo vide un parco: era la recinzionelungolaquale era fuggito per scappare dai fumogeni. Il bel tempo aveva attirato fuoridicasamoltagente, i bambini si rincorrevano sull’erba, qualchebarcadondolava sul laghetto, molti sedevano sulla riva, si erano tolti le scarpe e stavanocoipiediamollo nell’acqua... Si domandò se rivolte simili non fossero già avvenute in altreoccasioni.Ineffetti, le rovine affumicate in mezzo alle quali aveva cercato rifugio portavano i segni di battaglie precedenti. Poteva darsi che queste sommosse fossero un fenomeno necessario, una conseguenza inevitabile del modo di vivere di quel luogo, un’esplosione periodica dalla duplice funzione, arginare l’espansione demograficaeincanalare larabbia? Vendevano le solite salsiccette speziate, aveva abbastanza soldi percomprarseneunpaio e si mise in coda: erano ancora più buone delle altrevolte.Intornoaluii ragazzi correvano e giocavano a palla, gli innamorati si scambiavano baci, e le persone mangiavano, cantavano, ascoltavano il mangiadischi a tutto volume, prendevano il sole, dormivano, lanciavano sassi in acqua, si godevano la bella giornata. Avevano dimenticatocosìinfretta gli scontri e i morti? Gli pareva un tradimento, ma la cosa non lo intristiva. Mentre mangiava sdraiato sull’erba, quella loro avida voglia di vivere riempiva anche lui di allegria e di speranza. Adesso si sentiva in sintonia con loro, forse era addirittura felice. Appallottolò la carta delle salsiccette e la lanciònellaghetto. Fusolodopounpaiodi minutichesiaccorseche la palla di carta si era mossa sull’acqua. All’iniziopensòchefosse statoilventoaspingerla, manoneracosì:lefoglie sulla superficie del lago, le bollicine sotto il pelo dell’acqua, i pezzi delle canne e le alghe andavano tutti nella stessa direzione. L’acqua si muoveva! Lentamente, molto lentamente, scorreva.Provòdinuovo, gettò dei rametti: venivanotrascinatidalla corrente. La scoperta lo emozionò nel profondo, si sentì rinascere. Se era davverocosì,quell’acqua doveva sfociare da qualche parte... Si avviò lungo la riva per fare il giro del laghetto. Aveva una forma più o meno rotonda, con un diametro che non superavaidueotrecento metri. Da un lato una fontana di marmo vi riversava il suo getto, poco oltre avevano costruito una vasta terrazza, con una statua equestre su un alto piedistallo che si ergeva contro il cielo sereno. Le barchette colorate e leggere,dalfondopiatto, cullate sulla superficie increspata,eranoportate da ragazze e ragazzi che remavano fra grida di gioia. Trovò lo sbocco del lago dalla parte opposta alla fontana. Un corso d’acqua attraversato da due passerelle di legno, un ruscelletto tranquillo che serpeggiava verso il folto del parco. Erano acque basse e lente, il letto era molto stretto, bastavano due passi dall’una all’altra sponda, maperpiccoloemodesto che fosse, prima o poi sarebbe confluito in un fiume, e il fiume nel mare.Elìavrebbepotuto trovare un porto, una nave, e sarebbe stato libero di andare ovunque! Non voleva più pensareall’uomocheera stato fino a cinque minuti prima, come se non ci fosse più. Ormai doveva solo seguire quell’acqua senza mai perderla, lungo la riva – altrimenti poteva affittare una barca, o rubarla, insomma se la sarebbe procurata! Gli sembravagiàdisentireil rumoredelmare,eilsuo odoreintensoesalato,di vedere il blu scintillante e i riccioli delle onde dalle forme sempre nuove sul suo specchio in movimento, e i gabbianichescendevano in picchiata... Addio Epepe, pensò. Era pieno difiducia,prestosarebbe arrivatoacasa.
Scaricare