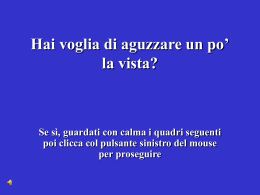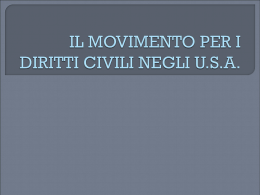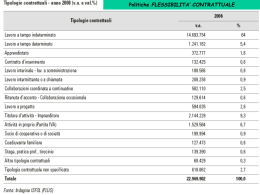Paola Somma, 2004, Casa, integrazione e segregazione, in Coin F. (ed.), Gli immigrati, il lavoro, la casa: tra segregazione e mobilitazione, Angeli, Milano, pp. 121-136 Casa e integrazione sociale Affrontare il tema dei rapporti tra casa e integrazione sociale comporta il rischio di ripetere ragionamenti e considerazioni note al limite dell’ovvietà. Che la casa non vada esclusivamente intesa nel senso fisico di «un tetto sopra la testa», ma che rappresenti un indicatore fondamentale del livello di integrazione all’interno di una determinata società e, al contempo, uno strumento decisivo per la partecipazione di individui e di gruppi alla vita della stessa società, è un’opinione ampiamente condivisa anche da chi guarda al problema da posizioni ideologiche diverse e con differenti obiettivi e priorità. A partire dalle formulazioni teoriche e dagli esperimenti messi in opera dai riformatori sociali tra la fine dell’ottocento e gli inizi del novecento, alla casa è sempre stata attribuita la funzione di favorire l’educazione e l’emancipazione dei lavoratori, di essere quindi un’indispensabile premessa alla loro integrazione. Anche molte iniziative paternalistiche, come i villaggi e le città operaie realizzate da alcuni imprenditori nello stesso periodo, pur motivate dall’intento principale di legare indissolubilmente il lavoratore al luogo del lavoro, si prefiggevano di rafforzarne l’adesione a dei valori condivisi e l’appartenenza stabile, seppure in condizioni di subordinazione, alla comunità. In ogni caso, che la preoccupazione principale fosse la conquista di una maggiore dignità per le famiglie dei lavoratori o il mantenimento di una struttura fortemente gerarchizzata, la disponibilità di una casa era considerata la prima tappa dell’inserimento in un nucleo di vita associata, mentre la diffusa inadeguatezza della condizione abitativa era percepita come un pericoloso segnale di mancata integrazione sociale. Dopo quei primi tentativi, il legame tra casa e integrazione non ha mai smesso di attrarre l’attenzione di studiosi di variegata formazione disciplinare e resta tuttora oggetto di dibattito e scontro politico per i legislatori e gli amministratori a livello nazionale e locale. Malgrado il tema sia stato sviscerato da molteplici punti di vista ed abbia dato luogo, in momenti e contesti diversi, ad una miriade di indagini, proposte, esperienze, esistono, però, buone ragioni per le quali è ancora utile e rilevante occuparsene. Uno dei principali motivi di interesse deriva, a mio avviso, dal fatto che non c’è un’unica e immutabile configurazione spaziale corrispondente a una 1 determinata organizzazione sociale. Al contrario, tutte e due le componenti del binomio spazio- società sono in continua trasformazione e si influenzano producendo esiti concreti che non ripresentano mai gli stessi connotati. Come ogni fase della ristrutturazione economica ha la sua questione delle abitazioni, nel senso che le «imperfezioni» del mercato impediscono a gruppi più o meno ampi di popolazione l’accesso ad una casa decente a un prezzo ragionevole, così l’integrazione o la mancanza di integrazione, l’adozione di politiche per una maggiore integrazione o al contrario di politiche finalizzate ad impedirla hanno come bersaglio gruppi variamente caratterizzati, ma che, comunque, possono essere definiti una minoranza, non perché necessariamente minoritari dal punto di vista numerico, ma perché minori sono le scelte e le capacità negoziali loro concesse e minore o inesistente è il loro potere. In questo senso è non solo giustificato, ma opportuno, che la riflessione sulle relazioni tra casa e integrazione sociale faccia riferimento specifico alla condizione degli immigrati extracomunitari, il che non significa che per tutti gli altri cittadini l’integrazione sia garantita, ma che nel momento attuale il rifiuto all’integrazione incanalato politicamente e consapevolmente alimentato a tutti i livelli istituzionali colpisce soprattutto questa minoranza. L’eccesso di enfasi con il quale si parla e si affronta il problema della casa degli immigrati, o piuttosto non si affronta lasciandolo alla «mano sapiente» del mercato, è una manifestazione del modo nel quale si sta costruendo la cosiddetta emergenza dell’immigrazione, mentre i concreti problemi delle persone immigrate vengono ignorati o trasformati in questioni di ordine pubblico e di repressione. Tale progetto ha contemporaneamente valenza economica, politica e simbolica. Per contrastarlo e modificarlo in senso democratico, non bastano generici appelli alla tolleranza, ma è necessaria una sistematica opera di svelamento e divulgazione dei meccanismi che lo sostengono, nonché un’accorta e incisiva campagna di promozione di modelli alternativi. Il termine integrazione è frequentemente usato come sinonimo di assimilazione, cioè l’inserzione di nuovi membri in una comunità esistente con la conseguente perdita di ogni riconoscibilità ed identità da parte del gruppo più debole. Altrettanto spesso viene contrapposto a quello di segregazione, per denotare la mancanza di impedimenti alla mescolanza residenziale e di norme che impongano la separazione dei vari gruppi sociali. Senza addentrarci in una disanima comparativa delle numerosi definizioni disponibili, va almeno ricordato che il contatto tra popolazioni diverse può dar origine, oltre alle due manifestazioni estreme dell’annientamento o 2 dell’inserimento senza conflitti, ad una gamma di situazioni intermedie nelle quali la coesistenza può essere il primo passo verso un maggiore livello di integrazione o la sua completa negazione. Ad esempio, si può verificare una stratificazione, cioè una certa mescolanza accompagnata da una significativa disparità di risorse e di potere o il pluralismo, che consente il mantenimento delle varie specificità a prezzo di una più o meno marcata separazione fisica. Nel contesto in cui questa riflessione si colloca, mi sembra ragionevole parlare di integrazione nel senso banale di normalità, considerando normale l’uguaglianza di diritti e doveri nella sfera pubblica e relegando ogni diversità all’ambito privato. Il che non vuol dire, ovviamente, che tale normalità sia la norma, ma che è appropriato ritenere un indispensabile presupposto all’integrazione degli immigrati extracomunitari il poter vivere nelle tipologie standard della popolazione locale, la mancanza di preclusioni per l’ingresso in determinati segmenti del mercato delle abitazioni, la possibilità di insediarsi in qualunque parte del territorio. Viceversa, la difficoltà o l’impossibilità di accedere ad un alloggio, non solo per la mancanza di sufficienti risorse finanziarie, anche se la povertà rimane certamente una delle cause principali del disagio abitativo, è un sicuro segnale di non integrazione, di esclusione o, come si usa dire ora, di mancanza di coesione sociale. Il rifiuto all’integrazione La riluttanza ad avere determinati vicini di casa può dar luogo a due reazioni, il rifiuto a far entrare gli individui ed i gruppi indesiderati all’interno dello spazio con il quale una comunità si identifica, o l’uscita dallo stesso spazio per non condividerlo con i nuovi arrivati. No black, coloured do not need to apply, non si affitta a meridionali, no makeroni, con questi e simili testi i cartelli razzisti esposti nei sobborghi delle città nordamericane, a Londra negli anni ’50, a Torino durante la grande immigrazione dalle regioni del sud, in Germania pressappoco nello stesso periodo, intimavano con rozza efficacia ai membri di ben precisi gruppi di popolazione di non avvicinarsi. Il rifiuto di un singolo proprietario ad affittare un alloggio, non per un giudizio circa le specifiche caratteristiche di un individuo e della sua famiglia, ma per un giudizio a priori, cioè un pregiudizio nei confronti di chiunque sia riconosciuto come appartenente ad una determinata categoria definita sulla base di caratteristiche etniche e/o razziali o della provenienza geografica, è la forma più esplicita di discriminazione. Ma ancor più significativa 3 del rifiuto ad affittare, che può in parte dipendere da più o meno giustificate preoccupazioni circa l’affidabilità dell’affittuario, è l’indisponibilità a vendere. Una forma di discriminazione, quest’ultima, apparentemente incomprensibile in un sistema di mercato e che più palesemente di altre ha il significato di divieto di ingresso in un territorio anche a chi potrebbe permetterselo. Questo tipo di situazione, nella quale l’accesso alla casa non è unicamente funzione del reddito, presuppone l’esistenza di una domanda solvibile da parte di gruppi non graditi e di un sistema legale e normativo che consenta di escluderli, che consenta cioè una vera e propria discriminazione su base etnica e razziale. Simili comportamenti sono stati per lungo tempo abituali negli Stati Uniti, dove hanno goduto di sanzioni ufficiali, sono stati praticati non solo dai privati proprietari e dalle agenzie immobiliari, ma dalle istituzioni governative e, infine, sono stati dichiarati illegali in seguito alle lotte per i diritti civili. Il Civil right act del 1968 dedica, infatti, un apposito titolo al fair housing, che vieta ogni discriminazione di «razza, colore, religione, sesso, nazione d’origine, nella vendita o nell’affitto di una casa», elenca i metodi e le tecniche discriminatorie più diffuse e descrive le procedure che le vittime devono seguire per chiedere i risarcimenti. Oltre trent’anni dopo la messa fuori legge delle pratiche discriminatorie individuali e istituzionali, numerose inchieste e denunce dimostrano che la segregazione non è scomparsa e che i diversi gruppi sociali, nel caso specifico i bianchi e i neri, non si sono integrati. L’intreccio di pregiudizi, discriminazione e speculazione- dal momento che indurre la trasformazione di un quartiere da tutto bianco a tutto nero, o viceversa, comporta variazioni nei prezzi che si traducono in guadagni per gli operatori immobiliari- non è stato districato. Da un lato il problema evolve e si ridefinisce in nuove forme, dall’altro precedenti situazioni persistono e si sovrappongono a fenomeni non previsti. Persino gli stessi progressi raggiunti grazie all’applicazione della legge si sono trasformati nell’inizio di nuovi problemi perché, ad esempio, l’inserimento di famiglie nere in quartieri bianchi ha provocato la fuoriuscita di questi ultimi e quindi l’inizio di una risegregazione e perché la mobilità delle famiglie nere non si è verificata ovunque, ma si è indirizzata più facilmente verso le aree dove già esisteva una certa mescolanza, con il risultato di accelerarne la trasformazione in zone tutte nere. Molte famiglie nere con un reddito medio si trovano, così, di fronte alla scelta tra l’abitare in un quartiere di buona qualità e abbastanza misto razzialmente, a prezzo di un forte isolamento sociale e di uno scarso potere politico, o rimanere in un’area con una 4 grande concentrazione di neri e quindi una forte rappresentanza, ma con un più basso livello di condizioni residenziali e ambientali in conseguenza della complessiva debolezza socioeconomica. In realtà, la segregazione precedente significava ineguaglianza, ma l’integrazione attuale è possibile solo a condizione di rimanere minoranza, al punto che molti ritengono l’integrazione residenzialel’ideale di neri e bianchi insieme- un problema secondario. La consapevolezza che le nuove regole consentono la vicinanza fisica dei neri ai bianchi, ma non eliminano le cause dell’ineguaglianza economica e politica, cioè della disparità di potere, e che l’integrazione residenziale è spesso in conflitto con gli obiettivi della coesione sociale e della rappresentanza politica, ha fatto perdere importanza all’integrazione come fine a se stessa. Ne derivano due considerazioni, la prima che un sistema legale equo che vieti la discriminazione è necessario, ma di per sé non garantisce l’integrazione, l’altra che la contiguità fisica delle abitazioni di famiglie con caratteristiche diverse non è automaticamente sinonimo di integrazione. Non è infrequente che all’impossibilità di accedere a determinati segmenti del mercato abitativo corrisponda, a scala urbana, il divieto per alcune categorie di popolazione di abitare in specifiche parti del territorio, nonché l’obbligo di insediarsi solo in altre ben delimitate porzioni. In questi casi, non si tratta di atteggiamenti individuali, seppure accettati dalla collettività, ma di comportamenti istituzionalmente riconosciuti e praticati dalle stesse autorità. La selezione e destinazione di ambiti spaziali ad uso esclusivo di gruppi di popolazione omogenea secondo criteri etnici e/o razziali, con la premeditata esclusione di altri, richiede oltre che la stesura di documenti e mappe, un vero e proprio piano e adeguati strumenti per la sua attuazione. La forma più esplicita di discriminazione a scala urbana è la zonizzazione etnica, cioè un provvedimento amministrativo che individua e delimita le aree nelle quali, per legge, alcuni gruppi non possono abitare né possedere una casa e quelle dove tale facoltà è loro concessa o imposta come unica localizzazione possibile. Dalle zoning ordinances adottate negli Stati Uniti, alcune delle quali sono state abrogate solo dopo la fine della seconda guerra mondiale, ai piani delle città sudafricane nel periodo dell’apartheid, gli esempi documentati sono molti e ormai ampiamente conosciuti, ma non è superfluo ricordarne alcune caratteristiche fondamentali. Benché la zonizzazione etnica sia stata pensata ed attuata con intenzioni ed effetti che penalizzavano i neri, in entrambi i casi erano previste limitazioni anche alla libertà di scelta dei bianchi che non potevano insediarsi o acquistare proprietà 5 al di fuori dei loro settori, il che non lascia dubbi sulla volontà di escludere ogni possibilità di integrazione. Inoltre, la separazione residenziale non era solo il frutto di un’ideologia perversa, ma una scelta razionale in funzione dell’ineguaglianza. Essere autorizzati ad abitare solo all’interno del territorio loro assegnato, significava per i neri anche godere di minori diritti, perché i regolamenti municipali sancivano la legittimità di requisiti e caratteristiche igieniche delle abitazioni diversi da quelli dei quartieri bianchi, di diversi standards per la dotazione dei servizi e per la manutenzione, di una più scadente qualità residenziale e urbana. Infine, contrariamente a quanto la propaganda uffciale cercava di far credere, la segregazione non era un fatto naturale, una circostanza spontanea che il governo accettava e si incaricava di regolare. La mescolanza, invece, era abituale, ma la separazione era il primo passo per la messa in opera di un sistema di ineguaglianze accumulate, necessario all’instaurazione di un nesso pressochè assoluto fra colore nero e povero. Nelle città sudafricane, la volontà di usare la separazione residenziale per rendere più acuta l’ineguaglianza era evidente già prima dell’entrata in vigore della legislazione per l’apartheid. Negli anni ’30, la principale fonte preoccupazione per le autorità era il gran numero di poor whites, cioè di bianchi che vivevano mescolati ai neri in slums così degradati che «il pericolo di epidemie era considerato di pari gravità a quello di far guadagnare favori al comunismo». L’unica soluzione trovata per migliorare le loro condizioni fu di farlo a spese dei neri. Si cominciò, quindi, con l’imporre un mercato del lavoro separato, il divieto di transazioni immobiliari e il divieto di promiscuità residenziale. In seguito, dopo le elezioni del 1948, per il cui esito il voto dei bianchi poveri fu determinante, si decise che gli slums erano il risultato della mescolanza razziale e che, per risolvere il problema alla radice, occorreva rimuovere i neri e metterli in apposite e ben confinate townships. Infine, il Group areas act del 1968 istituì il Ministero per lo sviluppo delle comunità, una denominazione tragicamente incongrua per una struttura che aveva l’incarico di vigilare per impedire qualsiasi forma di integrazione. Tra i suoi compiti c’erano quelli, una volta designate le zone di pertinenza di ciascuna comunità, di risistemare le persone «non qualificate», cioè i membri di un particolare gruppo di popolazione residenti, proprietari, o esercitanti attività economiche in un’area assegnata ad un altro gruppo, di assistere queste persone a disfarsi delle loro proprietà e di aiutare quelle qualificate ad acquistarle, di sviluppare efficaci zone cuscinetto per ridurre le possibilità di contatto, di effettuare operazioni di rinnovo edilizio e urbano e di operare con le autorità locali nelle diverse fasi della programmazione 6 e realizzazione dell’apartheid. E’ tristemente nota la ferocia dei deterrenti e delle misure punitive impiegate contro chi cercava di opporsi a queste norme, dalla distruzione degli spazi misti all’erezione di invalicabili barriere fisiche, al massiccio impiego della polizia e dell’esercito. Dove i comportamenti discriminatori dei privati come quelli istituzionalmente razzisti non sono più tollerati, almeno ufficialmente, o dove la consistenza numerica della minoranza rende difficile la sua completa separazione, la non integrazione viene perseguita e raggiunta attraverso l’autosegregazione di chi può scegliere. L’uscita da un determinato territorio di coloro che, per non subire la vicinanza dei nuovi arrivati o comunque di individui e gruppi considerati diversi, sceglie di autorinchiudersi in spazi confinati, protetti dagli intrusi, accessibili solo a chi ne fa parte perché li possiede, ha come conseguenza la moltiplicazione di quartieri esclusivi e di insediamenti recintati e dotati di propri sistemi di vigilanza, spesso armata. In genere, si tratta di insediamenti costruiti ex novo, dove si crea una comunità il cui legante è l’affinità di reddito e ideologica. Concentrazione e dispersione delle minoranze I comportamenti pubblici e privati, dei quali si è delineata una schematica tipologia, non si manifestano ovunque con la stessa intensità e le medesime forme. Assumono caratteri anche molto diversificati, la cui variabilità può essere ragionevolmente ricondotta alla concomitanza di una serie di condizioni che, nel loro complesso, costituiscono una sorta di filtro nazionale. Tra i vari elementi che concorrono alla definizione di questi filtri, è essenziale il livello di democrazia, definibile in base alle caratteristiche del sistema rappresentativo e legale, del mercato del lavoro, dell’organizzazione del welfare, del sistema familiare e della comunità che promuove l’integrazione interpersonale. Se uno o più di questi sistemi manca o non è adeguato, è assai probabile che si registri una diffusa non integrazione. Dal momento che la casa è uno dei più cospicui indicatori di ineguaglianza, perché status sociale, reddito, identità razziale e di classe sono intimamente legate con il tipo di alloggio, la sua localizzazione e le sue condizioni intrinseche e ambientali, è evidente che le vicende dell’edilizia residenziale pubblica forniscono elementi importanti circa gli atteggiamenti nei confronti dell’integrazione in diversi paesi e momenti storici (Huttmann, 1991). Le autorità preposte all’edilizia sociale hanno generalmente 7 oscillato tra la propensione e gli espliciti inviti a concentrare le minoranze in un numero ristretto di edifici, isolati, quartieri, fino a incoraggiare una vera e propria segregazione, e l’intenzione dichiarata di voler favorire l’integrazione attraverso la dispersione, una pratica che, a sua volta, esponendo le famiglie al rischio di aggressioni e allungando artificiosamente il tempo in lista d’attesa, ha spesso avuto risultati altrettanto discriminatori. Un esempio classico del primo tipo è il comportamento della Federal housing authority, che ha costantemente raccomandato l’omogeneità sociale e razziale come mezzo per stabilizzare la struttura demografica di un quartiere, nonché i suoi valori immobiliari, mentre nelle città europee sono frequenti i tentativi di dispersione delle minoranze. La tecnica della dispersione è sostanzialmente simile ovunque, ma il significato e la portata dei più o meno ingegnosi sistemi di quote escogitati può sfuggire, se non si tiene conto delle differenze nella composizione sociale e nel quadro istituzionale dei contesti di applicazione. In Olanda, negli anni della ricostruzione e del boom economico, non solo gruppi a basso reddito ma molte famiglie di buona condizione abitavano nell’edilizia pubblica, che offriva un numero di alloggi superiore a quelli del mercato privato. Grazie ad un livello del welfare in grado di influenzare positivamente anche le condizioni degli immigrati ed a sistemi di allocazione degli alloggi che usavano le stesse regole per tutti, i membri delle minoranze etniche erano abbastanza distribuiti nel territorio urbano e si potevano permettere una condizione abitativa decente, cosicchè, malgrado l’alto numero di immigrati dalle colonie e di lavoratori dall’area mediterranea, non c’erano veri e propri ghetti etnici. Fenomeni di concentrazione nei più vecchi quartieri centrali sono apparsi solo quando le famiglie olandesi hanno cominciato a trasferirsi verso i sobborghi. Ed è a questa «concentrazione per sottrazione» che le municipalità hanno cercato di reagire con la dispersione. Rotterdam, ad esempio, ha introdotto nel 1972 la regola del 5%, che consisteva nel non concedere il permesso di soggiorno nei quartieri dove le minoranze già raggiungevano tale percentuale. Nel 1979, la norma è stata modificata con l’introduzione del cosiddetto clustering volontario, cioè l’incoraggiamento a spostarsi in alcuni distretti di più recente costruzione, ognuno dei quali avrebbe dovuto ospitare una sua minoranza. Nel 1983, infine, ogni tentativo ufficiale di dispersione è stato abbandonato in applicazione agli indirizzi nazionali che suggerivano di «promuovere condizioni per l’emancipazione e la partecipazione di tutti, ridurre le diseguaglianze socioeconomiche, prevenire la discriminazione» (HBE, 1998). A Francoforte, dopo aver lasciato che le minoranze si concentrassero nelle zone più 8 degradate e con scarsità di servizi, solo in un secondo tempo si è optato per la dispersione, escludendo i nuovi arrivati dall’edilizia sociale in quei quartieri dove già raggiungevano il 30%. Queste misure, motivate dalla impossibilità di reagire ai problemi e alle tensioni generate dalla precedente concentrazione con interventi costosi, che avrebbero avuto pesanti ripercussioni sui bilanci locali, improponibili in un momento di crisi generale del welfare, e che si sarebbero scontrati con una forte riluttanza della popolazione «normale» a cooperare, hanno aggravato la discriminazione senza migliorare le condizioni di nessuno. Anche in Gran Bretagna, prima si è consentito al mercato di generare un modello di segregazione residenziale e, poi, si è imboccata la via della dispersione. Negli anni ’50 e ’60, i black britons, in conseguenza dell’esclusione di fatto dall’edilizia pubblica e del loro basso reddito, sono state confinati nelle aree centrali e nella prima corona periferica di un numero ristretto di città. Quando la responsabilità di trattare i problemi etnici con riferimento alla politica della casa è stata gradualmente trasferita alle autorità locali, le minoranze sono state discriminate dai criteri discrezionali dei funzionari, risultanti in maggiori ostacoli all’accesso, nella sistemazione negli alloggi più scadenti, in difficoltà a spostarsi verso situazioni migliori. L’adozione, nel 1976, del Race relations act comprendente direttive e regole contro la discriminazione, è arrivata troppo tardi per invertire la tendenza, perché all’abbandono delle pratiche di dispersione non ha fatto seguito la ricerca di una maggiore equità sociale, ma la distruzione dell’egemonia delle autorità locali, la massiccia privatizzazione del patrimonio pubblico e, in sostanza, la disponibilità di minori opportunità per tutti. Il livello complessivo e le modalità di funzionamento del welfare sono decisive anche per spiegare le differenze tra paesi, come ad esempio la Francia e la Svezia, dove il medesimo criterio dell’assimilazione è la giustificazione ufficiale della dispersione. In Francia, dove l’appartenenza ad un’etnia non può essere utilizzata con riferimento a nessun cittadino- tutti sono e devono sentirsi francesi- l’inserimento comporta per i nuovi arrivati la perdita di ogni distinzione e l’esistenza di quartieri etnici non è ritenuta accettabile. In realtà, le condizioni di quelli che arrivavano d’oltremare tra gli anni ‘50 e ‘60 erano tali da consentire loro d’insediarsi solo in villaggi di baracche e in alloggi inabitabili. Quando, in seguito ad una massiccia produzione di alloggi pubblici si è raggiunto un teorico equilibrio tra domanda e offerta, l’indicazione ufficiale è stata di disperdere le minoranze etniche per favorirne l’integrazione e prevenire la formazione di ghetti, ma, di 9 fatto, la segregazione è stata abitualmente incoraggiata alla scala di isolato o di gruppi di edifici. Le successive iniziative di rinnovo delle abitazioni ed i tentativi di avvicinare la popolazione più in difficoltà verso le località meglio dotate di servizi si sono scontrati con la contraddizione tra la volontà di indurre anche le famiglie a reddito medio ad insediarsi nelle zone sfavorite, per invertire il ciclo del degrado, e quella di aiutare soprattutto i più bisognosi. Dal presupposto che la mescolanza e la prossimità residenziale attenuano le distanze sociali e che, quindi, si può perseguire la mescolanza senza alterare le cause delle ineguaglianze, traggono origine le più recenti direttive circa la necessità di disperdere i poveri, di renderli spazialmente minoritari per favorirne l’integrazione. L’integrazione, intesa come un misto di famiglie con differenti caratteristiche demografiche socioeconomiche ed etniche è stata un costante obiettivo della politica della casa anche in Svezia, dove «la nazione è una comunità politica» e chiunque ne accetti le regole e adotti la cultura può diventare un cittadino. Nel periodo della crescita, il governo statale stipulava accordi con gli enti locali circa il numero di rifugiati e di immigrati che ciascuno avrebbe accolto e distribuiva fondi adeguati per la casa, l’istruzione e i servizi sociali. In seguito, si è accettato il modello della società multiculturale, ma non la creazione di comunità con una base territoriale. Una legge del 1975, infatti, riconosce l’esistenza legittima di differenze culturali e la formazione di comunità etniche le quali, però, non devono identificarsi con ambiti territoriali per evitare il pericolo che la libertà di scelte culturali possa indebolire il rifiuto della segregazione spaziale. In realtà, concentrazioni etniche esistono anche in Svezia, ma, fino a quando la prosperità generale e adeguate forme di redistribuzione hanno reso possibili dignitose condizioni di vita per tutti, si è riusciti ad evitare quelle forme di segregazione e discriminazione, che sono poi apparse in modo preoccupante con l’affermazione di un modello di stato neoliberista, che teorizza lo sviluppo ineguale e considera le minoranze «un partner non adatto perché non può essere usato per competere». Cittadini a tempo determinato Un buon sistema di welfare non elimina le diseguaglianze sociali, ma ne spunta gli estremi, ed è per questo che le esperienze europee mostrano significative differenze per quanto riguarda la politica dell’integrazione sociale, in senso lato e nei confronti degli immigrati e delle minoranze etniche in particolare. A partire dai primi anni ’70, 10 però, tali differenze tendono a scomparire, perché ovunque prevalgono le restrizioni all’ingresso di nuovi cittadini e tagli e riduzioni alle prestazioni del welfare. Tutti i governi hanno drasticamente ridimensionato, se non eliminato, l’erogazione di fondi all’edilizia pubblica per sostenere il mercato, hanno messo in discussione la politica di cittadinanza e adottato misure per il rimpatrio obbligatorio degli stranieri e, perfino, per negare l’asilo ai rifugiati politici. A proposito della questione della cittadinanza è opportuno ricordare che, nella maggior parte dei paesi europei, gli ostacoli all’integrazione residenziale e sociale hanno colpito e colpiscono sia fasce deboli della popolazione indigena che persone di altra nazionalità. In Germania, ad esempio, la discriminazione che, prima della riunificazione, riguardava prevalentemente gli immigrati provenienti dal bacino mediterraneo, colpisce ora anche cittadini tedeschi; in Italia, le prime vittime sono stati i lavoratori che dal meridione si spostavano al nord e solo negli anni più recenti gli immigrati extracomunitari; in Gran Bretagna, Francia, Olanda sono discriminati individui e gruppi che, a seconda del momento del loro arrivo, hanno la cittadinanza o sono stranieri. La variabilità nel tempo e nello spazio delle categorie di persone più esposte alla discriminazione conferma, oltre al fatto che nessuno dovrebbe ritenersene completamente al riparo, che l’etnicità non è un dato di natura, ma una costruzione culturale. In Gran Bretagna, il censimento etnico del 1991 ha elencato 10 categorie di popolazione, i bianchi e nove tipi di colorati- solo i bianchi non necessitano ulteriori suddivisioni. Anche le municipalità olandesi censiscono i residenti di «etnia non olandese» raggruppandoli in una serie di sottogruppi ed i dati dell’ultima rilevazione del 2001, a pochi mesi dall’entrata in vigore della moneta unica, includono italiani, spagnoli, e greci sotto la voce «etnia nord mediterranea» o «sudeuropea». Non si tratta di sfumature linguistiche, ma di scelte importanti, perché la catalogazione etnica è inevitabilmente il presupposto della discriminazione e può facilmente tradursi spazialmente nel vietare l’ingresso in un territorio, o meglio consentirlo solo per alcune funzioni e attività, il lavoro ed eventualmente il consumo. L’esclusione dalla casa non è necessariamente sinonimo di esclusione dal mercato del lavoro. Al contrario, la sistematica discriminazione ha come bersaglio principale quei lavoratori che si vogliono mantenere in una situazione di precarietà escludendoli dalla casa, giustamente considerata come la base della stabilità, il punto di partenza per un’integrazione- ed i diritti che ne derivano- che non si intende accettare. Del resto, l’attribuzione ai lavoratori dell’etichetta di temporaneo non è un fenomeno nuovo. Il gioco della parti tra gli 11 industriali del nord est, con i loro allarmi «senza immigrati chiudiamo», ed i sindaci e gli amministratori che chiedono espulsioni di massa, ha illustri, si fa per dire, precedenti. Per limitarsi ad un esempio, meritano di essere citate le decisioni di una commissione governativa del Sud Africa che, già nel 1921, sancì il principio che «i neri devono essere autorizzati ad entrare in città solo come lavoratori temporanei» e le dichiarazioni del primo ministro De Verwoerd che, nel 1956, ribadì il concetto «l’indigeno che entra nelle aree dei bianchi lo fa solo per servire». I guestarbeiter europei, che sono indispensabili all’economia, ma hanno diritto solo a un inserimento temporaneo, a rotazione, sono la versione democratica dell’idea della temporaneità che, spesso, viene abbinata a quella della selettività. La giustificazione deriverebbe dalla circostanza che gli scambi internazionali comportano non solo movimenti di beni e servizi, ma anche di popolazione e che i paesi ospiti devono comportarsi come le imprese che cercano determinati tipi di lavoratori e stabilire politiche tali da attirare determinati tipi di migranti. Are we competitive in the immigration market? Con questa do manda, si sintetizzava, nel 1990, l’urgenza di indagare per stabilire «se gli immigrati attratti dagli Stati Uniti sono più addestrati e produttivi di quelli che decidono di andare altrove, ad esempio in Canada o in Australia» (Borjas, 1990). Negli anni successivi la terminologia ed il linguaggio da import export- si parla di flussi e di stock di immigranti- sono diventati abituali ed una simile logica è sancita anche dai documenti dell’Unione Europea, nei quali si riconosce che un’immigrazione controllata può «alleviare carenze di manodopera» a patto che si verifichi nell’ambito di una complessiva strategia e che sia governata (Commission of the European Communities, 2000). Non stupisce, quindi, che le direttive europee contro la discriminazione appaiono basate più sull’affermazione del diritto alla libera scelta in un libero mercato, che non a preoccupazioni per la mancanza d’integrazione sociale. Il marketing sociale Il lavoratore è contemporaneamente uno dei fattori di produzione e un consumatore, in quanto fattore di produzione la sua precarietà ne riduce il costo, in quanto consumatore/cliente la sua precarietà lo rende più ricattabile e senza difesa anche nel mercato dell’abitazione. Aumentare la precarietà degli immigrati può indurre un senso di stabilità, più o meno fittizia, per i nativi, che possono essere portati a credere che una volta eliminati gli intrusi potranno vivere liberi e felici nel loro territorio, finalmente «paroni a casa nostra». Se il 12 mantenimento dell’inequità sociale richiede sia una base materiale che un adeguato apparato normativo, anche il livello di sostegno che una determinata comunità è disposta ad offrire a politiche che affrontino le ineguaglianze è in misura non piccola legato al benessere e, soprattutto, al senso di sicurezza dei suoi membri, nonché al tipo di leadership locale. In un momento come l’attuale, nel quale, a causa della ristrutturazione produttiva ed economica, «la gente cerca compensazione nei posti dove vive, cerca disperatamente nella comunità residenziale quel senso di coesione e di stabilità che non trova più nel luogo di lavoro» (Sennett, 1995), l’idea di comunità rischia di perdere ogni valore costruttivo per diventare solo il rifugio contro un mondo ostile. Ne è prova la diffusa popolarità di progetti politici basati sulla frantumazione sociale, sul localismo e sull’esaltazione dell’identità, progetti ai quali spesso incautamente si irride liquidandoli come folcloristici con il rischio, da un lato di non comprenderne la bieca efficacia, dall’altro di non accorgersi che proprio al livello locale possono sorgere tentativi di segno opposto, iniziative che rifiutano l’inevitabilità del peggio, come i contributi raccolti in questo volume bene testimoniano. La promozione della diversità come elemento di arricchimento e non solo fonte di paura ed il coinvolgimento delle comunità per cambiare il corso delle attività di governo, o la loro mancanza, non è un fenomeno che si sviluppa spontaneamente (Boal, 2000). Richiede attenzione, professionalità e risorse capaci di far maturare una diffusa consapevolezza che la migliore politica per l’integrazione è una buona politica sociale, fatta di misure per la casa, per l’istruzione, per maggiori opportunità che recano beneficio a tutti e indirizzare conseguentemente chi prende le decisioni. Iniziative delle autorità municipali contro la discriminazione e il razzismo si segnalano in molte città, alcune amministrazioni si sono dotate di strutture per monitorare e combattere la discriminazione, è stata creata la rete delle cosiddette città aperte, l’associazione delle città unite ha messo a punto la carta europea per la salvaguardia dei diritti umani ed in qualche caso si fa anche esplicito riferimento all’integrazione come obiettivo. Queste esperienze non sono sempre confontabili e un bilancio dei loro risultati concreti non è agevole (OECD, 1996), ma la loro potenzialità non va sottovalutata. Tra gli esempi di maggiore interesse, mi sembra possano essere incluse due iniziative: la campagna per l’integrazione promossa dal comune di Vienna e l’attività della Racial diversity task force di Oak Park, un quartiere dell’area metropolitana di Chicago. In tutte e due le situazioni, la casa è il fulcro di un progetto che non prevede solo reazioni difensive e che si articola in una serie di azioni coordinate. Nel territorio del 13 municipio di Vienna risiedono 275.000 immigrati, circa il 17,7% della popolazione, che non sono cittadini austriaci. Nel 2000, il Dipartimento per l’integrazione, i problemi delle donne, la protezione del consumatore e del personale, preoccupato perché una larga parte della popolazione indigena mostra un atteggiamento molto negativo nei confronti della cosiddetta questione degli stranieri e perchè la mistura di paura, insicurezza e incerte prospettive alimentata da campagne elettorali e dibattici politici fortemente emotivi produce problemi i cui effetti si constatano quotidianamente, ha avviato una campagna denominata Miteinander (insieme). Alla campagna biennale, finanziata con 24 milioni di scellini, collaborano molte istituzioni non governative e in particolare il Wien integration fund, un’associazione non profit per la promozione di una vita «rispettabile, eguale e aperta» per tutti gli abitanti. Alcune delle sue richieste non sono ancora state ufficialmente accolte dalle autoritàad esempio l’introduzione del diritto di voto per gli immigranti nelle elezioni locali, il diritto ad affittare alloggi di proprietà municipale indipendentemente dalla cittadinanza e dalla durata della residenza, l’esenzione della riunificazione familiare dalle quote annuali, il libero accesso al mercato del lavoro, la realizzazione di una legge nazionale contro la discriminazione- ma il fondo esercita una pressione molto importante. La campagna, il cui motto centrale è «diamo una possibilità alla coesistenza», è costruita su pochi punti molto concreti e facilmente comprensibili e su alcuni progetti pilota in cinque principali settori di intervento: una gamma variata e ben organizzata di corsi di lingua, dei programmi di addestramento e di istruzione superiore per i giovani, un forte sostegno alle donne in diversi ambiti, il miglioramento di parti di città degradate, la costruzione di nuovi edifici per obiettivi sociali, soprattutto scuole, un intenso e capillare lavoro contro la discriminazione e il razzismo. Dal momento che le minoranze etniche, come altri gruppi svantaggiati, sono considerati più un peso che un valore e che dove si verifica una conpresenza di persone con problemi sociali e di povere condizioni abitative, inevitabilmente la possibilità di conflitti è alta, il lavoro per l’integrazione è cominciato nei quartieri dove la percentuale di immigrati raggiunge il 30%. Rinnovo senza espulsioni, costruzione di nuovi edifici pubblici e di quartieri residenziali, prudente apertura delle abitazioni di proprietà municipale agli immigrati, lotta contro gli speculatori, introduzione di contributi finanziari per la casa a tutti, austriaci e immigrati sono gli strumenti applicati per migliorare la situazione abitativa (Briem, 2001). 14 Contemporaneamente è stata affidata agli esperti di una società di pubbliche relazioni una vera e propria campagna di marketing sociale. E’ interessante, mentre imperversano le azioni di marketing urbano tese a far credere che, per competere, le città devono perseguire l’ineguaglianza e la frammentazione sociale, il significato attribuito al marketing sociale, un significato più ampio di quello della cosiddetta pubblicità sociale, che denota semplicemente l’uso di tecniche pubblicitarie per far conoscere dei problemi d’interesse generale, ad esempio gli inviti al rispetto del codice della strada o a non bruciare i boschi. L’idea centrale del marketing sociale è che anche i valori intangibili, come i modelli sociali e le idee politiche e religiose, sono scambiati in condizioni di mercato, vale a dire in competizione con altri. Ne deriva la necessità, per vincere le resistenze più forti, di concentrarsi, nella scelta dei gruppi target, sui segmenti del mercato più difficili da raggiungere, di godere di una posizione di monopolio nei mezzi di comunicazione e di poter svolgere una funzione di canalizzazione di tutti messaggi. Infine, una campagna di marketing sociale può funzionare solo se alla comunicazione attraverso i media si accompagnano forme di comunicazione diretta. Per questo, oltre all’affissione di grandi manifesti sui muri della città, alle inserzioni sui quotidiani e settimanali, agli adesivi sui mezzi di trasporto pubblici e sui taxi, si è accompagnata la spedizione di un opuscolo di otto pagine a 400.000 famiglie. Nell’opuscolo si spiega che integrazione è una parola «ombrello» che significa molte cose: ridurre le differenze tra ricchi e poveri, dare eguali opportunità ad uomini e donne e a giovani e anziani nel mercato del lavoro, migliorare l’accesso all’educazione, alla sanità, alla casa, ai servizi sociali, promuovere il rispetto per altri sistemi di valori e la coesistenza di diversi stili di vita e tra i diversi gruppi etnici e le varie minoranze. Pochi mesi fa, l’amministrazione municipale ha vinto le elezioni e l’assessore è giustamente fiero del successo riportato grazie ai manifesti che propagandano i vantaggi dell’integrazione- e non a quelli che promettono sicurezza a spese dell’integrazione! In tutt’altro contesto, opera da alcuni anni la Racial diversity task force di Oak Park, il cui obiettivo principale è di preservare la diversità dei propri residenti, cioè una relativa mescolanza di bianchi e neri superiore a quella che si registra in generale nell’area metropolitana di Chicago, tuttora una delle più segregate degli Stati Uniti, facendone emergere gli effetti positivi in termini di vitalità economica e di stabilità residenziale. Come a Vienna, i settori di intervento privilegiati sono la casa e una campagna di informazione per spiegare che la segregazione non è un fenomeno naturale, che 15 dalla segregazione derivano svantaggi di ogni genere per tutta la società, che «l’integrazione residenziale è essenziale per un buon piano di città» e che a livello locale molto si può fare. Oltre a far adottare ordinanze per prevenire ogni pratica discriminatoria da parte delle agenzie immobiliari e a svolgere indagini per tenere sotto costante controllo la situazione e bloccare l’eventuale instaurarsi di fenomeni di segregazione, l’organizzazione promuove una serie di misure complementari, dalla concessione di incentivi per indurre le attività economiche a restare nell’area al ridisegno dei confini dei distretti scolastici per aumentare la diversità degli studenti e per impedire la risegregazione, dimostrando che le stesse tecniche abitualmente usate per favorire la segregazione possono essere impiegate con fini opposti. Le circostanze ed i contesti nei quali sono sorte e si sono sviluppate le esperienze di Vienna e di Chicago sono sicuramente non confrontabili, ma entrambe confermano la necessità di prestare attenzione, oltre che al dibattito sui diritti di cittadinanza, al funzionamento attuale e potenziale delle istituzioni nelle quali questi diritti sono messi in pratica. La società è costruita spazialmente, nel senso che le strutture spaziali che gli uomini creano non esistono indipendentemente dalla società che riflettono, ma possono amplificare certe tendenze e ridurne altre. Qualsiasi cosa si intenda per integrazione, è certo che la mancanza di integrazione è inestricabilmente legata a un disequilibrio di potere. L’esclusione dalla casa o l’esclusione attraverso la casa aggravano la frammentazione sociale e la segregazione residenziale è contemporaneamente una manifestazione di ineguaglianza ed un elemento che sostiene tale ineguaglianza. Conversamente, l’accesso alla casa non è sinonimo di integrazione, è una condizione necessaria, ma non sufficiente, al punto da far ritenere ad alcuni che la segregazione, se volontaria, può essere positiva in termini di maggiore solidarietà e possibilità di autodifesa. La teorica possibilità di risiedere ovunque non garantisce l’integrazione sociale, se persistono le cause dell’ineguaglianza, ma è anche vero che vietare l’insediamento residenziale comporta una serie di effetti indotti, perchè accredita la legittimità di altre forme di ineguaglianza, nel lavoro, nell’istruzione e in genere nella vita associata. Le politiche color blind, apparentemente neutrali, se non sono integrate e fortemente sostenute, non solo non producono una maggiore integrazione, ma possono avere effetti perversi, perché suscitano reazioni ostili dei gruppi che si sentono ingiustamente defraudati a presunto vantaggio di «non aventi diritto/i». L’integrazione richiede un alto grado di sensibilità urbanistica e di 16 professionalità, per evitare la concentrazione di problemi sociali e il sorgere di conflitti fra le domande democraticamente motivate dalla popolazione locale e l’obiettivo di combattere la segregazione. Per cambiare le relazioni interetniche, e le relazioni fra qualsiasi gruppo sociale, è necessario cambiare i giudizi circa la desiderabilità di un determinato stato di relazioni. Boal F. W. (a cura di) (2000), Ethnicity and Housing. Accommodating differences, Ashgate, Aldershot Borjas G. J. (1990), Friends or Strangers, Basic Books, New York Briem W. (2001), «Dem Zusammenleben Chancen geben», Perspektiven, p. 14- 19 Commission of the European Communities (novembre 2000), Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on a Community Immigration Policy, Bruxelles HBE Netherlands Journal of Housing and the Built Environment (1998), vol. 13, n. 1, numero speciale dedicato a «segregazione spaziale, concentrazione e formazione del ghetto», Delft University Press Huttmann E. D. (a cura di) (1991), Urban Housing. Segregation of Minorities in Western Europe and the United States, Duke University Press OECD (1996), Strategies for Housing and Social Integration in Cities, OECD, Parigi Sennett R., (1995), «Something in the City», Times Literary Supplement, 23 settembre 17
Scaricare