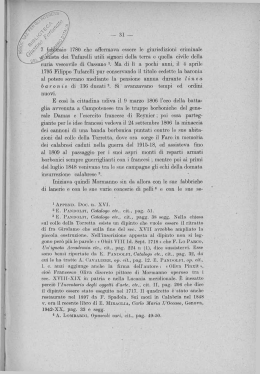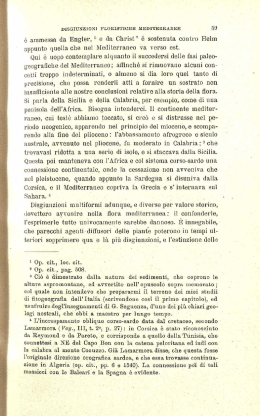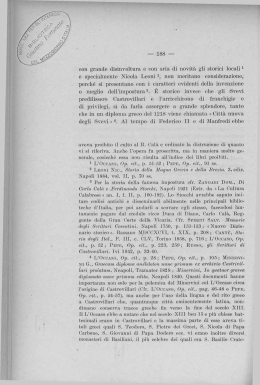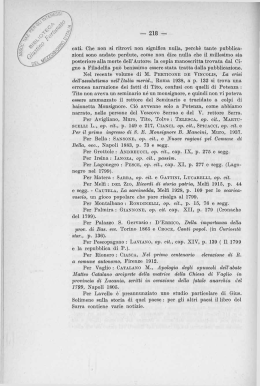INDICE Introduzione p. 1 1. Il ruolo internazionale degli Stati Uniti alla fine della guerra fredda p. 5 1.1 La guerra del Golfo p. 5 1.2 L’avvento dell’amministrazione Clinton p. 9 1.3 L’ “assertive multilateralism” e gli interventi umanitari e di promozione della democrazia: i casi della Somalia e di Haiti p. 13 2. La crisi bosniaca p. 24 2.1 Cenni storici sull’ex Jugoslavia p. 24 2.2 La situazione in Bosnia-Erzegovina p. 30 2.3 La guerra in Bosnia e l’atteggiamento della comunità internazionale p. 34 2.4 Clinton e la Bosnia p. 43 2.5 La svolta americana p. 59 2.6 Gli accordi di Dayton p. 67 3. La crisi del Kosovo p. 76 3.1 Cenni storici p. 76 3.2 Clinton e il secondo mandato p. 82 3.3 La crisi del Kosovo come affare internazionale p. 86 3.4 La NATO secondo Washington p. 91 3.5 La strada verso l’intervento p. 94 3.6 Rambouillet p. 101 3.7 La guerra della NATO p. 105 3.8 L’epilogo del conflitto e la conclusione diplomatica p. 120 3.9 Il Kosovo dopo il conflitto e considerazioni finali p. 124 Conclusioni p. 129 Bibliografia p. 135 INTRODUZIONE La dissoluzione dell’Unione Sovietica determinò una situazione internazionale nella quale gli Stati Uniti si trovarono a rivestire il ruolo di unica vera potenza mondiale. In tale contesto, essi raccolsero così onori ed oneri di un governo mondiale che fino ad allora era stato sorretto dagli equilibri del bipolarismo 1 . Questa condizione rappresentava sicuramente motivo di grande prestigio per gli americani, che tante energie avevano profuso per vincere lo scontro con il nemico comunista, nella contrapposizione ideologica fra la società occidentale e quella sovietica. Dall’altro lato, però, apriva scenari totalmente nuovi, che ponevano il governo degli Stati Uniti di fronte a scelte che avrebbero condotto il mondo verso una nuova era. La guerra fredda aveva senza dubbio generato divisioni fra popoli, stati e individui, nonché causato numerose situazioni di tensione nei vari momenti della sua storia, ma aveva dato vita ad un equilibrio mondiale in cui la deterrenza 2 era stata il fattore fondament ale per evitare conflitti che avrebbero potuto essere devastanti. Si era dunque creato un vuoto importante: un ordine internazionale doveva essere ricostituito. Gli americani ricoprivano inevitabilmente un ruolo di prima linea nell’adoperarsi per questo. Ma gli Stati Uniti avrebbero scelto di dominare la scena internazionale creando un ordine unipolare? Oppure avrebbero tentato di riportare al centro del governo mondiale le Nazioni Unite? Sarebbe nato un soggetto in grado di fronteggiare la potenza statunit ense? Questi sono gli interrogativi, dovuti alla fine della guerra fredda, ai quali cercherò, almeno parzialmente, di dare una risposta in questa tesi, introducendo la questione analizzando i primi interventi post-guerra fredda, e utilizzando gli interventi nell’ex Jugoslavia come case study. Gli Stati Uniti si trovarono disorientati durante i primi anni del nuovo ordine internazionale, di fronte a tutta una serie di fattori modificati dalla fine del bipolarismo: la globalizzazione, che nel corso di quegli anni subì un’intensa evoluzione, fu il processo che influì maggiormente in questo, cambiando notevolmente il modo di gestire non solo le vicende internazionali, ma anche l’economia. Con la fine della guerra fredda le varie scuole di pensiero storiche della cultura diplomatica statunitense confluirono in due filoni principali: da un lato quello globalista, che vide la nuova situazione internazionale come ideale per nella costruzione un mondo ispirato ai principi di libertà e democrazia da sempre esportati dagli Stati Uniti, dall’altro quello definito nazionalista che, pur 1 Per bipolarismo intendiamo l’inquadramento della politica internazionale nei due blocchi punto di riferimento rappresentati dalle superpotenze di Stati Uniti e Unione Sovietica. 2 Riferendosi al periodo storico della guerra fredda con l’espressione “deterrenza nucleare” si indica che il solo essere a conoscenza reciproca delle disponibilità nucleari di una superpotenza rispetto all’altra è sufficiente ad evitare lo scoppio di un conflitto. concordando sull’importanza del ruolo internazionale degli Stati Uniti, considerava il progetto globalista esagerato e guardava alla nuova situazione mondiale come ad un’occasione per alleggerire l’impegno internazionale americano 3 . Possiamo ben capire, dunque, quanti fossero gli scenari possibili all’inizio di una nuova era: gli Stati Uniti erano chiamati a scegliere di dover decidere cosa fare della propria supremazia disponendo delle opzioni più svariate, dalla scelta di totale isolazionismo (soluzione auspicata da qualcuno ma per la verità improponibile) a quella di un dispendioso interventismo a tutto campo (sinonimo di egemonia). Analizzeremo nel corso di questa studio come la condotta della politica estera americana sia caratterizzata da una moltitudine di fattori e dettata dalla strategicità geopolitica di uno specifico paese, ma anche dalla volontà di intervenire in determinate aree per garantire il rispetto di valori umani fondamentali. Scopriremo l’importanza del concetto di “interesse nazionale” e di quanto questo elemento influisca nelle scelte dell’amministrazione nella gestione delle questioni internazionali. Vedremo quale sia stato l’atteggiamento degli altri paesi che rivestono un ruolo internazionale rilevante - paesi europei, Russia e Cina – e il coinvolgimento degli organismi internazionali nella conduzione della politica mondiale. Registreremo infine l’influenza dell’opinione pubblica e delle scadenze elettorali rispetto alle politiche presidenziali. La scelta della trattazione delle crisi dell’ex Jugoslavia è stata dettata dall’interesse suscitato da scenari che presentano un aspetto cruciale della nuova società in cui viviamo: la convivenza multietnica. Il fatto che queste si siano verificate, per di più, in paesi molto vicini e legati al nostro da relazioni particolari, ha reso la ricerca ancora più avvincente. Le crisi nei Balcani degli anni ’90 hanno evidenziato, tra l’altro, quanto la prossimità di teatri di guerra in aree così vicine a noi ci porti ad un interessamento maggiore alla più generale questione della risoluzione delle controversie internazionali. I conflitti in oggetto hanno in questo modo offerto la possibilità di osservare le mosse degli Stati Uniti e di metterle in relazione a quelle degli altri paesi direttamente interessati alla risoluzione delle crisi. Un altro elemento importante nella scelta della trattazione è stata la volontà di studiare il ruolo degli Stati Uniti in una delle aree che nell’epoca della guerra fredda, pur con tutti gli attriti fra il regime jugoslavo e quello sovietico, si trovava sotto l’influenza dell’Unione Sovietica. L’aspetto più stimolante di una trattazione come questo studio è rappresentato, infatti, dalla possibilità di analizzare come l’intervento americano nei Balcani abbia costituito un banco di prova per il ruolo che gli Stati Uniti intendono giocare nell’Europa dopo la caduta del muro di Berlino, una questione che è strettamente legata al problema della ricostruzione della funzione internazionale della NATO 3 Walter Russel Mead, Il serpente e la colomba, Milano, Garzanti, 2001, pp. 311-312. dopo la dissoluzione del blocco in contrapposizione al quale tale organismo internazionale era stato costituito. Esamineremo inoltre le ripercussioni che la decisione di coinvolgere maggiormente la NATO nella risoluzione delle controversie internazionali ha avuto sul ruolo di altri organismi sovranazionali, in particolare sulle Nazioni Unite. Questo tema, in un contesto più generale riguardante le scelte compiute dall’amministrazione americana, ha costituito senza dubbio l’elemento che ha suscitato maggiore attenzione da parte di tutta l’opinione pubblica internazionale. I movimenti pacifisti hanno manifestato la loro forte contrapposizione alla strategia degli Stati Uniti, ma anche negli ambienti giuridici si è dibattuto molto sul tema della legalità delle azioni di politica estera americana. Tantissimi sono, oltre a questi, i temi specifici trattati riguardo le crisi balcaniche degli anni ’90 e questo è dovuto proprio al fatto che essi rappresentano uno scenario nuovo per la politica internazionale. Per citarne solo alcuni possiamo indicare quello sull’attuabilità degli interventi umanitari, sui nuovi tipi di armi utilizzate nei conflitti e sugli obiettivi da colpire, sull’impiego di truppe di terra, sui cosiddetti “danni collaterali”, sullo spessore dell’azione diplomatica e sul ruolo dell’Europa, sul dispiego di truppe ed amministrazioni internazionali nei periodi post-guerra e potremmo continuare ancora. Dobbiamo infine sottolineare che le critiche riguardanti l’azione politica dell’amministrazione Clinton hanno avuto ampio spazio nella storiografia statunitense. Si tratta certamente di una storiografia particolarmente recente, in gran parte costituita dagli articoli apparsi sulle varie riviste specializzate. In ogni caso essa, per quanto riguarda l’azione di Clinton nei primi anni del suo mandato, si divide in due filoni fondamentali: quello che ritiene che gli errori commessi negli interventi umanitari e di promozione della democrazia intrapresi nei primi anni della sua presidenza siano dovuti all’incapacità e all’inesperienza del presidente in politica estera, e coloro che invece fanno risalire la causa degli errori all’attuazione di una politica criticista nei confronti di quella che era stata la politica estera statunitense degli anni ’60 4 . Per quanto riguarda, invece, la seconda fase della gestione di Clinton, caratterizzata dall’azione vera e propria prima in Bosnia e poi in Kosovo, possiamo sommariamente dividere la storiografia fra coloro che vedono con favore, nella logica imposta dalla leadership americana, un deciso intervento atto sia a raggiungere gli scopi umanitari, che quelli di “eliminazione” dei regimi definiti pericolosi, e quella che invece critica, con varie sfumature, l’intervento degli Stati Uniti. Nei 4 Per la tesi che vede gli errori di Clinton causati dall’incapacità e l’inesperienza nella gestione della politica estera, vedi, tra gli altri, Leslie H.Gelb, Can Clinton Deal with the World?, “Washington Post”, 6 marzo 1994, p. C1. Per la tesi che ne vede invece una politica ispirata alla critica alla politica estera americana degli anni ’60, vedi, tra gli altri, Henry A. Kissinger, At Sea in a New World, “Newsweek”, International Edition, 6 giugno 1994, pp. 6-8. paesi dell’ex Jugoslavia particolare attenzione merita la contrapposizione delle tesi che da un lato vedono gli interventi degli Stati Uniti necessari per la salvaguardia delle popolazioni perseguitate, dall’altro giudicano l’intervento insufficiente a garantire una situazione di stabilità e pacificazione duratura in aree da sempre contese e caratterizzate dalla difficile convivenza multietnica 5 . Nello sviluppare le considerazioni appena fatte, il primo capitolo si soffermerà sull’atteggiamento degli Stati Uniti alla fine della guerra fredda. Esso costituirà una breve introduzione alla comprensione dei motivi che portarono all’intervento nelle crisi dell’ex Jugoslavia e tratterà l’argomento della guerra del Golfo, traccerà un profilo dell’amministrazione Clinton e affronterà gli interventi umanitari e di promozione della democrazia intrapresi in Somalia e ad Haiti. Il secondo capitolo esaminerà la crisi bosniaca e l’intervento americano che culminò nella conclusione degli accordi di Dayton. Infine, il terzo capitolo analizzerà la crisi del Kosovo con particolare attenzione alla decisione statunitense di condurre la guerra attraverso la NATO. Le fonti utilizzate nella stesura degli argomenti in oggetto sono rappresentate principalmente da documenti del governo degli Stati Uniti e del Congresso, fra i quali rivestono particolare rilevanza i “Public Papers” dei presidenti degli Stati Uniti. Altre fonti ufficiali utilizzate sono state quelle delle Nazioni Unite, prevalentemente costituite dalle risoluzioni del Consilio di Sicurezza, e della NATO. Un consistente apporto lo hanno fornito inoltre le memorie di alcuni dei principali protagonisti della vita politica del periodo e articoli apparsi sulla stampa coeva. Nella ricerca mi sono avvalso anche del prezioso riferimento costituito dai testi e dagli articoli di saggi e riviste riguardanti sia gli affari statunitensi in generale che quelli specifici sugli interventi nell’ex Jugoslavia, così come di altri concernenti le vicende balcaniche. Buona parte delle fonti, soprattutto quelle ufficiali, sono state reperite in linea. 5 Su questi temi particolare interesse suscitano gli articoli apparsi sulla rivista statunitense “Foreign Affairs”. Per quanto concerne la crisi del Kosovo, a sostegno dell’ipotesi interventista segnaliamo gli articoli di due fra i principali attori di quella vicenda: Madeleine K. Albright, The Testing of American Foreign Policy, “Foreign Affairs”, vol. 77, n. 6, novembre/dicembre 1998, pp. 50-64; Javier Solana, NATO’S Success in Kosovo, vol. 78, n. 6, novembre/dicembre 1999, pp. 114-120. Interessante a riguardo il dibattito svoltosi fra le righe della stessa rivista di relazioni internazionali negli articoli: Joseph S. Nye Jr., Redefining the National Interest, “Foreign Affairs”, vol. 78, n. 4, luglio/agosto 1999, pp. 22-35; Edward N. Luttwak, Give War a Chance, “Foreign Affairs”, vol. 78, n. 4, luglio/agosto 1999, pp. 36-44; Chester Crocker, A Poor Case for Quitting. Mistaking Incompetence for Interventionism, “Foreign Affairs”, vol. 79, n. 1, gennaio/febbraio 2000, pp. 183-186; Michael Mandelbaum, A Perfect Failure. NATO’S War Against Yugoslavia, “Foreign Affairs”, vol. 78, n. 5, settembre/ottobre 1999, 2-8; James B. Steinberg, A Perfect Polemic. Blind to Reality on Kosovo, “Foreign Affairs”, vol. 78, n. 6, novembre/dicembre 1999, pp. 128-133. CAPITOLO PRIMO IL RUOLO INTERNAZIONALE DEGLI STATI UNITI ALLA FINE DELLA GUERRA FREDDA 1.1 La guerra del Golfo L’Unione Sovietica era stata costretta dagli Stati Uniti ad abbandonare il confronto bipolare, non riuscendo più, a causa della crisi che attraversava, a stare al passo con la potenza americana. Gli Stati Uniti avevano raggiunto l’obiettivo che da decenni perseguivano: sconfiggere il baluardo comunista, liberando il mondo dalla minaccia che esso costituiva. L’ottimismo regnava negli ambienti go vernativi americani, che vedevano la prospettiva di un mondo “safe for democracy”6 . C’è da dire inoltre, che dopo tanti anni in cui l’attenzione negli scenari internazionali era stata assorbita prevalentemente dallo scontro ideologico, con la potenza sovietica l’interesse del popolo statunitense verso la politica internazionale si riduceva notevolmente, indirizzando le politiche americane più verso la tutela della sicurezza nazionale, nel contesto generale di un maggiore impegno nella cura degli affari interni. Ma quello che accadde in Medio Oriente nell’estate del 1990 non consentì agli Stati Uniti perdite di tempo sulle nuove strategie da perseguire in politica internazionale. Il 2 agosto, infatti, l’esercito irakeno occupò lo stato limitrofo del Kuwait e pochi giorni dopo il dittatore Saddam Hussein ne dichiarò l’annessione al suo paese come diciannovesima provincia 7 . Nella storia non si trovano ragioni che possano giustificare le mire di Saddam su quella regione, sebbene l’Iraq avesse rivendicato la propria sovranità su questo piccolo emirato almeno dal colpo di stato del nazionalista Abdul Karim Quassem del 1958, quando il Kuwait era ancora formalmente un protettorato britannico. Saddam, affermatosi come uomo forte del regime di Baghdad a partire dal 1969, rinnovò le rivendicazioni irakene sul Kuwait in quanto vi vedeva una pietra preziosa, sia in campo strategico, da utilizzare come retroterra nella guerra contro l’Iran, sia da un punto di vista puramente economico, poiché vi si trovavano numerosi giacimenti petroliferi che avrebbero arricchito il suo paese, in quell’ottica già florido 8 . 6 Giampaolo Valdevit, Politica estera, in Federico Romero, Giampaolo Valdevit, Elisabetta Vezzosi, Gli Stati Uniti dal 1945 ad oggi, Roma -Bari, Laterza, 1996, p. 97. Citazione dalla frase “to make the world safe for democracy”, usata dal presidente americano Woodrow Wilson nel 1917 per giustificare l’intervento degli Stati Uniti nella Prima Guerra Mondiale. 7 Ennio Di Nolfo, Storia delle Relazioni Internazionali 1918-1992, Roma -Bari, Laterza, 1997, p. 1389. 8 Ivi, pp. 1390-1392. Nell’azione che lo portò ad ordinare l’invasione del Kuwait nel 1991, l’Iraq cercò di sfruttare una situazione che sembrava favorevole in una prospettiva strategica: gli americani e i sovietici avevano già arricchito il potenziale militare irakeno, rinforzandolo per favorire la vittoria sugli integralisti nella guerra contro l’Iran, che durò dal 1980 al 1988. Questa accresciuta potenza avrebbe così permesso a Saddam di mettere le mani senza difficoltà su uno stato privo di una forte identità e del quale, quindi, nessuno si sarebbe curato, soprattutto in una situazione internazionale da ricostruire, in cui l’Unione Sovietica era in grave crisi e stava ormai cedendo nello scontro con gli Stati Uniti. Tuttavia, queste sono proprio le ragioni che fecero fallire il progetto di Saddam: il presidente degli Stati Uniti George W. H. Bush non poteva permettere ad un dittatore inaffidabile, in un mondo che cercava nuovi equilibri, di conquistare territori a suo piacimento, ancor di più se questi rivestivano un’enorme rilevanza sotto l’aspetto economico 9 . Così, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si riunì lo stesso giorno dell’invasione del Kuwait e condannò l’azione irakena approvando la risoluzione 660, la prima di una serie che avrebbero messo Saddam Hussein alle corde: se non si fosse ritirato dal Kuwait sarebbe andato incontro alla guerra. Da lì il dittatore irakeno iniziò con tutta una serie di esternazioni che miravano a scatenare il mondo arabo contro quello che lui definiva “il complotto imperialistico animato dagli Stati Uniti”. Tutto ciò gli permise di raccogliere qualche sparuto consenso, soprattutto negli ambienti integralisti10 . Dall’altro lato, però, Bush ne fece sempre più una questione personale fra lui e Saddam, determinato com’era ad agire fermamente per risolvere questa situazione ed assumersi la responsabilità di presidente della più grande potenza mondiale. Inoltre, la delicata area in cui aveva luogo questa crisi, spingeva fortemente gli Stati Uniti ad intervenire per mantenere il controllo sulla regione attraverso la protezione di Israele e la conduzione dei paesi integralisti islamici ad un processo di democratizzazione 11 . Furono proprio gli Stati Uniti a dare la spinta alle Nazioni Unite per adottare quelle risoluzioni che avrebbero portato all’azione contro Saddam. Essi non potevano correre il rischio di lasciare campo all’Iraq in una zona come quella mediorientale, da sempre caratterizzata da equilibri instabili. Per questo motivo si mobilitarono organizzando una coalizione internazionale che fosse la più ampia possibile, per fare pressione sulle Nazioni Unite, affinché queste recepissero le istanze americane. Anche l’Unione Sovietica, pur contraria in linea di principio ad un intervento armato, era ormai legata da accordi con gli Stati Uniti che l’avrebbero aiutata nella crisi che stava 9 Lawrence Freedman, Efraim Karsh, The Gulf Conflict 1990-1991, London, Faber and Faber, 1993, pp. 24-25. Di Nolfo, Storia delle Relazioni Internazionali 1918-1992, cit., p. 1393; Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 660/90, 2 agosto 1990, <http://ods-ddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/575/10/IMG/NR057510.pdf?OpenElement>, consultato il 20 maggio 2003. 11 Valdevit, Politica estera,, cit., pag. 98. 10 attraversando e che la spinsero a dare un tacito assenso all’iniziativa. Così, anche grazie ad un disinteresse della Cina, che la portò a non fare molto per opporsi, Bush fu in grado di aggregare un vasto consenso internazionale sulla propria proposta. Moltissimi paesi la approvarono, tanti altri si impegnarono ad impiegare le proprie forze militari, e ancora, altri paesi dell’area (su tutti l’Arabia Saudita) resero le basi militari del proprio territorio disponibili per l’azione, cosa di non poco conto per le strategie della guerra 12 . Il 29 novembre 1990 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, a seguito delle inadempienze di Saddam alle precedenti risoluzioni, approvò quella decisiva, la 678: se entro il 15 gennaio dell’anno successivo l’Iraq non si fosse conformato a tutti gli obblighi imposti dalle Nazioni Unite e quindi, principalmente, se non si fosse ritirato dal Kuwait, il Consiglio di Sicurezza avrebbe autorizzato gli stati membri a ricorrere a “ogni mezzo necessario” per conseguire l’intento e ristabilire la pace e la sicurezza in quell’area, in conformità all’art.42 della Carta delle Nazioni Unite13 . Nonostante l’autorizzazione all’uso della forza fosse già stato concesso dal Consiglio di Sicurezza in occasione della guerra di Corea nel 1950, era la prima volta che le Nazioni Unite lanciavano un ultimatum ad uno stato e che si interveniva per reazione al suo mancato rispetto. Dopo tutta una serie di tentativi di mediazione che rimasero vani, infatti, nella notte del 16 gennaio quella macchina militare che gli Stati Uniti stavano preparando da mesi passò all’azione 14 . L’intervento militare, in cui erano coinvolti, come abbiamo detto, molti paesi, fece parlare diffusamente di “operazione di polizia internazionale”. In realtà, nonostante essa fosse la risultanza di un’autorizzazione giunta dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e che all’azione prendessero parte molti paesi, furono gli Stati Uniti a svolgere il ruolo primario in questa guerra. Si mettevano in campo congegni militari sofisticatissimi, prevalentemente di appartenenza dell’esercito americano, che comprendevano mezzi fino a quel momento mai utilizzati15 . L’esercito irakeno cercò di reagire, anche lanciando attacchi missilistici su Israele, mossa che puntava alla ricerca di alleati tra i paesi islamici cercando di sfruttare l’annosa questione palestinese. Dopo i primi giorni di ferma resistenza la schiacciante superiorità della coalizione avversaria emerse nettamente. Si puntò, inizialmente, su attacchi aerei che indebolissero la 12 Freedman, Karsh, The Gulf Conflict 1990-1991, cit., pp. 342-361. Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 678/90, 29 novembre 1990, <http://ods-ddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/575/28/IMG/NR057528.pdf?OpenElement>, consultato il 20 maggio 2003; Benedetto Conforti, Le Nazioni Unite, Padova, Cedam, 1996, pag. 202. 14 Conforti, Le Nazioni Unite, cit., pp. 201-202. 15 Freedman, Karsh, The Gulf Conflict 1990-1991, cit., pp. XXIX-XXX. 13 resistenza militare e strategica dell’Iraq, scelta che permetteva di limitare le perdite umane e che quindi allontanava i ricorrenti incubi lasciati dalla guerra del Vietnam16 . Questa fu una fase molto spettacolare della guerra, ripresa dalle televisioni, che mostravano i bombardamenti su Baghdad come immagini di un videogame. Essa evidenziò anche l’effetto di spettacolarizzazione della notizia, componente che da quel momento iniziò a rivestire una grande importanza nell’impatto nei confronti dell’opinione pubblica mondiale. La CNN, tra l’altro, era l’unica televisione alla quale era stato permesso, dietro il pagamento di un adeguato corrispettivo al governo irakeno, di avere un inviato nella capitale 17 . In una seconda fase, poi, con l’esercito irakeno ormai allo stremo, si passò all’intervento di terra. Il 3 marzo Saddam fu costretto a firmare l’accordo che imponeva condizioni durissime per il suo paese. Oltre al risarcimento dei danni di guerra e all’embargo che pendeva sulla testa di tutto il suo popolo, l’Iraq fu assoggettato a tutta una serie di controlli da parte delle Nazioni Unite, che avrebbero ispezionato che il potenziale militare, in particolare nucleare, batteriologico e chimico appartenente a quello stato, fosse annullato 18 . Ci furono molte polemiche sulle sanzioni economiche, che gravavano soprattutto sulla popolazione. Dall’altro lato c’era chi criticava Bush per non aver fatto quello che da più parti si riteneva sarebbe stato possibile fare: far proseguire l’esercito statunitense, ormai alle porte di Bagdad, e catturare Saddam Hussein. Questa soluzione, tra l’altro, era caldeggiata all’interno dell’amministrazione Bush dall’allora sottosegretario alla difesa Paul Wolfowitz, il quale, convinto che gli Stati Uniti dovessero abbandonare la politica del containment, descrive l’atteggiamento di Bush come “lento a riconoscere l’importanza di rimuovere Saddam dal potere”19 . Come abbiamo visto, questo sarà solo il primo atto delle ostilità fra gli Stati Uniti e Saddam. Quella politica che aveva condotto gli Stati Uniti a promuovere la coalizione internazionale che intervenne per liberare il Kuwait, portò il governo di Washington, a fronte del crollo della potenza sovietica, a cercare di impedire che altri stati, soprattutto se retti da dittature ostili, potessero sfuggire al loro controllo e venire in possesso di armi di distruzione di massa. Dalle modalità attraverso le quali si sviluppò la parte assunta dagli Stati Uniti nella risoluzione della crisi del Golfo Persico tra il 1990 e il 1991, emerse chiaramente il ruolo forte che Washington si proponeva di rivestire nelle controversie internazionali. Nel caso specifico del Kuwait, proprio gli americani furono il vero e proprio fulcro di un’operazione, autorizzata sì dalle Nazioni Unite, ma in 16 Ivi, pp. 312-313, 334-338. Ivi, pp. XXXIII, 300, 319. 18 Ivi, pp. 430-433. 19 Laurie Mylroie, U.S. Policy toward Iraq, "Middle East Intelligence Bulletin", vol. 3, n. 1, gennaio 2001; Paul Wolfowitz, “The United States and Iraq” , in John Calabrese (a cura di), The Future of Iraq, Washington, DC, Middle East Institute, 1997, p. 108. 17 cui la veste statunitense era tutt’altro che di mero paese partecipante ad una coalizione internazionale. Anche il comando delle operazioni, infatti, fu preso direttamente dagli Stati Uniti20 . Tuttavia, possiamo notare come le prime manovre di Washington nell’ambito del nuovo ordine internazionale che andava ricostituendosi, si indirizzavano verso un coinvolgimento delle Nazioni Unite come mezzo di legittimazione delle loro politica. Fu possibile attuare questo progetto proprio grazie ad una pressoché totale padronanza del Consiglio di Sicurezza che gli americani ormai detenevano, con l’Unione Sovietica che stava divenendo sempre più ostaggio degli americani e con la conseguente posizione isolata della Cina 21 . Come vedremo, l’orientamento tenuto dall’amministrazione Clinton negli anni immediatamente successivi confermò, almeno inizialmente, questa tendenza. 1.2 L’avvento dell’amministrazione Clinton L’interesse del popolo americano negli affari internazionali, dopo anni di duro confronto bipolare, andava crollando. C’era l’esigenza di sicurezza interna e di benessere. Questo elemento fu acutamente colto dal candidato democratico alla elezioni del 1992 per la presidenza degli Stati Uniti, Bill Clinton, che puntò gran parte della sua campagna su temi di politica interna e, in particolare, di economia. Clinton, tra l’altro, sebbene fosse un buon conoscitore di politica internazionale, non aveva in questo campo un’esperienza pari a quella maturata dal proprio avversario, George Bush. A differenza di quest’ultimo, infatti, il candidato democratico aveva svolto la propria carriera politica principalmente come governatore dello Stato dell’Arkansas 22 . Clinton in campagna elettorale accusò Bush di tollerare tutta una serie di dittature e il suo impegno fu quello che, in politica estera, la sua amministrazione, "will not coddle dictators from Baghdad to Beijing"23 e cioè non avrebbe coccolato le dittature da Baghdad a Pechino. In realtà, i due non erano poi così distanti, potendosi entrambi definire “globalisti”. Il termine deriva in gran parte dall’ottimismo generato dal crollo dell’Unione Sovietica e dal conseguente affermarsi del processo di globalizzazione. Sia Bush sia Clinton, infatti, condividevano la visione di una situazione internazionale nella quale gli Stati Uniti non avrebbero più incontrato 20 Freedman, Karsh, The Gulf Conflict 1990-1991, cit., pp. 441-442. Ivi, pp. 441-442, XXIX-XXX. 22 William G. Hyland, Clinton’s World: Remaking American Foreign Policy, Westport, CT, Praeger., 1999, p. 21 15. 23 William J. Clinton, Transcript of Speech by Clinton Accepting Democratic Nomination, “New York Times”, 17 luglio 1992, p. A15. una resistenza apprezzabile nell’esportare i propri principi di democrazia liberale e libertà individuale. Entrambi ritenevano che fosse possibile aggregare il consenso della comunità internazionale attorno a questo progetto che presupponeva non solo un intervento contro aggressioni perpetrate ai danni di nazioni che non erano necessariamente al centro degli interessi vitali degli Stati Uniti, ma anche la persuasione che l’espansione del commercio internazionale e dei mercati fosse uno strumento quasi imprescindibile per garantire l’estensione della democrazia politica. All’idea globalista si contrapponevano coloro che ritenevano che questo progetto fosse troppo ambizioso. Pur concordando, infatti, sull’importanza del ruolo internazionale che gli Stati Uniti dovevano mantenere, essi vedevano nella fine dell’impero sovietico un’occasione per ridurre l’impegno internazionale americano 24 . Così, Clinton ebbe la meglio su Bush grazie all’abilità nel saper far presa sugli elettori in campagna elettorale, soprattutto rivolgendo al suo avversario la critica di essersi occupato eccessivamente di politica estera, sfruttando il periodo di recessione economica che stava attraversando il paese. Bill Clinton divenne così il quarantaduesimo presidente degli Stati Uniti raccogliendo il 43% dei suffragi, contro il 38% di Bush e il 19% del terzo candidato, il miliardario Ross Perot25 . Dopo la vittoria il neopresidente delegò gran parte del lavoro di politica estera ai suoi collaboratori, perché riteneva che, altrimenti, sarebbe stato distolto dall’attenzione che voleva porre agli affari interni. Lo staff del quale si contornò fu in gran parte composto dai collaboratori che già erano stati del Presidente Carter. Clinton si guardò bene, però, dall’inserire nei posti chiave personaggi di rilievo di quella presidenza, quali l’ex segretario di stato Cyrus R. Vance, l’ex segretario alla difesa Harold Brown, oppure l’ex consigliere per la sicurezza nazionale Zbigniew Brzezinski, che pure erano ancora molto attivi, ma che probabilmente erano troppo esperti per non offuscare la sua già fragile personalità in politica estera 26 . Così egli nominò come Segretario di Stato Warren Christopher, che era stato il vice di Vance con Carter e che fu visto anche negli ambienti democratici come troppo passivo, sebbene il suo operato parve adeguato finché le questioni internazionali non divennero di primaria importanza per l’amministrazione Clinton. Strobe Talbott, amico e compagno di classe di Clinton a Oxford, già giornalista della rivista “Time” e esperto di questioni russe, fu nominato “ambasciatore straordinario”. Ad una donna, Madeleine Korbel Albright, anche lei ex collaboratrice di Carter e più recentemente docente alla Georgetown University, fu conferito l’incarico di ambasciatrice alle 24 25 Mead, Il serpente e la colomba, cit., pp. 311-312. Federico Romero, Economia e politica, in Romero, Valdevit, Vezzosi, Gli Stati Uniti dal 1945 ad oggi, cit., p. 211. 26 Hyland, Clinton’s World, cit., p. 18. Nazioni Unite. A sorpresa il Segretario alla Difesa divenne Les Aspin, un membro del Congresso, che grazie ai legami che aveva con questo organismo, assunse ben presto un ruolo di eccessivo rilievo, cosa che indusse Clinton a sostituirlo un anno dopo la sua nomina col suo vice, William J. Perry, anch’egli un ex collaboratore di Carter. Il neopresidente mantenne anche il ge nerale Colin Powell nella carica di capo di stato maggiore delle forze armate, funzione che egli aveva già svolto nell’amministrazione Bush e che gli conferiva un’esperienza di tutt’altro rango negli affari internazionali rispetto a numerosi membri dello staff della Casa Bianca. Altro personaggio di esperienza fu Anthony Lake, nominato come consigliere per la sicurezza nazionale, che era stato per molti anni collaboratore del Dipartimento di Stato, compresi gli anni di Carter e che nel 1970 si era dimesso dallo staff di Henry Kissinger per protestare contro l’invasione statunitense della Cambogia 27 . Lo scenario politico mondiale era cambiato e a Clinton si chiedeva una politica che si adeguasse a questo nuovo stato dei fatti. Egli in campagna elettorale affermò: ”Dobbiamo difendere i nostri interessi, ma dobbiamo dividere il peso, dove possibile, attraverso azioni multilaterali per assicurare la pace, usando la NATO e una nuova forza rapida volontaria delle Nazioni Unite”28 . Nonostante fossero parole della campagna in corso, da queste dichiarazioni emerge con chiarezza l’idea del presidente: la “balance of power” non esisteva più e l’intenzione era quella di evitare la politica di dominio spendendo risorse per interventi a tutto campo e di cercare, invece, una condivisione gli sforzi con altri stati e organismi internazionali per azioni umanitarie mirate al mantenimento della pace e alla promozione della democrazia. L’uso della forza doveva essere attuato non solo nei campi di interesse vitale per gli Stati Uniti, ma esteso a tutti quelli in cui ci fossero stati interessi nel nome dei principi morali della comunità internazionale e doveva essere gestito attraverso una politica estera multilaterale e della sicurezza collettiva, nella quale le Nazioni Unite avrebbero avuto un ruolo centrale 29 . Si può meglio comprendere la logica ispiratrice della politica estera dell’amministrazione Clinton individuando nelle figure di Lake, di Talbott e della Albright quelle di menti pensanti del team del presidente. I tre si ritrovavano su molti punti, anche se provenivano da background diversi. Le idee di Lake e Talbott, infatti, erano influenzate della cosiddetta “sindrome del Vietnam”. Quella guerra non solo aveva provocato la morte di numerosi “ragazzi” americani, ma si era rivelata un evento che aveva reso gli Stati Uniti agli occhi altrui “solo un’altra nazione”, molto forte, ma non 27 Ivi, pp. 18-20. William J. Clinton, Address to the Los Angeles World Affairs Council, 13 agosto 1992, “New York Times”, 14 agosto 1992, p. A15. 29 Hyland, Clinton’s World, cit., p. 21. 28 invulnerabile 30 . Madeleine Albright, invece, nata a Praga, ma di origine ebraica, aveva una storia di rifugiata, prima dai nazisti, che occuparono il suo paese, e poi dai sovietici, che presero il potere in Cecoslovacchia dopo la sconfitta tedesca. Essa era dunque influenzata dalla “sindrome di Monaco”31 e questo la portava a dare molta importanza al tema della sicurezza nazionale. Dunque, si può ben comprendere come Lake e Talbott fossero più determinati a definire i limiti del potere americano, mentre la Albright fosse più orientata a pensare a come legittimare questo potere. L’idea di ottenere la legittimazione a questo tipo di politica attraverso il coinvolgimento delle Nazioni Unite come organismo da porre al centro del nuovo internazionalismo metteva d’accordo tutti gli uomini del presidente, sebbene Lake e Talbott pensassero ad un’America meno impegnata all’estero di quanto non volesse la Albright. Il progetto dell’amministrazione Clinton, poi, andava oltre, caldeggiando la creazione di una forza delle Nazioni Unite per missioni umanitarie o di mantenimento della pace nell’ambito della strategia di allargamento delle democrazie che avrebbe sostituito quella del containment del comunismo 32 . In realtà, l’interesse di Clinton per la politica estera fu piuttosto sporadico e questo, come vedremo, gli sarebbe costato molto. La squadra della quale si era contornato era composta dagli intellettuali più critici con la politica estera americana degli anni ’60 ed applicare le nuove idee non era facile, tanto che il presidente fu accusato da molte parti di utopismo. Anche Peter Tarnoff, sottosegretario di stato per gli affari politici, considerato il numero tre del dipartimento di Stato, criticò quest’indirizzo, affermando che non poteva costituire una guida pratica per la politica estera americana e sostenendo, sostanzialmente, che gli Stati Uniti avrebbero dovuto fare i conti con ciò che era nelle proprie possibilità. Quando queste dichiarazioni vennero rese note, Tarnoff fu smentito da Christopher, che dichiarò che gli Stati Uniti, nonostante i limiti nelle risorse, avrebbero dovuto essere “più impegnati e non meno; più ardenti nella promozione della democrazia, non meno; e più stimolati nella nostra leadership, non meno”33 . 1.3 L’ “assertive multilateralism” e gli interventi umanitari e di promozione della democrazia: i casi della Somalia e di Haiti 30 R. W. Apple Jr., Mediator Is Upset at U.S. Reluctance over Bosnia Talks, “New York Times”, 3 febbraio 1993, p. A1. 31 Espressione che deriva dall’errore storico commesso alla conferenza di Monaco nel 1938 dalle diplomazie occidentali nella politica di ricerca di un compromesso nei confronti di Hitler, al quale fu consentito, “per favorire la pace”, di occupare la regione dei Sudati, appartenente alla Cecoslovacchia e abitata prevalentemente dai tedeschi. (Di Nolfo, Storia delle relazioni internazionali 1918-1992, cit., pp. 238-252). 32 Hyland, Clinton’s World, pp. 22-24; Secretary of State Warren Christopher, Address at H.H. Humphrey Inst. Of Public Affairs re Russia, Minneapolis, Minnesota, 27 maggio 1993, <http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/briefing/dossec/1993/9305/930527dossec.html >, consultato il 21 maggio 2003. 33 Hyland, Clinton’s World, cit., pp. 25-26. La politica di promozione della democrazia e di intervento umanitario ebbe subito un riscontro con l’intervento in Somalia. In realtà, in origine la missione venne decisa e iniziata dal presidente Bush, che, accusato da più parti di inattivismo, a fronte di una situazione in cui la guerra civile stava imperversando sempre più e le persone che morivano di fame si moltiplicavano ogni giorno, ormai liberato dai vincoli della competizione elettorale che aveva perduto, decise l’invio dei marines senza un precedente accordo con le autorità somale, né un via libera dal Congresso. Era la prima volta che gli Stati Uniti intervenivano senza avere interessi diretti, ma per ragioni umanitarie 34 . Lo stato somalo aveva acquisito l’indipendenza nel 1960, formato dall’unione di quelle che erano due distinte colonie, quella britannica a nord e quella italiana a sud. Da quel momento la Somalia era divenuta teatro di scontro della guerra fredda, entrando a far parte dell’orbita sovietica e accogliendo un regime pseudo-socialista. Quando però la Somalia entrò in guerra con un altro stato filosovietico, l’Etiopia, l’Unione Sovietica le voltò le spalle. Il presidente Carter allora si mosse nella logica della “balance of power”, portando la Somalia, alla fine della guerra, nell’orbita dei paesi sotto il controllo degli Stati Uniti. Washington ottenne l’autorizzazione ad utilizzare della base navale di Barbera, che aveva un importante rilievo strategico. Gli americani contraccambiarono fornendo aiuti economici, che però furono interrotti nel 1988, a causa delle ripetute violazioni dei diritti umani da parte del regime somalo. Nel 1990, gli Stati Uniti decisero anche di far rimpatriare i propri cittadini e di chiudere la propria ambasciata a Mogadiscio. In seguito, dopo che nel 1991 la dittatura di Siad Barre era stata rovesciata, la parte nord del paese dichiarò la propria indipendenza e nel sud infuriarono i conflitti fra due fazioni, una guidata dal leader del governo provvisorio, Ali Mahdi e l’altra dal colonnello Mohammed Farah Aidid. La guerra divenne subito sanguinosissima e portò all’uccisione di migliaia di persone 35 . Per far fronte a questa situazione nel marzo 1992 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dopo aver già disposto l’embargo sulle armi sulla Somalia, approvò la risoluzione 742 imponendo un cessate il fuoco e inviando i primi aiuti umanitari. Gli scontri, però, continuarono e il quadro rimase gravissimo: in un’area completamente preda dei clan in combattimento la siccità rendeva disastrose le condizioni di vita della popolazione. Si decise così, nell’estate di quell’anno, di approvare un’ulteriore risoluzione, la 767, con la quale un primo contingente di caschi blu pakistani fu inviato in Somalia per proteggere gli aiuti umanitari che nel frattempo erano stati incrementati. Purtroppo fu soltanto una goccia nel mare, considerato che i caschi blu non erano in 34 Walter Clarke, Jeffrey Herbst, Somalia and the Future of Humanitarian Intervention, “Foreign Affairs”, vol. 75, n. 2, marzo/aprile 1996, pp. 71, 74. 35 Hyland, Clinton’s World, cit., p. 52; Department of Public Information, United Nations, United Nations Operation in Somalia I, <http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/co_mission/unosomi.htm>, consultato il 22 maggio 2003. grado, in quella situazione, di evitare che le derrate alimentari e i medicinali inviati per alleviare le sofferenze della popolazione finissero frequentemente nelle mani dei feroci clan36 . Erano in molti a credere che gli Stati Uniti, con gli ideali che volevano esportare, non potessero restare spettatori di una situazione del genere. Così, solo dopo l’offerta americana di truppe, le Nazioni Unite decisero velocemente una più energica missione, palesando ancora una volta la propria pressoché totale dipendenza dagli Stati Uniti. Il progetto prevedeva di creare un minimo di sicurezza in un paese allo sbando più totale e di consentire che gli aiuti umanitari arrivassero alla popolazione. L’amministrazione Bush non specificò i tempi di permanenza dell’esercito statunitense, anche se la missione si sarebbe limitata allo stabilimento della sicurezza nel paese e non mirata ad imporre una soluzione politica fra i clan37 . Così, con la risoluzione 794 le Nazioni Unite autorizzavano gli stati, in base al capitolo VII della Carta, l’utilizzo di “ogni mezzo necessario” per ristabilire per il mantenimento della sicurezza e l’arrivo degli aiuti umanitari. In base a tale risoluzione gli Stati Uniti decisero di intraprendere l’operazione denominata “Restore Hope”, assumendo il comando delle operazioni autorizzate dal Consiglio di Sicurezza attraverso la creazione di una forza multinazionale denominata UNITAF (Unified Task Force). 37000 uomini delle Nazioni Unite, di cui due terzi statunitensi, dal 9 dicembre si insediarono nel paese senza incontrare resistenza alcuna 38 . Dopo aver svolto questo compito, gli americani si sarebbero ritirati. Si pensava ad una missione senza troppi rischi, con tempi mediamente brevi, calcolabili in due o tre mesi circa. L’auspicio delle Nazioni Unite che tramite azioni diplomatiche si sarebbe potuti arrivare anche alla soluzione politica del problema restò irrealizzato a causa delle dichiarate cattive intenzioni dei capi rivali. In realtà, gli Stati Uniti si stava no imbarcando in una missione più dura del previsto, in un paese senza identità nazionale e senza istituzioni forti, dove le fazioni erano molto determinate e senza scrupoli. In qualche modo la decisione di intervenire in quell’area rispetto ad altre zone critiche fu dettata dall’esigenza di risposta ad una situazione drammatica messa in luce dai media e in particolare dalla TV 39 . Clinton, insediandosi alla Casa Bianca poco più di un mese dopo l’invio dei soldati, nonostante l’operazione partisse lasciando diversi dubbi sul reale obiettivo da perseguire, ereditava una situazione congeniale alle sue idee di impegno internazionale per operazioni umanitarie attraverso il coinvolgimento delle Nazioni Unite. Nella sua amministrazione Madeleine Albright 36 Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 746/92, 17 marzo 1992, <http://ods-ddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/011/05/IMG/NR001105.pdf?OpenElement>, consultato il 21 maggio 2003; Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 767/92, 24 luglio 1992, <http://ods-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/342/21/IMG/N9234221.pdf?OpenElement>, consultato il 22 maggio 2003. 37 Clarke, Herbst, Somalia, cit., p. 71. 38 Department of Public Information, United Nations, United Nations Operation in Somalia I, cit. 39 Clarke, Herbst, Somalia, cit., p. 72-73. interpretava al meglio la dottrina di umanitarismo, unita a quella di multilateralismo. Fu proprio lei a coniare il termine di “assertive multilateralism”, che esprimeva la volontà degli Stati Uniti di impegnarsi appieno nella promozione e nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale assieme a tutti coloro i quali condividessero questi valori, prime fra tutti le Nazioni Unite, che dovevano acquisire un ruolo di crocevia delle decisioni di politica internazionale 40 . Intanto, le operazioni in Somalia procedevano in modo abbastanza tranquillo, ottenendo il risultato, a marzo, di fermare le morti per fame, facendo apparire la missione come di grande successo per quello che parve un modello di intervento umanitario. Così, come previsto, si decise di ridurre il contingente americano, che passò dal massimo livello di 28000 unità a circa 4000 nel mese di giugno, mentre a maggio il comando della missione passò dalle mani statunitensi a quelle delle Nazioni Unite. Si trattava di un cambiamento della natura della missione: Clinton era determinato ad intervenire con più decisione in Somalia, a fronte di una situazione nella quale le violenze stavano comunque proseguendo. Così, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il 26 marzo 1993, approvò la risoluzione 814 che approvava la missione UNOSOM II (United Nations Operation in Somalia), che sostituiva la precedente UNOSOM I. In questo modo nel maggio dello stesso anno avvenne la transizione fra il comando militare UNITAF e quello UNOSOM II41 . La differenza sostanziale nei mezzi con i quali si intese in un secondo momento conseguire gli obiettivi prefissati. Il mandato della prima parte della missione (UNITAF), si era realizzata nell’ambito di quelle che definiamo operazioni di peace-keeping e cioè di mantenimento della pace. Questo tipo di missione avviene con il consenso dello stato dove si intraprendono e quindi anche delle eventuali parti in lotta, che anche in Somalia, dunque, consentirono il dispiego della missione internazionale. La natura della missione che si decise di intraprendere in un secondo momento, invece, era ben diversa: si trattava di un tipo di operazione che definiamo di peace-enforcement e cioè di attuazione della pace. Quest’altra categoria, infatti, richiede una maggiore intensità nell’intervento per il conseguimento dei fini umanitari, cioè un maggiore utilizzo della forza. Questo tipo di missione solitamente si intraprende quando nello stato dove si interviene vige una situazione di anarchia oppure uno stato di collasso delle istituzioni tale da richiederla. Una simile situazione era proprio quella delineatasi in Somalia, dove lo stato era praticamente inesistente e il paese era dominato dai clan in lotta 42 . 40 Hyland, Clinton’s World, cit., p. 55; Thomas W. Lippman, Madeleine Albright and the New American Diplomacy, Boulder, CO, Westview Press, 2000. pp. 22-23. 41 Department of Public Information, United Nations, United Nations Operation in Somalia I, cit.; Department of Public Information, United Nations, United Nations Operation in Somalia II – Background Text, 21 marzo 1997 (ultimo aggiornamento), <http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unosom2b.htm>, consultato il 22 maggio 2003. 42 Giuseppe Palmisano, La guerra “umanitaria”. Il caso del Kosovo, in Linda Bimbi (a cura di), Not in My Name. Guerra e diritto, Roma, Editori Riuniti, 2003, pp. 160-161. Questo cambio, per l’appunto, non fu ben visto dalle due fazioni in guerra e provocò dei forti risentimenti, soprattutto nel capo di uno dei clan, Aidid, che accusò le Nazioni Unite di favorire l’altra fazione in campo, quella capeggiata da Ali Mahdi43 . Così, nel corso della missione, il 5 giugno, in un agguato teso dagli uomini di Aidid, rimasero uccisi 25 caschi blu pakistani, 10 furono dichiarati dispersi e 54 feriti44 . Subito arrivarono dure condanne a questo evento. Clinton giudicò l’attacco di Aidid come “il più grave mai avvenuto contro un contingente umanitario delle Nazioni Unite”, dic hiarando che, come tale “non sarebbe potuto rimanere impunito”45 . Pochi giorni dopo il comando della missione tornò di nuovo nelle mani degli Stati Uniti, che iniziarono una serie di azioni di attacco contro postazioni di Aidid. Nello stesso tempo venne approvata una durissima risoluzione delle Nazioni Unite che, condannando l’atto di violenza nei confronti dei caschi blu, riaffermava la necessità di intraprendere tutti i mezzi necessari per disarmare le parti in lotta e prevedeva l’arresto e la persecuzione dei responsabili 46 . Sostanzialmente la missione assunse sempre più i connotati di vera e propria campagna militare contro Aidid. Proprio per questo iniziavano ad arrivare forti le proteste da parte dell’opinione pubblica nei confronti di un’azione rischiosa in un teatro dove gli Stati Uniti non avevano interessi diretti. Il Congresso americano, poi, che non era stato per niente coinvolto già dall’inizio della campagna somala, iniziò con più voci a chiedere il ritiro dei soldati. Anche alcuni collaboratori di Clinton, come Powell, si mostrarono scettici sull’ipotesi di catturare Aidid. Addirittura dagli ambienti stessi delle Nazioni Unite si sollevavano critiche verso l’atteggiamento americano. Ma l’amministrazione era decisa ad andare avanti, con la Albright che giustificava l’azione sostenendo che se non si fosse fermato Aidid la missione umanitaria non sarebbe potuta proseguire47 . La realtà era che ormai gli Stati Uniti pagavano l’errore di essere voluti andare oltre gli obiettivi umanitari dell’operazione, prendendo parte di riflesso nel conflitto somalo ed essendosi fatti coinvolgere in una spirale che portava allo scontro diretto contro Aidid e il suo clan. Il prezzo di questo sbaglio si mostrò presto in tutta la sua evidenza. Il 3 ottobre 1993, infatti, si verificò un 43 Department of Public Information, United Nations, United Nations Operation in Somalia II – Background Text, cit.; Clarke, Herbst, Somalia, cit., p. 76. 44 Department of Public Information, United Nations, United Nations Operation in Somalia II – Background Text, cit. 45 William J. Clinton, The President's News Conference, 17 giugno 1993, in Public Papers of the Presidents of the United States: William J. Clinton: 1993, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1993, vol. 1, p. 867. 46 Department of Public Information, United Nations, United Nations Operation in Somalia II – Background Text, cit. Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 837/93, 6 giugno 1993, <http://ods-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/332/32/IMG/N9333232.pdf?OpenElement>, consultato il 22 maggio 2003. 47 Hyland, Clinton’s World, cit., p. 57; Madeleine K. Albright, Yes, There Is a Reason to Be in Somalia, “New York Times”, 10 agosto 1993, p. A6. altro gravissimo evento, che segnò drammaticamente la missione in Somalia: un elicottero da combattimento “Black Hawk” fu abbattuto, causando la morte di 18 soldati americani, il ferimento di altri 75 e la cattura del pilota 48 . L’evento suscitò profonda emozione negli Stati Uniti: l’emittente televisiva CNN trasmise un filmato che mostrava il corpo di un soldato statunitense, ucciso in quell’occasione, gettato per strada e colpito e calpestato dalla folla inferocita. Era un gesto vile, che era da interpretare anche come una reazione d’odio contro la presenza americana nel paese. Un’ondata di indignazione provenne dall’opinione pubblica, che da un lato vedeva tornar fuori gli spettri della “sindrome del Vietnam”, dall’altro sollevava forti critiche nei confronti della politica di Clinton. Quest’ultimo si trovava a cercare di porre rimedio ad una situazione imbarazzante ed inaspettata, convinto com’era che il progetto per la Somalia fosse un’idea del tutto nuova per una politica americana moderata e ispirata all’umanitarismo. Il presidente stabilì subito la data del rientro del contingente americano dalla Somalia nel 31 marzo 1994, prevedendo di inviare a protezione delle truppe già presenti in quell’area, altri 5000 soldati. Inoltre, decise di inviare in Somalia l’ex ambasciatore Robert Oakley, per prendere contatti con l’odiato Aidid 49 . Il presidente Clinton, in seguito agli eventi, in un messaggio alla nazione sulla vicenda somala dichiarò: “Noi siamo andati perché solo gli Stati Uniti potevano aiutare a fermare una delle più grandi tragedie umane dei nostri tempi […] Non è il nostro lavoro ricostruire la società della Somalia e neanche creare un processo politico che possa condurre i clan della Somalia a vivere e lavorare in pace”50 , confessando la sua stessa sconfitta. Molti membri del Congresso continuavano a non lesinare critiche a Clinton, per quella che definivano una politica scellerata. Il Senato votò una legge che tagliò i fondi americani alle Nazioni Unite. Da quegli ambienti e da molti altri nell’opinione pubblica si vedeva in questa politica un fallimento, costituito dalla scelleratezza nel mandare soldati a giro per il mondo, in posti pericolosi e ostili per gli americani, in nome di un umanitarismo utopico. Si criticavano in particolar modo le Nazioni Unite, organismo tramite il quale gli Stati Uniti attuavano una politica multilateralista, ma probabilmente non in grado di sostenere direttamente la responsabilità di operazioni così delicate. Molte obiezioni a Clinton, in effetti, venivano poste sul tema del comando delle operazioni, lasciato in mano a quell’organismo, mentre la missione veniva sostenuta in maggioranza dai soldati americani. In conclusione, l’ambasciatore Oakley raggiunse accordi con Aidid sul ritiro del 48 Department of Public Information, United Nations, United Nations Operation in Somalia II – Background Text, cit.; Hyland, Clinton’s World, cit., pp. 57-58. 49 Hyland, Clinton’s World, cit., p. 58, Clarke, Herbst, Somalia, cit., pp. 76-77. 50 William J. Clinton, Address to the Nation on Somalia, 7 ottobre 1993, in Public Papers of the Presidents of the United States: William J. Clinton: 1993, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1993, vol. 2, p. 1704. contingente americano e sulla liberazione del pilota dell’elicottero. Il colonnello somalo, da parte sua, accettò un’inchiesta non di parte sull’assalto ai caschi blu pachistani avvenuta nel giugno dell’anno precedente 51 . Dunque, la gestione della missione in Somalia fu un fallimento per l’amministrazione Clinton, che uscì dalla vicenda fortemente screditata, alimentando ulteriormente i dubbi, che già c’erano sul suo conto, riguardo la dimestichezza negli affari esteri. L’idea di intervento umanitario subiva un forte ridimensionamento, unito ad un crescente scetticismo sul coinvolgimento delle Nazioni Unite negli interventi internazionali. Lo stesso Anthony Lake, in un articolo apparso sul “New York Times” il 6 febbraio 1994, scrisse che ”Il mantenimento della pace non è al centro della nostra politica estera”52 . Tuttavia la missione americana in Somalia, pur avendo rappresentato un umiliante fallimento per gli Stati Uniti, evitò la morte per fame di numerose persone: fu stimato che essa salvò la vita ad almeno 100000 persone 53 . I dubbi sul presidente vennero alimentati ulteriormente dall’approccio ad un’altra situazione internazionale, quella di Haiti. Dopo quasi un trentennio di occupazione degli Stati Uniti nell’isola, a partire dal secondo dopoguerra gli Stati Uniti non ave vano posto troppa attenzione nei confronti del piccolo stato. Le dittature dei Duvaliers, con François prima, detto “Papa Doc” e il figlio Jean-Claude poi, detto “Baby Doc”, non entusiasmavano gli americani, ma neanche venivano ripudiate, accertato che i comunisti non avessero alcuno spazio in quel paese. Così, gli americani si limitavano a fornire all’isola modesti aiuti, che erano mirati soprattutto alla promozione della democrazia. Le condizioni economiche del paese, però, restavano piuttosto precarie e la popolazione haitiana ne risentiva notevolmente, versando spesso in condizioni al limite della soglia di povertà. Nel 1986 a causa di questa situazione, scoppiarono disordini tali che costrinsero il dittatore “Baby Doc”, vicino al pubblico linciaggio, ad abbandonare in tutta fretta l’isola, prelevato da un aereo fornito dall’amministrazione Reagan. Il potere fu preso da una giunta militare che soltanto nel 1990 indisse le elezioni, a seguito delle quali divenne presidente un sacerdote cattolico (che però era anche stato sospeso a divinis per la sua adesione alla teologia della liberazione), Jean-Bertrand Aristide, il quale però fu ben presto destituito da un altro golpe militare 54 . Le vicende di Haiti, in quel momento, sebbene non riscuotessero il massimo gradimento dagli ambienti governativi americani, non suscitavano grande interesse nell’amministrazione Bush, 51 Clarke, Herbst, Somalia, cit. pp. 78-81; Hyland, Clinton’s World, cit., pp. 58-59. Anthony Lake, The Limits of Peacekeeping, “New York Times”, 6 febbraio 1994, P. A6. 53 Department of Public Information, United Nations, United Nations Operation in Somalia II – Background Text, cit.; Clarke, Herbst, Somalia, cit. pp. 84-85. 54 Hyland, Clinton’s World, cit., pp. 59-60. 52 tanto che l’unico provvedimento che prese fu quello di applicare un embargo economico nei confronti di quel paese 55 . In campagna elettorale Clinton promise di riportare al potere padre Aristide, oltre che di concedere l’asilo politico all’ondata di profughi haitiani che cercavano di arrivare negli Stati Uniti con imbarcazioni di emergenza, almeno fino al ripristino della democrazia nel paese. Bush, al contrario, si era sempre rifiutato di concedere loro questo particolare status. Una volta eletto, però, Clinton continuò nell’azione di intercettamento delle imbarcazioni dirette da Haiti verso gli Stati Uniti, rimandando indietro gli avventurieri, cosa che deluse chi si aspettava dei cambiamenti56 . Dall’altro lato, comunque, il neopresidente fece maggiori pressioni affinché venisse ripristinato il governo democratico di Haiti, attraverso un’azione decisa che promuovesse un embargo internazionale nei confronti del paese, in maniera anche da rimuovere le cause del flusso di rifugiati verso le coste statunitensi. Così, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite approvò, il 16 giugno 1993, con la risoluzione 841, l’embargo economico nei confronti di Haiti57 . La svolta si ebbe nell’estate del 1993, quando le Nazioni Unite appoggiarono una proposta americana denominata “Governors Island Agreement”, che prevedeva il graduale ritorno di Aristide al governo. La proposta fu accettata dal leader militare di Haiti Raoul Cedras, che garantì la sicurezza del legittimo presidente, a patto che quest’ultimo ritirasse la richiesta di inquisire i membri della giunta militare per il golpe del 1991. L’accordo prevedeva che padre Aristide sarebbe rientrato nel paese in un secondo momento. Per contribuire alla distensione del clima, le Nazioni Unite votarono la risoluzione 861, che sospendeva parzialmente l’embargo nell’isola 58 . Clinton si mostrò subito soddisfatto da come si stavano mettendo le cose e manifestò tutto il suo rallegramento in un discorso pronunciato a Filadelfia, alla cerimonia per la celebrazione della festa dell’indipendenza americana: “Oggi dobbiamo rallegrarci dello s tor ico accordo raggiunto nella tarda serata di ieri per restaurare la democrazia e il suo le ader eletto, il presidente Aristide, ad Haiti”59 I primi dubbi sulle buone intenzioni del regime di Cedras, però, arrivarono presto, quando al neo-nominato primo ministro Robert Malval, un sostenitore di Aristide, non fu concessa alcuna libertà di azione. Il dittatore passò in fretta a metodi ben peggiori: uno stretto collaboratore di 55 Ivi, p. 60. Ibidem 57 Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 841/93, 16 giugno 1993, <http://ods-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/354/58/IMG/N9335458.pdf?OpenElement>, consultato il 22 maggio 2003. 58 Department of Public Information, United Nations, United Nations Mission in Haiti, <http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/co_mission/unmih.htm>, consultato il 23 maggio 2003; Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 861/93, 27 agosto 1993, <http://ods-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/473/12/IMG/N9347312.pdf?OpenElement>, consultato il 22 maggio 2003. 59 William J. Clinton, Remarks at an Independence Day Ceremony in Philadelphia, Pennsylvania , 4 luglio 1993, in Public Papers of the Presidents of the United States: William J. Clinton: 1993, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1993, vol. 1, p. 997. 56 Aristide e il ministro della giustizia, anche lui designato dall’uomo che gli americani intendevano ripristinare al potere, furono assassinati. Il paese sprofondò ancora una vo lta nel terrore ed apparve chiaro come il regime di Cedras volesse rendersi conto fino a che punto gli americani fossero interessati alle questioni di un piccolo stato come Haiti. L’11 ottobre, nell’ambito delle operazioni preliminari che avrebbero permesso il rimpatrio di Aristide, ad una nave americana con a bordo caschi blu americani e canadesi specializzati in queste missioni, non fu permesso di attraccare, accolta da una folla inferocita che gridava “Somalia, Somalia!”. La nave fu così costretta a tornare indietro, suscitando manifestazioni di gioia nell’isola. Il piano “Governors Island Agreement” si rivelò un fallimento e il governo degli Stati Uniti, pur non avendo subito, in questa occasione, alcuna perdita di uomini, incassò un’altra sconfitta in quanto fu costretto alla ritirata solo da alcune centinaia di haitiani infuriati60 . Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, a quel punto, irrigidì l’embargo e dispose un blocco navale nei confronti di Haiti61 . Tuttavia, l’amministrazione Clinton non sembrava intenzionata a premere ulteriormente perché venisse ripristinato il governo democratico. L’ambasciatrice americana alle Nazioni Unite Madeleine Albright, in un discorso alle Nazioni Unite, disse che gli Stati Uniti avevano intenzione di agire in qua lsiasi modo tranne che attraverso “un intervento armato che nessuno vuole”, aggiungendo che la questione di Haiti non era stata per molto tempo nella “lista A” delle crisi62 . Questo scenario, però, presentava caratteristiche diverse rispetto alla crisi somala o a quella in Bosnia, dove già stavano emergendo i primi problemi e di cui ci occuperemo diffusamente nel secondo capitolo. Non dobbiamo dimenticare che stiamo parlando di un’area geograficamente vicina agli Stati Uniti e che Washington avesse maggiori interessi vitali nell’area di Haiti, piuttosto che in Bosnia. Ciononostante un sondaggio condotto dalla Gallup nel settembre 1994 ci rivela coma il 52% degli intervistati ritenesse che gli Stati Uniti non dovessero inviare truppe ad Haiti63 . D’altro canto, Clinton suscitava malumori tra i membri della sua stessa amministrazione che, come soprattutto nel caso di Lake, erano strenui sostenitori delle azioni di promozione della democrazia. Come scrisse in proposito “Newsweek”: “La politica a zigzag di Clinton è divenuta dominata da un gruppo di moralisti […] Parlano tutti lo stesso linguaggio, il Carteriano della politica dei ‘diritti umani prima’. Odiano tutti la politica americana degli anni ’80“64 . 60 Department of Public Information, United Nations, United Nations Mission in Haiti, cit.; Hyland, Clinton’s World, cit., p. 61. 61 Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 873/93, 13 ottobre 1993, <http://ods-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/555/41/PDF/N9355541.pdf?OpenElement>, consultato il 22 maggio 2003. 62 Hyland, Clinton’s World, cit., pp. 61-62. 63 Michael Golay, Foreign Affairs. Americans Shun Policeman’s Lot, in Michael Golay e Carl Rollyson (a cura di), Where America Stands: 1996, New York, John Wiley & Sons, 1996, p. 149. 64 Tom Masland, How Did We Get Here?, “Newsweek”, International Edition, 26 settembre 1994, p. 17. Così, legato com’era ai suoi collaboratori e alle loro idee, Clinton decise nuovamente di cambiare rotta nella strategia su Haiti. Facendo pressione sulle Nazioni Unite, nel maggio del 1994 vennero approvate ulteriori misure che rafforzavano le sanzioni economiche contro il regime di Cedras. Successivamente, a seguito degli scarsi risultati che produssero queste misure, persuase il Consiglio di Sicurezza ad approvare una risoluzione che autorizzasse l’uso della forza per ripristinare il governo democratico ad Haiti65 . I repubblicani si mostrarono contrari all’ipotesi di un invasione dell’isola, sostenendo che il ripristino di Aristide non valeva la perdita di una solo uomo 66 . Il 15 settembre Clinton rivolse un messaggio alla nazione nel quale dichiarava la propria volontà di intervenire: “ Ad Haiti abbiamo un caso nel quale il diritto è chiaro, nel quale il paese in questione è vicino, nel quale i nostri stessi interessi sono evidenti, nel quale la missione è realizzabile e limitata e nel quale le nazioni del mondo sono con noi. Dobbiamo agire”67 . Dopo aver avuto ulteriori titubanze, egli approvò una missione propostagli dall’ex presidente Carter, che chiese di recarsi ad Haiti per avere dei colloqui con Cedras, anche se i tempi dell’invasione dell’isola rimanevano comunque improcrastinabili. La missione diplomatica fu coronata da successo grazie a un compromesso che consentì a Cedras e ai suoi seguaci di abbandonare il paese e all’esercito delle Nazioni Unite, composto da soldati statunitensi come da quelli di altri continenti, di sbarcare incontrastato il 19 aprile nell’isola, permettendo il ritorno al potere di Aristide. Per non ripetere l’errore della Somalia Clinton fu esortato da più parti a prevedere i tempi del ritiro dei soldati americani. Le truppe americane, inizialmente presenti nel paese con 20000 unità, vennero ridotte gradualmente, fino a lasciare completamente il paese nell’aprile del 1996, dove rimase comunque un contingente sia civile che militare per portare alla stabilità il paese 68 . Nel paese si tennero nel dicembre del 1995 le elezioni presidenziali, che videro René Preval, già primo ministro con il presidente Aristide nel 1991, vincere con l’87,9% dei voti. Haiti, però, nonostante l’intervento continuava a pagare, soprattutto da un punto di vista economico, gli anni del regime e delle sanzioni imposte dalla comunità internazionale 69 . 65 Department of Public Information, United Nations, United Nations Mission in Haiti, cit. Hyland, Clinton’s World, cit., p. 63 67 William J. Clinton, Address to the Nation on Haiti, 15 settembre 1994, in Public Papers of the Presidents of the United States: William J. Clinton: 1994, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1994, vol. 2, p. 1560. 67 Hyland, Clinton’s World, cit., pp. 58-59. 68 Henry Kissinger, Does America Need a Foreign Policy? Toward a diplomacy for the 21st Century, New York, Simon & Schuster, 2001, pag. 259; Department of Public Information, United Nations, United Nations Mission in Haiti, cit. 69 Department of Public Information, United Nations, United Nations Mission in Haiti, cit.; Department of Public Information, United Nations, United Nations Transition Mission in Haiti, <http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/co_mission/untmih.htm>, consultato il 23 maggio 2003. 66 Ciò che emerge dall’analisi delle due vicende è la sostanziale inadeguatezza da parte dell’amministrazione Clinton rispetto alle strategie d’intervento. L’azione ad Haiti, pur costituendo solo la premessa di un processo di democratizzazione del paese ancora non del tutto completato, riuscì comunque a raggiungere l’obiettivo di ripristinare il legittimo presidente democraticamente eletto. Tale fine fu raggiunto soltanto quando gli Stati Uniti gettarono tutto il proprio peso ne lla vicenda. La loro iniziale titubanza, determinò invece un indebolimento del prestigio di Washington proprio perché la destituzione di Cedras appariva una meta facilmente conseguibile per le potenzialità americane. Chi ne risentì fu proprio personalmente il presidente Clinton, subissato di critiche per aver dimostrato quell’inesperienza in politica estera già paventata in campagna elettorale 70 . Questo rese chiaro al presidente a cosa potesse condurre un approccio debole in politica estera. Anche lo scenario somalo mise in luce gli errori di Clinton, che in questo furono quelli di non indicare un obiettivo chiaro alla missione prima (ma essendo stata intrapresa da Bush, a Clinton possiamo semmai attribuire la colpa di non averla adeguata ai suoi obiettivi di politica estera) e di estenderla poi, senza che ci si rendesse conto a cosa si stesse andando incontro. In questo, l’azzardo maggiore fu quello di cambiare la natura della missione, in un’area già di per sé difficile, trasformandola in operazione di peace-enforcement e prendendo di fatto parte al conflitto 71 . Nel breve periodo, la conseguenza delle missioni in Somalia e a Haiti fu che la politica degli interventi umanitari e di promozione della democrazia, a causa della sua riuscita non ottimale, andò perdendo vigore e lasciò spazio a cambiamenti di rotta nella strategia dell’amministrazione Clinton. Questo sarà dimostrato anche dalla decisione americana di non intervenire in Rwanda, dove nei mesi successivi alla vicenda somala i media internazionali misero in luce un’emergenza umanitaria simile e forse peggiore a quella della Somalia 72 . Anche il ruolo delle Nazioni Unite, come vedremo, sarà completamente ridimensionato dall’esperienza compiuta, che secondo l’establishment americano aveva palesato l’inadeguatezza di tale organismo nel gestire le vicende internazionali 73 . Tutto ciò avrebbe in parte finito per condizionare l’atteggiamento di Washington riguardo agli avvenimenti nell’ex Jugoslavia. 70 Stephen M. Walt, Two Cheers for Clinton’s Foreign Policy, “Foreign Affairs”, vol. 79, n. 2, marzo/aprile 2000, pp. 75-76. 71 Clarke, Herbst, Somalia, cit., pp. 82-84. 72 Ibidem; Walt, Two Cheers for Clinton’s Foreign Policy, cit., p. 77. 73 Clarke, Herbst, Somalia, cit., p. 81. CAPITOLO SECONDO LA CRISI BOSNIACA 2.1 Cenni storici sull’ex Jugoslavia La comprensione delle vicende che riguardano questo capitolo e più in generale di tutta la tesi, richiede inevitabilmente una breve esposizione dei trascorsi storici dei paesi dell’ex Jugoslavia. Elemento fondamentale per capire la storia di quest’area è l’invasione dei turchi nei territori della Serbia, della Bosnia, dell’Erzegovina e di gran parte della Croazia e il dominio che questo popolo esercitò in tutta la penisola balcanica dalla fine del XIV secolo fino alla sconfitta definitiva dell’Impero Ottomano nelle guerre del 1912-1374 . In questo lunghissimo arco di tempo le popolazioni di quell’area subirono forti angherie, soffrendo molto l’egemonia dei turchi, visti come i dominatori che tagliavano gli slavi fuori dal resto del mondo e come gli stranieri venuti per diffondere la religione islamica e per “contaminare” la purezza etnica della zona. Si sviluppò dunque un senso nazionalistico di appartenenza fortissimo, tramandato di generazione in generazione e legato ad un sentimento di rivalsa molto forte nei confronti dei dominatori, rimasto indelebile nel tempo. La vendetta si espresse nelle battaglie che a partire dal 1821 e fino alla definitiva cacciata dell’Impero Ottomano dall’area, videro la rivolta delle popolazioni75 . Già in quel periodo negli ambienti politici si iniziò a parlare della creazione di uno stato unico jugoslavo, a partire dalla convinzione che la ricerca di una lingua e una cultura comuni fossero sufficienti per unire popoli per certi versi già vicini. Quando parliamo di quella che adesso definiamo l’area dei paesi della ex Jugoslavia, infatti, dobbiamo subito dire che vi convivono ben sei gruppi nazionali: serbi, croati, sloveni, macedoni, montenegrini e musulmani bosniaci, oltre a tanti altri gruppi etnici minori quali albanesi, ungheresi, italiani, bulgari, rumeni, slovacchi, cechi, ucraini, rom, turchi, che si parlano tre lingue e due dialetti e che si praticano le religioni cattolica, ortodossa e musulmana. Si può ben capire, insomma, come la zona, oltre a trovarsi in una posizione strategicamente cruciale, in mezzo fra Levante e Mitteleuropa, sia complessa di per sé proprio da un punto di vista etnico e socio-culturale 76 . Nonostante l’odio comune per gli invasori turchi gli scontri fra i diversi gruppi autoctoni hanno caratterizzato un’area da sempre tormentata da continue dispute. Anche nel corso della prima 74 Joze Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991 – 1999, Torino, Einaudi Editore, 2001, p. 5. Ivi, p. 8; Aleksandar Pavkovic, The Fragmentation of Yugoslavia: Nationalism and War in the Balkans, New York, St. Martin’s Press, 2000, p. 15-16. 76 Pavkovic, The Fragmentation of Yugoslavia, cit., pp. 5-7; Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., p. 4. 75 guerra mondiale i vari popoli jugoslavi si trovarono a combattere su fronti opposti e dopo che negli anni Venti e Trenta i problemi fra le varie etnie restarono irrisolti, nonostante la formazione di uno stato unitario nel 1918, il secondo conflitto mondiale mise in luce tutta la debolezza scaturita dalla divisione. La penisola fu fatta oggetto dell’invasione di tedeschi, italiani, bulgari e ungheresi, che si spartirono i vari territori, all’interno dei quali si continuavano comunque a regolare i conti fra etnie 77 . Tale situazione si conservò fino a quando contro l’occupazione, già dal 1941, si levò una grande rivolta, nell’ambito della quale la frangia più determinata, formata dai partigiani comandati dal maresciallo croato Josip Broz Tito, dette una spinta determinante alla liberazione del paese, anche grazie all’aiuto degli inglesi, accomunati dall’interesse nello sconfiggere il nemico nazista. Forte del proprio contributo alla vittoria e non senza sanguinose repressioni nei confronti degli oppositori, Tito assunse così il potere e avviò un processo che avrebbe portato il nuovo stato jugoslavo verso un modello di tipo socialista ispirato all’Unione Sovietica. Fin dall’inizio, però, i rapporti del dittatore jugoslavo con Stalin ebbero momenti di scontro molto duri, tali da portare ad una rottura che configurò la Jugoslavia come un paese comunista, ma slegato da Mosca, permettendole così, negli anni successivi, di mantenere buoni rapporti anche con Washington e gli alleati europei, che vedevano lo stato balcanico come la prima crepa nel muro di cartapesta del blocco sovietico 78 . Alla Jugoslavia fu data una struttura di tipo federale, all’interno della quale furono costituite sei repubbliche, tenuti conto i presupposti di riconoscimento delle varietà etniche del paese. In realtà, i comunisti jugoslavi non dettero molto peso alla complessità che il paese aveva da sempre presentato, a partire dalla convinzione che l’elemento preminente fosse quello di costruire un tipo di società completamente nuova, di tipo socialista. La questione delle minoranze nelle varie repubbliche, così, non fu affrontata con il dovuto equilibrio. In Croazia venne assicurato alla minoranza serba lo status di nazione costitutiva, per premiare coloro che avevano attivamente partecipato alla resistenza antinazista. La Serbia, invece, abitata da popolazioni viste con diffidenza dal regime per non aver fornito un grande contributo alla battaglia contro i tedeschi, non ricevette la stessa considerazione: oltre a perdere i territori della Macedonia, costituitasi in repubblica autonoma, e il Montenegro, al quale la propria autonomia statale venne restituita, essa dovette subire la costituzione delle due province autonome della Vojvodina a nord e del Kosovo a sud. Inizialmente non fu quindi possibile alcun tipo di protesta, a causa del forte controllo del regime su 77 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., pp. 14-17; Pavkovic, The Fragmentation of Yugoslavia, cit., pp. 20-21. 78 Pavkovic, The Fragmentation of Yugoslavia , cit., pp. 54-55; Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., pp. 17-22; Noel Malcolm, Storia della Bosnia: dalle origini ai giorni nostri, Milano, Bompiani, 2000, pp. 259-260. tutta la società, ma i decenni successivi non risparmiarono critiche nei confronti di Tito, accusato di aver indebolito la Serbia in nome di uno stato jugoslavo più forte. Le suscettibilità nazionali erano state ferite e i problemi, negli anni, sarebbero emersi in tutta la loro evidenza 79 . Un’altra area calda per le complessità etniche e culturali che presentava era quella della Bosnia- Erzegovina. Anche in questo caso si agì tenendo in scarsa considerazione questo elemento, che frustrò non poco quelle popolazioni. La sua proclamazione come una delle sei repubbliche, infatti, non accontentò né i serbi, né i croati, che rivendicarono entrambi quei territori, né tantomeno soddisfece i musulmani che la popolavano, in quanto questi vennero riconosciuti solo come comunità religiosa e non quale gruppo etnico autonomo. Inoltre, alla regione del Sangiaccato, provincia bosniaca fino al 1878 e abitata prevalentemente da musulmani, non fu concessa l’autonomia promessa durante la lotta di liberazione, ma fu divisa fra Serbia e Montenegro. La costituzione della repubblica della Slovenia, in effetti, fu l’unica a non dare problemi, presentandosi essa come un territorio compatto dal punto di vista nazionale 80 . La nuova Jugoslavia disegnata da Tito, così, nasceva lacerata, e non solo per il diffuso scontento sollevato dalla divisione territoriale nelle sei repubbliche. Nonostante la trasformazione del paese da una società di tipo contadino ad una prevalentemente formata da masse operaie, infatti, la frattura fra il nord del paese, più sviluppato, e l’arretratezza del sud, rimase piuttosto evidente. Inoltre, le volontà politiche delle varie repubbliche andavano in direzioni opposte. Da un lato i serbi, che costituivano il perno del paese, sia perché numericamente più forti rispetto alle altre popolazioni, sia perché occupavano già gran parte dei posti chiave, sostenevano la centralizzazione statale, che ritenevano l’unico mezzo capace di mantenere compatta la nazione. Dall’altro i croati, sloveni e più moderatamente anche i macedoni, erano evidentemente inclini ad identificare le proprie identità rafforzando la federazione 81 . Il maresciallo Tito intanto proseguiva nel processo riformatore della nuova federazione jugoslava, al punto da arrivare, un po’ a sorpresa, ad aprire il paese al mercato e a portare nel 1966, in quasi tutte le repubbliche, nuovi amministratori, che andavano a rinnovare gran parte della classe politica del paese. La generale apertura del regime portò ad una situazione in cui la libertà di parola favoriva il fervore da parte di coloro che sollevavano rivendicazioni di tipo nazionale, alle quali si prestò però orecchio in maniera piuttosto iniqua. I musulmani bosniaci, infatti, nonostante fossero stati a lungo perseguitati proprio da Tito durante i primi anni del suo regime, vennero riconosciuti come una delle nazionalità costitutive della repubblica della Bosnia-Erzegovina. Questo elemento 79 Malcolm, Storia della Bosnia, cit., pp. 259-260; Pavkovic, The Fragmentation of Yugoslavia, cit., pp. 47-52; Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., pp. 19-20. 80 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., pp. 19-20 ; Malcolm, Storia della Bosnia, cit., pp. 261-262; Pavkovic, The Fragmentaton of Yugoslavia, cit., pp. 51-52. 81 Pavkovic, The Fragmentation of Yugoslavia, cit., p. 53; Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., p. 22. suscitò ancora una volta il malcontento dei serbi, che in Bosnia dopo la guerra avevano avuto un grosso peso e che scoprirono, tra l’altro, di non essere più l’etnia ma ggioritaria di quella repubblica. Inoltre, l’irritazione serba derivava anche dalla questione degli albanesi del Kosovo, ai quali fu concessa una più larga autonomia 82 . Questo stato di cose mise in evidenza una situazione troppo precaria per il regime che, dopo aver accontentato soltanto le più esigue istanze di emancipazione, decise di avviare delle purghe, che misero a tacere croati, serbi, sloveni e macedoni, ripristinando i vecchi gerarchi al potere nelle varie repubbliche. Nel 1974 venne intrapresa una ulteriore radicale riforma: fu approvata una nuova costituzione che attraverso l’accentramento del potere nelle mani del partito, al quale si contrapponeva una maggiore adattabilità verso le autonomie locali, riuscisse a trovare il giusto equilibrio per la gestione di una realtà che si manteneva realmente complicata. In realtà, la riforma non mutò la situazione in maniera sostanziale e provocò ancora una volta la delusione dei serbi, che contestavano non solo l’equiparazione del peso della propria repubblica ma anche la perdita del proprio controllo sulle province del Kosovo e della Vojvodina, alle quali veniva riconosciuta ancora maggiori libertà di autogoverno 83 . Le inquietudini del popolo serbo venivano spesso soffocate da Tito, ma quando il dittatore nel 1980 morì, tutto il malcontento maturato in quegli anni esplose. Oltre a lasciare la Jugoslavia in una situazione economica non proprio florida, il dittatore abbandonava la scena con il paese in una crisi politica evidente, senza un leader che fosse in grado di raccoglierne l’eredità e soprattutto che riuscisse ad arginare le istanze dei numerosi popoli presenti nell’area. I contrasti erano anche sulla riorganizzazione della Jugoslavia: gli sloveni volevano uno stato fortemente federale aperto all’occidente, mentre i serbi lo volevano centralizzato e autarchico. Dal punto di vista etnico le questioni kosovare e bosniache si mostravano ancora una volta quelle più esplosive, e i serbi dal canto loro si sentivano sempre più frustrati. Il nazionalismo serbo, poi, fomentava sempre più le richieste indipendentiste di croati e sloveni, che a loro volta facevano crescere il timore dei serbi di vedere il proprio popolo diviso nelle tre differenti unità statali della Serbia, della Bosnia e della Croazia 84 . Il vittimismo fra la popolazione serba, provocato da una diffusa insoddisfazione, sfociò verso la fine degli anni ’80 in massicce mobilitazioni, che portarono alla creazione di un movimento cavalcato da un membro del clan da tempo al potere in Serbia, Slobodan Milosevic. Egli si impossessò presto della guida nel partito comunista serbo, di cui divenne Segretario Generale nel 82 83 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., p. 24; Malcolm, Storia della Bosnia, cit., pp. 266-267. Pavkovic, The Fragmentation of Yugoslavia, cit., pp. 71-72; Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., p. 24. 84 77. Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., pp. 26-29; Pavkovic, The Fragmentation of Yugoslavia, cit., p. 1987. Fra i fattori che rafforzavano ulteriormente la figura di Milosevic c’era senza dubbio l’alleanza con la Chiesa ortodossa, ma soprattutto quella con l’Armata popolare, l’esercito creato da Tito e formato prevalentemente da uomini serbi. Già dagli anni immediatamente successivi alla scomparsa del dittatore jugoslavo, specialmente nelle repubbliche settentrionali si protestò molto contro l’esistenza di un esercito così vicino ai serbi, che veniva considerato un vero pericolo per le basi del regime. Per Milosevic, infatti, l’apporto dell’Armata popolare era un elemento molto importante sul quale poter contare 85 . Le mosse di Milosevic erano finalizzate principalmente a “riunire tutte le terre serbe sotto uno stesso tetto”. Ed egli, grazie al consenso di cui godeva e soprattutto all’appoggio dei servizi segreti, riuscì a sostituire i governi di Vojvodina, Montenegro e Kosovo con altri a lui graditi, in azioni che risultavano dei veri e propri colpi di mano. Nel dicembre 1989 Milosevic fu eletto presidente della Serbia 86 . Le insurrezioni, intanto, iniziavano a prendere corpo non solo in Serbia, ma anche in Slovenia e Croazia, dove vennero organizzate, fra il 1989 e il 1990, le prime elezioni libere. Questi eventi confermarono la volontà delle varie repubbliche di svincolarsi da una federazione ormai inesistente e senza credibilità, identificata sempre più con l’aspetto del nazionalismo serbo. Ciò non lasciò indifferente Milosevic: egli si mosse energicamente per frenare queste istanze di libertà, che turbavano il processo di creazione di una grande nazione serba. In un primo momento, Milosevic pensò di condurre, soprattutto in Slovenia, azioni simili a quelle che avevano portato alla sostituzione dei governi di Vojvodina, Montenegro e Kosovo. Le difficoltà ad attuarle, però, lo indussero a decidere di imporre un embargo economico sia alla Slovenia che alla Croazia. In Croazia però Milosevic andò oltre, sfr uttando le inquietudini della minoranza serba nel paese, provocate dall’elezione di Franjo Tudjman a presidente. Appena entrato in carica Tudjman aveva infatti adottato, in maniera del tutto inopportuna, dei provvedimenti mirati ad allontanare i serbi nell’amministrazione pubblica per ridurne l’influenza. Milosevic poté così avvalersi dei timori che serpeggiavano tra i serbi di Bosnia a seguito delle misure prese da Tudjman per fomentare fra i suoi concittadini una rivolta nei confronti del governo legittimo. Il fulcro di questa ribellione si ebbe nella città di Knin, roccaforte dell’etnia serba dalla grande valenza simbolica. La rivolta in Croazia investì presto tutta la regione della Krajina, che rivendicava la propria appartenenza alla madrepatria Serbia 87 . 85 Pavkovic, The Fragmentation of Yugoslavia, cit., pp. 103-105; Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., pp. 28-30. 86 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., p. 31; Pavkovic, The Fragmentation of Yugoslavia, cit., pp. 107-108. 87 pp. 30-32. Pavkovic, The Fragmentation of Yugoslavia, cit., pp. 128-130; Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., Nel 1990 si ebbero elezioni libere per il parlamento anche nella Bosnia- Erzegovina, dove la popolazione, secondo un censimento del periodo, era composta per il 44% da musulmani, per il 31% da serbi e per il 17% da croati. Le etnie vivevano nel paese in maniera sparsa, senza che l’una o l’altra prevalesse in nessuna parte del territorio 88 . Non è un caso se questa situazione portò in quegli anni a raffigurare la capitale Sarajevo come un modello di convivenza interetnica. Il risultato elettorale, però, vide i vecchi partiti nazionalisti prevalere e si verificò una spartizione fra le tre rappresentanze etniche di Alija Izetbegovic (bosniaca), Radovan Karadzic (serba) e Stjepan Kljuic (croata), che in sostanza non cambiò di molto lo stato delle cose ai vertici del paese 89 . In realtà, già negli anni antecedenti a questi fatti, le popolazioni serbe soprattutto della Croazia e della Bosnia-Erzegovina, iniziarono a ricevere armi dalla repubblica serba. Secondo molti studiosi Milosevic e i serbi in genere non capivano che le loro istanze erano impraticabili e improponibili, perché essi non avevano né il potenziale demografico, né le risorse materiali, oltre che la giustificazione storica, per costituire uno stato unico che racchiudesse la loro popolazione, sebbene credessero di poterlo creare attraverso una guerra fulminea 90 . Il vozd 91 rifiutò anche la proposta che venne dai presidenti di Slovenia, Croazia, Macedonia e Bosnia-Erzegovina di trasformare la Federazione in una confederazione di stati indipendenti92 . La situazione che preoccupava di più era quella della Bosnia, dove nel dicembre del 1991 la crisi rischiava di esplodere definitivamente: Karadzic, in risposta alle richieste di indipendenza della repubblica provenienti da Izetbegovic, decise di autoproclamare una “repubblica serba di Bosnia” con capitale Banja Luka, rivendicando la sovranità su oltre due terzi del territorio bosniaco, Sarajevo compresa 93 . Così, la rivolta fomentata da Milosevic nella Krajina fu soltanto il primo focolaio di una serie di guerre che in Jugoslavia, nel giro di pochi anni, avrebbero portato al processo di smembramento della Federazione. L’apporto dell’Armata popolare a favore della causa serba si fece sentire, rivelando fondati i timori delle altre repubbliche sull’influenza di questo fattore, ma non fu un elemento sufficiente per vincere le battaglie volute da Milosevic. La guerra in Slovenia durò soltanto dieci giorni, ma in Croazia fu ben più lunga e cruenta, caratterizzata anche dai fallimenti nei tentativi di mediazione da parte della comunità internazionale. Il presidente serbo non si aspettava l’interesse internazionale per queste vicende: nel 88 Branka Magas, Ivo Zanic (a cura di), The War in Croatia and Bosnia-Herzegovina, 1991-1995, London, Portland, OR., Frank Cass Publishers, 2001, p. 371. 89 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999,cit., p. 33. 90 Ivi, p. 32. 91 Nella lingua serbo-croata significa “duce” ed era il termine con il quale, già dai tempi in cui assunse la leadership del movimento serbo, veniva chiamato Slobodan Milosevic.. 92 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., p. 33. 93 Ivi, p. 106. frattempo venne costituita una “Conferenza sul futuro della Jugoslavia e dei suoi popoli”, mentre nel gennaio del 1992 la Slovenia e la Croazia furono riconosciute dalla Comunità Europea come repubbliche indipendenti. Gli Stati Uniti decisero di non seguire l’Europa in questa scelta, scegliendo una linea più attendista nel timore che gli eventi nei Balcani potessero precipitare da un momento all’altro 94 . Ma Milosevic e Tudjman stavano già trattando sottobanco per la spartizione della Bosnia-Erzegovina e la cacciata dei musulmani dall’area 95 . Proprio in quell’anno, infatti, ebbe inizio una crisi che avrebbe condotto a quella che probabilmente fu la più cruenta delle guerre jugoslave succedutesi dalla crisi della Federazione jugoslava: la guerra in Bosnia. 2.2 La situazione in Bosnia-Erzegovina La Comunità Europea cercò di intervenire nelle vicende intercorse in quegli anni in Croazia e Slovenia senza ottenere risultati tangibili. Per cercare una soluzione che frenasse l’escalation di violenza in Jugoslavia ci volle l’intervento delle Nazioni Unite. Il timore diffuso, soprattutto da parte degli Stati Uniti, era quello che intervenendo attraverso una missione di pace si sarebbe inserito un ulteriore elemento di destabilizzazione dell’area, rischiando di far impantanare una comunità internazionale già poco coesa, divisa com’era fra stati propensi a riconoscere l’indipendenza alle nuove repubbliche (come la Germania) ed altri renitenti a questa ipotesi96 . La scelta, così, andò verso l’approvazione da parte del Consiglio di Sicurezza di una risoluzione, la 713, che si limitava a prevedere il “generale e totale embargo su tutte le forniture di armi e materiale bellico alla Jugoslavia”97 . In tale contesto la comunità internazionale ed in particolare le Nazioni Unite iniziarono a pensare all’ipotesi del dispiegamento di un’operazione per il mantenimento della pace nell’area, adottando una serie ulteriore di risoluzioni che preludevano e preparavano ad una missione del genere. Il 21 febbraio 1992, infatti, dopo una serie di colloqui che, pur con alcuni ostacoli, portarono alla sostanziale accettazione da parte dei paesi direttamente interessati, il Consiglio di Sicurezza approvò con la risoluzione 743, una peace-keeping operation denominata UNPROFOR (United Nations Protection Force), proposta dal nuovo Segretario Generale delle Nazioni Unite Boutros-Ghali (succeduto a Pérez De Cuéllar che ebbe modo anch’egli di lavorare al progetto) e che 94 Ivi, pp. 106-107, 112-114. Susan L. Woodward, Balkan Tragedy: Chaos and Dissolution after the Cold War, Washington, DC, Brookings Institutions, 1995, p. 172. 96 Ivi, p. 82. 97 Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n.713/91, 25 settembre 1991, <http://ods-ddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/596/49/IMG/NR059649.pdf?OpenElement>, consultato il 28 marzo 2003. 95 aveva il compito di “creare le condizioni di pace e di sicurezza necessarie per raggiungere una soluzione generale della crisi jugoslava”98 . Per la missione si previde inizialmente la durata di un anno con un contingente di 14000 uomini da dislocare nelle aree calde della Krajina e della Slavonia, ma più avanti il suo incarico si sarebbe ampliato di molto, dispiegandosi nelle repubbliche di Croazia, Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Serbia e Montenegro e Macedonia. La missione operò di riflesso anche in Slovenia e vide impegnati, nel 1995, più di 38000 caschi blu appartenenti a 39 nazioni. Si trattò, sia come forze dispiegate, sia come spese, della più grande operazione mai intrapresa nella storia delle Nazioni Unite 99 . Come vedremo, la decisione di scegliere come sede centrale del comando della missione Sarajevo non servì da deterrente per l’esercito serbo. Divenne al contrario difficile mantenere il necessario collegamento fra le forze delle Nazioni Unite e la capitale bosniaca, che finì per ritrovarsi sempre più isolata dall’imminente guerra 100 . Il riconoscimento europeo delle repubbliche di Croazia e Slovenia, intanto, movimentò la già complessa situazione della Bosnia-Erzegovina. Il nodo principale, come abbiamo visto, stava nella presenza nella repubblica delle tre diverse etnie musulmana, serba e croata, elemento che vi scatenava le rivendicazioni dei presidenti serbo e croato, Milosevic e Tudjman, decisi a unire le rispettive etnie in un unico stato. Non fu un caso se il presidente bosniaco Alija Izetbegovic, nel luglio del ’91, avesse chiesto l’intervento dei caschi blu anche per la Bosnia-Erzegovina: la sua paura era quella che il conflitto si estendesse, andando oltre i confini della Croazia. Tuttavia la domanda non ricevette molto credito dalla comunità internazionale, che preferì inizialmente non gravare ulteriormente la missione, ignara delle continue istigazioni alla guerra civile che si effettuavano nei confronti del popolo bosniaco e del potere di dissuasione che invece avrebbe costituito la presenza di forze di pace in un paese e dove da secoli, soprattutto fra i serbi, si era radicato il desiderio di battersi per la propria etnia 101 . La situazione fu ulteriormente aggravata dalla scelta del parlamento bosniaco che, velatamente incoraggiato dal generale favore della comunità internazionale sul riconoscimento della repubblica, ma ovviamente boicottato dai deputati serbi, decise di organizzare un referendum sul riconoscimento dell’integrità territoriale della Bosnia-Erzegovina. Con questa mossa veniva violata 98 Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n.743/92, 21 febbraio 1992, <http://ods-ddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/011/02/IMG/NR001102.pdf?OpenElement>, consultato il 28 marzo 2003. 99 Department of Public Information, United Nations, United Nations Protection Force – Background text, settembre 1996 <http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/co_mission/unprof_b.htm>, consultato il 28 marzo 2003; Department of Public Information, United Nations, United Nations Protection Force – Mission Profile, 31 agosto 1996, <http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/co_mission/unprof_p.htm>, consultato il 28 marzo 2003; Shashi Tharoor, United Nations Peacekeeping in Europe, “Survival, The IISS Quarterly”, vol. 37, n. 2, estate 1995, p. 121. 100 Lewis MacKenzie, Peacekeeper: The Road to Sarajevo, Vancouver-Toronto, Douglas & McIntyre, 1993, pp. 106, 119, 121. 101 Richard Caplan, Post-Mortem on UNPROFOR, London, London’s Defence Studies 33, Brassey’s, 1996, p. 21; Woodward, Balkan Tragedy, cit., pp. 273, 285. sia la costituzione jugoslava, che le garanzie comunque chieste dalla Comunità Europea per il riconoscimento della repubblica nel coinvolgimento necessario di tutte e tre le etnie per prendere questa decisione 102 . Ad un certo momento le iniziative diplomatiche sembrarono portare ad una soluzione che non scontentasse nessuno, che vedeva la creazione di uno stato indipendente e confederale della Bosnia- Erzegovina, con due cantoni assegnati alla gestione di ognuna delle tre etnie 103 . In realtà l’illusione durò ben poco: nessuno degli interlocutori risultò realmente soddisfatto della soluzione auspicata, un po’ per la pressione delle ali più oltranziste di ogni parte, un po’ perché la divisione territoriale del piano Cutileiro 104 non garantiva un’equa distribuzione dei territori alle tre popolazioni e soprattutto non teneva conto delle minoranze comunque esistenti, dato che la presenza di ogni etnia nel territorio risultava sostanzialmente sparsa 105 . Così, il referendum deciso dal Parlamento bosniaco fu preso come pretesto da Milosevic e Karadzic per scatenare l’azione militare in Bosnia. L’obiettivo di non lasciare la Bosnia ai musulmani era infatti chiaro da tempo; i serbi non avevano perso tempo e già verso la fine del 1991 l’esercito di Milosevic aveva occupato importanti centri di comunicazione e creato numerose postazioni d’artiglieria intorno alle più importanti città 106 . Il 29 febbraio e il I marzo si tenne il referendum sull’indipendenza della Bosnia. Karadzic e i suoi organizzarono un boicottaggio che li vide impedire a molti il voto. Per contro, tanti serbi si recarono alle urne e votarono anche in modo favorevole all’indipendenza. L’affluenza alle urne fu pari al 63,4% dei circa 3200000 elettori che avevano diritto al voto e il 2 marzo venne annunciata la vittoria del sì con il 99,43% dei voti107 . L’illusione di una Bosnia realmente indipendente durò molto poco. Già subito dopo i risultati del referendum ci si rese conto della gravità della situazione: le forze paramilitari serbe innalza rono barricate e postazioni per cecchini nei pressi del parlamento di Sarajevo, che fecero pensare per qualche ora all’inizio della presa militare del paese. In quei giorni avvenne anche l’assassinio di un serbo che partecipava ad un corteo nuziale, ucciso da due uomini musulmani, episodio che venne preso dai serbi come pretesto per dimostrare i propositi musulmana nei loro confronti. La situazione ancora non era degenerata, ma sicuramente era molto tesa: i serbi avevano 102 Ali Rabia e Lawrence Liftschultz, Why Bosnia?, “Third World Quarterly, Journal of Emerging Areas”, vol. 15, n. 3, settembre 1994, p. 374. 103 Pirjevec, Le guerre jugoslave, cit., p. 132. 104 Il piano prende il nome dal ministro degli esteri José Cutileiro, incaricato dal mediatore inglese delegato dalla Comunità Europea Lord Carrington di presiedere un gruppo di lavoro autonomo che avrebbe dovuto ideare una piattaforma diplomatica per la soluzione della questione bosniaca. 105 Laura Silber, Allan Little, The Death of Yugoslavia, London, Penguin Books, 1995, pp. 241-242; Magas, Zanic (a cura di) The War in Croatia and Bosnia-Herzegovina 1991-1999, cit., p. 385. 106 Malcolm, Storia della Bosnia, cit., pp. 298-301. 107 Ivi, pp.301-302. organizzato vere e proprie formazioni paramilitari, decisi a non riconoscere il risultato del referendum, mentre Milosevic e Tudjman si incontravano per stabilire la spartizione dei territori. I croati non intendevano, dunque, rinunciare alla loro fetta di Bosnia 108 . In una situazione del gene re Izetbegovic fece pressioni perché il riconoscimento della Bosnia da parte di tutta la comunità internazionale avvenisse il più presto possibile. La sua speranza era che in questo modo l’offensiva da parte dei serbi sarebbe passata come un’aggressione di uno stato nei confronti di un altro, mentre senza il riconoscimento un eventuale conflitto si sarebbe potuto considerare come una guerra civile in cui la comunità internazionale non sarebbe intervenuta 109 . In realtà, questo elemento contava ben poco e gli inefficaci sforzi diplomatici della Comunità Europea mostravano i primi segni dell’inconsistenza dell’Europa, mentre il Presidente degli Stati Uniti George Bush, dichiarando diplomaticamente di essere soddisfatto del lavoro della Comunità Europea, faceva già trasparire la volontà di non impegnarsi nell’area 110 . Intanto, la situazione nel paese si stava aggravando: tra la fine di marzo e i primi giorni di aprile l’elemento che destava maggiore preoccupazione era l’arrivo a Bijeljina, città della Bosnia prevale ntemente popolata da musulmani e d’importanza strategica per le truppe serbe, delle milizie paramilitari chiamate “Le Tigri”, guidate da Zarko Raznjatovic-Arkan. Arkan era un serboaustraliano già implicato in rapine di banche ed ex killer dei servizi segreti jugoslavi, nonché uomo di Milosevic. A dire il vero in quel periodo “Le Tigri” non erano l’unica forza paramilitare giunta in Bosnia, ma sicuramente costituivano quella più pericolosa, già nota per le operazioni di pulizia etnica a Vukovar. Arkan e i suoi uomini, così, intrapresero veri e propri eccidi a sangue freddo per impaurire i musulmani e farli fuggire, mettendo le mani sulla pacifica cittadina. Tali iniziative, poi, si sarebbero estese in altre città bosniache prevalentemente abitate da musulmani, per proseguire le epurazioni ed aprire il campo alle truppe regolari di Milosevic. Non si è mai saputo con precisione quanti furono i musulmani uccisi in quegli assalti111 . Il 6 aprile 1992 arrivò per la Bosnia il riconoscimento da parte della Comunità Europea, seguito a ruota da quello degli Stati Uniti. La contropartita concessa a Milosevic di sospendere l’embargo nei confronti della Jugoslavia, ad eccezione di quello sulle armi, non soddisfece il vozd. 108 Ivi, pp. 302-304; Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., pp. 134-136. Ben Cohen, With no Peace to Keep: United Nations Peacekeeping and the War in the Former Yugoslavia, London, Grainpress Ltd, 1995, p. 53. 110 George W. H. Bush, The President’s News Conference with Foreign Journalists, 2 luglio 1992, in Public Papers of the Presidents of the United States: George W.H. Bush: 1992, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1992, vol. 1, p. 1066. 111 Malcolm, Storia della Bosnia, cit., pp. 308-309; Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., pp. 67, 142144. 109 Per Milosevic il riconoscimento di uno stato che, a suo dire storicamente non era mai esistito, rappresentava un atto illegittimo 112 . La reazione dei serbi, così, non si fece attendere: già nella notte fra il 4 e il 5 aprile forze speciali cercarono di occupare il palazzo presidenziale a Sarajevo, non riuscendoci, e crearono ancora una volta delle postazioni di franchi tiratori attorno alla città. Nelle strade del centro iniziò a riversarsi una folla senza distinzione di etnia inneggiante la pace, che il 6 aprile raggiunse un numero superiore alle 50000 unità. I cecchini appostati in quell’occasione spararono colpendo diversi manifestanti a morte 113 . Sarajevo da quel momento fu stretta dalla morsa dell’Armata popolare che prese il possesso di alcuni quartieri della città e si appostò sulle montagne intorno ad essa bombardandola a più riprese.. La capitale ormai era un vero e proprio campo di battaglia. Nonostante il governo di Belgrado continuasse ad affermare con menzogne insostenibili che quelle azioni erano mirate soltanto a difendere la popolazione serbo-bosniaca dai musulmani 114 , si trattava dell’inizio di un calvario per Sarajevo e per tutta la Bosnia. 2.3 La guerra in Bosnia e l’atteggiamento della comunità internazionale La guerra era ormai esplosa in Bosnia e veniva combattuta parallelamente dall’esercito regolare serbo di Radovan Karadzic e dai gruppi paramilitari che continuavano i loro terribili massacri . La battaglia così condotta portò i serbi alla conquista di molte cittadine bosniache in poco più di una settimana e iniziava già a mostrarsi in tutta la sua drammaticità. Le cifre lasciavano spazio a pochi dubbi: durante la campagna di primavera almeno 35000 persone avevano perso la vita e secondo le stime dell’UNHCR altre 420000 furono costrette ad abbandonare le proprie città con duecento case di media al giorno distrutte 115 . La Bosnia non disponeva di un esercito organizzato come quello di Karadzic e non era in grado di reagire in maniera decisa all’azione dei serbi. La speranza, quindi, continuava ad essere quella che il soccorso sarebbe arrivato dalla comunità internazionale. Purtroppo, nonostante alcuni tentativi diplomatici che soprattutto gli europei tentarono di intraprendere, una spinta decisa in tal senso continuò a non arrivare. L’unico segnale fu dato dall’ambasciatore americano a Belgrado Warren Zimmerman che, per incarico dell’allora segretario di stato americano James Baker, rivolse 112 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., pp. 145-146. Malcolm, Storia della Bosnia, cit., pp.306-307. 114 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., p. 149. 115 Leo Tindemans e altri, Unfinished Peace: Report of the International Commission on the Balkans, Washington, DC, Carnegie Endowment for International Peace, 1996, p. 40. 113 un monito a Milosevic in seguito a un bombardamento dell’aviazione serba su Sarajevo. Milosevic, negando l’evidenza, non fece che dichiararsi estraneo a tutto quello che stava accadendo: il suo obiettivo era quello di far passare il conflitto come una guerra interna alla Bosnia, in cui la Serbia non avrebbe partecipato in alcun modo. Nelle sue memorie, James Baker, inquadra con lucidità la situazione del periodo, scrivendo riguardo l’atteggiamento di Milosevic: “Questo divenne prassi consolidata durante la primavera e l’estate. Noi avremmo espresso le nostre preoccupazioni a Belgrado; Milosevic avrebbe negato ogni responsabilità, ma i combattimenti avrebbero avuto un calo; poi, qualche giorno dopo, i serbi avrebbero iniziato un’altra offensiva. Milosevic sarà un delinquente, ma è un delinquente sofisticato che comprende la politica occidentale”. 116 Cominciò, così, un lungo periodo in cui il presidente serbo ebbe sostanziale campo libero nella guerra contro la Bosnia, prendendosi gioco delle deboli diplomazie occidentali. Nonostante crescesse in quel periodo negli Stati Uniti la voglia di prendere l’iniziativa per trovare una soluzione al conflitto, Baker si prese premura di precisare: ”vogliamo rendere molto chiaro che non ci sarà l’unilaterale uso della forza da parte degli Stati Uniti” 117 . Il 27 maggio, dopo che da diversi giorni Sarajevo si trovava sotto i duri colpi dell’Armata popolare, adesso guidata da Ratko Mladic, personaggio tristemente distintosi per la ferocia mostrata nei combattimenti in Croazia, avvenne un episodio che riportò l’attenzione dell’opinione pubblica mondiale sulla crisi in Bosnia: nelle vicinanze del mercato centrale della capitale, in una via in cui circa duecento persone in fila, tranquillizzate da una tregua dichiarata dai serbi, cercavano di accaparrarsi del pane, furono sparati dei colpi che colpirono a morte almeno venti persone. Una troupe della televisione di Sarajevo giunse immediatamente sul luogo e riprese le crude scene successive al fatto. La velocità con cui i giornalisti si recarono sul posto permise alle persone di tutto il mondo, ancora una volta, di mettere gli occhi su quello che stava accadendo, grazie all’enfasi emotiva trasmessa dalla televisione, ma anche di dare adito ai serbi di accusare i musulmani di aver orchestrato l’attentato per accattivarsi le simpatie occidentali. Le imputazioni furono riprese dal comandante delle forze dell’UNPROFOR Lewis MacKenzie che, senza avere 116 James A. Baker III, with Thomas M. Defrank, The Politics of Diplomacy: Revolution, War and Peace 19891992, New York, G.P. Putnam’s Sons, 1995, p. 643-644. 117 James Baker, “Helping the New Independent States; Sanctions on Serbia-Montenegro”, 24 maggio 1992, U.S. Department Dispatch, Vol. 3, n. 22, 1 giugno 1992, <http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/briefing/dispatch/1992/html/Dispatchv3no22.html>, consultato il 25 maggio 2003. alcun indizio poiché si trovava a Belgrado, dette una versione dei fatti praticamente identica a quella dei serbi118 . In pochi però, ebbero dubbi sulla dinamica dell’accaduto e a seguito di questi fatti l’amministrazione Bush, dopo aver congelato le proprietà di Serbia e Montenegro negli Stati Uniti, fece pressione sulla Comunità Europea e sulle Nazioni Unite affinché venissero ripristinate le sanzioni economiche contro Belgrado. Nonostante l’opposizione del Segretario Generale delle Nazioni Unite Bo utros Ghali, dunque, il Consiglio di Sicurezza approvò il 30 maggio una risoluzione, la 757, che andava in tal senso e che, inoltre, istituiva una zona di sicurezza intorno a Sarajevo e al suo aeroporto per farvi confluire gli aiuti umanitari e incaricava la NATO di organizzare, per la prima volta nella sua storia, una “operazione di monitoraggio marittimo” nell’Adriatico sull’embargo 119 . La risoluzione fu un compromesso fra la diplomazia europea e quella statunitense che, per convincere Parigi a votarla, dovette rinunciare alla richiesta di negare alla Serbia lo status di unico paese ereditario della federazione jugoslava. Ne scaturì una scelta ibrida e per certi versi contraddittoria, che imponeva le sanzioni alla Serbia, ma non ai serbi bosniaci, mentre i musulmani erano colpiti dall’embargo sulle armi 120 . In realtà negli Stati Uniti iniziava a maturare la volontà di intervenire militarmente contro le postazioni serbe e infatti un gruppo di collaboratori di Baker elaborò un piano per rafforzare la pressione su Belgrado, con l’invio di mezzi militari nell’Adriatico che facessero temere in qualsiasi momento un intervento militare e che comunque monitorassero attentamente sull’embargo 121 . Ma questa soluzione presto tramontò perché il presidente Bush non aveva intenzione di “impantanarsi” in una situazione del genere proprio alla vigilia della campagna elettorale, oltre che creare dei dissapori con gli alleati europei. In ogni caso, pochi giorni dopo la risoluzione 757 le Nazioni Unite decisero, questa volta su iniziativa di Boutros Ghali, di inviare nella capitale bosniaca 60 osservatori militari e 1100 caschi blu per rendere effettiva la zona di sicurezza intorno all’aeroporto di Sarajevo e supervisionare il ritiro delle armi antiaeree e la concentrazione di quelle pesanti in punti prestabiliti nella città 122 . Con 118 MacKenzie, Peacekeeper, cit., p. 194; Cohen, With no Peace to Keep, cit., p. 55; Reginald Hibbert, War Among the South Slavs in the Wider Balkan Context, “International Relations”, vol. 12, n. 3, dicembre 1994, p. 4. 119 Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n 757/92, < http://ods-ddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/011/16/IMG/NR001116.pdf?OpenElement>, consultato il 8 aprile 2003. 120 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., p. 170. 121 Baker, with Defrank, The Politics of Diplomacy, cit., pp. 648-649. 122 Department of Public Information, United Nations, United Nations Protection Force – Background text, cit. la risoluzione 758 si cercò “di creare le condizioni necessarie per la libera consegna degli aiuti umanitari a Sarajevo e alle altre località della Bosnia-Erzegovina”123 . L’intento era anche quello di restituire vigore alla missione dell’UNPROFOR, che non raccoglieva molte simpatie fra i bosniaci a causa delle posizioni spesso filoserbe assunte dal suo comandante, il generale MacKenzie. Con la risoluzione 761 del 29 giugno il Consiglio di Sicurezza, infatti, autorizzava l’impiego dei 1100 caschi blu a Sarajevo per proteggere un ponte aereo umanitario, operazione che prendeva il nome di “Provide Comfort” e che fu possibile grazie agli aerei messi a disposizione dalla NATO 124 . Come già accaduto in Somalia, però, gli aiuti umanitari giunsero per la gran parte nelle mani sbagliate: questi divennero presto preda dei serbi, che li rivendevano alla popolazione a prezzi esorbitanti 125 . Il ruolo dell’UNPROFOR in Bosnia, così, era destinato a rafforzarsi ancora: il Consiglio di Sicurezza, dopo che un aereo britannico che trasportava aiuti a Sarajevo era stato attaccato dai serbi, approvò una ulteriore risoluzione, la 770, che invitava gli stati membri a prendere “tutte le misure necessarie” per garantire l’arrivo degli aiuti umanitari a Sarajevo e nelle altre località della Bosnia e quindi, implicitamente, permetteva agli stati l’uso della forza 126 . Le reazioni negative dei serbi a questa risoluzione furono mitigate in parte dall’interpretazione restrittiva della missione fornita dal Segretario Generale delle Nazioni Unite Boutros Ghali che, preso tra il fuoco statunitense da una parte e quello europeo dall’altra (con in testa Francia e Inghilterra), negò sostanzialmente ai caschi blu un intervento vero per proteggere gli aiuti qualora fosse risultato necessario. Così, la risoluzione rimaneva a metà strada, senza costituire un elemento tangibile nuovo che avrebbe cambiato il corso degli eventi in Bosnia. Probabilmente sarebbe bastato molto poco per intimorire le truppe di Mladic, ma la debole diplomazia occidentale non mosse i suoi passi in maniera decisa. I timori, in casa americana erano quelli legati al rischio di addentrarsi in un conflitto che probabilmente avrebbe richiesto l’impiego di truppe di fanteria, elemento che faceva tornare nuovamente le paure della “sindrome del Vietnam”. L’atteggiamento tentennante dell’amministrazione Bush, ormai a pochi mesi dalla competizione elettorale, non faceva che fornire, dall’altra parte, motivati argomenti al suo avversario nella corsa per la Casa Bianca, il democratico Bill Clinton, per attaccarlo. Egli dichiarò: “Non possiamo permetterci di 123 Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 758/92, <http://ods-ddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/011/17/IMG/NR001117.pdf?OpenElement>, consultato il 8 aprile 2003. 124 Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 761/92, <http://daccessods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=S/RES/761%20(1992)&Lang=E&Area=RESOLUTION>, consultato il 8 aprile 2003; Department of Public Information, United Nations, United Nations Protection Force – Background text, cit.; Cohen, With no Peace to Keep, cit., p. 83. 125 Michael Rose, Fighting for Peace: Bosnia 1994, London, The Harvil Press, 1998, p. 26. 126 Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 770/92, <http://ods-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/379/66/IMG/N9237966.pdf?OpenElement>, consultato il 9 aprile 2003; Department of Public Information, United Nations, United Nations Protection Force – Background text, cit. ignorare quello che appare come un deliberato e sistematico sterminio di esseri umani generato dalle loro origini etniche. Io comincerei con l’impiego di aerei contro i serbi per cercare di ripristinare le condizioni umane fondamentali” 127 . Di fronte ad una situazione così drammatica, la comunità internazionale non prospettava alcuna soluzione; un intervento efficace in Bosnia sarebbe stato molto dispendioso, stimando che avrebbe richiesto una presenza sul campo di almeno 400000 soldati. Scrive l’allora primo ministro inglese John Major nelle sue memorie: “Era inconcepibile che qualcosa di simile potesse essere intrapreso senza un totale coinvolgimento della NATO e questo non era prevedibile”128 . Intorno alla metà di agosto il governo britannico prese l’iniziativa organizzando a Londra una “Conferenza allargata sulla ex Jugoslavia”, alla quale furono invitate a partecipare le parti in causa nel conflitto, le repubbliche della ex Jugoslavia e molti altri stati, sia interessati nell’area balcanica, sia naturalmente quelli più impegnati dal punto di vista diplomatico. La conferenza, pur condannando le azioni serbe, si limitò ad approvare un documento ibrido e inconsistente, carico di buoni propositi, che prospettava l’impiego di associazioni umanitarie e l’espansione della missione dell’UNPROFOR a protezione di queste. Il piano non aveva una reale possibilità di essere messo in pratica soprattutto perché a differenza di quello che era avvenuto nella crisi del Golfo non si previde alcuna sanzione militare come garanzia dell’applicazione di questi impegni. Inoltre fu istituita una nuova permanente Conferenza sulla ex Jugoslavia. A presiederla furono chiamati in rappresentanza delle Nazioni Unite, Cyrus Vance, e in rappresentanza della Comunità Europea l’ex ministro degli esteri britannico David Owen. Vance, dopo essere già stato segretario di stato americano nell’amministrazione Carter, aveva ricoperto l’incarico di rappresentante personale per la Jugoslavia del segretario delle Nazioni Unite de Cuéllar ed era stato l’autore dell’omonimo piano, approvato dal Consiglio di Sicurezza con la Risoluzione 724 del 15 dicembre 1991, che attuava una delle tante tregue sottoscritte durante la guerra in Croazia in rappresentanza delle Nazioni Unite 129 . Milosevic e Karadzic non potevano che rivelarsi soddisfatti dai lavori della conferenza di Londra, dalla quale compresero fondamentalmente che potevano continuare nelle loro azioni senza troppi ostacoli, rassicurati quasi del fatto che l’intervento militare dell’occidente non ci sarebbe mai stato. La diplomazia occidentale, dal canto suo, prese l’occasione della conferenza per onorarsi di tanti sforzi per trovare una soluzione pacifica. A farlo furono soprattutto Major e Bush, che avevano bisogno di conseguire una vittoria diplomatica, il primo per affermare la propria leadership in 127 R. W. Apple Jr., State Dept. Asks War Crimes Inquiry into Bosnia Camps, “New York Times”, 6/8/92, p. 128 John Major, The Autobiography, London, Harper Colins Publishers, 1999, p. 535. Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., pp. 194-199. A9. 129 Europa, il secondo per contrastare le critiche di Clinton nella marcia verso le elezioni che si sarebbero tenute qualche mese dopo 130 . Lo stesso Boutros Ghali, risentito dal fatto di essere stato scavalcato dalle scelte della conferenza sull’UNPROFOR e soprattutto dall’elemento sostanziale che il numero ridotto dei caschi blu presenti in Bosnia non avrebbe garantito lo svolgimento dei compiti assegnatigli, scrive: “Non ero in carica neppure da sei mesi ed ero già ai ferri corti con i miei principali elettori. Avevo indisposto tanto gli Stati Uniti che le potenze europee nell’oppormi alle loro richieste di maggiori operazioni di pace delle Nazioni Unite, sottolineando che il Consiglio di Sicurezza non era disposto a fornire alle forze dell’ONU le armi e il mandato necessari per operare in maniera concreta nel mezzo di una guerra amara e sanguinosa”. A questa considerazione si aggiunse anche l’amara constatazione del Segretario Generale che anche dai paesi africani e islamici non mostrarono consenso per il suo operato 131 . Intanto, mentre le diplomazie occidentali discutevano, la guerra andava avanti più cruda che mai: nell’estate erano stati scoperti da alcuni giornalisti dei veri e propri campi di concentramento ricavati da strutture di ogni tipo dove i serbi rinchiudevano e uccidevano i musulmani132 . Così, la missione UNPROFOR proseguiva senza una vera spina dorsale, nonostante ne fossero stati ampliati i compiti e fossero stati cambiati i suoi vertici. La possibilità di agire per le truppe delle Nazioni Unite erano assai limitate, i soldati potevano aprire il fuoco solo per autodifesa, i convogli umanitari non erano adeguatamente protetti dalle grinfie serbe e la popolazione musulmana si rivelava spesso ostile alle forze dispiegate. Il governo di Sarajevo si mostrò contrariato dalle scelte della comunità internazionale che, di fatto, isolavano i musulmani favorendo l’aggressione serba. Izetbegovic formulò più volte richiesta ufficiale alle Nazioni Unite affinché l’embargo di armi al suo paese fosse sospeso di modo che, se la comunità internazionale non intendeva intervenire, almeno sarebbe stata data la possibilità a quel popolo di difendersi da solo. Chiaramente, a causa dell’indignazione che le richieste in tal senso suscitavano in campo serbo, le sinergie che legavano molti paesi soprattutto europei alla Serbia spinsero l’Occidente a non considerare la richiesta dei musulmani133 . 130 Woodward, Balkan Tragedy, cit., p. 302. Boutros Boutros-Ghali, Unvanquished: A U.S.-U.N. Saga, London, New York, I.B. Tauris Publishers, 1999, pp. 43-45. 132 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., pp. 186-187. 133 Magas, Zanic (a cura di), The War in Croatia and Bosnia-Herzegovina 1991-1995, cit., p. 389. 131 Questo fattore, ovviamente, creò un’inevitabile maturazione del contrabbando d’armi, ma non solo da parte musulmana. I serbi, già ben muniti, potevano contare sui rifornimenti che arrivavano dal suo alleato storico, la Russia, mentre i croati si mossero a tutto campo grazie alla potente macchina di marina mercantile di cui disponevano. Certamente fra i paesi maggiori fornitori di armi a Serbia e Croazia non potevano mancare i paesi europei. I musulmani, dal canto loro, avevano maggiori difficoltà anche per l’approvvigionamento illegale, a causa della loro posizione geografica. Il traffico, che spesso passava per la Croazia, richiedeva ai musulmani il pagamento di tangenti molto alte. E’ da segnalare, comunque, che i paesi islamici non fecero mancare il loro apporto ai fratelli musulmani, sia con invio di armi che di uomini che si recarono sul posto a combattere per una causa religiosa che invece i musulmani-bosniaci sentivano molto poco 134 . Intanto la decisione della corte costituzionale della Bosnia-Erzegovina, composta da soli musulmani, che dichiarava illegale la comunità croata della Herceg-Bosna, organizzata sotto la presidenza di Mate Boban con Mostar capitale, indispettì i croati, che riscoprirono le sinergie con i serbi nella guerra contro i musulmani 135 . Il protrarsi e l’espandersi del conflitto richiedeva sempre più un intervento della comunità internazionale. Bush aveva bisogno di intraprendere un’azione per dimostrare all’elettorato americano di essere in grado di arginare la situazione. Così, egli fece pressione sulle Nazioni Unite che approvarono, il 6 ottobre, la risoluzione 780, che istituì un tribunale internazionale simile a quello di Norimberga e poi, il 9 ottobre, la 781, che proibì “tutti i voli militari nello spazio aereo della Bosnia-Erzegovina, eccetto quelli dell’UNPROFOR o di altri in supporto di operazioni delle Nazioni Unite, inclusi quelli di assistenza umanitaria”136 . La misura venne presa per evitare gli attacchi aerei provenienti da velivoli partiti dall’aeroporto di Belgrado. Ancora una volta, però, la mancanza di un misura di rappresaglia contro un’eventuale violazione rivelò la risoluzione 781 un semplice avvertimento inascoltato. Lo stesso avvenne per la successiva risoluzione, la 786, che chiedeva alle parti la cessazione della violazione della “no- fly zone”, prevedendo il dispiego di ulteriori 75 osservatori militari nell’ambito della missione UNPROFOR negli aeroporti di Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro 137 . 134 Ivi, p. 390, Tom Gallagher, Bosnian Brotherhood, “Transition”, 15 marzo 1995, pp. 263-264; Tim Ripley, Air War in Bosnia, “Motorbooks International”, 1996, p. 81; Jasminka Udovicki, James Ridgeway (a cura di), Burn This House: The Making and Unmaking of Yugoslavia, Durham, London, Duke University Press, 1997, p. 190; Woodward, Balkan Tragedy, cit., pp. 263-264. 135 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., pp. 183, 209. 136 Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 780/92, 6 ottobre 1992, <http://ods-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/484/40/IMG/N9248440.pdf?OpenElement>, consultato il 10 aprile 2003; Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 781/92, 9 ottobre 1992, <http://ods-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/491/64/IMG/N9249164.pdf?OpenElement>, consultato il 10 aprile 2003; Department of Public Information, United Nations, United Nations Protection Force – Background text, cit. 137 Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 786/92, 10 novembre 1992, <http://ods-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/689/74/IMG/N9268974.pdf?OpenElement>, consultato il 10 aprile 2003; La soluzione fu individuata dopo il solito compromesso fra gli americani, ora più decisi a intraprendere un’azione vera, iniziando a considerare il problema non solo da un punto di vista elettorale ma anche strategico, in un’area che rischiava di divenire una vera polveriera per tutti i Balcani, e gli europei, attenti alla protezione dei caschi blu nell’area e neanche l’utilizzo da parte della NATO di aerei per il monitoraggio dei voli produsse gli effetti desiderati138 . Si poneva negli Stati Uniti anche un problema morale sul “nuovo ordine mondiale” proclamato dal presidente Bush alla vigilia della guerra del Golfo: bisognava muoversi a tutto campo in questo senso o era soltanto retorica utilizzata a piacimento? Il dibattito negli ambienti americani ferveva e il vicedirettore degli affari jugoslavi presso il Dipartimento di Stato, George Kenney, rassegnò le dimissioni in segno di protesta contro la politica dell’amministrazione. Lo stesso capo di stato maggiore delle forze armate Colin Powell prese posizione contro qualsiasi intervento americano nei Ba lcani. Egli però non poté sostenere a lungo questa posizione alla luce delle notizie delle brutalità compiute dai serbi. La rivelazione di questi atti spinsero il sottosegretario del Dipartimento di Stato Lawrence Eagleburger a pubblicare un memorandum che, con foto e documenti agghiaccianti provava una situazione drammatica: civili costretti a fuggire dalle loro case bruciate e fosse comuni per seppellire le vittime dei massacri. Il memorandum fu inviato al Segretario di Stato che preferì ignorarlo perché altrimenti la comunità internazionale sarebbe stata costretta ad intervenire a tutela della Convenzione di Ginevra 139 . Così, mentre Vance e Owen elaboravano il loro primo piano di pace che non sembrò riscontrare grandi favori e mentre gli attacchi su Sarajevo e su tutta la Bosnia da parte delle truppe di Mladic continuavano come se nulla fosse, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite approvò una ulteriore risoluzione, la 787. Essa instaurò un sostanziale blocco del traffico marittimo nei paesi della ex Jugoslavia, inasprendo così le sanzioni economiche contro la Jugoslavia, e dispose l’impiego di osservatori ai confini della Bosnia per impedire afflusso illegale d’armi ai paesi vicini (misura che rimase solo sulla carta) 140 . Department of Public Information, United Nations, United Nations Protection Force – Background text, cit.; Jane M. O. Sharp, Honest Broker or Perfidious Albion? British Policy in Former Yugoslavia, London, Institute for Public Policy Research, 1997, p. 19. 138 Cohen, With no Peace to Keep, cit., p. 152. 139 Georg Schild, The USA and Civil War in Bosnia, “Aussenpolitik”, vol. 47, n.1, 1996, p. 22; Roy Gutman, A Witness to Genocide: The First Inside Account of the Horrors of “Ethnic Cleansing” in Bosnia, Shaftsbury, Longman, 1993, p.xxxvi; Marko Attila Hoare, Civilian-Military Relations in Bosnia-Herzegovina 1992-1995, in Magas, Zanic (a cura di), The War in Croatia and Bosnia-Erzegovina, cit., p.195; Cohen, With no Peace to Keep, cit. p. 104. 140 Kofi Annan, Report of the Secretary-General Pursuant to General Assembly Resolution 53/35: The Fall of Srebrenica, 15 novembre 1999, <http://2002.xs4all.nl/surfnet/srebrenica.org/unsrerep.pdf>, consultato il 21 aprile 2003, § 30; Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., pp. 240-243; Consiglio di Sicurezza delle Na zioni Unite, Risoluzione n. 787/92, 16 novembre 1992, <http://ods-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/723/03/IMG/N9272303.pdf?OpenElement>, consultato il 10 aprile 2003. In realtà, verso la fine dell’anno, la spinta di Washington per un’azione che risolvesse la crisi si fece più forte. Eagleburger in una sessione della Conferenza sull’ex Jugoslavia denunciò con forza le atrocità serbe, chiedendo l’istituzione di un tribunale internazionale sui crimini di guerra. Bush, infatti, l’8 novembre era stato sconfitto nelle elezioni presidenziali da Bill Clinton e, ormai svincolato da obblighi elettorali, sembrò risvegliarsi: in poche settimane agì più di quanto non avesse fatto nei mesi precedenti. In questo contesto, come visto nel capitolo precedente, gli Stati Uniti rivelarono una maggiore propensione a intervenire in Somalia con 30000 uomini, sotto suggerimento del Pentagono, il quale riteneva che l’invio di truppe nel paese africano sarebbe stato meno rischioso di un impiego dell’esercito in Bosnia 141 . Si ebbero in quel periodo anche le elezioni in Serbia, dove il candidato appoggiato dall’occidente per una risoluzione della crisi, Milan Panic, subì una sonora sconfitta, seppur macchiata da brogli 142 . In una nuova sessione della Conferenza, convocata il 2 gennaio 1993, Vance ed Owen presentarono la bozza definitiva del loro piano. I meriti di esso riguardavano il ritorno a casa previsto per i profughi, ma la divisione della Bosnia-Erzegovina in tre popoli costitutivi, così come l’avevano configurata i due mediatori, non forniva sufficienti garanzie: gli unici a rivelarsi soddisfatti del piano erano i croati, che ne avrebbero ricavato enormi vantaggi territoriali, mentre i serbi non potevano accettare una situazione che toglieva loro una grossa fetta dei territori che avevano conquistato con l’offensiva, impedendo l’unione di questi alla Serbia. I musulmani sarebbero stati inoltre letteralmente in balia delle altre due etnie 143 . Il piano così configurato dette la spinta ai musulmani per riconquistare alcune delle terre occupate dai serbi, che secondo la bozza sarebbero tornate a loro, e spesso vennero utilizzati metodi simili a quelli usati da Arkan nella fazione opposta. Il conflitto si stava aggravando e inasprendo sempre più da ambo le parti e a dimostrazione di questo ci fu l’uccisione da parte dei serbi del vice primo ministro Hakija Turajlic, mentre stava rientrando a Sarajevo su un convoglio dell’UNPROFOR144 . In questo modo il piano Vance-Owen fallì, a denotare un insuccesso della diplomazia, che non riuscì a coinvolgere nella maniera opportuna i vari interlocutori e che cercò di arrivare in fretta ad una facile soluzione che scontentava soprattutto i più deboli. Il neo presidente Clinton, arrivato alla Casa Bianca, sembrò non concordare con questo modo di agire, criticando apertamente questa 141 Fraser Cameron, US Foreign Policy after the Cold War. Global Hegemon or Reluctant Sheriff?, London, Routledge, 2002, p. 21. 142 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., pp. 224-225. 143 Malcolm, Storia della Bosnia: dalle origini ai giorni nostri, cit., pp. 321-323. 144 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., pp.244-245. politica. In una dichiarazione carica di enfasi, il neo Segretario di Stato Warren Christopher, espresse le idee dell’amministrazione in merito: “[…] il conflitto in sé non ha dei confini naturali […] La risposta del mondo alla violenza nella ex Jugoslavia è un immediato e cruciale test su come si indirizzerà la tutela delle minoranze etniche e religiose nel mondo dopo la guerra fredda […] Tiranni aggressivi e minoranze spaventate stanno osservando per vedere se la pulizia etnica è una politica che il mondo tollererà. Se vogliamo promuovere la diffusione della libertà o se vogliamo incoraggiare l’emergere di democrazie pacifiche e multietniche la nostra risposta dev’essere un sonoro no”145 . 2.4 Clinton e la Bosnia L’arrivo di Clinton alla Casa Bianca faceva sperare che gli Stati Uniti avrebbero operato maggiori pressioni sulla comunità internazionale per affrontare la questione bosniaca. Dichiarazioni come quella citata di Christopher furono caratteristiche della strategia di Clinton in campagna elettorale. Molti degli uomini del presidente, anche dopo le elezioni, espressero in più occasioni la volontà dell’amministrazione che gli Stati Uniti si impegnassero nella promozione degli ideali di giustizia e di democrazia dei quali erano il simbolo. Nella vicenda bosniaca essi criticarono aspramente i lavori diplomatici evolutisi nei mesi precedenti giudicandoli non equi e che andavano a premiare gli aggressori, messi sullo stesso piano delle vittime musulmane 146 . L’amministrazione Clinton che, come abbiamo visto, ricevette da più parti le critiche di assumere posizioni utopistiche in politica internazionale, suscitò dunque notevoli speranze in campo musulmano. Essa però, come quella di Bush, nonostante la volontà del presidente di prendere in mano la situazione e assumersi la responsabilità del ruolo di superpotenza, non era affatto disposta ad inviare i propri soldati in Bosnia. Clinton, così, ipotizzò una soluzione comunque gradita ai musulmani, che in verità avevano già caldeggiato Baker e Eagleburger nelle ultime settimane del mandato di Bush: essa prevedeva l’abolizione dell’embargo sulle armi ai musulmani per equilibrare le forze in campo e l’impiego massiccio di aerei NATO per proibire ai serbi di sorvolare lo spazio 145 Secretary of State Warren Christopher, “New Steps Toward Conflict Resolution In the Former Yugoslavia”, U.S. Department of State, Washington, DC, 10 febbraio 1993, <http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/briefing/dossec/1993/9302/930210dossec.html >, consultato il 12 aprile 2003. 146 Rabia, Liftschultz, Why Bosnia?, cit. , p. 389. aereo bosniaco. Questa operazione, che prese il nome di “lift and strike”, avrebbe così combinato l’obbligo morale di soccorrere i musulmani con la riduzione al minimo dei rischi per i militari impegnati nelle operazioni 147 . Un’ipotesi così prospettata dovette scontrarsi sia con i paesi europei che avevano le proprie truppe dispiegate nell’area nell’ambito della missione delle Nazioni Unite, sia con il Pentagono. Perciò Clinton dovette far marcia indietro nei toni antiserbi, accettando una mediazione che non scontentasse gli alleati europei e la Russia, rinunciando, di fatto, anche agli interventi chirurgici del “lift and strike” e riabilitando la base del piano Vance-Owen, da lui tanto criticato148 . L’amministrazione americana per non perdere completamente la faccia affidò dunque al Segretario di Stato Christopher la presentazione di un piano in sei punti che si limitava ad impegnare gli Stati Uniti negli sforzi per la pace nell’area, con azioni non dissimili a quelle che già erano state intraprese nei mesi precedenti149 . La guerra stava assumendo risvolti sempre più drammatici, soprattutto da un punto di vista umanitario, e il presidente Clinton, un po’ a sorpresa dopo i passi indietro compiuti rispetto alle speranze suscitate in campagna elettorale, decise quindi, con il coordinamento delle Nazioni Unite e dell’UNHCR, a supporto del ponte aereo già predisposto con Sarajevo, di inviare aiuti umanitari nell’area attraverso un ponte effettuato con aerei americani per “rivolgersi al bisogno immediato delle aree isolate che non possono essere raggiunte in questo momento via terra”, premurandosi di precisare che: “la priorità per gli invii aerei sarà determinata senza riguardo ad affiliazioni religiose o etniche” e che: “nessun aereo da combattimento sarà usato in questa operazione”150 . L’obiettivo primario era quello di convincere i serbi che gli aiuti sarebbero arrivati comunque, così da indurli ad interrompere i blocchi degli aiuti via terra. C’era anche l’esigenza di tutelare l’operazione, messa a rischio dalla possibilità che i serbi la interpretassero come un affronto e che rinfocolassero la battaglia: gli Stati Uniti si presero premura di negare, in tal senso, il loro coinvolgimento diretto nel conflitto. L’operazione partì il 28 febbraio e vi parteciparono aerei da trasporto francesi e tedeschi, oltre che americani. Dopo la fine del programma, nell’agosto 1994, venne calcolato che soltanto il 10% dei lanci degli aiuti era finito nelle mani giuste e si seppe che i 147 Ivo H. Daalder, Gettino to Dayton: The Making of America’s Bosnia Policy, Washington DC, Brookings Institution, 2000, p. 83; Cohen, With no Peace to Keep, cit. p. 152; Carl Bildt, Peace Journey: The Struggle for Peace in Bosnia. London, Weidenfeld and Nicolson, 1998, p. 114; Maynard Giltman, US Policy in Bosnia: Rethinking a Flawed Approach, “Survival, The IISS Quarterly”, vol. 38, n. 4, inverno 1996-97, p. 72; Silber, Little, The Death of Yugoslavia, cit., pp. 279-280. 148 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, p. 255. 149 Secretary of State Warren Christopher, “New Steps Toward Conflict Resolution In the Former Yugoslavia”, cit. 150 William J. Clinton, Statement Announcement Airdrops to Provide Humanitarian Aid to Bosia-Herzegovina, 25 febbraio 1993, in Public Papers of the Presidents of the United States: William J. Clinton: 1993, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1993, vol. 1, p. 206. musulmani, per accaparrarsi le razioni, erano giunti spesso a risse furibonde. In ogni caso possiamo constatare che l’operazione riuscì comunque a colmare una parte dei bisogni della popolazione 151 . Intanto le denunce delle autorità bosniache sui soprusi dei serbi veniva no spesso ignorate dai responsabili dell’UNPROFOR, i quali tendevano molto a minimizzare la situazione. Così, arrivando segnali un po’ da ogni parte che la comunità internazionale non sarebbe intervenuta contro i serbi, essi si sentirono liberi di muoversi a proprio piacimento, continuando a violare ripetutamente risoluzioni delle Nazioni Unite che non prevedevano sanzioni in caso di mancata applicazione e proseguendo negli attacchi indiscriminati alle città musulmane e negli orribili massacri di civili 152 . Boutros-Ghali, nell’esporre il clima di indecisione e irrisolutezza che regnava nei primi mesi del 1993 e che dava vigore alle azioni dei serbi, scrive di Clinton: Da una parte, bloccava gli sforzi per raggiungere un accordo di pace, perché la sua realizzazione avrebbe richiesto l’invio di truppe americane in Bosnia; dall’altra, rifiutava le proposte per salvare le Nazioni Unite dall’impossibile situazione bosniaca perché un’evacuazione d’emergenza – una Dunquerque, come alcuni la chiamavano – avrebbe richiesto truppe americane per avere successo”153 . Il presidente americano, in realtà, dovette affrontare sia l’avversione degli alleati europei nell’intraprendere un’offensiva militare più decisa 154 , sia la propria indecisione sul da farsi, implicato com’era nella questione somala. Il 31 marzo il Consiglio di Sicurezza approvò la risoluzione 816, che rafforzava la no-fly zone nello spazio aereo della Bosnia-Erzegovina, violata innumerevoli volte, istituendo l’operazione denominata “Deny Flight”, che prevedeva l’impiego di caccia da combattimento nell’area. L’operazione fu assegnata alla NATO ed era la prima volta nella storia che l’Alleanza atlantica era impegnata in una operazione militare al di fuori dei sedici paesi membri155 . La “Deny Flight” apparve a molti segnare un sostanziale cambiamento di rotta nella politica per la risoluzione della crisi. Il problema era che i combattimenti nell’area avvenivano soprattutto con artiglieria pesante di terra e l’unico modo per togliere l’assedio alle popolazioni bosniache sarebbe stato proprio quello che Clinton non voleva e cioè un intervento militare via terra. Così la missione, che risultò alquanto dispendiosa, lasciò molte perplessità sulla sua efficacia, anche per il fatto che i caccia non avrebbero potuto né inseguire aerei nemici, né sparare contro un obiettivo 151 James Gow, Triumph of the Lack of Will: International Diplomacy and the Yugoslav War, London, Hurst & Company, 1997, p. 132. 152 Cohen, With no Peace to Keep, cit. p. 152. 153 Boutros-Ghali, Unvanquished: A U.S. – U.N. Saga, cit., p. 77. 154 Cohen, With no Peace to Keep, cit., p. 130. 155 Department of Public Information, United Nations, United Nations Protection Force – Background text, cit. terrestre neppure per difesa. Purtroppo la Deny Flight, che aveva l’intento di rafforzare l’iniziativa diplomatica del piano Vance-Owen, non solo fu di poco aiuto ai musulmani, ma rischiò anche di far precipitare ulteriormente la situazione irritando i serbi, che infatti il 12 aprile, quasi in contemporanea con l’inizio della missione, misero sotto assedio Srebrenica bombardandola con granate 156 . Durò per poco tempo l’illusione che il piano Vance-Owen, dopo essere stato fatto accettare a croati e musulmani, potesse essere accettato anche dai serbi. Le pressioni in questo senso su Karadzic arrivarono da Milosevic, che però non ebbe la meglio in una battaglia che portò al referendum fra i serbi-bosniaci, che naturalmente nella stragrande maggioranza respinsero il piano 157 . Al rifiuto dei serbi non giunse una forte reazione da parte della comunità internazionale, nonostante l’unanime disappunto per il fallimento del piano Vance-Owen. Il 6 maggio, con la risoluzione 824 le Nazioni Unite decisero di proclamare “zone di sicurezza”, le enclavi musulmane di Tuzla, Zepa, Gorazde e Bihac, dopo che, già alla fine di aprile era stato previsto questo particolare status per Srebrenica e Sarajevo. L’intento sarebbe stato quello di rendere tali zone “libere da ogni attacco armato o da qualsiasi altra azione nemica”, sul modello di quelle organizzate due anni prima nel Kurdistan irakeno. La lacuna fu che ancora una volta non si previde alcuna sanzione per il mancato rispetto della risoluzione, né tantomeno si inviò personale militare sufficiente per garantire una smilitarizzazione dell’area, cosicché le “zone di sicurezza” vennero schernite dai serbi e restarono campi di battaglia a tutti gli effetti. Il risultato mostrò il totale fiasco di una scelta mirata soltanto a placare l’opinione pubblica internazionale 158 . Gli occhi di tutto il mondo erano puntati sulla Casa Bianca e aspettavano una decisione da parte del presidente per fermare i massacri in corso in Bosnia, che nessuno voleva credere potessero essere commessi impunemente. Dal canto suo, Clinton si muoveva in maniera goffa, spiazzato da una situazione che non sapeva come affrontare. In quel periodo si ritornò a parlare anche di “lift and strike”, mentre il Dipartimento di Stato e gli interventisti Anthony Lake e Madeleine Albright 156 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit, pp. 264-267. Ivi, pp. 276-278 158 Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 819/93, 16 aprile 1993, <http://ods-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/221/90/IMG/N9322190.pdf?OpenElement>, consultato il 14 aprile 2003; Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 824/93, 6 maggio 1993, <http://ods-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/262/07/IMG/N9326207.pdf?OpenElement>, consultato il 14 aprile 2003; Department of Public Information, United Nations, United Nations Protection Force – Background text, cit.; Dick A. Leurdijk, The United Nations and NATO in Former Yugoslavia: Partners in International Cooperation, The Hague, Netherlands Athlantic Commission, Netherlands Institute of International Relations “Clingendael”, 1994, p. 41; Cohen, With no Peace to Keep, cit. p. 39; Jan Willem Honig, Norbert Both, Srebrenica: Record for a War Crime , London, Penguin Books, 1996, p. 108; Rabia, Liftschultz, Why Bosnia?, cit., p. 381. 157 incalzavano il presidente per intraprendere un’azione decisa che fermasse la catastrofe umanitaria 159 . La mancanza di consenso in Europa, però, non faceva che accrescere i dubbi del presidente e così l’amministrazione americana finì col perdere interesse verso la questione bosniaca. La proposta di Boutros-Ghali, che sosteneva l’invio di 70000 caschi blu in Bosnia-Erzegovina, fu giudicata “totalmente inaccettabile” da Washington160 , assolutamente non incline a far impantanare i propri soldati in un’area definita con poco gusto dal Presidente Clinton la “shooting gallery” 161 . Così, più per esigenza che per scelta, prevalse la linea di un nuovo containment che fu cara già a Bush, che tanto era stato attaccato da Clinton in campagna elettorale e che, alla luce del fatto che anche il conflitto croato- musulmano andava riacutizzandosi, esprimeva la volontà dell’amministrazione di evitare che gli scontri in Bosnia si ampliassero ulteriormente, attendendo che l’odio fra le etnie si fosse placato. Forse si ignorava che la rivalità tra le etnie in quell’area esisteva e covava da secoli, ma più probabilmente le cose stavano come le descrive Lord Owen: “La politica statunitense è impossibile da decifrare. Ogni giorno, un incubo”162 . L’Occidente, dopo il definitivo abbandono del piano Vance-Owen, a sostegno della tesi che vuole i paesi europei e su tutti la Francia, inclini a considerare il conflitto in Bosnia una guerra civile fra etnie che non potevano convivere nello stesso stato, appoggiò un accordo fra Milosevic e Tudjman sulla tripartizione della Bosnia-Erzegovina, il quale penalizzava fortemente i musulmani, che quindi lo rifiutarono 163 . In una guerra che proseguiva senza troppo clamore, la comunità internazionale non fece che elaborare proposte scialbe e inconsistenti, che non andavano a cambiare di fatto la situazione. In questo senso una ulteriore risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la 836, autorizzava i caschi blu all’uso della forza nell’espletamento del proprio mandato e incaricava la NATO di intervenire attraverso raid aerei se fosse stato richiesto dall’UNPROFOR e dal Segretario Generale. Ancora una volta però, a causa del linguaggio volutamente contraddittorio utilizzato nella risoluzione, questa fu interpretata nella maniera più restrittiva possibile, a palesare la mancanza di coesione nella comunità internazionale e non permise ai caschi blu di difendere effettivamente le zone di sicurezza, consentendo ai serbi di continuare a bombardarle con grande intensità 164 . 159 Daalder, Gettino to Dayton, cit., pp.14-18. Boutros-Ghali, Unvanquished: A U.S. – U.N. Saga, cit., p. 84. 161 William J. Clinton, Exchange with Reporters on Bosnia, 21 maggio 1993, in Public Papers of the Presidents of the United States: William J. Clinton: 1993, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1993, vol. 1, p. 714. 162 David Owen, Balkan Odissey, London, Victor Gollancz, p. 162. 163 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., pp. 296-299. 164 Ivi, pp. 291-293; Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 836/93, 4 giugno 1993, <http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/330/21/IMG/N9333021.pdf?OpenElement>, consultato il 14 aprile 2003 Department of Public Information, United Nations, United Nations Protection Force – Background text, cit. 160 La situazione non era mutata e i serbi, i primi giorni di agosto, intensificarono notevolmente l’offensiva che li portò a conquistare le alture dei monti Igman e Bjelasnica. Questo consentì alle truppe di Mladic di chiudere il cerchio attorno a Sarajevo, conquistando le ultime alture dalle quali i musulmani potevano ancora difendere la città e interrompendo l’unica strada dai quali arrivavano quei pochi aiuti umanitari165 . Le notizie che giungevano dal campo di battaglia sul collasso della fazione musulmana e di una probabile fine del conflitto a favore dei serbi, confermate anche dalle strazianti immagini televisive che arrivavano dalla Bosnia, indussero il presidente Clinton a prendere l’iniziativa sulla base della risoluzione 836 sugli attacchi aerei alle postazioni serbe. In un vertice della NATO tenutosi a Bruxelles, non senza i soliti dubbi da parte degli Stati che avevano le truppe dispiegate nell’ambito della missione delle Nazioni Unite, si dette il via libera all’iniziativa militare che evitasse lo strangolamento di Sarajevo 166 . La questione fu però caratterizzata più che altro dallo scontro che diveniva sempre più aspro fra il presidente americano e Boutros-Ghali, già manifestatosi nella fattispecie, proprio riguardo all’interpretazione restrittiva della risoluzione 836. La diatriba, peraltro di non poco conto, riguardava l’ipotesi che la NATO fosse stata da sola autorizzata ad intervenire scegliendo lei stessa luoghi e tempi dell’azione, ipotesi sostenuta da Clinton, oppure se l’attacco avrebbe richiesto una ulteriore approvazione da parte del Segretario Generale delle Nazioni Unite, come esso stesso chiese in quella occasione. Così si dovette giungere ad un compromesso che, grazie al sostegno di Parigi e Londra, vide la sostanziale accettazione della tesi di Boutros-Ghali sulla necessità dell’assenso delle Nazioni Unite per gli attacchi. I dissidi, dunque, anche se si fece credere che facessero parte di una normale dialettica, erano emersi ed erano destinati a riproporsi, ripercuotendosi sul rapporto con le Nazioni Unite, non solo degli Stati Uniti, ma anche della NATO 167 . Le discussioni furono in parte messe a tacere quando la prima esercitazione di monitoraggio della zona da parte di aerei militari della NATO fece temere ai serbi un imminente attacco e li convinse a lasciare i monti Igman e Bjelasnica alle truppe dell’UNPROFOR. Questo elemento certamente migliorò le condizioni umanitarie di Sarajevo, permettendo di riprendere l’arrivo di approvvigionamenti nella città, ma lasciava sotto tiro la capitale, dato che i musulmani, non avendo 165 Norman Cigar, Serb War Effort and Termination of the War, in Magas, Zanic (a cura di), The War in Croatia and Bosnia-Herzegovina, cit., p. 217. 166 Daalder, Gettino to Dayton, cit., pp. 19-20; Boutros-Ghali, Unvanquished: A U.S. – U.N. Saga, cit. pp. 8889; Cohen, With no Peace to Keep, cit., p. 155; Sharp, Honest Broker, cit., p. 31; Leurdijk, The United Nations, cit., p. 47. 167 Gregory L. Schulte, Former Yugoslavia and the New NATO, “Survival, The IISS Quarterly”, vol. 39, n.1, primavera 1997, pp. 22, 40; Daalder, Getting to Dayton, cit., p. 23; Boutros-Ghali, Unvanquished: A U.S. – U.N. Saga, cit., pp. 86-91, 116. riacquisito il controllo delle alture, ora in mano delle truppe delle Nazioni Unite, non avevano la possibilità di difenderla adeguatamente 168 . Si trattava della solita strategia serba per cui: “In un primo momento i serbi avrebbero occupato un territorio e inferto con orrende atrocità sulla popolazione civile. Allora, gli Stati Uniti, indignati, avrebbero minacciato un intervento in forze. Karadzic avrebbe fermato l’avanzata serba e l’Occidente avrebbe tirato un sospiro di sollievo, bloccando i preparativi per l’azione. Karadzic a quel punto avrebbe chiesto pubblicamente qualcosa in cambio delle ‘concessioni’ fatte. Nella confusione successiva i serbi avrebbero potuto consolidare il potere sul territorio occupato e raggrupparsi in attesa di lanciare un’altra mossa”169 . Intanto il lavoro diplomatico proseguiva con un nuovo progetto, elaborato da Owen, questa volta in collaborazione con Thorvard Stoltenberg, già ministro degli esteri norvegese, che aveva sostituito Cyrus Vance nel ruolo di copresidente della Conferenza per l’ex Jugoslavia. La mappa del progetto prevedeva una spartizione che assegnava il 53% del territorio ai serbi, il 30% ai musulmani e il 17% ai croati. Questa volta furono i musulmani a rifiutare il piano e, oltre al morale acquisito grazie ai successi che iniziavano ad ottenere attorno a Sarajevo, era la Casa Bianca in qualche modo a manovrarli: mentre poche settimane prima in un viaggio negli Stati Uniti Izetbegovic aveva ricevuto segnali poco confortanti sulla volontà di Clinton di impegnarsi a favore dei musulmani, nel caso del piano furono proprio gli americani a convincerli che il piano Owen-Stoltenberg era iniquo e inattuabile 170 . Il 25 maggio il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite approvò la costituzione del Tribunale penale Internazionale per l’ex Jugoslavia, che aveva l’incarico di perseguire i responsabili di crimini di guerra, genocidio e diritti contro l’umanità commessi nei territori della ex Jugoslavia dal 1991 in avanti. Queste notizie furono però messe in ombra da alcuni avvenimenti internazionali verificatisi nel mese di ottobre. Fra questi, l’abbattimento dell’elicottero americano in Somalia, con l’uccisione di 18 soldati e la decisione di Clinton di reagire prendendo parte, di fatto, al conflitto, creò non pochi tormenti nell’opinione pubblica americana, così come in quelli riguardanti il rapporto fra il governo degli Stati Uniti e Boutros-Ghali, ormai deteriorato. In Russia, invece, un tentativo di golpe poi fallito, operato da due leader della Duma che si asserragliarono con i loro uomini nel Parlamento russo, fece concentrare il presidente Boris Nikolaevic El’cin completamente sulla situazione interna 171 . 168 Leurdijk, The United Nations, cit., p. 48; Cohen, With no Peace to Keep, cit., p. 155; Sharp, Honest Broker, cit. p. 31. 169 Boutros-Ghali, Unvanquished: A U.S. – U.N. Saga, cit., pp. 90-91. Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., pp. 288, 313-315. 171 Ivi, pp. 322-323. 170 Alla fine del 1993 i combattimenti proseguirono incessantemente, mentre era chiaro ormai a tutti che le nuove iniziative diplomatiche che avevano cercato di portare ad un piano di pace erano fallite. L’amministrazione americana era ancora indecisa sul da farsi, ma stava rendendosi conto che la credibilità internazionale degli Stati Uniti era messa a serio rischio dall’atteggiamento tenuto nella vicenda bosniaca 172 . Così Clinton cercò di muoversi in qualche modo per trovare una soluzione, ma ogni volta che arrivava il momento di compiere il passo decisivo per un intervento sostanziale nell’area, il presidente faceva marcia indietro: la paura di impantanarsi in un conflitto così geograficamente lontano dagli Stati Uniti, senza sapere quanto sarebbe durato, probabilmente lo frenava in maniera decisiva, soprattutto dopo quello che era successo in Somalia. In visita a Mosca, in una conferenza stampa tenuta insieme a El’cin, Clinton disse: “Vogliamo che quella gente la smetta di uccidersi a vicenda e raggiunga una pace ragionevole”173 , a conferma di un approccio della Casa Bianca incline a pensare che la soluzione dovesse essere trovata direttamente dalle parti in lotta. In realtà, all’interno dell’amministrazione americana le differenze di approccio continuavano ad esserci, tant’è che l’ambasciatore a Belgrado Zimmermann, incaricato di gestire l’intervento umanitario degli Stati Uniti nell’area, resosi conto del fatto che l’azione della quale era responsabile serviva soltanto a coprire la sostanziale inazione del suo paese, rassegnò le dimissioni dall’incarico 174 . Anche l’ambasciatrice alle Nazioni Unite, Medeleine Albright, di ritorno da un viaggio dall’Europa orientale, chiedeva una maggiore attenzione nella politica nei Balcani. La rivolta in Russia, infatti, era stata sedata, ma il nazionalismo panslavo che ne aveva costituito una componente non aveva perso il suo slancio. Nelle elezioni del dicembre 1993, infatti, le forze cosiddette “rosso-brune”, che reclamavano la rinascita di un impero russo e che puntavano sulle alleanze con i paesi ortodossi europei, fra i quali la Serbia, vinsero le elezioni. L’idea della Albright, dunque, era quella di operare pressioni su Mosca per non farla andare alla deriva su posizioni filoserbe e di pacificare croati e musulmani per isolare i serbi175 . Così, mentre la posizione delle Nazioni Unite risultava sempre più priva di una reale strategia, durante il summit della NATO tenutosi il 10 e l’11 gennaio 1994 a Bruxelles, si minacciò 172 Fiona Watson, Richard Ware, Bosnia, the U.N. and the NATO Ultimatum, House of Commo ns Library, Research Paper, 94/33, 17 febbraio 1994, pp. 1-3, 11. 173 William J. Clinton, The President's News Conference With President Boris Yeltsin of Russia in Moscow, 14 gennaio 1994, in Public Papers of the Presidents of the United States: William J. Clinton: 1994, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1994, vol. 1, p. 57. 174 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., p. 346. 175 Rabia, Liftschultz, Why Bosnia?, cit., p. 391; Lenard J. Cohen, Russia and the Balkans: pan-Slavism, Partnership and Power, “International Journal, Canadian Institute of International Affairs”, vol. 49, n. 4, autunno 1994, p. 835; Daalder, Getting to Dayton, cit., p. 24. nuovamente i serbi di: “mettere in atto i raid aerei, per prevenire lo strangolamento di Sarajevo, delle zone di sicurezza e di altre aree minacciate della Bosnia-Erzegovina”176 . A dire il vero questo sembrò più che altro un modo per dare vigore alla NATO dopo la caduta del muro di Berlino e i serbi non si curarono molto neanche di questo ulteriore ammonimento: di fatto fu soltanto consentito ai 150 caschi blu canadesi dispiegati a Srebrenica di essere sostituiti da quelli olandesi177 . Nel frattempo il Senato degli Stati Uniti votava a stragrande maggioranza una risoluzione che chiedeva al governo del proprio paese di “prevedere ad armare adeguatamente il governo della Bosnia- Erzegovina come richiesta di assistenza nell’esercizio del diritto di autodifesa sancito dall’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite”178 . Fu ancora una volta una strage di civili, alla quale i media dettero grande risalto, a scuotere l’opinione pubblica e a costringere l’amministrazione americana a fare qualcosa di più. Nonostante stragi del genere, nelle quali erano stati coinvolti anche molti bambini, fossero state molte nei giorni precedenti e fossero state contornate dalle solite accuse serbe ai musulmani di averle provocate loro stessi per accattivarsi le simpatie dell’Occidente, per fare clamore ci volle il lancio di una granata su un affollato mercato in pieno centro di Sarajevo. L’esplosione provocò, il 5 febbraio, la morte di 68 persone e il ferimento di quasi 200. I serbi negarono ancora ogni responsabilità, senza che le forze dell’UNPROFOR fossero capaci di dare una spiegazione certa dell’accaduto, intimorite anche dalle possibili ritorsioni serbe 179 . Clinton, per assecondare l’opinione pubblica del suo paese, che dopo la strage al mercato di Sarajevo spingeva molto di più per un intervento aereo contro postazioni serbe in Bosnia, si dichiarò “inorridito” dall’accaduto e manifestò la volontà “di fare molto di più per fermare il bombardamento di Sarajevo e il massacro di innocenti”180 . Sebbene non tutti i membri dell’amministrazione, come il nuovo Segretario alla Difesa William Perry, concordassero con questo tipo di scelta, Clinton, spalleggiato da Madeleine Albright, fece pressione su Boutros-Ghali, il quale inviò una lettera al Segretario Generale della NATO Manfred Woerner per chiedere un intervento aereo contro le postazioni d’artiglieria e 176 Declaration of the Heads of State and Government Participating in the Meeting of the North Athlantic Council, Held at NATO Headquarters, Brussels, on 10-11 january 1994, Bruxelles, 11 gennaio 1994, <http://www.nato.int/docu/pr/1994/p94-003.htm>, consultato il 16 aprile 2003. 177 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., pp. 353-354. 178 U.S. Senate, Dole (e altri), Amendment n. 1281, 27 gennaio 1994, <http://thomas.loc.gov/cgibin/query/D?r103:2:./temp/~r1031wagSp ::>, consultato il 16 aprile 2003. 179 David Binder, Anatomy of a Massacre, “Foreign Policy”, n. 97, inverno 1994-95, p. 70-73; Silber, Little, The Death of Yugoslavia, cit., pp. 343-344; D. Owen, Balkan Odissey, cit., pp. 260, 261. 180 William J. Clinton, Remarks Announcing the NATO Decision on Air Strikes in Bosnia and an Exchange with Reporters, 9 febbraio 1994, in Public Papers of the Presidents of the United States: William J. Clinton: 1994, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1994, vol. 1, p. 218. mortaio che circondavano Sarajevo, “per impedire in futuro simili attacchi”181 . Boutros-Ghali, così, cambiò improvvisamente rotta sul da farsi, a dimostrazione di quanto egli fosse ormai in balia degli stati. Dopo un acceso dibattito il Consiglio della NATO, riunitosi il 9 febbraio, decise di intraprendere una storica decisione operativa. La delibera previde l’impiego di aerei per la protezione non solo delle forze delle Nazioni Unite, ma anche della popolazione civile. Inoltre si dispose la smilitarizzazione di alcune zone e che se tutte le armi pesanti attorno ad un’area di venti chilometri da Sarajevo non fossero state ritirate entro dieci giorni, esse sarebbero state “oggetto di attacchi aerei della NATO”182 . La scelta fu il frutto di un nuovo compromesso fra Washington e gli alleati europei. Questi ultimi, per consentire di disporre l’ultimatum, ottennero la promessa che l’amministrazione Clinton non avrebbe aiutato i musulmani e che invece avrebbero cercato di convincerli ad accettare la tripartizione della Bosnia. In più, la città di Pale, pur prevista come zona smilitarizzata per due chilometri, fu esclusa dall’ultimatum183 . La soluzione, dunque, apparve ancora una volta una decisione a metà, anche se, dopo ventidue mesi d’assedio, Sarajevo non poté più essere bombardata dalle alture che la circondavano. Questo risultato fu possibile grazie anche all’apporto del nuovo comandante delle forze UNPROFOR in Bosnia, il britannico Michael Rose, che con manovre spesso al limite della liceità, riuscì a strappare un accordo fra serbi e musulmani per la smilitarizzazione dell’area ancor prima della scadenza dell’ultimatum184 . I serbi però non mollarono la presa. All’alleggerimento dell’offensiva che erano stati costretti in qualche modo ad operare su Sarajevo, si accompagnò una maggiore violenza nell’azione bellica in città come Bihac, Olovo, Tuzla e Maglaj. I serbi, così, continuarono a sfidare l’Occidente mentre Belgrado persisteva nel a violare la no-fly zone. Il 28 febbraio quattro aerei serbi, inviati probabilmente per sondare fino a che punto la NATO sarebbe arrivata nell’azione, furono abbattuti da due caccia statunitensi, in attuazione della risoluzione 816 delle Nazioni Unite. Era la prima volta nella storia che la NATO veniva coinvolta in un combattimento e anche la prima volta che, dopo le ripetute violazioni dei serbi, la comunità internazionale prendeva delle contromisure alla mancata applicazione della risoluzione 185 . Il peggio sembrò passato per i cittadini di città che avevano subito ormai da mesi un assedio continuo che non risparmiava nessuno, ma i serbi reagirono alle mosse di Washington con offensive 181 Boutros-Ghali, Unvanquished: A U.S. – U.N. Saga, cit., p. 114. Decisions Taken at the Meeting of the North Atlantic Council on 9th february 1994, 9 febbraio 1994, <http://www.nato.int/docu/pr/1994/p94-015.htm>, consultato il 16 aprile 2003. 183 Rose, Fighting for Peace, cit., p. 52. 184 Ivi, pp. 48-52; Leurdijk, The United Nations, cit., p. 54; Cohen, With no Peace to Keep, cit., pp. 57-58. 185 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., pp. 366-367. 182 in molte enclavi musulmane. Fra queste la più violenta fu sferrata a partire dalla fine di marzo a Gorazde e in quasi un mese portò alla morte di 716 persone a al ferimento di quasi 2000. Il generale Rose, che al suo approdo in Bosnia come comandante delle forze UNPROFOR promise fermezza nella reazione contro la mancata applicazione da parte serba delle risoluzioni delle Nazioni Unite, una volta trovatosi ad affrontare questa crisi non seppe muoversi di conseguenza e soltanto quando la situazione risultò drammatica chiese l’intervento aereo della NATO. Il 10 aprile due F-16 dell’aviazione americana bombardarono le truppe d’attacco serbe, compiendo nuovamente un atto storico, visto che era la prima volta di un attacco NATO su un obiettivo di terra. I serbi bosniaci non recepirono e un altro attacco NATO si ebbe il giorno successivo. Mladic e Karadzic lanciarono proclami minacciosi contro la NATO e le Nazioni Unite e i pochi caschi blu presenti nell’area furono facile preda delle truppe serbe che presero in ostaggio 150 fra osservatori militari e caschi blu attorno Sarajevo 186 . Il dibattito e le polemiche sul da farsi ferveva sia fra gli alleati occidentali che all’interno della stessa amministrazione americana. Al solito atteggiamento prudente del Pentagono facevano da contrappeso i consiglieri civili della Casa Bianca, come Anthony Lake, che continuavano a chiedere, anche per una questione morale, una risposta da parte degli Stati Uniti187 . L’atteggiamento incerto e ambiguo del governo degli Stati Uniti non metteva certo in luce l’operato del presidente, accusato sempre più di inconsistenza e incapacità in politica estera. Il 22 aprile si tenne una sessione d’emergenza della NATO che decise per Gorazde un ultimatum simile a quello previsto per Sarajevo. La smilitarizzazione non avvenne, ma l’Occidente non seppe reagire all’ulteriore violazione, anche per l’opposizione del presidente francese François Mitterand, che temeva per i propri uomini impegnati nelle operazioni delle Nazioni Unite a Gorazde 188 . La credibilità della NATO e delle Nazioni Unite, a causa dei dissapori fra le maggiori potenze occidentali, era messa a dura prova. Intanto l’amministrazione americana manifestava un ritrovato interesse per la vicenda bosniaca, adoperandosi in iniziative diplomatiche che videro un accordo fra musulmani e croati, che prevedeva, tra le altre cose, una collaborazione fra i due eserciti. Questo significò l’invio da parte degli Stati Uniti di macchinari sofisticati che, secondo una dubbia interpretazione, erano esclusi dall’embargo, ma che comunque migliorarono molto le capacità militari delle forze musulmane. Inoltre, l’ambasciatrice americana alle Nazioni Unite Madeleine Albright si recò a Sarajevo a colloquio con Izetbegovic, dichiarando che i loro paesi sarebbero stati da quel momento 186 Ivi, pp. 374-377, 381; Annan, Report, cit., § 123, 133. James Gow, Bosnia I: Stepping up the Peace?, “The World Today”, vol. 51, n. 7, luglio 1995, p. 126. 188 Silber, Little, The Death of Yugoslavia, cit., pp. 369-370; Boutros-Ghali, Unvanquished: A U.S.-U.N. Saga, cit., p. 148. 187 indissolubilmente legati. Queste azioni furono viste da molte parti come un’iniziativa per isolare i serbi e convincerli a sedersi al tavolo delle trattative, ma sembrò anche una più chiara presa di posizione americana nel conflitto 189 . Negli Stati Uniti, a dire il vero, non si era mai abbandonata l’idea di rifornire davvero di armi i musulmani per consentire loro di contrastare l’offensiva serba. Fino a quel momento questa ipotesi era stata frenata soltanto dall’intenzione americana di non alimentare il fondamentalismo islamico, ma intorno alla fine di aprile negli ambienti del Dipartimento di Stato americano maturò l’idea di trovare un sistema per fornire questo aiuto in maniera clandestina, raggirando le risoluzioni prese dalle Nazioni Unite sull’embargo e senza sollevare questioni diplomatiche. L’avvenuta pacificazione fra Sarajevo e Zagabria dava da questo punto di vista nuove possibilità, dato che l’arrivo di armi in Bosnia necessitava inevitabilmente di un passaggio per il territorio croato 190 . Così Washington mosse i primi passi segreti favorendo un’operazione che prevedeva l’arrivo di armi iraniane in Bosnia attraverso la Croazia, tranquillizzando i croati che durante l’invio di queste armi ai musulmani gli Stati Uniti “avrebbero guardato dall’altra parte”, avallando così una singolare alleanza con l’Iran191 . Questa situazione accrebbe notevolmente la forza militare musulmana, anche perché Teheran, che già da tempo aveva inviato centinaia di mujaheddin ben preparati in Bosnia, non si limitò a fornire armi, ma organizzò a Sarajevo veri e propri corsi di addestramento per i bosniaci192 . Negli Stati Uniti, intanto, i repubblicani si mostrarono determinati a costruire una dura opposizione alla politica di Clinton, anche sulla gestione della questione bosniaca. A dimostrazione di questo il senatore Bob Dole, ignorando probabilmente le attività di armamento illegale che avvenivano già in Bosnia, presentò un emendamento alla legge di bilancio che chiedeva a Clinton di abolire unilateralmente l’embargo di armi alla Bosnia, cosa che mise in non poca difficoltà il presidente con le Nazioni Unite e nei rapporti con gli alleati europei193 . Nel frattempo i governi di Stati Uniti, Russia, Francia, Gran Bretagna e Germania, costituirono un “Gruppo di contatto” per la ricerca di una soluzione nel conflitto nella ex Jugoslavia. Questa scelta, segno della volontà di El’cin di instaurare una nuova collaborazione fra Russia ed Occidente, serviva da una parte per alleggerire il processo decisionale sulla questione bosniaca, dall’altra escludeva, di fatto, la Comunità Europea, così come le Nazioni Unite e il suo 189 Rose, Fighting for Peace, cit., pp. 68, 81, 100; Cigar, Serb War Effort and Termination of the War, cit., p. 223; Tim Ripley, Operation Deliberate Force: the U.N. and NATO Campaign in Bosnia 1995, Lancaster, Centre for Defense and Internationa Security Studies, 1999, p. 90. 190 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., pp. 383-385. 191 Maud S. Beelman, Dining with the Devil: America’s Tacit Cooperation with Iran in Arming the Bosnian, “Alice Patterson Foundation Reporter”, vol. 18, n. 2, 1997, pp. 23-32. 192 Cigar, Serb War Effort and Termination of the War, cit., pp. 221-223. 193 U.S. Senate, Dole (e altri), Amendment n. 2518, 10 agosto 1994 <http://thomas.loc.gov/cgibin/query/D?r103:13:./temp/~r103omHVDD::>, consultato il 17 aprile 2003. Segretario Generale, ormai sempre più isolato. Ma anche questa decisione non condusse a niente di concreto. Il piano proposto dal Gruppo di contatto avrebbe previsto la divisione della Bosnia in due parti, l’una da assegnare ai musulmano-croati, l’altra ai serbi, con le due entità che si sarebbero poi federate. Gli Stati Uniti fecero intendere ai musulmani di non essere più così decisamente schierati con loro: tale scelta cercava di raggiungere così un compromesso accettabile anche per gli europei. Il piano, però, trovò comunque la netta opposizione di Karadzic, che ebbe duri scontri con Milosevic, il quale adesso era più propenso a chiudere il conflitto 194 . Il rifiuto dei serbi del piano del Gruppo di contatto fu seguito da atti di provocazione e di sfida nei confronti dell’UNPROFOR, il quale richiese l’intervento degli aerei della NATO. I raid furono eseguiti, ma i risultati di tali azioni furono evanescenti, perché il generale Rose lasciò trapelare ai serbi quelle informazioni che consentirono a Mladic di far sfuggire le proprie truppe dall’attacco 195 . L’attenzione dei principali attori internazionali in quel periodo rimase sul tema della fornitura di armi agli eserciti in lotta. Se da una parte l’approvvigionamento illegale di armi ai musulmani proseguiva, dall’altra la stessa cosa venne predisposta dai russi per fornire materiale bellico ai serbi. Inoltre, come premio per l’ammorbidimento nelle posizioni di Milosevic, la comunità internazionale concesse alla Serbia un alleggerimento delle sanzioni economiche, sancito dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nella risoluzione 943 196 . Intanto il presidente Clinton, pressato dal Congresso, dovette affrontare la questione dell’embargo sulle armi ai musulmani. Il 15 ottobre, arrivati termine ultimo concessogli dal Congresso per decidere, suggerì una moratoria di sei mesi sull’embargo, che Izetbegovic accettò senza troppi indugi, ormai rifornitissimo di armi ed in grado comunque di lanciare controffensive ai serbi. Questa scelta, dunque, non minacciò la ritrovata sintonia col governo di Sarajevo. Questa fu confermata dalla visita rassicurante, nella capitale bosniaca, del nuovo vicesegretario di Stato americano per gli affari europei, Richard Holbrooke e ancora, il 3 novembre, dalla richiesta presentata all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite dall’ambasciatrice americana Madeleine Albright, di abolizione dell’embargo al governo di Sarajevo. La mozione fu approvata dall’Assemblea, ma l’astensione di Francia, Gran Bretagna e Russia preludeva al fatto che essa sarebbe stata respinta dal Consiglio di Sicurezza, come in realtà avvenne, mettendo in grande difficoltà il presidente Clinton negli accordi presi con il Senato 197 , ancor di più dopo le elezioni di 194 Pirjevec, Le guerre jugoslave1991-1999, cit., pp. 387-394. Ivi, p. 398. 196 Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 943/94, 23 settembre 1994, <http://ods-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/372/78/PDF/N9437278.pdf?OpenElement>, consultato il 17 aprile 2003. 197 Ripley, Operation Deliberate Force, cit., p. 94; Gow, The Triumph of Lack of Will, cit., p. 220; Lawrence Freedman, Why the West Failed, “Foreign Policy”, n. 97, inverno 1994-95, p. 69; Daalder, Getting to Dayton, cit., p. 31. 195 mid-term, che videro i repubblicani ottenere un risultato eloquente: per la prima volta in quarant’anni avevano conquistato la maggioranza assoluta in entrambi i rami del Congresso 198 . Il presidente americano, così, si ritrovava in una situazione tutt’altro che invidiabile: le pressioni del Congresso lo costringevano ad intensificare l’azione a favore dei musulmani, ma dall’altra parte lo mettevano in forte crisi con gli alleati europei, che si mostrarono molto irritati da una condotta del genere. Ne risentiva anche la situazione all’interno della stessa amministrazione: Lake e la Albright, quasi sul punto di rassegnare le dimissioni in seguito alle scelte oscillanti del presidente, furono rinfrancati dalla nuo va linea di condotta in qualche modo imposta dal Congresso. Il governo di Sarajevo, inoltre, sfruttò la situazione stringendo una stretta alleanza con i repubblicani americani e costringendo Clinton a dare ancor più attenzione alle loro ragioni, in quella che ormai negli Stati Uniti si era trasformata in una questione di politica interna 199 . Sul fronte di guerra, durante gli ultimi giorni dell’anno, grazie alla mediazione dell’ex presidente americano Jimmy Carter, fu firmata una tregua che prevedeva un cessate il fuoco che avrebbe dovuto prolungarsi quattro mesi. La tregua, però, durò meno del previsto e dopo giorni in cui, pur in maniera più blanda, si continuò a combattere, agli inizi di febbraio le battaglie ricominciarono in maniera violenta200 . I bosniaci, adesso, vantando rispetto ai mesi precedenti un rapporto di forza militare più equo con i serbi, erano in grado di fronteggiare le truppe di Mladic; per contro, in questa situazione l’atteggiamento del governo di Sarajevo, forte anche dell’appoggio politico americano, risultò irrigidirsi, complicando ancor di più ogni proposta diplomatica. Clinton, tra aprile e maggio del 1995, si rese conto di rischiare seriamente di essere travolto dalla vicenda bosniaca e cercò di muovere i passi perché la questione venisse risolta nel più breve tempo possibile. Così il presidente inviò a Belgrado uno dei diplomatici più esperti del Dipartimento di Stato, Robert Frasure, per trattare con Milosevic. L’abilità del presidente serbo portò al raggiungimento di un’intesa di base sul piano elaborato dal Gruppo di contatto in cambio di una sospensione delle sanzioni alla Jugoslavia. Tale accordo suscitò reazioni negative sia a Belgrado, da parte delle fazioni nazionalistiche che contestarono Milosevic, sia a Washington, dove le critiche a Clinton arrivarono tanto dal Congresso quanto dall’interno della propria amministrazione. In particolare, Madeleine Albright minacciò per la seconda volta nel giro di poco 198 Ferdianndo Fasce, Da George Washington a Bill Clinton. Due secoli di presidenti USA, Roma, Carocci, 2000, pp. 162-163. 199 Patrik Moore, January in Bosnia, “Transition”, 30 gennaio 1995, pp. 21-22; Daalder, Getting to Dayton, cit., pp. 84-87. 200 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., pp. 439 ; Annan, Report, cit., § 177. tempo le dimissioni. Inoltre, queste iniziative solitarie del governo americano irritarono ulteriormente i paesi europei201 . A minare gli accordi fra Frasure e Milosevic ci pensarono subito i serbo-bosniaci, riprendendo a bombardare con violenza Sarajevo. La NATO reagì impiegando aerei spagnoli per operare il primo bombardamento non collegato direttamente ad un’azione bellica della sua storia, colpendo un deposito di armi a Pale. Mladic rispose con minacce e fatti, con pesanti azioni su Tuzla e assalti alle truppe dell’UNPROFOR. Iniziò un periodo di schermaglie fra azioni serbe e risposte occidentali che portò ad un’escalation della guerra, senza che le popolazioni bosniache ne ricavassero realmente alcun beneficio. Le immagini televisive delle truppe delle Nazioni Unite, maltrattate e umiliate, suscitarono profonda emozione in tutto il mondo 202 . Così, mentre la credibilità della comunità internazionale, quella degli Stati Uniti in testa, delle Nazioni Unite e della NATO, erano messe a serio rischio, Clinton dichiarò nel corso di un intervento all’Accademia delle forze aeree a Colorado Springs di dover “rivedere attentamente ogni richiesta per un’operazione d’impiego per un uso temporaneo delle nostre truppe di terra”203 . La portaerei americana Roosevelt venne inviata nell’Adriatico, mentre i governi di Gran Bretagna e Francia organizzarono una Forza di reazione rapida che portò 12500 uomini ben armati dei due paesi a sostegno delle truppe UNPROFOR. La scelta segnò un punto di svolta nella politica di Londra e Parigi, ma mise in evidenza ancora una volta lo scavalcamento delle Nazioni Unite, dato che queste truppe iniziarono ad affluire in Bosnia già prima dell’avallo del Consiglio di Sicurezza. Inoltre la situazione provocò le dimissioni di Lord Owen dalla Conferenza di pace sulla ex Jugoslavia. Egli, infatti, si era reso conto che lo spazio per la diplomazia era ormai ridottissimo 204 . La guerra in Bosnia proseguiva incessante. La Forza di reazione rapida compiva azioni più che altro per garantire i caschi blu e le operazioni umanitarie, in un ambito comunque limitato. Il fatto che destò più clamore fu la conquista dei serbi dell’enclave di Srebrenica, già dichiarata area protetta dalle Nazioni Unite. Il 10 agosto infatti, Madeleine Albright informò il Consiglio di Sicurezza di avere prove certe di veri e propri massacri e eccidi di massa, disponendo di foto e 201 Bildt, Peace Journey, cit., p. 14, 28, 39; Helen Heigh-Phippard, The Contact Group on (and in) Bosnia: an Exercise in Conflict Mediation?, “International Journal”, Vol. 53, n. 2, primavera 1998, p. 309; Norman Cigar, How Wars End: War Termination and Serbian Decisionmaking in the Case of Bosnia, “South East European Monitor”, vol. 3, n. 1, 1996, p. 26; Ripley, Operation Deliberate Forece, cit., p. 95. 202 Richard Ware, Fiona Watson, Tom Dodd, Bosnia: Update and Supplementary Information, Research Paper, 95/69, House of Commons Library, 30 maggio 1995, p. 16-17; Cigar, How Wars End, cit., p. 11; Owen, Balkan Odissey, cit., pp. 323, 355; Ripley, Operation Deliberate Force, cit., pp, 107-110. 203 William J. Clinton, Remarks at the United States Air Force Academy Commencement Ceremony in Colorado Springs, Colorado, 31 maggio 1995, in Public Papers of the Presidents of the United States: William J. Clinton: 1995, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1995, vol. 1, p. 767. 204 Sharp, Honest Broker, cit., p. 53; Jane M. O. Sharp, Dayton Report Card, “International Security”, vol. 22, n. 3, inverno 1997-98, p. 113; D. V. Nicholls, Bosnia: UN and NATO, “The World Today”, vol. 53, n. 2, febbraio 1997, p. 31. filmati satellitari che mostravano sepolture in fosse comuni. Era la realtà cruda di quello che accadde nelle settimane precedenti a Srebrenica: tra le sette e le otto mila persone erano state uccise in questo modo 205 . La questione scatenò una valanga di polemiche: il governo americano fu accusato di essere stato in possesso di quelle informazioni già prima e durante l’accaduto e che avrebbe potuto fermare quel massacro. Quelle che destarono il maggiore scalpore però, ricaddero sui caschi blu olandesi che furono incolpati di non essere intervenuti per fermare l’aggressione, lasciando fare i serbi e tacendo poi su quello che avevano visto, compreso il fatto che all’azione avessero partecipato anche le truppe belgradesi206 . L’escalation del conflitto in Bosnia vide i serbi, dopo gli eventi di Srebrenica, puntare su Zepa con l’aiuto delle truppe di Belgrado. Questi fatti convinsero l’Occidente dell’insostenibilità di una situazione del genere e iniziò a farsi largo l’ipotesi di un intervento militare più deciso. L’amministrazione Clinton sembrò per la prima volta convergere tutta per questa ipotesi, dopo che l’anti- interventista, il generale Powell, fu congedato da capo di stato maggiore delle forze armate e che anche il numero uno del pentagono, William Perry, si rese conto che un’azione aerea avrebbe potuto incidere notevolmente nel corso degli eventi207 . Negli Stati Uniti si avvicinavano le elezioni presidenziali: Clinton, proprio in quel periodo, confidò ai suoi collaboratori che l’inazione statunitense nella crisi bosniaca rischiava seriamente di mettere a repentaglio la sua rielezione. Egli si rese conto che fosse giunto il momento di togliersi di mezzo la questione bosniaca 208 . 2.5 La svolta americana Nell’estate del 1995 il metodo della cosiddetta “doppia chiave”, che prevedeva una risposta militare alleata soltanto dopo l’avallo di Nazioni Unite e NATO, divenne totalmente inadeguato. Con questo sistema dalla procedura farraginosa, nei mesi precedenti, le truppe serbe erano infatti riuscite spesso ad eludere gli attacchi aerei alleati mirati a colpire postazioni serbe utilizzate nell’offensiva. La credibilità delle Nazioni Unite, poi, diminuiva ogni giorno. Significativa in 205 Cohen, With no Peace to Keep, cit., p. 84, 158; Rose, Fighting for Peace, cit., p. 238; Honig, Both, Srebrenica, cit., pp. 59-60; Daalder, Getting to Dayton, cit., p. 68; Magas, Zanic (a cura di), The War in Croatia and Bosnia-Herzegovina, cit., p. 255; Sharp, Honest Broker, cit., p. 56. 206 Magas, Zanic (a cura di), The War in Croatia and Bosnia-Herzegovina, cit., p. 255; Sharp, Honest Broker, cit., p. 56; Richard Holbrooke, To End a War, New York, Random House, 1998, p. 70; Cohen, With no Peace to Keep, cit., pp. 94, 100; Sharp, Dayton Report Card, cit., p. 112. 207 Daalder, Gettino to Dayton, cit., pp. 69-70; Sharp, Honest Broker, cit., p. 54. 208 Bob Woodward, The Choice, New York, Simon & Schuster, 1996, pp. 265, 328. proposito fu l’atteggiamento di Boutros-Ghali, che sembrava muoversi ignorando la gravità della situazione: impegnato com’era nella corsa alla rielezione a Segretario Generale, egli era intento più che altro a non scontentare i governi di Londra e Parigi, una volta che i suoi rapporti con gli Stati Uniti si erano definitivamente lacerati209 . L’amministrazione americana premeva per un intervento più deciso ed efficace della comunità internazionale, cercando sia di snellire la procedura decisionale per l’attacco, sia di approvare interventi militari a più largo raggio, da compiere non solo nell’area dove le truppe di Mladic avrebbero lanciato un’offensiva, ma contro tutti gli obiettivi militari serbi. In questo senso si indirizzarono le scelte: la NATO elaborò una serie di obiettivi da colpire, del resto da tempo individuati, che prevedevano da una parte la distruzione di ogni difesa aerea serba, dall’altra la distruzione di tutti gli armamenti che mettevano in pericolo le “zone di sicurezza” e i caschi blu. Lo stesso Milosevic fu informato dalla NATO sulla lista degli obiettivi da colpire nel caso in cui i serbi avessero compiuto ulteriori provocazioni 210 . Ormai era evidente il sostegno degli Stati Uniti al governo di Sarajevo nel conflitto bosniaco. Nonostante la decisione di porre il veto sulla richiesta di sospensione dell’embargo ai musulmani, presa per non deteriorare troppo i rapporti internazionali, Clinton sembrò non avere scelta sul da farsi. A convincerlo, più che l’impulso serbo nell’avanzata in Bosnia avvenuta nei mesi precedenti, fu l’imminenza delle elezioni presidenzia li che si sarebbero tenute l’anno successivo. Il presidente non desiderava che il senatore Bob Dole, il più probabile candidato repubblicano alla Casa Bianca nonché principale fautore della revoca dell’embargo al governo della Bosnia nella propria veste di leader della maggioranza repubblicana al Senato, potesse rivolgergli nel corso della campagna elettorale quelle medesime accuse che Clinton stesso aveva lanciato a Bush quattro anni prima 211 . Così l’amministrazione americana mise in pratica una prima fase di questo sostegno appoggiando l’esercito croato nell’intervento a difesa dell’enclave musulmana di Bihac, città che se entrata nelle mani dei serbi avrebbe reso impossibile il ripristino della sovranità del governo di Zagabria sulle regioni di Krajina, Ba nija e Lika. L’iniziativa dissuase l’esercito serbo che si ritirò. Il 3 agosto, però, i serbi bosniaci bombardarono Dubrovnik. L’episodio scatenò la reazione di Zagabria che, grazie anche all’impiego di sistemi militari tecnologici forniti dagli americani, sferrò 209 Pirjevec, Le guerre jugoslave, cit., p. 485. Cohen, With no Peace to Keep, cit., pp. 16, 26; Warren Christopher, In the Stream of History: Shaping Foreign Policy for a New Era, Stanford, CA, Stanford University Press, 1998, p. 349; Daalder, Getting to Dayton, cit., p. 79-81; Nicholls, Bosnia, UN and NATO, cit., p. 35; Ripley, Operation Deliberate Force, cit., p. 207; Sharp, Honest broker, cit., p. 57; Joris Janssen Lok, “Deny Flight” Turns to Affirmative Action, “Jane’s Defense Weekly”, 9 settembre 1995, p. 53. 211 Daalder, Getting to Dayton, cit., pp. 62-63; Cohen, With no Peace to Keep, cit., p. 159. 210 un’azione che in poco tempo segnò la cacciata delle truppe serbe ancora in territorio croato, senza che le truppe di Belgrado intervenissero a loro sostegno 212 . Come era ovvio il presidente Clinton guardava con favore il corso degli ultimi eventi nella ex Jugoslvia e sperava che potessero essere una spinta per una soluzione più rapida della crisi, mentre la Comunità Europea non condivise la politica di Tudjman. L’amministrazione americana non perse tempo ed elaborò un piano che chiedeva a Milosevic di riconoscere la Croazia e la Bosnia- Erzegovina in cambio dell’abolizione delle sanzioni contro Belgrado. Così facendo Karadzic sarebbe stato costretto ad accettare il piano del Gruppo di contatto secondo la spartizione 51:49. Una volta sottoscritto questo patto gli americani si sarebbero impegnati in una missione militare della NATO per imporre la pace. Con il piano si rendeva noto, però, che se i serbi avessero continuato nelle loro attività belliche gli Stati Uniti erano pronti a bombardarli anche unilateralmente e ad abolire l’embargo al governo di Sarajevo 213 . Gli Stati Uniti avevano assunto la leadership nella gestione della vicenda e ciò risultò chiaro non solo dalla dichiarata intenzione di bombardare unilateralmente nel caso in cui i serbi avessero perseverato nel conflitto, ma anche dal modo in cui essi elaborarono la proposta di pace: essa fu presentata non come una soluzione da discutere, bensì come una decisione già presa. Tuttavia il piano fu salutato con generale favore da tutti i principali paesi europei, nonché dalla Russia, per una soluzione che veniva giudicata sostanzialmente equa 214 . Per avanzare la proposta diplomatica l’amministrazione americana decise di intraprendere una missione fra Zagabria, Belgrado e Sarajevo, con a capo il vicesegretario di Stato Richard Holbrooke, e composta da membri di spicco del governo degli Stati Uniti, a conferma della rinnovata decisione di Clinton di cercar di risolvere la crisi. Dopo aver discusso con Milosevic e Tudjman e dopo aver riscontrato da parte dei comandanti delle Nazioni Unite una nuova opposizione ad una operazione giudicata azzardata, la nutrita delegazione, nonostante l’ostacolo dei serbi che bloccavano ogni accesso alla città, si recò a Sarajevo. L’imprudenza che portò la delegazione, pur di non chiedere il permesso ai serbi, a sfidare la tortuosa via d’accesso che costituiva l’unico passaggio non controllato dalle truppe di Mladic, causò un incidente nel quale morirono tre diplomatici francesi. Il fatto colpì molto tutta l’amministrazione Clinton, che viveva in prima linea quei fatti, come fino a quel momento non aveva fatto. Così fu inviata nei Balcani una 212 Magas, Zanic (a cura di), The War in Croatia and Bosnia-Herzegovina, cit., p. 103-104; Ripley, Operation Deliberate Force, cit., p. 183; Bildt, Peace Journey, cit., p. 74. 213 Sharp, Honest Broker, cit., p. 57; Bildt, Peace Journey, cit., p. 83; Ripley, Operation Deliberate Force, cit., p. 196; Christopher, In the Stram of History, cit., p. 349; Wesley K. Clark, Waging Modern War: Bosnia, Kosovo and the Future of Combat, New York, Public Affairs, 2001, pp. 51-52. 214 Daalder, Getting to Dayton, cit., pp. 110, 113; Christopher, In the Stram of History, cit., p. 349. ulteriore missione che vedeva Holbrooke determinato a chiudere, nel bene o nel male, in un paio di settimane i colloqui215 . Nel frattempo il conflitto vedeva ora in vantaggio croati e musulmani, forti dei nuovi armamenti di cui disponevano. Una situazione del genere, però, portava ad un’escalation nei combattimenti con i serbi che rispondevano per vendetta, intenzionati com’erano a non desistere. La strategia di Karadzic e Mladic era quella di prolungare la battaglia fino a alla metà di settembre, periodo in cui Clinton sarebbe stato costretto ad abolire l’embargo sulle armi ai musulmani come promesso al Congresso; così contavano sulla rottura della sinergia fra Washington e Mosca che avrebbe portato il Cremlino ad abolire a sua volta l’embargo contro la Jugoslavia, elemento che probabilmente non avrebbe lasciato indifferente Belgrado, con un conseguente allargamento del conflitto 216 . Mentre i serbi cercavano di sondare fino a che punto Washington facesse sul serio, gli Stati Uniti capirono il gioco dei serbi e cercarono di muoversi con cautela. Il 28 agosto, però, accadde un episodio che non consentì ulteriori temporeggiamenti: ancora una volta, un anno e mezzo dopo, i serbi colpirono di nuovo il mercato di piazza Markale a Sarajevo, compiendo una strage che vide la morte di 39 persone e il ferimento di altre 90. Anche questa volta le immagini crude del massacro furono trasmesse in tutto il mondo dalla CNN217 . L’episodio costituì la classica goccia che fece traboccare il vaso e Clinton si mostrò deciso a non esitare più. In quei giorni Boutros-Ghali fu colpito da una forte influenza e non poté gestire la situazione. Ad approfittarne fu il suo vice, Kofi Annan, il quale praticamente offrì carta bianca agli Stati Uniti: egli si adoperò perché la “chiave” di pertinenza delle Nazioni Unite per l’approvazione dei bombardamenti venisse superata agilmente, sapendo che per quello che riguardava poi i vertici militari della NATO non ci sarebbe stata alcuna opposizione. Annan, in questo modo, si garantì le simpatie americane nella corsa all’elezione alla Segreteria Generale delle Nazioni Unite 218 . La sera del 28 agosto venne data l’approvazione ai bombardamenti aerei. Fu un vero e proprio colpo di mano degli Stati Uniti, dato che prima di dare l’assenso all’azione non furono informati, oltre che il Segretario Generale in carica delle Nazioni Unite, neanche le autorità dei paesi che avevano le proprie truppe dispiegate nella missione UNPROFOR. Per assecondare l’amministrazione Clinton e non creare problemi, l’allora Segretario Generale della NATO Willy 215 Holbrooke, To End a War, cit., pp. 9-13; Christopher, In the Stream of History, cit., p. 380; Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., pp. 499-500; Daalder, Getting to Dayton, pp. 116-119. 216 Bildt, Peace Journey, cit., p. 94; Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., pp. 500-501. 217 Lok, “Deny Flight”, cit., p. 57; Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., p. 501. 218 Holbrooke, To End a War, cit., pp. 92, 99, 103; Boutros-Ghali, Unvanquished: A US-UN Saga, cit., p. 243; Cohen, With no Peace to Keep, cit., p. 159. Claes non convocò neppure il Consiglio dell’Alleanza per chiedere l’approvazione ai raid, limitandosi ad informarlo quando l’operazione era già in corso 219 . L’attacco, eseguito richiamando la risoluzione 836 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che in più di due anni non era mai stata realmente applicata, avvenne prima dell’alba del 30 agosto, quando circa 60 bomb ardieri NATO si levarono dalla portaerei Roosevelt, ormai da tempo inviata nell’Adriatico. Gli obiettivi serbi individuati, in gran parte sistemi di difesa aerea collocati nei dintorni di Sarajevo e Pale, furono colpiti con grande precisione dai sofisticati mezzi utilizzati. Dopo poche ore entrò in azione anche la Forza di reazione rapida, che lanciò granate contro postazioni serbe e altri obiettivi strategici. I serbi cercarono di difendersi come potevano, ma i loro sistemi militari ben poco potevano contro quei bombardieri che volavano a 10000 piedi da terra. L’unica perdita che riuscirono ad infliggere agli alleati fu l’abbattimento di un aereo francese, i cui due piloti riuscirono a catapultarsi fuori, ma furono catturati dai serbi: questo fattore condizionò molto, da quel momento, la politica francese 220 . I raid furono salutati con generale favore dall’opinione pubblica internazionale, mentre dal Palazzo di Vetro arrivavano indignate le proteste di Boutros-Ghali, che tentò di fermare i bombardamenti, ma che si rese conto di non avere ormai più voce in capitolo 221 . Clinton commentò la situazione dicendo: “[…] Gli Stati Uniti hanno preso l’iniziativa per rispettare gli impegni con la NATO […] La campagna di bombardamenti della NATO […] è la giusta risposta alle violenze di Sarajevo […] La NATO sta inviando questo messaggio forte e chiaro”222 . Prevalse dunque la linea sostenuta dalla Albright e da Holbrooke secondo cui gli Stati Uniti avrebbero dovuto prendere decisamente l’iniziativa assumendo il ruolo di potenza mondiale. Clinton, questa volta lo fece, scavalcando le procedure richieste dalle organizzazioni internazionali e abbandonando quel multilateralismo che lo aveva accompagnato nei primi anni della sua presidenza. Non solo: l’utilizzo della NATO come elemento centrale della campagna militare dava un forte segnale della leadership degli Stati Uniti in Europa e della volontà dell’amministrazione americana di dare una scossa ad un’organizzazione che rischiava di perdere la sua peculiarità dopo il crollo del blocco sovietico 223 . I serbi non furono sorpresi dall’attacco, ma reagirono comunque con dichiarazioni minacciose che accusavano l’Occidente di accanirsi contro di loro, mentre i musulmani ovviamente 219 Daalder, Gettino to Dayton, cit., p. 130; Holbrooke, To End a War, cit., p. 99; Ripley, Operation Deliberate Force, cit., p. 243. 220 Nicholls, Bosnia, UN and NATO, cit., p. 35; Ripley, Operation Deliberate Force, cit., pp. 255-256. 221 Annan, Report, cit., § 445. 222 William J. Clinton, Remarks on Arrival in Honolulu, Hawaii, 31 agosto 1995, in Public Papers of the Presidents of the United States: William J. Clinton: 1995, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1995, vol. 2, p. 1274. 223 Holbrooke, To End a War, cit., pp. 92, 102-103. accolsero i bombardamenti come una liberazione. In particolare Izetbegovic dichiarò: “Il mondo ha fatto finalmente quello che avrebbe dovuto fare tanto tempo fa”224 . Non era certo necessaria la dichiarazione del presidente bosniaco per accorgersi che l’azione militare, se questo fosse stato l’unico modo per risolvere la questione, era arrivata con quattro anni e centinaia di migliaia di morti, feriti, e rifugiati di ritardo. Lo sviluppo della questione bosniaca metteva in risalto l’incapacità di una diplomazia occidentale di calarsi in realtà del genere, difficili da comprendere. La situazione, inoltre, palesò l’inadeguatezza delle strutture internazionali, su tutte le Nazioni Unite, ma anche la NATO, che non riuscirono a dare il giusto apporto e la giusta credibilità per qualsiasi iniziativa diplomatica o militare. L’Europa, poi, perse l’occasione per assumere il ruolo che ci si aspettava potesse accollarsi per identificarsi come punto di riferimento forte e unitario per la politica internazionale. Invece, il perseverare della propensione fra i governi del vecchio continente a mantenere proprie posizioni autonome fece perdere l’occasione per intraprendere una reale politica estera comune. Dall’altro lato gli Stati Uniti poterono così affermare il loro ruolo di leader mondiali, nonostante le mille titubanze mostrate dalla politica di Clinton225 . A Washington si prese in considerazione l’ipotesi di bombardare anche la Serbia, ma alla fine prevalse la linea moderata 226 . Il I settembre si decise di sospendere i bombardamenti per 48 ore, pensando che la lezione potesse bastare. In quelle ore sembrò davvero che l’assedio di Sarajevo fosse finito, ma un incontro fra generali alleati e serbi fugò subito l’ottimismo. Il generale delle Nazioni Unite Bernard Janvier formulò ai serbi un secco ultimatum, a rispecchiare il cambiamento di rotta effettuato da Boutros-Ghali per non rimanere isolato: entro tre giorni le truppe di Mladic, come era già stato previsto diversi mesi prima dalle Nazioni Unite, avrebbero dovuto sgomberare dalla zona attorno a Sarajevo tutte le armi pesanti, consentire l’apertura dell’aeroporto della città e permettere alle truppe delle Nazioni Unite e alle organizzazioni umanitarie di muoversi liberamente227 . Tra i serbi prevalse la linea dura tenuta da Mladic su quella di Karadzic: resistere ad oltranza, consci del fatto che gli alleati erano in grado di sferrare attacchi aerei molto duri, ma non sufficienti a scovare truppe rintanate nei cunicoli e negli hangar sotterranei scavati nelle montagne bosniache 228 . Erano in molti, dopo la tregua, a pensare che i bombardamenti fossero stati sufficienti come monito. Oltre alle Nazioni Unite, che comunque spingevano per una soluzione di mediazione, a 224 Ivi, pp. 102-103. Ibidem; Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, pp. 504-505. 226 Owen, Balkan Odissey, cit., p. 351. 227 Leurdijk, The United Nations, cit., p. 80; Annan, Report, cit., § 452. 228 Cohen, With no Peace to Keep, cit., p. 17; Bildt, Peace Journey, cit., p. 96; Cigar, How Wars End, cit., p. 225 18. condividere questo auspicio furono anche gli europei, con i francesi in testa, condizionati dalla cattura dei loro due piloti229 . I serbi bosniaci non rispettarono l’ultimatum di Janvier e Mladic tornò a minacciare conseguenze terribili per le truppe delle Nazioni Unite in caso di ripresa dei bombardamenti. Così gli Stati Uniti ripresero ad operare pressioni sulla NATO per riprendere gli attacchi. Il generale Claes non ebbe difficoltà a riattivare l’operazione militare senza chiedere il consenso del Consiglio 230 . Sebbene i bombardieri avessero ricominciato a sganciare una quantità impressionante di bombe, il nucleo militare di Mladic era ancora vivo ed iniziò ad emergere la convinzione che per scardinarlo sarebbero servite le truppe di terra 231 . Un’ulteriore iniziativa diplomatica di Holbrooke, che parve aver trovato una soluzione che potesse andar bene a tutti e il cui accoglimento da parte di Milosevic aveva suscitato buone impressioni negli statunitensi, fu vanificata ancora una volta da Mladic, che fece lanciare un missile sulla città di Kutina. Il comportamento del comandante delle truppe serbe irritò notevolmente gli americani, i quali decisero di iniziare ad usare le armi più sofisticate di cui disponevano, impiegate ad allora solo nella guerra del Golfo. Tale decisione infastidì, tra l’altro, diversi governi europei, fra i quali quello russo. La guerra in quei giorni raggiunse il culmine, con gli attacchi che prendevano di mira obiettivi militari di ogni tipo in qualche modo riferiti ai serbi bosniaci e con il conseguente rischio di un inasprirsi del conflitto 232 . Dopo una decina di giorni di bombardamenti si decise di dare il permesso alle truppe croate e musulmane di sferrare l’offensiva via terra, mentre Holbrooke continuava nella sua tattica diplomatica, supportata dalle azioni militari233 . A quel punto, però, ci si rese conto che gli obiettivi individuati dalla NATO erano oramai esauriti, mentre l’esercito di Mladic era riuscito a mantenere viva l’ossatura della propria capacità militare. Il passo successivo sarebbe stato quello di passare a bombardare obiettivi strategici come centrali elettriche, aeroporti, dighe, opzione esclusa dall’Occidente perché avrebbe costituito, per le vittime civili e i rifugiati che avrebbe provocato, un impatto troppo forte sull’opinione pubblica. Questo fece sì che Holbrooke si mostrasse molto più disponibile al dialogo 234 . Da parte loro i serbi bosniaci non si resero conto della difficoltà in cui si trovava l’Occidente e non seppero cogliere fino in fondo i frutti di questa situazione. Forse se avessero resistito qualche 229 Ripley, Operation Deliberate Force, cit., p. 254. Ibidem; Daalder, Gettino to Dayton, cit., p. 132. 231 Pirjevec, Le guerre jugoslave, cit., p. 508. 232 Holbrooke, To End a War, cit., p. 143; Bildt, Peace Juorney, cit., p. 101; Ripley, Operation Deliberate Force, cit., pp. 272-273; Annan, Report, cit., § 457; Cigar, How Wars End, cit., p. 20 233 Ripley, Operation Deliberate Force, cit., p. 304; Cohen, With no Peace to Keep, cit., p. 160. 234 Holbrooke, To End a War, cit., p. 152; Bildt, Peace Journey, cit., p. 103; Daalder, Getting to Dayton, cit., p. 133. 230 altro giorno sarebbero riusciti a mostrarsi al mondo intero indenni dopo l’intervento della potenza della NATO. Invece, probabilmente sentendosi isolati dal fatto che né Belgrado né Mosca si muovessero in loro soccorso, Karadzic e Mladic incontrarono Holbrooke e si dichiararono disposti a togliere l’assedio a Sarajevo 235 . L’operazione Deliberate Force, che aveva costituito il primo massiccio intervento militare della storia della NATO, con 3400 raid aerei, tre quarti dei quali compiuti dagli americani, fu dichiarata a quel punto ufficialmente conclusa. Dopo che il Consiglio di Sicurezza ebbe ulteriormente ridotto le sanzioni contro Belgrado e dopo che i serbi bosniaci ebbero consentito la riapertura dell’aeroporto di Sarajevo e delle strade che consentivano l’accesso alla città, iniziò il lungo tourbillon di trattative per la risoluzione della vicenda bosniaca 236 . Così, dopo che in Bosnia avevano avuto luogo gli ultimi combattimenti mirati a guadagnare posizioni preziose in vista delle trattative sulla spartizione dei territori, Bill Clinton poté annunciare che “le parti in Bosnia hanno raggiunto un accordo su un cessate il fuoco per terminare tutte le attività militari ostili nei territori della Bosnia-Herzegovina, da mettere in pratica dal 10 ottobre”237 . Mentre si aspettava che la tregua entrasse in atto, i serbi bosniaci continuarono nelle ultime operazioni di pulizia etnica, operate dalle “Tigri” di Arkan nelle zone di Banja Luka, Prijedor e Zenica, dove prima della guerra i musulmani e i croati che vi vivevano erano più di mezzo milione e adesso, dopo la guerra, erano rimasti appena 20000 238 . La questione che, prima ancora del raggiungimento di un accordo di pace, suscitò polemiche fra i governi dei paesi impegnati nella risoluzione della crisi, fu quella dell’invio delle truppe di terra. Izetbegovic pretendeva che gli americani inviassero le proprie truppe come garanzia per i musulmani239 e il presidente Clinton parlò chiaramente: “L’unica organizzazione che può assumersi la responsabilità in maniera forte ed efficace è la NATO. E come leader della NATO gli Stati Uniti devono fare la loro parte ed inviare truppe per unirsi a quelle dei nostri alleati sotto il comando della NATO”240 . La mossa di Clinton preoccupava l’opposizione repubblicana e il suo candidato alle elezioni presidenziali, Bob Dole, sulla possibilità che il presidente in carica riacquisisse il consenso pubblico sulla politica estera, che fino a quel momento era stato flebile. Così, Dole si dichiarò contrario 235 236 Pirjevec, Le guerre jugoslave, pp. 512, 513. Annan, Report, cit., § 458; Ripley, Operation Deliberate Force, cit., p. 298; Daalder, Getting to Dayton, cit., p. 135. 237 William J. Clinton, Remarks Announcing the Bosnia-Herzegovina Cease-Fire Agreement and an Exchange With Reporters, 5 ottobre 1995, in Public Papers of the Presidents of the United States: William J. Clinton: 1995, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1995, vol. 2, p. 1536. 238 Cohen, With no Peace to Keep, cit., pp. 95-96; Udovicki, Ridgeway, Burn this House, cit., p. 198. 239 Bildt, Peace Journey, cit., p. 107. 240 William J. Clinton, Remarks at a Freedom House Breakfast, 6 ottobre 1995, in Public Papers of the Presidents of the United States: William J. Clinton: 1995, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1995, vol. 2, p. 1545. all’ipotesi di invio di truppe americane, precisando che in ogni caso sarebbe servita un’approvazione del Congresso e reiterò piuttosto la richiesta di cessazione dell’embargo sulle armi ai musulmani, istanza che ormai sembrava aver perduto la propria attualità241 . Le parole di Clinton, però, non misero in allarme soltanto certi ambienti politici di Washington, ma anche gli alleati europei degli Stati Uniti, primi fra tutti francesi. Nonostante Clinton avesse precisato i termini della collaborazione con le truppe degli stessi paesi europei, infatti, il timore nel vecchio continente era quello di una sproporzione. Clinton si muoveva pensando di inviare 25000 soldati in Bosnia a supporto di altrettanti europei. I francesi, invece, avrebbero gradito che della questione si fossero occupati soltanto gli europei, escludendo gli americani e ponendo le truppe sotto l’egida delle Nazioni Unite e non della NATO, cosa totalmente sgradita agli Stati Uniti242 . Nella gestione della crisi Washington dovette tener conto anche dei russi, che spingevano anch’essi perché una missione di pace in Bosnia venisse svolta dalle Nazioni Unite. Così, in un incontro tenutosi a New York, Clinton e El’cin mitigarono i loro dissidi, tanto che il 18 ottobre il nuovo incaricato russo nei Balcani si recò in visita a Belgrado con Carl Bildt, copresidente della Conferenza di pace sull’ex Jugoslavia, e Richard Holbrooke, per informare Milosevic che i negoziati di pace si sarebbero tenuti nella base aerea americana di Wright-Patterson, a Dayton, nello stato dell’Ohio 243 . 2.6 Gli accordi di Dayton “Vi do il benvenuto negli Stati Uniti per l’inizio di questi storici colloqui di pace […] Siamo qui per dare alla Bosnia-Erzegovina la possibilità di essere un paese in pace […] I colloqui che iniziano qui oggi offrono la migliore possibilità di raggiungere la pace da quando la guerra è iniziata quattro anni fa”244 . Così il Segretario di Stato americano Warren Christopher, il I novembre 1995, aprì i colloqui di pace a Dayton, nella base militare americana scelta appositamente per la sua collocazione tranquilla e isolata dai mass media, davanti alle delegazioni delle tre parti in causa, capeggiate da Milosevic, Tudjman e Izetbegovic. Le rappresentanze si presentarono ben preparate 241 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., p. 515. Ivi, pp. 515-516. 243 Ivi, p. 519. 244 Secretary of State Warren Christopher, Statement by Secretary of State Warren ChristopherOpening the Balkan Proximity Peace Talks, U.S. Department of State, Dayton (Ohio), 1 novembre 1995, <http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/briefing/dossec/1995/9511/951101dossec.html#top>, consultato il 24 aprile 2003. 242 all’appuntamento di Dayton, sostenute dai consiglieri più abili, attente a non cadere nei trucchi della rete diplomatica statunitense 245 . Alla vigilia dell’apertura del vertice, Clinton stesso ammise: “Costruire la pace in Bosnia è importante per l’America”246 . Il presidente sapeva che gran parte della sua credibilità in politica estera si giocava sulla risoluzione della vicenda bosniaca, considerando che mancava meno di un anno alle elezioni presidenziali. Così, egli stesso insieme a Holbrooke, prima ancora dell’inizio dei colloqui di Dayton, lanciò forti moniti alle tre parti in causa. Furono tutti esortati ad essere elastici al massimo perché fosse trovata una soluzione ragionevole e per questo si avvertirono i musulmani che raid aerei NATO in loro soccorso non ci sarebbero più stati, mentre sia con i croati che con i serbi si cercò di fare leva sulle sanzioni economiche, che, per i primi sarebbero state introdotte e per i secondi non sarebbero state abolite nel caso essi si fossero mostrati rigidi nelle loro posizioni247 . Questo modo di agire degli americani scaturì dal fatto che essi si rendevano ben conto della difficoltà reale di trovare un accordo per soddisfare le fazioni. D’altra parte ci si preoccupò da subito di far raggiungere alle delegazioni un accordo, qualunque esso fosse, indipendentemente dal fatto se poi sarebbe stato efficace, giusto o applicabile. Un elemento che dimostra quanto le diplomazie si fossero attivate per spingere le delegazioni a trovare una soluzione è senza dubbio il compromesso raggiunto fra gli Stati Uniti e la Russia: 1500 soldati di Mosca avrebbero partecipato alla forza di pace sotto l’egida della NATO, ma con una certa indipendenza di azione in caso di dissidi con l’Alleanza Atlantica, ottenendo che il vice comandante delle forze fosse proprio un russo. Questo accordo, che vedeva la sostanziale accettazione anche da parte del Cremlino alla linea di Washington, isolava ognuna delle tre fazioni in causa e non dava loro appigli diplomatici nel caso avessero fatto fallire le trattative 248 . Christopher, nel suo discorso di apertura dei lavori, elencò “alcune condizioni chiave da ottenere” nell’elaborazione del documento di pace sulla Bosnia-Erzegovina. Si trattava, in sostanza, dei quattro punti cardine che costituivano la base che la diplomazia occidentale aveva predisposto per i colloqui di pace e sui quali bisognava trovare un accordo. Essi prevedevano la costituzione della Bosnia- Erzegovina come uno stato sovrano e indipendente, pur con due entità diverse, quella serba e quella croato-bosniaca, l’attribuzione alla città di Sarajevo, quale simbolo internazionale della convivenza multietnica, di uno statuto speciale e la definizione di uno speciale accordo per 245 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., pp. 519-520. William J. Clinton, Remarks on the Balkans Peace Process and an Exchange with Reporters, 31 ottobre 1995, in Public Papers of the Presidents of the United States: William J. Clinton: 1995, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1995, vol. 2, p. 1701. 247 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., p. 520. 248 Cohen, With no Peace to Keep, cit., pp. 20, 27; Holbrooke, To End a War, cit., p. 258; Bildt, Peace Journey, cit., p. 116; Schulte, Former Yugoslavia, cit., p. 32. 246 garantire il rispetto dei diritti umani che prevedesse un sistema di giudizio riconosciuto dalle tre fazioni per tutti coloro che si fossero macchiati delle atrocità avvenute nell’area 249 . In questo elenco formulato da Christopher si omise volutamente di citare questioni ancor più laceranti, sui quali già erano fallite le altre iniziative diplomatiche e cioè quello del confine fra le due entità della Bosnia e quello sull’elezione degli organi comuni dello stato, nonché quello probabilmente più controverso, che era costituito dall’eventualità di federare la Repubblica serba di Bosnia con la Jugoslavia, come voluto con forza dai serbi250 . Le polemiche e le difficoltà, nonostante la volontà degli Stati Uniti di far passare all’opinione pubblica come secondari i temi realmente più caldi, non tardarono ad arrivare: i dissensi interni alle delegazioni non mancavano, mentre le trattative sui temi focali della spartizione dei territori all’una o all’altra entità e dello status di Sarajevo portarono ben pochi risultati. Ad un certo momento sembrò che la delegazione serba volesse addirittura abbandonare il tavolo delle trattative. Non contribuì certo a smorzare i contrasti la notizia arrivata dall’Aja, dove il procuratore generale del Tribunale per i crimini nell’ex Jugoslavia emise un mandato di cattura nei confronti di ufficiali serbi implicati nelle atrocità commesse a Vukovar e accusò di genocidio contro i musulmani, fra gli altri, anche Radovan Karadzic e Ratko Mladic 251 . Così, mentre un forte malcontento aleggiava fra le parti, divise, fra l’altro, da forti polemiche interne, gli americani lavoravano per riportare a Dayton la serenità necessaria per raggiungere un accordo. L’atteggiamento più intransigente lo ebbe proprio Izetbegovic, che si sentiva comunque in debito con la comunità internazionale e che probabilmente, nonostante la recente presa di distanze del presidente Clinton da ogni fazione, contava ancora sull’appoggio degli Stati Uniti. Milosevic, dal canto suo, si mostrò il più flessibile, mentre Tudjman il più subdolo dei tre 252 . Il 19 novembre gli americani lanciarono una sorta di ultimatum nei confronti degli interlocutori, secondo il quale entro le 16 di quello stesso giorno avrebbero dovuto concludere, nel bene o nel male, le trattative. I colloqui fra le parti, poi, si protrassero fino al 21 in modo frenetico e a tratti anche scorretto, ma sembrava comunque che tutto fosse destinato a fallire. Christopher, così, tentò l’ultima mediazione, ma i passi più importanti per l’accordo vennero compiuti proprio da Milosevic, che, facendo le ultime concessioni territoriali portò anche la delegazione bosniaca all’accettazione dell’accordo. “Non è una pace giusta, ma il mio popolo ha bisogno di pace” fu il 249 Secretary of State Warren Christopher, Statement by Secretary of State Warren Christopher, cit. Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., p. 521. 251 Daalder, Gettino to Dayton, cit., p. 129; International Criminal Tribunal for the Former Jugoslavia, Indictment Against Radovan Karadzic, Ratko Mladic, 14 novembre 1995, The Hague, The Nederlands, <http://www.un.org/icty/indictment/english/kar-ii951116e.htm>, consultato il 24 aprile 2003. 252 Holbrooke, To End a War, cit., pp. 291, 299, 309; Bildt, Peace Journey, cit., pp. 147, 152, 158. 250 commento di Izetbegovic, sapendo che questa volta, nel caso in cui egli non avesse accettato, gli americani l’avrebbero abbandonato definitivamente 253 . Così, il 21 novembre, un’ora dopo la conclusione dell’accordo, il presidente Clinton, con toni raggianti, poté annunciare: “I presidenti di Bosnia, Croazia e Serbia ha nno raggiunto un accordo di pace per finire la guerra in Bosnia, per finire il peggior conflitto in Europa dalla seconda guerra mondiale”254 . Clinton, ringraziando tutta la diplomazia americana, con Christopher e Holbrooke in testa, ottenne così, nonostante tutte le indecisioni che l’avevano accompagnato nella gestione della vicenda, una vittoria non indifferente, che gli permise di mostrarsi ai cittadini americani e di tutto il mondo come il pacificatore dei Balcani. Quelli che divennero noti come gli “Accordi di pace di Dayton”, stabilirono che la Bosnia sarebbe rimasta uno Stato internazionalmente riconosciuto suddivisa in una Federazione musulmano-croata, che avrebbe coperto il 51% del territorio, e una Repubblica serba, che avrebbe costituito il 49% di esso. La divisione territoriale fra le due entità si sarebbe dovuta compiere entro 90 giorni dalla firma dell’accordo. La capitale unitaria sarebbe stata Sarajevo, inserita però nella Federazione musulmano-croata. Si previde poi la costituzione dei seguenti organi: la Presidenza composta da tre membri ognuno rappresentante un’etnia, il Consiglio dei Ministri, il Parlamento bicamerale, la Banca nazionale e il Tribunale costituzionale. Gli organi eleggibili sarebbero stati scelti attraverso elezioni libere a suffragio universale entro sei mesi dalla firma e sotto la supervisione dell’OCSE, dando la possibilità ai profughi di votare nei luoghi in cui risiedevano prima della guerra. Al governo si attribuirono le competenze della gestione della politica estera e del commercio estero, delle dogane, della politica monetaria, dell’immigrazione, delle comunicazioni e il controllo del traffico aereo. Per quanto riguarda i profughi, il trattato prevedeva un “allegato”nel quale si stabiliva il rientro alle proprie case e la libertà di movimento delle persone in tutto il paese, mentre i criminali di guerra sarebbero stati perseguiti ed esclusi da qualsiasi incarico politico. Tutte le forze militari straniere, eccetto le truppe delle Nazioni Unite, avrebbero dovuto lasciare il paese entro trenta giorni, durante i quali le parti in lotta avrebbero dovuto ritirare le proprie truppe ciascuna nel rispettivo settore, delimitato da una linea di confine lunga 1000 km che separava le due zone con una fascia larga un miglio 255 . La clausola specifica sul ritiro delle forze militari straniere sembra fosse stata voluta direttamente dagli Stati Uniti ed era mirata soprattutto ad allontanare i mujaheddin dell’Iran e i 253 Bildt, Peace Journey, cit., pp. 147, 152, 158; Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit. p. 525. William J. Clinton, Remarks Announcing the Bosnia-Herzegovina Peace Agreement and an Exchange with Reporters, 21 novembre 1995, in Public Papers of the Presidents of the United States: William J. Clinton: 1995, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1995, vol. 2, p. 1776. 255 U.S. Department of State, The Dayton Peace Accords, <http://www.state.gov/www/regions/eur/bosnia/bosagree.html >, consultato il 25 aprile 2003. 254 fondamentalisti di altri paesi islamici, nonché a ridurre i fattori che avrebbero potuto costituire un pericolo per la stabilità dell’area e per truppe internazionali che vi sarebbero state inviate. Come contropartita Washington si impegnò a destinare ingenti risorse per la ricostruzione e soprattutto a fornire armi e addestramento all’esercito musulmano. Questa clausola, che rappresentò elemento fondamentale per l’accettazione degli accordi di pace da parte di Izetbegovic, fu stipulata sotto forma di accordo segreto fra il governo americano e quello bosniaco per non irritare le altre parti in causa, così come gli alleati europei, nonché il Pentagono. Proprio quest’ultimo era infatti fortemente contrario a questo patto, che avrebbe portato l’esercito musulmano, due anni dopo, ad affermarsi come parte più forte del paese 256 . Alla fine, per garantire l’attuazione dell’accordo di pace, le truppe internazionali che si decise di spiegare furono composte da 60000 soldati, dei quali 25000 americani. La nuova missione, denominata IFOR (Multinational Military Implementation Force) sostituiva di fatto l’UNPROFOR, soppiantando completamente il ruolo delle Nazioni Unite nell’area, dato che nasceva sotto l’egida della NATO. Così, l’Alleanza Atlantica iniziava ad assumere una veste completamente nuova rispetto alla struttura di alleanza difensiva che aveva mantenuto dalla sua costituzione, proponendosi come nuovo soggetto impegnato nel mantenimento della pace al di fuori dei confini degli stati membri, ma più come strumento della politica globale di Washington in Europa. Fu questo il cambio di rotta dell’amministrazione Clinton dopo l’esperienza fallimentare della Somalia 257 . Comunque, già il giorno successivo alla firma dell’accordo, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite approvò la risoluzione 1021 per revocare l’embargo sulle armi alle tre repubbliche firmatarie, imposto quattro anni prima con la risoluzione n. 713, nonché la 1022 ad abolire le sanzioni economiche contro la Jugoslavia. Le uniche a non essere revocate furono le misure contro i serbi bosniaci, che sarebbero rimaste in vigore fino a che le loro truppe in Bosnia non si fossero ritirate dietro la linea di separazione 258 . La cerimonia per la firma dell’accordo si svolse sottotono, in un’atmosfera tesissima, nonostante si fosse arrivati ad una conclusione effettiva. I serbo-bosniaci, convinti direttamente da Milosevic ad accettare l’accordo, non vi parteciparono per protesta contro il fatto di aver visto le carte della spartizione territoriale soltanto dopo aver già firmato e accorgendosi che a loro insaputa 256 Holbrooke, To End a War, cit., pp. 277, 320; Bildt, Peace Journey, cit., pp. 117, 147; Fiona Watson, Tom Dodd, The Dayton Agreement: Progress in Implementation, House of Commons Library, Research Paper, 96/80, 9 luglio 1996, p. 21; Sharp, Dayton Report Card, cit., p. 116. 257 Rose, Fighting for Peace, cit., p. 8. 258 Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 1021/95, 22 novembre 1995, <http://ods-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/368/59/PDF/N9536859.pdf?OpenElement>, consultato il 26 aprile 2003; Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 1022/95, 22 novembre 1995, <http://ods-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/368/65/PDF/N9536865.pdf?OpenElement>, consultato il 26 aprile 2003. qualcosa era cambiato. Nessuno era realmente soddisfatto della sostanza del documento. I media belgradesi, per quanto volessero presentarla come una vittoria di Milosevic, che sanciva l’allargamento della Serbia, ignoravano forse l’esplicito richiamo presente nel documento al principio di intangibilità delle frontiere. L’unico che probabilmente poteva sentirsi il vincitore delle trattative, nonostante fosse criticato dalle frange estremiste di essersi piegato alla volontà americana, come accadeva del resto ai leader di tutte e tre le repubbliche, fu Tudjman. Egli era riuscito a riconquistare tutto il territorio croato e buona parte di influenza sulla Bosnia. Izetbegovic, dal canto suo, poteva sentirsi tranquillizzato soltanto dagli aiuti americani che gli sarebbero arrivati259 . La Bosnia, in realtà, rimaneva uno stato diviso. L’enorme corazzata diplomatica messa in campo per la risoluzione della vicenda dimostra quanto fosse forte il desiderio di restituire credibilità alla comunità internazionale e di arrivare a tutti i costi ad un accordo. Molti nodi furono volutamente elusi per non rischiare di urtare la suscettibilità delle parti e questa strategia rese il documento prodotto a Dayton molto ambiguo. Il moralismo che pervadeva il testo mascherò le lacune sulle questioni calde, prima fra tut te quella sulla incriminazione dei criminali di guerra, i cui atti avevano costituito la pagina più nera del conflitto e riportato alla realtà cinquant’anni dopo in Europa, i sistemi di sterminio utilizzati dal nazismo. Ci si limitò debolmente a promettere la condanna per tali criminali, senza fare nel testo dell’accordo alcuna menzione al Tribunale internazionale per i crimini nell’ex Jugoslavia 260 . Primo fra tutti a voler chiudere comunque la vicenda era proprio Clinton, impegnato in quella che divenne una vera e propria battaglia di politica interna. Gran parte dei repubblicani erano contrari all’invio dei soldati in Bosnia e il presidente dovette far ricorso a tutta la sua forza per riuscire a far approvare al Congresso, il 14 dicembre, l’invio delle truppe. Clinton corse un rischio grossissimo con questa decisione, giocandosi, a pochi giorni dall’ingresso nell’anno elettorale, quasi tutta la propria credibilità: con l’opinione pubblica largamente contraria i soldati americani venivano inviati, dopo la vicenda somala, in un’altra pericolosa area con la possibilità che fossero nuovamente attaccati, questa volta dai serbi o dai mujaheddin261 . Il 27 novembre, proprio Clinton si rivolse alla nazione con un messaggio televisivo, nel quale sosteneva: 259 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., pp. 527-528 ; Cohen, With no Peace to Keep, cit., pp. 93-96; Bildt, Peace Journey, cit., p. 165. 260 U.S. Department of State, The Dayton Peace Accords, cit. 261 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., pp. 529, 534. ”[…] Con la fine della guerra fredda molte persone questionano ora sulla necessità della nostra continuata e attiva leadership nel mondo. […] Essi sostengono che per sentirci sicuri noi dobbiamo solo tenere al sicuro i nostri confini e che ora è venuto il tempo di lasciare ad altri il duro lavoro di leadership al di là dei nostri confini. Io disapprovo fortemente. Nel momento in cui la guerra fredda cede il posto al villaggio globale, la nostra leadership è necessaria più che mai poiché i problemi che sorgono al di là dei nostri confini possono velocemente diventare problemi nel loro ambito”262 . Dopo lo smacco subito in Somalia e il conseguente abbandono della tendenza a coinvolgere appieno le Nazioni Unite nella risoluzione delle controversie internazionali, Clinton si mosse dunque per imporre ancora una volta la supremazia degli Stati Uniti nella politica mondiale. Nonostante tutte le titubanze che avevano causato il prolungamento del conflitto, infatti, soltanto quando Clinton si decise, anche se più per motivi interni che umanitari, a chiudere la questione, si giunse realmente all’epilogo della vicenda. La diplomazia europea, dopo aver fallito ogni tentativo diplomatico in quattro anni, fu messa in disparte anche a Dayton, dove poté, in pratica, soltanto assistere alle trattative 263 . Questa situazione accrebbe il malumore fra i paesi europei. Le divisioni fra Stati Uniti e Europa sul modo di gestire tutta la crisi avevano alimentato e continuavano ad alimentare il caos nell’area, dove gli interlocutori si erano mostrati particolarmente sensibili ai sostegni dei diversi paesi occidentali. La Francia, in particolare, appoggiandosi alla Russia e alle buone relazioni che comunque manteneva con i serbi, riuscì ad intavolare con essi una trattativa che portò alla liberazione dei due piloti catturati tre mesi e mezzo prima, in cambio di agevolazioni economiche e finanziarie. Ma Parigi ottenne soprattutto la garanzia che Mladic non sarebbe stato perseguito dal Tribunale dell’Aia 264 . Tutto questo mostrò l’inconsistenza della diplomazia nell’affrontare tutta la vicenda bosniaca. I vari protagonisti occidentali non seppero trovare innanzitutto quell’unità che avrebbe consentito di affrontare la questione in maniera più decisa. Certo, su questo influì anche la mancanza di volontà, soprattutto da parte degli Stati Uniti, di impiegare i propri soldati in operazioni internazionali giudicate rischiose, e tale decisione risultava essere in contrasto con il 262 William J. Clinton, Address to the Nation on Implementation of the Peace Agreement in BosniaHerzegovina, 27 novembre 1995, in Public Papers of the Presidents of the United States: William J. Clinton: 1995, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1995, vol. 2, p. 1784. 263 Bildt, Peace Journey, cit., pp. 130-131; Susan L. Woodward, The United States Leads, Europe Pays, “Transition”, 12 luglio 1996, p. 13. 264 Bildt, Peace Journey, cit., p. 168; Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., pp. 529, 532, 534. ruolo dominante che essi vogliono assumere. In questo modo, dunque, enormi furono le calamità provocate da un conflitto durato tre anni e trascinatosi a causa di una comunità internazionale non in grado di prevedere mezzi di coercizione credibili per la violazione di provvedimenti da essa assunti. L’adozione da parte della diplomazia internazionale di una diversa strategia, invece, avrebbe potuto evitare il conflitto e in ogni caso avrebbe potuto condurre ad una più rapida e logica soluzione della crisi. La credibilità delle istituzioni internazionali stesse, poi, si era ridotta in misura considerevole dopo le vicende bosniache. La comunità internazionale entrava in un vortice in cui la certezza sulle procedure per un’azione militare internazionale stava venendo meno. La responsabilità di questo ricadeva sicuramente nell’adeguatezza degli orga nismi preposti, soprattutto dopo la fine della guerra fredda, ma anche e soprattutto sulle potenze mondiali, prima fra tutte gli Stati Uniti, che erano le uniche in grado di promuovere eventuali riforme di tali organizzazioni. Evidentemente però, esse erano poco interessate a farlo per non perdere il dominio nella politica internazionale. Incidenti si verificarono anche nei giorni dell’accordo: oltre ai serbi bosniaci che perseveravano nelle violenze sui civili e che sferrarono un attacco con granate all’ho tel Holiday Inn di Sarajevo, si verificarono degli scontri fra le truppe croate e i mujaheddin. Il giorno stesso della firma dell’accordo di Dayton, che avveniva a Parigi il 14 dicembre, forze musulmane aprirono il fuoco contro un elicottero francese delle Nazioni Unite 265 . L’accordo di Dayton si mostrò da subito, dunque, un documento fragile, che non sedava l’odio fra le etnie e non risolveva la gran parte dei problemi dell’area. Le ambizioni di serbi e croati su un paese che dava loro speranze di grandezza e auspici di unione per i loro popoli rimanevano tali. D’altro canto le conseguenze di un conflitto così aspro non potevano essere superate tanto facilmente: alla fine del conflitto si calcolò che le vittime erano state 200-250 mila circa, 50 mila i torturati, 20 mila i casi di stupro, 143 le fosse comuni scavate e 715 campi di concentramento creati. Inoltre, circa la metà della popolazione bosniaca, 2200000 persone, fu costretta ad abbandonare le proprie abitazioni. Le basi per la persecuzione dei crimini commessi, inoltre, non erano così solide da garantire che i protagonisti delle barbarie commesse sarebbero stati puntiti. Purtroppo, infatti, il Tribunale per i crimini dell’ex Jugoslavia, oltre ad essere stato ignorato a Dayton, ha manifestato tutte le sue lacune come sistema di persecuzione dei criminali di guerra, già soltanto per il problema della cattura di questi, nella stragrande maggioranza dei casi a tutt’oggi mai avvenuta 266 . 265 Ivi, p. 535. Theodor Meron, Answering for War Crimes: Lessons from the Balkans, “Foreign Affairs”, vol. 76, n.1, gennaio-febbraio 1997, pp. 2-8. 266 Purtroppo anche gli anni successivi all’accordo hanno rivelato una situazione rimasta instabile e a tutt’oggi il ritorno nelle proprie case degli sfollati si è realizzato soltanto in alcune zone, mentre in altre resta al momento di difficile attuazione. Inoltre, le istituzioni comuni, che presentano sistemi di rotazione o di convivenza delle etnie, ancora non funzionano come dovrebbero. A dimostrazione ulteriore delle difficoltà presenti nel paese c’è da dire, a fronte di scaramucce tuttora in corso, che in Bosnia stazionano ancora truppe internazionali, sostituita la missione denominata IFOR con un’altra che ha preso il nome di SFOR (Stabilization Force) e che ha l’obiettivo di dissuadere le nazionalità da nuovi conflitti267 . L’amministrazione Clinton, così, dopo aver dimostrato tutta la propria indecisione nell’affrontare questioni del genere, riuscì comunque, con gli sforzi profusi per raggiungere l’accordo di Dayton, ad ottenere quella che per l’opinione pubblica risultò una vittoria diplomatica. Il cambiamento di rotta di Clinton in politica estera gli consentì di salvare la faccia e, sebbene egli avesse mostrato di non avere una linea ben chiara e fosse stato influenzato dalle pressioni esercitate dai repubblicani dopo le elezioni di mid-term, gli permise di affrontare la campagna elettorale da questo punto di vista con maggior credibilità e in ogni caso scaricato della vicenda bosniaca. La promessa che le truppe americane sarebbero rimaste in Bosnia al massimo un anno fu un chiaro espediente per far accettare al Congresso, ma soprattutto all’opinione pubblica, la partecipazione americana alle missioni internazionali con i propri soldati, considerato che non sarebbe risultato opportuno far capire agli elettori che le truppe sarebbero rimaste nell’area più del previsto, come in realtà avvenne 268 . Gli Stati Uniti, però, dopo la definizione della questione bosniaca, non avevano concluso il loro lavoro nei Balcani. Ai colloqui di Dayton, infatti, Milosevic acquisì il merito per l’impegno profuso per il raggiungimento degli accordi di pace. Questo riconoscimento permise al presidente serbo di considerare la questione del Kosovo come un affare interno del proprio paese. In realtà, il vozd aveva capito da tempo di non avere più possibilità di mettere le mani sulla Bosnia e già pensava ad un’azione in quest’altra area, dove inevitabilmente esplose una crisi nei mesi successivi 269 . 267 Osservatorio Balcani, Guida – Bosnia Erzegovina, <http://www.osservatoriobalcani.org>, consultato il 29 aprile 2003; Task Force Eagle – SFOR XIII, History of SFOR, <http://www.tfeagle.army.mil/TFE/SFOR_History.htm>, consultato il 29 aprile 2003. 268 Gideon Rose, The Exit Strategy Delusion, “Foreign Affairs”, vol. 77, n. 1, gennaiofebbraio 1998, pp. 65-66; Hyland, Clinton’s World, cit., p. 141; Emily O. Goldman, Larry Berman, Engaging the World. First Impressions of the Clinton Foreign Policy Legacy, in Colin Campbell, Bert A. Rockman (a cura di), The Clinton Legacy, New York, Chatham House Publishers of Seven Bridges Press, 2000, pp. 231, 234-235; Task Force Eagle – SFOR XIII, History of SFOR, cit. 269 Richard Caplan, International Diplomacy and the Crisis in Kosovo, “International Affairs”, vol. 74, n. 4, agosto 1998, p. 750. CAPITOLO TERZO LA CRISI DEL KOSOVO 3.1 Cenni storici Tutti i testi di storia contemporanea sul Kosovo o sulla Jugoslavia fanno riferimento, spesso con un prologo, alla battaglia della Piana dei Merli. La ragione va rintracciata nell’alto valore simbolico, più che strategico, di ciò che avvenne nel 1389 nella regione chiamata Kosovo, abbreviazione di kosovo polje, che significa, per l’appunto, piana, campo dei merli. Si tratta di una battaglia che vide lo scontro fra i serbi e i turchi, entrata nella mitologia serba per il valoroso coraggio di alcuni combattenti serbi e per il tradimento commesso da altri serbi. Così, essa costituì un evento che assunse valore di insegnamento per la cultura serba di guardarsi dai traditori, ma anche di martirio, nello scontro fra cristianità e islam. Nel Kosovo, nel corso degli anni successivi, gli albanesi che abitavano l’area si convertirono in massa all’islam, e albanese, per i serbi, divenne sinonimo di musulmano. Così, nonostante la conversione di quel popolo all’isla m fosse avvenuta alcuni decenni dopo lo scontro del 1389, e siano certe le prove che a tradire i serbi, in quella occasione non furono gli albanesi, nella cultura serba si radicò l’accostamento fra traditore e albanese, che distorceva la memoria storica basilare per ogni paese 270 . Da qui ho anch’io iniziato per questo breve excursus storico sul Kosovo, regione che, come tutti i paesi della ex Jugoslavia, subì il dominio dell’impero ottomano, costituendo la valenza strategica fondamentale per le comunicazioni militari e commerciali 271 . La protesta albanese contro la cessione alla Grecia e al Montenegro di terre abitate da loro connazionali, che sfociò nella Lega di Prizren, nel 1878 segnò la rinascita degli albanesi e il superamento delle divisioni fra clan che dividevano la regione (composta per il 71% da musulmani, per il 19% da ortodossi e per il 10% da cattolici), nonché l’inizio di un lento processo di modernizzazione di tale società, che resta però tuttora di stampo fortemente patriarcale. La costituzione del governo provvisorio della lega nel 1881 fu soffocata nel sangue dai turchi. Soltanto nel 1912 l’alleanza fra gli stati balcanici permise la liberazione del Kosovo, che tornò a far parte dei territori di appartenenza del governo di Belgrado 272 . Durante que l periodo la Serbia tornò ad esercitare un vero e proprio regime di terrore nei confronti della popolazione kosovara, violando i più elementari diritti e incrinando, quindi, anche i 270 Marco Dogo, Kosovo, Albanesi e Serbi: le radici del conflitto, Cosenza, Marco Editore, 1992, pp. 9-13; Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., pp. 3-5. 271 Dogo, Kosovo, cit., p. 17. 272 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., pp. 13-14. rapporti con l’Albania. Nel corso dell’occupazione nazi- fascista lo stato divenne un protettorato tedesco, ma la regione del Kosovo finì in mano italiana, così come l’Albania. Gli albanesi si ritrovarono dunque, per la prima volta nella loro storia uniti in un unico stato. In Kosovo essi videro con molto favore le truppe d’occupazione, che invece vennero osteggiate dai connazionali di Albania, i quali, appoggiati da Tito, organizzarono un movimento di resistenza. Così, alla fine della guerra, gli albanesi vedevano tramontare di nuovo il progetto della Grande Albania, tornando ad essere divisi fra il regime comunista albanese di Enver Hoxha, fra l’altro molto legato a Tito, e il governo della nuova Jugoslavia. Il Kosovo, come abbiamo visto nel capitolo precedente, divenne allora, all’interno della Repubblica serba, provincia autono ma. Questo rappresentò il conto che i serbi dovettero pagare per la creazione di uno stato jugoslavo forte, che Tito vedeva solo attraverso l’indebolimento della Serbia 273 . Gli albanesi ebbero modo, attraverso questa autonomia, di radicare il loro nazionalismo, nonostante il forte controllo sulla popolazione esercitato dal regime comunista. Tali sentimenti nazionalistici trovarono sfogo in forti dimostrazioni, che nel 1968, mentre Tito si trovava impegnato nella crisi con l’Unione Sovietica causata dall’occupazione in Cecoslovacchia, portarono a manifestazioni di piazza per chiedere la fine delle discriminazioni subite dal regime e la proclamazione del Kosovo a repubblica indipendente. Le istanze erano temibili, perché rischiavano di irritare ancora di più i serbi, nonché di minare i già problematici rapporti con l’Albania di Enver Hoxha, schieratosi con Stalin e contro Tito. Dopo numerose discussioni fra i vertici jugoslavi si decise di concedere al Kosovo, se non l’indipendenza una più ampia autonomia. Questa decisione comportò che l’albanese diventasse lingua ufficiale della federazione jugoslava assieme al serbo, e permise agli albanesi l’accesso a tutti gli uffici pubblici274 . Anche la riforma costituzionale del 1974 riuscì a placare soltanto momentaneamente le istanze albanesi, dopo aver suscitato comunque le ire dei serbi. Dimostrazione di questo fu l’altra rivolta, avvenuta nel Kosovo nel 1981, dopo la morte di Tito. Nella regione, che chiedeva di staccarsi completamente dalla Serbia, si riuscirono a sedare i disordini solo attraverso il massiccio intervento dell’esercito. Quella, in effetti, sarebbe stata la scintilla che avrebbe provocato rimostranze indipendentiste anche in altre repubbliche della Jugoslavia, essendo fallito il tentativo di far credere alle popolazioni che le repressioni nei confronti delle manifestazioni albanesi erano rese necessarie dalla difesa di un territorio simbolicamente importante per i popoli slavi275 . Nel frattempo gli albanesi avevano avuto una vera e propria esplosione demografica, e divennero l’etnia largamente maggioritaria nel Kosovo: essi costituivano quasi il 90% della 273 Ivi, pp. 16-19. Ivi, pp. 24-25. 275 Ivi, pp. 26-27. 274 popolazione e il 95% di loro era musulmano 276 . Il peggio per loro arrivò quando al potere salì Milosevic, che nel 1989 impose il proprio controllo sulla regione. Così nei confronti degli albanesi si iniziarono a violare i più semplici diritti, e su di loro venne esercitato un severissimo regime controllo: alla polizia serba furono affidati poteri che prevedevano perquisizioni, arresti, torture indiscriminate, no nché processi di massa con maltrattamenti nel corso degli interrogatori277 . Gli albanesi si ritrovarono, in pratica, a dover vivere nella clandestinità, senza che le democrazie occidentali operassero il minimo sforzo per fermare tutto ciò. La popolazione cercò di insorgere di nuovo: il 2 luglio 1990 gli albanesi del parlamento del Kosovo, al quale era stato impedito di riunirsi, proclamarono l’indipendenza della regione, pur nell’ambito della Federazione jugoslava. Belgrado rispose all’azione proclamando “misure d’emergenza” ed avviando purghe che alla fine portarono la rimozione di decine di migliaia di albanesi da posti di responsabilità, oltre che allo scioglimento di ogni tipo di associazione. Questa reazione convinse i leader kosovari ad intensificare la loro protesta organizzando, come era avvenuto in Slovenia e in Croazia, un referendum per l’indipendenza, che si tenne nell’estate del 1991 e che vide un voto quasi unanime per il distacco dalla Jugoslavia 278 . L’ingenuità commessa dagli albanesi in quell’occasione fu di credere che i loro ideali di giustizia avrebbero prevalso e non accettarono così le proposte di alleanza che venivano da Zagabria per costituire un fronte militare a sud della Serbia. Essi, invece, si appellarono vanamente alla commissione Badinter, istituita dalla Comunità Europea con il compito di decidere sul riconoscimento delle Repubbliche jugoslave, ignorando il fatto di non averne titolo perché il Kosovo era solo una provincia autonoma. Il suo riconoscimento internazionale, tra l’altro, avrebbe creato considerevoli problemi per la stabilità dell’area 279 . Nonostante la repressione serba proseguisse, i kosovari perseverarono nel loro sforzo per ottenere l’indipendenza: nel maggio 1992 organizzarono elezioni clandestine che videro la netta vittoria della Lega democratica del Kosovo, fondata tre anni prima da Ibrahim Rugova. Egli, quale professore di letteratura albanese e scrittore, era noto per gli ideali politici che lo vedevano teorizzare l’indipendenza del Kosovo con metodi politici e non violenti e per questo era chiamato il “Gandhi dei Balcani”. L’enorme sproporzione di forze militari a vantaggio dei serbi, non avrebbe consentito, secondo la teoria di Rugova, l’indipendenza kosovara, e avrebbe invece provocato inutili spargimenti di sangue. Per questo, egli fu tollerato da Milosevic, che lo vide come un uomo innocuo: Rugova, promovendo il boicottaggio delle istituzioni ufficiali, permetteva alle forze serbe 276 F. W. Carter, H. T. Norris (a cura di), The Changing Shape of the Balkans, London, UCL Press, 1996, p. 9. Fabian F. Schmidt, Teaching the Wrong Lesson in Kosovo, “Transition”, 12 luglio 1996, pp. 8-12. 278 Ivi, pp. 4-5; Tim Judah, Kosovo: War and Revenge, New Haven-London, Yale University Press, 2000, p. 277 113. 279 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., pp. 556-557. di non avere grossi problemi nella repressione degli albanesi del Kosovo, e consentì quindi all’esercito di concentrarsi unicamente sul fronte croato 280 . Nella clandestinità forzata i kosovari si organizzarono creando un vero e proprio statoombra, dotato delle strutture di ogni tipo. Tale entità, se da un lato dimostrò metodo in una battaglia che dette al mondo intero testimonianza di una società in grado di autogestirsi, dall’altro operava in condizioni precarie e provocava forti disagi alla popolazione (soprattutto per le deficienze in campo medico che in quegli anni videro l’aumento delle malattie infettive e del tasso di mortalità infantile). Questo stato di cose provocava il risentimento da parte degli oppositori di Rugova, che contestavano questa strategia poiché, a loro giudizio, il boicottaggio di massa era un atteggiamento autolesionista che portava vantaggi soltanto al regime di Milosevic 281 . Per capire comunque quale fosse l’umore della popolazione serba nei confronti degli albanesi basta citare un’inchiesta del 1997, che rivelava che il 41,8% credeva che l’unico sistema per risolvere la questione kosovara fosse quello dell’espulsione degli albanesi dalla regione. Per di più, l’opposizione di Belgrado non appariva sulla questione più morbida del governo stesso 282 . L’isolamento al quale portava questo metodo di conduzione della battaglia kosovara venne evidenziato, nei primi anni Novanta, dal comportamento della comunità internazionale, che non sentì il bisogno di intervenire a tutela degli albanesi. L’unico aiuto sarebbe potuto arrivare dai fratelli dell’Albania, paese che però versava in condizioni di estrema povertà e troppo preso dalle vicende interne per avanzare azioni di rilievo, che fossero anche soltanto il riconoscimento unilaterale di indipendenza per il Kosovo 283 . Per uscire da questo isolamento Rugova, eletto nell’ottobre del 1991 presidente di una repubblica clandestina, decise di creare un governo in esilio al capo del quale nominò un medico, Bujar Bukoshi. Il governo si installò a Stoccarda e il suo obiettivo fu quello di propagandare la causa kosovara, con l’intento di sensib ilizzare l’opinione pubblica europea, ma anche con lo scopo di raccogliere contributi finanziari fra gli albanesi di tutta Europa per sostenere economicamente lo stato ombra in Kosovo. L’operazione ebbe un’ottima riuscita per il grande senso di appartenenza delle comunità albanesi all’estero e consentì il funzionamento dell’apparato statale clandestino kossovaro, anche se comportò pure la prosecuzione della segregazione degli albanesi e non apportò nessun sostanziale miglioramento delle condizioni del Kosovo nei confronti della Serbia 284 . 280 Judah, Kosovo, cit., p. 11, 61; Caplan, International Diplomacy, cit., p. 751. Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., pp. 557-558. 282 Stefan Troebst, Conflict in Kosovo: Failure of Prevention? An Analytical Documentation, 1992-1998, Flensburg, European Centre for Minority Issues, 1998, p. 11. 283 Ivi, pp. 22-25; Judah, Kosovo, cit., p. 85. 284 Caplan, International Diplomacy, cit., p. 750; Gazmend Pula, Modalities of Self-Determination – The Case of Kosova as a Structural Issue for Lasting Stability in the Balkans, “Sudosteuropa”, vol. 45, 1996, n. 4-5, p. 380. 281 Il morale dei kosovari, poi, subì un ulteriore duro colpo dopo la conclusione degli accordi di Dayton, nell’ambito dei quali la questione della regione non era stata affrontata per non indisporre Milosevic e concedergli una contropartita per il fatto di aver ceduto su alcuni punti decisivi per la conclusione dell’accordo di pace, ergendosi al ruolo di pacificatore dei Balcani285 . Una situazione del genere non poteva che portare da parte albanese ad una ribellione più violenta di quella condotta da Rugova. Nel 1997 le numerose violazioni dei diritti commesse dalla polizia serba provocarono la morte di 35 persone. Il funerale di una di queste, un insegnante albanese, si trasformò in manifestazione di massa e fu oggetto della prima apparizione pubblica dell’Uck (Ushtria Clirimtare es Kosoves), il movimento di liberazione nazionale albanese costituitosi nel frattempo. Nell’occasione, tre guerriglieri mascherati, che sfoggiavano divise mimetiche con stampato lo stemma dell’Albania, fecero una sorta di rito nel quale uno di loro, sullo stile dei terroristi irlandesi dell’IRA, giurò che il sangue del defunto non era stato versato invano e che la lotta di liberazione del Kosovo sarebbe stata portata avanti286 . L’Uck aveva come slogan quello di “Kosovo indipendente”, ma anche “Grande Albania”, il che stava a significare la volontà di unione di tutti gli albanesi in un unico stato comprensivo dei territori di Serbia, Macedonia e Montenegro. In relazione alla situazione che stava attraversando l’Albania in quegli anni, negli ambienti dell’Uck si vedeva la regione del Kosovo come guida per la creazione del grande stato unitario albanese e se ne accostava la funzione a quella che era stata verso la metà dell’Ottocento quella del Piemonte per l’Italia. Quest’idea portò ad una collaborazione transfrontaliera che produsse traffico di persone, denaro e armi287 . Il movimento era formato da poliziotti e militari albanesi, che la Repubblica del Kosovo di Rugova aveva cercato di arruolare senza successo, nonché da giovani studenti o ex studenti già da anni in lotta contro le autorità serbe. Ne facevano parte anche molti banditi e malavitosi in genere. La sopravvivenza dell’Uck era garantita grazie ai finanziamenti che anch’esso riceveva dalla diaspora albanese residente in Europa, soprattutto in Germania e Svizzera, costituita dai vecchi oppositori del regime di Tito, che avevano invece goduto del sostegno di Hoxha 288 . L’Uck si richiamava anche alla strategia attuata dal Movimento di liberazione della Palestina che teorizzava la risposta alla violenza dello stato con altrettanta violenza. L’organizzazione, secondo la stampa belgradese, aveva provocato nel 1996 alcuni incidenti grazie all’appoggio dei servizi segreti albanesi, italiani, tedeschi e americani, anc he se in realtà non esistono elementi credibili che dimostrino ciò. Il primo di questi incidenti fu quello dell’11 febbraio, 285 Pirjevec, Le guerre jugoslave, cit., p. 559. Judah, Kosovo, cit. p. 136. 287 Judith Lange, The War Next Door: A Study of Second Track Intervention During the War in ex-Jugoslavia, Lansdown, Hawthorn Press, 1998, pp. 35-36. 288 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., p. 560. 286 quando attentati furono commessi con delle bombe in cinque campi di esuli serbi dalla Krajina. Da qui iniziò un’escalation di incidenti che vedeva protagoniste le opposte fazioni: il 21 aprile un nazionalista serbo colpì a morte uno studente albanese e per risposta, il giorno dopo, 10000 donne parteciparono per protesta ad una manifestazione pubblica, la più grande avvenuta da molti anni in Kosovo e che preannunciava episodi più gravi: questi puntualmente avvennero e videro l’uccisione, in tre città del Kosovo, di tre poliziotti e due civili serbi289 . Queste azioni proseguirono anche nel corso dell’anno successivo e il pericolo di una rivolta albanese diveniva palpabile. Rugova, dal canto suo, continuò nella sua linea di lotta nonviolenta, operando per far passare sotto silenzio questi episodi e tentando di far credere che fossero orchestrati dai servizi segreti serbi290 . Ciò non faceva che dividere nella battaglia i kosovari. Come se non bastasse, nella situazione di tensione, influì anche il tragico momento che stava vivendo l’Albania, dove il cambiamento di regime in corso portò ad una situazione caotica che incoraggiò il traffico d’armi e la creazione di campi d’addestramento per l’Uck. Tali condizioni favorirono l’espansione degli atti di terrorismo in Kosovo, compiuti non solo contro i serbi, ma anche contro gli albanesi accusati di collaborare con loro 291 . Dal canto suo Milosevic si dife ndeva sostenendo di garantire agli albanesi del Kosovo tutti i diritti civili e di essere costretto a reprimere gli atti di terrorismo che gli albanesi compivano per ambizioni separatiste. Ciononostante, la situazione creatasi in quel periodo portò il Kosovo a ricevere quell’attenzione internazionale che Rugova, con i suoi metodi pacifici, non era riuscito a raggiungere. Gli Stati Uniti, già dal giugno del 1996, si convinsero ad aprire a Pristina un proprio ufficio d’informazioni, che aveva lo scopo di seguire da vicino le vicende della regione. In seguito, venne riattivato anche il Gruppo di contatto, del quale adesso faceva parte anche l’Italia, che aveva messo a disposizione un gran numero di soldati per la missione NATO in Bosnia e che avrebbe guidato la missione delle Nazioni Unite per la normalizzazione della situazione in Albania 292 . Questo era il segno che la comunità internazionale iniziava a comprendere quali fossero le reali intenzioni di Milosevic e che la situazione in qualche modo dovesse essere affrontata, in quella che gli Stati Uniti giudicavano da tempo un’area chiave per la stabilità politica di tutto il Mediterraneo 293 . 289 Indipendent International Commission on Kosovo, The Kosovo Report: Conflict, International Response, Lesson Learned, Oxford, Oxford University Press, 2000, p. 51; Schmidt, Teaching the Wrong Lesson in Kosovo, cit., p. 13; Pula, Modalities of Self-Determination, cit. p. 392. 290 Lange, The War Next Door, cit., pp. 33-34. 291 Ibidem; Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., pp. 561-562. 292 Troebst, Conflict in Kosovo, cit., pp. 59-64; Giovanni Scotto, Emanuele Arielli, La guerra del Kosovo: anatomia di un’escalation, Roma, Editori Riuniti, 1999, p. 82. 293 Caplan, International Diplomacy, cit, p. 751. 3.2 Clinton e il secondo mandato Come abbiamo visto il presidente americano Bill Clinton gestì la vicenda bosniaca guardando alle elezioni presidenziali che si sarebbero tenute nel novembre del 1996. I fallimenti di politica estera nei primi anni del mandato, ma anche quelli riguardo la riforma sanitaria su cui egli tanto puntò in campagna elettorale, fecero sì che le elezioni di mid-term del 1994 si trasformassero in una sorta di referendum sul primo biennio dell’amministrazione Clinton. La percezione di Clinton come un politico più liberal di quanto egli si fosse presentato nella campagna elettorale del 1992 consegnarono ai repubblicani il risultato storico che garantiva loro la maggioranza in entrambi i rami del Congresso 294 . Clinton subì valanghe di critiche di ogni tipo. Da un lato vi furono quelli, come l’ex segretario di stato Henry Kissinger, che lo accusarono di aver perseguito una strategia di politica estera che, ispirandosi alla critica nei confronti della politica statunitense degli anni ‘60, lo aveva condotto a intraprendere azioni inadeguate al periodo post-guerra fredda 295 . Dall’altro lato, molti altri ritennero che il presidente fosse privo di una vera e propria strategia in politica estera e gli contestarono di non avere: “alcun centro strategico, alcuna convinzione, nessuna sicurezza e una tendenza a dare la colpa ad altri” 296 , criticandone le capacità, la distrazione e la debolezza. Di sicuro Clinton, in seguito alla sconfitta subita nelle elezioni dal partito democratico, cambiò modo di agire, un po’ perché costrettovi, pressato dal Congresso, un po’ per riconquistare quei consensi che gli avevano permesso di vincere nel 1992 e che a causa dei numerosi smacchi che aveva subito non aveva più. La gestione della vicenda in Bosnia, prima condotta in maniera molto blanda e in un secondo momento più decisa, dimostra tutta l’incoerenza della sua politica estera, che in quel caso risultò mutevole perché mirata alle elezioni presidenziali che si sarebbero tenute nel 1996 con l’obiettivo di presentarsi al voto a questione risolta per acquisire meriti che gli facilitassero l’elezione per un secondo mandato. La stessa iniziativa di inviare in quell’area 25000 soldati fu dettata dall’inevitabilità di quella scelta: l’impegno internazionale che gli Stati Uniti avevano assunto non poteva non essere combinato alla partecipazione alla forza di pace. Sebbene il presidente sapesse quali rischi corresse e quale fosse l’umore dell’opinione pubblica riguardo 294 Romero, Economia e politica, cit., pp. 211-212; Fasce, Da George Washington a Bill Clinton, cit., pp. 162- 295 Kissinger, At Sea in a New World, cit., p. 7. Gelb, Can Clinton Deal with the World?, cit., p. C1. 163. 296 l’invio di truppe americane al di fuori dei propri confini, un eventuale rinuncia ne avrebbe infatti costituito l’ennesimo fallimento diplomatico. Del resto, durante tutti gli anni della sua presidenza, la strategia perseguita da Clinton, a fronte di numerosi in interventi in diverse aree del mondo, trasse dall’esperienza del Vietnam la necessità di ottenere il massimo degli obiettivi politici e militari riducendo al minimo le perdite di soldati americani297 . Inoltre occorre non dimenticare che Clinton fu il primo presidente che si trovò ad affrontare lo scenario internazionale del dopo-guerra fredda e con questo tutte le incertezze che ne scaturivano: ogni strategia sarebbe stata dunque da sperimentare. Clinton riuscì ad affrontare la campagna elettorale del 1996 con alle spalle il successo degli accordi di Dayton. Tale risultato, insieme alla vittoria conseguita nel braccio di ferro con il Congresso a maggioranza repubblicana sulla questione della legge di bilancio, consentì al presidente di giungere al voto da una posizione di vantaggio 298 . Da un sondaggio pubblicato dal “Washington Post”, emerge chiaramente il recupero di gradimento di Clinton sui temi di politica estera: la fiducia dei cittadini americani nei confronti di come il presidente aveva gestito le vicende internazionali crebbe infatti dal 37% del 1994 al 54% dell’anno delle presidenziali 299 . La campagna elettorale questa volta si svolse molto di più sui temi di politica estera rispetto al 1992 e Bob Dole cercò di attaccare Clinton proprio mettendo in evidenza gli errori che il presidente aveva commesso in quel campo. Il presidente in carica si difese con molta abilità: mentre nel 1992 aveva elaborato insieme al suo vice, Al Gore, un opuscolo, Putting People First, incentrato sulla critica alla politica estera di Bush, nel 1996 egli lo preparò il nuovo, Between Hope and History, da solo. La propaganda metteva in risalto una sfilata di successi conseguiti dalla sua amministrazione, in contrapposizione all’ipotesi isolazionista che, secondo l’accusa democratica, rischiava di riprendere corpo in caso di vittoria di Dole 300 . Clinton vinse le elezioni presidenziali del 1996 ottenendo il 49,24% dei suffragi, contro il 40,71% di Dole 301 . La vittoria si verificò grazie all’assunzione, dopo il 1994, delle posizioni neoconservatrici, soprattutto in materia di riforma del welfare. Ma un aiuto a Clinton fu dato anche dalla nuova crisi che si prospettò nell’estate del 1996 in Irak, alla vigilia delle elezioni. Numerose volte, nel corso di quegli anni, Saddam Hussein era stato protagonista di provocazioni relative alla violazione delle risoluzioni impostegli dalle Nazioni Unite. Il presidente Clinton in quell’occasione, a differenza di quello che era accaduto in passato, con molta abilità colse l’opportunità per mostrarsi 297 Goldman, Berman, Engaging the World, cit., p. 231, 246. Hyland, Clinton’s World, cit., p. 145. 299 Richard Morin (a cura di), An ABC-Washington Post Poll, “Washington Post”, 19 gennaio 1997, p. A22. 300 Hyland, Clinton’s World, cit., p. 146. 301 Federal Election Commission – United States of America, 1996 Electoral and Popular Vote Summary, <http://www.fec.gov/pubrec/elecpop.htm>, consultato il 6 maggio 2003. 298 deciso ai cittadini americani: egli rispose alla crisi con un’azione che prevedeva un intervento militare con bombardamenti intimidatori contro il dittatore e l’immediato inasprimento dei provvedimenti nei suoi confronti302 . Il discorso sullo stato dell’Unione, pronunciato il 4 febbraio 1997, somiglia più a quello che fu di Bush rispetto a quello che lo stesso Clinton pronunciò quattro anni prima. Era il solito proclama carico di enfasi, che elencava tutti gli obblighi morali degli Stati Uniti, senza abbandonare il principio della promozione della democrazia, né la volontà di mantenere la leadership mondiale nella gestione delle situazioni internazionali 303 . In realtà, Clinton si preparava ad un mandato diverso dopo la lezione imparata nel corso dei quattro anni precedenti, ed aveva abbandonato da tempo l’idea di intervento umanitario e di promozione della democrazia, come dimostrava la decisione di non intervenire in un altro paese africano, il Rwanda, dove nel 1994 infuriò un’altra sanguinosa guerra. Clinton avrebbe continuato a muoversi tenendo conto all’opinione pubblica, attento a non scontentarla, nonostante il secondo mandato gli consentisse una maggiore libertà. I cittadini americani volevano vedere gli Stati Uniti guidare lo scenario internazionale e Clinton li accontentò, sia pur intervenendo in maniera sporadica e talvolta esitante 304 . Subito dopo le elezioni Clinton effettuò alcune modifiche alla propria squadra di politica estera e di difesa. Al Dipartimento di Stato Warren Christopher fu sostituito da Madeleine Albright, che divenne la prima donna a ricoprire tale incarico. William Perry fu sostituito al Pentagono da William Cohen, senatore repubblicano uscente. Clinton sostituì Anthony Lake, come consigliere per la sicurezza nazionale con il suo vice, Sandy Berger 305 . Si trattava di personalità di più alto livello rispetto a quelli che avevano accompagnato Clinton durante il suo primo mandato. Mentre nel 1992 la scelta dei membri era avvenuta sulla base di incarichi di governo precedentemente assunti, questa volta il presidente si prese premura, selezionando personalmente i personaggi, di sceglierli vicini alle proprie tendenze nelle politiche da intraprendere 306 . L’opinione pubblica americana accolse con generale favore le scelte del presidente, apprezzando il rilievo della nuova squadra di governo. I consensi maggiori arrivavano sulla nomina di Madeleine Albright, che negli anni precedenti aveva ricoperto l’incarico di ambasciatrice alle Nazioni Unite. In questo ruolo essa si era distinta per la sua energia, che impiegò, tra l’altro, nella 302 Hyland, Clinton’s World, cit., pp. 171-174. William J. Clinton, Address Before a Joint Session of the Congress on the State of the Union, 4 febbraio 1997, in Public Papers of the Presidents of the United States: William J. Clinton: 1997, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1997, vol. 1, pp. 109-117. 304 Hyland, Clinton’s World, cit., pp. 200, 202-203. 305 Ivi, pp. 150-151. 306 Ivi, p. 151. 303 battaglia contro il Segretario Generale Boutros-Ghali. Il rapporto fra i due diplomatici risultò da subito piuttosto teso, soprattutto per una diatriba sugli arretrati degli Stati Uniti nel pagamento dei contributi dovuti alle Nazioni Unite. Lo scontro proseguì, come abbiamo visto, nella politica sulla Bosnia e culminò, proprio due settimane dopo la rielezione di Clinton, con la decisione della Albright di opporsi in Consiglio di Sicurezza alla rielezione di Boutros-Ghali: gli Stati Uniti, furono l’unico paese a votare contro quella risoluzione. Il mese successivo, quando la Albright era già stata promossa a Segretario di Stato, Kofi Annan venne eletto nuovo Segretario Generale delle Nazioni Unite307 . Il generale favore che raccolse la nomina della Albright alla segreteria di stato è dimostrato dall’atteggiamento nei suoi confronti da parte del Senato americano, che il 23 gennaio 1997 ne ratificò la nomina all’unanimità. Il risultato assumeva valore ancor più di rilievo se si considera che il Senato era controllato dai repubblicani, che tra l’altro si erano mostrati molto ostili agli esponenti della prima amministrazione Clinton308 . La scelta della Albright inseriva nell’amministrazione una vera e propria “star”. Gli ambienti politici statunitensi vivevano un periodo di vuoto di personaggi di rilievo e il suo arrivo lo colmò. La Albright amava essere sotto i riflettori, essere acclamata, apparire in televisione: insomma il personaggio effervescente che era si trovò a perfetto agio nel ruolo che le era stato assegnato 309 . Sicuramente la decisione di Clinton significava l’intenzione di muoversi in maniera più determinata negli scenari di politica estera e la Albright rappresentava al meglio, essendo originaria di un paese che aveva vissuto a stretto contatto con la cortina di ferro, la volontà di stare sempre con gli occhi ben aperti sul mondo. Nella prima intervista, il 25 gennaio, alla trasmissione televisiva “Larry King Live”, essa espresse la volontà di far interessare il popolo americano alla politica estera 310 . Lo stesso Clinton, ancora nel discorso sullo stato dell’Unione, si prese premura di dichiarare che “il nemico dei nostri tempi è l’inazione” e in riferimento all’impegno in Bosnia che “quando l’Europa è stabile, prospera e in pace l’America è più sicura”. L’ampia menzione della NATO, preludeva ad un nuovo intervento dell’organizzazione nei Balcani 311 . 307 Ibidem; Lippman, Madeleine Albright, cit., pp. 23-27. Lippman, Madeleine Albright, cit., p. 28. 309 Ivi, pp. 2-3. 310 Secretary of State Madeleine K. Albright, Interview on CCN-TV “Larry King Live”, Washington, D.C., 24 gennaio 1997, <http://secretary.state.gov/www/statements/970124a.html>, consultato il 7 maggio 2003. 311 William J. Clinton, Address Before a Joint Session of the Congress on the State of the Union, cit., pp. 109, 115. 308 3.3 La crisi del Kosovo come affare internazionale In Kosovo i gruppi di guerriglieri dell’Uck, per la verità non così ingenti, riuscirono comunque ad intensificare le azioni, cosa che indusse molti serbi, tra la metà del ‘96 e l’inizio del ’98, ad abbandonare la regione, sebbene Belgrado cercasse in ogni modo di difendere i propri connazionali per farli rimanere in un area dalla così alta rilevanza simbolica. La zona dove l’Uck agiva maggiormente era quella della Drenica, nel nord del Kosovo, non lontana dalla città di Pristina e abbastanza vicina alla Serbia 312 . Milosevic era sempre più intenzionato a rispondere militarmente contro queste iniziative, incoraggiato in questo anche dal fatto che in Occidente l’Uck non riscuoteva molte simpatie, tanto che l’inviato speciale degli Stati Uniti nei Balcani, l’ambasciatore Robert Gelbard. lo definì “un gruppo terrorista”. Così Milosevic, che nel luglio del 1997 era stato eletto presidente della Federazione jugoslava, si sentì autorizzato a combattere e reprimere l’Uck come tale: in seguito ad incursioni dei guerriglieri nella città di Drenica, dove ormai i serbi erano quasi completamente espulsi, egli ordinò una violenta incursione, che avvenne fra la fine di febbraio e l’inizio di marzo del 1998 con l’utilizzo di artiglieria pesante, carri armati ed elicotteri, e provocò la morte di 29 persone, soprattutto fra anziani, donne e bambini 313 . Nei primi giorni di marzo le azioni delle unità serbe proseguirono in altre città, spesso per reprimere le manifestazioni di protesta contro il massacro dei giorni precedenti: a Donje Prekaze e Lausa una strage ancor peggiore fece 58 vittime, fra i quali uno dei capi storici dell’Uck, Adem Jashari, trucidato insieme a quasi tutta la sua famiglia. Questo atteggiamento da parte delle forze serbe, che provocò la fuga di 17000 profughi albanesi, produsse anche una reazione che portò giovani albanesi ad arruolarsi nell’Uck, che in poco tempo raggiunse la forza di 12000 guerriglieri314 . In seguito a questi avvenimenti i primi segnali da parte della comunità internazionale iniziavano ad arrivare: il commissario europeo per le relazioni internazionali fece sapere che non sarebbe stata più accettabile la tesi di Milosevic di considerare la questione del Kosovo come un fatto interno e che non si sarebbe consentito al dittatore una nuova guerra nei Balcani 315 . Tutto questo mentre il procuratore generale del Tribunale per i crimini commessi nell’ex Jugoslavia, la 312 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., p. 563. Caplan, International Diplomacy, cit., p. 753; Indipendent International Commission on Kosovo, The Kosovo Report, cit., p. 146; Tim Judah, Kosovo’s Road to War, “Survival, The IISS Quarterly”, vol. 41, n. 2, estate 1999, p. 23. 314 Schmidt, Teaching the Wrong Lesson in Kosovo, cit., p. 15; Troebst, Conflict in Kosovo, cit., pp. 3-4; Indipendent International Commission on Kosovo, The Kosovo Report, cit., p. 68. 315 Troebst, Conflict in Kosovo, cit., p. 56. 313 canadese Louise Arbour, si attivava per indagare sugli eventuali responsabili degli massacri avvenuti nei giorni precedenti in Kosovo, Milosevic compreso 316 . Il Gruppo di contatto si riunì nel marzo del 1998 ed elaborò un documento che condannava le violenze delle forze serbe, ma anche quelle dell’Uck, e invitava il governo jugoslavo ad allontanare le sue forze dalla provincia del Kosovo entro dieci giorni. Inoltre, si auspicava la presenza di organizzazioni internazionali in Kosovo per fornire aiuto alla popolazione albanese e per controllare la situazione, nonché l’applicazione di un nuovo embargo sulle armi e una moratoria sugli aiuti finanziari alla Jugoslavia. Si trattava, in sostanza, del compromesso fra la posizione di Russia, Francia e Italia più vicina alle ragioni serbe rispetto a quella di Gran Bretagna e Stati Uniti, propensi ad una soluzione più incisiva. Ricominciava così il braccio di ferro fra europei e americani (appoggiati dagli inglesi), già verificatosi nel corso della gestione della crisi bosniaca 317 . Era Madeleine Albright, in particolare, a restare insoddisfatta sulla soluzione individuata dal Gruppo di contatto, confermando il suo carattere battagliero e dimostrando subito in che modo volesse affrontare la questione. La Albright avrebbe voluto da tempo contrastare Milosevic in maniera più incisiva e questo le provocò numerose resistenze a Washington. In quel periodo, soprattutto il Segretario alla Difesa William Cohen nutriva forti dubbi su un nuovo intervento nell’area, che avrebbe potuto essere interpretato come un sostegno alle istanze separatiste albanesi. Le resistenze, poi, arrivavano forti dall’Europa per i solidi legami economici che paesi come la Russia, la Francia e la stessa Italia vantavano nei confronti della Jugoslavia 318 . Le truppe di Milosevic non si ritirarono secondo i termini stabiliti, anzi intrapresero nuove offensive. L’atteggiamento di Milosevic portò il Gruppo di contatto, su pressione di Russia, Francia e Italia, a decidere per una semplice posposizione dei tempi per l’eventuale applicazione delle sanzioni minacciate 319 . Anche il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si mosse in modo piuttosto docile, con l’approvazione della risoluzione 1160, che deplorava l’uso “eccessivo della forza” da parte delle truppe di Milosevic, ma che condannava anche “tutti gli atti di terrorismo” dell’Uck. Inoltre, si istituiva un regime di embargo sulle armi sulla Jugoslavia e sul Kosovo 320 . Nel frattempo, la Lega democratica di Ibrahim Rugova organizzò per il 22 marzo elezioni clandestine che furono tollerate dal regime di Belgrado. L’affluenza alle urne fu alta (85%), ma ormai il fronte kosovaro era diviso: l’Uck si stava espandendo molto, elemento che permise la “liberazione” di vasti territori del Kosovo centrale. Il movimento di liberazione kosovaro, che ormai 316 Caplan, International Diplomacy, cit., p. 755. Troebst, Conflict in Kosovo, cit. pp. 40-46. 318 James P. Rubin, Countdown to a Very Personal War, “The Financial Times, Weekend”, 30 settembre -1 ottobre 2000, p. IX; Clark, Waging Modern War, cit., pp. 109,113. 319 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit. p. 565. 320 Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 1160/98, 31 marzo 1998, <http://ods-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/090/23/PDF/N9809023.pdf?OpenElement>, consultato l’8 maggio 2003 317 si stimava potesse contare in tutto su 40-50000 uomini, impose il proprio controllo sul 30-40% del territorio della regione, dove continuava l’opera di allontanamento dei serbi e il divieto di attività per tutti i partiti politici. Il tentativo di Rugova e Bukoshi di organizzare un movimento militare rivale dimostrava con tutta evidenza la spaccatura esistente; le nuove Forze armate della Repubblica kosovara, furono così create con l’approvazione americana, i finanziamenti sauditi e l’appoggio logistico turco, ma confluirono quasi subito nell’Uck, vanificando il tentativo di Rugova 321 . Milosevic, abile nel rafforzarsi nei momenti topici, costituì un governo di unità nazionale e organizzò un referendum per chiedere ai cittadini se accettare le richieste internazionali sul Kosovo. Il risultato fu un secco no (94,43% sul 73% degli aventi diritto), sostenuto dalla propaganda del regime che riteneva di avere forze sufficienti per risolvere da solo la questione sbarazzandosi in poco tempo dei terroristi che turbavano la convivenza etnica nella regione 322 . Alla fine di giugno, così, 25000 poliziotti e 30000 soldati dotati di grandi mezzi militari, ripresero l’azione in Kosovo. Dopo alcuni successi dei guerriglieri a Pristina, le forze serbe diedero l'assalto alla cittadina di Decani, sede di un importante monastero medievale serbo. In cinque giorni la città fu bruciata quasi completamente e la popolazione albanese cacciata del tutto, con 42000 persone che si dettero alla fuga verso il Montenegro, che concesse loro asilo. A Podgorica, infatti, le elezioni presidenziali erano state vinte da Milo Djukanovic, che si era distinto proprio per le posizioni critiche assunte contro il suo avversario Momir Bulatovic, uno degli alleati più fedeli di Milosevic. Il governo montenegrino avviò un programma che lo portò ad intraprendere relazioni economiche con l’occidente ed a condannare l’azione della Serbia nel Kosovo 323 . Le azioni delle forze serbe ebbero grande eco in occidente, nonostante il regime belgradese si ostinasse, com’era già accaduto in Bosnia, a negare l’evidenza dei fatti sostenendo che le case erano state bruciate dagli albanesi stessi per mettere in cattiva luce i serbi. Richard Holbrooke, in seguito proprio a quegli ultimi eventi, si recò a Belgrado nel tentativo di far incontrare Rugova e Milosevic. Il diplomatico americano riuscì a far incontrare i due, ma il colloquio fu bruscamente interrotto dalla notizia di un’offensiva serba in corso su Decan, intrapresa da Milosevic per risposta alla decisione di Clinton di ricevere Rugova alla Casa Bianca324 . L’8 giugno i ministri degli esteri dell’Unione Europea, seguiti a ruota dal governo degli Stati Uniti, decisero di bloccare i conti serbi nelle proprie banche e di proibire gli investimenti dei loro 321 Michael McGwire, Why Did We Bomb Belgrade?, “International Affairs”, vol. 76, n. 1, gennaio 2000, pp. 322 Tim Youngs, Tom Dodd, Kosovo, Research Paper, 98/73, House of Commons Library, 27 ottobre 1998, p. 4-6. 18. 323 Indipendent International Commission on Kosovo, The Kosovo Report, cit., p. 54; Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, pp. 567-568. 324 Judah, Kosovo, cit., pp. 144, 155, Indipendent International Commission on Kosovo, The Kosovo Report, cit., p. 147. paesi in Serbia. Inoltre, considerato il Gruppo di contatto un organismo ormai bloccato ed incapace di prendere delle decisioni, soprattutto per l’ostruzionismo praticato Mosca, si pensò che risultasse necessaria da subito l’attivazione della NATO: l’11 giugno il Consiglio dell’Alleanza decise di prendere in esame tutte le opzioni militari per bloccare in tempo la crisi e nello spazio aereo dell’Albania e della Macedonia furono organizzate manovre militari denominate “Detrmined Falcon”. La missione, cui presero parte 83 aerei, fu un esplicito avvertimento a Milosevic, ma anche ai guerriglieri dell’Uck: un’ulteriore intensificazione degli scontri nell’area no n sarebbe stata tollerata e avrebbe causato una risposta militare della NATO 325 . In verità, le differenze fra la situazione della Bosnia e quella del Kosovo sono molte: innanzi tutto il Kosovo era provincia autonoma, alla quale era stata sì sottratta tutta l’autonomia, ma di fatto appartenente all’autorità della repubblica serba. La Bosnia, invece, pur non essendo riconosciuta da Milosevic era, a prescindere dalla questione del riconoscimento internazionale, a tutti gli effetti una repubblica della federazione. Per contro, c’è da dire che, mentre la Bosnia era abitata per un terzo da serbi, nel Kosovo essi costituivano una esigua minoranza, anche se in Bosnia tutti gli abitanti parlavano la stessa lingua, mentre in Kosovo questo non accadeva, poiché gli abitanti costituivano gruppi etnici distinti. La differenza più importante, però, probabilmente risiede nel fatto che nel caso della Bosnia l’intervento esterno della comunità internazionale era auspicato dalla legittima autorità di Sarajevo (il governo di Izetbegovic) contro l’aggressione serba al paese, mentre per quanto riguarda il Kosovo la legittima autorità era costituita da Milosevic, il quale evidentemente non avrebbe mai acconsentito che questo avvenisse. In questo caso, dunque, l’eventuale intervento dell’occidente avrebbe richiesto una guerra contro le truppe governative della Serbia. Risulta chiaro, dunque, che il motivo che portò la comunità internazionale ad agire in maniera meno tergiversante sia da ricercare nell’esperienza assunta nella gestione della vicenda bosniaca: si cercò così, attraverso una pronta pressione nei confronti di Milosevic, di evitare che nei Balcani scoppiasse una nuova guerra fra etnie. Tuttavia, questo non impedì agli alleati occidentali di commettere molti degli errori già commessi nella crisi bosniaca, che non facevano che fomentare la voglia di Milosevic di mettere le mani su una terra dalla così grande importanza nazionalistica 326 . Uno dei motivi che incoraggiavano Milosevic erano le divisioni nella comunità internazionale: in particolar modo la Russia era nettamente contraria ad un eventuale intervento aereo contro il Kosovo. Proprio il presidente russo El’cin, dietro richiesta del cancelliere tedesco 325 Marc Weller, The Crisis in Kosovo 1989-1999: From the Dissolution of Yugoslavia to Rambouillet and the Outbreak of Hostilities, vol. 1: International Documents and Analysis, Centre of International Studies University of Cambridge, Cambridge, Documents and Analysis Publishing Ltd, 1999, p. 217; Statement on Kosovo Issued at the Meeting of the North Atlantic Council in Defence Ministers Session, 11 giugno 1998, <http://www.nato.int/docu/pr/1998/p98-077e.htm>, consultato l’8 maggio 2003; Clark, Waging Modern War, cit., p. 120. 326 Hyland, Clinton’s World, cit., pp. 44-45. Helmut Kohl, invitò Milosevic al Cremino il 16 giugno. Milosevic sapeva di poter contare sull’alleato russo, ma El’cin gli avrebbe dato appoggio solo se avesse ascoltato i suoi consigli. Il vozd, così, si impegnò a ritirare le proprie forze speciali dal Kosovo e a riprendere i contatti con Rugova per trovare una soluzione pacifica alla questione, ricevendo la garanzia da Mosca che si sarebbe opposta con il veto alle Nazioni Unite contro un’eventuale proposta di intervento della NATO. Inoltre Milosevic promise che le delegazioni diplomatiche accreditate a Belgrado sarebbero potute tornare a visitare la provincia 327 . Holbrooke, così, colse subito l’occasione per inviare in Kosovo d’accordo con i russi, una vera e propria missione di osservatori diplomatici denominata KDOM (Kosovo Diplomatic Observer Mission), costituitasi il 6 luglio e composta da sole 50 persone. Nonostante le ridotte dimensioni, essa costituì nei mesi successivi un mezzo prezioso per documentare le ripetute violazioni dei diritti umani da parte delle forze di polizia, considerato che neanche ai giornalisti era consentito visitare l’area. Milosevic fu così costretto ad interrompere le attività delle sue forze, dando modo all’Uck di riacquistare terreno. Una volta verificatosi ciò, le forze serbe poterono dimostrare la necessità del loro ulteriore intervento per fronteggiare i “terroristi” 328 . 3.4 La NATO secondo Washington Gli eventi in Kosovo, nel frattempo, non lasciavano indifferenti gli ambienti politici di Washington, dove, soprattutto per timore che il conflitto potesse estendersi coinvolgendo altri paesi e risultando così pericoloso per la stabilità dell’area, si era acceso un intenso dibattito sulla possibilità di un intervento militare. Madeleine Albright, strenua sostenitrice dell’ipotesi interventista, si trovava in contrapposizione con i vertici del Pentagono ed ebbe la meglio. Ella convinse il presidente Clinton che per intraprendere una politica più decisa bisognasse innanzi tutto sganciarsi dal dannoso confronto serrato con il Congresso, che avevo condizionato l’azione del presidente in numerose precedenti situazioni. L’idea del Segretario di Stato di imboccare una strada decisa che portasse all’intervento, dunque, non proveniva tanto dagli intenti umanitari, quanto dalla volontà di dimostrare la leadership a livello globale degli Stati Uniti e convincere definitivamente la 327 Oleg Levitin, Inside Moscow’s Kosovo Muddle, “Survival, The IISS Quarterly”, vol. 42, n.1, primavera 2000; Indipendent International Commission on Kosovo, The Kosovo Report, cit., p. 144; Tim Youngs, Kosovo: The Diplomatic and Military Options, Research Paper, 98/93, House of Commons Library, 7 luglio 1998, p. 11. 328 Judah, Kosovo, cit., p. 177. maggioranza repubblicana dell’autorevolezza dell’amministrazione in carica. Per far questo Clinton, sempre secondo la Albright, avrebbe dovuto insistere fortemente sull’utilizzo della NATO, pensando al nuovo ruolo che essa avrebbe potuto avere dopo la caduta del muro di Berlino: una volta estintosi il nemico sovietico, essa avrebbe dovuto subire una forte ristrutturazione, diventando un mezzo della politica americana in Europa 329 . Ivo Daalder, già consigliere alla Casa Bianca per i Balcani, fotografava alla perfezione la situazione: “Durante la guerra fredda, la NATO era un’alleanza militare con basi politiche, che univa una comunità impegnata per lo più a sostenere i principi di democrazia e libertà individuale e che cercava, se necessario, di difendersi da un possibile attacco dell’Unione Sovietica e dei suoi alleati del Patto di Varsavia. Con la cessazione della minaccia militare e politica ai suoi partner, a tenere insieme l’Alleanza restano ora solo i principi politici che univano gli aderenti alla NATO. Ciò suggerisce l’opportunità di rovesciare le priorità: la NATO deve trasformarsi in un’alleanza politica su basi militari” 330 . Al timore del Vietnam, dunque, col cambio della guardia al Dipartimento di Stato, si aggiunge l’influenza nella politica americana della “sindrome di Monaco”, che come abbiamo visto faceva parte del bagaglio storico personale di Madeleine Albright. La “sindrome di Monaco” è uno degli schemi della cultura internazionale degli Stati Uniti e vede l’attendismo passivo a fronte di un aggressione, sfociare in un meccanismo a catena, che durante la guerra fredda era stato rappresentato con l’ “effetto domino”. Gli Stati Uniti, dunque, venivano chiamati da questa teoria a controllare ed egemonizzare potenziali aree che, se trascurate, avrebbero potuto portare ad una degenerazione del conflitto 331 . Restava poi all’ampia discrezionalità dei policy- maker di decidere quali fossero le aree che per questo motivo potevano essere di vitale importanza per gli interessi del paese. Possiamo rilevare che già a partire dalla guerra in Bosnia questo tipo di politica si era fatta strada, ma solo dopo il cambio di rotta di Clinton nell’ultimo periodo del suo primo mandato. I 329 Rubin, Countdown, cit. p. IX; Ted Galen Carpenter, Kosovo as an Omen: The Perils of the “New NATO”, in Ted Galen Carpenter (a cura di), NATO’s Empty Victory: a Postmortem on the Balkan War, Washington, DC, CATO Institute, 2000, p. 173; Indipendent International Commission on Kosovo, The Kosovo Report, cit., pp. 56, 157, 159160. 330 Ivo H. Daalder, NATO in the 21st Century: What Purpose. What Missions?, Washington, DC, Brookings Institutions Press, 2000, p. 25. 331 Mario Del Pero, Federico Romero, Le Ragioni di una guerra: gli Stati Uniti, “Europa-Europe”, 4/1999, <http://www.europaeurope.it/rivista/9904index.htm>, consultato il 9 maggio 2003. bombardamenti della NATO, che condussero ai colloqui di Dayton, portati avanti con successo dagli Stati Uniti, non fecero che rafforzare, dal punto di vista americano, questo tipo di politica. Da lì in avanti quel modo di agire sarebbe stato un punto di riferimento fondamentale per gli Stati Uniti per la politica da int raprendere nei Balcani. Le linee guida di questa strategia erano: l’obbligo di contrastare sul nascere l’uso della forza serba, l’eventuale utilizzo di mezzi militari come strumento per piegare Belgrado ad una soluzione diplomatica e la fiducia nella NATO al quale era contrapposta una sfiducia nelle Nazioni Unite nella gestione operativa delle crisi332 . Dallo slancio dato dalla gestione della crisi bosniaca, dunque, si guardava alla risoluzione della questione kosovara come un campo ideale per proseguire il progetto di coinvolgimento della NATO. Questo progetto irritava non poco gli alleati europei, che manifestarono a più riprese tutta la loro insofferenza rispetto allo scavalcamento delle Nazioni Unite, ma soprattutto rispetto alla scelta americana di intraprendere una politica “unipolare”333 . La volontà di intraprendere una strategia unilaterale si manifestò già nell’estate del 1998, quando Clinton decise di intervenire con attacchi missilistici contro i campi di addestramento e le installazioni dei terroristi islamici in Afghanistan e in Sudan, senza chiedere l’autorizzazione al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Pochi mesi dopo accadde la stessa cosa con i bombardamenti effettuati sull’Iran, ai quali però partecipò questa volta anche la Gran Bretagna 334 . Nella questione kosovara, invece, i primi segnali in questo senso furono manifestati dagli Stati Uniti inviando alla fine di giugno Richard Holbrooke ed altri membri dell’amministrazione americana a colloquio con esponenti dell’Uck. Mentre l’inviato speciale degli Stati Uniti nei Balcani, Robert Gelbard, aveva definito pochi mesi prima l’Uck un gruppo terrorista, adesso negli ambienti del Dipartimento di Stato si era propensi a riconoscere il movimento non più come tale. La motivazione di questa scelta era data dal fatto che la radicalizzazione del conflitto, che tra l’altro si attribuiva soltanto a Milosevic, aveva ormai portato all’Uck il sostegno di gran parte della popolazione albanese 335 . Gli europei, dal canto loro, non approvavano questa linea di legittimazione dell’Uck, ritenendo che si dovesse puntare tutto su Rugova. Alla volontà di Madeleine Albright di intervenire con la NATO essi rispondevano che ciò non avrebbe potuto essere fatto senza il coinvolgimento del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite: era un chiaro palliativo per non intervenire in Kosovo, dato che il veto della Cina e della Russia non avrebbero permesso l’approvazione di una tale operazione. Tra l’altro in quel periodo gli inglesi, per un attimo dimentichi della “special 332 Ibidem. Schulte, Former Yugoslavia, cit., p. 27. 334 Michael T. Klare, Washington veut pouvoir vaincre sous tous les fronts, “Le Monde Diplomatique”, maggio 1999, p. 8. 335 Caplan, International Dipomacy, cit., p. 758; Clark, Waging Modern War, cit., p. 122. 333 relationship”, presentarono proprio alle Nazioni Unite, senza avvertire gli Stati Uniti, una bozza di risoluzione che chiedeva al Consiglio di Sicurezza di autorizzare la NATO all’uso della forza per affrontare la crisi nel Kosovo 336 . Questa mossa irritò ovviamente Washington e, in alcuni colloqui telefonici, l’allora ministro degli esteri britannico Robin Cook spiegò alla collega americana che aveva agito così perché i suoi giuristi gli avevano consigliato che quella sarebbe stata l’unica via percorribile, cosa che servì unicamente ad innervosire Madeleine Albright e a ricevere da lei una delle sue colorite risposte: “cambia i giuristi!”337 . L’arrivo di Tony Blair a Downing Street ricompose l’incidente secondo le tesi americane. Il premier inglese, per recuperare i rapporti con Clinton, sosteneva che la catastrofe umanitaria che stava avvenendo in Kosovo era sufficiente ad autorizzare di per sé un intervento da parte della NATO anche senza l’autorizzazione delle Nazioni Unite 338 . Sappiamo bene che invece questa tesi non trova riscontro, oltre che nel trattato del Nord Atlantico, nella Carta delle Nazioni Unite, che all’articolo 53 cita esplicitamente: “nessuna azione coercitiva potrà venire intrapresa in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali senza l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza”, a meno che questa non sia una chiara azione di autodifesa. Nei mesi successivi il Segretario Generale della NATO, Javier Solana, fece elaborare da giuristi compiacenti, una tesi che prevedeva la possibilità, nel caso di un intervento umanitario, di intraprendere azioni anche senza l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla base del diritto internazionale generale, dato che la Carta non menzionava tale eventualità. Questa posizione suscitò notevoli polemiche in molti stati europei, ma non scalfì la volontà americana di procedere comunque 339 . 3.5 La strada verso l’intervento Intanto il conflitto in Kosovo era tutt’altro che cessato: nel luglio del 1998 l’Uck conquistò Orahovac, riuscendo per la prima volta ad assumere il controllo completo di una città. Da lì però, pochi giorni dopo partì la controffensiva serba, che portò alla riconquista di quella città. L’azione 336 Youngs, Dodd, Kosovo, cit., p. 35. Rubin, Countdown, cit., p. IX; Clark, Waging Modern War, cit., p. 125. 338 Tim Youngs, Mark Oakes, Paul Bowers, Kosovo: NATO and Military Action, Research Papers, House of Commons Library, 99/34, p. 9. 339 Ibidem; Rubin, Countdown, cit., p. IX; Judah, Kosovo, cit., p. 185; Youngs, Dodd, Kosovo, cit., p. 38; Palmisano, La guerra “umanitaria”, cit., p. 172-175. 337 delle truppe serbe in quel periodo fu mirata soprattutto all’eliminazione della rete dei guerriglieri dell’Uck, che nelle battaglie pagava soprattutto il fatto di non essere strategicamente ben organizzato. I serbi, soprattutto grazie al fatto di poter contare adesso non solo sulle unità di polizia, ma anche su quelle dell’Armata jugoslava inviate da Belgrado, riuscirono in questo obiettivo, eliminando intere unità di guerriglieri. Ciò segnava una svolta nella strategia militare di Milosevic, che fino ad allora si era limitato a far svolgere alle truppe dell’Armata il pattugliamento delle frontiere con la Macedonia e l’Albania. L’esercito regolare jugoslavo da quel momento prese direttamente il comando delle operazioni e costituì un elemento determinante per l’andamento della battaglia: le azioni sistematiche contro le città portarono i serbi a riconquistare il controllo su Malisevo, considerata la capitale segreta dell’Uck 340 . Queste notizie, che ebbero forte eco in tutto l’occidente, convinsero il Senato degli Stati Uniti ad approvare una risoluzione che invitava Clinton a promuovere davanti al Tribunale dell’Aia un’accusa contro Milosevic per crimini di guerra 341 . Il 9 agosto il Gruppo di contatto tornò a riunirsi, proponendo un piano di pace che prevedeva per il Kosovo il ripristino dell’autonomia di cui godeva la provincia prima del colpo di mano di Milosevic, restaurandola sul modello del sistema in vigore in Alto Adige. Questa proposta non fu ben accolta a Belgrado, dove anche l’opposizione, capitanata dal socialdemocratico Vojislav Kostunica, si mostrava compiacente alla condotta tenuta dal regime. All’unità del campo serbo facevano da contrapposto le divisioni in campo kosovaro. Ibrahim Rugova si mostrò disponibile a trattare sulla base della proposta elaborata dal Gruppo di contatto, mentre l’Uck non volle neanche prenderla in considerazione 342 . L’avanzata serba, che portò alla caduta dell’ultimo caposaldo dell’Uck, Junik, costrinse la popolazione albanese a fuggire in massa dalle proprie abitazioni. In settembre le forze serbe intensificarono ancora gli attacchi contro gli albanesi, costringendo altre migliaia di albanesi a rifugiarsi nei boschi. Secondo le stime dell’UNHCR i profughi ammontavano già in quel periodo a 300000 unità, dei quali un terzo fuggirono cercando rifugio verso l’Albania, la Macedonia, la Bosnia, la Serbia, la Turchia e altri paesi europei, mentre i restanti 200000 rimasero in Kosovo cercando in molti casi riparo nei boschi e vagando per giorni e giorni senza acqua né cibo. Solo in quell’ultimo periodo nella regione erano stati uccisi 1500 kosovari e 100 serbi e 45000 erano le 340 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., p. 572. U.S. Senate, Expressing the sense of the Congress regarding the culpability of Slobodan Milosevic for war crimes, crimes against humanity, and genocide in the Former Yugoslavia, and for other purposes, 18 luglio 1998, <http://frwebgate.access.gpo.gov/cgibin/useftp.cgi?IPaddress=162.140.64.21&filename=sc105is.txt&directory=/diskc/wais/data/105_cong_bills >, consultato il 9 maggio 2003. 342 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., p. 574. 341 abitazioni distrutte, mentre tutta la popolazione versava in condizioni al limite della sopravvivenza, affamata e con carestie ed epidemie diffuse in tutto il paese343 . Un ulteriore aggravamento della crisi avrebbe portato alla disfatta dell’esercito dell’Uck, poco attrezzato rispetto alle capacità di quello serbo e quindi non in grado di affrontare adeguatamente l’imminenza del rigido inverno. Ciò convinse l’Europa ad assecondare la linea degli Stati Uniti: il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il 23 settembre, approvò così la risoluzione 1199, nella quale si accusavano le forze serbe di provocare una catastrofe umanitaria. Inoltre, la risoluzione minacciava, sulla base degli impegni presi da Milosevic con El’cin, che nel caso in cui la Jugoslavia non si fosse impegnata a ritirare le proprie truppe ed a cessare i combattimenti permettendo agli osservatori diplomatici di entrare in Kosovo, la comunità internazionale si sarebbe riservata di intraprendere “ulteriori passi e misure aggiuntive” nei suoi confronti344 . In realtà, il provvedimento fu il solito frutto di un compromesso per rendere la decisione accettabile alla Russia e alla Cina, e per questo risultò piuttosto ambiguo. In base a questa risoluzione però, il Consiglio della NATO, riunitosi il giorno dopo in Portogallo, autorizzò il proprio comandante supremo, il generale Wesley Clark, a lanciare il cosiddetto “Activation Warning” (avviso di attivazione) per un intervento militare in Kosovo. Esso costituiva il preludio ad attacchi aerei come quelli operati in Bosnia tre anni prima 345 . A Belgrado, dove dilagava il nazionalismo e dove i pochi oppositori del regime, nella migliore delle ipotesi, venivano etichettati come venduti all’occidente, le mosse della comunità internazionale vennero ignorate. Il regime sosteneva in modo piuttosto stravagante la propria estraneità ai fatti che avvenivano in Kosovo, accusando la propaganda occidentale di connivenza con il separatismo albanese. Il 26 settembre a Drenica avvenne un massacro nel qua le morirono 19 persone, fra cui donne e bambini colpiti alla nuca dalle forze di polizia mentre fuggivano. Il governo belgradese si ostinò a sostenere, nonostante fossero state scoperte inconfutabili prove sull’accaduto, che le operazioni in Kosovo non erano più in corso e la situazione era pacifica 346 . La comunità internazionale, a quel punto, attraverso il Gruppo di Contatto, decise di accogliere il piano elaborato il mese precedente dall’ambasciatore americano in Macedonia 343 Ivi, pp. 574-575; United Nations High Commissioner for Refugees Fundraising Report, UNHCR Global Appeal 1999 – Federal Republic of Yugoslavia, I dicembre 1998, <http://www.unhcr.ch/cgibin/texis/vtx/home/+7wwBmKeaCJpwwwwkwwwwwwwhFqhT0yfEtFqnp1xcAFqhT0yfEcFqcQd5dVdaWKK8Dzmx wwwwwww/opendoc.htm>, consultato il 19 maggio 2003. 344 Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 1199/98, 23 settembre 1998, <http://ods-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/279/96/PDF/N9827996.pdf?OpenElement>, consultato il 9 maggio 2003. 345 Statement by the Secretary General following the ACTWARN decision, 24 settembre 1998, <http://www.nato.int/docu/pr/pr98e.htm#September>, consultato il 9 maggio 2003. 346 Youngs, Dodd, Bowers, Kosovo: NATO and Military Action, cit., p. 8; Judah, Kosovo, cit., p. 186; Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., p. 575. Christopher Hill: un’amministrazione provvisoria trilaterale serba-albanese- internazionale avrebbe condotto la provincia alla riacquisizione dell’autonomia, mantenendovi comunque la sovranità serba 347 . I guerriglieri dell’Uck, stremati dalla situazione creatasi, colsero l’occasione per proclamare, l’8 ottobre, l’unilaterale “cessate il fuoco”, ritirando anche i propri uomini dai boschi: mostrando buona volontà il movimento sperava di convincere la comunità internazionale della necessità di un intervento NATO in loro soccorso 348 . In un incontro avvenuto lo stesso giorno, i ministri degli esteri di Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Germania e Russia si incontrarono per decidere sull’annosa questione della procedura da seguire per l’attivazione degli interventi militari in Kosovo: il rappresentante russo Igor Ivanov chiarì la posizione del suo paese facendo sapere che, se la questione fosse stata sottoposta al Consiglio di Sicurezza delle Nazione Unite egli avrebbe utilizzato il proprio diritto di veto per bloccare l’attacco. Nel caso in cui si fosse deciso di far agire la NATO direttamente senza il coinvolgimento delle Nazioni Unite, tuttavia, la Russia avrebbe fatto “soltanto un gran strepito”349 . A quel punto gli Stati Uniti, ottenuto il tacito assenso russo, non avrebbero avuto difficoltà nell’utilizzo della forza, se non fosse stato per un ulteriore problema a cui, a quel punto, si trovò di fronte il Dipartimento di Stato: una volta intervenuti contro i serbi chi avrebbe impedito ai kosovari di chiedere l’indipendenza della regione o peggio ancora l’annessione all’Albania? In questo modo, infatti, si sarebbe rischiata l’eventualità di una reazione a catena che avrebbe potuto portare a giustificare anche un’eventuale richiesta serba per l’annessione della loro Repubblica di Bosnia nella federazione jugoslava. Per questo, gli Stati Uniti decisero che la strategia da adottare, anche per la questione del Kosovo, avrebbe dovuto essere quella già intrapresa per la Bosnia: l’utilizzo della forza rimaneva la base, che sarebbe stata comunque accompagnata dalla diplomazia per rendere possibile in qualsiasi momento un compromesso pacifico. Si trattava della scelta degli Stati Uniti per la cosiddetta “diplomazia dell’ultimatum”, che avrebbe portato all’escalation militare per sostenere la capacità di deterrenza dell’Alleanza 350 . Le Nazioni Unite continuavano a mostrare ancora una volta tutta la loro incapacità decisionale. La risoluzione 1199 non era stata rispettata da Milosevic e questo forniva alla NATO ulteriori alibi per agire autonomamente. La posizione della Russia non tranquillizzava certo il vozd, che decise così di incontrare Richard Holbrooke. Quest’ultimo, osteggiato dalla Albright nella ricerca di un compromesso diplomatico, elaborò un piano per convincere la Serbia a raggiungere un 347 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., p. 577. Clark, Waging Modern War, pp. 134-135 349 Judah, Kosovo, cit., p. 183. 350 Weller, The Crisis in Kosovo, cit., p. 218; Del Pero, Romero, Le ragioni di una guerra, cit. 348 accordo sulla piattaforma elaborata dalla risoluzione 1199. Questa soluzione fu accettata da Milosevic e dette a tutti l’illusione che un accordo di pace avrebbe potuto essere raggiunto. Il presidente jugoslavo poté così pubblicare un testo con i punti principali conseguiti con l’accordo: l’integrità territoriale della Jugoslavia restava ferma, mentre al Kosovo si garantivano governo e forze di polizia autonomi, nonché lo svolgimento, entro nove mesi, di elezioni libere con la supervisione dell’OSCE. Milosevic, però, omise volutamente di informare la propria opinione pubblica di altre e ben più importanti concessioni che fu costretto a fare agli americani: dopo il rientro nelle proprie case degli albanesi, esse prevedevano la riduzione delle forze serbe nella regione ai livelli precedenti all’inizio degli scontri (12000 soldati e 10000 poliziotti), il dispiego sul territorio di 2000 osservatori dell’OSCE che avevano il compito di vigilare sull’applicazione dell’accordo e soprattutto l’accettazione del sorvolo della zona da parte di aerei della NATO, comunque disarmati, nell’ambito di un’operazione denominata “Eagle Eye”, che prevedeva, tra l’altro, la rimozione delle postazioni antiaeree serbe 351 . Lo scetticismo negli ambienti internazionali sulla reale volontà di Milosevic di applicare l’accordo era alto: “Dobbiamo ora vedere i progressi che Milosevic traduca i suoi impegni in concreta realtà […] Non ci fidiamo di quello che il presidente Milosevic dice, ma di quello che il mondo intero vede”, dichiarò il presidente Clinton352 . Inoltre, per mettere sotto pressione Milosevic, lo stesso giorno la NATO fece un passo in più: dopo l’ ”Activation Warning” deciso poco meno di un mese prima, venne approvato il piano d’azione per gli attacchi aerei contro la Jugoslavia (ACTORD) 353 . La data per l’eventuale inizio dei raid venne resa elastica per consentire a Milosevic di disporre dei tempi tecnici necessari per ritirare le proprie truppe. I movimenti delle forze serbe, però, sembravano essere verso il Kosovo anziché di ritorno verso la Serbia e così, Wesley Clark, il 24 ottobre si recò a Belgrado insieme a Klaus Naumann, presidente del comitato militare della NATO: nel corso dei colloqui i due avvertirono Milosevic che se non avesse ritirato le truppe la NATO avrebbe iniziato i raid entro tre giorni354 . Anche il Consiglio di Sicurezza, nello stesso giorno, riconosceva per la prima volta il ruolo della NATO nella missione di verifica del rispetto degli accordi approvando la risoluzione 1203 e 351 Youngs, Dodd, Bowers, Kosovo: NATO and Military Action, cit., p. 8; Youngs, Kosovo, cit., pp. 15-16; Judah, Kosovo, cit., p. 186; Clark, Waging Modern War, cit., pp. 142-143. 352 William J. Clinton, Remarks on the Situation in Kosovo and an Exchange With Reporters , 13 ottobre 1998, in Public Papers of the Presidents of the United States: William J. Clinton: 1998, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1998, vol. 2, p. 1793. 353 Statement to the Press by the Secretary General Following Decision on the ACTORD, 13 ottobre 1998, <http://www.nato.int/docu/pr/pr98e.htm#October>, consultato il 10 maggio 2003. 354 Clark, Waging Modern War, cit., pp. 149-153. solo allora Milosevic ubbidì, ritirando le proprie truppe a poche ore dalla scadenza dell’ultimatum355 . A dire il vero negli Stati Uniti non si guardò con troppa fiducia agli ultimi eventi. Ormai la tattica del “tira e molla” di Milosevic era nota a tutti e questa volta l’intenzione americana era quella di non sottostare alle manovre del vozd. Gli intenti di Madeleine Albright, dunque, strenua sostenitrice dell’intervento, non erano certo tramontati dopo l’accordo raggiunto da Holbrooke con Milosevic e in quel periodo il suo obiettivo era quello di sfruttare la pausa per far passare l’inverno e raccogliere fra gli alleati europei i necessari consensi per l’azione militare 356 . Nel frattempo, i verificatori OSCE arrivavano in Kosovo, ma in numero praticamente dimezzato rispetto all’accordo Milosevic-Holbrooke, a causa della renitenza degli stati ad inviarli in una zona molto pericolosa, considerato anche che i serbi frapponevano non poche difficoltà burocratiche per il loro ingresso nel paese. Anche il presidente Clinton, preoccupato che gli osservatori inviati in Kosovo cadessero in ostaggio dei serbi, si mostrò restio al loro invio357 . L’atteggiamento prudente era consigliato dal fatto che egli non stava attraversando nel suo paese uno dei suoi momenti migliori: lo scandalo sessuale riguardante l’accusa nei confronti di Clinton per una presunta relazione extraconiugale con la sua ex stagista Monika Lewinsky minacciava il presidente di impeachment 358 . Del ritiro delle truppe serbe imposto con la minaccia dalla comunità internazionale approfittarono i guerriglieri dell’Uck, che si decisero a riprendere i combattimenti. Questo causò una nuova ondata di scontri in Kosovo: le forze di polizia serba rientrarono nella regione per fronteggiare gli albanesi, seppur in misura limitata per evitare la reazione della NATO. L’Uck, tra l’altro, poteva farsi forte degli incontri avuti nei mesi di novembre e dicembre con i diplomatici statunitensi, i quali, in cambio della promessa che i kosovari non avrebbero esteso il conflitto alla Macedonia e che non avrebbero avviato contatti con i guerriglieri islamici, si impegnarono a fornire loro armi e addestratori messi a disposizione dai servizi segreti di molti paesi occidentali 359 . A Belgrado, intanto, la possibilità di un intervento militare da parte della NATO preoccupava non poco i capi dell’armata Jugoslava, considerata anche la notevole sproporzione dei mezzi a disposizione fra le parti. Per questo motivo i vertici militari iniziarono ad esprimere dissenso sulla politica di Milosevic. In quei giorni trapelò la notizia di un possibile colpo di stato nel paese, la cui macchinazione venne però attribuita dalla stampa belgradese alla CIA. In ogni caso 355 Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 1203, 24 ottobre 1998, <http://ods-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/321/21/PDF/N9832121.pdf?OpenElement>, consultato il 10 magio 2003. 356 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., p. 580. 357 Judah, Kosovo, cit., p. 188. 358 Fasce, Da George Washington a Bill Clinton, cit., pp. 167-168. 359 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., pp. 580, 581. la decisione di Milosevic di rimuovere il capo di stato maggiore dell’esercito insieme a venti ufficiali conferma il timore di Milosevic nei confronti degli ambienti militari e la sua determinazione nel voler rimanere saldamente in sella 360 . Il lavoro dei verificatori non riuscì a fermare la battaglia che verso la fine dell’anno era ormai ripresa in maniera piuttosto cruenta e che provocava incidenti e vittime da ambo le parti. Il 15 gennaio 1999, per rappresaglia all’uccisione di tre suoi uomini, forze della polizia serba armate d’artiglieria pesante fecero irruzione nel villaggio di Racak, rastrellando casa per casa la popolazione e provocando la morte di 45 persone, 23 delle quali ammassate su un colle e giustiziate in massa 361 . Il giorno dopo il capo dei verificatori dell’OSCE, il generale William Walker, visitò la cittadina e poté rendersi conto con i suoi occhi, insieme a numerosi giornalisti che lo accompagnavano, di ciò che era accaduto: persone che tentavano di fuggire erano state freddate nella maggior parte dei casi con colpi alla nuca. La notizia dell’eccidio fece il giro del mondo provocando una nuova indignazione generale. Lo stesso Walker tenne una conferenza stampa nella quale chiese che i responsabili di quell’episodio venissero perseguiti dal Tribunale dell’Aia 362 . Il governo di Belgrado sostenne che le persone uccise erano cadute in scontri con la polizia, accusando il diplomatico americano di diffamare le autorità serbe e di sostenere la battaglia terroristica dell’Uck. A Louise Arbour, procuratore generale del Tribunale dell’Aia, fu impedito di visitare la zona, a conferma che le cose non erano andate come le descriveva Belgrado. Walker venne invitato ad abbandonare il paese quale persona non gradita, ma grazie all’intervento presso Milosevic di Wesley Clark, che minacciò nei suoi confronti l’intervento NATO, egli rimase al comando della missione dell’OSCE363 . Dopo che Walker passò ai diplomatici americani le informazioni ufficiali sull’accaduto sembrava essere arrivato il momento per Madeleine Albright di dare la spinta decisiva per l’attacco. Ella vedeva in Milosevic il problema di tutta la questione kosovara ed interpretò l’eccidio di Racak come il segnale del fallimento della missione diplomatica di Holbrooke. Lo staff del Dipartimento di Stato, per evitare di fare il gioco di Milosevic, decise allora di far seguire un eventuale intervento militare alla mancata accettazione da parte di Belgrado, non di una soluzione transitoria, ma di una proposta definitiva sul Kosovo, come si era fatto nel ’95 per la Bosnia. La proposta prevedeva l’accettazione dell’autogoverno per gli albanesi, ai quali sarebbe stato chiesto di congelare la richiesta di indipendenza. Se i serbi non avessero accettato ci sarebbe stato l’intervento NATO, se 360 E. Roberts, Next Balkans Flashpoint?, “The World Today”, vol. 54, n. 4, aprile 1999, p. 7; Richard Caplan, Cristopher’s Hill Road Show, “The World Today”, vol. 54, n. 1, gennaio 1999, pp. 13-14. 361 Schmidt, Teaching the Wrong Lesson in Kosovo, cit., p. 17. 362 Indipendent International Commission on Kosovo, The Kosovo Report, cit., p. 81. 363 Youngs, Oakes, Bowers, Kosovo: NATO and Military Action, cit., p. 11. invece a rifiutare tale proposta fossero stati gli albanesi, gli Stati Uniti non avrebbero più garantito loro gli aiuti364 . Questo progetto però, avrebbe richiesto un impegno di soldati americani e non solo nell’intervento aereo, ipotesi che si scontrava con la volontà del Pentagono, restio a inviare proprie truppe di terra anche solo per una missione di mantenimento della pace. Così, la Albright si impegnò in una serie di colloqui con il Segretario alla difesa Cohen e con i più alti vertici delle forze armate e della CIA per elaborare un piano comune. L’accordo fu trovato dopo qualche giorno e fu subito sottoposto all’attenzione del presidente Clinton, che lo approvò senza troppi dubbi. Il passo successivo fu quello di tentare di convincere gli alleati della validità del piano. La Gran Bretagna convenne con la proposta americana, mentre la Francia sostenne che un eventuale intervento militare della NATO avrebbe richiesto un’autorizzazione da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Di fronte alla risolutezza di Washington, però, anche Parigi accettò la proposta. Bisognava, poi, accertarsi che anche la Russia, come già aveva fatto intendere pochi mesi prima Ivanov, no n si sarebbe opposta troppo all’intervento: il tacito accordo col ministro degli esteri di Mosca fu confermato, favorito dalla volontà russa di mantenere saldi i buoni rapporti economici con gli Stati Uniti365 . Gli europei, comunque, chiesero alla Albright la convocazione del Gruppo di contatto: il vertice, riunitosi a Londra il 29 gennaio, decise di avviare, per l’applicazione del piano elaborato dagli Stati Uniti, i colloqui fra le parti kosovara e serba. L’obiettivo rimaneva quello di giungere ad una soluzione secondo il progetto di Hill di una amministrazione trilaterale della durata di tre anni 366 . Nel contempo la NATO si dichiarò pronta ad un intervento militare in Kosovo qualora questo fosse risultato necessario. Il Segretario Generale fu autorizzato dal Consiglio dell’Alleanza ad agire senza ulteriori procedure 367 . Questo, come previsto, escludeva il coinvolgimento delle Nazioni Unite, il che fece indignare Belgrado, che inviò una protesta al Consiglio di Sicurezza. Il suo Segretario Generale Kofi Annan, però, non sembrò propenso ad accogliere l’istanza serba, che quasi ignorò, avallando, in pratica, l’ipotesi di intervento “unilaterale” della NATO 368 . 364 Judah, Kosovo, cit., pp. 192-193; Rubin, Countdown, cit., p. IX. Pirjevec, Le guerre jugoslave, cit., pp. 586-587 ; Levitin, Inside Moscow’s Kosovo Muddle, cit., p. 134; Ted Galen Carpenter, Damage to Relations with Russia and China, in Carpenter (a cura di), NATO’s Empty Victory, cit., p. 81. 366 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., p. 587. 367 Statement by the North Atlantic Council on Kosovo, 30 gennaio 1999, <http://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-012e.htm>, consultato l’11 maggio 2003. 368 Weller, The Crisis in Kosovo 1989-1999, cit., p. 221. 365 3.6 Rambouillet Il luogo scelto per intavolare le trattative diplomatiche sulla base della bozza di soluzione proposta da Hill fu Rambouillet, in un castello di una cittadina francese che somigliava a Dayton soltanto per l’isolamento dal mondo esterno che lo caratterizzava 369 . Le delegazioni si presentarono all’appuntamento nel modo più variegato: per gli albanesi si recarono in Francia oltre ad Ibrahim Rugova, affiancato dal nuovo Movimento Democratico Unito, anche alcune personalità indipendenti e ben cinque esponenti dell’Uck. I serbi protestarono vivamente per la presenza dei “terroristi” albanesi e minaccia rono di disertare le trattative. Alla fine gli uomini di Belgrado garantirono la loro presenza ai colloqui di pace, anche se con una delegazione priva del suo personaggio principale, Slobodan Milosevic, che preferì rimanere nel suo paese per paura di essere raggiunto dall'ordine di cattura del tribunale dell'Aja. Milosevic garantì comunque a Madeleine Albright che la sua delegazione si sarebbe mostrata flessibile ai colloqui, con l'unico intento di salvaguardare i serbi del Kosovo. Il presidente serbo vi inviò, oltre che il vicepresidente del consiglio dei ministri Ratko Markovic, i rappresentanti delle più disparate etnie della Jugoslavia, per dare dimostrazione del peso che esse avevano nel suo paese e per dimostrare che gli albanesi non erano l’unica popolazione dell’area: il regime di Belgrado si ostinava a sostenere che essi in Kosovo non costituivano la maggioranza. In realtà, i personaggi scelti erano fortemente legati al suo partito o a quello della sinistra jugoslava legata alla moglie del vozd Miriana Markovic, e per questo erano privi sia di una credibilità di rappresentanza della società multietnica jugoslava, sia di un reale peso politico per la riuscita dei colloqui370 . Gli incontri, nonostante le tante difficoltà, ebbero comunque inizio il 6 febbraio e furono condotti da Christopher Hill in testa, insieme all’ambasciatore austriaco a Belgrado, Wolfgang Petrisch e al viceministro degli esteri russo Boris Majovski. L’atmosfera si presentò subito tesissima, ancor più che a Dayton, anche perché i serbi in quei giorni avevano di nuovo ammassato le proprie truppe in Kosovo. I mediatori furono addirittura costretti ad organizzare sedute separate per serbi e albanesi, le quali delegazioni, così come composte, rifiutavano di incontrarsi371 . Alle delegazioni fu subito chiarito che non ci sarebbe stata disponibilità per consistenti modifiche al piano proposto: per un periodo transitorio di tre anni il Kosovo, pur rimanendo sotto la 369 Pirjevec, Le guerre jugoslave 19911999, cit., p. 588 Ivi, pp. 588-589; Weller, The Crisis in Kosovo 1989-1999, cit., p. 228; James Rubin, A Very Personal War, parte II: The Promise of Freedom, “Financial Times Weekend”, 7-8 ottobre 2000, p. I. 371 Pirjevec, le guerre jugoslave 1991-1999, cit., p. 589. 370 sovranità jugoslava, si sarebbe autogovernato sotto il controllo di una forza NATO, rimandando ad una conferenza da tenersi al termine di tale periodo la definizione dello status definitivo della provincia 372 . Gli scogli si presentarono, dunque, già prima dell’inizio dei colloqui: i serbi contestavano anche il fatto che questi sarebbero stati condotti all’estero, pensando che in questo modo si sarebbe dato riconoscimento internazionale della crisi, che invece essi volevano presentare come un problema interno. Essi erano contrari anche ad una tregua nel conflitto, che dal loro punto di vista avrebbe significato il riconoscimento dell’Uck come forza belligerante 373 . Nel documento elaborato dalla diplomazia occidentale si chiedeva per le forze NATO in Kosovo la totale immunità e l’accesso illimitato a tutto il territorio jugoslavo con l’utilizzo, nell’ambito della missione, di tutte le infrastrutture di trasporto, senza che fosse corrisposto alcun compenso alla Federazione jugoslava 374 . Il dispiego di soldati NATO sul territorio jugoslavo era di per sé un elemento difficile da accettare per Milosevic, per la prevedibile reazione negativa del popolo e dell’opinione pubblica che avrebbe comportato 375 . Il testo dunque, risultava oltremodo penalizzante nei confronti dei serbi, che molti analisti politici per questo criticarono duramente. Lo stesso Henry Kissinger afferma: “rispetto i motivi umanitari per l'intervento. Ma questo non assolve le democrazie dalla necessità di raggiungere una soluzione sostenibile. L'accordo di Rambouillet non passa tale test. Condurre un negoziato basato su un testo disegnato interamente nelle cancellerie internazionali cercando di imporlo con la minaccia dei bombardamenti aerei ha solo aggravato la crisi in Kosovo”376 . In effetti Christopher Hill, durante tutta la fase dell’elaborazione del documento e delle trattative di pace, lavorò a stretto contatto con gli Stati Uniti e in particolare con Madeleine Albright. Essa, con Clinton distratto dallo scandalo Lewinsky, divenne la vera fautrice della politica di Washington e già alla fine di gennaio avrebbe voluto lanciare a Milosevic l’ultimatum decisivo per l’intervento, convinta soltanto dagli alleati europei della necessità di convocare una conferenza di pace 377 . A quel punto Washington cercò di fare pressione più sugli alleati stessi che sulle parti in causa (che mai si incontrarono a Rambouillet) per convincerli che l’unica opzione possibile sarebbe stata quella militare 378 . 372 Rubin, Countdown, cit., p. IX. Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., p. 590. 374 Clark, Waging Modern War, cit., p. 163. 375 Judah, Kosovo’s Road, cit., pp. 14-15. 376 Henry A. Kissinger, Kosovo and the Vicissitudes of American Foreign Policy, in William J. Buckley (a cura di), Kosovo: Contending Voices on Balkan Interventions, Grand Rapids, MI, William B. Eerdmans Pub., 2000, p. 304. 377 Scotto, Arielli, La guerra del Kosovo, cit., pp. 135, 136. 378 James George Jatras, NATO's Myths and Bogus Justifications for Intervention, in Carpenter (a cura di) NATO’s Empty Victory, cit., p. 24. 373 La conferenza dovette essere prolungata di dieci giorni per cercare di giungere ad una soluzione. Per questo motivo il Segretario di Stato americano cercò di far comprendere alla delegazione albanese, della quale l’Uck era la componente che ne aveva assunto il comando, di non insistere sulla questione di un referendum sull’indipendenza, ma di accettare l’intero contenuto del testo proposto dal piano Hill. Così facendo sarebbe risultato chiaro al mondo intero che l’indisponibilità ad accettare il piano di pace veniva soltanto da Milosevic, e l’intervento militare avrebbe potuto essere giustificato. Dal canto suo, Milosevic comprese la strategia americana e si rifiutò di accettare gli appelli a moderare la sua posizione, rivoltigli a più riprese dai mediatori. Ciononostante ad un certo momento i serbi, probabilmente informati di quale fosse il progetto di Washington, mostrarono di non essere del tutto contrari ad un impiego di forze internazionali nel Kosovo, qualora queste fossero state impiegate sotto l’egida delle Nazioni Unite, sul modello della missione UNPROFOR. La missione sarebbe stata così composta da caschi blu dotati solo di armi leggere. Questa proposta però, non era gradita agli americani, così come dagli albanesi, ma il ministro degli Esteri italiano Lamberto Dini dette si mostrò invece possibilista con Belgrado e fu ammonito per questo dalla Albright: “Lamberto, ciò non ha senso. Il punto essenziale è che i serbi accettino la forza NATO”379 . Madeleine Albright, a quel punto, per far accettare la piattaforma agli albanesi, osteggiata soprattutto dal più alto rappresentante dell’Uck a Rambouillet, il giovane Hashim Thaci, decise di passare alla minaccia: se gli albanesi non avessero accolto il piano di pace sarebbero venuti meno nei loro confronti tutti gli aiuti occidentali. Senza consultare gli alleati europei, poi, promise loro il referendum sull’indipendenza del Kosovo alla fine della triennale amministrazione internazionale, senza che questo fosse previsto dal testo che sarebbe stato firmato. Inoltre, per far capire quale fosse la determinazione nel far intervenire la NATO nel caso in cui i serbi non avessero accettato l’accordo, essa organizzò un incontro a Rambouillet fra Thaci e il generale Wesley Clark, nel quale il generale avrebbe informato dettagliatamente il leader albanese sui piani d’intervento già pronti contro la Jugoslavia. I francesi furono irritati da tale atteggiamento e per rivalsa, sostene ndo che tale gesto avrebbe turbato i serbi, impedirono a Clark di incontrare Thaci nel castello che ospitava i colloqui di pace 380 . Il 23 febbraio, dopo essersi recata in patria per spiegare il senso dell’accordo, la delegazione albanese firmò il documento nel quale fu incluso un riferimento alla “volontà espressa del popolo” 379 Judah, Kosovo, cit., p. 207; Rubin, Countdown, cit., p. IX; Scotto, Arielli, La guerra del Kosovo, cit., p. 137; Lamberto Dini, Fra Casa Bianca e Botteghe Oscure. Fatti e retroscena di una stagione alla Farnesina, Milano, Guerini, 2001, pp. 63-64. 380 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., pp. 593-594 ; Judah, Kosovo, cit., pp. 215, 217; Clark, Waging Modern War, cit., pp. 169-170. di cui tener conto per definire la sorte della provincia al termine dei tre anni dell’amministrazione internazionale 381 . Il piano non si presentava come il migliore per risolvere la questione: non sarebbe stata certo un’operazione di peace-keeping di soli tre anni a tranquillizzare una situazione generata da decenni e aggravata dai recenti spargimenti di sangue. Gli Stati Uniti erano riusciti comunque a raggiungere il loro obiettivo di ricevere il sì degli albanesi, isolando Belgrado e costringendo gli alleati europei ad accettare gli eventuali raid NATO. A Milosevic, per evitare ciò, non sarebbe rimasto che accettare il diktat americano 382 . 3.7 La guerra della NATO I margini per proseguir e la trattativa diplomatica sembravano esistere ancora dopo la conclusione dei colloqui di Rambouillet. Per favorire il negoziato, su suggerimento degli europei, si scelse di prendere una pausa per consentire alle parti una riflessione serena sul da farsi, soluzione che tra l’altro permetteva alla NATO di organizzarsi in vista di un possibile intervento 383 . La delegazione albanese, dopo le titubanze mostrate durante le trattative, confermò in maniera decisa la linea suggerita dagli americani, alla quale aveva aderito Hashim Thaci, che si affermò in Kosovo come il vero leader dell’Uck. Il senatore Bob Dole ricevette una delegazione dell’Uck negli Stati Uniti per manifestare loro l’apprezzamento degli americani per gli sforzi compiuti nella conclusione dell’accordo di pace 384 . Dall’altra parte Milosevic non dimostrò alcuna volontà di apertura per arrivare ad una soluzione negoziata. Durante gli ultimi giorni di febbraio, quando ancora i colloqui di Rambouillet erano in corso, il Segretario Generale della NATO Sola na inviò un serio monito a Belgrado, dopo aver ricevuto segnali di preoccupazione da parte del presidente albanese Pandeli Majko sulle manovre delle truppe serbe in Kosovo. Lo stesso Ibrahim Rugova, ormai figura di poco peso, denunciò la ripresa delle azioni da parte delle truppe serbe ai capisaldi dell’Uck 385 . Milosevic sembrava sordo a quanto numerosi membri della comunità internazionale cercavano di fargli capire: egli non era disposto ad accettare che le truppe internazionali della 381 Weller, The Crisis in Kosovo 1989-1999. Rubin, A Very Personal War, parte II: The Promise of Freedom, cit., p. I; Federico Fubini, Il bacio di Madeleine, ovvero come (non) negoziammo a Rambouillet, “Limes”, n. 2/99, p. 19. 383 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., p. 595. 384 Judah, Kosovo, cit., p. 220. 385 Youngs, Oakes, Bowers, Kosovo: NATO and Military Action, cit., p. 15. 382 NATO si insediassero nel suo territorio. Forse il presidente serbo non capì fino in fondo quale fosse il vero intento degli americani e perseverò nell’atteggiamento di sfida che ne contraddistingueva il personaggio: il suo ministro degli Interni il 9 marzo emise dei mandati di cattura nei confronti di “terroristi e separatisti albanesi” esponenti dell’Uck, fra i quali anche Hashim Thaci. Lo stesso tentativo di Holbrooke, prodigo nel tentare le ultime carte diplomatiche per convincere Milosevic, andò a vuoto. Il vozd si dichiarò addirittura convinto che la vicenda sarebbe stata risolta nel giro di una settimana con l’eliminazione dell’Uck. Anche il primo ministro inglese Tony Blair, a conoscenza di notizie che davano l’intensificarsi dell’offensiva serba, si attivò avvertendo il presidente serbo che rischiava l’incriminazione presso il Tribunale dell’Aja. Neanche l’intervento del ministro degli Esteri russo Ivanov, che invitò Milosevic a chiedere lui stesso l’intervento internazionale per consentire alla Russia di parteciparvi, sortì alcun effetto 386 . I motivi che spinsero Milosevic a non cambiare comportamento furono certamente il forte nazionalismo che pervadeva tutta l’opinione pubblica belgradese, ma anche la convinzione che l’Occidente non avrebbe avuto il coraggio di intervenire. Egli era confortato anche dal fatto che di minacce di intervento militare negli ultimi anni ne aveva subite moltissime, senza che poi queste fossero state messe realmente in pratica 387 . Il 15 marzo, al Centro internazionale di Avenue Klébert a Parigi, si aprì la conferenza che avrebbe dovuto vedere la firma delle parti al piano di Rambouillet. Già il 18 marzo gli albanesi firmarono, mentre i serbi non cambiarono idea e non accettarono il documento. Il capo della delegazione serba Milan Mlutinovic contestò fortemente il testo dell’accordo che, a suo dire, era stato modificato sottobanco per danneggiare il popolo serbo, vittima di un complotto occidentale. Neppure il rappresentante russo Boris Majovski firmò il documento: il governo moscovita non se la sentì di avallarlo per non dare l’assenso all’intervento militare contro la Serbia, ma decise anche di chiarire la propria posizione critica nei confronti di un Milosevic totalmente inamovibile sulle proprie posizioni 388 . Il documento di Rambouillet veniva considerato a Belgrado una vera e propria congiura contro il popolo serbo. A quel punto si capì che l’intervento era alle porte: il 19 marzo i verificatori dell’OSCE vennero ritirati e l’unico che poteva fermare la macchina militare, Milosevic, peggiorava invece la situazione, ordinando alle proprie truppe di intraprendere azioni durissime, atte a eliminare una volta per tutte l’Uck 389 . 386 Ivi, p. 18; Schmidt, Teaching the Wrong Lesson in Kosovo, cit., p. 18; Pirjevec, Le guerre jugoslave 19911999, cit., pp. 596-597. 387 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., p. 597. 388 Youngs, Oakes, Bowers, Kosovo: NATO and Military Action, cit., pp. 18-19. 389 Ibidem; Schmidt, Teaching the Wrong Lesson in Kosovo, cit., p. 19. Lo stesso giorno il presidente degli Stati Uniti Bill Clinton spiegò le ragioni che portavano all’opzione dell’uso della forza: “Si tratta di una crisi umanitaria, ma anche di qualcosa di più. È un conflitto senza frontiere naturali. Minaccia i nostri interessi nazionali. Se si prolungherà, spingerà i profughi oltre frontiere e coinvolgerà gli stati vicini. Indebolirà alla credibilità della NATO da cui dipende la stabilità dell'Europa, e la nostra stessa credibilità. Con ogni probabilità, rinfocolerà le animosità storiche incluse quelle che possono coinvolgere l'Albania, la Macedonia, la Grecia e perfino la Turchia. Queste divisioni hanno ancora il potenziale per fare diventare il prossimo secolo un secolo veramente violento in quella parte del mondo che sta a cavallo dell'Europa, dell'Asia e del Medio Oriente”390 . Nei giorni successivi alla partenza dei verificatori le forze serbe intensificarono fortemente l’offensiva contro gli albanesi, colpendo sistematicamente anche la popolazione civile, che dovette subire uccisioni, saccheggi e anche stupri. In molte cittadine gli albanesi erano costretti alla fuga, in un clima discriminatorio pesantissimo che pervadeva il Kosovo. In quei giorni era quasi impossibile rimanere nelle case: a coloro che decidevano di rimanere nei propri villaggi i negozianti serbi si rifiutavano persino di vendere cibo 391 . Milosevic, che tramite i suoi uomini lasciava aperta qualche speranza sulla possibilità di trovare un accordo diplomatico, continuava però a manifestare personalmente la totale chiusura ad un compromesso. Richard Holbrooke tentò l’ultima carta diplomatica recandosi a Belgrado il 22 e il 23 marzo, tentando di far capire al vozd che la NATO questa volta sarebbe intervenuta davvero. Milosevic continuò nel secco rifiuto all’idea delle truppe NATO in Kosovo, con il solito atteggiamento di sfida nei confronti dell’occidente e soprattutto degli Stati Uniti392 . Non si capiva bene quale fosse la logica strategica che portasse il presidente serbo a rifiutare ogni tipo di mediazione e a dovere così affrontare la potenza militare occidentale. In ambienti dell’opposizione serba, così come negli Stati Uniti e in Europa, si pensò che Milosevic si fosse reso conto di non essere in grado di controllare il Kosovo e per questo, nello spirito nazionalistico che contraddistingueva il suo popolo, avesse deciso di perderlo conducendo una battaglia valorosa e disperata; agendo in questo modo egli si sarebbe mostrato all’opinione pubblica come un eroe, scaricato da ogni responsabilità per la perdita del controllo sulla provincia, che sarebbe ricaduta sul nemico occidentale. Un’altra ipotesi credibile era quella che Milosevic, in base ad informazioni che 390 William J. Clinton, The President’s New’s Conference, 19 marzo 1999, in Public Papers of the Presidents of the United States: William J. Clinton: 1999, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1999, vol. 1, p. 410. 391 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., pp. 599-600. 392 Judah, Kosovo, cit., p. 227 possedeva, fosse convinto che se la Serbia avesse resistito qualche giorno ai bombardamenti la NATO avrebbe rinunciato a proseguire negli attacchi393 . Holbrooke da Belgrado si recò a Bruxelles per informare Javier Solana degli esiti ne gativi dei colloqui. Il Segretario Generale della NATO annunciò così, lo stesso 23 marzo, il fallimento delle iniziative diplomatiche e per questo motivo di avere dato mandato al generale Clark di “iniziare le operazioni aeree nella Repubblica Federale di Jugoslavia”394 . Nello stesso tempo il Segretario Generale inviò una lettera ai governi di Albania, Macedonia e Slovenia per garantire loro la protezione NATO in caso di minaccia da parte dell’esercito jugoslavo 395 . Quella scelta rappresenta per l’Alleanza atlantica un crocevia storico, che la vide per la prima volta impegnata in un'azione militare contro uno stato sovrano. Veniva così violata non solo la Carta delle Nazioni Unite, ma anche la costituzione dell’Alleanza, che l’aveva vista nascere nel 1949 come alleanza difensiva. Questo elemento rese titubanti molti stati membri, ma non fermò comunque il progetto di Washington di ridare linfa ad un organismo che con la fine della guerra fredda rischiava di perdere le ragioni della sua esistenza. In questo modo gli Stati Uniti cercarono nella NATO uno strumento di attuazione della loro politica neo- unilateralista in Europa. In questo influì sicuramente la storia del personaggio che maggiormente spinse per la guerra, Madeleine Albright. Con Wesley Clark, entrambi di origine ebraica, giocarono un ruolo fondamentale nell’interpretare la crisi come un rischio per l’umanità: non si poteva consentire a Milosevic ciò che si consentì a Hitler nel ’38; bisognava intervenire per evitare l’estensione del conflitto 396 . Gli alleati europei furono costretti a subire la volontà della potenza americana e si dovettero adeguare a questo progetto: la Gran Bretagna rinnovò la “special relationship” con gli Stati Uniti, la Francia cercò di assumere una posizione importante nell’Alleanza per acquisire un ruolo di rilievo nella politica mondiale consono alla “grandeur”, la Germania per dare il suo primo apporto unitario ad un’operazione militare a fianco dell’occidente, l’Italia per non perdere l’occasione di assumersi, almeno in quella circostanza, la responsabilità degli impegni internazionali 397 . Le motivazioni ufficiali che gli attori internazionali fornirono per spiegare quella decisione erano ben diverse da quelle reali: prima di tutto si sostenne con forza che, la lezione imparata nella crisi in Bosnia, portava ad impegnarsi prontamente per arrestare il processo di pulizia etnica che Milosevic stava incontestabilmente attuando nella regione del Kosovo. Il presidente serbo veniva paragonato da alcuni esponenti occidentali ai dittatori più sanguinari della storia dell’umanità. 393 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., pp. 600-601. Press Statement by Dr. Javier Solana, Secretary General of NATO, 23 marzo 1999, <http://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-040e.htm>, consultato il 13 maggio 2003. 395 Tim Youngs, Mark Oakes, Paul Bowers, Kosovo: Operation “Allied Force”, Research Paper, 99/48, House of Commons Library, 29 aprile 1999, p. 9. 396 Daalder, NATO in the 21st Century, cit., p. 25; Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., pp. 601-602. 397 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., p. 602. 394 All’obiezione che veniva posta da molte parte agli Stati Uniti sullo scavalcamento delle Nazioni Unite nel processo decisionale dell’intervento in Kosovo essi rispondevano adducendo che le risoluzioni 1199 e 1203 del Consiglio di Sicurezza, nel riferimento che contenevano al capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, erano sufficienti elementi di per sé per poter attivare un’organizzazione regionale dello spessore della NATO. Questa interpretazione non soddisfece i critici dell’intervento, né tantomeno i giuristi, molti dei quali contestavano anche l’elaborazione del testo di Rambouillet come espressione della reale volontà di giungere ad una soluzione negoziata. I più critici nei confronti degli americani, oltre ad accusarli di volere quella guerra per sperimentare nuove armi, chiesero loro provocatoriamente perché, secondo questa logica, non si fosse intervenuti anche in altri paesi dove esistevano problemi di minoranze simili a quello del Kosovo 398 . La prima fase dell’intervento militare prevedeva la distruzione dei radar e del sistema antiaereo serbo, per garantire la sicurezza dei voli della NATO. Secondo le aspettative della NATO la Serbia si sarebbe piegata entro pochi giorni, date le enormi potenzialità di cui disponevano i paesi dell’Alleanza in rapporto alle capacità del sistema di difesa jugoslavo 399 . Nella notte fra il 23 e il 24 marzo il governo di Belgrado proclamò l’ ”imminente pericolo dello stato di guerra” e intervenne affinché le poche voci di dissenso interne rimaste non potessero più esprimersi tramite radio o carta stampata. Molti giornalisti occidentali quella stessa sera furono oggetto di arresti e perquisizioni, che portarono le autorità locali all’espulsione di quelli dei paesi più direttamente impegnati nel conflitto contro la Jugoslavia. A coloro i quali fu consentito di rimanere nel paese furono sequestrati i mezzi tecnici propri, dovendo così utilizzare le strutture tecniche della televisione di stato di Belgrado e in questo modo costretti a subire una forte censura 400 . L’attacco ebbe inizio il 24 sera “verso le otto”, come lo stesso Javier Solana annunciò il giorno successivo in una conferenza stampa. Vi furono impegnati 80 aerei messi a disposizione da 13 paesi NATO e missili lanciati dalle portaerei americane e britanniche presenti nel mar Adriatico. Gli obiettivi da colpire, già durante la prima notte, non furono limitati alle installazioni militari serbe in Kosovo, ma anche a quelli nella Vojvodina e nella Serbia centrale. Inoltre si colpì nei dintorni di Belgrado un aeroporto militare, un trasmettitore radio, il centro congressi ed altri edifici militari. Si cercò subito, insomma, di creare un impatto psicologico forte sulla Serbia, mostrando la potenza della NATO. “I nostri primi rapporti ci indicano che questi primi bombardamenti hanno 398 David L. Byman, Matthew C. Waxman, Kosovo and the Great Air Power Debate, “International Security”, vol. 24, n. 4, primavera 2000, p. 15; Catherine Guicherd, International Law and the War in Kosovo, “Survival, The IISS Quarterly”, vol. 4, n. 2, estate 1999, p. 19; Palmisano, La guerra “umanitaria”, cit., p. 169; Ignacio Ramonet, Nouvel ordre global, “Le Monde Diplomatique”, giugno 1999, p. 1. 399 Clark, Waging Modern War, cit., p. 176. 400 Rubin, A Very Personal War, parte II: The Promise of Freedom, cit., p. IX; Pirjevec, Le guerre jugoslave, cit., p. 604. avuto successo. Tutti gli aerei della NATO sono tornati intatti alle loro basi”, dichiarò ancora Solana 401 . Il governo di Belgrado proclamò lo stato di guerra, abolendo di fatto tutti i diritti civili e denunciando all’opinione pubblica l’aggressione occidentale. Anche la guerra della propaganda era iniziata: fonti militari serbe dichiararono alla stampa che due aerei della NATO erano stati abbattuti e che numerosi missili erano stati intercettati, senza però fornirne le prove. In realtà nella prima notte di guerra furono tre Mig-29 jugoslavi ad essere annientati in volo 402 . Lo stesso 25 marzo il presidente americano Clinton registrò un messaggio indirizzato alla popolazione serba per spiegare i motivi dell’attacco: “Voglio parlare in maniera candida a tutto il popolo serbo, per spiegare le nostre ragioni per questa azione e per come ci potrà essere una rapida soluzione della crisi. Prima di tutto non posso enfatizzare in maniera troppo forte che gli Stati Uniti e i nostri alleati europei non hanno niente contro il popolo serbo. Rispettiamo la vostra orgogliosa storia e cultura […] Chiediamo a tutti i serbi e a tutte le persone di buona volontà di stare con noi nella ricerca di una fine a questo evitabile ed inutile conflitto"403 L’inizio dei bombardamenti creò il caos più completo in Kosovo, dove l’Uck, approfittando dei bombardamenti, cercò di sferrare una controffensiva alle forze serbe, le quali reagirono pesantemente. La popolazione civile era terrorizzata e cercava in ogni modo di fuggire, mentre i regolamenti di conti dall’una e dall’altra parte si mostravano in tutta la loro crudezza. Il rischio era quello che della situazione approfittassero i serbi per espellere tutti gli albanesi dall’area. Anche per evitare questo le forze dell’Uck chiesero ai governi occidentali rifornimenti di armi per fronteggiare le truppe di Milosevic 404 . Alcuni paesi europei non concordavano sull’uso della forza contro la Jugoslavia, sebbene non avessero protestato più di tanto contro la decisione americana. Di questo era a conoscenza il governo di Belgrado che a seguito dell’attacco della NATO interruppe le proprie relazioni diplomatiche con Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Germania, ma non con Italia e Grecia. L’Italia, tra l’altro, forniva le proprie basi per gran parte degli aerei in partenza per gli attacchi in Serbia, ma decise di lasciare aperta la propria ambasciata a Belgrado per tutta la durata del conflitto, anche in un secondo momento quando decise di partecipare con propri mezzi all’attacco. La Russia 401 Press Conference by Secretary General, Dr. Javier Solana and SACEUR, Gen. Wesley Clark, 25 marzo 1999, <http://www.nato.int/kosovo/press/p990325a.htm>, consultato il 13 maggio 2003; Clark, Waging Modern War, cit., pp. 196, 209. 402 Clark, Waging Modern War, cit., pp. 196, 209. 403 William J. Clinton, Videotaped Address to the Serbian People, in Public Papers of the Presidents of the United States: William J. Clinton: 1999, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1999, vol. 1, pp. 454455. 404 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., p. 605. confermò l’atteggiamento di “protesta formale” promesso a Madeleine Albright, presentando al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il 26 marzo, una proposta che condannasse l’attacco, ma evitando di appoggiare attraverso la fornitura di armamenti il governo serbo 405 . Le operazioni militari della NATO nei primi giorni proseguirono, secondo le dichiarazioni del portavoce NATO Jamie Shea, con i bombardamenti mirati su obiettivi “esclusivamente militari”406 . Lo stesso portavoce della NATO smentì la notizia diffusa il 27 marzo da una radio di Belgrado riguardo l’abbattimento di quattro aerei alleati, ma poche ore dopo fu costretto a confermare che un aereo “invisibile” Stealth F-117 era stato abbattuto. I due piloti furono recuperati grazie ad un’operazione di salvataggio delle forze americane, che mostrarono così tutta la loro efficienza. L’abbattimento era avvenuto grazie alla “soffiata” di un ufficiale americano ai serbi, fatto che spinse il comando militare della NATO a ridurre da 600 a 100 le persone che avevano accesso al sistema computerizzato utilizzato per i bombardamenti407 . Il 27 marzo Javier Solana fece sapere che “una più ampia gamma di operazioni aeree” sarebbero iniziate 408 . Si trattava dell’inizio della seconda fase dell’operazione “Allied Force”, che prevedeva il concentramento degli attacchi sulle truppe serbe dislocate in Kosovo. Si prendeva coscienza del fatto che la “guerra psicologica” contro Belgrado non aveva sortito gli effetti sperati e si passava a quella che sarebbe dovuta essere la fase focale dell’intervento militare. Gli aerei erano stati fatti volare a 5000 metri da terra per evitare la contraerea serba e, a causa delle condizioni meteorologiche non buone, si cercò di evitare di far bombardare zone a rischio, per non provocare vittime civili. Ciò influì molto sul morale degli occidentali, che iniziavano ad avere dubbi sulla riuscita dell’operazione 409 . Il dibattito negli ambienti militari della NATO ferveva: a differenza di ciò che pensava Clark, il capo delle forze aeree della NATO Mike Short era nettamente contrario ad effettuare bombardamenti contro le truppe d’artiglieria serba, che avrebbe messo a rischio la vita degli uomini dell’Alleanza. Egli si rivelò invece più favorevole a colpire obiettivi sedi militari nevralgiche per il regime. Ad un certo momento l’inasprirsi dello scontro con il suo superiore lo portò a pensare seriamente di dare le dimissioni 410 . 405 Oksana Antonenko, Russia, NATO and European Security after Kosovo, “Survival, The IISS Quarterly”, vol. 41, n. 4, inverno 1999-2000, p. 133; Youngs, Oakes, Bowers, Operation “Allied Force”, cit., p. 11. 406 Press Conference by NATO Spokesman, Jamie Shea and Air Commodore David Wilby, SHAPE, NATO Headquarter, Bruxelles, 26 marzo 1999, <http://www.nato.int/kosovo/press/p990326a.htm>, consultato il 13 maggio 2003. 407 Youngs, Oakes, Bowers, Operation “Allied Force”, cit., p. 12; Clark, Waging Modern War, cit., pp.. 214215. 408 Statement by the Secretary general of NATO, Dr. Javier Solana, on the Initiation of a Broader Range of Air Operations in the Federal Republic of Yugoslavia, 27 marzo 1999, <http://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-044e.htm>, consultato il 13 maggio 2003. 409 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., p. 609. 410 Ivi, pp. 609-610. L’operazione militare, se da una parte veniva condotta direttamente dai vertici della NATO, dall’altra era coordinata dal comando di una “task force” del Pentagono, denominata “Noble Anvil”, attraverso la quale il presidente Clinton prendeva direttamente le decisioni più importanti. Secondo gli americani i fallimenti iniziali dell’operazione erano dovuti all’inefficienza degli armamenti messi a disposizione degli europei. Per questo, il Pentagono si prodigò per mettere in campo nuovi e più sofisticati armamenti di cui disponeva e che potevano sopperire alle difficoltà incontrate fino a quel momento 411 . In realtà, il problema non era quello dei mezzi militari, in ogni caso ampiamente sufficienti a superare la resistenza serba, quanto la reale volontà di utilizzarli. Edward Luttwak, componente di spicco del Centro di studi strategici internazionali di Washington, scrisse in un articolo apparso su Foreign Affairs: “la possibilità immediata di salvare migliaia di albanesi dal massacro e centinaia di migliaia dalla deportazione non voleva la vita di pochi piloti”412 . Il Pentagono vedeva in quel conflitto un “conflitto minore” e per questo non voleva rischiare uomini e mezzi 413 . La strategia di Milosevic, invece, era ben diversa: sebbene nei primi giorni di guerra fossero stati abbattuti dagli aerei NATO diversi Mig jugoslavi diretti verso la Bosnia con l’intento di attaccare le truppe della SFOR, l’obiettivo principale rimaneva quello di provocare l’esodo degli albanesi dal Kosovo. Gli orrori nella regione proseguivano incessantemente e coinvolgevano leader politici e militari dell’Uck, così come la popolazione civile. L’emergenza umanitaria scoppiò già all’inizio di aprile e raggiunse livelli impensati dai paesi occidentali: secondo un rapporto dell’UNHCR i rifugiati erano 262000414 . Il 7 aprile le autorità di Belgrado decisero di sigillare le frontiere con Macedonia ed Albania, costringendo i fuggiaschi ad accamparsi dove capitava, ma comunque in Kosovo. Molti di questi tornarono indietro verso i loro villaggi, secondo alcuni osservatori occidentali costretti dalle forze serbe, che li avrebbero utilizzati come scudi umani a protezione delle loro postazioni militari. La macchina umanitaria si attivò soltanto verso la metà di aprile per accogliere i fuggiaschi che erano riusciti a superare le frontiere con l’Albania e la Macedonia. Il conflitto ebbe ripercussioni anche sui mus ulmani che abitavano la zona del Sangiaccato e in più occasioni le forze internazionali in Bosnia furono poste in stato di allerta. Milosevic fu ammonito e minacciato numerose volte di incriminazione dal Tribunale dell’Aia 411 Clark, Waging Modern War, cit., p. 202. Luttwak, Give War a Chance, cit., pp. 40-41. 413 Clark, Waging Modern War, cit., p. 246. 414 Youngs, Oakes, Bowers, Operation “Allied Force”, cit., pp. 12-14; Christopher Layne, Collateral Damage in Yugoslavia, in Carpenter (a cura di), NATO’s Empty Victory, cit., p. 52; Indipendent International Commission on Kosovo, The Kosovo Report, cit., pp. 201-202. 412 insieme ai suoi esecutori, ma nonostante ciò l’Armata jugoslava gli rimase fedele, continuando nelle azioni di pulizia etnica 415 . Le immagini che provenivano dal Kosovo se non altro fornivano un ottimo mezzo propagandistico a disposizione dell’alleanza per sostenere la prosecuzione dell’intervento contro i serbi, e che convinsero una buona parte dell’opinione pubblica internazionale che l’occidente non potesse permettere quella barbarie 416 . Le polemiche di quel periodo infuocavano nell’opinione pubblica occidentale: i critici della guerra NATO sostenevano che il conflitto non aveva fatto che peggiorare la già critica situazione kosovara e puntavano il dito in particolare sugli Stati Uniti e sulla loro politica di potenza. Le critiche alla guerra voluta da Madeleine Albright iniziavano ad arrivare anche dallo stesso Pentagono, che accusava il Segretario di Stato di non aver calcolato le difficoltà di una guerra condotta contro un dittatore senza scrupoli417 . In campo kosovaro, invece, faceva discutere la posizione assunta da Ibrahim Rugova, il quale inviava, tramite i mezzi di comunicazione, messaggi che invitavano la NATO a sospendere i bombardamenti. In occidente si pensò che Rugova fosse ostaggio di Milosevic e che questo lo obbligasse a tenere un atteggiamento conciliante, cosa in seguito confermata. In realtà, però, egli aveva deluso i propri compatrioti ed era ormai un esponente di secondo piano nel movimento kosovaro: lo stesso Thaci escluse i membri del suo partito dal nuovo governo 418 . Il presidente del Montenegro Milo Djukanovic aveva da tempo dimostrato di essere contrario alla politica di Milosevic, impedendo alle sue truppe, attraverso la chiusura delle frontiere con la Serbia, di accedere alle postazioni militari nel suo territorio. Nonostante questo neanche la repubblica montenegrina fu risparmiata dai bombardamenti della NATO. Djukanovic manifestò così tutto il suo rammarico nei confronti dell’atteggiamento occidentale, trovatosi fra il fuoco di Milosevic che si muoveva per favorire un colpo di stato a Podgorica, e i bombardamenti della NATO sul suo paese 419 . I tragici avvenimenti che stavano avvenendo in Kosovo dettero la spinta per una nuova fase dell’azione militare: essa prevedeva di colpire, oltre agli obiettivi militari sui quali ci si era concentrati fino a quel momento, anche obiettivi civili e infrastrutture come sedi di ministero, ponti 415 Youngs, Oakes, Bowers, Operation “Allied Force”, cit., p. 14; Judah, Kosovo, cit., p. 255. Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., p. 612. 417 Youngs, Oakes, Bowers, Operation “Allied Force”, cit., p. 57; Roberts, Next Balkan Flashpoint?, cit., p. 114; Rubin, A Very Personal War, parte II: The Promise of Freedom, cit., p. IX. 418 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., pp. 613-614. 419 Youngs, Oakes, Bowers, Operation “Allied Force”, cit., p. 18. 416 e raffinerie, in modo da rendere complicati all’esercito serbo le comunicazioni e l’approvvigionamento 420 . Il 3 aprile fu bombardato il palazzo del ministero degli Interni a Belgrado, episodio che segnò l’inizio degli attacchi su obiettivi civili anche sulla capitale. La decisione fu presa direttamente da Solana, per evitare di sottoporre la questione a procedure decisionali che l’avrebbero messa in discussione. Egli in realtà agì su ordine degli Stati Uniti, che ritenevano necessaria quella fase, anche se in molti paesi europei quella scelta suscitò i soliti malcontenti che però non sfociarono in opposizione forte e concreta alla linea intrapresa 421 . Semmai, la nuova fase del conflitto destò più violente proteste nell’opinione pubblica di tanti paesi. Erano in molti a chiedersi che senso avesse bombardare obiettivi civili a Belgrado, come in altre città della Serbia, rischiando di provocare vittime civili, quando in Kosovo, come le immagini dimostravano, la situazione umanitaria era sempre più drammatica. Allora perché non concentrarsi maggiormente sull’attacco alle forze serbe in Kosovo? Più avanti si andava nei giorni con i bombardamenti e più ci si rendeva conto, proprio negli ambienti militari, che se Milosevic avesse continuato a resistere, per riuscire davvero a garantire ai kosovari il ritorno nelle proprie case sarebbe risultata necessaria un’azione diversa: oltre che l’utilizzo degli elicotteri Apache, in grado di bombardare volando a basse quote, si iniziava a pensare anche ad un intervento delle truppe di terra. Proprio dagli ambienti della NATO, già nei primi giorni di aprile, trapelavano notizie sullo studio di un progetto per l’impiego di un’opzione del genere, che fu ipotizzata per i primi di maggio, proprio da Wesley Clark, il quale era favorevole ad un ingresso di truppe dall’Albania 422 . In verità, il 24 marzo, nel discorso alla nazione sull’inizio dei bombardamenti in Kosovo, Clinton aveva dichiarato: “le nostre truppe prenderanno parte in quella missione per il mantenimento della pace. Ma non intendo impiegare le nostre truppe in Kosovo a combattere una guerra”423 . Era evidente, infatti, che nonostante nello stesso discorso Clinton avesse affermato: “Porre fine a questa tragedia è un imperativo morale. E’ importante anche per l’interesse nazionale dell’America”424 , il conflitto in oggetto, come abbiamo detto, veniva considerato dall’establishment americano di secondaria importanza. In un successivo momento, alla luce degli eventi bellici, il presidente americano sembrò non escludere una tale ipotesi con l’impegno di truppe americane. Per non allarmare il Pentagono né il 420 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., pp. 617-618. Rubin, A Very Personal War, parte II: The Promise of Freedom, cit., p. IX. 422 Clark, Waging Modern War, cit., pp. 263, 300, 343. 423 William J. Clinton, Address to the Nation on Airstrikes Against Serbian Targets in the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro), 24 marzo 1999, in Public Papers of the Presidents of the United States: William J. Clinton: 1999, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1999, vol. 1, p. 452. 424 Ivi, p. 451. 421 Congresso, però, egli non intendeva far trapelare queste notizie 425 . Le dichiarazioni ufficiali dell’Alleanza, per questo, non confermavano, tanto che il portavoce NATO Jamie Shea, alle domande dei giornalisti sull’argomento dichiarava: “Sappiamo che ulteriori 8000 uomini jugoslavi sono stati inviati in Kosovo nelle ultime settimane. Questo dimostra quanto sia difficile per Belgrado cercare di mantenere l’area sotto controllo, ma per quanto riguarda le truppe di terra NATO, no, la politica è l’unica che sapete ed è quella da continuare per portare la violenza ad una fine usando i nostri mezzi aerei e di impiegare in seguito una forza internazionale di sicurezza”426 . I più propensi all’intervento via terra erano gli inglesi, convinti che se si fosse fatta comprendere a Milosevic l’intenzione dell’Alleanza per questa eventualità, probabilmente egli avrebbe rinunciato a resistere anche ai bombardamenti. Nell’amministrazione americana, Madeleine Albright era più vicina alle posizioni inglesi e grazie a questo gli attriti fra Washington e Mosca sull’argomento furono presto sedati427 . La Russia, dal canto suo, naturalmente non manifestava favore ad un’ipotesi del genere. Ad alcune dichiarazioni bellicose che fecero temere per lo scoppio di una guerra ben più grande, fecero seguito le tranquillizzazioni di Mosca sul fatto che il suo impegno sarebbe rimasto forte, ma solo sul piano diplomatico e politico, ma non militare 428 . Tutte le trattative diplomatiche dall’inizio della guerra, molto deboli per la verità, fallirono inesorabilmente. La NATO, così, sorpresa dalla resistenza serba decise, dopo tre settimane di bombardamenti, di agire con ulteriore maggior determinazione. La campagna aerea si intensificò, con voli senza interruzioni che portassero a bombardare un maggior numero di obiettivi. Vennero colpiti sistematicamente i ponti sul Danubio, le industrie principali del paese, centrali elettriche, raffinerie, nella prospettiva di intaccare il morale della popolazione serba e farla insorgere contro Milosevic. Si abbandonava in qualche modo la politica che aveva visto l’Alleanza cercare di limitare al massimo le vittime civili; in questa nuova fase si iniziarono ad utilizzare bombe più convenzionali e non più quelle “intelligenti” impiegate fino a quel momento 429 . Il 6 aprile un missile cadde sulla cittadina di Aleksinac, provocando la morte di 17 persone e il ferimento di molte altre. Il 12 aprile durante un attacco sferrato ad una linea ferroviaria fu colpito un treno passeggeri e i morti furono molti, 55 secondo fonti serbe e 10 secondo quelle della NATO. 425 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., p. 621. Press Conference by Jamie Shea and Brigadier General Giuseppe Marani, NATO Headquarter, Bruxelles, 19 aprile 1999, <http://www.nato.int/kosovo/press/p990419a.htm>, consultato il 14 maggio 2003. 427 Rubin, A Very Personal War, parte II: The Promise of Freedom, cit., p. IX; Judah, Kosovo, cit., p. 270. 428 Youngs, Oakes, Bowers, Operation “Allied Force”, cit., p. 21. 429 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., p. 625 426 Il 14 aprile in Kosovo, colonne di profughi albanesi furono scambiate per unità delle forze serbe e furono colpite: vi rimasero uccise 75 persone 430 . Il 12 aprile Madeleine Albright incontrò a Bruxelles alcuni esponenti dell’Uck e lo stesso giorno trapelò la notizia secondo la quale gli Stati Uniti avevano iniziato negoziati segreti per armare l’organizzazione. La decisione era probabilmente mirata a dare una spinta decisiva al conflitto via terra, considerato che l’opzione dell’invio di fanteria non raccoglieva i necessari consensi in occidente 431 Tali notizie furono ampiamente utilizzate dalla propaganda belgradese per convincere l’opinione pubblica mondiale del torto che la Serbia stava subendo. La NATO decise allora di colpire i centri nevralgici del potere e, dopo aver bombardato i ripetitori della televisione di Belgrado e il palazzo sede del Partito socialista di Milosevic, il 23 aprile prese di mira la sede del ministero dell’Informazione, causando la morte di 16 fra giornalisti e tecnici. L’episodio suscitò enorme scalpore, anche per le indiscrezioni, apparse sui giornali, secondo cui le autorità serbe sarebbero state informate di quell’attacco, ma non avrebbero avvertito le persone che erano in quell’edificio 432 . Gli eventi di quei giorni, dopo aver portato alla luce tutti gli orrori che avvenivano in Kosovo, mettevano in risalto l’escalation coercitiva della NATO nella scelta operata di ricorrere a bombardamenti più duri. Manifestazioni di piazza si tennero a Belgrado. Molte persone riversate nelle vie della città, difendevano come scudi umani gli obiettivi a rischio di bombardamento. In molti, anche in occidente, iniziavano a rendersi conto che, sebbene Milosevic attuasse una politica oppressiva e nazionalistica, era la povera gente la vittima maggiore, non solo delle mosse di Milosevic, ma anche della guerra 433 . Mentre le operazioni militari continuavano senza tregua, dal 23 al 25 aprile si tenne a Washington un vertice per celebrare i cinquant’anni di vita della NATO. La data probabilmente fu scelta credendo che la guerra sarebbe già stata conclusa e invece le difficoltà incontrate fecero svolgere il summit sottotono, in un clima decisamente teso. Il presidente francese Jacques Chirac minacciò di lasciare il summit per protesta contro il metodo attraverso cui si era deciso di allargare gli obiettivi serbi da colpire. Se egli avesse davvero lasciato il vertice l’Alleanza avrebbe mostrato a Milosevic tutte le sue spaccature, incoraggiandolo oltremodo a resistere. Fortunatamente, non senza polemiche, il vertice proseguì. Fu approvato un documento che accettava unanimemente il ruolo 430 Ibidem Tim Butcher, US Opens Secret Talks on Arming KLA, “Daily Telegraph”, 12 aprile 1999, <http://www.telegraph.co.uk/htmlContent.jhtml?html=%2Farchive%2F1999% 2F04%2F12%2Fwkos112.html&secureR efresh=true&_requestid=354482>, consultato il 15 maggio 2003. 432 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., p. 626; Philip M. Taylor, Propaganda and the Web War, “The World Today”, giugno 1999, p. 10; Youngs, Oakes, Bowers, Operation “Allied Force”, cit., pp. 22, 24. 433 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., pp. 626-627. 431 “interventista” della NATO al di fuori dei paesi che la compongono, nell’ambito delle operazioni atte a garantire la pace e la sicurezza. Nell’evidente ricerca di un compromesso si giunse anche alla conclusione che la scelta di intraprendere operazioni militari da parte dell’organizzazione senza l’avallo delle Nazioni Unite era ritenuto possibile soltanto in casi eccezionali 434 . In questo contesto, passi avanti da parte dell’Alleanza furono compiuti attraverso la scelta di coinvolgere maggiormente la Russia nel processo diplomatico. Mosca, tra l’altro, aveva bisogno di un rilancio a livello internazionale. L’establishment statunitense, inoltre, era sempre più orientato a non correre il rischio dell’impiego delle truppe di terra. Dopo un mese di operazioni militari, però, si iniziava anc he a rendersi conto che non era possibile pensare ad una resa incondizionata della Serbia. I danni dei bombardamenti ricadevano in prevalenza sulla popolazione, senza riuscire a piegare definitivamente la resistenza del vozd. La guerra stava anche provocando continui dissidi fra gli alleati e questo rafforzava l’idea di condurre la crisi ad una conclusione: solo da quel momento si pensò di impostare le iniziative diplomatiche con più elasticità di quanto era avvenuto a Rambouillet 435 . Il 22 aprile, proprio l’ex primo ministro russo Viktor Cernomyrdin, nominato rappresentante speciale del presidente El’cin nei colloqui, per il suo orientamento filoccidentale, incontrò Milosevic in una Belgrado sotto i bombardamenti e ridotta senza luce e senza acqua. Alla fine del colloquio emerse la volontà del presidente serbo di accettare una forza internazionale in Kosovo, purché agisse sotto l’egida delle Nazioni Unite. Le diplomazie occidentali, nel frattempo, cercavano di comprendere quanto Milosevic fosse più disponibile al dialogo dopo un mese di bombardamenti e quanto perseverare nell’azione militare sarebbe servito a farlo cedere definitivamente. Il presidente serbo dal canto suo, nell’intento di ottenere il massimo da quella situazione, cercava di capire quali fossero le motivazioni che portavano gli alleati a dare maggiore spazio alla diplomazia. Egli, in ogni caso, compì un altro gesto distensivo: a Belgrado ricevette il reverendo americano Jesse Jackson, impegnato in iniziative di pace, al quale rilasciò tre soldati americani catturati il 31 marzo sulla frontiera fra la Macedonia e il Kosovo. Nel contempo, inviò una lettera al presidente Clinton, chiedendogli un incontro personale e ammettendo i crimini commessi nei mesi precedenti, pur addossandone la responsabilità alle milizie paramilitari serbe e scagionando, quindi, le truppe regolari jugoslave 436 . 434 Ivi, p. 627; Rodman, Peter, W., The Fallout from Kosovo, “Foreign Affairs”, vol. 78, n. 4, giugno/agosto 1999, p. 47-48; Carpenter, Kosovo as an Omen, cit., pp. 173-174; Daalder, NATO and the 21st Century, cit., p. 25; Youngs, Oakes, Bowers, Operation “Allied Force”, cit., p. 26. 435 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., pp. 628, 629. 436 Youngs, Oakes, Bowers, Operation “Allied Force”, cit., pp. 16, 29; Clark, Waging Modern War, cit., p. 286. Tra la fine del mese di aprile e l’inizio di maggio si tennero stretti colloqui fra i vertici statunitensi e quelli russi, ai quali parteciparono le più alte cariche dei due paesi, Clinton e il vicepresidente Gore da una parte e El’cin, Chernomyrdin e Ivanov dall’altra. Gli intensi incontri rafforzarono le relazioni fra Washington e Mosca e costituirono il punto di partenza per giungere alla risoluzione della crisi. Per formulare la proposta di compromesso fu deciso di investire il vertice dei paesi più industrializzati del mondo che si sarebbe tenuto il 6 maggio a Bonn, in Germania 437 . In quell’occasione i ministri degli esteri dei paesi componenti il G8 si accordarono su un documento di base: esso prevedeva un’immediata cessazione dei combattimenti nel Kosovo, con il ritiro delle forze serbe, ma anche la smilitarizzazione dell’Uck e il passaggio della provincia sotto il controllo di una “presenza internazionale civile e di sicurezza”. Non si citava la NATO, ma le Nazioni Unite nella creazione di un’”amministrazione ad interim” per la pacificazione del Kosovo e il ritorno nelle proprie case dei profughi 438 . Il documento, sebbene risultasse evasivo nei punti più controversi, rappresentava comunque un passo avanti nella ricerca di una soluzione per la crisi, soprattutto nella questione delle truppe internazionali. Inoltre, all’accordo aveva partecipato anche la Russia, che durante il conflitto, fino a quel momento si era manifestata critica nei confronti della NATO, anche se più in maniera formale che sostanziale. In questo modo Milosevic non aveva più vie d’uscita e se non si fosse dimostrato disponibile ad una soluzione mediata sarebbe rimasto una volta di più isolato 439 . Gli Stati Uniti, in quel periodo, decisero di intensificare ulteriormente il proprio contributo militare alle operazioni NATO e consentirono quindi un’intensificazione dei raid. Uno dei motivi che li spinse a compiere questa scelta fu quello di non dare a Milosevic la sensazione che l’occidente fosse spaccato e non fargli sperare che le concessioni sarebbero potute essere maggiori. L’incremento dei voli e dei bombardamenti condusse ad un’inevitabilmente crescita negli incidenti: il I maggio un caccia F-16 dell’aeronautica americana fu abbattuto e i piloti furono ancora una volta salvati dalla cattura, mentre gli errori compiuti nei raid su obiettivi civili causarono numerose vittime 440 . L’obiettivo della NATO, a quel punto, era quello di arrivare prima possibile all’epilogo del conflitto e in questa logica vanno inquadrate le massicce incursioni di quei giorni. Vennero 437 Judah, Kosovo, cit., p. 275. Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 1244/99, Annex 1: Statement by the Chairman on the conclusion of the meeting of the G-8 Foreign Ministers held at the Petersberg Centre on 6 May 1999, 10 giugno 1999, <http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/172/89/PDF/N9917289.pdf?OpenElement>, consultato il 15 maggio 2003. 439 John Mackinlay, Ready for Kosovo?, “The World Today”, vol. 54, n. 6, giugno 1999, p. 4; McGwire, Why Did We Bomb Belgrade?, cit., p. 11. 440 International Institute for Strategic Studies, Air-Power over Kosovo: A Historic Victory?, “Strategic Comments”, vol. 5, n. 7, settembre 1999, pp. 1-2; Pirjevec, Le guerre jugoslave, cit., pp. 630-631. 438 impiegate, tra l’altro, armi sempre più potenti: suscitò clamore l’utilizzo delle pesantissime bombe alla grafite, che nei bombardamenti contro le centrali elettriche garantivano blackout totali, oltre che liberare sostanze cancerogene. Già molte polemiche aveva suscitato l’impiego in Kosovo di armi all’uranio impoverito in grado di distruggere la corazza dei carri armati: questa sostanza aveva già causato la “sindrome del Golfo”, nome preso dalle malattie, soprattutto leucemiche, di cui i soldati statunitensi impiegati nella guerra del Golfo furono vittima. Non si escludeva, tra l’altro, che tali armi fossero state usate anche in Bosnia 441 . Tuttavia, l’incidente più grave dal punto di vista diplomatico fu quello che avvenne il 7 maggio, quando tre ordigni a guida satellitare colpirono l’ambasciata della Cina a Belgrado: nell’esplosione persero la vita tre giornalisti cinesi e rimasero ferite altre venti persone, fra le quali alcuni diplomatici di Pechino. L’episodio rischiò di mettere a repentaglio le già fragili relazioni fra Cina e Stati Uniti, oltre che di turbare l’ordine internazionale. Manifestazioni antiamericane si tennero in successione in tutta la Cina e costrinsero Clinton a rivolgere “scuse e condoglianze al presidente Jiang Zemin e a tutto il popolo cinese” precisando che in ogni caso che si era trattato di “un isolato, tragico evento”442 . La versione ufficiale dei fatti spiegò che l’errore era avve nuto perché le carte a disposizione della CIA segnalavano nell’edificio, dove in realtà risiedeva l’ambasciata della Cina, la presenza della direzione jugoslava di approvvigionamento dell’esercito. Altre versioni furono date sull’accaduto: una di queste vedeva l’attacco NATO mirato a colpire un centro di ascolto e comunicazione messo a disposizione della Serbia dai cinesi per garantire loro le comunicazioni con le truppe in tutto il paese (essendo stati distrutti quelli di proprietà del regime) e per avvertire degli attacchi che avvenivano sulla città. Un’altra ancora voleva la presenza di un uomo di Milosevic fra quelli dell’intelligence americana a Belgrado, il quale aveva volutamente orchestrato l’episodio per screditare l’Alleanza. Secondo Belgrado, inve ce, l’azione era stata deliberatamente architettata dai “falchi” americani per far fallire ogni ipotesi di soluzione diplomatica con il coinvolgimento delle Nazioni Unite. Più o meno della stessa versione era convinta Pechino, che intanto protestava in tut te le sedi contro quello che giudicava un “deliberato atto di guerra” nei suoi confronti443 . Malgrado questo episodio, la violenza dell’Alleanza comunque non si placò, e verso la fine di maggio la frequenza dei bombardamenti fu intensificata ulteriormente. Inoltre, il 24 maggio, il procuratore generale del Tribunale dell’Aia Louise Arbour, presa visione dei documenti che le 441 Pirjevec, Le guerre jugoslave, cit., p. 631; Christine Abdelkrim-Delanne, Ces armes si peu conventionelles, “Le Monde Diplomatique”, giugno 1999, p. 11. 442 Clark, Waging Modern War, cit., pp. 296-297; William J. Clinton, Remarks at the White House Strategy Meeting on Children, Violence, and Responsibility, 10 maggio 1999, in Public Papers of the Presidents of the United States: William J. Clinton: 1999, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1999, vol. 1, p. 733. 443 Carpenter, Damage to Relations with Russia and China, cit., pp. 83, 90. erano giunti dai governi occidentali, emise un mandato di comparizione nei confronti di Milosevic e di altri quattro esponenti del regime di Belgrado, accusandoli di crimini di guerra e contro l’umanità. Questo gesto fu interpretato come una mossa del Tribunale stesso per evitare che nelle future trattative di pace potesse rientrare anche una sorta di amnistia per Milosevic, dopo che per tutto il conflitto si era evitato di emettere provvedimenti nei suoi confronti. La scelta del Tribunale in un momento così delicato rischiò di provocare la resistenza un’ancor più strenua resistenza da parte della Serbia e la complicazione delle trattative diplomatiche 444 . 3.8 L’epilogo del conflitto e la conclusione diplomatica Proseguivano intanto, sulla base del documento approvato alla riunione del G8 di Bonn, le trattative diplomatiche, alle quali iniziò a partecipare, per incarico dell’Unione Europea, il presidente della Finlandia Martti Ahtisaari, considerato un ottimo mediatore e già impegnato nei Balcani come collaboratore di Vance e Owen fra il ’92 e il ’93. Egli si occupò, dalla seconda metà di maggio, in colloqui con Cernomyrdin e il sottosegretario di Stato americano Strofe Talbott. Il problema di fondo rimaneva quello delle truppe internazionali: Madeleine Albright si manifestava ferma nell’idea che sarebbero dovute essere poste sotto il comando della NATO, mentre Milosevic si mostrava nettamente contrario ad accettare l’autorità di un organismo che ancora stava compiendo operazioni militari contro il suo paese 445 . Un segnale importante per la mediazione fu dato dal presidente russo El’cin, il quale, attento a tenere saldi i rapporti, soprattutto economici, con Washington, destituì dalla carica di primo ministro Evgenij Primakov, da sempre critico nei confronti della politica estera americana 446 . Nell’ambito delle ottime sinergie esistenti in quel momento fra i governi degli Stati Uniti e della Russia, venne trasmesso un messaggio congiunto a Milosevic, nel quale si minacciava l’invasione del Kosovo da parte delle truppe della NATO e nel quale Mosca affermava la propria volontà, se egli avesse persistito nella sua rigidità, di avallare in Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite l’azione dell’Alleanza 447 . 444 Youngs, Oakes, Bowers, Operation “Allied Force”, cit., pp. 52-53; International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, The Prosecutor of the Tribunal Against Slobodan Milosevic, Milan Milutinovic, Nikola Sainovic, Dragoljub Ojdanic, Vlajko Stojiljkovic, The Hague, The Nederlands, 24 maggio 1999, <http://www.un.org/icty/indictment/english/mil-ii990524e.htm>, consultato il 16 maggio 2003; Judah, Kosovo, cit., pp. 280-281. 445 Judah, Kosovo, cit., p. 275. 446 Levitin, Inside Moscow’s Kosovo Muddle, cit., p. 137. 447 Rubin, A Very Personal War, parte II: The Promise of Freedom, cit., p. IX. In effetti in quei giorni si stavano intensificando i segnali che portavano a prospettare l’ipotesi dell’utilizzo delle truppe di terra. I paesi della NATO rafforzavano il contingente delle truppe presenti già in Macedonia portandolo a 50000 unità, mentre la strada di collegamento fra Durazzo e Kukes, la città di frontiera fra Albania e Kosovo, era in corso di ampliamento. In realtà, si trattò soltanto di fare ulteriore pressione psicologica su Milosevic, affinché egli si piegasse al tavolo delle trattative 448 . Il 28 maggio Milosevic, a seguito di un incontro con Cernomyrdin, espresse la sostanziale accettazione al piano formulato dal G8. Esso prevedeva, rispetto al progetto di Rambouillet, due importanti differenze: le truppe NATO che si sarebbero dispiegate in Kosovo non avrebbero avuto libertà di movimento, se non in una fascia di cinque chilometri sul confine fra il Kosovo e la Serbia, mentre si garantiva il coinvolgimento delle Nazioni Unite nel governo della provincia 449 . Le rapidità con la quale Milosevic accettò quel compromesso sorprese gli stessi mediatori. Le ragioni che lo portarono a quella decisione sono probabilmente da ricercare nelle difficoltà serie con le quali il presidente si stava scontrando. Innanzitutto la sua speranza che l’alleanza atlantica si sarebbe sfaldata fu delusa: la pressione che si cercò di fare sia da un punto di vista militare sia da quello psicologico, riuscì, anche se con maggiori difficoltà del previsto. Inoltre, un reale appoggio da parte del governo di Mosca alla Serbia non arrivò mai. La coalizione impiegò alcune fra le più potenti armi di cui possedeva e fu in grado di intraprendere durante il conflitto in media 300 bombardamenti al giorno. Il paese in questo modo, dopo più di due mesi di guerra, si trovò in ginocchio, colpito duramente nelle sue comunicazioni e infrastrutture energetiche, civili e industriali. Inoltre, l’esercito dell’Uck, favorito dai bombardamenti e dagli aiuti americani, era adesso in grado di preoccupare seriamente le truppe serbe in Kosovo. Per di più, la popolazione serba, stremata dai bombardamenti, iniziava a dare segni di insofferenza nei confronti del regime, che stava perdendo consensi450 . Nonostante l’intesa fosse stata ormai raggiunta l’Alleanza continuò a bombardare, scettica sulle mosse di Milosevic. Il 7 giugno, nel corso di uno scontro fra forze serbe e Uck nei pressi della frontiera con l’Albania, le forze della NATO colpirono pesantemente con i raid le truppe di Belgrado, inferendo loro un durissimo colpo: 224 furono i soldati uccisi in quell’occasione 451 . Il 9 giugno fu dunque firmato fra il generale Michael Jackson, comandante della forza multinazionale della NATO denominata KFOR (Kosovo Force), che ormai stazionava da tempo in 448 Judah, Kosovo, cit., pp. 210-211. Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., p. 635. 450 Barry R. Posen, The War for Kosovo: Serbia’s Political-Military Strategy, “International Security”, vol. 24, n. 4, primavera 2000, pp. 72-73, 76; Judah, Kosovo, cit., pp. 254, 282; International Institute for Strategic Studies, AirPower over Kosovo, cit., pp. 1-2. 451 Judah, Kosovo, cit., p. 284. 449 Macedonia, e i comandanti dell’esercito jugoslavo, l’accordo di base che prevedeva il totale abbandono del Kosovo da parte delle forze serbe entro 11 giorni. La KFOR sarebbe stata composta da 50000 uomini suddivisi in cinque zone di controllo sotto il comando di Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia 452 . Il giorno dopo il presidente americano Clinton poteva annunciare in un messaggio trasmesso alla nazione: “Stasera per la prima volta in 79 giorni i cieli sopra la Jugoslavia sono in silenzio. L’esercito e la polizia serba si stanno ritirando dal Kosovo. Il milione di uomini, donne e bambini costretti ad uscire dal proprio paese si sta preparando a ritornare a casa”453 . Solo in quel momento Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite approvò una risoluzione, la 1244, che autorizzava l’operazione delle truppe internazionali della NATO in Kosovo con l’obiettivo di pacificare l’area. La risoluzione, inoltre, richiedeva al Segretario Generale di istituire una speciale amministrazione ad interim per organizzare la gestione politica della provincia, che in seguito prese il nome di UNMIK (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo). Nel testo approvato si faceva riferimento a tutti i principi raggiunti con l’accordo del vertice del G8 di Bonn, inserito come annesso all’interno della risoluzione 454 . Il coinvolgimento di Pechino nella decisione vide l’astensione in Consiglio di Sicurezza della Cina, che in cambio chiese e ottenne l’inserimento nella risoluzione di un chiaro riferimento al ruolo che le Nazioni Unite avrebbero mantenuto nelle crisi internazionali, clausola che gli Stati Uniti furono costretti ad accettare a malincuore 455 . L’ipotesi che alcuni giuristi vicini agli stati che intrapresero l’azione bellica sostennero, riguardo il fatto che la risoluzione 1244 avrebbe significato un’autorizzazione a posteriori da parte delle Nazioni Unite all’operazione della NATO, ammettendo dunque il vizio sulla mancata autorizzazione del Consiglio su di essa, non trova fondamento. La risoluzione, infatti, non presentava alcun esplicito riferimento all’intervento NATO in Kosovo. Il fatto che fosse stata approvata una risoluzione che guardava avanti rispetto alla situazione creatasi in Jugoslavia dimostrerebbe semmai l’ipotesi del ripristino di una legalità precedentemente violata. Inoltre, in quest’analisi, non va trascurato che la Russia e la Cina avevano avanzato, pochi giorni dopo l’inizio dei bombardamenti, una risoluzione di esplicita condanna nei confronti dell’intervento militare 456 . 452 Posen, The War for Kosovo, cit., pp. 77-78. William J. Clinton, Address to the Nation on the Military Technical Agreement on Kosovo, 10 giugno 1999, in Public Papers of the Presidents of the United States: William J. Clinton: 1999, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1999, vol. 1, p. 913. 454 Consiglio di Sicure zza delle Nazioni Unite, Risoluzione n, 1244/99, 10 giugno 1999, <http://ods-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/172/89/PDF/N9917289.pdf?OpenElement>, consultato il 15 maggio 2003. 455 Indipendent International Commission on Kosovo, The Kosovo Report, cit., pp. 99, 163. 456 Palmisano, La guerra “umanitaria”, cit., pp. 169-170. 453 Riguardo la questione delle truppe internazionali, trattative parallele si erano svolte fra i governi di Mosca e Washington su una possibile integrazione delle truppe NATO con soldati russi. Gli Stati Uniti si opposero fermamente a questa ipotesi, temendo che avrebbe potuto portare a una spartizione del Kosovo. Per questo motivo, i russi, sempre in quel periodo, condussero attraverso alti responsabili dell’esercito, contatti con Milosevic. L’accordo segreto raggiunto fra i servizi segreti di Mosca e quelli di Belgrado prevedeva l’occupazione da parte dell’esercito russo della città di Pristina e di tutta la zona nord-occidentale, ricca di miniere e di santuari ortodossi, dove si sarebbero radunati tutti i serbi abitanti nella regione, sancendo così una sorta di unificazione di una parte del Kosovo con la Serbia. Questo fu probabilmente uno dei motivi che indussero maggiormente il presidente serbo ad accettare le truppe internazionali 457 . Tutto ciò fu confermato dalla realtà dei fatti: già l’11 giugno, circa duecento soldati russi dispiegati nell’ambito delle forze SFOR in Bosnia, furono spediti a Pristina, dove furono accolti dai serbi come dei liberatori. Essi occuparono l’aeroporto della città per consentire lo sbarco di 10000 commilitoni che si sarebbero insediati nell’area. L’episodio lasciò sbigottito tutto l’occidente, deciso a non permettere che quella zona finisse sotto controllo dei russi. La tensione in quei giorni fu fortissima, tanto da far temere uno scontro fra le forze della NATO e quelle di Mosca: soltanto il rifiuto da parte del generale Michael Jackson all’ordine di Wesley Clark di utilizzare gli elicotteri Apaches per bloccare la pista di atterraggio dell’aeroporto evitò uno scontro fra colossi. Il governo degli Stati Uniti chiese ed ottenne dai governi di Ungheria, Bulgaria e Romania di non permettere ad aerei russi il sorvolo del loro territorio. In questo modo essi, disponendo di razioni alimentari per soli due giorni, furono costretti a trattare: riuscirono comunque ad ottenere che l’aeroporto di Pristina rimanesse nelle loro mani, mantenendo in Kosovo 3600 uomini in tutto, dislocati anche nelle aree sotto il comando delle altre nazioni, che intanto avevano iniziato a far affluire le proprie truppe nella regione 458 . 3.9 Il Kosovo dopo il conflitto e considerazioni finali Alla fine del conflitto, secondo le stime dell’UNHCR, un totale di circa 848100 albanesi furono espulsi o fuggirono dal Kosovo, dei quali 444600 si diressero verso l’Albania, 244500 verso la Macedonia e altri 69900 verso il Montenegro. Fra questi, poco più di 91000 furono accolti da 29 457 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., p. 637. Carpenter, Damage to Relations with Russia and China, cit., p. 81; Clark, Waging Modern War, cit., pp. 376-379, 394-402; Levitin, Inside Moscow’s Kosovo Muddle, cit., p. 138; Judah, Kosovo, cit., p. 284. 458 paesi nell’ambito del “Programma Umanitario di Evacuazione”. Almeno 67000, ma probabilmente più del doppio furono le case della regione distrutte o seriamente danneggiate durante il conflitto. Il controesodo di massa che ebbe luogo, assunse dimensioni impressionanti già dal momento in cui le truppe internazionali fecero il loro ingresso in Kosovo e nel giro di tre settimane vide il ritorno nelle proprie città di più di 600000 persone, risultando essere uno dei più grandi della storia moderna 459 . Nello stesso periodo circa 180000 persone di etnia serba e rom fuggirono nella direzione opposta, verso la Serbia 460 . Alla fine del 2000 si calcolava che fossero 250000 i rifugiati dal Kosovo di quelle etnie 461 . La tragedia che si era compiuta nei confronti degli albanesi, dunque, non era destinata a chiudersi: nonostante le assicurazioni che provenivano dall’occidente sul fatto che da quel momento il compito delle forze internazionali sarebbe stato quello di garantire anche la sicurezza dei serbi, i proclami di vendetta iniziarono ancor prima della conclusione degli accordi di pace e la messa in pratica di ciò non tardò ad arrivare 462 . Le forze internazionali non furono in grado, nel primo periodo d’insediamento, di mantenere la sicurezza in una situazione di sostanziale anarchia, caratterizzata dal caos generale; l’Uck, tra l’altro, era ancora forte di almeno 20000 uomini carichi di rabbia nei confronti dei serbi ed intenzionati ad accaparrarsi la gestione del paese in competizione per questo con il partito di Ibrahim Rugova. Non solo: la presenza nella regione delle truppe russe suscitava nel movimento intenzioni bellicose nei confronti di quelli che venivano considerati gli alleati dei serbi463 . In quello scenario, il primo problema che la nuova amministrazione provvisoria si trovò ad affrontare fu quello di una rapida smilitarizzazione dell’Uck. Così, attraverso l’impegno dell’intelligence americana e inglese ed i contatti che queste condussero con l’organizzazione, si raggiunse un accordo che prevedeva la smilitarizzazione dei suoi uomini e il loro contestuale reclutamento in un corpo di polizia di nuova costituzione. La soluzione, però, fu soltanto parzialmente applicata dall’Uck, essendo non condivisa da alcuni dei suoi esponenti, e la rese in una certa misura vana, tanto che le stesse fonti ufficiali della KFOR dichiararono soltanto il 20 settembre quale data della completata smilitarizzazione 464 . Un altro grosso problema che l’amministrazione delle Nazioni Unite era quello della ricostruzio ne. Per quanto riguardava la Serbia l’occidente non era assolutamente intenzionato ad 459 United Nations High Commissioner for Refugees, Kosovo Statistics, “Refugees”, vol. 3, n. 116, 1999, p. 11. Per i traumi subiti dalla popolazione vedi tra gli altri: Natale Losi, Luisa Passerini, Silvia Salvatici (a cura di), Archives of Memory: Supporting Traumatized Communities through Narration and Remembrance, “Psychosocial Nootebook”, vol. 2, October 2001. 460 Ibidem. 461 Osservatorio sui Balcani, Dossier RFY (Serbia e Montenegro), <http://www.unimondo.org/balcani/dossier/serbia/index-2000.html >, consultato il 18 maggio 2003. 462 Schmidt, Teaching the Wrong Lesson in Kosovo, cit., p. 22. 463 Indipendent International Commission on Kosovo, The Kosovo Report, cit., p. 104. 464 Rubin, A Very Personal War, parte II: The Promise of Freedom, cit., p. IX; KFOR Objective/Mission, <http://www.nato.int/kfor/kfor/objectives.htm>, consultato il 16 maggio 2003. aiutare Milosevic in questo. Si auspicava, anzi, che il paese voltasse pagina impegnandosi in riforme democratiche ed economiche. Soltanto dopo che Milosevic fu sconfitto, nel settembre del 2000, dal suo ex alleato Vojislav Kostunica, il processo di democratizzazione del paese iniziò a fare pur lenti passi in avanti e con esso ebbe luogo anche l’ammorbidimento delle sanzioni economiche e il reintegro della Serbia nelle organizzazioni internazionali. La collaborazione della Serbia con la comunità internazionale è divenuta da allora molto più salda, come dimostra l’arresto a Belgrado dello stesso Milosevic e la sua consegna nel giugno del 2001 al Tribunale Internazionale per i Crimini nell’ex Jugoslavia. Il processo di rinnovamento va avanti però non senza ostacoli: il 12 marzo 2003 è stato ucciso il primo ministro serbo Zoran Djindjic, probabilmente colpito dalla mafia belgradese, episodio che conferma la forza di cui ancora dispongono gli elementi antidemocratici e nazionalisti nel paese 465 . Dall’altra parte la ricostruzione del Kosovo ripartiva da mille difficoltà, dal un punto di vista delle istituzioni, ma soprattutto da quello strutturale. La comunità internazionale si era accollata l’arduo compito di dare una certezza a tanta gente alla quale era stato sottratto tutto e che aveva subito violenze nelle sfere più intime. Il problema più grave, però, rimase quello di garantire a tutti la sicurezza. I serbi erano presenti in piccole comunità in tutto il Kosovo, anche se costretti per la maggior parte a vivere nel nord del paese o addirittura in Serbia. Le vendette, nella regione a maggioranza albanese, furono all’ordine del giorno: con le dovute proporzioni furono i serbi adesso a dover subire le angherie da parte degli albanesi così tanto sottomessi nei mesi precedenti. Le stesse parole del generale Jackson nei mesi successivi al conflitto delineano molto bene la situazione: “Due torti non fanno una ragione nella cultura dell’Occidente, ma la fanno sicuramente nei Balcani” 466 . A tutt’oggi la forza internazionale della NATO composta da circa trenta paesi (della NATO e non) è presente in Kosovo. Notevoli passi in avanti sono stati compiuti grazie alla gestione dell’amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite, che è riuscita comunque, attraverso un lento processo, a migliorare la situazione: dopo un primo periodo di difficoltà nel solo dare alle persone un tetto sotto il quale vivere, il rientro nelle città degli albanesi è ora definitivamente completato. Ancora molte sono, però, le famiglie in cerca di persone care scomparse, sia da parte albanese che da quella serba. Una prima organizzazione istituzionale è stata creata attraverso la collaborazione fra autorità internazionali e kosovare ed elezioni libere sotto la supervisione dell’OSCE si sono già tenute, anche se boicottate dai serbi e da una frangia albanese. Numerose strutture civili sono state 465 Osservatorio sui Balcani, Dossier/approfondimenti: Djindjic: un omicidio politico, 19 marzo 2003, <http://www.osservatoriobalcani.org>, consultato il 16 maggio 2003; International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, The Accused: Slobodan Milosevic, 21 gennaio 2003, <http://www.un.org/icty/glance/milosevic.htm>, consultato il 17 maggio 2003; Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., p. 645. 466 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cir., pp. 644-645. realizzate e in molte di queste la convivenza multietnica non sembra impossibile. Resta da capire come e quando l’amministrazione delle Nazioni Unite possa lasciare la regione, in che modo il Kosovo possa autogovernarsi e quanto ancora sia necessario l’impiego di truppe internazionali. Pur essendo da tempo iniziata una kosovarizzazione delle autorità che amministrano la regione, ci sono molte ombre su quale potrà essere la soluzione di autogoverno kosovaro prospettata nell’accordo di pace del giugno ’99 e quando l’amministrazione delle Nazioni Unite potrà lasciare la gestione definitivamente in mano alla politica locale. Così come i frequenti incidenti che ancora si verificano nella regione fra le fazioni serbe e quelle albanesi non danno certezze su quando la convivenza nel paese potrà finire di dipendere dalla presenza nell’area da forze straniere. La situazione così delineata, insomma, ci porta a prospettare una non facile e rapida normalizzazione dell’instabile situazione in Kosovo 467 . Milosevic, in un discorso televisivo alla nazione alla fine del conflitto, proclamò la sua vittoria nella guerra contro l’occidente. Questo non può stupire, considerata la propaganda tipica di tutti i regimi. Sicuramente il presidente non uscì vittorioso da quel conflitto, ma alcuni dati ci indicano che egli non ne uscì neanche umiliato, come le differenze delle forze in campo avrebbero potuto far pensare. Tralasciando il numero delle vittime della guerra, sempre difficile da calcolare e caratterizzato da cifre contrastanti, nonostante la potenza bellica messa in campo dalla NATO l’Armata jugoslava subì meno perdite del previsto: durante tutto il corso del conflitto e in particolar modo nella prima parte, l’esercito serbo riuscì, grazie a mosse semplici ma astute, a mantenere intatta la gran parte del suo contingente. Alla fine della guerra, infatti, emerse che per ingannare gli aerei dell’Alleanza che volavano a 5000 metri di altezza, i serbi costruirono appositamente carri armati in materiali rudimentali, grazie ai quali riuscirono a perdere soltanto 15 mezzi di quelli veri. Enorme sorpresa suscitò infatti ne gli ambienti militari occidentali la ritirata delle truppe serbe dal Kosovo, che vide 47000 soldati con mezzi praticamente intatti rientrare in Serbia 468 . La NATO aveva effettuato 38004 voli, dei quali 10484 utilizzati per attacchi, aveva distrutto la quasi totalità dei Mig-29 a disposizione dell’esercito jugoslavo, ma soltanto dieci postazioni missilistiche antiaeree, lasciando praticamente intatto il sistema di difesa serbo. La guerra costò circa sette miliardi di dollari e per la ricostruzione si previde di stanziare solo per i primi tre anni dai 500 ai 750 milioni di dollari. Essa, inoltre, lasciò sul campo, come dimostrano le stesse cifre delle 467 Hans Haekkerup, UNMIK at Two: Foreword of the Special Representative of the Secretary-General, Pristina, giugno 2001, <http://www.unmikonline.org/2ndyear/unmikat2p2.htm>, consultato il 17 maggio 2003; United Nations Mission in Kosovo, UNMIK at Two: Turning Point for Self-Governance, <http://www.unmikonline.org/2ndyear/unmikat2p3.htm>, consultato il 17 maggio 2003; Osservatorio sui Balcani, Dossier per paese : Kossovo (USM), <http://www.osservatoriobalcani.org>, consultato il 18 maggio 2003. 468 Judah, Kosovo, cit., p. 285; Posen, The War for Kosovo, cit., pp. 58-61, 64; McGwire, Why Did We Bomb Belgrade?, cit., p. 11; Clark, Waging Modern War, cit., p. 406. Nazioni Unite, moltissimi ordigni inesplosi e l’inquinamento dell’ambiente e dell’atmosfera, che, come nel Golfo, provocarono gravi malattie ai civili, ma anche ai militari presenti nell’area 469 . In tutto l’occidente si proclamò la “vittoria per un mondo più libero, per i nostri valori democratici”, ma soprattutto “per un’America più forte”470 . La frase citata, pronunc iata dal presidente americano Bill Clinton, rappresenta in qualche modo lo specchio della guerra in Kosovo. L’intervento militare, infatti, costituì sicuramente un aiuto alla popolazione kosovara: la pressione militare esercitata con i bombardamenti sulle strutture militari e civili nei centri nevralgici delle più importanti città della Serbia e non solo, mise sicuramente in difficoltà Milosevic, costretto a trattare a causa del collasso che stava rischiando di subire il suo regime. Soprattutto però, mise in evidenza la volontà americana di dimostrare la propria egemonia e di esercitarla in Europa. Le iniziative, infatti, furono spesso prese unilateralmente dagli Stati Uniti senza consultare gli alleati, mentre le operazioni militari più importanti sottostavano al comando statunitense anziché a quello della NATO. Gli americani mostrarono così la loro superiorità dal punto di vista militare: i mezzi usati nel conflitto, soprattutto quelli tecnologicamente più avanzati, erano forniti dall’esercito statunitense. L’egemonia americana, ovviamente, irritò gli europei, rivelatisi ancora una volta ancora incapaci di configurarsi come forza unitaria e per questo una volta ancora umiliati nel quadro politico internazionale. Essi furono soltanto capaci di intralciare le azioni americane, ma non di fermarle. Per non parlare della Russia, rilegata al ruolo di partner secondario e utilizzata soltanto nel negoziato con Milosevic 471 . Per la prima volta nella storia un conflitto veniva vinto utilizzando solamente forze aeree. Le perdite della NATO furono così ridottissime, che, grazie anche all’utilizzo di aerei senza pilota che fornivano informazioni satellitari, furono limitate a due aerei e nessun uomo perso in battaglia472 . Proprio in una situazione come quella verificatasi in Kosovo, la logica utilizzata contrasta con ciò che sarebbe risultato necessario per difendere una popolazione dalla pulizia etnica: la strategia richiesta sarebbe stata proprio quella dell’intervento di terra, magari attenuandone i rischi con attacchi più efficaci condotti nell’area da velivoli in grado di colpire da quote più basse e accompagnati da bombardamenti aerei sugli obiettivi logistici dell’esercito serbo. A riguardo, l’affermazione del generale Morillon, ex comandante delle truppe UNPROFOR fu colorita ma 469 International Institute for Strategic Studies, Air-Power over Kosovo, cit., pp. 1-2; Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., pp. 641-642; United Nations Mission in Kosovo, Chronology, <http://www.unmikonline.org/chrono.htm>, consultato il 17 maggio 2003. 470 William J. Clinton, Address to the Nation on the Military Technical Agreement on Kosovo, cit., p. 913. 471 International Institute for Strategic Studies, Air-Power over Kosovo, cit., pp. 1-2; Elisabeth Pond, Kosovo, Cathalist for Europe, “The Washington Quarterly”, vol. 22, n. 4, autunno 1999, p. 81. 472 Clark, Waging Modern War, cit., p. 427. chiara: “Che tipo di soldati sono questi – pronti a uccidere, ma non a morire?”473 . Evidentemente l’ironia utilizzata non era rivolta ai soldati stessi, quanto ai vertici dell’Alleanza e soprattutto agli americani, che sembrarono voler fare la guerra senza però assumersi quelle responsabilità che essa richiede. Ma, come abbiamo già detto, il teatro kosovaro era considerato di secondaria importanza e non valeva il sacrificio di vite umane occidentali. La scelta di imporre a Milosevic una piattaforma diplomatica per lui fortemente penalizzante e la rigidità con la quale si decise di condurre i colloqui di Rambouillet fa dubitare più che sulle capacità diplomatiche degli occidentali, sulla reale volontà degli Stati Uniti di condurre in porto la trattativa. In ogni caso, sicuramente ci fu un errore di sottovalutazione della resistenza serba: probabilmente si pensava che Milosevic avrebbe ceduto molto presto ai bombardamenti della NATO. Questo, come abbiamo visto, non accadde, e portò all’intensificazione della pressione militare. La cosiddetta “diplomazia dell’ultimatum”, condotta alacremente dall’amministrazione americana, condusse ad un processo escalativo dal quale era difficile uscire. Si entrò in un vortice nel quale, per dimostrare le reali capacità deterrenti della NATO, si ricorse ad un’intensificazione degli attacchi che andava, più che a beneficio della popolazione kosovara, a danno di quella serba. La scelta occidentale di utilizzare gli attacchi aerei per limitare le perdite di propri soldati, rese questo ancor più difficile. I benefici conseguiti a salvaguardia dell’etnia albanese del Kosovo, come abbiamo visto, sono stati pochi, specialmente se si considera che dall’inizio del conflitto le violenze nei loro confronti portarono più vittime di qua nte ne erano state provocate dal 1989. La NATO, al contrario, da quel momento si configurava a tutti gli effetti come organismo militare per la gestione delle crisi internazionali, nell’ambito del nuovo unilateralismo che gli Stati Uniti intesero intraprendere e del quale la guerra del Kosovo fu il banco di prova: l’obiettivo, insomma, era stato raggiunto 474 . 473 Paul Robinson, “Ready to Kill but not to Die”: NATO Strategy in Kosovo, “International Journal”, vol. LIV, n. 4, autunno 1999, p. 677. 474 Del Pero, Romero, Le ragioni di una guerra, cit.; Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, cit., p. 641. CONCLUSIONI La trattazione sviluppata nell’elaborato ci ha portato ad analizzare la politica estera americana alla fine della guerra fredda ed i suoi sviluppi nel corso degli anni, con particolare riferimento all’intervento nelle crisi balcaniche degli anni ’90. E’ innegabile il fatto che il crollo dell’Unione Sovietica abbia generato una situazione d’instabilità, nella quale l’equilibrio creatosi con l’ordine internazionale bipolare era venuto meno. Questa situazione aveva iniziato a prospettarsi già dalla fine degli anni ’80, quando l’Unione Sovietica iniziò a palesare tutte le difficoltà nello stare al passo con la potenza degli Stati Uniti. La prima circostanza in cui Washington si trovò ad affrontare uno scenario internazionale nella nuova posizione di unica superpotenza fu la crisi del Golfo. In quell’occasione gli Stati Uniti mostrarono tutta la determinazione nell’assumere il ruolo di guida nelle vicende internazionali. Così, l’allora presidente Bush coinvolse un’ampia coalizione di stati, che con l’autorizzazione all’uso della forza da parte delle Nazioni Unite intraprese quella che fu definita un’operazione di polizia internazionale. In quel modo si delineò l’intenzione degli Stati Uniti nei primi anni del postbipolarsimo: creare un ordine globale per un mondo libero e democratico, nel quale essi sarebbero stati il paese guida nell’esportazione della democrazia e della pace, con le Nazioni Unite coinvolte come strumento di consenso nell’ambito della risoluzione delle controversie internazionali. Dopo le prime manovre compiute in questo contesto da Bush, il primo presidente che si trovò nella situazione di dover scegliere una linea di politica estera post-guerra fredda fu Bill Clinton. Egli, sebbene avesse attaccato Bush riguardo alle scelte compiute, finì comunque per condividere l’idea di globalismo già prospettata dal suo predecessore il quale, per rispondere alle critiche di inattivismo, aveva nel frattempo intrapreso la missione umanitaria in Somalia. Clinton, così, ben si adeguò alla situazione ereditata: egli decise di proseguire la missione, che inizialmente aveva avuto l’unico scopo di alleviare le sofferenze di una popolazione ridotta in condizioni disastrose dalla guerra che infuriava fra i clan, e che quindi non era mirata ad imporre una soluzione politica nel paese. L’amministrazione Clinton, pochi mesi dopo il suo insediamento, mostrò la sua determinazione nell’intervenire in maniera più decisa per risolvere l’emergenza umanitaria somala. Così gli Stati Uniti e le Nazioni Unite trasformarono la missione in peace-enforcement operation, impegnandosi contro la volontà delle fazioni in lotta in un’operazione complicata e piena d’insidie. L’inesperienza di Clinton in politica estera, alla quale era accompagnata quella del suo entourage, condus se il governo degli Stati Uniti a commettere alcuni errori. Fu quello che avvenne anche nella questione di Haiti, dove l’indecisione dell’amministrazione portò ad allungare i tempi per la risoluzione della crisi. Il contemporaneo fallimento della missione in Somalia mise in luce tutta l’incapacità di Clinton nell’affrontare con la dovuta decisione questioni del genere. Da lì in avanti la politica americana fu certamente influenzata dagli smacchi personali subiti da Clinton, che tra l’altro avevano condotto il partito democratico ad una storica sconfitta nelle elezioni di mid-term del 1994. Il presidente da quel momento cercò di improntare la propria politica estera meno all’idealismo e più al realismo. La gestione della crisi bosniaca mostra tutta l’esitazione dell’amministrazione americana nel risolvere in maniera determinata una situazione umanitaria grave almeno quanto quella somala. Al tempo stesso, però, con il profilarsi della campagna per la Casa Bianca del 1996, la politica del presidente dovette tener conto anche dell’orientamento dell’elettorato americano, che non lo avrebbe sostenuto nella rielezione qualora le decisioni di Washington avessero ripetuto gli errori dei primi anni del mandato di Clinton e rievocato i fantasmi della “sindrome del Vietna m”. Inoltre, subentrò all’interno dell’establishment americano la paura che un’eventuale vittoria dei serbi nella guerra in Bosnia avrebbe provocato un effetto “domino” che avrebbe portato Milosevic ad aspirare a nuove conquiste, accrescendo le condizioni di instabilità dell’area. La volontà americana era quella di non permettere che si verificasse una situazione in cui qualsiasi regime si sarebbe sentito incoraggiato ad intraprendere aggressioni. Era la cosiddetta “lezione di Monaco”, paradigma della cultura statunitense, oltre che di quella europea, che aveva insegnato come una politica attendista nei confronti di dittatori considerati pericolosi portasse ad ingenerare un meccanismo a catena, come era accaduto nel caso di Hitler nel 1938. Altri fattori concorrono a spiegare come l’iniziale temporeggiamento del governo degli Stati Uniti nella risoluzione crisi bosniaca sia stato seguito, in un secondo momento, da una fase di maggiore attenzione alla vicenda. Uno di questi fu la propensione del Pentagono ad impegnarsi nella crisi somala perché considerata meno rischiosa di quella bosniaca; un altro vide Clinton influenzato nella sua azione dalla pressione esercitata dal congresso repubblicano per un’azione più decisa del governo degli Stati Uniti a favore del governo di Sarajevo. Alla scelta statunitense contribuì anche la speranza che l’Unione Europea avrebbe assunto un ruolo di maggior rilievo nella risoluzione di una crisi che, per ragioni geografiche, era molto più destabilizzante per l’Europa che per gli Stati Uniti. Il graduale abbandono del coinvolgimento delle Nazioni Unite nelle decisioni di politica internazionale, che comunque erano sempre maturate a Washington, fu un altro elemento che caratterizzò la nuova linea politica statunitense. Durante la gestione della crisi bosniaca, infatti, gli Stati Uniti entrarono in aperto conflitto con l’allora Segretario Generale delle Nazioni Unite Boutros-Ghali. La motivazione principale di questa rottura va rintracciata nella volontà americana di superare le farraginose procedure delle Nazioni Unite e scavalcare l’opposizione sulle questioni critiche di alcuni membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. Per portare gli Stati Uniti verso una politica estera più efficiente e decisa l’amministrazione Clinton puntò sulla NATO, l’organismo che con la fine della contrapposizione bipolare rischiava di perdere le ragioni della propria esistenza. Proprio la NATO fu utilizzata in Bosnia nelle prime operazioni militari della sua storia: gli Stati Uniti vollero i raid aerei contro i serbi per imporre, dopo aver mostrato molte titubanze, la cosiddetta “diplomazia dell’ultimatum”. Essi, infatti, nel tentativo di far accettare ai serbo-bosniaci le condizioni del piano di pace, intrapresero decise iniziative diplomatiche unite all’utilizzo della coercizione esercitata attraverso bombardamenti contro postazioni serbe in Bosnia. Così a Dayton venne raggiunto un accordo che non andava necessariamente verso la ricerca della miglior soluzione per ottenere una pace duratura, quanto invece mirava a conseguire l’obiettivo di costringere comunque i serbo-bosniaci ad accettare una soluzione negoziata, qualunque essa fosse. A questa situazione contribuì anche la volontà di Clinton di presentarsi alle elezioni presidenziali del ’96 a vicenda bosniaca risolta e preferibilmente dopo aver dimostrato la propria capacità nel conseguire un accordo di pace per la Bosnia. I colloqui di Dayton furono condotti in modo piuttosto determinato dagli americani, i quali minacciarono le parti di forti ritorsioni nel caso in cui non avessero accettato la piattaforma diplomatica. L’accordo fu raggiunto per le concessioni che Milosevic fece in extremis, poiché il leader serbo aveva capito che l’attenzione della comunità internazionale sulla vicenda bosniaca non gli avrebbe permesso di ottenere molto. Fu infatti da quel momento che egli scelse di spostare le proprie mire sul Kosovo. Clinton, grazie anche alle mosse più decise di politica estera portate a termine nella seconda parte del suo primo mandato, riuscì a garantirsi la rielezione. Già dall’inizio del suo secondo mandato manifestò la volontà di proseguire in quella linea politica che gli aveva permesso di mantenere il consenso popolare nonostante le brutte figure subite nelle operazioni in Somalia e ad Haiti. Nella campagna di pulizia etnica in Kosovo i serbi non avrebbero avuto libertà di azione quanta ne avevano avuta in Bosnia, proprio perché la determinazione americana nella nuova politica da intraprendere era ben diversa, anche alla luce dell’esperienza vissuta. Nella nuova crisi che andava prospettandosi Stati Uniti scelsero così quella della prosecuzione della linea già avviata, applicando la diplomazia dell’ultimatum questa volta a Rambouillet. La conferenza diplomatica della cittadina francese rappresentò certamente la fase cruciale della crisi del Kosovo, e vide gli americani cercare di imporre a Milosevic un piano diplomatico per lui molto penalizzante. L’obiettivo rimaneva quello di non consentire a Milosevic alcuno spazio nelle proprie mire di “riunificazione del popolo serbo” e di appropriazione delle terre che avrebbero composto la “grande Serbia”, nella logica suggerita dalla lezione di Monaco. La pressione sugli albanesi perché firmassero la piattaforma furono molto forti: alla fine, utilizzando quelle stesse minacce che già erano state esercitate sulle parti in contrasto nei colloqui di Dayton, gli albanesi firmarono. I serbi, tuttavia, si rifiutarono di firmare l’accordo e la loro intransigenza consentì a Washington di presentare Belgrado come la parte ostile a una soluzione diplomatica, e di trovare quindi una legittimazione per l’uso della forza a difesa della popolazione albanese del Kosovo. Per applicare questa soluzione la NATO parve lo strumento più adeguato. Essa infatti garantiva al meglio la necessità di affermazione della politica americana e di applicazione di essa insieme ad un gruppo di stati alleati. In poche parole la NATO rappresentava l’organismo da riattivare come strumento della politica unilateralista americana in Europa, nella quale i partner recitavano un ruolo da comprimari. Nel seguire rigidamente i criteri dettati dalla sindrome di Monaco non venivano comunque abbandonati quelli della sindrome del Vietnam. Lo scenario del Kosovo, infatti, considerato dall’establishment americano di secondaria importanza strategica, prevedeva l’impiego di sole forze d’aviazione. Ciò limitava al massimo i rischi di eventuali perdite di soldati da parte di Washington. La guerra del Kosovo passò così alla storia come l’unica vinta senza il dispiego di truppe di terra. Questo elemento, unito ad un’inaspettata resistenza da parte serba, portò alla graduale intensificazione delle operazioni aeree. Inoltre, la speranza di Milosevic che l’Alleanza si incrinasse o che arrivasse un appoggio da parte di Mosca non faceva che inasprire il conflitto. Milosevic, alla fine, rimase deluso dalla coesione dell’Alleanza e dalla posizione acquiescente all’occidente tenuta dalla Russia. Così la NATO ebbe modo di mostrare le proprie capacità deterrenti: guidata dagli Stati Uniti si propose definitivamente come nuovo organismo militare da impiegare nella risoluzione delle questioni internazionali. Gli Stati Uniti finirono pertanto per conseguire gli obiettivi che si erano prefissati nell’ergersi a paese guida per la risoluzione delle controversie internazionali. Questa politica, però, non ha condotto ad una soluzione accettabile nelle vicende balcaniche. In effetti, se esaminiamo la situazione attuale nelle aree in cui si è verificato l’intervento della NATO e della diplomazia occidentale negli anni ’90, notiamo che queste sono migliorate ben poco. Il fatto che forze multinazionali e amministrazioni ad interim siano tuttora dispiegate in Bosnia e in Kosovo non possono certo attestare il successo delle operazioni della NATO o delle stesse Nazioni Unite. In Kosovo, addirittura, la situazione si è completamente rovesciata e oggi vittima delle violenze sono soprattutto i serbi, costretti a subire la vendetta per mano degli albanesi. La diplomazia occidentale, con quella americana in testa, non ha saputo dare una risposta adeguata a crisi gravi, per averle volute utilizzare più come campo di prova di un’egemonia mondiale, scavalcando tra l’altro le Nazioni Unite, che per la reale volontà di risolvere le questioni di fondo. Clinton, nei primi anni della sua presidenza, mantenne alto l’impegno internazionale degli Stati Uniti, ma amministrò la politica estera in maniera fortemente titubante, cosa che lo condusse a subire alcune sconfitte personali. Questo può essere attribuito alla sua inesperienza e incapacità, o magari al tentativo di intraprendere una politica utopistica scaturita dalla critica alla politica estera americana degli anni ’60. Senza dubbio egli si trovò nella difficoltà di dover affrontare una situazione internazionale totalmente nuova, nella quale gli Stati Uniti si trovarono a raccogliere la completa eredità della politica mondiale. In una fase successiva del suo mandato, Clinton, pur influenzato da diversi fattori, cambiò strategia, adottandone una più decisa. Ciò lo portò al conseguimento di obiettivi importanti per il proprio paese nel ruolo di unica superpotenza, ma non per la risoluzione dei problemi in questione. Pur senza voler fare del falso moralismo verrebbe allora da chiedersi quali siano le prospettive del mondo se l’atteggiamento del paese leader mondiale indiscusso nell’affrontare situazioni definite “umanitarie” è questo. I più recenti avvenimenti hanno visto gli Stati Uniti accentuare ulteriormente la politica unilateralista, scavalcando completamente il coinvolgimento di qualsiasi organismo sovranazionale nella politica mondiale ed utilizzando spesso le ragioni umanitarie come pretesto. La concezione del ruolo internazionale che gli Stati Uniti mostrarono nella gestione crisi dell’ex Jugoslavia, risulta dunque perfino superata. La guerra mossa all’inizio del 2003 all’Iraq, accusato di possedere armi di distruzione di massa, ha palesato la volontà americana di fronteggiare senza indugio tutti i regimi cosiddetti “canaglia”, pericolosi per la sicurezza nazionale statunitense. Questa strategia è sicuramente scaturita in seguito agli accadimenti dell’11 settembre, nell’obiettivo di fronteggiare a tutto campo la minaccia terroristica475 . Personalmente, però, credo che la strategia di risposta alla violenza con altrettanta violenza non sia la giusta risposta per combattere il terrorismo. Gli attentati attribuiti all’organizzazione terroristica Al Qaeda verificatisi nei mesi scorsi e la stessa strage delle Twin Towers dimostrano come l’interventismo americano rischi di condurre soltanto ad un’escalation nella violenza, che costituisce un serio pericolo per l’umanità intera. Nella logica del mantenimento della leadership e soprattutto della salvaguardia delle minoranze messe a rischio da dittatori senza scrupoli è naturale avanzare forti iniziative 475 George W. Bush, The National Security Strategy of the United States of America, 17 settembre 2002, <http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.html>, consultato il 3 giugno 2003. diplomatiche multilaterali e finalizzate al reale raggiungimento di una soluzione negoziata. Non è escludibile comunque, in situazioni critiche che trovano un’impossibilità palese di giungere una soluzione diplomatica, l’uso mirato della forza. Non è sicuramente prospettabile, però, una situazione in cui gli interventi militari sono intrapresi senza vagliare prima ogni opzione diplomatica, senza tener conto dei cosiddetti “danni collaterali” e soprattutto senza tener conto adeguatamente del background storico che caratterizza ogni area di intervento. L’inadeguata considerazione di questi fattori ha causato, a mio giudizio, il fallimento nella risoluzione delle questioni bosniaca e kosovara. BIBLIOGRAFIA I. Fonti I.1. Fonti federali e del Congresso • Baker, James, Helping the New Independent States; Sanctions on Serbia-Montenegro, 24 maggio 1992, U.S. Department Dispatch, Vol. 3, n. 22, 1 giugno 1992, <http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/briefing/dispatch/1992/html/Dispatchv3no22.html>, consultato il 25 maggio 2003. • Bush George W., The National Security Strategy of the United States of America, 17 settembre 2002, <http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.html>, consultato il 3 giugno 2003. • Bush, George W. H., The President’s News Conference with Foreign Journalists, 2 luglio 1992, in Public Papers of the Presidents of the United States: George W.H. Bush: 1992, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1992, vol. 1. • Clinton, William J., Address Before a Joint Session of the Congress on the State of the Union, 4 febbraio 1997, in Public Papers of the Presidents of the United States: William J. Clinton: 1997, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1997, vol. 1. • Clinton, William J., Address to the Nation on Airstrikes Against Serbian Targets in the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro), 24 marzo 1999, in Public Papers of the Presidents of the United States: William J. Clinton: 1999, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1999, vol. 1. • Clinton, William J., Address to the Nation on Haiti, 15 settembre 1994, in Public Papers of the Presidents of the United States: William J. Clinton: 1994, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1994, vol. 2. • Clinton, William J., Address to the Nation on Implementation of the Peace Agreement in Bosnia-Herzegovina, 27 novembre 1995, in Public Papers of the Presidents of the United States: William J. Clinton: 1995, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1995, vol. 2. • Clinton, William J., Address to the Nation on Somalia, 7 ottobre 1993, in Public Papers of the Presidents of the United States: William J. Clinton: 1993, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1993, vol. 2. • Clinton, William J., Address to the Nation on the Military Technical Agreement on Kosovo, 10 giugno 1999, in Public Papers of the Presidents of the United States: William J. Clinton: 1999, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1999, vol. 1. • Clinton, William J., Exchange with Reporters on Bosnia, 21 maggio 1993, in Public Papers of the Presidents of the United States: William J. Clinton: 1993, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1993, vol. 1. • Clinton, William J., Remarks Announcing the Bosnia-Herzegovina Cease-Fire Agreement and an Exchange With Reporters, 5 ottobre 1995, in Public Papers of the Presidents of the United States: William J. Clinton: 1995, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1995, vol. 2. • Clinton, William J., Remarks Announcing the Bosnia-Herzegovina Peace Agreement and an Exchange with Reporters, 21 novembre 1995, in Public Papers of the Presidents of the United States: William J. Clinton: 1995, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1995, vol. 2. • Clinton, William J., Remarks Announcing the NATO Decision on Air Strikes in Bosnia and an Exchange with Reporters, 9 febbraio 1994, in Public Papers of the Presidents of the United States: William J. Clinton: 1994, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1994, vol. 1. • Clinton, William J., Remarks at a Freedom House Breakfast, 6 ottobre 1995, in Public Papers of the Presidents of the United States: William J. Clinton: 1995, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1995, vol. 2. • Clinton, William J., Remarks at an Independence Day Ceremony in Philadelphia, Pennsylvania , 4 luglio 1993, in Public Papers of the Presidents of the United States: William J. Clinton: 1993, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1993, vol. 1. • Clinton, William J., Remarks at the United States Air Force Academy Commencement Ceremony in Colorado Springs, Colorado, 31 maggio 1995, in Public Papers of the Presidents of the United States: William J. Clinton: 1995, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1995, vol. 1. • Clinton, William J., Remarks at the White House Strategy Meeting on Children, Violence, and Responsibility, 10 maggio 1999, in Public Papers of the Presidents of the United States: William J. Clinton: 1999, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1999, vol. 1. • Clinton, William J., Remarks on Arrival in Honolulu, Hawaii, 31 agosto 1995, in Public Papers of the Presidents of the United States: William J. Clinton: 1995, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1995, vol. 2. • Clinton, William J., Remarks on the Balkans Peace Process and an Exchange with Reporters, 31 ottobre 1995, in Public Papers of the Presidents of the United States: William J. Clinton: 1995, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1995, vol. 2. • Clinton, William J., Remarks on the Situation in Kosovo and an Exchange With Reporters , 13 ottobre 1998, in Public Papers of the Presidents of the United States: William J. Clinton: 1998, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1998, vol. 2. • Clinton, William J., Statement Announcement Airdrops to Provide Humanitarian Aid to Bosnia-Herzegovina, 25 febbraio 1993, in Public Papers of the Presidents of the United States: William J. Clinton: 1993, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1993, vol. 1. • Clinton, William J., The President’s New’s Conference, 19 marzo 1999, in Public Papers of the Presidents of the United States: William J. Clinton: 1999, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1999, vol. 1. • Clinton, William J., The President's News Conference With President Boris Yeltsin of Russia in Moscow, 14 gennaio 1994, in Public Papers of the Presidents of the United States: William J. Clinton: 1994, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1994, vol. 1. • Clinton, William J., The President's News Conference, 17 giugno 1993, in Public Papers of the Presidents of the United States: William J. Clinton: 1993, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1993, vol. 1. • Clinton, William J., Videotaped Address to the Serbian People, in Public Papers of the Presidents of the United States: William J. Clinton: 1999, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1999, vol. 1. • Federal Election Commission – United States of America, 1996 Electoral and Popular Vote Summary, <http://www.fec.gov/pubrec/elecpop.htm>, consultato il 6 maggio 2003. • Secretary of State Madeleine K. Albright, Interview on CCN-TV “Larry King Live”, Washington, D.C., 24 gennaio 1997, <http://secretary.state.gov/www/statements/970124a.html>, consultato il 7 maggio 2003. • Secretary of State Warren Christopher, “New Steps Toward Conflict Resolution In the Former Yugoslavia”, U.S. Department of State, Washington, DC, 10 febbraio 1993, <http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/briefing/dossec/1993/9302/930210dossec.html>, consultato il 12 aprile 2003. • Secretary of State Warren Christopher, Address at H.H. Humphrey Inst. Of Public Affairs re Russia, Minneapolis, Minnesota, 27 maggio 1993, <http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/briefing/dossec/1993/9305/930527dossec.html>, consultato il 21 maggio 2003. • Secretary of State Warren Christopher, Statement by Secretary of State Warren Christopher Opening the Balkan Proximity Peace Talks, U.S. Department of State, Dayton (Ohio), 1 novembre 1995, <http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/briefing/dossec/1995/9511/951101dossec.html#top>, consultato il 24 aprile 2003. • Task Force Eagle – SFOR XIII, History of SFOR, <http://www.tfeagle.army.mil/TFE/SFOR_History.htm>, consultato il 29 aprile 2003. • U.S. Department of State, The Dayton Peace Accords, <http://www.state.gov/www/regions/eur/bosnia/bosagree.html>, consultato il 25 aprile 2003. • U.S. Senate, Dole (e altri), Amendment n. 1281, 27 gennaio 1994, <http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/D?r103:2:./temp/~r1031wagSp::>, consultato il 16 aprile 2003. • U.S. Senate, Dole (e altri), Amendment n. 2518, 10 agosto 1994 <http://thomas.loc.gov/cgibin/query/D?r103:13:./temp/~r103omHVDD::>, consultato il 17 aprile 2003. • U.S. Senate, Expressing the sense of the Congress regarding the culpability of Slobodan Milosevic for war crimes, crimes against humanity, and genocide in the former Yugoslavia, and for other purposes, 18 luglio 1998, <http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi- bin/useftp.cgi?IPaddress=162.140.64.21&filename=sc105is.txt&directory=/diskc/wais/data/ 105_cong_bills>, consultato il 9 maggio 2003. I.2. Nazioni Unite • Annan, Kofi, Report of the Secretary-General Pursuant to General Assembly Resolution 53/35: The Fall of Srebrenica, < http://2002.xs4all.nl/surfnet/srebrenica.org/unsrerep.pdf>, 15 novembre 1999, consultato il 21 aprile 2003. • Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n 757/92, 30 maggio 1992, <http://ods-ddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/011/16/IMG/NR001116.pdf?OpenElement>, consultato l’8 aprile 2003. • Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n, 1244/99, 10 giugno 1999, <http://ods-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/172/89/PDF/N9917289.pdf?OpenElement>, consultato il 15 maggio 2003. • Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 1021/95, 22 novembre 1995, <http://ods-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/368/59/PDF/N9536859.pdf?OpenElement>, consultato il 26 aprile 2003. • Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 1022/95, 22 novembre 1995, <http://ods-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/368/65/PDF/N9536865.pdf?OpenElement>, consultato il 26 aprile 2003. • Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 1160/98, 31 marzo 1998, <http://ods-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/090/23/PDF/N9809023.pdf?OpenElement>, consultato l’8 maggio 2003. • Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 1199/98, 23 settembre 1998, <http://ods-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/279/96/PDF/N9827996.pdf?OpenElement>, consultato il 9 maggio 2003. • Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 1203, 24 ottobre 1998, <http://ods-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/321/21/PDF/N9832121.pdf?OpenElement>, consultato il 10 magio 2003. • Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 1244/99, Annex 1: Statement by the Chairman on the conclusion of the meeting of the G-8 Foreign Ministers held at the Petersberg Centre on 6 May 1999, 10 giugno 1999, <http://ods-dds- ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/172/89/PDF/N9917289.pdf?OpenElement>, consultato il 15 maggio 2003. • Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 660/90, 2 agosto 1990, <http://ods-ddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/575/10/IMG/NR057510.pdf?OpenElement>, consultato il 20 maggio 2003. • Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 678/90, 29 novembre 1990, <http://ods-ddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/575/28/IMG/NR057528.pdf?OpenElement>, consultato il 20 maggio 2003. • Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 746/92, 17 marzo 1992, <http://ods-ddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/011/05/IMG/NR001105.pdf?OpenElement>, consultato il 21 maggio 2003. • Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 758/92, 8 giugno 1992, <http://ods-ddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/011/17/IMG/NR001117.pdf?OpenElement>, consultato l’8 aprile 2003. • Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 761/92, 29 giugno 1992, <http://daccessods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=S/RES/761%20(1992)&Lang=E&Area=RESO LUTION>, consultato l’8 aprile 2003. • Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 767/92, 24 luglio 1992, <http://ods-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/342/21/IMG/N9234221.pdf?OpenElement>, consultato il 22 maggio 2003. • Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 770/92, 13 agosto 1992, <http://ods-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/379/66/IMG/N9237966.pdf?OpenElement>, consultato il 9 aprile 2003. • Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 780/92, 6 ottobre 1992, <http://ods-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/484/40/IMG/N9248440.pdf?OpenElement>, consultato il 10 aprile 2003. • Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 781/92, 9 ottobre 1992, <http://ods-dds- ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/491/64/IMG/N9249164.pdf?OpenElement>, consultato il 10 aprile 2003. • Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 786/92, 10 novembre 1992, <http://ods-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/689/74/IMG/N9268974.pdf?OpenElement>, consultato il 10 aprile 2003. • Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 787/92, 16 novembre 1992, <http://ods-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/723/03/IMG/N9272303.pdf?OpenElement>, consultato il 10 aprile 2003. • Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 819/93, 16 aprile 1993, <http://ods-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/221/90/IMG/N9322190.pdf?OpenElement>, consultato il 14 aprile 2003. • Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 824/93, 6 maggio 1993, <http://ods-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/262/07/IMG/N9326207.pdf?OpenElement>, consultato il 14 aprile 2003. • Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 836/93, 4 giugno 1993, <http://ods-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/330/21/IMG/N9333021.pdf?OpenElement>, consultato il 14 aprile 2003. • Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 837/93, 6 giugno 1993, <http://ods-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/332/32/IMG/N9333232.pdf?OpenElement>, consultato il 22 maggio 2003. • Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 841/93, 16 giugno 1993, <http://ods-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/354/58/IMG/N9335458.pdf?OpenElement>, consultato il 22 maggio 2003. • Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 861/93, 27 agosto 1993, <http://ods-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/473/12/IMG/N9347312.pdf?OpenElement>, consultato il 22 maggio 2003. • Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 873/93, 13 ottobre 1993, <http://ods-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/555/41/PDF/N9355541.pdf?OpenElement>, consultato il 22 maggio 2003. • Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 943/94, 23 settembre 1994, <http://ods-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/372/78/PDF/N9437278.pdf?OpenElement>, consultato il 17 aprile 2003. • Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n.713/91, 25 settembre 1991, <http://ods-ddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/596/49/IMG/NR059649.pdf?OpenElement>, consultato il 28 marzo 2003. • Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n.743/92, 21 febbraio 1992, <http://ods-ddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/011/02/IMG/NR001102.pdf?OpenElement>, consultato il 28 marzo 2003. • Department of Pub lic Information, United Nations, United Nations Operation in Somalia I, <http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/co_mission/unosomi.htm>, consultato il 22 maggio 2003. • Department of Public Information, United Nations, United Nations Operation in Somalia II – Background Text, 21 marzo 1997 (ultimo aggiornamento), <http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unosom2b.htm>, consultato il 22 maggio 2003. • Department of Public Information, United Nations, United Nations Mission in Haiti, <http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/co_mission/unmih.htm>, consultato il 23 maggio 2003. • Department of Public Information, United Nations, United Nations Transition Mission in Haiti, <http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/co_mission/untmih.htm>, consultato il 23 maggio 2003. • Department of Public Information, United Nations, United Nations Protection Force – Background text, settembre 1996 <http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/co_mission/unprof_b.ht m>, consultato il 28 marzo 2003. • Department of Public Information, United Nations, United Nations Protection Force – Mission Profile, <http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/co_mission/unprof_p.htm>, consultato il 25 maggio 2003. • Hans Haekkerup, UNMIK at Two: Foreword of the Special Representative of the SecretaryGeneral, Pristina, giugno 2001, <http://www.unmikonline.org/2ndyear/unmikat2p2.htm>, consultato il 17 maggio 2003. • International Criminal Tribunal for the Former Jugoslavia, Indictment Against Radovan Karadzic, Ratko Mladic, 14 novembre 1995, The Hague, The Nederlands, <http://www.un.org/icty/indictment/english/kar- ii951116e.htm>, consultato il 24 aprile 2003. • International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, The Accused: Slobodan Milosevic, 21 gennaio 2003, <http://www.un.org/icty/glance/milosevic.htm>, consultato il 17 maggio 2003. • International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, The Prosecutor of the Tribunal Against Slobodan Milosevic, Milan Milutinovic, Nikola Sainovic, Dragoljub Ojdanic, Vlajko Stojiljkovic, The Hague, The Nederlands, 24 maggio 1999, <http://www.un.org/icty/indictment/english/mil- ii990524e.htm>, consultato il 16 maggio 2003. • United Nations High Commissioner for Refugees Fundraising Report, UNHCR Global Appeal 1999 – Federal Republic of Yugoslavia, 1° dicembre 1998, <http://www.unhcr.ch/cgibin/texis/vtx/home/+7wwBmKeaCJpwwwwkwwwwwwwhFqhT0yfEtFqnp1xcAFqhT0yfEc FqcQd5dVdaWKK8Dzmxwwwwwww/opendoc.htm>, consultato il 19 maggio 2003. • United Nations High Commissioner for Refugees, Kosovo Statistics, “Refugees”, vol. 3, n. 116, 1999, p. 11. • United Nations Mission in Kosovo, Chronology, <http://www.unmikonline.org/chrono.htm>, consultato il 17 maggio 2003. • United Nations Mission in Kosovo, UNMIK at Two: Turning Point for Self-Governance, <http://www.unmikonline.org/2ndyear/unmikat2p3.htm>, consultato il 17 maggio 2003. I.3. NATO • Decisions Taken at the Meeting of the North Atlantic Council on 9th february 1994, 9 febbraio 1994, <http://www.nato.int/docu/pr/1994/p94-015.htm>, consultato il 16 aprile 2003. • Declaration of the Heads of State and Government Participating in the Meeting of the North Athlantic Council, Held at NATO Headquarters, Brussels, on 10-11 January 1994, Bruxelles, 11 gennaio 1994, <http://www.nato.int/docu/pr/1994/p94-003.htm>, consultato il 16 aprile 2003. • KFOR Objective/Mission, <http://www.nato.int/kfor/kfor/objectives.htm>, consultato il 16 maggio 2003. • Press Conference by Jamie Shea and Brigadier General Giuseppe Marani, NATO Headquarter, Bruxelles, 19 aprile 1999, <http://www.nato.int/kosovo/press/p990419a.htm>, consultato il 14 maggio 2003. • Press Conference by NATO Spokesman, Jamie Shea and Air Commodore David Wilby, SHAPE, NATO Headquarter, Bruxelles, 26 marzo 1999, <http://www.nato.int/kosovo/press/p990326a.htm>, consultato il 13 maggio 2003. • Press Conference by Secretary General, Dr. Javier Solana and SACEUR, Gen. Wesley Clark, 25 marzo 1999, <http://www.nato.int/kosovo/press/p990325a.htm>, consultato il 13 maggio 2003. • Press Statement by Dr. Javier Solana, Secretary General of NATO, 23 marzo 1999, <http://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-040e.htm>, consultato il 13 maggio 2003. • Statement by the North Atlantic Council on Kosovo, 30 gennaio 1999, <http://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-012e.htm>, consultato l’11 maggio 2003. • Statement by the Secretary General following the ACTWARN decision, 24 settembre 1998, <http://www.nato.int/docu/pr/pr98e.htm#September>, consultato il 9 maggio 2003. • Statement by the Secretary General of NATO, Dr. Javier Solana, on the Initiation of a Broader Range of Air Operations in the Federal Republic of Yugoslavia, 27 marzo 1999, <http://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-044e.htm>, consultato il 13 maggio 2003. • Statement on Kosovo Issued at the Meeting of the North Atlantic Council in Defence Ministers Session, 11 giugno 1998, <http://www.nato.int/docu/pr/1998/p98-077e.htm>, consultato l’8 maggio 2003. • Statement to the Press by the Secretary General Following Decision on the ACTORD, 13 ottobre 1998, <http://www.nato.int/docu/pr/pr98e.htm#October>, consultato il 10 maggio 2003. I.4. Memorie: volumi • Baker, James A. III, with Defrank, Thomas M., The Politics of Diplomacy: Revolution, War and Peace 1989-1992, New York, G.P. Putnam’s Sons, 1995. • Bildt Carl, Peace Journey: The Struggle for Peace in Bosnia. London, Weidenfeld and Nicolson, 1998. • Boutros-Ghali, Boutros, Unvanquished: A U.S.-U.N. Saga, London, New York, I.B. Tauris Publishers, 1999. • Christopher, Warren, In the Stream of History: Shaping Foreign Policy for a New Era, Stanford, CA, Stanford University Press, 1998. • Clark, Wesley K., Waging Modern War: Bosnia, Kosovo and the Future of Combat , New York, Public Affairs, 2001. • Dini, Lamberto, Fra Casa Bianca e Botteghe Oscure. Fatti e retroscena di una stagione alla Farnesina, Milano, Guerini, 2001. • Holbrooke, Richard, To End a War, New York, Random House, 1998. • Major, John, The Autobiography, London, Harper Colins Publishers, 1999. • Owen, David, Balkan Odissey, London, Victor Gollancz, 1995. I.5. Memorie: articoli • Albright, Madeleine K., The Testing of American Foreign Policy, “Foreign Affairs”, vol. 77, n. 6, novembre/dicembre 1998. • Rubin, James P., A Very Personal War, parte II: The Promise of Freedom, “Financial Times Weekend”, 7-8 ottobre 2000. • Rubin, James P., Countdown to a Very Personal War, “The Financial Times, Weekend”, 30 settembre-1 ottobre 2000, p. IX. • Solana, Javier, NATO’S Success in Kosovo, vol. 78, n. 6, novembre/dicembre 1999. I.6. Stampa coeva • Abdelkrim-Delanne, Christine, Ces armes si peu conventionelles, “Le Monde Diplomatique”, giugno 1999. • Albright, Madeleine K., Yes, There Is a Reason to Be in Somalia, “New York Times”, 10 agosto 1993. • Apple, R. W. Jr., Mediator Is Upset at U.S. Reluctance over Bosnia Talks, “New York Times”, 3 febbraio 1993. • Apple, R. W. Jr., State Dept. Asks War Crimes Inquiry into Bosnia Camps, “New York Times”, 6 agosto 1992. • Butcher, Tim, US Opens Secret Talks on Arming KLA, “Daily Telegraph”, 12 aprile 1999, <http://www.telegraph.co.uk/htmlContent.jhtml?html=%2Farchive%2F1999%2F04%2F12 %2Fwkos112.html&secureRefresh=true&_requestid=354482>, consultato il 15 maggio 2003. • Clinton, William J., Address to the Los Angeles World Affairs Council, 13 agosto 1992, “New York Times”, 14 agosto 1992. • Clinton, William J., Transcript of Speech by Clinton Accepting Democratic Nomination, “New York Times”, 17 luglio 1992. • Gelb, Leslie H., Can Clinton Deal with the World?, “Washington Post”, 6 marzo 1994. • Kissinger, Henry A., At Sea in a New World, “Newsweek”, International Edition, 6 giugno 1994. • Klare, Michael T., Washington veut pouvoir vaincre sous tous les fronts, “Le Monde Diplomatique”, maggio 1999. • Lake, Anthony, The Limits of Peacekeeping, “New York Times”, 6 febbraio 1994. • Masland, Tom, How Did We Get Here?, “Newsweek”, International Edition, 26 settembre 1994. • Morin, Richard (a cura di), An ABC-Washington Post Poll, “Washington Post”, 19 gennaio 1997. • Ramonet, Ignacio, Nouvel ordre global, “Le Monde Diplomatique”, giugno 1999. II. Studi II.1. Volumi • Cameron, Fraser, US Foreign Policy after the Cold War. Global Hegemon or Reluctant Sheriff?, London, Routledge, 2002. • Caplan, Richard, Post-Mortem on UNPROFOR, London, London’s Defence Studies 33, Brassey’s, 1996. • Carter, F. W., Norris, H. T. (a cura di), The Changing Shape of the Balkans, London, UCL Press, 1996. • Cohen, Ben, With no Peace to Keep: United Nations Peacekeeping and the War in the Former Yugoslavia, London, Grainpress Ltd, 1995. • Conforti, Benedetto, Le Nazioni Unite, Padova, Cedam, 1996. • Daalder, Ivo H., Getting to Dayton: The Making of America’s Bosnia Policy, Washington, DC, Brookings Institution, 2000. • Daalder, Ivo H., NATO in the 21st Century: What Purpose. What Missions?, Washington DC, Brookings Institutions Press, 2000. • Di Nolfo, Ennio, Storia delle Relazioni Internazionali 1918-1992, Roma-Bari, Laterza, 1997. • Dogo, Marco, Kosovo, Albanesi e Serbi: le radici del conflitto, Cosenza, Marco Editore, 1992. • Fasce, Ferdianndo, Da George Washington a Bill Clinton. Due secoli di presidenti USA, Roma, Carocci, 2000. • Freedman, Lawrence, Karsh, Efraim, The Gulf Conflict 1990-1991, London, Faber and Faber, 1993. • Gow, James, Triumph of the Lack of Will: International Diplomacy and the Yugoslav War, London, Hurst & Company, 1997. • Gutman, Roy, A Witness to Genocide: The First Inside Account of the Horrors of “Ethnic Cleansing” in Bosnia, Shaftsbury, Longman, 1993. • Honig, Jan Willem, Both, Norbert, Srebrenica: Record for a War Crime, Harmondsworth, Penguin Books, 1996. • Hyland, William G., Clinton’s World: Remaking American Foreign Policy, Westport, CT, Praeger, 1999. • Indipendent International Commission on Kosovo, The Kosovo Report: Conflict, International Response, Lesson Learned, Oxford, Oxford University Press, 2000. • Judah, Tim, Kosovo: War and Revenge, New Haven-London, Yale University Press, 2000; • Kissinger, Henry, Does America Need a Foreign Policy? Toward a diplomacy for the 21st Century, New York, Simon & Schuster, 2001. • Lange, Judith, The War Next Door: A Study of Second Track Intervention During the War in ex-Jugoslavia, Lansdown, Hawthorn Press, 1998. • Leurdijk, Dick A., The United Nations and NATO in Former Yugoslavia: Partners in International Cooperation, The Hague, Netherlands Athlantic Commission, Netherlands Institute of International Relations “Clingendael”, 1994. • Lippman, Thomas W., Madeleine Albright and the New American Diplomacy, Boulder, CO, Westview Press, 2000. • MacKenzie, Lewis, Peacekeeper: The Road to Sarajevo, Vancouver-Toronto, Douglas & McIntyre, 1993. • Malcolm, Noel, Storia della Bosnia: dalle origini ai giorni nostri, Milano, Bompiani, 2000; • Mead, Walter Russel, Il serpente e la colomba, Milano, Garzanti, 2002. • Pavkovic, Aleksandar, The Fragmentation of Yugoslavia: Nationalism and War in the Balkans, New York, St. Martin’s Press, 2000. • Pirjevec, Joze, Le guerre jugoslave 1991 – 1999, Torino, Einaudi, 2001. • Ripley, Tim, Operation Deliberate Force: the U.N. and NATO Campaign in Bosnia 1995, Lancaster, Centre for Defense and Internationa Security Studies, 1999. • Rose, Michael, Fighting for Peace: Bosnia 1994, London, The Harvil Press, 1998. • Scotto, Giovanni, Arielli, Emanuele, La guerra del Kosovo: anatomia di un’escalation, Roma, Editori Riuniti, 1999. • Sharp, Jane M. O., Honest Broker or Perfidious Albion? British Policy in Former Yugoslavia, London, Institute for Public Policy Research, 1997. • Silber, Laura, Little, Allan, The Death of Yugoslavia, Harmondsworth, Penguin Books, 1995. • Tindemans, Leo e altri, Unfinished Peace: Report of the International Commission on the Balkans, Washington, DC, Carnegie Endowment for International Peace, 1996. • Troebst Stefan, Conflict in Kosovo: Failure of Prevention? An Analytical Documentation, 1992-1998, Flensburg, European Centre for Minority Issues, 1998. • Weller, Marc, The Crisis in Kosovo 1989-1999: From the Dissolution of Yugoslavia to Rambouillet and the Outbreak of Hostilities, vol. 1: International Documents and Analysis, Centre of International Studies University of Cambridge, Cambridge, Documents and Analysis Publishing Ltd, 1999. • Woodward, Bob, The Choice, New York, Simon & Schuster, 1996. • Woodward, Susan L., Balkan Tragedy: Chaos and Dissolution after the Cold War, Washington, DC, Brookings Institution, 1995. II.2. Saggi e articoli • Antonenko, Oksana, Russia, NATO and European Security after Kosovo, “Survival, The IISS Quarterly”, vol. 41, n. 4, inverno 1999-2000. • Beelman, Maud S., Dining with the Devil: America’s Tacit Cooperation with Iran in Arming the Bosnian, “Alice Patterson Foundation Reporter”, vol. 18, n. 2, 1997. • Binder, David, Anatomy of a Massacre, “Foreign Policy”, n. 97, inverno 1994-95. • Byman, David L, Waxman, Matthew C., Kosovo and the Great Air Power Debate, “International Security”, vol. 24, n. 4, primavera 2000. • Caplan, Richard, Cristopher’s Hill Road Show, “The World Today”, vol. 54, n. 1, gennaio 1999. • Caplan, Richard, International Diplomacy and the Crisis in Kosovo, “International Affairs”, vol. 74, n. 4, agosto 1998. • Carpenter, Ted Galen, Damage to Relations with Russia and China, in Carpenter, Ted Galen (a cura di), NATO’s Empty Victory: a Postmortem on the Balkan War, Washington, DC, CATO Institute, 2000. • Carpenter, Ted Galen, Kosovo as an Omen: The Perils of the “New NATO” , in Carpenter, Ted Galen (a cura di), NATO’s Empty Victory: a Postmortem on the Balkan War, Washington, DC, CATO Institute, 2000. • Cigar, Norman, How Wars End: War Termination and Serbian Decisionmaking in the Case of Bosnia, “South East European Monitor”, vol. 3 , n. 1 , 1996. • Cigar, Norman, Serb War Effort and Termination of the War, in Magas, Zanic (a cura di), The War in Croatia and Bosnia-Herzegovina, 1991-1995, London, Portland, OR, Frank Cass Publishers, 2001. • Clarke, Walter, Herbst, Jeffrey, Somalia and the Future of Humanitarian Intervention, “Foreign Affairs”, vol. 75, n. 2, marzo/aprile 1996. • Cohen, Lenard J., Russia and the Balkans: pan-Slavism, Partnership and Power, “International Journal, Canadian Institute of International Affairs”, vol. 49, n. 4, autunno 1994. • Crocker, Chester, A Poor Case for Quitting. Mistaking Incompetence for Interventionism, “Foreign Affairs”, vol. 79, n. 1, gennaio/febbraio 2000. • Del Pero, Mario, Romero, Federico, Le Ragioni di una guerra: gli Stati Uniti, “EuropaEurope”, 4/1999 <http://www.europaeurope.it/rivista/9904index.htm>, consultato il 9 maggio 2003. • Freedman, Lawrence, Why the West Failed, “Foreign Policy”, n. 97, inverno 1994-95. • Fubini, Federico, Il bacio di Madeleine, ovvero come (non) negoziammo a Rambouillet, “Limes”, n. 2/99. • Gallagher, Tom, Bosnian Brotherhood, “Transition”, 15 marzo 1995. • Giltman, Maynard, US Policy in Bosnia: Rethinking a Flawed Approach, “Survival, The IISS Quarterly”, vol. 38, n. 4, inverno 1996-97. • Golay, Michael, Foreign Affairs. Americans Shun Policeman’s Lot, in Golay, Michael, Rollyson, Carl (a cura di), Where America Stands: 1996, New York, John Wiley & Sons 1996. • Goldman, Emily O., Berman, Larry, Engaging the World. First Impressions of the Clinton Foreign Policy Legacy, in Campbell, Colin, Rockman, Bert A. (a cura di), The Clinton Legacy, New York, Chatham House Publishers of Seven Bridges Press, 2000. • Gow, James, Bosnia I: Stepping up the Peace?, “The World Today”, vol. 51, n. 7, luglio 1995. • Guicherd, Catherine, International Law and the War in Kosovo, “Survival, The IISS Quarterly”, vol. 4, n. 2, estate 1999. • Heigh-Phippard, Helen, The Contact Group on (and in) Bosnia: an Exercise in Conflict Mediation?, “International Journal”, vol. 53, n. 2, primavera 1998. • Hibbert, Reginald, War Among the South Slavs in the Wider Balkan Context, “International Relations”, vol. 12, n. 3, dicembre 1994. • Hoare, Marko Attila, Civilian-Military Relations in Bosnia-Herzegovina 1992-1995, in Magas, Zanic (a cura di), The War in Croatia and Bosnia-Erzegovina, 1991-1995, London, Portland, OR, Frank Cass Publishers, 2001. • International Institute for Strategic Studies, Air-Power over Kosovo: A Historic Victory?, “Strategic Comments”, vol. 5, n. 7, settembre 1999. • Jatras, James George, NATO's Myths and Bogus Justifications for Intervention, in Carpenter, Ted Galen (a cura di), NATO’s Empty Victory: a Postmortem on the Balkan War, Washington, DC, CATO Institute, 2000. • Judah, Tim, Kosovo’s Road to War, “Survival, The IISS Quarterly”, vol. 41, n. 2, estate 1999. • Kissinger, Henry A., Kosovo and the Vicissitudes of American Foreign Policy, in William J. Buckley (a cura di), Kosovo: Contending Voices on Balkan Interventions, Grand Rapids, MI, William B. Eerdmans Pub., 2000. • Layne, Christopher, Collateral Damage in Yugoslavia, in Carpenter, Ted Galen (a cura di), NATO’s Empty Victory: a Postmortem on the Balkan War, Washington, DC, CATO Institute, 2000. • Levitin, Oleg, Inside Moscow’s Kosovo Muddle, “Survival, The IISS Quarterly”, vol. 42, n.1, primavera 2000. • Lok, Joris Janssen, “Deny Flight” Turns to Affirmative Action, “Jane’s Defe nse Weekly”, 9 settembre 1995. • Losi, Natale, Passerini, Luisa, Salvatici, Silvia (a cura di), Archives of Memory: Supporting Traumatized Communities through Narration and Remembrance, “Psychosocial Nootebook”, vol. 2, October 2001. • Luttwak, Edward N., Give War a Chance, “Foreign Affairs”, vol. 78, n. 4, luglio/agosto 1999. • Mackinlay, John, Ready for Kosovo?, “The World Today”, vol. 54, n. 6, giugno 1999. • Magas, Branka, Zanic, Ivo (a cura di), The War in Croatia and Bosnia-Herzegovina, 19911995, London, Portland, OR, Frank Cass Publishers, 2001. • Mandelbaum, Michael, A Perfect Failure. NATO’S War Against Yugoslavia, “Foreign Affairs”, vol. 78, n. 5, settembre/ottobre 1999 • McGwire, Michael, Why Did We Bomb Belgrade?, “International Affairs”, vol. 76, n. 1, gennaio 2000. • Meron, Theodor, Answering for War Crimes: Lessons from the Balkans, “Foreign Affairs”, vol. 76, n.1, gennaio- febbraio 1997. • Moore, Patrik, January in Bosnia, “Transition”, 30 gennaio 1995. • Mylroie, Laurie, U.S. Policy toward Iraq, “Middle East Intelligence Bulletin”, vol. 3, n. 1, gennaio 2001. • Nicholls, D. V., Bosnia: UN and NATO, “The World Today”, vol. 53, n. 2, febbraio 1997. • Nye, Joseph S. Jr., Redefining the National Interest, “Foreign Affairs”, vol. 78, n. 4, luglio/agosto 1999. • Palmisano, Giuseppe, La guerra “umanitaria”. Il caso del Kosovo, in Bimbi, Linda (a cura di), Not in My Name. Guerra e diritto, Roma, Editori Riuniti, 2003. • Pond, Elisabeth, Kosovo, Cathalist for Europe, “The Washington Quarterly”, vol. 22, n. 4, autunno 1999. • Posen, Barry R., The War for Kosovo: Serbia’s Political-Military Strategy, “International Security”, vol. 24, n. 4, primavera 2000. • Pula, Gazmend, Modalities of Self-Determination – The Case of Kosova as a Structural Issue for Lasting Stability in the Balkans, “Sudosteuropa”, vol. 45, n. 4-5, 1996. • Rabia, Ali, Liftschultz, Lawrence, Why Bosnia?, “Third World Quarterly, Journal of Emerging Areas”, vol. 15, n. 3, settembre 1994. • Ripley, Tim, Air War in Bosnia, “Motorbooks International”, 1996. • Roberts, E., Next Balkans Flashpoint?, “The World Today”, vol. 54, n. 4, aprile 1999. • Robinson, Paul, “Ready to Kill but not to Die”: NATO Strategy in Kosovo, “International Journal”, vol. 54, n. 4, autunno 1999. • Rodman, Peter W., The Fallout from Kosovo, “Foreign Affairs”, vol. 78, n. 4, giugno/agosto 1999. • Romero, Federico, Economia e politica, in Romero, Federico, Valdevit, Giampaolo, Vezzosi, Elisabetta, Gli Stati Uniti dal 1945 ad oggi, Roma-Bari, Laterza, 1996. • Rose, Gideon, The Exit Strategy Delusion, “Foreign Affairs”, vol. 77, n. 1, gennaio- febbraio 1998. • Schild, Georg, The USA and Civil War in Bosnia, “Aussenpolitik”, vol. 47, n. 1, 1996. • Schmidt, Fabian F., Teaching the Wrong Lesson in Kosovo, “Transition”, 12 luglio 1996. • Schulte, Gregory L., Former Yugoslavia and the New NATO, “Survival, The IISS Quarterly”, vol. 39, n.1, primavera 1997. • Sharp, Jane M. O., Dayton Report Card, “International Security”, vol. 22, n. 3, inverno 1997-98. • Steinberg, James B., A Perfect Polemic. Blind to Reality on Kosovo, “Foreign Affairs”, vol. 78, n. 6, novembre/dicembre 1999. • Taylor, Philip M., Propaganda and the Web War, “The World Today”, giugno 1999. • Tharoor, Shashi, United Nations Peacekeeping in Europe, “Survival, The IISS Quarterly”, vol. 37, n. 2, estate 1995. • Udovicki, Jasminka, Stitkovac, Ejub, Bosnia and Hercegovina: The Second War, in Udovicki, Jasminka, Ridgeway, James (a cura di), Burn This House: The Making and Unmaking of Yugoslavia, Durham, London, Duke University Press, 1997. • Valdevit, Giampaolo, Politica estera, in Romero, Federico, Valdevit, Giampaolo, Vezzosi, Elisabetta, Gli Stati Uniti dal 1945 ad oggi, Roma-Bari, Laterza, 1996. • Walt, Stephen M., Two Cheers for Clinton’s Foreign Policy, “Foreign Affairs”, vol. 79, n. 2, marzo/aprile 2000. • Wolfowitz, Paul, “The United States and Iraq” , in Calabrese, John (a cura di), The Future of Iraq, Washington, DC, Middle East Institute, 1997. • Woodward, Susan L., The United States Leads, Europe Pays, “Transition”, 12 luglio 1996. II.3. Altri studi • Osservatorio sui Balcani, Dossier per paese : Kossovo (USM), <http://www.osservatoriobalcani.org>, consultato il 18 maggio 2003. • Osservatorio sui Balcani, Dossier RFY (Serbia <http://www.unimondo.org/balcani/dossier/serbia/index-2000.html>, e Montenegro), consultato il 18 maggio 2003. • Osservatorio sui Balcani, Dossier/approfondimenti: Djindjic: un omicidio politico, 19 marzo 1999, <http://www.osservatoriobalcani.org>, consultato il 16 maggio 2003. • Osservatorio sui Balcani, Guida – Bosnia Erzegovina, <http://www.osservatoriobalcani.org>, consultato il 29 aprile 2003. • Ware, Richard, Watson, Fiona, Dodd, Tom, Bosnia: Update and Supplementary Information, Research Paper, 95/69, House of Commons Library, 30 maggio 1995. • Watson, Fiona, Dodd, Tom, The Dayton Agreement: Progress in Implementation, House of Commons Library, Research Paper, 96/80, 9 luglio 1996. • Watson, Fiona, Ware, Richard, Bosnia, the U.N. and the NATO Ultimatum, House of Commons Library, Research Paper, 94/33, 17 febbraio 1994. • Youngs, Tim, Dodd, Tom, Kosovo, Research Paper, 98/73, House of Commons Library, 27 ottobre 1998. • Youngs, Tim, Kosovo: The Diplomatic and Military Options, Research Paper, 98/93, House of Commons Library, 7 luglio 1998. • Youngs, Tim, Oakes, Mark, Bowers, Paul, Kosovo: NATO and Military Action, Research Papers, House of Commons Library, 99/34, 24 marzo 1999. • Youngs, Tim, Oakes, Mark, Bowers, Paul, Kosovo: Operation “Allied Force”, Research Paper, 99/48, House of Commons Library, 29 aprile 1999.
Scarica