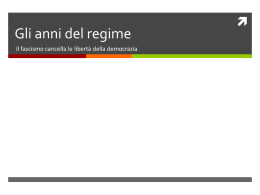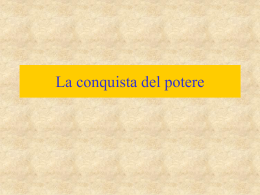l’antifascista mensile degli antifascisti di ieri e di oggi Fondato nel 1954 da Sandro Pertini e Umberto Terracini anno LIX - n° 1, 2, 3 - Gennaio - Febbraio - Marzo 2012 L’editoriale di Antonella Amendola Se penso che il primo direttore è stato Sandro Pertini mi viene un brivido e mi sento piccola piccola. Cari lettori, nell’assumere la direzione dell’Antifascista forte è la commozione, perché questo giornale ha accompagnato la vita della mia famiglia e di tante persone care: lo ricordo nel formato più grande, ben impilato nella severa biblioteca di mio padre Pietro Amendola. Fin da bambina ero curiosa di leggerlo, andavo soprattutto a cercare tra le pagine le fotografie, perché quei volti di persone sobrie, dallo sguardo leale, sapevano raccontarmi con semplicità e concretezza le mille storie dell’antifascismo italiano, tutte diverse e pur tutte uguali nel comune denominatore di rigore morale e amore per la libertà. L’antifascista è qualcosa di più di una pubblicazione cartacea, è quasi un piccolo organismo vivente che racchiude il tesoro inestimabile dell’esperienza vissuta e della memoria: i padri lo consegnano ai figli con trepidazione. Sono passati tanti anni, viviamo in un altro secolo, in un altro millennio, eppure quella tragica vicenda di dittatura, violenza, guerra che il nostro Paese ha vissuto rimane vicina, ancora ci inquieta. Troppo evidente è stata, da parte di certi ambienti, in tempi recenti, la tentazione di rovesciare il tavolo delle regole e di oscurare la Costituzione. Troppo smaccata la corsa verso l’illegalità conclamata. Del resto non vivremmo oggi la stagione del governo tecnico se la politica, nel senso più nobile della parola, avesse mantenuto saldo nelle sue mani il governo della difficile situazione. C’è ancora bisogno di antifascisti, cari lettori. Noi siamo sentinelle vigili pronte a cogliere i malesseri derivanti dal mancato riconoscimento dei diritti delle minoranze, dai nuovi 10 febbraio Giorno del ricordo e suoi equivoci Nazionalismi, fascismo, nazismo, comunismo in Venezia Giulia, Istria, Dalamazia di Nicola Terracciano Uno storico degno di questo nome non teme di affrontare con coraggio, lucidità, alcun tema, perché egli è mosso, deve essere mosso solo dallo “spirito di verità”, cercando di avvicinarsi con scrupolo di informazione e di metodo, per quanto è possibile (essendo la vicenda storica di una complessità inimmaginabile), sulla segue a pagina 2 Manifesto ufficiale del Giorno del Ricordo 2012 I luoghi della storia Attualità Convegno Bufalini a pagina 5 PORTA S. PAOLO di Mario Tempesta È tra le più imponenti e meglio conservate porte originali dell’intera cerchia muraria di Roma Antica risalente al III secolo d.C., forse sul luogo ov’era la Porta Raudusculana. Ad oriente ed occidente della Piramide Cestia (fatta edificare dal septemviro Caio Cestio Epulone tra il 18 e 12 a.C.) furono costruite due porte che davano il passo alla Via Ostiense, la strada che collega Roma ad Ostia - e quindi al suo antico porto, e ad una sua biforcazione tracciata nell’immediato esterno delle Mura. La duplicazione dell’asse stradale e degli ingressi urbani era stata necessaria dall’intensità dei traffici tra Roma e il Porto di Ostia. E la Piramide, quasi come un immenso spartitraffico, divideva l’ingresso orientale, che dava origine al “Vicus portae Raudusculanae” fino alla sommità dell’Aventino, da quella occidentale che portava alla vera via Ostiense verso gli “horrea”, i granai, della “Marmorata” lungo le sponde del Tevere. Quest’ultima fu edificata come una piccola porta ma venne presto chiusa sia per la crescita d’importanza del porto segue a pagina 12 Poste Italiane s.p.a. - spedizione in abbonamento D.L. 353/2003 (conv.in. L. 46 del 27.02.2004) - Art.1, comma 2, DCB - Roma Cultura Pino Aprile a pagina 8 Memorie Renzo Laconi a pagina 16 Noi Garibaldo 100 anni a pagina 18 Lettere ... a Terracciano a pagina 23 2 Attualità L’editoriale razzismi, dalle politiche che non perseguono l’interesse nazionale, la promozione del lavoro, dei giovani, delle donne, ma solo i propri miopi interessi di cassetta, la disgregazione territoriale. Troverete un giornale rinnovato e più ricco di rubriche, più al passo coi tempi. Ma come sempre il meglio arriverà da voi, con i vostri contributi, con la testimonianza della vita associativa dell’Anppia, il cui presidente Guido Albertelli voglio oggi ringraziare per la fiducia che mi dà. Ricordatevi che i grandi protagonisti che hanno qualcosa da insegnare siete voi. base di documenti (senza documenti non c’è storia, ma altra cosa), a come sono andati “realmente”, “veramente” i fatti. Le vicende storiche che hanno toccato le comunità di cultura, di lingua italiane in Venezia Giulia (con epicentro Trieste), l’Istria (con epicentro Pola e Fiume), la Dalmazia (con epicentro Zara e Spalato) sono complesse e intricate ed ancora oggi dividono e arroventano la memoria collettiva. Quelle aree hanno conosciuto insediamenti di origine veneziana, quindi di cultura italiana, dall’epoca medievale, legati all’espansione economica, culturale della “Serenissima Repubblica di Venezia”, che aveva il dominio dell’Adriatico, divenuto per secoli quasi un lago veneziano, contendendolo da un lato al mondo musulmano e dall’altro al mondo austriaco, che si era impadronito dell’area di Trieste dal 1382 (che conserverà tuttavia una larga autonomia e rivendicherà sempre la sua appartenenza, a partire dalla lingua, alla civiltà italiana) e poi di quasi tutta l’area iugoslava odierna (dalla Slovenia, alla Croazia, alla Serbia). Nei secoli le comunità di civiltà italiana si sono concentrati nell’area costiera, distinguendosi socialmente ed economicamente dalle aree interne, abitate da comunità slovene, croate, serbe, montenegrine, di diversa cultura, religione (ortodossa, islamica), di diversa economia, contadina, più che cittadina e commerciale. Questo dualismo, pur implicando uno strisciante stato endemico di tensione, non aveva provocato situazioni conflittuali clamorose fino alla crisi dell’impero multietnico austriaco che, di fronte al processo nazionale italiano ottocentesco, per contrastarlo, appoggiò da un lato un sentimento-anti-italiano negli sloveni e nei croati, largamente utilizzati nella repressione dei moti nazionali italiani, sia alimentando un nazionalismo serbo, sempre in funzione anti-italiana, secondo la tattica antica del dividere, per continuare a governare quel complesso impero di origine medievale. Risale quindi all’Austria, nella sua opposizione al processo di unificazione italiana, la prima lucida politica di aizzamento degli odi tra italiani e sloveni, croati, serbi, che avrà altri dolorosi capitoli tra Ottocento e Novecento. Si ebbero interventi repressivi contro l’identità italiana delle comunità esistenti all’interno dell’impero asburgico, colpendo scuole, tradizioni, ruoli sociali, suscitando per reazione nelle comunità italiane quel fenomeno storico che si chiama “irredentismo”, il desiderio cioè di ricongiungersi alla madrepatria italiana, a quella civiltà italiana, che erano la matrice della loro identità storica. L’Italia nello slancio ancora risorgimentale rispose a quell’appello entrando per questo motivo nella I guerra mondiale, accettata e sentita come quarta guerra di indipendenza dall’Austria, per completare il processo di unificazione con il ritorno del Trentino, della Venezia Giulia, dell’Istria e delle comunità costiere della Dalmazia. Questa era la sostanza dell’accordo segreto di Londra, col quale nel 1915 il Regno d’Italia entrò in guerra contro l’Austria, la Germania, la Turchia. La vittoria con un prezzo inimmaginabile di sacrifici e di morti (600.000 morti e 1.200.000 feriti su una popolazione intorno ai venti milioni, che provocò una voragine generazionale, delle migliori energie giovanili del paese, che fu la causa profonda della crisi del dopoguerra) significò il sostanziale compimento del Risorgimento con il ricongiungimento di Trento, Trieste, Gorizia, l’Istria, ma con limitazioni nei confronti degli accordi, nel senso che rimasero fuori le comunità dalmate, compensate con la conquista dell’Alto Adige, del Sud Tirolo austriaco. Si aprì allora una divisione politica ed ideologica nel paese, con il mito falso della “vittoria mutilata”, portata avanti da ambienti nazionalisti (si pensi a D’Annunzio) e del primo fascismo, che arroventò i rapporti tra il Regno d’Italia ed il neonato Regno di Iugoslavia, che rivendicava secondo lo stesso principio nazionale richiamato dagli italiani la maggioritaria presenza croata, slava da Fiume in giù, appoggiato dalle altre potenze vincitrici come Francia, Inghilterra, Stati Uniti (col presidente Wilson). Sarebbe occorso il prevalere della linea della preveggente saggezza di un Gaetano Salvemini, che proponeva (con accuse isteriche subìte di “disfattista”) di cedere l’Alto Adige, meglio Sud Tirolo, territorio sostanzialmente austriaco, di lingua e cultura tedesche (come è anche oggi) e richiedere dall’alto di questo comportamento il riconoscimento dei diritti storici delle comunità italiane costiere della Dalmazia. Invece prevalse un atteggiamento accesamente nazionalista italiano, accortamente utilizzato dal fascismo nella sua propaganda e nel suo affermarsi. Mussolini definiva gli slavi barbari, il cui numero non poteva essere titolo di diritti contro gli esponenti minoritari della secolare civiltà italiana. Quando ci fu l’avvento pieno del totalitarismo nero, fu attuata “una italianizzazione forzata e violenta” di tutti i territori conquistati con la I guerra mondiale, dall’Alto Adige, all’Istria, colpendo l’uso della lingua, i sistemi scolastici, le forme organizzative austriache, slovene, croate, slave, suscitando una reazione sorda anti-italiana e antifascista, ponendo le basi delle tragedie successive. Risale quindi al fascismo in modo massiccio e diretto la principale responsabilità delle sanguinose vicende dei decenni successivi. Con la conquista della Iugoslavia nel 1941 tra Germania nazista e Italia fascista, ci fu un ulteriore processo di italianizzazione forzata, estesa alla Slovenia, ad aree croate, che non poteva non suscitare, come in altre aree dell’Europa, una “Resistenza iugoslava” che ebbe varie 3 Attualità La scomparsa di Giorgio Bocca Era un giornalista non comune. Non comune per molti aspetti. Per esempio era sincero, roccioso, presuntuoso. Un po’ il carattere degli uomini piemontesi di Giustizia e Libertà che frequentò durante la Resistenza, periodo formativo della sua giovinezza. Di fatto quando incontrava una persona che non gli piaceva, sparava con la penna e così si fece molti nemici. Il suo pregio era la sincerità, l’amore per la verità e la ricerca della documentazione Quello che pochi giornalisti hanno, come lui, è l’efficacia dello scritto, la sintesi del pensiero, il destare piacere nella lettura. Viveva negli ultimi anni in un Paese che non sentiva suo, così lontano da quello per cui aveva combattuto, così che la denuncia era l’aspetto più comune nei suoi articoli. Nei suoi libri più recenti predominante era l’amore per la sua terra, per i posti nei quali aveva fatto il partigiano, le montagne dove d’inverno è freddo, il mitra nella neve e dove nei casali dei contadini si poteva trovare un po’ di caldo, senza paura del tradimento. Noi antifascisti l’abbiamo amato perché lo sentivamo nostro e nostre sentivamo le sue battaglie giornalistiche contro il sistema senza ideali che ci attanaglia da anni. Bocca assomigliava molto a Enzo Biagi nella qualità della persona e nel coraggio rispetto ai potenti. Non per caso entrambi facevano parte delle formazioni Giustizia e Libertà. Giorgio Bocca Guido Albertelli componenti ideologiche e politiche (dagli autonomisti ai comunisti, ai socialisti, ai monarchici). La repressione fascista fu durissima con crimini di guerra (fucilazioni, distruzioni di villaggi con eccidi di bambini, donne, bambini), per i quali la Iugoslavia ha invano nel dopoguerra richiesto di processore criminali italiani, come il generale Roatta (già implicato nel delitto fascista dei Fratelli Rosselli in Francia). Il baratro degli odi tra italiani, visti tutti come fascisti assassini direttamente o complici, e l’elemento sloveno, croato, serbo si accrebbe, fino a divenire un abisso, che fu alla base degli eccidi degli anni successivi, così come avvenne in tante altre parti dell’Europa orientale. Sono stati il fascismo, anzitutto, soprattutto, e il nazismo, ad essere responsabili di fronte al tribunale della storia e dell’umanità, perché sono stati essi con i loro comportamenti storici di violenza e prepotenza disumane a creare le condizioni storiche tragiche e terribili delle rese di conti, delle vendette che da parte slovena, croata, serba, si sono avute negli anni successivi. Il fascismo si rese ulteriormente responsabile anche dopo la sua caduta a Roma nel luglio 1943, quando Mussolini, liberato da Hitler, costituì nel Centro-Nord la nuova versione fascista-nazista della Repubblica Sociale di Salò, attuando con i nazisti ulteriori crimini, collaborando anche per lo sterminio degli ebrei, per la Shoah, che si svolse anche in territorio italiano con il campo di sterminio della Risiera di San Saba a Trieste. La Resistenza iugoslava, specialmente nella sua componente comunista, che faceva capo a Tito, portò avanti azioni di vendetta in modo maggioritario contro fascisti che si erano macchiati di crimini o di attiva complicità con il regime, ma coinvolse anche innocenti, che furono atrocemente massacrati e buttati negli inghiottitoi carsici dell’area, chiamati, “foibe”, o annegandoli con pietra al collo lungo la costa. Le cifre parlano di 5.000-15.000 vittime tra il 1943-1945, comprendendo anche quelli che furono mandati in campi di concentramento, dove morirono per le condizioni drammatiche di quegli ambienti. Già allora cominciò il primo esodo giuliano-dalmata, quello che si definisce “l’esodo nero”, cioè di quei fascisti direttamente o indirettamente responsabili di crimini e azioni poco chiare, che scapparono. Gli aspetti atroci di quelle vendette e del successivo tragico fenomeno dell’esodo di circa 250.000 italiani della Venezia Giulia, dell’Istria, della Dalmazia dopo il 1945 e fino al 1956 sono da imputare al totalitarismo comunista iugoslavo, che impose un regime unico violento e una slavizzazione forzata di quei territori, coinvolgendo nella repressione non solo gli italiani, ma anche gli oppositori anti-comunisti. Quei 250.000 italiani costretti all’esodo furono ospitati in 109 campi disseminati in varie parti d’Italia o emigrarono in altri paesi, integrandosi a poco a poco nella Comunità italiana, pur con episodi e momenti infami di settori della componente comunista italiana, che li giudicava con gli occhi ideologici di filo-fascisti o di anticomunisti. Quindi nella fase finale delle vendette atroci e dell’esodo è stato il terzo tragico totalitarismo del Novecento, quello comunista, pur nella versione titoista, non russa, (che portò simpatie occidentali ad esso e quindi tendenza a non chiamarlo al tribunale della storia) ad essere il responsabile, accanto al fascismo, al nazismo già richiamati, a provocare la tragedia giuliano-dalmata. Essa non può assolutamente essere messa a confronto con la Shoah, sia per le dimensioni numeriche (si pensi solo ai 6 milioni di morti ebrei, di cui due milioni di bambini), sia per le forme demoniache di eliminazione, sia perché gli ebrei non si erano macchiati di alcun fenomeno di violenza contro 4 Attualità i tedeschi, gli italiani, gli austriaci, i polacchi o altri popoli che in modo diretto o indiretto collaborarono allo sterminio. Chiunque compie questo paragone è un infame di fronte alla storia e all’umanità. Gli unici che non possono e non devono ricordare la tragedia giulianodalamata sono i fascisti e loro eredi, perché sono essi i principali responsabili, con i nazisti e i comunisti, di quell’evento. Possono farlo con spirito di umanità e di giustizia storica solo quelli che non sono stati e non sono fascisti-postfascisti, clericali, comunisti-postcomunisti. È giusto il “Giorno del Ricordo”, è giusto che un popolo si pieghi a esplorare momenti neri e duri della propria storia, ma non doveva essere scelto il 10 febbraio, sia perché troppo vicino al 27 gennaio, “Giorno della Memoria” della Shoah, sia perché contesta sostanzialmente (in modo equivoco e indegno) quel trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947 tra l’Italia e le Potenze Alleate, che è vero segnò la concessione di quelle aree alla Iugoslavia, come avvenne per decine e decine di aree dell’Europa (si pensi al ritorno di aree tedesche alla Polonia), ma non implicò ad esempio la divisione dell’Italia, come avvenne per la Germania. L’Italia, pur essendo una delle principali responsabili con il suo totalitarismo fascista della più devastante e disumana guerra della storia, alleata con il totalitarismo nazista di Hitler e di Auschwitz, del militarismo giapponese, non fu punita con la divisione del paese, come avvenne per la Germania, ad esempio, e quindi quel trattato del Resti dalle foibe da: blog.armandoleotta.com 10 febbraio non va condannato e collegato ad un evento di disumanità. Era il massimo che si poteva concedere ad una nazione responsabile e sconfitta e l’Italia fu salvata da altre punizioni giuste solo per la dignità di popolo espressa dall’antifascismo e dalla Resistenza, come richiamarono solennemente i presidenti del consiglio dopo la Liberazione, Ferruccio Parri, uno dei capi della Resistenza, ed Alcide De Gasperi, che firmò a Parigi il trattato. Il “Giorno del Ricordo”, pur doveroso, anche per l’ostracismo che veniva e viene dal mondo comunista e postcomunista e dagli ambienti militari, doveva avere altra data, altro richiamo e stare lontano dal 27 gennaio. Esso è stato volpinamente, machiavellicamente approvato come legge della Repubblica del 30 marzo 2004 n. 92 con il II Governo Berlusconi, che aveva l’appoggio di forze di derivazione fascista o post-fascista (e le doveva quindi assecondare e premiare) e al suo interno anche fascisti espliciti (come Tremaglia) o post-fascisti (come Fini, Alemanno, Gasparri), clericali come Buttiglione, leghisti indegni, nemici dell’Italia, che hanno appoggiato ogni iniziativa che implicava e implica critica all’Italia come nazione, trasformisti e traditori di tutte le risme, incapaci di uno scatto di dignità di fronte alla propria storia e alla storia del proprio paese. Fascisti, post-fascisti, clericali, leghisti si sono impadroniti di un evento, così strumentalizzandolo e offendendolo, che potesse servire ad oscurare o attenuare soprattutto, anzitutto l’effetto dirompente annuale del “Giorno della Memoria” del 27 gennaio, che chiama continuamente e giustamente e impietosamente al tribunale della memoria e della storia fascisti e clericali, qualunquisti e opportunisti. Come ulteriore tentativo volpino, machiavellico, di contrapporsi al 27 gennaio, quel governo ha approvato e considerato il 10 febbraio come “solennità civile” (art. 1, comma 3), qualifica e riconoscimento che non ha il “Giorno della Memoria” della Shoah (vedi il testo della legge 20 luglio 2000, n.211). Il fatto che il 10 febbraio sia solennizzato spesso solo da ambienti fascisti, post-fascisti e clericali (che non hanno nessun titolo a farlo, anzi sono i responsabili di quella tragedia), nell’ostracismo, nel disinteresse delle forze comuniste e post-comuniste, testimonia come su questa vicenda ci sia non un doveroso e solenne impegno di verità e di umanità, ma sostanzialmente, secondo una considerazione personale, una lotta sorda e infame ideologica, di potere e di memoria tra l’egemone potere possente clerical-fascista-postfascista e suoi servi o utilizzatori opportunisti (tipo Berlusconi col codazzo di traditori di tutte le risme del suo governo e del suo schieramento, tipo Bossi col suo infame leghismo secessionista), interessati soprattutto ad allontanare al massimo da sé il collegamento con la Shoah e ad appiattire antistoricamente fascismo, nazismo, comunismo, quando il comunismo è stato dal 1941 al 1945 in prima linea alleato di Stati Uniti, Inghilterra, Francia contro nazismo, fascismo, militarismo giapponese con un costo di milioni e milioni di morti e che il campo di sterminio nazista di Auschwitz fu liberato emblematicamente dall’Armata Rossa, e il mondo comunista-post-comunista, ferocemente attaccato al suo potere, ancora possente e pervasivo, incapace di una doverosa autocritica feroce di tanti aspetti tragici del passato comunista, leninista e stalinista, nazionale e internazionale. Attualità Un convegno di successo nel decennale della scomparsa Paolo Bufalini e la costruzione dell’Italia democratica Negli interventi ricordato l’antifascista, l’uomo politico, l’umanista di Jolanda Bufalini I l 15 dicembre 2011 si è tenuto a palazzo Giustiniani un convegno in ricordo di Paolo Bufalini a 10 anni dalla morte. L’iniziativa si è svolta a palazzo Giustiniani, in una affollata sala Zuccari. La prestigiosa sede del Senato è stata scelta e concessa perché Paolo Bufalini è stato senatore dal 1963 al 1992: trenta anni cruciali della prima repubblica durante i quali egli ha dato il suo contributo alla costruzione della democrazia e di una maggiore giustizia sociale, in battaglie epocali che vanno dalla difesa dei braccianti agricoli di Avola, contro cui, il 2 dicembre 1968, la polizia aprì il fuoco, all’impegno per il superamento della Guerra Fredda, al lavoro – in collaborazione con il presidente del Consiglio di allora Bettino Craxi, per il nuovo Concordato. Tante erano le persone arrivate da Roma, i tanti che sono stati suoi compagni di partito o anche avversari ma che avevano nei suoi confronti stima e affetto (cito fra gli altri Alfredo Reichlin, Antonio Rubbi, Mario Quattrucci, Gianni Cervetti, Giulio Spallone, Bice e Franca Chiaromonte, Marisa Rodano, sapendo di fare torto ai moltissimi che ci hanno onorato della loro presenza), tanti giovani come l’attuale segretario del Pd romano Marco Miccoli, dalla Sicilia (Mimmi Bacchi, Simona Mafai, Marina Marconi), dall’Abruzzo (dove papà è ricordato in particolare per le lotte nelle terre dei Torlonia, nel Fucino, e dove, ora, mio fratello Marcello svolge principalmente la sua attività di musicista), da Bologna, dove viveva mio fratello Delio e, poiché i nipoti di Paolo sono sparsi a studiare in diversi paesi d’Europa, Alessandro Bufalini e Luca Mazzacuva sono arrivati dalla Spagna e dall’Olanda, Francesco Mazzacuva da Milano. Giovani e anziani mescolati, in una combinazione che apre il cuore perché tiene insieme, nel ricordo di una persona a molti cara, la storia di generazioni diverse. Tanta era la gente, che era affollata anche una saletta adiacente collegata in videoconferenza. Il convegno è stato il frutto di una mia proposta a cui hanno risposto con entusiasmo e prontezza Guido Il presidente Napolitano saluta i relatori prima del convegno dal sito del Quirinale Albertelli, presidente dell’Anppia e Giuseppe Vacca, presidente del Gramsci, e si è avvalso della preziosa collaborazione di Giovanni Matteoli, che è stato per molti anni stretto collaboratore di Paolo e ora lavora presso la presidenza della Repubblica nello staff di Giorgio Napolitano, di Silvio Pons (direttore della fondazione Gramsci), di Giuseppe Mennella, funzionario alla presidenza del Senato, di Simonetta Carolini dell’Anppia, di Franca Franchi del Gramsci. In prima fila, su uno scranno al centro della Sala sedeva, ad ascoltare il contributo dei relatori, il capo dello Stato Giorgio Napolitano, che con Paolo ha condiviso, nel Pci, battaglie e impostazione ideale, entrambi collocati nell’area riformista di quel grande partito che ha organizzato nell’antifascismo e nei primi 50 anni della Repubblica il mondo del lavoro. In sala c’erano anche Clio e il figlio maggiore di Napolitano, Giovanni, coetaneo e amico, soprattutto, di mio fratello Marcello: il rapporto fra le famiglie Napolitano e Bufalini, infatti, è stato non solo politico ma di amicizia e consuetudine di incontri, nelle case o anche, in occasione di festività, di pranzi insieme. Il mondo di relazioni amicali di mio padre era vastissimo, non solo politico perché egli era persona di grande cultura. Non dico un intellettuale perché Paolo considerava la sua posizione di politico colto come “superiore” a quella dell’intellettuale puro, che spesso – secondo la sua idea – con l’impoliticità pecca di schematismo. Fra i suoi amici c’erano poeti, come Michele Parrella e storici (Santo Mazzarino, Paolo Spriano, Giuseppe Boffa), artisti (Renato Guttuso). Nel tempo che io ricordo, le sue frequentazioni più assidue alle quali alla passione politica si combinava l’amicizia che coinvolgeva le famiglie erano queste: Giorgio e Pietro Amendola, Enrico e Letizia Berlinguer, Maurizio e Marcella Ferrara, Franco e Giuliana Ferri, Pietro e Laura Ingrao, Pio e Giuseppina La Torre, Emanuele Macaluso, Giorgio e Clio Napolitano, Antonello e Fulvia Trombadori. Un gruppo di romani: Annamaria Ciai e Renzo Trivelli, Claudio Verdini e Giuliana Gioggi. Il medico di Togliatti, Mario Spallone e il compagno di lotte in Abruzzo, Giulio Spallone. Prima del 1968 c’era anche Aldo Natoli, ancora negli album fotografici ci siamo noi ragazzini con i figli dei Natoli. Ma con la scissione del Manifesto i rapporti si interruppero, tale era la durezza dell’epoca. Prima ancora, a Palermo, i Colajanni, Panzieri, Lombardo Radice. Una grande amicizia ci fu a Roma con Pancrazio De Pasquale che le lotte politiche interne avevano allontanato da Palermo quando mio padre vi arrivò Al convegno del 15 dicembre 2011 gli oratori che hanno rievocato le diverse fasi della vita di Bufalini sono stati il presidente del Senato Renato Schifani, la presidente del gruppo Pd Anna Finocchiaro, Emanuele Macaluso, Albertina Vittoria, 5 6 Attualità Nicola Mancino, Ivano Dionigi, Gennaro Acquaviva, Guido Albertelli, Giuseppe Vacca; non mi dilungo sugli interventi perché l’Anppia sta preparando la pubblicazione degli atti. Il presidente della Repubblica non ha parlato in quella occasione ma ha trovato il modo di ricordare Paolo Bufalini poco dopo, in occasione della cerimonia per la laurea honoris causa tributatagli dalla Università di Bologna. Riportiamo dall’articolo di Ilaria Venturi apparso su Repubblica Bologna il 30 gennaio 2012: “Napolitano ha tenuto a far avere al rettore Ivano Dionigi anche un altro testo, ricordando il comune interesse intellettuale che li lega alla figura del senatore Paolo Bufalini: l’Ode rivolta a Mecenate di Orazio tradotta dallo stesso Bufalini «curando sino alle sfumature». Il Capo dello Stato ha concluso la sua lezione magistrale non a caso ricordando Nino Andreatta e Paolo Bufalini per «la stesura della risoluzione in Senato nell’autunno del 1977 con cui per la prima volta anche il maggior partito della sinistra italiana si riconobbe nell’impegno europeistico e nell’alleanza Nato». Il Centro studi per la permanenza del classico dell’Ateneo di Bologna, fondato da Dionigi e ora diretto dai I partecipanti nella Sala Zuccari del Senato dal sito del Quirinale suoi allievi, sta pubblicando la nuova edizione delle traduzioni di Orazio e i quaderni con gli appunti personali dello stesso Bufalini. Per questo Napolitano ha anche portato una dedica a lui dello stesso Bufalini in latino, elogio a un suo discorso: «Tibi gratulor mihi gaudeo». Toponomastica “romana”: intitoliamo una strada al fascista e razzista Giorgio Almirante Il sindaco di Roma, Alemanno, ha riproposto di intitolargli una via Il segretario de La Destra, Francesco Storace, ha chiesto al sindaco di Roma, Gianni Alemanno, di mantenere la promessa fatta ai suoi elettori di intitolare una via della città a Giorgio Almirante. Gli antifascisti e i democratici tutti non possono ignorare i trascorsi di Almirante. Questi fu segretario de La difesa della razza, rivista quindicinale che apparve tra il 1938 e il 1943, espressione del più convinto razzismo del regime fascista. Fu caporedattore della rivista Il Tevere - periodico che si distinse per una campagna anti ebraica prima ancora della promulgazione delle leggi razziali - e tra i firmatari del Manifesto della razza, precursore delle leggi razziali medesime. Dopo l’8 settembre, Almirante aderì alla famigerata Repubblica di Salò i cui scherani, al fianco dei nazisti, carceravano, fucilavano e deportavano partigiani e patrioti che combattevano per la libertà d’Italia - firmando egli stesso gli ordini di fucilazione. Nel Roma 1969. Almirante con i giovani fascisti davanti alla facoltà di Giurisprudenza 1947 fu infatti condannato per il suo collaborazionismo. In anni più recenti, nel 1973, la Camera dei deputati autorizzò la Procura generale di Milano a procedere contro di lui per “tentata ricostituzione del partito fascista’. Non si può consentire che Roma, città medaglia d’oro della Resistenza, possa accettare tale proposta. L’intitolazione di una via o di una piazza deve rappresentare la storia e l’identità di un Paese per fornire ai cittadini, e ancor più alle nuove generazioni, un esempio di vita e un modello di cittadinanza: che esempio sarebbe intitolare una via a un fascista collaborazionista che contribuì in prima persona alla persecuzione antiebraica? E proprio a Roma che ha visto lo scempio dei 1024 deportati ebrei il 16 ottobre 1943?, che ha visto la barbarie delle Fosse Ardeatine? Attualità La scomparsa di Oscar Luigi Scalfaro È morto nel sonno il 29 gennaio, a 93 anni. Per suo volere le esequie sono state celebrate in forma privata anziché con funerale di Stato, come previsto per i presidenti emeriti della Repubblica L’ attività politica di O. L. Scalfaro, classe 1918, cominciò prestissimo nella sua Novara. Dirigente dell’Azione cattolica, durante il ventennio aiutò gli antifascisti nella lotta clandestina. Nel 1946 fu eletto deputato alla Costituente e, da allora, fu sempre rieletto nella sua circoscrizione (Torino-Novara-Vercelli). In quella veste fu membro della commissione giustizia e nella giunta delle autorizzazioni a procedere. Magistrato, fu vice presidente della commissione speciale per la Corte costituzionale e ricoprì la carica di segretario e vice presidente del suo gruppo parlamentare. Consigliere nazionale della Dc, entrò nella direzione del partito durante la segreteria De Gasperi. Sottosegretario al Lavoro nel primo gabinetto Fanfani, nel governo Scelba fu sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e anche allo Spettacolo. Promosse in quel periodo la nascita dell’Opera nazionale ciechi civili e si batté attivamente per il ritorno di Trieste all’Italia e per la sistemazione degli esuli della terra istriana. Come sottosegretario allo Spettacolo mise a segno il risanamento degli enti lirici, teatrali e cinematografici dipendenti dallo Stato. Sottosegretario alla Giustizia nei governi Segni e Zoli, dopo le elezioni del 1958 fu eletto presidente della commissione Interni della Camera; dal ’59 al ’62 fu sottosegretario all’Interno. Ebbe il primo incarico da ministro, ai Trasporti, nel terzo governo Moro, carica ricoperta anche nel secondo governo Leone. Nuovamente ministro dei Trasporti nel primo governo Andreotti, nel secondo fu nominato alla Pubblica istruzione e poi eletto alla vice presidenza della Camera. Rieletto deputato il 3 giugno 1979, Scalfaro fece parte della commissione Esteri e riconfermato nel ruolo di vice presidente della Camera. Nel 1983, rieletto deputato per la decima volta, fu ministro dell’Interno nel primo e secondo governo Craxi, ultimo incarico di governo da lui svolto. I funzionari che collaborarono con lui lo ricordano «mattiniero, efficiente, instancabile, uomo di grande dirittura morale e correttezza». Craxi, all’epoca presidente del Consiglio, gli conferì la delega per sottoscrivere accordi bilaterali internazionali in tema di lotta al traffico di stupefa- Oscar Luigi Scalfaro Foto di archivio storico centi e contro il terrorismo. Scalfaro all’Interno si pose il problema dell’ordine pubblico negli stadi, e costituì il primo comitato nazionale in collaborazione col Coni. Nel 1987 il Presidente della Repubblica Cossiga gli affidò l’incarico di formare il governo, incarico al quale rinunciò. Come magistrato, Scalfaro fu Pubblico ministero presso le corti d’assise speciali di Novara ed Alessandria e, lo ha ricordato più volte, visse un’esperienza di profondo travaglio che segnò la sua vita: sostenne l’accusa in un processo contro un fascista poi condannato a morte pur dichiarandosi, già allora, contrario alla pena capitale. Nel 1992 ritornò ai vertici delle istituzioni prima con una breve parentesi da presidente della Camera quindi - in una situazione politica assai complessa: si era in piena “tangentopoli” e la pressione della mafia sugli apparati dello Stato culminava nell’assassinio del giudice Falcone a Capaci - con il salto al Quirinale, il 25 maggio. Un settennato complesso e caratterizzato soprattutto dal lungo confronto-scontro con il primo governo Berlusconi. Nel 1999 il passaggio delle consegne a Carlo Azeglio Ciampi e il trasferimento a Palazzo Giustiani come senatore a vita. Strenuo difensore della Carta costituzionale, al quale spetta di diritto il riconoscimento di Padre della Patria, nel 2006 fu presidente del Comitato “Salviamo la Costituzione”, poi divenuto Associazione e del quale l’Anppia è stata tra i fondatori, e capeggiò il Comitato per il NO al referendum sulla riforma costituzionale, composto dai partiti del centro sinistra, dalle principali organizzazioni sindacali, dai Comitati Dossetti e dalle associazioni Libertà e giustizia, Acli, Giovani per la Costituzione ed altri. Per dieci anni è stato presidente dell’INSMLI (Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione in Italia) sostenendo la difesa della memoria e dei valori della Resistenza, partecipando a tutte le iniziative utili alla diffusione e alla conoscenza dei principi e delle regole della democrazia italiana che aveva contribuito a delineare nella sua veste di Costituente. Per questo prediligeva il rapporto coi giovani, con i quali riusciva ad instaurare un rapporto grande empatia. Tutta l’Anppia – il nazionale e le federazioni provinciali con le quali ha costantemente collaborato – sente il vuoto lasciato, ancora una volta, da figure come Oscar Luigi Scalfaro nella società civile, nella politica attiva, in tutte quelle forme di espressione che mettono al centro della vita di una nazione moderna la partecipazione responsabile di ogni cittadino, nel nome e nel segno della democrazia attuata e non agognata. 7 8 Cultura Fratelli-coltelli: l’epopea dell’unità vista dal Sud Intervista a Pino Aprile, autore del caso letterario dell’anno scorso, Terroni, in cui narra la storia dell’unità d’Italia vista dal Sud di Antonella Amendola C on il suo primo libro «Terroni», rilettura impietosa della conquista del Sud da parte dei piemontesi, ha venduto 250.000 copie. Un fatto straordinario per un libro di storia nel nostro Paese. Ora Pino Aprile, che continua a definirsi semplicemente giornalista, con «Giù al Sud», quasi un’opera corale ricca di voci e spunti, investiga i tanti fermenti di un Sud che non vuole più essere solo il grande deposito di braccia per lo sviluppo del Nord. In questa intervista esclusiva l’autore torna sul Risorgimento mancato, inficiato dal sangue, esamina la politica nei confronti del Sud dalla prima repubblica a oggi e consiglia al governo Monti di affrontare al più presto il tema bollente. Secondo lei «Terroni», caso letterario strepitoso dello scorso anno, ha provocato qualche scossone nel dibattito degli storici togati? Pino Aprile è riuscito a seminare il dubbio sulla versione più patinata dell’unità d’Italia? «All’inizio, c’è stato il silenzio. Poi, qualcuno, e con particolare riferimento alle stragi, ha detto che si trattava di fantasiose ricostruzioni. Probabilmente, da accademico, trovava fastidioso il raccontare la storia in modo così divulgativo, sentimenti inclusi. Ma io ero emozionato (avvilito, furioso, deluso, addolorato) mentre scrivevo di quelle pagine buie del Risorgimento e della discriminazione a danno del Sud, ancora dopo 150 anni. E, con una scelta che chiunque può legittimamente criticare, ho deciso di riportare anche le emozioni che mi agitavano, mentre ne riferivo. Mi è parsa una forma di onestà in più, invece di fingere un distacco e una freddezza che non avevo. E non ho. Quando l’imprevista dimensione del Pino Aprile foto di Massimo Sestini successo di “Terroni” non ha potuto più giustificare il silenzio, alcuni (quelli di prima, ma non solo) hanno detto che si trattava di cose note. Vero, ma non a tantissimi, se la reazione più comune, fra i lettori, è lo stupore, lo sconcerto. Direi che a chiudere questo genere di polemiche è stato il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che il 14 agosto 2011, nel centocinquantesimo anniversario della strage di Pontelandolfo, tramite Giuliano Amato, presidente del comitato per le celebrazioni dell’Unità, con un suo messaggio ha chiesto perdono agli abitanti di Pontelandolfo per il massacro compiuto dai bersaglieri guidati dal colonnello Pier Eleonoro Negri. Da 50 anni i sindaci del paese domandavano ai diversi presidenti della Repubblica il riconoscimento di paese martire, senza avere risposta. “Lei non è uno storico”, mi ha obiettato un accademico. Vero, mai preteso di esserlo: sono un giornalista, ovvero un divulgatore e uso linguaggio e tecniche proprie della mia professione. La più letta storia d’Italia l’ha scritta un giornalista, Montanelli». In sintesi che cosa accadde al Sud in quegli anni? Lei ritiene che l’impresa di Garibaldi e il piano strategico dei piemontesi siano assimilabili a una mera guerra di conquista coloniale? «Di sicuro Garibaldi non voleva quel che poi accadde, ebbe l’onestà di dirlo e di denunciare le sofferenze, l’oppressione alle quali furono sottoposti i meridionali. Persino Bixio si lamentò in Parlamento del troppo sangue che si spargeva al Sud. Detto da lui, fucilatore seriale! Cavour si sarebbe accontentato di un regno del Nord. Ma colse l’occasione e governò gli eventi. Nessuno dei “padri della patria” era mai stato al Sud, e molti non ci andarono mai nemmeno dopo: ne sapevano (e il verbo può trarre in inganno) per sentito dire. E dire male. Il Sud non era più povero del Nord, non era arretrato, aveva oltre il doppio degli studenti universitari del resto d’Italia messo insieme. Quanto al regime oppressivo, mentre il Piemonte giustiziava quasi il doppio dei condannati a morte della Francia che era quattro volte più popolosa, il Regno delle Due Sicilie mandava sul patibolo solo Agesilao Milano, che aveva infilato la sua baionetta nella pancia del re! Conquistato il Sud, i massacri furono tali che, a detta di Napoleone III, alleato del Piemonte, i Savoia fecero in un anno quello che i Borbone non avevano fatto in un secolo. Il Sud venne trasformato in colonia interna, e tale è ancora oggi, sulla scorta del sistema inaugurato dalla Gran Bretagna per avviare la rivoluzione industriale. Si pensi che cosa erano Irlanda, Scozia, Galles per la Gran Bretagna. Le aziende meridionali, fra le più grandi d’Italia, furono chiuse o fatte fallire. Le colonie interne devono fornire clienti e braccia a buon mercato, non merci in concorrenza». Che giudizio dà dei Borboni? È d’accordo con quanto affermato recentemente da Paolo Mieli e cioè che i Borboni persero il regno perché trascurarono di coltivare le alleanze internazionali, in particolare il rapporto con gli inglesi? «Completamente d’accordo. Lo dico ora e vi avevo fatto cenno (con minori argomenti) nel mio libro. Il mondo mutava velocemente in quegli anni. Forse si può fare un parallelo con quel che avviene oggi, con il crollo dell’impero sovietico, la comparsa di una forma molto potente e aggressiva di revanscismo islamico, l’irrompere di paesi eufemisticamente in via di sviluppo nel ruolo di 9 Cultura potenze economiche mondiali, dalla Corea, al Brasile, alla Cina. Chi, come il Regno delle Due Sicilie, non entrò nel gioco grosso, alleandosi ai forti per abbattere i deboli (non necessariamente piccoli: fu disintegrato l’impero austroungarico, poi quello ottomano), invece di governare il cambiamento lo patì. Mieli lo ha raccontato come meglio non si può». Ritiene che la politica nei confronti del Sud, nei governi della prima repubblica, dal dopoguerra, fu male impostata? A che cosa servì la Cassa per il Mezzogiorno? «Il Sud fu ed è il bancomat d’Italia. Chi accusa il Sud del “sacco del Nord” trascura la curiosa circostanza di un ladro che diventa sempre più povero del derubato! Già nei primi mesi dell’Unità d’Italia ci sono osservatori del Nord e del Sud che raccontano la spoliazione del Mezzogiorno. Inascoltati, dileggiati, costretti a lasciare il Parlamento. Francesco Saverio Nitti poi mostra, con le carte a sua disposizione, in quanto Presidente del Consiglio, come i soldi del Sud vengono rastrellati e portati al Nord, con tasse squilibrate, spesa pubblica concentrata al Nord, commesse statali solo al Nord. La Cassa per il Mezzogiorno nacque con ottime intenzioni, fece molto bene, all’inizio, poi divenne sempre più uno strumento per fornire risorse a potentati e clientele locali, gregari di quello economico settentrionale, e dirottare la gran parte dei fondi al Nord. Il massimo che si spese, con la Cassa, per fare quello che nel resto d’Italia si faceva di più e meglio e prima (strade, fogne, ponti, bonifiche) fu lo 0,5 per cento del prodotto lordo: un duecentesimo. E il restante 99,5? Oggi non è cambiato niente: andate a vedere, su www. nelMerito.it, la ricerca del professor Gianfranco Viesti, su come sono stati spesi circa 46 miliardi di euro di fondi per le aree sottoutilizzate (Fas: quasi tutti i soldi sono stati sottratti e usati per altro, specie al Nord)». Il governo Monti per ora non ha parlato di Sud. Ritiene che ci possa essere un nuovo impegno in quella direzione? «Credo (spero) che Monti si sia reso conto dell’errore fatto nel dimenticare il Sud, come fosse un fardello appeso alla sola parte d’Italia di cui valga la pena occuparsi. Sospetto che il suo ministro per la Coesione nazionale, Fabrizio Barca, lo abbia aiutato a comprendere come stanno le cose. E il suo incontro con gli amministratori regionali e comunali del Mezzogiorno può avergli fornito elementi utili: è uno che prende appunti. E poi, per quel che s’è visto finora, persino li rilegge». Lei è forse il primo scrittore che ha parlato del movimento dei Forconi nel suo secondo libro, “Giù al Sud”. Di che cosa si tratta? Può essere una riedizione del Boia chi molla? «Non credo. Ho conosciuto alcuni fondatori del Movimento, mentre il Movimento nasceva: dei disperati, non rassegnati. Imprenditori agricoli, zootecnici, che hanno visto le loro aziende, magari attive da generazioni, sfiorire o chiudere per debiti con l’Inps (50mila su 200mila, in circa tre anni, mi dissero) svenduti a esattori di Equitalia. Aziende alle quali lo Stato chiede il rispetto di norme fiscali, contrattuali e sanitarie. Tutto giusto e costoso; peccato che quello Stato non garantisca, poi, anche il valore del prodotto così ottenuto, che va sul mercato allo stesso prezzo di quelli che giungono da paesi dell’Est o africani, ai quali non si impongono gli stessi obblighi, gli stessi costi. La rivolta dei Forconi è genuina, nasce dal mancato ascolto delle ragioni di gente operosa e trascurata. Il che non esclude che organizzazioni opportunistiche, criminali (la mafia) o politiche cerchino di usarla. Ma almeno finora i Forconi hanno mostrato di sapersi difendere». Tra le tante realtà meridionali portate alla luce da «Giù al Sud» quali crede che possano fare da volano a un’effettiva ripresa del Mezzogiorno? «Tutto il Sud si sta muovendo, in modo scoordinato, ma sempre più alla ricerca di progetti, azioni unificanti. Non è detto che riesca a farlo davvero. Ma quello che sta accadendo in Calabria è stupefacente, con i giovani magnifici di “Io resto in Calabria”, di “E adesso ammazzateci tutti” e cooperative e associazioni. Non so dove porterà tutto questo, so che non c’era mai stato». La secessione invocata dai leghisti, nel quadro dell’Europa in crisi, è diventata un vuoto slogan o ancora c’è chi ci crede? «C’è chi ci crede, minoranze, al Nord e al Sud. Al Nord ne parlano; al Sud, se la disattenzione e l’insulto continueranno, la tentazione può diventare più seria, diffusa (e persino giustificata) che al Nord». La copertina del nuovo libro di Pino Aprile Tra i pensatori meridionalisti del passato chi ancora oggi è d’attualità? «Tutti, perché ognuno di loro ha portato ricerca, saggezza, conoscenza, cui chiunque voglia occuparsi dell’argomento deve abbeverarsi. E quei meridionalisti sono sempre stati i migliori uomini del loro tempo: Fortunato, Nitti, Salvemini, Dorso, Rossi Doria, Zanotti Bianco, Saraceno, Fiore». Umanamente come si è trovato a dirigere grandi settimanali del Nord? «Benissimo. Il Nord non è il razzismo dei Borghezio, dei Calderoli, dei sindaci che vogliono usare gli extracomunitari come lepri per allenare i cacciatori. Gli inglesi dicono che è il barattolo vuoto che fa più rumore, e poi non dimentichi che io ero il meridionale, ma pure il direttore (o vicedirettore). Per cui potevi sentirti dire: “Sei meridionale, ma sei bravo”. Frase nella quale, nascosto da un doppio complimento, si celava un pregiudizio inconsapevole». Quale sarà il suo prossimo impegno di scrittore? «Ho ancora qualcosa da dire sul Sud. Abbiamo in troppi taciuto per troppo tempo». 10 Cultura UNA BELLA SORPRESA “Spegni la luce che passa Pippo” di Fabio Ecca V i sono scoperte che avvengono quasi per caso. Qualche giorno fa, cercando su internet pubblicazioni e ricerche sulla Grande Guerra, mi sono imbattuto in un volume curioso dal titolo certamente enigmatico. Ho scoperto così che “Spegni la luce che passa Pippo” di Cesare Bermani è una preziosa ricerca sulle voci, le leggende e i miti della storia contemporanea. È raro pensare al XX secolo come un periodo ricco di tradizioni orali ma a ben vedere queste interessano vari aspetti della nostra quotidianità. La loro natura storica è rimasta però a lungo inesplorata e il volume di Bermani cerca di colmare questa lacuna. Il titolo si riferisce giustappunto ad una delle tradizioni più diffuse della Seconda Guerra Mondiale, quella dell’aereo – il “Pippo”- che passava di notte e il cui ronzio era portatore di speranza o di morte. Il libro analizza i prin- per tutto il novarese seguendo gli scioperi e le altre manifestazioni. Nella zona si svilupparono quindi molti racconti, più o meno reali, di scioperanti che aspettavano di vedere apparire all’orizzonte la “macchina rossa” che iniziava così ad avere un significato simbolico. Nella battaglia di Lumellogno dell’agosto 1922, in cui si scontrarono fascisti e proletari antifascisti della zona agricola della bassa Novarese, alcuni contadini racconteranno di aver creduto di vedere proprio l’autovettura di Ramella nella mani degli aggressori in camicia nera. Proprio tale evento avrebbe sancito la sconfitta del movimento del proletariato agricolo in quella sanguinosa battaglia. In tutta l’Italia il fascismo dal 1940 aveva iniziato a diffondere la voce che gli aeroplani anglo-americani lanciassero sul territorio nazionale “caramelle avvelenate” insieme a matite o penne esplosive. A supportare la nascita di tale leggenda, esisteva una cospicua diffusione di materiale di propaganda italiana e tedesca. Si trattava quindi di un vero e proprio atto di terrorismo mediatico messo in atto nei confronti dei bambini dal fascismo. Contemporaneamente, si era diffusa anche la leggenda del “Pippo”, un aeroplano antropomorfo, metà uomo e metà macchina, che passava e dispensava morte. Si trattava ,diceva la leggenda, di un aviatore solitario che agiva esclusivamente per mitragliare treni, camion e carretti civili. La leggenda serviva per accusare l’esercito avversario di essere crudele e di voler uccidere gli italiani. Non a caso a Bologna il mitico aereo veniva anche chiamato il “Pippetto ferroviere”, poiché bombardava vicino alle reti ferrate e ai suoi snodi, mentre al Sud avrebbe preso il nome di “Ciccio ‘o ferroviere”. La leggenda aveva però anche un altro scopo: convincere gli italiani, anche i più piccoli, di spegnere le luci quando, la notte, si temevano i bombardamenti. A dimostrazione di tutto ciò, nasceva persino una filastrocca che veniva cantata ai bambini: «Sono Pippo, volo dritto: Se vedo un lumicino butto un bombolino se vedo un lumicione butto un bombolone». cipali miti sviluppatisi in Italia nel periodo contemporaneo e comprende, tra le altre, la trattazione degli amuleti di prima linea, delle lettere a catena e della storia del carro armato del PCI. Tra le più interessanti, si può leggere la leggenda socialista della “macchina rossa”. Secondo Ramella era il segretario della Federterra novarese nel 1918-1921, composta all’epoca da cinquantamila lavoratori. Ramella era l’uomo di punta dell’organizzazione socialista e dirigeva le grandi lotte contro il “caporalato” e a favore dell’introduzione delle otto ore per i lavoratori ortofrutticoli. La Camera del Lavoro di Novara gli aveva messo a disposizione una macchina rossa, con dipinte sul retro della carrozzeria “falce, martello e spiga”, e con questa il leggendario segretario si spostava Anche Giovanni De Luna menziona in “La televisione e la nazionalizzazione della memoria storica”, la leggenda del Pippo che egli definisce come «la voce più inquietante prodotta dall’Italia in guerra» (p.212). Insomma, “Spegni la luce che passa Pippo” di Cesare Bermani, edito da Odradek nel 1996, è un libro particolare, curioso per i suoi contenuti ma attento nel rispettare la più rigorosa ricerca scientifica. Un libro prezioso da conservare e da consultare ogni volta che un mito, una storia o una leggenda si presenta davanti a noi. Cultura La Resistenza a Roma nei quartieri Prati e Trionfale I l Circolo Giustizia e Libertà, fondato da partigiani attivi nella Resistenza romana, vive da oltre sessant’anni in Via Andrea Doria 79 ed è impegnato nella trasmissione della memoria storica. Ha tra l’altro già organizzato un ciclo di convegni titolati “Momenti di libertà” nei quali si ricorda agli studenti e ai cittadini residenti la storia del quartiere nel periodo di Roma occupata dai nazisti, dal 10 settembre 1943 al 4 giugno 1944. Negli ultimi anni ha già realizzato quelli relativi ai Municipi XVII, V e XI. Il successo di questi eventi ha indotto il Circolo ad ideare in collaborazione con la Scuola Romana dei Fumetti un libretto, curato da giovani sceneggiatori e disegnatori, sulla Resistenza nei quartieri Prati, Trionfale e Valle dell’Inferno (ora Valle Aurelia) che risulti efficace per cogliere l’interesse e la curiosità di altri giovani per un tempo che sembra lontano ma è sempre vivo nei ricordi di chi lo ha vissuto e dei loro figli e che rappresenta un simbolo dei valori morali e civili della città. Sono stati scelti per essere rappresentati nei fumetti cinque personaggi con storie diverse ma tutti simboli della lotta al fascismo e al nazismo. Questa pubblicazione, costata un anno di lavoro, è destinata gratuitamente agli studenti della terza media delle scuole pubbliche romane. Il Circolo, assolutamente apartitico, garantisce l’obiettività dei racconti e la verità La graphic novel sulla Resistenza a Roma curata dalla Scuola Romana dei Fumetti dei fatti tutti documentati. La speranza che lo anima è quella di riuscire a pubblicare, con il patrocinio del Comune di Roma e dei Municipi, le storie di tutti i quartieri romani coinvolti in avvenimenti dolorosi ma eroici ad un tempo, durante l’occupazione nazista. Il Circolo GL ringrazia la sensibilità della consigliera di Roma Capitale Maria Gemma Azuni per il contributo economico assegnato e l’ANPPIA che ha reso possibile la stampa dell’opuscolo. INVITO ALLA LETTURA Carlo Pisacane LA RIVOLUZIONE a cura di Aldo Romano, 2a ed. 2011, pag. 432, con foto, 20,00 La parola progresso suona nella bocca degli uomini d’ogni condizione, d’ogni partito, ma è da pochissimi, anzi quasi da nessuno compresa. I sorprendenti trovati della scienza che, applicati all’industria, al commercio, al vivere in generale, trasformano in mille guise i prodotti, sono fatti innegabili: noi vediamo, ove erano gruppi di capanne, sorgere superbe città; campi aspri e selvaggi squarciati dall’aratro, e resi fecondi; selve, monti, mari, superati; rozzi velli trasformati in finissime stoffe; le intemperie vinte con l’arte; le tenebre cacciate da fulgidissima luce; il navigar contro i venti; il percorrere con portentosa celerità sterminate distanze; finanche il fulmine reso rapido messaggiero dell’uomo; l’immensità dei cieli, le viscere della terra esplorate; gli astri, gli animali, i vegetabili, i minerali, tutti studiati, classificati, misurati... Se questo è il progresso, niuno può negarlo o non comprenderlo. “Edizione integrale dell’opera più famosa e più importante di Pisacane, controllata sul manoscritto originale, con le correzioni e le cancellature operate dall’autore, preceduta da un lungo saggio introduttivo sulla vita, sulla spedizione di Sapri e sul pensiero rivoluzionario di Carlo Pisacane, un combattente dimenticato del Risorgimento italiano, ma il cui pensiero è ancora” oggi attuale. L’opera può essere richiesta direttamente a [email protected] oppure telefonando al n. 0974 62028 Al prezzo di copertina si aggiungono le spese di spedizione: piego di libro ¤ 1,50, raccomandata ¤ 3,60, contrassegno ¤ 5,50. Chi vuole può anticipare l’importo sul conto corrente postale n. 16551798 intestato a Giuseppe Galzerano. 11 I luoghi della storia 12 segue da pagina 1 di Fiumicino sia perché i granai del Tevere erano meglio collegati tramite la via Portuense; demolita nel 1888 ne resta soltanto una descrizione di Rodolfo Lanciani: “essa misura m. 3,60 di luce ed ha le spalle murate con massi di travertino grossi m. 0,67. I battenti della porta sono formati da cornici intagliate, poste verticalmente, la soglia monolite di travertino è lunga oltre m. 4 e si trova nello stesso piano della Piramide”. Il nome originale della porta superstite era “Porta Ostiensis”, perché da lì iniziava, come tuttora inizia, la via Ostiense. La storia di ogni porta, oltre alle proprie caratteristiche architettoniche, è fatta anche di aneddoti e curiosità che restituiscono la “vita quotidiana” delle varie epoche. È ricordata, fra l’altro, dallo storico Ammiano Marcellino perché, nel 357 d.C, “venne trascinato con somma cura attraverso la porta Ostiense” l’obelisco che attualmente si erge in piazza S. Giovanni in Laterano. Con la perdita d’importanza del porto di Ostia anche il ruolo preminente della porta venne meno finché, coinvolta nel processo di cristianizzazione di tante altre porte romane, fu ribattezzata col nome attuale di “Porta S. Paolo” perché era l’uscita per la Basilica di S. Paolo “fuori le mura”, che aveva ormai ereditato l’importanza che fino a qualche secolo prima era del porto. Di conseguenza, non era più necessario mantenere i due fornici, che, anzi, in caso di pericolo esterno avrebbero comportato una maggiore difficoltà difensiva. Infatti, quando tra il 401 e il 403, l’imperatore Onorio ristrutturò buona parte delle mura e delle porte, provvide anche, come in quasi tutti gli altri interventi, a ridurre ad uno solo i fornici d’ingresso (ma non la controporta) demolendo la parte centrale e ricostruendola con una sola arcata (ad un livello circa un metro più alto della precedente) ed a fornire la facciata di un attico con una fila di finestre ad arco per dar luce alla camera di manovra. Con l’occasione rinforzò le due torri rialzandole di merli e finestre. La lapide commemorativa dei lavori che Onorio ha lasciato su ogni intervento da lui effettuato sulle mura o sulle porte, sembra fosse presente almeno fino al 1430. L’attuale “Porta S. Paolo” - molto rimaneggiata dai successivi restauri di Massenzio, del citato Onorio, di Belisario, forse anche di Narsete, e dei papi Niccolò V, Pio IV, Alessandro VII, Benedetto XIV, ecc. fino ai nostri giorni - è quindi ad un solo fornice chiusa fra due alte torri, con un cortiletto che la separa dalla controporta, sul quale si affaccia un bel tabernacolo medievale con l’immagine di S. Pietro.Era in origine unita alla basilica di S. Paolo da un lungo portico coperto oggi non più esistente ed ha vissuto anch’essa la sua parte di storia romana: nel 549 vide entrare i Goti di Totila che da qui riuscirono a penetrare nella città a causa del tradimento della guarnigione, che lasciò la porta aperta; nel 1407 accolse re Ladislao ma tre anni dopo fu teatro di uno scontro cruento fra lo stesso Ladislao ed i Romani; nel 1522 vi entrò in Roma Adriano VI appena eletto papa, in un alternarsi di avvenimenti belli e brutti. Per molti secoli, le porte della città hanno scandito la vita di Roma con la loro apertura e chiusura perché, oltre alla funzione militare di difesa per la quale le Mura erano state costruite, hanno avuto in passato altri compiti e destinazioni: di collegamento con le strade principali, di controllo di polizia delle persone, di cordoni sanitari, dell’attività di dogana. Già dal V secolo ed almeno fino al XV, è attestato - come prassi normale - l’istituto della “concessione in appalto e della vendita a privato delle porte cittadine e della riscossione del pedaggio” per il relativo transito. In un documento del 1467 è riportato un bando che specifica le modalità di vendita all’asta delle porte cittadine per un periodo di un anno pagabile in “rata semestrale”. Il prezzo d’appalto per la porta “S. Paulo” non era molto alto perché a quell’epoca il traffico cittadino - per quella porta - non era intenso come una volta, ancorché sufficiente ad assicurare un congruo guadagno al compratore. Guadagno regolamentato da precise tabelle che riguardavano la tariffa di ogni tipo di merce ma che era abbondantemente arrotondato da abusi di ogni genere a giudicare dalla quantità di “gride”, editti e minacce che venivano emessi. All’interno del “Castelletto” - la controporta che sembra una piccola fortificazione – è attualmente ospitato il “Museo della Via Ostiense”, con la ricostruzione dei porti di Ostia e dei monumenti ritrovati lungo la “via Ostiensis”. La struttura della porta è in travertino ed è fiancheggiata da due torri a base semicircolare (a ferro di cavallo). Sul suo lato interno Massenzio, all’inizio del IV secolo, ne edificò un’altra con funzione di controporta (l’unica controporta delle mura aureliane interamente conservata), sempre a due fornici in travertino, collegata alla precedente da due muri chiusi a tenaglia a formare una sorta di piccola fortificazione chiamata “Castelletto”, all’interno 1943, granatieri a Porta S. Paolo foto di archivio della quale doveva trovar posto sia la guarnigione militare che la stazione dei gabellieri per la riscossione del pedaggio sulle merci in entrata e in uscita. Di certo, gli interventi hanno comunque reso l’intera struttura asimmetrica, irregolare e architettonicamente squilibrata, con il fornice esterno non in linea con quelli interni, le torri poco più alte della facciata e, in generale, dimensioni piuttosto sproporzionate. All’altezza della controporta, sul lato orientale, in corrispondenza dell’attuale via R. Persichetti, doveva trovarsi una “posterula”, di cui però non rimane nulla perché quel punto I luoghi della storia 13 è stato devastato nel 1943 in occasione di un bombardamento aereo. Una strana particolarità della controporta, unica in tutta Roma, è che la chiusura era verso la città anziché, come normalmente accadeva, verso l’interno della struttura. Soprattutto in epoca medievale quando i nemici esterni rappresentavano un pericolo paragonabile a quello delle fazioni armate interne alla città, la Porta doveva costituire una sorta di piccola fortezza per una guarnigione armata che all’occorrenza avrebbe potuto rinchiudersi all’interno. La porta ha infatti subìto diversi attacchi S. Paolo e nel bastione predisposto intorno alla vicina piramide di Caio Cestio. L’8 gennaio, dopo 3 giorni di assedio, Porta S. Paolo cadde insieme alla Porta Appia, seguite a un mese di distanza dalla Porta Tiburtina e dalla Porta Prenestina, lasciando via libera all’ingresso trionfale in Roma del nuovo papa. Sulla torre orientale è presente un’iscrizione a memoria dei lavori che Benedetto XIV effettuò nel 1749 per il restauro di tutta la cinta muraria da qui a Porta Flaminia. Intorno al 1920 la Porta fu isolata dalle Mura Aureliane per agevolare il traffico dell’area adiacente sul lato orientale ed in seguito, a causa del bombardamento durante la II Guerra eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza”. L’Armistizio era stato firmato il 3 settembre a Cassibile, in Sicilia, ma doveva restare segreto per alcuni giorni per dar modo agli italiani di sganciarsi dai tedeschi. Vista però l’eccessiva titubanza del Governo e degli alti comandi militari italiani, il Gen. Dwight Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane, che nel frattempo aveva avviato le manovre per lo sbarco di Salerno e “non intendeva continuare la sanguinosa farsa di combattere contro truppe di fatto fuorigioco”, rese pubblico l’Armistizio mettendo gli italiani di fronte al fatto compiuto. La dichiarazione proprio dall’interno, soprattutto nel 1410. In quell’anno la città era in mano al re Ladislao di Napoli e tre papi – Benedetto XIII, Alessandro V, Giovanni XXIII (!) - si combattevano per ottenere il riconoscimento ufficiale, spalleggiati dalle più potenti famiglie romane in lotta fra loro; il popolo romano, in preda alla più totale anarchia, al seguito degli Orsini, sostenitori dell’antipapa Alessandro V Filargo di Creta (1409-1410), fu protagonista di diversi violenti scontri lungo le mura, culminati nell’attacco alla guarnigione napoletana asserragliata proprio nella Porta Mondiale, andò distrutto anche il tratto di mura occidentale che la collegavano alla Piramide Cestia. Nel tragico settembre del 1943 proprio sulle mura di Porta S. Paolo si svolse uno degli avvenimenti più popolari che dettero inizio alla guerra civile che dilaniò l’Italia da quel momento sin’oltre la fine della II Guerra Mondiale. Tutto incominciò la sera dell’8 settembre dopo che le stazioni radio avevano diffuso il messaggio del Capo del Governo, Maresciallo Pietro Badoglio, che annunciava l’armistizio: “… ogni atto di ostilità contro le forze angloamericane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad dell’Armistizio (e qualche tempo dopo anche il capovolgimento delle alleanze) determinò l’estrema incertezza dei responsabili politici e militari nell’adottare le decisioni con ripercussioni su tutti i fronti nei quali erano impegnati i reparti italiani. Lo sconcertante vuoto di direttive politiche e militari ebbe tremende conseguenze e provocò la rabbiosa reazione e repressione da parte delle truppe tedesche. Infatti, temendo il cambio di fronte degli Italiani, Hitler aveva predisposto che le armate di Rommel a Nord e quelle di Kesserling al Centro-Sud, impegnate a contrastare l’avanzata degli anglo-americani, fossero pronte a neutralizzare gli alti I luoghi della storia 14 comandi politico-militari italiani secondo il piano segreto “Alarico”. A Roma era altissima la concentrazione di truppe italiane per la presenza di ben 6 Divisioni. Di queste la Divisione “Granatieri di Sardegna” composta da 11.000 uomini, già dalla fine di luglio del ’43, era stata spiegata nella periferia Sud-Ovest di Roma con apprestamenti difensivi su 13 capisaldi e 14 posti di blocco collocati in corrispondenza delle strade di accesso alla Capitale, concepiti, però, per contrastare un eventuale attacco anglo-americano. Ogni caposaldo aveva un posto di blocco con sbarramento sulla strada principale e varie postazioni di tiro di cannoni. Scattato il piano “Alarico”, Kesserling, scampato ad un duro bombardamento alleato su Frascati ove aveva il suo Quartier Generale, ordinò al gen. Kurt Student di muovere su Roma con la 2° Divisione Paracadutisti, accampata tra Ostia e Pratica di Mare. Qualche ora dopo, al caposaldo 5 di Ponte MaglianaOstiense, un’autocolonna tedesca cercò di occupare il posto di blocco. Qui ebbe inizio l’epopea tragica che si concluderà con il conosciuto episodio di “Porta S. Paolo”, dove si svolsero i combattimenti che, nell’accezione comune, corrispondono a quella che 1943, Porta S. Paolo foto di archivio comandante della Divisione Granatieri di Sardegna, gen. Gioacchino Solinas, ordinò alla sua batteria di cannoni di aprire il fuoco dalla collina dell’EUR contro i tedeschi. I combattimenti che interessarono la Divisione Granatieri di Sardegna ed i reparti ad essa dati di rinforzo (a seguito della richiesta del Solinas al gen. Carboni, comandante di tutte le truppe dislocate in Roma) presero l’avvio alle ore 21 circa del giorno 8 settembre presso il caposaldo n. 5 dislocato nella zona del Ponte della 1943, Porta S. Paolo foto di archivio viene definita “La Difesa di Roma”. In effetti, lì, si ebbero gli scontri finali di una battaglia che durò circa 3 giorni e si sviluppò lungo un arco virtuale di circa 28 km. a sud della Capitale, da via Boccea a via Collatina, con i militari coadiuvati da numerosi gruppi di civili. In assenza di ordini coerenti dallo Stato Maggiore Generale, il Magliana - Ponte della Creta - E 42, ora EUR, e proseguirono fino a circa le 17.00 del giorno 10 settembre coinvolgendo in diversa misura i restanti capisaldi e, dopo il loro ripiegamento, la zona della Piramide Cestia e di Porta S. Paolo. L’inaspettata reazione degli italiani costrinse i tedeschi ad arretrare ma, poco dopo, una seconda colonna di 1000 uomini si presentò al caposaldo 6 sulla Laurentina, lanciando un attacco. I loro corazzati però stentarono ad avanzare per il fuoco dei cannoni dei Granatieri. Il primo episodio della Resistenza italiana era iniziato; uomini che - a fronte della fuga di Vittorio Emanuele III, il “resoldato”, dell’erede Umberto, del Governo, del Capo di Stato Maggiore Vittorio Ambrosio e dei Capi di Stato Maggiore dell’Esercito, Mario Roatta, della Marina, Raffaele De Courten, e dell’Aereonautica, Renato Sandalli con i loro familiari - combatterono strenuamente contro i tedeschi. Numerosi scontri a fuoco si ebbero anche all’interno della città come a S. Giovanni e al Colosseo, ad opera di cittadini accorsi a combattere contro l’ex-alleato. La mattina del 10 una parte dei militari, che aveva avuto la peggio altrove ed era stata costretta a ritirarsi, si riunì intorno a Porta S. Paolo; ad essi si unirono civili giunti spontaneamente od organizzati dai partiti antifascisti. Fino al pomeriggio del 10 settembre 1943 Porta S. Paolo fu teatro di uno degli scontri legati all’occupazione tedesca di Roma. Qui ebbero luogo i furiosi combattimenti tra i Granatieri di Sardegna, che il giorno precedente si erano rifiutati di lasciarsi disarmare dai tedeschi, e numerosi gruppi di “uomini e donne di ogni età e condizione”. “La Difesa di Roma” fu fatta sia dai militari che dai civili i quali I luoghi della storia poterono combattere anche con un migliaio di armi corte e lunghe, cedute dal Servizio Informazioni Militari (SIM) e prelevate dai depositi clandestini del SIM di via Silla 91, dal Museo dei Bersaglieri di Porta Pia, dall’Officina Scattoni di via Galvani e dall’officina biciclette Collalti a Campo dé Fiori. Questo importante contributo politicomilitare è stato attestato dal futuro deputato del PCI Antonello Trombadori, che nel suo “Diario” racconta: “Mi trovavo a Roma al Grand Hotel con Longo ed altri per conferire con l’aiutante di Giacomo Carboni e col figlio di Carboni, Guido (capitano). Luigi Longo ed io eravamo lì perché grazie alla rete di contatti messa in piedi da Giuseppe Di Vittorio, dovevamo accordarci con il SIM (sempre Carboni) per la consegna di armi in vista di una sollevazione popolare”. Nonostante la schiacciante superiorità numerica e d’armamento delle truppe tedesche, il fronte resistenziale riuscì ad attestarsi lungo le mura di Porta S. Paolo innalzando barricate e facendosi scudo con le vetture dei tram rovesciate. Nel corso della battaglia, il generale Giacomo Carboni si prodigò nel tenere alto il morale dei soldati e mandò i carabinieri a staccare i manifesti “disfattisti”, che davano imminenti le trattative con i tedeschi. Alle 15,30 del giorno 10, gli ufficiali dei Granatieri, cui si era aggiunto il tenente in congedo assoluto per ferita sul fronte grecoalbanese Raffaele Persichetti, decisero di ripartire all’attacco dando ordine ad un plotone del “Genova Cavalleria” ed a un gruppo di civili di porsi a guardia delle alture del quartiere S. Saba, che dominano la piazza di Porta S. Paolo. Contemporaneamente alla stazione Ostiense sul binario 3 c’era un “commando” di civili e militari del nascente CNL, capitanati dal magg. Carlo Benedetti. Alle 16.00, il gen. Giorgio Carlo Calvi di Bèrgolo, genero di Vittorio Emanuele III e comandante di Corpo d’Armata, comunicò al gen. Solinas l’avvenuta firma dell’armistizio con i tedeschi e l’ordine di cessazione delle ostilità. Tra le condizioni dell’armistizio, che dichiarava “Roma Città Aperta”, c’era la consegna delle armi e lo scioglimento dei reparti; ma nei dettati segreti di Hitler, “accettati con riluttanza da Kesserling”, c’era la deportazione in Germania dei soldati italiani. Nel primo pomeriggio la Resistenza fu travolta dai mezzi corazzati tedeschi e il Capo di Stato Maggiore della Divisione “Centauro”, colonnello Leandro Giaccone, firmò la resa a Frascati, presso il Quartier Generale tedesco. La “Difesa di Roma” costò 1167 militari caduti o dispersi e secondo dati “ufficiali” 241 civili, fra cui 43 donne (il dato “stimato” è di oltre 400 civili). Tra i molti cittadini che pagarono il loro eroismo con la morte figurano l’operaio diciottenne Maurizio Cecati e il fruttivendolo Ricciotti che, finito il lavoro ai Mercati Generali, si improvvisò eccezionale tiratore. Morì colpito Porta S. Paolo oggi foto Maurizio Galli da una scheggia il professore di Storia dell’Arte al Liceo classico Visconti, Raffaele Persichetti, uno degli ultimi caduti a Porta S. Paolo; decorato con Medaglia d’oro al V.M. - la prima Medaglia d’Oro della Resistenza - il suo nome è divenuto simbolo di quanti, soldati e civili, si sono sacrificati nella Difesa di Roma. La “battaglia di Porta S. Paolo” è considerata il vero e proprio esordio della Resistenza italiana e in essa si può misurare emblematicamente il comportamento dei vari protagonisti, indifferenti poi alla campagna di terrore seminata dal Maresciallo Rodolfo Graziani a proposito delle “notti di S. Bartolomeo” che avrebbero atteso infallibilmente tutti i militari che non avessero ubbidito agli ordini del nuovo “Stato Nazionale Repubblicano”, più noto come “Repubblica di Salò”. Quattro lapidi apposte sulle Mura ricordano vicende dolorose che hanno segnato col sangue la difesa della Libertà e della Democrazia: i fatti del 10 settembre 1943; lo sbarco di Anzio; i Caduti della Resistenza; i Caduti del Terrorismo. A circa settanta anni da quegli eventi, la Porta sfrutta una delle sue particolarità: quella di formare con la Piramide di Caio Cestio ed i cipressi del Cimitero Acattolico un quadretto di particolare suggestione, riprodotto in innumerevoli dipinti. Mario Tempesta, Roma, 22 febbraio 2012 15 16 Memorie Renzo Laconi, un politico da riscoprire di Maurizio Orrù A l giorno d’oggi capita spesso che illustri protagonisti della nostra storia patria diventino improvvisamente obsoleti e dimenticati. Ahimè! Questa amara considerazione vale anche per Renzo Laconi, indimenticabile protagonista delle vicende politiche e culturali della Sardegna del secondo Novecento. Il Nostro è stato un intellettuale raffinato e acuto, un oratore “trascinatore di folle” e un appassionato cultore ed estimatore delle lezioni politiche di Antonio Gramsci. Molte sono le riflessioni e gli scritti nei quali Renzo Laconi riprende le argomentazioni gramsciane, elaborandole e collocandole all’interno del mondo culturale sardo e nazionale del suo tempo. Il Nostro è stato un uomo di cultura giuridica e istituzionale, esponente di una giovane generazione venuta al socialismo e al comunismo attraverso l’esperienza della ferrea dittatura mussoliniana. Egli incentrava il suo pensiero e azione, in Sardegna, sul nesso autonomia regionale, rinascita economico e sociale e una rigorosa e credibile programmazione democratica, nella Costituente e nel Parlamento, sui rapporti tra democrazia e trasformazione sociale. Renzo Laconi è stato un valente dirigente politico nazionale del Pci, apprezzato e fidato collaboratore di Palmiro Togliatti. Fu uno dei maggiori e brillanti protagonisti dell’elaborazione della Carta Costituzionale, cui apportò un contributo fondamentale sulle tematiche autonomiste. A tale scopo scrive Eugenio Orrù, direttore dell’Istituto Gramsci della Sardegna, nella sua recente pubblicazione, La caverna di Platone, Ed. Tema, 2010: “(…) La sua concezione autonomistica non consente banalizzazioni, che non sono mancate. Egli si propone e si presenta come uno degli artefici principali della Costituzione regionalista, uno degli uomini più aperti, certo nella specificità culturali e politiche del suo tempo, agli approdi costituzionali più moderni e alle tematiche oggi più attuali. Non è perciò retorica richiamare, nell’era della globalizzazione, l’attualità del pensiero di Renzo Laconi, di colui che ha svolto un ruolo essenziale nella costruzione del dettato costituzionale, di colui che è stato il più lucido assertore della specialità artefice e protagonista indiscusso della battaglia per la Rinascita (…)”. Renzo Laconi fu ininterrottamente per quattro legislature deputato al Parlamento della Repubblica (1948-1967), membro del Comitato Centrale del Pci e Segretario regionale dal 1957 al 1962 e vicepresidente del Gruppo Parlamentare del Partito comunista. Ruoli politici e istituzionali che Laconi portò avanti con coerenza e rettitudine, con passione e orgoglio in senso comunista e antifascista. Laconi pensava e rifletteva che se la “sua Sardegna” voleva uscire dall’atavico sottosviluppo (che ancora oggi permane assoluto) l’autonomia regionale poteva essere la migliore panacea ai tanti mali che affliggevano le genti sarde, ovvero delineare una forma di autogoverno democratico, attraverso l’ascesa delle masse popolari a responsabilità di governo. A tale riguardo, scrive Maria Luisa Di Felice nel suo saggio introduttivo, Renzo Laconi. Per la Costituzione, scritti e discorsi, Ed. Carocci, 2010: “(…) Il pensiero di Laconi conosceva ulteriori, fondamentali sviluppi quando individuava nell’autonomia uno strumento basilare per la crescita democratica e civile, per la trasformazione sociale ed economica della Sardegna. Laconi fu tra i protagonisti nel processo che portò i comunisti sardi a guardare con convinzione verso l’autonomia. Era Togliatti a ribadire la necessità che i compagni sardi si uniformassero maggiormente alla linea del partito, e nel II Consiglio Nazionale (aprile 1945) li invitava a non temere di essere autonomisti, poiché l’autonomia era una “rivendicazione democratica rispondente agli interessi del popolo sardo”. Ancora oggi, viene ricordato nella memoria collettiva dei sardi, e non solo, per la sua oratoria brillante ed estremamente rigorosa. Scrive Enrico Berlinguer, indimenticato segretario nazionale del PCI: “(…) Egli fu, come tutti ben sappiamo, fra i nostri oratori più efficaci e brillanti, tanto nelle aule parlamentari quanto sulle piazze: La sua oratoria era sottile e insieme appassionata fino alla veemenza polemica più spietata, logica e rigorosa e insieme semplice e prontamente umana, e raggiungeva a volte, soprattutto quando si rivolgeva ai lavoratori più poveri della sua terra, quasi gli accenti dell’apostolato. Credo che i suoi comizi saranno a lungo ricordati e rimpianti dalle decine di migliaia di lavoratori, non solo sardi, che hanno avuto anche una sola volta occasione di ascoltarlo (dal discorso commemorativo al Comitato centrale del PCI, 10 luglio 1967).” Renzo Laconi con la sua poderosa personalità politica e culturale non può e non deve essere rimosso dalla Storia sarda e nazionale; è necessario approfondire il suo pensiero e le sue riflessioni. È necessario ripensare a quest’uomo per meglio interpretare il presente evanescente e un futuro denso di incognite. 17 Memorie La Cattiva Reputazione La storia non è come una macchina, che quando si fa vecchia deve essere per forza revisionata. Eppure sembra che per alcuni sia così. Hanno iniziato i finti storici, gli pseudo-storici, ora anche gli storici veri e propri. Riscoprire un documento, osservare, studiare con il distacco del tempo e la mente fredda, a dire il vero, ha aiutato a comprendere e scoprire molti fatti scomparsi dalla memoria comune, evidenziando talvolta situazioni molto più importanti di quanto pensassimo. Ma troppo forte è la tentazione di farsi portatori di nuove verità a distanza di decenni, soprattutto se le verità che si vuole riportare a galla sono considerate più vere di quelle vecchie, perché necessarie a nuove teorie, ad un nuovo mondo. La storia la scrivono i vincitori si dice, e se in parte è vero, è vero anche che i figli, i nipoti dei perdenti hanno molto spesso la tentazione di riscriverla. Ecco spuntare quindi i Petacco, i Pansa, pure i Bruno Vespa, pronti a presentare volumoni di centinaia di pagine, con il nulla dentro dal punto di vista scientifico e bibliografico, ma che con l’aiuto del marketing, con la polemica costruita ad arte, con l’uso della televisione, riescono a farsi passare da storici, quelli veri dico, e le loro teorie diventano nuove teorie, per molta gente, purtroppo. Dario Biocca non è uno storico di quel tipo, è uno storico veramente. Cosa l’avrà portato a scrivere di Gramsci e del “ravvedimento” di quest’ultimo a distanza di ottant’anni? Che tornaconto ne poteva avere, visto che per addurre elementi inconfutabili alle sue teorie non ha esitato ad appoggiarsi all’art. 176 del Codice penale, per lui in uso già dal 1934, ma che invece il professor Joseph A. Buttigieg ha dimostrato essere del 1962?. Malafede? Errore filologico? Qui non si sta parlando di una persona qualsiasi, ma di Antonio Gramsci, di un uomo morto in carcere per difendere le sue idee. Eppure Biocca non ha esitato a mettere in piazza le sue teorie sul fatto che Gramsci avesse chiesto i domiciliari, perché ravveduto, come obbligava l’art. 176. Nella risposta a Buttigieg, su “La Repubblica” del 19 marzo 2012, Biocca - dopo avere incassato il colpo - conclude sostenendo che comunque Gramsci, negli ultimi due anni di carcere si chiuse in un silenzio che si protrasse fino alla morte, insinuando senza troppi veli che la teoria sul ravvedimento del politico qualche appiglio lo potrebbe comunque avere. Biocca, il silenzio di Gramsci è stato un grande esempio, anche per lei. A star zitti alle volte si guadagna in stima, in autorevolezza e successo. Invece no, meglio parlare, anzi, sparlare. cattivareputazione.blogspot.it Serra Pietro di Serramanna, ammonito perché Pentecostale di Lorenzo Di Biase La Circolare Ministeriale n. 600/158 del 9 aprile 1935 conosciuta come la “Circolare Buffarini-Guidi” (dal nome del Sottosegretario all’Interno che la firmò) era rivolta ai Prefetti del territorio nazionale per proibire il culto pentecostale in tutto il Regno perché esso “si estrinseca e concreta in pratiche religiose contrarie all’ordine sociale e nocive all’integrità fisica e psichica della razza”. Di conseguenza fu messo al bando il movimento pentecostale, furono chiusi tutti i luoghi di culto e avvennero molti arresti, ammonizioni, invii al confino sia di semplici credenti che di pastori pentecostali. Nonostante la persecuzione religiosa posta in atto dal regime i pentecostali continuavano a riunirsi in località campestri e remote o in casa di qualcuno di essi ma sempre con il timore di essere scoperti e perseguitati. Nelle maglie del regime fascista nel 1942, in quanto adepto della Chiesa Cristiana Pentecostale, incappò anche il sardo Serra Rafaele Pietro, residente a Roma in Via Frontino 33, ma originario di Serramanna. Egli nacque nel centro agricolo campidanese il 27 luglio 1901 alle ore 13 da Antonio e fu Collu Maria. Il Serra fu sorpreso il 19 febbraio 1942 in una casa di Via Muzio Attendolo “assieme a numerosi pentecostieri all’atto di svolgere il loro culto” e per tale motivo fu denunziato alla Commissione Provinciale per l’Ammonizione, così recita un verbale stilato dalla Questura di Roma in data 28 marzo ’42 conservato nel fascicolo n. 106943 del Fondo Casellario Politico Centrale presso l’Archivio Centrale dello Stato. In una lettera del 16 marzo 1942 - indirizzata all’Ufficio Confino e al Casellario Politico Centrale - a firma del Capo della Polizia Carmine Senise, riportante tutto un elenco di persone da sottoporre al provvedimento del confino o della ammonizione, appare anche quello di Pietro Serra. E quest’ultimo fu sottoposto ai vincoli dell’Ammonizione dalla Commissione Provinciale riunitasi il 17 marzo 1942 nei locali della Regia Prefettura di Roma sotto la direzione del Prefetto Fusco Comm. Umberto. Alla riunione inoltre parteciparono il Questore Petrunti Comm. Nicola, il Procuratore del Re Gatta Comm. Enrico, il Colonnello dei Reali Carabinieri Frignani Cav. Uff. Ercole, il Console della M.V.S.N. Guglielmi Cav. Nicola e il Commissario Aggiunto in veste di Segretario della Commissione Santini Dott. Arnaldo. Il provvedimento consisteva in una serie di limitazioni tra le quali spiccava quella di non ritirarsi la sera più tardi “dell’Avemaria” né uscire al mattino più presto dell’alba. Inoltre fu inserito in un elenco di persone da arrestarsi in determinate circostanze (inserito nell’elenco 5° - pregiudicati per delitti comuni). Poi, in seguito al ventennale della marcia su Roma Serra Pietro fu prosciolto dai vincoli dell’ammonizione con atto di clemenza del Duce. Per disposizione del Questore di Roma fu sottoposto a vigilanza da parte della polizia politica del regime. Serra Rafaele Pietro morì in Roma il 28 luglio 1973. La Circolare Buffarini-Guidi che diede la stura alla persecuzione religiosa venne abolita il 16 aprile 1955, dopo vent’anni dalla sua emanazione e dopo ben sette anni dalla entrata in vigore della Costituzione repubblicana. Fatto apparentemente inspiegabile! 1818 Noi I 100 anni di Garibaldo, una vita per la democrazia L ivorno, 31 gennaio 2011. Benifei accompagnato dall’inseparabile Osmana arriva al Teatro Civico poco dopo le 17. L’atrio è già stracolmo di persone che vogliono festeggiare Garibaldo. Entra, guarda con stupore prima e con emozione poi (gli avevano nascosto i festeggiamenti, tanto che era un po’ stupito del fatto che nessuno si ricordasse di un anniversario così importante) le tantissime persone che lo vogliono salutare, stringergli la mano. Garibaldo e sua moglie Osmana vengono accompagnati verso due grandi e comode poltrone, ed il primo saluto è quello delle loro nipoti che eseguono dei pezzi di musica classica. Arrivano poi i saluti del coordinatore della Società Volontaria di Soccorso del comune di Livorno, dell’Ammiraglio del Porto di Livorno, del Presidente Nazionale dell’ANPPIA, del Sindaco della Città Alessandro Cosimi, del Presidente della Provincia e dei rappresentanti di tutte le organizzazioni nate a Livorno per volontà di Garibaldo. Vengono letti i telegrammi augurali del Vescovo di Livorno e dell’ex Questore e vengono consegnate a Benifei delle pergamene di ringraziamento per l’impegno sociale, culturale e politico profuso da sempre per la difesa della democrazia. Nel teatro segue una lunga intervista a Garibaldo, e alle domande che gli sono poste, risponde con la solita ironia e simpatia. Un abbondante buffet, organizzato da varie associazioni tra cui la Cooperativa 8 Marzo, accoglie i numerosissimi intervenuti. Ma Garibaldo e Osmana mangiano ben poco, impegnati come sono a stringere mani e a fare foto. Tutti vogliono farsi ritrarre con loro. L’atrio del teatro è addobbato con le foto di Garibaldo e su uno schermo si susseguono le immagini più significative di Garibaldo e Osmana, nei momenti d’impegno sociale e politico. Si suonano le chitarre, s’intonano i canti della Resistenza, tutto in un clima gioioso, tutti vogliono ringraziare questo piccolo grande uomo, che ha dato veramente tanto alla città di Livorno. Da Campiglia a Livorno, gli anni della formazione Garibaldo Benifei nasce, ultimo di dodici figli, il 31 gennaio 1912 a Campiglia marittima. Il padre, Garibaldo, iscritto al Partito repubblicano, muore tre mesi prima della sua nascita. La madre si chiama Maria Mariani. La famiglia Benifei si trova da subito a vivere in difficilissime condizioni economiche: la bottega del calzolaio del padre passa in gestione al figlio maggiore, Antonio; il secondogenito, Rito, lavora come muratore. L’uno socialista, l’altro anarchico, nell’immediato dopoguerra i due fratelli si impegnano nella lotta politica. Antonio viene eletto consigliere comunale nel 1919. Dal 1920 le squadracce fasciste cominciano a fare irruzione nelle case, distruggono le sedi di partito, aggrediscono i rappresentanti delle associazioni dei lavoratori. La casa di via Cavour della famiglia Benifei viene incendiata e devastata nel giugno del 1921 e nel luglio 1922, in cerca di Antonio e Rito, i quali però erano già fuggiti da Livorno. Al resto della famiglia (Garibaldo, la madre, il fratello Eros e le altre sorelle) viene intimato di lasciare il paese entro poche ore. Così dalla stazione di Campiglia, una sera di luglio del 1922, Garibaldo raggiunge per la prima volta Livorno, dove si stabilisce definitivamente nel 1923. A 12 anni lascia la scuola e comincia a lavorare come “portantino” presso la Vetreria Rinaldi insieme al fratello Eros: vi rimane tre anni, durante i quali partecipa alla sua prima riunione sindacale e allo sciopero indetto dagli operai anziani organizzatisi per protestare contro le difficili condizioni di lavoro nella fabbrica. Fa poi il garzone, prima al bar Bizzi in via Solferino (luogo di ritrovo degli antifascisti livornesi), poi al caffè Bristol, all’angolo di piazza Cavour (frequentato invece da molti dirigenti fascisti). Nel 1923 entra nella sezione giovanile della Pubblica Assistenza (SVS). L’antifascismo militante e il carcere Il suo impegno diretto nella politica attiva e nelle file del Partito comunista si ha nel 1931, quando il fratello Eros, entrato nel 1928 nell’organizzazione clandestina del partito, gli chiede di recapitare a Roberto Vivaldi del materiale di propaganda fatto entrare di nascosto dalla Francia: volantini, manifesti, copie dell’Unità, di Stato Operaio. Negli anni successivi l’impegno politico clandestino di Garibaldo si fa più vico e attivo. È anche tra i dirigenti della Federazione giovanile del partito che, in occasione dei funerali del comunista Mario Camici nel luglio 1933, ricevono il compito di coinvolgere e far scendere in piazza il maggior numero possibile di giovani. La partecipazione dei livornesi è massiccia e la polizia fascista non interviene. Garibaldo viene arrestato la prima volta nel luglio del 1933; in Questura è picchiato selvaggiamente. Trasferito a Roma, viene condannato dal Tribunale speciale a un anno di reclusione per il reato di propaganda comunista. In carcere prima a Regina Coeli, poi a Livorno, in regime d’isolamento, ai Domenicani, conosce Sandro Pertini, il futuro Presidente della Camera e dell’Assemblea Costituente. Uscito nell’estate del 1934, viene assunto in una fabbrica di radiatori e riprende l’attività politica di opposizione al regime, come molti altri giovani livornesi negli anni tra il 1936 e il 1939, sull’onda dell’entusiasmo per gli avvenimenti di Spagna, con le vittorie del fronte repubblicano. Ed è solo per un caso fortuito che, una sera alla fine del 1937 sfugge all’arresto e al confino, mentre insieme ad altri compagni sta per imbarcarsi su un grosso motoscafo che dal Calambrone doveva raggiungere, appunto, la Spagna. Alla fine di agosto del 1939 il gruppo dirigente livornese del partito decide di mandare in stampa ben diecimila volantini contro la guerra, sentita ormai come imminente, e contro le violenze del nazi-fascismo. Alla diffusione dei volantini, la reazione della milizia fascista è durissima e Garibaldo, che si occupava delle sottoscrizioni per il Soccorso rosso e del materiale di propaganda a stampa, è nuovamente arrestato. Nel marzo del 1940 è a Roma, processato dal Tribunale speciale e condannato a 7 anni per attività sovversiva. Nei primi di giugno del 1940 è trasferito nel carcere di Castel franco Emilia 19 Noi (Modena). La scarcerazione avviene il 26 agosto del 1943, un mese dopo la caduta di Mussolini. La lotta partigiana e la liberazione Rientrato a Livorno, devastata dai bombardamenti, partecipa da subito Vincenzo. Alla fine di giugno il Comando militare alleato comunica che le formazioni partigiane dovevano essere sciolte e disarmate. Garibaldo, insieme ad altri, chiede con insistenza che si lasci proseguire ai partigiani la lotta gennaio 1945 dal sindaco Furio Diaz, nella casa comunale del Villaggio di Ardenza. Nel febbraio del 1945 Garibaldo e Osmana vengono inviati dal partito, per risolvere alcune questioni delle locali sezioni, prima all’Isola d’Elba e poi a Piombino, dove li raggiunge la notizia della fine della guerra e della liberazione del Paese. Inizia così un sodalizio di vita nutrito non solo dall’amore reciproco, ma anche dalla condivisione dei valori di libertà e giustizia sociale. L’impegno nella cooperazione e nella solidarietà Il depliant pubblicato da Comune di Livorno e Istoreco per i cento anni di Benifei alle prime riunioni della Concentrazione antifascista. Tra il settembre e l’ottobre del 1943 nasce ufficialmente, seguendo le indicazioni dei dirigenti nazionali, il Comitato di Liberazione Nazionale livornese: Garibaldo è incaricato di mantenere i collegamenti tra il Comitato di Liberazione dell’area di Livorno e quelli degli altri paesi della provincia e anche dell’area pisana. Fino all’estate del 1944mprtende parte attivamente alla guerra di liberazione nelle file partigiane. Il CLN comincia ad assumere una dimensione sempre più interprovinciale e Garibaldo coordina le azioni e le attività dei distaccamenti tra Livorno e Grosseto, in particolare operando tra Castagneto e San al fianco dell’esercito alleato, ma non ottenendo l’approvazione considera terminata la sua esperienza nella Resistenza. Così fa ritorno prima a Vada, dove prende contatti con il Comitato federale del Pci, e poi a Livorno, proprio il giorno dopo la liberazione della città dai tedeschi (19 luglio 1944). Osmana In quella stessa estate del 1944 comincia frequentare Osmana Benetti, tuttora compagna della sua vita. Anche lei militante nel Pci, aveva preso parte alle lotte partigiane con funzioni di collegamento e di diffusione del materiale di propaganda, organizzatrice e protagonista dei Gruppi di difesa della donna. Garibaldo e Osmana si fidanzano; il matrimonio è celebrato il 24 A Piombino gioca un ruolo fondamentale nella ricostruzione, il movimento cooperativo (in particolare la cooperativa “La Proletaria”), che si diffonde via via nei paesi vicini. Gran parte del ruolo di Garibaldo all’interno del partito, in quegli anni, è proprio verso il rafforzamento di questa realtà, che conosce un rapidissimo sviluppo a Livorno e provincia. Nel 1946 è eletto presidente provinciale della Lega delle Cooperative e in seguito entra anche nel consiglio nazionale: compito questo che svolge con grande passione, perché da sempre convinto che la pratica della cooperativa sia la realizzazione concreta di molti degli ideali di unità e fratellanza che avevano animato le lotte antifasciste e la Resistenza. Nel 1948, a causa del mutato clima politico, nel pieno della “guerra fredda”, Garibaldo è accusato insieme a molti altri responsabili di organismi cooperativi di violazione delle leggi sui dazi doganali (per una questione di “pacchi dono” inviati dagli Stati Uniti). Si trova così nuovamente, dopo gli anni del regime, a vivere in clandestinità per circa un anno; arrestato e condannato a tre mesi di reclusione, trascorre tre giorni nel carcere dei Domenicani. In appello la pena gli viene cancellata e può riprendere i suoi incarichi ai vertici del movimento e all’interno del partito. Nel 1957 Garibaldo è uno dei soci fondatori dell’ARCI, di cui firma personalmente l’atto costitutivo a Firenze. Da sempre impegnato nelle attività di assistenza ai più deboli e nel volontariato, ricopre negli anni successivi a Livorno veri incarichi direttivi: principalmente nell’ECA (Ente comunale di Assistenza) e nella Società Volontaria di Soccorso. Dell’Eca di Livorno è nominato 20 Noi presidente verso la metà degli anni Settanta, succedendo a Ernesto Santopadre. È sua l’iniziativa di far nascere, nei locali di fianco alla sede dell’associazione, un asilo per i bambini intitolato a Primetta Marrucci. Nella SVS di Livorno rimane volontario in servizio attivo per un lungo periodo. Partecipa, già dagli anni Sessanta, allo sviluppo del movimento regionale e nazionale delle Pubbliche Assistenza, in cui ricopre anche incarichi dirigenziali. Dal 1981 al 1987 viene nominato presidente: in questi anni fa ristrutturare la vecchia sede dell’associazione, ancora danneggiata dai bombardamenti, provvede all’apertura di nuovi ambulatori tuttora attivi, istituisce il primo servizio con medico a bordo in ambulanza. Al termine del mandato continua la sua partecipazione alla vita dell’associazione anche nel ruolo attivo di presidente del collegio dei Probiviri, che mantiene ancora oggi. Verso il futuro: i giovani nel villaggio globale Garibaldo, credendo fermamente nei valori della pace, dei diritti umani, della solidarietà internazionale e del rispetto tra i popoli, convinto che “una società dove molti sono gli esclusi è una società senza futuro”, è anche uno dei fondatori, ancora oggi nell’esecutivo, dell’Associazione Livornese di solidarietà con il Popolo Saharawi. Dal 1993 l’associazione promuove scambi interculturali tra bambini e famiglie, gemellaggi, adozioni a distanza e molteplici iniziative finalizzate a costruire una solidarietà concreta tra il popolo saharawi e quello livornese, nell’ottica di una sempre più ricca interazione tra queste due culture così differenti. Nel 2002 riceve una targa d’argento dal comune di Livorno come riconoscimento per l’impegno civile e la continua testimonianza ai giovani dei valori di libertà e giustizia. Nel 2007 è presidente onorario dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea nella provincia di Livorno. Ma l’impegno più appassionato di Garibaldo dal dopoguerra ad oggi è quello all’interno dell’Anppia, di cui è fondatore a livello nazionale con Umberto Terracini, e presidente, a Livorno, fino ai giorni nostri. Un impegno assiduo il suo nel portare testimonianza di storia e di vita nelle scuole (interviste, progetti, viaggi con le classi sui luoghi degli eccidi fascisti e nazisti) affinché i giovani comprendano i valori della democrazia, della giustizia, della libertà. DA PARMA N on si cancellano la storia e il valore della Resistenza jugoslava Fascisti, leghisti e destre anticomuniste vorrebbero fosse eliminata l’intitolazione a Tito della piccola strada di Parma esistente dagli anni ’80, e in alternativa introdotta “via martiri delle foibe”. È una richiesta grave e assolutamente inaccettabile, espressione di quel “revisionismo storico” mirante a sminuire il valore della Resistenza antifascista, oscurare i crimini fascisti e nazisti, e rivalutare in qualche modo il fascismo. Morti delle foibe, nel settembreottobre ’43 e nel maggio ’45, furono alcune centinaia di italiani (migliaia aggiungendo dispersi e fucilati in guerra, deportati e morti in campi di concentramento jugoslavi, ecc.) in gran parte militari, capi fascisti, dirigenti e funzionari dell’amministrazione italiana occupante la Jugoslavia, collaborazionisti. Morti per atti di giustizia sommaria, vendette ed eccessi, da parte di partigiani jugoslavi, derivanti dall’odio popolare e dalla rivolta nei confronti dell’Italia fascista. Considerare questi morti indistintamente, accomunarli tutti insieme, non rende giustizia a quella parte di loro che furono vittime innocenti. Vittime, non martiri. La stessa legge statale del 2004 istitutiva del “giorno del ricordo delle vittime delle foibe” non usa mai la parola “martiri”. Violenza di proporzioni di gran lunga superiori, sistematica e pianificata, e precedente, è stata quella del fascismo a partire dal 1920. Azioni delle squadracce contro centri culturali, sedi sindacali, cooperative agricole, giornali operai, politici e cittadini di “razza slava”, poi, nel ventennio, la chiusura delle scuole slovene e croate, il cambiamento della lingua e dei nomi, l’italianizzazione forzata, infine, nell’aprile del ’41, l’aggressione militare, l’invasione della Jugoslavia da parte dell’esercito del re e di Mussolini, pochi giorni dopo quella da parte della Germania nazista. L’Italia si annesse direttamente alcuni territori (come Lubiana e parte della Slovenia), altri tenne sotto controllo, in condizioni di occupazione particolarmente dure e crudeli, non meno di quelle naziste. Distruzione di interi villaggi sloveni e croati, dati alla fiamme, massacro di decine di migliaia di civili, campi di concentramento. Di qui la rivolta contro l’Italia fascista, lo sviluppo impetuoso del movimento partigiano delle formazioni repubblicane e comuniste guidate da Tito, la grande lotta antifascista e antinazista nei Balcani. Enorme è stato il tributo jugoslavo alla guerra contro il nazifascismo: su una popolazione di 18 milioni di abitanti dell’intero Paese, furono al comando di Tito 300.000 combattenti alla fine del ’43 e 800.000 al momento finale della liberazione, 1.700.000 furono i morti in totale, sul campo 350.000 i partigiani morti e 400.000 i feriti e dispersi. Da 400.000 a 800.000, ovvero da 34 a 60 divisioni, furono i militari tedeschi e italiani tenuti impegnati nella lotta, con rilevanti perdite inflitte ai nazifascisti. Una lotta partigiana su vasta scala, che paralizzò l’avversario e passò progressivamente all’offensiva, un’autentica guerra, condotta da quello che divenne un vero e proprio esercito popolare e che fece di Tito più di un capo partigiano, un belligerante vero e proprio, riconosciuto e considerato a livello internazionale. La Resistenza della Jugoslavia è stata di primaria grandezza in Europa e da quella esperienza la Jugoslavia è uscita come il paese più provato e al tempo stesso più trasformato. La Resistenza jugoslava ancor più di altre è stata più di una guerriglia per la liberazione del proprio territorio, è stata empito universale di una nuova società, ansia di superamento delle barriere nazionali, anelito di pace, libertà e giustizia sociale, da parte di tanti uomini e tante donne del secolo scorso. Ai partigiani jugoslavi si unirono, l’indomani dell’8 settembre ’43, 21 Noi quarantamila soldati italiani, la metà dei quali diedero la vita in quell’epica lotta nei Balcani; essi, col loro sacrificio, riscattarono l’Italia dall’onta in cui il fascismo l’aveva gettata. A questi italiani devono andare il ricordo e la riconoscenza della Repubblica democratica nata dalla Resistenza. Comitato Antifascista e per la Memoria Storica – PARMA DA VERONA R iprendono nel 2012 le numerose iniziative scaligere. L’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, l’ANPI, l’ANPPIA e l’ANED, per ricordare il GIORNO DELLA MEMORIA, hanno organizzato una serie di iniziative di cui diamo conto qui di seguito. 14 gennaio Presso la sala “Berto Perotti” dell’IVrR, è stato presentato il libro Quella del Vajont Tina Merlin, una donna contro di Adriana Lotto (Cierre 2011). Ha presentato il volume Lorenza Costantino alla presenza dell’Autrice. “Il nome di Tina Merlin resta legato alla tragedia del Vajont. Fu infatti la prima giornalista, e unica fino alla catastrofe, a denunciare l’operato della Sade (Società Adriatica di Elettricità) di voler realizzare la diga che, con la nazionalizzazione dell’energia elettrica, sarà ceduta all’Enel. Tina Merlin era una cronista di vaglia, una voce libera che dalle colonne de “l’Unità” dava spazio ai timori dei montanari sui pericoli incombenti per le popolazioni della valle. Aveva partecipato alla Resistenza e per ricordare il contributo delle donne alla lotta di liberazione scrisse un libro di racconti partigiani Menica e le altre. Animata da grande passione per il suo mestiere, viveva il lavoro come una missione occupandosi fra l’altro di emigrati, di territorio ferito, di montagna abbandonata, di sviluppo sostenibile e di ecologia. Si occupò sempre di emancipazione femminile che secondo lei, moglie e madre, era inscindibile dal lavoro. Per le sue denunce sui pericoli della costruzione della diga del Vajont fu denunciata per turbativa dell’ordine pubblico, processata e infine assolta. Rimase ai margini della grande stampa, quasi fosse stato attuato nei suoi confronti una sorta di ostracismo. Morirà a Belluno il 22 dicembre 1991 a 65 anni”. 21 gennaio Presso la sala “Berto Perotti” dell’IVrR, il 21 gennaio è stato proiettato il documentario E come potevamo noi cantare. Milano 1943 – 1945. Le deportazioni. Un film di Vera Paggi, Dario Venegoni, Leonardo Visco Gilardi. Regia di Massimo Buda. Era presente Dario Venegoni. E come potevamo noi cantare con il piede straniero sopra il cuore tra i morti abbandonati nelle piazze sull’erba dura di ghiaccio, al lamento d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero della madre che andava incontro al figlio crocifisso al palo del telegrafo? Alle fronde dei salici, per voto, anche le nostre cetre erano appese, oscillavano lievi al triste vento’. (Salvatore Quasimodo, Alle fronde dei salici – 1945) 4 febbraio Presso la sala “Berto Perotti” dell’IVrR ha avuto luogo l’incontro: Storia di Luisa. Una bambina ebrea di Mantova, conversazione di Donatella Levi con Maria Bacchi e Fernanda Goffetti, curatrici della ricerca che è stata pubblicata nel 2011 dall’editore Gianluigi Arcari di Mantova. Ha introdotto l’incontro Roberto Bonente “Storia di Luisa, mette bambini e Adriana Lotto autrice del libro su Tina Merlin adolescenti al centro: sia come oggetti di ricerca che come soggetti attivi nella trasmissione delle conoscenze sul passato. Un passato, quello compreso tra il 1938 e il 1945, di cui si parla e sul quale ci si «emoziona» ma sul quale troppo poco ancora si riflette e si studia. Chi l’ha vissuto direttamente ed è in grado ricordarlo ora è anziano e a quel tempo aveva l’età delle ragazze e dei ragazzi a cui ci rivolgiamo oggi; si tratta di difficili ricordi d’infanzia”. Il violino di Andrea Testa ha accompagnato alcuni momenti dell’incontro. 11 febbraio Si è tenuta la conferenza dal titolo: Prima della Shoha, relatore Carlo Saletti, introdotta da Roberto Buttura. Carlo Saletti è curatore con Ernesto De Cristofaro del libro Precursori dello sterminio. Binding e Hoche all’origine dell’eutanasia dei malati di mente nella Germania nazista, edito nel 2012 dalla casa editrice ombre corte di Verona. “Tra i primi sostenitori della necessità di procedere a eliminazioni programmate di vite umane erano stati, agli inizi degli anni Venti, il giurista Karl Binding e lo psichiatra Alfred Hoche. Nell’abiura dei più elementari principi umanitari, questi precursori dello sterminio, che predicavano la soppressione di tutti quei malati giudicati dalla scienza medica inguaribili, affidarono il loro messaggio a un breve libro destinato a fare scuola’. 18 febbraio Nella sede dell’ANPPIA, ANPI e IVrR, sala “Berto Perotti” è stata indetta la Giornata del tesseramento 22 Noi Verona, 25 febbraio il relatore Roberto Bonente ANPPIA 2012. L’incontro ha avuto come tema: Fare oggi la storia dell’antifascismo. L’esperienza modenese, Tema trattato da Claudio Silingardi, direttore dell’Istituto storico di Modena. Ha introdotto Roberto Bonente, consigliere nazionale ANPPIA. Claudio Silingardi è uno dei curatori del Dizionario storico dell’antifascismo modenese realizzato dall’istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Modena. L’obiettivo fondamentale del Dizionario è quello di restituire volti e voci, per quanto possibile, ai molteplici fenomeni e casi di opposizione al fascismo dall’inizio degli anni Venti fino alla svolta dell’8 settembre 1943, adottando come contesto spaziale di riferimento l’intera provincia modenese. 25 febbraio Organizzato un incontro-conversazione con Roberto Bonente, tenuto presso la sala “Berto Perotti” dell’IVrR dal titolo: In memoria dei veronesi caduti nei campi di deportazione. Nel 1966, per celebrare il XX anniversario della Liberazione, la sezione veronese dell’Associazione nazionale ex deportati pubblicò un piccolo ma prezioso libretto: In memoria dei veronesi caduti nei campi di deportazione. Scritto da Alfredo Molin, deportato a Mauthausen e che sarà in seguito presidente dell’Aned di Verona, con una presentazione di Augusto Tebaldi, deportato a Flossenburg, voleva essere «uno scarno tremendo rendiconto finale di una inumana operazione, la cui impressionante vastità è rispecchiata anche per questo angolo d’Europa da nomi e cifre: una pagina indimenticabile di dolore e di sacrificio, troppo spesso dimenticata e misconosciuta». Nella guerra che si combatte nel mondo tra il bene e il male, dovete dare il vostro nome alla bandiera del bene e avversare senza tregua il male. (Giuseppe Mazzini) DA MILANO Il Coordinamento ANPI Milano e il Comitato Antifascista per la difesa della Democrazia zona Sei di Milano ci inviano il comunicato stampa sull’ennesima provocazione fascista di Forza Nuova O ggi 10 febbraio 2012 “Giorno del Ricordo” ore 17.00 presso la Sala Polifunzionale del Comune di Milano “SEICENTRO” in Via Savona 99 a Milano (Zona sei) alle ore 17.00 circa, una quindicina di persone con viso coperto da maschere e passamontagna hanno fatto irruzione nella sala Teseo dove è in esposizione, a cura della Fondazione Memoria della Deportazione con il Patrocinio del Consiglio di zona sei la Mostra: FASCISMO FOIBE ESODO “La tragedia del confine orientale”. Imbrattare i cartelloni, lanciare volantini firmati Forza Nuova, urlare contro la commessa e i cittadini in sala, ecco l’azione vile dei “visitatori”. Al contrasto deciso dei presenti, i quindici lasciavano la sala senza potere continuare l’opera di danneggiamento dei cartelloni. Sdegno e piena condanna dalle forze Democratiche della zona, l’ANPI di Zona e Il Comitato Antifascista per la difesa della Democrazia zona sei Milano INVITANO tutti i cittadini a visitare la mostra domani… proprio per capire che la verità dà sempre fastidio ai “fascisti” e proprio la verità particolare del Giorno del Ricordo ancor più infastidisce chi da sempre confonde, infanga, inquina, revisiona, fatti e azioni che sono la nostra storia. Milano città medaglia d’Oro della Resistenza, non può accettare questa forma di violenza fisica e di pensiero, ancora una volta la nostra risposta democratica, civile e di presidio antifascista si muoverà sul territorio raccontando verità portando cultura e chiedendo alle Istituzioni e cittadini tutti, vigilanza e negazione di qualsiasi spazio al fascismo, al razzismo. DA TORINO Lutto a Torino Carmela Mayo ci ha lasciati I l 18 gennaio è deceduta a Torino Carmela Mayo vedova Levi che faceva parte del Comitato Direttivo della Federazione Anppia di Torino. Aveva appena compiuto 97 anni era nata il 14 gennaio 1914). Nata a Gradisca d’Isonzo (Gorizia), la sua famiglia giunse profuga a Torino nel 1915. Dopo una iniziale adesione al fascismo, che la vide protagonista delle attività delle “Giovani italiane”, Carmela inizia un percorso di ribellione alle ingiustizie e alla propaganda anti semita. Le leggi razziali segnano il suo definitivo distacco dal fascismo e l’inizio di un percorso che la porterà alla militanza antifascista. Nel novembre 1943 aveva sposato 23 Noi Mario Levi, noto ebreo antifascista, membro del PCI, condannato a 3 anni di reclusione perché, ufficiale dell’esercito, aveva fornito armi ai “sovversivi” durante l’occupazione delle fabbriche ed era stato difeso dall’on. Terracini dinanzi al Tribunale Militare. A inizio guerra era stato poi internato, con altri ebrei, ad Ateleta, in Abruzzo. Per sfuggire alle ricerche dei tedeschi, durante la Resistenza la coppia si rifugia nelle Valli Valdesi sotto falso nome (Olaro). Qui Carmela si unisce alla 105a Brigata partigiana Garibaldi “Carlo Pisacane” e opera quale staffetta portaordini tra la brigata e il comando di Torino e come redattrice di un giornale clandestino. È significativa la sua partecipazione ai Gruppi di difesa della donna, che dà inizio alla sua attività politica dedicata al mondo femminile. Dopo la Liberazione Carmela si adopera nel settore sociale riunendo l’Associazione Pionieri d’Italia (ragazzi fino ai 15 anni) e difendendo i diritti delle donne. Nell’Anppia, da vedova, ha dato un valido contributo di idee e di attività insieme a Rita Comoglio ved. Bazzanini, tuttora viva e quasi coetanea. Carmela Mayo in una rara foto giovanile Lettere Sollecitati a replicare allo “sfogo” pubblicato nel numero scorso, i lettori rispondono Due Risposte a Terracciano La lettera di Nicola Terracciano pubblicata sul mensile L’antifascista dell’ottobre - dicembre 2011 (p. 2) dipinge dell’Italia attuale un quadro a nero di pece, dove tutto è buio e non si distinguono forme. Mentre si legge, in certo modo vi si ritrova se stessi, perché ognuno di noi (intendo noi democratici e antifascisti) soffre nelle proprie viscere la bruttura del mondo quale si è andato delineando da qualche decennio a questa parte. Per noi italiani in particolare si aggiunge l’umiliazione di un paese in preda all’illegalità e alla rapina. Eppure, proseguendo nella lettura delle due “colonne infami” si ricevono stilettate ulteriori, non più ascrivibili all’oggetto rappresentato, ma inerenti alla rappresentazione stessa. Insieme al presente, viene coperto di fango anche il passato, anche quello più nobile, quello che dovrebbe e forse potrebbe segnare la via del riscatto. Giudizi gettati qua e là, così perentori e ingiusti che non possono essere lasciati senza risposta puntuale. “ imperversano partiti e loro cinghie di trasmissione che sono i sindacati di cosiddetto centro-destra e di cosiddetto centro-sinistra ”. Anche la CGIL, anche la FIOM, che si stanno battendo contro, che continuano a lottare, che sono ancora l’unica organizzazione di massa contro l’arbitrio finanziario? Un po’ di solidarietà non stonerebbe. Già, ma a rileggere daccapo l’articolo, si scopre che aveva preso le mosse proprio dall’arbitrio finanziario, assunto però come “mercato” e “fiducia” (sfiducia) degli altri paesi nei confronti di un’Italia peccatrice. Terracciano assume la finanza nazionale e internazionale come termometro, laddove sappiamo tutti che è il cancro. “ la cara miracolosa democrazia repubblicana conquistate [sic!] con lacrime e sangue dall’Antifascismo e dalla Resistenza, specialmente non comunisti [sic!] ”. Palesemente la foga rabbiosa fa smarrire all’autore il rispetto, oltre che della verità, delle concordanze grammaticali. A parte questo, ognuno ha il diritto giuridico di essere anticomunista nella maniera e nella misura che crede, ma affermare che la democrazia e la repubblica furono riconquistate in Italia grazie alla Resistenza soprattutto non comunista è un falso storico, una pura e semplice menzogna! E, tra l’altro, vogliamo ricordarci, se non altro un pochino, l’oscuro lavorio nell’ombra di certi “resistenti non comunisti”, come ad esempio Pacciardi e Sogno, golpisti in futuro, ma all’opera già allora per una democrazia imbrigliata? Ma vediamo il seguito della frase: “ non comunisti (cioè non bacati, contorti, capovolti, ridimensionati dal mito totalitario stalinista) ”. Personalmente, sono nato alla politica come socialista; mi iscrissi al PSI nel 1963 all’età di 23 anni; vi militai fino al 1976 quando, disgustato dalle prime avvisaglie del craxismo, passai con convinzione e passione al PCI, del quale era allora segretario e guida Berlinguer. Sottoscrizioni Anna Canitano (Morlupo) 25,00 Bruno Bevilacqua (Mi): 15,00 Eolo Passalacqua (Vi) in memoria del padre Luigi: 130,00 Maria Rosa Militano (Mi) in memoria del marito perseguitato politico Pasquale Melara: 60,00 Mirella Bertolino (To) in memoria del padre Guglielmo: 170,00 Neviana Dusi (Cesenatico) in memoria del padre Luigi Dusi e della madre Ada Pagan: 30,00 Pina Specchio Quagliotti (Ao): 10,00 Valentina Lucchi (Bo) in ricordo del marito Medardo Anderlini: 100,00 Lettere Non ho mai cambiato le mie idee e i miei valori di fondo, salvo che su questioni di analisi contingente, ad esempio sul grado di snaturamento raggiunto prima dal PSI (negli anni del centro-sinistra), poi dal PCI (negli anni Ottanta). Non posso perciò che essere d’accordo che lo stalinismo sia stato una tragedia per il comunismo internazionale e anche per il comunismo italiano: nel suo sbandamento totale dopo la Bolognina ha certo avuto parte non secondaria il crollo del mito sovietico, che nei cuori di troppi comunisti si legava troppo inestricabilmente con l’ideale comunista. Ma come negare che, nonostante quest’ipoteca, e in parte anche grazie ad essa, il PCI, dal ’45 all’84, fece molte grandi cose? Vogliamo elencarle? Sarebbe troppo lungo! Facciamo a capirci! “ il sostanziale “colpo di stato” del novembre-dicembre 1945 ordito dal Vaticano, dai democristiani di De Gasperi, dai comunisti di Togliatti, dai socialisti proletari di Nenni, dai liberali di Croce e di altri contro il governo del rinnovamento radicale democratico dell’azionista liberal-socialista Parri ”. Si salvi chi può! Ma si salva solo Parri. La carta costituzionale, un capolavoro politico e giuridico riconosciuto come tale da tutto il mondo, compresi storici e giuristi, viene declassato a colpo di stato! Data l’ammucchiata dei personaggi elencati non sembra trattarsi solo della questione della costituzionalizzazione del Concordato con la Chiesa cattolica, ma anche di altro: di che cosa? Terracciano avrebbe fatto bene a spiegare. A questo punto viene il dubbio che, nonostante le sue precedenti professioni mercatiste e anticomuniste, egli avrebbe vagheggiato, dopo la caduta del fascismo, la rivoluzione socialista immediata e una sorta di repubblica sovietica (fatalmente, gli piaccia o no, egemonizzata da Stalin). Questo avrebbero dovuto fare nel ’45-’48 Togliatti, Nenni e i loro “antagonisti-complici”? Saggiamente, non vollero farlo. Ma, se anche avessero voluto, non avrebbero potuto, dati i vincoli internazionali oggettivi. La storia non è così semplice, e non la si capisce con la rabbia e il disprezzo generalizzato. “Maggioranze eroiche politiche e intellettuali con il “vero popolo lavoratore” [la maggioranza silenziosa?] hanno compiuto il miracolo della “ricostruzione’, con l’aiuto degli Alleati e in particolare degli Stati Uniti d’America ”. Viva la DC! Viva Saragat! Viva la CIA! Non ne verrà nulla di buono, se all’attuale sfascio aggiungiamo lo smarrimento della memoria, l’oblio di quanto fece la classe lavoratrice che, con l’aiuto determinante delle sue organizzazioni sindacali e politiche, sognò un mondo migliore e, mentre sognava, trasformò davvero l’Italia e tante altre nazioni in paesi civili, o anche soltanto meno incivili. Giovanni Cerri (Roma) Sull’ultimo numero della nostra rivista ho letto l’articolo del signor Nicola Terracciano. Sono rimasta esterrefatta ed ho pensato ad un uomo molto infelice e, soprattutto, inutile a se stesso e pericoloso per la società nella quale vive; dirò brevemente il perché, anche se il nostro “amico” è di quel genere di persone che non si convince. Ho partecipato – come modesta staffetta – alla lotta di Liberazione nel bolognese in una Brigata gloriosa – la “Bolero’. Io ero – e sono rimasta – COMUNISTA anche se mi adeguo alle ginnastiche politiche attuali. Nella Brigata i comunisti erano la maggioranza (ed anche i Caduti), ma anche altre ideologie – o assenza di ideologie – erano presenti ed attive: lo scopo era unitario, cacciare i nazi-fascisti e conquistare la LIBERTÁ e la DEMOCRAZIA. Finita la guerra ci siamo dedicati TUTTI (cioè tutto il popolo e non solo una minoranza americaneggiante) alla ricostruzione materiale e morale. Partiti, Sindacati, Istituzioni tutti per un unico scopo. E sono stati anni lunghi e colmi di battaglie politiche e sindacali. Occorrerebbero libri molto grossi per descriverle anche per sommi capi. Io ho fatto a lungo parte di queste battaglie, all’interno delle Istituzioni. Oggi ho quasi 86 anni, ne ho lavorati 47 e vivo della mia pensione in un appartamento che non è mio. Non ho mai preso nulla che non fosse frutto del mio lavoro, neppure quando ho fatto parte di organi dirigenti. Ma non soltanto io ho vissuto in modo onesto e pulito: come me milioni di italiani ed anche sindaci, politici, sindacalisti, giudici, poliziotti ecc. ecc. Certo la corruzione esiste, la mafia, la ‘ndrangheta ecc. sono realtà vere e pericolose. La corruzione ci opprime, specie dopo la triste epopea berlusconiana che tutto copriva (e copre). La maggioranza degli italiani è convinta che è necessario lottare “contro” e lo fa, anche se spesso il prezzo è molto alto. Pensa di mettere nel “mucchio” dei corrotti anche i tanti giudici, poliziotti, sindacalisti, intellettuali, politici abbattuti vigliaccamente? E studenti, e popolo? Inoltre, le sembrano “corrotti” milioni di persone (lavoratori, donne, studenti, pensionati, disoccupati ecc.) che lottano nelle piazze? O sono la maggioranza del Paese convinta ed unita dei propri diritti e nel nome di chi tutto ha sacrificato? Sono d’accordo soltanto su una citazione della lettera del signor Terracciano: la nobiltà della figura di Parri. Ma era a capo di un partito molto piccolo (anche se intellettualmente di livello alto) e da solo non avrebbe potuto fare molto. Ma Lui lavorava assieme agli altri Partiti del CLN nati dalla Resistenza e composti da persone oneste e decise. Anche i Comunisti. Per quanto riguarda il “colpo di stato” del novembre-dicembre 1945, provi ad indagare sui suoi amici americani e sul Convegno di Yalta… Lei, signor Terracciano, che cosa ha fatto o fa per cambiare la situazione? Dalla sua lettera emerge una persona pericolosa per la società italiana: rabbiosa, astinente e comodamente inutile, per poter dire “l’avevo detto”… Gabriella Zocca (Bologna) l’antifascista Mensile dell’ANPPIA Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti Direttore Responsabile: Antonella Amendola REDAZIONE: Corsia Agonale, 10 – 00186 Roma Tel 06 6869415 Fax 06 68806431 www.anppia.it anppia.blogspot.com [email protected] TIPOGRAFIA Cierre Grafica srl Roma - Via del Mandrione 103A PROGETTO GRAFICO Marco Egizi www.3industries.org Prezzo a copia: 2 euro Abbonamento annuo: 15,00 euro Sostenitore: da 20,00 euro Ccp n. 36323004 intestato a “l’antifascista” Chiuso in redazione il: 5 aprile 2012 finito di stampare il: 16 Aprile 2012 Registrazione al Tribunale di Roma n. 3925 del 13.05.1954
Scaricare
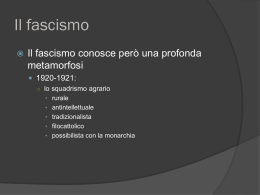
![Le origini e la presa del potere [g]](http://s2.diazilla.com/store/data/000068864_1-7a3b7b6cfdf5e3492d6f39a327d65d39-260x520.png)