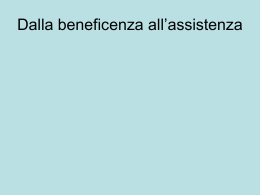70 ERBA Il volume illustra, attraverso immagini e documenti significativi, gli aspetti principali del complesso rapporto fra la donna lavoratrice e il mondo della produzione, ovvero il processo di trasformazione dell’identità femminile (individuale e collettiva) nella società italiana del XX secolo. La ricerca – con focus sull’Emilia-Romagna – affronta la tematica, ripercorrendo tempi e fasi della inclusione/esclusione femminile nel mondo del lavoro, individuandone cause e ragioni. Dalla difficoltà di accedere ad occupazioni ritenute ‘naturalmente maschili’ di fine Ottocento-inizio Novecento, si passa a delineare il riconoscimento ad esercitare tutte le professioni ottenuto dopo la prima guerra mondiale, riconoscimento tuttavia negato durante il periodo fascista, e si arriva infine al raggiungimento della parità duramente conquistata con le lotte degli anni 1950-1960. La narrazione, dall’Unità d’Italia agli anni Sessanta del secolo scorso, prende in esame gli ambiti lavorativi esclusivamente femminili, le loro caratteristiche (salari più bassi, status inferiore, minore qualificazione) e la loro evoluzione; le riviste, le associazioni e le donne che portano avanti le richieste delle lavoratrici; le filosofie sul tema del lavoro che dominano lo spazio comunicativo e sociale; la legislazione (protettiva, discriminatoria, espulsiva) connessa a tali visioni del lavoro; le conseguenze sulle strutture sociali e sulla mentalità dominante. DONNE E LAVORO: UN’IDENTITÀ DIFFICILE Lavoratrici in Emilia Romagna (1860-1960) DONNE E LAVORO: UN’IDENTITÀ DIFFICILE € 15,00 Rossella Ropa e Cinzia Venturoli Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna Soprintendenza per i beni librari e documentari EMILIA ROMAGNA BIBLIOTECHE ARCHIVI Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna Soprintendenza per i beni librari e documentari EMILIA ROMAGNA BIBLIOTECHE ARCHIVI N. 70 Copertina di Sergio Vezzali © 2010 Testi e immagini Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna www.ibc.regione.emilia-romagna.it © 2010 EDITRICE COMPOSITORI s.r.l. Via Stalingrado, 97/2 - 40128 Bologna Tel. 051/3540111 - Fax 051/327877 E-mail: [email protected] http://www.compositori.it ISBN 978-88-7794-701-7 DONNE E LAVORO: UN’IDENTITÀ DIFFICILE Lavoratrici in Emilia Romagna (1860-1960) Rossella Ropa e Cinzia Venturoli Il volume è pubblicato in occasione della mostra allestita per la prima volta a Imola, nella Salannunziata, dal 30 gennaio al 14 febbraio 2010, nell’ambito delle iniziative del Comitato per le celebrazioni del 60º anniversario della Costituzione Italiana composto da Regione EmiliaRomagna, Provincia di Bologna, Comune di Bologna, Ufficio Territoriale di Governo di Bologna, Alma Mater Studiorum Università di Bologna e Ufficio Scolastico Regionale. Mostra promossa da Regione Emilia-Romagna - Presidenza Giunta IBC - Soprintendenza per i beni librari e documentari a cura di Rossella Ropa e Cinzia Venturoli coordinamento Annamaria Bernabè organizzazione Paola Bussei, Liana D’Alfonso, Carlo Tovoli progetto grafico Pablo comunicazione | Fabio Bolognini apparati fotografici Le riproduzioni fotografiche del materiale documentario conservato presso la Biblioteca comunale dell’Archiginnasio, l’Istituto storico Parri Emilia-Romagna, la Fondazione Istituto Gramsci Emilia-Romagna sono state eseguite dal Laboratorio dell’IBC (Andrea Scardova); quelle della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze dallo Studio Gap di Firenze (Mario Setter); quelle della Biblioteca Universitaria di Bologna dallo Studio fotografico Roncaglia di Modena. Le rimanenti sono state direttamente fornite dalle istituzioni culturali che le possiedono. comunicazione Ufficio Stampa IBC Agenzia Informazione e Ufficio Stampa della Regione Emilia-Romagna Per informazioni: www.ibc.regione.emilia-romagna.it www.regione.emilia-romagna.it/costituzione Si ringraziano per la cortese disponibilità e collaborazione i direttori e gli operatori degli enti per l’autorizzazione a pubblicare il materiale documentario e fotografico: Archivi Alinari di Firenze; Archivio Centro Italiano Femminile di Roma; Archivio del lavoro di Sesto S. Giovanni (Milano); Archivio di Stato di Bologna; Archivio fotografico Cineteca del Comune di Bologna; Archivio storico “Donatella Turtura”, Flai Cgil nazionale di Roma; Archivio storico del Comune di Bologna; Archivio storico del Comune di Modena; Archivio storico del Comune di Parma; Archivio storico dell’Università di Bologna; Archivio storico della Provincia di Bologna; Associazione Paolo Pedrelli, Archivio storico sindacale di Bologna; Biblioteca civica d’Arte Luigi Poletti di Modena; Biblioteca comunale dell’Archiginnasio di Bologna; Biblioteca comunale Giulio Cesare Croce di S. Giovanni in Persiceto (Bologna); Biblioteca dell’Accademia Nazionale di Agricoltura di Bologna; Biblioteca Italiana delle Donne di Bologna; Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; Biblioteca Reale di Torino; Biblioteca Universitaria di Bologna; Centro italiano di documentazione sulla cooperazione e l’economia sociale di Bologna; Civica Raccolta stampe Achille Bertarelli di Milano; Collezioni d’Arte e di Storia della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna; Dipartimento di colture arboree dell’Università di Bologna; Fondazione Istituto Gramsci Emilia-Romagna di Bologna; Fotomuseo Giuseppe Panini di Modena; Fototeca della Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia; Gruppo “Tracce di una storia”, Centro Sociale Ricreativo Culturale Santa Viola di Bologna; Istituto per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea della provincia di Forlì-Cesena (Forlì); Istituto storico della Resistenza e di storia contemporanea di Modena; Istituto storico Parri Emilia-Romagna di Bologna; Istituzione Villa Smeraldi, Museo della civiltà contadina di S. Marino di Bentivoglio (Bologna); Musei civici di Carpi; Museo civico d’Arte di Modena; Museo civico del Risorgimento di Bologna; Museo dell’Assistenza Infermieristica di Bologna; Museo della civiltà contadina di Bastiglia (aut. prot. 7266/2009). Sommario Donne e lavoro VII Maria Giuseppina Muzzarelli Introduzione XI Rossella Ropa e Cinzia Venturoli Lavorare al femminile XV Fiorenza Tarozzi DALL’UNITÀ D’ITALIA ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE 1 Rossella Ropa Tra due secoli La ‘questione’ del lavoro femminile 3 Le attività tradizionali 8 I lavori di cura 35 Le lavoratrici dello Stato 52 Le donne si organizzano 67 La conquista dei diritti 82 L’intervento dello Stato 90 La prima guerra mondiale Lavorare in tempo di guerra 95 Mobilitarsi in tempo di guerra 100 RACCONTO PER IMMAGINI 105 DAL REGIME FASCISTA AGLI ANNI SESSANTA 123 Cinzia Venturoli Il fascismo e la seconda guerra mondiale La donna nella propaganda fascista 125 Le donne organizzate: fasci femminili e sezioni operaie e lavoranti a domicilio 130 Le donne organizzate: massaie rurali e donne in Africa 135 Le donne al lavoro, lavori da donne 141 Nelle fabbriche 149 Lavorare in campagna 154 Altri mestieri 158 I littoriali del lavoro femminile 161 Donne in guerra 163 Il secondo dopoguerra e gli anni Cinquanta Votare ed essere votate. Donne sulla scena pubblica 167 Il diritto al lavoro 174 La legislazione 177 Richieste e rivendicazioni per il lavoro in campagna e in fabbrica 182 Le operaie 187 Il lavoro a domicilio: mutamenti e persistenze 190 La campagna 193 Mestieri e professioni 196 BIBLIOGRAFIA 205 INDICE DEI NOMI 212 Donne e lavoro Donne e lavoro: un’endiadi che indica sacrificio e libertà, limite e insieme risorsa. Una coppia di termini il cui significato cambia radicalmente a seconda della collocazione geografica e cronologica, che cambia nel lungo periodo ma anche nel corso di qualche decennio con conseguenze sulle sorti individuali e collettive. Una combinazione che è diversa dalla pur analoga fra uomini e lavoro e questo dato è al centro della ricerca che segue. Endiadi, si è detto, e in senso proprio, giacché una delle parole appare, seppur solo in qualche misura, il possibile complemento dell’altra. Il lavoro ha, in effetti, la potenzialità, ma non sempre l’effettiva capacità, di rendere più piena la realizzazione personale e sociale di chi lo pratica. Il lavoro conferisce identità e consente modificazioni ed ascese sociali modificando lo status individuale e famigliare: per gli uomini nei secoli è stato così, ma non per le donne. Alle donne il lavoro, quasi sempre impegnativo ma interstiziale, aggiustato, a termine, non specializzato, non ha dato le stesse possibilità di relazioni e di realizzazione. Le donne hanno sempre lavorato ma spesso per sostituzioni temporanee, con pochi riconoscimenti e regolarmente con minori retribuzioni e ineguali diritti. Le cose al riguardo hanno cominciato a cambiare solo in tempi relativamente recenti e di questo non si deve perdere memoria. Prendiamo il mezzo secolo e oltre che corre dalla fine dell’Ottocento agli anni Sessanta del Novecento: in Italia e dunque anche in Emilia-Romagna i cambiamenti sono stati enormi dovuti alla tecnologia, alle vicende politiche, agli assetti sociali. Cambiamenti altrettanto rilevanti hanno riguardato la condizione delle donne e molti di essi sono correlati al lavoro. Il lavoro risulta sempre più scelto dalle donne e non solo subito, un lavoro anche qualificato e spesso esercitato in ambiti mai calcati in precedenza. Ancora: lavoro che ha dato non solo reddito ma anche identità e libertà, lavoro che ha risolto problemi ma contestualmente originato difficoltà e drammi, basti pensare alla difficile conciliazione con la maternità. Si parla nelle pagine che seguono di lavoro disciplinato ed equiparato a quello maschile ma con paghe che in alcuni casi ancora oggi sono inferiori a quelle percepite dagli uomini. Le affermazioni nel campo del lavoro di cui si parla sono state raggiunte anche grazie alle drammatiche vicende belliche che hanno allontanato gli uomini da fabbriche e officine dando così alle donne un peso in più ma anche una possibilità di dimostrare le loro capacità. Le eterne riserve, le usuali ‘socie non pagate’ si sono trasformate in coprotagoniste della produzione e del lavoro impiegatizio: a situazioni eccezionali ha corrisposto uno spazio usualmente negato alle donne che queste ultime hanno saputo occupare senza successive retrocessioni. Resta il fatto che in caso di crisi le donne sono tendenzialmente le prime a perdere il lavoro e su questo siamo chiamati a riflettere e ad intervenire. Nel periodo analizzato in questo volume assistiamo all’assommarsi ‘ufficiale’ e non solo surrettizio di lavoro domestico ed extradomestico fin quasi all’esaurimento delle VIII Donne e lavoro forze; assistiamo al superamento del lavoro infantile, al pionieristico raggiungimento di settori usualmente preclusi. L’endiadi, insomma, mostra un’infinità di aspetti che oscillano fra fatica e indipendenza, giogo e libertà. Se le facce del fenomeno sono dunque innumerevoli, altrettanto numerose appaiono le teorie da proporre alla riflessione e, in particolare, le indicazioni di approfondimento per i più giovani. Questo lavoro si ripropone proprio per uno scopo del genere: far capire la complessità e insieme la rilevanza del tema e rendere conto del lungo percorso che ha portato le donne nelle corsie ospedaliere non solo come infermiere, nelle scuole anche come dirigenti, nelle aziende in ruoli tecnici elevati, in politica agli apici delle posizioni. Non tutto è stato raggiunto, sia chiaro, ma certamente nell’ultimo secolo è stata fatta una lunga e faticosa strada che va ricordata non solo per rendere merito a chi si è battuto per ottenere i risultati che sono sotto gli occhi di tutti ma anche per evitare passi indietro, tanto più possibili quanto più si è ignari e si attraversano fasi di crisi economica e di basso impegno civile. Oggi per i più giovani è quasi scontato che una donna lavori fuori casa e che eserciti o aspiri ad esercitare lo stesso mestiere di un uomo. Per i più è anche ovvio che la donna lavori di più assumendosi pure l’onore delle cure domestiche. È un fatto che la tecnologia abbia dato una mano alle donne grazie ad invenzioni apparentemente modeste ed in realtà strepitose, dalla lavatrice agli aspirapolveri semoventi di recente ideazione. Non so quante fra le più giovani siano consapevoli del faticoso iter percorso e quanto ancora oggi risulti difficile a molti l’accettazione dell’emancipazione femminile! I dati della ricerca Istat del 2006 sulla violenza subita dalle donne invitano a riflettere sulle resistenze ad accettare che la donna lavori, sia autonoma, raggiunga posizioni di comando, guadagni più di un uomo e così via. Una condizione tanto difficile da accettare da indurre anche a violenze. L’autonomia raggiunta dalle donne rende peraltro inaccettabile il subire e ciò fa lievitare le denunce di violenze da parte delle donne: per dire come il cammino che porta all’equiparazione sia scivoloso e tortuoso e come parte di esso attraversi il campo del lavoro. Uno studio come questo si ripropone di far conoscere e di aiutare a ricordare, di accrescere la consapevolezza e di istruire nella manutenzione dei diritti faticosamente acquisiti. Propone un dialogo con parole ed immagini frutto di una ricerca iconografica che ha lo scopo di collocare la partecipazione femminile al lavoro all’interno di scenari sociali ed urbani molto diversi da quelli che sono sotto i nostri occhi. Le botteghe, le fabbriche ma anche le città sono, infatti, profondamente cambiate e le riproduzioni fotografiche aiutano ad immaginare oltre a costituire una prova storica, anzi una fonte da maneggiare con le dovute cautele. Le parole come le immagini dedicate al lavoro femminile richiedono sistematicità di collocazione e rigore di interpretazione, esigono un quadro di riferimento stabile e la disponibilità di un abbecedario adeguato che consenta a chi si accosta ad esse di superare il semplice, ma pur utile, impatto con il diverso, anzi il ‘tipico’ d’un tempo che fu per cogliere invece nel differente il simile, lo iato ma anche la continuità, le persistenze che si intrecciano con le abissali distanze. Calati come siamo nella nostra contemporaneità, che per molti riassume l’interezza delle vicende storiche, non è facile prendere contezza dei cambiamenti intervenuti e delle ragioni di essi, della relatività della nostra attuale condizione, globalizzazione compresa: se viviamo in tempi di scenari planetari e di fenomeni di ciclopiche proporzioni non meno rilevanti furono i cambiamenti che hanno fronteggiato le nostre nonne e bisnonne, dalla radio alle ferrovie fino all’automobile e alla possibilità di controllare le nascite. Donne e lavoro IX Bisogna insegnare a cogliere lo specifico e a collocarlo in un quadro generale, occorre far capire che la storia è prima di tutto cronologia ma anche connessione e intreccio: di piani, di temi, di domande e di relative risposte. L’endiadi donne e lavoro è un grumo di aspettative e di esperienze, di consapevolezze e di fatti, di conquiste e di mancati raggiungimenti di obiettivi: è un grimaldello per arrivare ad una possibile interpretazione del passato ma anche un rilevatore della condizione attuale. Una situazione, la nostra, nella quale dura fatica l’acquisizione del fatto che il lavoro delle donne è un fattore di crescita, un elemento di civiltà, una condizione di libertà e di uguaglianza, una condizione che richiede cura e sforzi di conciliazione ma anche di accettazione di nuovi ruoli e inediti equilibri per i quali è urgente la rivisitazione di stereotipi duri a morire. Si tratta di materia complessa che va insegnata ai più giovani mostrando e pungolandoli ad interrogarsi, proponendo quesiti più che certezze, stimolando alla riflessione e alla reazione. È solo a partire dall’educazione, dalla scuola, dalle generazioni in formazione che si possono ottenere garanzie di continuazione di quel cammino di civiltà che ha portato le donne a lavorare non solo per la sopravvivenza ma anche per la partecipazione alla costruzione di un mondo nel quale fatiche e soddisfazioni possano essere sempre più equamente condivise. Maria Giuseppina Muzzarelli Vicepresidente e Assessore Europa, cooperazione internazionale, pari opportunità della Regione Emilia-Romagna Introduzione Rossella Ropa e Cinzia Venturoli Per analizzare il processo di trasformazione dell’identità femminile (individuale e collettiva) nella società italiana del Novecento, processo che ha portato le donne ad esprimersi come cittadine sulla scena pubblica, l’attenzione deve soffermarsi – quasi per necessità – sulla presenza delle donne nel mondo del lavoro. Il loro inserimento produttivo ha infatti comportato, nel corso del tempo, una profonda rielaborazione dell’organizzazione sociale in cui tendenzialmente non esiste più separazione tra ruolo maschile e ruolo femminile. La mostra – con focus sull’Emilia-Romagna – si propone di illustrare questo tema, ripercorrendo tempi e fasi della inclusione/esclusione femminile nel mondo del lavoro, individuandone cause e ragioni. Dopo aver tratteggiato l’impossibilità di accedere ad occupazioni ritenute ‘naturalmente maschili’ di fine Ottocento-inizio Novecento, si è passati a delineare il riconoscimento ad esercitare tutte le professioni ottenuto dopo la prima guerra mondiale, riconoscimento negato e cancellato durante il periodo fascista, arrivando infine a illustrare la realizzazione della parità duramente conquistata con le lotte degli anni Cinquanta-Sessanta. Inoltre, all’interno delle diverse scansioni temporali in cui si dipana la mostra, si sono presi in considerazione: gli ambiti lavorativi esclusivamente femminili, le caratteristiche di tali ambiti (salari più bassi, status inferiore, minore qualificazione) e la loro evoluzione; le associazioni, le riviste e le donne che portano avanti le richieste delle lavoratrici; le filosofie sul tema del lavoro che dominano lo spazio comunicativo e sociale; la legislazione (di volta in volta: protettiva, discriminatoria, espulsiva) che da tali visioni del lavoro femminile scaturisce; le conseguenze sulle strutture sociali e sulla mentalità dominante. Si è cercato, dunque, di esemplificare, attraverso una scelta necessariamente limitata di immagini e documenti significativi, alcuni aspetti basilari delle condizioni di vita e dei problemi sorti nel complesso rapporto che si instaura fra la donna lavoratrice e il mondo della produzione, collegando questa particolare condizione con i fermenti culturali e rivendicativi dei movimenti femministi e operai. La mostra ha precisi limiti cronologici che non sono parsi arbitrari: prende l’avvio dagli ultimi decenni dell’Ottocento per concludersi con gli anni Sessanta del Novecento. Tra fine Ottocento e inizio Novecento sembrano infatti convergere un insieme di processi che concorsero a definire l’identità collettiva delle donne lavoratrici, ma soltanto in parte la legittimarono e la resero visibile. Innanzitutto, si ebbero profonde trasformazioni economiche e sociali, che interessarono il mondo delle campagne, l’industria, il terziario e influenzarono il mercato del lavoro femminile e le stesse tipologie di lavoratrici. In agricoltura la modernizzazione dei rapporti di produzione consolidava e ampliava i salariati agricoli, in particolare in area padana, determinando un forte incremento delle donne braccianti. Nell’industria, il settore tessile, a prevalente composizione femminile, registrava muta- XII Introduzione menti del ciclo produttivo che comportavano lo sviluppo del sistema di fabbrica, il quale, però, conviveva con la permanenza del lavoro a domicilio. Inoltre, imponenti fenomeni di migrazione territoriale determinavano un sensibile flusso di manodopera dalle campagne alle città in espansione; in queste ultime aumentarono le opportunità di lavoro non soltanto negli opifici, ma anche nella fitta rete di laboratori e di atelier: le lavoratrici dell’ago (modiste, sartine, cucitrici, ecc.) si moltiplicavano, aggiungendosi al gruppo delle domestiche e delle balie, di più antica tradizione. Si sviluppava, infine, il settore terziario e nelle amministrazioni pubbliche soprattutto le maestre e le impiegate si affermavano come nuove figure del lavoro femminile. Nel frattempo, si istituzionalizzavano altri mestieri legati all’ambito sanitario, come quelli della levatrice e dell’infermiera. Nello stesso periodo, cresceva in Italia il bisogno di forme più ampie di cittadinanza: si andavano costituendo associazioni femminili che, accanto alla battaglia per il voto, si interessavano in modo particolare al lavoro delle donne; giungeva poi a maturazione il processo di gestazione dell’organizzazione sindacale che aveva avuto inizio dal lungo e complesso intreccio tra Società di mutuo soccorso, Leghe di resistenza e, in seguito, Camere del lavoro e Federazioni sindacali di categoria. Le associazioni femminili coglievano, con lucidità, nel lavoro una delle possibili vie di accesso all’emancipazione femminile, poiché poteva consentire autonomia e indipendenza e promossero le tante esperienze e attività per cercare di porre fine allo sfruttamento ad esso connaturato. A loro volta, gli organismi sindacali furono indotti a misurarsi con realtà lavorative in cui le donne costituivano la quasi totalità ed esprimevano capacità di organizzazione e di lotta.1 Il fascismo propose un modello femminile, quello di moglie e di madre prolifica, funzionale alla creazione dello Stato totalitario, che doveva però fare i conti con la presenza delle donne in tutti i settori lavorativi. Il regime agì con la propaganda, l’educazione, l’organizzazione di associazioni strettamente legate ai lavori femminili, quali le Massaie rurali e la Sezione operaie e lavoranti a domicilio e con provvedimenti legislativi al fine di fare accettare alle donne una riduzione dello spazio lavorativo a quei settori di cura, considerati adatti alla ‘natura delle donne’. La seconda guerra mondiale, la mobilitazione e la Resistenza accelerarono un processo che portò, nell’immediato secondo dopoguerra, all’acquisizione del voto e alla presenza pubblica, e politica, delle donne. All’Assemblea Costituente il tema del lavoro e della possibilità di accesso a tutte le carriere fu discusso a lungo e venne inserito a pieno titolo nella Costituzione repubblicana. Iniziò quindi un periodo in cui numerosi furono i decreti attraverso i quali i principi costituzionali entrarono nella legislazione. Nel 1963, finalmente, vennero varate leggi che permettevano alle donne l’accesso a tutte le carriere e fu sancita la proibizione del licenziamento per matrimonio. Il boom economico di quegli anni, poi, segnava una forte cesura nella società italiana: trasformazioni radicali investivano i modi di produrre e di consumare, di vivere il presente e di progettare il futuro, persino di pensare e di sognare.2 I nuovi ordinamenti e il ‘miracolo italiano’ aprivano strade nuove all’inizio delle quali la mostra lascia le donne.3 1 Cfr. GLORIA CHIANESE, Storie di donne tra lavoro e sindacato, in Mondi femminili in cento anni di sindacato, a cura di G. Chianese, Roma, Ediesse, 2008. 2 Cfr. GUIDO CRAINZ, Storia del miracolo italiano. Culture, identità, trasformazioni fra anni Cinquanta e Sessanta, Roma, Donzelli, 1996. 3 Alla fine degli anni Cinquanta gli italiani erano pronti per un nuovo stile di vita e si apprestavano a compiere un salto notevole vista la situazione di grave disagio da cui provenivano. I mutamenti coinvolsero tutti gli aspetti della vita: si passò infatti dall’economia agricola ad un’economia industriale, da una forte Rossella Ropa e Cinzia Venturoli XIII Per illustrare questi temi si sono utilizzate varie fonti: iconografiche (immagini d’epoca, manifesti, cartoline, pubblicità, ecc.) e scritte (documenti d’archivio, testi di decreti, opuscoli, volantini, articoli di quotidiani e riviste, racconti, romanzi, memorie, testimonianze). Nel primo caso, l’obiettivo era quello di proporre delle immagini che dessero conto della presenza delle donne nel mondo del lavoro tenendo presente sia le diverse realtà provinciali sia le diverse categorie lavorative da tratteggiare (si è cercato di documentare non solo quelle prevalentemente femminili ormai entrate nell’immaginario collettivo come le mondine, ma anche quelle in cui le donne erano meno rappresentate come le fornaciaie) e tentando di far fronte alle difficoltà di reperimento riguardanti soprattutto il periodo fine Ottocento-inizio Novecento. Le fotografie relative a quell’epoca sono, infatti, rare e solo eccezionalmente presentano figure femminili al lavoro.4 Molti i motivi, e alcuni di questi attengono alle caratteristiche tecniche proprie della fotografia in quegli anni: ancora all’inizio del Novecento occorrevano attrezzature particolari che richiedevano assistenti e lunghi tempi di posa; le fotografie erano quindi costose e appannaggio di una clientela facoltosa. L’obiettivo principale della committenza padronale era quello di illustrare i prodotti della propria impresa e mostrarne i macchinari, per cui la presenza umana era puramente accessoria. Ancora più scarse le immagini che ritraggono donne nel corso di scioperi. Anche i periodici come «L’Illustrazione italiana» e «La Domenica del Corriere», ricchi peraltro di illustrazioni a carattere sociale, solo sporadicamente ospitano rappresentazioni delle tante proteste femminili di quegli anni. Poche le eccezioni, tra le quali la manifestazione delle operaie tessili di Torino e le lotte nelle campagne del parmense, che si ritrovano anche in una delle celebri copertine de «La Domenica del Corriere», firmate da Achille Beltrame. A meritare gli onori della cronaca, insomma, erano solo quegli episodi che colpivano l’opinione pubblica per la loro imponenza o che impressionavano per il livello di durezza assunto dallo scontro, così come lo sciopero e la manifestazione delle 500 giovani apprendiste sarte (le ‘piccinine’) entrate a far parte dell’immaginario collettivo degli italiani anche grazie alle immagini a loro dedicate. Ben diversa la situazione durante la prima guerra mondiale: le immagini davano visibilità, per la prima volta a livello di massa, al lavoro delle donne, occupate poi in ambiti considerati generalmente maschili, come nel caso delle tramviere e delle operaie addette alla produzione di armamenti.5 Il conflitto portò, infatti, a una grande, nuova crescita demografica ad una crescita zero, da una famiglia estesa ad una nucleare, da una società contadina ad una urbana, da una scarsissima mobilità sociale a una situazione più dinamica, da stili di vita differenziati all’omologazione, da culture regionali e locali omogenee, che si esprimevano con i rispettivi dialetti, a una cultura nazionale con una lingua unificante, da uno status della donna dipendente dall’autorità del padre e del marito a una condizione femminile autonoma. Nel primo quindicennio post-bellico si trovano solo segni ed intenzioni in nuce, di ciò che si esplicitò negli anni successivi. La società italiana si avviava verso radicali modifiche negli stili di vita della famiglia e delle donne in particolare (basti pensare all’ingresso nelle case degli elettrodomestici): un altro capitolo della storia del nostro paese. 4 Non sempre dunque è stato possibile documentare la realtà regionale di quel periodo e si è cercato di colmare i vuoti mostrando comunque le donne al lavoro in altre zone del paese. 5 Sull’argomento cfr. LILIANA LANZARDO, Dalla bottega artigiana alla fabbrica, Roma, Editori Riuniti, 1999 (Storia fotografica della società italiana); LUCIA MOTTI, Trecento foto per raccontare un secolo di storia, in Donne nella CGIL: una storia lunga un secolo, a cura di L. Motti, Roma, Ediesse, 2006; PAOLA DI CORI, Il doppio sguardo. Visibilità dei generi sessuali nella rappresentazione fotografica (1908-1918), in La grande guerra. Esperienza, memoria, immagini, a cura di Diego Leoni, Camillo Zadra, Bologna, il Mulino, 1986, pp. 765-800. XIV Introduzione immissione delle donne nelle attività produttive e alla progressiva sostituzione del personale maschile, richiamato al fronte, con quello femminile nel normale lavoro dei campi, negli uffici, nelle fabbriche, tanto che, alla fine della guerra, le donne occupate nell’industria bellica risultavano essere circa 200.000. Le immagini che offre del lavoro il fascismo sono numerose e, sovente, danno conto di momenti propagandistici e di incontro fra gli esponenti del partito fascista e le donne al lavoro. Particolari sono le immagini di manifestazioni come i Littoriali del lavoro in cui le donne mostravano la loro abilità nella professione. La seconda guerra mondiale ripropose la mobilitazione e la presenza delle donne nei lavori maschili. Nell’immediato secondo dopoguerra le donne erano soprattutto rappresentate nella loro nuova veste di elette ed elettrici, parlamentari, costituenti. Il lavoro femminile si concentrò e si mostrò nella ricostruzione; con il passare degli anni, si affacciò agli anni Sessanta proponendo nuove professioni: la donna magistrato, la poliziotta, l’operaia specializzata. Tra le fonti scritte, di particolare rilievo sono state le carte di polizia, da esse è stato possibile raccogliere una serie di informazioni riguardanti soprattutto i lavori delle donne nel primo periodo preso in esame. I documenti redatti da questori e prefetti restituiscono, infatti, le immagini di miseria e di rassegnazione di molte lavoratrici alle quali non restava altra scelta se non quella di chiedere sussidi per integrare lo scarso salario; tratteggiano le disavventure occorse nei rapporti con i padroni (nel caso delle domestiche); mettono in evidenza il modo in cui le amministrazioni pubbliche vagliavano la moralità delle loro dipendenti (nel caso di maestre e impiegate); accennano agli incidenti sul lavoro connessi all’impiego di nuovi congegni meccanici, l’affollamento, la giovane età delle operaie, i lunghi orari di lavoro (nel caso delle operaie); e, infine, segnalano con puntualità le lotte intraprese dalle donne per migliorare le condizioni lavorative. Per far emergere la realtà dei mestieri femminili, una realtà ‘sommersa’ soprattutto alla fine dell’Ottocento, si è fatto ricorso – oltre ad articoli apparsi sui numerosi periodici femminili dell’epoca e alle inchieste svolte dal Ministero dell’agricoltura, industria e commercio e dalle varie associazioni con obiettivi economici o più propriamente sociali, analisi utili a delinearne alcuni elementi tipici – anche alla letteratura. Se è legittimo riconoscere validità documentaria a testi letterari che rinviano a situazioni storiche, economiche e politiche, questo vale tanto più per i romanzi sociali del periodo (il riferimento è in particolare alle novelle di Matilde Serao), spesso documenti di storia quotidiana, vere inchieste socio-culturali in cui compaiono pagine utili per ricostruire la mentalità collettiva dell’epoca.6 Il periodo fascista offre una notevole produzione di opuscoli realizzati per la propaganda, l’educazione e il coinvolgimento delle donne, il regime si auto-rappresentava sulla stampa quotidiana e periodica ed è per questo motivo che fra le fonti scritte del Ventennio esaminate non potevano certo mancare quelle di questo tipo. Il catalogo si apre con un saggio di Fiorenza Tarozzi, in cui viene tracciato il percorso lavorativo delle donne lungo un secolo di storia, contributo prezioso che fornisce un essenziale inquadramento alla ricerca. 6 Francesco Bruni, nella nota introduttiva a Il romanzo della fanciulla di Matilde Serao, scrive: «Le novelle della Serao generose di aperture su certe dimensioni ignorate dalle fonti storiche vere e proprie, potrebbero integrare le fonti stesse, delle quali giustamente, ma talora con un po’ di esclusivismo, si servono gli storici», Napoli, Liguori, 1985, p. XIII. Lavorare al femminile Fiorenza Tarozzi Donna moderna è per noi quella che libera dai pregiudizi medievali, resa serena e forte da una concezione giusta della vita, spezza il giogo secolare che l’uomo le impose secondo la vecchia teoria del diritto del più forte, e pur rimanendo femminilmente dolce e buona, sa difendere la propria dignità e mettere un prezzo al proprio lavoro; regina veramente nella casa per intelletto ed amore, utile alla società come fattore economico, sposa e madre se la fortuna lo vuole, lavoratrice solitaria, tenace e dignitosa se le venissero negati la grazia del volto e il fascino della parola.1 Così Ines Oddone Bitelli, direttrice di uno dei primi giornali socialisti femminili, tratteggiava l’immagine della donna che entrava nel secolo XX, così voleva che fosse e chiedeva alle sue lettrici di essere: ‘donne moderne’, lavoratrici intelligenti ed energiche che nella vita si mostravano capaci di assumere la propria parte di responsabilità e non riparavano all’ombra della protezione paterna o maritale; lavoratrici in grado di mettere un prezzo al proprio lavoro a difesa della propria dignità; lavoratrici convinte nel sostenere con forza la consapevolezza del proprio ruolo all’interno del mondo del lavoro e sollecite nella denuncia di soprusi e sfruttamenti. Insomma donne forti di un ruolo storicamente avuto nel mondo lavorativo, ma anche storicamente taciuto, invisibili produttrici di beni per la famiglia e per la società. È del resto innegabile il fatto che le donne abbiano sempre lavorato all’interno e all’esterno della sfera domestica; basta osservare i dipinti a noi giunti fin dai secoli più lontani per vedere lavoratrici nei campi, nelle botteghe artigiane, nei primi opifici e poi nelle fabbriche, nelle case. Immagini di fiere di paese ci trasmettono memoria di ragazze che esibivano gli emblemi del proprio mestiere per attirare l’attenzione di possibili datori di lavoro: la cuoca esperta portava un mestolo nel grembiule, le ragazze di un caseificio uno sgabello. Olwen Hufton ci dice come Daniel Defoe, nel narrare dei mercati di paese del primo Settecento, descrivesse la forza lavoro femminile «altamente sfacciata» nel modo di attirare l’attenzione sul proprio talento.2 Ancora diari e documenti privati ci danno conto dei contatti tra le famiglie e i possibili datori di lavoro per garantire un impiego stabile e non temporaneo alle giovani fanciulle. Diversamente le fonti così dette ufficiali, pur non tacendo totalmente sul lavoro femminile, non ne hanno, almeno in passato, dato rilevanza, al punto che per l’età preindustriale mancano dati certi per quantificare la presenza lavorativa delle donne e la consistenza della manodopera femminili. Registri fiscali e parrocchiali non fanno cenno a mestieri e professioni femminili, perché le donne – al contrario degli uomini che venivano sovente registrati in relazione al mestiere – erano indicate in base al loro 1 Donna moderna, in «La donna socialista», 22 luglio 1905. OLWEN HUFTON, Donne, lavoro e famiglia, in Storia delle donne in Occidente. Dal Rinascimento all’età moderna, a cura di Natalie Zemon Davis, Arlette Farge, Roma-Bari, Laterza 1991, p. 18. 2 XVI Lavorare al femminile stato civile (nubili, maritate, vedove) oppure per il ruolo all’interno della famiglia (madre, moglie, figlia). Quando anche ci si trova di fronte a dati statistici più accurati, nel passato accadeva spesso che il lavoro delle donne non venisse registrato perché temporaneo o intermittente. Un discorso a parte poi, andrebbe fatto per il lavoro a domicilio, non definito come tale se non in tempi a noi molto vicini e, di conseguenza, non considerato e non quantificato.3 Ecco quindi che i numeri, almeno fino all’Ottocento avanzato, sono fallaci e travisanti. Certo non è facile dire quante fossero le donne che ovunque prestavano la loro opera nelle fattorie agricole o nelle case dei paesi e delle città come lavoratrici ‘di fatica’ con compiti che andavano dal trasportare pesanti carichi di biancheria avanti e indietro dal lavatoio, vuotare latrine, portare pesanti carichi di verdure, cucinare, pulire. Ma testimoni e studiosi affermano come nel corso dei secoli XVII e XVIII la servitù femminile costituisse il più grande gruppo occupazionale nella società urbana rappresentando il dodici per cento della popolazione in ogni città europea. Partendo da questo dato complessivo altre osservazioni sono possibili: le case signorili pullulavano di un gran numero di addetti ai servizi di vario genere, in questo grande insieme le donne occupavano le gerarchie più basse: erano sguattere, serve, lavandaie (solo alcune dame di compagnia e, più tardi, istitutrici). Quelle abili nel cucito potevano godere di qualche privilegio in più. Anche nelle botteghe e nei pubblici esercizi si potevano vedere donne al lavoro: gli osti impiegavano le ragazze come bariste, cameriere e sguattere, nelle trattorie a conduzione famigliare si potevano vedere giovani donne dare una mano nella produzione per la vendita del cibo o nel sorvegliare forni e fuochi.4 Man mano che le città acquisivano una rilevanza economica, sia come sedi di mercato sia come luoghi di produzione, aumentò anche l’impegno delle donne nelle attività artigianali. Nelle città le donne tentarono anche la via del piccolo commercio di merci di propria produzione o acquistate o importate. Se, in genere, l’attività di queste ‘merciaie’ e ‘bottegaie’ era numericamente contenuta, non mancarono casi di donne che alla morte lasciarono ingenti eredità. Sia pure entro limitati spazi era dunque consentito alle donne un lavoro che portasse guadagno; tuttavia, specie in età moderna, il modello della donna salariata venne ampiamente combattuto. La donna indipendente era vista come una figura innaturale e detestabile, mentre si riteneva che il padre o il marito avrebbero dovuto darle una casa contribuendo anche al suo mantenimento. E nella casa doveva svolgersi tutta l’attività femminile; se il bilancio famigliare chiedeva l’intervento attivo della donna essa poteva guadagnarsi da vivere lavorando a domicilio come filatrice o tessitrice, secondo l’immagine di una forza lavoro in cooperazione in cui il marito intrecciava, la moglie e le figlie filavano mentre i bambini più piccoli preparavano il filo. Anche nel campo delle professioni troviamo donne a cui era consentito di svolgere attività legate alla medicina e all’ostetricia, quest’ultima ritenuta terreno privilegiato dell’abilità e dell’esperienza femminile. La figura dell’ostetrica primeggiò a lungo, soprattutto in età in cui la morale comune vietava agli uomini di effettuare visite ginecologiche. Le levatrici sono rimaste nel tempo figure professionalmente riconosciute per le notevoli capacità pratiche messe in atto; la loro attività venne progressivamente regolata da norme e regolamenti e, per la loro preparazione sorsero vere e proprie scuole di formazione. 3 Cfr. FIORENZA TAROZZI, Lavoratori e lavoratrici a domicilio, in Operai, a cura di Stefano Musso, Torino, Rosenberg & Sellier, 2006, pp. 109-161. 4 Cfr. Il lavoro delle donne, a cura di Angela Groppi, Roma-Bari, Laterza, 1996. In particolare: parte prima L’età medievale e parte seconda L’età moderna. Fiorenza Tarozzi XVII Tutte queste presenze di donne lavoratrici confermano il fatto che il lavoro femminile non è mai mancato, quello che manca sono i dati relativi ad una sua quantificazione e l’indeterminatezza quantitativa del lavoro femminile permane fino alle soglie del mondo industrializzato del primo Ottocento all’apparire dei primi rilevamenti statistici. Ancora per tutto il secolo XIX comunque le cifre che emergono, raccolte in modo diverso e frammentario, sono semplici indicatori di un fenomeno, non reali quantificazioni di una presenza lavorativa costante e crescente. Prendiamo il caso del lavoro a domicilio. Nelle statistiche di fine Ottocento si parla di un numero rilevante di famiglie il cui lavoro era legato alla tessitura in casa (il telaio artigianale casalingo non era stato ‘ucciso’ dalla fabbrica, anzi si era rafforzato in un mercato che esigeva una produzione sempre maggiore e che la fabbrica non era in grado di soddisfare); dai dati comunque non si evince quanti fossero i lavoratori maschi e quante le femmine. Anche altre lavoratrici erano ‘invisibili’ alle statistiche. «Silenziose e rassegnate», così una collaboratrice del citato periodico femminile «La donna socialista», definiva le merlettaie che aveva visto al lavoro nei centri della Riviera ligure, zone dove «tutte le donne dai 5 anni alla decrepitezza lavorano le belle trine del tombolo»; un lavoro che le costringeva a ore e ore col busto curvo appoggiate ai cavalletti, una posizione antiigienica e portatrice, alla lunga, di notevoli malformazioni fisiche. Alcune lavoravano per commissione di magazzini o di rivenditori e avevano una sorta di contratto che ne fissava i compensi; altre lavoravano per committenti privati, per conto proprio, con una prospettiva incerta di guadagno. Guadagni, in ogni caso, irrisori, documentava l’autrice.5 In quell’articolo emergeva anche la questione delle malattie determinate dalle condizioni innaturali e antiiegieniche cui le donne erano costrette durante il lavoro, una denuncia che ritroviamo in tante altre pagine del giornale.6 Costipazione cronica, emorroidi, malattie del basso ventre, deviazione della colonna vertebrale, asimmetria del torace a causa della posizione curva alla quale spesso erano obbligate, tubercolosi, miopia, sordità erano tra le malattie più frequenti che colpivano le giovanissime lavoratrici delle fabbriche. Numerose erano, poi, le operaie cotoniere soggette a deformazioni degli arti inferiori causate dall’umidità, così come anche le operaie canapine e linaiuole soggette a morte per tisi. E ancora: cenciaiuole, lavoranti di cappelli, pellicce, spazzole e pennelli venivano colpite da catarri cronici a causa dell’inalazione di enormi quantità di polveri. Fu sicuramente la stampa femminile a dare voce e visibilità alle questioni legate al mondo del lavoro femminile. Le donne che lavoravano e lottavano per il riconoscimento della dignità del proprio impegno economico nella famiglia erano le protagoniste di rubriche fisse in periodici come «Eva», «La Difesa delle Lavoratrici», «La donna socialista», solo per citare alcuni titoli. Le collaboratrici di «Eva» (periodico ferrarese diretto da Rina Melli)7 tratteggiano con lucidità il lavoro delle lavoratrici dei campi e delle risaie della Valle Padana, ma numerose sono anche le notizie che ci offrono sul lavoro femminile nel settore tessile e dell’abbigliamento: stracciaie, smollettatrici, berrettaie, bustaie, setaiole, filandiere. E ancora fiascaie, trecciaiole, sigaraie, tabacchine. Molte le notizie dalle sartorie e dal lavoro domestico (che sappiamo essere diffuso anche nei paesi a più 5 Cucitrici, ricamatrici, merlettaie, in «La donna socialista», 27 gennaio 1906. Si veda, ad esempio, Le donne che lavorano. Fatiche e compensi, in «La donna socialista», 14 ottobre 1905. 7 SUSANNA GARUTI, Tra vecchi e nuovi mestieri: i lavori delle donne in «Eva», in Le donne in area padana: politica, lavoro, immaginario, numero unico di «Padania. Storia cultura istituzioni», VIII, 1994, 16, pp. 95-110. 6 XVIII Lavorare al femminile alto tasso di industrializzazione come Francia e Gran Bretagna) che assieme ad antichi mestieri come la lavandaia, la balia e la stiratrice rimanevano prerogative femminili. Lavoratrici non qualificate, sempre sfruttate da orari estenuanti e da paghe miserrime. Tutto ciò si evince anche da dati relativi a studi effettuati presso la Camera di Bologna all’inizio del Novecento e apparsi su «La donna socialista». La donna – si legge in un articolo firmato da Zelinda Roveri attenta collaboratrice del periodico – era occupata tanto nel lavoro diurno che notturno, in media la sua giornata di lavoro era di 12 ore, ma sovente anche di 13 o 14, arrivando fino a 15. E i salari erano nettamente inferiori a quelli dell’uomo: «abbiamo che di 197.842 donne, superiori ai 15 anni, che lavorano, 3.169 non guadagnano più di 10 soldi al giorno, 21.195 hanno dai 50 ai 75 centesimi il giorno; 55.230 dai 76 centesimi a una lira; 70.484 stanno fra la lira e la lira e mezza; 26.540 oscillano fra i 30 soldi e le due lire; 8.798 raggiungono i lauti guadagni superiori alle due lire ma non a 2,50 e finalmente solo 2.069 possono dire: guadagno una giornata umana, perché prendo più di 50 soldi al giorno».8 Questi dati dimostrano con evidenza come le condizioni di partenza delle donne nel mercato del lavoro fossero molto più deboli rispetto a quelle degli uomini. Ciononostante nella società contemporanea sempre nuovi impieghi si aprivano al mondo femminile fuori dalle mura domestiche, a partire dalle così dette occupazioni da ‘colletto bianco’, lavori divenuti disponibili con l’espandersi dei servizi e dei commerci.9 Gli uffici statali e le compagnie di assicurazione assunsero segretarie e dattilografe; le compagnie telefoniche e del telegrafo impiegarono donne come operatrici,10 i negozi e i grandi magazzini accolsero giovani commesse.11 In genere i datori di lavoro fissavano un limite d’età per le loro dipendenti e non mancavano regolamenti in cui era previsto il licenziamento in caso di matrimonio: tutto ciò per mantenere una forza-lavoro modello costituita da giovani donne in genere al di sotto dei venticinque anni e non sposate. Anche se cambiava il luogo di lavoro si voleva continuare a non confondere, e soprattutto a non mutare, per le lavoratrici, il tipo di relazione tra la casa e il lavoro nella consapevolezza che il lavoro portava via le donne dalla casa e che ciò non era bene per la moglie e per la madre. Pur persistendo tutti questi pregiudizi e queste mentalità difficili da modificare, tra fine Ottocento e inizio Novecento si verificò un massiccio spostamento dal lavoro domestico (urbano e rurale, famigliare, artigianale e agricolo) a quello impiegatizio. Le commesse di negozio aumentarono in Germania da 32.000 nel 1882 a 174.000 nel 1907, mentre in Gran Bretagna l’amministrazione pubblica centrale e locale impiegava 7.000 donne nel 1881 e 76.000 nel 1911; e il numero delle donne impiegate in esercizi e aziende private era salito nello stesso periodo da 6.000 a 146.000. Se l’economia dei servizi e delle altre occupazioni terziarie offriva una garanzia sempre più ampia di posti di lavoro per le donne, l’avvento di una economia dei consumi le rendeva anche il principale obiettivo del mercato capitalistico.12 E il lancio della 8 Le donne che lavorano. Fatiche e compensi cit. Cfr. JOAN W. SCOTT, La donna lavoratrice nel XIX secolo, in Storia delle donne. L’Ottocento, a cura di Geneviéve Fraisse, Michelle Perrot, Roma-Bari, Laterza, 1991, pp. 355-385. 10 Cfr. MARIA LINDA ODORISIO, Le impiegate del Ministero delle Poste, in Il lavoro delle donne cit., pp. 398-420. 11 MARIA TERESA SILLANO, Appunti per la storia delle commesse de La Rinascente, in Le donne in area padana cit., pp. 126-140. 12 Cfr. GABRIELLA TURNATURI, La donna fra il pubblico ed il privato: La nascita della casalinga e della consumatrice, in Lavoro/non lavoro, «Nuova DWF», 12-13, 1979, pp. 8-29. 9 Fiorenza Tarozzi XIX ‘donna nuova’ fu al centro dell’impegno delle industrie pubblicitarie che entravano nella loro prima fase di splendore. La pubblicità si concentrava sulle donne perché erano loro che decidevano per lo più gli acquisti di casa. La donna andava trattata con maggiore rispetto almeno da questo settore della società capitalistica: la trasformazione del sistema distributivo – i negozi multipli e i grandi magazzini che progressivamente si sostituivano ai negozietti e al mercato, così come le vendite su catalogo per ordinazione tramite posta che soppiantarono i venditori ambulanti – formalizzò questo rispetto con la deferenza, l’adulazione, le vetrine e la pubblicità. Erano soprattutto le signore della borghesia ad essere trattate con riguardo, esse infatti potevano permettersi di spendere in oggetti utili per la casa, ma anche in articoli voluttuari come oggetti da toeletta e in abbigliamento alla moda. Se il messaggio pubblicitario contribuì a creare nuovi stereotipi femminili, occorre però dire come il mercato femminile contribuì a creare, a sua volta, un numero cospicuo di nuovi impieghi per le donne. La donna nuova, la donna moderna, vedeva aprirsi dunque maggiori possibilità di ingresso nel mondo del lavoro, compreso quello delle professioni. Ostetriche (si è già detto), infermiere, maestre: ecco alcune delle professioni più squisitamente femminili, o ritenute tali da un’opinione pubblica che vedeva il mondo cambiare, ma cercava di rallentarne i ritmi o di contenerne gli effetti. La maestra è, a tal proposito, un esempio a tutto tondo. L’allargamento dell’istruzione alle donne di fatto generò un duplice risvolto: da un lato la maggior presenza di bambine a scuola richiedeva un numero sempre crescente di personale femminile, dall’altro si vide nella maestra il riprodursi all’esterno della famiglia del ruolo e della funzione materna, verso cui la donna doveva profondere ogni suo impegno e ogni suo sforzo. Crebbero nella seconda metà del XIX secolo le Scuole Normali per la formazione dei maestri, a cui si chiedeva per esercitare la professione di essere muniti di ‘patente’; e le Scuole Normali, nate per preparare insegnanti si riempirono rapidamente di fanciulle che cercavano nel lavoro di maestre una professione che consentisse loro di guadagnare, di rendersi indipendenti dalle famiglie, di poterne anche contribuire al mantenimento. Fu una vera e propria esplosione di presenza femminile nel mercato del lavoro: basti pensare che in Italia, a quindici anni dalla legge Casati emanata nel 1859 per il riordino del sistema scolastico, il numero delle maestre superava abbondantemente quello dei maestri.13 Ciò pose il problema di dove collocarle: solo nelle sezioni femminili o anche in quelle maschili? È forse opportuno ricordare che per lungo tempo in città le classi elementari erano ben distinte tra maschili e femminili in nome di una rigida morale che ribadiva come non si potessero «lasciare insieme lupi e agnelli, nibbi e colombe». E poi si aggiungeva – e di queste norme la precettistica ottocentesca è fonte storica eccezionale – che le donne mancavano di «quella forza morale che è pur indispensabile nel maestro per mantenere la scolaresca disciplinata» e spesso le maestre manifestavano «una snervante mollezza di carattere» dannoso per gli alunni. Insomma erano proprio quei tratti materni che tanto si volevano vedere emergere nelle donne a essere assunti, in questo caso, come limiti alla loro professionalità. A partire dagli inizi del Novecento, comunque, il numero crescente di maestre negli istituti scolastici servì ad abbattere progressivamente gli antichi pregiudizi, creandone però in poco tempo uno nuovo, vale a dire l’idea che l’insegnamento fosse la professione più adatta per le donne. La sempre più consistente presenza femminile nel lavoro ‘fuori di casa’ comportò anche il cambiamento di una mentalità diffusa circa il ruolo e le capacità delle donne. 13 Cfr. SIMONETTA SOLDANI, Maestre d’Italia, in Il lavoro delle donne cit., pp. 368-397. XX Lavorare al femminile Fu un processo non sempre facile, tant’è vero che si tentò di opporvi argini quali un salario inferiore, l’assenza di norme giuridiche e di tutela e ancora la ricerca di ‘lavori femminili’, ‘da donne’. Da qui emerse la ‘questione’ della lavoratrice dibattuta nelle sedi dei partiti politici e dei sindacati, sulle pagine dei giornali socialisti, nelle conferenze pubbliche tenute anche da donne di alto profilo come (e ne citiamo solo alcune) Anna Kuliscioff, Argentina Bonetti Altobelli, Rina Melli, Maria Goia che si impegnarono per ottenere riconoscimenti economici, norme giuridiche e ruolo sociale definito e riconosciuto per la lavoratrice salariata. Una battaglia, peraltro, sostenuta anche dalle Società femminili e maschili di mutuo soccorso e dalle Leghe di resistenza, che crebbero sempre più numerose tra il secondo Ottocento e il primo Novecento. Certo non mancarono ostacoli all’affermazione di quella ‘donna nuova’ di cui tanto si parlava, di quella ‘donna moderna’ produttrice di ricchezza sociale, compagna dell’uomo, lavoratrice intelligente ed energica che nella vita sapeva e voleva assumersi la propria parte di responsabilità civile e morale e non riparava nell’ombra della protezione maritale o paterna. Dalla donna moderna ci si aspettava che, pur rimanendo femminilmente dolce e buona, sapesse difendere la propria dignità e mettere un prezzo al proprio lavoro, e l’uomo cosciente e ‘moderno’ non avrebbe potuto che vedere di buon occhio questo mutamento, questo risveglio delle donne, questa emancipazione anche nel campo del lavoro. È comunque solo nel corso del Novecento che si può cogliere la crescente influenza delle donne negli ingranaggi della società, sia pure attraverso percorsi non sempre facili e lineari. Se negli anni della Grande guerra le donne sperimentarono spazi fino a quel momento loro preclusi, la fine del conflitto parve riportarle, spesso non senza il loro consenso, nel ruolo tipico di madre e di sposa. Certamente le donne, prima ancora degli uomini, hanno subito e subiscono le scosse di economie in crisi e pagano per prima l’adattamento del mercato del lavoro. Ma sono anche state capaci e sono capaci di ribadire energicamente il desiderio dell’affermazione di se stesse come individui autonomi, economicamente indipendenti, capaci anche di inventarsi una propria carriera. Un percorso tortuoso, non sempre validamente affiancato da norme e leggi opportune. Fu a partire dagli anni a cavallo tra XIX e XX secolo che si iniziò a parlare di legislazione sociale e ad estenderne gli interventi al mondo femminile.14 Erano anche gli anni in cui si iniziava a cogliere sia da parte del movimento emancipazionista femminile sia del crescente movimento associativo operaio, il valore del lavoro come momento di crescita e di trasformazione del ruolo della donna nella società. La prima legge a favore delle donne, quella del 1902, si presentò come legge di tutela ed era diretta sostanzialmente a salvaguardare la loro capacità di procreazione. Si trattava insomma di una legislazione protettiva che andava a contribuire a quel processo di costruzione del genere maschile e femminile proprio dell’epoca. Due generi di cui la donna rappresentava l’anello debole, secondo un modello in cui le donne erano inferiori agli uomini e la maternità era la loro principale funzione sociale. La legge Carcano, quella del 1902 appunto, fu parzialmente modificata negli anni successivi con il divieto del lavoro femminile notturno e con la difesa delle lavoratrici madri attraverso l’introduzione del congedo di maternità obbligatorio, sia pur limitato a quattro settimane dopo il parto e senza remunerazione. La legge, riferita esclusivamente alle operaie di fabbrica (che produsse anche l’effetto di disincentivare l’occupazione femminile nel- 14 Cfr. MARIA VITTORIA BALLESTRERO, Dalla tutela alla parità. La legislazione italiana sul lavoro delle donne, Bologna, il Mulino, 1979. Fiorenza Tarozzi XXI l’industria), subì degli aggiustamenti nel 1910 e nel 1923, che istituivano e rafforzavano le casse di maternità finanziate dai datori di lavoro e dai contributi delle lavoratrici che avrebbero dovuto compensare la perdita di salario. L’introduzione dei nuovi limiti di legge al lavoro delle operaie rendeva meno appetibile il loro impiego e nell’immediato venne registrata una progressiva perdita di peso della presenza femminile nelle fabbriche. Questa situazione si modificò negli anni del primo conflitto mondiale, che portò a una nuova grande immissione delle donne nelle attività produttive e alla necessaria sostituzione del personale maschile con quello femminile nei campi, nelle fabbriche, negli uffici. Alla fine della guerra, però, operaie e impiegate furono in gran parte rimandate a casa, a rioccupare l’antico ruolo tra i fornelli, reintegrate nei tradizionali ruoli femminili. Gli anni della crisi profonda del sistema liberale e dell’avvento del fascismo furono quelli in cui si concluse la prima fase della legislazione sul lavoro delle donne. L’Italia, ratificando la convenzione di Washington nel 1919, approvava nel 1922 una legge nella quale erano fissati per le donne i limiti minimi d’età per l’ammissione al lavoro, il divieto al lavoro notturno e l’astensione obbligatoria dal lavoro per gestanti e puerpere. Questa legislazione protettiva aveva come soggetto protagonista le operaie delle fabbriche. Intanto però il mondo del lavoro femminile fuori di casa andava, come già sottolineato, facendosi sempre più composito: ostetriche, maestre, insegnanti, commesse, impiegate erano nuove figure in costante aumento. Di loro però, fino ad allora, ben poco si era interessato il sistema legislativo. L’affermazione dei loro diritti, quindi, apriva nuovi scenari, soprattutto significative divennero le battaglie delle donne del ceto medio, professioniste spesso laureate, per avere libero accesso alle professioni e per accedere agli impieghi pubblici. Le aspirazioni di queste donne, già manifestate negli ultimi decenni dell’Ottocento, trovarono una prima, anche se incompleta, risposta nella legge del 1919 con la quale solo veniva abrogata l’istituto dell’autorizzazione maritale consentendo l’ammissione delle donne «a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici» con esclusione di quelli che si riferivano a funzioni implicanti poteri politici o giurisdizionali. Le donne dunque restavano di fatto diseguali; anche un settore come quello dell’insegnamento le vide tagliate fuori dall’esercizio della loro professione in alcune scuole. L’inferiorità naturale delle donne a svolgere lavori di responsabilità trovò poi traduzione in legge durante gli anni del regime, quando fu loro vietato l’insegnamento di storia, filosofia ed economia nelle scuole superiori e quando, anche, vennero espulse dagli impieghi pubblici e privati. Se nella legge del 1919 si poteva leggere un intreccio tra uguaglianza e protezione, i testi legislativi successivi ebbero come concetto portante quello della tutela, non essendo il valore dell’uguaglianza uno tra quelli a cui si ispiravano i legislatori fascisti. Il regime aveva chiaro il rapporto gerarchico di subordinazione della donna all’uomo, inoltre si preoccupava di assicurare l’occupazione ai maschi capofamiglia espellendo, se necessario, le donne dal mercato del lavoro. La donna nella società fascista doveva affermarsi come ‘sposa e madre esemplare’, la casalinga esperta in economia domestica – vale a dire nel buon funzionamento della casa – e la massaia rurale erano i modelli sostenuti dalla propaganda. Per quelle donne che invece continuavano a lavorare fuori casa, occorreva trovare provvedimenti protettivi in nome dell’interesse della razza. Una serie di interventi presi tra il 1923 e il 1925 e la legge del 26 aprile 1934 davano corpo a quel progetto. Per le donne che lavoravano veniva riproposto uno scenario prebellico declinato, questa volta, in chiave demografico-razziale: la protezione della donna andava letta e realizzata come ‘salvaguardia della stirpe nazionale’. XXII Lavorare al femminile Il campo di applicazione della legge del 1934 era rivolto pressoché esclusivamente alle lavoratrici occupate nei settori industriali e commerciali; ne erano invece esclusi altri campi di forte presenza femminile come i lavori agricoli, quelli svolti a domicilio, il lavoro domestico. Ancora da ribadire è come durante tutto il ventennio si susseguirono provvedimenti di carattere espulsivo delle donne dal pubblico impiego come dal lavoro privato, provvedimenti che andavano a colpire in particolare le donne della piccola e media borghesia che numerose erano entrate nella pubblica amministrazione e nella scuola. Obiettivo non mascherato del regime era quello di limitare l’occupazione femminile extradomestica senza distinzione tra le classi sociali: contadine, proletarie, impiegate, professioniste dovevano trovare nella casa, nella domesticità dei compiti e degli affetti, la loro realizzazione. Di nuovo una guerra veniva a riproporre la necessità di utilizzare in maniera massiccia le donne nel settore produttivo ed economico. Nel dopoguerra, poi, si aprivano nuovi scenari a partire dal dettato costituzionale che stabiliva la parità di trattamento tra lavoratori e lavoratrici.15 Il testo dell’art. 37 comma 1 è però al tempo stesso innovativo e conservativo o, come è stato detto, carico di ‘ambiguità volute’ là dove si afferma che per le donne, anche in un regime di parità, si devono garantire le condizioni per consentire loro l’adempimento della loro funzione ‘essenziale’ di madri. La Costituzione repubblicana aveva stabilito l’uguaglianza formale fra i sessi, ma la conquista dei diritti civili andava intrecciandosi da parte delle donne con la sempre più nitida percezione di muoversi in un terreno culturale e sociale dove il persistere di vecchie consuetudini finiva per non garantire loro una reale parità. E di parità raggiunta si può parlare solamente a partire dal 1977, quando una nuova legge cancellava le forme di tutela e, nel rispetto delle norme comunitarie, poneva fine alla a lungo dominante legislazione protettiva. A quella legge ne sono seguite altre di particolare rilievo: nel 1991 quella sulle pari opportunità, fortemente voluta dalle donne in quanto intesa come strumento in grado di intervenire e di rimuovere le discriminazioni e fare crescere l’idea di uguali opportunità uomo-donna nel lavoro; nel 1992 la legge sull’imprenditoria femminile per favorire la nascita di imprese composte per il 60% da donne, società di capitali gestiti per almeno 2/3 da donne e imprese individuali; la legge comunitaria del 1999 che impone il divieto assoluto delle donne al lavoro notturno durante la gravidanza e fino al compimento del primo anno del bambino; la legge dell’8 marzo 2000 sui congedi parentali, una normativa che punta ad una maggiore condivisione dei compiti all’interno del nucleo familiare, una legge con la quale la cura dei figli smette di essere esclusiva prerogativa delle madri. E non si tratta certo dell’approdo finale, bensì di progressive tappe di un percorso sempre in via di sviluppo, un percorso molto ben documentato da Rossella Ropa e Cinzia Venturoli nelle immagini della mostra e nel catalogo che l’accompagna. 15 Cfr. ANNA ROSSI-DORIA, Le donne sulla scena politica italiana agli inizi della Repubblica, in EADEM, Dare forma al silenzio. Scritti di storia politica delle donne, Roma, Viella, 2007, pp. 127-208. Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale Rossella Ropa Tra due secoli La ‘questione’ del lavoro femminile La presenza delle donne nel mondo del lavoro è documentata dai censimenti della popolazione italiana, che fotografarono, nei decenni successivi all’Unità d’Italia, l’evolversi del fenomeno e le sue sfaccettature. Una presenza estesa e variegata questa, non sporadica e non occasionale: le donne che lavoravano non erano certo, in quegli anni, un’eccezione, ma la norma. Le rilevazioni di fine Ottocento-inizio Novecento evidenziavano, però, fin da subito la difficoltà di classificare le donne per professioni, soprattutto nei comuni rurali, nonché l’esistenza di differenziazioni nel modo di percepire la propria attività da parte delle stesse donne. Mancava, infatti, soprattutto nelle contadine, la coscienza del proprio lavoro, la consapevolezza di svolgere un’attività qualificabile come lavorativa.1 Comunque, nel censimento del 1881 veniva riscontrato che il 51% della popolazione femminile (contro l’84,6% di quella maschile) era impegnato stabilmente in un’attività extradomestica che la caratterizzava tanto da classificarla ai fini di un documento ufficiale quale appunto un censimento. In particolare, il 27% delle donne era occupato in agricoltura, il 16,9% nell’industria, un 4% era definito personale di servizio, mentre nelle altre professioni la presenza delle donne presentava percentuali inferiori all’1%. Analizzando, invece, l’incidenza della presenza femminile nelle singole categorie, era possibile rilevare che il 65,9% degli individui dediti a mestieri connessi all’igiene della persona erano di sesso femminile (pettinatrici, stiratrici, ecc.) e che il 62,8% del personale di servizio erano donne, le quali rappresentavano anche il 58,8% degli insegnanti, il 25,8% del personale sanitario,2 il 37,3% degli impiegati in agricoltura ed il 45,5% degli occupati nelle produzioni industriali.3 La condizione di dipendenza salariale della donna, soprattutto di ceto medio-basso, costituiva, dunque, una realtà diffusa e consolidata; il sesso femminile svolgeva un ruolo essenziale nell’economia di famiglie e Stati.4 Vi era, però, un enorme divario fra l’importanza del suo ruolo produttivo e il riconoscimento che a questo si faceva corrispondere nel campo economico come in quello 1 Per i limiti delle rilevazioni statistiche ottocentesche, soprattutto nei riguardi del lavoro femminile cfr. FIORENZA TARICONE, BEATRICE PISA, Operaie, borghesi, contadine nel XIX secolo, Roma, Crucci, 1985, pp. 146-153. 2 Tutte le specializzazioni sanitarie parevano essere rigidamente strutturate per sesso: le levatrici in particolare erano rigorosamente donne, i veterinari erano soltanto uomini; l’unica eccezione era rappresentata dalla categoria degli infermieri, dove entrambi i generi erano quasi equamente rappresentati. 3 Cfr. F. TARICONE, B. PISA, Operaie, borghesi, contadine nel XIX secolo cit., pp. 265-271. 4 Le numerose indagini condotte nel corso degli ultimi decenni dell’Ottocento con obiettivi economici o con scopi più propriamente sociali (quella di VITTORIO ELLENA, La statistica di alcune industrie italiane del 1880, L’Inchiesta industriale del 1872, e le Ricerche sopra la condizione degli operai nelle 4 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale dei diritti civili e politici. Le donne svolgevano, infatti, i mestieri più umili, meno specializzati e mal pagati. Il loro lavoro, verso la fine dell’Ottocento, costava agli imprenditori la metà di quello maschile, come rilevato da una indagine compiuta nel 1895 da Pietro Sitta, ordinario di economia politica all’Università di Ferrara: «Nei nostri cotonifici e nelle nostre filande di lino e di canape, nelle fabbriche di tabacchi, di zolfanelli, ecc. [la retribuzione della donna] giunge appena ad una lira al giorno, mentre gli uomini ne guadagnano da due a quattro. E si noti che essa deve lavorare bene spesso per giornate lunghissime, di 14 e fino di 17 ore».5 Dal punto di vista dei datori di lavoro la manodopera femminile rappresentava una risorsa attraente e competitiva per ragioni economiche e di politica gestionale: per i bassi salari, per l’antica consuetudine con un lavoro intenso e costante nel tempo e per la loro maggiore docilità. Sia dalle organizzazioni sindacali e politiche, sia dalle associazioni emancipazioniste l’obiettivo della parità salariale venne a più riprese rivendicato come «il diritto delle lavoratrici sempre conculcato».6 L’estrema precarietà, frammentarietà e flessibilità erano poi elementi strutturali del lavoro non qualificato e privo di riconoscimento sociale delle donne; in città il loro lavoro era fluttuante per definizione: «Vi sono – scriveva la Giunta comunale di statistica di Milano – operai, in ispecie donne, che lavorano non per un solo produttore, ma per parecchi e dello stesso genere e di diverso, ed anche per privati, secondo loro consigliano la ricerca, o il bisogno, o il caso».7 Potevano lavorare tra le pareti domestiche, dove combinavano con assidua attività gli impegni domestici e familiari e il lavoro per un salario, ma era altrettanto normale trovarle nelle filande, nelle cartiere, nelle fornaci, nelle cave e nelle miniere. Campo privilegiato di impiego, però, erano le lavorazioni poco produttive, che richiedevano molto tempo e fatica ed erano il più delle volte ausiliarie rispetto al lavoro qualificato vero e proprio: Mentre agli uomini sono aperte tutte le occupazioni, richiedano esse la forza o l’abilità, alla donna non è concesso l’adito che per quelle dove richiedesi soltanto destrezza e per di più che non esigono doti di mente e cognizioni tecniche straordinarie, la sua imperfetta educazione non permettendole di attendere a lavori complicati e difficili.8 Così era per le mansioni di aiuto e servizio che svolgevano nelle fabbriche tessili dove preparavano e legavano i fili dell’ordito; così era per la scelta degli stracci e la cer- fabbriche del 1877) offrivano un quadro eloquente della situazione: se alcuni mestieri erano esclusivi delle donne (la trattura della seta, la manifattura dei tabacchi, ecc.) non vi era campo di attività dal quale fosse esclusa la maestranza femminile. 5 PIETRO SITTA, Il lavoro della donna, Roma, Tip. dell’Unione Cooperativa Editrice, 1895, p. 10. Se si confrontano i salari con il costo di alcuni generi di prima necessità ai primi del Novecento (pane L. 0,36 il kg, farina L. 0,40 il kg, carne L. 1,23 il kg, olio L. 2,35 il kg, carbone L. 0,08 il kg) appare evidente la modestia dei livelli retributivi. Per i prezzi cfr. L’arte del truciolo a Carpi, Carpi, [s.n.], 1979, p. 21. 6 CRISTINA BACCI, A uguale lavoro uguale salario, Milano, Libreria edizioni Avanti, 1917. 7 VOLKER HUNECKE, Classe operaia e rivoluzione industriale a Milano 1859-1892, Bologna, il Mulino, 1982, p. 174, citato in SIMONETTA ORTAGGI CAMMAROSANO, Condizione femminile e industrializzazione tra Otto e Novecento, in Tra fabbrica e società. Mondi operai nell’Italia del Novecento, a cura di Stefano Musso, Milano, Feltrinelli, 1999, pp. 109-172: 113. 8 P. SITTA, Il lavoro della donna cit. p. 11. Tra due secoli ARNALDO MARCHETTI, Ritratto di contadina con carico di fieno sulle spalle, 1920 ca., Archivi Alinari, Firenze 5 6 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale nita delle lane nelle cartiere e nei lanifici; così nelle miniere dove svolgevano il duro lavoro di manovalanza trasportando enormi blocchi di minerale; così era nell’edilizia dove erano addette alla costruzione di strade e ferrovie.9 A cavallo tra i due secoli, emergevano, però, alcune nuove tendenze: accanto alle proletarie cominciava a registrarsi la presenza, nel mondo del lavoro extradomestico, di donne borghesi che, per problemi economici10 o per insoddisfazioni personali, erano spinte a trovarsi una occupazione consona alla propria condizione sociale e culturale. La diffusione (dibattuta, non facile, criticata) della scolarizzazione femminile, infatti, schiudeva le porte a nuove possibilità di lavoro per le donne ‘di civil condizione’, dapprima in quei settori che rappresentavano una proiezione dei caratteri materni nella società (l’insegnamento e le professioni sanitarie), poi in ruoli impiegatizi e nelle libere professioni. Osservava Emilia Mariani, protagonista delle prime associazioni magistrali, al VI Congresso degli insegnanti del 1888, sottolineando quanto di innovativo emergeva da questa nuova presenza femminile nel mondo del lavoro salariato: Non sono trent’anni che all’infuori della povera operaia costretta dal bisogno, nessuna donna avrebbe osato rivolgersi al lavoro come fonte di libero e onesto guadagno. Allora, quando era priva del sostegno naturale del padre o del marito, ricorreva alla porta di un chiostro per nascondervi la sua miseria, e la sua inettezza, per chiedervi quella protezione che fuori le mancava. Ora invece noi la vediamo dopo aver frequentato le Scuole superiori, i Licei, le Università, entrare nelle industrie, nel commercio, far la maestra, darsi all’arte, al giornalismo, alle lettere, cercando di guadagnarsi nel modo più dignitoso e decoroso la vita, con una serietà e una disinvoltura che altamente la onorano. Anzi ora le donne, non contente degli umili e ristretti lavori cui si sono sin’ora dedicate, fanno ressa intorno agli uffici pubblici, insistendo per essere abilitate a novelli impieghi, desiose di ampliare il modo della loro attività, di esercitare le nuove forze acquisite nella nobile palestra del lavoro.11 Era una presenza questa che, ancora nell’ultimo decennio dell’Ottocento, riguardava poche migliaia di donne concentrate nelle grandi città, ma che stava iniziando ad avere un impatto sociale di sicuro più consistente della sua reale portata numerica. Sempre più donne, infatti, stavano diventando ‘visibili’ fuori da casa e il loro lavoro iniziò ad essere descritto, documentato, commentato con un’attenzione senza precedenti da filosofi, sociologici, medici, politici, giuristi che discutevano sulla sua convenienza, addirittura sulla compatibilità tra femminilità e produttività.12 I timori principali erano relativi soprattutto agli effetti negativi che ne derivavano dal punto di vista sociale e morale. Il lavoro femminile extra-domestico veniva considerato pericoloso fattore di disgregazione sociale: la donna impiegata nel lavoro, oltre a trascurare i figli che necessitavano delle sue cure, assaporava il gusto della propria indipendenza. In tal modo l’autorità del marito avrebbe potuto essere limitata, allentan- 9 S. ORTAGGI CAMMAROSANO, Condizione femminile e industrializzazione tra Otto e Novecento cit., p. 113. 10 In quegli anni erano, comunque, aumentate le difficoltà economiche del ceto medio, difficoltà che potevano essere superate e risolte con l’inserimento delle donne borghesi nel mercato del lavoro. Il loro salario avrebbe, infatti, contribuito al risanamento del bilancio familiare, soprattutto in caso di avversità capitate al padre o al marito. 11 Discorso riportato sulla rivista «La donna», 15 settembre 1888. 12 JOAN W. SCOTT, La donna lavoratrice nel XIX secolo, in Storia delle donne. L’Ottocento, a cura di Geneviéve Fraisse, Michelle Perrot, Roma-Bari, Laterza, 1991, pp. 355-385: 356. Tra due secoli 7 do, quindi «i legami di famiglia che è il fondamento primo dello Stato e della civile società».13 «Il posto della donna è nella casa» diventava, quindi, la ‘parola d’ordine’ dei sostenitori di un modello di organizzazione sociale in cui il lavoro dell’uomo doveva essere sufficiente a soddisfare tutte le necessità economiche della famiglia, asserzione peraltro utilizzata anche per sostenere la disparità salariale tra i due sessi e la necessità che la donna abbandonasse la propria occupazione dopo il matrimonio. In questo senso il lavoro doveva venire considerato dalle donne borghesi come un ‘passatempo’ senza ulteriori complicazioni né implicazioni di natura professionale concreta, per questo venivano avviate ad occupazioni considerate poco appetibili dagli uomini e comunque inadatte a costituire una reale alternativa alla «carriera» matrimoniale. Il lavoro delle donne veniva poi considerato fattore di una potenziale devastazione morale, pubblica e privata. Molto presto la figura dell’operaia sembrò incarnare il modello di una femminilità più libera, combattiva e cosciente dei propri diritti. I contemporanei deploravano soprattutto la cattiva influenza che l’ambiente «fisicamente e moralmente corrotto» della fabbrica esercitava sulle fanciulle, facendo loro acquisire «quel sentimento di indipendenza che le rende proterve, intolleranti al dovere».14 L’interesse dell’opinione pubblica nei confronti della questione era particolarmente vivo, tanto che il Comitato centrale per la pubblica moralità nel 1912 predisponeva un questionario, compilato dai soci e dalle associazioni aderenti, relativo «all’influenza delle condizioni del lavoro femminile sulla prostituzione e, in generale, della moralità femminile negli opifici», incaricando il dottor Paolo Cesare Rinaudo, studioso di scienze sociali, di ricavarne una relazione. Il rapporto conclusivo individuava nell’industrialismo una delle principali cause della diffusa immoralità tra le lavoratrici. La concentrazione delle operaie nelle fabbriche, infatti, provocava la diffusione di «turpiloquio, bestemmia, assenza del pudore, amoreggiamenti, seduzioni, irreligiosità». Il comportamento delle operaie era frutto in gran parte dei «discorsi immorali che si tengono negli stabilimenti» nonché dell’esempio dei compagni di lavoro, «gente resa immorale dalle letture, dagli eccitamenti all’odio di classe, dalla negazione dei principi cristiani e dalla predicazione del libero amore». I rimedi proposti per risolvere tale situazione venivano individuati nella diffusione di «sani principi morali e religiosi» e di un senso di responsabilità nell’uomo e di dignità nella donna.15 L’opposizione al lavoro femminile proveniva anche da fisiologi e igienisti, che scesero in campo perché allarmati dalle presunte conseguenze negative del lavoro sulla gravidanza e, soprattutto, sulla prole. Nel giro di pochi anni, le ragioni di ordine morale messe in campo a salvaguardia della donne e della famiglia, cellula base della società, cedevano il passo a preoccupazioni più dirittamente connesse alla dimensione sociale della maternità e alla salvaguardia delle generazioni future. Il timore di un possibile decadimento fisico degli italiani veniva sollevato da medici e ostetrici – «allevatori della razza umana» – che lamentavano «la decadenza fisico-organica che, fino alla nascita, si verifica del prodotto umano delle classi lavoratrici, specie delle città». Il decadimento fisico trovava conferma nella diminuzione di peso e statura, fin dalla nascita, dei figli della classe lavoratrice: si riteneva che questo processo fosse conse13 P. SITTA, Il lavoro della donna cit., pp. 11, 12, 19. STEFANO BONOMI, Intorno alle condizioni igieniche degli operai e in particolare delle operaie in seta della provincia di Como, «Annali universali di medicina», 1873, p. 233, citato in F. TARICONE, B. PISA, Operaie, borghesi, contadine nel XIX secolo cit., p. 249. 15 COMITATO CENTRALE ITALIANO PER LA PUBBLICA MORALITÀ, Il lavoro femminile e la moralità, Torino, G. degli Artigianelli, 1913, pp. 3-15. 14 8 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale guenza dell’ingresso della donna nel mondo del lavoro, anch’essa trascinata in quei «logoranti ingranaggi di attività umana che hanno specialmente per miraggio il miglioramento economico». Se ne auspicava, quindi, l’utilizzo in settori lavorativi più consoni «ed in armonia con la particolare costituzione del suo corpo, e con la speciale funzione del suo organismo».16 Il mondo ottocentesco in tema di relazioni fra i generi si era organizzato attorno al principio delle sfere separate, dove agli uomini competeva quella pubblica e alle donne spettava l’ambito privato, quello degli affetti familiari e della soggezione all’autorità maschile. Se nel corso dell’Ottocento era stato facile occultare e respingere le richieste delle donne nel nome della tradizione e del ‘buon senso’, nel Novecento un simile atteggiamento non sembrava più praticabile. La determinazione mostrata nella rivendicazione dei diritti civili e politici, l’impegno nello studio, le nuove possibilità di lavoro che si estendevano al mondo della scuola e degli impieghi, le associazioni cui le donne avevano dato vita, la fondazione di riviste che aiutavano a riflettere sulla propria condizione, l’attiva presenza nel mondo cattolico e nei partiti politici, primo fra tutti quello socialista, erano i segnali forti di un cambiamento nelle italiane. Esse svilupparono una maggior coscienza del loro valore nelle attività svolte, il lavoro per esse veniva ad assumere una configurazione diversa, iniziava ad essere inteso come una fonte di autonomia, un mezzo per promuovere uguaglianza e indipendenza economica. Le attività tradizionali Le mezzadre, le braccianti, le risaiole Pur con le grandi differenze che contraddistinguevano le campagne italiane all’indomani dell’Unità, il lavoro femminile era un dato costante e tradizionale nelle società rurali. Le donne erano una componente essenziale della manodopera agricola: zappavano, seminavano, mietevano, compivano insieme agli uomini gran parte dei lavori nei campi, oltre a farsi carico degli oneri connessi alla conduzione della casa, alla maternità, all’allevamento dei figli. Il lavoro delle donne contadine, comunque, si connotava in modo diverso a seconda dei sistemi di conduzione del fondo e dell’organizzazione familiare, che in Emilia poteva essere essenzialmente di due tipi, quella dei mezzadri e quella dei salariati agricoli. All’interno della famiglia colonica le donne potevano svolgere diverse attività: tutte lavoravano nei campi sotto la direzione del reggitore (il capofamiglia), nella casa alle dipendenze della reggitrice (la capofamiglia) e molto spesso in attività extra-agricole per le necessità familiari o, più raramente, per piccoli mercati locali. In alcuni contesti questo lavoro si inseriva in un ambito produttivo più importante: era il caso di alcune aree delle campagne reggiane e soprattutto modenesi e di vaste zone della montagna bolognese. Qui le contadine lavoravano a domicilio, intrecciando il truciolo e la paglia, organizzate da imprenditori che destinavano i loro prodotti ai mercati di importanti città europee. I compensi del lavoro per il mercato andavano al capofamiglia, salvo piccole somme che potevano costituire un fondo gestito dalle donne e destinato, ad esempio, all’acquisto di beni per bambini o anziani, oppure potevano rimanere alle singole per 16 GIUSEPPE VICARELLI, Lavoro e maternità. Malattie professionali e gravidanza. Studio etnico, clinico e sociale, Torino, Utet, 1914, pp. 15-17, 27-28. Tra due secoli 9 uso personale: «I soldi dei cappelli [di paglia] li tenevo io in famiglia per vestire le bambine, con l’approvazione della suocera. I soldi dei cappelli: a ciascuno i suoi».17 I tipi di lavoro agricolo che le contadine eseguivano erano molti e potevano essere anche particolarmente duri, spesso, infatti, le donne lavoravano a fianco degli uomini svolgendo la stessa attività; non di rado, però, erano escluse da quelli in cui venivano utilizzati la vanga e l’aratro, considerati troppo pesanti e faticosi. La consuetudine aveva poi definito occupazioni abitualmente di pertinenza femminile come la raccolta della frutta, la lavorazione del lino, alcune fasi della lavorazione della canapa, l’allevamento del baco da seta e la mondanatura del riso. Le donne, molto spesso anche le bambine, si rendevano utili anche in altri modi: raccoglievano frutti selvatici, erbe e fascine, producevano ceste e scope, filavano e tessevano e si impegnavano nel trasporto di carichi pesanti (la provvista di acqua o di legna), spesso in sostituzione delle bestie da soma. Sono nata il 24 aprile 1910 nel comune di Teodorano [frazione di Cusercoli, in provincia di Forlì]. La mamma e il babbo erano contadini […] eravamo sette figli […]. Sono andata poco a scuola, ho fatto la prima, la seconda e poi dovevo andare in terza, ma… c’era da lavorare… la mamma si ammalò ed io rimasi a casa. Nel 1911 siamo diventati contadini e fino ai venti anni ho lavorato nel campo, ho tenuto i bachi da seta, facevo l’erba, mietevo, rastrellavo e andavo a prendere l’acqua lontano da casa. Io e la mia sorella avevamo dei tacchini in cortile e li badavamo con le canne perché altrimenti andavano a far danno in quello degli altri… non avevo neanche quattro anni! Badavo anche ai maiali… Giocare? Mai! Non mi era mai possibile perché era necessario lavorare. La mia mamma aveva il telaio e faceva anche la tela per gli altri e me a dvaneva con e’ dvanadue, a faseva i gumsel e i canel [io facevo le matasse, i gomitoli e i cannelli]. […]. La mamma tesseva il cotone, ma anche il lino e la canapa.18 Queste attività erano fondamentali in economie familiari spesso precarie e modeste, indispensabili in momenti di crisi o di carestia. Spesso la possibilità di una vita meno misera era determinata proprio dalle attività delle donne.19 L’unica figura femminile che non svolgeva lavori agricoli era la reggitrice. A lei spettava il governo della casa, che spesso consisteva nel mandare avanti una grande comunità familiare e nel prendersi cura durante la giornata di bambini ed infermi. Le competeva, inoltre, la gestione di alcune attività produttive minori, come l’allevamento degli animali da cortile e la conduzione dell’orto. I proventi della vendita di questi prodotti rimanevano nelle sue mani e andavano a costituire un fondo che veniva utilizzato per particolari bisogni della famiglia. La reggitrice, dunque, era l’unica donna che poteva accedere, con il suo lavoro, a una piccola somma di denaro. Per la sua posizione al vertice della gerarchia famigliare era investita di importanti responsabilità e di compiti direttivi nei confronti delle altre donne. A lei facevano capo spesso aspetti importanti delle relazioni familiari, come quelli che riguardavano le strategie matrimoniali e le relazioni parentali. Nei poderi di piccole dimensioni la divisione dei ruoli poteva essere meno rigida e la reggitrice si divideva tra casa, cortile e campi a seconda delle necessità. 17 Percorsi di vita femminile. La donna attraverso l’immagine tra Ottocento e Novecento, a cura di Luciana Nora, Carpi, Nuova Grafica, 1990, p. 19. 18 Testimonianza di Domenica Giovannetti, tratta da Voci di donne: storia di paese. Cusercoli 18812006, Testimonianze a cura di Germana Cimatti, narrazione di Alba Piolanti, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2006, pp. 36-37. 19 JOAN W. SCOTT, LOUISE A. TILLY, Lavoro femminile e famiglia nell’Europa del XIX secolo, in La famiglia nella storia, a cura di Charles E. Rosenberg, Torino, Einaudi, 1979, p. 200. 10 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale Questo lavoro affannato e continuo – le donne filavano e intrecciavano la paglia anche nei momenti che avrebbero dovuto essere di riposo –, indispensabile per far quadrare il bilancio familiare, era in realtà non riconosciuto, cancellato e subordinato all’interno della famiglia mezzadrile, della quale unico capo era il padre o uno dei fratelli (il reggitore) cui tutti professavano «una sottomissione completa e un’obbedienza passiva» e che, come stabiliva il contratto di mezzadria «rappresenta la società di fronte al padrone del fondo, come pure in tutte quante le relazioni collettive coi terzi e colle autorità amministrative e politiche».20 All’interno della logica che sovrintendeva all’organizzazione tradizionale della famiglia contadina e che rimaneva alla base di tanta parte del mondo rurale, il lavoro delle donne restava schiacciato e svalutato: disperso in mille attività (dal campo, all’aia, alla casa) raramente autonomo e specializzato, era in Comune di Castel S. Pietro dell’Emilia, ogni caso condizionato dalle esigenze Tariffa votata dall’assemblea dei possidenti della comunità familiare che non ripartiva di Castel S. Pietro dell’Emilia nell’Adunanza del 25 marzo 1902, ed equamente fra i suoi membri poteri e van- accettata dalla Lega di miglioramento degli taggi. Un lavoro essenziale alla vita della operai, e dalle Unioni professionali del famiglia, eppure mai valutato, mai mone- lavoro, 1902, Archivio di Stato, Bologna tizzato, impossibile a calcolarsi, un lavoro perennemente complementare e accessorio. Lavoro negato eppure indispensabile mezzo di sopravvivenza. Se le condizioni di vita delle mezzadre potevano, in particolar modo nei periodi di crisi, essere precarie e durissime, quelle delle braccianti erano spesso ai limiti della sopravvivenza. La donna lavora da mattina a sera, parte in casa, parte in campagna. Giunta all’età di 14-15 anni si reca a giornata, anch’essa come tutto il resto della famiglia e va a zappar la melica [erba medica] oppure a mondar riso, nel quale lavoro guadagna in due o tre anni quel po’ di argento e di corredo che deve necessariamente avere per trovar marito. Dai 18 ai 24 si accasa, e quindi le sue cure sono rivolte ad allattare e allevare i figli, ammanire il pasto della famiglia, preparare la pasta per il pane, ed anche, quando il tempo lo permette, zappare il tratto di melica assegnato alla famiglia, recarsi alla mondanatura dei risi e in giornata qua e là a seconda delle circostanze. Quando le occupazioni di casa le lasciano un po’ di tempo libero si reca nelle risaie e va a pescar rane e a prender pesci, che molte volte si mangiano freschi e altre si conservano salati per l’inverno, oppure va a raccogliere i semi del pabbio per dar da mangiare alle galline, che si allevano per essere vendute. In questi giri per la campagna è assai facile che un po’ di riso, di melica, di erba 20 GIULIANA CORNELIO, Sebben che siamo donne… La contadina italiana dall’Unità alla prima guerra mondiale, in Esistere come donna. Catalogo della mostra tenuta a Milano nel 1983, Milano, Mazzotta, 1983, pp. 115-116: 115. Tra due secoli 11 o di legna venga portata a casa, specialmente quando le escursioni si fanno nelle ore notturne. La cura della famiglia, i lavori faticosi e il cibo insufficiente avvizziscono presto queste donne, le quali a trent’anni paiono mature, a quaranta vecchie, a cinquanta decrepite.21 L’inchiesta parlamentare sulle condizioni di vita dei contadini, condotta da Stefano Jacini, riferiva che i braccianti della provincia di Bologna nel 1881 si nutrivano in gran parte di polenta e di acqua; nell’imolese abitavano nelle «case più luride, più antigieniche», nel modenese «godevano peggior salute che gli animali»22 (erano diffusissime pellagra,23 scorbuto, tifo); ebbene i giornalieri avevano una vita media di 34,2 anni in provincia di Bologna e di 32,5 a Ravenna.24 Le loro indescrivibili condizioni di vita furono denunciate dall’on. Gregorio Agnini alla Camera dei deputati nella seduta del 3 maggio 1893: «Nel basso bolognese […] gli attuali proprietari sono per i lavoratori assai peggiori di quello che erano i padroni degli schiavi; a questi, almeno, era assicurata la vita. Oggi ai contadini in genere, e ai giornalieri in particolare, manca perfino il necessario».25 Ad inizio Novecento, secondo i dati forniti dall’inchiesta della Società umanitaria dedicata alla disoccupazione agricola, il fenomeno del bracciantato femminile era in espansione26 soprattutto in alcune aree della provincia di Bologna, Ferrara e Ravenna. Nei due comuni indagati per la provincia di Bologna, San Giovanni in Persiceto e Molinella, le donne rappresentavano rispettivamente il 22,3 e il 46,1% dell’intero gruppo dei «lavoratori liberi». Nel comune di Ravenna esse costituivano il 49,6% degli 8.969 braccianti censiti, mentre nel ferrarese su quattro comuni indagati, tre (Portomaggiore, Argenta e Copparo) vedevano addirittura una preminenza femminile.27 21 GIUNTA PER L’INCHIESTA AGRARIA E SULLE CONDIZIONI DELLE CLASSI AGRICOLE, Atti, vol. VIII, Roma, Forzani, 1887, pp. 627-628. 22 Ivi, vol. II, Roma, 1881, p. 234. 23 Soprattutto la pellagra era divenuta la dimostrazione esplicita e prepotente del legame esistente tra salute e condizioni sociali, un legame che non poteva essere sottinteso neppure dai medici che, schierati con Cesare Lombroso, davano una spiegazione connessa non alla carenza alimentare ma ai ‘vizi’ dei braccianti. Infatti essa dimostrava come fossero le condizioni di produzione nelle aree mezzadrili a rendere necessario il ricorso al mais come unico mezzo di alimentazione. La pellagra era diventata così simbolo di una condizione di vita, «chiave di lettura per riconoscersi in una unica realtà di sfruttamento» (ROBERTO FINZI, Quando e perché fu sconfitta la pellagra in Italia, in Salute e classi lavoratrici in Italia dall’Unità al fascismo, a cura di Maria Luisa Betri, Ada Gigli Marchetti, Milano, Angeli, 1982, pp. 391-430) e, in definitiva, strumento di coesione e di lotta sociale nelle campagne. Non a caso essa era il problema sanitario maggiormente trattato dai periodici socialisti che ne sostenevano l’ipotesi ipoalimentare indicata da Paolo Mantegazza, contro l’ipotesi tossica sostenuta dai giornali borghesi. 24 GIUNTA PER L’INCHIESTA AGRARIA E SULLE CONDIZIONI DELLE CLASSI AGRICOLE, Atti, vol. II cit., pp. 254, 256, 258. 25 Dalla interpellanza di Gregorio Agnini alla Camera, il 3 maggio 1893, sull’argomento «Controversie fra capitale e lavoro nel basso bolognese» citato in ILVA VACCARI, La donna nel ventennio fascista (1919-1943), in Donne e Resistenza in Emilia-Romagna, Milano, Vangelista, 1978, pp. 23-254: 37. 26 Il fenomeno del bracciantato femminile divenne dirompente quando si verificò quel profondo processo di proletarizzazione che negli ultimi anni dell’Ottocento riguardò soprattutto le pianure delle province settentrionali e zone molte vaste della bassa bolognese, ferrarese e ravennate. Il forte aumento delle famiglie bracciantili – a struttura nucleare o estesa e di dimensioni ridotte – era frutto di processi di trasformazione complessi, di cui la crisi agraria con il suo contributo alla disgregazione degli aggregati domestici contadini costituiva soltanto l’ultimo anello, anche se il più rilevante. Cfr. MAURA PALAZZI, Donne delle campagne e delle città: lavoro ed emancipazione, in Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità ad oggi. L’Emilia-Romagna, a cura di R. Finzi, Torino, Einaudi, 1997, pp. 375-409: 385. 27 SOCIETÀ UMANITARIA, UFFICIO DEL LAVORO, La disoccupazione nel Basso Emiliano. Inchiesta diretta nelle province di Ferrara, Bologna e Ravenna, Milano, Tip. degli operai, 1904, citato in M. PALAZZI, Donne delle campagne e delle città cit., p. 386. 12 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale L’origine di questo fenomeno era da imputare ai minori salari pagati a parità di lavoro: «Il lavoro delle donne va allargandosi a discapito della manodopera maschile – veniva scritto nell’inchiesta – molti lavori che prima erano fatti dagli uomini, ora invece sono eseguiti dalle donne». Il processo di sostituzione riguardava, fra gli altri, la battitura del granoturco, il trasporto della paglia e «i lavori del riso, compiuti nei luoghi più difficili e melmosi». Ad Alfonsine «le donne fanno il lavoro di carriola, che è il più faticoso, al pari degli sterratori, ed eccettuati l’aratura, la vangatura e il trasporto, partecipano a tutti gli altri lavori del campo e della risaia».28 Questa cospicua presenza si traduceva in un forte contributo delle donne al reddito di casa. Nella stima dei bilanci familiari dei braccianti il numero delle giornate di lavoro di uomini e donne non erano di solito molto diversi.29 A San Giovanni in Persiceto si valutava che nelle famiglie bracciantili il marito fosse occupato nei lavori agricoli per 135 giornate e la moglie per 104. Il primo aggiungeva poi diverse giornate nei lavori di sterro, mentre la seconda contribuiva con la coltivazione di un piccolo orto e l’allevamento di alcuni animali: bachi, pollame, nei casi migliori un maiale. In ogni caso al lavoro femminile veniva attribuito minor valore. La differente valutazione si esprimeva in questo caso con la discriminazione salariale, che prevedeva per il lavoro delle donne a parità di mansioni, tariffe di solito non superiori alla metà e solo raramente uguali a due terzi di quelli maschili. La grande povertà e la precarietà del lavoro delle braccianti si traduceva in una forte flessibilità: spesso svolgevano attività diverse in diversi periodi dell’anno, attività integrative alle quali ricorrevano secondo le necessità della famiglia. In varie province emiliane potevano anche partecipare ai lavori nei settori agro-industriali, ad esempio nella produzione di conserve di pomodoro, nella lavorazione della frutta o negli zuccherifici. Fra tutte queste occupazioni, una contribuì più delle altre a dare una forte identità sociale alle donne che vi partecipavano: la risaia. Le donne vi eseguivano molti lavori ma i più femminilizzati erano la roncatura e la monda, quest’ultimo – stancante e gravoso perché svolto per molte ore al giorno con la schiena ricurva e le gambe immerse in acque melmose e malsane – rendeva necessarie, per quaranta giorni alla fine della primavera, un numero elevato di lavoratrici. Dalla fine dell’Ottocento cominciò, perciò, a diventare molto consistente il flusso migratorio che ogni anno portava le donne emiliane nelle risaie del Piemonte, della Lombardia e, in misura minore, del Veneto. L’Emilia forniva il contingente di gran lunga più numeroso di emigrate per la monda: da essa provenivano, nel 1905, il 37% di tutte le risaiole. In quell’anno il fenomeno coinvolse ben 13.181 donne provenienti soprattutto da Piacenza (con più di 6.000 unità), Reggio, Modena e, in misura minore, Bologna; quote inferiori venivano da Ferrara e Parma.30 Le emigrate affrontavano condizioni di vita e di lavoro molto pesanti: la loro giornata veniva pagata meno e durava un’ora di più di quella delle locali; gli alloggi erano 28 Ivi, p. 387. Nello stesso periodo, però, nelle aree meno toccate dalla proletarizzazione delle campagne, come in quelle montane e collinari e in ampie zone della Romagna, le giornate lavorative si diversificavano maggiormente: nel cesenate, ad esempio, una stima della Camera del Lavoro attribuiva agli uomini una media di 125 giornate all’anno e alle donne solo 33. CAMERA DEL LAVORO DEL CIRCONDARIO DI CESENA, Relazioni. Statistica 1906, Cesena, [s.n.], 1907, p. 23, citato in M. PALAZZI, Donne delle campagne e delle città cit., p. 386. 30 MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, Le condizioni di lavoro nelle risaie, Roma, Tip. nazionale di G. Bertero & C., pp. 145-151, citato in M. PALAZZI, Donne delle campagne e delle città cit., pp. 388-389. 29 Tra due secoli 13 spesso baracche presso il luogo di lavoro, cioè in luoghi malsani dove era facile ammalarsi di malaria. Così descriveva la loro situazione l’on. Angiolo Cabrini in un discorso pronunciato al Parlamento nel marzo 1903: L’ingegno umano che inventò, secondo il poeta, cose stupende, ideò in talune zone risicole questa specie di prolungamento della Santa Inquisizione. Udite: le risaiole lavorano, stese in lunga fila, con i piedi e con i polpacci nell’acqua, nel fango; e curve della persona così da aver la testa a livello, o poco più su, delle ginocchia. Dietro sull’argine, c’è il fattore, che prodiga questi epiteti: «Lavorate, fannullone! Lavorate, bestiacce!». Dinanzi – ecco la geniale trovata! – el tiracoll (il tiracollo). È costui un contadino […] giovane scelto fra i più robusti, egli riceve una specie di soprassoldo per lavorare intensamente, il più presto possibile. Le disgraziate che lo seguono non debbono mai lasciare crescere la distanza che sta tra loro e il tiracollo al principiar del lavoro… Tiracollo, parola scultoria, che dà la visione delle vittime con la corda al collo, trascinate faticosamente in avanti.31 E ancora: Il menù delle risaiole eccolo qua: un pane di farina mista (dovrebbe essere frumento e granturco, ma molte volte c’è la segala) a colazione; una minestra di riso e fagioli a desinare; una minestra di riso e fagioli a cena. Niente vino! Niente latte! Niente carne! È il regime vegetariano ed astemio portato all’ultima espressione; una quaresima che dura appunto circa 40 giorni. E meno male gli alimenti fossero sani! Ma nei paesi di risaia il commercio viene accumulando lungo l’anno i generi di consumo scadenti, avariati, corrotti, e si attende la stagione del riso per venderli alle squadre delle forestiere.32 Sul lavoro delle risaiole non speculavano solo proprietari terrieri ma anche ‘caporali’ senza scrupoli che per loro le assumevano: «Le chiama e le sorveglia poi sul lavoro il caporale, costui viene pagato con 20 o 30 lire più delle operaie, dal padrone; spesso però avviene che il caporale assoggetti ad un tributo di 5 centesimi settimanale ogni mondina».33 Proprio queste esperienze di sfruttamento fecero maturare in loro una coscienza nuova: le risaiole, infatti, furono protagoniste importanti delle lotte che si svilupparono nelle campagne emiliane a partire dalla fine dell’Ottocento, lotte la cui portata andò ben al di là dei confini regionali. Esse organizzarono scioperi per migliorare le condizioni di orario e di salario e parteciparono da protagoniste alle proteste bracciantili.34 A Conselice, nel 1890, due mondine morirono negli scontri con la polizia35 e molte altre, negli anni successivi conobbero l’arresto e il carcere. Il risultato fu un’adesione, più ampia che in qualsiasi altra regione italiana, a organizzazioni dei lavoratori come le Leghe ‘miste’, ma anche la creazione nei primi anni del Novecento di numerose Leghe femminili.36 31 CAMERA DEL LAVORO DI REGGIO EMILIA, Alle risaiole. Discorso pronunciato dal deputato A. Cabrini al Parlamento nazionale nella seduta del 2 marzo 1903, Reggio Emilia, Società anonima cooperativa tra lavoranti tipografi e affini, 1903, p. 15. 32 Ivi, p. 13. 33 Ivi, p. 11. 34 Cfr. paragrafo La lotta delle donne nelle campagne. 35 Le mondine di Conselice chiedevano un aumento di 25 centesimi sul salario. Cfr. I. VACCARI, La donna nel ventennio fascista cit., p. 36. 36 Cfr. paragrafo Le associazioni. 14 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale Le lavandaie Ci volevano tre giorni per fare il bucato: prima i panni si lavavano nel fiume, poi si facevano bollire con la cenere e infine bisognava sciacquarli di nuovo nel fiume. […]. Si andava alle quattro di mattina perché l’acqua era ancora chiara e pulita.37 Fra i tanti mestieri che le donne svolgevano, nel periodo considerato, uno dei più diffusi era quello delle lavandaie, proprio perché si configurava come una sorta di prolungamento delle mansioni svolte nell’ambito domestico. Praticato dalle appartenenti ai ceti più umili, in modo spesso informale38 e privo di riconoscimento sociale, appare estremamente difficile una sua quantificazione,39 date le caratteristiche di lavoro sottratto a ogni controllo.40 Più semplice la descrizione delle meschine condizioni di lavoro, un lavoro scarsamente remunerato (a Bologna alla fine dell’Ottocento generalmente veniva corrisposto un salario mensile di 25 lire) che impegnava per 18-20 ore al giorno pressoché tutti i giorni dell’anno, e che a volte poteva accompagnare l’intero arco di vita delle donne, dall’infanzia alla vecchiaia – come documenta il caso di Filomena Migliorini di 66 anni colta da morte improvvisa mentre stava lavorando lungo il canale di via Lame –.41 Anche se ‘lavare i panni sporchi’ in generale rimaneva una costante nella vita, poteva comunque essere ‘giocata’ in vario modo, secondo diverse strategie: poteva diventare lavoro a tempo pieno o costituire una soluzione di ripiego, ai limiti della sopravvivenza, cui ricorrere in determinate fasi della vita particolarmente critiche; poteva essere l’unica fonte di reddito o fonte integrativa di altre più redditizie; poteva essere abbinato ad altri lavori extra-domestici o a domicilio. La varietà e l’elasticità del rapporto delle donne con questa attività pare emblematica, pare mostrare come poteva articolarsi il lavoro produttivo nelle diverse vite femminili. A Bologna l’attività delle lavandaie si svolgeva nella parte solcata dalle derivazioni del Canale del Reno. I lavatoi, costruiti lungo il canale, si trovavano fuori delle mura in località Crocetta, alla Grada nel tratto che precedeva il ponte della Carità su via S. Felice, al ponte delle Lame dietro la Chiesa della Visitazione, infine in via Capo di Lucca. 37 Testimonianza di Giovannina Betti, detta Velia, nata a Cusercoli in provincia di Cesena il 14 giugno 1917, in Voci di donne. Storia di paese. Cusercoli 1881-2006 cit., p. 61 e p. 254. 38 Gli strumenti di lavoro erano composti da una tavola o un’asse di legno dove appoggiare gli indumenti e sbatterli vigorosamente (ma spesso era sufficiente un masso in riva al fiume), un contenitore di acqua che veniva scaldata spesso sul posto con bracieri, e la cenere o il sapone per lo più fatto in casa (con grassi animali cui si univa soda caustica o pece greca, il tutto bollito in una caldaia e poi fatto raffreddare in un basso contenitore). 39 Nonostante l’assenza di dati ufficiali, è possibile affermare che la maggior parte della biancheria a Bologna era trattata dalle lavandaie, vista la quasi totale assenza di lavanderie «impiantate su basi razionali». Nel periodo preso in considerazione, infatti, esistevano in città solo «la lavanderia Bolognese, quella degli Ospedali e quella militare di Borgo Panigale», del resto non tutte a disposizioni dei privati. FRANCO CRISTOFORI, Bologna. Immagini e vita tra Ottocento e Novecento, Bologna, Alfa edizioni, 1978, p. 96. 40 Proprio per le caratteristiche di mestiere non regolato e non riconosciuto, la documentazione che di esso rimane è sempre frammentaria, eterogenea, il più delle volte indiretta e scandita dai ritmi di occasionali incontri con le istituzioni, spesso filtrata attraverso la lente deformante delle parole di un osservatore esterno, in genere quelle di un poliziotto in caso di incidenti, di morti improvvise sul lavoro, di furti di biancheria subiti. 41 Rapporto di Pubblica Sicurezza, Bologna, 30.11.1897, in Archivio di Stato di Bologna (d’ora in poi ASBo), Gabinetto di Prefettura, serie 951, 1897, «Relazioni di Pubblica Sicurezza». Tra due secoli 15 PIETRO POPPI, Lavandaie lungo il canale Reno e retro della Chiesa di Santa Maria della Visitazione al Ponte delle Lame a Bologna, ca. 1900, Collezioni d’Arte e di Storia della Fondazione Cassa di Risparmio, Bologna ROBERTO SEVARDI, Lavandaie nei pressi di Reggio Emilia, ca. 1920, Fototeca della Biblioteca Panizzi, Reggio Emilia 16 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale Le loro diverse tipologie – a trincea, a gradinata, a ponte levatoio – imponevano condizioni di lavoro più o meno faticose. Il lavatoio a trincea poteva essere costituito da una sola barriera scavata lungo la sponda del canale, dietro al quale le donne lavavano stando all’asciutto, oppure a due trincee a gradinata, disposte in modo che se il livello dell’acqua invadeva la prima trincea poteva essere usata la seconda posta più in alto; ne erano esempio i lavatoi delle Lame e quelli della Crocetta. Il lavatoio della Grada, invece, era costituito da ‘gradinate’: le lavandaie poggiavano i piedi sul gradino più alto fra quelli immersi e lavavano sul gradino soprastante. Nel periodo invernale impiantavano sul gradino sommerso delle botti scoperchiate per restare all’asciutto. Altri lavatoi erano molto spesso del tipo ‘a ponte levatoio’, cioè un semplice tavolato di legno posto a livello dell’acqua, molti si trovavano lungo le Moline, nella via Repubblicana e al Cavaticcio: in questo caso le donne erano costrette a lavorare in ginocchio e piegate a terra, non avendo alcun piano di appoggio più elevato.42 Le condizioni di lavoro erano pessime anche dal punto di vista igienico: secondo il responso delle analisi chimico-batteriologiche del fiume Reno – analisi compiute dal laboratorio di igiene della Regia Università della città nel 1903 – lo stato delle acque in cui le lavandaie erano ‘immerse’ per la maggior parte del tempo non era in sostanza diverso da quello delle fogne.43 La fatica, l’insalubrità ma anche la pericolosità paiono caratterizzare il mestiere, un esempio su tutti: nell’agosto del 1896 Annunziata Gardini, dopo aver lavato biancheria per tutto il giorno alla Grada, scivolò e fu travolta dalle acque ma venne, fortunatamente, tratta in salvo.44 Proprio nella consapevolezza delle drammatiche condizioni di fatica e sfruttamento, la categoria a Bologna cominciava ad organizzarsi fondando nel 1884 una Società di mutuo soccorso, caratterizzata da finalità di sostegno e reciproco aiuto tra i soci, in cui però la presenza delle donne era poco significativa.45 Diversa, invece, la caratterizzazione della Lega di miglioramento lavoranti lavandai, costituita nel 1901 presso la locale Camera del Lavoro e contrassegnata da una più esplicita connotazione di classe e da finalità e azioni decisamente rivendicative.46 La Lega, appunto, presentava, nell’ottobre dello stesso anno, ai padroni e ai conduttori di lavanderie, una serie di proposte che prevedevano innanzitutto la riduzione dell’orario di lavoro (dalle sei di mattino alle sei di sera, con intervalli di mezz’ora per la colazione e di un’ora per il pranzo, per sei giorni alla settimana «non esclusi i giorni festivi in caso di urgenza, e fatta eccezione del 1° maggio, festa operaia») e un aumento di salario («L. 2,50 al giorno in contanti, da pagarsi settimanalmente»). Per le lavandaie, la Lega richiedeva lo stesso orario e trattamento lavorativo dei colleghi, ma non la parità salariale (quello femminile richiesto era di L. 1,75): «uguale mercede per uguale lavoro» rimaneva, dunque, solo un principio. 42 Bologna città d’acqua, a cura di Stefano Pezzoli, Cecilia Ugolini, Sergio Venturi, Bologna, Compositori, 1998, pp. 96-97. 43 LABORATORIO D’IGIENE DELLA REGIA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, Il canale di Reno ed i suoi inquinamenti, Bologna, Stab. tip. succ. Monti, 1903. 44 Rapporto di Pubblica Sicurezza, Bologna, 14.8.1896, in ASBo, Gabinetto di Prefettura, serie 934, 1896, «Relazione di Pubblica Sicurezza». 45 Statuto della Società di mutuo soccorso fra i lavandai di Bologna, Bologna, Soc. tip. Azzoguidi, 1884. 46 Lega di miglioramento lavoranti lavandai, Sezione della Camera del Lavoro, Bologna, 31.10.1901, in ASBo, Gabinetto di Prefettura, serie 1001, 1901, cat. 6, fasc. 2 «Sciopero dei lavoranti lavandai». Tra due secoli 17 Di fronte al deciso rifiuto della controparte di dialogare, la Lega decideva di sospendere il lavoro a partire dal 17 novembre. L’agitazione, secondo fonti prefettizie, avrebbe interessato una settantina di lavoranti e dopo qualche giorno si sarebbe esteso coinvolgendo per solidarietà altre categorie.47 Andrea Costa, nel concludere il 25 novembre 1901, il Congresso nazionale dei lavoratori della terra, rivolgeva un saluto agli scioperanti, testimoniando un diffuso interesse nei confronti del movimento cittadino. Iniziava così a svilupparsi la sindacalizzazione delle lavandaie a Bologna. Le domestiche Giovani, nubili, di recente immigrazione, pressoché analfabete, appartenenti ai ceti più umili, residenti presso le famiglie borghesi che le impiegavano: questi sembrano essere i tratti che compongono la tipologia più frequente delle domestiche alla fine dell’Ottocento. Però, intorno a questo nucleo centrale più nitido si estende una zona di confine mobile che non è possibile circoscrivere esattamente. Proprio perché l’attitudine ai lavori casalinghi si presupponeva innata in ogni donna, tutte potevano svolgere questo mestiere che si poteva configurava come una risorsa elastica, occasionale e transitoria. Era possibile andare a servizio per qualche tempo o per tutta la vita, a seconda delle circostanze (per superare difficoltà economiche transitorie proprie o della famiglia oppure per integrare stabilmente il bilancio domestico) e soprattutto in modi molto diversi (di cui alcuni non incompatibili con la gestione di una famiglia propria), svolgendo al contempo altri mestieri oppure alternandoli. L’estrema precarietà e flessibilità erano qualità strutturali del lavoro non qualificato delle donne appartenenti alle classi popolari in quel periodo.48 Ebbene, proprio per queste caratteristiche, il mestiere coinvolgeva un numero crescente di giovani.49 Secondo i dati riportati dal censimento del 1901 (dati che offrivano indicazioni assai approssimative soprattutto in questo settore), le addette ai servizi domestici rappresentavano circa un terzo dell’intera classe operaia femminile: oltre 400.000 su 1.371.426 impiegate nelle industrie.50 Impossibile invece determinare quante emiliane, in quegli anni, partirono dalle aree più povere della regione per andare a servire nelle grandi città. Nella relazione presentata al congresso femminile di Bergamo del settembre 1913, dedicata alle «addette ai servizi domestici», Nina Rignano Sullam dichiarava: «in quasi tutte le regioni d’Italia le fanciulle, partendosi dalle province a industria poco sviluppata o di scarso rendimento agricolo […] si riversano in larghe correnti migratorie nelle città principali».51 Fra le regioni che fornivano domestiche l’Emilia era citata al primo posto (seguita da Veneto, Umbria, 47 Lettera del Questore al Prefetto, Bologna, 18.11.1901, in ASBo, Gabinetto di Prefettura, serie 1001, 1901, cat. 6, fasc. 2 «Sciopero dei lavoranti lavandai». 48 MARGHERITA PELAJA, Mestieri femminili e luoghi comuni. Le domestiche a Roma a metà Ottocento, «Quaderni storici», XXIII, 1988, 68, pp. 497-518. 49 La femminilizzazione del servizio domestico, tipico del periodo, faceva parte di un più ampio processo di trasformazione, nel cui ambito gli uomini si orientavano verso lavori contraddistinti da una maggiore autonomia individuale. 50 I dati sono ripresi da NINA RIGNANO SULLAM, Le addette ai lavori domestici. Collocamento, assistenza, istruzione, Milano, Tipo-lit. Rebeschini, 1914, p. 5. Nina Rignano Sullam (1871-1945), attiva nelle associazioni di mutuo soccorso e inserita nell’ambiente di stampo democratico e socialista milanese, fu tra le co-fondatrici dell’Unione femminile nel 1899. La relazione citata fu presentata al Congresso nazionale femminile di Bergamo nel settembre del 1913. 51 N. RIGNANO SULLAM, Le addette ai servizi domestici cit., p. 7. Le destinazioni privilegiate erano Milano, Torino, Firenze e Roma. 18 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale GIUSEPPE MICHELINI, Domestica con bambini a Riccione, 1913, Fondo Famiglia Michelini, Archivio fotografico Cineteca del Comune, Bologna Marche, Abruzzo): «le contadinelle dell’Emilia e della pianura lombarda, dei Castelli e della campagna romana, taluna dalla Toscana, tornano d’estate al paese per coadiuvare le famiglie nel lavoro dei campi o per unirsi alle schiere delle mondine all’epoca della monda del riso». Il fenomeno era evidentemente ampio se il collocamento delle donne poteva avvenire in modi molto diversi: uffici aperti da istituzioni filantropiche, agenzie private, relazioni informali con portinai e negozianti, inserzioni sui giornali.52 All’inizio del Novecento, settori riformisti dell’opinione pubblica cominciarono a prendere posizione – attraverso inchieste e opuscoli di denuncia – contro le loro precarie e talvolta drammatiche condizioni di lavoro. Veniva scritto che nelle abitazioni della borghesia era prassi comune che la serva dormisse in qualche «bugigattolo» senza aria né luce o che la sera accomodasse «la sua cuccia nell’andito», che il vitto fosse scarso e scadente, che la giornata di lavoro non avesse limiti e che, nel migliore dei casi, venissero concesse, a differenza dei colleghi maschi, solo quattro ore di libertà ogni quindici giorni.53 Veniva denunciato «il lavoro illimitato; qualche volta sproporzionato all’età ed alla loro fisica costituzione»:54 fare il bucato, stare in cucina, fare le pulizie, trasportare acqua, legna e carbone, cucire e rammendare, spesso anche sorvegliare i bambini e curare gli anziani e gli infermi. 52 M. PALAZZI, Donne delle campagne e delle città: lavoro ed emancipazione, in Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità ad oggi. L’Emilia-Romagna cit., p. 390. 53 FLORES REGGIANI, Un problema tecnico e un problema morale: la crisi delle domestiche a Milano (1890-1914), in Donna lombarda 1860-1945, a cura di Ada Gigli Marchetti, Nanda Torcellan, Milano, Angeli, 1992, pp. 149-179: 155. 54 CLEMENTINA GIUSTI PESCI, Proposta per la classe delle domestiche presentata alla assemblea della Federazione Emiliana delle Donne Italiane il 3 marzo 1913, Bologna, Tip. succ. Monti e Noè, 1913, p. 5. Tra due secoli 19 Se a tutto questo si aggiunge la pratica ancora ben viva delle punizioni fisiche55 e se si tiene presente che nel 1901 il 9% del personale di servizio in Italia era composto da bambine di età compresa dai 9 ai 15 anni,56 acquista verosimiglianza, anche se non valore di generalizzazione, la figura di Agnese, protagonista della novella Tiranni minimi di Gerolamo Rovetta: «smunta, magra e sbalordita» a dodici anni ‘sfacchinava’ senza tregua come sguattera, cuoca, cameriera e bambinaia per cinque lire al mese in una famiglia borghese, per poi morire consunta dalla fatica e dalla tisi.57 Del resto la sua vicenda appare convenzionale al confronto di quella, reale, della servetta undicenne assunta «per carità» (e quindi senza retribuzione, ma solo in cambio di vitto e alloggio) che nel 1918 fuggì dopo tre anni di servizio e chiese rifugio, gravemente denutrita e ferita per i colpi di frustino ricevuti come castigo, all’Asilo Mariuccia di Milano.58 Quanto alla condizione salariale, l’inchiesta condotta da Nina Rignano Sullam nel 1913 stabiliva che le «domestiche abili» potevano percepire dalle 20 alle 35 lire mensili mentre le «ragazze di primo servizio» dalle 8 alle 15 lire:59 indubbiamente una «paga da miseria», pur se talvolta integrata dall’assegnazione di vitto, alloggio, indumenti e se inserita in un panorama generalizzato di basse retribuzioni. Allo sfruttamento brutale, si aggiungevano la possibilità di subire perquisizioni degli effetti personali, licenziamenti senza preavviso per sospetti non provati, umiliazioni e rimproveri gratuiti, imposizioni di regole maniacali, nonché l’obbligo di vestire in modo anonimo e disadorno. La lunga abitudine – veniva scritto in una inchiesta – ci ha fatto dimenticare che sono esseri come noi e purtroppo fino dall’infanzia li consideriamo come persone inferiori e però li comandiamo con troppa autorità, spesso con maniere sprezzanti.60 Ciononostante, anche perdere un lavoro così negativamente caratterizzato poteva spingere alla disperazione e portare a decisioni estreme, come nel caso di Cesira Lelli, «servente presso il signor Zamboni in via Barberia» che, essendo stata licenziata, tentava il suicidio gettandosi dalla finestra.61 Le relazioni giornaliere stilate dagli ufficiali di Pubblica Sicurezza di Bologna registravano, in quegli anni, un’elevata percentuale di suicidi tra le domestiche, così come una lunga serie di violenze sessuali perpetrate a loro danno, ulteriori indici della loro particolare vulnerabilità. Un esempio su tutti: a Camugnano il possidente Antonio Elmi «non potè mandare ad effetto il suo intento» perché Elena Palmieri, domestica tredicenne, «avendo opposto resistenza» riusciva «a liberarsi 55 Nel Codice civile del nuovo Stato italiano i padroni erano responsabili «pei danni cagionati dai loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze alle quali li [avevano] destinati» (art. 1153). Coerentemente con questo principio, il padrone poteva usare mezzi di correzione o di disciplina nei loro confronti. Tali norme assimilavano i domestici ai minori. Cfr. RAFFAELLA SARTI, Quali diritti per la donna? Servizio domestico e identità di genere dalla Rivoluzione francese a oggi, s.i.p., Bologna, 2000, p. 12. 56 N. RIGNANO SULLAM, Le addette ai lavori domestici cit., p. 3. 57 GEROLAMO ROVETTA, Tiranni minimi, in Novelle, Milano, Fratelli Treves, 1898, p. 194 e p. 209, citato in F. REGGIANI, Un problema tecnico e un problema morale cit., p. 156-157. 58 ANNARITA BUTTAFUOCO, Le Mariuccine. Storia di una istituzione femminile laica: l’asilo Mariuccia, Milano, Angeli, 1988, pp. 134-135. L’ente fu fondato da Ersilia Majno per l’educazione delle ragazze povere e abbandonate. 59 N. RIGNANO SULLAM, Le addette ai lavori domestici cit., p. 11. 60 C. GIUSTI PESCI, Proposta per la classe delle domestiche cit., p. 4. 61 Rapporto di Pubblica Sicurezza, Bologna, 26.2.1899, in ASBo, Gabinetto di Prefettura, serie 983, 1899, «Relazioni giornaliere di Pubblica Sicurezza». 20 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale e a fuggire», sottraendosi al tentativo di stupro.62 Giovani, separate dalla famiglia d’origine, e quindi senza reti di protezione, le domestiche pare fossero esposte, più di ogni altro gruppo occupazionale, alle insidie e alle lusinghe dei padroni con cui il loro lavoro le poneva in contatto diretto e quotidiano: «Per la moralità ogni sorta di pericoli; le insidie dei padroni, talvolta le imprudenze delle padrone, quando per esempio la madre dice al figliolo “fa un po’ di corte alla cameriera così ci servirà meglio”. L’esempio è preso dal vero – scriveva Clementina Giusti Pesci – e molti più gravi ne potrei citare».63 Il nuovo Stato unitario, nonostante l’urgenza di risolvere tale situazione, non si occupò di regolare questa occupazione: le domestiche furono a lungo escluse da larghissima parte delle leggi relative alla regolamentazione del lavoro o alla tutela delle lavoratrici introdotte in Italia. Non vennero infatti comprese in quelle sul lavoro dei fanciulli e delle donne, sulla tutela della maternità, sulla limitazione dell’orario di lavoro, ecc.64 Il lavoro domestico rimaneva abbandonato quasi del tutto all’arbitrio dei singoli. Ciò portava le donne dell’associazionismo femminile a prendere posizione e a dichiarare quanto fosse necessario promuovere il miglioramento delle «condizioni morali e materiali di questa classe di lavoratori», considerare le domestiche come «lavoratrici a contratto con obblighi di pari grado per ambo le parti» e, soprattutto provvedere a istituire «la pensione per la vecchiaia e la invalidità».65 Auspicavano, infine, la costituzione di «organizzazioni di lavoratrici domestiche che, partendosi dalla forma iniziale della Mutualità, sviluppino nella classe lo spirito di previdenza e solidarietà, il sentimento della dignità umana, il desiderio di elevazione e di progresso, premendo e agitandosi per il conseguimento delle riforme sopra indicate».66 Nonostante gli obiettivi di riforma delle associazioni femminili, le serve rimasero per lungo tempo le lavoratrici con minori diritti e con minori possibilità di sperimentare una vita indipendente. Le lavoranti a domicilio Nel periodo preso in considerazione una miriade di cucitrici, ricamatrici, merlettaie, trecciaiole, tessitrici, sarte, modiste, infilatrici di perle o di coroncine di rosario lavoravano a domicilio, fuori dagli opifici, ma comunque alle dipendenze e sotto la direzione degli imprenditori. Una attività subordinata che non era, dunque, scomparsa con l’affermarsi del sistema di fabbrica, ma che prima aveva convissuto con esso, poi ne era divenuto un elemento strettamente complementare,67 venendo a prefigurarsi come una «forma produt62 Relazione giornaliera dei reati ed avvenimenti, Bologna, 20.2.1889, in ASBo, Gabinetto di Prefettura, serie 709, 1889, «Relazioni di Pubblica Sicurezza». 63 C. GIUSTI PESCI, Proposta per la classe delle domestiche cit., p. 5. 64 Solo nel 1923 beneficiarono di quelli sull’assicurazione obbligatoria contro l’invalidità e la vecchiaia. 65 C. GIUSTI PESCI, Proposta per la classe delle domestiche cit., p. 4 e p. 6. 66 N. RIGNANO SULLAM, Le addette ai lavori domestici cit., p. 21. 67 Coma ha scritto Stefano Merli nel suo imprescindibile studio sulle origini del capitalismo industriale italiano «da una prima fase artigianale e manifatturiera in cui il telaio era sparso nella campagna presso il singolo tessitore proprietario del suo strumento di lavoro oppure riunito in piccole fabbriche dirette da un capo operaio, padrone dei suoi telai, che lavoravano per conto di un imprenditore, si era passati a un sistema di fabbrica vero e proprio nel quale il telaio casalingo sussisteva, anzi era incrementato come appendice della fabbrica, specie per certe lavorazioni come i tessuti di cotone [...] e per certe seterie». S. MERLI, Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale. Il caso italiano 18801900, Firenze, La Nuova Italia, 1972, p. 60. Tra due secoli Ricamatrici a Cavriago, 1919, Fototeca della Biblioteca Panizzi, Reggio Emilia 21 22 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale tiva apparentemente arretrata che in qualche misura incarna il “sogno” descritto da alcuni teorici del “capitale”: accumulazione e profitto senza operai, con forza-lavoro atomizzata e dispersa nell’indistinto del ciclo frazionato. La dipendenza è travestita in formale “autonomia”. Lo sfruttamento “aggiuntivo” si converte in autosfruttamento. La produzione si realizza attraverso l’apparente dissolversi del rapporto di produzione».68 Ebbene, questo tipo di lavoro era praticato, in massima parte, dalle donne: nel censimento del 1901 su 117.642 lavoranti a domicilio 69.722 erano donne, concentrate in massima parte in Lombardia, Piemonte ed Emilia; un dato che rimase costante nel corso del Novecento, proprio perché, svolto in casa, poteva conciliarsi con le mansioni domestiche. Le lavoranti a domicilio producevano, in genere, semilavorati destinati all’industria tessile e a quella dell’abbigliamento:69 erano soprattutto questi i settori che prosperavano sullo sfruttamento del loro lavoro, «così faticoso, così miseramente retribuito, così intenso e dannoso alla salute».70 Le migliaia di donne impegnate a domicilio, in quell’avvio di secolo, costituivano un mondo sommerso, invisibile, clandestino. «Silenziose e rassegnate» venivano, infatti, definite le merlettaie della Riviera ligure, zone in cui «tutte le donne dai cinque anni alla decrepitezza lavorano le belle trine» un lavoro che le costringeva a stare «per lunghe ore col busto curvo in avanti sul tombolo appoggiato ai cavalletti», tutte ugualmente con un’espressione sul viso «stanca e sofferente», come documentava l’articolista de «La donna socialista», rivista femminile che andava affrontando il tema rimasto a lungo inesplorato. Alcune lavoravano su commissione di negozi e magazzini, altre per privati. Tutte con una prospettiva di guadagno irrisoria. Dopo molte domande e molti confronti ho potuto calcolare che il lavoro delle merlettaie è valutato dai sei ai nove centesimi all’ora, oscillazione dovuta alla maggiore o minor capacità dell’operaia ed all’età sua. […]. «Potrò guadagnare 35 centesimi lavorando cinque o sei ore» mi diceva una sposina. E una giovane baldanzosa: «Io guadagno 60 o 70 centesimi per 9 o 10 ore, ma se lavorassi tutto il giorno [in corsivo nel testo] potrei prendere una lira». Di quante ore avrebbe dovuto essere la giornata di quell’infelice, già macilenta e anemica?71 Vari, miseri, incerti: la realtà di questi salari dimostra che si trattava di un settore dove lo sfruttamento poteva essere ignobile e meschino. Gli esempi si possono moltiplicare, ma anche cambiando area geografica e campo lavorativo il quadro non muta: paghe inaccettabili per orari di lavoro impossibili, ancora e sempre sfruttamento. Il salario delle trecciaiole toscane, negli anni di fine Ottocento, era di 10-13 centesimi per un cappello per il quale occorrevano due giorni di lavoro; le cucitrici della capitale, sempre nello stesso periodo, ‘sgobbando’ dalle sette di mattina alle otto di sera, guadagnavano 3,60 lire alla settimana (e a loro carico spesso erano le matasse di cotone, gli aghi e il consumo della macchina da cucire, spesso fornita dalla ditta che ne tratteneva il costo dalle retribuzio68 Il lavoro a domicilio ha accompagnato l’intera storia del capitalismo industriale come modo di produzione la cui essenziale caratteristica era quella di trasferire all’esterno dell’impresa i rischi connessi alla sua gestione. LUIGI MARIUCCI, Il lavoro decentrato. Discipline legislative e contrattuali, Milano, Angeli, 1979, p. 22. 69 Erano soprattutto le industrie cotoniera, serica, laniera a incrementare il lavoro a domicilio femminile. Ne fa fede l’aumento del numero dei telai domestici riportato in quegli anni nelle statistiche industriali. Cfr. FIORENZA TAROZZI, Lavoratori e lavoratrici a domicilio, in Operai, a cura di S. Musso, Torino, Rosenberg & Sellier, 2006, pp. 109-161: 111-113. 70 Le merlettaie, «La donna socialista», 24 febbraio 1906. 71 Ibidem. Tra due secoli 23 GIUSEPPE GRAZIOSI, Donna al telaio nei dintorni delle campagne modenesi, ca. 1910, Museo Civico d’Arte, Modena ni); mentre nel 1900 le tessitrici a domicilio milanesi arrivavano con fatica a ricevere unadue lire al giorno, per un numero imprecisato di ore di lavoro massacrante.72 In assenza di riconoscimenti contrattuali e di norme legislative a tutela, le lavoranti a domicilio si trovavano poi a svolgere la propria attività in ambienti angusti e spesso sovraffollati, dove si accumulavano, indifferentemente, scatole, merce in lavorazione e persone: [...] in una inchiesta privata a Bologna (1907) per l’allargamento di via Clavature, ho visto, in una stanza di 14 mq. di superficie, ben sette lavoratrici, accaparrate da una sottoimprenditrice della industria domestica. E gli esempi possono moltiplicarsi all’infinito, […] delle perenni violazioni che, alle leggi fisiologiche, e anche a quelle scritte, porta il lavoro a domicilio.73 Tale situazione derivava anche dall’impossibilità per queste donne di riconoscersi come gruppo omogeneo. Più disarmate e maggiormente ricattabili dai padroni – perché donne, perché isolate a lavorare nelle proprie abitazioni, perché spesso disperse nelle campagne – le lavoranti a domicilio con molta difficoltà riuscivano a dare vita a Società di mutuo soccorso o a Leghe di resistenza che avrebbero loro permesso di mettere in atto forme di pressione collettiva, cercando così di migliorare le proprie condizioni di 72 Cfr. F. TAROZZI, Lavoratori e lavoratrici a domicilio cit., pp. 119-120. ERNESTO BERTARELLI, La lotta contro il «lavoro in casa», «Critica sociale», XIX, 5-6, 1-16 marzo 1909, pp. 80-81, citato in Ivi, p. 124. 73 24 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale lavoro. Sole, senza il momento dell’organizzazione, non potevano che continuare a subire passivamente, chiudendosi in una disperata difesa dei loro minimi livelli di vita. In questo contesto difficile e complesso, tuttavia, cominciarono a emergere forme organizzative di settore su sollecitazione di esponenti, uomini e donne, del Partito socialista. A Carpi, ad esempio, a fine Ottocento cominciarono a formarsi le Leghe delle trecciaiole che ben presto si convertirono in vere e proprie cooperative, la trasformazione [...] partì dai centri di produzione della bassa reggiana e arrivò alla costituzione di Federazioni e Consorzi interprovinciali e poi alla Federazione nazionale [dei lavoratori del truciolo] che si proponeva di incentivare l’associazionismo fra gli addetti alla produzione della treccia, affinché l’autogestione operaia potesse sempre più contare nel consolidare l’industria del truciolo, qualificandone ed estendendone la produzione a vantaggio dei lavoratori associati.74 Nell’area della ‘bassa’ emiliana che gravitava intorno a Carpi e interessava le province di Modena e Reggio Emilia, in effetti, la lavorazione del truciolo – sia sotto forma di trecce, sia in forma più limitata di cappelli – costituiva l’attività manifatturiera prevalente. Risalente al XVI secolo, l’utilizzazione del legno di salice75 aveva dato vita a una intensa attività a domicilio in cui erano impegnati per circa sei mesi all’anno, in coincidenza della pausa nei lavori agricoli, migliaia di lavoratrici. Nel febbraio del 1905 si tenne il primo congresso interprovinciale delle organizzazioni delle trecciaiole in cui temi centrali del dibattito furono la necessità di aumenti retributivi e l’urgenza di disciplinare il lavoro a domicilio; questione, quella della tutela, che fu ripresa e ripresentata nel corso degli anni successivi, ad esempio nell’agosto del 1910 al primo congresso nazionale dei lavoratori del truciolo a Carpi e, ancora, nell’agosto del 1912 al terzo congresso nazionale tenutosi a Reggio Emilia. Però, il disinteresse da parte dello Stato prevalse anche nel primo dopoguerra, nella convinzione secondo cui il lavoro a domicilio era una forma arcaica e transitoria di impegno lavorativo, e l’Italia continuò ad essere uno dei pochi paesi europei privo di una legislazione specifica che mettesse ordine in una realtà, invece, largamente rappresentativa del mercato del lavoro. Le lavoranti a domicilio quindi rimasero prive di leggi di tutela (infortuni, malattie) e previdenziali (invalidità, vecchiaia). Le lavoratrici dell’ago Nella società di fine Ottocento–primi Novecento, il lavoro di sarta presentava caratteristiche compatibili con modelli pensati per le donne, soprattutto quelle dei ceti operai; compatibilità dimostrata anche dal fatto che le scuole professionali femminili preparavano le giovani proprio a mestieri che avessero queste caratteristiche, primi fra tutti il cucito e il ricamo.76 74 L’arte del truciolo a Carpi, Carpi, [s.n.], 1979, p. 20. Dal legno di salice o di pioppo, opportunamente coltivati, venivano tratte delle sottili paglie (trucioli) – uniformi per spessore, larghezza e lunghezza – che venivano poi intrecciate a formare una lunga fettuccia (trecce), utilizzata da donne esperte per confezionare cappelli di paglia. 76 A titolo di esempio, quando nel 1895 venne aperta la scuola professionale «Regina Margherita» di Bologna le ottantacinque allieve vennero «suddivise nei laboratori di taglio e confezione biancheria, sartoria da donna e bambino, modisteria, ricamo in bianco e a colori, maglieria, fiori artificiali, stiratura, cucina, decorazione delle ceramiche». Donne scuola lavoro. Dalla scuola professionale «Regina Margherita» agli istituti «Elisabetta Sirani» di Bologna (1895-1995), a cura di Brunella Dalla Casa, Imola, Galeati, 1996, p. 34. 75 Tra due secoli 25 La sua stessa flessibilità era funzionale al modo in cui la forza lavoro femminile si presentava sul mercato del lavoro. Infatti, le competenze scolastiche acquisite potevano essere messe a frutto in vario modo: potevano essere utilizzate dalle donne nelle sartorie o nelle industrie dell’abbigliamento, ma anche costituire la base di una piccola attività artigianale che aveva nell’abitazione il suo luogo di realizzazione o, infine, essere utilizzate per far quadrare il bilancio, in certi momenti di crisi, con il ricorso al lavoro a domicilio, una risorsa che poteva dare alla famiglia una capacità di sopravvivenza altrimenti più incerta. Il mestiere subì, dunque, un forte processo di femminilizzazione per diversi motivi: l’estendersi del consumo di abiti confezionati, che portava alla trasformazione delle sarte in vere e proprie operaie, una maggior domanda di abiti femminili e biancheria, oltre all’assunzione delle donne in ruoli secondari nelle sartorie per uomini.77 Tuttavia tale processo fu tutt’altro che omogeneo e riguardò, innanzitutto, le regioni centro-settentrionali e i grandi centri urbani. Nel censimento del 1881 le donne erano assolutamente preponderanti nel nord – con punte massime in Lombardia, Piemonte e Liguria – e nel centro del paese. Il settore di taglio e confezione di biancheria, che ne coinvolgeva più di 170.000 (circa un terzo delle quali concentrato in Lombardia) era quasi completamente femminilizzato.78 Quarant’anni dopo, nel 1911, la percentuale di sarte rispetto alla popolazione era aumentata in modo ancor più considerevole.79 Secondo i dati del primo censimento degli opifici e stabilimenti industriali del 1911 in Emilia-Romagna erano concentrate l’8% delle 513 sartorie con più di dieci addetti e il 12% delle 166 imprese di taglio e cucitura di biancheria.80 Qui, ad esempio, operavano cinque ditte produttrici di busti da donna: quattro si trovavano in provincia di Parma e occupavano 475 operaie, mentre a Bologna la ditta Pancaldi ne utilizzava oltre 90.81 Sempre nella nostra città operava l’Aemilia Ars, l’impresa per la produzione di merletti e ricami a punto antico sorta per iniziativa di Lina Bianconcini Cavazza82 a fine 77 Nel corso degli ultimi decenni dell’Ottocento e dei primi del Novecento si assistette in Italia allo sviluppo del settore dell’abbigliamento, sviluppo legato a importanti mutamenti sia nella domanda sia nell’organizzazione della produzione e quindi del lavoro. Fanno parte del primo aspetto l’aumento del consumo di abiti confezionati e anche lo sviluppo di due nuovi tipi di mercato riguardanti l’alta moda e la biancheria. Un impulso alla riorganizzazione del lavoro venne invece dalla tecnologia. L’invenzione e poi, nella seconda metà del secolo, la diffusione della macchina per cucire, aumentò la produttività e la regolarità del lavoro consentendo di ridurre i costi e favorendo la produzione di abiti confezionati. La storia di questa macchina e la sua grande diffusione nel corso del Novecento è legata ad aspetti importanti del lavoro femminile. Basti pensare che essa entrò rapidamente non solo nelle sartorie, ma anche nelle case (nella sua diffusione fu sperimentata per la prima volta la vendita a rate) e nelle scuole femminili (le professionali, talvolta anche le Normali dove venivano formate le maestre e persino, in casi molto più rari, anche le elementari). Cfr. M. PALAZZI, Donne sole. Storia dell’altra faccia dell’Italia tra antico regime e società contemporanea, Milano, Bruno Mondadori, 1997, p. 149. 78 Ivi, p. 152. 79 La presenza femminile era largamente preponderante fra le salariate, minoritaria fra i proprietari e i direttori. Questo settore però si dimostrava essere il comparto in cui cominciavano a diffondersi forme di piccola imprenditoria femminile, derivate da iniziative autonome. Cfr. M. PALAZZI, Donne sole cit., p.155. 80 MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, Censimento degli opifici e delle imprese industriali al 10 giugno 1911, vol. III, Roma, [s.n.], 1914, citato in M. PALAZZI, Donne sole cit., pp. 154-155. 81 M. PALAZZI, L’industria emiliana alle soglie del XX secolo, in Studi in memoria di Luigi Dal Pane, Bologna, Clueb, 1982, pp. 893-949: 934. 82 Lina Bianconcini Cavazza (1861-1942), moglie del conte Francesco, non fu solo imprenditrice di successo ma anche promotrice di iniziative di carattere sociale, culturale e politico. Nel 1915, ad esempio, istituì l’Ufficio notizie alle famiglie dei militari. Cfr., a tale proposito, il paragrafo Mobilitarsi in tempo di guerra. 26 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale Ottocento.83 Il progetto perseguito dalla contessa tendeva al recupero di antichi esemplari di trine (a cui si affiancavano disegni originali più innovativi, spesso basati su schizzi di Alfonso Rubbiani), attraverso cui fondare un miglioramento del gusto ed un rilancio dell’artigianato di qualità. Venne così avviata una raffinata produzione caratterizzata da un virtuosismo tecnico pari se non superiore alla qualità degli originari manufatti cui si ispirava. L’impresa aveva anche precise finalità filantropiche: si avvaleva, infatti, del lavoro prezioso di donne della città e della provincia bisognose di svolgere un’attività remunerata, come rilevato dalla stessa Bianconcini Cavazza nel 1903: «[L’Aemilia Ars è] una istituzione che porta sollievo a molte miserie nascoste, che permette a tante madri di non trascurare i loro doveri allontanandosi di casa per lavoro, a tante figlie di venire in aiuto di genitori vecchi e malati, a tante ragazze di utilizzare con decoro e profitto le ore libere della loro giornata».84 L’azienda presentava poi aspetti peculiari – di tipo imprenditoriale, sociale e politico – che valgono a spiegare il suo successo durato fino al 1936. Di particolare originalità furono i risvolti connessi alla commercializzazione – sviluppata sui mercati europei e statunitensi grazie alla personalizzazione del prodotto, la creazione di una rete flessibile di vendita, la presenza alle grandi esposizioni internazionali come quella di Torino del 1902 – ed all’organizzazione del lavoro femminile. La trasparenza nella definizione del rapporto costi/prezzi, la scelta di alcune lavoratrici per definire tale rapporto, la partecipazione delle lavoratrici agli utili nella percentuale del 35%, la formazione gratuita di una forza lavoro composta soprattutto di donne povere, furono tra gli elementi caratterizzanti di questa innovativa impresa al femminile. L’industria dell’abbigliamento era, dunque, una combinazione di manifattura e lavoro a domicilio. Coesistevano, infatti, piccoli laboratori semiartigianali che assumevano il lavoro da una o più ditte e utilizzavano aiutanti o apprendiste, la realtà più diffusa, e ditte di dimensioni medie, i cui addetti superavano le cento unità che, oltre ad avvalersi largamente di lavoranti a domicilio, generalmente producevano abiti confezionati a basso costo. I laboratori e le realtà produttive di dimensione artigianali, dove ancora si cucivano abiti su misura, si dividevano in atelier per signora e in sartorie per uomo. Nei 83 Nel 1898 a Bologna venne fondata, per iniziativa di nobili, imprenditori e artisti, l’Aemilia Ars, impresa che aveva lo scopo di promuovere le industrie artigianali emiliane e dar vita ad un rinnovamento nelle arti decorative, applicate agli oggetti di uso quotidiano. Al suo interno, un particolare rilievo venne assunto proprio dalla produzione di merletti e ricami a punto antico. L’impresa, attraverso i suoi artisti (il principale artefice Alfonso Rubbiani, ma anche Achille Casanova, Giuseppe De Col, Edoardo Collamarini, Augusto Sezanne, Alfredo Tartarini), forniva modelli e nuovi disegni alle varie industrie e ai laboratori artigiani della regione che si sarebbero occupati della realizzazione. L’attività copriva tutti i settori delle arti applicate: dai mobili alla ceramica, dai vetri ai ferri battuti, dalle rilegature in cuoio ai gioielli, al ricamo, non trascurando gli interventi decorativi su edifici pubblici e privati. Il successo e la notorietà dell’Aemilia Ars sul mercato nazionale ed estero furono sanciti dalla sua partecipazione a diverse esposizioni internazionali (Torino 1902, Liegi 1905, Milano 1906, Bruxelles 1910) e dai numerosi riconoscimenti e premi conseguiti. Pur ottenendo una significativa affermazione e pur avendo sviluppato l’aspetto commerciale della produzione con l’apertura di un negozio-galleria in via Ugo Bassi a Bologna, la società stabilì, nel 1903, di chiudere per mancanza di fondi. Venne deciso comunque di mantenere in attività la manifattura di merletti e ricami a punto antico. Cfr. Aemilia Ars 1898-1903. Arts & Crafts a Bologna, a cura di Carla Bernardini, Doretta Davanzo Poli, Orsola Ghetti Baldi, Milano, A+G edizioni, 2001. 84 LINA BIANCONCINI CAVAZZA, Note relative allo scopo e alla economia dell’azienda, in Aemilia Ars, azienda merletti e ricami a punto antico, Bologna, 1903, citato in VITTORIO CAPECCHI, ADELE PESCE, L’Aemilia Ars “merletti e ricami”: storia di un’impresa tutta femminile, in Aemilia Ars 18981903. Arts & Crafts a Bologna cit., pp. 127-153: 142. Tra due secoli 27 primi lavoravano solo donne, mentre nei secondi si potevano trovare sarti e sarte. A Bologna una delle attività di sartoria più rinomate fu avviata da Giovanni Maria Policardi nel 186085 e poi continuata dal figlio Lorenzo: sotto la sua direzione, la sartoria si occupò esclusivamente di alta moda. Alcune fotografie scattate negli anni Venti dal fotografo Villani documentano le stanze dell’atelier di piazza Minghetti. I locali erano stati sontuosamente arredati nella parte destinata alla presentazione dei capi di abbigliamento, ai salottini di prova, ai luoghi di ricevimento della clientela, costituita prevalentemente dall’aristocrazia locale e nazionale.86 Agli inizi del Novecento erano presenti in città anche la sartoria di Virginia Moretti, aperta nel 1907 in via Castiglione con una ventina di dipendenti, e quella delle sorelle Liverani (Luisa, Adele e Maria), creata nel primo dopoguerra, che Una sarta e la sua ‘piccinina’, 1880 ca. Civica raccolta Stampe Achille Bertarelli, Milano proseguiva il lavoro di un celebre atelier, fondato nel 1862 da Clementina Moschini, occupandone anche la sede storica di via Val d’Aposa.87 Queste sartorie per signora, chiamate anche scuole, erano ambienti prevalentemente femminili dove lavoravano ‘sartine’ e ‘maestre’: le une sottoposte alle altre in una struttura rigidamente gerarchica basata sulla lenta acquisizione dei segreti del mestiere, anche se alla maggior parte delle operaie era negato il momento più creativo dell’ideazione e del taglio. La maestra organizzava e distribuiva il lavoro, insegnava il mestiere alle apprendiste e manteneva la disciplina. Spesso infliggeva multe ingiuste, assegnava incarichi eccessivi e pretendeva ore supplementari (durante gli scioperi non era raro che le sarte richiedessero di limitarne l’autorità).88 Le paghe delle sarte da donna erano inferiori sia a quelle dei colleghi maschi sia a quelle delle sarte che confezionavano abiti da uomo. A fine Ottocento, i salari medi giornalieri oscillavano da 75 centesimi a 1,25 lire, ma alle più giovani spettava un compenso compreso tra i 40 centesimi e le due lire. A mansioni particolari 85 Artisti del quotidiano, sarti e sartorie storiche in Emilia-Romagna, a cura di Elisa Tosi Brandi, Bologna, Clueb, 2009, p. 91. 86 Ivi, pp. 180-181. 87 Ivi, p. 183. 88 Cfr. FIORELLA IMPRENTI, Operaie e socialismo. Milano, le leghe femminili, la Camera del lavoro (1891-1918), Milano, Angeli, 2007, p. 147. 28 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale Lo sciopero delle ‘piccinine’ a Milano, «L’Illustrazione italiana», 6 luglio 1902, Istituto storico Parri Emilia-Romagna, Bologna Lettera della sartoria Policardi alla Camera di Commercio di Bologna, 24 gennaio 1919, Archivio di Stato, Bologna equivalevano retribuzioni più elevate: le sarte che utilizzavano le macchine da cucire guadagnavano circa tre lire a giornata, mentre le maestre e le capo-reparto potevano arrivare a sette lire.89 Ai bassi salari corrispondevano giornate di lavoro intensissime. Gli orari andavano dalle 12 alle 16 ore al giorno, con significative oscillazioni in base alle esigenze di produzione: Dolorosa è la vita che conducono nelle città migliaia e migliaia di ragazze del popolo: sarte e modiste. Esse cominciano la vita del laboratorio a 9 o 10 anni, con un orario che dalle otto del mattino (inverno) e dalle sette (estate) le tiene sedute fino alle 21 certe sere e al venerdì e al sabato fino alle 23 e alle 24, con una breve mezz’ora di riposo verso il mezzodì, per mangiare un boccone. Questa la regola generale. Vengono poi le eccezioni che si verificano due, tre volte per settimana, in cui per finire la «toilette» alla signora X che deve recarsi al ballo, della signora Y che deve recarsi a una conversazione, la padrona prega le operaie di rimanere qualche ora in più al lavoro, per dare l’ultimo punto, e così si fermano fino alle ore 23 anziché uscire alle ore 20 come al solito. Tutto questo lavoro extra non rende loro un centesimo in più, poiché la mercede dell’operaia sarta […] comprende orari supplementari, giorni festivi e in qualche laboratorio più barbaro, anche la notte!.90 Non erano contemplate neppure pause per il pranzo, era la maestra che stabiliva, di volta in volta secondo le necessità del lavoro e delle consegne, se e quando mangiare: «appena cacciato giù l’ultimo boccone, che si era dovuto magari nascondere nel candi- 89 90 Ivi, p. 148. Sarte e modiste, «La donna socialista», 17 marzo 1906. Tra due secoli 29 do grembiale per non sentirsi una strapazzata, giù di nuovo colla testa sul lavoro, senza poter digerire, col cibo che sta sullo stomaco».91 La moda e il clima concorrevano a determinare periodi di febbrile attività (in genere corrispondenti con i mesi estivi e invernali, più il periodo a ridosso del Carnevale) in cui per giorni interi le sarte rimanevano in laboratorio anche fino a venti ore di seguito, alternati a periodi di ozio forzato e di mancato guadagno, non compensato dalle retribuzioni, troppo esigue, dei mesi lavorativi.92 In questo quadro di sfruttamento non sorprende che le indagini promosse dall’Unione femminile di Milano rilevassero un elevato tasso di morti per tubercolosi fra le sartine, conseguenza della scarsa alimentazione e delle lunghe ore di lavoro passate in ambienti sovraffollati, angusti, privi di aria e di luce.93 Erano soprattutto le giovanissime apprendiste, le ‘piccinine’, a patire questa situazione lavorativa: ragazzine dai sette ai dodici anni che ufficialmente venivano assunte per imparare il mestiere ma che, in realtà, erano utilizzate per compiere svariate mansioni che non avevano niente a che fare con l’apprendistato, come ricorda Teresa Noce nel suo Rivoluzionaria professionale: «Non avevo ancora dodici anni che cambiai mestiere. Provai a fare la sarta in un piccolo ma elegante atelier. […]. Qui vi erano tre lavoranti e due apprendiste: oltre a me, una quattordicenne che già “sedeva”, cioè non faceva solo le corse e le pulizie, ma stava anche qualche ora seduta a cucire».94 Rientravano, dunque, abitualmente nei loro compiti svolgere vari servizi domestici e commissioni, tra cui la consegna degli abiti alle clienti. Lo scatolone usato, particolarmente pesante per esili schiene di bambine, le identificava ed è con questo ‘strumento di lavoro’ che compaiono nelle immagini qui riprodotte. La loro paga era quasi simbolica: 25-35 centesimi per una intensa giornata lavorativa. Furono 500 di loro che nel giugno del 1902 a Milano scesero in sciopero. In tale occasione, tra le varie richieste, fu presentata anche quella di una limitazione del carico dello scatolone «in modo che le bambine fino ai nove anni non portassero un peso superiore ai quattro chili e fino ai dodici anni non superiore ai dieci».95 Lo sciopero si concluse ai primi giorni di luglio con la completa vittoria delle ‘piccinine’.96 Fu indubbiamente un successo del quale per molto tempo rimase il ricordo: il fatto che delle ragazzine, fino a quel momento disorganizzate, fossero riuscite a condurre una lotta ordinata e a imporre le loro richieste ai proprietari divenne quasi un mito, riproposto continuamente nei comizi operai.97 91 Le sartine, «La lotta», 12-13 maggio 1899. Appello della Lega di mutuo soccorso e di difesa fra le lavoranti sarte da donna in Milano, 1892, citato in S. MERLI, Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale. Il caso italiano 1880-1900, vol. II, Documenti, cit., pp. 142-144. 93 Cfr. ERSILIA BRONZINI MAJNO, Relazione sul lavoro delle donne, Milano, Tip. milanese, 1900. La relazione fu presentata al Congresso nazionale di previdenza nel giugno del 1900. Cfr. Dizionario biografico delle donne lombarde, a cura di Rachele Farina, Milano, Baldini & Castoldi, 1995, pp. 223-227. 94 TERESA NOCE, Rivoluzionaria professionale, Milano, La Pietra, 1974, p. 14. 95 SOCIETÀ UMANITARIA, UFFICIO DEL LAVORO, Origini, vicende e conquiste delle organizzazioni operaie aderenti alla Camera del Lavoro in Milano, Milano, Tip. milanese, 1909, pp. 300-301, citato in S. ORTAGGI CAMMAROSANO, Condizione femminile e industrializzazione tra Otto e Novecento cit., pp. 109-172: 150. 96 Le ‘piccinine’ ottennero un minimo di paga di 50 centesimi, dieci ore di lavoro ed un’ora di intervallo per il pranzo, la retribuzione del lavoro domenicale e la riduzione del peso dello scatolone. Cfr. F. IMPRENTI, Operaie e socialismo cit., p. 181. 97 Ivi, p. 182. 92 30 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale In quegli anni, però, le sarte avevano ormai compreso la necessità di organizzarsi e il vantaggio dell’associarsi: a Bologna nel 1910 si costituiva la Federazione lavoranti sartorie per signora e Albertina Gasperini, sua segretaria, così rievoca lo sciopero che portò poi alla sua fondazione: Non posso dimenticare quell’ottobre del 1909 quando organizzai, con l’aiuto di Argentina Altobelli, il primo sciopero delle sartine bolognesi che fu totale e che durò 15 giorni. […]. Alla fine le nostre proposte furono accolte e i salari aumentarono del 50% e fu anche stabilito che non si poteva più fare il licenziamento in tronco. L’accordo fu firmato […] per le lavoratrici [da] Argentina Altobelli e per i padroni [da] Policardi e Collina per la sartoria Baroni. L’8 marzo 1910, per la festa della donna, inaugurammo la bandiera della Lega delle sartine e facemmo una festa da ballo al teatro Verdi che durò tutta la notte.98 Sempre a Bologna nel marzo del 1919 si riunivano le oltre sessanta organizzazioni (Leghe di sarte e sarti, modiste, cravattaie, bretellaie, bustaie, ecc.) che costituivano la Federazione nazionale addetti all’industria dell’abbigliamento e vestiario.99 I numerosi scioperi delle sarte che si susseguirono in quegli anni nelle maggiori città italiane rimangono a testimonianza della loro combattività, della loro carica rivendicativa. Le operaie Al compimento del processo di unificazione nazionale si realizzava anche in Italia una trasformazione produttiva che portava in pochi decenni il paese nel novero degli stati industrializzati. Nelle regioni settentrionali il lavoro a domicilio veniva sostituito dalla grande produzione in serie: la fabbrica attirava allora fuori dalle mura domestiche, e spesso anche lontano dai paesi di origine, migliaia di donne. Nell’inchiesta voluta dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio sullo stato degli opifici italiani nel 1880 veniva, infatti, rilevato «un fatto notabile: vale a dire la grande prevalenza che ha nell’industria italiana il lavoro delle donne e dei fanciulli. Sopra 382.131 operai, solo 103.562 cioè il 27,10% sono uomini adulti; 188.486 (49,32%) sono donne; 90.083 (23,58%) sono fanciulli dell’uno e dell’altro sesso», intendendo per fanciulli i ragazzi di meno di 14 anni.100 A Bologna, secondo quanto riferito da Aristide Ravà nella Relazione della Giunta di statistica riguardante il lavoro negli stabilimenti industriali elaborata negli anni Settanta dell’Ottocento, vi erano 118 stabilimenti industriali in cui erano impiegati 4.334 operai (1.276 donne e 432 ragazzi di ambo i sessi, di età non inferiore ai 10 anni). Di questi, 1.300 risultavano concentrati in due stabilimenti: 925 nella Manifattura tabacchi (con la presenza di 720 donne) e 316 nell’Arsenale militare di artiglieria (con 119 donne). Le ore di lavoro erano in media di 10-12, con punte di 15 nei molini, nelle cartiere, nei brillatoi, nei panifici. Il salario maschile variava dalle L. 1 98 Testimonianza di Albertina Gasperini, nata a Bologna nel 1887, in LUCIANO BERGONZINI, LUIGI ARBIZZANI, La Resistenza a Bologna. Testimonianze e documenti, vol. II, La stampa periodica clandestina, Bologna, Istituto per la storia di Bologna, 1969, pp. 134-135: 134. 99 I. VACCARI, La donna nel ventennio fascista cit., p. 55. 100 VITTORIO ELLENA, La statistica di alcune industrie italiane, Roma, Tip. eredi Botta, 1880, pp. 29-31, citato in S. ORTAGGI CAMMAROSANO, Condizione femminile e industrializzazione tra Otto e Novecento cit., pp. 109-172. Tra due secoli Operaie in posa in uno stabilimento per la lavorazione del truciolo a Carpi, ca. 1910-1913, Fotomuseo Giuseppe Panini, Modena Sala confezione tortellini della ditta Bertagni di Bologna, «L’Illustrazione italiana», 1909, Istituto storico Parri Emilia-Romagna, Bologna 31 32 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale alle L. 3,50 al giorno, quello femminile da 75 centesimi a L. 1,50, quello dei ragazzi da 25 a 50 centesimi.101 La manodopera femminile veniva impiegata in gran numero nell’industria meccanica, chimica ed estrattiva, in settori più tradizionali come l’abbigliamento e l’alimentare, ma la prevalenza delle donne era assoluta nell’industria tessile. Era una presenza pressoché esclusiva nella produzione della seta grezza dove l’intervento delle macchine era minimo e il ruolo femminile decisivo perché: «le nostre donne hanno occhio buono e dita agili […] e, poverette, si accontentano di salari i quali eccedono di poco la metà di quelli che si danno in Francia».102 Era poi una presenza nettamente in aumento nell’industria del cotone, dove invece la tecnologia era avanzata e i telai meccanici consentivano la diminuzione dello sforzo muscolare, portando gli imprenditori a sostituire gli uomini con le donne per «far risparmio di salari».103 L’organizzazione del lavoro, in questi luoghi, era centrata quasi esclusivamente sull’uso incontrollato della manodopera femminile e su infime retribuzioni – generalmente inferiori del 50% rispetto a quelli maschili, già bassi – per impieghi che portavano a un rapido deperimento fisico e a malattie professionali «contratte per lavoro troppo prolungato in luoghi insalubri».104 In filanda, ad esempio, i bozzoli venivano messi a macerare nell’acqua a 70-75 gradi in bacinelle riscaldate direttamente dal vapore. La filatrice prendeva i bozzoli immergendo le mani nell’acqua bollente, li liberava dalle incrostazioni e, afferrata un’estremità della bava, ne svolgeva il filo e lo avvolgeva sugli aspi dandogli contemporaneamente un certo numero di torsioni. L’abilità del lavoro consisteva nel dare al filo la sottigliezza che lo rendesse lucente senza diminuirne la resistenza. Spesso una stessa persona svolgeva tutte queste operazioni, aiutata da una bambina (chiamata ‘sbattitrice’) che poteva fare girare la ruota che muoveva gli aspi o afferrare i bozzoli che erano nell’acqua bollente, individuare l’estremità del filo e porgerlo poi alla filatrice. Ero alta quattro dita, non arrivavo nemmeno alle macchine – racconta Anna Giorgis, entrata in filanda a dodici anni – il mio era il lavoro dla sbatosa [della sbattitrice]. Il primo giorno, al mattino, ho osservato. Nel pomeriggio toglievo già i cuchet [bozzoli] mi sono bruciata le mani nell’acqua bollente. Dopo cinque o sei giorni avevo già le mani pelate […] tutte le mani che sanguinavano. La pelle era a brandelli, le dita e i palmi delle mani bruciati […]. Sanguinavano e come le mani... Alla sera quando tornavo a casa non sapevo più dove tenerle le mani. Al mattino quando mi lavavo nell’acqua fredda, dolori che davano al cuore neh…105 Insieme alle donne, dunque, lavoravano nelle filande moltissime bambine – generalmente tra gli otto e i dieci anni – che condividevano i mali prodotti dal tipo di lavo101 MUNICIPIO DI BOLOGNA, Relazione della Giunta di Statistica riguardante il lavoro negli Stabilimenti industriali considerato sotto il rapporto della salute degli operai, a norma delle richieste contenute nella circolare della R. Prefettura di Bologna, in data 16 ottobre 1872, n. 41, Bologna, [1873], in ASBo, Camera di Commercio (1863-1927), «Relazioni fra industriali e operai», fasc. 3/2. 102 Ivi, p. 43. 103 Ivi, p. 33. 104 RODOLFO MORANDI, Storia della grande industria in Italia, Torino, Einaudi, 1977, p. 124. 105 Testimonianza di Anna Giorgis, nata a Peveragno (Cuneo) nel 1916, in NUTO REVELLI, L’anello forte. La donna: storie di vita contadina, Torino, Einaudi, 1983, p. 140. Tra due secoli 33 ro e le lunghe giornate di sfruttamento, 14-15 ore a fine Ottocento, scese a 11 a inizio Novecento, però con ritmi produttivi molto più intensi. Questa, comunque, era una situazione largamente generalizzata poiché tutte le addette all’industria tessile ottenevano a fronte di «orari estenuanti», «infime mercedi».106 La pratica di servirsi di bambine era estesa anche nei cotonifici dove, dopo un breve apprendistato, venivano messe a lavorare al telaio: «Ma ero piccola, non ci arrivavo – racconta Anna Anselmo – mi mettevo con la pancia sopra al rotolo per passare i fili, facevo una vita!». Per facilitarla nelle manovre le costruirono persino una predella di legno: «Io salivo e, ah! Ero come un re, diventavo grande come loro… allora lo facevo andare, non era mai fermo il mio telaio».107 Anche nei cotonifici le donne subivano ore di impiego massacranti, spesso senza alcuna interruzione o con pochissimo tempo per mangiare e riposarsi, alle quali andavano aggiunte quelle per il lavoro straordinario, notturno e festivo, «le infinite eccezioni e violazioni dovute alle cosiddette ragioni produttive o al capriccio padronale»,108 nonché le ore di marcia a piedi per tornare a casa o per recarsi in fabbrica, l’obbligo generalizzato alla pulizia dei locali, l’intensificazione dei ritmi produttivi e dei carichi di fatica a seguito della meccanizzazione, per cui spesso le donne erano costrette a seguire il lavoro su due telai. Nei riguardi delle operaie, poi, il rigore era massimo e gli ordinamenti di fabbrica prevedevano multe, ammonizioni, castighi e licenziamenti in caso di cattivo lavoro, disobbedienza ai superiori, spostamento dalle macchine senza permesso, ritardo di qualche minuto all’entrata, assenza ingiustificata (nella quale era compresa anche l’astensione per aver partecipato al funerale di un congiunto o di una compagna di lavoro), schiamazzi (era proibito parlare, cantare, genericamente «far rumore»), pause troppo lunghe anche per i bisogni fisiologici.109 Si trattava di un regime di fabbrica durissimo, in cui alla rigidità dei regolamenti si aggiungeva spesso l’arbitrio dei capireparto, che si realizzava in ambienti di lavoro malsani e pericolosi. Nelle fabbriche dove si lavora il cotone, non esiste, per così dire, ventilazione: porte e finestre devono restare ermeticamente chiuse anche durante i grandi calori dell’estate perché la minima corrente d’aria solleverebbe in vortici il minuto e fitto pulviscolo che riempie l’ambiente. Con tutto ciò l’aria ne è satura, esso penetra, deleterio, ad ogni respiro nei polmoni, predestinando una percentuale fortissima di operaie a vittime della tisi, il terribile flagello del proletariato.110 La situazione igienico-sanitaria era talmente precaria che, in una inchiesta nazionale del 1877 sulle condizioni degli operai nelle fabbriche, risultavano insalubri non solo i cotonifici ma anche le fabbriche di fiammiferi, le cartiere, le concerie di pelli, gli stabilimenti dove si lavorano stracci, le tintorie, le filande, i lanifici, «praticamente quasi tutte le industrie presso le quali allora si fece l’inchiesta».111 Né migliori furono i risul106 R. MORANDI, Storia della grande industria in Italia cit. p. 122. Testimonianza di Anna Anselmo, nata a Montanaro (Torino) nel 1898, in BIANCA GUIDETTI SERRA, Compagne. Testimonianze di partecipazione politica femminile, vol. I, Torino, Einaudi, 1977, pp. 60-61. 108 S. MERLI, Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale cit., p. 200. 109 Ivi, pp. 157-158. 110 MARGHERITA SARFATTI, Le donne che lavorano. Le operaie cotoniere, «La donna socialista», 23 marzo 1906. 111 S. MERLI, Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale cit., p. 187. 107 34 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale tati relativi ai servizi igienici o ai locali dove si permetteva alle donne di mangiare e di allattare i propri figli (il tempo concesso per l’allattamento nei locali delle fabbriche era di venti minuti ed esso non era conteggiato tra le ore di lavoro). Ancora nel 1905 le condizioni non erano sostanzialmente migliorate se «La donna socialista», tratteggiando il «danno fisiologico che viene alla razza umana dalle fatiche eccessive a cui è assoggettata la donna che passa la giornata nelle officine e nei laboratori», poteva fare un lungo elenco di malattie professionali – risultato di varie inchieste ministeriali compiute in quel periodo a tale proposito – a cui erano pericolosamente soggette le lavoratrici, in particolar modo tubercolosi e deformazione degli arti.112 Negli stabilimenti industriali erano molto frequenti anche gli infortuni; questi si concentravano soprattutto nelle ore notturne, alla fine del lavoro giornaliero e negli ultimi giorni della settimana, a dimostrazione di come la stanchezza e il logoramento fisico ne fossero la causa, alla pari delle macchine che senza alcuna protezione mangiavano «mani, dita e braccia».113 Da questo punto di vista la questione risultava veramente drammatica: tra il 1879 e il 1881, in soli tre anni, 2.091 erano state le morti causate da incidenti. Peraltro nel corso degli anni Ottanta circa un terzo degli scioperi proclamati mirava al miglioramento delle condizioni produttive, poiché l’impiego di nuovi congegni meccanici, l’affollamento, la giovane età delle operaie, i lunghi orari di lavoro rendevano inevitabile il ripetersi di infortuni spesso gravi,114 come quelli accaduti, ad esempio, nel 1895 e ancora nel 1900 al laboratorio pirotecnico e all’arsenale, stabilimenti di Bologna,115 o quello successo nel 1906 a Padova «nella fabbrica di retine per incandescenza Aner» dove [...] verso le 71/2, quando le ragazze addette stavano per abbandonare il lavoro, improvvisamente scoppiava una vasca capace di 25 litri di collodio, e ripiena di codesta infiammabilissima materia. Allo scoppio fragoroso seguì l’incendio. Parecchie ragazze che erano nel laboratorio furono investite dalle fiamme riportando gravissime ustioni alla faccia, al petto, alle braccia, alle gambe. Cinque di esse vennero ricoverate all’ospedale e tre versano in pietose condizioni tanto che si teme per la loro vita.116 Se le macchine avevano trasformato le condizioni di lavoro inserendo migliaia di lavoratrici nel mercato produttivo, esse non avevano inciso altrettanto profondamente sulla qualità della vita delle donne. L’occupazione femminile si configurava come subalterna e precaria, una dura necessità economica a cui sfuggire appena possibile, di solito dopo il matrimonio o la maternità. Sul finire del secolo però anche fra le operaie cominciarono ad agitarsi fermenti nuovi e sempre più frequenti furono gli episodi di lotte sindacali con al centro le donne che rivendicavano la parità salariale, la tutela della maternità e il miglioramento delle condizioni di lavoro. 112 Le donne che lavorano. Fatiche e compensi, «La donna socialista», 14 ottobre 1905. Su questi temi cfr. Salute e classi lavoratrici in Italia dall’Unità al fascismo cit. 113 S. MERLI, Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale cit., p. 212. 114 ADA LONNI, Fatalità o responsabilità? Le «jatture» degli infortuni sul lavoro: la legge del 1898, in Salute e classi lavoratrici in Italia dall’Unità al fascismo cit., pp. 738-739. 115 Relazione di Pubblica Sicurezza, Bologna, 18 maggio 1895, in ASBo, Gabinetto di Prefettura, serie 911, 1895; Relazione della Questura, Bologna, 21 dicembre1900, in ASBo, Questura, Archivio generale, n. 556; Relazione dell’ospedale Maggiore, Bologna, 18 maggio 1900, in ASBo, Questura, Archivio generale, n. 556. 116 Le donne che lavorano. Le vittime di Padova, «La donna socialista», 3 marzo 1906. Tra due secoli 35 I lavori di cura Le balie Nell’epoca considerata: [...] il corpo delle donne valeva non solo come forza-lavoro e macchina di riproduzione ma poteva produrre valore esso stesso; in tutte le regioni della penisola, l’allattamento costituiva una delle funzioni economiche più importanti della donna, sia direttamente, come possibilità di far gravare il meno possibile i nuovi nati sul bilancio alimentare della famiglia, sia indirettamente, come fonte di entrate in denaro per i bambini presi a balia.117 Le origini di tale mestiere sono rintracciabili nel ‘baliatico assistenziale’ che si sviluppò all’interno delle strutture caritative per l’infanzia, fin dalla fondazione degli ospedali stessi.118 Il baliatico, cioè l’allattamento dei neonati abbandonati, poteva essere interno o esterno all’ospizio. Nel primo caso la nutrice risiedeva all’interno dell’ospedale, nel secondo caso l’infante era affidato «a balia di fuori», cioè ad una donna che, per mestiere o anche ‘per voto’, lo allattava e lo allevava in casa propria riconsegnandolo al compimento dell’età prescritta dal regolamento della struttura sanitaria. Disposizioni assai differenti regolavano il baliatico nelle diverse regioni italiane e nei diversi periodi. Un dato era, comunque, ovunque costante: le possibilità di sopravvivenza erano più alte per i bambini affidati a baliatico esterno rispetto a quelli allevati all’interno dell’istituto.119 Le cause dell’alto indice di mortalità potevano essere le più varie – cattive condizioni igieniche, locali inadatti, carenza di cure – ma di certo incidevano in maniera rilevante la scarsezza di cibo e la sua inadeguatezza a soddisfare le esigenze delle nutrici, come rilevato da Matilde Serao in un suo articolo, apparso su «Il mattino» di Napoli il 27 maggio 1897, nel quale la scrittrice, attenta indagatrice sociale, affrontava il fenomeno dell’infanzia abbandonata analizzando la situazione nell’ospizio dell’Annunziata della città partenopea. Le nutrici avevano fame, sempre: anzi tutto perché i loro due, i loro tre, i loro quattro poppanti, succhiavano il loro sangue e i midolla [sic], non trovando più latte nel petto: e poi erano cibate scarsamente e malamente, con molti legumi, con molte verdure, legumi di bassa qualità, verdure inferiori, vinello acido, quando vi era il vinello. Queste donne entrate là dentro diventavano pallide, smorte, smarriti tutti i colori della salute dimagravano sempre, diventavano deboli e fiacche; molte non resistevano oltre il quarto, il quinto mese […] queste nutrici diventavano irascibili e nervose, si ammalavano spesso, il latte si inacidiva e dalla loro fame, quella dei poppanti si mutava in delirio di fame e indi di morte.120 117 LUCETTA SCARAFFIA, Essere uomo, essere donna, in Storia sociale delle donne nell’Italia contemporanea, a cura di Anna Bravo, Margherita Pelaja, Alessandra Pescarolo, Lucetta Scaraffia, RomaBari, Laterza, 2001, pp. 3-76: 17. 118 Il compito di ricevere «gli infanti esposti» nel territorio bolognese venne attribuito all’ospedale di via D’Azeglio, detto di San Procolo, fin dal XII secolo. Cfr. UMBERTO FERRI, L’ospizio Esposti e l’Asilo di maternità in Bologna. Cenni storici, funzione e ordinamento, Bologna, Stab. poligrafici riuniti, 1933; I bastardini. Patrimonio e memoria di un ospedale bolognese, Bologna, Edizioni A.G.E, 1990. 119 GIOVANNA DA MOLIN, Introduzione, in Trovatelli e balie in Italia, Atti del convegno Infanzia abbandonata e baliatico in Italia secc. XVI-XIX, a cura di G. Da Molin, Bari, Cacucci, 1994, pp. 7-8. 120 MATILDE SERAO, Figli della Madonna, «Il mattino» di Napoli, 27 maggio 1897, citato in WANDA DE NUNZIO SCHILARDI, L’infanzia abbandonata nel romanzo sociale dell’Ottocento (Ranieri, Mastriani, Serao), in Trovatelli e balie in Italia cit., pp. 527-552: 547. 36 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale FOTO CHOMON, Balie e bambini dell’asilo per i lattanti fondato a Bologna nel 1881, fine Ottocento, Biblioteca Reale, Torino Anche se questa fosca descrizione delle condizioni di vita delle balie interne di certo non corrispondeva a tutte le realtà assistenziali dell’epoca, era comunque possibile che non se ne discostasse di molto, soprattutto nel caso in cui l’organizzazione degli ospizi fosse economicamente debole. Avere un numero di nutrici adeguato all’interno della struttura era una necessità: i bambini che venivano abbandonati, nella quasi totalità, erano nati da pochi giorni e avevano l’esigenza di essere immediatamente allattati al momento dell’arrivo ma ciò concorreva ad aumentare l’impegno finanziario a cui però gli amministratori spesso non riuscivano a far fronte.121 Dall’attività così concepita, prendeva corpo un ‘baliatico privato’ – praticato dalle famiglie aristocratiche e borghesi nel corso dell’Ottocento – che, a sua volta, veniva esercitato in due modi: affidando il neonato ad una balia di campagna che lo allevava a casa propria e lo restituiva ai genitori quando lo svezzamento era stato completato oppure ospitando la nutrice nella propria casa, in modo da controllare rigidamente il processo di allevamento e di educazione del bambino. Questi comportamenti delle classi agiate furono negativamente commentati e, a volte, ferocemente contestati dai contemporanei: si giunse a dire che i bambini erano considerati dalle madri dell’alta borghesia un incomodo rispetto agli impegni sociali e mondani. Giudizi sfavorevoli, largamente condivisi, che costituirono anche i punti di forza della propaganda in favore dell’allattamento materno: numerosi manuali ed opuscoli del tempo veicolarono, infatti, la diffusione di quello che divenne un principio medico insindacabile. Un esempio su tutti: nel testo qui esposto, innanzitutto, veniva121 La mancanza di fonti dirette e studi sulle condizioni di vita e di lavoro delle balie interne nel periodo considerato non permette di precisare meglio la loro situazione lavorativa. Tra due secoli 37 no elencati dettagliatamente i vantaggi che dall’allattamento materno potevano derivare al bambino e alla stessa madre che allattava: L’opera di protezione della prima infanzia, cui attendono in ogni paese e medici e filantropi, si esplica innanzi tutto col favorire l’allattamento materno. Quale metodo infatti può con questo gareggiare sia dal lato fisiologico che morale e umano? Il latte materno è il vero alimento che meglio si confaccia ai progressivi bisogni del bambino, e l’affetto e le cure di una madre non vi è mezzo o denaro che possa sostituirle.122 E ancora: «Si vede subito come sia sempre da preferirsi e da raccomandarsi quel sistema che non allontana il piccino dalla propria madre, essendo ormai un fatto acquisito che il valore speciale, anche di uno scarso quantitativo di latte materno, e le cure materne costituiscono una tal somma di beneficio da sorpassare i vantaggi offerti da opulenti nutrici mercenarie».123 Si passava poi a giustificare l’assunzione di una balia solo nei casi di inabilità fisica: «vuole infatti il regolamento che a fruire dell’aiuto del baliatico siano ammesse soltanto quelle donne che per malattia o difetto fisico sono incapaci assolutamente ad allattare»124 e «d’altra parte è unanime giudizio di pediatri e ginecologi che ben poche sono le madri che non possono assolutamente allattare: siano in rapporto collo stato delle mammelle o della salute in generale le cause per cui l’allattamento materno è sconsigliabile o impossibile, si riducono ad un numero così esiguo da turbare e confondere i facili fautori dell’allattamento mercenario».125 Infine, si terminava con il motto «a ciascun bambino la propria mamma».126 Nonostante le aspre critiche e i severi moniti, il fenomeno del ‘baliatico mercenario’ aumentò in misura considerevole dando luogo a un vero e proprio ‘esodo’ che interessò una parte consistente della popolazione femminile italiana: migliaia di giovani puerpere127 – in gran parte appartenenti alla classe bracciantile, spinte dunque dal bisogno e dalla miseria – per recarsi a nutrire i neonati delle famiglie borghesi lasciavano i propri figli di pochi mesi, privandoli di un bene prezioso ed esponendoli al rischio di malattie, talvolta mortali. La partenza, spesso subita con rassegnazione, si inseriva nell’ambito di precise strategie economiche che tendevano a garantire la sopravvivenza della famiglia. Era un esercito silenzioso, che sfuggiva a controlli e statistiche, non beneficiava di nessuna garanzia sul piano contrattuale e, una volta entrato nell’intimità delle famiglie borghesi, cadeva nel silenzio e nell’oblio. Accanto alla schiera di domestiche, cuoche, guardarobiere, le balie andavano a far parte di quello che è stato definito «l’invisibile quotidiano».128 Fare la balia non comportava solamente l’impatto, spesso traumatico, con la grande città e con i problemi di inserimento nella famiglia ospitante – l’assunzione di un codice linguistico (l’italiano) di cui raramente la balia aveva competenza, la necessità di adeguarsi a comportamenti e a tempi inusuali, l’accettazione di norme spesso in contrasto con le consuetudini del proprio luogo di provenienza – ma anche e soprattutto la 122 PAOLO GALLI, L’aiuto materno, Faenza. Tip. G. Montanari, 1907, p. 6. Ivi, p. 8. 124 Ivi, p. 5. 125 Ivi, p. 7. 126 Ivi, p. 8. 127 Impossibile dare una rigorosa definizione quantitativa del fenomeno per l’assenza di dati dovuti ad accertamenti ufficiali. 128 DANIELA PERCO, Balie da latte. Note e testimonianze su alcune esperienze di lavoro, in Balie da latte. Una forma peculiare di emigrazione temporanea, a cura di D. Perco, Feltre, 1984, pp. 15-50: 15. 123 38 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale disgregazione del nucleo famigliare perché l’assenza influenzava, talora in modo duraturo e quasi inevitabilmente, i rapporti affettivi. Le donne, infatti, rimanevano lontane da casa almeno dai sette ai 18 mesi (ma la loro attività poteva protrarsi nel tempo come balia asciutta anche per diversi anni, talvolta presso la medesima famiglia) lasciando i figli neonati da parenti o vicini che venivano compensati in genere con un terzo del proprio salario. Difficilmente venivano stipulati contratti di lavoro regolari, gli accordi erano quasi sempre verbali, e la garanzia era data dall’enorme differenza sociale dei due contraenti. Il viaggio era generalmente pagato dai padroni. L’attività era considerata privilegiata, dal punto di vista salariale, rispetto ad altri mestieri ma le retribuzioni variavano sensibilmente sia in relazione alle famiglie sia alle città in cui le balie si trovavano a lavorare: negli anni Venti potevano raggiungere le 100 lire mensili. Almeno dalla metà del 1918 il collocamento delle balie cominciò a realizzarsi, quasi esclusivamente, attraverso la mediazione di specifiche agenzie. La regolamentazione sanitaria, resa esecutiva proprio in quel periodo, ne prevedeva l’istituzione, o comunque la legalizzazione di quelle già esistenti, da parte dei Prefetti provinciali. Nel gennaio del 1919, poi, un ulteriore decreto obbligava le agenzie a tenere un registro con l’elenco delle donne, residenti nel Comune, autorizzate ad esercitare il baliatico e a comunicare all’ufficiale sanitario comunale i dati anagrafici delle balie iscritte e di quelle collocate. L’ufficio di Enrico Conte, pubblicizzato su «L’illustrazione italiana» fin dal 1911, fungeva da collettore dell’intera zona di Feltre e ne aveva assorbito per lungo periodo le molte potenzialità di lavoro: un flusso consistente di balie provenienti dal bellunese, infatti, affluirono soprattutto nelle città di pianura tra cui Bologna e in certa misura anche Forlì, Parma e Piacenza.129 Dopo aver regolarizzato la sua posizione nella primavera del 1919,130 Conte continuò a svolgere la sua attività, raccogliendo e schedando le richieste di personale che venivano inoltrate dalle famiglie, residenti per lo più nelle città dell’area padana. L’intermediario poi contattava le aspiranti balie, spesso in stato di avanzata gravidanza, che lasciavano una loro fotografia in base alla quale avveniva la scelta da parte dagli eventuali padroni. Il compenso per l’agenzia – che garantiva non solo il perfetto stato di salute ma anche l’ineccepibile moralità della donna – veniva patuito sulla parola e fissato nell’entità di una mezza mensilità percepita dalla balia. Prima del varo legislativo, invece, le famiglie che avevano bisogno di una nutrice si recavano direttamente dalle aspiranti o utilizzavano intermediari: chiedevano a un fiduciario locale (Sindaco, prete, medico, levatrice) garanzie sulla correttezza morale delle donne e inviavano, o facevano trovare al loro arrivo in famiglia, un medico per verificare la qualità del latte e lo stato di salute. La visita medica diventò obbligatoria all’inizio del Novecento come conseguenza della massiccia campagna promossa dal governo per debellare le malattie veneree. Il manifestarsi di casi di sifilide all’interno di alcuni brefotrofi aveva indotto i medici del tempo a prendere in considerazione tra i «canali di contagio accidentale» anche il ‘baliatico mercenario’. Di qui l’attenzione dei legislatori per il fenomeno, attenzione che portava progressivamente alla sua regolamentazione dal punto di vista sanitario. 129 FRANCA MODESTI, Emigrazione femminile e baliatico nella provincia di Belluno tra Ottocento e Novecento, in Balie da latte. Una forma peculiare di emigrazione temporanea cit., pp. 7-13: 9. 130 Lettera del Sottoprefetto al Sindaco di Feltre, Feltre, 12 aprile 1919, citata in ANNAMARIA BAGATELLA SENO, Criteri di selezione e canali di assunzione delle balie, in Balie da latte. Una forma peculiare di emigrazione temporanea cit., pp. 51-65: 58. Tra due secoli 39 Nel decreto, varato il 4 agosto 1918, per la «tutela igienica del baliatico», esso veniva subordinato a «speciale autorizzazione da rilasciarsi dal Sindaco, alle donne di buona condotta, riconosciute fisicamente idonee in seguito a visita medica».131 Durante il controllo medico, oltre ad effettuare tutti gli esami clinici per accertare che le balie fossero immuni da malattie affettive trasmissibili, veniva ricostruita, attraverso un colloquio con la paziente, l’anamnesi della stessa al fine di accertare anche l’assenza di patologie ereditarie. Il medico, considerato l’esito delle analisi, sottoscriveva poi un certificato di sana e robusta costituzione di cui il Sindaco si serviva per rilasciare alla balia richiedente l’autorizzazione, completa di dati anagrafici, connotati e fotografia. Le levatrici Quello della levatrice era un tradizionale mestiere femminile, frutto di una cultura secolare, dell’esperienza diretta di donne, basato sulla conoscenza del corpo secondo convinzioni empiriche, ascientifiche ma riconosciuto socialmente. Poiché aiutava a dare la vita, nella civiltà contadina, la levatrice godeva di grande autorità e prestigio: «depositaria dei segreti delle donne e delle famiglie, testimone della nascita di ogni membro della comunità, le veniva spesso accordato il ruolo di accompagnare i bambini al fonte battesimale, ma anche di presiedere alla spartizione delle eredità o a dirimere piccole controversie fra le famiglie».132 Lo Stato unitario, per far fronte soprattutto alla necessità di debellare dannose abitudini legate alla gravidanza (la morte per parto era allora diffusa, come pure la febbre puerperale ed altre patologie legate alle scarse precauzioni igieniche) decideva di istituzionalizzare la figura della levatrice, medicalizzando il parto e subordinando il tradizionale sapere femminile a quello medico-scientifico, in rapida ascesa nella seconda metà dell’Ottocento. Di qui la trasformazione di una antica prerogativa delle donne in una vera e propria professione rigidamente codificata. Vari interventi legislativi, dunque, nel corso del tempo cercarono di definire le competenze della levatrice e disciplinare l’esercizio della sua attività; questi riguardarono sostanzialmente la strutturazione di un corso di studi per conseguire il diploma, la lotta alla febbre puerperale, l’istituzione e la regolamentazione delle condotte ostetriche, infine il tentativo di limitare il massiccio ricorso popolare alle cosiddette ‘levatrici abusive’. Il primo decreto in grado di intervenire in maniera esauriente sulla materia fu quello riguardante la sanità pubblica, varato nel 1865 e seguito da due regolamenti applicativi – il primo del 1874, il secondo del 1876 – firmati da Ruggero Bonghi, allora ministro della Pubblica Istruzione. In particolare con il secondo provvedimento veniva stabilito che le scuole di ostetricia dipendessero direttamente dalle cliniche universitarie e prevedessero corsi teorico-pratici di durata triennale ai quali potevano accedere solo allieve di età comprese tra i 18 e i 36 anni che avessero frequentato la terza elementare, purché in possesso di un certificato di buona condotta e dell’assenso del padre se nubili e del marito se coniugate.133 131 Tutela igienica del baliatico, Milano, Soc. ed. Portafoglio, 1918 (Collezione legislativa «Portafoglio», n. 2351). 132 CLAUDIA PANCINO, Il bambino e l’acqua sporca. Storia dell’assistenza al parto dalle mammane alle ostetriche (secoli XVI-XIX), Milano, Angeli, 1984, p. 228. 133 Cfr. ALESSANDRA GISSI, Le segrete manovre delle donne. Levatrici in Italia dall’Unità al fascismo, Roma, Biblink editore, 2006, p. 22. 40 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale Una Scuola di ostetricia era presente anche nell’Ateneo bolognese.134 Di certo, l’ammissione a tali corsi costituiva, oltre a una sicura opportunità professionale per il futuro, motivo di orgoglio personale se Dora Persiani in Cosci scriveva al Prefetto, nel novembre 1896, allegando il proprio biglietto da visita con impressa la dicitura «allieva levatrice nella Regia Università di Bologna».135 Sempre con il regolamento del 1876, si cercava di sostituire, in modo graduale, le cosiddette ‘irregolari’ con ostetriche depositarie e portatrici di saperi scientifici. La disposizione transitoria n. 43, infatti, permetteva alle donne che già esercitavano il mestiere, sprovviste però di regolare abilitazione, di ottenere il diploma sostenendo soltanto un esame pratico, entro tre anni dall’entrata in vigore della legge, termine prorogato fino al 1894. La sanatoria, che faceva fronte ad una situazione oggettiva di bisogno,136 creava di certo una conflittualità fra dimensioni culturali diverse, tra professionalità ispirate a principi talvolta antitetici e dava avvio ad un lungo periodo di polemiche e recriminazioni da parte delle diplomate, durante il quale l’obiettivo di eliminare le ‘irregolari’, nella pratica fallì, se ancora nel 1913 veniva scritto che la loro presenza era «micidiale per le madri e per i neonati, indecorosa e umiliante per noi levatrici».137 La vera e propria medicalizzazione del parto fu sancita e promossa dalla Legge sulla tutela dell’igiene e della sanità, emanata nel dicembre del 1888,138 con la quale venivano istituite le condotte ostetriche obbligando i Comuni a stipendiare una levatrice diplomata, che portasse la propria assistenza a tutte le donne, comprese quelle prive di mezzi e, in questi casi, a titolo gratuito. A tali norme venne aggiunto, nel 1890, il Regolamento speciale con istruzioni per l’esercizio ostetrico delle levatrici dei Comuni del Regno.139 Venne promulgato al fine di specificare le misure sanitarie a cui dovevano attenersi le levatrici – i movimenti da compiere presso le partorienti, le cure igieniche da applicare alla madre e al bambino, gli strumenti ed accessori da avere con sé – e introdusse l’obbligo di chiamare il medico in caso di parti irregolari e di tenere un vero e proprio registro dove annotare, oltre ai dati anagrafici della partoriente, varie informazioni sull’andamento dei parti a cui avevano dato assistenza. 134 A Bologna una vera e propria scuola di ostetricia fu istituita nel 1804 e affidata alla direzione di Maria Dalle Donne, laureata in filosofia e medicina nel 1799. Per maggiori informazioni su tale argomento cfr. OLIMPIA SANLORENZO, Maria Dalle Donne e la Scuola di Ostetricia nel secolo XIX, in La presenza femminile dal XVIII al XX secolo. Ricerche sul rapporto Donna/Cultura Universitaria nell’Ateneo bolognese, Bologna, Clueb, 1988, pp. 147-158. 135 ASBo, Gabinetto di Prefettura, serie 931, 1896, cat. 14, fasc. 1, prot. n. 2636. La donna richiedeva l’intervento delle autorità per ricercare il marito Igino, ufficiale del I reggimento Cacciatori d’Africa, scomparso a Massaua, «e se ancora vivo farlo obbligare per l’alimento dei figli e della povera madre». Le indagini disposte dal Ministero degli Esteri non diedero esito positivo. In ogni caso, la Persiani completò, con successo, gli studi, risultando nell’elenco delle levatrici esercenti e residenti a Bologna nel 1901 e pubblicato nel locale Foglio degli Annunzi Legali della provincia di Bologna n. 80 del 1901. Cfr. il documento in ASBo, Gabinetto di Prefettura, serie 997, 1901, cat. 1, «C.S.P. Carte e telegrammi senza pratica». 136 All’epoca molti Comuni erano ancora privi di assistenza ostetrica ufficiale o spesso la presenza di una unica levatrice si rivelava insufficiente. Una circolare del Consiglio di Stato del 13 febbraio 1890 aveva definito legittimo l’esercizio delle abusive nei Comuni privi di assistenza ostetrica ufficiale o dove si fosse rivelato insufficiente il lavoro di un’unica levatrice. A. GISSI, Le segrete manovre delle donne cit., p. 23. 137 La levatrice condotta sui monti, «Gazzetta italiana per le levatrici», 1913, 18, p. 296. 138 Legge 22 dicembre 1888, n. 5849. 139 Regolamento speciale ed istruzioni per l’esercizio ostetrico delle levatrici nei Comuni del Regno, Roma, Tip. di L. Cecchini, 1890. Tra due secoli 41 L’ambizione di istituzionalizzare e controllare la figura della levatrice passò anche attraverso l’inserimento di norme specifiche nei nuovi Codici. In quello Civile la levatrice aveva l’obbligo di registrare presso l’Ufficiale di Stato la nascita di vivi o morti, in assenza del padre o di un procuratore. Il Codice Penale del 1888, invece, puniva la procurata morte, l’occultamento e la sostituzione d’infante, il procurato aborto, e regolamentava il dovere della levatrice di fornire, nel caso in cui vi fosse una richiesta dell’autorità giudiziaria, chiarimenti ed informazioni circa diagnosi di gravidanza, di parto avvenuto, di età e situazioni di neonati abbandonati. Intanto, il numero delle levatrici in Italia continuava a crescere in maniera costante e graduale: se nel 1871 erano 9.432, nel 1901 passarono a 13.886, per arrivare a 15.900 nel 1921.140 Anche i dati regionali confermavano questa tendenza: oltre 900 ostetriche registrare nel censimento «Bollettino delle levatrici. Periodico mensile del 1901, 1.112 in quello del 1911 e illustrato fondato e diretto dal dott. cav. Muzio 1.287 nella rilevazione del 1921. Pazzi, ostetrico primario degli ospedali di Bologna» a. I, n. 1, 30 gennaio 1898, Biblioteca Comunale Nel 1901 delle 360 levatrici che dell’Archiginnasio, Bologna risultavano censite nei ducati emiliani, 118 esercitavano a Bologna,141 e un servizio ostetrico era previsto dalla maggior parte dei Comuni della provincia. La situazione era sicuramente fra le migliori del paese «se si pensa che c’erano regioni in cui un solo Comune su dieci aveva una levatrice abilitata e a livello nazionale i Comuni in regola non rappresentavano nemmeno il 50% del totale».142 Il numero delle levatrici aumentava anche se le loro condizioni di vita e di lavoro non erano, di certo, facili: all’epoca, lo stipendio annuo era veramente esiguo, soprattutto se equiparato ai gravosi compiti nei confronti delle comunità ed alle responsabi140 A. GISSI, Le segrete manovre delle donne cit., p. 36. Dieci di esse erano autorizzate a tenere «pensioni di partorienti» come disposto dalla legge sanitaria del 22 dicembre 1898. Si trattava di una pratica, consolidatasi nei secoli, a tutela delle «gravide illegittime». Regolarizzando l’esistenza di questi ‘pensionati’, lo Stato li sottoponeva a registrazioni e a controlli igienici. Cfr. il Foglio degli annunzi legali della provincia di Bologna n. 80, in ASBo, Gabinetto di Prefettura, serie 997, 1901, cat. 1, «C.S.P. Carte e telegrammi senza pratica». 142 C. PANCINO, Le ostetriche lombarde nell’Ottocento, in Donna lombarda 1860-1945 cit., pp. 225-233: 225. 141 42 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale lità civili e penali:143 oscillava dalle 300 alle 500 lire per le ostetriche condotte144 ed era differenziato da Comune a Comune.145 All’inadeguato riconoscimento economico si aggiungeva poi l’instabilità del posto di lavoro – poiché potevano essere rimosse in qualsiasi momento dal loro incarico – l’assenza del diritto alla pensione ed a forme di assicurazione in caso di malattia. A partire dalle inadeguate condizioni di lavoro, sorsero tra le levatrici spinte rivendicazioniste che diedero luogo alle prime forme organizzative. Il 6 febbraio 1888, a Milano, venne, infatti, annunciata la nascita di una associazione denominata Società italiana delle levatrici.146 Sei anni dopo la sua fondazione, in regione le si affiancarono la Società bolognese delle levatrici, presieduta dal dottor Muzio Pazzi,147 e quella emiliana, nella quale figurava lo stesso Pazzi come segretario. Obiettivi dichiarati dei sodalizi emiliani erano il mutuo soccorso e l’aggiornamento scientifico: [...] le levatrici, guidate da persone serie, da medici benemeriti della loro classe, hanno compreso lo spirito della società, l’indirizzo degli studi odierni e formando associazioni e fondando giornali e procurandosi libri utili e guide, facendo riunioni, congressi, istituendo una federazione hanno dimostrato di essere in regola col progresso.148 Certo nacquero dal bisogno e dalla volontà di difendere, garantire e tutelare la professione ma forte fu la spinta a differenziare il nuovo ruolo dell’ostetrica da quello della levatrice tradizionale, sottolineando l’importanza dell’istruzione. Questo però «comportò non solo l’accettazione ma anche la difesa dell’ideologia medica ufficiale, del ruolo voluto dalla classe medica per l’ostetrica, della sua posizione subordinata nella gerarchia delle professioni sanitarie».149 In questo senso è significativo che le levatrici bolognesi si lasciassero organizzare – e che la rivista della loro associazione fosse diretta – da uno dei più famosi medici ostetrici della città. Pazzi fu, infatti, il fondatore del periodico illustrato «Il bollettino delle levatrici» il cui programma era quello di «prestare l’istruzione scientifica alla levatrice volgarizzando le difficili teorie di medici143 Spesso chiamata ad assistere un parto che, dopo la visita non riteneva essere di sua competenza, la levatrice, mandato a chiamare il medico, si trovava poi ad agire da sola perché, o la distanza o il maltempo o la notte, facevano desistere il medico dall’assolvere il suo dovere. L’unica cosa che rimaneva da fare era allora agire con ‘prudenza e scienza’, sperando in un esito felice per non essere incolpata di incuria e incorrere nei rigori della legge. 144 Il Comune di Gaggio Montano, ad esempio, bandì un concorso nel 1898 per un posto di levatrice alla quale sarebbe spettato «uno stipendio di L. 300, più L. 2 ogni parto di donne non povere e centesimi 50 per ogni visita richiesta dalle medesime» («Bollettino delle levatrici», 30 ottobre 1898). Ben diversi gli stipendi delle levatrici che insegnavano nei vari istituti ostetrico-ginecologici: un concorso bandito a Palermo prevedeva un compenso di L. 1.000 «oltre all’alloggio, alla biancheria, al vitto, al lume, ed al fuoco» («Bollettino delle levatrici», 30 giugno 1898). Esse dovevano assistere i neonati e le donne durante la gravidanza, il parto e il puerperio ma soprattutto dirigere le allieve nelle esplorazioni ostetrico-ginecologiche e nell’assistenza ai parti, ma sempre sotto lo stretto controllo del medico. 145 Alla richiesta della Società italiana delle levatrici del 1891 di uniformare gli stipendi e di garantirne uno minimo non venne data risposta alcuna. 146 Cfr. C. PANCINO, Le ostetriche lombarde nell’Ottocento cit., p. 231. 147 Muzio Pazzi, primario di ostetricia e ginecologia e direttore dell’Asilo di maternità a Bologna, fu fortunato autore di una breve Storia scientifico-sociale della levatrice e dei Cento racconti per la levatrice, pubblicati a Bologna, rispettivamente nel 1895 e nel 1898. 148 Rendiconto del 1894 della Società emiliana delle levatrici con sede in Bologna, Milano, Tip. L. Marchi, 1895, p. 5. 149 C. PANCINO, Le ostetriche lombarde cit., p. 231. Tra due secoli 43 ostetrici […] che per il loro arido tecnicismo clinico sembrano quasi inaccessibili per la mente delle levatrici. Il nostro giornale […] sarà corredato di figure illustrative, onde sussidiare la mente delle levatrici con utili impressioni visive».150 Nella rivista, pubblicata a Bologna dal gennaio 1898 al marzo 1899,151 venivano raccontati i casi più interessanti della pratica ostetrica, comunicate difficoltà e soddisfazioni della professione, analizzate le responsabilità civili e penali che gravavano sull’assistenza prestata e a cui era destinata una rubrica fissa titolata «Giurisprudenza sanitaria». Il comitato di redazione era composto esclusivamente da uomini e uomini erano pure i collaboratori, sia per la parte medica sia per quella giuridica. Il loro atteggiamento, a dir poco ambivalente, oscillava tra un evidente paternalismo, un velato scetticismo per le capacità della categoria e un più raro entusiasmo per il riconoscimento dei loro diritti e delle competenze da loro acquisite. Così infatti si esprimeva Pazzi nell’illustrare il resoconto morale della Società Emiliana delle levatrici nel 1894: Il Comitato direttivo ha diramato una circolare per invitare ad assistere a sette conferenze […] frattanto, per mia modesta iniziativa, si sta organizzando un comitato di conferenzieri, allo scopo di impartire l’istruzione alle levatrici, almeno in tutti i capoluoghi della regione emiliana […] né posso tacervi la cortesia esemplare del prof. Giovanni Calderini, il quale ha concesso a tutte le levatrici di potere usufruire delle lezioni cliniche e pratiche, da lui stesso e da suoi egregi assistenti impartite allo Spedale S. Orsola. Sta ora in voi approfittare tanto delle lezioni clinico-pratiche, quanto delle conferenze per raggiungere meglio quel grado di indipendenza intellettuale e morale di cui avete diritto. Come vedete il Comitato direttivo si è adoperato e si adopera continuamente per il miglioramento della vostra classe.152 Nel frattempo, il 22 maggio 1892, durante il primo congresso nazionale delle levatrici, si era costituita la Federazione nazionale alla quale aderirono le diverse società sorte in tutto il paese. Il «Giornale per le levatrici», pubblicato dalla Guardia Ostetrica di Milano già dal 1886, ne divenne l’organo ufficiale. Si diffuse così la figura della nuova levatrice che si riconosceva nelle leggi dello Stato, operava in nome della scienza, combatteva ignoranza, superstizione e pregiudizio, si faceva portavoce nelle campagne di conoscenze mediche a vantaggio della salute della popolazione. Le infermiere Infermiere è quegli che per professione assiste agli ammalati nell’Ospitale o in case private. Fare l’infermiere non è la stessa cosa come darsi a un mestiere qualunque, a quello del domestico, fattorino, operaio, ecc.; chi si accinge ad assistere gli infermi deve sentire dentro di sé una certa vocazione, deve essere deciso a dedicarsi del tutto a una vera vita di sacrificio. Più ancora che l’uomo, è, per sua natura, adatta all’ufficio d’infermiera la donna.153 150 «Il bollettino delle levatrici», I, 1, 30 gennaio 1898, pp. 4-5. La rivista cessò le pubblicazioni per mancanza di fondi, come dichiarava il suo direttore Muzio Pazzi in La dottoressa Maria Dalle Donne, prima insegnante di ostetricia minore nella Regia Università di Bologna. Discorso commemorativo letto nel Teatro anatomico dell’Archiginnasio il 21 settembre 1909 in occasione del VII Congresso nazionale delle levatrici, Castel S. Pietro dell’Emilia, Tip. A. Conti, 1910, p. 5. 152 Rendiconto del 1894 della Società emiliana delle levatrici con sede in Bologna cit., p. 6. 153 GIOVANNI PUGLIESI, Il manuale dell’infermiere, Venezia, [s.n.], 1915, p. 9. 151 44 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale Così, si esprimeva il dottor Giovanni Pugliesi, già primario dell’ospedale di Lodi e direttore di quello di Venezia, nel suo Il manuale dell’infermiere. Il medico, continuando nella sua trattazione, elencava le qualità essenziali per quella professione sanitaria: dolcezza nelle maniere, passo e mano leggeri, fedeltà e obbedienza, pazienza e dedizione, pulizia, prudenza e discrezione, tratteggiando quelle che all’epoca erano considerate prerogative femminili. Proprio per questa presupposta ‘naturale predisposizione’, minori furono le resistenze da parte dell’opinione pubblica verso l’esercizio di quei lavori che apparivano come un’estensione delle attività di cura e assistenza che, da sempre, le donne svolgevano, non solo in famiglia ma anche all’interno delle comunità, fornendo soccorso in caso di bisogno, di malattia o in momenti significativi quali nascita e morte. Ed è forse questo il motivo che portò a un consolidamento della presenza delle donne nel settore sanitario tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento: un settore in grado di offrire una collocazione lavorativa rispondente alle ‘naturali’ caratteristiche delle donne. Proprio in quel periodo importanti scoperte scientifiche contribuivano a dare un forte e positivo impulso alla medicina portando il campo sanitario e ospedaliero ad una svolta significativa: nascevano e si perfezionavano branche specialistiche, l’ospedale perdeva il tradizionale carattere di ‘ospizio’ per poveri per assumere quello di ‘luogo per la diagnosi e la cura’, aumentavano anche i pazienti, bisognosi di terapie particolari, di trattamenti qualificati. Tutto questo richiedeva l’inserimento sempre maggiore di laici salariati forniti di un alto livello professionale per far fronte alla somministrazione di cure specialistiche. All’epoca, l’assistenza agli ammalati era affidata principalmente a personale religioso, mentre il ruolo delle infermiere laiche si affiancava e si confondeva con quello delle inservienti; questa confusione di funzioni si ritrova anche nella letteratura archivistica dove spesso venivano usati i due concetti e le due denominazioni come sinonimi. In un documento riguardante l’amministrazione ospedaliera di metà Ottocento si riteneva che «potrebbe essere meglio stabilire una sola classe di persone al servizio col titolo di infermiere, anziché farne due, una di infermiere e una di serventi». Solo più tardi si affermava che «le serventi attualmente addette alle infermerie sono di una categoria inferiore alle infermiere». In effetti, quanto veniva ordinato alle inservienti doveva venir eseguito anche dalle operatrici sanitarie, alle quali «servirà per ciò di norma, la stessa istruzione, coll’avvertenza che alle infermiere apparterranno inoltre le operazioni di bassa chirurgia, che non sono di taglio».154 Ad esse era, dunque, richiesto di «riattare i letti, cambiare le lenzuola sudice e i traversi ogni volta che lo credano necessario […], di pulire scrupolosamente gli ambienti […], di sorvegliare che ai malati non vengano rimessi pillole, unguenti e cerotti […], così pure che i malati non consegnino ai parenti i cibi dell’ospedale»,155 oltre che somministrare medicamenti di base e svolgere le normali operazioni relative all’igiene del malato. Mansioni, dunque, di custodia e sorveglianza piuttosto che terapeutiche nel vero senso del termine. Pare ovvio che si dedicassero a questa professione soprattutto donne dei ceti popolari, non solo per gli incarichi svolti ma anche per le pessime condizioni lavorative: in 154 Archivio di Stato di Bergamo, Delegazione provinciale, Beneficenza, XIX secolo, citato in EDOARDO MANZONI, Storia e filosofia dell’assistenza infermieristica, Milano, Masson, 1996, p. 108. 155 Regolamento interno dell’Ospedale degli Infermi, redatto dalla Congregazione di Carità di Cesena nel dicembre 1862, citato in SANDRA MONTALTI, La formazione del personale infermieristico a Cesena tra la fine dell’800 e l’inizio del ’900, in Sanità e società a Cesena 1297-1997, a cura di Stefano Arieti, Giovanni Camaeti, Claudio Riva, Cesena, Il Ponte Vecchio, 1999, pp. 289295: 290. Tra due secoli 45 una inchiesta condotta, su area nazionale, dalla Camera del Lavoro di Parma nel 1897 veniva delineata una situazione «quale ha riscontro in pochi altri settori»: turni di lavoro di 12 ore consecutive (a volta addirittura di 24), spesso senza «diritto al vitto né di un piccolo riposo», per un salario giornaliero che si aggirava attorno a lire 1/1,80, poco più di quanto percepito dalle inservienti, senza possibilità di avanzamenti di carriera (i ruoli di capo-sala o sorvegliante erano di esclusiva competenza del personale religioso), né diritto alla pensione. In molti casi, poi, le infermiere dovevano subire gli arbitrii delle suore che, con un semplice rapporto disciplinare, potevano determinare sospensioni dello stipendio fino a cinque giorni con l’obbligo del servizio.156 Se la bassa retribuzione, poi, risultava essere l’unica risorsa economica di una famiglia, poteva metterne in serie difficoltà le capacità di sussistenza. È il caso, ad esempio, di Caterina Piccinelli, vedova di un postino, costretta a Risultati delle inchieste particolari negli anni 1901 rivolgersi alla Direzione delle poste e 1908, in ANNA CELLI, Per le scuole delle e dei telegrafi per mendicare un infermiere, «Nuova Antologia», 1º ottobre 1908, sussidio. Caterina, addetta in un Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, Bologna ospedale bolognese «ne riceve mercede giornaliera di una lira, vive miseramente […] e collo scarso guadagno deve provvedere al mantenimento suo e di tre figli di tenera età».157 Intanto si faceva strada nell’opinione pubblica la necessità di avere personale infermieristico diversamente preparato, maggiormente qualificato, in numero sufficiente e diventava, dunque, fondamentale superare le tristi arretratezze della condizione lavorativa. Affinché tale riforma potesse concretamente realizzarsi occorreva investire nella formazione professionale. A tale scopo, nel 1890, venne avviata a Cesena una scuola per infermieri.158 Il corso, aperto a uomini e donne, era della durata di quattro mesi ed orga156 S. MERLI, Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale cit., pp. 272-273. Lettera del Prefetto di Bologna al Direttore delle Poste e Telegrafi, Bologna, 19 dicembre 1896, in AsBo, Gabinetto di Questura, serie 229, 1896, cat. 9/B «Informazioni», prot. n. 3130. 158 Vale la pena ricordare che nel periodo esaminato poche erano le scuole esistenti nel Regno: nel 1902 solo 25 ospedali, su un totale di 1.304, avevano istituito un corso per infermieri. S. MONTALTI, La formazione del personale infermieristico a Cesena cit., p. 290. 157 46 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale nizzato in lezioni teorico-pratiche. Tra i requisiti di ammissione: l’ottima condotta civile e morale, saper leggere e scrivere correttamente e, per le donne, essere rigorosamente nubili o vedove (si temeva che le sposate potessero non erogare un servizio di buona qualità).159 Solo nel 1901, venne istituito un nuovo corso destinato però esclusivamente a donne, a testimonianza della progressiva femminilizzazione della professione.160 Lo sforzo di organizzare l’attività professionale delle infermiere in Italia si deve principalmente ad Anna Fraentzel Celli,161 la quale, nel primo decennio del Novecento, svolse diverse inchieste sull’argomento arrivando a delinearne un quadro desolante.162 Da una tabella, pubblicata a corredo di un suo saggio del 1908,163 è possibile estrapolare informazioni preziose sulle condizioni di lavoro negli ospedali emiliano-romagnoli: le donne sostenevano turni di 10-15 ore al giorno, per un compenso – in cui spesso non erano compresi né il vitto né l’alloggio – che variava dalle 40 alle 66 lire al mese; non avevano diritto al riposo settimanale, e nessun beneficio previdenziale. Per emendare quella realtà, Celli riteneva essenziali alcuni presupposti di base, quali: scuola preparatoria tecnico-pratica della durata di almeno sei mesi e obbligo, per l’assunzione, di avere frequentato almeno la quinta classe elementare per incrementare le conoscenze professionali; separazione del lavoro di infermiera da quello di inserviente; indipendenza del personale laico da quello religioso e abolizione dei sorveglianti uomini per favorire possibilità di carriera; abitazione e vitto nell’ospedale, riposo giornaliero, settimanale ed annuale senza diminuzione di stipendio; iscrizione alla Cassa per gli infortuni, per l’invalidità e la vecchiaia; salario anche in caso di malattia per migliorare la situazione lavorativa. A queste condizioni Celli aggiungeva la rinuncia ai vincoli familiari, chiedendo dunque una dedizione assoluta alle donne che intendessero abbracciare questa che, più che una attività lavorativa, assumeva le caratteristiche di una vera e propria missione. Se in altre professioni già aver marito e figli porta seco un aggravio di lavoro per la donna e per conseguenza una diminuzione della sua attività, nella professione di infermiera diventa addirittura un’ironia. Assistere i malati non richiede soltanto tutta la nostra attività, ma tutti i nostri pensieri e tutto il nostro cuore. Può una donna che ha figli, dar tutta la miglior parte di sé ai malati affidati alle sue cure? Può una donna ai suoi doveri di madre unire quelli di una buona infermiera? Non parliamo delle difficoltà materiali. Dopo 12 ore di servizio passato nella corsia degli ammalati, essa torna a casa e deve dedicarsi alla famiglia, sbrigare le faccende di casa. […]. La professione d’infermiera ha bisogno di tutto l’individuo, non può dividerlo colla famiglia, cioè coi doveri della figliolanza!164 Non mancarono le polemiche e le contestazioni intorno a questa sua idea di richiedere per le donne ancora la condizione di nubilato o vedovanza ma, al di là di questo 159 Ivi, pp. 290-292. In Emilia-Romagna, secondo i dati raccolti con i vari censimenti, si poteva notare una lieve prevalenza di personale femminile: nel 1901 870 infermiere contro 801; nel 1911 1.167 e 950; nel 1921 1.576 contro 1.531. 161 Anna Fraentzel Celli (1878-1958) diplomata infermiera in Germania, si trasferì in Italia dopo aver sposato Angelo Celli, direttore dell’istituto di Igiene dell’Università di Roma. Appartenente all’Unione Femminile, istituì il Comitato scuole per i contadini dell’Agro Romano e si dedicò alla lotta antimalarica, al miglioramento delle condizioni di vita dei contadini della campagna romana e, in generale, alla sensibilizzazione sanitaria e igienica della società italiana. 162 I vari interventi di Anna Celli vennero raccolti nel volume La donna infermiera in Italia, Roma, Tip. naz. di G. Bertero & C., 1908. 163 ANNA CELLI, Per le scuole delle infermiere, «Nuova Antologia», 1° ottobre 1908, pp. 481-489. 164 Ivi, p. 486. 160 Tra due secoli 47 aspetto, le sue proposte suscitarono, al tempo, un notevole interesse anche se furono applicate e introdotte nel sistema sanitario con molta lentezza, se ancora nel 1913, come risulta dal regolamento per il personale dell’istituto ortopedico Rizzoli, le infermiere avevano compiti assimilabili a quelli degli inservienti, quali la pulizia dei locali.165 Nel frattempo, però, nascevano aggregazioni sindacali, in gran parte costituite da uomini, con lo scopo di rappresentare il personale ospedaliero nelle controversie non solo retributive e migliorative del trattamento lavorativo ma anche di formazione, protezione, assistenza degli aderenti. Queste associazioni si riunirono già nel 1914 a Venezia in una assise nazionale per richiedere una maggiore tutela della categoria.166 Nel 1919, invece, le aderenti al Consiglio nazionale delle donne italiane, provenienti dalla Croce Rossa, costituirono l’Associazione nazionale italiana tra le infermiere (Aniti) allo scopo di incrementare l’assistenza, il mutuo soccorso in caso di malattia e la previdenza fra le aderenti. Il sodalizio possedeva anche un proprio organo di stampa, il «Bollettino d’Informazione». L’Aniti, avendo nello statuto le caratteristiche peculiari richieste, venne riconosciuta e affiliata al Consiglio internazionale delle infermiere nel 1922. Poco dopo ne fu estromessa: l’avvento del fascismo le aveva tolto le caratteristiche di apoliticità, aconfessionalità, costituzione su base democratica, richieste per poter rimanere all’interno dell’organismo sovranazionale.167 Le crocerossine Uno dei settori tipici e tradizionali di impegno femminile era quello delle crocerossine che risaliva all’iniziativa pionieristica dell’inglese Florence Nightingale durante la guerra di Crimea (1853-1856). In Italia il volontariato femminile in questo campo era stato promosso dalla Croce Rossa, sorta nel 1864, e successivamente incentivato da donne di ceto medio-alto, come Sita Camperio Meyer,168 che, supportata dalla organizzazione cui apparteneva, aveva dato vita a Milano nel 1907 al primo corso per crocerossine. Ad esso seguì l’apertura, il 9 febbraio 1908, di una scuola nell’ospedale militare del Celio a Roma, atto che segnava ufficialmente la nascita del Corpo delle infermiere volontarie. Il corso era di cinque mesi – i primi quattro dedicati alle lezioni teoriche, l’ultimo di esercitazioni pratiche – e si concludeva con un esame abilitante. All’atto dell’iscrizione si richiedeva l’adesione alla Croce rossa italiana e l’impegno a intervenire in caso di guerra o nelle missioni di soccorso alle popolazioni colpite da epidemie e calamità naturali. In Emilia-Romagna, nello stesso periodo, si inauguravano le scuole infermieristiche di Modena e di Bologna, istituita quest’ultima il 16 marzo 1908, con «95 iscritte, di cui 39 seguirono il corso e 56 sostennero l’esame, ottenendo il diploma di infermiera e la medaglietta dopo i tre anni regolamentari di studi».169 165 Regolamento organico per il personale dell’istituto ortopedico Rizzoli in Bologna, Bologna, Coop. Tip. Azzoguidi, 1913, p. 8. 166 E. MANZONI, Storia e filosofia dell’assistenza infermieristica cit., p. 108. 167 Ibidem. 168 Sita Camperio Meyer (1877-1967) si diplomò infermiera della Cri nel luglio del 1909 e nel novembre 1911 conseguì il grado superiore. Pluridecorata, nel 1933 ottenne il più alto riconoscimento con la medaglia «Nightingale». Cfr. STEFANIA BARTOLONI, Italiane alla guerra. L’assistenza ai feriti 1915-1918, Venezia, Marsilio, 2003, pp. 50-57. 169 CROCE ROSSA ITALIANA, COMITATO REGIONALE DELLA VI CIRCOSCRIZIONE, La scuola infermiere volontarie di Bologna (1914-1915-1916), Bologna, Stab. poligrafico emiliano, 1915, p. 5. Pare che a Bologna già dal 1903, per la collaborazione fra Scuola samaritana e Università popolare, fosse in 48 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale La prima mobilitazione che vide le ‘dame bianche’ all’opera riguardò il terremoto che colpì drammaticamente la Calabria e la Sicilia nel dicembre del 1908. Dopo molti dubbi, furono impiegate 260 volontarie: una parte venne distribuita negli ospedali delle città costiere, altre accolsero i profughi nei centri di smistamento di Firenze e Napoli mentre alcune si imbarcarono sulla nave Taormina e sui treni ospedale.170 Importante fu poi la loro partecipazione alla missione per lo sgombero dei malati e dei feriti sulla nave Menfi nella guerra italo-turca. Per l’occasione furono selezionate 66 infermiere che prestarono la loro opera dall’ottobre 1911 al marzo 1912 riportando in Italia 1.238 degenti.171 L’operazione fu un successo anche per l’impatto esercitato sull’opinione pubblica: le crocerossine diedero una immagine di forza, sicurezza, serenità e riuscirono, con fermezza, a ribaltare tutti i luoghi comuni che le volevano deboli e fragili, facili a svenimenti e pianti, incapaci dunque di portare vero soccorso e di solo intralcio per i medici. Nel frattempo un gruppo di volontarie era stato inviato sul fronte balcanico e altre, nell’inverno 1915, si recarono sui luoghi del terremoto della Marsica. Allo scoppio della grande guerra l’organizzazione della Croce Rossa si mise in moto per mobilitare le ‘bianche sorelle’, che furono coinvolte in gran numero in opere di assistenza sanitaria nelle immediate retrovie del fronte, sui treni-ospedale destinati al trasporto dei feriti172 e nei luoghi di ricovero del paese. Secondo calcoli sommari, nel 1917 le volontarie erano quasi 10.000 e altrettante quelle organizzate da altre associazioni di soccorso.173 Le infermiere impiegate al fronte furono oltre un migliaio.174 In questa loro attività alternavano momenti di riposo a un impegno al limite della sopportazione. Dopo ogni assalto, l’arrivo convulso di feriti le mobilitava, in netto contrasto con i ritmi più tranquilli delle strutture territoriali. Ad esse spettava sedare la paura di chi era scampato alla carneficina, consolare quelli al limite della follia, calmare chi con rabbia imprecava contro il conflitto e non voleva tornare in trincea, assistere i moribondi, ricomporre i morti e scrivere alle famiglie dei soldati che non ce la facevano. Condivisero il pericolo, il dolore e l’orrore di un massacro privo di senso. Oltre alle difficili e talvolta impossibili condizioni di lavoro, alla scarsa strumentazione, all’assenza di farmaci e locali adeguati, le volontarie dimostrarono grandi capacità di adattamento: in stanze fredde e spartane dovettero imparare a convivere con furiosi bombardamenti, freddo, disagi, fame, parassiti e topi. Molte dovettero faticare non poco per essere accettate. La dichiarata ostilità di alcuni ufficiali medici e i diffusi pregiudizi sulle capacità femminili agirono, soprattutto agli inizi, come deterrente al pieno utilizzo delle volontarie. Per non funzione un corso per infermiere. Sull’organizzazione del capoluogo emiliano cfr. M. PAZZI, La Scuola Samaritana bolognese, Bologna, Parmeggiani, 1903. 170 S. BARTOLONI, Italiane alla guerra cit., p. 62. 171 Ivi, p. 72. 172 Durante il conflitto, operarono ventiquattro treni ospedale che svolsero un ruolo importante anche nel recupero dei prigionieri malati. Ben attrezzate, provviste di tutte le figure e i servizi necessari per garantirne l’autosufficienza, le unità sanitarie su rotaie erano composte da quattordici vetture, compreso un settore riservato ai contagiosi. Di norma il numero degli addetti previsti era di otto ufficiali, quarantotto fra sottufficiali e militi e quattro infermiere. I convogli, durante il conflitto, arrivarono a contenere oltre 300 posti letto. Cfr. Donne al fronte. Le infermiere volontarie nella Grande Guerra, a cura di S. Bartoloni, Roma, Jouvence, 1998, pp. 127-128. 173 Si mobilitarono anche le antiche società di soccorso come la Scuola Samaritana, la Croce Verde, la Croce Bianca che istituirono varie sezioni femminili. Sulle cifre della mobilitazione cfr. S. BARTOLONI, Italiane alla guerra cit., p. 18. 174 Donne al fronte cit., p. 139. Tra due secoli 49 ARNALDO ROMAGNOLI, Soldati feriti assistiti dalle crocerossine all’interno dell’infermeria allestita nei magazzini ferroviari della stazione di Bologna, 1915-1918, Collezioni d’Arte e di Storia della Fondazione Cassa di Risparmio, Bologna parlare del poco rispetto che, talvolta, usarono loro gli inservienti o gli infermieri tenuti ad eseguire gli ordini da loro impartiti essendo equiparate al grado di ufficiale. Va ricordato che non percepivano alcun compenso per il lavoro svolto. Negli ospedali territoriali, invece, le militanti rossocrociane erano presenti in tutti i reparti, e lavoravano sia nelle sale operatorie sia nelle corsie. Responsabili degli strumenti chirurgici e degli armadietti contenenti farmaci e bende, distribuivano la colazione e la terapia prescritta, accompagnavano il primario o il capo reparto nella visita giornaliera, medicavano laddove era necessario, seguivano i pazienti nelle sale fisioterapiche, in quelle per la rieducazione e portavano in giardino chi non poteva recarvisi da solo. Infine, al momento dei pasti aiutavano chi non era in grado di provvedere a se stesso. Nel pomeriggio, dopo la consegna alle colleghe del secondo turno e il riposo dei feriti, alcune si occupavano dei degenti che svolgevano varie attività – di solito di tipo artigianale – nei laboratori per la rieducazione professionale, mentre ad altre spettavano la distribuzione di libri 50 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale e la lettura per i pazienti che non potevano o non sapevano leggere, l’aiuto nella compilazione di lettere, il riordino del guardaroba e, infine, servire la cena. La giornata si chiudeva con l’arrivo delle volontarie addette al turno di notte. Oltre alle cure e al conforto, cercavano di organizzare un minimo di attività sociale per lo svago e la socializzazione. La mobilitazione delle crocerossine scatenò nell’opinione pubblica reazioni contrastanti che andarono da timidi incoraggiamenti, a malcelati disagi, fino a una aperta opposizione. La paura dei benpensanti nasceva dall’improvvisa libertà di cui, soprattutto ragazze e giovani signore, avrebbero usufruito e si accompagnava ai timori dell’eccessiva vicinanza fra i due sessi. Nonostante la figura della crocerossina fosse tale da promuovere l’impegno femminile senza contraddire, anzi estendendo e perfezionando il lavoro di cura e di assistenza normalmente svolto, tutto ciò avveniva nella promiscuità degli ospedali, dove queste donne venivano quotidianamente in contatto con uomini sconosciuti e più precisamente col loro corpo bisognoso di cure: Ierlaltro il presidente ci aveva convocate per dirci che i nuovi richiami rendono più difficile il servizio e chiederci di venire più presto e di assumere anche i cosiddetti bassi servizi. Naturalmente, accettammo di tutto cuore. E così in talune sale facciamo il servizio intero. Per fortuna, anche i soldati trovano ogni cosa naturale (siamo le sorelle) e così non vi è imbarazzo né da una parte, né da l’altra.175 L’insistenza sul ruolo sororale e/o materno delle infermiere serviva proprio a occultare e rimuovere quello sessuale, minimizzando rischi e tentazioni dovuti alla convivenza, evitando quel disordine morale che poteva derivarne: E qui si rivela l’infermiera di vocazione, che sa diventare semplicemente una mamma, anche con ragazzoni che hanno quasi la sua età, e riesce a compiere le più umili bisogne con quella prestezza di mano, con quella delicatezza di modi, con quella semplice affettuosità che ispirano una confidenza rispettosa e placano ogni allarme di pudore. Non sono più un uomo e una donna, di fronte l’uno all’altro: sono due creature, unite nello stesso spirito e nello stesso sentimento e mentre l’una dà, l’altra riceve, con cuore puro, il più ineffabile dei doni, la carità.176 In questo senso tanto l’accento posto sul ruolo materno quanto la distanza sociale tra crocerossine (di ceto medio-alto) e pazienti (in maggioranza contadini) doveva servire da antidoto fissando confini netti. Si comprende così la ragione del divieto, dettato dai regolamenti, alle infermiere di occuparsi di ufficiali (generalmente di estrazione sociale omogenea alla loro), se non in casi di emergenza. Alle volontarie venivano, invece, affidati i soldati semplici i quali non avrebbero osato mancare loro di rispetto. L’impegno in queste attività diede modo ad una parte di donne di ‘uscire allo scoperto’, varcare i confini chiusi della famiglia, assumere una nuova rilevanza pubblica e 175 ANTONIETTA GIACOMELLI, Dal diario di una Samaritana. Ai nostri soldati e alle loro infermiere, Milano, A. Solmi, 1917, pp. 38-39. Giacomelli (1857-1949), nota negli ambienti del riformismo religioso, durante la guerra si impegnò in una intensa attività assistenziale come infermiera samaritana. Su di lei cfr. ANNA SCATTIGNO, L’educazione della donna nella cultura modernista: Antonietta Giacomelli, in L’educazione delle donne. Scuole e modelli di vita femminile nell’Italia dell’Ottocento, a cura di Simonetta Soldani, Milano, Franco Angeli, 1989, pp. 531-550. 176 ELISA MAJER RIZZIOLI, Accanto agli eroi. Crociera sulla “Memfi” durante la conquista di Libia, Milano, Libreria ed. milanese, 1915, p. 80. Rizzioli nata a Venezia nel 1880, frequentò il primo corso della città e fece servizio nella guerra del 1915, sostenne l’impresa fiumana e aderì al fascismo fondando nel 1925 i Fasci femminili. Morì a Milano nel 1930. Tra due secoli 51 utilità sociale. L’eccezionalità delle circostanze le portava lontane da casa per lunghi mesi, rompeva i ritmi della loro quotidianità, consentiva di intrecciare nuove relazioni personali all’interno di una cornice di elevato valore morale. Dei significati del volontariato delle crocerossine si hanno interessanti riscontri nelle loro testimonianze, dove si coglie spesso la coesistenza tra sentimenti di pietà e dolore per lo strazio dei feriti e sentimenti di soddisfazione, di appagamento per l’occasione avuta di mostrare, appunto, il proprio valore.177 Molto spesso, quest’ultimo appare il tema dominante, quello che dà il tono agli scritti: Oggi è partito Castelli, una delle glorie del nostro bravo primario. Quando rammento in quale stato pietoso è arrivato sei mesi fa… pareva un caso disperato. Egli mi ricorda una mattina emozionante della scorsa estate, nella quale ero stata destata dall’allarme degli aeroplani. Mi ero vestita a precipizio ed ero andata all’ospedale di corsa. Della gente che abita incontro [sic], usciva correndo verso il rifugio vicino. Uno mi gridò appresso: «Imprudente!». Un altro: «L’arresteranno». Ma chi oserà arrestare uno che va a compiere il proprio dovere? Intanto s’era udito lo scoppio di parecchie bombe. Quando salii le scale dell’ospedale, vidi tracce di sangue […]. Tutti i feriti e i malati dell’ultimo piano erano stati portati abbasso, i più gravi nei letti vuoti del primo piano, gli altri nei rifugi. Nessuna confusione, nessuna diserzione, il panico era stato vinto dal sentimento del dovere. Solo Castelli, non trasportabile, era rimasto di sopra con suor Blandina. Salii per darle il cambio. Traversando le sale, vidi le tracce della furia con la quale erano state sgombrate. Dai letti vuoti pendevano le coperte, qua e là erano vesti trascinate per terra, oggetti caduti e rovesciati. La suora non volle muoversi. Rimanemmo entrambe, mentre nel cielo seguitava il fragore della lotta aerea, e ogni tanto si distingueva lo scoppio di una bomba. Il ferito voleva mandarci via: «Voialtre sorelle, non siete soldati» diceva. Io risposi: «Sì, siamo soldati anche noi, figliolo e siamo così contente di condividere un briciolino dei vostri pericoli». S’udiva sul tetto passare il rombo di un motore. Una bomba, in quel mentre, scoppiava vicino.178 Fermezza, dignità, coraggio, dimostrati senza dubbio da Maria Antonietta Clerici la quale, dopo la rotta di Caporetto nell’ottobre del 1917, rifiutò di abbandonare i feriti gravi intrasportabili e per questo venne imprigionata nel campo di concentramento di Katzenau: Lo sgombero dei feriti leggeri e trasportabili sui treni, continuava intanto febbrile e incessante. Un lavoro vertiginoso e fantastico! Sgombrammo in pochi giorni – credo – circa duemila feriti. La sera del 27 [ottobre 1917], verso le ventitre, mi ritirai in camera esausta per la stanchezza e per l’angoscia. Poco dopo arrivò, per noi infermiere, l’ordine di ritirarci. Io non avevo ancora compreso che l’ospedale era destinato a rimanere, per continuare l’assistenza ai feriti gravi intrasportabili; non avevo ancora concepito – né l’avrei potuto – l’orrore della situazione. Pensavo che tutti i feriti avrebbero avuto al domani la possibilità di salvarsi, e contavo di partire con uno degli ultimi treni ospedale. […] Certo, in quel momento io non prevedevo né la ritirata precipitosa che si iniziò per la III armata la stessa notte, né lo stato d’animo mio allorché mi trovai, più tardi, di fronte ai molti feriti che avrei dovuto lasciare in balia dell’ignoto. […] Salii in reparto. Fui salutata come una benedizione da quei poveri ragazzi che, inchiodati a letto dalle gravi ferite, vedevano gli altri mettersi in salvo. […] Feriti al cranio, al petto, all’addome…, moltissimi polmonitici. Qualcuno agonizzava… […]. Sentii che la mia persona scompariva di fronte a quegli infelicissimi, sentii che qualsiasi sorte, qualunque sventura mi fosse riservata, io non potevo lasciare quei ragazzi, che tutto avevano dato alla Patria. 177 Cfr. ANTONIO GIBELLI, La Grande guerra degli italiani 1915-1918, Milano, Rizzoli, 1998, pp. 201-205. 178 A. GIACOMELLI, Dal diario di una Samaritana cit., pp. 22-23. 52 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale Allora chiamai a raccolta le mie energie migliori, ed imposi all’animo mio la calma e la serenità necessaria. Intuii la gravità dell’atto che compivo rifiutando di mettermi in salvo, ma ebbi forte, diritta, chiara, la visione della via da seguire… e mi decisi.179 Con motivazioni fra le più varie, Clerici manifestò una capacità di scelta per quei tempi inedita e insospettata, come fecero la gran parte delle italiane durante il primo conflitto mondiale. Le lavoratrici dello Stato Le tabacchine Tra le donne ammesse alle dirette dipendenze dello Stato, anche se in attività periferiche rispetto alla sua gestione, vi erano quelle che lavoravano nelle manifatture tabacchi.180 Tutte le fasi della lavorazione del prodotto erano esercitate fondamentalmente da manodopera femminile: nel 1901 lavoravano nel settore, su un organico di 13.313 unità, 12.044 donne pari al 90,5% del totale,181 divise in diciassette stabilimenti, dislocati su tutto il territorio nazionale, tra cui quelli capaci dei più alti livelli produttivi erano a Milano, Venezia, Torino, Firenze, Roma e, in Emilia-Romagna, a Modena e a Bologna.182 Nel 1865 la manifattura di Bologna occupava 1.159 operai e «produceva kg 1.300 di tabacchi divisi in ventiquattro prodotti, fra cui otto qualità di sigari». Dopo alcuni decenni di decremento di produzione e di manodopera, nel 1905 la crisi poteva dirsi superata: alla produzione – venivano trattati 1.455 chili di tabacco, divisi in dodici prodotti – erano impiegate 439 persone,183 di cui 361 donne e una «avventizia al di sotto dei 15 anni».184 179 MARIA ANTONIETTA CLERICI, Al di là del Piave, coi morti e coi vivi. Ricordi di prigionia, Como, Libreria ed. V. Omarini, 1919, pp. 11-14. Allieva a partire dal marzo 1912, diplomata nel dicembre 1914, partecipò al conflitto fino alla rotta di Caporetto, dopo di che venne internata a Katzenau, condividendo la sua esperienza di prigionia con altre due infermiere volontarie Maria Andina e Maria Concetta Chludzinska. Rientrata in Italia nel maggio 1918, ottenne vari riconoscimenti. 180 Le attività connesse alla produzione del tabacco in tutti i paesi sono sempre state considerate una prerogativa dello Stato e sono state svolte in un regime di monopolio per la loro alta redditività. Le manifatture esistenti negli Stati pre-unitari vennero, pertanto, organizzate dal nuovo Regno d’Italia in una struttura centralizzata, la Regia Cointeressata, e dal 1884 la lavorazione del tabacco fu gestita direttamente dallo Stato, in specie dal Ministero delle Finanze, attraverso la Direzione generale dei Monopoli. 181 S. SOLDANI, Strade maestre e cammini tortuosi. Lo Stato liberale e la questione del lavoro femminile, in Operaie, serve, maestre, impiegate, a cura di Paola Nava, Torino, Rosenberg & Sellier, 1992, pp. 289-352: 296 e GIORGIO PEDROCCO, Le operaie delle manifatture tabacchi, in Operaie, serve, maestre, impiegate cit., pp. 353-362: 354. 182 In Emilia chiusero, nel corso dell’Ottocento, le manifatture di Parma e Ferrara. 183 I pochi uomini in servizio erano in genere addetti alla manutenzione degli impianti. 184 La manifattura tabacchi di Bologna fu istituita nel 1801 nel luogo dell’ex convento di S. Maria Nuova in via Riva Reno. Con la caduta del governo napoleonico e il ritorno di quello pontificio, la manifattura acquistò importanza, anche a seguito della chiusura di quella di Ferrara, tanto che nel 1817 impiegava 76 operai destinati alla lavorazione di ben 32 prodotti diversi: dai sigari comuni ai Virginia, Levante e Moro, con una produzione annua di kg 171.000 di tabacco lavorato. Nel 1831 impiegava già 400 operai che, nel giro di alcuni anni, giunsero a 600. Per i dati qui riportati cfr. «Il Tabacco», numero unico pubblicato in occasione dell’Esposizione internazionale di Milano, [Roma, 1906], pp. 47-48. Tra due secoli 53 Le manifatture erano luoghi anomali nel panorama industriale italiano per il ricorso prevalente ad una manodopera femminile altamente qualificata. A differenza degli opifici in cui le donne erano spesso relegate in mansioni residuali e di servizio, qui le tabacchine – organizzate in squadre e, per lungo tempo, fornite di una tavoletta di legno duro e di un coltello quali unici strumenti di lavoro – dimostravano di avere una essenziale capacità professionale fatta di destrezza, precisione ed eleManifattura dei tabacchi di Bologna. Laboratorio vata agilità manuale. per la formazione delle boette dei tabacchi in La gestione dell’attività da parte polvere, «Il tabacco», numero unico pubblicato in dello Stato si traduceva da una parte occasione dell’Esposizione internazionale di nella tutela delle lavoratrici e dal- Milano, 1906, Biblioteca dell’Accademia l’altra in una rigida disciplina azien- Nazionale di Agricoltura, Bologna dale. Da una parte, infatti, assicurava loro una «notevole stabilità di impiego», un orario di lavoro giornaliero di otto ore a fronte delle dieci e più di altri comparti industriali e un salario di circa tre lire al giorno – ma era soprattutto il cottimo, e quindi il duro lavoro, a garantirne il livello – considerato comunque «notevolmente superiore a quello delle operaie private» e soprattutto «certo».185 Di contro comportava il loro inquadramento entro un complesso sistema di norme, di emanazione ministeriale, che – forse meno arbitrarie di quelle in vigore nelle industrie private – erano di certo più invadenti e rigide. L’articolato regolamento disciplinava rigidamente, nei modi e nei tempi, l’esecuzione del lavoro delle tabacchine, ne scandiva l’intera giornata dall’ingresso in fabbrica, arrivava a controllarne persino la condotta privata e a condizionarne lo stile di vita: venivano, infatti, sanzionati con severità non solo i ritardi e le infrazioni sul lavoro ma anche i comportamenti ritenuti immorali o contrari all’ordine pubblico. Sigari valutati come difettosi, risate in laboratorio, battute considerate troppo licenziosa, risposte brusche all’esortazione di un capo-laboratorio potevano costare alle ‘colpevoli’ anche diversi giorni di sospensione dal lavoro, con conseguente cospicua perdita di salario. Così, seguendo il rigido regolamento disciplinare, venivano multate «per aver cantato» o sospese «per aver fatto chiasso in laboratorio» ragazzine di 11 o 12 anni che, tra l’altro, venivano assunte come ‘avventizie’ in violazione del limite di 15 anni imposto per l’ingresso in fabbrica, in ragione di presunte esigenze di produzione.186 Ad assicurare il rispetto dell’organizzazione interna alle manifatture vi era un complesso apparato di sorveglianza, strutturato gerarchicamente che vedeva, ai vertici e nei 185 MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, UFFICIO DEL LAVORO, Notizie sull’applicazione della legge 19 giugno 1902, n. 241, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, Roma, Officina poligrafica italiana, 1906, citato in S. SOLDANI, Strade maestre e cammini tortuosi cit., p. 298. 186 ORNELLA BIANCHI, Le lavoratrici del tabacco nella storia del sindacalismo italiano, in Mondi femminili in cento anni di sindacato, a cura di Gloria Chianese, Roma, Ediesse, 2008, pp. 87-105: 9091 e LORETTA GIOVANELLI, Vita di fabbrica delle sigaraie modenesi tra Otto e Novecento. Una ricerca sui registri disciplinari, in Operaie, serve, maestre, impiegate cit., pp. 363-376. 54 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale ruoli strategici per il mantenimento della disciplina e del funzionamento della produzione, personale maschile, e nei singoli laboratori, a diretto contatto con le operaie, con compiti oltre che di controllo anche di insegnamento, le cosiddette ‘maestre’ e le sorveglianti, selezionate dalla Direzione tra le operaie più affidabili.187 Una vasta gamma di sanzioni – dalle multe alla riduzione del salario, dalle sospensioni al licenziamento – era il naturale corollario di questo complesso sistema disciplinare, allestito con la funzione di assicurare la corretta e puntuale esecuzione del lavoro ma anche e soprattutto di dissuadere, ancor prima di punire e reprimere, insofferenza e ribellione come pure qualsiasi forma di organizzazione sindacale e politica.188 Il sistema aziendale repressivo; l’azione di razionalizzazione del lavoro messo in atto dalle direzioni che, per contenere i costi di produzione, fornivano tabacco di scarsa qualità così da costringere a consegnare prodotti imperfetti retribuiti in misura minore; l’intensificazione dei ritmi produttivi, spinti fino a richiedere il confezionamento di oltre mille sigari al giorno, quantità raggiunta solo dalle più abili o a costo di rinunciare alle già scarse pause, finirono con l’alimentare le proteste delle tabacchine, che scioperavano per ottenere miglioramenti lavorativi, salariali e, in particolare, la copertura pensionistica. Il peggioramento delle condizioni di lavoro alimentava, infatti, una forte insofferenza verso quell’assegno di ‘valetudinarietà’ riconosciuto alle operaie anziane o inabili al lavoro, a patto che avessero maturato almeno 35 anni di servizio e avessero 60 anni di età.189 A tutto questo si aggiungeva anche l’insalubrità del lavoro. Proprio per valutare le condizioni sanitarie delle lavoratrici del tabacco, nei primi anni del Novecento veniva realizzata una inchiesta ministeriale, coordinata dal medico deputato Angelo Celli, che si basava su un campione di 8.100 giovani donne, fra i 20 e i 25 anni, di varie manifatture, con meno di cinque anni di lavoro. Secondo i risultati raggiunti dall’indagine, l’84% di esse era in buona salute e le mediocri condizioni del 15% erano dovute essenzialmente alle precarie condizioni di vita e all’ereditarietà:190 il quadro patologico di queste ultime era perciò dovuto a una serie di fattori negativi (abitazioni malsane, precoce avviamento al lavoro, alimentazione insufficiente, scarsa igiene) piuttosto che alla lavorazione del tabacco, facile alibi per giustificare gli allarmanti dati statistici sulla morbilità delle lavoratrici caricando su questi fattori esterni le responsabilità maggiori delle loro precarie condizioni di salute. L’inchiesta ministeriale, dunque, rispose in maniera sorprendentemente ottimistica ai quesiti di fondo sullo stato di salute delle tabacchine là dove affermava che «la lavorazione del tabacco, quale si svolgeva nelle manifatture italiane e nelle industrie del monopolio di Stato, non è per se stessa nociva alla salute né delle operaie né della loro prole».191 187 LUCIANA SPINELLI, Disciplina di fabbrica e lavoro femminile. Le operaie delle Manifatture dei Tabacchi (1900-1914), «Società e storia», VII, 1985, 28, pp. 319-372: 362-370; F. IMPRENTI, Operaie e socialismo cit., pp. 206-208; O. BIANCHI, Le lavoratrici del tabacco nella storia del sindacalismo italiano cit., p. 91. 188 Venivano proibite e punite con il licenziamento la diffusione della stampa antigovernativa, la partecipazione a forme collettive di protesta, l’organizzazione – o anche solo l’adesione – alle Leghe di resistenza. Cfr. S. MERLI, Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale cit., pp. 172-173. 189 Era una sorta di esigua pensione l’ammontare della quale poteva variare da un minimo di 3/10 ad un massimo di 2/5 dell’ultimo salario. Cfr. O. BIANCHI, Le lavoratrici del tabacco nella storia del sindacalismo italiano cit., p. 94; L. GIOVANELLI, Vita di fabbrica delle sigaraie modenesi cit., p. 376. 190 Il lavoro femminile nell’Ottocento e nel Novecento. Le tabacchine. Coltivatrici, produttrici e venditrici, a cura di F. Taricone, Roma, Gangemi editore, 2005, p. 61. 191 MINISTERO DELLE FINANZE, Sulle condizioni igieniche e sanitarie dell’industria del tabacco in Italia, Roma, Tip. Elzeviriana, 1908, citato in G. PEDROCCO, Le operaie delle manifatture tabacchi cit., p. 359. Tra due secoli 55 Ben diverse le conclusioni a cui arrivò il dottor Luigi Tavernari nel suo Saggio d’igiene industriale sulla Regia Manifattura dei Tabacchi di Modena192 che metteva in luce la tossicità e la nocività delle manifatture e la stretta correlazione tra patologie sofferte dalle operaie e lavorazione del tabacco. Il prodotto fermentato, manipolato quotidianamente, tenuto in grembo per tutta la giornata, i vapori e le polveri respirati, la sedentarietà forzata, la scarsa igiene, l’affollamento dei laboratori avevano effetti deleteri sulla salute di queste donne – sicuramente malnutrite e già provate da un carico di lavoro che andava ben oltre a quello di fabbrica – e portavano a disturbi ovarici e respiratori, artrosi, glaucoma e tubercolosi.193 Sul finire dell’Ottocento, però, le tabacchine avevano ormai compreso la necessità di organizzarsi e il vantaggio dell’associarsi: già nel 1874 nasceva una Società di mutuo soccorso fra le operaie della manifattura bolognese il cui statuto del 1883 prevedeva l’assistenza delle socie in caso di malattia, un sussidio di una lira al giorno alle partorienti e un contributo mensile per le anziane.194 Da qui derivava il loro essere riuscite a diventare «una parte importante della classe operaia organizzata», «dotate di una lunga esperienza e di una crescente capacità di affrontare i loro problemi per la soluzione dei quali avrebbero negli anni successivi affrontato lunghe lotte».195 Lunghe e aspre lotte che le portarono ad ottenere, nel 1904, un nuovo regolamento con il quale veniva definito ogni aspetto normativo e salariale del rapporto di lavoro e riconosciuto loro il diritto di sciopero, una giornata di sette ore (con un’ora di riposo), l’istallazione di cucine economiche all’interno delle manifatture per farsi un pasto caldo, l’allestimento di stanze di allattamento, due mesi pagati di malattia e la cassa-pensioni,196 trovandosi così ad avere, come lavoratrici, una dignità e una sicurezza che altre di certo non possedevano. Le impiegate Alla fine dell’Ottocento in Italia si assisteva al fenomeno della femminilizzazione del lavoro impiegatizio pubblico e privato. La necessità di sviluppare le attività nei settori commerciali e nei servizi, aveva reso indispensabile il reclutamento di manodopera sufficientemente istruita, specializzata ma a costi ridotti. L’offerta si rivolse dunque alle donne della piccola borghesia urbana che, grazie alla diffusione dell’istruzione pubblica, potevano offrire un livello di preparazione culturale adeguata alle nuove professioni e una riserva di lavoro a buon mercato. Per questo, enti statali, compagnie di assicurazione e attività commerciali cominciarono ad ingaggiare segretarie, dattilogra- 192 LUIGI TAVERNARI, Saggio d’igiene industriale sulla Regia Manifattura dei tabacchi di Modena, Roma, Soc. ed. Dante Alighieri, 1900. 193 Il dottor Rosario Vitanza, che studiò le sigaraie palermitane, non esitò ad affermare una netta e conclamata correlazione tra lavoro nelle manifatture e maggiore incidenza di episodi abortivi e mortalità neonatale. Cfr. L. SPINELLI, Disciplina di fabbrica e lavoro femminile cit., pp. 350-351. 194 Statuto della Società di Mutuo soccorso fra gli operai e le operaie della Manifattura Tabacchi di Bologna, fondata il 1º aprile 1874, Bologna, Soc. tip. Azzi, 1883. 195 FRANCA PIERONI BORTOLOTTI, Vita di fabbrica e attività politica delle sigaraie fiorentine dal 1874 al 1893, «Movimento operaio e socialista in Liguria», 1960, 4, p. 15. 196 MINISTERO DELLE FINANZE, DIREZIONE GENERALE DELLE PRIVATIVE, Regolamento del personale e mercede giornaliera delle Manifatture dei Tabacchi, Roma, [s.n.], 1904 che siglò conquiste importanti e precoci, ma che le tabacchine non riuscirono poi a modificare fino al 1921. Cfr. S. SOLDANI, Strade maestre e cammini tortuosi cit., p. 298. 56 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale fe, archiviste; uffici postali e compagnie telefoniche e telegrafiche ad assumere operatrici; negozi e grandi magazzini a reclutare commesse e istituzioni scolastiche a ricercare insegnanti. Nelle mansioni d’ufficio le donne venivano considerate adatte per loro qualità ‘naturali’: pazienza e attenzione, docilità e sottomissione, discrezione ma, soprattutto, economicità. Le impiegate si rivelarono un buon investimento perché il rapporto tra costi e rendimento era estremamente conveniente, in primo luogo per le pubbliche amministrazioni, dove furono assunte soprattutto nel campo delle comunicazioni, settore che ebbe un rapidissimo sviluppo negli ultimi decenni dell’Ottocento grazie all’invenzione e al perfezionamento di nuove tecnologie. Lo sforzo economico e organizzativo per diffondere il servizio postale, telegrafico e telefonico, essenziale per il consolidamento del moderno Stato, rese necessaria un’attenta politica degli ingaggi attraverso un incremento del personale femminile, assunto però in forma precaria. Le prime donne vennero impiegate dal Ministero dei Lavori pubblici (poi Comunicazioni) nel 1863: erano addette alle poste e ai telegrafi, negli uffici postali soprattutto come ricevitrici o supplenti;197 negli uffici telegrafici, dopo aver prestato servizio come giornaliere e dopo aver superato un concorso per esami, potevano raggiungere la qualifica di ausiliarie; negli uffici telefonici potevano trovare lavoro come commutatoriste, centraliniste, contabili, segretarie d’amministrazione.198 All’inizio, questa possibilità di lavoro era offerta solo alle vedove o alle orfane di un dipendente, conformemente ad una prassi tipica del mondo artigianale, per la quale, in caso di morte del capo dell’azienda familiare, era possibile per la parente assumerne il ruolo. Nel 1865 questa clausola famigliare venne resa meno vincolante, anche se la consanguineità poteva ancora rappresentare un elemento di preferenza nella scelta da effettuarsi. È il caso questo di Emma Tinarelli, proposta dal marito, titolare dell’ufficio postale di Mordano, come sua supplente «nei casi di assenza o impedimento».199 Vista l’ottima condotta politico-morale e il buon livello di studi, l’istanza venne accolta. La richiesta presentata al Ministero dal titolare dell’ufficio postale di Praduro e Sasso, Domenico Bartolini, al fine di poter cedere il proprio impiego alla figlia Teodolinda, che già ne era supplente, non trovò invece accoglimento. Il questore, infatti, pur constatando il possesso da parte della ragazza dei requisiti necessari di buona condotta morale e capacità, doveva peraltro rilevare che il suo comportamento sul posto di lavoro dava adito a critiche: «è giovane, assai poco diligente e non mantiene la necessaria segretezza. Permette l’entrata nell’ufficio a persone estranee e vuolsi apra talvolta lettere private. Perciò l’ufficio postale, a dire di molti, non sarebbe bene affidato».200 Gli accerta197 I ricevitori erano responsabili ed organizzatori delle cosiddette ‘ricevitorie’ – gli odierni uffici postali – successivamente fornite di servizio telegrafico e telefonico; mentre i supplenti, di fatto, erano salariati del ricevitore, non avevano nessuna garanzia, né tutela del posto di lavoro. 198 MARIA LINDA ODORISIO, Le impiegate del Ministero delle Poste, in Il lavoro delle donne, a cura di Angela Groppi, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 398-420: 404. 199 Lettera della Questura del circondario di Bologna al Prefetto, Imola, 19 novembre 1895, in ASBo, Gabinetto di Prefettura, cat. 3, fasc. 10 «Poste e telegrafi», 1895. 200 Lettera della Questura del circondario di Bologna al Prefetto, Bologna, 14 luglio 1895, in ASBo, Gabinetto di Prefettura, cat. 3, fasc. 10 «Poste e telegrafi», 1895. A tale proposito, è necessario sottolineare che il Codice Penale prevedeva come «Delitto contro l’inviolabilità dei segreti», l’aprire arbitrariamente lettere e telegrammi diretti ad altri, sopprimere corrispondenza epistolare o telegrafica nonché «l’abuso e la rivelazione di segreto epistolare o telegrafico da parte del personale addetto a quei servizi», in DALMAZIO MAFFIOLI, Riordinamento dell’Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi. DD. RR. 26 gennaio 1899, nn. 43 e 44, Milano, Soc. ed. Libraria, 1899, p. 191. Tra due secoli 57 menti eseguiti dalle pubbliche autorità riguardavano soprattutto e in particolar modo il comportamento tenuto dalle impiegate. Per la Direzione delle Poste e dei Telegrafi si rendeva necessario verificarne la moralità poiché «per avere titolo ad assumere il posto, devono risultare di costumi integerrimi»:201 Armida Bacchetti, ad esempio, si dimostrava di buona condotta politica «ma non così [per] quella morale imperocchè costei vive coll’ufficiale telegrafico Bacialli Giovanni, il quale ha fatto con la stesTelegrafista, «L’Illustrazione italiana», 1893, sa solo il matrimonio religioso e l’Ar- Istituto storico Parri Emilia-Romagna, Bologna mida ha avuto una bambina».202 Nei confronti delle impiegate delle Poste il pedagogismo dello Stato assunse caratteri molto pervasivi, a partire dalla proibizione del matrimonio e la cacciata per immoralità di chi si macchiasse – magari per non perdere il posto – del reato di concubinaggio fino all’istituzione di qualifiche separate, che permettevano di evitare comunque ‘l’innaturale competizione’ con gli uomini, passando attraverso una rigida delimitazione degli spazi e delle sezioni di lavoro (suddivise in maschili e femminili) per garantire la debita ‘separazione dei sessi’.203 Per le impiegate delle poste la clausola del nubilato fu abolita nel 1899 e lo Stato si limitò da allora a chiedere puntigliosamente, in ottemperanza alle norme vigenti, l’autorizzazione del marito.204 Nonostante tutto, questo sbocco professionale costituiva uno dei pochi lavori dignitosi e rispettabili per le donne: nel censimento del 1881 erano impiegate presso il Ministero delle Poste 1.518 donne e, in quello del 1911, 2.707. Un incremento, la cui consistenza reale peraltro, non venne effettivamente registrata dalle statistiche ufficiali che riportavano solo le impiegate di ruolo; mentre, pur non disponendo di un dato effettivo, è stato stimato indicativamente che nella sola categoria delle supplenti nel 1908 si contassero almeno 10.000 donne su un totale di 16.000 dipendenti non di ruolo.205 201 ASBo, Gabinetto di Questura, serie 241, 1897, cat. 9/B, prot. n. 82. Lettera della Sotto-Prefettura del circondario di Vergato al Prefetto di Bologna, Vergato, 29.6.1895, in ASBo, Gabinetto di Prefettura, cat. 3, fasc. 10 «Poste e telegrafi», 1895. 203 Osserva Simonetta Soldani che «Il problema non era di igiene o di salvaguardia della prole, ammesso che di questo si trattasse in altre situazioni, e che fosse comunque ragionevole parlare di ‘incompatibilità fra servizio e stato coniugale’ in rapporto a condizioni di lavoro ritenute ‘insostenibili per una gestante o una puerpera’, come faceva nel 1911 una Commissione reale chiamata a studiare i problemi del personale telefonico. Ciò che si voleva era piuttosto inculcare norme di vita, indicare quale fosse il posto della donna all’indomani del matrimonio, farla uscire da un circuito che – in quanto pubblico – era di per sé incongruo con la sua nuova condizione». S. SOLDANI, Strade maestre e cammini tortuosi cit., p. 296. 204 Cfr. Regolamento speciale pel personale degli uffici postali, Milano, Società editrice libraria, 1911 (Collezione legislativa «Portafoglio» n. 1340-1342). 205 M. L. ODORISIO, Le impiegate del Ministero delle Poste cit., p. 399. 202 58 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale Le prime impiegate provenivano di frequente dalla piccola e media borghesia, anche a Bologna è possibile individuare un flusso di ragazze di tale ceto sociale che si indirizzava verso questa occupazione. Un esempio su tutti: la ventunenne Adalgisa Bozzani, proposta come «aiuto fiduciario» del commesso postale di Molinella, proveniva da una famiglia di estrazione piccolo-borghese (il padre era proprietario di una avviata calzoleria in via Ugo Bassi e la famiglia, risiedente a Villa Brun, fuori porta S. Isaia, viveva agiatamente). Inoltre, la ragazza, «dotata di sufficiente coltura […] gode la pubblica fiducia».206 Il 40% circa delle impiegate statali a livello nazionale proveniva dalla provincia e spesso si doveva trasferire in città, quindi lontano dalla famiglia, in condizioni difficili sia socialmente (la donna sola, priva di controllo famigliare, era sempre oggetto di sospetti e maldicenze) sia economicamente. Il loro salario, infatti, non consen- NYTA JASMAR [Clotilde Scanabissi], tiva di vivere autonomamente in modo decoroso. Ricordi di una telegrafista, Bologna, Il loro livello culturale era piuttosto alto (il 55% Libreria editrice C. Galleri, 1913, risultava diplomata alla scuola superiore) ma le Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze loro possibilità di carriera erano praticamente inesistenti così come non avevano diritto alla pensione, alle ferie retribuite, né alla stabilità di impiego, tutte prerogative invece riconosciute agli uomini almeno dal 1881. Soprattutto le telegrafiste, però, non si diedero per vinte e dopo anni di intensissime lotte sindacali,207 grazie anche al relativo appoggio dei partiti di sinistra, riuscirono a ottenere il riconoscimento di impiegate di ruolo. La loro situazione però rimase sempre svantaggiata rispetto a quella degli uomini, sia dal punto di vista retributivo sia da quello delle possibilità di carriera. Le opportunità di avanzamento erano estremamente ridotte: un’ausiliaria poteva al massimo diventare direttrice della sezione femminile e «per arrivare a guadagnare il massimo dello stipendio consentito al suo grado avrebbe dovuto lavorare per almeno 45 anni consecutivi raggiungendo al termine della carriera uno stipendio pari a un terzo di quello percepito da un suo collega con la stessa anzianità».208 Così descriveva le condizioni di lavoro delle ausiliarie telegrafiche, considerate l’aristocrazia delle impiegate del Ministero delle Poste, una grande scrittrice dell’epoca, Matilde Serao, in un racconto del 1884, intitolato Telegrafi dello Stato (Sezione femminile): Le trattavano come tante bestie da soma, con quei tre miserabili franchi al giorno, scemati dalle tasse, dalle multe, dai giorni di malattia: e invece, esse avevano, quasi tutte il diploma di 206 Lettera della Questura del circondario di Bologna al Prefetto, Bologna, 10 aprile 1895, in ASBo, Gabinetto di Prefettura, cat. 3, fasc. 10 «Poste e telegrafi», 1895. 207 La Federazione dei Postelegrafonici sorse nel 1902 e fu presieduta, per un primo periodo, da Filippo Turati. 208 M. L. ODORISIO, Le impiegate del Ministero delle Poste cit., p. 408. Tra due secoli 59 grado superiore e al telegrafo prestavano servizio come uomini, come impiegati di seconda classe, che però avevano duecento lire al mese […]. Non erano nominate né con decreto regio, né con decreto ministeriale: un semplice decreto del direttore generale, revocabile da un momento all’altro. Se le telegrafiste facevano cattiva prova, le potevan rimandare a casa, tutte, senza che avessero diritto di lagnarsi. L’avvenire? Quale avvenire? Erano fuori pianta, non avevano da aspettar pensione: anzi, diceva il regolamento che a quarant’anni il Governo le licenziava, senz’altro: cioè se avevano la disgrazia di restar telegrafiste sino a quarant’anni, il Governo le metteva sulla strada, vecchie, istupidite, senza sapere fare altro, consumate nella salute e senza un soldo.209 Fare l’impiegata, nonostante tutto, segnava per le donne l’arricchimento, l’affermazione della propria identità attraverso nuove forme di consapevolezza. Anche io ho infranto le pastoie; ho spezzato la dorata catenella […]. Vivrò del mio lavoro! Oh la gioia di esser liberi […]. Non voglio essere una parassita e tanto meno una schiava affermava Marina, protagonista del romanzo Ricordi di una telegrafista di Nyta Jasmar, pseudonimo di Clotilde Scanabissi Samaritani.210 Il volume – scritto da una telegrafista di Budrio, punita con un trasferimento a Torino per avere attentato con il volume «alla moralità telegrafica»– narra la vita immaginaria di una ragazza dell’alta borghesia che nel 1903 sceglieva di fare la telegrafista per ottenere la libertà. Marina incarnava l’immagine ‘negativa’ dell’impiegata: viveva in un raffinato e lussuoso pied à terre, vestiva di seta e merletti, si preparava raffinati pranzi, aveva una relazione con un giovane, insomma faceva tutto quello che la società borghese sospettava si nascondesse dietro a quella pur debole possibilità di autonomia femminile, e lo viveva con voluttà: E sento un piccolo rimorso pensando alle povere colleghe che dispongono del solo stipendio ed hanno debiti. Però la mia vera gioia è la libertà! Abbasso l’etichetta! Evviva le gambe incrociate e l’abbandono del corpo dove si sente attratto: abbasso la rigidezza!211 Le impiegate spesso erano costrette a difendere la propria reputazione dai continui attacchi di coloro che, per motivi diversi, non approvavano la presenza delle donne negli uffici: «Recentemente tutti i periodici riportarono una requisitoria contro le signo- 209 M. SERAO, Telegrafi dello Stato (Sezione femminile), «Nuova Antologia», ottobre 1884, pp. 86-87. Il racconto apparve per la prima volta sulla rivista letteraria in due puntate, nell’ottobre e nel novembre 1884 e venne raccolto, successivamente, nel volume Il Romanzo della fanciulla, pubblicato nel 1885. La scrittrice era stata, per un certo periodo, impiegata presso un ufficio del telegrafo. 210 NYTA JASMAR [Clotilde Scanabissi], Ricordi di una telegrafista, Bologna, Libreria editrice Costantino Galleri, 1913. Clotilde Scanabissi, nacque a Budrio il 4 marzo 1873 in una modesta famiglia di commercianti. Telegrafista per alcuni anni, l’8 dicembre 1904 sposava Tommaso Samaritani – da qui lo pseudonimo, anagramma del cognome dell’uomo – di nobile famiglia lughese ormai impoverita. Il matrimonio durò poco, dopo alcuni anni i due si separarono. Morì a Budrio il 10 novembre 1931. Il volume venne pubblicato a spese dell’autrice. Il numero di pagine fa riferimento all’edizione della casa editrice Einaudi del 1975, p. 7. 211 Ivi, pp. 56-57. È particolarmente significativo che una povera telegrafista di paese, quale era l’autrice, potesse mettere in scena un rovesciamento così radicale della prospettiva moralistica dominante, segno indubbio della potenzialità positiva che si nascondeva dietro a questi nuovi lavori, seppur così poco rispettati. 60 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale rine impiegate, con una statistica fatta da un americano sulle ore che perdono le ragazze impiegate, ciarlando, specchiandosi, ravviandosi i capelli, ecc.».212 Se la loro rappresentazione, che dava la stampa e che aveva in gran parte l’opinione pubblica, rimandava a molti e tristi luoghi comuni – frivole, chiacchierone, impertinenti, spesso ignoranti e maliziose, incuranti del loro lavoro, mai della loro toilette – ben diversa e più complessa era la realtà di donne e lavoratrici che compariva sui giornali di categoria o su quelli delle associazioni femministe: articoli e prese di posizione che denotavano una chiara presa di coscienza sia politica sia di genere. Organizzate e consapevoli, si opponevano alla valutazione negativa che veniva data del loro lavoro: Le telegrafiste si ribellano ad un tale giudizio ed hanno tanta coscienza del loro dovere, hanno acquistato tanta esperienza del lavoro e della lotta quotidiana, da poter con piena cognizione di causa affermare che nessuna differenza invece esiste fra il lavoro compiuto dagli uomini e quello compiuto dalle donne […] concludendo e per rispondere a chi suggerisce al Ministro che le donne non rendono quanto gli uomini, noi diciamo che non credete a quello che dite. Voi sapete che della donna più docile per natura, più facilmente addomesticabile, per atavismo soggetta, potete farne più agevolmente uno strumento di produzione e sfruttamento e […] dopo aver accasermato gli uomini tenendoli in servizio tutto il giorno, è venuta la volta delle donne, le quali, finché non trionfi il principio che a uguale lavoro si deve corrispondere uguale mercede, voi cominciate col denigrarle nell’opera loro, per poterle meglio sfruttare.213 Oppure cercavano di attirare l’attenzione sugli aspetti più degradanti del loro lavoro: I sacrifici di ogni genere fatti per conservarsi il posto sono spesso fatti anche nel lodevole intento di procurarsi, dopo una vita di lavoro, un pane per la vecchiaia, mediante la pensione. Ma anche in questo lo Stato borghese e necessariamente sfruttatore, ha trovato il mezzo per eludere tali speranze. Con dei lunghi periodi di avventiziato, fuoriruolato o periodi consimili, non calcolati agli effetti della pensione, trova il mezzo di levare a queste disgraziate, oltre alla polpa della gioventù, anche l’ossame della vecchiaia.214 I ritmi incalzanti del lavoro da sbrigare, sotto l’incubo delle multe per gli errori o i ritardi, la rigida disciplina che imponeva il silenzio e la concentrazione costante, le difficoltà economiche che opprimevano quasi tutte le impiegate, le palesi ingiustizie che a causa del loro sesso erano costrette a subire, contribuivano a creare un clima di solidarietà e lo sviluppo di una forte coscienza politica. Le postelegrafoniche si mobilitarono con collette, articoli di denuncia, assemblee, scioperi e numerose campagne di solidarietà a favore di colleghe anziane a cui non veniva riconosciuto il diritto di pensione, a sostegno delle compagne punite con trasferimenti, multe e sospensioni perché 212 SOFIA BISI ALBINI, Le impiegate italiane, «Vita femminile», settembre 1910, citato in M.L. ODORISIO, Le impiegate del Ministero delle Poste cit., p. 415. 213 ROMELIA TROISE, In difesa del lavoro femminile, «L’Unione Postale e Telegrafica», 1° agosto 1903, citato in M. L. ODORISIO, Le impiegate del Ministero delle Poste cit., p. 418. 214 Le postelegrafoniche, «La Difesa delle Lavoratrici», 20 luglio 1917. Le redattrici della rivista delle donne socialiste espressero una sostanziale apertura verso le impiegate, anche se considerate appartenenti al ceto piccolo borghese, sostenendo la necessità di una lotta comune contro il precariato e lo sfruttamento. Cfr. F. TARICONE, «La difesa delle lavoratrici»: socialismo e movimento femminile, in «La Difesa delle Lavoratrici», reprint a cura di Giulio Polotti, Milano, Istituto europeo studi sociali, 1992, 3 voll. Tra due secoli 61 colpevoli di militare nel sindacato, per la statalizzazione del servizio delle centraliniste e per l’abolizione del divieto di matrimonio. Impararono, dunque, a difendersi e ad affermare i loro diritti di lavoratrici. Le maestre Quando lo Stato unitario, con la legge Casati,215 decise che l’istruzione elementare doveva diventare obbligatoria poteva disporre di 17.000 maestri mentre ne servivano almeno 50.000. Per colmare questo bisogno e formare al più presto il numero di insegnanti necessari, vennero istituite le cosiddette Scuole Normali triennali e comprensive di tirocinio.216 Dopo due anni di corso era previsto il conseguimento di una patente per l’insegnamento nel corso inferiore delle scuole elementari, al completamento dei tre anni quella per l’insegnamento nel corso superiore.217 Separate per sesso, come le classi di alunni a cui erano destinati gli insegnanti, le scuole prevedevano curricula studiorum diversificati: per le studentesse era prescritto un insegnamento «abbreviato ed alleggerito», adatto al cervello femminile.218 Era convinzione dei legislatori, all’epoca, che alle maestre servisse imparare solo quello che avrebbero dovuto insegnare – i rudimenti del leggere, dello scrivere e del far di conto – aggiungendovi la ‘naturale disposizione a educare’ i più piccoli e le bambine. Oltre che nelle scuole femminili, le donne potevano essere impiegate nelle scuole dette ‘rurali’, istituite in Comuni poverissimi, in genere composte da una sola classe di grado inferiore, seppur mista. Il fatto che le maestre potessero avere allievi maschi non mancò di suscitare allarmismi e proteste: era opinione comune che le donne mancassero di «quella forza morale che è pur indispensabile per mantenere la scolaresca disciplinata», oppure che presentassero una «snervante mollezza di carattere» che si rifletteva dolorosamente sugli alunni venendo meno l’esempio della forza, del coraggio, della fermezza, in una parola della virilità.219 Si evidenziava anche il pericolo che correva la moralità nelle classi maschili per la presenza o l’avvenenza delle insegnanti. Ma, ormai, le maestre 215 Regio decreto legislativo 13 novembre 1859, n. 3725 del Regno di Sardegna, entrato in vigore nel 1860 ed esteso, con l’unificazione, a tutta Italia. Con questa legge, che prese il nome dal ministro della Pubblica Istruzione Gabrio Casati, la formazione elementare venne demandata ai Comuni ed articolata in due cicli: uno inferiore, biennale, obbligatorio e gratuito, istituito nei luoghi in cui ci fossero almeno cinquanta alunni e uno superiore, anch’esso biennale, presente solo nei Comuni con popolazione superiore a 4.000 abitanti. 216 Potevano essere ammessi alle Scuole Normali, dopo aver superato un esame, ragazzi di 16 anni con la quarta elementare e ragazze di 15 – per la precoce maturità – in possesso della terza elementare. 217 Ci si rese presto conto, però, che, per l’alto ed importante compito a cui erano destinati gli insegnanti – formare i cittadini del nuovo Stato – essi abbisognavano di studi meno approssimativi e di maggior durata; di conseguenza, vennero potenziate le Scuole Normali ed i loro programmi. Nel 1883, inoltre, fu previsto un corso preparatorio intermedio per le ragazze, prima di due, poi di tre anni, tra le classi elementari e le Scuole Normali, e nel 1886 questo corso fu definito ‘scuola complementare’, riservata sempre alle sole ragazze e demandata alle iniziative delle singole città, in realtà insegnamento scadente e inadeguato (per i ragazzi il corso fu soppresso, perciò essi frequentavano le scuole tecniche o il ginnasio inferiore prima di iscriversi alla Normale). Fu anche abolita la patente inferiore e la Scuola Normale, fino allora distinta in inferiore e superiore, fu unificata. 218 AURORA DELMONACO, La signorina a quadretti e altre lavoratrici insegnanti, in Mondi femminili in cento anni di sindacato cit., pp. 209-272: 226. 219 La donna nel corso elementare maschile, «Il Rinnovamento scolastico», 1892, 2. 62 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale erano una realtà: nell’anno scolastico 1863-1864 rappresentavano il 46,2% degli insegnanti elementari (15.820 donne a fronte di 18.443 uomini); nel periodo 1875-1876 il 50,6% (23.818 donne contro 23.267 uomini), nell’arco temporale 1881-1882 il 55%; nel 1901 le maestre raggiunsero le 44.561 unità rispetto ai 21.178 maestri. In Emilia-Romagna le donne erano più dell’80% del personale insegnante delle scuole pubbliche a Piacenza e superavano il 70% a Bologna, Forlì, Modena, Ravenna, Reggio Emilia. Gli anni successivi avrebbero confermato la tendenza in atto, portando il numero delle maestre a 42.000 nel 1907 e 55.000 circa alla vigilia della prima guerra mondiale.220 D’altronde quella era pressoché l’unica professione non manuale «per la quale al vederla seguita da una donna non si gridasse allo scandalo»:221 veniva riconosciuta la sua ‘naturale vocazione’, esaltato il carattere tutto ‘materno’ del suo insegna- «Corriere delle maestre. Monitore didattico mento ma queste ‘virtù’ venivano settimanale illustrato», a. XXIV, n. 17, 20 considerate, fino alla legge Nasi del febbraio 1921, Istituto storico Parri 1903,222 comunque inferiori alle com- Emilia-Romagna, Bologna petenze maschili e retribuite perciò un terzo in meno di quelle, non sottovalutando perciò neppure la possibilità di risparmio per le finanze pubbliche, visto lo scarno salario erogato: a Bologna nel 1880 le maestre avevano uno stipendio che poteva variare dalle 1.000 alle 1.100 lire all’anno (800 le supplenti) a fronte di quello maschile che andava dalle 1.750 alle 1.550 (1150 i supplenti).223 L’esercito magistrale femminile, che aveva cominciato a formarsi, proveniva in misura consistente dai ceti medi224 per diversi fattori: da una parte, l’accesso all’istru220 S. SOLDANI, Maestre d’Italia, in Il lavoro delle donne cit., pp. 368-397: 377. GIULIO FASELLA, La riforma delle scuole medie e l’istruzione della donna, Milano, Vallardi, 1906, p. 7, citato in S. SOLDANI, Strade maestre e cammini tortuosi cit., p. 308. 222 Il decreto, che prese il nome dal ministro della Pubblica Istruzione Nunzio Nasi che lo emanò, stabilì l’equiparazione degli stipendi a parità di compiti. 223 Cfr. Tabella degli stipendi del personale insegnante nelle Scuole elementari del Comune di Bologna, in Piano organico. Regolamento disciplinare per le scuole elementari del Comune di Bologna, Bologna, Regia tipografia, 1880, p. 22. 224 Marcello Dei rileva la seguente provenienza di classe: borghesia 16,5%; piccola borghesia urbana 28,5%; piccola borghesia agraria 8%; classe media impiegatizia 35,5%; classe operaia 11,5%. Cfr. MARCELLO DEI, Le radici storiche delle maestre. Indagine sulle origini sociali degli insegnanti elementari dei primi decenni del 1900, «Polis», 1993, 1, citato in A. DELMONACO, La signorina a quadretti cit., p. 229. 221 Tra due secoli 63 zione aveva preparato a soluzioni lavorative diverse da quelle manuali che sarebbero state considerate inadeguate alla loro condizione sociale; dall’altra, le difficoltà economiche in cui si trovava all’epoca una fascia consistente di appartenenti alla piccola borghesia rendevano le famiglie meno rigide nel considerare lesivo del proprio onore il lavoro delle figlie che, tra l’altro, potevano avere impedimenti nello sposarsi proprio per i suddetti problemi economici che non permettevano di procurare una dote adeguata. Il lavoro, dunque, per queste giovani poteva diventare un modo per aiutare la famiglia e un elemento di relativa indipendenza da essa. Il fenomeno veniva così analizzato e commentato da Anna Kuliscioff: Queste povere classi medie che vanno in malora hanno pure figliole, senza dote e senza blasone, che non possono neppure sognare un modesto matrimonio e sono spinte volere o no ad invadere il campo professionale. Maestre che crescono come funghi […] che vengono osteggiate, derise e devono raccomandarsi a tutti i santi moderni, che si chiamano uguaglianza e libertà, per poter vivere modestamente e poter bastare a se stesse.225 Dunque, anche la carriera professionale delle maestre era «sparsa di tanti triboli»,226 per la misera situazione retributiva, le pessime condizioni di lavoro, le frequenti angherie delle autorità locali e dei superiori e la costante ostilità del clero che vedeva nell’insegnante della scuola pubblica un pericoloso tramite per la laicizzazione della società. L’esiguità dello stipendio percepito non riusciva a garantirne la sopravvivenza, spesso rendeva indispensabile l’esercizio di almeno una attività collaterale o la richiesta di un sussidio. Conferme di tale situazione provengono dalle numerose richieste di aiuti economici inoltrate alle pubbliche autorità: la trentenne Maria De Witt, traendo «i mezzi di sussistenza unicamente dalla propria occupazione di maestra comunale di Loiano con l’annuo stipendio di L. 660»227 e non vivendo a carico di parenti, fu costretta a chiedere, ottenendolo, un sussidio alla Regia beneficenza. La disperata situazione retributiva era conosciuta dai contemporanei se Matilde Serao, nel suo racconto Scuola Normale femminile, faceva morire la maestra Giulia Pessenda fra gli stenti, nella miseria assoluta a cui la condannava lo stipendio del comune di Olevano. La Pessenda non potendo aspettare il concorso, ha subito accettato il posto di maestra rurale, comune di Olevano, nel Cilento, con cinquecento franchi all’anno di retribuzione. Nel grave freddo di due anni fa, non aveva potuto ottenere una indennità per il fuoco di casa, dopo avere invano scritto più volte all’ispettore scolastico e al provveditore, per qualche sussidio, la vecchia madre le si è ammalata di bronchite e le è morta. Nell’anno seguente, il comune di Olevano, avendo dovuto sopportare qualche spesa maggiore nel bilancio, ha diminuito di cento lire la retribuzione della maestra elementare; la Pessenda è rimasta, con- 225 ANNA KULISCIOFF, Il sentimentalismo nella questione femminile, «Critica sociale», 1892, 9, citato in M.L. ODORISIO, Le impiegate del Ministero delle Poste cit., p. 402. 226 ARISTIDE GABELLI, L’Italia e l’istruzione femminile, «Nuova Antologia», V, 1870, p. 154, citato in L. SCARAFFIA, Essere uomo, essere donna cit., p. 50 e in ILARIA PORCIANI, Sparsa di tanti triboli: la carriera della maestra, in Le donne a scuola. L’educazione femminile nell’Italia dell’800, a cura di I. Porciani, Firenze, Il sedicesimo, 1987, pp. 170-173: 170. 227 Lettera della Questura del circondario di Bologna al Prefetto, Bologna, 26.1.1902, in ASBo, Gabinetto di Prefettura, serie 1020, cat. 10 «Domande di impiego», fasc. «Ministero Pubblica Istruzione, sottofasc. 3 «Casa Reale», 1902. 64 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale tentandosi di quello, in mancanza di meglio […]. Nell’estate ultima la Pessenda non ha usufruito delle vacanze non avendo forse i mezzi per recarsi in Piemonte; nell’agosto è stata presa dal tifo petecchiale, che è stato mal curato dal medico condotto. Essendosi nel paese diffusa la voce che la sua malattia era contagiosa, ella è stata abbandonata da tutti […] quindi non si può ben accertare il giorno della sua morte, avendola poi ritrovata morta e quasi nera, sul letto, in una stanza senza mobiglio, con le finestre aperte e un lume spento, per terra, in un angolo.228 I frequenti spostamenti delle sedi di servizio, l’impossibilità di fare carriera si andavano ad aggiungere a carichi eccessi di lavoro: orari lunghi, il più delle volte raddoppiati con le classi serali; corsi spesso sovraffollati, con sessanta e più bambini, in cui le maestre erano obbligate a seguire contemporaneamente i piccoli che imparavano a fare le aste e i più grandi che compitavano sui loro sillabari; scolari talvolta di difficile controllo perché costretti in stanze buie e malsane. Ma soprattutto, specie se giovani e non sposate,229 potevano essere oggetto di pesanti attenzioni e di ricatti a sfondo sessuale da parte delle autorità (Sindaci ed ispettori scolastici), dalle quali dipendevano per la conferma del posto di lavoro. Anche quando non venivano cacciate dai villaggi230 e non erano obbligate a dare prove umilianti della propria verginità per sfatare le maldicenze231 – come documentano abbondantemente le cronache del tempo – le maestre, soprattutto nelle campagne, erano guardate con sospetto e spesso giudicate dalla ipocrita morale dell’epoca. Emilia Mariani, tra le principali protagoniste delle prime associazioni magistrali in Italia, così descriveva le pesanti esperienze delle giovani: Le poverette con rara abnegazione si disponevano al duro e faticoso ufficio, abbandonando casa, parenti, amici, per andare in lontani posti sconosciuti, dove avrebbero avuto bisogno di protezione, di aiuto, di consiglio, e invece non trovavano sovente che malvagità e ignoranza, ed erano perseguitate, tormentate, sedotte.232 Il loro contegno veniva attentamente analizzato e controllato, il comportamento tenuto doveva dimostrarsi ineccepibile poiché essa «ha debiti gravi verso gli allievi, verso il prossimo, verso il mondo intero che ha diritto di attendere da lei nella giovane generazione un miglioramento nel bene».233 Un esempio su tutti: le informazioni 228 M. SERAO, Scuola Normale Femminile, «Nuova Antologia», 1º gennaio 1885, pp. 482-483. Il nubilato di molte maestre era spesso legato alle difficili condizioni di lavoro. 230 Un esempio su tutti: nel 1898, in un piccolo centro nei pressi di Pordenone, la prima maestra, benché accompagnata dal Sindaco e dall’Ispettore scolastico, era stata ricevuta «da una sessantina di persone che, radunate in sulla piazza, battevano la tarantella gridando No volemo la maestra, fuori la maestra, mentre in su la piazza stessa sorgeva un palo con all’estremità un pezzo di corda e un cartello che diceva: Se la maestra verrà sarà schernita e bruciata», citato in «Il Corriere delle maestre», 1898. La dinamica di questo episodio rientra nei rituali con i quali la cultura contadina tradizionale stigmatizzava lo sconfinamento dei comportamenti previsti per i rispettivi generi. Cfr. a tale proposito L. SCARAFFIA, Essere uomo, essere donna cit., p. 53. 231 Esemplare a questo proposito la vicenda di Itala Donati, maestra nel 1883 in un Comune del pistoiese e costretta dal Sindaco, noto donnaiolo, ad abitare accanto a casa sua. In seguito alle maldicenze che si diffusero si suicidò, lasciando alcune lettere nelle quali protestava la propria innocenza, confermata poi dall’autopsia. Il clamore suscitato dal fatto fu altissimo. Cfr. GIORGIO BINI, La maestra nella letteratura: uno specchio della realtà, in L’educazione delle donne cit., pp. 331-362. 232 EMILIA MARIANI, Per le maestre, «Il Rinnovamento scolastico», 19 agosto 1893. 233 A proposito delle maestre, «Giornale delle donne», 19 novembre 1886. 229 Tra due secoli 65 GIUSEPPE FANTUZZI, Alunni di una scuola di Reggio Emilia, ca. 1910, Fototeca della Biblioteca Panizzi, Reggio Emilia 66 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale predisposte dalla delegazione di Pubblica Sicurezza di Molinella nel settembre 1898 su Alessandrina Deserti, aspirante moglie di un brigadiere dei carabinieri, ne sottolineavano la perfetta condotta morale, tale da impedire qualsiasi diceria che avrebbe potuto derivare dalla attività professionale svolta. La ragazza, ventiseienne maestra elementare a San Martino in Argine, conduceva infatti vita ritirata «e quasi esclusivamente di scuola e famiglia, evitò sempre anche le malignità e dicerie facili a correre nei piccoli paesi».234 Nonostante le situazioni che si trovavano a dover affrontare, o forse proprio a causa di queste, nel corso degli ultimi anni dell’Ottocento le maestre cominciarono a battersi per avere condizioni di lavoro meno precarie, più dignitose, per far meglio valere i propri diritti, organizzandosi in associazioni di categoria e mutuo soccorso e osando denunciare apertamente le situazioni di illegalità più clamorose di cui erano vittime. Si andarono così costituendo nel 1901 l’Unione nazionale delle maestre e dei maestri, più tardi Unione Magistrale Nazionale, il cui primo congresso venne proprio tenuto a Bologna, e l’Associazione Niccolò Tommaseo che, dal luglio del 1906, aggregò gli insegnanti cattolici.235 Nello stesso periodo, a Bologna, la Società degli insegnanti – fondata fin dal 29 giugno 1862 ma per soli fini culturali – mutò di indirizzo maturando strategie e iniziative di assistenza e previdenza tra i soci. Il sodalizio si sciolse nel 1919 per dare vita alla Federazione dei maestri della provincia di Bologna che ne assunse il patrimonio, gli oneri e le finalità, continuandone l’opera. Le due associazioni ebbero un peso determinante nell’orientamento pedagogico e didattico locale.236 Nel 1897, poi – accanto alle riviste di settore più ricche di informazioni, di proteste, di proposte come «Il Risveglio educativo» e «Il rinnovamento scolastico» – compariva, pubblicato dall’editore Vallardi, il «Corriere delle maestre» che, rivolto a donne e pensato in primo luogo per loro, ma diretto e fatto quasi esclusivamente da uomini, si caratterizzò inizialmente per il racconto di esperienze di vita, per gli appelli alla solidarietà che avevano al centro casi eclatanti di soprusi, insomma per la capacità di coinvolgere in campagne di opinione di grande respiro quelle insegnanti che, dal punto di vista politico e culturale, potevano restare decisamente periferiche.237 La presenza di questa «falange ardita, attiva, intelligente» di maestre consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri, «franche e ferme»238 nel rivendicarli, portò all’obbligo del concorso per le assunzioni del 1885, ai miglioramenti salariali fissati nel 1886, alle norme introdotte nel 1893 per ridurre «l’indecente indugio» di molte amministrazioni nel pagamento degli stipendi, alla legge di revisione del monte-pensioni nel 1894 e alle riforme che, tra il 1903 e il 1911,239 oltre a fissare procedure più rigide per 234 Lettera della R. Delegazione di Pubblica Sicurezza di Molinella al Questore, Molinella, 12 settembre 1898, in ASBo, Gabinetto di Questura, serie 249, cat. 9/B «Informazioni», 1898. 235 A tale proposito cfr. ESTER DE FORT, L’associazionismo degli insegnanti elementari dall’età giolittiana al fascismo, «Movimento operaio e socialista», 1981, 4, pp. 375-404. 236 Nel 1894 venne costituita la Federazione Magistrale Emiliana. Cfr. MIRELLA D’ASCENZO, La Scuola elementare nell’età liberale. Il caso Bologna 1859-1911, Bologna, Clueb, 1997. 237 Su questo tema cfr. S. SOLDANI, Maestre d’Italia cit., p. 387. 238 E. MARIANI, Il pareggiamento degli stipendi fra maestri e maestre, 1905, in EADEM, Ascensione femminile, Torino, Comitato pro Voto Donne, 1918, p. 97 e p. 104. 239 Nel 1911 con la legge Daneo-Credaro (dai nomi dei ministri della Pubblica Istruzione Eduardo Daneo e Luigi Credaro che la promossero) il pagamento degli stipendi degli insegnanti elementari fu avocato allo Stato, sottraendo le maestre all’arbitrio delle amministrazioni locali e avallando così la stabilità d’impiego. Tra due secoli 67 i concorsi e garanzie più puntuali per la stabilizzazione del posto di lavoro, sancirono il diritto delle maestre a ricevere retribuzioni uguali a parità di lavoro svolto e di accedere alla ‘carriera’ di direttrici didattiche.240 Le donne si organizzano Le associazioni In Italia la spinta propulsiva all’associazionismo femminile avvenne all’indomani dell’Unità. Erano soprattutto le intellettuali che, unite in sodalizi, cercavano di avviare la costruzione e la diffusione di nuovi modelli di comportamento e di nuovi rapporti tra donne, per farle emergere dalla marginalità in cui leggi, costumi e organizzazione sociale le costringevano.241 La loro azione era tesa a creare strutture di sostegno, di assistenza e di educazione dirette a donne del proletariato o appartenenti alla piccola borghesia al fine di fornire loro strumenti teorico-pratici utili per affrontare le battaglie per la rivendicazione dei diritti politici e civili tra cui emergeva quello relativo al lavoro. Attorno ai primi anni Ottanta dell’Ottocento si costituivano, per questo fine, le Leghe di tutela degli interessi femminili, associazioni fondate e dirette da donne, formatesi in diverse città italiane, soprattutto ad opera di maestre, di lavoratrici del terziario – telegrafiste, impiegate, ecc. – e di alcune operaie.242 Anna Maria Mozzoni, insieme a Paolina Schiff, fondavano a Milano nel 1881 la Lega promotrice degli interessi femminili che operò per circa dieci anni; alla Lega fu affiancata l’Unione delle lavoranti, riservata alle sole lavoratrici, per promuoverne i miglioramenti nelle condizioni salariali e di orario di lavoro, e per sostenere con sussidi le socie disoccupate. All’Unione delle lavoranti aderirono le sigaraie milanesi che, dalla spontaneità delle prime proteste, si aprivano a forme di attività organizzata, mentre nel 1883 si costituiva sempre a Milano, per impulso di Paolina Schiff, uno dei primi sindacati femminili di categoria, quello delle orlatrici.243 Nel 1884 esistevano ormai «parecchi sodalizi di donne, amministrate dalle sole operaie le quali volentieri rubano qualche ora dedicata al riposo per accudire ai bisogni sociali e al comune benessere».244 240 S. SOLDANI, Maestre d’Italia cit., p. 385 e p. 388. Cfr. A. BUTTAFUOCO, La filantropia come politica. Esperienze dell’emancipazionismo italiano nel Novecento, in Ragnatele di rapporti. Patronage e reti di relazione nella storia delle donne, a cura di Lucia Ferrante, Maura Palazzi, Gianna Pomata, Torino, Rosenberg & Sellier, 1988, pp. 166-187. 242 A. BUTTAFUOCO, Cronache femminili. Temi e momenti della stampa emancipazionista in Italia dall’Unità al fascismo, Arezzo, Dipartimento di studi storico-sociali e filosofici, Università degli studi di Siena, 1988, p. 55. A partire dalla loro costituzione è possibile parlare correttamente di ‘movimento politico delle donne’ in Italia sia perchè per la prima volta gruppi prevalentemente femminili si strutturavano intorno ad un tema comune, l’emancipazione delle donne, sia per la loro presenza relativamente diffusa su territorio nazionale; sia per un tentativo di coordinamento che fu perseguito. 243 BARBARA IMBERGAMO, ANNA SCATTIGNO, «Una forza nuova». Le donne nel movimento dei lavoratori dalle prime organizzazioni alla repressione fascista, in Donne nella CGIL: una storia lunga un secolo. 100 anni di lotte per la dignità, i diritti e la libertà femminile, a cura di Lucia Motti, Roma, Ediesse, 2006, pp. 169-199: 170. 244 Dalla testimonianza di una sigaraia all’inaugurazione ufficiale della Fratellanza artigiana femminile (5 ottobre 1884), in F. PIERONI BORTOLOTTI, Alle origini del movimento femminile in Italia (1848-1892), Torino, Einaudi, 1963, p. 194. 241 68 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale GIUSEPPE FANTUZZI, Socie e sede della Società nazionale di patronato e mutuo soccorso delle giovani operaie a Reggio Emilia, ca. 1900, Fototeca della Biblioteca Panizzi, Reggio Emilia A Bologna, già nel 1890, era attivo un Comitato per il miglioramento delle condizioni della donna; a Milano, nel 1893, fu fondata la Lega per la tutela degli interessi femminili, composta da un comitato di donne che si riconoscevano nel Partito socialista, la cui segretaria era Linda Malnati. L’associazione aveva «per principio la causa femminile» e la sua attività si articolava su un programma minimo di intervento pratico locale, che prevedeva l’istituzione di una cassa di beneficenza, una campagna per il miglioramento delle condizioni morali ed economiche delle maestre d’asilo, delle telegrafiste, delle telefoniste, l’istruzione professionale per le figlie delle operaie, l’ammissione delle donne ai consigli di amministrazione delle opere pie e corsi di istruzione e di aggiornamento. Una Lega con scopi affini nacque a Torino nel 1894 per opera di Emilia Mariani e Irma Scodnik che, l’anno successivo, promossero la formazione di associazioni simili a Venezia, Roma, Napoli e Palermo. Nel maggio 1898 le Leghe femminili, considerate sovversive, furono sciolte d’autorità e ciò avrebbe indotto molte emancipazioniste a puntare più sul carattere operativoassistenziale del loro intervento che non su quello propriamente politico. In questo senso fu fondata, nel 1899 a Milano, l’Unione femminile, da un gruppo di donne diverse per estrazione sociale e formazione culturale: Ersilia Majno Bronzini, Nina Rignano Sullam, Ada Garlanda Negri, Adele Riva, Rebecca Calderini, ecc. L’associazione si diffuse presto in altre città italiane, ad esempio a Roma, la cui sezione era presieduta da Anna Celli. Per le donne dell’Unione, il lavoro femminile aveva un valore in sé, non solo e non unicamente come contributo al bilancio familiare, per cui tendevano a rendere professionali, attraverso una serie di corsi teorico-pratici, attività tradizionali245 e a creare 245 Ad esempio, per le domestiche veniva attivata una struttura di scuola-convitto tra le più moderne e stabili nel tempo. Era, infatti, ancora fiorente nel 1938 quando il regime fascista obbligò l’Unione a sciogliersi. Cfr. A. BUTTAFUOCO, La filantropia come politica cit., p. 177. Tra due secoli 69 nuovi mestieri. Preparavano ispettrici di fabbrica per l’applicazione delle norme sul lavoro femminile, ancor prima che la legge le prevedesse; infermiere laiche quando negli ospedali erano presenti soprattutto suore; visitatrici delle carceri e delegate del Comune per indagini sulle condizioni di vita e di lavoro nei quartieri più poveri, ecc. Una caratteristica peculiare dell’Unione era, infatti, proprio quella di professionalizzare ed istituzionalizzare la tradizionale presenza delle donne in campi lavorativi dove venivano richieste ‘sensibilità e pietà’, lavori che la modernità richiedeva ormai di essere condotti con criteri nuovi e scientifici, e non più soltanto seguendo ruoli sociali stereotipati, lavori che per le donne dell’Unione dovevano essere pagati adeguatamente perché utili alla collettività e quindi produttivi. Uno sguardo sommario all’insieme delle attività delle organizzazioni emancipazioniste mette in luce la grande varietà di iniziative che venivano impostate con programmi rispondenti a diverse esigenze, ma un dato emerge chiaro: anche nelle associazioni più piccole e periferiche convivevano, anzi erano strettamente interdipendenti, le campagne per la ricerca della paternità con l’aiuto concreto alle madri nubili; le agitazioni per il diritto di voto con i corsi professionali per le operaie o di istruzione politica sui diritti delle lavoratrici.246 L’opera dell’emancipazionismo assumeva forme e contenuti più originali proprio nel settore della preparazione al lavoro per il quale, accanto ad iniziative di taglio più tradizionale, si andavano sperimentando modalità di intervento e progetti del tutto nuovi. Queste associazioni avevano colto con lucidità nel lavoro, accanto all’istruzione, la via di accesso all’emancipazione femminile. Nello stesso periodo, proprio per far fronte alle drammatiche condizioni di fatica e sfruttamento a cui erano sottoposte le donne nel lavoro industriale, venivano create, per iniziativa spontanea delle lavoratrici o su stimolo di figure eminenti mosse da fini filantropici, le prime Società di mutuo soccorso femminili – sia di orientamento laico sia religioso – caratterizzate da finalità di sostegno e reciproco aiuto tra le iscritte. A quella bolognese, costituitasi negli anni Settanta dell’Ottocento, avevano aderito donne soprattutto dei ceti popolari: sarte, cucitrici, cameriere, orlatrici, lavandaie, sigaraie, insegnanti, modiste, stiratrici che «al febbraio 1878 ammontavano alla cifra considerevole di 864».247 Accanto a questi sodalizi si andavano organizzando le Leghe di resistenza, senza le quali, veniva osservato nel 1890, «la battaglia del lavoro purtroppo è sempre una sconfitta»,248 caratterizzate da una esplicita connotazione di classe e da finalità e azioni decisamente rivendicative. Già dalla metà degli anni Ottanta dell’Ottocento ne esistevano diverse di sarte, di sigaraie, di cucitrici.249 Le Camere del Lavoro, che nacquero a partire dai primi anni Novanta dell’Ottocento (in Emilia-Romagna, a Piacenza nel 1891 e a Bologna nel 1893), offrivano sostegno e coordinamento agli scioperi e alle azioni delle Leghe nei centri urbani e nelle campagne, dove anche le donne del bracciantato si andavano organizzando, in particolare nella Pianura padana. L’importanza di queste associazioni nei primi anni del Novecento è testimoniata anche e soprattutto dal numero delle loro iscritte: nelle Leghe agricole le donne erano circa 246 Ivi, pp. 177-178. Rapporto sulla gestione e sull’operato della Società operaia di Bologna nel 1877 del presidente avv. Ferdinando Berti all’assemblea delle sezioni riunite maschile e femminile del 25 marzo 1876, Milano, [s.n.], 1878, p. 35. 248 F. PIERONI BORTOLOTTI, Alle origini del movimento femminile in Italia cit., p. 196. 249 Cfr. S. MERLI, Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale, vol. II, Documenti, cit., pp. 142, 245, 431. 247 70 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale 92.000 pari al 21,6% degli iscritti, ed erano circa 50.000, pari al 10,1% degli iscritti, in quelle operaie.250 La distribuzione regionale conferma quella geografia di presenze organizzate e di lotte al femminile di cui si sono indicati i lineamenti in precedenza. In Emilia si contava l’adesione più alta delle donne alle Leghe agricole251 (74%, vale a dire 68.827 iscritte), regione dove era preponderante il fenomeno del bracciantato, legato all’affermazione di una agricoltura capitalistica, e nella quale si ebbe più intensa e rapida la diffusione delle idee socialiste e la contrapposizione tra lavoratori e padronato. Nell’industria l’adesione delle donne alle Leghe era distribuita in modo più uniforme, con punte più alte in Lombardia (29,5%) ma l’Emilia era al secondo posto col 23,5% (vale a dire 12.026 iscritte).252 Il 26,4% delle lavoratrici dell’industria iscritte alle Leghe appartenevano al settore della filatura, tessitura e tintoria, il 16,8% alle manifatture tabacchi. Nel 1903 si era poi costituito a Roma il Consiglio nazionale delle donne italiane, presieduto da Gabriella Spalletti Rasponi. Il comitato promotore, composto per lo più da donne dell’aristocrazia, si era formato nel 1899 per impulso dell’International Council Women, la prima organizzazione internazionale del movimento suffragista nata negli Stati Uniti nel 1888. Il comitato promotore aveva dato vita, nel corso del tempo, alla Federazione romana delle opere di attività femminili, presieduta da Lavinia Taverna, e alle federazioni lombarda, diretta da Sabina Parravicino di Revel e piemontese, coordinata da Giulia Bernocco Fava Parvis.253 Le posizioni moderate dell’associazione vennero alla luce durante il primo Congresso nazionale delle donne italiane, organizzato proprio dal Consiglio nazionale nell’aprile del 1908 a Roma. La stessa presidente, nel suo discorso di apertura dei lavori, dichiarava: «se rivendichiamo per la donna alcuni diritti è perché la crediamo pronta a sostenere i nuovi doveri che la moderna civiltà le impone senza che per questo abbia a dimenticare quelle che furono e saranno sempre le più belle delle sue glorie: la maternità e l’educazione dell’uomo».254 Le donne parevano essere nelle condizioni di dover dare garanzie sull’uso che avrebbero fatto dei diritti eventualmente concessi loro. Da qui l’impegno alla salvaguardia del ‘naturale’ destino di madre della donna. Ciononostante, il Congresso fu una occasione importante: diede voce e visibilità a donne, non qualificabili né per appartenenza politica né per categoria di lavoro, che agivano in una situazione pubblica e politica, in una sfera che per definizione era propria dell’uomo e negata alla donna. Intanto, tra la fine degli anni Novanta dell’Ottocento e l’inizio del Novecento si andava definendo la linea di intervento del movimento cattolico sulla ‘questione’ fem250 L’unica fonte utile che fornisce dati omogenei in ambito nazionale è quella compilata dal Ministero dell’Interno nel 1910, ma con dati del 1908, che fa riferimento alle donne iscritte alle Leghe dei lavoratori in agricoltura e nell’industria. La fonte non fa distinzione tra Leghe di ispirazione socialista e quelle di ispirazione cattolica, diffuse in particolare nel Veneto e nel settore tessile. Cfr. MINISTERO DELL’INTERNO, Dati statistici riassunti per provincie e per compartimenti relativi alle condizioni intellettuali e morali della donna ed alla partecipazione di essa ad alcuni fatti della vita sociale. Raccolti per la Commissione ministeriale incaricata di esaminare se e in quali limiti convenga di estendere alla donna il voto amministrativo, Roma, 1910, pp. 36-37, citato in Donne nella CGIL: una storia lunga un secolo cit., pp. 198-199. 251 All’Emilia seguivano la Lombardia con l’8,3% e la Puglia con il 6,3%. 252 A queste regioni seguiva il Piemonte con il 14,2%. 253 Cfr. F. TARICONE, L’associazionismo femminile italiano dall’Unità al fascismo, Milano, Unicopli, 1996. 254 GABRIELLA SPALLETTI RASPONI, Intervento al Congresso femminile di Roma, «Pensiero e azione», 10-25 maggio 1908, p. 4. Tra due secoli 71 ROBERTO SEVARDI, Soci e socie della Società di mutuo soccorso barbieri e parrucchiere di Carpineti, ca. 1920, Fototeca della Biblioteca Panizzi, Reggio Emilia minile. Anche per i cattolici uno dei punti di partenza nella riflessione e nell’azione era rappresentato dal problema del lavoro delle donne e della sua possibile limitazione. La pubblicazione della Rerum Novarum, nel maggio del 1891, costituendo il riferimento teorico principale e una legittimazione all’azione dei cattolici nel sociale, rappresentò una guida anche su tale specifico problema. Quanto alla vera e propria organizzazione delle donne, sul finire del secolo essa si articolò in varie forme: si costituirono sezioni femminili nei comitati diocesani dell’Opera dei Congressi, su espresso invito di Monsignor Radini Tedeschi, che aveva colto l’importanza di una iniziativa propositiva dei cattolici sul posto della donna nella società moderna; mentre, nell’ambito del movimento democratico cristiano, si formarono organizzazioni in cui si cominciò a parlare di ‘femminismo cristiano’.255 Numerose operaie e lavoratrici agricole aderirono ai Fasci femminili democraticocristiani, mostrando di se stesse ««un’immagine del tutto nuova; anch’esse erano uscite di casa, tenevano discorsi e conferenze in pubblico, scrivevano sui giornali, viaggiavano», sia pure nello spirito ‘missionario’ dell’opera di cristianizzazione della società, messa a rischio dalla diffusione di idee socialiste, e nella difesa del primato della famiglia come luogo proprio di espressione della donna. Le più attive in queste organizzazioni si muovevano tra le proletarie con una attenzione particolare al ruolo della donna, alla sua nuova identità, al lavoro extra-domestico, visto come un dato, magari di segno negativo, ma in qualche modo irreversibile e carico di conseguenze per la condizione sociale e i diritti femminili.256 255 A tale proposito cfr. PAOLA GAIOTTI DE BIASE, Le origini del movimento cattolico femminile, Brescia, Morcelliana, 1963. 256 A. BUTTAFUOCO, Cronache femminili cit., pp. 72-73. 72 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale Fu questa attenzione alla drammatica condizione delle donne lavoratrici che portò il gruppo raccolto intorno ad Adelaide Coari, iniziatrice del Fascio democratico-cristiano femminile di Milano e animatrice della Federazione femminile cattolica milanese, a maturare posizioni più schiettamente ‘femministe’. Così al primo Convegno femminile nazionale (1907), promosso dalla Federazione femminile cattolica milanese, a cui aderirono sia l’Unione femminile sia il Consiglio nazionale delle donne, veniva presentato e discusso quel ‘programma minimo femminista’ che testimoniava l’acquisita consapevolezza, da parte delle cattoliche, dello spessore civile e politico della ‘questione’ femminile e che poteva segnare l’inizio di un dialogo e di una collaborazione fra le diverse correnti del nascente femminismo italiano. In grande sintesi i punti del programma erano: parità salariale, ampliamento e riforma dell’istruzione femminile, riforma del codice civile e penale (nel senso di autorizzare la donna sposata a disporre dei propri beni e di introdurre la ricerca di paternità), infine, il voto amministrativo.257 Soltanto un anno dopo, invece, con le polemiche sull’insegnamento religioso emerse durante il Congresso femminile romano, ogni ipotesi di largo consenso programmatico venne a cadere.258 Le cattoliche uscirono, per iniziativa personale e per imposizione delle gerarchie ecclesiastiche, dal movimento emancipazionista dando vita all’Unione tra le donne cattoliche d’Italia, di impronta prettamente confessionale, che ben poco manteneva di quel programma minimo di rivendicazioni che il primo femminismo cristiano aveva elaborato.259 La stampa femminile e il lavoro Nel periodo preso in esame comparvero riviste politiche, espressione dell’associazionismo emancipazionista, diverse da quelle delle donne militanti nel movimento socialista o in quello cattolico, diverse ancora dai bollettini delle organizzazioni di categoria delle lavoratrici. Le prime ad uscire furono proprio le riviste legate al mondo del lavoro femminile. Tra Ottocento e Novecento, quando le donne ebbero accesso a varie attività, iniziarono a venire pubblicati i primi giornali professionali e sindacali che non soltanto curavano l’aggiornamento tecnico-scientifico, ma affrontavano i problemi più generali della categoria, da quelli organizzativi a quelli retributivi. Tra questi il «Giornale per le Levatrici» (1887), primo esempio in Italia di una stampa specializzata di tal genere,260 e «Il Corriere delle maestre» (1897) il cui obiettivo era di offrire alle insegnanti italiane consigli didattici e notizie del mondo scolastico.261 L’esperienza di questi primi periodici non rimase isolata. Ad essi, infatti, ne seguirono altri, soprattutto dopo la prima guerra mondiale, che coinvolgevano diverse categorie professionali come «La Voce delle impiegate» (1919) il cui scopo era di sensibilizzare le ‘signorine mezzemaniche’ riguardo ai propri problemi lavorativi, «La Berrettaia» 257 Ivi, p. 82. La proposta di Linda Malnati di abolire l’obbligatorietà dell’insegnamento religioso nella scuola per introdurvi invece lo studio comparato della storia delle religioni fu votata a maggioranza e produsse quella spaccatura definitiva con le cattoliche. 259 Cfr. CECILIA DAU NOVELLI, Società, Chiesa e associazionismo femminile, Roma, AVE, 1988. 260 Cfr. paragrafo Le levatrici. 261 Cfr. paragrafo Le maestre. 258 Tra due secoli 73 (1922), organo della Società di Mutuo Soccorso delle lavoratrici di Milano; «La Risaiola» pubblicato a Lodi (1919) in cui comparivano notizie prevalentemente sindacali ed informazioni legali sui diritti delle mondine. Mentre il primo gravitava in aerea socialista, il secondo era collegato all’attività di Leghe operaie di ispirazione cattolica, come pure «La donna nei campi», supplemento de «La Terra», pubblicato a Roma nel 1919. Più squisitamente politici furono i periodici nati durante la stagione emancipazionista dalla seconda metà dell’Ottocento. Fare un giornale per le donne e magari scritto da donne si confermava essere una importante operazione culturale, in cui trovavano spazio le voci sia dei movimenti delle donne di matrice democratica, socialista o cattolica.262 Il periodico più rilevante di questo primo periodo fu sicuramente «La donna», fondato e diretto da Gualberta Alaide Beccari.263 Il primo numero uscì a Padova il 22 aprile 1868, poi la rivista seguì le sorti della sua fondatrice che si trasferì prima a Venezia e infine a Bologna, dove la rivista fu pubblicata fino al 10 agosto 1891, con periodicità settimanale e poi quindicinale.264 L’intento principale era quello di informare ed educare la donna in tutti gli ambiti perché, come scriveva Beccari: «tutto è quistione di educazione. I più ardui problemi sociali non attendono la loro soluzione se non dall’educazione individuale e collettiva».265 Dopo il trasferimento della redazione a Bologna, l’impegno politico della rivista si fece più specifico e una attenzione particolare venne rivolta alle lotte del mondo del lavoro. Tra le collaboratrici del periodico emergevano i nomi delle principali protagoniste del femminismo ottocentesco tra cui: Anna Maria Mozzoni, Giorgina Saffi, Giulia Cavallari Cantalamessa, Malvina Frank ed Ernesta Napollon.266 Il ventennio tra gli anni Novanta dell’Ottocento ed i primi dieci anni del Novecento rappresentò un periodo cruciale per il movimento femminile: l’emancipazionismo si andò strutturando in organizzazioni che, pur operando su base locale, tendevano a coordinarsi in associazioni nazionali, fenomeno che ebbe il suo pieno sviluppo nel primo Novecento. Alla stampa veniva dunque attribuito un ruolo fondamentale: informazione, collegamento tra gruppi, discussione, elaborazione culturale. All’inizio del nuovo secolo nacquero contemporaneamente e in breve successione una trentina di testate di diverso indirizzo: laiche e riferibili all’emancipazionismo democratico, come «L’Unione femminile» (1901), «La voce della donna» (1903), «Cronache femminili» (1904), «L’Alleanza» (1906); socialiste, come: «Eva» (1901), «L’operaia socialista» (1902), «La donna socialista» (1905); cattoliche, come «L’Azione muliebre» (1901), «La donna» (1902), «Pensiero e Azione» (1904). Per la prima 262 Cfr. A. BUTTAFUOCO, Cronache femminili cit., pp. 23-24. Il sottotitolo cambiò nel corso del tempo: dapprima «Periodico morale e istruttivo», divenne più tardi «Periodico di educazione compilato da donne italiane» e infine, dopo un decennio di pubblicazioni, «Propugna i diritti femminili». 264 Nello stesso periodo venivano, inoltre, pubblicate altre testate: «La donna. Giornale per l’emancipazione della donna» di Firenze, diretta da Adolfo Scander Levi; «La Cornelia», «Cordelia», «L’Aurora», «Il giornale delle donne», «La missione della donna», «La Rassegna degli interessi femminili». Quanto ai contenuti, questi non avevano, in complesso, «elementi che li differenziassero in modo tale da segnare nettamente una loro fisionomia specifica». A. BUTTAFUOCO, Cronache femminili cit. p. 26. 265 GUALBERTA ALAIDE BECCARI, Alle mie associate, «La donna», 15 ottobre 1878. 266 Cfr. B. PISA, Venticinque anni di emancipazionismo femminile in Italia. Gualberta Alaide Beccari e la rivista «La Donna» (1868-1890), Roma, Quaderni Fiap, s.d. [1983]. 263 74 «La Donna. Propugna i diritti femminili», a. XIV, serie II, n. 1, 5 dicembre 1883, Biblioteca Universitaria, Bologna Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale «L’azione muliebre. Organo del femminismo cristiano», a. I, n. 2, 1º febbraio 1901, Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze volta, infatti, si produceva una stampa specificatamente rivolta alle donne sia nell’ambito del movimento socialista sia di quello cattolico. Ai primi del secolo i giornali socialisti per le donne nacquero per iniziativa e sforzo personale di alcune militanti come la ferrarese Rina Melli la quale, lanciando «Eva» nel 1901, scriveva con orgoglio che il nuovo settimanale era il primo nell’ambito della ricca stampa socialista «fatto esclusivamente per le donne».267 Sempre a Ferrara – mentre «Eva» veniva trasferito a Genova, dove fu pubblicato fino al 23 agosto 1903 – uscì nel 1902 il quindicinale «L’operaia socialista», per iniziativa di Giuseppe Tamarozzi, libraio. Esistenza stentata ebbe anche «Anima e vita» diretto da Ernestina Lesina, che uscì a Piacenza soltanto per sei numeri (dal luglio all’ottobre del 1902).268 Sorte analoga, sebbene meno precaria, toccò al settimanale «La donna socialista», uscito dal luglio del 1905 all’aprile del 1906 grazie al lavoro di Ines Oddone Bitelli. Il foglio bolognese era destinato soprattutto alle lavoratrici e attento a valorizzare «l’immagine di una donna moderna […] produttrice di ricchezza sociale, compagna dell’uomo e lavoratrice intelligente ed energica che assume 267 Volantino di propaganda a stampa, Ferrara, 1901, citato in A. BUTTAFUOCO, Cronache femminili cit., pp. 67-68. 268 Ivi, p. 69. Tra due secoli «La Difesa delle Lavoratrici», a. 1, n. 1, 7 gennaio 1912, Fondazione Istituto Gramsci Emilia-Romagna, Bologna 75 «Parva favilla. Organo bimensile dell’Unione femminile cattolica italiana per la città e diocesi di Bologna», a. III, n. 12, 25 giugno 1920, Biblioteca Universitaria, Bologna nella vita la sua piena responsabilità».269 Un osservatorio particolare, spesso presente in questi giornali, era quello legato al mondo del lavoro femminile; non mancavano quasi mai pagine dedicate alle lotte per l’occupazione e per il miglioramento delle condizioni di vita sia nelle fabbriche sia nelle campagne. Il fatto nuovo fu la nascita, nel gennaio 1912, de «La Difesa delle Lavoratrici». «Oppresse e sfruttate», «perpetuamente dimenticate» e «assenti dalla vita vera» del paese, con il nuovo foglio «le donne del lavoro» avrebbero avuto modo «di far sentire alfine la loro voce».270 Il giornale, stampato a Milano dalla tipografia della società editrice dell’«Avanti!», era diretto da Anna Kuliscioff e facevano parte della redazione tutte le migliori penne del socialismo femminile: Angelica Balabanoff,271 Linda Malnati, Margherita Sarfatti, Maria Bornaghi, Argentina Altobelli, Giselda Brebbia, Maria Goia. «Non siamo agli inizi; né veniamo come delle intruse»: con queste parole annunciavano la «forza nuova» rappresentata, nel Partito socialista e nel sindacato, 269 A. GIGLI MARCHETTI, Le risorse del repertorio dei periodici femminili lombardi, in Donne e giornalismo. Percorsi e presenze di una storia di genere, a cura di Silvia Franchi, Simonetta Soldani, Milano, Angeli, 2004, pp. 295-308: 305. 270 La forza nuova, «La Difesa delle Lavoratrici», 7 gennaio 1912. 271 Angelica Balabanoff aveva diretto «Su compagne!», supplemento al «Secolo nuovo» di Venezia. Il giornale, si fuse, dopo breve vita, con « La Difesa delle Lavoratrici». 76 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale dalle «donne del lavoro».272 Con concisione ed efficacia, l’editoriale del primo numero evocava la partecipazione delle donne alle lotte e all’organizzazione del movimento operaio e sindacale in Italia tra Otto e Novecento, ma anche il difficile percorso di costruzione e di legittimazione della figura delle lavoratrici, cui competeva ormai il dovere di condividere le lotte dei loro compagni e il diritto che ne conseguiva all’esercizio del suffragio politico. Tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del Novecento venivano sviluppandosi anche associazioni femminili di orientamento cattolico che diedero vita ad alcune iniziative giornalistiche destinate alle donne, tra cui le più significative furono «L’Azione muliebre», fondata a Milano nel 1901 e diretta da Elena Da Persico, e «Pensiero e azione» progettata nel 1904 da Adelaide Coari, già segretaria di redazione de «L’Azione muliebre»; la prima più aristocratica e moderata, la seconda decisamente più attenta alle drammatiche condizioni delle donne lavoratrici, tanto da avere un supplemento – «L’operaia» – proprio dedicato a questo tema.273 La rivista della Coari, che voleva essere portavoce e promotrice di tutte le rivendicazioni necessarie a salvaguardare la dignità della donna e a favorirne l’effettiva partecipazione alla vita sociale, nel 1908 veniva accusata pubblicamente di modernismo dai cattolici più intransigenti e cessava le pubblicazioni per intervento delle autorità ecclesiastiche. L’Unione fra le donne cattoliche, che venne istituita a Roma nel 1908 e la cui prima presidente fu Cristina Giustiniani Bandini, aveva in «Parva favilla» la sua rivista, mentre «Fiamma viva», pubblicata nel 1921, fu quella della Gioventù femminile cattolica. Sempre nell’ambito cattolico nel 1909, a Vicenza, cominciava ad essere pubblicato il giornale «La donna e il lavoro» fondato e diritto da Elisa Salerno. La «causa santa» dell’elevazione femminile, dell’operaia in particolare, era lo scopo che il periodico si proponeva, «fornendo armi di difesa alla lavoratrice stessa educandola, istruendola, formandole la coscienza cristiana».274 Nell’estate del 1917 veniva sconfessato dalle autorità ecclesiastiche di Vicenza ed Elisa Salerno ne riprendeva le pubblicazioni nel dicembre 1918 dopo aver mutato il titolo della testata in «Problemi femminili» che cessava le pubblicazioni nel 1927. Nel primo decennio del Novecento si moltiplicavano le riviste rivolte alle donne: alla stampa si affidava ancora il compito di educare le lettrici, soprattutto le lavoratrici, proprio per dare loro il modo di interpretare le trasformazioni che comunque l’identità femminile andava subendo sotto la spinta di mutamenti culturali, economici, sociali complessivi. Per le emancipazioniste era necessario «conservare e rivitalizzare i principi basilari, naturali ed abbattere i pregiudizi, quella credenza divenute legge che avevano conculcato le leggi di natura, prima fra tutte la pretesa superiorità dell’uomo sulla donna; ma bisognava anche contrastare la tendenza di un’identificazione delle donne ‘nuove’ col modello maschile dominante o di un comportamento mimetico con gli uomini».275 La ‘donna nuova’ proposta dai periodici di primo Novecento era, però ancora collocata nella cornice della famiglia e la sua identità si doveva ridefinire a partire dal suo essere moglie e madre. Questi i temi infatti che si ritrovano in «La Voce della donna», quindicinale nato a Bari nel dicembre 1903; in «Cronache femminili» periodico torinese fondato nel 1904 da Emilia Mariani; ne «L’Alleanza», foglio settimanale pavese, avviato nell’aprile del 1906, per iniziativa della socialista Carmela Baricelli che 272 La forza nuova, «La Difesa delle Lavoratrici», 7 gennaio 1912. Per l’analisi dei due periodici cfr. P. GAIOTTI DE BIASE, Le origini del movimento cattolico femminile, Brescia, Morcelliana, 1963. 274 «La donna e il lavoro», 27 dicembre 1912. 275 A. BUTTAFUOCO, Cronache femminili cit., p. 91. 273 Tra due secoli 77 in un suo editoriale scriveva: «il nostro femminismo, o italiane non falsa, non degenera la natura femminile; ma la innalza al grado di dignità umana e la nobilita nell’intelletto e nel cuore. Il femminismo come l’intendiamo noi […] non distruggerà mai [la femminilità] della madre affettuosa, della sposa innamorata, della fanciulla gentile!».276 Uscito fino all’ottobre 1911, il periodico aveva ospitato gli scritti di tutte le esponenti più prestigiose e note dell’emancipazionismo dell’epoca: Paolina Schiff, Linda Malnati, Emilia Mariani, Teresa Labriola e Giselda Brebbia. Di particolare rilievo nel panorama delle pubblicazioni analoghe fu «L’Unione femminile», bollettino della omonima associazione fondata da Ersilia Majno, pubblicato a Milano dal 1901 al 1905,277 la cui attenzione era puntata prevalentemente sull’attività di denuncia – oltre che della disparità giuridica e della oppressione morale – dello sfruttamento subito dalle donne nel mondo del lavoro, con analisi e informazioni sempre puntuali, e con il dichiarato intento di sensibilizzare le donne alla richiesta di una pronta approvazione del disegno di legge socialista sulla regolamentazione del lavoro femminile. Le riviste nate nell’immediato primo dopoguerra erano accomunate da una caratteristica distintiva che le differenziava in modo piuttosto netto dalle precedenti. Tutte si ponevano, infatti, come interpreti della ricerca di protagonismo politico che sembrava animare le donne dopo la loro ampia partecipazione alla mobilitazione in occasione del conflitto, del loro desiderio di fare contare le esperienze acquisite e le capacità dimostrate, di dare un senso nuovo alla politica rendendosi visibili e soprattutto essendo riconosciute. Durante il conflitto, però, molte associazioni erano scivolate su posizioni nazionaliste e «Voce nuova», settimanale milanese voluto nel 1919 dalla dirigenza dell’Unione femminile nazionale e diretto da Paolina Tarugi e Sofia Ravasi, costituisce un esempio quanto mai rappresentativo delle trasformazioni profonde in questo senso, subite da almeno una parte del movimento. Secondo Teresa Labriola, che vi pubblicò gli interventi più significativi, era quello il momento del ‘femminismo politico’, contrapposto al ‘femminismo puro’, fatto di alleanze, strategie, scelte di campo.278 Ebbene, il giornale non si occupava più di proletarie o di lavoratrici ma aveva deciso di rivolgersi soprattutto alla borghesia, poiché il popolo era ad essa soggetto e per alleviare le sue condizioni era necessario «educare» la classe dominante, la «più responsabile» chiamata «nelle contingenze d’oggi, fatalmente ad essere esempio e guida alle masse».279 La scelta di campo era stata fatta.280 Le donne protagoniste Molte intellettuali dell’epoca si interessarono, in modo particolare, al lavoro delle donne, cogliendo in esso, con lucidità, una delle possibili vie di accesso all’emancipazione femminile, consentendo autonomia e indipendenza; proprio per questo era necessario porre fine allo sfruttamento ad esso connaturato. 276 CARMELA BARICELLI, Calunnia, «L’Alleanza», 5 gennaio 1907. Il periodico cessò le pubblicazioni nel 1905 per riprenderle poi nel 1908 con il titolo di «Unione femminile nazionale». 278 A. BUTTAFUOCO, Cronache femminili cit., p. 275. 279 SOFIA RAVASI, La via più breve, «Voce nuova», 19 luglio 1919. 280 Teresa Labriola, Margherita Sarfatti, Giselda Brebbia, Regina Terruzzi, Ester Lombardo ritennero di trovare nel fascismo l’espressione delle loro convinzioni. 277 78 Anna Maria Mozzoni,281 una delle principali protagoniste dell’emancipazionismo ottocentesco, sin dai primi scritti (La donna e i suoi rapporti sociali, 1864), poneva al centro della sua riflessione la denuncia delle misere condizioni di impiego delle donne, inserendosi però polemicamente, ai primi del Novecento, nel dibattito sulle leggi di tutela del lavoro femminile, sostenute invece da Anna Kuliscioff. In breve, venivano richieste la parità salariale, le otto ore di lavoro, il riposo domenicale, la proibizione del lavoro notturno, pericoloso e insalubre, l’astensione dal lavoro nei due mesi precedenti e nei due successivi al parto.282 «Non accettate protezione – scriveva nel 1890 – chiedete giustizia».283 La sua diffidenza era motivata dal timore che norme ‘protettive’ – il divieto di lavoro notturno, di imposizione di straordinari, di mansioni pesanti – potessero contribuire a renderlo di minor valore rispetto a quello degli uomini, a legittimare differenziazioni salariali e a ostacolare la libertà di lavoro della donna che rischiava, in tal modo, di essere ricondotta alla famiglia e alla casa «come una gallina nel suo pollaio – scrisse nel 1898 – a covare le sue uova nella solitudine e nel silenzio».284 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale COMITATO DI PROPAGANDA PEL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI INTELLETTUALI, MORALI E GIURIDICHE DELLA DONNA, La donna nella famiglia, nella città e nello Stato, discorso detto a Bologna il 16.11.1890 dalla signora Anna Maria Mozzoni, Bologna, Tip. A. Pongetti, 1891, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, Bologna 281 Anna Maria Mozzoni (1837-1920). Il suo impegno era rivolto soprattutto alla estensione del diritto di voto alle donne e a promuovere l’istruzione femminile. Dal 1870 al 1890 collaborò al giornale «La donna», attento ai temi dell’emancipazione e sensibile alla questione sociale. Nel 1881 costituiva la Lega promotrice degli interessi femminili. Dopo aver collaborato con il deputato socialista Agostino Bertani alla prima inchiesta sulla condizione dei contadini, si avvicinò alle idee socialiste e con Filippo Turati fondò la Lega socialista milanese. In seguito, pur restando in buoni rapporti con molti esponenti socialisti, non esitò a denunciare la scarsa attenzione che il Partito socialista andava dedicando alla ‘questione’ femminile e ne prese le distanze. Pubblicò: Dei diritti della donna (1865), La donna in faccia al progetto del nuovo codice civile italiano (1865), Un passo avanti nella cultura femminile (1866), Il bonapartismo in Italia. Delle scienze morali considerate in ordine all’educazione della donna (1867). 282 Cfr. UNIONE FEMMINILE, Per una legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Notizie e documenti, Milano, Tip. nazionale di V. Ramperti, 1902, p. 26. 283 A.M. MOZZONI, Sentimentalismo, «L’Italia del popolo», 26-27 novembre 1890, citato in F. PIERONI BORTOLOTTI, Alle origini del movimento femminile in Italia cit., p. 202. 284 A.M. MOZZONI, Legislazione a difesa delle donne lavoratrici. «Dagli amici mi guardi Iddio», «Avanti!», 7 marzo 1898. Tra due secoli 79 Anna Kuliscioff,285 una delle figure più rigorose sul piano teorico e certo la più sensibile ad una politica di reale emancipazione delle donne nel Partito socialista, redasse nel 1897 il progetto di legge sulla protezione del lavoro femminile e minorile nelle fabbriche. Scriveva, infatti, nel 1892: La macchina, la grande forza rivoluzionaria dell’industria, ha rivoluzionato anche la donna, l’ha prima di tutto emancipata dalla pentola e messa in condizione di lotta per l’esistenza uguali a quelle dell’uomo. L’ha resa pari all’uomo nella miseria e nell’aspirazione a scuotere il giogo del capitalismo. I famosi diritti politici e civili della donna, che sembrano mera accademia, diventano necessità assoluta per le lavoratrici.286 Per lei la legge di tutela era un importante obiettivo di lotta contro lo sfruttamento delle operaie da parte degli industriali, capace di rafforzare la loro presenza in fabbrica attraverso una maggiore consapevolezza dei loro diritti di donne e di lavoratrici e rispondeva a Mozzoni sostenendo che: «se il presagio dei licenziamenti avesse fondamento, certamente i socialisti sarebbero i primi a combattere qualsiasi legge a tutela del lavoro delle donne».287 La protezione legale era invocata a difesa di una manodopera debole che subiva il lavoro come una necessità ed era esposta dal bisogno ad un utilizzo disumano. Negli schieramenti diversificati che si produssero attorno alla proposta anche tra le socialiste si manifestarono pareri opposti: Emilia Mariani,288 ad esempio, sosteneva che l’unica legge protettiva del lavoro delle donne era quella che avrebbe sancito «mercede uguale a lavoro uguale e salario minimo adeguato negli altri casi».289 La richiesta di parità salariale era presente, d’altra parte, nel primo progetto di legge elaborato nel 1895 a Milano dall’Associazione generale delle operaie e dal Coordinamento delle Società operaie femminili,290 che fu ripreso in larga parte in quello redatto da Anna Kuliscioff, nel quale tuttavia non figurava più il tema della parità salariale. Era 285 Anna Kuliscioff (1854 ca.–1925) nata in Russia da famiglia agiata, sedicenne si iscrisse al Politecnico di Zurigo. Nel 1878 fu arrestata con Andrea Costa a Parigi ed espulsa. Venne nuovamente arrestata a Firenze, dove si era rifugiata. Assolta dopo un lungo processo, riprese in Svizzera gli studi che terminò in Italia laureandosi in medicina. Nel 1888 fondò con Filippo Turati la Lega socialista milanese. Affrontò la ‘questione’ femminile dal punto di vista delle disuguaglianze economiche e sociali. Nel 1890 tenne a Milano una conferenza dal titolo Il monopolio dell’uomo, suo primo organico scritto sulla necessità dell’emancipazione della donna. Nel gennaio 1891 fondò con Turati «Critica sociale» e nel 1892 svolse un ruolo importante per la fondazione del Partito dei lavoratori italiani. Nei moti del 1898 contro il caro-pane venne arrestata e condannata a due anni di prigione, poi liberata in seguito a indulto. Nel 1911 fondò il periodico «La Difesa delle Lavoratrici». Allo scoppio della prima guerra mondiale chiamò le donne a lottare per la difesa della pace. 286 A. KULISCIOFF, Il sentimentalismo nella questione femminile, «Critica sociale», 1892, p. 141, citato in F. PIERONI BORTOLOTTI, Alle origini del movimento femminile in Italia cit., p. 239. 287 A. KULISCIOFF, In nome della libertà della donna, «Laissez faire, laissez aller!», «Avanti!», 19 marzo 1898, citato in F. PIERONI BORTOLOTTI, Socialismo e questione femminile in Italia 1892-1922, Milano, Mazzotta, 1974, p. 77. 288 Emilia Mariani (1854-1917), maestra elementare e presidentessa della Lega per la tutela degli interessi femminili di Torino, fu un’aperta sostenitrice dei diritti politici e sociali delle donne e tra le principali protagoniste delle prime associazioni di insegnanti in Italia. Un obiettivo costante della sua battaglia politica fu la necessità dell’equiparazione degli stipendi tra maestri e maestre. Fu poi tra le fondatrici delle riviste «Vita femminile» e nel 1899 «L’Italia femminile». 289 E. MARIANI, Il Primo Maggio delle donne lavoratrici, citato in A. BUTTAFUOCO, Cronache femminili cit., p. 63. 290 A. BUTTAFUOCO, Cronache femminili cit., p. 65. 80 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale il progetto che recava il nome di Ersilia Majno.291 una delle protagoniste dell’emancipazionismo milanese di fine Ottocento. La fondatrice dell’Unione femminile, si interessava in modo particolare del lavoro delle donne e, con l’associazione, nel 1901 si impegnò in un enorme sforzo di propaganda per la legge di tutela, formulando una petizione che fu inviata a centinaia di organizzazioni, Leghe, Camere del Lavoro, per poi essere presentata alla Camera. In essa veniva scritto: Giova ricordare come la necessità dell’intervento legislativo ad impedire o a limitare l’ignobile sfruttamento del lavoro delle donne e dei fanciulli, ad ovviare gl’immani danni sociali che ne sono effetto, sia stata intuita sino nelle prime timide riunioni in cui la classe operaia, tra l’indifferenza dei più, affermava il suo diritto nuovo.292 Nel frattempo, la parità salariale, l’istituzione di una Cassa di maternità, la regolamentazione del lavoro erano le rivendicazioni con più forza portate avanti dalle donne nei circoli e nei congressi operai, nei programmi dei convegni femministi e delle Camere del Lavoro perché parevano aprire alle donne un varco di legittimazione, di affermazione del valore del proprio lavoro, armi per l’affermazione dei propri diritti. Linda Malnati,293 ad esempio, intervenendo al primo Congresso di attività pratica femminile organizzato dall’Unione femminile nel 1908, sostenne il diritto delle donne alla giornata lavorativa di otto ore, la parità retributiva e l’istituzione di moderni nidi d’infanzia.294 La Malnati, oltre a essere segretaria della Lega per la tutela degli interessi femminili di Milano, fu tra le fondatrici della Camera del Lavoro di Milano, insieme a Carlotta Clerici e Giuditta Brambilla. Diverse tra le donne più attive nell’opera di organizzazione e di propaganda ricoprirono funzioni direttive proprio in queste istituzioni, a riprova della centralità del lavoro nella ‘questione’ femminile, come Maria Giudice295 responsabile ai primi del Novecen291 Ersilia Majno (1859-1933) Si impegnò a favore delle donne più disagiate dapprima nell’Associazione generale di mutuo soccorso e istruzione fra le operaie di Milano, poi nella Società di mutuo soccorso e miglioramento fra sarte e nella Sezione femminile della Camera del Lavoro. Diede vita a quello che viene definito ‘femminismo pratico’, fondando nel 1899 l’Unione femminile, reggendone per alcuni anni la presidenza e prodigandosi nel contempo in una serie di iniziative collaterali quali il Comitato contro la tratta delle bianche e l’Asilo Mariuccia, istituto quest’ultimo da lei voluto per l’educazione delle fanciulle povere e abbandonate. 292 Cfr. UNIONE FEMMINILE, Per una legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli cit., p. 3. 293 Linda Malnati (1855-1921), maestra e organizzatrice delle associazioni delle insegnanti elementari, fu tra le principali organizzatrici del movimento operaio femminile a Milano, esponente di quel gruppo di donne, vicine alle posizioni socialiste, che svolsero un ruolo centrale per la formazione culturale e il diritto al lavoro delle donne meno abbienti. Partecipò ai moti sociali del 1898 e venne per questo sospesa dall’insegnamento e denunciata, essendo poi riabilitata nel 1900. Oltre ad aver fondato la Società Figlie del lavoro, rivolta alla tutela degli interessi delle lavoratrici, nei primi anni del Novecento fu una sostenitrice del movimento per l’Università popolare milanese. Collaborò a numerosi giornali e riviste, tra cui «Vita femminile» e «La Difesa delle Lavoratrici», con articoli a sostegno soprattutto delle maestre elementari, criticando la discriminazione salariale di cui erano fatte oggetto. 294 B. IMBERGAMO, A. SCATTIGNO, «Una forza nuova». Le donne nel movimento dei lavoratori cit., pp. 173-174. 295 Maria Giudice (1880-1953). Maestra elementare, propagandò l’emancipazione femminile e dei lavoratori. A Voghera, stampò «La donna che piange», in cui trattava i problemi delle lavoratrici. Negli anni 1903-1904 per gli accesi toni dei suoi articoli, fu incriminata e processata. Fuggita in Svizzera, assieme ad Angelica Balabanoff, pubblicò il periodico «Su, compagne». Rientrata in Italia, operò nelle cooperative vinicole dell’Emilia, poi si trasferì a Milano. Nel 1914 diresse lo sciopero delle lavoratrici tessili in Valsesia. Scrisse per «La Difesa delle Lavoratrici», per «Il grido del popolo» e fu attiva nel 1917 nelle giornate di rivolta contro la guerra, motivo per il quale fu arrestata. Tra due secoli 81 to della Camera del Lavoro di Voghera, prima di assumere, in anni più tardi, la responsabilità della Federazione torinese del Partito socialista. E ancora: Maria Goia,296 maestra elementare, che fu responsabile delle Camere del Lavoro di Cervia e di Faenza prima ancora di entrare a far parte della Commissione nazionale del Partito socialista (1906) indirizzando la propria attenzione verso le lavoratrici agricole, nel quadro dell’azione sindacale svolta dalla rivista «Il seme», da lei fondata e diretta; e Argentina Altobelli297 che fece parte del Consiglio direttivo della Camera del Lavoro di Bologna fin dalla fondazione e, dal 1906 fu segretaria della Federazione Nazionale dei Lavoratori della Terra che aveva contribuito a fondare, un ruolo d’eccezione, unico fra le dirigenti del movimento sindacale e non solo in Italia. Le stesse rivendicazioni venivano portate avanti anche da Luisa Anzoletti298 Adelaide Coari299 che diedero vita ad organizzazioni e riviste cattoliche di stampo femminista, propagandando una forma di associazione sindacale non paternalistica, aconfessionale e combattiva, che non condannasse le donne alla pura rassegnazione ma le rendesse coscienti della loro condizione, così da esprimere le proprie esigenze di lavoro, e a soddisfarle anche attraverso forme di lotta quali lo sciopero. Con serrata e stringata logica filosofica scriveva Luisa Anzoletti: «Ci volete umili? Senza libertà ci costringete solo ad 296 Maria Goia (1878–1924) si iscrisse al Psi nel 1898 e fece lavoro di propaganda e di organizzazione dei nuclei operai in varie zone dell’Emilia. La sua abilità oratoria è ricordata da una canzone popolare che celebra «il suo bel parlare». Contro la guerra di Libia coordinò le dimostrazioni anticolonialiste delle donne; mentre nel 1913 fondò un nuovo periodico «La nuova terra» sulle cui pagine svolse un’accesa propaganda contro il primo conflitto mondiale. Per questa sua attività fu incarcerata dal 1916 al 1917, uscendo dalla prigione con la salute gravemente compromessa. 297 Argentina Altobelli (1866–1942) fu instancabile organizzatrice del lavoro e delle lotte nelle campagne tanto che, durante il suo mandato, gli iscritti passarono da 75.000 a 1 milione e conquistarono l’abolizione del lavoro a cottimo e la giornata di otto ore. Redattrice del periodico «La Confederazione del lavoro», collaborò sia con giornali socialisti («Avanti!» e «Riscossa») sia con periodici destinati alla propaganda fra donne («Su, compagne» e «La Difesa delle Lavoratrici») e si prodigò a favore di tutte le campagne per l’emancipazione delle donne: per il divorzio, per il diritto di voto, per la partecipazione delle donne alla vita sociale e politica. 298 Luisa Anzoletti (1863-1925). Nacque da famiglia agiata ed ebbe una raffinata cultura classica. A ventisei anni cominciò a maturare il suo interesse per l’educazione femminile. Da tale interesse nacquero due opuscoli che ebbero notevole risonanza nel mondo cattolico di inizio secolo: La donna nel progresso cristiano (1895) e La donna nuova (1898). In quel periodo il giudizio dell’Anzoletti sul femminismo era ancora negativo: l’unica vera battaglia in favore della donna era quella di una educazione religiosa e culturale più esigente, per una migliore e più efficace capacità di influenza nella società. Durante il 1902 svolse un’ampia battaglia antidivorzista. Dal 1904 iniziò la sua collaborazione con l’«Azione Muliebre» e «La donna del popolo». Anzoletti avvertiva ormai che non si trattava soltanto di rinnovare e migliorare l’educazione delle donne, ma anche di considerare la nuova condizione sociale creata dal massiccio ingresso delle donne nel mondo del lavoro. Non a caso Adelaide Coari affidò a lei la prolusione del primo Convegno femminile nazionale, promosso dalle cattoliche nel 1907. Quando le gerarchie ecclesiastiche intervennero, Anzoletti rimase comunque attiva nel gruppo redazionale de «La donna» di Torino. 299 Adelaide Coari (1881-1966). Maestra, verso la fine del 1901 il problema educativo e la questione femminile cominciarono a diventare due poli di interesse evidenti nella sua attività: in quel periodo veniva scelta come segretaria di redazione del periodico «Azione muliebre» e cominciò a partecipare alle attività del Fascio democratico cristiano di Milano. Nel 1904 lasciò la rivista e investì tutte le sue energie nel gruppo, fondando poco dopo «Pensiero e Azione», organo della nascente Federazione femminile milanese. Nel 1908 il giornale dovette sospendere le pubblicazioni per le accuse di modernismo. Il Vaticano abbastanza drasticamente liquidò il movimento. Coari smise ogni attività politica e, accettando il ‘suggerimento’ del silenzio, si dedicò alla difficile opera di rieducazione sociale avviata da Don Orione. 82 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale essere umiliate».300 E intanto, la Coari, preparando il primo Convegno femminile nazionale (1907), ribadiva su «Le pagine dell’operaia», rivolgendosi alle lavoratrici: Quante rivendicazioni avete da ottenere voi operaie! Voi vi siete mai domandate perché pure lavorando come l’uomo, siete pagate meno? […]. Non avete mai pensato perché voi che sopportate tante dure condizioni nei vostri opifici, nei vostri laboratori, e sentite vivo il bisogno di leggi che tolgono tante ingiustizie, che riparino tante cattive condizioni vostre, che pongano un freno allo sfruttamento che si fa di voi, del vostro lavoro, non potete portare la vostra voce là dove queste leggi partono, né potete mandarvi nessuno che vi difenda?301 Insieme, poi, vergavano quel ‘programma minimo femminista’, in cui veniva richiesta la parità salariale e il miglioramento delle condizioni lavorative delle donne, presentato al Convegno e su cui si trovarono d’accordo sia le socialiste sia le liberali.302 Le donne qui citate non furono sole ad affermare il valore in sé del lavoro femminile, lottando per l’affermazione di diritti imprescindibili. Accanto ad esse, indiscutibili leader carismatiche, una miriade di altre, di ogni ceto sociale, impegnate a organizzare inchieste, a dirigere riviste, a promuovere iniziative politiche e sociali di notevole rilievo. Così, per esempio, Maria Pasolini, autrice di alcune importanti monografie sull’organizzazione familiare di mezzadri e braccianti e organizzatrice di varie attività in favore delle ragazze contadine in provincia di Ravenna; così Ernesta Stoppa, educatrice e antesignana del mutualismo femminile a Lugo di Romagna, per la quale scuola e lavoro portavano al miglioramento delle condizioni di vita delle donne; così Giorgina Saffi, fondatrice della sezione femminile della Società di mutuo soccorso forlivese e figura di punta nelle battaglie a sostegno dell’istruzione femminile; e tutte le lavoratrici che, riunite in società, in leghe, in associazioni non si arresero. La conquista dei diritti Le lotte delle donne nelle campagne Alla fine dell’Ottocento si rilevava una indiscutibile partecipazione agli scioperi agrari da parte delle donne, attestata persino dalle parzialissime statistiche ministeriali,303 una partecipazione che vedeva come protagoniste soprattutto risaiole e braccianti della realtà agraria padana. Si disegnava così, in quel periodo, una geografia delle rivendicazioni femminili che aveva in particolare nelle campagne emilianoromagnole il nucleo centrale, proteste che sedimentarono nel primo decennio del Novecento e si svilupparono fino al primo dopoguerra. Una tradizione di lotta e di organizzazione destinata, però, a sfaldarsi con gli attacchi dello squadrismo fascista e l’avvento del regime. 300 R. FARINA, Introduzione, in Esistere come donna cit., p. 13. «Le pagine dell’operaia», numero unico in occasione del Primo Convegno femminile nazionale, 1907, citato in A. BUTTAFUOCO, Cronache femminili cit., p. 81. 302 Cfr. MARIA GRAZIA TANARA, Femminismo cristiano. Le donne cattoliche e la sfida del lavoro, in Esistere come donna cit., pp. 153-158. 303 MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, DIREZIONE CENTRALE DI STATISTICA, Statistica degli scioperi avvenuti nell’industria e nell’agricoltura durante gli anni dal 1884 al 1891, Roma, Tip. naz. G. Bertero, 1892. 301 Tra due secoli Lettera della Legione dei Carabinieri Reali di Bologna al Prefetto della Provincia, 25 luglio 1900, Oggetto: Astensione dal lavoro di 200 risaiole di Molinella, Archivio di Stato, Bologna 83 Lettera della Legione dei Carabinieri Reali di Bologna al Prefetto della Provincia, 12 giugno 1888, Oggetto: Sciopero di risaiuole ed arresto di cinque istigatrici, Archivio di Stato, Bologna Intorno al 1886 in Emilia venivano spesso segnalati, tra gli scioperi agrari, episodi esclusivamente femminili. Dal 1886 al 1893, infatti, su 53 astensioni dal lavoro locali – segnalate dai Prefetti al ministero dell’Agricoltura, industrie e commercio – ben 18, vale a dire il 34%, vedevano coinvolte risaiole, (ed è ragionevole presumere che molti dei restanti fossero scioperi misti) e, nei cinque anni successivi, su un totale di 24.975 scioperanti emiliani per motivi salariali ben 9.747, poco meno del 40%, risultavano donne.304 Le mondine scesero in lotta una prima volta nel 1886305 e poi più volte negli anni successivi a Molinella, Budrio, Baricella, Minerbio, insomma nell’ampia area della bassa pianura del Reno.306 Esse chiedevano aumenti salariali, e, nel corso del tempo, l’assunzione prioritaria di lavoratrici locali rispetto a quelle ‘venute da fuori’, la riduzione dell’orario a nove ore, la nomina di sorveglianti da parte dei braccianti. Queste 304 MANUELA MARTINI, Divisione sessuale dei ruoli e azione collettiva nelle campagne padane di fine Ottocento, in Donne e spazio nel processo di modernizzazione, a cura di Dianella Gagliani, Mariuccia Salvati, Bologna, Clueb, 1995, pp. 75-110: 81. 305 In questi primi scioperi le risaiole ottennero l’aumento della paga giornaliera da 70 centesimi a una lira, ostinato obiettivo salariale di quegli anni di crisi. Cfr. M. MARTINI, Divisione sessuale del lavoro e azione collettiva cit., p. 82. 306 Lettera della Legione dei Carabinieri Reali di Bologna al Prefetto della Provincia, Bologna, 25.7.1900, in ASBo, Gabinetto di Prefettura, serie 990, 1900, cat. 6 «Agitazioni operaie, scioperi», fasc. «Molinella e basso bolognese. Agitazioni di operai disoccupati, scioperi, ecc.». 84 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale Arresti in massa degli scioperanti di Copparo, «L’Illustrazione italiana», 21 luglio 1907, Istituto storico Parri Emilia-Romagna, Bologna ultime rivendicazioni, avanzate nel 1893 e poi abbandonate nell’insuccesso, furono riprese nel 1897 durante le agitazioni proseguite per quaranta giorni, che condussero al buon esito delle trattative, portate avanti da commissioni di donne scioperanti.307 Le lavoratrici, dunque, prendevano la parola, agivano collettivamente, ottenevano importanti esiti ma risultavano essere anche vittime delle repressioni poliziesche; forza pubblica e magistratura non sembravano operare distinzioni di genere nei confronti delle donne implicate nei conflitti di lavoro: già nello sciopero del 1888 vennero fermate «cinque istigatrici»308 e delle 46 scioperanti di Molinella, arrestate nel 1897, ben 40 furono condannate da uno a tre mesi di reclusione, pene non inferiori a quelle inflitte ai loro compaesani di sesso maschile.309 Nella prima decade del Novecento l’impennata di scioperi nel settore agricolo vedeva, già nel 1901, la partecipazione di 53.000 donne e di 26.000 tra fanciulli e ragazze.310 Ancora una volta tornavano ad essere protagoniste le braccianti emiliane, la maggior parte delle quali era organizzata in Leghe.311 A Molinella uno sciopero del 307 GUIDO CRAINZ, Padania. Il mondo dei braccianti dall’Ottocento alla fuga dalle campagne, Roma, Donzelli, pp. 72-73; M. MARTINI, Divisione sessuale dei ruoli e azione collettiva nelle campagne padane di fine Ottocento cit., p. 107. 308 Lettera della Legione dei Carabinieri Reali di Bologna al Prefetto della Provincia, Bologna, 25.7.1900, in ASBo, Gabinetto di Prefettura, serie 647, 1888, «Reati. Scioperi e disordini», cat. 1, fasc. 16 «Scioperi e disordini». 309 M. MARTINI, Divisione sessuale dei ruoli e azione collettiva nelle campagne padane di fine Ottocento cit., p. 89. 310 Lotte agrarie in Italia. La Federazione nazionale dei lavoratori della terra 1901-1902, a cura di Renato Zangheri, Milano, Feltrinelli, 1960, p. XXVIII. 311 Già all’inizio del secolo a Molinella circa il 66% delle braccianti avventizie (878 su 1.328 lavoratrici) era iscritta a una Lega. Nel 1911 nella zona di Ravenna le organizzate erano, con buona approssimazione, vicine, al 70-80% delle donne. Cfr. M. MARTINI, Divisione sessuale dei ruoli e azione collettiva nelle campagne padane di fine Ottocento cit., pp. 99-100. Tra due secoli 85 1903 coinvolse nelle risaie 3.500 tra lavoratori e lavoratrici per 73 giorni e si concluse con esito favorevole.312 Nelle numerose agitazioni delle risaiole, nel biennio 1905-1906, la rivendicazione della precedenza delle lavoratrici locali rispetto alle ‘forestiere’ toccava un tema che si intrecciava, in quegli anni, con la lotta per il collocamento e la richiesta delle otto ore lavorative. Infatti, solo esercitando un controllo sul mercato del lavoro tramite un’organizzazione del collocamento sindacale che regolasse le migrazioni verso le risaie, era possibile, da un lato, sottrarre le donne allo sfruttamento dei cosiddetti ‘caporali’ (intermediari che ingaggiavano le lavoratrici per conto dei padroni) e, dall’altro, gestire lotte efficaci per la riduzione delle ore di lavoro in risaia, senza il timore di veder boicottare gli scioperi dall’arrivo di ‘crumire’ reclutate nelle zone vicine a quelle dove si svolgeva la lotta. Argentina Altobelli, dal 1906 segretaria della Federazione Nazionale dei Lavoratori della Terra che aveva contribuito a fondare, sulla penosa questione del crumiraggio, si espresse più volte, sottolineando come solo attraverso l’organizzazione era possibile costruire attorno alle lavoratrici una rete di solidarietà che consentisse di non disperderne nel fallimento i sacrifici e le lotte. Gli scioperi nell’Argentano del 1906 e soprattutto del 1907 furono esemplari di tale capacità del movimento operaio: non solo vennero aperte sottoscrizioni (che raggiunsero le migliaia di lire) per soccorrere gli scioperanti ma centinaia di famiglie romagnole ne accolsero i figli, consentendo loro la prosecuzione della lotta e il raggiungimento degli obiettivi, tanto che il quotidiano «Avanti!» poteva intitolare Non vi sono più fanciulli ad Argenta! un articolo del 25 aprile 1907. La fanfara della Lega intonò l’Inno dei lavoratori, un fremito scosse il fascio delle bandiere, e la folla si pose in cammino per un ampio stradale diritto, sotto l’uggiosa acquerugiola insistente. I fanciulli degli scioperanti, raccolti in gruppo all’ombra dei vessilli spiegati in testa al corteo, procedevano seri e silenziosi, più stupiti che addolorati di quella separazione – che non sapevano spiegarsi – dalle loro mamme […]. Due sere prima gli uomini e le donne avevano applaudito con un entusiasmo quasi forsennato, nei locali della Lega, la lettura delle lettere con le quali i compagni di Lugo e di Ravenna domandavano i bambini. Ma ora giunti alla stazione, ove essi si sarebbero dovuti separare dai loro piccini, una tristezza infinita serrava i loro cuori, anche gli uomini avevano un nodo di pianto alla gola. […]. Finalmente il treno si mise in moto […]. Le donne con la faccia congestionata e rigata di lacrime chiamavano ancora a voce alta i loro figlioli […]. Il treno scomparve. La fanfara tornò ad intonare l’Inno, tutte le bocche la cantarono, a voce alta con frenesia; le donne si avviarono verso l’uscita tenendosi a braccetto, gli uomini si strinsero loro accanto, cantando ancora, cantando sempre.313 Nel giugno del 1907 Altobelli, sulle pagine della «Confederazione del Lavoro», rivolgeva alle donne, alle «madri proletarie» di Argenta un saluto pieno di ammirazione per i «sacrifici eroici» compiuti.314 Le lotte di quegli anni condussero infine all’approvazione di una legge sul lavoro nelle risaie che fissava l’orario a nove ore giornaliere per le lavoratrici locali e dieci per 312 LUIGI ARBIZZANI, La Federazione provinciale dei lavoratori della terra (1901-1915) e le Camere del Lavoro di Bologna, in Il sindacato nel bolognese. Le Camere del Lavoro di Bologna dal 1893 al 1960, a cura di L. Arbizzani et alii, Roma, Ediesse, 1988, pp. 111-156: 122. 313 Non vi sono più fanciulli ad Argenta!, «Avanti!», 25 aprile 1907. 314 Lo sciopero di Argenta è finito con la vittoria dei lavoratori!, «Confederazione del lavoro», 8 giugno 1907, citato in B. IMBERGAMO, A. SCATTIGNO, «Una forza nuova». Le donne nel movimento dei lavoratori cit., p. 175. 86 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale le forestiere e che proibiva, seppure con limitata efficacia, la mediazione dei ‘caporali’; una legge che, nella fase progettuale, fu fortemente criticata e avversata dalle organizzazioni dei lavoratori ma che costituiva pur sempre un primo tentativo di sottoporre il lavoro a controllo e di garantire alcuni diritti. Le lavoratrici della terra, poi, furono attive protagoniste del grande sciopero attuato nell’estate del 1908 nel parmense, tanto che «La Domenica del Corriere», dedicò loro la copertina del numero di metà maggio. La lotta fu molto violenta e arrivò ad assumere la forma del boicottaggio coinvolgendo anche gli addetti alle stalle perché le Leghe si trovarono di fronte alla resistenza compatta e decisa dell’Associazione agraria che raccoglieva i proprietari della zona e che organizzò il crumiraggio su vasta scala.315 Il governo Giolitti resistette alle pressioni degli agrari perché fossero prese misure d’eccezione, ma in giugno la proclamazione di uno sciopero cittadino di solidarietà contro l’arrivo di ‘crumiri’ diede luogo a gravi incidenti con la forza pubblica che durarono alcuni giorni, furono aggravati dall’impiego della cavalleria e si conclusero con l’occupazione della Camera del Lavoro da parte della truppa e con l’arresto di un certo numero di aderenti alle Leghe. Anche durante il ‘biennio rosso’ nelle campagne vi furono numerosi scioperi in cui i braccianti continuarono a chiedere miglioramenti nelle condizioni di lavoro, pagati però a caro prezzo: Gertrude Grassi, ventitrenne incinta, nel corso di una manifestazione svoltasi nel giugno 1919 a Bologna per reclamare la requisizione delle terre incolte, venne gravemente ferita dalle forze dell’ordine inviate ad arginare la protesta e morì in ospedale cinque giorni dopo; Adalgisa Galletti, ventunenne, perse la vita perché durante un comizio, svoltosi a Decima di Persiceto nell’aprile del 1920 per la riforma del capitolato colonico, i carabinieri avevano aperto il fuoco. Gertrude e Adalgisa appartenevano a quelle categorie sociali sulle quali più pesantemente gravavano le difficoltà economiche del primo dopoguerra.316 Le lotte delle donne nelle città Nel periodo esaminato gli scioperi delle donne (operaie, tabacchine, trecciaiole, sarte, ecc.) testimoniavano di una nuova combattività delle lavoratrici: nell’ultimo decennio dell’Ottocento, ad esempio, le donne che decidevano di sospendere il lavoro nell’industria furono il 31% del totale delle occupate, una percentuale rilevante che dimostrava il loro grado di organizzazione.317 Se la richiesta di aumenti salariali accomunava le lavoratrici in lotta, nei diversi settori produttivi l’eterogeneità delle mansioni e degli accordi vigenti con i padroni in termini di salario, orario, regolamenti aziendali, così come la scarsissima legislazione in materia di lavoro esistente, facevano sì che ogni categoria avesse piattaforme rivendicative diverse e che giungesse a conquiste diverse nel corso del tempo. Le tabacchine che, come dipendenti dello Stato avevano conquistato condizioni di lavoro migliori di quelle delle operaie degli stabilimenti privati, ottenute con una serie 315 Lo sciopero ebbe inizio per il sabotaggio, da parte degli agrari, degli accordi stipulati nel 1907, accordi che stabilivano il salario ad ora anziché a giornata (con tariffa minima di 23 centesimi l’ora per gli uomini e di 16 per le donne; un chilo di pane costava più di 40 centesimi) e l’orario fissato ad 11 ore di lavoro per i braccianti e a 13 per i salariati fissi aventi cura del bestiame. 316 I. VACCARI, La donna nel ventennio fascista cit., p. 60. 317 IDOMENEO BARBADORO, Il sindacato in Italia. Dalle origini al Congresso di Modena della Confederazione del Lavoro (1908), Milano, Teti, 1979, pp. 40-41. Tra due secoli Corteo di operaie cotoniere a Torino, «L’Illustrazione italiana», 20 maggio 1906, Istituto storico Parri Emilia-Romagna, Bologna 87 88 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale di scioperi a fine Ottocento, proseguirono le lotte nei primi del Novecento raggiungendo salari superiori a quelli delle altre categorie operaie e maggiori tutele.318 Le tessili protestavano contro il continuo svilimento del salario, ma anche contro la prassi che voleva che fossero le lavoranti a procurarsi l’illuminazione per il lavoro serale.319 Le trecciaiole toscane tra il 1896 e il 1897, furono protagoniste di lotte che coinvolsero almeno 27.000 donne in un’imponente agitazione a cui partecipò anche la Camera del Lavoro: protestavano contro la decurtazione dei salari compiuta dagli intermediari, i cosiddetti ‘fattorini’, e proseguirono la lotta negli anni successivi, ma in forme meno tumultuose e più collegate all’organizzazione di classe, fino ad organizzare una delle poche cooperative di produzione femminile dell’epoca.320 Certamente, data la varietà delle tipologie contrattuali nel settore industriale, non pare un caso che Lettera del Ministero dell’Interno, Direzione l’organizzazione delle operaie sia stata generale di Pubblica Sicurezza al Prefetto di più lenta anche in Emilia-Romagna e Bologna, 27 settembre 1888, Oggetto: Operaie che gli scioperi di cui pur vi è traccia – Manifattura tabacchi, Archivio di Stato, a Bologna, ad esempio, di operaie della Bologna cartiera o della manifattura tabacchi – riguardassero spesso singole aziende e dunque numeri limitati di lavoratrici e pochi giorni di agitazione. Fra le lavoratrici dell’industria, salari e orari variavano di settore in settore, di zona in zona, nei singoli stabilimenti e al loro interno in base alle mansioni più o meno qualificate che esse ricoprivano. Ciò rendeva l’organizzazione ben più frammentaria e difficile, ed è probabilmente ascrivibile a questo, oltre che alla scarsità e dispersione delle fonti per quegli anni, il minor numero di episodi di lotta di cui si è a conoscenza nel settore industriale rispetto a quello agricolo.321 A inizio Novecento, a Bologna – dopo le agitazioni isolate che si erano avute alla fine dell’Ottocento, di certo più limitate e frammentate di quelle delle campagne – le lavoratrici di alcuni settori (tessitrici, bustaie, fiammiferaie, ecc.) cominciavano azioni di sciopero con motivazioni ed obiettivi sistematicamente ripresi da uno all’altro, e con la tendenza ad investire più fabbriche e più gruppi di operaie dello stesso settore, coinvolgendo di anno in anno un numero crescente di partecipanti e quindi facendo conoscere alla città non la manifestazione sporadica o il tumulto verificatosi in circostanze 318 Cfr. S. SOLDANI, Strade maestre e cammini tortuosi cit., pp. 289-352. S. MERLI, Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale cit., p. 9. 320 B. IMBERGAMO, A. SCATTIGNO, «Una forza nuova». Le donne nel movimento dei lavoratori cit., p. 171. 321 Ivi, p. 175. 319 Tra due secoli 89 straordinarie, ma l’adozione regolare dello sciopero come strumento di resistenza e di organizzazione delle classi lavoratrici.322 Le agitazioni erano in massima parte dovute a peggioramenti della condizione lavorativa riguardanti sia i modi della retribuzione sia la misura e il controllo del lavoro, oltre che l’orario e il regolamento di fabbrica. Ai nuovi provvedimenti presi in questo senso reagirono, ad esempio, le tessitrici del cotonificio Valla, con uno sciopero di 19 giorni che si concluse positivamente grazie all’intervento della Camera del Lavoro.323 Anche le tessitrici dello stabilimento Sabbatini, chiedevano, oltre ad aumenti salariali, un nuovo regolamento di fabbrica per il superamento delle vecchie forme di utilizzazione della forza lavoro, aggravate e non più sostenibili a causa dell’introduzione di nuovi metodi di sfruttamento, derivanti questi dalle ristrutturazioni e razionalizzazioni attuate dai padroni.324 Tra gli scioperi più importanti del 1900 vi fu quello delle bustaie della fabbrica Rinaldi. Le rivendicazioni di queste donne erano rivelatrici di un doppio effetto di sfruttamento che era venuto determinandosi per problematiche relative alla riorganizzazione interna. Il proprietario, avendo aumentato la forza motrice e quindi intensificato il ritmo di lavoro, era intenzionato a licenziare una parte delle operaie e a ridurre la paga delle altre; nello stesso tempo erano le lavoratrici che, secondo le forme più tradizionali di prestazione d’opera, dovevano pagare la quota di consumo del gas e le riparazioni delle macchine. Le operaie non intendevano accettare nessuno di questi aggravamenti della loro condizione e il proprietario dovette trattare con una commissione della Camera del Lavoro che, nel frattempo, aveva aperto una sottoscrizione di solidarietà con le scioperanti, e finì dopo 15 giorni con l’accettare buona parte delle loro richieste. Risultato significativo dello sciopero fu anche il costituirsi in Lega di resistenza di quelle operaie, con l’adesione di altre lavoratrici dello stesso settore.325 Anche le fiammiferaie della ditta Pezzoli, particolarmente combattive, dovettero affrontare problemi relativi alla trasformazione aziendale in seguito ai quali il proprietario voleva imporre loro riduzioni salariali e aumenti dei carichi lavorativi. Al termine dello sciopero «le mercedi e l’orario» rimasero «quelle di prima, ma avendo la fabbrica un grosso fondo di merce» furono licenziate 40 donne, alle quali però venne corrisposta almeno una gratifica di 30 lire.326 In regione, altri scioperi significati si ebbero nel 1907 a Parma, dove più di mille operaie delle sei fabbriche di busti esistenti (che esportavano in tutto il mondo il prodotto abile e paziente di queste donne), ottennero l’eliminazione del cottimo, le otto ore di lavoro e il riconoscimento della loro Lega e, sempre nel 1907, a Spilamberto, nel modenese, dove le setaiole sospesero il lavoro per 38 giorni per protestare contro indescrivibili condizioni di lavoro. Il primo dopoguerra, insieme alle polemiche sul lavoro delle donne e la loro smobilitazione, portò anche all’iscrizione di mezzo milione di lavoratrici alla Camera Generale del Lavoro.327 Furono queste lavoratrici che parteciparono con grande inten- 322 IGNAZIO MASULLI, Crisi e trasformazione. Strutture economiche, rapporti sociali e lotte politiche nel bolognese 1880-1914, Bologna, Istituto per la storia di Bologna, 1980, p. 230. 323 Lettera di Valla al Prefetto di Bologna, Bologna, 2.8.1900, in ASBo, Gabinetto di Prefettura, serie 990, 1900, cat. 6 «Agitazioni operaie», fasc. 2 «Agitazioni, scioperi». 324 I. MASULLI, Crisi e trasformazione cit., p. 235. 325 Ibidem. 326 Lettera della Legione territoriale dei Carabinieri Reali al Prefetto della Provincia, Bologna, 30.4.1902 in ASBo, Gabinetto di Prefettura, serie 1017, 1902, cat. 6, fasc. II «Bologna. Agitazioni operaie, dimostrazioni, scioperi, congressi». 327 La donna lavoratrice, «Almanacco della donna italiana», 1921, p. 109. 90 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale sità alle lotte del cosiddetto ‘biennio rosso’ a partire dal 1919 fino al 1921. La mobilitazione fu imponente a livello nazionale con scioperi generali e occupazioni di fabbriche che coinvolsero le operaie dei settori meccanici e metallurgici, delle industrie tessili, le sarte, le impiegate delle poste, le maestre, le lavoranti dei giocattoli, le cravattaie, le spazzolaie e le lavoratrici del vetro, «risolute e altere sempre, sicure nel loro valore di produttrici» come le operaie laniere e cotoniere del biellese che nell’estate del 1919 scesero in sciopero invadendo le vie cittadine.328 In queste mobilitazioni si esprimeva pubblicamente e con piena consapevolezza la volontà delle donne di ‘mettere in mostra’ la propria presenza. L’avvento del fascismo, però, mise fine al protagonismo operaio femminile. L’intervento dello Stato La legislazione sul lavoro femminile Nella seconda metà dell’Ottocento il mondo del lavoro era già popolato di donne: soprattutto migliaia di giovani e giovanissime affollavano gli opifici. La progressiva sostituzione della fabbrica alla manifattura e la logica della concentrazione di capitale avevano infatti esteso un modo di produzione basato essenzialmente sullo sfruttamento illimitato, senza vincoli legali della loro forza lavoro. L’uso indiscriminato delle donne e dei bambini era considerato dagli industriali una ‘necessità’: i loro bassi salari – argomentavano – garantivano la possibilità di fronteggiare la concorrenza straniera in un periodo di crisi in cui non era possibile ricorrere al rinnovamento dei macchinari.329 Della ‘questione’ del lavoro industriale delle donne si cominciò, comunque, a discutere soprattutto a partire dagli ultimi decenni dell’Ottocento, quando la condizione delle operaie divenne oggetto di inchieste e di proposte di disciplinamento: preoccupazioni suscitavano soprattutto i danni fisici che il lavoro industriale procurava alle operaie, incidendo sulla salute della prole e contribuendo a una loro degenerazione (denutrizione, deformazioni, morbilità).330 Per tali ragioni lo Stato decise di intervenire e affrontare intanto la scandalosa situazione del lavoro minorile:331 l’11 febbraio 1886 venne approvata la legge n. 3657 sul lavoro dei fanciulli, primo atto della legislazione sociale in Italia. La legge, povera di contenuti e molto al di sotto dello standard delle consimili leggi europee,332 introduce- 328 Battaglie biellesi, «La Difesa delle Lavoratrici», 6 luglio 1919. L’industria italiana si andava sviluppando in una fase particolarmente difficile a livello internazionale: la crisi del 1873 e la lunga depressione che ne seguì e che durò fino almeno al 1896. 330 Le leggi di tutela riguardarono soprattutto le operaie, ma il mondo del lavoro dell’epoca era tuttavia popolato da donne che operaie non erano. Di loro la legge si occupò ben poco: qualche sporadico provvedimento aveva via via consentito l’accesso delle donne a determinati impieghi (telefoniste, insegnanti, levatrici) e persino qualche funzione semi-pubblica (membri dei collegi dei probiviri per le controversie individuali di lavoro). Tuttavia, nessuna specifica ‘protezione’ legale era stata accordata alle donne lavoratrici. 331 L’età media di ammissione al lavoro si aggirava all’epoca fra i cinque e i sette anni e la quasi totalità dei minori occupati erano bambine. Cfr. MARIA VITTORIA BALLESTRERO, Dalla tutela alla parità. La legislazione italiana sul lavoro delle donne, Bologna, il Mulino, 1979, p. 16. 332 Su tale argomento cfr. Ivi, pp. 11-12. 329 Tra due secoli 91 Per la legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, «Avanti», 21 febbraio 1902, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, Bologna va il divieto di utilizzare il lavoro dei minori di nove anni in opifici, cave e miniere; limitava a otto ore giornaliere l’orario di lavoro per i minori di dodici anni e a sei ore il lavoro notturno dei giovani dai dodici ai quindici anni; vietava l’impiego dei minori di quindici anni nei lavori pericolosi ed insalubri. Questa norma si applicava solo negli opifici, vale a dire negli stabilimenti con motore meccanico o fuoco continuo o nei quali fossero occupati almeno dieci operai. L’esclusione dei piccoli stabilimenti aveva una notevole importanza pratica perché sottraeva alla disciplina legale non solo alcune industrie in cui il lavoro dei minori era più faticoso e pericoloso, ma soprattutto il lavoro a domicilio e i laboratori, nei quali erano occupate un gran numero di ragazze.333 Nulla, poi, veniva disposto per le donne. Per arrivare alla regolamentazione del loro lavoro furono necessari sedici anni; anni che vedevano crescere la partecipazione delle donne alle lotte operaie e al movimento di emancipazione e il Partito socialista assumere l’iniziativa per una legislazione ‘protettiva’. Tra il 1900 e il 1901, ad esempio, furono promosse numerose manifestazioni per propagandare una legge che regolamentasse il lavoro delle donne, manifestazioni sostenute essenzialmente dalle Camere del Lavoro che organizzarono in tutta Italia nel febbraio del 1902, i cosiddetti ‘cento comizi’, per cercare di sensibilizzare l’opinione pubblica e far pressione sul Parlamento. L’iter parlamentare che portò all’approvazione della legge 19 giugno 1902, n. 242 sul lavoro delle donne e dei fanciulli fu lungo e faticoso: ebbe inizio nel dicembre 1900, con la presentazione da parte del ministro Paolo Carcano del disegno di legge governativo, seguito nel maggio del 1901 da quello socialista. Quest’ultima proposta, legata al nome di Anna Kuliscioff, era per i tempi audacemente progressiva (pur essendo più arretrata 333 M.V. BALLESTRERO, La protezione concessa e l’eguaglianza negata: il lavoro femminile nella legislazione italiana, in Il lavoro delle donne cit., pp. 445-469: 447-448. 92 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale delle proposte avanzate da alcune Camere del Lavoro): cercava di favorire la protezione della lavoratrice madre e aveva l’ambizione di ricomporre il dissidio tra lavoro extradomestico ed esigenze familiari riducendo l’orario di lavoro a otto ore giornaliere, disposto al fine di ottenere che la donna fosse libera il sabato alle 15 e potesse così «accudire alle settimanali faccende domestiche», e assicurando un effettivo riposo domenicale. La richiesta della parità salariale, invece, era stata cassata, si temeva infatti che potesse sortire l’effetto di far abbassare i salari maschili anziché elevare quelli femminili. In Parlamento, un’apposita commissione cercò di armonizzare la proposta socialista con il disegno di legge governativo, elaborando infine un testo che non si discostava di molto da quest’ultimo e che teneva largamente conto degli interessi degli imprenditori.334 Le misure adottate erano complessivamente modeste: l’orario di lavoro giornaliero veniva fissato a dodici ore (con un intervallo di due ore, mai messo in pratica) e veniva previsto un riposo settimanale di ventiquattro ore; veniva vietato il lavoro sotterraneo per le donne di qualsiasi età mentre quello notturno era interdetto solo alle minorenni, la sua abolizione per le altre era rinviata di cinque anni, per non turbare «ad un tratto, con grandi riforme, ordinamenti industriali già formati».335 Veniva prevista anche l’istituzione del congedo di maternità, consistente in quattro settimane dopo il parto (nessun riferimento faceva invece la legge al periodo precedente il parto); tuttavia, per il periodo di riposo forzato non erano previsti né la retribuzione, né un indennizzo. Dalla sfera di applicazione della normativa, entrata in vigore il 1º luglio 1903, erano esclusi il settore agricolo336 e il lavoro a domicilio.337 Le disposizioni subirono, inoltre, una serie di correzioni e mutilazioni che ridussero in gran parte la sua già modesta portata: le norme transitorie dilazionavano l’esecuzione di alcuni articoli, il regolamento di attuazione limitava ulteriormente la sfera di applicazione della legge e una serie di circolari ministeriali, accogliendo le richieste degli industriali, ammetteva numerose deroghe ai divieti e al congedo di maternità. La tutela, comunque scarsa e contrastata, era accordata poi essenzialmente alle sole operaie e, nell’intenzione dei legislatori, tendeva a salvaguardare la loro capacità riproduttiva: «il fine è di evitare che le donne minorenni si infiacchiscano e diano al paese generazioni di deboli e infelici» dato che «la donna debole procrea uomini deboli».338 La legge dunque rispecchiava le idee allora diffuse sulla naturale inferiorità delle donne e sulla maternità come loro unica funzione sociale. La legge Carcano (dal nome del ministro che l’aveva presentata) venne parzialmente modificata con la legge 7 luglio 1907, n. 416 (confluita poi nel Testo Unico sul lavoro delle donne e dei fanciulli del 10 novembre 1907, n. 816) che introduceva il divieto di lavoro notturno per le donne di qualsiasi età, prevedendo comunque numerose eccezioni.339 334 F. PIERONI BORTOLOTTI, Socialismo e questione femminile in Italia cit., p. 70. M.V. BALLESTRERO, Dalla tutela alla parità cit., p. 20. 336 Nel periodo esaminato, l’unica legge che venne emanata riguardò le mondine: l’articolo 82 del Regio Decreto 1º agosto 1907, n. 636 (Testo unico delle leggi sanitarie) garantiva alle risaiole l’astensione dal lavoro nell’ultimo mese di gravidanza e nel primo dopo il parto. 337 Anche se la nozione di opificio risultava più ampia che nella precedente legge del 1886, poiché vi erano compresi i luoghi in cui lavoravano normalmente più di cinque operai. 338 Il passo è tratto dagli atti parlamentari senza citazione specifica, cfr. M.V. BALLESTRERO, Dalla tutela alla parità cit., p. 22. 339 Ad esempio, l’art. 32 del regolamento di attuazione (Regio Decreto n. 442 del 1909) consentiva la deroghe al lavoro notturno nelle industrie «che trattavano materie suscettibili di rapida alterazione e che non permettevano sospensione di lavorazione». M.V. BALLESTRERO, La protezione concessa e l’eguaglianza negata cit., p. 455. 335 Tra due secoli 93 Il 17 luglio 1910, con legge n. 520 veniva istituita finalmente la Cassa di maternità, deputata al pagamento del sussidio a favore delle lavoratrici in congedo e finanziata con i contributi posti a carico delle lavoratrici e degli imprenditori: solo a partire da quella data le lavoratrici poterono godere, nel periodo di assenza dal lavoro, di una prestazione economica (sussidio di 30 lire erogato dalla Cassa e di 10 lire dallo Stato) che comunque aveva carattere di elargizione assistenziale, fissata in una cifra predeterminata e non ragguagliata al salario.340 Con il deflagrare del conflitto, le donne venivano irreggimentate nelle industrie di guerra e costrette a lavori pesanti e nocivi, il governo, infatti, si era affrettato ad emanare norme per rendere partecipi le donne ‘al difficile momento’; così con Regio Decreto 14 agosto 1914, n. 925 era stato sospeso il divieto di lavoro notturno, mentre il decreto legge n. 1136 del 1916 riammetteva le donne ad alcuni lavori esclusi dal Testo Unico del 1907 e dal successivo regolamento di attuazione, suscitando la netta contrarietà delle donne socialiste espressa su «La Difesa delle Lavoratrici». La grande mobilitazione aveva reso evidente che le donne stavano assumendo un ruolo centrale nella costruzione dello Stato ma il risultato di quel processo non fu il riconoscimento di diritti politici, per i quali le donne avrebbero dovuto aspettare un altro dopoguerra. Dopo il primo conflitto mondiale, invece, arrivarono riforme che ampliavano i diritti civili: la legge 17 luglio 1919, n. 1176 sulla capacità giuridica abrogava l’istituto dell’autorizzazione maritale341 e sanciva all’art. 7 l’ammissione delle donne «a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti i pubblici impieghi» esclusi soltanto «quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali, o l’esercizio di diritti o podestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato».342 Questo articolo, giustamente considerato una tappa decisiva dell’emancipazione femminile, ebbe tuttavia una applicazione che ne doveva impoverire notevolmente l’effetto. Il regolamento applicativo del gennaio 1920 precludeva, infatti, alle donne ogni funzione direttiva, la carriera diplomatica, quella nell’esercito e nella magistratura, lasciando poi ampia discrezionalità alle amministrazioni di individuare casi di esclusione non previsti dal regolamento stesso. Un caso esemplare in tal senso fu quello delle insegnanti: il Ministero della Pubblica Istruzione venne autorizzato a non ammettere per regolamento le donne all’insegnamento in talune scuole e/o di talune materie, con questa motivazione: «la formazione della mente e del carattere del cittadino devono compiersi nella scuola media di secondo grado in ispecie attraverso certi insegnamenti, e questi non possono essere affidati alla donna, la quale non dà adeguato affidamento per le sue qualità fondamentali, che non sono modificabili da tirocinio e cultura».343 Può essere di qualche interesse, poi, riportare come i membri della Commissione ministeriale del Senato sul progetto di legge difendessero questo provvedimento da chi lo considerava dannoso per la famiglia. Nella relazione da essi stilata si leggeva: 340 M.V. BALLESTRERO, Dalla tutela alla parità cit., p. 27. Peraltro, già durante il conflitto, la normativa vigente aveva subìto significative sospensioni in funzione delle esigenze finanziarie dello Stato. Il 21 gennaio 1917 il decreto luogotenenziale n. 54 aveva, infatti, resa non necessaria l’autorizzazione maritale per le operazioni relative ai prestiti di guerra, fatte direttamente dalle donne sposate presso gli istituti di emissione. I. VACCARI, La donna nel ventennio fascista cit., pp. 57-59. 342 M.V. BALLESTRERO, La protezione concessa e l’eguaglianza negata cit., p. 458. 343 Ivi, p. 460. 341 94 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale L’evoluzione sociale va rendendo sempre più numeroso lo stuolo di quelle che non trovano una posizione soddisfacente nel matrimonio o comunque nella compagine famigliare […] ad ogni buon modo le donne che hanno la vocazione della famiglia e la sensibilità di adempiervi, non vi rinunciano così facilmente, solo perchè virtualmente abilitate alle carriere delle professioni; e quelle che tali vocazioni non hanno, troveranno nella via meglio aperta a procurarsi decorose occupazioni un incentivo di più a non diventare delle irregolari.344 Con le amare vicende del dopoguerra, e nel momento del passaggio dal sistema liberale al regime fascista, si concludeva anche la prima, lunga e complessa fase della legislazione sul lavoro delle donne. 344 PAOLO EMILIO BENSA, Per la capacità giuridica e professionale della donna, Relazione della Commissione del Senato sul progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati il 9 marzo 1919, in Giurisprudenza italiana e La legge, Torino, Utet, 1919, pp. 24-32, citato in M. PALAZZI, Donne sole cit., p. 423. La prima guerra mondiale Lavorare in tempo di guerra Per tutti gli interstizi una fiumana di donne è penetrata, gorgogliando e frusciando, nei luoghi degli uomini: campi, fabbriche… talune, è vero, assomigliano ai bambini, specie quando ancora non ne hanno di propii: si stancano, si distraggono, sospirano, liticano, s’impuntano, scioperano, minacciano, strillano. Ma le più, insomma, lavorano e sono preziose, e s’ha bisogno di loro… la donna è prima di tutto un essere pratico il cui lavoro sociale è utilissimo se il suo compito è limitato.1 Così si esprimeva lo scrittore Ugo Ojetti nel 1917 sul «Corriere della sera». A parte il tono paternalistico, si trattava di un significativo, e del resto inevitabile, riconoscimento. Con lo scoppio della Prima guerra mondiale, infatti, le donne furono chiamate a rimpiazzare gli uomini nei luoghi e nei ruoli lasciati dagli uomini impegnati al fronte: non solo li dovettero sostituire a capo delle famiglie, di cui spesso divennero l’unico punto di riferimento e le uniche procacciatrici di reddito, ma anche nei posti lavorativi e nei ruoli direttivi e amministrativi fino ad allora preclusi, come, ad esempio, nella conduzione delle aziende familiari. La Grande guerra – evento traumatico che coinvolse grandi masse causando la rottura degli equilibri fra i sessi nella famiglia e nella società2 – fu una esperienza collettiva che coinvolse tutte le donne e le cui conseguenze furono numerose: spesso comportò l’accettazione di responsabilità mai assunte prima di allora, con la sperimentazione di competenze di solito considerate non adeguate alla ‘natura’ femminile o svalorizzate. Il primo conflitto mondiale ebbe, dunque, conseguenze molto rilevanti per l’entrata in massa delle donne sulla scena pubblica e in particolare nel mondo del lavoro. Dal confronto fra i dati dei censimenti del 1911 e del 1921 risulta che, industria a parte, in 1 SALIO [Ugo Ojetti], Le donne e la guerra, «Il Corriere della sera», 30 aprile 1917, citato in A. GIBELLI, La Grande guerra degli italiani cit., p. 190. 2 «Le crisi costituiscono spesso un importante osservatorio per analizzare le relazioni fra i sessi e le condizioni che influiscono sul loro condizionamento o le loro trasformazioni. Le fasi in cui, in molte società, si interrompono provvisoriamente o si abbandonano in via definitiva vecchi equilibri familiari, economici, sociali, culturali, si caratterizzano anche per una messa in discussione o comunque per una modifica, più o meno duratura più o meno generalizzata, della peculiare divisione dei ruoli e dei poteri femminili e maschili dominanti in un dato contesto, sia nell’ambito privato delle relazioni sia in quello pubblico dei rapporti sociali. Quando la crisi provoca un’interruzione o una sospensione della divisione dei ruoli dominante e in particolare produce assenza o allontanamento degli uomini adulti, le donne si possono trovare a svolgere funzioni familiari e sociali normalmente interdette al loro sesso, di conseguenza il loro spazio di azione ne risulta ampliato sia nell’ambito domestico sia in quello lavorativo. La guerra è un fenomeno di questo tipo, un evento sociale che coinvolge grandi masse di uomini e donne in esperienze che comportano effetti significativi anche in termini di soggettività e di identità sociale». M. PALAZZI, Donne sole cit., pp. 362-363. 96 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale tutti gli altri comparti (trasporti e comunicazioni, commercio, banche e assicurazioni, amministrazione pubblica e privata, professioni e arti liberali) la presenza di manodopera femminile aumentò in cifre assolute, ma – a causa della crescita complessiva dell’occupazione – solo in alcuni di essi si verificò un aumento anche in percentuale: nei trasporti, e soprattutto nel settore bancario e assicurativo (dove passò dal 3,5 all’11,4%), nell’amministrazione (dal 4,7 al 12,9%) e nelle professioni.3 Nelle manifatture la loro presenza aumentò nei settori già fortemente femminilizzati, come quelli tessili, dell’abbigliamento e alimentari, spesso convertiti per esigenze belliche, ma anche nei comparti a prevalente manodopera maschile, come quello meccanico, della produzione di armamenti e in generale di allestimento di materiali bellici.4 Se in generale alla fine del 1916 nell’industria delle munizioni le donne rappresentavano il 18% della manodopera occupata, in alcuni spolettifici raggiungevano il 95% e nella lavorazione delle granate il 90%. Così, secondo i dati forniti dal Comitato nazionale per il Munizionamento, negli stabilimenti impegnati nella produzione militare le donne «al 1º agosto 1914 […] erano appena 1760, al 1º marzo 1916 esse erano divenute 6.000, 60.000 circa al 31 ottobre 1916 e 90.000 al 31 dicembre 1916»,5 salirono poi a 140.000 nel 1917 per toccare il massimo di quasi 200.000 alla fine della guerra.6 Ecco come rilevava la novità delle ‘donne al tornio’, Donna Paola, la scrittrice Paola Baronchelli Grosson, autrice di diversi libri e opuscoli dedicati alla mobilitazione della donna per la guerra, tra cui La donna della nuova Italia. Documenti del contributo femminile alla guerra, pubblicato nel 1917: Soltanto due anni addietro un ingegnere, un capo-tecnico avrebbe riso come di una stramberia all’idea di mettere una donna al tornio… cioè al congegno tradizionalmente di competenza mascolina […] Ebbene le notizie in possesso del Ministero Armi e Munizioni dimostrano che le donne possono eseguire, ed oggi eseguiscono, gran parte delle lavorazioni per la produzione del materiale da guerra, quali: la lavorazione dei cannoni da piccolo e medio calibro; la fabbricazione dei proiettili e bombe di tutti i calibri; la lavorazione e il montaggio di macchine di precisione, cioè motori per aviazione e per automobili, e macchine utensili; la lavorazione a caldo per la trafilatura dei proiettili; la lavorazione dei più potenti esplosivi; la manovra delle gru; l’estrazione dei minerali di ferro ed altri occorrenti alla fabbricazione delle armi, ecc.7 «Le massaie della guerra» le chiamavano su «L’Illustrazione italiana» commentando l’immagine certo non usuale di donne che sistemavano bombe in un cortile, ‘moder3 Ciò era l’indizio di una linea di tendenza innescata dalla guerra, che il ritorno alla ‘normalità’ del dopoguerra non fu sufficiente a invertire. Per i dati cfr. A. GIBELLI, La Grande guerra degli italiani cit., p. 191. Inoltre, su tale argomento, cfr. BARBARA CURLI, Italiane al lavoro 1914-1920, Venezia, Marsilio, 1998. 4 Per favorire un avvicinamento graduale delle donne a questo tipo di lavoro per loro certamente inusuale, a Bologna, per iniziativa e intervento di privati, venne aperta una scuola professionale femminile. L’intento non era tanto l’addestramento, in generale attuato all’interno delle fabbriche, ma proprio quello di vincere le diffidenze femminili. Cfr. M. PALAZZI, Donne sole cit., p. 416. 5 COMITATO NAZIONALE PER IL MUNIZIONAMENTO, Il lavoro femminile nella industria di guerra italiana, Roma, Calzone, 1917, pp. 20-21. 6 Cfr. COMITATO CENTRALE DI MOBILITAZIONE CIVILE, I comitati regionali di mobilitazione industriale (1915-1918), Milano-Roma, L. Alfieri, [dopo 1925] e A. GIBELLI, La Grande guerra degli italiani cit., p. 184. 7 DONNA PAOLA [Paola Baronchelli Grosson], La donna della nuova Italia. Documenti del contributo femminile alla guerra (maggio 1915-maggio 1917), Milano, R. Quintieri editore, 1917, p. 242. La prima guerra mondiale 97 ne Penelopi’ non più impegnate a fare e a disfare la tela in attesa del ritorno dell’uomo dalla guerra, ma a sostituirlo in tutti i posti di lavoro lasciati sguarniti.8 A colpire maggiormente la fantasia, suggerendo pezzi di colore sui giornali e la pubblicazione di fotografie, fu soprattutto la comparsa delle donne in occupazione davvero inconsuete (soprattutto tramviere e spazzine), ricoprendo le quali esse sembravano modificare le regole della società civile, quasi mascolinizzarsi, anche per via delle ‘divise’ che le identificavano: «Esse portano in testa una specie di cuffia grigia ed hanno un lungo soprabito dello stesso colore», scriveva «L’avvenire d’Italia» quando comparvero le tramviere a Bologna «sulle linee di S. Stefano, di S. Ruffillo e della Mascarella», subito aggiungendo, quasi a voler rassicurare i lettori, che «tutte adempirono al loro incarico con vera gentilezza».9 Per utilizzare queste donne, però, era necessario che le istituzioni prendessero delle precauzioni, come quelle di stabilire precise regole di comportamento per gli utenti al fine di rispettare, nonostante le precarietà dei tempi, le necessità del vivere civile, così il Prefetto scriveva al Sindaco sottolineando l’opportunità di evitare «gli ingombri del pubblico nell’interno delle vetture, pericolosi e poco convenienti per la morale e la decenza» vietando «di ingombrare in piedi lo spazio delle corsie longitudinali nello interno delle vetture stesse».10 Molto più scontato fu l’impiego delle donne negli speciali laboratori – che vennero installati appositamente – o nella lavorazione a domicilio per la produzione di indumenti militari, impiego che registrò uno straordinario incremento. Ad esempio, il laboratorio sartoriale di Bologna, costituito dalla Fondazione Formiggini11 e convertito nel 1915 per confezionare divise affinché «lo Stato potesse realizzare risparmi sulle sue forniture» e perché trovassero «conveniente occupazione le donne povere appartenenti a famiglie di richiamati alle armi o di disoccupati», nel 1917 produsse 15.181 pezzi e nei primi quattro mesi del 1918 «23.949, più 8.656 capi in lana».12 Non meno importante fu l’azione delle donne nelle campagne: secondo calcoli attendibili, su una popolazione di 4,8 milioni di uomini che lavoravano in agricoltura, 2,6 furono richiamati alle armi, sicché le mogli dei mezzadri, dei piccoli proprietari e dei coltivatori affittuari si trovarono per la prima volta in grande numero a sostituire i mariti nella direzione delle aziende, mentre le braccianti con il proprio lavoro non dovevano più integrare il salario sovente insufficiente dei mariti, bensì mantenere interi nuclei familiari spesso composti unicamente di bambini e anziani, con un aggravio di fatica e di responsabilità. 8 Il riferimento è all’articolo Penelope moderna, apparso su «La lettura» nell’agosto del 1916, citato in A. GIBELLI, La Grande guerra degli italiani cit., p. 192. 9 Le donne tramviere in servizio, «L’Avvenire d’Italia», 26 ottobre 1916. 10 Lettera del Prefetto di Bologna al Sindaco, Bologna, 6 novembre 1916, in Archivio del Comune di Bologna, Carteggio amministrativo, Titolo XIII «Opere pubbliche», Rub. 1, Sez. 2 «Strade e piazze», n. corda 439, anno 1916. 11 La fondazione, istituzione pubblica di beneficenza eretta in ente morale con RD 17.4.1913, fu costituita in seguito alle disposizioni testamentarie del dottor Alberto Sabatino Formiggini, modenese, che lasciò il suo patrimonio ai Comuni di Bologna e Modena perché fossero aperti laboratori retti con moderni sistemi ed atti a combattere e lenire la disoccupazione operaia. All’epoca presidente della fondazione era l’avvocato Demos Altobelli e nel comitato di gestione era attiva Argentina Altobelli. Il laboratorio ebbe sede dapprima nel salone di Palazzo dei Notai, poi in via Zamboni, 6. Cfr. Il laboratorio della Fondazione Formiggini in Bologna, maggio 1917-maggio 1918, «La vita cittadina», maggio 1918, p. 121. 12 Ibidem. 98 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale Le contadine, dunque, videro dilatarsi i tempi e i cicli abituali di lavoro (col coinvolgimento delle più giovani e delle più anziane) e dovettero coprire mansioni dalle quali erano tradizionalmente esentate. A cadere era soprattutto la divisione del lavoro che voleva affidati agli uomini i compiti più pesanti e impegnativi, come vangare, seminare, falciare e persino guidare le macchine agricole: «Tutti i lavori che dovevano fare gli uomini, li facevo anch’io. – raccontava una donna –. Andavo persino a sporgere i covoni, a scaricare il grano, ad aiutare a trebbiare quando veniva la macchina». E ancora: «Alla Riviera a trebbiare mi ricordo, eravamo tutte donne, c’era qualche macchinista… ma per il resto facevamo tutto noi. Chi buttava i covoni, chi tagliava».13 I dati di cui si dispone sembrano dimostrare che l’impegno femminile fu maggiore nelle regioni dove il coinvolgimento nei lavori agricoli era già nel passato più esteso, come in Emilia-Romagna.14 A Parma, scriveva Antonio Bizzozero, direttore della Cattedra ambulante di agricoltura della città, c’era chi «colla sola suocera» aveva governato trentadue capi di bovini e coltivato 6000 mq. di terreno a pomodoro; chi, con l’aiuto di due garzoni aveva prodotto «600 forme di grana Parmigiano» e, in due anni, «ingrassato oltre centotrenta maiali»; chi aveva consegnato «alle commissioni incaricate alle requisizioni bovine, il fieno e la paglia compiendo talora lunghi e faticosi tragitti»; chi aveva sostituito il marito come macchinista alle latterie sociali; e infine chi, dal mestiere di sarta svolto fino ad allora, era passata a condurre un’azienda dotata di sette macchine trebbiatrici e a occuparsi dell’assunzione di salariati, della stipulazione dei contratti relativi alla pressatura dei foraggi con l’autorità militare e, in generale, a impegnarsi nella direzione e amministrazione di complesse imprese agricole.15 Furono il grande impegno e la perizia di queste donne a consentire, nonostante la gravità del momento, di contenere i danni provocati dalle contingenze belliche, come riconobbe il ministro dell’Agricoltura, Giovanni Ranieri nel gennaio 1917: «Nessuno saprà mai mettere abbastanza in luce il paziente lavoro, la tranquilla rassegnazione, la pertinace costanza della donna di campagna, alla quale è dovuto in gran parte se la terra, priva di tante braccia valide e di volontà operose date alla guerra, ancora produce di che alimentare le genti italiane».16 Nonostante il contributo dato, il massiccio ingresso delle donne nei lavori e negli ambienti maschili provocò diffidenze e atteggiamenti di rigetto che non di rado attingevano ai più triti stereotipi e a pregiudizi moralistici. Nelle fabbriche metalmeccaniche la presenza femminile era talvolta avvertita come inutile e non necessaria: «Non meno di un centinaio di donne si notavano [nel reparto] in permanenza oziose: si leggevano romanzi, si scrivevano lettere, si faceva la calza, si 13 I brani delle testimonianze sono tratti da A. BRAVO, Donne contadine e prima guerra mondiale, «Società e storia», 1980, 10, p. 847 e p. 856. 14 M. PALAZZI, Donne sole cit., pp. 414-415; S. SOLDANI, Donne senza pace. Esperienze di lavoro, di lotta, di vita tra guerra e dopoguerra (1915-1920), in Le donne nelle campagne italiane del Novecento, a cura di Paola Corti, «Annali Istituto A. Cervi», 1991, 13, pp. 11-56. 15 Il libro d’oro delle donne dell’agro parmense. Le donne premiate negli anni di guerra 19161917, a cura di Antonio Bizzozero, Parma, Tip. Pelati, 1920, pp. 33, 35, 37, 40. Nel volume sono elencate le motivazioni dei premi alle donne parmensi, premi che il ministero dell’Agricoltura aveva deciso di assegnare con decreto nel luglio del 1917 a tutte le italiane «che si erano distinte in modo esemplare, per operosità costante e produttiva, nell’attendere ai lavori agrari e alla direzione di questi». Cfr. M. PALAZZI, Donne sole cit., pp. 414-415 e S. SOLDANI, Donne senza pace cit., pp. 17-18. 16 I. VACCARI, La donna nel ventennio fascista cit., p. 48. La prima guerra mondiale 99 chiacchierava e si dormiva in luogo di lavorare», scriveva, in un rapporto al suo dirigente, un caposquadra dell’Ansaldo, descrivendo l’apporto delle donne alla produzione.17 E ancora le nuove assunte potevano essere considerate oggetto di favoritismi interessati da parte di dirigenti maschi, o donne che approfittavano della nuova condizione e vivevano nel lusso, sciupando i loro salari «per abbigliarsi in modo non consono Donne mentre puliscono cartucce a Villa Contri alla loro condizione», come in Bologna, 1915-1918, Museo Civico denunciava il Prefetto di Bologna del Risorgimento, Bologna nel febbraio del 1917.18 Per quanto elementi di rottura e di mutamento si fossero introdotti nei rapporti tra i generi durante il conflitto, nel dopoguerra si affermò nettamente una controtendenza. Finito il tempo del grande scontro, tutti provavano un forte bisogno di sicurezza a cui lo Stato rispose prescrivendo alle donne il rientro nei ranghi, nei Spazzine in via Riva Reno a Bologna, 1916, ruoli familiari, nei compiti pro- Museo Civico del Risorgimento, Bologna creativi e materni. Secondo la retorica dominante, la parentesi della guerra doveva essere chiusa anche in questo senso. Nell’ambito del lavoro, la riconversione a un’economia di pace provocò una drastica riduzione dell’occupazione femminile. Solo per pochi settori, come quello impiegatizio, la guerra rappresentò una tappa del processo di espansione della presenza femminile. Nell’industria il processo di smobilitazione della forza lavoro femminile fu molto rapido, più lento ma comunque profondo nell’agricoltura. I modi in cui vennero pagati i sussidi di disoccupazione rivelano in modo inequivocabile il significato che le istituzioni attribuivano alla mobilitazione della manodopera femminile. A Bologna, per esempio, le sovvenzioni furono concesse soltanto alle donne che erano state operaie anche prima del conflitto e in ogni caso per un ammontare più basso e per un tempo più limitato di quanto avveniva con gli uomini (140 giornate contro 150). Alle braccianti il sussidio venne sospeso nel dicembre 1919, quando iniziava il periodo di disoccupazione stagionale: secondo la logica fatta prevalere dalle autorità la mancanza di lavoro, a quel punto, non era imputabile alla guerra e perciò i loro diritti si estinguevano.19 17 A. GIBELLI, La Grande guerra e gli italiani cit., p. 193. Lettera del Prefetto al Ministro dell’Interno, Bologna, 21 febbraio 1917, in ASBo, Gabinetto di Prefettura, b. 1275. 19 I. VACCARI, La donna nel ventennio fascista cit., pp. 57-59. 18 100 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale In un contesto come questo, le medaglie d’oro e i miseri premi conferiti alle donne che si erano particolarmente distinte con il loro lavoro, al di là della retorica, avevano soprattutto il significato di dichiarare conclusa un’emergenza, ripristinare gli equilibri prebellici nelle relazioni fra i sessi, chiudere la parentesi: «mentre i reduci tornavano a casa, le loro mogli avrebbero dovuto tornare “in” casa».20 Mobilitarsi in tempo di guerra Tra gli aspetti della mobilitazione femminile per il conflitto ebbero maggiore eco quelli di tipo assistenziale. Nell’assistenzialismo patriottico confluirono la tradizione caritativa tipica del mondo cattolico, quella filantropica di segno laico ma anche attività di sostegno elaborate dal femminismo. Ad alimentarlo fu un volontariato espresso specialmente da donne di estrazione borghese e aristocratica. Le cosiddette ‘Dame visitatrici’ e quelle che si mettevano a disposizione dei vari ‘Uffici assistenza’ e ‘Uffici dono’,21 sorti un po’ ovunque, avevano il compito di recare sostegno, conforto e aiuto materiale alle famiglie dei mobilitati nonché agli stessi soldati che si trovavano in licenza, nelle retrovie o ai feriti negli ospedali. Nell’esecuzione di queste e altre funzioni simili, considerate tipicamente femminili e consone al decoro borghese, veniva esaltato il ruolo materno della donna, una maternità simbolica, per così dire estesa dalla sfera privata a quella pubblica. Questo ruolo materno, questa sorta di maternage di massa, si esplicava in varie forme. Le donne, come direttrici e come lavoranti, si impegnarono a fondo, oltre che nell’attività di laboratori di cucito e per la confezione di divise e di indumenti adatti a proteggere i militari dal freddo, nella raccolta della lana, e ancora nei servizi dei cosiddetti ‘Uffici Notizie’ che avevano il compito di favorire i contatti tra i combattenti e le famiglie e di trasmettere informazioni soprattutto su feriti, dispersi, morti e prigionieri. La sede centrale, che coordinava e dirigeva le 8.400 sezioni periferiche per le notizie riguardanti i militari di terra,22 venne istituita a Bologna per iniziativa di un gruppo di nobildonne guidate da Lina Bianconcini Cavazza. La contessa arrivò a concedere il primo piano del suo palazzo di via Indipendenza 69 per impiantarvi l’ufficio fino al 1916, quando, data la sopravvenuta inadeguatezza della sede, questo fu trasferito presso i locali delle Poste situati in via Farini 3.23 Il sistema funzionava in questo modo: Ogni sede di Corpo d’armata e le principali città hanno una sezione dell’Ufficio: le sottosezioni trovansi nelle sedi dei distretti o dei centri di mobilitazione o degli ospedali cha abbiano un cospicuo numero di letti […]. Ogni sottosezione ha la sua visitatrice, una schiera di signore e signorine che si recano negli ospedali più volte alla settimana e fanno l’elenco dei militari feriti o malati colle loro generalità e colla natura delle malattie, e raccolgono insieme quelle noti20 M. PALAZZI, Donne sole cit., p. 422. A Bologna fu istituito il Laboratorio per i doni ai soldati combattenti, presieduto da Giulia Montanari. Cfr. I. VACCARI, La donna nel ventennio fascista cit., p. 45. 22 Il coordinamento delle informazioni dei ‘militari di mare’ veniva attuato dall’altro ufficio centrale di Roma. 23 ELISA ERIOLI, L’«Ufficio Notizie alle famiglie dei militari». Una grande storia di volontariato femminile bolognese, in Archiviare la guerra. La Prima Guerra Mondiale attraverso i documenti del Museo del Risorgimento, a cura di Mirtide Gavelli, «Bollettino del Museo del Risorgimento», L, 2005, pp. 75-90: 78. 21 La prima guerra mondiale 101 ROBERTO SEVARDI, Comitato di assistenza civile di Reggio Emilia. Confezione di calzature per militari, 1919, Fototeca della Biblioteca Panizzi, Reggio Emilia zie che ogni militare desidera di aggiungere affinché siano trasmesse alla famiglia. Se i militari appartengono, per la residenza della loro famiglia, alla sezione, le notizie vengono catalogate e trattenute nello schedario della sezione; se appartengono invece ad altre sezioni, le schede vengono inviate a quella sezione che si incarica tosto di comunicare le notizie desiderate alla famiglia; in ambi i casi una copia delle schede è inviata alla sede centrale in Bologna, la quale deve servire da tramite e coordinamento fra tutte le sezioni e deve sapere indirizzare le ricerche per tutte le domande che le vengono rivolte. Se una richiesta di notizie pertanto giunge a una sezione, questa guarda prima nei suoi schedari e, se non trova il nome, ne fa richiesta all’ufficio centrale: questo o ha notizie e le spedisce tosto, o non le ha, e allora invia domanda al colonnello del reggimento cui appartiene il soldato, e si è sicuri che dopo 8 o 10 giorni al massimo arriva dal colonnello la risposta: che il militare sta bene, o è ferito, o malato, o disperso.24 All’interno dell’ufficio bolognese 350 volontarie25 si dividevano nella gestione dello spoglio della corrispondenza: dalle richieste di notizie che giungevano da sezioni e sottosezioni a quelle dei privati che scrivevano direttamente alla struttura nella speranza di accelerare i tempi di risposta; dalle comunicazioni dei comandi militari e dei depositi alla corrispondenza dei cappellani dalle zone di guerra che fornivano dati sui combattenti.26 Il lavoro di smistamento era febbrile: in alcuni periodi, soprattutto in concomitanza degli attacchi, le bolognesi arrivarono a smistare diecimila informazioni al giorno, tanto che al termine del conflitto lo schedario dell’ufficio contava 12 milioni di schede-notizie. 24 ALBANO SORBELLI, Accanto alla guerra. L’Ufficio notizie, «La Lettura», XVI, 1, 1º gennaio 1916, pp. 63-69: 65-66. 25 Complessivamente le donne mobilitate nei vari uffici furono circa 25.000. Cfr. E. ERIOLI, L’«Ufficio Notizie alle famiglie dei militari» cit., p. 78. 26 Ivi, p. 81. 102 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale Iniziative particolarmente rilevanti, poi, furono messe in atto per propagandare e favorire la sottoscrizione ai vari prestiti nazionali lanciati dallo Stato per rastrellare il risparmio privato. La Federazione emiliana del Consiglio nazionale delle donne italiane invitava a partecipare alla sottoscrizione utilizzando «i mille e mille modesti rivoli del risparmio femminile», i «prodotti nascosti della virtù e della previdenza muliebre» poiché «la donna lavoratrice che si mostrasse capace, in un momento tanto grave per la Patria, di apportarle con le sue sole forze così cospicue risorse economiche, dimostrerebbe con eloquenza al legislatore come la soggezione giuridica dell’autorizzazione maritale Ufficio notizie di Bologna, «La lettura. Rivista non sia più per lei, che tanta resisten- mensile del Corriere della Sera», a. XII, 1916, za sa mostrare ai dispendi, che lavora, Museo Civico del Risorgimento, Bologna guadagna, risparmia, e per ciò stesso ha il diritto di amministrare e tutelare col marito l’azienda domestica».27 Nelle attività di sostegno allo sforzo bellico sembravano venire alla luce quell’inventiva e quelle capacità non solo di risparmio ma anche di riutilizzo che erano considerate virtù tipicamente femminili e che costituivano una risposta a tempi di penuria e di restrizioni. Le donne adoperarono, per farne cappotti, frammenti di pellicce prelevati da indumenti usati; promossero allo stesso scopo l’allevamento dei conigli; idearono forme di riuso della carta di giornali o confezionarono i cosiddetti ‘scaldaranci’ piccoli rotoli di carta paraffinata per riscaldare il rancio nelle gavette; realizzarono speciali superfici compresse detti ‘coltroni’ (grandi coltri) che proteggevano i soldati dal vento e dal freddo; concepirono particolari indumenti antiparassitari contenenti miscele per tener lontani i pidocchi che tormentavano i fanti in trincea e idearono ‘fasce da piedi’ che, imbevute di una speciale miscela chimica, scongiurarono i temuti congelamenti, causati del corredo militare inadatto e incompleto. Le donne provvidero persino a organizzare la raccolta di noccioli di frutti (pesche, albicocche, prugne) per vari usi farmacologici e di saponificazione.28 Persino la maschera antigas, simbolo di una guerra combattuta coi mezzi più terrificanti, fu creata a quanto pare dalle donne di un comitato bolognese, prima di essere perfezionate da esperti chimici e di entrare stabilmente nel corredo dei militari.29 Le iniziative si moltiplicarono. Per i figli delle donne che dovevano lavorare furono improvvisati nidi e asili per bambini e ricreato27 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE DONNE ITALIANE, FEDERAZIONE EMILIANA, Le piccole risparmiatrici e il prestito nazionale. Conferenza di Gilda Chiari Allegretti detta in Bologna il 10 gennaio 1916 sotto gli auspici dell’Università popolare, Bologna, Stab. poligrafico Emiliano, 1916, p. 9 e p. 24. 28 Cfr. A. GIBELLI, La grande guerra degli italiani cit., pp. 197-201. 29 La proprietaria di un negozio di merceria di Bologna, Bianca Bordoli, ebbe per prima l’idea di creare una mascherina contro i gas asfissianti. Certo l’arnese ideato era rudimentale, ma diede modo al prof. Giacomo Ciamician dell’Ateneo felsineo di perfezionarlo, tanto che il modello risultante pare fosse adottato dal governo. Cfr. I. VACCARI, La donna nel ventennio fascista cit., p. 46. La prima guerra mondiale 103 ri per fanciulli. A Bologna ne sorsero sei, per merito di Elena Sanguinetti Ghiron, che assistevano circa 800 fra bimbi e ragazzi. La meritevole attività venne ricordata da Giulia Cavallari Cantalamessa nel suo L’opera di una donna nel periodo della guerra.30 Per i profughi delle terre invase vennero attrezzati posti di ristoro. A Piacenza, importante nodo ferroviario, furono organizzati da Gilberta Nasalli Rocca che aveva mobilitato a tal fine una numerosa schiera di collaboratrici. Per provvedere di indumenti i feriti e i figli di richiamati furono attivati vari laboratori, tra cui si distinse quello dipendente dal Comitato femminile di assistenza di Reggio Emilia, presieduto da Virginia Guicciardi Fiastri.31 Queste e molte altre attività femminili vennero riportate nel volume La donna nella nuova Italia. Documenti del contributo italiano alla guerra,32 scritto da Paola Baronchelli Grosson, nota come Donna Paola, che ne fornì, a guerra ancora in corso, un quadro ampio e dettagliatissimo. La pubblicazione può essere considerata anche un utile documento dell’epoca su come poteva venire presentata la mobilitazione patriottica femminile ai contemporanei. La scrittrice infatti collegava le conquiste prodotte dal femminismo – «lo studio che libera la mente» e il «guadagno che libera il corpo» – con il nuovo bisogno di partecipazione e di protagonismo, fino a quel momento impedito o negato: L’ultimo ventennio del femminismo aveva abbastanza illuminata e sorretta la donna e si deve all’azione sua il contegno consapevole e pur docile che toglieva, forse, la possibilità di isolati esempi di eroismo […] ma che offriva al Paese l’esempio di una intera massa di coscienti, di volonterose, di anonime donne, accettanti l’olocausto come un supremo dovere, accettanti l’obbligo di cooperare anche con la mente e col braccio, perché l’olocausto non fosse un semplice gesto sacerdotale ma il contributo attivo al definitivo riscatto dell’Italia dalla servitù dello straniero. Così questo contributo si è offerto subito complesso: la donna ha dato, senza versare inutili lacrime dagli occhi e paga di versare entro il cuore le sacre lacrime che nessuno vede e che perciò non reclamano l’apologia della sensibilità muliebre… i propri uomini: figli, mariti, fratelli, amici. E, anche ella si è messa in linea, agli ordini dei dirigenti la vita sociale, senza che le vanità dell’arrivismo inducessero maggiori dislivelli nella qualità e nella sincerità dell’offerta […]. Ma poiché i dislivelli sociali esistono […] le offerte della collaborazione femminile presero subito il loro posto determinato e l’aristocratica offrì piuttosto contributo filantropico e la borghese offrì piuttosto contributo civile e la popolana offrì piuttosto contributo di mano d’opera. Tutte poi, sia con l’immediato esborso di denaro sia col mediato risparmio, offersero anche il proprio contributo economico.33 La donna dunque, acquisite «una nuova liberazione, una coscienza morale e una disponibilità materiale che, di colpo, la svellevano dalle sue due grandi soggezioni: l’ignoranza e il matrimonio»,34 rompeva antichi steccati, andava a invadere un territorio tradizionalmente affidato al dominio del genere maschile, la guerra. In effetti, il coinvolgimento e l’impegno di migliaia di donne in nuove mansioni e in varie attività culturali, propagandistiche e solidaristiche furono in grado di produrre maggiore visibilità accanto ad inedite forme di autonomia e di mobilità. La partecipazione alla guerra, sia attraverso il lavoro volontario sia in quello remunerato, si rivelò un mezzo per praticare esperienze differenti la cui valenza e i cui esiti variarono in modo significativo. Un agire complesso, ampio e multiforme. 30 GIULIA CAVALLARI CANTALAMESSA, L’opera di una donna nel periodo della guerra, Bologna, Stabilimenti poligrafici riuniti, 1919. 31 Cfr. I. VACCARI, La donna nel ventennio fascista cit., p. 45. 32 DONNA PAOLA, [Paola Baronchelli Grosson], La donna nella nuova Italia cit. Nel 1915 aveva intanto pubblicato, per la Bemporad di Firenze, La funzione della donna in tempo di guerra. 33 Ivi, p. 43. 34 Ivi, p. 27. Racconto per immagini Racconto per immagini NICOLA BIONDI, Donne e operai impegnati in lavori stradali, ca. 1895-1910, Archivi Alinari, Firenze GIUSEPPE GRAZIOSI, Contadina con maialini a Savignano sul Panaro, ca. 1900-1910, Museo Civico d’Arte, Modena 107 108 Racconto per immagini GIUSEPPE MICHELINI, Risaiuole al lavoro in una tenuta di Molinella. Aia da riso ripresa dai tetti, 1903, Collezioni d’Arte e di Storia della Fondazione Cassa di Risparmio, Bologna PAOLO BETTINI, Lavandaie alla periferia di Bologna, inizio Novecento, in FRANCO CRISTOFORI, Bologna, gente e vita dal 1914 al 1945, Bologna, Alfa, 1980, Istituto storico Parri Emilia-Romagna, Bologna Racconto per immagini Operaie della fornace Galotti di Bologna, 1910, Collezione Budriesi, Gruppo «Tracce di una storia», Centro sociale ricreativo culturale Santa Viola, Bologna Donne al lavoro nello stabilimento ceramico Saime negli anni Venti, Fotomuseo Giuseppe Panini, Modena 109 110 Racconto per immagini FRATELLI ALINARI, Ritratto di tre eleganti signore, in abiti degli anni Venti, in un salone della Sartoria Policardi a Bologna, Archivi Alinari, Firenze Impiegato di azienda seduto alla scrivania del suo ufficio. La segretaria è di spalle, ca. 1920, Archivi Alinari, Firenze Racconto per immagini Impiegate alle macchine calcolatrici, 1910-1920, Archivi Alinari, Firenze F. DE’ FRANCESCHI, Ritratto di scolaresca con maestra, Bologna, ca. 1900, Fondo Renzo Comani, Archivio fotografico Cineteca del Comune, Bologna 111 112 Racconto per immagini ACHILLE BELTRAME, Il primo congresso delle donne italiane a Roma. La seduta inaugurale nella sala degli Orazi e dei Curiazi in Campidoglio, «La Domenica del Corriere», 3-10 maggio 1908, Istituto storico Parri Emilia-Romagna, Bologna Racconto per immagini 113 ACHILLE BELTRAME, Sciopero agrario nel Parmigiano: come le scioperanti tentano di impedire la partenza del bestiame abbandonato nelle stalle, «La Domenica del Corriere», 10-17 maggio 1908, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, Bologna 114 Racconto per immagini Le massaie della guerra, «L’Illustrazione italiana», 20 maggio 1917, Istituto storico Parri Emilia-Romagna, Bologna Donne alla lavorazione delle bombe, in COMITATO NAZIONALE PER IL MUNIZIONAMENTO, Il lavoro femminile nell’industria di guerra italiana, Roma, Calzone, 1917, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, Bologna Racconto per immagini 115 Bologna. Giornata della madre e del fanciullo, 1933, Archivio storico del Comune, Bologna Modena. Cerimonia di premiazione corso per donne della sezione operaie e lavoranti a domicilio, 1941, Fondo Bandieri, Fotomuseo Giuseppe Panini, Modena 116 Racconto per immagini Agenda della massaia rurale, 1936, Istituto storico Parri Emilia-Romagna, Bologna Operaie al lavoro nella fabbrica della ditta Giordani, produttrice di carrozzine e biciclette, 1930, Studio Villani, Archivio Alinari, Firenze Racconto per immagini 117 Località Fossalta. Casa della madre e del bambino. Asilo infantile, gestito dalle suore salesiane. Gruppo di bimbi delle mondine con una puericultrice a tavola durante la colazione, 1941, ca., Fondo Bandieri, Fotomuseo Giuseppe Panini, Modena Donne tramviere, 21 agosto 1940, Biblioteca Civica d’Arte L. Poletti, Modena 118 Racconto per immagini La signora Venusta Landini ripresa nell’aia della sua casa rurale in mezzo a galli e galline, 1942, Istituzione Villa Smeraldi, Museo della civiltà contadina, S. Marino di Bentivoglio, Bologna Pianura bolognese, Affondamento dei fasci di canapa, 1943, Istituzione Villa Smeraldi, Museo della civiltà contadina, S. Marino di Bentivoglio, Bologna Racconto per immagini Bologna. Ludi del lavoro, 1942, Fondo Nino Comaschi, Archivio fotografico Cineteca del Comune, Bologna Trecciaiole a Monghidoro, Bologna, 1952, Fondo Aldo Ferrari, Archivio fotografico Cineteca del Comune, Bologna 119 120 Racconto per immagini Infermiera ferrista, 1952, Fondo Aldo Ferrari, Archivio fotografico Cineteca del Comune, Bologna Lavori sul fondo «Barabana», Sala Bolognese, Bologna, 1957, Centro italiano di documentazione sulla cooperazione e l’economia sociale, Bologna Racconto per immagini Manifestazione 1956, Associazione Paolo Pedrelli, Archivio storico sindacale, Bologna Faenza. Produzione calze nello Stabilimento OMSA, 1945 ca., Studio Villani, Archivi Alinari, Firenze 121 122 Racconto per immagini «Panorama di vita femminile», numero speciale, 1951, Archivio fotografico Centro Italiano Femminile, Roma Dal regime fascista agli anni Sessanta Cinzia Venturoli Il fascismo e la seconda guerra mondiale La donna nella propaganda fascista Il regime fascista proponeva alla donna, attraverso la propaganda, il ruolo di moglie e madre, in una posizione subordinata all’uomo. Questo modello era da un lato simile a quello tradizionale, presente nella cultura cattolica, ma diveniva peculiare nel fascismo dove il corpo delle donne era nazionalizzato e la maternità si trasformava in un dovere nei confronti della patria; tanto che il codice penale elaborato da Alfredo Rocco, nel 1930, vedeva inserito l’aborto nel titolo X, delitti «contro l’integrità e la sanità della stirpe».1 Con il varo della politica demografica questa concezione venne chiaramente esplicitata: era necessario per il fascismo fare crescere numericamente la popolazione italiana e, al tempo stesso, curare la ‘razza’ al fine di permettere all’Italia di divenire una potenza nel panorama mondiale. Questo era un compito da affidare alle donne e il 26 maggio 1927, in quello che è ricordato come il discorso dell’Ascensione, Benito Mussolini sottolineò proprio queste esigenze. Bisogna quindi vigilare il destino della razza, bisogna curare la razza, a cominciare dalla maternità e dall’infanzia; [bisogna] dare una frustata demografica alla Nazione. Questo vi può sorprendere; qualcuno di voi può dire: «Ma come, ce n’era bisogno?» Ce n’è bisogno. Qualche inintelligente dice: «Siamo in troppi». Gli intelligenti rispondono: «Siamo in pochi». Affermo che, dato non fondamentale ma pregiudiziale della potenza politica, e quindi economica e morale delle Nazioni, è la loro potenza demografica. […]. Signori, l’Italia, per contare qualche cosa, deve affacciarsi sulla soglia della seconda metà di questo secolo con una popolazione non inferiore ai 60 milioni di abitanti. La politica pro-natalista era vista anche come un mezzo normalizzatore, in grado di favorire la ricostruzione «dell’ordine morale», ovvero del tradizionale sistema dei rapporti fra i sessi messo in discussione, secondo l’interpretazione fascista, dalla prima guerra mondiale e dagli eventi del primo dopoguerra. Madri e padri, dunque: gli uomini celibi dal 1926 dovevano pagare una tassa e gli omosessuali erano fuori legge dal 1931, tutto affinchè si costituissero sempre più famiglie fasciste, ovvero nuclei composti da numerosi figli, da una madre completamente dipendente dal marito anche in base alle convinzioni dell’inferiorità femminile. Numerosi erano i saggi, gli scritti, le prese di posizione pubbliche di studiosi, docenti universitari, gerarchi e dello stesso Mussolini, che affermavano la «naturale» inferiorità della donna rispetto all’uomo. 1 Codice Rocco, Titolo X, articoli 545-547. 126 Dal regime fascista agli anni Sessanta L’uomo è incalcolabilmente superiore alla donna. La filosofia non le deve alcun sistema, la scienza nessuna scoperta, l’arte nessun monumento. La donna imparò e ripeté talvolta ciò che gli uomini avevano fatto, non li precorse mai e non li riassunse. Il genio, che è la sintesi di un popolo o di un’epoca, ebbe sempre nome da uomo.2 La famiglia, numerosa e fascista, era quindi al centro della propaganda e della costruzione del modello fascista, tanto che nel 1937 vennero istituiti l’Ufficio centrale demografico e l’Unione fascista tra le famiglie numerose, su decisione del Gran consiglio del fascismo, e in funzione pro-natalista furono presi numerosi provvedimenti di legge: nel 1937 il matrimonio ed il numero di figli divennero un criterio per gli avanzamenti di carriera, quindi i padri di numerosi figli avevano vantaggi, si vedevano assegnare premi e sussidi, per i figli e per il matrimonio. Nella costruzione dello stato assistenziale fascista spazio ebbe, evidentemente, la costituzione di organismi che si occupavano della maternità e dell’infanzia: a questo tendeva l’Opera nazionale maternità e infanzia (Onmi), istituto articolato in federazioni provinciali, che aveva lo scopo di assistere le donne bisognose ed i bambini fino Benito Mussolini, Discorso dell’ascensione, all’età scolare. Si affiancarono ai provvedimenti Roma, 1927, Fondazione Istituto Gramsci legislativi e agli organismi assistenziali Emilia-Romagna, Bologna la creazione di feste e di giornate in cui sottolineare l’importanza della famiglia e della maternità. Fra queste nel 1933 fu istituita la Giornata della Madre e dell’Infanzia. Ogni 24 dicembre, si sarebbero dovute festeggiare tutte le madri «prolifiche». Scriveva il podestà di Ravenna: il Duce la cui azione indefessa ha la precisione matematica di un assioma e lo slancio lirico della poesia, ha voluto che la celebrazione si concretasse in provvedimenti utili e avesse luogo nella giornata spiritualmente più propizia: la vigilia di Natale. Nel giorno in cui tutti gli spiriti sono protesi verso il santo mistero della maternità e il popolo italiano adora in essa la figura simbolica di tutte le madri.3 2 ALFREDO ORIANI, Il matrimonio, con prefazione di Benito Mussolini, Bologna, Cappelli, 1923, citato in PIERO MELDINI, Sposa e madre esemplare ideologia e politica della donna e della famiglia durante il fascismo, Rimini-Firenze, Guaraldi, 1975, pp. 31-32. 3 La Giornata della Madre e del Fanciullo, «Il Comune di Ravenna», 1934, p. 114, citato in GIOVANNA MARCHIANÒ, Fascismo e organizzazione del consenso: la politica demografica, in Storia dell’Emilia-Romagna, a cura di Aldo Berselli Bologna, University Press, 1980, p. 753. Il fascismo e la seconda guerra mondiale 127 Fu poi celebrata la «Saga della nuzialità» e nel 1937 a Bologna 1020 coppie decisero di sposarsi alla presenza del segretario del partito nazionale fascista Achille Starace proprio durante la saga della nuzialità che si svolse il 21 aprile. La cerimonia, che seguiva il rito matrimoniale celebrato per ogni singola coppia, prevedeva una funzione religiosa e la consegna di un premio di nuzialità. In quella occasione vennero ricordati i significati che il regime dava all’incremento demografico e si mise in luce come, in realtà, la natalità non fosse aumentata come il fascismo auspicava: L’iniziativa bolognese è stata segnalata a tutti gli italiani, affinchè essi, dopo le larghe provvidenze del Regime, comincino a dare più tangibili prove della loro adesione alla lotta demografica impegnata dal Fascismo per la vita, l’avvenire e la potenza dell’Italia imperiale. Infatti non solo la potenza militare dello Stato ma anche «l’avvenire e la sicurezza della Nazione» come si è espresso il Duce sono legati ai problemi assillante in tutti i paesi di razza bianca e anche nel nostro». Nella piena consapevolezza che la condizione insostituibile del primato sta nel numero, il Fascismo non desisterà un attimo dalla sua guerra ai disertori di una così vitale battaglia: i celibi e i coniugati egoisti senza prole.4 Nonostante la martellante propaganda e i numerosi provvedimenti la campagna demografica non ebbe successo tanto che la nuzialità e la natalità, nel paese e nella nostra Regione, andò diminuendo. Infatti, l’incremento annuo del tasso di nuzialità bolognese che era costantemente salito dal 1881, per divenire del 9,3 per mille annuo nel 1921, diminuì al 6,7 nel 1931 per risalire lievemente al 7,7 nel 1936. Per quanto riguarda la Regione, si passò dal 9,6 all’8 per arrivare al 4,4 nel 1936. I quozienti di natalità erano in molte città della regione, molto più bassi di quelli sperati dal regime ed inferiori a quelli nazionali: in provincia di Bologna e Ravenna, ad esempio, il quoziente di natalità per mille abitanti nel 1933 era di 17,5 e 16,7; in quella di Ferrara 24,1, attorno al 22 nelle province di Modena e Forlì. Parma aveva un quoziente di 18,3. Infine le province di Piacenza e Reggio Emilia 19,3 3 e 20,9. A livello nazionale il quoziente era di 23,5.5 Alle donne che lavoravano si addebitava il mancato successo della politica demografica e la «crisi economico-morale della famiglia»:6 il lavoro femminile crea due danni: la mascolinizzazione della donna e l’aumento della disoccupazione maschile. La donna che lavora si avvia alla sterilità; perde la fiducia nell’uomo; considera la maternità come un intoppo, un ostacolo, una catena; se sposa, difficilmente riesce ad andare d’accordo con il marito; concorre alla corruzione dei costumi; in sintesi inquina la vita della stirpe.7 Anche la Chiesa cattolica riteneva che le donne dovessero restare a casa e che bisognasse creare le condizioni sociali ed assistenziali affinché questo fosse possibile. Le madri di famiglia prestino l’opera loro in casa sopra tutto o nelle vicinanze della casa, attendendo alle faccende domestiche. Che poi le madri di famiglia, per la scarsezza del sala4 «Il Comune di Bologna», aprile 1937, pp. 53-54. «Corriere padano», citato in G. MARCHIANÒ, Fascismo e organizzazione del consenso cit., p. 766. 6 La politica demografica di Benito Mussolini a cura e con prefazione di Paolo Orano, Roma, Pinciana, 1937, p. 4. 7 GUGLIELMO DANZI, Europa senza europei, presentazione di Mussolini, Roma, Edizioni Roma, 1935, p. 27. 5 128 Dal regime fascista agli anni Sessanta rio del padre, siano costrette ad esercitare un’arte lucrativa fuori delle pareti domestiche, trascurando così le incombenze e i doveri loro propri, e particolarmente la cura e l’educazione dei loro bambini, è un pessimo disordine, che si deve con ogni sforzo eliminare. Bisogna dunque fare di tutto perché i padri di famiglia percepiscano una mercede tale che basti per provvedere convenientemente alle comuni necessità domestiche.8 Le donne erano comunque presenti nel mondo del lavoro e molti vedevano in questa presenza una minaccia alla moralità, tanto che, ad esempio, Nicola Pende, uno dei più noti ed ascoltati scienziati dell’epoca,9 scriveva: È noto che le delinquenza femminile è più alta nei paesi in cui maggiore è la presenza di operaie, mentre è meno forte dove le donne attende al lavoro della terra ed è minore dove la donna si occupa esclusivamente di lavori domestici.10 Ferdinando Loffredo, intellettuale del tempo, rincarava la dose asserendo: [...] la donna che, senza la più assoluta e comprovata necessità, lasci le pareti domestiche per recarsi al lavoro, la donna che, in promiscuità con l’uomo, gira per le strade, sui trams, sugli autobus, vive nelle officine e negli uffici, deve diventare oggetto di riprovazione, prima e più che di sanzione legale. La legge può operare solo se l’opinione pubblica ne forma il substrato: questa, a sua volta, può essere determinata da tutto un insieme di altre misure che indirettamente e insensibilmente operino sulla opinione pubblica.11 Secondo Loffredo bisognava arrivare a far uscire tutte le donne dal mondo del lavoro per tornare ad una situazione in cui le donne fossero assoggettate completamente agli uomini.12 Chiara e netta, quindi, l’immagine della donna nella propaganda fascista: madre di numerosi figli e, se possibile, lontana dal mondo del lavoro. In questo ambito ideologico, il regime varò numerose leggi in merito al lavoro delle donne, distinte in leggi protettive e leggi espulsive, provvedimenti questi ultimi che avevano la finalità di limitare e marginalizzare la presenza delle donne dapprima nel pubblico impiego, quindi nel lavoro privato. I principali interventi che furono rivolti al pubblico impiego riguardarono innanzitutto la scuola, settore ad alta occupazione femminile. Nel 1923, e poi nel 1940, alle donne fu precluso l’incarico di preside nelle scuole o istituti di istruzione media, nel 1926 le donne vennero escluse dall’insegnamento della storia, della filosofia e dell’economia nei licei e dall’insegnamento di lettere e di storia negli istituti tecnici. Dalla scuola l’attenzione del legislatore fascista si spostò verso altri settori della pubblica amministrazione. Nel 1934 venne approvata una legge che autorizzava le amministrazioni dello Stato a stabilire, nei bandi di concorso, l’esclusione delle donne o a porre dei limiti nelle assunzioni femminili, legge che venne estesa al settore privato nel 1938 prevedendo un limite del 10% dei posti per le donne. L’anno successivo, il Regio Decreto n. 989/1939 stabiliva una tipologia di mansioni per il personale femminile nell’impiego pubblico e privato. Fra questi 8 Lettera Enciclica Quadragesimo Anno, del Sommo Pontefice Pio XI. Fu anche docente di Patologia medica dimostrativa nella Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università bolognese. 10 NICOLA PENDE, Bonifica umana e razionale, Bologna, Cappelli, 1933, p. 135. 11 FERDINANDO LOFFREDO, Politica della famiglia, Milano, Bompiani, 1938, p. 365. 12 F. LOFFREDO, Politica della famiglia cit., pp. 369-370. 9 Il fascismo e la seconda guerra mondiale 129 servizi di dattilografia, telefonia, stenografia, servizi di raccolta e prima elaborazione di dati statistici; servizi di formazione e tenuta di schedari; servizi di lavorazione, stamperia, verifica, classificazione, contazione e controllo dei biglietti di Stato e di banca, servizi di biblioteca e di segreteria dei Regi istituti medi di istruzione classica e magistrale; servizi delle addette a speciali lavorazioni presso la Regia zecca. L’articolo 4 della stessa legge, suggeriva altri impieghi ritenuti «particolarmente adatti» alle donne, quali annunciatrici addette alle stazioni radiofoniche; di cassiere (limitatamente alle aziende con meno di 10 impiegati); di addette alla vendita di articoli di abbigliamento femminile, articoli di abbigliamento infantile, articoli casalinghi, articoli di regalo, giocattoli, articoli di profumeria, generi dolciari, fiori, articoli sanitari e femminili, macchine da cucire; addette agli spacci rurali cooperativi dei prodotti dell’alimentazione, limitatamente alle aziende con meno di 10 impiegati; di sorveglianti negli allevamenti bacologici ed avicoli; di direttrici dei laboratori di moda. Molti furono, poi, i provvedimenti protettivi elaborati sempre alla luce della politica demografica del regime che trovava necessario «preoccuparsi di tutti i problemi inerenti il lavoro delle madri operaie», le lavoratrici dovevano essere tutelate e «la tutela deve assumere un carattere assistenziale, igienico-sanitario, in vista della loro funzione di madre».13 Durante il regime fascista furono due i provvedimenti sul lavoro delle donne e dei fanciulli che venero emanati nel 1923, con un regio decreto convertito in legge nel 1925, e nel 1934, con la legge entrata in vigore nel 1936. Le leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli, considerate una normativa di ordine pubblico, si inserivano in una politica legislativa già tracciata da leggi precedenti, riproponendola in chiave demografico razziale. Affermò Mussolini alla Camera: la nuova legge ha una portata totalitaria. La necessaria tutela delle deboli forze del minore non rispetto a particolari attività produttive ma estesa il più 13 Esclusione delle donne da alcune cattedre, «Il Corriere della sera», 29 dicembre 1926, Istituto storico Parri Emilia-Romagna, Bologna BRUNO BIAGI, Scritti di politica corporativa, Bologna, Zanichelli, 1934, p. 201. 130 Dal regime fascista agli anni Sessanta possibile è una forma – fra le più importanti – di tutela demografica diretta alla potenza non soltanto numerica ma qualitativa della nazione e per tale suo carattere rientra nei fini essenziali dello stato fascista.14 Rispetto alla disciplina del lavoro, infatti, era separato il trattamento delle lavoratrici madri; nella legge era prevista, fra le altre cose, l’astensione obbligatoria dal lavoro un mese prima e sei settimane dopo il parto, due periodi di riposo al giorno per allattare e l’istituzione delle camere di allattamento. Lo Stato doveva quindi tutelare le donne come madri o future madri. Il campo di applicazione della legge del 1934 non era esteso a settori in cui in realtà molto alta era la presenza di donne: il lavoro agricolo, il lavoro a domicilio, il lavoro domestico. Nessuna norma garantiva, poi, le lavoratrici contro i licenziamenti né impediva ai datori di lavoro di licenziarle non appena avessero contratto matrimonio, così come nessuna norma garantiva qualifiche e salari uguali a quelli dei lavoratori.15 Le donne organizzate: fasci femminili e sezioni operaie e lavoranti a domicilio Durante il ventennio fascista, l’allineamento e il coinvolgimento delle donne fu cercato attraverso l’istituzione dei fasci femminili ai quali si aggiunsero l’organizzazione delle massaie rurali e quella delle operaie in fabbrica e a domicilio.16 Il primo fascio femminile d’Italia venne fondato a Monza da Elisa Savoia nel marzo 1920:17 sempre in quell’anno era stato istituito il fascio bolognese18 ed anche il fascio femminile di Bondeno, in provincia di Ferrara, che, nel luglio, aveva circa un centinaio di iscritte. I gruppi femminili, secondo lo schema proposto dal Popolo d’Italia e ripreso da Chiurco, nei suoi volumi in cui racconta la «Rivoluzione fascista», avevano lo scopo di coordinare il lavoro di propaganda, beneficenza, assistenza, sotto il controllo dei fasci, non possono prendere iniziative di carattere politico, sebbene partecipino alle adunate e adunanze dei Fasci, in seno ai Gruppi femminili possono sorgere scuole serali, circoli istruttivi, cicli di conferenze, squadre ginniche, compagnie filodrammatiche.19 In molte realtà le donne che fondarono, nei primi anni Venti, i fasci femminili erano insegnanti, o più specificamente maestre. Lo era la già citata Elisa Savoia e lo era Pia Bortolini20, segretaria del fascio femminile di Bologna, due insegnanti erano presenti 14 PARTITO NAZIONALE FASCISTA, La politica sociale del fascismo, La libreria dello Stato, anno XIV, 1936, pp. 36-37. 15 MARIA VITTORIA BALLESTRERO, La protezione concessa e l’eguaglianza negata: il lavoro femminile nella legislazione italiana, in Il lavoro delle donne, a cura di Angela Groppi, Bari, Laterza, 1996, pp. 445-44. 16 GISELA BOCK, Le donne nella storia europea. Dal Medioevo ai nostri giorni, Roma-Bari, Laterza, 2003, p. 333. 17 I fasci femminili sciolti nel 1920 vennero poi ricostituiti nel 1921, cfr. ALBERTO DE BERNARDISCIPIONE GUARRACINO, Dizionario del fascismo, Milano, Bruno Mondadori, 1998, p. 260. 18 «Il Comune di Bologna», gennaio 1927, p. 40. 19 GIORGIO ALBERTO CHIURCO, Rivoluzione fascista, vol. IV, anno 1922, Firenze, Vallecchi, 1929, p. 25. 20 MIRELLA D’ASCENZO, Momenti e figure femminili dell’associazionismo magistrale femminile tra Otto e Novecento, in L’altra metà della scuola. Educazione e lavoro delle donne tra Otto e Novecento, a cura di Carla Ghizzoni, Simonetta Polenghi, Torino, SEI, 2008, pp. 243-245. Il fascismo e la seconda guerra mondiale 131 nel direttorio del primo fascio ravennate. Quando nel 1928 nacque il fascio di Faenza, fra le 61 aderenti 35 erano insegnanti.21 Le funzioni dei fasci femminili doveva essere «quasi essenzialmente assistenziale e più determinatamente apolitica».22 O per meglio dire di propaganda e di educazione al fascismo, in un ruolo ausiliare rispetto a quello maschile. Elisa Majer Rizzioli interventista e infermiera volontaria durante il primo conflitto mondiale che aveva aderito al movimento fascista nel 1920 e nel 1922 partecipò alla marcia su Roma,23 descriveva così i fasci femminili: i Fasci Femminili per avere ragione di essere, non scimmiottando i fasci maschili, manipolando dell’indigesta politica, lasciarono cortei e camicia nera, si innalzarono alla valorizzazione della maternità come sentimento di Patria e alla valorizzazione di tutti gli elementi sociali che falla maternità si diffondono come luce solare24. Presenza «discreta» nei fasci femminili, non dimenticando mai che la «vera vocazione delle donna» doveva essere la famiglia, una famiglia che diventava fascista grazie all’impegno femminile. In pubblico la donna fascista «non si sgolerà in grida, non si sbraccerà in saluti romani. Ma costituirà soprattutto una restaurazione della donna nei suoi compiti tradizionali: con quel tanto in più che basti a farla donna del suo tempo».25 Alla fine degli anni Venti si ritenne che i fasci femminili dovessero diventare una delle strutture del partito nazionale fascista e in questo contesto vi furono alcuni cambiamenti all’interno della stessa organizzazione: nel 1926 Roberto Farinacci, durante la sua breve esperienza come segretario del partito nazionale fascista, costrinse alle dimissioni Elisa Majer Rizzioli, che fu sostituita da Angiola Moretti. Il 20 dicembre 1929, una direttiva, impose la supervisione centrale di tutte le nomine e organizzazioni giovanili: per disposizione di Mussolini, passarono al Ministero dell’Educazione Nazionale rendendo così pressoché nulla la già scarsissima influenza politica dei fasci femminili, che dovevano subire anche la «concorrenza» delle organizzazioni cattoliche26, così come lamentavano le dirigenti.27 Sopravvivevano in Italia, in quegli anni, ben poche organizzazioni al di là di quelle fasciste. Vi erano le organizzazioni delle donne professioniste, la Fildis; rari sodalizi di ispirazione liberale, e il Consiglio nazionale delle donne italiane, che ancora nel 1927 aveva sezioni in numerose località italiane e sedi principali a Roma, in Toscana, a Parma e a Bologna, oltre che a Ravenna. Federate al Consiglio erano le Industrie femminili italiane, l’Unione cristiana delle giovani, le assistenti sanitarie, la 21 CLAUDIA BASSI ANGELINI, Le signore del fascio l’associazionismo femminile fascista nel Ravennate 1919-1945, Ravenna, Longo, 2008, pp. 34-42. 22 ESTER LOMBARDO, «Almanacco della donna Italiana», 1927, p. 276. 23 HELGA DITTRICH-JOHANSEN, Le «Militi dell’idea». Storia delle organizzazioni femminili del Partito Nazionale Fascista, Firenze, Olschki, 2002, p. 243. 24 ELISA MAJER RIZZIOLI, «Almanacco della donna Italiana», 1927, p. 277. 25 La donna madre nel fascismo, «Critica Fascista», 1931, p. 11. 26 Le organizzazioni cattoliche erano certamente quelle che raccoglievano un numero elevato di donne, sicuramente molto maggiore di quelle fasciste, almeno negli anni Venti: basti pensare che, a livello nazionale, nel 1925 i fasci femminili avevano 40.000 iscritte, mentre l’Unione femminile cattolica ne contava 160.000. 27 Il provvedimento del 1929 venne contestato da alcune dirigenti, quali Maria Pezzè Pascolato, Wanda Gorjux Bruschi e la bolognese Pia Bortolini. 132 Federazione laureate e diplomate, l’Associazione dottoresse in medicina e chirurgia, l’Unione italiana assistenza all’infanzia, l’Opera nazionale assistenza materne.28 Infine nel 1931 il segretario del partito nazionale fascista, Giovanni Giurati, ordinò la totale subordinazione a tutte le direttive del partito da parte dei gruppi femminili.29 All’inizio degli anni Trenta si chiedeva sempre più alle donne di iscriversi alle organizzazioni fasciste e di partecipare alle loro attività che consistevano, soprattutto, in «un programma altissimo di educazione morale, sociale e patriottica, atto a formare e a creare la futura madre delle nuove generazioni, perfetta come donna di casa non solo nelle sue virtù materiali e casalinghe, ma anche nello spirito profondamente fascista».30 I compiti dei fasci femminili erano così riassunti nel Primo libro del fascista: Dal regime fascista agli anni Sessanta I fasci femminili, Milano, s.d., Biblioteca comunale dell’Archiginnasio, Bologna I Fasci femminili hanno il compito di divulgare e tenere desta l’idea fascista anche fuori dell’ambito della famiglia, di migliorare la preparazione spirituale e culturale della donna italiana, di concorrere ad attuare tutte le attività assistenziali del Regime, di svolgere negli ambienti femminili azione di propaganda per la difesa ed il potenziamento della razza, di collaborare con le organizzazioni sindacali ed economiche per l’autarchia della Nazione.31 L’assistenza era quindi uno degli ambiti essenziali in cui si potevano, o meglio dovevano, muovere le donne dei fasci, tanto che i fasci femminili furono definiti «organi esecutivi dell’assistenza».32 Le attività assistenziali dei fasci femminili si intrecciavano e si sovrapponevano a quelle di istituzioni come l’Onmi e dell’Eca, enti in cui erano presenti le rappresentanti dei fasci femminili e portavano con sé numerose funzioni e significati. Innanzitutto cercavano di coinvolgere e dimostrare alle persone come il regime fascista fosse attento alle esigenze delle classi sociali più disagiate, di come il regime si adoperasse per la «difesa della razza» e per l’incremento demografico. Vi era però anche una funzione di controllo sociale e politico: il controllo della «moralità», dell’adesione alle idee fasciste, del rispetto dei precetti 28 «L’Almanacco della donna italiana», 1927, pp. 282-283. VICTORIA DE GRAZIA, Le donne nel regime fascista, Venezia, Marsilio, 2007, p. 327. 30 AUGUSTO TURATI, I Fasci Femminili - Statuto delle Giovani e Piccole Italiane, Milano, Libreria d’Italia, 1929, p. 19 ed anche WANDA GORJUX, L’educazione femminile, «Il giornale della donna», 1° aprile 1933, p. 3. 31 PARTITO NAZIONALE FASCISTA, Il Primo Libro del Fascista, Roma, Mondadori, 1942. 32 «Il Comune di Bologna», ottobre 1932, p. 20. 29 Il fascismo e la seconda guerra mondiale 133 religiosi e la verifica della presenza dei requisiti ritenuti necessari per l’assistenza erano compiti della visitatrice fascista.33 Fino alla prima metà degli anni Trenta l’attività e le funzioni della visitatrice erano estremamente simili a quelle della dama di carità, e quindi una missione adatta alle donne della borghesia, così come possiamo leggere nella descrizione che ne fa Maria Pezzè Pascolato: Si può girare l’Italia da un capo all’altro: non c’è pericolo di trovare una sede troppo di lusso per la delegazione o la segreteria dei fasci femminili. Semplicità, spesso povertà francescana. Donne fasciste che hanno una bella casa, comoda e ben riscaldata, passano ore ed ore ogni giorno in una squallida stanzetta, senza il cappotto – (la pelliccia non la portano in ufficio perché «se ne vergognano» davanti a certi poveri cenci …). Ascoltano storie di tribolazioni sino a tarda ora: Ascoltare con pazienza» è il comandamento del Duce. Tornano a casa stanche morte.34 Alla fine degli anni Trenta, la visitatrice diventò sempre più simile ad una sorta di assistente sociale di partito, vennero istituiti corsi per la sua formazione, fu previsto che indossasse una divisa turchina e divenne una stipendiata. Nella regione Emilia-Romagna, come in tutto il territorio nazionale, i fasci femminili si dedicarono alla creazione di strutture e di attività rivolte all’assistenza, numerosissimi gli esempi: a Ferrara, ad esempio nel 1927, il fascio femminile aveva aperto un ambulatorio per i bambini figli degli iscritti al partito e al sindacato fascista. Questa attività suscitò il plauso del «Corriere padano» che si compiacque di come le donne, lasciata «ogni velleità di suffragismo e di femminismo», facevano ora «le infermiere, le istitutrici, le suore di carità, rimanendo cioè squisitamente donne, anche partecipando alla vita politica».35 A Reggio Emilia fu il Laboratorio dove le «giovinette possono acquisire il maggior dono che a una donna possa farsi: l’abilità nei lavori muliebri».36 A Rimini le donne fasciste gestivano il «guardaroba del povero» ed avevano aperto un ambulatorio ostetrico; a Bologna l’attività di particolare rilievo a cui le donne si erano dedicate era quella delle colonie estive.37 Il tesseramento per i fasci femminili non raggiunse le cifre sperate ed ipotizzate dal regime, anche nelle realtà in cui più vi era stata attività in questo senso, a Reggio Emilia, nonostante il «fervido» impegno di Laura Marani Argnani, nel 1930, 25 erano i fasci femminili e 752 le iscritte in tutta la provincia, nel 1938 raddoppiarono, ed erano 3473 nel 1940.38 A Forlì su 420.000 abitanti 731 erano, nel 1930, le aderenti. A Ravenna l’aumento delle iscrizioni si ebbe dalla metà degli anni Trenta: 3000 nel 1936, 4659 nel 1937 e, in costante crescita fino al 1939, quando le donne iscritte erano 7763. Dati che non si discostano da quelli nazionali. Fra le organizza33 PAOLA BENEDETTINI ALFERAZZI, Organizzazioni femminili fasciste dell’anno X, «Almanacco della donna italiana», 1933, p. 352. 34 MARIA PEZZÈ PASCOLATO, Fasci femminili, «Gerarchia», n. 2, 1932, p. 117. 35 «Corriere padano», 10 novembre 1927 citato in G. MARCHIANÒ, Fascismo e organizzazione del consenso cit., pp. 756-757. 36 ADOLFO ZAVARONI, La Donna del Fascio II. Le iniziative sociali del fascismo femminile reggiano, «L’almanacco», dicembre 2000, p. 37. 37 «Il Comune di Bologna», agosto 1927, p. 730 ed anche «L’Assalto», 16 agosto 1930, p. 4. 38 LAURA MARANI ARGANI, I Fasci femminili nella provincia di Reggio nell’Emilia dal 1921 al 1940, Reggio Emilia, 1940, p. 5. 134 Dal regime fascista agli anni Sessanta zioni femminili i fasci furono quelle che difficilmente riuscirono a radicarsi fra la popolazione, passando dalle 40.000 unità nel 1925, alle 743.786 del 1937 e 1.217.036 nel 1943. Nel 1935 fu istituito, in via sperimentale, un «Ufficio di assistenza e di avviamento per le giovani» per le ragazze che arrivavano in città in cerca di lavoro».39 Il fascismo creò poi una ulteriore organizzazione legata al mondo femminile: la Sold, Sezioni operaie e lavoranti a domicilio, sorta in seno ai fasci femminili. Questa organizzazione aveva una rivista, «Lavoro e famiglia», diretta dal 1938 al 1943 da Tullio Cianetti attraverso la quale venivano fornite informazioni sulle «attività femminili che maggiormente interessano le famiglie operaie e le lavoratrici a domicilio».40 Fra le collaboratrici della rivista troviamo, ad esempio, Rachele Ferrari del Latte, insegnante, interventista ed attiva nel fascismo milanese fino dai primi anni Venti, Maria Diez Gasca, che diresse anche il mensile «Casa e Lavoro» dedicato alla razionalizzazione del lavoro domestico. La Sold era aperta non solo alle lavoratrici – diversamente a quello che succedeva per le organizzazioni maschili – ma anche alle mogli degli operai e ad altri membri femminili delle famiglie operaie.41 Fra i compiti di questa organizzazione vi erano la propaganda «fascista ed educativa, l’assistenza morale per le lavoratrici» ed anche azioni più legate al lavoro quali il collocamento.42 Fra le funzioni della Sold non vi erano, invece, azioni tipicamente sindacali quali il rafforzamento del potere contrattuale delle lavoratrici, ma l’organizzazione si limitava a svolgere e a promuovere attività assistenziali, educative e propagandistiche. Ancora una volta, l’accento era posto sull’essere madre e moglie, sulla famiglia, mettendo così in secondo piano e cancellando l’identità di lavoratrice.43 Era previsto per le iscritte un fazzoletto triangolare nero e argento da indossare sugli abiti, per le segretarie un distintivo, la «M. oro con due stellette oro su fondo nero». Mentre labaro e fiamma come simboli rispettivamente per le segretarie provinciali e comunali. L’iscrizione a questa organizzazione non era particolarmente costosa, essendo la quota di due lire e mezza contro le dieci lire dell’iscrizione al partito nazionale fascista. La Sold passò dalle 309.945 iscritte del 1938 a 501.415 nel 1939, per ricevere poi un forte impulso dall’entrata in massa delle donne nell’economia di guerra, che fece passare le iscritte da 616.264 nel 1940 a 864.922 del 1942.44 Nel 1938 alla Sold erano iscritte, in Emilia-Romagna 12.883 donne che rappresentavano lo 0,78% della popolazione femminile, mentre in Italia erano 309.694, ovvero l’1,43%. A Reggio Emilia nel 1938 le iscritte alla Sold erano 1050, crebbero poi nell’anno successivo (3000) e divennero 3473 nel 1940.45 Questi dati non soddisfacevano Laura Marani che affermava come difficile fosse la «la penetrazione negli animi» di queste lavoratrici.46 39 «L’almanacco della donna», 1935, pp. 138-139. V. DE GRAZIA, Le donne cit., p. 244. 41 Primo libro del fascista, cit. 42 Ibidem. 43 V. DE GRAZIA, Le donne cit., p.245. 44 Compendio statistico, 1938-1942, p. 14-16. 45 L. MARANI ARGNANI, I Fasci femminili nella provincia cit., p. 5. 46 Ivi, p. 9. 40 Il fascismo e la seconda guerra mondiale 135 Le donne organizzate: massaie rurali e donne in Africa Le massaie rurali Negli anni Trenta il regime si avviava sempre più ad assumere il carattere totalitario, quello di una dittatura fondata e retta dal Duce, con un partito unico e con una rete di organizzazioni per la mobilitazione ed il controllo delle masse.47 Con l’intento di coinvolgere il maggior numero possibile di donne che vivevano e lavoravano in campagna, nel 1933 fu fondata la Federazione nazionale fascista delle massaie rurali, a capo della quale fu nominata Regina Terruzzi, che denunciò la difficoltà di coinvolgere le donne. Riunire in un organismo le donne è più difficile che non riunire gli uomini. Questi sono abituati alla comunità della osteria, della piazza, della caserma. Il lavoro obbliga la donna alla vita collettiva della fabbrica, dei campi; ma questa è temporanea, e quella è nella gioventù. Appena si maritano restano in casa. Appena la raccolta, la vendemmia, la mietitura sono finite, tornano alla vita solitaria della famiglia.48 Il 28 agosto 1934 nacque la sezione massaie rurali sotto il controllo del partito nazionale fascista nell’ambito dei fasci femminili.49 Le sezioni si propongono di promuovere la propaganda educativa presso le massaie dalla campagna nei centri rurali curandone in modo particolare l’assistenza morale, sociale e tecnica; di promuovere l’istruzione professionale delle massaie rurali perché possano compiere con competenza e con modernità di vedute le molteplici mansioni loro affidate, con particolare riferimento alla coltivazione dell’orto, dell’allevamento degli animali domestici, all’artigianato e alle piccole industrie casalinghe, inducendo a tal uopo corsi di economia domestica e puericultura; di migliorare l’arredamento e l’igiene delle case rurali; di fare apprezzare tutti i vantaggi della vita dei campi, per contrastare le dannose tendenze all’urbanesimo.50 Gli scopi e i progetti che dovevano essere seguiti dall’Organizzazione delle massaie rurali non erano poi così differenti da quelli dei fasci femminili e la Sold, ciò che la caratterizzava erano i soggetti che coinvolgeva, ovvero «le donne che risiedono abitualmente in Comuni a carattere rurale, che appartengono a famiglie di proprietari coltivatori diretti, coloni e mezzadri, operai agricoli, che abbiano l’età richiesta per l’ammissione ai Fasci femminili»; ed anche l’intento di «far apprezzare tutti i vantaggi della vita dei campi, per contrastare, come il Fascismo vuole, le dannose tendenze all’urbanesimo»,51 nell’ambito della campagna ruralista del regime. L’organizzazione per le massaie rurali registrò in Italia 371.658 iscritte del 1934, numero che calò a 241.000 nell’agosto successivo. Lo sforzo propagandistico fu però tale che alla fine del 1938 le Massaie rurali inquadravano più del 5% della popolazione femminile nazionale con punte massime in Emilia (9,86) e in Piemonte (8,47). Nel 1943 l’associazione arrivò a registrare 2.491.792 iscritte. 47 EMILIO GENTILE, Fascismo storia e interpretazione, Roma-Bari, Laterza, 2002, p. 27. Lettera di Regina Terruzzi a Mussolini, Milano, 5 dicembre 1934, citata in H. DITTRICH-JOHANSEN, Le «militi dell’idea» cit., pp. 161-162. 49 «L’Almanacco della donna italiana», 1935, pp. 139-140. 50 Ibidem. 51 Primo libro del fascista, cit. 48 136 Dal regime fascista agli anni Sessanta In Emilia-Romagna nel 1941 a Bologna vi erano 57.876 iscritte e 69.890 a Reggio Emilia; la federazione di Ravenna era al penultimo posto con le sue 25.800 massaie rurali.52 Le iscrizioni erano incoraggiate anche attraverso agevolazioni economiche, ad esempio prevedendo posti riservati nei mercati e riduzioni per le tasse di posteggio nei mercati stessi.53 Per l’iscrizione alle Massaie rurali non era richiesta, così come avveniva per altre organizzazioni, la «prova di fede fascista» e i controlli non erano così rigidi. Vi sono esempi di donne con trascorsi antifascisti, che potevano anche avere portato a condanne, la cui iscrizione fu accettata.54 L’alta partecipazione all’associazione rurali in Emilia-Romagna è spiegabile attraverso numerosi fattori, per quanto riguarda le mondine e le braccianti, costrette al collocamento tramite il sindacato fascista, l’iscrizione era necessaria per ottenere il lavoro, inoltre, ipotizza Perry R. Willson «il fatto che in queste aree, prima del fascismo, ci fosse già una tradizione di coinvolgimento femminile nei sindacati agricoli può aver spianato la strada agli organizzatori fascisti. In breve, in queste regioni, l’appartenenza delle donne a organizzazioni politiche non era una novità».55 A questo si può aggiungere che il clero, i sacerdoti delle parrocchie di campagna, vedevano in modo positivo la partecipazione a questa organizzazione. L’attività consisteva, quindi, in assistenza e beneficienza, nell’organizzare corsi e concorsi legati ai temi della casa rurale, dell’economia domestica, dell’allevamento degli animali da cortile, nella bachicultura e nella tessitura.56 Lo scopo del programma di formazione era introdurre i cosiddetti metodi di coltivazione «razionali», attraverso l’introduzione di tecniche considerate «moderne e scientifiche» che dovevano sostituire quelle tradizionali, come previsto anche nello statuto della stessa associazione. Non rare erano le mostre agricole, comunali, provinciali e regionali, dove le massaie rurali portavano lavori di tessitura, coperte di lana, di canapa e cotone; cestini e lavori di vimini, sporte di foglie di granoturco, cappelli di paglia, lavori a maglia. Le partecipazioni a questi corsi erano solitamente abbastanza alte, tanto che Claudia Bassi Angelini, ipotizza che il partecipare alle iniziative delle Massaie rurali, che a volte assomigliavano a quelle di un dopolavoro, fosse una gradita e occasione di socialità.57 Consigli e articoli tecnici venivano poi pubblicati sulle riviste ed in particolare sull’«Agenda della massaia rurale» e in volumi. Le massaie rurali, così come le donne aderenti alle altre associazioni, partecipavano alle adunate, alle cerimonie, alle manifestazioni e lo facevano, solitamente, in costume tradizionale, con il grembiule, il fazzoletto al collo e lo scialle sulle spalle, così che anche nell’immagine potessero riassumere e rappresentare il modello della donna fascista: legata alle tradizioni, incurante della moda, prosperosa madre di famiglie numerose. Durante gli incontri a Roma, al cospetto del duce, sovente si poteva riscontrare, nelle partecipati, quella sorta di fascinazione per Mussolini che era caratteristico del sistema totalitario e che massimamente si espresse negli anni Trenta, come si accennava.58 Scriveva una massaia rurale di Bologna nel 1937: 52 A. ZAVARONI, La Donna del Fascio cit., p. 30. H. DITTRICH-JOHANSEN, Le «militi dell’idea» cit., p. 170. 54 C. BASSI ANGELINI, Le «signore del fascio» cit., p. 99-102. 55 PERRY R. WILLSON, Contadine e politica nel ventennio. La sezione Massaie rurali dei Fasci femminili, «Italia contemporanea», 218, 2000, pp. 31-48. 56 «L’Agenda della massaia rurale», anno XV. 57 C. BASSI ANGELINI, Le «signore del fascio» cit., p. 99-102. 58 E. GENTILE. Fascismo cit., pp. 113-170. 53 Il fascismo e la seconda guerra mondiale 137 La regina Elena riceve gli omaggi delle massaie rurali nel salone del palazzo del Podestà durante la celebrazione del II centenario della nascita di Luigi Galvani, Bologna, 19 ottobre 1937, Foto Gambini, Archivio storico dell’Università, Bologna ho 35 anni, mio marito 37, Fascista di vecchia data; ho 4 figli, 3 femmine e un maschio. La mia famiglia è composta di n. 6 persone tutti in buona salute e tutti tesserati con tessere del Pnf. Il più piccolo balilla della Lupa; si vive onestamente col lavoro. Duce, io mi son sentita sempre vicino a voi. Ho sempre avuto per voi un amore sopra naturale; nei momenti difficili passati ho pregato Dio per voi che non vi venisse a mancare quel coraggio come è vostra abitudine per affrontare tutte le ingiustizie fatteci da Nazioni amiche. Duce, io vivevo sempre nella speranza di vedervi da vicino ma la mia possibilità non permetteva di fare spese di più di quelle che erano necessarie per la famiglia. Grazie a Dio per volontà vostra il 20 di questo mese avete ordinato l’adunata a Roma di tutte le donne d’Italia. Io come donna Fascista e come massaia rurale datosi la minima spesa partecipai a questa grande adunata. Duce, ora vi scrivo per ringraziarvi del trattamento che avete usato verso di noi donne in tutto e per tutto che non riuscirò mai e poi mai a dimenticare la mia giornata così felice. Ebbi la fortuna di vedervi da vicino, poter rendermi conto della vostra bontà, ammirai le vostre parole e quel sì… che noi rispondemmo alle vostre domande è un giuramento fatto col cuore davanti a voi da noi donne d’Italia e lo manterremo in qualunque momento voi lo comandate. Molto probabilmente le domande di cui si fa cenno nella lettera sono quelle poste nel discorso tenuto proprio il 20 giugno 1937 durante l’adunata delle donne delle varie provincie italiane Come donne italiane e fasciste voi avete dei particolari doveri da compiere, voi dovete essere le custodi dei focolari (sì). Voi dovete dare con la vostra vigilante attenzione, col vostro indefettibile amore, la prima impronta alla prole che noi desideriamo (sì, sì).59 59 I Fasci femminili, cit. 138 Dal regime fascista agli anni Sessanta La lettera della donna bolognese continuava di tutto quello che ho potuto vedere a Roma specie della inaugurazione della colonia estiva e dell’assistenza all’infanzia tutto per volontà vostra, racconto tutto a questa gente ma soffro tanto perché con le mie parole mi sembra di non riuscire bene a far capire a loro la grandezza e la bellezza di Roma. Duce, con tutto questo io vi ringrazio di avermi così illuminata. Vi giuro che educherò la mia famiglia secondo i vostri insegnamenti. Chiedo a voi una cosa sola. Una vostra fotografia che rimanga per noi tutti un perpetuo ricordo della vostra bontà e un incitamento per la nostra fede. Rimanendo ai vostri ordini io e la mia famiglia. A Noi.60 Il tono e il modo di scrittura ci fa dire che, sicuramente, la massaia rurale bolognese, così affascinata, non era una bracciante o una mondina, visto che queste non potevano certamente avere l’istruzione necessaria per scrivere in quel modo, poteva essere piuttosto la moglie di un proprietario o, comunque, apparteneva ad una classe sociale più elevata. Il consenso, un consenso così «affascinato» era in effetti più caratteristico della media borghesia che delle classi popolari. La mobilitazione delle donne per la campagna d’Africa Una delle caratteristiche dell’espansione coloniale durante il fascismo è il tentativo di coinvolgimento della popolazione italiana, novità assoluta rispetto all’atteggiamento del governo liberale. Dopo l’attacco all’Etiopia, le conseguenti sanzioni comminate all’Italia dalla Società delle Nazioni il 3 novembre 1935, in realtà non così incisive, vennero trasformate in un mezzo per sollecitare l’orgoglio nazionale.61 Innanzitutto venne chiesto alle donne, alle massaie di organizzare l’alimentazione per incrementare l’utilizzo di prodotti nazionali, «autarchici», per svincolare così l’Italia dalle importazioni, le donne avrebbero dovuto «sorreggere l’industria italiana con la loro tenace fiducia».62 In questo contesto fu organizzata la giornata della fede.63 Era il 18 dicembre 1935, secondo il documentario Luce L’atto di fede del popolo italiano, «nel trigesimo delle sanzioni, auspice S.M. la Regina – tutte le spose d’Italia hanno offerto il loro anello nuziale simbolo di una fede sublimata dalla carità di patria», pioveva visto che la regina Elena era accompagnato dal cancelliere di corte che le teneva l’ombrello mentre saliva gli scalini dell’altare della patria dove lesse il suo discorso per invitare le italiane a donare la fede nuziale. Subito dopo di lei altre donne donarono la fede nuziale, fra queste Rachele ed Edda Mussolini, e poi, in modo simbolico, alcune suore diedero l’anello della consacrazione. Anche uomini, evidentemente fecero questo gesto, ma la cerimonia fu improntata alla mobilitazione delle donne. La giornata della Fede era stata un ulteriore tentativo di nazionalizzare le donne e aveva rappresentato, scrive Petra Terhoeven, «una illustrazione simbolica delle richieste che la nazione in guerra avrebbe posto alle donne, complementari a ciò che chiedeva alla parte maschile della popolazione». 60 Lettera data 25 giugno 1937, citata in H. DITTRICH-JOHANSEN, Le «militi dell’idea» cit., pp. 168-169. NICOLA LABANCA, Oltremare. Storia dell’espansione coloniale italiana, Bologna, il Mulino, 2002, p. 189. 62 «L’Almanacco della donna italiana», 1936, pp. 55-56. 63 Su questo si veda, fra l’altro PETRA TERHOEVEN, Oro alla patria. Donne guerre e propaganda nella giornata della Fede fascista, Bologna, il Mulino, 2006. 61 Il fascismo e la seconda guerra mondiale 139 L’intenzione era quella di mobilitare le donne e in tutta Italia, evidentemente, le organizzazioni fasciste si erano mobilitate affinché le donne consegnassero le fedi. Richiesta che non fu accolta sempre con grande favore, almeno secondo quello che viene ricordo nelle testimonianze.64 Ad esempio, sull’appennino bolognese si ricorda che Volevano portare la civiltà in Africa, il Duce, altroché, gli andava a sparare, altro che la civiltà. Mia madre non consegnò la fede, fece finta d’averla persa, quando la chiesero.65 Io non avevo paura, e non volevo darci la fede, mia suocera, dice lui lì non me la prende la fede; e mio marito diceva, abbiamo una bottega, siamo segnati, dobbiamo dargliela, ma lei non gliela diede, quando è morta e poi quando ne abbiamo riesumate le ossa, l’aveva ancora nel dito, è questa che io porto adesso, perchè la mia mi è toccata di dargliela.66 Laura Marani, scriveva invece di una realtà diversa, in cui, grazie alla sua azione di convincimento, le donne diedero, infine, la fede. Le massaie rurali, care piccole donne, hanno dato la vera che avevano ricevuto all’altare, e l’hanno data con un misto di dolore e d’orgoglio commoventissimo. Mi avevano detto che in un villaggio montano le massaie invitate ad offrire gli anelli, avevano risposto in coro «tutto al Duce, fuorché la fede». Io vado lassù. Entro: spiego loro il significato di quest’offerta. […] una ad una vennero a consegnarmi l’anello. Solo una giovanissima sposa rimaneva riluttante; poi, infine, esclama: «ho aspettato tre anni di fidanzamento per avere questo anello, e volete che me lo cavi dal dito?». Mi avvicino, l’accarezzo: scoppia in pianto: si toglie l’anello e mi dice con un misto di rabbia e fierezza: «a lei, lo porti al DUCE».67 Non si può dire, evidentemente, quanto la presenza della segretaria dei fasci femminili, donna caparbia e estremamente convinta delle proprie idee fasciste, abbia incentivato la donazione. Certamente dove la presenza delle organizzazioni fasciste era più serrata, difficile diveniva non seguire le direttive. Nella retorica di regime, le donne furono considerate un elemento fondamentale per la guerra d’Etiopia: Sono veramente lieto di rivolgere a voi, donne dell’Urbe, e con voi alle donne di tutta Italia, l’espressione della mia più profonda simpatia. La fulgida Vittoria riportata dalle nostre truppe nell’A.O. si deve all’eroismo dei vostri figliuoli, dei vostri mariti, dei vostri fratelli, ma si deve anche a voi, o donne di Roma e d’Italia. L’Italia fascista. cinta dall’assedio societario organizzato da 52 Paesi, vi aveva affidato un compito delicato e decisivo: quello di fare di ogni famiglia italiana un fortilizio per resistere alle sanzioni. Con magnifica disciplina, con patriottismo superbo, voi, o donne, avete assolto a questo compito che il Regime vi aveva affidato. La Patria vi tributa la sua gratitudine, mentre il vostro esempio rimarrà consegnato nelle pagine della storia italiana.68 Dopo la conquista dell’Etiopia si poneva il problema della presenza delle donne nella vita nelle colonie. Scriveva Gadda: 64 ANNA MARIA PAZZAGLIA, Immagini e ruolo delle donne nella società emiliana negli anni precedenti il secondo conflitto mondiale, in ILVA VACCARI, La donna nel ventennio fascista 1919-1943, Milano, Vangelista, 1978, p. 297. 65 Intervista a Ines Crisalidi, raccolta da chi scrive, 1995. 66 Intervista a Filomena Vecchi, raccolta da chi scrive, 1995. 67 A. ZAVARONI, La donna del fascio cit., pp. 32-33. 68 Discorso dell’8 maggio 1936, in BENITO MUSSOLINI, Scritti e Discorsi dell’Impero, novembre 1935-XIV – 4 novembre 1936-XV, Edizione definitiva X, Milano, Hoepli Editore, 1936. 140 Dal regime fascista agli anni Sessanta c’è da esprimere la certezza che le donne italiane, ove se ne dia loro l’occasione, sapranno essere in colonia quello che sono in patria: le compagne, le madri, le consolatrici di chi lavora, di chi osa, di chi vince, poiché la vittoria è ben spesso il premio di una volontà senza sosta e di una paziente fatica.69 L’espansione coloniale, italiana ed europea, è stata soprattutto una esperienza al maschile e nelle colonie italiane, sino agli anni Venti, le donne furono un sesto rispetto agli uomini. Lo sforzo del regime verso una emigrazione famigliare non ebbe grandi risultati se non dalla metà degli anni Trenta: i ricongiungimenti famigliari furono massimi in Libia, in Eritrea prima della guerra d’Etiopia e in questo paese in seguito alla colonizzazione rurale. Da Ferrara nel triennio 1933-1935, ad esempio, furono 22 le famiglie coloniche, composte da 156 membri, che emigrarono in Tripolitania. In Eritrea, alla fine del 1938, vi erano 67.000 italiani di cui un quinto donne.70 In particolar modo la così detta spedizione dei ventimila, che portò sulla «Quarta sponda» 14.633 e 11.000 persone, fu una emigrazione di famiglie, organizzata anche grazie agli enti regionali di colonizzazione «Almanacco annuario della donna», 1936, di Veneto, Romagna e Puglia. Il Biblioteca Italiana delle Donne, Bologna governo fascista chiedeva quindi alle donne di recarsi nelle colonie e assegnava loro un duplice compito: riunire o creare nuove famiglie e contemporaneamente diffondere la cultura italiana agli «indigeni». Bisognava dunque preparare le donne alla «nuova missione»: per questo motivo, nel 1937, il governo stabilì la presenza di una collaboratrice all’interno di ogni sezione dei fasci, con il compito di «infondere nelle iscritte il sentimento coloniale» e l’anno successivo furono istituiti campi precoloniali nelle varie regioni italiane. I primi campi si allestirono ad Alessandria, Cuneo, Genova, Varese, Brescia, Vicenza, Venezia, Trieste, Bologna e Roma. In questi corsi le lezioni alternavano le tematiche care al regime, come la difficoltà dell’espansione italiana, la difesa della razza e il pericolo del meticciato, con la presentazione dei problemi di ordine quotidiano che le donne avrebbero potuto trovare una volta giunte a destinazione. Si creò anche la Giornata Coloniale, il 9 di maggio, in cui venivano rilasciati i diplomi di partecipazione ai corsi. 69 CARLO EMILIO GADDA, La donna si prepara ai suoi compiti coloniali, «Le Vie d’Italia», n. 10, ottobre 1938, p. 1251. 70 N. LABANCA, Oltremare cit., pp. 397-403. Il fascismo e la seconda guerra mondiale 141 Le donne al lavoro, lavori da donne «La donna idealmente è madre prima di essere tale naturalmente. Madre per i figli, per i fratelli, per gli infermi, per i piccoli affidati alla sua educazione»,71 scriveva Giovanni Gentile; secondo il fascismo esistevano dei mestieri adatti alle donne, lavori che «per natura» erano considerati femminili, ovvero i lavori di cura: questi impieghi venivano accettati più facilmente, fermo restando che il modello ideale di donna fascista era la donna di casa, la madre, la moglie, così come già illustrato. Scriveva Nicola Pende: noi ci auguriamo che il lavoro delle donne sia sempre più disciplinato e ristretto in Italia a quelle professioni ed a quei mestieri appropriati ed adatti alla psicologia femminile, e dove uomini e donne non devono lavorare mescolati in ambienti spesso moralmente oltre che igienicamente malsani.72 Di questo pensiero si trovava traccia negli scritti teorici, nei discorsi di propaganda e nei testi scolastici. Ad esempio, nel testo di seconda elementare: Progetti e progettini. Che cosa farai quando sarai grande? Maria dichiara che coltiverà il suo orto, Amelia farà la ricamatrice, Marcella studierà da maestra. Sarina vorrebbe poter frequentare l’Accademia Fascista di Orvieto e dedicarsi all’educazione fisica dei fanciulli. Ed io cosa farò? – pensa Lunella. La sua mente vaga come in un sogno: si vede adulta, simile alla mamma, col peso di una casa addosso. – Ecco – dice alfine – farò quello che fa la mamma. Terrò la casa ben in ordine, accudirò al desinare, rammenderò la biancheria, e quando mi avanzerà un po’ di tempo leggerò qualche libro. Poi avrò dei bambini, molti bambini, e dedicherò loro tutte le mie cure, affinchè crescano belli, sani, laboriosi, coraggiosi, degni della nostra madre Patria. Con diversa intonazione, ma sulla stessa scia, Maria Diez Gasca affermava che la donna non doveva fare professioni o mestieri considerati da uomini: in luogo di troppe numerose e mediocri avvocatesse, medichesse, ingegneresse e impiegate di amministrazioni pubbliche e private, oggi si possono gettare sul mercato del lavoro e molto ben agguerrite, professioniste della casa, dell’alimentazione, di particolari insegnamenti, dell’assistenza ospedaliera e sociale, le quali oltre a risolvere il problema angoscioso del pane quotidiano e del proprio avvenire, raggiungono socialmente un alto valore economico e produttivo tutt’altro che da disprezzare.73 Quindi se proprio le donne dovevano lavorare, era più conveniente, secondo la dottrina fascista, che lo facessero in campi giudicati a loro consoni e lo facessero per un tempo limitato, quando ancora non erano sposate.74 L’assistenza era ritenuto uno di questi ambiti femminili e fu proprio infatti durante il fascismo che nacque nel 1927 la scuola Scuola superiore fascista di assistenza socia71 GIOVANNI GENTILE, La donna nella coscienza moderna, XLII. Preliminari allo studio del fanciullo, Opere complete a cura della Fondazione Giovanni Gentile per gli Studi Filosofici, Firenze, Sansoni, 1969. 72 N. PENDE, Bonifica umana e razionale cit., p.135. 73 MARIA DIEZ GASCA, Nuove professioni femminili, «Difesa sociale», n. 10, 1936. 74 Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, Primo convegno nazionale del lavoro femminile commerciale, citato in V. DE GRAZIA, Le donne cit., p. 229. 142 Dal regime fascista agli anni Sessanta le per formare le assistenti sanitarie visitatrici,75 autorizzata con il regio decreto legge 15 agosto 1925. La scuola che era diretta da Angiola Moretti si proponeva di preparare tecnicamente e spiritualmente il personale femminile che è chiamato a svolgere nelle fabbriche una delicata opera di assistenza sociale ai lavoratori. Con essa i segretari di fabbrica potranno disporre di personale tecnico specializzato a compiere le più delicate mansioni assistenziali in favore delle classi lavoratrici e delle loro famiglie.76 Potevano presentare domanda di ammissione le laureate in giurisprudenza, scienze politiche, economiche e commerciali, in età compresa fra i 25 e i 35 anni, iscritte al Pnf e munite di una presentazione ufficiale della fiduciaria provinciale che attestasse il possesso dei «requisiti morali e politici». La Scuola terminò la sua attività nel 1943, dopo aver diplomato circa 500 allieve che trovarono occupazione in aziende industriali e presso le Unioni Provinciali dei Lavoratori dell’Industria, distribuite su tutto il territorio nazionale, soprattutto nelle zone in cui più presenti erano le industrie, ovvero nelle regioni centro-settentrionali. Era previsto poi anche un corso per assistente sanitaria visitatrice abilitata a lavorare nel campo della prevenzione di malattie endemiche quali la tubercolosi, la malaria, il tracoma. Le donne erano presenti nell’ambito sanitario in diverso modo e in diverse proporzioni: rarissime le donne medico e le donne dentiste. Mestiere femminile, anche se non esclusivamente, era poi quello dell’infermiera. Il numero di infermiere crebbe dal 1921 al 1936 con regolarità: dai censimenti possiamo rilevare come le infermiere fossero in Italia nel 1921, 15.197 e gli infermieri 12.067; in Emilia donne e uomini erano in un numero pressoché simile: 1576 donne e 1531 uomini. Dieci anni dopo il numero delle donne che svolgevano questa professione era aumentato: nel Regno 19.944 le donne, 14.964 gli infermieri. In Emilia 1941 le infermiere e 1475 gli uomini. Era quindi iniziata una decisa femminilizzazione di questa professione causata anche dal fatto che le scuole di formazione organizzate dal regime erano riservate alle donne. L’assistenza infermieristica venne infatti regolamentata nel 1925 con lo stesso regio decreto che stabiliva l’istituzione delle scuole per le assistenti visitatrici cui si è fatto cenno. In questo decreto, convertito in legge il 18 marzo 1926, si stabilivano i criteri per la istituzione di scuole convitto professionali per infermiere che duravano due anni durante i quali venivano impartiti da medici insegnamenti tecnico-pratici. La direttrice della scuola si doveva occupare della «educazione morale» delle allieve che venivano ammesse dopo aver frequentato la scuola media di primo grado, seppur non fosse un titolo di studio obbligatorio. Alla domanda di ammissione doveva essere allegata una dichiarazione firmata da due persone in cui fosse garantita la moralità della candidata e fra le materie insegnate nel corso vi erano l’economia domestica e ospedaliera, cultura militare e religiosa, patologie tropicali ed etica professionale.77 La norma prevedeva che le allieve infermiere, compiuto il tirocinio nei reparti e il corso teorico-pratico, complessivamente di durata biennale, una volta superato l’esame di Stato, conseguissero il diploma di infermiera professionale.78 Rimanevano comun- 75 Professione e genere nel lavoro sociale, a cura di Pierangela Benvenuti, Roberto Sgatori, Milano, Franco Angeli, 2000, pp. 90-92. 76 FRANCO MARTINELLI, Assistenti sociali nella società italiana contributo ad una sociologia della professione, Roma, Istituto per gli studi di servizio sociale, 1965, p. 22. 77 EDOARDO MANZONI, Storia e filosofia dell’assistenza infermieristica, Milano, Masson, 1996. 78 LUCIA CONTI, L’infermieristica dall’Unità di Italia al Fascismo, «L’infermiere», n. 1, 2006. Il fascismo e la seconda guerra mondiale 143 que valide le precedenti modalità di formazione per gli infermieri generici, formazione in questo caso estesa indifferentemente a uomini e donne e regolamentata poi con leggi del 1925 e 1927. Naturalmente restavano in funzione e venivano ampliate le scuole della Croce Rossa: a Bologna, ad esempio, ne viene costruita una nel 1931 presso l’ospedale S. Orsola. Un altro settore della sanità in cui le donne lavoravano era quello della maternità e dell’infanzia dove, evidentemente, altissima era la presenza femminile fino ad arrivare ad un mestiere esercitato esclusivamente dalle donne come quello delle levatrici. Dai due censimenti del 1921 e 1931 possiamo vedere che in Italia in dieci anni il numero delle levatrici diminuì passando da 15.900 a 15.514, in Emilia vi fu un calo di 55 unità, si passò infatti da 1287 a 1232. Nel 1927, per l’ammissione ai corsi triennali delle Scuole di Ostetricia era richiesto il diploma di scuola media inferiore o la licenza complementare. Nel 1937, dopo lunghe polemiche, il titolo di levatrice viene sostituito per legge con quello di ostetrica e nel 1940 si elaborò un nuovo regolamento per l’esercizio professionale delle ostetriche (R.D. n. 1364). Nel 1938 l’Omni s’incaricò di creare corsi di perfezionamento per le levatrici che erano le uniche persone che assistevano e potevano quindi intervenire durante i parti del 95% delle italiane. Sovente si applicava a questo mestiere, di grande responsabilità e di grande fatica, soprattutto per le levatrici del forense, una buona dose di retorica. La levatrice assolve nella funzione dell’assistenza una missione particolarmente delicata, fatta di scienza sia pur elementare, ma anche di tenerezza. La sua presenza al letto della prossima madre già rappresenta un aiuto conscio, una difesa contro l’oscuro pericolo, un conforto dello spirito che alleggerisce le atroci trafitture del corpo squassato. Alleviatrice di pene e garante di vita, la levatrice, la «comare», è la vera madre del primo periglioso momento: è essa che apre per prima gli occhi del neonato alla immensa bellezza della luce e la piccola boccuccia all’immenso grido iniziale conquistatore della vita: è essa che ricopre per prima il nudo e fumigante germoglio umano, dei lini e delle fasce per difenderlo dalle fredde insidie dell’ambiente: è essa che accorre dovunque, nel tugurio, nella cascina, tra le alpestri asperità, di giorno di notte, per recare, umile, misconosciuta sovente, sempre mal pagata, l’aiuto della sua breve tecnica, della sua esperienza, dell’igiene, a rendere scevro di pericoli lo sbocciar lieto della vita umana dal dolore santo della maternità.79 I compiti della levatrice, oltre alla gravidanza e al parto, dovevano coprire i primi anni della vita del bambino e quindi coincidere con attività di puericoltura.80 Con l’avvento del fascismo e lo scioglimento dei partiti e dei sindacati, si ebbe la creazione del sindacato nazionale fascista delle levatrici; nel 1934 il sindacato iniziò la pubblicazione della rivista «Lucina», proprio organo mensile diretto da Maria Vittoria Luzzi, presidente della Corporazione delle ostetriche e per questo unica donna al Consiglio superiore delle corporazioni. Vista l’importanza che veniva data all’incremento demografico, la professione della levatrice era soggetta ad una attenzione particolare; attenzione rivolta anche alle possibili pratiche di aborto, tanto che le levatrici, così come i medici, erano obbligati a denunciare e a registrare, parti ed aborti, e a segnalare anche i sospetti casi di aborto procurato o auto procurato. La condanna per il procurato aborto era l’ammonizione e il 79 PIETRO CAPASSO, Le buone ancelle della maternità, «Gazzetta Italiana delle Levatrici», Anno XXII, 15 aprile 1933, XI, n. 4. 80 Ibidem. 144 Dal regime fascista agli anni Sessanta confino, condanne che venivano comminate spesso anche in seguito a segnalazioni anonime o di «voce diffusa».81 I podestà di Comuni in cui non vi era una condotta ostetrica sovente chiedevano che fossero inviate al confino da loro le levatrici, così da poter intervenire, almeno nei casi più urgenti e gravi. Per questo, ad esempio, a Castelgrande in provincia di Potenza fu mandata Irma, levatrice di Rimini. Una donna di Bologna, è invece ricordata in molte testimonianze raccolte in Basilicata. La prima figlia di Giovanni nacque in Basilicata. Quando la moglie si accorse di aspettare un figlio chiese consiglio ad alcune vicine e queste consigliarono subito una nota levatrice; ma non seppero lì per lì dire il nome perché tutti, in paese, la indicavano semplicemente come «la bolognese». Dissero che fosse una buona donna, e poi educata, pulita, anzi pulitissima. Tutti i parti della bolognese andavano bene; e poi, si sa, aveva studiato a Bologna, veniva da quelle terre dove hanno molto più rispetto per la vita umana. Giovanni ed Anna andarono a trovare la bolognese e l’ostetrica li accolse con molta cordialità.82 Alessandra Gissi ipotizza che «la bolognese» fosse una confinata, Clementina C., nata a Sant’Agata Bolognese, diplomata in ostetricia presso l’Università di Bologna durante la prima guerra mondiale, mandata al confino dapprima a Lipari e quindi a Miglionico nel 1928, dove restò anche dopo aver scontato la pena. Stessa scelta fu fatta da Rosina M. di Parma che, confinata nel 1928 a Rapone, località del potentino dove non vi era assistenza ostetrica, vi rimase per tutta la vita.83 Sempre legato alla maternità vi era poi un’altra occupazione, svolta soprattutto dalle donne di campagna, ovvero la balia. Mestiere che prosegue ancora durante il periodo fascista per il quale assume una valenza particolare, visto che solitamente erano le giovani donne di campagna che allattavano i figli della borghesia cittadina: una ulteriore occasione per sottolineare la bontà dello stile di vita rurale. In campagna l’allattamento materno è sempre in onore […]; la nutrice dovrà essere scelta nell’elemento agricolo, perché le donne conservano quelle doti di pazienza, di arrendevolezza, di minor emotività, che sono indispensabili nella funzione che ad esse viene richiesta.84 Alle madri vere, nella retorica di regime, si affiancavano le maestre, donne in grado, così come le infermiere, di «esplicare quelle doti che ogni donna ha in sé anche inconsapevolmente. Ossia sacrificio, dedizione e rinuncia, dimenticanza di sé, abnegazione».85 Nella scuola le donne rappresentavano il 70% del totale ed erano presenti massicciamente nelle scuole elementari, mentre le redini della scuola fascista erano saldamente nelle mani degli uomini. Nei censimenti del 1921 e del 1931 vediamo come effettivamente la presenza femminile in ambito scolastico fosse estremamente alta. Purtroppo i dati non indicano quanti fossero i maestri e quanti i docenti di altri gradi di scuo- 81 Potevano essere ammonite in base all’articolo 165 del regio decreto del 18 giugno 1931, in cui possiamo leggere che era «diffamata la persona la quale è designata dalla voce pubblica come abituale colpevole […] dei delitti contro l’integrità e la sanità della stirpe commessi da persone esercenti l’arte sanitaria». ALBERTO AQUARONE, L’organizzazione dello Stato totalitario, Torino, Einaudi, 2003, p. 555. 82 VITO MAUROGIOVANNI, Lungo viaggio nella Basilicata del ’50, citato in ALESSANDRA GISSI, Le segrete manovre delle donne, levatrici in Italia dall’unità al fascismo, Roma, Biblink, 2006, pp. 121-122. 83 A. GISSI, Le segrete manovre delle donne cit., pp. 122-123. 84 GIULIO CASALINI, La madre e il suo bambino, Torino-Genova, Casanova, 1929, p. 221. 85 «La donna italiana», n. 4, aprile 1934. Il fascismo e la seconda guerra mondiale 145 la, comunque possiamo vedere come a livello nazionale, nel 1921, 161.271 erano le donne e 46.826 gli uomini. Dieci anni dopo gli impiegati in questo settore erano diminuiti ma la proporzione rimaneva pressochè invariata. Nella nostra Regione i dati ci mostrano la stessa massiccia presenza femminile 10.612 a fronte di 2599; nel 1931, poi, 9320 erano le donne nella scuola e 2392 gli uomini. Nel 1936 in Italia vi erano 22.435 maestri mentre le maestre erano 88.111. Nell’anno scolastico 1920-1921 al liceo insegnavano 1076 uomini e 316 donne, mentre nella scuole normali insegnavano 829 donne e 426 uomini.86 A livello universitario, in Emilia-Romagna nove erano le docenti su un totale di 416. Secondo alcune stime nel 1938 le cattedre occupate da donne nei licei variava fra il 2 e il 3%, mentre l’insegnamento elementare e medio inferiore registravano una ben più alta percentuale.87 La dimostrazione di questa sproporzione è rintracciabile nei dati delle iscrizioni alla scuola normale, che con la riforma Gentile divenne Istituto magistrale. Nell’anno scolastico 1922-1923 gli alunni erano 28.994, di cui 2225 maschi e 26.769 femmine. Tre anni dopo la proporzione maschi-femmine degli iscritti all’istituto magistrale era di uno a dieci.88 Era talmente evidente la sproporzione che si cercò di incentivare le iscrizioni maschili attraverso l’introduzione di agevolazioni, l’istituzione di borse di studio a favore dei maschi, l’apertura di istituti magistrali nelle località prive di altre scuole secondarie, l’esonero degli aspiranti maestri dal pagamento delle tasse scolastiche. Però il numero delle maestre continuò a crescere, sebbene la distinzione dei concorsi per le classi maschili, femminili e miste, favorisse il passaggio in ruolo dei maestri.89 Le donne potevano quindi insegnare, ma preferibilmente alle elementari e, negli altri gradi, solo ed esclusivamente materie giudicate consone alle loro capacità, tanto che si era arrivati, come detto in precedenza, ad una legge che stabiliva quali discipline la donna poteva insegnare. In ogni settore del lavoro umano possono le donne avere un posto; ma sia il suo posto. Quando l’ordine corporativo devia le donne da certi impieghi, pubblici e privati, compie un atto positivo dell’avviamento delle donne ai suoi impieghi. Può la donna, per esempio, insegnare? Senza dubbio. Anzi lo deve. Ma solo in quei gradi dell’insegnamento e in quelle discipline in cui la sua maestria non può essere surrogata da quella, di diverso tono, dell’uomo.90 Alle donne, ritenute non dotate né di genio né di capacità di sintesi, si riconosceva una grande memoria, «incapace di trasformare fondamentalmente il dato, la donna per virtù di memoria si colloca al primo posto e sopravanza i suoi concorrenti»91 e quindi 86 Essere donne insegnanti: storia, professionalità e cultura di genere, a cura di Simonetta Ulivieri, Torino, Rosenberg & Sellier, 1996, pp. 39-40. 87 MICHELA DE GIORGIO, Le italiane dall’Unità a oggi, modelli culturali e comportamenti sociali, Roma-Bari, Laterza, 1992, p. 472. 88 ANTONIO SANTONI RUGIU, Maestre e maestri. La difficile storia degli insegnanti elementari, Roma, Carocci 2006, p. 108. 89 RINO GENTILI, La scuola italiana nel ventennio fascista, Istituto Regionale per la Storia della Resistenza e della guerra di Liberazione in Emilia-Romagna, Annale 3, 1983, Scuola e educazione in Emilia Romagna fra le due guerre, a cura di Aldo Berselli e Vittorio Telmon, Bologna, Editrice Clueb, 1983, p. 63. 90 Delle scuole femminili, radiocomunicazione del 19 marzo 1939 citata in ESTER DE FORT, La scuola elementare dall’Unità alla caduta del fascismo, Bologna, il Mulino, 1996, p. 449. 91 NAZARENO PADELLARO, Pedagogia ed antipedagogia, Roma, Scuola salesiana del libro, 1940. 146 Dal regime fascista agli anni Sessanta poteva insegnare quelle materie e soprattutto in quelle scuole in cui l’imparare e l’insegnare si riducevano ad esercizi mnemonici. Ernesto Codignola in un articolo del 1933 affermava che solo nelle prime classi della scuola elementare il rendimento delle maestre è migliore di quello dei maestri.92 Lo stipendio non era certamente alto, le difficoltà erano molte, spesso la sede scolastica era lontano da casa e, a scuola, la pulizia dei locali era lasciata alla buona volontà delle maestre e degli scolari.93 Le classi erano numerose e soprattutto in campagna vi erano le pluriclassi. Il regime fascista impiegò molte energie per l’educazione totalitaria, affinché fosse cresciuto ed educato «l’uomo nuovo fascista»,94 investendo di questo compito maestri, e soprattutto maestre.95 Molti furono i provvedimenti, da quelli che via via fascistizzava la riforma varata da Gentile, all’introduzione del libro unico nel 1928. Il comportamento degli alunni e degli studenti fu militarizzato con l’adozione di riti, simboli e cerimonie legate all’ideologia fascista, la storia, la geografia e le altre materie divennero veicoli della retorica del regime. Agli insegnanti fu imposto fra il 1929 e il 1931 il giuramento di fedeltà al regime: non prestare giuramento significava essere allontanati dal posto di lavoro. Fra chi fece questa scelta possiamo ricordare Lina Merlin, che dopo la seconda guerra mondiale divenne deputata alla costituente, oppure, a livello emiliano, la ferrarese Alda Costa, socialista che prestò poi il giuramento ma con riserva. Dopo queste vicende il prefetto ordinò una perquisizione nella casa della maestra dove vennero trovati il ritratto del deputato socialista Giacomo Matteotti – assassinato due anni prima dai fascisti – giornali, tessere del partito socialista e lettere di esponenti di questo partito. Il 17 marzo 1926 Alda Costa fu allontanata dall’insegnamento e le venne sospeso lo stipendio. Qualche mese più tardi fu licenziata con atto prefettizio per «aperta ed esplicita professione di fede socialista». In seguito fu condannata al confino ed arrestata a Milano, dove si era trasferita in cerca di lavoro. Venne condotta dapprima alle isole Tremiti e poi in un piccolo paese della Basilicata.96 Il controllo non era solo politico, ma anche «morale», ovvero le maestre dovevano agire e vestirsi in modo ritenuto consono, rispettoso della «pubblica decenza», senza preoccuparsi delle mode. Le insegnanti dovevano essere un esempio, un modello, così come veniva ricordato in una circolare del 1929: Lo stile di serietà morale e d’interiore disciplina cui il Fascismo importa la vita nazionale, e che deve avere nella scuola la sua maggiore efficacia, per la preparazione delle nuove generazioni ai compiti futuri, esige che anche nelle forme esteriori si rifletta e si manifesta la dignità e l’elevatezza di pensiero e di sentimento cui tutta l’opera educativa si ispira. Rinnovo perciò a tutti i nostri Presidi e Direttori di scuole l’esortazione di curare che siano strettamente osservate le norme già emanate da questo Ministero sul modo di vestire delle signore insegnanti e dalle alunne nelle scuole. A tal uopo è opportuno ricordare che esse debbono indossare grem- 92 ERNESTO CODIGNOLA, La carriera magistrale, «La Nuova scuola italiana», 1933. GIOVANNI GENOVESI, MAURA GELATI, La scuola attraverso i giornali di classe. Indagine sull’insegnamento elementare in un comune parmense durante il periodo fascista (1928-1935), Istituto Regionale per la Storia della Resistenza e della guerra di Liberazione in Emilia Romagna, Annale 3, 1983, Scuola e educazione in Emilia-Romagna fra le due guerre cit., pp. 158 e 178. 94 E. GENTILE, Fascismo cit., p. 25. 95 Attività femminile fascista, «Il giornale della donna», 1º marzo 1929. 96 ANNA MARIA QUARZI, ANNAMARIA ANSALONI, L’azione politica e formativa di Alda Costa, in I. VACCARI, La donna nel ventennio fascista cit., pp. 312-314. 93 Il fascismo e la seconda guerra mondiale «Il Comune di Bologna», Attività del Comitato bolognese dell’ente nazionale della moda, maggio 1934, p. 55, Biblioteca comunale dell’Archiginnasio, Bologna 147 LIDIA MORELLI, IRENE FACCIO, Il lavoro della giovinetta italiana nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale femminile, Torino, S. Lattes & C., 1938, Biblioteca comunale dell’Archiginnasio, Bologna biuli di giusta lunghezza, oltre il ginocchio, accollati e con le maniche lunghe. Per le signore insegnanti sono convenienti i colori scuri, e così pure per le alunne dei corsi superiori. […] le signore insegnanti dinnanzi alle scolaresche debbono essere, anche nell’aspetto esteriore, esempio e modello di austerità morale, di signorile contegno, di massima correttezza, così che le giovanissime creature affidate alle loro cure vedano in esse attuato un superiore ideale di maternità per il quale è gioia ed orgoglio far sacrificio d’ogni vanità femminile, nella ricerca soltanto di quella nobile bellezza interiore, che si manifesta nella luce delle idee.97 Se le insegnanti non si dovevano occupare di moda, dovevano però occuparsi di cucito ed altri «lavori donneschi», inseriti nei programmi scolastici. Si insegnavano lavori come «tagliare, cucire, scalzettare [che erano] quasi una necessità istintiva della donna. Si comincia da bambine, ci si trova donne fatte, massaie a capo di una casa, madri», come possiamo leggere in un manuale di cucito, libro di testo per le scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale femminile.98 97 Circolare12 febbraio 1929, n. 35 ministro Giuseppe Belluzzo, ministro della Pubblica Istruzione dal 9 luglio 1928 al 12 settembre 1929. 98 LIDIA MORELLI, IRENE FACCIO, Il lavoro della giovinetta italiana nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale femminile, Torino, S. Lattes & C., 1938. 148 Dal regime fascista agli anni Sessanta I lavori di cucito e di ricamo erano praticati dalle donne sia per la famiglia, sia presso il proprio domicilio sia a livello di sartoria. In quegli anni, anche in seguito alle sanzioni, la propaganda di regime si incentrò molto sulla moda italiana e sui tessuti italiani. Grande sviluppo ebbero quindi le sartorie e la moda, che in molti casi divenne anche veicolo di propaganda. Secondo Nicola Pende: Il campo del governo delle case e quello della beneficenza ed assistenza civile. Ecco le due nobilissime ed utilissime sfere di lavoro in cui signore e signorine delle classi agiata dovrebbero far consistere la loro giornata lavorativa, dopo una opportuna preparazione culturale e pratica che è più difficile a farsi di quanto creda.99 Sovente, però le donne di quelle classi sociali si affidavano al lavoro di altre donne per il «governo della casa». Chi andava presso le famiglie a lavorare erano giovani se non giovanissime ragazze che lasciavano la campagna per andare in città per accudire i bambini o per svolgere i lavori domestici. Lì da noi chi andava via, andava a fare la domestica, perchè non c’era mica altro. Quindi la maggioranza di noi, anche le mie due sorelle più grandi tutte siamo andate a servizio, a fare la domestica, non mi vergogno mica a dirlo perchè, lo so che è un lavoro, neanche umiliante, perchè si facevano i lavori in casa oppure si guardavano i bambini, io, più che altro, guardavo dei bambini, perchè io ero ancora tanto giovane io avevo dei bambini da guardare, da portare fuori, da andare a fare un po’ di spesa, perchè poi, dove ero io, c’era un’altra signora che veniva la mattina a fare i lavori, abitava a Bologna, veniva a fare le pulizie, da mangiare, io ero addetta solo al bambino e ad andare a fare un po’ di spesa che c’erano dei negozi lì vicino e del resto il mio lavoro era quello lì, quindi non è che uno possa venire su da capire certe cose, cioè da capire come si svolgeva la vita allora.100 Secondo i censimenti il numero delle domestiche aumentò dal 380.614 del 1921, quando gli uomini censiti come domestici erano 65.017, alle 585.000 del 1936, quando la disoccupazione era in aumento, nelle campagne e nelle fabbriche. Nella nostra Regione nel 1921 erano 27.682, contro 5053 uomini, e dieci anni dopo erano 33.890 e 4687 gli uomini. Lo stipendio, concordato solitamente con il padre, variava dalle 30 alle 60 lire al mese. Per questa cifra non certo alta, per vitto e alloggio le ragazze che andavano a servizio lavoravano sette giorni su sette, dalla mattina alla sera, spesso senza un contratto regolare tanto l’organizzazione Unione femminile nazionale si impegnò per la legalizzazione dei contratti di lavoro delle domestiche.101 Anche se fu difficile dare una regolamentazione giuridica a questo particolare tipo di lavoro. Nel 1938 le donne che lavoravano nelle case di ebrei dovettero concludere, in seguito alle leggi razziali, il loro lavoro e quindi le organizzazioni fasciste, come la Sold, vennero mobilitate per trovare loro un altro lavoro. Questo era, nella retorica razzista del regime, descritto come un evento positivo visto che si erano «sottratte all’influenza, all’insidia, al predominio dell’avida razza ebraica per crescere da italiane e da cristiane in una casa dove si pensa, si crede e si vive con animo italiano».102 99 N. PENDE, Bonifica umana razionale cit., p. 135. Intervista a Alfonsina Luccarini, raccolta da chi scrive, 1994. 101 V. DE GRAZIA, Le donne cit., pp. 258-260. 102 RACHELE FERRARI DEL LATTE, La difesa della razza, «Lavoro e famiglia», n. 1, dicembre 1938, p. 3. 100 Il fascismo e la seconda guerra mondiale 149 Nelle fabbriche La donna italiana lavora quasi esclusivamente per bisogno. La donna italiana se può fare a meno del lavoro fuori di casa ne fa a meno, si accontenta della vita casalinga, della famigliola, della casetta anche povera, del pane anche scarso, purché sicuro.103 Così si poteva leggere nella prima pagina de «Il giornale della donna», organo del partito nazionale fascista nel 1933, e tre anni prima sull’«Almanacco della donna italiana» era stato scritto che «molte donne devono contribuire a sostenere direttamente la famiglia anche dopo aver preso marito». In effetti, nel 1931 sulla percentuale di donne impiegate nell’industria (il 23,6 del totale), 18,2 % erano donne sposate. La crisi economica degli anni Trenta aveva prodotto da un lato disoccupazione e, dall’altro, la necessità del lavoro sia per gli uomini che per le donne. La disoccupazione e il disagio erano diffusi, tanto che nel 1932 il presidente della Congregazione di carità bolognese rilevava come gli esercizi degli anni 1929-1930 avessero registrato disavanzi per la necessità di intensificare la beneficenza a fronte dei «grandi bisogni provocati dal disagio economico delle classi povere della città».104 Le famiglie numerose, così auspicate dal regime, avevano difficoltà economiche, tanto che sovente si rivolgevano alla segreteria particolare del duce per avere un aiuto, organismo strumento della politica assistenziale legata strettamente alla creazione del consenso e alla costruzione del «mito di Mussolini».105 Alla segreteria si rivolse anche una operai bolognese del Pirotecnico nella seconda metà degli anni Trenta, rivolgendosi a Mussolini Eccellenza, la sotto scritta madre di 12 figli trovandosi in condizioni disagiate avendo da 7 mesi i 4 figli grandi disoccupati e anche quando lavorano col turno il guadagno non è sufficiente. I 5 bambini che vanno a scuola non glieli posso mandare perché sono tutti senza scarpe. Mio marito pure lavora col turno. Io sono al Pirotecnico e guadagno 8 lire al giorno e siccome lavoro mi anno tolto l’assistenza, a lire 100 sussidio al mese ma mi occorrerebbero almeno 10 chili di pane al giorno per sfamare la mia famiglia e spesso sento piangere i miei bambini perché anno fame. Stato di Famiglia, C.A. fu Cesare, 1885; D.E. moglie fu Carlo, 1897; figli: Carlo, 1914, Cesarino, 1917; Amleto 1918; Clara, 1919; Anselmo, 1921; Elfa, 1922; Ugo, 1924; Raul, 1925; Eliseo, 1926; Romolo, 1928; Benito, 1933. Sono venuta a Roma sperando di poter parlare a Vostra Eccellenza ma siccome vedo che è impossibile spero che questa mia Le giungerà e già che so quanto Ella sia buono e giusto spero Vorrà interessarsi al mio caso pietoso. […] Nella speranza di essere esaudita perché so che nessuno si rivolge a Vostra Eccellenza inutilmente, porgo devoti ossequi e ringrazio di tutto cuore.106 Nella retorica del regime la disoccupazione era causata anche dalla presenza delle donne nelle fabbriche, tanto che lo stesso Benito Mussolini, nel 1934 scrisse sul «Popolo d’Italia»: Il lavoro femminile è la seconda delle grandi spine del problema [della disoccupazione]. La donna operaia e lavoratrice in genere interseca oltre la disoccupazione anche la questione 103 «Il giornale della donna», 15 febbraio 1933-XI. Archivio storico comunale di Bologna, Eca, Verbali del comitato dei Patroni, seduta del 26 febbraio 1932. 105 Sulla segreteria particolare del duce si veda: TERESA MARIA MAZZATOSTA, CLAUDIO VOLPI, L’italietta fascista, Bologna, Cappelli, 1980. 106 Lettera di E.C. alla segreteria particolare del fuce, Bologna, s.d., (1936), citata in H. DITTRICHJOHANSEN, Le «Militi dell’idea» cit., p. 174. 104 150 Dal regime fascista agli anni Sessanta demografica. Il lavoro, ove non è diretto impedimento, distrae dalla generazione, fomenta una indipendenza e conseguenti mode fisiche e morali contrarie al parto. L’uomo, disorientato, e soprattutto disoccupato in tutti i sensi, finisce per rinunziare alla famiglia. Oggi come oggi, macchina e donna sono due grandi cause di disoccupazione. Nel particolare, la donna salva molto spesso una famiglia ammalata o addirittura se stessa, ma il suo lavoro è, nel quadro generale, fonte di amarezze politiche e morali. Il salvataggio di pochi individui è pagato con il sangue di una moltitudine. Non vi è vittoria senza i suoi morti. L’esodo delle donne dal campo del lavoro avrebbe senza dubbio una ripercussione economica su molte famiglie, ma una legione di uomini solleverebbe la fronte umiliata e un numero centuplicato di famiglie nuove entrerebbe di colpo nella vita nazionale. Bisogna convincersi che lo stesso lavoro che causa nella donna la perdita degli attributi generativi porta nell’uomo una fortissima virilità fisica e morale.107 Pur ammettendo che escludere le donne dal lavoro avrebbe significato un ulteriore peggioramento delle condizioni degli operai e delle famiglie, secondo Mussolini questo era l’unico modo per evitare umiliazioni agli uomini, che, disoccupati mentre vi erano donne che lavoravano, si sarebbero sentititi sminuiti nella loro virilità. Nonostante ciò non vennero applicate alle operaie le limitazioni che invece erano state stabilite per i lavori impiegatizi e per le insegnanti, di cui si è detto. Le donne quindi rimasero presenti nelle fabbriche e, in seguito alle leggi sulla maternità, sovente tornavano al lavoro anche dopo la nascita dei figli. Questa loro presenza, a volte voluta per avere indipendenza in una abbozzata trasformazione sociale e personale, a volte solo per necessità, era ben presente alle organizzazioni fasciste che, pur cercando di limitarne la portata, non potevano non fare i conti con essa. I saggi provvedimenti presi in questi ultimi tempi dal Governo Fascista per assicurare alle impiegate e alle operaie le cure necessarie e la conservazione del posto durante il periodo in cui i riguardi per il riposo sono necessari alla salute della madre e del bambino, mentre contribuiranno efficacemente all’incremento della nostra potenza demografica […] permetteranno alle donne di contribuire, in modo sempre più considerevole, a coadiuvare ai bisogni della famiglia, ed accrescere la produzione e gli scambi, ed a migliorare quindi, seppur indirettamente, tutta quanta l’economia nazionale. Largo dunque alle donne!108 Complessivamente, dai censimenti possiamo rilevare come nel settore industriale nel 1921 in Italia erano impiegati 1.273.391 donne e 4.081.204 uomini e in Emilia 84.081 donne per 267.934 uomini. Dieci anni dopo, gli impiegati nel settore industriale erano 1.252.404 donne e 4.057.270 a livello nazionale e 74.383 donne e 258.477 uomini in Regione. Le donne operaie erano il 27,6% del totale di categoria nel 1921 e dieci anni dopo la loro percentuale era del 23,6%. È forse interessante anche notare che la percentuale sul complesso della popolazione femminile impiegata nell’industria era molto simile nei due censimenti: 7,9 nel 1921 e 7,5 dieci anni dopo.109 Nel 1936 la forza lavoro femminile raggiunse il 28,4% aumentando rispetto al 1931, ma rimanendo inferiore al 1921. Si può quindi affermare che la politica di contenimento, e di allontanamento, delle donne dal lavoro in fabbrica ebbe un successo limitato: le donne erano, e rimasero, occupate negli opifici, in particolar modo nelle 107 B. MUSSOLINI, Macchina e donna, «Il Popolo d’Italia», 31 agosto 1934. «Almanacco della donna italiana», 1930, p. 294. 109 Dati pubblicati nel VII Censimento della popolazione, 1931, vol. IV, parte I, p. 127. 108 Il fascismo e la seconda guerra mondiale 151 industrie […] che richiedono minore fatica fisica e quelle alle quali l’elemento femminile si sente maggiormente inclinato, ossia le industrie tessili e quelle dell’abbigliamento propriamente detto.110 Le donne erano principalmente nelle industrie tessili e dell’abbigliamento, quindi al terzo posto le industrie alimentari, poi le industrie chimiche, le industrie per la lavorazione dei minerali, della carta, delle pelli, cuoi e simili, del legno, dei trasporti.111 In Emilia-Romagna erano funzionanti, in quel tempo, 27 filande, collocate soprattutto a Forlì, Meldola, Modigliana, San Mauro, Santa Sofia. La filanda Majani a Forlì fra il 1918 e il 1929 aveva dato lavoro a più di 500 operai, quasi esclusivamente donne. La recessione mondiale del 1929, condusse Napoleone Majani al fallimento. La produzione di seta viscosa si affermava in quegli anni e a Forlì, entrano in funzione alla fine del 1926 gli impianti dell’azienda del Conte Paolo Orsi Mangelli. Le maestranze impiegate nei primi 5 anni si aggirano intorno alle 1400-1500 unità e di queste la percentuale femminile era cospicua. Il declino dell’industria della seta naturale rese disponibile mano d’opera femminile abile ed esperta, retribuita tradizionalmente con salari bassissimi, per i reparti tessili della nuova fibra (torcitura, aspatura, binatura ecc.) in cui le mansioni erano pressoché identiche.112 In questo settore sulle 23.520 operaie impiegate, il 13% circa aveva meno di 15 anni, il 28,5% si trovava nel gruppo di età compresa tra i 15 e i 18 anni, il 58% aveva tra 18 e 65 anni; molto bassa era la percentuale delle donne anziane. La manodopera operaia femminile risultava, in media più giovane di quella maschile e più della metà delle operaie erano nubili.113 Nel settore tessile vi erano le fabbriche che caratterizzarono il lavoro delle donne fino al secondo dopoguerra, fra questo il Calzificio Reggiano che negli anni Trenta, quando apparteneva alle manifatture Maglierie Milano, occupava 2300 operaie. Anche nelle fabbriche alimentari la presenza femminile era cospicua, così come nell’industria chimica. In questo settore molto attiva era la ditta Gazzoni di Bologna, che produceva l’idrolitina, la pasticca del Re Sole, un antimalarico e un ricostituente, fra le altre cose. Interessante è a questo proposito un articolo, se così possiamo dire, celebrativo di questa industria bolognese comparso sulla rivista del Comune di Bologna, dove, pur riportando due fotografie in cui chiaramente si vedono maestranze in prevalenza, se non esclusivamente, costituite da donne, all’interno dello scritto non vengono mai nominate. Come se delle operaie fosse meglio non parlare, per non sollevare le contraddizioni esistenti fra il modello femminile proposto e propagandato e il lavoro femminile. Nelle fabbriche chimiche vi erano in prevalenza operaie, come nella Hatù che venne fondata a Bologna nel 1922 da Franco Goldoni e che aveva i suoi stabilimenti a Casalecchio di Reno dove venivano prodotti profilattici, tettarelle per biberon, succhiotti per bambini, guanti in gomma. Questo opificio fu acquisito dalla Maccaferri nella cui orbita, dal 1927, entrò anche la fabbrica di siringhe e termometri Ico, che impiegava manodopera 110 «Almanacco della donna italiana», 1930, p. 295. Ivi, pp. 295-296. 112 BRUNA BIANCHI, Lavoro e produzione della seta artificiale. Il caso della fabbrica di Padova (19251933), in Annali 1980. Impresa e manodopera nell’industria tessile, Venezia, Marsilio, 1980, p. 127. 113 Istituto Centrale di Statistica del Regno d’Italia, Censimento industriale e commerciale al 15 ottobre 1927, vol. VII, 1931. 111 152 Dal regime fascista agli anni Sessanta Lavoratrici nella nuova sede de «Il Resto del Carlino» fra le vie Dogali, Milazzo e Montebello, 24-25 ottobre 1936, Archivio storico dell’Università, Bologna femminile. Un’altra fabbrica che vedeva impiegate moltissime donne era la Giordani che, nel 1928, sviluppò la produzione della carrozzina per bambini e negli anni 1930 costruì le prime biciclette per bambini con stabilizzatori laterali. Allo scoppio della seconda Guerra Mondiale l’officina Giordani, allora in via Niccolò dell’Arca, dava lavoro a più di 1300 persone. Nel secondo dopoguerra, nel 1961, lo stabilimento dava lavoro a più di mille operai di cui l’80% donne. Le donne erano poi molto presenti anche nelle manifatture tabacco di Modena e di Bologna. In questa venne istituito un asilo aziendale, così come la legge prevedeva, e di ciò venne data notizia e grande rilievo sulla stampa cittadina. Bologna, tra le due guerre, era stata teatro di importanti trasformazioni industriali: il quadro delle produzioni si presentava abbastanza articolato con un comparto metalmeccanico emergente e il 27% di occupati su circa 80.000 addetti nel settore secondario. I dati statistici confermavano anche una crescita occupazionale femminile (oltre il 25% nel settore) e un diffuso tessuto di piccole imprese la cui dimensione media era di circa cinque unità. Anche nel giornale cittadino, «Il Resto del Carlino» che nel 1936 è nella nuova sede fra le vie Dogali, Milazzo e Montebello dove riceve la visita di Mussolini, sono occupate numerose donne. Durante il fascismo si ebbe la collocazione delle lavoratrici in un sistema di qualifiche separato e diverso da quello degli operai maschi; per le donne esistevano solo due categorie e in genere, a parità di settore, il salario di un’operaia di qualifica più elevata, era inferiore a quello del lavoratore maschio di qualifica più bassa. I salari delle operaie erano, in media, circa la metà di quello percepito dagli uomini. Nel 1925, ad esempio, a parità di mansioni, nell’industria automobilista il rapporto fra il salario femminile e quello maschile era il 53,37%; nelle industrie meccaniche del 54,67%; nell’indu- Il fascismo e la seconda guerra mondiale 153 stria della carta da imballaggio il 51,26% e in quella della carta paglia il 58,65%. Per quanto riguarda il comparto tessile al tradizionale basso livello delle retribuzioni rispetto ad altri settori si accentuò durante questo periodo, in seguito alle riduzioni di stipendio volute dal regime, e quindi si aggravò sempre più la percentuale di scarto fra i salari di operaie ed operai.114 Già nel 1924 gli stipendi delle donne che lavoravano in filanda non raggiungeva le sei lire al giorno, ovvero 35 lire la settimana di 48 ore e in alcuni reparti del setificio di Ferrara le operaie non arrivavano a cinque lire al giorno.115 Tre anni dopo le paghe per le «filatrici provette» erano negli opifici forlivesi di 10,50 lire a Forlì, 9 a Medola e San Mauro, 9,30 a Santa Sofia e 8,60 a Modigliana. Le paghe giornaliere delle apprendiste erano la metà.116 Nel 1932 nella fabbrica di seta artificiale Orsi Mangelli, le tariffe erano inferiori: la paga minima giornaliera era di 4 lire e la massima di 6,40. Per gli uomini la paga massima giornaliera era di 23,6 lire e la minima 14,8. Le condizioni erano quindi molto difficili e anche le associazioni cattoliche si occuparono delle lavoratrici: ad esempio nel 1928 le donne cattoliche di Reggio cercarono di mettere in pratica un programma di assistenza alle lavoratrici in cui si chiedeva, fra l’altro, il rispetto del riposo festivo, orientamento professionale per le ragazze, assistenza alle contadine e alle emigranti.117 Le condizioni igieniche e di lavoro erano in generale molto difficili tanto che nel 1940, a Torino, un ispettore dell’assistenza mutualistica riportava con preoccupazione le condizioni di salute delle lavoratrici in età compresa fra i 14 e i 18 anni. Tutte soffrivano di affaticamento cronico, la metà almeno era afflitta da vene varicose, scoliosi o altre deformità scheletriche ed altre patologie. Per tutte comunque lavorare era importante. A causa di queste condizioni, dello stipendio basso, della riduzione delle giornate di lavoro, nonostante la riorganizzazione del lavoro all’interno delle istituzioni corporative, la centralizzazione delle trattative sindacali e il conseguente divieto di sciopero, sancito dalla legge del 3 aprile 1926,118 le donne dimostrarono il loro scontento anche attraverso questa forma di dissenso: nel 1927 le astucciaie di Bologna, le operaie dello Iutificio di Ravenna, tre anni dopo a Piacenza le bottonaie e sempre contro le riduzioni di salario le tessitrici di Modigliana e le operaie della manifattura tabacchi di Modena. Le filandaie di Spilamberto scioperarono invece contro le multe applicate dalla dirigenza delle fabbrica. Negli anni Trenta nelle file dell’antifascismo clandestino si andava elaborando la necessità che in Italia venissero effettuati scioperi, rivendicazioni economiche, anche dall’interno dei sindacati fascisti.119 114 INES PISONI CERLESI, La parità di salario in Italia: lotte e conquiste delle lavoratrici dal 1861 a oggi, Roma, Editrice Lavoro, 1959, p. 86. 115 «L’Unità», 30 luglio 1924. 116 «Il popolo di Romagna», 31 luglio 1937, citato in I. VACARI, La donna nel ventennio fascista cit., p. 135. 117 I. VACCARI, La donna nel ventennio fascista cit., p. 149. 118 L’articolo 18 del capo terzo della legge prevedeva esplicitamente che gli impiegati e gli operai, che « in numero di tre o più previo concerto, abbandonano il lavoro, o lo prestano in modo da turbare la continuità o la regolarità, per ottenere diversi patti di lavoro dai loro principali, sono puniti con la multa da lire cento a mille», ALBERTO AQUARONE, L’organizzazione dello Stato totalitario, cit., 2003, p. 450. 119 TERESA NOCE, In prima fila le lavoratrici per il pane e il lavoro!, s.l., Edizioni del P.C. d’I., Piccola biblioteca proletaria, n. 4, 1931, p. 20. 154 Dal regime fascista agli anni Sessanta Nel 1930 le operaie del bottonificio piacentino si videro diminuire le ore di lavoro e lo stipendio del 10-20%; questo innescò una serie di proteste ed anche uno sciopero bianco, le protagoniste dei quali furono quasi esclusivamente le donne. Il prefetto annotava che le donne, entrate normalmente negli stabilimenti, restavano inoperose. Il 26 marzo, quattro giorni dopo l’inizio della protesta, la fabbrica venne sgomberata con l’intervento della polizia e le operaie furono sostituite da altre appositamente reclutate. Lo stesso Arpinati, secondo i documenti ritrovati in archivio di Stato, intervenne con un telegramma in cui autorizzava la serrata, il licenziamento delle scioperanti e l’assunzione di altra manodopera.120 Nello stesso anno scioperarono le operaie della filanda di Spilamberto, astenendosi in novembre dal lavoro e manifestando lungo le vie del paese, per protestare contro il padrone della fabbrica che chiedeva lavoro straordinario senza compenso, che comminava molte multe e che, cosa mai successa prima secondo le testimonianze, impediva alle donne di cantare durante il lavoro, come solevano fare per alleviare la fatica.121 Il 28 febbraio 1938, le orlatrici di tomaie di Modena manifestarono il loro malcontento e per questo denunciate all’autorità giudiziaria «per il delitto di cui al 2° capoverso dell’art. 502 del codice penale».122 Lavorare in campagna Come già accennato, il regime fascista si impegnò, soprattutto a livello propagandistico, in una campagna di ruralizzazione. Vennero messi in atto provvedimenti, leggi, messaggi pubblici che, dal 1927, coinvolsero la popolazione con l’intento di ricomporre l’economia rurale, le istituzioni sociali, le relazioni famigliari e lavorative. Il vivere in campagna veniva presentato come il modo migliore di vivere: la campagna, prospera e serena, contro la città, dove vi era sterilità e disoccupazione. Nonostante ciò, a causa delle disagiate condizioni economiche, molte persone decidevano di spostarsi dalle campagne verso le città e per questo vennero varati provvedimenti che obbligavano i disoccupati a ritornare verso i luoghi di residenza originari. Al tempo stesso fu incoraggiato lo spostamento delle famiglie verso le zone agricole da poco bonificate. Da Ravenna partirono 500 uomini e 50 donne per andare a bonificare le paludi di Ostia, nel 1933 erano emigrate da Ferrara verso l’Agro Pontino 76 famiglie, 162 nel 1934.123 Dopo il 1938 a questa emigrazione si aggiunse quella verso la Germania, che riguardò, fino al 1943, 50.000 lavoratori, fra cui anche molte donne: dall’Emilia-Romagna ne partirono 2404, più del 42% di tutte le emigrate. Modena era al secondo posto fra le città da cui vennero effettuate le partenze.124 La donna era una figura chiave della struttura economica contadina: non solo in quanto la reggitrice della casa, ma anche perché prestatrice d’opera. Braccianti, coadiuvanti, massaie, ma al contempo domestiche, addette agli animali da cortile. Le sole incombenze casalinghe continuavano ad essere estremamente impegnative: il bucato, 120 Documenti citati in I. VACCARI, La donna nel ventennio fascista cit., p. 166. Testimonianza di Maria Bartolotti, citata in I. VACCARI, La donna nel ventennio fascista cit., pp. 168-169. 122 I. VACCARI, La donna nel ventennio fascista cit., p. 172. 123 Ivi, p. 140. 124 MAURA PALAZZI, Donne delle campagne e delle città lavoro ed emancipazione, in L’EmiliaRomagna, a cura di Roberto Finzi, Torino, Einaudi, 1997, pp. 406-407. 121 Il fascismo e la seconda guerra mondiale 155 fatto con la cenere, richiedeva molti giorni di lavoro e di fatica, visto il peso che raggiungeva la biancheria di canapa una volta bagnata, le bocche da sfamare erano molte e il preparare pranzo e cena era estremamente impegnativo, solo per fare pochi esempi. Le donne si occupavano della cura dell’orto e degli animali da cortile e parte del risultato di questo lavoro andava, ancora durante il fascismo, a costituire le regalie dovute al padrone del terreno su cui la famiglia viveva e lavorava. La presenza femminile in agricoltura diminuì durante il regime fascista: nel censimento nel 1921, con un dato non dissimile da quelli del 1911, il 30,6% degli occupati in agricoltura erano donne, mentre nel 1931 la percentuale era del 19%. In Emilia nel 1921 lavoravano nel settore primario 306.327 donne e 610.452 uomini, dieci anni dopo erano 207.778 e 634.390 uomini. A livello nazionale nel 1921 le donne erano 3.117.222 e gli uomini 7.146.884, nel 1931erano rispettivamente 1.534.482 e 6.544.683. In agricoltura negli anni Trenta vigeva il così detto coefficiente Serpieri secondo cui l’unità lavorativa femminile valeva il 60% di quella maschile. Nel 1930 la paga oraria per un bracciante era in media di 1,70, mente una donna guadagnava 1,15 lire ed un ragazzo 0,90 centesimi. Due anni dopo gli uomini avevano una paga di 1,55 lire, le donne 1,10 e i ragazzi 0,90 centesimi. In quegli anni anche l’agricoltura fu interessata dalla disoccupazione e le percentuali mostrano come le donne braccianti fossero fra le maggiormente colpite e, anche per questo, furono protagoniste di scioperi, così come era accaduto per le operaie. Le richieste riguardavano la necessità di avere un lavoro e una retribuzione adeguata. Ad esempio, il 17 aprile 1930 a Villa Argine Reggio Emilia, furono arrestate 12 ragazze perché accusate di aver cantato la strofa «Quando bandiera rossa si cantava, 30 lire al giorno si pigliava, ora che si canta Giovinezza, si va a letto con la debolezza».125 Nello stesso anno a Medicina e a San Biagio di Argenta vi furono altri scioperi ed occupazioni di terreni in maggioranza condotte da donne. Nell’agosto del 1932, per più di due giorni, duecentocinquanta mondine romagnole non si presentarono nei campi.126 Fra le lavoratrici agricole, la figura più idealizzata, più stereotipata e più presente nel sistema produttivo agricolo era la mondina della Val Padana e del delta del Po. La campagna del riso durava otto settimane e la mondina era una figura che difficilmente poteva essere integrata nell’immagine femminile che il regime voleva propagandare: ragazze e donne che lavoravano nell’acqua melmosa fino alle ginocchia, con le gambe nude, che in molti casi vivevano lontane da casa e che, a causa delle fatiche, dell’ambiente malsano avevano il più alto tasso di aborti spontanei di qualsiasi altro gruppo. La propaganda dipingeva queste donne, esposte alle condizioni a cui si è fatto cenno, come giovani spensierate che vivevano allegramente il loro lavoro. Ad esempio, nel 1925 sul settimanale dedicato alle mondine si poteva leggere una strofa di un canto composto sul tema di Giovinezza che recitava «Quando il sole la risaia/tutta infuoca di calor/la mondina fresca e gaia/canta i canti dell’amor».127 A cui pare fare da controcanto un’altra strofa, tratta dal repertorio tradizionale delle cante delle mondariso: «non badare se son smortina/È la risaia che mi rovina/Quando poi sarò a casa mia/I miei colori ritorneran/Non badare se io canto/La passione l’ho di dentro/Il mio cuore non è contento». 125 LUISA STEFANI, La donna nella Resistenza reggiana, «Ricerche storiche», a. IX, n. 2, luglio 1975, pp. 15-16. 126 MIRCA MODONI, Le donne nelle campagne, in Donne bolognesi nella Resistenza, Bologna, Tip. Moderna, 1975. 127 «La mondina. Settimanale della Federazione provinciale pavese della Corporazioni sindacali fasciste», giugno 1925, citato in V. DE GRAZIA, Le donne cit., p. 253. 156 Dal regime fascista agli anni Sessanta Il lavoro della monda occupava nelle risaie emiliano-romagnole un buon numero di mondine locali, mentre altre donne dovevano recarsi in Lombardia e in Piemonte, affrontando viaggi e soggiorni estremamente disagiati. Le retribuzioni giornaliere per le cosìddette mondine forestiere diminuirono alla fine degli anni Venti passando dalle 21,80 lire del 1926 alle 17,65 nel 1929 e alle 10,64 nel 1931. Solamente agli inizi degli anni Trenta – pare su suggerimento di Angiola Moretti – Augusto Turati fondò la Pro-assistenza mondariso, che coordinava le iniziative assistenziali private delle donne lombarde coi servizi sindacali e di partito: in quella primavera del 1930, le mondine che si dovevano allontanare da casa per recarsi sulle risaie furono accolte con servizi di ristoro lungo la strada.128 Gli anni 1930 e 1931 furono caratterizzati da lunghi scioperi, provocati proprio da questa progressiva diminuzione del salario.129 Nel 1931 vennero organizzati scioperi che coinvolsero più di duemila lavoratrici a Medicina,130 250 mondine nel faentino in agosto si ribellarono e si rifiutarono di lavorare oltre l’orario, furono organizzati degli scioperi anche in Piemonte dove si recavano moltissime donne emiliano-romagnole per richiedere aumenti di stipendio, brande con le quali sostituire la paglia su cui le donne erano costrette a dormire durante i 40 giorni della monda. Le mondine chiedevano, poi, di avere il latte la mattina, la carne almeno la domenica e la pasta che potesse, di tanto in tanto, sostituire il riso. Nel 1931 nel Novarese e nel Vercellese venne fatto uno sciopero di tre giorni che coinvolse le mondine emiliane e venete.131 Veniva stampato un foglio clandestino, «La Risaia» in cui si cercava di coinvolgere tutte le mondine nelle rivendicazioni. Numerosi furono, infine, i provvedimenti che il regime fascista prese in quegli anni verso le mondine, anche grazie alle proteste e agli scioperi. Nel 1933 fu concessa la riduzione del 75% del prezzo del viaggio per le mondine che dovevano spostarsi verso le risaie fuori dalla regione, nel 1935 venne stabilito che le mondine dovessero avere a disposizione una branda per la notte. Nel 1936 le spese per il viaggio furono addebitate ai proprietari e i trasporti venivano ora effettuati con vagoni passeggeri e non più su carri bestiame; nel 1937 furono pagate in più le ore straordinarie e le ore festive e il vitto migliorò.132 Per tenere più sotto controllo questa categoria di lavoratrici e per evitare gli scioperi e lo svilupparsi al loro interno di forme di avversione al regime, oltre ai provvedimenti di cui si è detto, vennero messe in atto azioni di propaganda. Per ciò lo stesso Starace cominciò a recarsi nelle zone dalla risaia, nel vercellese, in Lomellina e nella bassa padana, portando «i saluti di Mussolini» e somme da destinare all’assistenza. Ugualmente fecero i dirigenti locali e le donne delle organizzazioni fasciste. Sul piano giuridico, bisognò invece aspettare fino alla fine degli anni Trenta, per vedere qualche disposizione riguardante le mondine e tutte le lavoratrici agricole: con il decreto legge del 7 agosto 1936 si estesero i diritti di maternità alle lavoratri- 128 I. VACCARI, La donna nel ventennio fascista cit., p. 131. CAMILLA RAVERA, La donna italiana dal primo al secondo Risorgimento, Roma, Edizioni di Cultura sociale, 1951, pp. 127-129. 130 M. MODONI, Le donne nelle campagne cit., 1975, pp. 15-16. 131 DIANELLA GAGLIANI, Forme di protesta soggettività bracciantile in Emilia Romagna 1929-1939, in Geografia e forme del dissenso sociali in Italia durante il fascismo (1928-1934), a cura di Marinella Chiodo, 1990, p. 264. 132 LUIGI ARBIZZANI, Le lavoratrici delle campagne durante il fascismo e la Resistenza nella Valle Padana, «Annali Cervi», 13, Bologna, il Mulino,1991, pp. 228-231. 129 Il fascismo e la seconda guerra mondiale 157 Il segretario federale Franz Pagliani accompagnato dal segretario dell’unione fascista lavoratori dell’agricoltura, passa in rassegna alle mondine occupate nelle risaie del carpigiano, 1941 ca., fondo Bandieri, Fotomuseo Giuseppe Panini, Modena ci agricole e il 28 aprile 1938 le autorità sanitarie proibirono il lavoro in stato avanzato di gravidanza. Le donne della campagna, così come accadeva in città, affiancavano il lavoro fuori casa – della monda del riso, della raccolta della frutta e di tutti gli altri lavori caratteristici dell’economia agricola come la lavorazione della canapa – a quello svolto in casa, sovente senza nessuna regolamentazione. Il lavoro a domicilio era quindi, e lo fu anche in momenti successivi, un lavoro caratteristicamente femminile. Ancora una volta il fascismo vedeva in questo un lavoro adatto alle donne, perché fatto in casa, all’interno della famiglia, come un ausilio al guadagno del padre o del marito, senza quindi «sottrarre» posti di lavoro agli uomini con il vantaggio «morale» di evitare i contatti promiscui.133 La prima definizione legislativa del lavoro a domicilio avvenne nel 1924, ma, afferma Maria Vittoria Ballestrero, la legislazione fascista, in realtà, non proteggeva le lavoranti a domicilio, lasciando che questa occupazione continuasse a rappresentare una forma di super sfruttamento: il salario era molto basso, legato al cottimo. Molto spesso era lavoro, diremmo oggi, «in nero» visto che si evadevano i pur modesti obblighi previdenziali.134 Il lavoro a domicilio poteva essere di cucito, ricamo e tessitura, oppure poteva essere legato alla lavorazione dei prodotti agricoli, come la paglia o i trucioli. 133 PAOLO GRECO, Il lavoro a domicilio nell’ordinamento corporativo, «Il diritto del lavoro», 1928, I, p. 298. 134 MARIA VITTORIA BALLESTRERO, Dalla tutela alla parità: la legislazione italiana sul lavoro delle donne, Bologna, il Mulino, 1979, p. 81. 158 Dal regime fascista agli anni Sessanta Altri mestieri Negli anni Trenta più di un quarto della forza lavoro in Italia era rappresentata dalle donne e una donna su quattro fra i 14 e i 65 anni risultava attiva, fra queste, in città, molte erano impiegate nel piccolo commercio, soprattutto nel settore alimentare, della ristorazione, della merceria. Non disponiamo di studi particolareggiati su questo tema, ma a titolo di esempio si può ricordare come le donne fossero titolari, fra il 1926 e il 1939, del 27,9% degli esercizi commerciali.135 In Emilia nel 1921 il censimento registrava 16.644 donne e 63.384 uomini impiegati in questo campo. Nell’ambito della ristorazione venne emanato un decreto grazie al quale il prefetto poteva impedire alle donne l’accesso alla somministrazione di bevande alcoliche negli esercizi pubblici «anche se trattisi di esercizi nei quali la vendita al minuto o il consumo delle bevande alcoliche non costituisca prestazione unica od essenziale dell’esercizio». Il divieto, che non si applicava alla moglie del titolare, era emanato in nome della moralità e dell’ordine pubblico.136 Appartenevano alla categoria del commercio anche le titolari di laboratori di modisteria, sartoria e ricamo. Le donne erano presenti, fin dalla prima guerra mondiale, in uffici pubblici e privati, e il fascismo cercò di mantenerle in una posizione subordinata attraverso norme interne di sbarramento alla carriera: ricordiamo ad esempio il decreto ministeriale 29 febbraio 1928 che fissava nel grado di ragioniere del gruppo B il livello massimo conseguibile dal personale femminile nell’amministrazione dei Monopoli di Stato. Le segretarie, soprattutto quelle del settore pubblico, sovente erano accompagnate da ironia, fin da quando, nell’immediato dopoguerra, erano considerate delle inefficienti «usurpatrici» di posti di lavoro. Il perfetto vade-mecum della signorina impiegata è quella di assentarsi saltuariamente, di tanto in tanto, per alcuni giorni nessuno dei quali, beninteso, cade di domenica; e durante le ore di ufficio le operose attendono alla fabbricazione di fiori, e quelle a tendenza sentimentale a lettura intensiva dei romanzi di Guido da Verona od altri simili, con gite collettive per i corridoi, a chiacchierare con speciale considerazione per i fattacci del giorno.137 La terziarizzazione degli anni Trenta che, seppur non particolarmente incisiva, portò ad un aumento dell’occupazione femminile in questo settore, a fronte di una diminuzione di quella industriale, produsse qualche significativa concentrazione di impiegate soprattutto nelle grandi città e gli anni Trenta furono importanti per le donne negli impieghi privati, regolati dalla nuova legge sul contratto di impiego del 1924, che incise su un quadro normativo che sino ad allora era stato vago e indeterminato.138 Furono loro, le giovani o meno giovani segretarie d’azienda, le dattilografe, le elaboratrici di dati ai primi apparati di schedatura meccanica, le destinatarie e, al tempo 135 M. PALAZZI, Donne delle campagne e delle città: lavoro ed emancipazione cit., p. 401. Articolo 188 del regio decreto del 6 maggio 1940, n. 635 e prima ancora, articolo 101, comma 3, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 137 Atti Parlamentari Camera dei deputati, Leg. XXV, prima sessione, seduta del 25 febbraio 1921, p. 8144. Su questi temi si veda PATRIZIA FERRARA, Le donne negli uffici (1863-2002), in Impiegati, a cura di Guido Melis, Torino, Rosenberg & Sellier, 2004, pp. 125-162. 138 MARCO SORESINA, Mezzemaniche e signorine. Gli impiegati privati a Milano (1880-1939), Milano, Franco Angeli, 1992. 136 Il fascismo e la seconda guerra mondiale stesso le protagoniste, di romanzi e di film del così detto cinema dei telefoni bianchi, un genere d’evasione costituito da melodrammi romantici e commedie sofisticate di ambiente genericamente alto borghese, fra questi «Segretaria privata» di Goffredo Alessandrini. Una pellicola del 1931 dove la protagonista, una dattilografa di provincia, trova, con l’aiuto di un usciere, impiego in una banca di Roma ed è presa di mira dalle avances di un pedante capo del personale, mentre si innamora del direttore della banca: inevitabile il finale coronamento del sogno d’amore. Questo è forse uno dei primi film italiani sulla donna lavoratrice e uno dei primi a parlare di «molestie sessuali» sul lavoro. Dello stesso tema trattava, una decina di anni dopo, il romanzo di Luciana Peverelli, Sogni in grembiule nero dove Titti, una matura segretaria mette in guardia una giovane collega sulla possibile richiesta di favori sessuali in cambio di lavoro. Le donne impiegate nelle amministrazioni, pubblica e privata, erano il 14,5% della categoria, nel 1921 e nel 1931, essendo aumentate notevolmente rispetto al 1911 quando erano il 4,8%. Sul complesso della popolazione femminile erano nel 1921 e nel 1931 lo 0,3%. In Emilia gli impiegati uomini, nel pubblico e nel privato, erano 47.891 e 4066 le donne. Dieci anni dopo gli impiegati pubblici maschi erano 22.677, 1233 i privati, e le donne impiegate nel settore pubblico erano 3254 a fronte di 675 che lavoravano presso privati. Escludendo gli insegnanti e i militari. Nel comune di Bologna alla fine di gennaio 1937 su 2031 impiegati 429 erano donne, di cui 166 assunte in pianta stabile e 263 erano avventizie. Erano soprattutto bidelle, 187; 98 le insegnanti delle istituzioni integrative della scuola; 51 le maestre; 52 le vere e proprie impiegate, per la maggior parte nei gradini più bassi dell’amministrazione.139 Difficile era per le donne pensare di poter far carriera, ostacolate dalla mentalità comune e dalle leggi, come detto. Si scriveva su volumi e su giornali di come fosse innaturale per 139 159 Le telefoniste, vignetta «L’almanacco della donna italiana», 1925, Biblioteca Italiana delle Donne, Bologna LUCIANA PEVERELLI, Sogni in grembiule nero, «Mani di Fata», 1940, Collezione privata Bologna in cifre, «Bollettino del Comune di Bologna», n. 1, 1937, p. 34. 160 Dal regime fascista agli anni Sessanta la donna cercare di migliorare la propria posizione lavorativa. Gina Lombroso, medico e figlia di Cesare Lombroso, affermava che fare carriera era innaturale per la donna visto che l’indipendenza, economica e non solo, lasciava «inappagata la sete d’affetto (sete in lei naturale) – ed eccita l’insoddisfacente senso di ambizione (in lei non naturale) fa la donna moderna smoderatamente ambiziosa, assai più dell’uomo».140 Era d’altra parte ritenuto non così femminile studiare, laurearsi e poi pensare di poter impiegarsi in professioni legate ai propri studi. Leggiamo ancora le parole di Gina Lombroso La donna antica non poteva studiare, ma non doveva neppure subire la sequela di esami che ne tormenta oggi l’adolescenza. La donna antica non poteva spirare alla gloria, all’indipendenza ma il suo cervello non era mai sotto pressione, ma la carica a lei affidata corrispondeva ai suoi istinti. Una donna medico, avvocato, sarà inferiore nel cucinare e nel rattoppare alla giovane sposa incolta dedicatasi unicamente fin dall’infanzia a queste occupazioni.141 L’istruzione universitaria, sicuramente elitaria, era negli anni Venti e Trenta ancora prevalentemente a presenza maschile: nel 1921 era iscritto all’università italiana lo 0,5% delle ragazze fra i 20 e i 24 anni, contro il 2,5% dei maschi di pari età. Le poche donne che frequentavano le aule universitarie lo facevano soprattutto nelle facoltà umanistiche, il 47,4% e il 69,8% delle iscritte nel 1925 e nel 1936; mentre le facoltà tecnico-scientifiche registravano la presenza del 38,7%, nel 1925, e il 22,35 nel 1936. L’ambito umanistico più frequentato dalle donne era quello letterario, 39,8% e 62,6%. Le docenti erano pochissime e nel 1939 su 416 docenti delle quattro Università della nostra Regione le donne erano 9. Le donne laureate e diplomate avevano fondato nel 1920 la Fildis, Federazione italiana laureate diplomate istituti superiori, che, fino al suo scioglimento nel 1935, prese posizione contro le limitazioni poste all’impiego delle donne nella scuola, e nel 1929 inviò «al Ministero dell’Educazione Nazionale un’istanza tendente ad ottenere il ripristino dei diritti delle professoresse ad insegnare nelle scuole secondarie superiori ed un’altra al Capo del Governo con la richiesta di abrogare le limitazioni esistenti per la donna nella carriera amministrativa».142 Il giornalismo fu la professione intellettuale in maggior espansione negli anni tra le due guerre, in quanto sopravviveva una concezione letteraria del mestiere ed appariva, quindi, più adatto alle donne, anche se non erano certamente rare le critiche verso le donne scrittrici e giornaliste, anche su giornali locali, in cui forte era la preoccupazione per le sorti del «ragù e delle calze»: non si capisce perché mai tanta letteratura femminile sul mercato librario. Spuntan donne letterate, filosofe, sociologhe d’ogni parte. Son cose che non si spiegano o se mai potrebbero spiegarsi seguendo gli indici demografici e il numero dei matrimoni malandati. Il campo letterario non è stato mai messo tanto a rumore come in questi tempi da facinorose donne con la velleità violenta della carta stampata. Siamo sotto l’incubo d’una letteratura femminile a base di donne clorotiche, di Bovary in ritardo, di incomprese, di allucinate. Questi gli argomenti che 140 GINA LOMBROSO, La donna nella vita riflessioni e deduzioni, Bologna, Zanichelli, 1923, pp. 16-20. Ibidem. 142 FIORENZA TARICONE, La FILDIS e l’associazionismo femminile, in La corporazione delle donne ricerche e studi sui modelli femminili nel ventennio fascista, a cura di Marina Addis Saba, Firenze, Vallecchi, 1988, pp. 155-156 e 165. 141 Il fascismo e la seconda guerra mondiale 161 si succedono con una monotonia esasperante e con la complicità dolosa di critici ed editori sciocchi. Povere calze nostre, povero ragù, povero bucato.143 Fra le professioni – quella in cui più presenti erano le donne – erano quelle legate alla sanità, come si è visto. In quest’ambito le donne medico e dentiste erano molto poche: nel censimento del 1921 gli uomini medici erano 28.714, le donne 613. I dentisti 1497, le donne che facevano questa professione 244. In Emilia-Romagna 2012 i medici; 133 le donne medico; 78 i dentisti; 3 le dentiste. Dieci anni dopo, nel Regno d’Italia i medici erano 32155; 795 le donne che esercitavano questa professione; 861 i dentisti e 30 le dentiste. In Emilia 2302 i medici e 54 le dottoresse; 26 dentisti e nessuna donna. Nell’ambito della eccezionalità donne come Maria Bortolotti, ingegnere e direttrice di cantiere o le donne architetto. Alcune fasciste protestarono poi perchè le donne erano scarsissimamente rappresentate nel Consiglio superiore delle corporazioni; unica eccezione la già citata Vittoria Maria Luzzi della Corporazione delle ostetriche. Il ministro per le Corporazioni, Giuseppe Bottai, nel 1931 nominò come prima delle tre consigliere donne Adele Pertici Pontecorvo, esperta di diritto del lavoro e fautrice dei diritti delle donne, che in Italia era stata la prima donna notaio. I littoriali del lavoro femminile Dal 1934 vennero organizzati i littoriali, ovvero gare universitarie di cultura e di sport che coinvolgevano solo gli studenti maschi: nel 1939 i littoriali si aprirono alle donne e in quello stesso anno furono organizzati anche i littoriali del lavoro. La partecipazione femminile era rigorosamente separata da quella maschile, così come era giudicato conveniente per tutti i momenti educativi e ricreativi, per evitare la «promiscuità».144 Nel caso dei littoriali della cultura, verrebbe da dire che la separazione delle gare poteva essere messa in atto per non porre in diretta competizione rappresentati di studenti e di studentesse; in effetti, le opere femminili, nell’edizione di Trieste– dove per la prima volta le donne erano presenti – vennero esposte separatamente in un apposito salone. E di là si entra nel regno della donna, dove, con ogni avvenimento che non ci dispiace, si sono collocate anche le pitture e le sculture di tante giovani italiane. Certamente talune di queste opere, per la bravura, meriterebbero di essere considerate maschie, e di andarsene, temibili esuli, nelle altre sale; ma infine sono di donne.145 Opere talmente belle da essere definite «maschie». I littoriali femminili della cultura si occupavano di temi «da donne», ovvero «adatti alle attitudini naturali della donna. Si parlerà dei compiti della donna nella scuola, nelle colonie, per il prestigio della razza nell’economia rurale; della maternità in arte; di problemi di moda».146 143 «Il popolo di Romagna», 16 gennaio 1932, p. 3, citato in I. VACCARI, La donna nel ventennio fascista cit., p. 117. 144 PIETRO CAPORILLI, L’educazione giovanile nello stato fascista, Roma, Sapientia, 1930, passim. 145 Alla mostra dei Littoriali, «Il piccolo», 28 marzo 1939, citato in Cultura a passo romano storia e strategie dei Littoriali della cultura e dell’arte, a cura di Ugoberto Alfassio Grimaldi, Marina Addis Saba, Milano, Feltrinelli, 1983, p. 149. 146 Cultura a passo romano cit., p. 156. 162 Dal regime fascista agli anni Sessanta Nel 1939 fu deciso di affiancare ai littoriali della cultura e dello sport quelli del lavoro, maschili e femminili, sempre organizzati dagli universitari. Le concorrenti si sarebbero dovute affrontare in una prova generale di cultura fascista, ed una prova tecnica riservata ai vari settori produttivi e cioè: agricoltura (per mondine, raccoglitrici di olive, massaie rurali che si dedicano all’allevamento del baco da seta o all’allevamento di animali da cortile), industriali (riservato alle lavoratrici dell’industria dolciaria, alle lavoranti sarte, alle lavoranti ceramiste), commercio (per le stenografe, dattilografe, lavoratrici ortofrutticole), artigianato (per merlettaie, ricamatrici in oro, camiciaie).147 Questi primi littoriali si sarebbero tenuti a Catania, quelli maschili, e a Venezia, quelli femminili. Nel 1941, quando i littoriali si tennero a Pisa, vennero introdotti concorsi riguardanti la preparazione della donna alla vita domestica, ovvero «gare per la preparazione della donna alla vita famigliare. La casa operaia e la casa rurale». Le gare di selezione comunale si tennero fra il 1º e il 15 gennaio 1941, il mese successivo i pre-littoriali e i littoriali si sarebbero svolti dal 3 al 12 marzo.148 I pre-littoriali femminili, così come quelli maschili, si svolsero in ogni Comune capoluogo di provincia con la partecipazione complessiva di 17.018 donne, 5402 in più rispetto all’anno precedente, almeno a seconda di quanto si legge sulle pubblicazioni ufficiali. A Ferrara si presentarono 296 concorrenti, a Forlì 37, a Parma 92, a Piacenza 93, a Reggio Emilia 22, a Ravenna 51. Infine Bologna vide la partecipazione ai pre-littoriali di 529 lavoratrici. Durante le gare di selezione le concorrenti dovevano affrontare una prova orale di «cultura fascista» allo scopo di accertare la loro conoscenza della vita politica del Paese e dell’Impero (autarchia, protezione della madre e del fanciullo, assistenza alle famiglie dei richiamati, preparazione spirituale e mobilitazione civile, preparazione alla vita domestica e alla lotta contro gli sprechi, preparazione alla vita coloniale, tutela della donna lavoratrice e provvidenze del Regime per le famiglie dei lavoratori) sempre in rapporto alla posizione e alla funzione della donna nella vita nazionale.149 A Pisa il concorso per lavoratrici ortofrutticole venne vinto da una dipendente del Consorzio agrario provinciale di Ferrara. La classifica finale di questa competizione vide Bologna arrivare seconda con 57 punti e quindi Modena tredicesima, Ferrara quindicesima, Ravenna ventiduesima e Piacenza subito dietro Parma trentaquattresima. Forlì e Reggio Emilia furono rispettivamente cinquantacinquesima e cinquantasettesima. In aprile si tenne poi a Milano la mostra dei Littoriali maschili e femminili del lavoro dove vennero esposti i lavori prodotti durante i littoriali. Grande enfasi, grande retorica sui littoriali quando l’Italia era già entrata in guerra. L’anno successivo i littoriali si tennero a Salsomaggiore e a Fidenza, con la stessa organizzazione, con altri tipi di lavori su cui gareggiare: 147 «Il Resto del Carlino», 20 novembre 1939. PNF - GUF, Littoriali maschili e femminili del lavoro: Torino-Pisa-Milano, marzo-aprile-maggio 1941, Bologna, Società Anonima Poligrafici Il Resto del Carlino, 1941. 149 Ibidem. 148 Il fascismo e la seconda guerra mondiale 163 Le gare più rapide sono state quelle dell’erboristeria e delle cravatte. L’erboristeria è una materia nuovissima per i Littoriali, ma ha raccolto un folto gruppo di concorrenti. Compito delle cravattaie era invece quello di comporre una cravatta nel tempo massimo di mezz’ora e in omaggio a questi tempi guerrieri, le cravatte erano tutte in grigio verde, da soldato. Ma la lotta scenicamente più movimentata e interessante si è avuta nel corso delle magliaie. Il locale era stato trasformato in una nitida e ronzante officina. La prima a finire il compito è stata una giovane fascista di Forlì.150 Negli articoli sui giornali veniva sottolineato il «fervore» con cui le giovani partecipavano alle gare, riprendendo amplificando i temi della propaganda fascista; ad esempio si pone sotto la luce dei riflettori il ruralismo e il lavoro agricolo femminile. Ai temi soliti si aggiungeva quindi la mobilitazione del fronte interno e delle donne chiamate a sostituire gli uomini nel lavoro: «Resto del Carlino», 6 marzo 1943, Biblioteca comunale dell’Archiginnasio, Bologna. e così appare sempre più manifesta l’importanza di queste gare del lavoro femminile agricolo specie in questi tempi nei quali l’uomo diserta il campo per procurane altri più vasti e tanto necessari al lavoro e all’esistenza dei suoi figli. È la donna che resta nella casa e sul campo che moltiplica se stessa per sopperire alle deficienze della mano d’opera, per riempire i vuoti. Oggi il pollaio, la conigliera, domani, se sarà necessario la stalla e il gregge: ora l’orto, domani, il campo; non ha limiti la fatica quando la sorregge e la fortifica l’amore. Amore per la terra benedetta, amore per l’uomo che la difende, perché egli possa un giorno ritrovarla tutta curata, feconda come il grembo della sua compagna.151 Nel marzo 1943 si tennero i pre-littoriali del lavoro e «Il Resto del Carlino» ne diede notizia, corredata dalle fotografie delle partecipanti delle gare ortofrutticole e dei lavori domestici.152 Qualche mese dopo l’Italia si sarebbe trovata ad affrontare l’armistizio. Donne in guerra Nel 1925 fu approvata la prima legge sull’Organizzazione della Nazione per la guerra153 che definiva le modalità e i principi secondo i quali tutte le attività del paese si sarebbero trasformate per sostenere la produzione bellica e per garantire la continuità 150 «Il Resto del Carlino», 24 marzo 1942. MIRO ZORZI, Fotocronaca delle gare Littoriali, Ricordi di Salso, «Architrave», numero speciale per i littoriali del lavoro anno XX. 152 «Il Resto del Carlino», 6 e 10 marzo 1943. 153 Legge 8 giugno 1925, n. 969. 151 164 Dal regime fascista agli anni Sessanta della vita civile. Nel 1931 seguì la Disciplina dei cittadini in tempo di guerra,154 in cui erano elencati i compiti che spettavano alla donna durante il conflitto: la mobilitazione civile prevedeva la sostituzione del personale delle amministrazioni, industrie, servizi e aziende, necessaria per affrontare l’assenza degli uomini chiamati al fronte e l’assistenza ai combattenti. Per questo fu istituito un elenco di donne professioniste. Secondo quanto riportato dall’«Almanacco della donna» nel 1936 le professioniste censite erano 180 avvocatesse procuratrici; cinque notaie; 795 «medichesse»; 30 dentiste; due veterinarie; 195 «ingegneresse chimiche»; 13 architette; 391 giornaliste e 134.985 insegnanti.155 A queste si dovevano poi aggiungere le operaie, le donne occupate in agricoltura, le impiegate nelle amministrazioni e nel commercio. Già nel 1936, erano state organizzate squadre di volontarie. Squadre specialiste in servizi tecnici (laureate in ingegneria, in matematica, chimica, fisica, astronomia, nonché tutte quelle donne che hanno diplomi speciali come: radiotelegrafiste, telefoniste, e rami tecnici in genere. Squadre di ausiliarie di pronto soccorso, medichesse, farmaciste e coloro che hanno seguito corsi speciali per il pronto soccorso in caso di difesa aerea. Squadre di automobiliste per trasporti di carattere vario. Squadre di propagandiste, laureate in legge, lettere, giornalisti, scrittrici, conferenziere, da adibirsi a tutti i lavori di propaganda e di informazione. Squadre di ordine, costituite da donne che abbiano un certo prestigio, per cooperare alla vigilanza dei rifugi, affinché non si diffonda il panico e nell’espletamento di tutte quelle manifestazioni che possano rendersi necessarie.156 La mobilitazione delle donne in vista del conflitto non si interruppe e anzi si intensificò quando ormai la seconda guerra mondiale era alle porte dell’Italia. Il 30 novembre 1939 si tenne a Bologna il primo convegno nazionale sui compiti della donna fascista in guerra.157 Il 5 giugno 1940 i giornali diedero notizia dei provvedimenti varati dal Consiglio dei ministri. Fra questi un «disegno di legge concernente la assunzione di personale femminile e di pensionati per assicurare il funzionamento dei servizi civili». Venne quindi disposto che per sostituire il personale maschile delle pubbliche amministrazioni richiamato alle armi si potesse, in deroga alle limitazioni che erano presenti, assumere delle donne.158 Nel febbraio 1943 gli uomini impiegati nei teatri e nei cinematografi, con qualche eccezione riguardanti i mutilati di guerra e gli anziani, vennero sostituiti da personale femminile.159 Non stupisca che in piena guerra, con le città soggette a bombardamenti, si parli di spettacoli e cinematografi; in effetti erano ancora in funzione questi locali: a Bologna, ad esempio, esistevano nel 1940 ventitre sale cinematografiche e cinque teatri, anche se in periodo bellico ne funzionava regolarmente un numero minore.160 Un altro settore in cui le donne furono chiamate a sostituire gli uomini, fu quello dei trasporti, urbani e ferroviari, dove le donne vennero assunte come fattorini e bigliettaie.161 154 Legge 14 dicembre 1931, n. 1699. «L’Almanacco della donna italiana», 1936, pp. 51-52. 156 Ibidem. 157 «Il Resto del Carlino», 30 novembre 1939. 158 «Il Resto del Carlino», 5 giugno 1940. 159 «Il Resto del Carlino», 7 marzo 1943. 160 ANGELA VERZELLI, Vivere nonostante tutto, Bologna 1938-1945. Guida ai luoghi della guerra e Resistenza, Bologna, Aspasia, 2005, p. 59. 161 «Il Resto del Carlino», 7 marzo 1943. 155 Il fascismo e la seconda guerra mondiale 165 Problemi si verificarono anche a livello delle strutture ospedaliere, soprattutto per quanto riguarda il personale paramedico, in cui ancora alta era la percentuale maschile. Se infatti i medici potevano ottenere dispense per rimanere nel loro ospedale, così non era per infermieri, portantini e per i paramedici. La loro sostituzione con personale femminile era complessa, più complessa di quella che avveniva per altri settori visto che serviva una preparazione specifica non acquisibile con corsi di poche ore: si affiancarono così al personale religioso, come detto molto presente in questo campo, le volontarie della Croce Rossa, a cui si chiesero turni suppletivi per l’emergenza bellica.162 Nell’ambito dell’assistenza vennero mobilitati, e non potrebbe essere altrimenti, anche i Fasci femminili, che furono impegnati nella distribuzione dei sussidi, nell’assistenza alle famiglie e alle vedove e agli orfani di guerra. Il campo in cui si impegnarono fu anche quello rivolto ai feriti e ai soldati, con visite agli ospedali, l’organizzazione delle «madrine di guerra», l’invio di pacchi al fronte, l’organizzazione di posti di ristoro alla stazione per i militari in transito, l’istituzione della befana del soldato, che si affiancava alla befana fascista rivolta, negli anni precedenti, ai bambini, nella nota commistione fra assistenza e propaganda.163 La mobilitazione coinvolgeva, evidentemente, anche le industrie, che in alcuni casi si trasformarono in industrie di guerra ed in altri aumentarono la loro produzione che era ora destinata alla produzione bellica. Alla fine del biennio 1940-1941 la presenza delle donne nelle fabbriche bolognesi impiegate nella produzione bellica ebbe un incremento del 100% rispetto agli inizi del 1940. In quattro delle 30 aziende con produzione bellica, il numero delle donne si avvicinava o superava quello degli uomini: alla Baschieri e Pellagri di Marano di Castenaso e alla Fratelli Bassi, due polverifici e alla Ducati che produce condensatori e apparecchi radiotrasmittenti per le forze armate. Alla Giordani che costruiva ora anche minuterie e arredi per l’esercito e involucri per mine e bombe a mano le donne erano 420 e 108 gli uomini.164 Le condizioni economiche peggiorarono con l’avanzare della guerra, le donne si trovarono, sempre più sole, a dover affrontare i razionamenti e i danni della guerra. I salari delle operaie e delle donne che lavoravano in campagna non erano sufficienti e questa fu la molla che fece scattare numerosi scioperi in tutta la Regione. Difficile riuscire a dare conto di tutti gli scioperi che vennero organizzati, in realtà grandi e piccole, in città e in campagna, in quel primo biennio di guerra. A solo titolo di esempio ricordiamo gli scioperi delle mondine del 1940. Negli anni successivi numerose furono poi le proteste delle operaie.165 La guerra aveva scalfito sia il consenso che la credibilità del regime: si era persa la fiducia nello Stato. Ciò è evidente sia a livello della provincia di Bologna166 che in tutta la nazione,167 si stava sviluppando una specie nuova di antifascismo, che non era più l’antifascismo politico degli anni Venti, ma un antifascismo che potremmo definire di 162 FIORENZA TAROZZI, Organizzazione sanitaria e malattie, in Bologna in guerra 1940-1945, in Bologna in guerra 1940-1945, a cura di Brunella Dalla Casa, Alberto Preti, Milano, Franco Angeli, 1995, p. 276. 163 «La fiamma», n. 1, 15 giugno 1941. 164 LORENZO BOLELLI, L’industria bolognese attraverso il fondo dell’Ispettorato regionale del lavoro, in Bologna in guerra 1940-1945 cit., pp. 210-211. 165 I. VACCARI, La donna nel ventennio fascista cit., pp. 173-180. 166 Cfr A. PRETI, Spirito pubblico, fronte interno e carte di Polizia, in Bologna in guerra cit. 167 AURELIO LEPRE, Le illusioni, la paura, la rabbia, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1989. 166 Dal regime fascista agli anni Sessanta guerra. Pane e pace erano le rivendicazioni più presenti nelle manifestazione delle donne che, dall’armistizio in poi, si fecero sempre più presenti. La situazione diviene sempre più drammatica fino ad arrivare all’8 settembre, quando cominciarono anche a formarsi i primi nuclei della Resistenza. La più ampia ondata di scioperi, maschili e femminili, si ebbe nel 1944, durante l’occupazione nazista, sia nelle campagne che nelle città. La piattaforma rivendicativa prevede la riduzione dell’orario di lavoro, aumenti salariali, la distribuzione di generi alimentari, ma si chiedeva anche la fine della guerra. Le donne, a questo punto, organizzate dai partiti e nei gruppi di difesa della donna cominciarono ad impegnarsi nella lotta di resistenza, in cui agli scioperi, ora con valenze anche politiche, si affiancarono tutte le azioni e i compiti che le donne portarono avanti in questo periodo, come si può leggere anche nei giornali clandestini e nei volantini scritti dalle e per le donne.168 La mobilitazione femminile fascista continuò anche nella Repubblica sociale e Piera Gatteschi Fondelli, fascista della prima ora, propose di costruire un «corpo ausiliario femminile» in cui organizzare le donne e «meglio concretare le iniziative sorte dallo spirito patriottico femminile». La Gatteschi Fondelli riteneva di dover dividere le volontarie in tre categorie, in base ai mestieri e alle professioni: Gruppo 1: pulitrici, serventi alle mense, lavandaie, aiutanti sarte, cuciniere, autiste. Gruppo 2: magazziniere: casermaggio, vestiario, viveri; avvistamento contraereo, dattilografe, telefoniste centraliniste, aiutanti di sanità. Terzo gruppo: telegrafiste, marconiste, disegnatrici, interpreti, segretarie di comando, infermiere.169 Fu fondato il Saf, Servizio ausiliario femminile. Secondo il decreto legislativo firmato da Mussolini il 18 aprile 1944, questo servizio ausiliario era costituito da Volontarie per i servizi ospedalieri: le infermiere ausiliarie diplomate nei corsi istituiti dai Gruppi Femminili del Pfr [Partito fascista repubblicano] d’intesa con la Cri e il personale femminile di fatica addetto agli ospedali Volontarie per i servizi militari: le addette, con qualsiasi incarico e mansioni, ai lavori di ufficio e di servizio presso i comandi militari, caserme, preside, depositi. Volontarie per i posti di ristoro: le donne che svolgono le loro attività nei posti mobili dell’immediato retrofronte, elle località di transito delle truppe, nelle cucine e nei refettori presso i reparti militari Volontarie per la difesa contraerea: le aerofoniste, le marconiste, utilizzate per i servizi di difesa contraerea.170 Tra i loro compiti c’era anche quello definito «casalingo» di tener in ordine e rammendare le uniformi dei combattenti. Il fascismo non voleva che si dimenticasse completamente il ruolo della donna di casa. 168 «La compagna», 15 gennaio 1945. LUCIANO GARIBALDI, Le soldatesse di Mussolini con il memoriale inedito di Piera Gatteschi Fondelli, generale delle ausiliarie della Rsi, Milano, Mursia, 1997, p. 109. 170 Ivi, pp. 111-113. 169 Il secondo dopoguerra e gli anni Cinquanta Votare ed essere votate. Donne sulla scena pubblica Scriveva Maria Bellonci: «2 giugno di sera, in una cabina di legno povero e con in mano un lapis e due schede mi trovai all’improvviso di fronte a me, cittadino».1 E fu proprio questo l’evento caratterizzante il dopoguerra e la nascita della Repubblica italiana. Le donne avevano chiesto il diritto di voto fin dall’Ottocento e, dopo il ventennio fascista in cui questa richiesta era stata sopita, durante la guerra ripresero con forza a rivendicare la piena cittadinanza. A Roma il 7 ottobre 1944 grazie all’iniziativa della Commissione per il voto alle donne dell’Unione donne italiane, dell’Alleanza femminile Pro Suffragio e della Fildis, fu presentato al governo Bonomi un documento in cui veniva ribadita l’assoluta necessità del suffragio femminile.2 Qualche giorno dopo, il 25 ottobre, sempre a Roma fu costituito dalle rappresentanti dei movimenti femminili dei partiti presenti nel Comitato di Liberazione Nazionale il Comitato pro voto a cui aderirono anche le donne della Federazione italiana laureate e diplomate istituti superiori e dell’Alleanza pro suffragio. Marisa Rodano affermava che l’attività del Comitato fosse necessaria ma ben poca cosa visto che in realtà «il diritto di eleggere e di essere elette le donne italiane se lo stessero conquistando combattendo nell’Italia occupata». Su «Noi donne», giornale dell’Unione donne italiane (Udi), venne pubblicata una petizione rivolta al governo di liberazione nazionale. Contro il fascismo e contro l’oppressore tedesco abbiamo lottato accanto ai nostri uomini, con tenacia e coraggio nei duri mesi della occupazione. Sentiamo di esserci così acquistato il diritto di partecipare pienamente all’opera di ricostruzione del nostro paese. Confidiamo pertanto che la nostra legittima aspirazione sia presa in esame dagli uomini di Governo e sia finalmente resa alle donne d’Italia quella giustizia e quella eguaglianza di diritti che è alla base di ogni ordinamento veramente democratico.3 Intanto, nell’Italia occupata, all’interno dei gruppi di difesa della donna si discuteva del diritto di voto tanto che il decreto che lo sancì, ebbe una vastissima eco sui giornali clandestini. Allo stesso tempo, sui giornali della Repubblica di Salò questa decisione venne accolta con una ironia direi sprezzante, sostenendo che il voto alle donne non 1 Il 1946 di Maria Bellonci, Processo al 1946, numero speciale di «Mercurio», p. 172. Tra le firmatarie: Rita Montagnana Togliatti, Bastianina Musu Martini, Giuliana Nenni, Marisa Cinciari Rodano, Josette Lupinacci e Libera Levi Civita. 3 Petizione da far firmare dal maggior numero di donne possibile e da far approvare in apposite assemblee, riunioni, comizi femminili. «Noi Donne - Rivista quindicinale dell’Unione delle Donne Italiane», anno I, n. 7, Roma, 1º dicembre 1944. 2 168 Dal regime fascista agli anni Sessanta era un tema né urgente né interessante visto che le donne erano più protette da un regime come quello fascista piuttosto che nell’Italia liberata. «Il Resto del Carlino» scriveva che «mentre si muore di fame ci si preoccupa del voto alle donne».4 Vi era poi chi, come Mario Borsa su «Il Corriere dell’informazione», che affermava come le italiane il voto se lo fossero «visto offrire senza aver fatto nulla o ben poco per ottenerlo», contraddicendo e negando le iniziative e le rivendicazioni a cui noi abbiamo fatto brevemente cenno. Non tutti i politici dell’Italia libera erano d’accordo nel riconoscere il diritto di voto alle donne, qualcuno riprendeva vecchie convinzioni quali quella che, facendo votare una donna, sarebbe stato come dare due voti al marito perché, inevitabilmente, la donna avrebbe votato seguendo le indicazioni dell’uomo di casa. Ci si interrogava se le donne fossero progressiste o conservatrici, se avrebbero votato ascoltando il marito o il sacerdote, dimenticando la possibilità che le donne avessero una loro opinione politica. Il decreto legislativo luogotenenziale del 1º febbraio 1945, n. 23 – Estensione alle donne del diritto di voto – fu adottato in extremis nel Consiglio dei ministri presieduto da Ivanoe Bonomi il 30 gennaio, giorno dell’entrata in vigore delle disposizioni date ai Comuni dell’Italia liberata per la formazione delle liste elettorali per le amministrative. Prima di vedersi riconoscere il diritto di voto, amministrativo e politico, le donne avevano già ricoperto ruoli pubblici: dapprima nelle repubbliche partigiane, poi partecipando ai lavori della Consulta, l’assemblea transitoria costituita nell’aprile 1945. I membri della Consulta erano 455 designati dai partiti del Comitato di liberazione nazionale, fra questi vi erano 13 donne: cinque designate dal partito comunista (Adele Bei, Teresa Noce, Rina Picolato, Elettra Pollastrini, Gisella Della Porta), tre da quello socialista (Clementina Calligaris, Jole Lombardi e Claudia Maffioli), due erano le democristiane (Laura Bianchini e Angela Cingolani Guidi), due le azioniste (Bastianina Martini Musu e Ada Marchesini Gobetti) e una liberale (Virginia Minoletti Quarello). Rina Picolato, sarta di Torino, organizzatrice dei Gruppi di difesa della donna scriveva sulle pagine di «Noi Donne» del 31 agosto 1945: «le donne porteranno un contributo concreto alle riunioni della Consulta, sollevando e discutendo i problemi dell’infanzia, della scuola, i problemi così complessi dell’assistenza, quello gravissimo dell’alimentazione», temi che, come vedremo, furono proprio quelli più frequentati nell’agire politico e sociale delle donne. Per la prima volta nelle aule del parlamento italiano nella seduta del 1º ottobre 1945 parlò, una donna Angela Cingolani Guidi e lo fece sottolineando la difficoltà che trovavano le donne ad entrare nelle istituzioni e nei luoghi della politica. Ardisco pensare, pur parlando col cuore di democratica cristiana, di poter esprimere il sentimento, i propositi e le speranze di tanta parte di donne italiane: credo proprio di interpretare il pensiero di tutte noi consultrici, invitandovi a considerarci non come rappresentanti del solito sesso debole e gentile, oggetto di formali galanterie e di cavalleria di altri tempi, ma pregandovi di valutarci come espressione rappresentativa di quella metà del popolo italiano che ha pur qualcosa da dire (applausi), che ha lavorato con voi, con voi ha sofferto, ha resistito, ha combattuto, con voi ha vinto con armi talvolta diverse, ma talvolta simili alle vostre e che ora con voi lotta per una democrazia che sia libertà politica, giustizia sociale, elevazione morale. (approvazioni – applausi). Colleghi Consultori, nel vostro applauso ravviso un saluto per la donna che per la prima volta parla in quest’aula. Non un applauso dunque per la mia persona, ma per me quale rappresentante delle donne italiane che ora, per la prima volta, partecipano 4 «Il Resto del Carlino», 31 gennaio 1945. Il secondo dopoguerra e gli anni Cinquanta 169 alla vita politica del Paese. […] Parole gentili, molte ne abbiamo intese nei nostri riguardi, ma le prove concrete di fiducia in pubblici uffici non sono molte in verità. Qualche assessore come la collega Velletri, qui presente, una Vicesindaco come la nostra di Alessandria e qualche altro incarico assai, assai … sporadico. Nonostante dubbi, tentennamenti, scarsa fiducia nella determinazione delle donne e nella loro capacità di esercitare il loro diritto al voto, la loro partecipazione alle elezioni fu molto alta: il 2 giugno le votanti rispetto alle aventi diritto, che erano il 52,2% dell’intero elettorato, furono l’89%, con una differenza irrilevante rispetto agli uomini, per i quali il dato corrispondente fu dell’89,2%. Dobbiamo ricordare che anche per molti uomini le elezioni del 2 giugno furono il primo incontro con la libera espressione di voto. Si presentarono in quella occasione 51 liste: 36 non ottennero alcun seggio, la democrazia cristiana ebbe il 35,2% dei voti che corrisposero a 207 seggi, il partito socialista il 20,7% e 115 seggi, il partito comunista il 19% e 104 seggi, l’unione democratica nazionale 6,8% e 41 seggi e il fronte dell’uomo qualunque 5,3% e 30 seggi, il partito repubblicano ebbe il 4,4% e 23 seggi. Non furono molte le donne presenti nelle liste: il partito che presentò il più alto numero di donne fu quello comunista, 68 candidate, seguito da quello democristiano con 30 e da quello socialista con 16. Le elette alla Costituente, su un totale di 556 deputati, furono 21: nove erano della democrazia cristiana e del partito comunista; due del partito socialista e una dell’uomo qualunque. Ai fini di un più efficiente svolgimento del proprio lavoro, l’Assemblea deliberò la nomina di una Commissione per la Costituzione, composta di 75 membri scelti dal presidente sulla base delle designazioni dei vari gruppi parlamentari in modo da garantire la partecipazione della totalità delle forze politiche, con l’incarico di predisporre un progetto di Costituzione da sottoporre al plenum dell’Assemblea. Le donne fra i 75 membri della Commissione furono: Maria Federici, Lina Merlin, Teresa Noce e Nilde Iotti, il 6 febbraio 1947 si aggiunse Angela Gotelli. Durante i lavori dell’Assemblea vennero affidati alle parlamentari temi, ancora una volta, considerati femminili: l’assistenza, la scuola, la cura: nella Commissione dei Settantacinque o in seduta plenaria, esse parlarono di assistenza in 145 occasioni, di famiglia in 146, di istruzione in 147, di pace in 148, di donne lavoratrici in 149, di donne nei pubblici uffici 150. A questo stato di fatto vi furono due sole eccezioni: il 1° febbraio 1947 Nilde Iotti parlò alla Commissione dei Settantacinque di autonomie locali e il 3 maggio Angela Cingolani Guidi intervenne in Assemblea in materia di partecipazione dell’Italia ad organizzazioni internazionali. Bisogna annotare come, anche negli interventi pubblici, durante i comizi vi era una sorta di suddivisione informale degli argomenti da trattare: agli uomini spettavano quelli più prettamente politici ed alle donne quelli inerenti la ricostruzione e l’assistenza. Come se alle donne fosse tacitamente, o meno, proibito, o per lo meno sconsigliato, partecipare a dibattiti su altri temi non «femminili», nei comizi o in parlamento.5 Una situazione questa che si protrasse per lungo tempo anche nelle amministrazioni locali, possiamo infatti affermare che, almeno fino ai mandati amministrativi degli anni Ottanta, alle donne, consigliere o assessori, si affidavano quasi esclusivamente incarichi legati proprio a questi temi: l’assistenza, la beneficenza, e, a volte, la scuola; in un portare al di fuori delle mura domestiche quel lavoro di cura che è affidato, tra5 ANNA GAROFALO, L’Italiana in Italia, Bari, Laterza, 1956, p. 105. 170 Dal regime fascista agli anni Sessanta dizionalmente, alle donne.6 L’impegno delle donne divenne quindi, per utilizzare le parole di Anna Rossi Doria una «politicizzazione dei ruoli tradizionali».7 Nella Costituzione italiana possiamo rintracciare vari articoli che riguardano in modo specifico le donne e in particolar modo l’eguaglianza con l’uomo anche nel campo del lavoro. Prima di tutto vi è l’articolo 3 in cui si enuncia il principio di pari dignità sociale e dell’eguaglianza di fronte alla legge «senza distinzione di sesso»: fu proprio una donna, la socialista Lina Merlin a proporre l’introduzione di questo termine, temendo che l’uso di «cittadino» per comprendere entrambi i generi, maschile e femminile, non garantisse davvero l’eguaglianza e la parità: molti di voi sono insigni giuristi e io no, però conosco la storia. Nel 1789 furono solennemente proclamati in Francia i diritti dell’uomo e del cittadino, e le costituzioni degli altri paesi si uniformarono a quella proclamazione che, in pratica, fu solamente platonica, perché cittadino è considerato solo l’uomo con i calzoni, e non le donne, anche se oggi la moda consente loro di portare i calzoni Insisto sul mio emendamento anche in vista degli sviluppi d’ordine legislativo che ne seguiranno.8 Teresa Mattei chiese che nell’articolo 3, al secondo comma, fosse aggiunto «di fatto».9 L’articolo 37 è un ulteriore articolo in cui viene sancita la parità di trattamento tra lavoratori maschi e femmine.10 Angelina Merlin in terza sottocommissione aveva proposto un testo diverso da quello poi approvato.11 Dopo la discussione venne poi posto all’attenzione dell’Assemblea un articolo, elaborato da Maria Federici, il cui primo comma recitava: «La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore». Se la sua approvazione non diede luogo ad alcuna discussione, il dibattito si fece vivace quando fu posto all’attenzione e alla discussione il secondo comma: «Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione». Le polemiche si concentrarono proprio sul termine «essenziale» voluto da Aldo Moro.12 Il deputato liberale Roberto Lucifero lesse nell’«essenziale» un «freno al fenomeno dilagante dell’immissione della donna nel campo sociale, politico e del lavoro», e questo non fece altro se non confermare, alle comuniste, i loro timori e perplessità che questo insistere sulla maternità come funzione essenziale della donna potesse essere un freno ed un condizionamento per le donne.13 6 A. VERZELLI, Il voto alle donne, Tempi moderni, Bologna, 1989. ANNA ROSSI DORIA, Diventare cittadine. Il voto alle donne in Italia, Firenze, Giunti, 1996, p. 86. 8 Citato in A. ROSSI DORIA, Diventare cittadine. Il voto alle donne in Italia cit., p. 14. L. MERLIN, La mia vita cit., pp. 93-94 9 TERESA MATTEI, Difendiamo la Costituzione!, discorso pronunciato a Cinisello Balsamo il 26 aprile 2004, pp. 6-7. 10 Sul dibattito relativo all’articolo 37 si veda anche VITTORIA BALLESTRERO, Dalla tutela alla parità cit., pp. 109-128. 11 «Alla donna sono riconosciuti, nei rapporti di lavoro, gli stessi diritti che spettano ai lavoratori. La remunerazione di ogni cittadino, sia uomo, sia donna, deve assicurargli un’esistenza dignitosa, tenuto conto del carico familiare». 12 ALDO MORO, in Atti dell’Assemblea Costituente cit., pp. 203, 207, 208, citato in BRUNELLA MANOTTI, Le donne alla Costituente, Repubblica, Costituente e voto alle donne, Atti del convegno Prefettura di Parma, Università degli Studi di Parma, Parma, Battei, 2007. 13 ANNAMARIA GALOPPINI, Il lungo viaggio verso la parità. I diritti civili e politici delle donne dall’Unità ad oggi, Bologna, Zanichelli, 1980. 7 Il secondo dopoguerra e gli anni Cinquanta 171 Per quanto riguarda l’accesso delle donne a tutti gli impieghi, negata come visto dal fascismo, fu approvato l’articolo 51 non senza discussioni e riformulazioni dello stesso. In una prima proposta l’articolo recitava: «Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubbliche e alle cariche elettive in condizione di eguaglianza, conformemente alle loro attitudini». L’inciso, conformemente alle loro attitudini, era visto come una limitazione verso l’accesso al lavoro e alla possibilità di esercitare una professione: le donne rischiavano, nuovamente, di vedersi aprire la strada solamente in quei campi giudicati «femminili». Maria Federici intervenne. Onorevoli colleghi, noi donne di tutti i settori dell’Assemblea abbiamo colto un’intenzione particolare nell’articolo 48 [ora 51], e cioè che si volesse limitare alle donne la possibilità di accedere ai pubblici uffici o alle cariche elettive […]. Non solamente per le carriere o per le cariche elettive, ma per tutte le manifestazioni del lavoro si deve verificare la possibilità che chi lavora segua la propria attitudine […], poiché le attitudini non si provano se non col lavoro; escludere le donne da determinati lavori significherebbe non provare mai la loro attitudine a compierli». evidentemente qui c’è l’idea di creare una barriera nei riguardi delle donne. E tuttavia che cosa può far pensare che le donne non siano capaci di accedere a posti direttivi? E che le donne non possano accedere alle cariche pubbliche, alle cariche dello Stato? È un pregiudizio, un preconcetto. E del resto tutta la storia delle affermazioni femminili dimostra che sempre si sono dovuti superare dei preconcetti. Abbiamo condotto le donne alle cattedre, le abbiamo ammesse negli ospedali in funzione di medici, le abbiamo ammesse nei laboratori chimici, le abbiamo ammesse dappertutto e mi pare che nessuno possa disconoscere la loro capacità di lavoro e il contributo da esse portato a tutte le attività, anche culturali e scientifiche.14 Dopo un partecipato dibattito l’articolo venne modificato, fu tolta la parte riguardante le presunte «attitudini» e fu inserita la parte finale del testo: «secondo i requisiti stabiliti dalla legge». Un altro articolo per l’approvazione del quale vi furono polemiche è l’articolo 98 (ora 106) riguardante l’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive e in particolar modo per l’entrata delle donne in magistratura, un ambito in cui la presenza femminile fu difficile e contrastata.15 La prima formulazione proposta era: «i magistrati sono nominati con decreti del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio superiore della Magistratura, in base a concorso seguito da tirocinio. Possono essere nominate anche le donne nei casi previsti dalle norme sull’ordinamento giudiziario». In assemblea plenaria, la prima a chiedere parola fu Teresa Mattei. Noi non possiamo ammettere che alle donne rimangano chiuse porte che sono invece aperte agli uomini. Sia tolto ogni senso di limitazione e sia anzi affermato, in forma esplicita e piena, il diritto alle donne ad accedere ad ogni grado della Magistratura come di ogni altra carriera.16 Molte deputate intervennero durante un dibattito in cui furono ripresi vecchi stereotipi sulla incapacità di giudizio della donna e di cui si darà conto più avanti, quindi furono presentati due emendamenti: l’emendamento Rossi-Mattei, che affermava in manie- 14 MARIA FEDERICI, Assemblea Costituente, seduta 22 maggio 1947, pp. 4170-4171. M. FEDERICI, La donna alla Costituente, in Studi per il ventesimo anniversario dell’Assemblea Costituente, vol. II, Firenze, Vallecchi, 1969, p. 201. 16 T. MATTEI, in Atti della Assemblea Costituente, seduta plenaria 18 marzo 1947, p. 2270. 15 172 Dal regime fascista agli anni Sessanta ra chiara il diritto di accesso a tutti i gradi della magistratura anche per le donne, e quello della Federici, che richiedeva la soppressione di qualsiasi limitazione, senza però fare riferimento esplicito al sesso femminile. Il 26 novembre 1947 l’Assemblea Costituente votò: l’emendamento Rossi-Mattei non passò per 153 voti contrari e solo 120 favorevoli. Il giorno successivo le deputate di tutti i gruppi riuscirono a far approvare un ordine del giorno in cui possiamo leggere: l’Assemblea Costituente, considerato che l’articolo 48 garantisce a tutti i cittadini di ambo i sessi il diritto di accedere alle cariche elettive e agli uffici in condizione di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, afferma che per quanto riguarda l’accesso della donna alla magistratura, l’articolo 48 contiene le garanzie necessarie per la tutela di questo diritto.17 La presenza delle donne all’Assemblea Costituente, come visto, fu attiva, propositiva e combattiva. Nel frattempo, dopo aver ottenuto il diritto di voto, le donne cominciarono ad affacciarsi sulla scena pubblica e l’alfabetizzazione politica delle donne fu in gran parte affidata alle due associazioni femminili di massa nate entrambe nell’autunno del 1944: il Centro Italiano Femminile (Cif), di matrice cattolica e l’Unione Donne Italiane (Udi), legata ai partiti comunista e socialista. Per le donne, l’attività e la presenza nei partiti risultò più complessa, meno agevole, più difficile vista la mentalità comune.18 «Noi donne» divenne la voce ufficiale dell’Udi, l’associazione nata dai Gruppi di Difesa che si proponeva «di unire tutte le donne italiane in una forte associazione» in grado di «difendere gli interessi particolari delle masse femminili e risolvere i problemi più gravi e urgenti di tutte le donne lavoratrici, delle massaie e delle madri»,19 stimolando la partecipazione attiva alla vita sociale e politica del paese, l’iscrizione delle donne ai sindacati, realizzando un’articolata opera di assistenza nell’ambito della ricostruzione, ed organizzando conferenze su problemi riguardanti le madri e i bambini e la promozione di corsi scolastici di base. La volontà iniziale fu dunque quella di creare un’organizzazione che coinvolgesse le donne di ogni idea politica, tale unità fu, però, di brevissimo periodo. Solo inizialmente infatti, l’Udi vide la partecipazione di donne cattoliche, già presenti nei Gruppi di Difesa, poi Maria Rimoldi, presidente delle donne cattoliche, propose la costituzione di un organismo separato, il che portò alla nascita del Cif,20 federazione di associazioni, istituzioni ed enti femminili di ispirazione cristiana che si inseriva in una lunga tradizione di associazionismo femminile.21 Alla nascita di questa organizzazione aveva contribuito anche Giovanni Battista Montini, futuro papa Paolo VI, che aveva intenzione di fare del Cif un punto d’incontro tra un nascente movimento politico femminile e l’associazionismo cattolico più tradizionale che vedeva ancora con difficoltà un impegno politico attivo.22 17 Ibidem. NELLA MARCELINO, «La lotta», 1º dicembre 1945. 19 L’Unione delle donne italiane si è costituita a Roma, «L’Unità», 21 novembre1944. Cfr. anche MARISA CINCIARI, Un anno di vita dell’Udi. Molto lavoro fatto – molto lavoro da fare!, «Noi Donne», n. 3, 1945. 20 Sulle origini del Cif, cfr. PAOLA GAIOTTI DE BIASE, La donna nella vita sociale e politica della Repubblica 1945-1948, Donne e Resistenza in Emilia-Romagna, Milano, Vangelista, 1978. 21 PATRIZIA GABRIELLI, Il club delle virtuose: Udi e Cif nelle Marche dall’antifascismo alla guerra fredda, Ancona, Il lavoro editoriale, 2000, pp. 65-73. 22 Azione programmatica sviluppi del Cif, citato in P. GABRIELLI, Il club delle virtuose cit., p. 73. 18 Il secondo dopoguerra e gli anni Cinquanta 173 Il campo privilegiato delle associazioni femminili fu quello dell’assistenza ai bambini, ai reduci alle famiglie.23 Tentando dapprima di rispondere alle emergenze, come avvenne rispetto ai bambini residenti in zone nelle quali la guerra aveva causato i maggiori disagi. Dal 1947, dopo una decisione del Comitato centrale del Pci, si iniziò a preparare l’organizzazione per aiutare i bambini, vi si impegnarono donne dell’Udi e dei partiti della sinistra ed anche rappresentanti degli enti amministrativi, nonché numerosissime famiglie che senza alcun compenso ospitarono, in alcune zone dell’EmiliaRomagna, Toscana e Marche questi bambini.24 Sempre rivolti all’infanzia vi furono altri momenti di organizzazione e di lotta, infatti, convinte che non bastasse dare cibo e riparo, le donne cominciarono ad impegnarsi nell’organizzazione delle colonie e degli asili nei quali alla cura si cercò di affiancare un progetto educativo. Organizzare asili e mense fu uno dei punti sui cui l’Udi si impegnò e su cui chiese la collaborazione di tutte le donne, del sindacato, del Cif e di Azione cattolica. Queste ultime avevano però una visione differente, tanto che Vittoria Rossi, dirigente di Azione cattolica affermò: su due punti noi cattoliche siamo assolutamente ferme: la libertà di educare i nostri figli e l’unità indissolubile della nostra famiglia. Le mense che tolgono alla donna la fatica di preparare il pranzo le tolgono per ciò stesso la gioia di essere lei la regina che accudisce, sia pure con sacrificio, ai suoi cari. In tal modo la famiglia si distrugge.25 Non solo la visione era differente, ma anche i mezzi messi a disposizione delle diverse associazioni dall’autorità centrale.26 Questo non significava che le donne non entrassero anche nei partiti, sia nelle commissioni femminili che, più raramente, negli organi direttivi. Una particolare situazione si verificò per le donne emiliano-romagnole dei partiti di sinistra, quella di essere inviate in luoghi lontani a fare lavoro politico fra le donne. Le destinazioni erano solitamente al sud: Sicilia, Campania, Calabria, Abruzzo; ma anche la Lombardia nella zona di Lecco e Como, ad esempio, o a Brescia o, ancora, nel Veneto. I racconti di quelle esperienze hanno alcuni tratti in comune: innanzi tutto le difficoltà materiali e la diffidenza o addirittura l’aperta ostilità mostrata dai parroci o dalle autorità locali a cui si andava incontro. La reazione era spesso la pazienza e la costanza e a volte, quando le interruzioni divenivano intollerabili, l’appello al diritto di espressione garantito dalla Costituzione era un’arma utilizzabile. Io avevo sempre con me due documenti, ricorda Margherita Preti, il libretto da bracciante agricola e la Costituzione italiana. Questo mi permetteva di mostrare la mia condizione di lavoratrice a chi mi stava ad ascoltare e, con la Costituzione in mano, chiedevo ai carabinieri il rispetto dei miei diritti. 23 ALESSANDRO ALBERTAZZI, ANNA MARIA STAGNI, Il primo anno di vita del Centro Italiano Femminile in Emilia-Romagna, in P. GAIOTTI DE BIASE, La donna nella vita sociale e politica della Repubblica cit. 24 Su questo si veda, fra l’altro, GIOVANNI RINALDI, I treni della felicità. Storie di bambini in viaggio tra due Italie, Roma, Ediesse, 2009. 25 Citato in FIORENZA TARICONE, Il centro italiano femminile dalle origini agli anni Settanta, Milano, Franco Angeli, 2001, p. 51. 26 Nel suo congresso del 1948 l’Udi rese noto di aver ricevuto, assieme all’Inca Cgil, un contributo per l’organizzazione dell’attività di assistenza, 60 milioni a fronte dei 300 assegnati al Cif e dei 600 dati alla Pontificia commissione di assistenza. Citato in F. TARICONE, Il centro italiano femminile cit. p. 52. 174 Dal regime fascista agli anni Sessanta 8 marzo 1959. Lavoro, assistenza, istruzione, migliore tenore di vita chiedono le donne, a cura della Federazione bolognese del PCI, 1959, manifestipolitici.it, a cura della Fondazione Istituto Gramsci Emilia-Romagna, Bologna Il diritto al lavoro Durante la guerra non solo le donne avevano sostituito gli uomini nelle industrie e nei servizi, ma avevano cercato di conservare il proprio lavoro per poter sostenere loro stesse e la famiglia. Con il ritorno dei soldati, però, furono presi dei provvedimenti che penalizzarono la presenza della donna nel mondo del lavoro, ad esempio venne varato un decreto che lasciava la libertà di licenziare i lavoratori che avevano altri cespiti, i lavoratori assunti dopo il 30 giugno 1943 e le donne ricadevano facilmente in queste due categorie; inoltre il 4 agosto 1945 il governo decretò che per il successivo biennio il 50% delle assunzioni, nel pubblico e nel privato, doveva essere riservato ai reduci. La reazione delle lavoratrici e dei sindacati fu immediata e già alla fine del mese di agosto la Commissione consultiva femminile sollecitava Udi, Cif e sindacato ad impegnarsi per impedire questa discriminazione. Nonostante ciò, il ministro dei Trasporti Ugo La Malfa dispose il licenziamento di 4000 avventizie delle Ferrovie. Le donne si mobilitarono, tennero manifestazioni e dopo un comizio in un cinema romano, una delegazione di loro guidata da Adele Bei, fu ricevuta dal ministro.27 Su «Noi donne» nel settembre 1945 si leggeva: Parlo di voi, lavoratrici dell’industria, e del commercio, che in questi ultimi tragici anni avete lavorato tanto non solo con impegno e serietà, ma (riconosciamolo signori uomini), con tanta capacità da soddisfare a tutti gli indici della produzione e del rendimento. Parlo di voi, impiegate e dattilografe il cui stipendio doveva sostenervi e vestirvi e forse anche mantenere qualche famigliare. Era poco ma era una base. Parlo di te, tramviera, che raccoglievi dei nervosi passeggeri migliaia e migliaia di lire e guai se sbagliavi ad aprire una delle mille porte che azionavi in un giorno. Parlo di te, maestrina, il cui stipendio poteva servirti per comperare forse una scarpa al mese. «Cambino mestiere», dice certa gente. Ma non ve lo danno un mestiere nuovo. «Rimangano a casa a far la calza». Ma e chi guadagna per riempire il piatto? Forse che trasformandovi tutte in lavoranti a domicilio potreste guadagnare da vivere? «Facciano le donne di servizio» come se le dattilografe, le impiegate, le operaie potessero improvvisarsi donne di servizio. E poi è possibile che nessun altro orizzonte debba aprirsi alle donne italiane?28 27 È brava ma… donne nella Cgil 1944-1962, a cura di Simona Lunadei, Lucia Motti, Maria Luisa Righi, Roma, Ediesse, 1999, p. 53. 28 «Noi donne», 31 settembre 1945. Il secondo dopoguerra e gli anni Cinquanta 175 L’articolo di «Noi donne» continuava esortando le donne a ribellarsi a questo tentativo di licenziarle per risolvere il problema della disoccupazione, le si invita ad affidarsi ai sindacati. Molti pensavano che, in una situazione così complessa come quella dell’immediato dopoguerra, in cui la povertà e la disoccupazione erano molto presenti si dovesse in effetti allontanare le donne dal lavoro.29 Eco di queste opinioni si ebbero anche sulla stampa: ad esempio sul settimanale dei reduci bolognesi, «L’italiano» si sosteneva che le donne lavorassero non per necessità ma per comprare «le borsette alla moda, il cappellino e le calze di seta», e che quindi dovessero lasciare il loro posto agli uomini.30 Lo stesso giornale lanciò un sondaggio fra i suoi elettori per sapere se le «donne dovevano comandare». Il sondaggio ebbe il risultato, forse un po’ scontato, di raccogliere giudizi negativi sulle donne che «volevano fare l’uomo»: il 90% secondo i redattori del giornale. Mentre ragazze corrono in jeep una voce femminile dalla Consulta ha rivendicato per il suo sesso precise responsabilità pubbliche, e forti nuclei di donne impiegate non si mostrano affatto disposte a farsi soppiantare dagli uomini che tornano. Si tratta di una temporanea ubriacatura del femminino o esistono motivi veritieri per la trasformazione del costume nazionale? [si insite] per la penetrazione delle donne nel lavoro, negli studi, e nella lotta elettorale. Anche se volessimo potremmo cacciarle indietro? E non può essere una buona cosa che, la tradizionale «ochetta italiana» pratica solo di cucina e di moda, apprenda a ragionare di dottrine e statistiche? [così] non rischia di vedere cadere e il rispetto cavalleresco da parte dell’uomo e l’accettazione da parte della donna delle funzioni di guida del proprio uomo?31 I temi del lavoro delle donne rispetto al ritorno dei reduci furono ripresi anche da «L’appello», giornale della democrazia cristiana bolognese. Moltissimi reduci quando partirono quattro, sei, dieci anni fa, per il fronte lavoravano, il loro posto fu preso in gran parte dalle donne; ora che sono tornati queste donne, a meno che non si tratti di capo famiglia o di casi speciali di famiglie numerose, debbono tornare a casa ad occuparsi delle faccende domestiche. […] Resta vivo il dissenso e aperta la discussione intorno alla donna, nubile o coniugata, che non sia capo famiglia. Nel nostro caso il sacrificio delle donne lavoratrici, andrebbe non a vantaggio della collettività, bensì a beneficio di qualche singolo reduce. L’eliminazione delle donne, anche di tutte, dal lavoro non basterebbe a dare onorevole sistemazione ai reduci.32 Le donne dell’Udi e le cattoliche erano contrarie ai licenziamenti visto che, come veniva scritto su «Azione femminile», «fra i diritti il primo da difendere è precisamente il diritto al lavoro».33 La discussione sulla presenza delle donne nel mondo del lavoro non terminò nei primi anni del dopoguerra ma fu costantemente ripresa almeno fino alla metà degli anni Cinquanta. Vi era chi, ancora, credeva che il compito precipuo della donna fosse quel29 Su questo si veda ROSSELLA ROPA, La presenza delle donne sulla scena pubblica nella stampa locale di area cattolica (1945-1946), in La fondazione della Repubblica modelli e immaginario repubblicani in Emilia e Romagna negli anni della Costituente, a cura di Mariuccia Salvati, Milano, Franco Angeli, 1999, pp. 310-334. 30 «L’italiano», 25 novembre 1945. 31 «L’italiano», 25 novembre 1945. 32 «L’appello» 9 dicembre 1945. 33 «Azione femminile», 16 novembre 1945. 176 Dal regime fascista agli anni Sessanta lo di accudire ai figli e che quindi il lavoro, o almeno non tutti i lavori, fossero adatti a lei. Il 14 giugno 1956, in un editoriale su «L’Avanti», il deputato socialista e sindacalista Ferdinando Sarti scriveva accompagnando la partenza delle delegate italiane alla conferenza mondiale delle lavoratrici: quella del diritto al lavoro per assicurare l’indipendenza della donna non deve essere una rivendicazione indiscriminata. Le donne debbono rivendicare un lavoro, e soltanto quello che non contrasta con la particolare natura del loro complesso fisico e psichico. Non ci piacciono le donne muratrici o stradine, o guidatrici di camion, che invece sollecitano l’orgoglio di quale nostra graziosa amica dell’Udi. La donna lavoratrice, oltre che essere tale, è prima di tutto madre e sposa. Perciò noi dobbiamo batterci perché il lavoro che per essa giustamente rivendichiamo non sia in conflitto con questo suo insostituibile umano destino. In questo articolo erano riproposti – da un esponente di rilievo del partito socialista – temi e stereotipi sulla «funzione» della donna e sulla impossibilità della donna stessa di esercitare qualsiasi mestiere o professione. Come possiamo immaginare le donne dell’Udi, direttamente sollecitate dall’ironia del sindacalista, intervennero. Per prima Ada Alessandrini che definì sconcertante un articolo «così legato a passate visioni della donna, in cui si ripropone il ruolo materno come il destino femminile».34 La risposta del deputato socialista pubblicata su «Noi Donne» l’8 luglio non fece altro se non ribadire, con una ironia un po’ greve, le sue posizioni. Le donne dell’Udi mi considerano un reazionario, una specie di capo della Confindustria dei mariti. Le reazioni al mio modesto scritto dimostrano che talune emancipatissime donne dell’Udi sono affette da un inguaribile complesso di inferiorità nei confronti degli uomini, che credono di superare rivendicando tutti i mestieri anche i più rudi. Questa polemica a distanza continuò sul giornale dell’Udi dove il 2 settembre intervenne anche Concetto Marchesi, esponete del partito comunista, affermando che se si comincia a distinguere e a dire che «questo non è lavoro da donna» ricomincia a spirare il soffio della boria mascolina. L’onorevole Sarti dimentica i tanti gravosissimi lavori a da secoli cui attende la donna della campagna e della città. Dall’inizio del secolo al 1951 vi era stata in Italia una costante diminuzione della presenza femminile al lavoro, tanto che se nel 1901 le donne costituivano quasi un terzo della popolazione attiva, nel 1951 erano un quarto: le donne volevano invertire questa tendenza.35 Qualche tempo prima, nel 1953, le donne bolognese avevano stilato un documento «la carta dei diritti delle donne bolognesi», in cui uno dei diritti irrinunciabili da rivendicare era proprio la «difesa del lavoro manuale ed intellettuale», perché la donna potesse «avere la sicurezza del suo pane quotidiano». Similmente il Cif ribadiva, sul periodico «Cronaca», che il diritto al lavoro era inalienabile, visto che era sancito anche dalla Costituzione.36 34 «Noi donne» primo luglio 1956. LUCIANO BARCA, Prospettive dell’occupazione e qualificazione femminile nell’attività economica italiana. La preparazione professionale della donna, Atti del Convegno organizzato dal Comitato di associazioni femminili per la parità di retribuzione, Milano, 3-4-5 aprile 1959. Firenze, La nuova Italia, 1959, p. 77. 36 «Cronache», gennaio 1954. 35 Il secondo dopoguerra e gli anni Cinquanta «L’italiano», 25 novembre 1945, Biblioteca comunale dell’Archiginnasio, Bologna. 177 «Cronache», gennaio 1954, Archivio Centro Italiano Femminile, Roma. La legislazione Le delegate riunite nel Congresso mondiale della donna che si tenne a Copenaghen dal 5 al 10 giugno 1953 fissarono l’elenco dei diritti che dovevano essere riconosciuti a tutte le donne indipendentemente dalla loro «razza, nazionalità e posizione sociale». Fra gli altri vi erano: diritto ad un lavoro garantito diritto di libera scelta di una professione o mestiere diritto ad accedere a qualsiasi impiego pubblico e amministrativo pari possibilità di avanzamento in tutti i campi del lavoro per uguale lavoro uguale salario parità di diritto all’assicurazione sociali diritto alla protezione della madre e del bambino da parte dello Stato riposo pre e post-natale retribuito riconoscimento alle lavoratrici agricole dei diritti accordati alle lavoratrici delle fabbriche: salari, lavoro garantito, protezione della madre e del bambino.37 Questi diritti erano, in Italia, in parte già sanciti dalla Costituzione, ma dovevano essere tradotti in leggi e norme che potessero completare e rendere reali i diritti delle donne in tema di lavoro. Il primo intervento legislativo nel campo del lavoro femminile fu la legge n. 860 del 1950, ovvero la legge sulla tutela per le lavoratrici madri, tutela prevista nell’articolo 37 della Costituzione. L’iniziativa legislativa, promossa dalla Cgil, era stata fatta propria nel 1948 dalle donne del fronte popolare, Teresa Noce in testa. In questa proposta si chiede37 Carta dei diritti delle donne bolognesi, a cura del Consiglio delle donne bolognesi, Bologna, Steb, 1953, pp. 37-38. 178 Dal regime fascista agli anni Sessanta va l’estensione della tutela a tutte le donne, comprese le casalinghe e quindi l’eguaglianza di fronte alla maternità di tutte le lavoratrici, la corresponsione di un’indennità, per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, pari al 100% della retribuzione. Teresa Noce sottolineava che il progetto era scaturito da riunioni, comizi, assemblee operaie nelle fabbriche ed incontri con esperti, per questo la stessa Noce definì il progetto una legge popolare, approvata e attesa «dalle operaie come le contadine, le impiegate come le casalinghe, le mamme di Torino e di Milano come quelle di Matera e di Nuoro, di qualunque fede politica».38 Il progetto, secondo la sua relatrice, avrebbe dovuto garantire che la tutela fisica della donna incominciasse dall’inizio della gravidanza ed estendersi anche dopo il parto. E doveva proteggere non solo la mamma, ma anche il bambino. Per questo chiedemmo sale di allattamento attrezzate sul luogo di lavoro o il permesso pagato perché la mamma potesse uscire per allattare il figlio, per questo richiedevamo asili nido sul luogo di lavoro, oppure nei quartieri di abitazione e nei paesi. [Perciò] presentammo una formulazione che richiedeva sempre e in ogni caso l’asilo nido, ma che lasciava alle commissioni interne, sul luogo di lavoro e alle organizzazioni sindacali locali la facoltà di accordarsi sulla possibilità di creare l’asilo nido in fabbrica o localmente, ma sempre gratuito per le lavoratrici e a spese dei datori di lavoro.39 La proposta di legge, firmata da un gruppo di deputate, fu presentata in parlamento il 14 giugno 1948 e come prima firmataria vi era proprio Teresa Noce. Due anni dopo, il 27 giugno 1950, fu presentato da Amintore Fanfani e da Maria Federici il progetto che poi diventò legge. Vi erano alcune differenze rispetto al così detto progetto Noce: l’indennità fu stabilita all’80%, ad esempio, e non al 100%, e la legge non riguardava le lavoratrici a domicilio, le mezzadre e le impiegate statali. La presenza di questa legge che tutelava le donne in gravidanza fece sì che alcuni datori di lavoro pensassero di non rispettarla licenziando le donne. Ecco che quindi che il 23 novembre 1950 venne proposto da Teresa Noce e dal socialista Sansone un ulteriore provvedimento, una legge il cui solo articolo recitava: «a decorrere dal 3 novembre 1950, data di pubblicazione della legge 26 agosto 1950, n. 859, i datori di lavoro non possono licenziare le proprie dipendenti, gestanti o puerpere, a meno che non si rendano colpevoli di infrazioni al contratto di lavoro», proposta che venne trasformata nella legge n. 986 varata in quello stesso anno. Le donne, che non potevano più essere licenziate durante la gravidanza, continuavano però a correre il rischio di essere licenziate in seguito al matrimonio e, probabilmente, questo era anche un modo per evitare la legge sulla tutela della lavoratrice madre. Numerosissimi i casi segnalati, tanto che la senatrice Lina Merlin fece su questo tema una interrogazione al Senato nella seduta del 30 gennaio 1951. In questa interrogazione la senatrice affermò, fra l’altro: che cosa si vuole fare, onorevole Sottosegretario, quando si licenzia? Si vuole eludere la Costituzione e si vuole eludere anche la legge sulla maternità. Si è mai sentito dire che un uomo sia licenziato perché si sposa? Evidentemente no. Ora, perché si vuol licenziare la donna che va a nozze? Forse perché si temono le conseguenze visibili del matrimonio? Ma chi, nel 1951, si scandalizzerebbe dei segni esteriori della maternità, che tutti consideriamo sacra? E se la maternità, oltre ai segni esteriori, porta anche una diminuzione della capacità lavorativa, è qui 38 39 Una legge popolare: tutela della maternità, «Notiziario Cgil», n. 30, 30 ottobre 1948, pp.769-770. T. NOCE, Rivoluzionaria professionale, Milano, Bompiani, 1977, pp. 407-408. Il secondo dopoguerra e gli anni Cinquanta 179 che dovrebbe entrare in vigore la legge sulla maternità. Ma, fatta la legge, trovato l’inganno, e si ricorre allora all’inganno per poter licenziare queste donne. Io ho voluto denunciare in sede politica tali fatti, che non sono così sporadici come lei onorevole Sottosegretario ha voluto asserire. In moltissime realtà lavorative le donne venivano licenziate per matrimonio: a Roma, ad esempio, nel 1954 in alcune aziende esistevano regolamenti interni che prevedevano la risoluzione automatica del contratto di lavoro in caso di matrimonio;40 numerose segnalazioni venivano dall’Emilia-Romagna, tanto che si ritenne di raccoglierne alcune in un «libro bianco» pubblicato dall’Udi.41 In questo testo si può leggere, ad esempio, che a Reggio Emilia alla Banca agricola commerciale le dipendenti venivano licenziate quando si sposano in base all’articolo 76 licenziamento ad nutum del contratto di lavoro. Quest’articolo con la sua formulazione dà possibilità all’azienda di licenziare per qualsiasi motivo i propri dipendenti e di questo articolo ci si avvale per licenziare le lavoratrici che si sposano. La Banca nazionale del lavoro, dopo aver licenziato tutte le donne nel 1947 non ne ha più assunte. A Modena, in una fabbrica di scatolame in metallo: vi sono occupati 60 donne e 10 uomini. In questa fabbrica, all’atto dell’assunzione, viene fatto firmare alle lavoratrici un documento con il quale si impegnano a dimettersi qualora contraggano matrimonio. A Parma, nel settore bancario, secondo quanto segnalò l’Udi al prefetto, ad eccezione delle Casse di risparmio le donne venivano sistematicamente licenziate. Alla Barilla erano segnalati licenziamenti dopo il matrimonio. Inoltre, agli ospedali riuniti, come in altri ospedali, era stata ripristinata la clausola del nubilato o della vedovanza come requisito per l’ammissione alle scuole convitto per le infermiere.42 Il presidente dell’ospedale neuropsichiatrico San Lazzaro di Reggio Emilia, promise, in seguito ad un dibattito sorto in quella città, che avrebbe osservato la legge non licenziando le donne in stato di gravidanza, a quel punto, le donne chiesero anche che venisse abolita la clausola del nubilato nel contratto per le nuove assunte. La prassi di introdurre il vincolo del nubilato e del conseguente licenziamento per matrimonio introdotte dalle direzioni degli ospedali psichiatrici, indusse il ministro della sanità ad emanare una circolare in cui specificava che quella clausola era «da ritenere antisociale e senza fondamento giuridico».43 In questa situazione numerose furono le proposte di legge d’iniziativa di deputati che furono elaborate: il 5 giugno 1956, prima firmataria Ada Guelfi Del Vecchio, 21 deputate presentarono un progetto «di disciplina dei licenziamenti delle donne che si sposano». Il 20 giugno 1958 Lina Merlin e Anna Matera De Lauro firmarono la proposta di legge «divieto di licenziamento dai posti d’impiego e di lavoro delle donne che si sposano»; il 6 maggio 1959, prima firmataria Giuseppina Re; 18 deputati – in questo caso fra le firme troviamo anche quelle di uomini –presentarono la proposta di legge «divieto di licenziamento per causa di matrimonio». Infine il 28 giugno 1962 il ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il ministro di Grazia e Giustizia e col ministro del Tesoro presentarono la legge «divie40 «Cronache», n.1, 1954. Libro bianco sui licenziamenti per causa di matrimonio in Italia Situazioni e documentazione, a cura di L. Merlin, Roma, Tip. L. Morara, 1961. 42 Ivi, pp. 33-34. 43 Circolare 21 giugno 1960. 41 180 Dal regime fascista agli anni Sessanta to di licenziamento del personale femminile per causa di matrimonio». La legge fu approvata alla Camera il 17 ottobre 1962, dopo il passaggio al Senato, ritornò alla Commissione lavoro e previdenza della Camera dei deputati che la approvò. Il 3 gennaio 1963, la legge venne promulgata. Questa legge constava di sei articoli: i primi due riguardavano il divieto di licenziamento per causa di matrimonio e gli altri quattro intervenivano sulla tutela delle lavoratrici madri. Nel quarto comma del primo articolo venivano prese in considerazione anche le dimissioni volontarie e si affermava che erano «nulle le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo di cui al precedente comma», ovvero fino ad un anno dopo la celebrazione delle nozze «salvo che siano dalla medesima confermate entro un mese all’Ufficio del lavoro». Questa norma era stata introdotta per contrastare la pratica di far firmare, al Proposta di legge firmata da sole donne contro il momento dell’assunzione, dimissioni licenziamento per matrimonio, 1956, Camera dei in bianco, che il datore di lavoro deputati, atti parlamentari on line. poteva poi utilizzare al momento del matrimonio. «Per uguale lavoro uguale salario» era scritto nella carta di Copenaghen. In effetti, in Italia, questa richiesta era lontana da corrispondere a verità nell’industria e nell’agricoltura. Ad esempio nell’industria tessile una operaia specializzata nella lavorazione della lana percepiva 152,50 lire all’ora, un manovale comune 154,65. Fra i chimici l’operaia di prima categoria guadagnava 139,60 lire, mentre il manovale comune 147,50. Anche nei lavori statali la situazione era simile. Ad esempio nei Monopoli, uno specializzato riceveva 501.000 lire l’anno, una specializzata 453.000. In generale nel 1954 il salario femminile era di circa il 16% inferiore a quello maschile. Due anni prima, un gruppo di parlamentari, fra cui Teresa Noce, avevano presentato la proposta di legge «Applicazione della parità di diritti e della parità di retribuzioni per un pari lavoro». Nel 1954 cominciò la discussione della proposta Noce in commissione Industria, i pareri esposti furono discordanti e nel 1956 venne approvata la legge n. 741 sulla parità di remunerazione. Nel 1957 le Acli chiedevano ancora «il giusto riconoscimento del valore del lavoro femminile, la parità salariale e previdenziale».44 44 «Noi donne», n. 39, 6 ottobre 1957. Il secondo dopoguerra e gli anni Cinquanta 181 Nel 1951 il Bureau international du Travail riunito a Ginevra il 6 giugno aveva emanato una Convenzione: la Convention sur l’égalité de rémunération, conosciuta come Bit 100, in cui veniva prevista la necessaria parità di salario fra uomini e donne. Questa convenzione fu ratificata, in tempi e in momenti estremamente differenti, nei paesi europei e mondiali: in Italia fu riconosciuta con la legge n. 741 del 22 maggio 1956.45 Sulla necessità di stabilire l’uguaglianza salariale, applicando così l’articolo 37 della Costituzione, si trovarono d’accordo, seppur con sfumature differenti, le donne di tutti gli schieramenti politici e sindacali: dalla Cgil, alla Uil alle donne delle associazioni cattoliche.46 Nel 1957, nel trattato che fonda il Mercato Comune Europeo l’articolo 119 recitava «Ciascuno stato membro assicura durante la prima tappa, e in seguito mantiene, l’applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro». Il primo accordo interconfederale per la parità salariale fu siglato nel 1960. A rappresentare la Confederazione generale dei lavoratori vi era Vittorio Foa, per i lavoratori metalmeccanici della Fiom Luciano Lama e per le lavoratrici del settore tessile Lina Fibbi. Il settore agricolo restava escluso dalla legge del 1956 ed era ancora in vigore il coefficiente Serpieri, per l’abolizione del quale l’Udi pensò di presentare una legge d’iniziativa popolare che constava di due articoli. Art. 1: la capacità lavorativa della donna contadina, sia essa coltivatrice diretta, mezzadra, colona, compartecipante, è uguale ad ogni effetto a quella dell’uomo. È abrogata ogni contraria o diversa valutazione, risultante dalla legge, dai contratti individuali e collettivi, dagli usi o da ogni altra fonte di diritto, in base alle quali la capacità lavorativa della donna contadina sia valutata in modo inferiore a quella dell’uomo. Art. 2: Il governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentita apposita commissione parlamentare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, anche con decreti separati, le norme necessarie in materia previdenziale ed assistenziale per adeguare la legislazione vigente alle disposizioni della presente legge.47 Le 50.000 firme richieste per la presentazione della legge furono raccolte e il 25 ottobre 1962 furono consegnate alla Presidenza del Senato. Una delegazione di mille lavoratrici, secondo il quotidiano «L’Unità», fu ricevuta da Cesare Merzagora e quindi dai gruppi parlamentari e dalla segreterie nazionali delle Confederazioni sindacali. Discussa in Commissione, questa legge ebbe un parere positivo dall’unanimità dei componenti48 e la parità di salario in agricoltura fu ottenuta nel 1964 quando venne emanata la legge sulle «nuove norme in materia di contratti agrari»: così, dopo 30 anni, non era più in vigore il coefficiente Serpieri. Nonostante la legge e il lavoro sindacale, su 78 contratti nazionali rinnovati nel 1962, solo 27 prevedevano l’uguaglianza di retribuzione.49 Tutte le leggi fino a qui descritte erano necessarie per accogliere il dettame dell’articolo 3 e dell’articolo 37 della Costituzione. Per l’applicazione dell’articolo 51 45 Per un elenco completo si veda: http://www.ilo.org/. «Noi donne», n. 41, 20 ottobre 1957, pp. 24-25 47 «Noi donne», n. 48, 3 dicembre 1961, pp. 28-31. 48 137a seduta pubblica, resoconto stenografico, 26 maggio 1964, pp. 7404-7405. 49 DARA KOTNIK, Le donne al guinzaglio. Ma ora si stanno muovendo per la parità dei diritti-chi le ferma più?, «Panorama», n. 16 del gennaio 1965. 46 182 Dal regime fascista agli anni Sessanta furono emanate le leggi che sancirono, almeno sulla carta, la possibilità per le donne di esercitare qualsiasi mestiere e di accedere a qualsiasi carriera. Il rapporto fra le donne e la possibilità di entrare in magistratura fu molto complesso, come si è visto analizzando la discussione alla Costituente e come si dirà più avanti. Nel 1951 tre deputate presentarono una proposta di legge in cui si stabilivano le norme per la partecipazione delle donne alle giurie popolari nelle Corti d’Assise. E la legge 1441/1956 ammise le donne nelle giurie popolari delle Corti d’Assise e come componenti dei tribunali per minorenni. Con la legge del 9 febbraio 1963, n. 66, le donne furono ammesse «ai pubblici uffici ed alle professioni», ad esclusione di Guardia di finanza e Forze armate. Lungo e complesso, quindi, l’iter legislativo attraverso il quale gli articoli della Costituzione potevano trovare le norme per essere messi in pratica. Richieste e rivendicazioni per il lavoro in campagna e in fabbrica L’immediato dopoguerra poneva i lavoratori della terra di fronte a numerosi problemi, fra questi la necessità, per fare fronte alla disoccupazione, di effettuare tutti i lavori indispensabili per ricominciare la produzione anche sui terreni incolti. A questo si affiancarono richieste di miglioramento delle condizioni salariali e dell’abolizione di alcune consuetudini come quella delle regalie. Già nel 1944 su «Noi donne» si trovava un articolo in cui si metteva in luce come questo «dono obbligatorio» nei confronti dei proprietari dei fondi pesasse soprattutto sulle spalle delle donne. Chi maggiormente sente il peso di quest’usanza di carattere feudale sono le donne contadine. Sono esse che curano il pollame, che si alzano di notte per assicurarsi che le chiocce non rompano le uova, che preparano il mangime; e sono le donne che di soliti traggono vantaggio dai prodotti del pollaio. Col ricavato dalla vendita del pollame, le massaie contadine comprano spesso gli abiti loro e dei bimbi. [… ] Negli ultimi anni che precedettero il fascismo, in qualche località il contadino era riuscito a sottrarsi all’obbligo umiliante delle regalie. Poi il fascismo, ha rimesso in vigore dovunque tale obbligo. Ma il fascismo è finito. E con esso dovrebbero essere finiti tutti i residui feudali ancora esistenti nel nostro paese.50 Sovente queste regalie, per protesta, venivano donate agli ospedali o alle mense dei poveri, come avvenne a Bologna nell’inverno 1945-1946. Il 22 marzo1946 fu raggiunto un accordo per i circondari di Forlì, Rocca San Casciano, Cesena e Rimini che prevedeva l’abolizione delle regalie. Nell’immediato dopoguerra, a causa delle difficili condizioni di vita, molte furono le proteste e gli scioperi messi in atto dai lavoratori della terra. Il primo sciopero provinciale dei braccianti bolognesi per un nuovo contratto ebbe luogo nell’estate del 1947. Nel maggio 1948 vi fu lo sciopero delle mondine che chiedevano il contratto. Nel giugno quindici mondine vennero arrestate perché avevano cercato di impedire l’impiego dei lavoratori «crumiri». Le agitazioni furono numerose tanto che nel periodo maggio giugno 1948 nell’area bolognese gli scioperanti furono 14.846 di cui 8477 donne per una perdita complessiva di 237.320 giornate di lavoro. Iniziarono in quel dopoguerra anche i cosiddetti scioperi a rovescio: il 15 marzo 1949, in Emilia-Romagna, circa 4000 contadini diedero il via ad un’occupazione di 50 «Noi donne», 25 ottobre 1944, p. 2. Il secondo dopoguerra e gli anni Cinquanta 183 terre incolte e la polizia intervenne per allontanarli effettuando complessivamente una ventina di arresti. Sul finire del 1949 si diffuse sempre più questo tipo di protesta, braccianti e mondine lavoravano anche dove il padrone non avrebbe voluto, a rischio dell’arresto visto che si trattava di entrare in modo abusivo sulla proprietà privata.51 La contrapposizione politica, i riflessi della guerra fredda si fecero sempre più cogenti e in questo clima di crescente tensione si arrivò allo sciopero generale dei braccianti e dei salariati fissi per rivendicare il primo contratto di lavoro nazionale il 16 maggio 1949. Durante questi scioperi, in provincia di Bologna, ai confini con quella di Ferrara, il 17 maggio 1949 fu uccisa una bracciante, Maria Margotti e circa 30 persone furono ferite. Il contesto in cui avvenne era particolarmente drammatico e lacerante: le forze dell’ordine spararono verso gli scioperanti che si erano recati a Marmorta, una frazione di Molinella, per protestare contro l’impiego dei «crumiri» nel lavoro dei campi durante gli scioperi. Maria Margotti divenne, per gli scioperanti e soprattutto per le donne un «simbolo e una bandiera», numerosissime furono le persone che seguirono il suo funerale e la stampa di sinistra diede largo spazio a questo avvenimento. Di grande interesse è l’analisi del racconto fatto proprio sulla stampa, quotidiana e periodica;52 qui Maria Margotti una donna lavoratrice – era infatti una bracciante ed una operaia – venne descritta anche come madre: «avete ucciso una madre» era, ad esempio, il titolo di un articolo di «Noi donne».53 Probabilmente sottolineare il suo essere madre, significava sì rimarcare la drammaticità dell’avvenimento, ricordando le sue due figlie rimaste orfane dopo la precedente morte del padre, ma, si può forse affermare, che mettere in rilievo nella descrizione l’‘essere madre’ significasse anche altro. In questo, come in altre numerose occasioni, possiamo ipotizzare una sorta di transizione nel modello femminile: la donna, da madre e sposa, stava diventando anche lavoratrice e donna impegnata in politica, mentre ancora il ruolo famigliare era estremamente importante e definente per le figure femminili. Fin da subito, evidentemente, questo avvenimento ebbe risonanza locale e nazionale.54 Ci pare opportuno poi sottolineare come Maria Margotti sia stata ricordata come mondina, quando in realtà era una operaia della fornace di Argenta ed una bracciante. Sicuramente il fatto che sia stata uccisa su un argine può avere influenzato l’immagine cristallizzata nel ricordo, ma anche in questo caso ci pare che l’esemplarità del mestiere di mondina e la caratterizzante presenza di queste figure professionali nelle zone da noi analizzate abbiano fatto includere anche Maria Margotti in questa categoria, quasi a renderla ancora più «simbolo e bandiera». In seguito allo sciopero i braccianti ottennero un aumento dell’indennità infortuni; l’impegno a corrispondere l’indennità di caro-pane e le prestazioni farmaceutiche ai loro familiari; l’emanazione della legge che estende il sussidio e l’indennità di disoccupazione a tutti i braccianti e salariati agricoli e che rappresenta una delle più grandi conquiste sul piano della legislazione sociale. Nel 1957 a Sala Bolognese nella tenuta Barabana, le donne e gli uomini braccianti occuparono la terra per evitare lo smembramento della tenuta e il loro allontanamento, 51 A. VERZELLI , PAOLA ZAPPATERRA, La vita, il lavoro, le lotte. Le mondine di Medicina negli anni Cinquanta, Bologna, Aspasia, 2001, p. 24. 52 Le donne, le lotte, la memoria, 1949-1999 a cinquant’anni dalla morte di Maria Margotti, ricerca a cura dell’archivio storico dell’Udi e dell’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, Ferrara, Editrice il globo, 1999. 53 «Noi donne», 29 maggio 1949. 54 Atti Parlamentari Camera dei deputati CCXXXT, seduta di venerdì 20 maggio 1949. 184 Dal regime fascista agli anni Sessanta l’occuparono e la lavorarono. Nel ferrarese l’anno successivo, in seguito ad annunciati licenziamenti, venne messo in atto una protesta che prevedeva di mietere il grano con le macchine ma con la falce: in questo modo si salvava il raccolto, a mezzadria con il padrone del terreno, ma si lasciava sul campo la paglia che non era a mezzadria, ma che spettava tutta al proprietario. Un impegno gravoso a cui donne e uomini si dedicarono con l’aiuto degli abitanti delle località, «Questa solidarietà attiva non è mai venuta meno alle donne e ai braccianti del ferrarese. […] Si sono viste andar sui campi le casalinghe e le merciaiole, gli studenti e le studentesse, i commercianti, gli operai; dai paesi si muoveva la venditrice di frutta e il farmacista».55 Nel 1959 a Ravenna i braccianti arrivano a fare 80 giornate di sciopero con una piattaforma rivendicativa che prevedeva aumenti salariali, fine della sperequazione salariale tra uomini e donne, contrattazione per l’imponibile di manodopera. Uomini e donne, quindi, scioperavano in quegli anni sulle stesse piattaforme rivendicative e con le stesse modalità, dovendo affrontare le stesse difficoltà e gli stessi rischi. E a quelle comuni si affiancavano richieste più legate alle esigenze delle donne, quale l’estensione della legge sulla maternità, si faceva strada, quindi, una mobilitazione più specifica legata ad una attenzione al coinvolgimento delle donne da parte delle associazioni e dei partiti, così come si è visto. È in quest’ambito che nel 1953, in vista della Conferenza nazionale delle lavoratrici, il Congresso della Donna Italiana elaborò una serie di punti e di problemi da porre alla discussione delle mezzadre: Rispetto dei diritti e della dignità delle donne mezzadre e colone. Per l’acquisizione di tutti i diritti sanciti per legge a degli accordi sindacali in favore di oltre mezzo milione di donne della categoria. L’alleggerimento del lavoro e la riduzione delle ore lavorative con l’impiego di un più largo numero di macchine. Il giusto riconoscimento del proprio apporto nella produzione e compenso adeguato al lavoro svolto. Abitazione sane e sufficienti per tutte le famiglie. Contro i tuguri, fonte di malattie e di degenerazione sociale. Tutela della maternità, dell’infanzia e vecchiaia per mezzadre. Potenziamento delle attrezzature scolastiche e costruzione di scuole.56 L’impegno delle donne era rivolto, quindi, all’ottenimento di leggi che, mettendo in pratica il dettato costituzionale, prevedessero l’estensione della legge sulla lavoratrice madre anche a chi lavorava nel settore agricolo e garantissero l’effettiva parità fra uomo e donna. Coinvolgere le donne nell’organizzazione sindacale era un obiettivo considerato essenziale dai partiti e dal sindacato.57 I dirigenti sindacali decisero, nel giugno 1947, di creare la Commissione femminile nazionale, composta da «sei comuniste, sei socialiste, sei democristiane e cinque rappresentanti delle minoranze»,58 sancendo così ufficialmente il ritorno delle donne nell’organizzazione sindacale che avevano dovuto abbandonare con l’avvento del fascismo. 55 «Noi donne», n. 28, 13 luglio 1958, p. 15. «Bollettino unione donne italiane» n. 1-2, febbraio 1953, p. 17. 57 «Noi donne», 25 ottobre 1944. 58 «Notiziario Cgil», n. 8, 20 settembre 1047, p. 16. 56 Il secondo dopoguerra e gli anni Cinquanta 185 Le donne avevano difficoltà a fare lavoro politico e sindacale: la timidezza, la non abitudine a parlare in pubblico, l’estraneità ad una situazione in cui far valere i propri diritti erano le cause di questa difficoltà che colpivano non tanto le dirigenti nazionali ma soprattutto i quadri intermedi e le operaie. «Siamo alle prime armi della vita sindacale democratica; alle prime armi sono le donne ed anche molti uomini».59 Il problema della disoccupazione e del blocco delle attività produttive erano fra i primi da affrontare: il 12 novembre 1945 a Santa Sofia, in provincia di Forlì, le filandiere manifestano per ottenere lo sblocco della seta. In quello stesso anno a Bologna, una delegazione composta dalle rappresentanze femminili della Camera del Lavoro, dell’Udi, dei partiti socialista, comunista, repubblicano e della sinistra cristiana protestano con la direzione della Cassa di Risparmio per il licenziamen«La lotta» 20 maggio 1949, Fondazione Istituto Gramsci Emilia-Romagna, Bologna to di alcune impiegate. Il tema del contratto, del superamento delle disparità salariale e dei licenziamenti erano fra quelli più sentiti in quei primi anni del dopoguerra, sia nelle grandi fabbriche sia nelle piccole attività.60 Ad esempio, scesero in sciopero su questi problemi le sarte bolognesi.61 Una richiesta era ben presente nelle rivendicazioni delle donne, ed era quella di avere strutture tali da sostenere le donne nel loro lavoro: asili, mense e spogliatoi nelle fabbriche, assistenza, colonie per i bambini fra le altre cose e le operaie delle industrie alimentari posero poi all’attenzione un tema estremamente importante: quello della salubrità sul posto di lavoro.62 Nel giugno 1949, durante gravi incidenti a Forlì, causati dall’intervento delle forze dell’ordine nel corso di uno sciopero alla Mangelli, fu gravemente ferita Jolanda Bertaccini.63 In quegli anni si susseguirono licenziamenti di massa, quando si decideva di chiudere, spostare, riorganizzare le industrie, ma anche a sfondo politico quando venivano allontanati i sindacalisti, gli operai e le operaie più attive sul piano politico; le reazioni a queste decisioni prevedevano scioperi ed anche attività di solidarietà per gli operai colpiti dai provvedimenti. A Bologna, emblematica di questa situazione, fu la vicenda della Barbieri e Burzi. Il 5 dicembre si tenne nella fabbrica un’assemblea dei lavoratori contro il licenziamen59 «La lotta», 4 gennaio 1947. Su questo si veda R. ROPA, La presenza delle donne sulla scena pubblica. Lavoro e lotte a Bologna, «Resistenza oggi, quaderni bolognesi di storia contemporanea», giugno 2004. 61 «La lotta», 14 maggio 1948. 62 «La lotta», 28 maggio 1948. 63 Camera dei deputati, resoconto stenografico, seduta di lunedì 17 ottobre 1949, p. 12290. 60 186 Dal regime fascista agli anni Sessanta Bologna. Delegazione di lavoratori della provincia presso lo stabilimento Barbieri e Burzi in solidarietà agli scioperanti, 30 gennaio 1948, Associazione Paolo Pedrelli, Archivio storico sindacale, Bologna Il secondo dopoguerra e gli anni Cinquanta 187 to di Giorgio Barnabà, capofabbrica, contro la nomina di un nuovo vice direttore generale e per l’assunzione di 40 lavoratori, come previsto dall’accordo siglato. Iniziò in quel momento una lunga e dura agitazione che portò all’occupazione e all’autogestione dell’officina. Il blocco delle merci, deciso immediatamente dalle autorità e accolto con commenti positivi su una parte della stampa locale e nazionale, impedì di dare uno sviluppo produttivo significativo all’occupazione e dopo 34 giorni di occupazione, la Camera del Lavoro fu costretta a sospendere la lotta: vennero così confermati il licenziamento di Barnabà e di altri 40 operai.64 Durante questo periodo numerosi furono gli scioperi e le azioni di solidarietà, fu coinvolta tutta la città, e non solo attraverso le pagine dei giornali: le manifestazioni si susseguirono, la popolazione venne invitata a sostenere economicamente la causa dei lavoratori. Anche il Consiglio comunale di Bologna fu coinvolto e la vicenda ebbe eco nazionale tanto che il ministro del Lavoro, Fanfani, tentò senza successo una mediazione.65 L’autogestione continuò per alcune settimane grazie ad azioni di solidarietà organizzata, provenienti in particolar modo dalle campagne. Durante un’altra vertenza, lunga e complessa, si mise in atto lo stesso meccanismo di solidarietà. Facciamo riferimento alle Officine Reggiane. Per protestare contro gli annunciati licenziamenti la fabbrica fu occupata dal 1950 al 1951, quando furono licenziati 5000 lavoratori. Le donne, anche in questo caso, ebbero un ruolo importante per tenere accesa l’attenzione sul problema e per proporre azioni di solidarietà ai lavoratori delle Reggiane. Qualche anno dopo fu una importante fabbrica bolognese a licenziare: nel luglio 1952, 960 dipendenti della Ducati, di cui 600 donne ricevettero una lettera di licenziamento o di sospensione a tempo indeterminato. Il 27 luglio i sindacati indissero uno sciopero generale in tutta la provincia contro il tentativo di liquidazione dell’azienda. Nel 1954 vi furono scioperi alla Pancaldi in seguito ai quali furono sospese 12 lavoratrici, fra cui le due della commissione interna. In questa fabbrica le donne scioperarono anche nel 1961. Le operaie Scriveva all’inizio degli anni Cinquanta Camilla Ravera: Nelle fabbriche, nelle manifatture, nei laboratori, nelle aziende varie lavorano oggi milioni di donne. La conquista del posto di lavoro costa pesanti e faticose ricerche, insistenze, lotte: la strada per arrivare all’occupazione è dura e penosa per tutti in Italia; ma durissima e cosparsa di particolari amarezze e umiliazioni per le donne, a cui si vuole concedere il lavoro soltanto a condizione che esso costi meno dell’eguale lavoro maschile, che esoneri il più possibile dagli obblighi e contributi dell’assistenza e della previdenza sociale, e dal rispetto delle qualifiche, delle carriere e così via.66 Nei primi anni del dopoguerra le donne costituivano gran parte dei due milioni di disoccupati registrati, soprattutto a causa della ristrutturazione dell’industria tessile e 64 MAURO BOARELLI, Strategie del conflitto: la vertenza «Barbieri e Burzi». Distretti, imprese, classe operaia. L’industrializzazione dell’Emilia-Romagna, a cura di Pier Paolo D’Attorre, Vera Negri Zamagni, Milano, Franco Angeli, 1992. 65 «Progresso d’Italia», dal 27 gennaio al 1° febbraio 1948. 66 CAMILLA RAVERA Parole semplici e vere alle donne italiane, s-l., s.d., p. 1. 188 Dal regime fascista agli anni Sessanta manifatturiera ad altissima composizione operaia femminile. La presenza delle donne nelle fabbriche era però una realtà ormai consolidata: nel 1951, le donne erano il 28% con cifre che aumentavano. In Emilia-Romagna nel 1951 vennero censite 90.557 donne che lavoravano in fabbrica e 324.821 uomini. Negli anni dal 1954 al 1961 vi fu un aumento complessivo di due milioni e 300 mila unità circa di occupati in questo settore e fra questi un milione e 300 mila erano donne. Nel 1958 il 30,3% delle donne occupate lo erano nel settore industriale. Fino alla fine degli anni Cinquanta le condizioni del lavoro operaio delle donne nell’industria, italiana ed europea, erano ancora molto difficili; molto spesso i peggiori posti di lavoro, quelli con una paga bassa, in stabilimenti disagiati, in locali non riscaldati, erano riservati alle donne a cui si affidavano i lavori monotoni, in Italia e in Europa.67 Sulle donne gravava anche il peso, al di fuori della fabbrica, delle molte responsabilità nella gestione del ménage familiare. La carenza di strutture, così come già accennato, peggiorava la situazione. Affermava Laura Diaz in un intervento al Parlamento: non abbiamo purtroppo ancora trovato chi efficacemente sappia dire tutto il doloroso carico di fatica di milioni di donne italiane, le quali, uscendo esauste dalla porta della fabbrica, trovano a casa il fardello delle cure domestiche, i mastelli di panni da lavare, i fornelli cui accudire, le stoviglie da governare, le cure morali e materiali da dedicare al marito ed ai figli. È disarmante ed amaro il constatare come questo umiliante stato di doppio sfruttamento operato sulla donna continui a d essere non soltanto accettato da buona parte dell’opinione pubblica, in prevalenza maschile, ma considerato persino come una condizione normale. E non è comprensibile, onorevole Fanfani, l’asserito desiderio suo, del Governo e della maggioranza che lo sostiene, di affrontare indirizzi di rinnovamento della società senza dedicare nemmeno una piccola parte del programma governativo a questi aspetti della condizione della società in cui viviamo. La società italiana, e non soltanto la donna, ha bisogno di un ampio sviluppo della rete dei servizi sociali. E chiarisco subito che per servizi sociali intendo il complesso di strumenti rivolti a conciliare l’espletamento dei doveri familiari della donna con il suo lavoro extradomestico, con il suo diritto al lavoro extradomestico.68 Le donne cercavano di alleviare ed organizzare meglio il loro lavoro, chiedendo, creando, gestendo strutture come quelle dedicate all’infanzia a cui si è fatto cenno. Un’altra iniziativa che venne presa in quegli anni fu la richiesta di avere l’istituzione del servizio pubblico di lavatrici meccaniche. Nel 1955 il progetto venne realizzato, in via sperimentale, grazie al contributo del comune di Bologna che aveva dovuto superare gli ostacoli posti dalla Giunta provinciale amministrativa che non riteneva di poter approvare questa spesa. Vi fu l’apertura di un primo servizio e quindi solo nel 1957 vennero aperte otto lavanderie in altrettanti punti della città. Superate le prime diffidenze – la paura che «la macchina» potesse rovinare la biancheria – le donne si trovarono soddisfatte del servizio. Gli uomini erano, e rimasero, un po’ spiazzati dalle novità: «mia moglie da trent’anni fa il bucato da sé; cosa sono tutte queste novità», affermavano. Le donne cercavano, quindi, di portare la loro attività all’esterno dell’ambito domestico, si impegnavano nel lavoro, nella politica, nell’amministrazione, si ponevano fuori dal modello conosciuto. «Io non capisco, non capisco proprio, cosa vogliono fare le 67 MICHÈLE AUMONT, Femmes en usine: les ouvrières de la métallurgie parisienne, Paris, Spes, 1953. Resoconto stenografico, Intervento di Laura Diaz, III legislatura - discussioni - seduta antimeridiana dell’8 marzo 1962, pp. 27911 ss. 68 Il secondo dopoguerra e gli anni Cinquanta 189 Bologna. Asilo della cooperativa operai fornaciai, anni ‘50, Centro italiano di documentazione sulla cooperazione e l’economia sociale, Bologna. donne oggi. Non vogliono più tenere i figli, non vogliono più lavare, ma che cos’è che volete fare?», affermava un po’ smarrito, un assessore del comune di Bologna.69 Le donne continuarono ad essere prevalenti in industrie quali quelle tessili, ora non più filande della seta ma produttrici di tessuti diversi, quelle alimentari, quelle chimiche. Ma non mancava la loro presenza in tutti i settori industriali. A partire dalla seconda metà degli anni Cinquanta le donne espulse dal manifatturiero tradizionale e quelle che arrivavano dalla campagna, furono assunte in quei settori dove la meccanizzazione dei processi produttivi permetteva la sostituzione della manodopera maschile qualificata; produzione di massa ed accentuazione della quantità rispetto alla qualità portano alla richiesta di una manodopera flessibile, mobile, dequalificata, sottopagata, caratteristiche queste che storicamente connotano la forza lavoro femminile. Aumentarono gli occupati nell’industria, mutarono i settori industriali di maggior sviluppo, aumentarono i consumi, cambiarono le aspirazioni e le richieste di uomini e donne. Vi fu una attenzione diversa anche da parta dei mass media al lavoro della donna: nel 1958 venne trasmessa in televisione una delle prime inchieste sul lavoro femminile, La donna che lavora, curata da Ugo Zatterin e Giovanni Salvi. L’inchiesta di otto puntate prendeva in considerazioni i diversi settori del lavoro della donna e metteva in luce il doppio ruolo a lei affidato, il lavoro esterno e lavoro interno alla famiglia, attraverso le testimonianze dirette di mondine, paglierine, operaie, commesse e madri di famiglia. La fine degli anni Cinquanta, il 1958, segnarono un radicale mutamento nella storia economica e sociale italiana: si entrava nel cosiddetto boom economico. 69 VITTORINA TAROZZI, Lavatrici meccaniche, nuovo servizio sociale, in Comunisti, i militanti bolognesi del PCI raccontano, Roma, Editori Riuniti, 1983, pp. 263-265. 190 Dal regime fascista agli anni Sessanta Il lavoro a domicilio: mutamenti e persistenze Nel 1950 Teresa Noce, che era stata segretaria del sindacato dei tessili, e Giuseppe Di Vittorio proposero un disegno legge per la regolamentazione del lavoro a domicilio, disegno che decadde nel 1950 a causa dello scioglimento delle Camere. La proposta di legge, oltre a definire il lavorante a domicilio e l’imprenditore che si avvaleva del lavoro a domicilio, vietava l’intermediazione (art. 2), stabiliva il sistema da adottare per la retribuzione (art. 6) e garantiva ai lavoranti a domicilio il trattamento riservato ad ogni altro lavoratore per ciò che riguardava le festività, la gratifica e l’indennità di licenziamento (art. 10). In alcune regioni come l’Emilia e la Toscana già dalla fine degli anni Quaranta erano state avanzate richieste perché venisse approvata una legge capace di tutelare i lavoratori, o per meglio dire le lavoratrici, a domicilio. Nel 1948, ad esempio, a Reggio Emilia la commissione femminile del sindacato, ancora unitario, organizzò la Conferenza della donna reggiana lavoratrice a cui parteciparono 5000 donne. In quell’occasione fu approvato da tutte le rappresentanti delle diverse correnti un documento che, oltre a sancire i principi del diritto al lavoro e della parità salariale, affrontava proprio il problema del lavoro a domicilio.70 Il disegno di legge fu ripresentato nel 195471 e il 13 marzo 1958 fu approvata la legge di regolamentazione del lavoro a domicilio. Questa legge, accogliendo le proposte contenute nel progetto Noce-Di Vittorio, allargava la definizione di «lavorante a domicilio»; eliminava la figura dell’intermediario; obbligava gli imprenditori che intendevano affidare lavoro a domicilio ad iscriversi in un apposito registro presso l’ufficio provinciale del lavoro. Inoltre, con questa legge, le lavoranti a domicilio vennero equiparate alle altre lavoratrici per la tutela della maternità. L’applicazione della legge risultò troppo macchinosa e largamente inevasa, lasciando il lavoro a domicilio in un’area di sfruttamento delle donne. Anche questo settore andava mutando: da lavoro che coinvolgeva soprattutto le donne contadine, come impiego complementare o sostitutivo di quello agricolo, diventava una occupazione strettamente legata all’espansione economica e dei cambiamenti della produzione industriale. Soprattutto nei settori produttivi come il tessile, l’abbigliamento, la ceramica e l’industria chimica, in particolare il settore farmaceutico e cosmetico e quella delle materie plastiche il lavoro a domicilio, sottopagato e facilmente «in nero», permetteva di fare fronte alla concorrenza senza dover effettuare importanti innovazioni strutturali negli opifici.72 Nel reggiano, nel carpigiano, in tutta l’Emilia-Romagna, era estremamente diffuso questo particolare tipo di lavoro, visto che era presente una tradizione ormai centenaria della lavorazione della paglia, del truciolo e del cappello, che occupava, soprattutto nei mesi invernali, centinaia di lavoratrici la cui paga – molte volte l’unica fonte della famiglia – era di appena 30 o 50 lire per treccia. La paga di una lavoratrice trecciaiola che lavorava dalle 12 alle 15 ore al giorno era di L. 150-300.73 Tradizionalmente le trecciaiole lavoravano a casa propria, d’inverno nella stalla, ed erano pagate a seconda del numero di trecce prodotte ed i guadagni derivati da questa 70 P. GAIOTTI DE BIASE, La donna nella vita sociale e politica cit., p. 225. Camera dei deputati, Atti Parlamentari - Documenti - Disegni di legge e Relazioni, vol. XXIV. 72 RINA PICOLATO, La piaga sociale del lavoro a domicilio, «Rinascita», n. 6, giugno 1957, pp. 283-284. 73 P. GAIOTTI DE BIASE, La donna nella vita sociale e politica cit., p. 224. 71 Il secondo dopoguerra e gli anni Cinquanta 191 attività rappresentavano una cospicua fonte di reddito per le famiglie, ma con differenze tra la famiglia bracciantile e quella mezzadrile o contadina. Nella prima tutti facevano la treccia, uomini, donne e bambini. I guadagni che ne derivavano servivano quasi sempre, soprattutto nel periodo invernale quando per gli uomini non c’era lavoro, a mantenere la famiglia. Si faceva la treccia per comprare da mangiare. Nella famiglia contadina invece erano le donne e i bambini che facevano la treccia. Nel 1950 le donne di Lavino, nel Bolognese, guadagnavano 36 lire al giorno lavorando la paglia.74 Quando cominciò il tramonto di questo tipo di produzione, si cominciò a lavorare con le confezioni: camicie, maglie, pantaloni. Massiccia era la presenza di occupazione femminile nel lavoro a domicilio, la cui composizione sociale variava dalle operaie tradizionali a quelle licenziate dalla fabbrica, alle donne di famiglie artigiane, alle mezzadre e alle braccianti, così come notevole era il divario tra il salario di queste lavoratrici e quello delle operaie di fabbrica che risultava intorno al 60-70%: per realizzare un salario che potesse avvicinarsi a quello dell’operaia, le lavoratrici a domicilio dovevano lavorare «13-14 ore al giorno, senza alcuna tutela assicurativa, senza usufruire delle normali indennità contrattuali di fine anno, per ferie, festività, gratifica natalizia».75 Anche questo fu un tema affrontato nelle rivendicazioni sindacali e quando la Snia Viscosa annunciò la smobilitazione della fabbrica, lavoratrici a domicilio e operaie si unirono in una lotta che riuscì ad imporre al nuovo proprietario, la Bloch, il riconoscimento della parità di salario a parità di produzione.76 Il lavoro a domicilio, seppur sottopagato e non regolamentato, era a volte indispensabile per far quadrare il magro bilancio familiare. Lo si afferma in una inchiesta condotta nel 1955 sul periodico «Noi donne». Ave è una sposa di Correggio. Ha due figli e con lei vive la vecchia mamma. Suo marito lavora in una fabbrica di prodotti alimentari ed alla fine del mese, se tutto va bene, riesce a portare a casa una trentina di mila lire. Mille lire al giorno per cinque persone, senza contare luce, fitto, gas ed altre spese. La famiglia non va avanti. Ava cerca un lavoro. Ma le fabbriche continuano a licenziare, anziché assumere. Un bel giorno infine, Ave trova una possibilità di lavoro a Carpi, in provincia di Modena, stanno sorgendo come funghi piccole e grandi industrie d’abbigliamento. Non assumono in fabbrica, ma a chi sia capace di lavorare di cucito danno lavoro da portare a casa.77 Nel marzo del 1962, Giorgio Bocca, in una serie di articoli pubblicati su «Il Giorno» scriveva raccontando del carpigiano, zona in cui il lavoro a domicilio era, da sempre, estremamente presente e dove, in questa fine degli anni Cinquanta, la produzione di maglieria si affiancava a quella delle trecce, fino a sostituirla: centinaia di fabbrichette con il nome dell’azienda sopra: Clorinda, Miriam, Lucy, Giba, Noemi, Effegi, Globus, Marilyn, Magic, a volte i nomi delle mogli e delle figlie, un miraggio paesano della Bassa. Sono fabbrichette strane, magari senza una macchina e con poche operaie ma capaci di fornire quantità inverosimili di maglie. Più che fabbriche, luoghi di recapito e di smistamento per le lavoranti a domicilio, ma sì, quelle lunghe fila di donne in bicicletta con i fagotti appoggiati sul manubrio, matasse di lana se rincasano, maglie se vanno in azienda. Nelle aziende si rifinisce il lavoro e si commercia. 74 «L’Unità», edizione di Bologna, 21 gennaio 1950. R. PICOLATO, La piaga sociale del lavoro a domicilio, «Rinascita», n. 6, giugno 1957, pp. 283-284. 76 P. GAIOTTI DE BIASE, La donna nella vita sociale e politica cit., p. 225. 77 «Noi donne», n. 47, 27 novembre 1955. 75 192 Dal regime fascista agli anni Sessanta Soliera-Modena. Lavorante a domicilio su macchina per la produzione di teli per maglieria, ca. 1960, Archivio comune di Soliera, Fotomuseo Giuseppe Panini, Modena Il secondo dopoguerra e gli anni Cinquanta 193 Carpi nel 1961 esportò prodotti per trenta miliardi, ovvero la metà dell’esportazione nazionale. Solo una piccola parte di queste maglie erano prodotte dagli operai interni alle fabbriche, la maggior parte della produzione veniva fatta dagli oltre 47.000 lavoranti a domicilio distribuiti fra la provincia di Modena e le altre province limitrofe.78 Nel 1963 era più di un milione la stima che si poteva fare sul numero di donne che lavoravano a domicilio, a volte aiutate dai bambini e dai genitori. In questa sorta di «fabbriche» famigliari venivano eseguiti lavori di vario tipo: dipinte ceramiche, impacchettati prodotti chimici, avvolte bobine, intrecciati cappelli e cestini, confezionate maglie e camicie. I salari continuavano ad essere molto bassi, in provincia di Modena, ad esempio, si andava dalle 105 lire giornaliere alle 250, secondo i dati ricavati da un questionario effettuato dai sindacati sovente le lavoratrici a domicilio dovevano anche acquistare la macchina su cui lavoravano. Le donne che lavoravano a casa loro ricevevano, mediamente, uno stipendio all’ora pari al 56% di quello percepito dalle operaie.79 La campagna Nel 1947 vi erano nella provincia di Bologna circa 45.000 famiglie di lavoratori agricoli, vi sono quindi 45.000 massaie che sopportano assieme al marito, quando addirittura non sono vedove, il peso della famiglia, spesso molto numerosa, che arriva in certi casi ai 20-25 componenti e che ha sempre una media dai 4 ai 9 componenti. Oltre a queste ve ne sono altre migliaia che esplicano il loro lavoro nei campi. In tutto noi abbiamo nella provincia di Bologna circa 50.000 donne che hanno come occupazione principale quella agricola ed altre, circa 35.000, che, sempre di famiglia agricola, si dedicano all’agricoltura solo saltuariamente. Vi sono le braccianti e mondine, in tutto circa 24.000, le donne delle famiglie dei mezzadri, dei fittavoli, dei piccoli proprietari coltivatori diretti.80 Alcuni mestieri della campagna ancora esclusivamente femminili, come quello della monda del riso, alla vigilia del boom andavano scomparendo per diversi motivi. Innanzitutto i cambiamenti economici e tecnologici, quindi la volontà delle donne di cambiare mestiere. Nonostante questo, per tutti gli anni Cinquanta la monda era ancora molto praticata come nei secoli precedenti; un mestiere faticoso, sottopagato, insalubre. Renata Viganò definiva la monda un mestiere «retorico»,81 tanto che le braccianti molto spesso vennero rappresentate proprio durante la monda, «mestiere da donna» e quindi, faticoso e sottopagato.82 78 LUISA CIGOGNETTI, MARIO PEZZINI, Dalle paglie alle maglie. Carpi: la nascita di un sistema produttivo, in Distretti, imprese, classe operaia cit, pp. 157-190. 79 PIERPAOLO LUZZATTO FEGIZ, Il volto sconosciuto dell’Italia dieci anni di sondaggi Doxa, Milano, Giuffrè, 1956. 80 «La lotta», 7 marzo 1947. 81 RENATA VIGANÒ, Mondine, Modena, Arti grafiche modenesi, 1952, p. 25. 82 FRANCO CAZZOLA, MANUELA MARTINI, Il movimento bracciantile in area padana, in PIERO BEVILACQUA, Storia dell’agricoltura italiana in età contemporanea, II, Uomini e classi, Venezia, Marsilio, 1990, pp. 773-774. 194 Dal regime fascista agli anni Sessanta Dopo la retorica del fascismo, il film «Riso amaro», le descrizioni un po’ fantasiose e mitizzate che in letteratura erano state fatte, le mondine rivendicavano che vi fosse una descrizione precisa del loro lavoro. Scriveva Davide Lajolo: ricordi, mi dicevi di dire chiaro sui giornali che era tempo di farla finita con il colore, le storielle, le invenzioni allegre sulle mondine? Scrivete la verità, quello che siamo e come lo siamo e la gente ci capirà di più.83 Per le donne che partivano verso le risaie lontane, il viaggio era fatto sui treni bestiame, «cavalli otto, uomini quaranta, ma le mondine anche in settanta» scriveva Renata Viganò.84 Sui carri bestiame, perché alle mondine era vietato salire sui treni passeggeri, come fecero presente alcune deputate in una interpellanza parlamentare nel 1951.85 Nella proposta di legge sul lavoro delle mondine presentata in Parlamento nel 1953 un articolo prevedeva esplicitamente che fosse «in ogni caso vietato il trasporto delle lavoratrici mediante vetture o veicoli non destinati originariamente al trasporto di persone». Nel 1956 venne decisa la diminuzione di coltivazione del riso, ma, nonostante questo, alla vigilia del boom, nel 1958, per la prima volta si invertì la situazione: ovvero la richiesta di manodopera era superiore all’offerta, forse perché le donne «Al lavoro faticoso e insalubre della risaia preferiscono altri lavori, di maglieria, di sartoria, eseguiti a domicilio».86 Nel decennio 1950-1960 ebbe inizio il cosiddetto processo di femminilizzazione delle campagne causato da mutamenti economico-sociali: L’espansione del settore industriale richiamava manodopera maschile provocando un esodo dalle campagne e la donna sostituiva il marito; in tale periodo la presenza delle donne aumentò significativamente contro una presenza maschile ridottasi di quasi la metà87 e molte donne furono costrette ad assumere il ruolo di capofamiglia diventando così soggetti visibili anche nelle rilevazioni statistiche.88 Il processo di femminilizzazione dell’agricoltura condusse alla presenza delle donne nella direzione delle aziende, soprattutto di quelle cooperative: percorso lungo e complesso che trovò una sua prima realizzazione proprio alla fine degli anni Cinquanta. Ad esempio nella cooperativa agricola di Baricella nel 1957 furono elette, per la prima volta, quattro donne alla direzione. Le donne chiedevano poi di potersi specializzare, ma non sempre erano ascoltate, come sottolinearono le donne di Castelfranco Emilia alla Conferenza delle donne della campagna emiliana tenutasi a Ferrara nel 1962: esiste ancora molta prevenzione nei nostri confronti: lavoriamo come gli uomini, ma se chiediamo una scuola per la specializzazione agricola delle donne per diventare trattoriste, potatrici, magari anche agronome, tutti ci rispondono con una risata.89 83 «Noi donne», n. 23, 6 giugno 1945, p. 5. R. VIGANÒ, Mondine cit., p. 60. 85 Camera dei deputati, resoconto stenografico, seduta 28 giugno 1951. 86 «Annuario dell’agricoltura italiana», 1959, citato in GUIDO CRAINZ, Storia del miracolo italiano, Torino, Donzelli, 2005, p. 72. 87 AMALIA SIGNORELLI, Il pragmatismo delle donne. La condizione femminile nella trasformazione delle campagne, in Storia dell’agricoltura in età contemporanea , vol. II, Venezia, Marsilio, 1990, p. 630. 88 F. TARICONE, Le donne di Coldiretti , Percorsi e strategie (1953-2003), Roma, B&C Editoria, 2003, p. 69. 89 «Noi donne», n. 6, 11 febbraio 1962. 84 Il secondo dopoguerra e gli anni Cinquanta Ferrara. Donna specializzata in potatura, «Noi donne», n. 10, 7 marzo 1964, Fondazione Istituto Gramsci Emilia Romagna, Bologna 195 196 Dal regime fascista agli anni Sessanta Un esempio di questa volontà di specializzazione fu, ad esempio, il seguire il corso per potatrice tenuto a Ferrara. «È una bellezza discutere da pari a pari con gli uomini e decidere insieme come va fatta la potatura o a quali condizioni vendere la frutta»90 affermava una delle quattro donne iscritte al corso, donne con una scolarità bassa, come era comune nelle campagne, donne che in quel momento restavano una eccezione ma che, comunque, mostravano una nuova tendenza. Mestieri e professioni Le donne ebbero, in questo secondo dopoguerra, in una Regione come quella emiliano-romagnola un importante ruolo all’interno delle cooperative di lavoro. Durate il regime fascista le cooperative, sorte nel primo dopoguerra, vennero dapprima aggredite dalle squadre armate e poi proibite e, infine, fascistizzate. Non tutta la cooperazione che aveva avuto salde radici nel Nord Italia nel primo ventennio del Novecento, era stata però completamente distrutta dal fascismo: alla caduta del regime nel 1943 vi erano in Italia oltre 12.000 cooperative con più di tre milioni di soci.91 Nelle cooperative di consumo molto esigua era la presenza femminile, 13.101 nel 1934 su un totale di 329.984; questo nonostante che queste fossero le cooperative in cui le donne erano maggiormente presenti. Esistevano comunque, nel 1928, cooperative «di lavori donneschi».92 Nel dopoguerra le cooperative erano viste come uno strumento efficace per riparare ai danni della guerra che si era appena conclusa, una guerra che, come è noto, era stata devastante non solo per la popolazione ma anche per il territorio e le strutture agricole, artigianali e industriali. Anche per questo l’attenzione verso le cooperative era molto viva, tanto che già nel periodo della clandestinità i dirigenti del Comitato di Liberazione Nazionale diedero indicazioni per la creazione di nuove cooperative o per la ricostruzione di quelle distrutte durante il ventennio93 e, nel 1945, a Roma venne rifondata la Lega a cui aderirono cooperatori che si richiamarono ai partiti comunista, socialista, repubblicano, liberale, alla democrazia del lavoro, al partito d’azione e alla sinistra cristiana. I cooperatori cattolici rifondarono la Confederazione delle cooperative. Tra il 21 aprile e il 31 dicembre 1945 nella provincia di Bologna furono effettivamente costituite oltre 250 aziende autogestite94 e nel 1951 le cooperative esistenti in Italia erano circa 25.000.95 Nel febbraio 1946 venne costituita la Direzione generale della cooperazione e nel maggio 1947 fu approvato dall’Assemblea Costituente quello che divenne l’articolo 45. 90 «Noi donne», n. 10, 7 marzo 1964. MASSIMO FORNASARI, VERA ZAMAGNI, Il movimento cooperativo in Italia. Un profilo storicoeconomico (1854-1992), Firenze, Vallecchi, 1997, p. 145. 92 MARIO MARAZZITTI, ROBERTO SANI, La cooperazione femminile nel periodo fascista: ideologia ed esperienza, in L’audacia insolente la cooperazione femminile 1886-1986,Venezia, Marsilio, 1986, pp. 147-150. 93 VALERIO CASTRONOVO, Dal dopoguerra a oggi, in Renato Zangheri, Giuseppe Galasso, Valerio Castronovo, Storia del movimento cooperativo in Italia la Lega nazionale delle cooperative e mutue 1886-1986, Torino, Einaudi, 1987. pp. 498 e ss. 94 LUIGI ARBIZZANI, NAZARIO SAURO ONOFRI, GIULIANA RICCI GAROTI, L’unione di mille strumenti Storia della cooperazione bolognese dal 1943 al 1956, Bologna, Editrice Emilia-Romagna, 1991 p. 95. 95 M. FORNASARI e V. ZAMAGNI, Il movimento cooperativo in Italia. Un profilo storico-economico (1854-1992) cit., p. 145. 91 Il secondo dopoguerra e gli anni Cinquanta 197 Anche a Modena vennero riattivate cooperative e ne sorsero di nuove già prima della Liberazione, quasi per un impulso spontaneo ad associarsi per risolvere i problemi legati alla disoccupazione, alla ricostruzione ed alle difficoltà nel reperire merci e prodotti di sostentamento. Si formarono anche in quella realtà cooperative di consumo, agricole, di lavoro e di servizio, cantine sociali, latterie e fu rinsaldato il rapporto donne-cooperative: a Modena, nella primavera del 1948, si era costituita in seno alla Federazione Provinciale delle Cooperative e Mutue di Modena una sezione femminile che organizzò il 29 agosto 1948 il primo Convegno Provinciale delle Donne Cooperatrici.96 Le donne erano presenti nelle cooperative, in quelle agricole, nelle cooperative di consumo, come impiegate negli uffici delle varie organizzazioni cooperative, ma erano anche protagoniste e fondatrici di cooperative come quelle in cui si riunivano le sarte. A Bologna, il 25 ottobre 1948, venne costituita da 25 sarte una cooperativa, nel 1954 la Cooperativa Abbigliamento contava 300 socie e nel 1960, dodici anni dopo la sua fondazione, i soci erano oltre 500, tra cui una decina di uomini.97 Cooperative simili nacquero, anche per iniziativa dell’Udi, in molte località della Regione allo scopo di «eliminare la speculazione degli intermediari» e di assicurare un adeguato guadagno alle socie. Fra queste, ad esempio, cooperative di magliaie a Carpi, di sarte e pantalonaie a Reggio Emilia, delle lavoratrici della paglia a Scandiano. In seguito nacquero nella provincia di Ravenna cooperative di sarte, magliaie, parrucchiere ed anche per la lavorazione delle canne palustri. Se queste cooperative erano legate all’Udi e alla Lega nazionale delle cooperative, anche le organizzazioni cattoliche, il Cif fra le altre, si occuparono di cooperazione femminile nell’ambito della produzione soprattutto nell’ambito dei lavori «esclusivamente muliebri», ovvero sartorie, ricami e così via. Scriveva nel febbraio 1948 Vittoria Fabris sul settimanale della Confederazione delle cooperative: la cooperativa fra lavoranti a domicilio ha una fondamentale finalità sociale: quella di riportare la donna al lavoro a domicilio, mantenendola così nella sua posizione naturale di madre, sposa, figlia. È evidente che ciò in vista dei riflessi morali e spirituali ha grande rilievo per la solidità del nucleo famigliare. La donna infatti è il perno su cui gravita l’ordine della famiglia.98 A Bologna sorse nel marzo 1951 una cooperativa legata all’Azione Cattolica, denominata Artico, in cui una quarantina di operaie si erano riunite per confezionare abiti, biancheria, abiti da lavoro.99 Ruoli ‘femminili’, quindi, e cooperative che si occupavano di lavori ‘femminili’, così come era nell’immagine tradizionale della donna. Un altro mestiere da donne era, lo abbiamo visto, quello dell’insegnamento. Nell’Italia del secondo dopoguerra il mondo della scuola continuava ad essere un luogo frequentato dalle donne: alle elementari e alle scuole d’infanzia le donne, considerate ancora come seconde mamme, erano molto o esclusivamente presenti. Ancora, crescendo i bambini, alle scuole medie e alle 96 Io, noi, le cooperative le donne della cooperazione modenese raccontano, a cura di Gabriella Vignudelli, Modena, Edizioni apm, 2005, pp. 6-7. 97 REMIGIO BARBIERI, Diecimila capi di maglieria esportati dalle sarte di Bologna, «Centro italiano della moda», 15 novembre 1960. 98 MARCO GALLO, FRANCESCO DI DOMENICANTONIO, Cooperazione femminile, emancipazione della donna. Mondo cattolico (1945-1955), in L’audacia insolente la cooperazione femminile cit., p. 178. 99 «Azione muliebre», marzo 1951, pp. 18-20. 198 Dal regime fascista agli anni Sessanta Sarte della cooperativa abbigliamento di Bologna, ca. 1960, Centro italiano di documentazione sulla cooperazione e l’economia sociale, Bologna superiori, diminuiva la presenza dei docenti di sesso femminile, per essere esiguo all’università,100 in Italia e nel contesto internazionale.101 In Emilia-Romagna su 17.388 maestri, censiti nel 1951, gli uomini erano solo 3600; in Italia su un totale di 224.542 gli uomini erano 58.630. Gli Istituti magistrali, le Facoltà di Magistero erano frequentati per la maggior parte da donne; nella Facoltà di Bologna, ad esempio, nel 1955, anno di fondazione, il totale degli iscritti era 201, di cui 148 donne; dieci anni dopo su 673 iscritti, 547 erano le donne.102 Il giornale locale di Bologna si lamentava che le donne avessero preso troppi posti nell’istituzione scolastica, avevano «stravinto», arrivando «al punto che mentre gli uomini sono esclusi dalla direzione di certi istituti femminili, la professoressa può diventare preside di un liceo». In effetti erano state abolite le limitazioni risalenti al periodo fascista. L’articolista de «Il Resto del carlino» proseguiva poi affermando che la scuola «dopo la macchina da scrivere e la cuffia telefonica, è stata la prima preda delle donne 100 Enciclopedia della donna, a cura di Dina Bertoni Jovine, Roma, Editori Riuniti, 1965, vol. II, pp. 244-245. Si veda anche TINA TOMASI, Dalla scuola normale al liceo magistrale, «Scuola e città», giugno-luglio 1965, pp. 425-430. 101 ROBERT W. CONNELL, Questioni di genere, Bologna, il Mulino, 2006. 102 Da Magistero a scienze della formazione. Cinquant’anni di una Facoltà innovativa dell’Ateneo bolognese, Bologna, Clueb, 2006, p. 676. Il secondo dopoguerra e gli anni Cinquanta 199 emancipate». In questa situazione di scuola ‘femminilizzata’, concludeva il giornalista «le parole dell’apostolo Timoteo “non permetto alla donna di fare da maestra” acquistano un forte sapore di ironia».103 Un mestiere femminile, e che durante il fascismo era stato ulteriormente femminilizzato, era quello dell’infermiera. Nel 1951 infatti su 1404 persone che facevano questo mestiere gli uomini erano solo 325, in Italia il totale era 16.648 e gli uomini 3.257. Nell’ambito delle professioni mediche e paramediche, le ostetriche continuavano ad essere solo donne, mentre i dentisti quasi esclusivamente maschi (solo sei le donne dentiste in Regione su un totale di 226; 2336 gli uomini dentisti in Italia sul totale di 2411); anche i medici erano ancora in prevalenza uomini, e non poteva essere che così visto il poco tempo passato dalla fine del fascismo e della seconda guerra mondiale. Il terziario era un altro campo in cui la presenza femminile si era fatta evidente, come già detto: negli anni Cinquanta si ebbe un aumento delle presenze del 32% per le donne e del 30% per gli uomini.104 In uffici privati e pubblici le donne erano quindi presenti e «La Domenica del Corriere», ritenne necessario dare dei suggerimenti alle impiegate. Fra questi possiamo leggere: abbiate cura della vostra persona, non fate la «civetta» in ufficio: potrebbe anche costarvi il posto. Siate eleganti, con giudizio: cercate di evitare gli abiti troppo sfarzosi. Siate riservata, siate seria. Non mangiate né fumate in ufficio. Non siate troppo zelante, non siate pettegola. Abbiate una vita vostra, frenate il cuore, se possibile.105 Il contatto con il pubblico, con gli altri impiegati, con il capoufficio e il direttore poteva esporre la donna a rischi, secondo una certa mentalità, tanto che il professor Emilio Zanini scriveva nel 1961: là dove negli opifici, nei laboratori, nei servizi pubblici e privati, negli uffici il lavoro di svolge con promiscuità. In un’atmosfera materialistica lontana dalla concezione cristiana, là dove i dirigenti, i capiufficio, i capireparto indulgono sulla licenziosità dei discorsi che si svolgono durante i riposi e sulla lettura di pubblicazioni illecite, le donne, specie le nubili e le giovanissime, si vengono a trovare in condizioni di grave disagio e se non sono difese da una retta educazione, da una adeguata formazione religiosa e da una forte volontà, possono accedere a deviazioni, non di rado di indubbia gravità.106 Negli uffici privati, a volte non erano rispettate le condizioni previste dai contratti e dagli obblighi assicurativi. Per «pigrizia o in odio a tutte le noiose pratiche sindacali e assicurative», come scrive il giornale delle donne cattoliche «Donne d’Italia», cosa che le donne accettavano quasi sempre «specie quando la necessità di lavorare è prepotente. Perché anche le donne impiegate lavorano per bisogno o per desiderio di indipendenza».107 Le impiegate di Bologna e provincia, riunite in assemblea, secondo il resoconto pubblicato da «La lotta» nel 1947 rilevavano 103 «Il Resto del Carlino», 13 dicembre 1950, p. 3. Camera dei deputati, resoconto stenografico, III legislatura - discussioni - seduta antimeridiana dell’8 marzo 1962, pp. 27911. 105 «La lotta», 11 luglio 1948, p. 10. 106 EMILIO ZANINI, Il lavoro della donna nella società italiana di oggi, La donna e le professioni, Atti del convegno di studi organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, 5-8 settembre 1961, Milano, Società editrice Vita e Pensiero, p. 42. 107 «Donne d’Italia», n. 10, ottobre 1954, pp. 8-9. 104 200 Dal regime fascista agli anni Sessanta la necessità da parte degli organi dello stato di un maggiore interessamento per le impiegate; la necessità che la Camera del lavoro locale e la Confederazione generale del lavoro intensifichi la sua azione per inquadrare nelle sue file tutte le impiegate degli studi professionali, dando anche a queste lavoratrici la possibilità di usufruire di un contratto di lavoro che permetta loro una vita dignitosa.108 Nel dopoguerra, e per tutti gli anni Cinquanta la presenza delle donne negli uffici pubblici continuò a sollevare delle polemiche, e non solo per la loro «moralità»: si chiedeva, da più parti, il loro allontanamento adducendo la necessità di fare spazio agli uomini. Nel 1945 era stato chiesto di ripristinare la legge del 1938 inerente i limiti della presenza femminile negli uffici pubblici, «Siamo stufi di vedere “segnore” e “segnorine” impiegate dello Stato le quali a noi uomini l’impiego hanno levato», si affermava. La legge non venne ripristinata, nelle amministrazioni pubbliche rimasero le donne. La percentuale femminile continuò a salire, anche se solitamente per le donne era difficile fare carriera, sia per la presenza di una mentalità ostile sia per alcuni regolamenti o provvedimenti legislativi quale quello del 7 maggio 1948, n. 557 con il quale le donne – pur riammesse ai concorsi per il personale tecnico di vigilanza presso l’Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti – venivano espressamente escluse (art. 2) da quelli per l’accesso ai gradi più elevati. Non tutte le carriere erano veramente possibili per le donne e le vere discussioni si fecero quando esse chiesero di entrare – così come la Costituzione sanciva – nelle professioni da sempre considerate maschili. La presenza delle donne in magistratura è il cuore di questa situazione. Il 7 novembre 1947, nella seduta pomeridiana dell’Assemblea Costituente, nell’ambito del dibattito sull’assetto da dare alla magistratura, l’onorevole Giuseppe Bettiol, democristiano e laureato in giurisprudenza, dichiarava: San Paolo diceva «Tacciano le donne nella Chiesa», se San Paolo fosse vivo direbbe «Facciano silenzio le donne anche nei tribunali», cioè non siano chiamate le donne ad esplicare questa funzione, la quale può arrivare (per fortuna noi abbiamo in parte eliminato questo pericolo) a pronunziare una sentenza di morte. Perché il problema dell’amministrazione della giustizia è un problema razionale, è un problema logico, che deve essere impostato e risolto in termini di forte emotività, non già di quella commozione puramente superficiale che è propria del genere femminile. Quindi a mio avviso, le donne non dovrebbero essere chiamate ad esplicare la funzione giurisdizionale. Le donne, quindi, secondo il parere dell’onorevole Bettiol, non potevano, a causa della «loro natura», occupare cariche nella magistratura. Da San Paolo a Shakespeare, per trovare una base se non scientifica almeno culturale per escludere le donne dalla magistratura: «nel Mercante di Venezia ha giudicato Porzia e Porzia ha giudicato male», affermava l’onorevole Giovanni Persico, avvocato iscritto al gruppo del partito socialista lavoratori italiani, che aggiungeva: «la donna sarà la madre dei giudici, sarà la ispiratrice dei giudici, ma è bene che lasci questa grave e talvolta terribile responsabilità agli uomini», parole non in netto contrasto a quelle pronunciate dallo stesso onorevole l’8 marzo 1947 quando, in occasione della giornata internazionale della donna, disse: 108 «La lotta», 23 maggio 1947. Il secondo dopoguerra e gli anni Cinquanta 201 noi diamo la massima importanza alla femminilità, la quale non soltanto rappresenta la bellezza della vita, ma è il conforto dell’uomo nella battaglia che ogni giorno combatte per la causa della libertà. Non possiamo parlare della donna senza ricordare le parole di Mazzini che la disse sorella, madre, sposa, profumo della casa, speranza dell’avvenire.109 Giovanni Leone, avvocato democristiano e futuro presidente della Repubblica, affermava di non essere completamente contrario all’ingresso delle donne, seppur con delle limitazioni legate, ancora una volta, alle caratteristiche «naturali». Si ritiene, però, che la partecipazione illimitata delle donne alla funzione giudiziaria non sia per ora da ammettersi. Che la donna possa partecipare, con profitto per la società, a quella amministrazione della giustizia dove più può far sentire le qualità che le derivano dalla sua femminilità e dalla sua sensibilità, non può essere negato: si accenna qui, oltre che alla giuria – nel caso che questo istituto sia ripristinato – a quei procedimenti per i quali è più sentita la necessità della presenza della donna, in quanto richiedono un giudizio il più possibile conforme alla coscienza popolare. Anche il Tribunale dei minorenni sarebbe la sede più idonea per la partecipazione della donna. Ma, negli alti gradi della Magistratura, dove bisogna arrivare alla rarefazione del tecnicismo, è da ritenere che solo gli uomini possano mantenere quell’equilibrio di preparazione che più corrisponde per tradizione a queste funzioni.110 L’onorevole Carlo Molè, iscritto al gruppo Democrazia del lavoro, dichiarava il 31 gennaio 1947, nella seduta pomeridiana, alla Commissione di «aver combattuto questa proposta sia in Consiglio dei ministri, che in seno alla Sottocommissione e non può che ripetere brevissimamente che ritiene non trattarsi né di superiorità, né di inferiorità della donna di fronte all’uomo nella funzione giurisdizionale: è soprattutto per i motivi addotti dalla scuola di Charcot riguardanti il complesso anatomo-fisiologico che la donna non può giudicare». L’onorevole Maria Federici il 26 novembre 1947, nella seduta antimeridiana l’Assemblea Costituente, criticò fortemente gli oppositori. Onorevoli colleghi, abbiamo inteso voci intonate e voci stonate, voci favorevoli e voci sfavorevoli; abbiamo sentito portare innanzi argomenti così triti e così superficiali da generare, almeno in me, un senso di mortificazione. Abbiamo sentito citare argomenti di puro valore accademico, che molto spesso mi hanno fatto ripensare a quella accolta di illustri accademici che perse il suo tempo per discutere se un pesce vivo pesasse più di un pesce morto! Si trattava di fare una semplice prova e di rimettersi alla bilancia. Ora anche qui, onorevoli colleghi, facciamo la prova, vediamo se la donna è veramente in grado di coprire le cariche che sono inerenti all’alto esercizio della Magistratura. A tutto quanto è stato detto, io potrei rispondere che una raffinata sensibilità, una pronta intuizione, un cuore più sensibile alle sofferenze umane e un’esperienza maggiore del dolore non sono requisiti che possano nuocere, sono requisiti preziosi che possono agevolare l’amministrazione della giustizia. Potrei rispondere che le donne avranno la possibilità di fare rilevare attraverso un lungo tirocinio la loro capacità; saranno sottomesse e sottoposte ai concorsi e a una rigida selezione. Le donne che si presenteranno a chiedere di salire i gradi della Magistratura devono avere in partenza (e li avranno) i requisiti che possono dare loro una certa garanzia di successo. Non so invece che cosa rispondere a coloro i quali ci hanno proposto di imitare i modelli domestici. Prima di tutto è uno sbaglio psicologico, perché noi donne amiamo differenziarci 109 Camera dei deputati, resoconto stenografico, seduta di sabato 8 marzo 1947, p. 1904. Seduta pomeridiana dell’Assemblea Costituente 7 novembre 1947, citato in ROMANO CANOSA, Il giudice e la donna cento anni di sentenze sulla condizione femminile in Italia, Milano, Mazzotta, 1978, p. 41. 110 202 Dal regime fascista agli anni Sessanta Shell a Cesenatico, Fondo Nino Comaschi, 1956-1958 ca., Archivio fotografico Cineteca del Comune, Bologna fra noi sia pure nel dettaglio di un vestito o nel particolare di un ornamento, e se qualcuno che siede qui ha la propria moglie che in casa fa la calza, non ritengo questo un argomento valido per invogliare una donna che chiede una toga ad accettare anziché una toga una calza. Nel 1951 le deputate democristiane Erisia Tonietti Gennai e Maria Federici presentarono una legge sulla partecipazione delle donne alle giurie popolari nelle Corti d’Assise che prevedeva il numero massimo di due donne in giuria, l’anno successivo Maria Maddalena Rossi, Pci, e la repubblicana Mary Tibaldi Chiesa presentarono due ordini del giorno su questo tema. Nel 1953 deputati di diversi partiti presentano una proposta di legge per l’ammissione delle donne nelle giurie, infine nel 1955 fu approvata in Consiglio dei ministri su proposta dell’onorevole Moro un progetto di legge e nel luglio 1956 la Camera dei deputati approvò la legge che consentiva l’accesso delle donne nelle giurie popolari e che prevedeva obbligatoriamente la presenza come componente privata nel Collegio giudicante del Tribunale dei minori.111 111 «Noi donne», n. 32, 5 agosto 1956, p. 5. Il secondo dopoguerra e gli anni Cinquanta 203 Nel 1958 tre donne fecero ricorso al Consiglio di Stato perché il concorso di uditore giudiziario era stato riservato ai soli maschi, non ottenendo sentenze favorevoli.112 L’ingresso delle donne in magistratura fu infine sancito dalle legge n. 66 del 1963. Annunziata dall’onorevole democristiana Maria Coco il 5 agosto 1960, posta in discussione nella prima Commissione nel 1962 dove fu approvata il 28 novembre con il titolo «Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni», la legge prevedeva l’abrogazione della legge n. 1176 del 1919 e apriva la strada all’applicazione della Costituzione e permise, nel maggio del 1963, l’organizzazione del primo concorso per uditore giudiziario aperto alle candidate donne a cui risultarono idonee otto candidate. La migliore di queste si piazzò al quarto posto della graduatoria. La legge del 1963 pur consentendo l’accesso delle donne a tutte le cariche pubbliche, mantenne una riserva sulla possibilità di arruolamento nelle Forze Armate. Nella legge n. 66/1963 si sottolineava che per l’accesso al servizio militare era necessaria l’emanazione di una apposita legge. Questo avvenne 36 anni dopo con la legge del 20 ottobre 1999. Nel 1964 vi fu il primo concorso per la carriera diplomatica aperto alle donne, qualche anno prima, nel 1959 era nato il Corpo di polizia femminile con la legge n. 1083 e nel 1961 le prime 69 donne poliziotto entrarono in servizio con le funzioni previste dalla legge, ovvero: – prevenzione e accertamenti dei reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, la famiglia e l’integrità e sanità della stirpe nonché dei reati in materia di tutela del lavoro delle donne e dei minori; – indagini ed atti di polizia giudiziaria relativi a reati commessi da donne o da minori degli anni 18 o in loro danno; – vigilanza ed assistenza di donne e di minori nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o che siano stati, comunque, convocati presso gli uffici di pubblica sicurezza; – eventuali compiti di assistenza nei confronti di donne nonché di minori in stato di abbandono morale e sociale mediante opportuni collegamenti con autorità ed enti che tali specifici compiti perseguono. Una legge che chiedeva alle donne poliziotto di occuparsi di donne, di minori e di morale. 112 R. CANOSA, Il giudice e la donna cit., p. 42. Bibliografia La bibliografia non ha pretese di completezza. È composta esclusivamente dalle opere consultate nel corso della preparazione del catalogo e della mostra ed ha più i connotati di uno strumento di controllo o di un repertorio di testi che hanno guidato la ricerca. L’altra metà dell’impiego. La storia delle donne nell’amministrazione, a cura di Chiara Giorgi, Guido Melis, Angelo Varni, Bologna, Bononia University Press, 2005. ARBIZZANI LUIGI, Le lavoratrici delle campagne durante il fascismo e la Resistenza nella Valle Padana, «Annali dell’Istituto Alcide Cervi», 1991, 13, pp. 223-246. ARRU ANGIOLINA, Lavorare in casa d’altri: servi e serve domestici a Roma nell’800, «Annali della Fondazione Lelio e Lisli Basso», VII, 1983-1984, pp. 95-160. ARRU ANGIOLINA, Il matrimonio tardivo dei servi e delle serve, «Quaderni storici», XXIII, 1988, 68, pp. 469-496. ARRU ANGIOLINA, Protezione e legittimazione: come si usa il mestiere di serva nell’Ottocento, in Ragnatele di rapporti. Patronage e reti di relazione nella storia delle donne, a cura di Lucia Ferrante, Maura Palazzi, Gianna Pomata, Torino, Rosenberg & Sellier, 1988, pp. 381-416. L’arte del truciolo a Carpi, Carpi, [s.n.], 1979. Artisti del quotidiano. Sarti e sartorie storiche in Emilia-Romagna, a cura di Elisa Tosi Brandi, Bologna, Clueb, 2009. L’audacia insolente. La cooperazione femminile 1886-1986, Venezia, Marsilio, 1986. Balie da latte. Istituzioni assistenziali e private in Toscana tra XVII e XX secolo, a cura di Adriana Dadà, Roma, Morgana edizioni, 2002. Balie da latte. Una forma peculiare di emigrazione temporanea, a cura di Daniela Perco, Feltre, [s.n.], 1984. BALLESTRERO MARIA VITTORIA, Dalla tutela alla parità. La legislazione sul lavoro delle donne, Bologna, il Mulino, 1979. BALLESTRERO MARIA VITTORIA, La protezione concessa e l’eguaglianza negata: il lavoro femminile nella legislazione italiana, in Il lavoro delle donne, a cura di Angela Groppi, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 445-469. BARBAGLI MARZIO, Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo, Bologna, il Mulino, 1984. BARTOLONI STEFANIA, Donne nella Croce Rossa Italiana tra guerre e impegno sociale, Venezia, Marsilio, 2005. BARTOLONI STEFANIA, Italiane alla guerra. L’assistenza ai feriti 1915-1918, Venezia, Marsilio, 2003. BASSI ANGELINI CLAUDIA, Le signore del fascio. L’associazionismo femminile fascista nel Ravennate 1919-1945, Ravenna, Longo, 2008. BECALLI BIANCA, Donne e uomini nella divisione del lavoro, Milano, Angeli, 1991. BIANCHI ORNELLA, Le lavoratrici del tabacco nella storia del sindacalismo italiano, in Mondi femminili in cento anni di sindacato, a cura di Gloria Chianese, Roma, Ediesse, 2008, pp. 87-105. BIGARAN MARIAPIA, Donne e rappresentanza nel dibattito e nella legislazione tra ’800 e ’900, in La sfera pubblica femminile. Percorsi di storia delle donne in età contemporanea, a cura di Dianella Gagliani, Mariuccia Salvati, Bologna, Clueb, 1992, pp. 63-72. BINI GIORGIO, La maestra nella letteratura, in L’educazione delle donne. Scuole e modelli di vita femminile nell’Italia dell’Ottocento, a cura di Simonetta Soldani, Milano, Angeli, 1989, pp. 331-362. BOCK GISELA, Le donne nella storia europea. Dal Medioevo ai nostri giorni, RomaBari, Laterza, 2003. 206 BOSERUP ESTER, Lavoro delle donne. La divisione sessuale del lavoro nello sviluppo economico, Torino, Rosenberg & Sellier, 1982. BRAVO ANNA, Donne contadine e prima guerra mondiale, «Società e Storia», III, 1980, 10, pp. 843-862. BRAVO ANNA, Lavorare in tempo di guerra, «Memoria», 1990, 30, pp. 69-88. BUTTAFUOCO ANNARITA, Cronache femminili. Temi e momenti della stampa emancipazionista in Italia dall’Unità al fascismo, Arezzo, Dipartimento di studi storicosociali e filosofici, Università degli studi di Siena, 1988. BUTTAFUOCO ANNARITA, La filantropia come politica. Esperienze dell’emancipazionismo italiano nel Novecento, in Ragnatele di rapporti. Patronage e reti di relazione nella storia delle donne, a cura di Lucia Ferrante, Maura Palazzi, Gianna Pomata, Torino, Rosenberg & Sellier, 1988, pp. 166-187. BUTTAFUOCO ANNARITA, “In servitù regine”. Educazione ed emancipazione nella stampa politica femminile, in L’educazione delle donne. Scuole e modelli di vita femminile nell’Italia dell’Ottocento, a cura di Simonetta Soldani, Milano, Angeli, 1989, pp. 363-392. BUTTAFUOCO ANNARITA, Tra cittadinanza politica e cittadinanza sociale. Progetti ed esperienze del movimento politico delle donne nell’Italia liberale, in Il dilemma della cittadinanza, Diritti e doveri delle donne, a cura di Gabriella Bonacchi, Angela Groppi, Roma-Bari, Laterza, 1993, pp. 104-127. CALAMANDREI CARLO, L’assistenza infermieristica. Storia, teoria, metodi, Firenze, La Nuova Italia, 1993. CANOSA ROMANO, Il giudice e la donna. Cento anni di sentenze sulla condizione femminile in Italia, Milano, Mazzotta, 1978. CAPECCHI VITTORIO, PESCE ADELE, L’Aemilia Ars “merletti e ricami”. Storia di un’impresa tutta femminile, in Aemilia Ars 1898-1903. Arts & Crafts a Bologna, a cura di Carla Bernardini, Doretta Davanzo Poli, Orsola Ghetti Baldi, Milano, A+G edizioni, 2001, pp. 127-153. CASALINI MARIA, Le serve e i loro padroni, in Operaie, serve, maestre, impiegate, a cura di Paola Nava, Torino, Rosenberg & Sellier, 1992, pp. 265-286. Bibliografia CHIANESE GLORIA, Storia sociale della donna in Italia (1800-1980), Napoli, Guida, 1980. CONNELL W. ROBERT, Questioni di genere, Bologna, il Mulino, 2006. Le crocerossine nella Grande guerra. Aristocratiche e borghesi nei diari e negli ospedali militari. Una via per l’emancipazione femminile, a cura di Paolo Scaletti, Giuliana Variola, Udine, Gaspari, 2008. CURLI BARBARA, Italiane al lavoro 19141920, Venezia, Marsilio, 1998. DALLA CASA BRUNELLA, Giorgina Saffi e l’associazionismo femminile di fine Ottocento: la Società operaia femminile di Forlì, in Le donne in area padana: politica, lavoro, immaginario, numero unico di «Padania. Storia, cultura, istituzioni», VIII, 1994, 16, pp. 48-65. DALLA CASA BRUNELLA, Istruzione, lavoro ed emancipazione femminile nel mutualismo di fine Ottocento. Alcune considerazioni, in La sfera pubblica femminile. Percorsi di storia delle donne in età contemporanea, a cura di Dianella Gagliani, Mariuccia Salvati, Bologna, Clueb, 1992, pp. 101-112. D’ASCENZO MIRELLA, La scuola elementare nell’età liberale. Il caso Bologna 18591911, Bologna, Clueb, 1997. DAU NOVELLI CECILIA, Società, chiesa e associazionismo femminile, Roma, AVE, 1988. DE FORT ESTER, La scuola elementare dall’Unità alla caduta del fascismo, Bologna, il Mulino, 1996. DE GIORGIO MICHELA, Le italiane dall’Unità ad oggi. Modelli culturali e comportamenti sociali, Roma-Bari, Laterza, 1992. DE GRAZIA VICTORIA, Le donne nel regime fascista, Venezia, Marsilio, 2007. DELMONACO AURORA, La signorina a quadretti e altre lavoratrici insegnanti, in Mondi femminili in cento anni di sindacato, a cura di Gloria Chianese, Roma, Ediesse, 2008, pp. 209-272. DI CORI PAOLA, Il doppio sguardo. Visibilità dei generi sessuali nella rappresentazione fotografica (1908-1918), in La Grande Guerra. Esperienza, memoria, immagini, a cura di Diego Leoni, Camillo Zadra, Bologna, il Mulino, 1986, pp. 765-800. Il dilemma della cittadinanza. Diritti e doveri delle donne, a cura di Gabriella Bonacchi, Angela Groppi, Roma-Bari, Laterza, 1993. Bibliografia DITTRICH-JOHANSEN HELGA, Le «Militi dell’idea». Storia delle organizzazioni femminili del Partito Nazionale Fascista, Firenze, Olschki, 2002. DOMENICALI ORNELLA, Emancipazione femminile e pacifismo in Maria Goia, in Le donne in area padana: politica, lavoro, immaginario, numero unico di «Padania. Storia, cultura, istituzioni», VIII, 1994, 16, pp. 66-82. La donna nella famiglia e nel lavoro, a cura di Giovanna Rossi, Giuseppina Malerba, Milano, Angeli, 1993. Donne al fronte. Le infermiere volontarie nella Grande Guerra, a cura di Stefania Bartoloni, Roma, Jouvence, 1998. Donne e giornalismo. Percorsi e presenze di una storia di genere, a cura di Silvia Franchi, Simonetta Soldani, Milano, Angeli, 2004. Donne e professioni nell’Italia del Novecento, a cura di Giovanna Vicarelli, Bologna, il Mulino, 2007. Donne e spazio nel processo di modernizzazione, a cura di Dianella Gagliani, Mariuccia Salvati, Bologna, Clueb, 1995. Donne e uomini nelle guerre mondiali, a cura di Anna Bravo, Roma-Bari, Laterza, 1991. Le donne in area padana: politica, lavoro, immaginario, numero unico di «Padania. Storia, cultura, istituzioni», VIII, 1994, 16. Donne nella CGIL: una storia lunga un secolo. 100 anni di lotte per la dignità, i diritti e la libertà femminile, a cura di Lucia Motti, Roma, Ediesse, 2006. Donne, scuola, lavoro. Dalla scuola professionale “Regina Margherita” agli istituti “Elisabetta Sirani” di Bologna 18951995, a cura di Brunella Dalla Casa, Imola, Galeati, 1996. DUBY GEORGES, PERROT MICHELLE, Storia delle donne in Occidente. L’Ottocento, a cura di Geneviéve Fraisse, Michelle Perrot, Roma-Bari, Laterza, 1991. E’ brava ma… donne nella Cgil 1944-1962, a cura di Simona Lunadei, Lucia Motti, Maria Luisa Righi, Roma, Ediesse, 1999. Educazione e ruolo femminile. La condizione delle donne in Italia dal dopoguerra ad oggi, a cura di Simonetta Ulivieri, Scandicci, La Nuova Italia, 1992. L’emancipazione femminile in Italia. Un secolo di discussioni 1861-1961: atti del Convegno organizzato dal Comitato di associazioni femminili per la parità di retribu- 207 zione in occasione del primo centenario dell’Unità d’Italia, Torino, 27-28-29 ottobre 1961, Firenze, La Nuova Italia, 1963. ERIOLI ELISA, L’ “Ufficio Notizie alle famiglie dei militari”. Una grande storia di volontariato femminile bolognese, in Archiviare la guerra. La Prima Guerra Mondiale attraverso i documenti del Museo del Risorgimento, a cura di Mirtide Gavelli, «Bollettino del Museo del Risorgimento», L, 2005, pp. 75-90. Esistere come donna, Milano, Mazzotta, 1983. Essere donne insegnanti. Storia, professionalità e cultura di genere, a cura di Simonetta Ulivieri, Torino, Rosenberg & Sellier, 1996. FERRARA PATRIZIA, Le donne negli uffici, in Impiegati, a cura di Guido Melis, Torino, Rosenberg & Sellier, 2004, pp. 125-162. FIUMI ALESSANDRA, Infermieri e ospedale: storia della professione infermieristica tra ’800 e ’900, Verona, Nettuno, 1993. FURLAN PAOLA, Il lavoro delle donne dalla ricostruzione agli anni Sessanta, Bologna, Futura Press, 1993. GABRIELLI PATRIZIA, Il club delle virtuose. Udi e Cif nelle Marche dall’antifascismo alla guerra fredda, Ancona, Il lavoro editoriale, 2000. GAGLIANI DIANELLA, Welfare State come umanesimo e antipatronage. Un’esperienza delle donne nel secondo dopoguerra, in La sfera pubblica femminile. Percorsi di storia delle donne in età contemporanea, a cura di Dianella Gagliani, Mariuccia Salvati, Bologna, Clueb, 1992. GAIOTTI DE BIASE PAOLA, La donna nella vita sociale e politica della Repubblica 19451948, Milano, Vangelista, 1977, pp. 9-182. GAIOTTI DE BIASE PAOLA, Le origini del movimento cattolico in Italia, Brescia, Morcelliana, 1963. GALOPPINI ANNAMARIA, Il lungo viaggio verso la parità. I diritti civili e politici delle donne dall’Unità ad oggi, Bologna, Zanichelli, 1980. GARIBALDI LUCIANO, Le soldatesse di Mussolini, Milano, Mursia, 1997. GAROFALO ANNA, L’Italiana in Italia, Bari, Laterza, 1956. Genere. La costruzione sociale del femminile e del maschile, a cura di Simonetta Piccone Stella, Chiara Saraceno, Bologna, il Mulino, 1996. 208 GIANNETTO MARINA, «Tre lire al giorno, pazienza, attenzione, minori distrazioni»: le donne nelle Poste e telegrafi, in L’altra metà dell’impiego. La storia delle donne nell’amministrazione, a cura di Chiara Giorgi, Guido Melis, Angelo Varni, Bologna, Bononia University Press, 2005, pp. 31-48. GIGLI MARCHETTI ADA, Le risorse del repertorio dei periodici femminili lombardi, in Donne e giornalismo. Percorsi e presenze di una storia di genere, a cura di Silvia Franchi, Simonetta Soldani, Milano, Angeli, 2004, pp. 295-308. GIORGI CHIARA, L’emarginazione femminile nella pubblica amministrazione tra le due guerre: storie di donne, in L’altra metà dell’impiego. La storia delle donne nell’amministrazione, a cura di Chiara Giorgi, Guido Melis, Angelo Varni, Bologna, Bononia University Press, 2005, pp. 79-98. GIOVANELLI LORETTA, Vita di fabbrica delle sigaraie modenesi tra Otto e Novecento. Una ricerca sui registri disciplinari, in Operaie, serve, maestre, impiegate, a cura di Paola Nava, Torino, Rosenberg & Sellier, 1992, pp. 363-376. GISSI ALESSANDRA, Le segrete manovre delle donne. Levatrici in Italia dall’Unità al fascismo, Roma, Biblink, 2006. GUIDICINI PAOLO, ALVISI CATERINA, L’arzdaura. Donne e gestione familiare nella realtà contadina, Milano, Angeli, 1994. IMBERGAMO BARBARA, SCATTIGNO ANNA, «Una forza nuova». Le donne nel movimento dei lavoratori dalle prime organizzazioni alla repressione fascista, in Donne nella CGIL: una storia lunga un secolo, a cura di Lucia Motti, Roma, Ediesse, 2006, pp. 169-199. IMPRENTI FIORELLA, Operaie e socialismo. Milano, le Leghe femminili, la Camera del Lavoro (1891-1918), Milano, Angeli, 2007. In guerra e in pace. Storia fotografica del Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, Roma, Palombi, 1990. LANZARDO LILIANA, Dalla bottega artigiana alla fabbrica, Roma, Editori Riuniti, 1999, (Storia fotografica della società italiana). LANZARDO LILIANA, Donne e guerra, in Guerra vissuta, guerra subita, Bologna, Clueb, 1991, pp. 19-108. Bibliografia LANZARDO LILIANA, Il mestiere prezioso. Racconti di ostetriche, Torino, Gruppo editoriale Forma, 1985. Il lavoro delle donne, a cura di Angela Groppi, Roma-Bari, Laterza, 1996. Il lavoro di balia. Memoria e storia dell’emigrazione femminile da Ponte Buggianese nel ’900, a cura di Adriana Dadà, Ospedaletto (Pisa), Pacini editore, 1999. Il lavoro femminile nell’Ottocento e nel Novecento. Le tabacchine. Coltivatrici, produttrici e venditrici, a cura di Fiorenza Taricone, Roma, Gangemi editore, 2005. MAHLER VANESSA, Tenere le fila. Sarte, sartine e cambiamento sociale 1860-1960, Torino, Rosenberg & Sellier, 2007. MANZONI EDOARDO, Storia e filosofia dell’assistenza infermieristica, Milano, Masson, 1996. MARCHIANÒ GIOVANNA, Fascismo e organizzazione del consenso. La politica demografica, in Storia dell’Emilia Romagna, a cura di Aldo Berselli, Bologna, University Press, 1980. MARTINELLI FRANCO, Assistenti sociali nella società italiana contributo ad una sociologia della professione, Roma, Istituto per gli studi di servizio sociale, 1965. MARTINI MANUELA, Divisione sessuale dei ruoli e azione collettiva nelle campagne padane di fine Ottocento, in Donne e spazio nel processo di modernizzazione, a cura di Dianella Gagliani, Mariuccia Salvati, Bologna, Clueb, 1995, pp. 75-110. MARTINI SILVIA, L’associazionismo economico delle donne: un vuoto da colmare?, in La sfera pubblica femminile. Percorsi di storia delle donne in età contemporanea, a cura di Dianella Gagliani, Mariuccia Salvati, Bologna, Clueb, 1992, pp. 73-80. MERLI STEFANO, Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale. Il caso italiano 1880-1900, Firenze, La Nuova Italia, 1972. Mondi femminili in cento anni di sindacato, a cura di Gloria Chianese, Roma, Ediesse, 2008. MONTALTI SANDRA, La formazione del personale infermieristico a Cesena tra la fine dell’800 e l’inizio del ’900, in Sanità e società a Cesena 1297-1997, a cura di Stefano Arieti, Giovanni Camaeti, Claudio Riva, Cesena, Il Ponte Vecchio, 1999, pp. 289-295. Bibliografia MOTTI LUCIA, Trecento foto per raccontare un secolo di storia, in Donne nella CGIL: una storia lunga un secolo, a cura di Lucia Motti, Roma, Ediesse, 2006. NAVA PAOLA, La fabbrica dell’emancipazione. Operaie della Manifattura tabacchi di Modena. Storie di vita e di lavoro, Roma, Utopia, 1896. ODORISIO MARIA LINDA, Le impiegate del Ministero delle Poste, in Il lavoro delle donne, a cura di Angela Groppi, RomaBari, Laterza, 1996, pp. 398-420. Operaie, serve, maestre, impiegate, a cura di Paola Nava, Torino, Rosenberg & Sellier, 1992. ORTAGGI CAMMAROSANO SIMONETTA, Condizione femminile e industrializzazione tra Otto e Novecento, in Tra fabbrica e società. Mondi operai nell’Italia del Novecento, a cura di Stefano Musso, Milano, Feltrinelli, 1999, pp. 109-172. PALAZZI MAURA, Donne delle campagne e delle città: lavoro ed emancipazione, in Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità ad oggi. L’Emilia Romagna, a cura di Roberto Finzi, Torino, Einaudi, 1997, pp. 375-409. PALAZZI MAURA, Donne sole. Storia dell’altra faccia dell’Italia tra antico regime e società contemporanea, Milano, Bruno Mondadori, 1997. PALAZZI MAURA, Famiglia, lavoro e proprietà. Le donne nella società contadina tra continuità e trasformazione, in Società rurale e ruoli femminili in Italia fra Ottocento e Novecento, a cura di Paola Corti, «Annali dell’Istituto A. Cervi», XII, 1990, pp. 25-80. PALAZZI MAURA, Il lavoro delle contadine, in Tra passione e professione. Il lavoro della canapa nelle fotografie di un cicloturista: Antonio Pezzoli (1870-1943), a cura di Angela Tromellini, Stefano Pezzoli, Silvio Fronzoni, Bologna, Editrice Compositori, 2001, pp. 127-135. PALICI DI SUNI ELISABETTA, Il lavoro delle donne nell’Italia del Novecento tra parità e protezione, in L’altra metà dell’impiego. La storia delle donne nell’amministrazione, a cura di Chiara Giorgi, Guido Melis, Angelo Varni, Bologna, Bononia University Press, 2005, pp. 17-30. PANCINO CLAUDIA, Il bambino e l’acqua sporca. Storia dell’assistenza al parto dalle mammane alle ostetriche, Milano, Angeli, 1984. 209 PANCINO CLAUDIA, La comare levatrice. Crisi di un mestiere nel XVIII secolo, «Società e storia», 1981, 4, pp. 593-638. PANCINO CLAUDIA, La levatrice nelle prime regolamentazioni dell’Italia unita, in Operaie, serve, maestre, impiegate, a cura di Paola Nava, Torino, Rosenberg & Sellier, 1992, pp. 377-385. PANCINO CLAUDIA, Le ostetriche lombarde nell’Ottocento, in Donna lombarda 18601945, a cura di Ada Gigli Marchetti, Nanda Torcellan, Milano, Angeli, 1992, pp. 225-233. PASSERA OLGA, Assistenza infermieristica. Storia sociale, Milano, Casa editrice Ambrosiana, 1993. PEDROCCO GIORGIO, Le operaie delle manifatture tabacchi, in Operaie, serve, maestre, impiegate, a cura di Paola Nava, Torino, Rosenberg & Sellier, 1992, pp. 353-362. PELAJA MARGHERITA, Mestieri femminili e luoghi comuni. Le domestiche a Roma a metà Ottocento, «Quaderni storici», XXIII, 68, 1988, pp. 497-518. Percorsi di vita femminile. La donna attraverso l’immagine tra Ottocento e Novecento, a cura di Luciana Nora, Carpi, [s.n.], 1990. PESCAROLO ALESSANDRA, Il lavoro a domicilio femminile: economie di sussistenza in età contemporanea, in Tra fabbrica e società. Mondi operai nell’Italia del Novecento, a cura di Stefano Musso, Milano, Feltrinelli, 1999, pp. 173-195. PESCAROLO ALESSANDRA, Il lavoro delle donne e l’industria domestica, «Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli», XXX, 1997, pp. 173-195. PESCAROLO ALESSANDRA, Il lavoro e le risorse delle donne, in Storia sociale delle donne nell’Italia contemporanea, a cura di Anna Bravo, Margherita Pelaja, Alessandra Pescarolo, Lucetta Scaraffia, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp.127-178. PIERONI BORTOLOTTI FRANCA, Alle origini del movimento femminile in Italia 1848-1892, Torino, Einaudi, 1975. PIERONI BORTOLOTTI FRANCA, Socialismo e questione femminile in Italia 1892-1922, Milano, Mazzotta, 1974. PISA BEATRICE, Una azienda di Stato a domicilio: la confezione di indumenti militari durante la grande guerra, «Storia contemporanea», XX, 1989, 6, pp. 953-1006. 210 PISONI CERLESI INES, La parità di salario in Italia. Lotte e conquiste delle lavoratrici dal 1861 a oggi, Roma, Editrice Lavoro, 1959. PORCIANI ILARIA, Sparsa di tanti triboli: la carriera della maestra, in Le donne a scuola. L’educazione femminile nell’Italia dell’800, a cura di Ilaria Porciani, Firenze, Il sedicesimo, 1987, pp. 170-173. PROCACCI GIOVANNA, La protesta delle donne delle campagne in tempo di guerra, «Annali dell’Istituto Alcide Cervi», 1991, 13, pp. 57-87. Professione e genere nel lavoro sociale, a cura di Pierangela Benvenuti, Roberto Sgatori, Milano, Angeli, 2000. Ragnatele di rapporti. Patronage e reti di relazione nella storia delle donne, a cura di Lucia Ferrante, Maura Palazzi, Gianna Pomata, Torino, Rosenberg & Sellier, 1988. REGGIANI FLORES, Un problema tecnico e un problema morale: la crisi delle domestiche a Milano (1890-1914), in, Donna lombarda 1860-1945, a cura di Ada Gigli Marchetti, Nanda Torcellan, Milano, Angeli, 1992, pp. 149-179. ROPA ROSSELLA, La presenza della donna sulla scena pubblica. Lavoro e lotte a Bologna, «Resistenza oggi. Quaderni bolognesi di storia contemporanea», XXIV, 2004, 5, pp. 35-42. ROPA ROSSELLA, La presenza delle donne sulla scena pubblica nella stampa locale di area cattolica (1945-1946), in La fondazione della Repubblica modelli e immaginario repubblicani in Emilia e Romagna negli anni della Costituente, a cura di Mariuccia Salvati, Milano, Angeli, 1999. ROSSI-DORIA ANNA, Le donne sulla scena politica, in Storia dell’Italia repubblicana, Torino, Einaudi, 1994, vol. I, pp. 780-846. SALVATI MARIUCCIA, Studi sul lavoro delle donne e peculiarità del caso italiano, in Alla ricerca del lavoro tra storia e sociologia. Bilancio storiografico e prospettive di studio, a cura di Varni Angelo, Torino, Rosenberg & Sellier, 1998, pp. 113-132. SALVATICI SILVIA, Contadine dell’Italia fascista. Presenze, ruoli, immagini, Torino, Rosenberg & Sellier, 1999. SANTONI RUGIU ANTONIO, Maestre e maestri. La difficile storia degli insegnanti elementari, Roma, Carocci, 2006. Bibliografia SARTI RAFFAELLA, Servire al femminile, servire al maschile nella Bologna sette-ottocentesca. Introduzione alla ricerca, in Operaie, serve, maestre, impiegate, a cura di Paola Nava, Torino, Rosenberg & Sellier, 1992, pp. 237-264. SARTI RAFFAELLA, La servitù domestica come problema storiografico, «Storia e problemi contemporanei», 1997, 20, pp. 159-184. SAVELLI LAURA, Contadine e operaie. Donne al lavoro negli stabilimenti della Società Metallurgica Italiana, «Annali dell’Istituto Alcide Cervi», 1991, 13, pp. 119-132. SCARAFFIA LUCETTA, Essere uomo, essere donna, in Storia sociale delle donne nell’Italia contemporanea, a cura di Anna Bravo Anna, Margherita Pelaja, Alessandra Pescarolo, Lucetta Scaraffia, RomaBari, Laterza, 2001, pp. 3-76. SCOTT W. JOAN, La donna lavoratrice nel XIX secolo, in Storia delle donne in Occidente. L’Ottocento, a cura di Geneviéve Fraisse, Michelle Perrot, Roma-Bari, Laterza, 1991, pp. 355-385. La sfera pubblica femminile. Percorsi di storia delle donne in età contemporanea, a cura di Dianella Gagliani, Mariuccia Salvati, Bologna, Clueb, 1992. SIGNORELLI AMALIA, Il pragmatismo delle donne. La condizione femminile nella trasformazione delle campagne, in Storia dell’agricoltura in età contemporanea, vol. II, Venezia, Marsilio, 1990. SIRONI CECILIA, Storia dell’assistenza infermieristica, Roma, Nuova Italia Scientifica, 1991. SOLDANI SIMONETTA, Donne educanti, donne da educare. Un profilo della stampa femminile toscana (1770-1945), in Donne e giornalismo. Percorsi e presenze di una storia di genere, a cura di Silvia Franchi, Simonetta Soldani, Milano, Angeli, 2004, pp. 309-353. SOLDANI SIMONETTA, Le donne, l’alfabeto, lo Stato. Considerazioni su scolarità e cittadinanza, in La sfera pubblica femminile. Percorsi di storia delle donne in età contemporanea, a cura di Dianella Gagliani, Mariuccia Salvati, Bologna, Clueb, 1992, pp. 113-136. SOLDANI SIMONETTA, Donne senza pace. Esperienze di lavoro, di lotta, di vita tra guerra e dopoguerra (1915-1920), «Annali dell’Istituto Alcide Cervi», 1991, 13, pp. 11-56. Bibliografia SOLDANI SIMONETTA, Maestre d’Italia, in Il lavoro delle donne, a cura di Angela Groppi, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 368397. SOLDANI SIMONETTA, Strade maestre e cammini tortuosi. Lo Stato liberale e la questione del lavoro femminile, in Operaie, serve, maestre, impiegate, a cura di Paola Nava, Torino, Rosenberg & Sellier, 1992, pp. 289-352. SPINELLI LUCIANA, Disciplina di fabbrica e lavoro femminile: le operaie della manifattura dei tabacchi (1900-1914), «Società e storia», VII, 1985, 28, pp. 319-372. Storia della famiglia italiana 1750-1950, a cura di Marzio Barbagli, David I. Kertzer, Bologna, il Mulino, 1992. Storia delle donne in Occidente. Il Novecento, a cura di Françoise Thebaud, Roma-Bari, Laterza, 1992. SULLEROT EVELYNE, La donna e il lavoro. Storia e sociologia del lavoro femminile, Milano, Etas Kompass. 1969. TAGLIALATELA EMILIA, «Non volo d’aquila, ma volo di rondine». Le impiegate tra società e sindacato, in Mondi femminili in cento anni di sindacato, a cura di Gloria Chianese, Roma, Ediesse, 2008, pp. 273-334. TARICONE FIORENZA, Il centro italiano femminile dalle origini agli anni Settanta, Milano, Franco Angeli, 2001. TARICONE FIORENZA, La FILDIS e l’associazionismo femminile, in La corporazione delle donne. Ricerche e studi sui modelli femminili nel ventennio fascista, a cura di Marina Addis Saba, Firenze, Vallecchi, 1988. TARICONE FIORENZA, PISA BEATRICE, Operaie, borghesi, contadine nel XIX secolo, Roma, Carucci editore, 1985. TAROZZI FIORENZA, Lavoratori e lavoratrici a domicilio, in Operai, a cura di Stefano Musso, Torino, Rosenberg & Sellier, 2006, pp. 109-161. TAROZZI FIORENZA, Solidarietà sociale e associazionismo femminile. Alcune riflessioni, in La sfera pubblica femminile. Percorsi di 211 storia delle donne in età contemporanea, a cura di Dianella Gagliani, Mariuccia Salvati, Bologna, Clueb, 1992, pp. 81-90. TAROZZI FIORENZA, Tradizioni politiche femminili in Emilia Romagna tra Ottocento e Novecento, in Le donne in area padana: politica, lavoro, immaginario, numero unico di «Padania. Storia, cultura, istituzioni», VIII, 1994, 16, pp. 7-17. TERHOEVEN PETRA, Oro alla patria. Donne guerre e propaganda nella giornata della Fede fascista, Bologna, il Mulino, 2006. THÉBAUD FRANÇOIS, La Grande Guerra: età della donna o trionfo della differenza sessuale?, in Storia delle donne in Occidente. Il Novecento, a cura di François Thebaud, Roma-Bari, Laterza, 1992, pp. 25-90. TOMASSINI LUIGI, Mercato del lavoro e lotte sindacali nel biennio rosso, «Annali dell’Istituto Alcide Cervi», 1991, 13, pp. 87118. Trovatelli e balie in Italia. Atti del convegno Infanzia abbandonata e baliatico in Italia secc. XVI-XIX, a cura di Giovanna Da Molin, Bari, Cacucci, 1994. VACCARI ILVA, La donna nel ventennio fascista (1919-1943), in Donne e Resistenza in Emilia Romagna, Milano, Vangelista, 1978, pp. 23-254. VERZELLI ANGELA, ZAPPATERRA PAOLA, La vita, il lavoro, le lotte. Le mondine di Medicina negli anni Cinquanta, Bologna, Aspasia, 2001. WILLSON R. PERRY, Contadine e politica nel ventennio. La sezione Massaie rurali dei Fasci femminili, «Italia contemporanea», 2000, 218, pp. 31-48. ZANINI EMILIO, Il lavoro della donna nella società italiana di oggi. La donna e le professioni. Atti del convegno di studi organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, 5-8 settembre 1961, Milano, Vita e Pensiero, 1962. ZAPPATERRA PAOLA, Loro venivano avanti ma noi non stavamo zitte. Mondine a Bentivoglio nelle lotte del dopoguerra, Bologna, Aspasia, 2008. Indice dei nomi Addis Saba Marina, 160n., 161n. Agnini Gregorio, 11, 11n. Albertazzi Alessandro, 173n. Alessandrini Ada, 176 Alessandrini Goffredo, 159 Alfassio Grimaldi Ugoberto, 161n. Altobelli Argentina, XX, 30, 75, 81, 81n., 85, 97n. Altobelli Demos, 97n. Andina Maria, 52n. Ansaloni Annamaria, 146n. Anselmo Anna, 33, 33n. Anzoletti Luisa, 81, 81n. Aquarone Alberto, 144n., 153n. Arbizzani Luigi, 30n., 85n., 156n., 196n. Arieti Stefano, 44n. Aumont Michèle, 188n. Bacchetti Armida, 57 Bacci Cristina, 4n. Bacialli Giovanni, 57 Bagatella Seno Annamaria, 38n. Balabanoff Angelica, 75, 75n., 80n. Ballestrero Maria Vittoria, XXn., 90n., 91n., 92n., 93n., 130n., 157, 157n. Barbadoro Idomeneo, 86n. Barbieri Remigio, 197n. Barca Luciano, 176n. Baricelli Carmela, 76, 77n. Barnabà Giorgio, 187 Baronchelli Grosson Paola [Donna Paola], 96, 96n., 103, 103n. Bartolini Domenico, 56 Bartolini Teodolinda, 56 Bartoloni Stefania, 47n., 48n. Bartolotti Maria, 154n. Bassi Angelini Claudia, 131n., 136, 136n. Beccari Gualberta Alaide, 73, 73n. Bei Adele, 168, 174 Bellonci Maria, 167, 167n. Belluzzo Giuseppe, 147n. Beltrame Achille, XIII Benedettini Alferazzi Paola, 133n. Bensa Paolo Emilio, 94n. Benvenuti Pierangela, 142n. Bergonzini Luciano, 30n. Bernardini Carla, 26n. Bernocco Fava Parvis Giulia, 70 Berselli Aldo, 126n., 145n. Bertaccini Jolanda, 185 Bertani Agostino, 78n. Bertarelli Ernesto, 23n. Bertoni Jovine Dina, 198n. Betri Maria Luisa, 11n. Betti Giovannina, 14n. Bettiol Giuseppe, 200 Bevilacqua Piero, 193n. Biagi Bruno, 129n. Bianchi Bruna, 151n. Bianchi Ornella, 53n., 54n. Bianchini Laura, 168 Bianconcini Cavazza Lina, 25, 25n., 26, 26n., 100 Bini Giorgio, 64n. Bisi Albini Sofia, 60n. Bizzozero Antonio, 98, 98n. Blandina, suora, 51 Boarelli Mauro, 187n. Bocca Giorgio, 191 Bock Gisela, 130n. Bolelli Lorenzo, 165n. Bonghi Ruggero, 39 Bonomi Ivanoe, 168 Bonomi Stefano, 7n. Bordoli Bianca, 102n. Bornaghi Maria, 75 Borsa Mario, 168 Bortolini Pia, 130, 131n. Bortolotti Maria, 161 Bottai Giuseppe, 161 Bozzani Adalgisa, 58 Brambilla Giuditta, 80 Bravo Anna, 35n., 98n. Brebbia Giselda, 75, 77 Bruni Francesco, XIVn. Buttafuoco Annarita, 19n., 67n., 68n., 71n., 73n., 74n., 76n., 77n., 79n., 82n. Cabrini Angiolo, 13, 13n. Calderini Giovanni, 43 Indice dei nomi Calderini Rebecca, 68 Calligaris Clementina, 168 Camaeti Giovanni, 44n. Camperio Meyer Sita, 47, 47n. Canosa Romano, 201n., 203n. Capasso Pietro, 143n. Capecchi Vittorio, 26n. Caporilli Pietro, 161n. Carcano Paolo, 91 Casalini Giulio, 144n. Casanova Achille, 26n. Casati Gabrio, 61n. Castelli, soldato, 51 Castronovo Valerio, 196n. Cavallari Cantalamessa Giulia, 73, 103, 103n. Cavazza Francesco, 25n. Cazzola Franco, 193n. Celli Angelo, 54 Celli Fraentzel Anna, 46, 46n., 68 Chianese Gloria, XIIn., 53n. Chiari Allegretti Gilda, 102n. Chiodo Marinella, 156n. Chiurco Giorgio Alberto, 130n. Chludzinska Maria Concetta, 52n. Ciamician Giacomo, 102n. Cinciari Rodano Marisa, 167, 167n., 172n. Cianetti Tullio, 134 Cigognetti Luisa, 193 Cimatti Germana, 9n. Cingolani Guidi Angela, 168 Clerici Carlotta, 80 Clerici Maria Antonietta, 51, 52, 52n. Coari Adelaide, 72, 76, 81, 81n., 82 Coco Maria, 203 Codignola Ernesto, 146, 146n. Collamarini Edoardo, 26n. Connell Robert W., 198n. Conte Enrico, 38 Conti Lucia, 142n., Cornelio Giuliana, 10n. Corti Paola, 98n. Costa Alda, 146 Costa Andrea, 17, 79n. Crainz Guido, XIIn., 84n., 194n. Credaro Luigi, 66n. Crisalidi Ines, 139n. Cristofori Franco, 14n. Curli Barbara, 96n. D’Ascenzo Mirella, 66n., 130n. Da Molin Giovanna, 35n. Da Persico Elena, 76 Dalla Casa Brunella, 24n., 165n. Dalle Donne Maria, 40n. Daneo Eduardo, 66n. Danzi Guglielmo, 127n., 213 D’Attorre Pier Paolo, 187n. Dau Novelli Cecilia, 72n. Davanzo Poli Doretta, 26n. De Bernardi Alberto, 130n. De Col Giuseppe, 26n. De Fort Ester, 66n., 145n. De Giorgio Michela, 145n. De Grazia Victoria, 132n., 134n., 141n., 148n., 155n. De Nunzio Schilardi Wanda, 35n. De Witt Maria, 63 Defoe Daniel, XV Dei Marcello, 62n. Della Porta Gisella, 168 Delmonaco Aurora, 61n., 62n. Deserti Alessandrina, 66 Di Cori Paola, XIIIn. Di Domenicantonio Francesco, 197n. Di Vittorio Giuseppe, 190 Diaz Laura, 188, 188n. Diez Gasca Maria, 134, 141, 141n. Dittrich-Johansen Helga, 131n., 135n., 136n., 149n. Donati Itala, 64n. Donna Paola [v. Baronchelli Grosson Paola] Ellena Vittorio, 3n., 30n. Elmi Antonio, 19 Erioli Elisa, 100n., 101n. Faccio Irene, 147n. Fanfani Amintore, 178, 187 Farge Arlette, XVn. Farina Rachele, 29n., 82n. Fasella Giulio, 62n. Federici Maria, 169, 170, 171, 171n., 178, 201, 203 Ferrante Lucia, 67n. Ferrara Patrizia, 158n. Ferrari del Latte Rachele, 134, 148n. Ferri Umberto, 35n. Fibbi Lina, 181 Finzi Roberto, 11n., 154n. Foa Vittorio, 181 Formiggini Alberto Sabatino, 97n. Fornasari Massimo, 196n. Fraisse Geneviéve, XVIIIn., 6n. Franchi Silvia, 75n. Frank Malvina, 73 Gabelli Aristide, 63n. Gabrielli Patrizia, 172n. Gadda Carlo Emilio, 139, 140n. Gagliani Dianella, 83n., 156n. Gaiotti De Biase Paola, 71n., 76n., 172n., 173n., 190n., 191n. 214 Galasso Giuseppe, 196n. Galletti Adalgisa, 86 Galli Paolo, 37n. Gallo Marco, 197n. Galoppini Annamaria, 170n. Gardini Annunziata, 16 Garibaldi Luciano, 166n. Garofalo Anna, 169 Garuti Susanna, XVIIn. Gasperini Albertina, 30, 30n. Gatteschi Fondelli Piera, 166 Gavelli Mirtide, 100n. Gelati Maura, 146 Genovesi Giovanni, 146n. Gentile Emilio, 135n., 136n., 146n. Gentile Giovanni, 141, 141n. Gentili Rino, 145n. Ghetti Baldi Orsola, 26n. Ghizzoni Carla, 130n. Giacomelli Antonietta, 50n., 51n. Gibelli Antonio, 51n., 95n., 96n., 97n., 99n., 102n. Gigli Marchetti Ada, 11n., 18n., 75n. Giorgis Anna, 32, 32n. Giovanelli Loretta, 53n., 54n. Giovannetti Domenica, 9n. Gissi Alessandra, 39n., 40n., 41n., 144, 144n. Giudice Maria, 80, 80n. Giurati Giovanni, 132 Giusti Pesci Clementina, 18n., 19n., 20, 20n. Giustiniani Bandini Cristina, 76 Goia Maria, XX, 75, 81, 81n. Goldoni Luigi, 151 Goriux Bruschi Wanda, 131n., 132n. Gotelli Angela, 169 Grassi Gertrude, 86 Greco Paolo, 157n. Groppi Angela, XVIn., 56n. Guarracino Scipione, 130n. Guelfi Del Vecchio Ada, 179 Guicciardi Fiastri Virginia, 103 Guidetti Serra Bianca, 33n. Guidi Mussolini Rachele, 138 Hufton Olwen, XV, XVn. Hunecke Volker, 4n. Imbergamo Barbara, 67n., 80n., 85n., 88n. Imprenti Fiorella, 27n., 29n., 54n. Iotti Nilde, 169 Jacini Stefano, 11 Jasmar Nyta [Scanabissi Samaritani Clotilde], 59, 59n. Kotnik Dara, 181n. Indice dei nomi Kuliscioff Anna, XX, 63, 63n., 75, 79, 79n., 91 La Malfa Ugo, 174 Labanca Nicola, 138n., 140n. Labriola Teresa, 77 Lajolo Davide, 194 Lama Luciano, 181 Lanzardo Liliana, XIIIn. Lelli Cesira, 19 Leone Giovanni, 201 Leoni Diego, XIIIn. Lepre Aurelio, 165n. Lesina Ernestina, 74 Levi Civita Libera, 167n. Liverani sorelle (Luisa, Adele, Maria), 27 Loffredo Ferdinando, 128, 128n. Lombardi Jole, 168 Lombardo Ester, 77n., 131n., Lombroso Cesare, 11n., 160. Lombroso Gina, 160, 160n. Lonni Ada, 34n. Luccarini Alfonsina, 148n. Lucifero Roberto, 170 Lunadei Simona, 174n. Lupinacci Josette, 167n. Luzzatto Fegiz Pierpaolo, 193n. Luzzi Maria Vittoria, 143, 161 Maffioli Claudia, 168 Maffioli Dalmazio, 56n. Majer Rizzioli Elisa, 50n., 131, 131n. Majno Bronzini Ersilia, 19n., 29n., 68, 77, 80, 80n. Majani Napoleone, 151 Malnati Linda, 68, 72n., 75, 77, 80, 80n. Manotti Brunella, 170n. Mantegazza Paolo, 11n. Manzoni Edoardo, 44n., 47n., 142n. Marani Argani Laura, 133, 133n., 134n., 139 Marazzitti Mario, 196n. Marcelino Nella, 172n. Marchesi Concetto, 176 Marchesini Gobetti Ada, 168 Marchianò Giovanna, 126n., 127n. Margotti Maria, 183 Mariani Emilia, 6, 64, 64n., 66n., 68, 76, 77, 79, 79n. Mariucci Luigi, 22n. Martinelli Franco, 142n. Martini Manuela, 83n., 84n., 193n. Masulli Ignazio, 89n. Matera De Lauro Anna, 179 Matteotti Giacomo, 146 Mattei Tersa, 170, 170n., 171, 171n. Maurogiovanni Vito, 144n. Mazzatosta Teresa Maria, 149n. Indice dei nomi Meldini Pietro, 126n. Melis Guido, 158n. Melli Rina, XVII, XX, 74 Merli Stefano, 20n., 29n., 33n., 34n., 45n., 54n., 69n., 88n. Merlin Lina, 146, 169, 170, 178, 179, 179n. Merzagora Cesare, 181 Migliorini Filomena, 14 Minoletti Quarello Virginia, 168 Modesti Franca, 38n. Modoni Mirca, 155n., 156n. Molè Carlo, 201 Montagnana Rita, 167n. Montalti Sandra, 44n., 45n. Montanari Giulia, 100n. Montini Giovanni Battista, 172 Morandi Rodolfo, 32n., 33n. Morelli Lidia, 147n. Moretti Angiola, 130, 142, 156 Moretti Virginia, 27 Moro Aldo, 170, 170n. Moschini Clementina, 27 Motti Lucia, XIIIn., 67n., 174n. Mozzoni Anna Maria, 67, 73, 78, 78n. Musso Stefano, XVIn., 22n. Mussolini Benito, 125, 126n., 127n., 129, 131, 135n., 136, 139n., 149, 150, 150n. Mussolini Edda, 138 Musu Martini Bastianina, 168 Napollon Ernesta, 73n. Nasalli Rocca Gilberta, 103 Nasi Nunzio, 62n. Nava Paola, 52n. Negri Ada Garlanda, 68 Nenni Giuliana, 167n. Nightingale Florence, 47 Noce Teresa, 29, 29n., 153n., 168, 169, 177, 178, 178n., 180, 190 Nora Luciana, 9n. Oddone Bitelli Ines, XV, 74 Odorisio Maria Linda, XVIIIn., 56n., 57n., 58n., 60n., 63n. Ojetti Ugo [Salio], 95n. Onofri Nazario Sauro, 196n. Orano Paolo, 127n. Oriani Alfredo, 126n. Orione Luigi, 81n. Orsi Mangelli Paolo, 151 Ortaggi Cammarosano Simonetta, 4n., 6n., 29n., 30n. Padellaro Nazareno, 145n., Palazzi Maura, 11n., 12n., 18n., 25n., 67n., 94n., 95n., 96n., 98n., 100n., 154n., 158n. 215 Palmieri Elena, 19 Pancino Claudia, 39n., 41n., 42n. Parravicino di Revel Sabina, 70 Pasolini Maria, 82 Pazzaglia Anna Maria, 139n. Pazzi Muzio, 42, 42n., 43, 43n., 48n. Pedrocco Giorgio, 52n., 54n. Pelaja Margherita, 17n., 35n. Pende Nicola, 128, 128n., 141, 141n., 148, 148n. Perco Daniela, 37n. Perrot Michelle, XVIIIn., 6n. Persiani Cosci Dora, 40 Persico Giovanni, 200 Pertici Pontecorvo Adele, 161 Pescarolo Alessandra, 35n. Pesce Adele, 26n. Pessenda Giulia, 63 Peverelli Luciana, 159 Pezzè Pascolato Maria, 131n., 133, 133n. Pezzini Mario, 193n. Pezzoli Stefano, 16n. Piccinelli Caterina, 45 Picolato Rina, 168, 190n., 191n. Pieroni Bortolotti Franca, 55n., 67n., 69n., 78n., 79n., 92n. Pio XI, 128n. Piolanti Alba, 9n. Pisa Beatrice, 3n., 7n., 73n. Pisoni Cerlesi Ines, 153n. Polenghi Simonetta, 130n. Policardi Giovanni Maria, 27 Policardi Lorenzo, 27 Pollastrini Elettra, 168 Polotti Giulio, 60n. Pomata Gianna, 67n. Porciani Ilaria, 63n. Preti Alberto, 165n. Preti Margherita, 173, 173n. Pugliesi Giovanni, 43n., 44 Quarzi Anna Maria, 146n. Radini Tedeschi Giacomo Maria, 71 Ranieri Giovanni, 98 Ravà Aristide, 30 Ravasi Sofia, 77, 77n. Ravera Camilla, 156n., 187, 187n. Re Giuseppina, 179 Reggiani Flores, 18n., 19n. Revelli Nuto, 32n. Ricci Garoti Giuliana, 196n. Righi Maria Luisa, 174n. Rignano Sullam Nina, 17, 17n., 19, 19n., 20n., 68 Rinaldi Giovanni, 173n. 216 Rinaudo Paolo Cesare, 7 Riva Adele, 68 Riva Claudio, 44n. Rocco Alfredo, 126 Ropa Rossella, XXII, 175n., 185n. Rosenberg Charles E., 9n. Rossi Maria Maddalena, 202 Rossi Vittoria, 173 Rossi-Doria Anna, XXIIn., 170, 170n. Roveri Zelinda, XVIII Rovetta Gerolamo 19, 19n. Rubbiani Alfonso, 26, 26n. Saffi Giorgina, 73, 82 Salerno Elisa, 76 Salio [v. Ojetti Ugo] Salvati Mariuccia, 83n., 175n. Salvi Giovanni, 189 Samaritani Tommaso, 59n. Sanguinetti Ghiron Elena, 103 Sani Roberto, 196n. Sanlorenzo Olimpia, 40n. Sansone Luigi Renato, 178 Santoni Rugiu Antonio, 145n. Sarfatti Margherita, 33n., 75, 77n. Sarti Ferdinando, 176 Sarti Raffaella, 19n. Savoia Elisa, 130 Scanabissi Samaritani Clotilde [v. Jasmar Nyta] Scander Levi Adolfo, 73n. Scaraffia Lucetta, 35n., 63n., 64n. Scattigno Anna, 50n., 67n., 80n., 85n., 88n. Schiff Paolina, 67, 77 Scodnik Irma, 68 Scott Joan W., XVIIIn., 6n., 9n. Serao Matilde, XIV, XIVn., 35, 35n., 58, 59n., 63, 64n. Sezanne Augusto, 26n. Sgatori Roberto, 142n. Signorelli Amalia, 194n. Sillano Maria Teresa, XVIIIn. Sitta Pietro, 4, 4n., 7n. Soldani Simonetta, XIXn., 50n., 52n., 53n., 55n., 57n., 62n., 67n., 75n., 88n., 98n. Sorbelli Albano, 101n. Soresina Marco, 158n. Spalletti Rasponi Gabriella, 70, 70n. Spinelli Luciana, 54n., 55n. Stagni Anna Maria, 173 Starace Achille 127, 156 Stefani Luisa, 155n. Stoppa Ernesta, 82 Indice dei nomi Tamarozzi Giuseppe, 74 Tanara Maria Grazia, 82n. Taricone Fiorenza, 3n., 7n., 54n., 60n., 70n., 160n., 173n., 194n. Tarozzi Fiorenza, XIV, XVIn., 22n., 23n., 165n. Tarozzi Vittorina, 189n. Tartarini Alfredo, 26n. Tarugi Paolina, 77 Taverna Lavinia, 70 Tavernari Luigi, 55, 55n. Telmon Vittorio, 145n. Terhoeven Petra, 138, 138n. Terruzzi Regina, 77n., 135, 135n. Tibaldi Chiesa Mary, 202 Tilly Louise A., 9n. Tinarelli Emma, 56 Tomasi Tina, 198n. Tonietti Gennai Erisia, 202 Torcellan Nanda, 18n. Tosi Brandi Elisa, 27n. Troise Romelia, 60n. Turati Augusto, 132n., 156 Turati Filippo, 58n., 79n. Turnaturi Gabriella, XVIIIn. Ugolini Cecilia, 16n. Ulivieri Simonetta, 145n. Vaccari Ilva, 11n., 13n., 30n., 86n., 93n., 98n., 99n., 100n., 102n., 103n., 153n., 154n., 161n., 165n. Vecchi Filomena, 139n. Venturi Sergio, 16n. Venturoli Cinzia, XXII Verzelli Angela, 164n., 170, 183n. Vicarelli Giuseppe, 8n. Viganò Renata, 193, 193n., 194n. Vignudelli Gabriella, 197n. Villani, fotografo, 27 Vitanza Rosario, 55n. Volpi Claudio, 149n. Willson Perry R., 136n. Zadra Camillo, XIIIn. Zamagni Vera, 187n., 196n. Zangheri Renato, 84n., 196n. Zanini Emilio, 199, 199n. Zappaterra Paola, 183n. Zatterin Ugo, 189 Zavaroni Adolfo, 133n., 136n., 139n. Zemon Davis Natalie, XVn. Zorzi Miro, 163n. Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna Presidente: Ezio Raimondi Direttore: Alessandro Zucchini Consiglio Direttivo: Giordano Conti, Giovanni De Marchi, Laura Muti, Clementina Santi, Siriana Suprani, Isabella Zanni Rosiello Responsabile del servizio “Soprintendenza per i beni librari e documentari”: Rosaria Campioni Finito di stampare nell’anno 2010 da Editrice Compositori, Bologna
Scarica