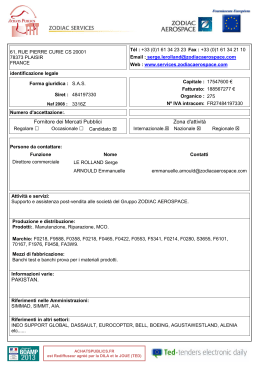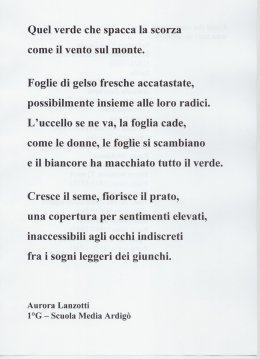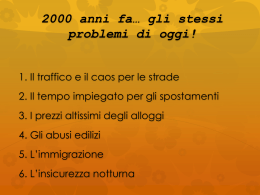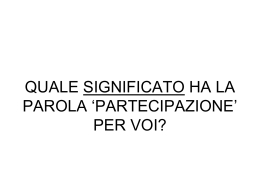leggi, scrivi e condividi le tue 10 righe dai libri http://www.10righedailibri.it Le strade 214 I edizione: novembre 2012 © 1939 Éditions Grasset & Fasquelle © 2012 Fazi Editore srl Via Isonzo 42, Roma Tutti i diritti riservati Titolo originale: S’il est minuit dans le siècle Traduzione dal francese di Maurizio Ferrara ISBN: 978-88-6411-191-9 www.fazieditore.it Victor Serge Se è mezzanotte nel secolo introduzione di Goffredo Fofi traduzione di Maurizio Ferrara Introduzione di Goffredo Fofi Al Congresso internazionale degli scrittori per la difesa della cultura tenutosi a Parigi nel giugno del 1935, quando il Fronte Popolare stava per annunciarsi e il Partito Comunista Francese se ne faceva partecipe e propagandista su pressione sovietica, dopo che Mosca l’aveva osteggiato in Germania con la conseguente vittoria del nazismo, erano presenti delegazioni internazionali soprattutto europee e “compagni di strada” di mezzo mondo. Lo promossero tra gli altri, tra i più attivi e convinti, André Malraux, André Gide, che più tardi, visitata l’URSS, ne sarebbe tornato amaramente deluso e avrebbe scritto coraggiosamente il suo celebre Ritorno dall’URSS, e gli ormai retorici e imbalsamati Romain Rolland e Henri Barbusse. Vi parlarono, tra i tanti famosi, gli ancora poco noti Brecht (sulla linea del Partito Comunista Tedesco degli anni precedenti, quando quello aveva rifiutato ostinatamente una politica di alleanza con la socialdemocrazia, con i risultati che si sanno) e Musil (che rivendicò il diritto dello scrittore di non occuparsi direttamente di politica e disse pressappoco: «Mi dicono che la politica ri- VII guarda tutti e perciò tutti devono occuparsene; anche l’idraulica riguarda tutti, ma se si rompe un rubinetto io chiamo l’idraulico»), e vi fu qualche grave imprevisto. Il maggiore, il suicidio di uno degli organizzatori, il giovane scrittore surrealista di grande talento René Crevel, conquistato a forme di impegno vicine ai comunisti e per questo vituperato da Breton, anche se fu Crevel ad aver permesso che l’intervento di quest’ultimo venisse pronunciato, letto però non da lui ma da un Éluard già conquistato all’engagement. Vi fu anche, ad agitare l’idillio dei difensori internazionali della cultura, il vibrante intervento del nostro Salvemini che, accogliendo l’invito degli amici di Victor Serge e soprattutto di Magdeleine Paz, straordinaria giornalista e militante d’area trotskista, rimproverò ai sovietici – la delegazione russa comprendeva alcuni fedelissimi del regime stalinista come Kol’cov, Kirson ed Ehrenburg e un malmesso e spaventato Pasternak (che se la cavò con un intervento estemporaneo su poesia e malattia) – di parlare ipocritamente di difesa della cultura mentre uno scrittore come Victor Serge, peraltro di lingua francese e di nascita e nazionalità belga, figlio di un esule dalla Russia zarista, era, come tanti altri, deportato negli Urali. Kol’cov e Kirson, stalinisti a oltranza, finirono per perdere la vita nelle “purghe” di pochi anni dopo. Quando il vecchio Rolland andò in URSS poche settimane dopo, diventato da leader pacifista e scrittore umanista con propensioni gandhiane un sostenitore accanito del regime sovietico visto come prima difesa dalla prepotenza nazista e disposto per questo a prender per buona la sua propaganda, vi venne accolto entusiasticamen- VIII te e fece presente a Stalin che la detenzione di Serge non favoriva la simpatia degli intellettuali francesi per l’URSS. Così Stalin fece liberare Serge e suo figlio, che aveva allora intorno ai dieci anni, e lo scrittore, pur con tutte le immaginabili difficoltà (si mantenne lavorando a Parigi come correttore di bozze nelle tipografie dei giornali, là dove la forza del sindacato era più grande di quella del Partito Comunista), pubblicò i suoi saggi sulla storia della rivoluzione russa vista davvero dal suo interno, i suoi pamphlet straordinariamente lucidi sulla politica staliniana, e anche, presso Grasset, il romanzo Se è mezzanotte nel secolo. C’era stata l’uccisione di Kirov (si legga Il caso Tulaev, che è il migliore e il più ambizioso tra i romanzi di Serge, dove tra i personaggi compare lo stesso Stalin) ed era servita al regime per far partire a Mosca i grandi processi contro gli oppositori, di un’evidenza dittatoriale che ovviamente non venne colta da coloro che non volevano vedere, come le migliaia di intellettuali conquistati in tutto il mondo alla causa sovietica. Il nemico principale era diventato non più il capitalismo ma il nazismo, e Stalin arrivò a trattare perfino con quello (l’atroce patto Molotov-Ribbentrop) per avere più tempo nella preparazione della guerra a tutto danno della Polonia e di altri paesi collocati geograficamente in mezzo alle due nefaste potenze. E il mondo assistette al paradosso che gli imputati confessavano cose che non avevano mai fatto e pensato. La letteratura critica nei confronti del tradimento della rivoluzione era ampia a destra ma estremamente scarsa a sinistra. Cerchiamo di ricordare le poche opere si- IX gnificative, sottoposte alle invettive o al disprezzo dell’esaltata intellighenzia dell’impegno. Onore al merito, il primo libro importante venne da Panait Istrati, grande appassionato vagabondo e scrittore romeno di lingua francese, che nel 1929 osò mettere in piazza con Verso l’altra fiamma le sue brucianti disillusioni dopo una lunga visita “ufficiale” in Unione Sovietica. Venne poi Gide, il più odiato perché il più noto: 1936, Ritorno dall’URSS. Nel 1941 Koestler dette alle stampe Buio a mezzogiorno, che disse dei processi quello che fuori dell’URSS sembrava inconcepibile. Ascoltiamo Serge, nelle Memorie di un rivoluzionario: «I vecchi bolscevichi erano compenetrati da un tale fanatismo di partito, da un tale patriottismo sovietico, che diventavano capaci di accettare i peggiori supplizi, e per ciò stesso erano incapaci di un tradimento. Le loro stesse confessioni provano così la loro innocenza. [...] L’immensa maggioranza dei bolscevichi si sono del resto lasciati fucilare nella notte senza prestarsi al gioco abominevole delle confessioni per compiacenza politica». Altri capisaldi: 1945, La fattoria degli animali di Orwell; 1951, Un mondo a parte di Gustaw Herling, il primo grande libro a raccontare il gulag dall’interno, nello stesso anno in cui Serge pubblicava le sue Memorie; 1957, Il dio che è fallito, sei testimonianze di chi era stato comunista, Koestler, Orwell (il titolo del libro era suo), Gide, ma anche Ignazio Silone, Richard Wright, Louis Fischer e Stephen Spender (il saggio di Silone era apparso su «Comunità» nel 1949, il più noto Uscita di sicurezza apparve senza data ma intorno al 1955 o al ’56 in un opuscolo dell’Associazione per la libertà della cultu- X ra, e fu ripreso in volume solo nel 1965). Con la destalinizzazione le testimonianze e le memorie si moltiplicarono, ma a scriverle non si correva più alcun rischio. Ricordo le più forti: Aleksandr Solženicyn, Evgenija Ginzburg, Nadežda Mandel’štam, Vasilij Grossman e naturalmente Varlam Šhalamov, dalla Kolyma. Tante altre se ne possono aggiungere. Nel cinema, il gulag è stato mirabilmente narrato nel capolavoro di Vitalij Kanevsky Sta’ fermo, muori, risuscita, dal punto di vista di un ragazzino e non di un confinato politico ed eravamo già nel 1989… Il gulag, appunto. È questo il tema del romanzo di Serge Se è mezzanotte nel secolo. Lo avessero letto i giornalisti e gli storici che hanno frettolosamente – è stato di moda – comparato Auschwitz e la Siberia, i lager nazisti e i campi sovietici, gli avrebbe permesso di evitare banalità e imprecisioni. Così come ieri era di moda tra gli intellettuali conformisti (quasi tutti) schierarsi dalla parte dell’URSS, così è diventato di moda tra i loro allievi e seguaci denunciare le equivalenze tra nazismo e stalinismo in gloria dei sistemi occidentali, di regimi capitalistici più o meno democratici, di una democrazia potentemente manipolata. «Che fare, se è mezzanotte nel secolo?», si chiede, dal gulag, uno dei personaggi del romanzo di Serge dietro il quale si nasconde certamente qualche individuo reale, qualche vero perseguitato. Tema del romanzo è l’implacabile meccanismo del sospetto e della repressione “preventiva” che Stalin ha messo a punto con la sua polizia politica, la GPU, in anni in cui l’opposizione, pur divisa al suo interno, era tuttavia ancora attiva e Trotskij non era XI stato ancora mandato in esilio (la condanna a morte del secondo dei massimi leader e artefici della vittoria del bolscevismo era stata solo procrastinata, dal boia del Kremlino, per i soliti motivi di credibilità internazionale). I vecchi bolscevichi sanno di avere ben poco da sperare dal regime e dalla “nuova classe”, i comunisti dell’ultima ora, che Stalin ha saputo lusingare e conquistare assai facilmente. Sanno che prima o poi toccherà anche a loro, che prima o poi verranno arrestati, che gli verrà fatto confessare il falso con il ricatto del “destino della rivoluzione” o più brutalmente, con la tortura, sanno che potrebbero trasformarsi in delatori a loro volta, e che alla fine di questo calvario li aspetta o la morte o il confino, la Siberia, il gulag. In anni di deportazioni di massa, di carestia, e anche di accerchiamento internazionale, di piani quinquennali a tappe forzate. Il quadro che Serge ci trasmette di quest’epoca di lupi è bensì attento a raccontarci anche i non politici, non solo i repressi e i repressori, anche ciò che c’è intorno: la vita quotidiana e la fame quotidiana delle popolazioni (poco convinte, a parte i funzionari, delle idee propagate dal regime), i piccoli eroismi e le piccole viltà di una quotidianità angosciante, in una feroce scarsità di beni e sotto un ramificato controllo sociale, poliziesco. Ciò nonostante, nel carcere e nel gulag i vecchi rivoluzionari cercano di resistere, di incontrarsi, di sopravvivere senza doversi vergognare delle proprie azioni, e cercano perfino di cospirare, incrociando altre storie, altre vite: come le loro, diverse dalle loro. Le loro esistenze si confrontano con quelle di chi in quei luoghi ci è nato e di chi vi è stato deportato prima di loro, nell’immenso paese scelto per XII far da prigione collettiva e di massa e come luogo di accoglienza e di lavoro forzato per intere popolazioni trasferite da lontanissimi altrove. Finché non si muore, si ha nientemeno che il compito di edificare il socialismo in quella parte dell’impero e di contribuire all’affermazione di un sistema economico decisamente schiavista. I personaggi di Serge non sono mai degli sprovveduti, sono soprattutto dei militanti, sono dei rivoluzionari, quasi sempre dei bolscevichi, e il loro tormento è quello di chi non ha altro scampo se non insistere, non arrendersi, non cedere fino all’ultimo respiro alle menzogne e alle violenze del nemico. Quello che Serge ci mostra è il vero volto del gulag, sperimentato dal di dentro, dal punto di vista di chi è stato costretto a conoscerlo bene ed è riuscito a sopravvivere, è riuscito perfino a uscirne in grazia di strane circostanze internazionali, nella provvisorietà di un momento storico preciso e irripetibile. Ma Se è mezzanotte nel secolo non è solo questo, non è solo il possente affresco di un’epoca tragica, del cui significato per la storia del Novecento e del cui valore di testimonianza il suo autore era ben cosciente. È anche un romanzo ed è un vero romanzo. I romanzi di Victor Serge sono sempre caratterizzati dalla coralità. Lo interessa l’epoca, e nell’epoca non i personaggi qualsiasi ( i “piccoli uomini” della grande letteratura russa dell’Ottocento e, di nuovo, di quella odierna) bensì coloro che hanno preso in mano il proprio destino, che hanno scelto di contribuire attivamente alla distruzione di un ordine (il capitalismo, il potere borghese) e alla costruzione di un nuovo ordine, o meglio, di XIII una inedita armonia (il socialismo, e non “la dittatura del proletariato” o di un partito che afferma di parlare in nome del proletariato mentre lo piega e asservisce). Sono, vogliono essere, romanzi di tipo nuovo, perché Serge ha un modello, Dos Passos, e ha avuto di fronte o a fianco i grandi scrittori della rivoluzione, quelli che hanno cercato nuove forme letterarie che fossero coerenti alle nuove forme di una società in costruzione. Che grande scrittore avrebbe potuto essere Serge se avesse scelto di fare, di ritorno dall’URSS, il romanziere, smettendo di fare il militante! Ma non c’è da rammaricarsi che così non sia stato e che egli abbia scelto di mettere al primo posto la Rivoluzione e non la Letteratura. Le sue Memorie restano, per esempio, uno dei grandi libri del Novecento, di quelli che permettono al lettore di capir meglio i dilemmi di quel secolo, e la sua grandezza come il suo abominio. «L’intellighenzia russa mi aveva di buon’ora insegnato che il senso stesso della vita consiste nella partecipazione cosciente al compimento della storia. Questo vuol dire pronunciarsi attivamente contro tutto ciò che sminuisce gli uomini e partecipare a tutte le lotte che tendono a liberarli e a farli più grandi. Che questa partecipazione sia inevitabilmente intaccata da errori non ne diminuisce l’imperativo categorico; peggiore è l’errore di vivere soltanto per sé, secondo tradizioni tutte intaccate di inumanità», ha scritto Serge nelle ultime pagine del libro. Ancora: «Nel corso della battaglia il problema è ottenere la massima efficacia pratica e insieme rispettare che cosa c’è dietro il nemico: il problema della guerra senza odio, in una parola. La rivoluzione russa, benché diretta XIV da uomini probi e intelligenti, non lo risolse; le masse avevano ricevuto dal dispotismo un’educazione troppo funesta, non estranea ai dirigenti stessi. Non disconosco, enunciando questo giudizio, la potenza dei fattori economico-storici; essi sono in gran parte condizione dell’azione, ma non ne determinano tutta la qualità. A questo punto interviene il fattore umano». Ribellarsi è giusto, anche se è diventato vieppiù fondamentale, pensando ai fallimenti del Novecento, avere la massima considerazione del rapporto simbiotico che deve esistere tra i fini e i mezzi. Leggere Serge ci permette di capire una cosa che abbiamo voluto dimenticare e che era ben presente alle popolazioni del suo tempo, e a quelli che, provenendone, si sono fatti intellettuali e politici sentendo come un obbligo anzitutto morale la necessità assoluta della rivoluzione (e si trattava in particolare di giovani). Serge non è un “pentito” dei tanti che, di fronte al fallimento dell’esperimento sovietico, hanno decretato la fine delle rivoluzioni. Serge è ben cosciente che la rivoluzione è una necessità imprescindibile, sempre. E che la scelta non può che essere, ieri come oggi, quella di ribellarsi all’ingiustizia e alla corruzione del potere che ci manipola e condiziona, che ci opprime. La scelta è pur sempre tra socialismo o barbarie. Forse oggi più che mai. E la letteratura? Cito ancora una volta dalle Memorie, là dove Serge si spiega meglio di quanto non possa fare un suo lettore: «Sapevo che non avrei mai avuto il tempo per rifinire le mie opere. Avrebbero avuto ugualmente un valore. Altri, meno combattenti, avrebbero fatto dello stile perfetto; quel che avevo da dire non avrebbe- XV ro potuto dirlo, loro. A ciascuno il suo compito». Eppure l’opera letteraria di Serge, non solo quella del memorialista, dello storico, del saggista, è tra le più appassionanti del Novecento. Se è mezzanotte nel secolo lo dimostra. Come diceva di sé Céline, con molta pazienza anche Serge avrebbe potuto scrivere libri letterariamente perfetti, ma non ne aveva il tempo e non ne aveva la voglia, aveva di meglio da fare, ed è in questo “meglio” che risiedono la qualità e la forza dei suoi romanzi. «Nel nostro tempo, i bambini devono capire». XVI SE È MEZZANOTTE NEL SECOLO Alla memoria di KURT LANDAU, ANDRÉS NIN, ERWIN WOLF, scomparsi a Barcellona e la cui stessa morte ci è stata rubata, a JOAQUÍN MAURÍN, in una prigione spagnola, a JUAN ANDRADE, JULIAN GORKIN, KATIA LANDAU, OLGA NIN e tramite loro a tutti quelli di cui impersonano l’audacia, dedico i messaggi dei loro fratelli di Russia. PARTE PRIMA Il Caos Mikhail Ivanovič Kostrov, per niente superstizioso, sentiva arrivare le cose nella sua vita, preannunciate da indizi quasi impercettibili. Così il suo arresto. C’era stato il tono inconsueto del rettore, mentre gli diceva: «Mikhail Ivanovič, ho deciso di sospendere momentaneamente il suo corso… È giunto al Direttorio, vero?». Timore di allusioni alla nuova svolta politica, ovviamente. «Mi prepari piuttosto», continuava il rettore, «un breve corso sulla Grecia…». Un divario di circa duemila anni. In quel momento, Kostrov sentì di commettere un errore, ma lo commise con allegria, per il piacere di spaventare un po’ quel fifone ben saldo al suo posto, il quale sfoggiava un tono di voce particolare quando telefonava al segretario del comitato. «Ottima idea», disse, «ho in mente da tempo una serie di lezioni sulla lotta di classe nella città antica… C’è spazio per una nuova teoria della tirannia». Con la testa china sulle scartoffie, il rettore evitava il suo sguardo. Per via del cocuzzolo pelato della testa, sembrava che fosse tonsurato. «Senza esagerare con le nuove teorie, però. Arrivederci», mormorò tra le grosse labbra. E proprio scorgendo la tonsura, Mi- 7 khail Ivanovič si sentì istradato verso certi avvenimenti… Uscì da lì con un’idea precisa: qualcuno mi ha denunciato, chi? Poi la memoria gli fece ritrovare l’immagine di una donnetta sciatta e tarchiata, con il busto un po’ forte, fasciata in un impermeabile dei depositi militari. Fronte stretta, bocca lunga, sguardo privo di cordialità – qualcosa di un roditore nell’insieme del viso –, quella donna non gli piaceva. Nella mano grassoccia, una cartella da militante certamente piena zeppa di documenti importanti. Tesi del comitato di settore per gli agitatori, lista degli attivisti eccetera… «Compagno professore, lei non è stato molto chiaro sui termidoriani di sinistra… oppure io non ho afferrato il suo pensiero… Erano, lei ha detto, l’ho annotato, cattivi termidoriani e, sostenendo Barras e Tallien, andavano incontro alla loro rovina… Non capisco affatto la sua distinzione tra buoni e cattivi termidoriani…». Tu mi sorvegli, piccola canaglia, sei stata tu, proprio tu, a denunciarmi… Lei usciva in quell’istante dalla sala di Dia-Mat – dialettica materialista – con la cartella in avanti, e quell’odioso petto flaccido, intenta a parlare forte con la voce un po’ rauca, fatta per le tribune di tavole mal piallate e gli striscioni rossi… Naturalmente, parlava del giornale murale. «Non è lecito», diceva in tono imperioso, «anzi è inammissibile! Il comitato di redazione…». Alla parola inammissibile, Kostrov non ebbe più dubbi. Delatrice. Affrettò il passo per non doverle rivolgere il saluto, ma lei già lo salutava con allegria e alle sue spalle spuntava la testa ricciuta di Irina, una giovane ziriana, delle alte terre della Kama, che lui trovava deliziosa con il suo viso liscio, gli occhi allungati, gli zigomi prominenti, le labbra sottili dise- 8 gnate da un miniaturista dell’età della renna. «Allora, compagna», le chiese, «il suo tema? Va bene?». Lei fece sì, sì, con la testa, seria e gioiosa, gioiosa solo in fondo agli occhi: granelli d’oro lontani come sul fondo dell’acqua. Parlarono per qualche istante, poi furono separati da una fiumana di studenti, perché suonavano le undici. Quella sera, seduto a tavola di fronte a Ganna, in mezzo a loro Tamaročka appollaiata sulla sedia dallo schienale pitturato, domandò: «E cosa diresti, Ganna, se mi arrestassero?». Ganna non smise di servire alla bimba il piatto di minestra. Un tenue rossore le coprì le guance, gli occhiali cerchiati di tartaruga sembrarono un po’ storti quando lei disse semplicemente: «Credi?». La bimba ascoltava, topolino in agguato. Nel nostro tempo, i bambini devono capire. Devono sapere. È meglio prepararli che mentire con loro di continuo. Quando hanno arrestato Vanil Vanilič, al piano di sotto, quindici giorni fa, la sua Svetlana, alla quale avevano detto che «papà è andato a Leningrado, sai, all’Accademia delle Scienze», alla fine si è lamentata dicendo che la ingannavano. «E io so che papà è in prigione, lo so, lo so! E mi rattrista che papà è in prigione, ma perché tutti quanti dite bugie?». L’ebreo del terzo piano era in prigione. Anche il cognato di Marusja. Svetlana, sette anni, diceva a Tamaročka, sei anni: «Ho visto un uomo che è stato fucilato: veniva a casa di mia zia, aveva un nasone, era un uomo brutto, sono contenta che lo hanno fucilato». Il nonno la rimproverava: «Svetlana, non sta bene parlare 9 così, Svetlana, devi pensare al dolore degli altri». (Un vecchio rimbambito, il nonno, che simpatizzava cautamente per la setta dei Čurikovci). Imbronciata, Svetlana si ostinava, guardandolo da sotto la sua ampia fronte bombata: «E io, nonno, ti dico che è un uomo brutto, e allora hanno fatto bene, hanno fatto bene a fucilarlo…». Saltellava su un piede ripetendo: «Hanno fatto bene». Probabilmente lo diceva per veder spuntare i lucciconi negli occhi del nonno e un lieve tremito sulle sue labbra, da cui capiva che lui le voleva bene e che era debole. Tamaročka osservava quella scena, ascoltava tutto. Come le vuole bene, il nonno, e come lei lo tormenta! Svetlana, quanto sei cattiva, pensava. E faceva un balzo di lato, picchiava sulla spalla di Svetlana e scappava dietro la panchina per farsi rincorrere… Allora il nonno guardava, stagliata con la sua pietra grigia contro il cielo pallido, la figura eretta di un uomo emaciato, severo, tutto in linee alte. Così dritto. Così duro. Così bello. L’Inquisitore. Il nonno sospirava. Eppure era soltanto il naturalista Timirjazev, perché le bambine andavano a passeggiare in viale Tverskoj, all’incrocio di Malaja Nikitskaja. In quella via calma, una banale chiesa bianca sulla destra: lì si sposò Puškin cent’anni prima. Puškin: Nessuna felicità quaggiù, ma la calma e la volontà. Al nonno piaceva quel verso, lui che non aveva avuto né calma né volontà. Come lo stesso Puškin. Come quasi tutti quaggiù. Ma quel verso conteneva un’armonia, una menzogna stupenda. No: una verità dell’aldilà. Più vera della verità, superiore. La calma e la volontà non 10 esistono; dominano tutto; inaccessibili e supreme, reali e irreali. Nessuno può capirlo, nessuno… Di fronte alla chiesa, un palazzetto basso, circondato da un’inferriata rafforzata da uno steccato, contro l’indiscrezione: ci viveva Maksim Gorkij. Quello lì non aveva bisogno di niente. Né calma né felicità né volontà! Scriveva inesorabilmente cose sdolcinate e stomachevoli, quasi senza anima… Forse ne soffriva, perché si deve pur soffrire sentendo di avere così poca anima alle soglie della morte. Pregherei volentieri per te, Aleksej Maksimovič, ma le tue pagine non mi fanno venire la voglia, pensava il nonno… Tutto quell’universo, e anche più vasto, più complicato, era in quell’istante nell’anima di Tamaročka, sei anni, topolino in agguato, che mangiucchiava qualcosa, a tavola, con gli occhi spalancati. Sopra di lei, l’uomo e la donna scrutavano nel loro intimo il futuro. «Credi?», ripeté Ganna. Kostrov si accorse di saperlo. Prescienza, presentimento sono parole di ignoranti che però dicono quello che dicono. Si fa la somma di una quantità di osservazioni subconsce e di calcoli, il risultato è una certezza immediata, forse non proprio razionale, ma tra le più valide. «Sicuro. In sei settimane, abbiamo avuto trecento arresti a Mosca, ci pensi? Tutti uomini della mia generazione, militanti della guerra civile, oppositori del ’26’27, e tutti si erano fatti da parte per essere lasciati in pace…». Ganna rifletteva. Ganna, straordinariamente simile a una ragazzina studiosa, con le guance rosa, il naso un po’ all’insù, i capelli tirati all’indietro. Anche a letto, al mo- 11 mento delle carezze, Kostrov voleva che lei tenesse gli occhiali di tartaruga, per la serietà divertente che conferivano al suo viso infantile. Allora arrossiva deliziosamente. «No, permettimi di toglierli, sto a disagio…». Il riso del maschio la contrariava, si faceva di porpora mentre Mikhail ripeteva: «Te lo proibisco, tesoro, tesoro…», chinandosi su di lei, nuda. L’amava, non sapeva se davvero l’amasse. Si vive così, senza sapere. «Se ti arrestano», chiese Ganna, «non pensi che mi licenzieranno dall’ufficio di Statistica?». Possibile, infatti… «Venderai il divano… E il mio completo scuro». Risero. Il divano, il completo scuro, ultime risorse! Erano pronti. Due giorni dopo fu arrestato. Semplicemente, per strada, prima della fermata del tram. Sul marciapiede comparve al suo fianco un tizio e, camminando con il suo stesso passo, lo raggiunse di sbieco. Berretto e soprabito miseri, giovane viso di uomo rozzo. «Compagno Kostrov, le chiedo di seguirmi…». «Lo so, lo so», fece Mikhail Ivanovič, quasi liberato dal peso dell’attesa. L’altro non si stupì. «Di qua». Entrarono in un cortile con il selciato sconnesso. Vi ristagnavano alcune pozzanghere di pioggia, un’auto inzaccherata dal fango della notte precedente sostava davanti a una porta che si apriva su un corridoio buio… Dalle cantine saliva un odore dolciastro di marciume. Kostrov sguazzò in una pozzanghera, contrariato al pensiero che si sarebbe sporcato i pantaloni, ancora più contrariato perché si accorgeva di pensare a una cosa tanto stupida. Il tizio gli aprì la portiera dell’auto. «Salga, cittadino». Il comitato della cooperativa di alloggio prega gli inquilini in ritardo con la pigione… pena l’iscrizione nella lista nera… Coo- 12 perativa di alloggio n. 6767, Lenin vive in eterno. Kostrov lesse quelle righe affisse sull’intonaco screpolato… In eterno! Branco d’idioti! L’auto sobbalzò tra le pozzanghere, svoltò davanti al campanello impazzito di un tram, si slanciò verso la torre quadrata, massiccia, fatta di mattoni rossi della porta della Trinità, corse lungo i merli del Cremlino, l’alto colonnato bianco del Gran Teatro, rallentò sotto un ritratto gigantesco del Capo, che ricopriva tutta la facciata di un grande magazzino in costruzione, si fermò di colpo in piazza Dzeržinskij all’altezza di una porta come un’altra, sorvegliata da un soldato che aveva in testa una sorta di casco di stoffa a punta. Sopra la porta, una maschera di bronzo annerito abbozzava un brutto sorriso tra la barba. Salve Marx, gli disse tra sé Kostrov. Ti fa il solletico, questa baionetta? Fai bene a non mostrarti in mezzo a noi, altrimenti potresti varcare anche tu questa porta, vecchio fratello, e saresti ben servito… Aveva solo idee puerili che andavano e venivano alla rinfusa nel cervello sferzato da un vento freddo. Ma non la paura: una specie di sollievo, un desiderio di sbeffeggiare… *** Più tardi, sprofondò nella noia di una lunga attesa inutile in un ufficio vuoto; da lì fu fatto scendere con l’ascensore in una delle tante sezioni del Caos; dal Caos risalì alla superficie del silenzio, in tutta tranquillità; e poi sopraggiunse quel dolore al cuore. Così gira una chiave in una serratura, dall’altro lato della porta; e dietro quella porta c’è l’ignoto della desolazione. Soddisfatto di sé, 13 Kostrov avrebbe potuto dire: «Sapete, stare in galera non mi mette in agitazione. Ne ho viste ben altre. Per esempio a Lvov, in Polonia, nel ’20, i poliziotti mi hanno catturato in una retata di sospetti, ero proprio nei guai, amici miei. Se avessero guardato meglio il mio passaporto ceco, come minimo mi avrebbero impiccato. Nel ’21, altra storia a Tiflis, meno pericolosa, certo, poiché i socialdemocratici georgiani furono informati per bene. Noe Agašvili venne a trovarmi nella prigione del Metek, ci eravamo conosciuti a Parigi. “La vostra sommossa?”, mi disse. “Ma sono io a tenerne le fila, caro mio. Ti metto al sicuro, nel tuo stesso interesse. To’, vuoi fare una partita a scacchi?”. Devo dirvi che Agašvili non ha mai dimenticato lo scacco matto che gli ho inflitto a Pietroburgo dopo l’insurrezione di luglio, dove abbiamo combattuto l’uno contro l’altro all’angolo della Millionnaja… L’ho arrestato proprio io un po’ di tempo dopo la sovietizzazione; a quest’ora lo avranno deportato in Uzbekistan… Nel ’24, a Rusčuk, in Bulgaria, un brutto momento… Nel ’28, a Mosca, ho però fatto belle discussioni ideologiche con il giudice istruttore. Non prive di effetto, dal momento che lui ha poi preso una brutta piega, o meglio una buona: è nelle isole Solovki, cinque anni, five years, Sir… per deviazionismo di estrema sinistra… Qui, dopotutto, mi sento in famiglia, a casa mia. Ci sbattono in galera, lo vuole la politica. Lo stoccaggio del grano si avvicina, sarà un fiasco, ovviamente, i calcoli di verifica della commissione del Piano lo indicano a sufficienza. Allora, hanno paura di noi, sebbene stiamo zitti…». Il Caos era una camerata rettangolare che conteneva sei giacigli e trenta prigionieri. Il vapore degli aliti scor- 14 reva lungo le pareti, il fumo del tabacco era tale che ci si muoveva in una nuvola soffocante. Faceva molto caldo, si aveva la carne madida di sudore, il mal di testa, la voglia di vomitare. C’era sempre qualcuno che vomitava, bisognava pisciare e defecare nel bugliolo; e i nuovi arrivati, confinati in quell’angolo, vivevano nella puzza e tra i sudici rumori organici. Si dormiva sopra e sotto i letti; per muoversi, si riservava di comune accordo, stringendosi gli uni agli altri, accovacciati e in piedi, uno spazio angusto lungo il muro di fondo, chiamato il viale. A turno, ognuno poteva sgranchirsi un po’ le gambe. Di sera, da qualche parte lassù, dopo parecchi piani che erano universi chiusi, sovrapposti, un’orchestra di ottoni iniziava a suonare un’aria travolgente per far danzare, nel circolo del 4° battaglione speciale, uomini in uniforme e donne bionde, castane, brune, rosse, sì, anche rosse, troppo incipriate, con le spalle coperte da quei graziosi scialli sgargianti che erano venduti a ventuno rubli nella cooperativa del servizio politico. Un fantasma con la barbetta, in piedi nella foschia del Caos, raccontava di aver rivenduto alcuni di quegli scialli, «e ora, lassù, quelle puttane si dimenano, mentre io sto qui per sei scialli, ah, se la vita è così, merda!», le ingiurie gli colavano dalla bocca, gli ottoni si esaltavano. Trenta fantasmi con le voci soffocate dal regolamento si agitavano lì dentro, adattandosi a vivere gli uni sugli altri, a grattarsi senza infastidire troppo il vicino, a dividere equamente l’acqua tiepida, il pane nero, pezzettini di zucchero, ad ammazzare il tempo, ad ammazzare la paura. Si poteva stilare una lista abbastanza completa dei delitti possibili, abietti e nobili, immaginari, finti, reali, incredibili, catalogan- 15 do le loro storie che del resto si raccontavano soltanto a fior di labbra, per timore delle spie. «Guarda un po’, quel vecchio, a destra del bavoso che se ne sta coricato per tutto il tempo, è una spia. Gli hanno promesso qualcosa affinché si metta a sentire, senta tutto e anzi calchi la dose. Ovunque andrà, non ce lo lasceremo scappare, puoi credermi». Si poteva stilare una lista ancora più completa delle sofferenze vane e delle innocenze inconsapevoli nello scrutare un po’ le loro coscienze di fantasmi. L’Anziano era il più alto, il più ossuto e il più assennato degli abitanti del Caos: le sopracciglia cespugliose e il mento di pietra squadrata spuntavano in mezzo alla nebbia di tabacco scadente, a ogni difficoltà, e ristabilivano l’ordine, la pace. «Ho tutto Dostoevskij nel mio Caos n. 16», diceva con orgoglio, «e anche di più. Trentuno disgrazie stamattina». Due trotskisti, uno vero e uno dubbio, il vero sotto il letto, l’altro sopra, discutevano a voce bassa le obiezioni di Radek alla teoria della rivoluzione permanente. Mikhail Ivanovič li notò, ma anche lui aveva abiurato nel ’29, riconoscendo che la collettivizzazione… Si dimostrarono poco socievoli. Disorientato, Mikhail Ivanovič cercò e ottenne la simpatia di un gobbo pallido, che aveva fabbricato sapone illegalmente. Il fantasma trasandato che percorreva lentamente il viale – quattro metri e ottanta da un capo all’altro – si fermò all’improvviso e disse ad alta voce: «Cittadini e compagni! Scusate se mi prendo la libertà. Non ne posso più. Chiedo il permesso di piangere. Hai capito, Anziano? Il permesso di piangere». La voce risoluta dell’Anziano venne dalla zona d’ombra, sotto il telaio luminoso della finestra. 16 «Piangi, vecchio mio, finché vuoi, finché puoi. Questo è il tuo unico diritto di cittadino. Vi proibisco di ridere, compagni. Prova soltanto a non fare rumore. Il regolamento è la legge suprema». Guardarono. Le partite di dadi e di dama s’interruppero. Dadi e pedoni di mollica di pane secco smisero istantaneamente di esistere. L’uomo (non era più un fantasma) aveva il viso terribilmente scavato, color muro, terra, amarezza, follia. Non ci sono parole per descrivere quel colore della faccia umana che nessuno ha mai dipinto. Irta di peli cinerei, quella faccia, e gli occhi come buchi, con un barlume nel fondo. L’uomo disse: «Sono accusato di spionaggio. E sono soltanto un povero diavolo, cittadini e compagni, ve lo giuro, un povero diavolo!». Le sue parole si contorcevano come singhiozzi, ma il suo viso rimaneva asciutto. Aveva il pomo d’Adamo sporgente, il collo magro, solcato da tendini. Dopo una pausa, l’Anziano rispose dal profondo del suo angolo. «Di cosa sei accusato, non ci riguarda. Dirò persino che non riguarda nemmeno te. Il potere sa quello che fa anche quando ci schiaffa in galera. Poveri diavoli, lo siamo tutti, ed è proprio la disgrazia più grande in questa faccenda…». La spia si guardava attorno con una sorta d’irritazione. Si passò sul viso, dall’alto in basso, le dita gracili e sporche. Asciutto, completamente. «E ora non riesco a piangere. Non ci riesco più, cittadini, scusatemi. Mi è passata. Vita da cani, purché finisca». 17 L’Anziano ribatté in tono sentenzioso: «La seduta permanente del Caos n. 16 continua. Passiamo all’ordine del giorno». *** Mikhail Ivanovič visse nel Caos sette settimane, piene di tanti piccoli episodi – i giorni passavano in fretta, sebbene le ore fossero lente e pesanti – ma vuote nella sua memoria. Lì gli uomini esistevano con un risalto particolare, la durata li schiacciava ma il tempo propriamente detto non esisteva. Mikhail Ivanovič ricevette un pacco della moglie: buon segno, non era consentito nei casi difficili. La decina di uova sode – che le guardie avevano brutalmente rotto e tagliato con un coltello sporco – gli dimostrò che Ganna non era stata licenziata il 15 dall’ufficio di Statistica. Ma il mercoledì seguente, aspettò invano, in ansia ogni volta che si udivano dei passi avvicinarsi alla porta. Tatarev, speculatore, un ruminante flaccido, la cui corpulenza piano piano si afflosciava, ricevette un po’ di leccornie che spartì: metà alla camerata, metà a lui. Mise la sua parte sulla coperta grigia e la contemplò. Le fettine di pane secco sembravano dorate, irradiavano luce. Tatarev le guardò fino a sera e le mangiò di notte, annusandole a lungo e producendo un fastidioso rumore di mandibole. Schifoso ruminante. Due uomini ebbero la dissenteria. Furono lasciati per parecchi giorni nel Caos che si riempì di fetore. La vita usciva da loro, a vista d’occhio, con scariche sanguinolente per tutto il giorno, tutta la notte. Erano un meccanico accusato di sabotaggio e un ex rivenditore accusato di frode. 18 L’Anziano spiegava due volte al giorno al sorvegliante del settore: «Ti dico che stanno crepando, compagno capo, e che è contro il regolamento per l’igiene». «Bene, bene», diceva il sorvegliante, «non creperanno mica stasera. Non c’è posto nel lazzaretto, aspettate fino a domani». Bisognava forse aspettare che la morte liberasse due letti nel lazzaretto per trasferirvi quei moribondi puzzolenti. Lassù, l’orchestra suonava dalle nove alle undici i suoi pezzi di bravura; le brune, le castane, le bionde, anche le rosse con le spalle coperte dagli scialli vistosi volteggiavano nelle braccia dei militari… Una camicia fu rubata a Zia Scoreggia, un giovanotto distinto, accusato di occultismo, al quale la natura aveva inflitto un posteriore un po’ sproporzionato. Una zia lo riforniva di vettovaglie: perciò il suo doppio soprannome. Rifiutò come un’indegnità la perquisizione generale proposta dall’Anziano, ma quel fatto suscitò lunghi dibattiti, una vera crisi di coscienza all’interno del Caos dove i ladri, che formavano una frazione organizzata sotto la presidenza di Malyš il Tappo, del mercato di Smolensk, decretarono che esigevano la restituzione dell’oggetto rubato durante la notte, in caso contrario si vantavano di scoprire il colpevole e di fargli passare la voglia di ricominciare. Al mattino Zia Scoreggia ritrovò, ai piedi del pagliericcio, la camicia a cui mancava un grande lembo di stoffa. Una cosa straordinaria, segreta, inverosimile, fu quando Malyš riportò dai cessi, dove tutti insieme andavano due volte al giorno a schierarsi sopra i buchi, mentre i compagni del secondo e terzo turno aspettavano in piedi da- 19 vanti a voi, quelli del secondo turno già con le mutande abbassate, perché i sorveglianti latravano all’ingresso: «Più in fretta, più in fretta, cittadini!» – una cosa straordinaria fu quando Malyš il Tappo riportò da lì mezzo litro d’acquavite per la frazione dei ladri. Quell’alcol prodigioso fu bevuto tra iniziati. In tal modo si manifestò un’aristocrazia nel Caos. Kostrov si commosse quando, all’una del mattino, un membro della frazione gli passò un fondo di bicchiere di quel tonico divino. Stava pensando senza un motivo alla morte di Svetlana*, ma quel goccio di alcol lo riscosse, fu sicuro che a quell’ora Svetlana dormiva tutta rosea, con il pugno chiuso sotto il mento e l’orsacchiotto di peluche coricato al suo fianco. I due trotzkisti dei primi giorni erano andati via, sostituiti da altri due, operai della fabbrica Amo, uno dei quali non capiva nulla delle idee. Arrivò anche un contabile socialdemocratico molto pulito che, inspiegabilmente, diventò unto e bisunto sin dal giorno dopo. Attaccò bottone con Kostrov a proposito della democrazia operaia. «Lei è in ritardo di dodici anni, egregio compagno». Mikhail Ivanovič fu sul punto di arrabbiarsi. «Noi non abbiamo niente, ma proprio niente in comune con il menscevismo. Tra la controrivoluzione kautskiana e noi…». Discussero parecchio, ostili tra loro, eppure amichevolmente. Il socialdemocratico sembrava ebreo, conosceva le regioni di Ufa, Semipalatinsk, Kansk, Šenkursk, poiché vi era stato deportato per sette anni. Sta* Distrazione dell’autore che qui – e in altri due brani del libro – attribuisce il nome di Svetlana alla figlia di Kostrov, chiamata in precedenza Tamaročka. [N.d.T] 20 volta si augurava di essere inviato in Kazakistan. In seguito, Mikhail Ivanovič non sarebbe più riuscito a ricordarne il viso: era infatti un viso comune e, in genere, parlavano sdraiati ai piedi di un tramezzo, nel buio. D’altra parte, Mikhail Ivanovič avrebbe riconosciuto tra mille l’interlocutore dal suo alito sgradevole e da un tic delle labbra che ogni tanto facevano ciaf ciaf. C’erano pochi casi gravi in quel Caos, diversamente dal Caos 18 dove più della metà dei prigionieri potevano aspettarsi di essere eliminati prima della fine del trimestre. Lì soltanto un impiegato postale (furto di pacchi) e un carrettiere (furto di due sacchi di granaglie) correvano il rischio dell’esplosione del cranio con una pallottola di Nagan, in virtù della legge del 7 agosto 1932 sul carattere sacro della proprietà collettiva. Il carrettiere lo diceva senza apparente emozione: «Sono recidivo, capisci? Mi hanno perdonato una volta, ma non credo che siano disposti a rifarlo…». Trascorreva il tempo sdraiato, con le mani dietro la nuca, osservava tutto e parlava poco; la sua vita interiore si riduceva, all’incirca una volta all’ora, a una sfilza di bestemmie mormorate tra sé: «Ah, cazzo, ah, gli stronzi, perdio!» (in realtà, erano molto peggio e in tono monotono). L’impiegato postale, giovane e biondo, membro della gioventù comunista, sembrava più rinfrancato. Malyš il Tappo, che intuiva certe cose alla prima occhiata, gli aveva detto davanti a tutti, nel viale: «Tu non sei un cattivo ragazzo, sei invece una canaglia fatta e finita. La solidità della tua zucca non mi dà pensiero, perché sei destinato a una carriera rispettabile nei campi di concentramento. Guarderai gli altri maneggiare il piccone, riempirai le tue piccole schede e farai par- 21 te della squadra d’assalto. Non negare, è sicuro, come è sicuro che hai denunciato i tuoi compagni. Non negare, fratello, tanto non insisto». Il giovane impiegato diventò paonazzo. Non si vedeva l’Anziano, ma la sua voce emergeva sempre al momento giusto da dietro una cortina di fumo acre. Liquidò l’incidente che stava per scoppiare. «Chiudi il becco, Malyš! Nessuno ha il diritto di mettere in dubbio l’assoluta onorabilità dei cittadini del Caos». L’Anziano incuriosiva Mikhail Ivanovič. Munito di qualche pezzo di carta igienica che la guardia gli dava due volte alla settimana, si piantava in mezzo al viale e proponeva: «Qualcuno desidera scrivere alle autorità proletarie?». Con i capelli lunghi e dritti, la folta barba nera a collare, la carne livida sotto gli occhi infossati, le spalle alte e quadrate, eretto sulle lunghe gambe divaricate, diceva quelle parole con un indefinibile accento di scherno. Un controrivoluzionario?, si chiedeva Mikhail Ivanovič. Un giorno, avendogli offerto la sua parte di minestra (aveva un po’ di febbre, quel giorno), lo interrogò: «E lei, Anziano, quale articolo del codice lo ha condotto qui?». Di solito se lo dicevano volentieri. Del resto, tranne se avevano voglia di confidarsi, non si dicevano niente di più e si trattava di un’indicazione molto vaga. L’Anziano gli fece uno strano occhiolino e rispose: «Non glielo dirò, vecchio mio. E forse neppure io lo so. Ci sono casi del genere, ce ne sono. Nel Caos, lo vede, la metà dei fratelli mente e l’altra metà non sa quello che dice perché né gli uni né gli altri sanno precisamen- 22 te cosa gli sta capitando. Devo però dirle che credo nel destino. Ognuno ha il suo destino, è poco ma sicuro, e c’è ancora per tutti un destino dove tutto figura in bilancio come si direbbe nella revisione dei calcoli della commissione del Piano. Solo che, lei sarà d’accordo, non si può vivere senza segreti. Ci vuole un mistero nel Caos. Ebbene, sono io! Nessuno sa cosa io sia. Non lo dirò mai. A nessuno. Nemmeno a loro…». La parola loro assunse proporzioni insolite nella sua bocca e nei suoi occhi. Abbracciò i quindici piani di cemento, i duecento uffici, i battaglioni speciali, il collegio segreto, tutto quello che non si sa di tale prodigiosa armatura, potente e complicata, nella quale gli uomini sono trascinati altrettanto inesorabilmente dei chicchi nel setaccio. «Possono tenermi qui fino al giudizio universale, compagno. Non gli dirò niente. Niente, capito? Vorrebbero sapere tutto, ah ah ah! E forse non sanno neppure quello che vogliono da me. E io sto zitto. Questo è il segreto. Forse non c’è niente. Forse c’è tutto». La parola tutto conteneva la minaccia, la confessione, lo sgomento, la notte, l’ironia – tutto. L’Anziano rideva. La sua bocca dalla dentatura gialla era sana, un’infima luce degli occhi brillava sotto le sopracciglia – molto lontano. Poi, serio, si chinò quasi all’orecchio di Mikhail Ivanovič: «Fai bene a scrivere biglietti a quelli là ogni tre giorni. Bisogna farlo». «Perché?», chiese Mikhail Ivanovič. «Perché hanno tante scatole. Contrassegnano i biglietti con un numero e li archiviano in scatole, e metto- 23 no le scatole in armadi, ci sono quindici piani di armadi, fratello. È importante». Mikhail Ivanovič pensò che l’Anziano si facesse beffe di lui; in ogni caso, non lasciava trasparire nulla. No, è pazzo, si disse Mikhail Ivanovič. Ma da quel momento lo rispettò di più. E continuò a scrivere biglietti ogni tre giorni: Al compagno giudice istruttore degli Affari politici, reclamo di… membro del Partito dal 1917. …Al compagno procuratore incaricato del controllo del Servizio politico… reclamo di… membro del Partito dal 1917. …Al compagno presidente del Collegio speciale del Servizio politico… reclamo di… …Al compagno presidente della Commissione Centrale di Controllo del Partito, recl… Erano piccoli rettangoli di carta igienica scritti con una matita all’anilina; testi indignati, umiliati, supplichevoli, precisi, infantili, nebulosi, contorti, falsi e veri. Siccome erano una ventina di cittadini del Caos a scriverli, l’Anziano ne consegnava tutto un fascio al capoguardia due volte alla settimana. *** Quando Mikhail Ivanovič fu improvvisamente tirato fuori da quel mondo sotterraneo, ricondotto alla superficie della terra, alla luce del sole della vita normale, si ritrovò in un piccolo ufficio abbastanza ordinato, adorno 24 di un ritratto del Capo appeso di fronte a una mappa di Mosca. La finestra si affacciava su tetti screziati dal sole, dove piccole guglie di un verde delizioso attiravano lo sguardo. Era rassicurante vedere la vita che continuava in modo così sereno. Residui di neve sporcata dal fumo finivano di sciogliersi sugli spioventi dei tetti esposti a nord. Una guardia immobile aspettava sulla soglia, il piccolo ufficio era vuoto. Avendo girato la testa, Mikhail Ivanovič si riconobbe – male, con un sussulto spiacevole – nel vetro di un armadio pieno di fascicoli. La sua immagine scarna vi vacillava su uno sfondo di scartoffie. Era dimagrito, invecchiato, impallidito. Il naso gli parve più duro, ma come svuotato: una strana inconsistenza si esprimeva in quel viso di vagabondo con la barba arruffata. Mikhail Ivanovič riconobbe in se stesso l’abitante del Caos. Cittadino del Caos, si disse con amara ironia, perché aveva appena pensato: diavolo, un regime simile fa presto a distruggerti l’organismo. «Buongiorno, Mikhail Ivanovič!», disse alle sue spalle una voce cordiale. Il giudice istruttore, un bel militare sulla trentina, con la sigaretta in bocca, lo scrutava come una vecchia conoscenza. «Si segga. Sigaretta?». Il colloquio fu privo di senso. In definitiva, nulla veniva rimproverato a Mikhail Ivanovič. Solamente, ecco: era opportuno che sondasse lui stesso la sua coscienza. Poi si sarebbero spiegati tra compagni. Nessuno dubitava della sua lealtà: proprio a essa, anzi, si faceva appello in tale circostanza. I due uomini seduti l’uno di fronte all’altro, intenti a fumare, sembravano impegnati in un gioco complicato con frasi a doppio senso che univano 25 la minaccia velata all’esortazione allettante; il tono passava dal paterno all’ufficiale. «Insomma, sarà come lei vorrà!», disse infine il giudice istruttore. «Mi scusi, ma ho poco tempo…». In quel momento Mikhail Ivanovič proruppe: «Però, no! Cos’è questo brutto scherzo? Mi prende in giro? Voglio sapere di che si tratta, capito? E voglio che lei sappia in quali condizioni mi tengono. Che ci siano prigioni simili nel quindicesimo anno della rivoluzione, è uno scandalo orrendo. Dubito che le prigioni fasciste…». «Oh, oh», fece lentamente il giudice istruttore, «ecco un paragone infelice, che puzza di controrivoluzionario lontano un miglio…». Mikhail Ivanovič arrossì. Del resto, quello scatto di collera lo aveva stancato. I battiti del cuore gli riempivano il petto con un rumore opprimente. Volle prendere una sigaretta, ma le dita tremanti trovarono solo il vuoto, sotto un foglio di carta velina, nel pacchetto del giudice. «Si calmi», disse tranquillamente quest’ultimo. «Non sapevo che lei fosse alloggiato così male. E comunque un militante informato come lei dovrebbe capire che siamo sopraffatti dal lavoro. Io trascorro le notti a lavorare, egregio compagno, e non ho nemmeno un giorno di riposo. Se le carceri sono affollate, la colpa non è della dittatura del proletariato, ma della controrivoluzione che ci assale da tutte le parti. Mi scusi se le ricordo queste verità essenziali. Beva un bicchiere d’acqua. La farò mettere in una cella singola, dove starà molto bene. Arrivederci, Mikhail Ivanovič. E rifletta, Mikhail Ivanovič». Spingeva con calma e gentilezza il prigioniero per le spalle. Nel lungo corridoio oscuro che Mikhail 26 Ivanovič seguì, precedendo la guardia, tutte le porte numerate erano chiuse. A un tratto, una si aprì e una giovane donna bionda dai capelli scarmigliati, dai grandi occhi cerchiati, uscì con tale impeto che quasi urtò il passante. «Non così in fretta, cittadina», disse da qualche parte una voce maschile, autoritaria e cupa. Era già il passato, mai più sarebbero ricomparsi quei grandi occhi cerchiati, quei biondi capelli scarmigliati. Mikhail Ivanovič imprecava tra sé: ah, perdio, è davvero il Caos, e quella carogna, quella carogna, con le sue sigarette, la sua faccia da ipocrita… …Ascensore. Di nuovo, due uomini di fronte che si sfioravano: l’uno grosso, ben piantato, impettito nella giubba dell’uniforme. L’altro barcollante, tormentato da un prurito sotto l’ascella, in preda a una rabbia nauseabonda. «Entri, cittadino» (educatamente). Mikhail Ivanovič udì richiudersi la porta della cella. L’uomo dell’ascensore non aveva avuto un viso: un ovale anonimo al posto del viso, un ovale… Mikhail Ivanovič si aspettava il Caos e all’improvviso c’era il silenzio, l’ordine, una luce soffusa, la solitudine. Girò su se stesso: la porta. Ancora: la finestra. Sbarre. Lastra di ferro, all’esterno. La brandina. Si sedette. Inspiegabile: una brusca tristezza da far piangere. Tutti quei compagni degli attimi passati – scomparsi per sempre. E quella solitudine, quel colloquio a tu per tu con l’altro se stesso, che non gli somigliava più, irsuto e sporco, sconvolto dalla rabbia, essendo ormai compromessa la sua fredda ragione. Con la testa tra le mani, chiuse gli occhi, curvò la schiena. Ho sbagliato a lamentarmi del Caos, ah! Ma forse sarebbe stata la stessa cosa se non si fosse lamen- 27 tato. Ah, il silenzio opprimeva! Avrei dovuto chiedere qualche libro… Il tavolo era vuoto. Che strano sradicamento! La voce grave e beffarda dell’Anziano, gli ammiccamenti di Malyš il Tappo, le guance sciupate di Tatarev, l’odore di bestie umane e di tabacco forte del Caos… La nostalgia lo afferrò alla gola. Separato – per sempre – da quella miseria, solo qui, solo, solo, solo, solo, solo… La prima notte fu pesante, nonostante il piacere della biancheria pulita e delle lenzuola. Ganna, Svetlana – cosa facevano in quel momento? Stava per addormentarsi, quando un viso si avvicinò al suo. Biondi capelli scarmigliati attorno alla fronte, uno sguardo senza fondo di occhi azzurri, incavati, la bocca nera – la bocca nera mormorava: «Mi torturano, capisce? Non posso rispondere a tutte le loro domande, alle loro domande per tutta la notte, sempre le stesse, sempre diverse. Impazzisco, mi capisce? Allora» (la voce diventò supplichevole con l’inflessione di Ganna) «mi aiuti, dunque, Mikhail Ivanovič…». E di colpo gli occhi non furono più azzurri, ma scuri, circondati dalla sottile montatura di tartaruga, ed era Ganna. Ganna torturata. «Miša», diceva, «Miša, facciamola finita. Non resisto, non ne posso proprio più. Miša, abbi pietà di noi…». Emerse da quell’incubo, con la fronte sudata. Si vide sdraiato nella luce della lampadina elettrica, nel silenzio notturno, nella solitudine, fuori dal tempo. E i giorni e le notti trascorsero nel vuoto, placidamente. *** 28 Tutto iniziò con un dolore astruso nella regione del cuore. Ma era proprio la regione del cuore? Non sappiamo esattamente né dove sia né cosa sia il nostro cuore. Il pensiero deviò subito dalla sua divagazione normale e, facendo strani giri, si diresse verso un focolaio d’inquietudine. Il dolore persisteva, come se provasse gusto a trovarsi lì, in quel petto caldo. Mikhail Ivanovič si ricordò di una mano posata a quell’altezza sulla sua carne e che v’indugiava, una mano rinfrescante. Ganna mormorava: «Mi piace sentire i battiti del tuo cuore… Eppure è terribile sentire i battiti di un cuore. Certe volte ho paura del mio, di notte…». Quelle parole e quel gesto non gli erano mai tornati in mente prima; adesso suscitarono una smorfia, forse quella di un sorriso disorientato, sulla faccia imperlata di sudore. Il dolore si allargava, scavando, frugando dentro di lui nell’area del cuore, area-del-cuore… Sentì che il naso si assottigliava, che la pelle sulle tempie era simile a un foglio di pergamena e che il sudore, freddo e insieme ardente – oppure né freddo né ardente, peggio, un sudore di angoscia – gli inumidiva il viso. Devi controllarti, è solo un attacco cardiaco – e se fosse qualcosa di peggio, devi controllarti lo stesso, controllati. Quando se ne stava coricato, era solito contemplare sul soffitto della cella le linee e le ombre che si vedevano nell’intonaco bianco. La sua fantasia vi scopriva forme, troppo immobili, ma che lui cambiava a suo piacimento. Tentò di ritrovarle: una maschera giapponese, una vaga testa di Puškin, un busto femminile senza braccia, una vela… Il sudore e il dolore furono più forti di quel gioco risibile. La sua mente era ormai ridotta a un lumicino rinta- 29 nato in qualche angolo, sotto il cranio, che rischiarava il tetro sfacelo interiore. Nella sua carne si aggirava il dolore, chiuse gli occhi, li riaprì – non c’era un limite, non c’era… Sudore, sudore di morte. Sul soffitto, la lampadina elettrica. E il dolore svanì, così come era venuto. Mikhail Ivanovič Kostrov, professore incaricato di Stor-Mat – materialismo storico – all’università comunista intitolata a Sverdlov, si alzò dal suo giaciglio di prigioniero, in mutande e camicia, corse alla porta a piedi nudi sull’assito freddo, bussò adagio allo spioncino, ascoltò il silenzio tranquillamente illuminato della cella. Passi felpati scivolarono nel corridoio, ci fu uno schiocco di dita, un colloquio sottovoce. La realtà tornava in blocco, di colpo. Una della porte vicine si aprì e si richiuse. To’, ancora lo interrogano. Ogni notte, da cinque giorni, to’… La porta si aprì all’improvviso e Mikhail Ivanovič indietreggiò davanti a una guardia alta e larga di spalle – cinturoni, corregge – che entrava, veniva verso di lui, guardando ogni cosa – il letto disfatto, il bugliolo, il tavolo pulito, un tozzo di pane, tutto, e anche l’uomo, il prigioniero: le sue mutande di dubbio aspetto, la sua camicia aperta sul petto villoso, i suoi piedi nudi, bruni come quelli degli zingari e coperti anch’essi di peli. «Che succede, cittadino?». Non succedeva niente. Più niente. Che io sia stato sul punto di morire, non ha in fondo nessuna importanza per te, cittadino, per questi muri, per loro. Mikhail Ivanovič lo percepì meglio di quanto lo pensasse, con un po’ di pietà per se stesso, mista a un’ira improvvisa contro di loro. Aggrottò le sopracciglia, le narici si gonfiaro- 30 no come quando diventava cattivo e, con cattiveria, disse educatamente (non era mai così educato come nei momenti in cui la cattiveria gli faceva fremere le narici, cosa che si notava benissimo): «Niente. Ho pensato di star male. Mi scusi, stimato compagno, per il disturbo». La guardia lo scrutava con occhi umani: scuri, sagaci, privi di bontà – ah, occhi che facevano mirabilmente il loro mestiere: «Sì… Lei è in un bagno di sudore. Può capitare. Torni a letto. Domani le manderò il medico». Può capitare? Cosa può capitare? Mikhail Ivanovič si rimise a letto, si coprì. «Non si dia troppo disturbo», disse sorridendo, «è inutile. Manderò via il suo medico, caro compagno». Si girò verso il muro in modo brusco. Gli occhi sagaci l’osservarono per un secondo, attentamente. Il catenaccio fu tirato, ritornò il silenzio, la luce notturna, la ruvidezza del muro grigio, il fievole benessere del corpo rilassato dopo la crisi, l’approssimarsi del sonno, gli ultimi pensieri prima del sonno, quasi sempre i medesimi: quelli voluti, quelli non voluti. …Non si finisce mai di vivere e ogni giorno ha la stessa vana, vana, vana pena… Il cuore pulsava con regolarità. *** 31
Scaricare