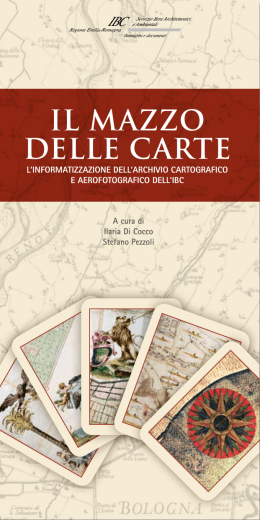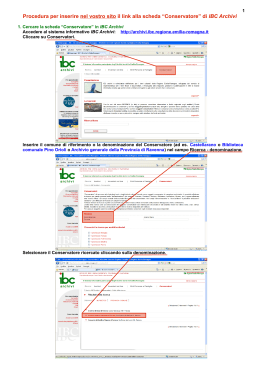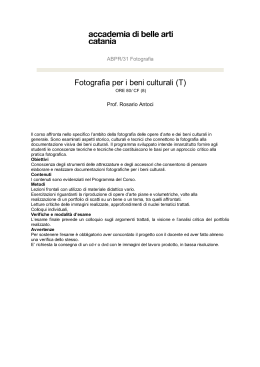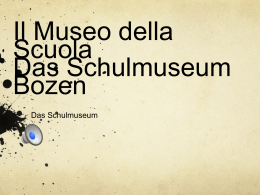INFORMAZIONI INFORMAZIONICOMMENTI COMMENTIINCHIESTE INCHIESTESUI SUIBENI BENICULTURALI CULTURALI IBC 2013 INFORM AZIO NI CO M M E NT I INCHIE ST E SUI B E NI CULT URAL I IBC INFORMAZIONI, COMMENTI, INCHIESTE SUI BENI CULTURALI annata XXI, anno 2013, numero unico registrazione del Tribunale di Bologna, n. 4677 del 31 ottobre 1978 ISSN 1125-9876 direttore responsabile Angelo Varni Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna direttore scientifico Ezio Raimondi presidente onorario Ezio Raimondi capiredattori Valeria Cicala, Vittorio Ferorelli presidente Angelo Varni redattori Rosaria Campioni, Laura Carlini, Isabella Fabbri, Maria Pia Guermandi, Piero Orlandi, Orlando Piraccini, Carlo Tovoli direttore Alessandro Zucchini sede di redazione Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna via Galliera 21 - 40121 Bologna tel.: (+39) 051.527.6610 [email protected] www.ibc.regione.emilia-romagna.it/rivista.htm realizzazione editoriale Bononia University Press via Farini 37 - 40124 Bologna tel.: (+39) 051.232.882 [email protected] www.buponline.com progetto grafico e impaginazione Alessio Bonizzato stampa Tipografia Moderna – Bologna consiglio direttivo Giordano Conti, Giovanni De Marchi, Laura Muti, Siriana Suprani © Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna. Tutti i diritti riservati Non tutti gli articoli pubblicati rispecchiano necessariamente gli orientamenti degli organi dell’Istituto: tutti, comunque, sono ritenuti validi sul piano dell’informazione e utili al dibattito sulla gestione e la valorizzazione dei beni culturali. Sommario Editoriale 5 Continuare, cambiando Angelo Varni Biblioteche e archivi 7 Vite in festa Paola Sobrero 12 Un Garamond bolognese per Einaudi Elisa Rebellato 16 Teatro in archivio Pierluigi Tedeschi, Lella Vinsani 21 Una città per gli archivi Alessandro Alfier 26 Fatti da donne Claudia Giuliani 29 Accedere per ricordare Elisabetta Arioti, Gabriele Bezzi 34 Una cattiva educazione Gianluca Gabrielli 39 Cultura popolare Fotografie di Marco Pesaresi Musei e beni culturali 55 Siamo tutti ospiti Valeria Cicala 59 Al prossimo incontro Sara Maccioni 64 Musica per ricostruire Lidia Bortolotti 68 Frammenti di moda Marta Cuoghi Costantini 72 Le Muse si divertono Laura Carlini, Giulia Pretto 76 “VersoVerdi”: i musei e i percorsi da esplorare Isabella Fabbri, Micaela Guarino 80 Toni e Za, insieme a Riccione Orlando Piraccini 84 Allestire l’invisibile Maria Gregorio 89 100 case popolari Fotografie di Fabio Mantovani 115 Confotografia Fotografie di Iolanda Di Bonaventura, Evelina Favaro, Sara Sagui, Giorgio Serri Territorio e beni architettonici-ambientali 137 Cento case e un affresco Sara Marini 141 Riciclare la città Renato Bocchi, Fabrizia Ippolito 150 Strutture di regime Claudia Castellucci 156 Confotografia Alessandra Chemollo 161 Questo è un MAST! Piero Orlandi 166 Storie di case, in prospettiva Federico Zanfi 173 Al bordo della strada Fotografie di Matteo Sauli Storie e personaggi 191 Il mestiere di scrivere Ezio Mauro 195 Silenzio in campo Vittorio Ferorelli 200 Spazio ai Migliori Valeria Cicala 204 Agire, raccontare, resistere, testimoniare: il ruolo del teatro Micaela Casalboni Editoriale Continuare, cambiando Angelo Varni L’annale con cui l’Istituto per i beni culturali si presenta ai lettori della sua tradizionale rivista offre uno spazio di riflessione sui temi che più hanno caratterizzato l’attività svolta nell’anno trascorso, ma nel contempo mira a misurarsi con la complessa problematica del rapporto tra la scrittura affidata al supporto di sempre, la carta, e quella mediata dagli strumenti on line. Già, perché – e il lettore più attento lo avrà ben notato – la consueta pubblicazione trimestrale si è interrotta ed è stata sostituita da una proposta, a mio parere non meno ricca di suggestioni e di analisi, “lanciata” negli spazi illimitati dell’informatica. Una scelta sofferta, per la necessaria rottura di una tradizione di successo, ma pure rivolta con qualche coraggio a trovare un punto di passaggio, o forse di ancoraggio, tra passato e innovazione. Certo non sono mancate, in tale iniziativa, le ragioni di natura economica, che in un periodo come questo non possono non avere un peso per chi opera con denaro pubblico e deve restare in saggio equilibrio tra valore della proposta culturale e stretta dei bilanci. Sono però convinto che il passaggio effettuato fosse comunque indispensabile, di là da ogni considerazione contingente, e in particolare proprio per un’istituzione che fa della valorizzazione del mondo culturale la propria ragion d’essere. Appunto per capire dove sta andando la “cultura” in un mondo che avanza a ritmi incalzanti e che trasforma incessantemente tutto quanto ci circonda e prima di tutto noi stessi. Per capire in che modo trasmettere i contenuti di sempre con un’efficacia che forse deve affrontare le necessità di nuovi linguaggi e di nuove metodologie. Per capire quali nuove forme di dialogo con il pubblico stiano affiorando, diverse da quelle con cui ci siamo formati. È un piccolo passo il nostro. Altri certo ne seguiranno, per meglio riuscire a calare le nostre valutazioni e le nostre interpretazioni dei “beni culturali” nel magma indistinto di una comunicazione sempre più affollata e convulsa. Forse con la necessità di ben più profonde meditazioni sulle modalità stesse di presentazione delle nostre proposte di lettura della società. Ma intanto ci collochiamo in questo ambito intermedio, dove cartaceo ed elettronico si rimandano l’uno all’altro, nell’ambizione di accrescere il valore e la forza divulgativa di entrambi. Un tentativo per il quale ringrazio tutti i collaboratori dell’Istituto che con grande generosità l’hanno reso possibile. B iblioteche e archivi Tra le fotografie di Marco Pesaresi conservate a Savignano sul Rubicone emerge un percorso dedicato alla cultura popolare delle feste sacre e profane nel territorio di Rimini. Vite in festa Paola Sobrero Marco Pesaresi era nato a Rimini nel 1964, dove è mancato in circostanze tragiche nel dicembre 2001, dopo aver attraversato il mondo. La sua carriera di fotografo professionista, a seguito della frequentazione a Milano dell’Istituto europeo di design, era iniziata nel 1990 con l’ingresso nell’agenzia Contrasto, dove si è occupato di aspetti sociali difficili e complessi, come l’emarginazione, la droga, l’emigrazione, la prostituzione.1 Lo conoscevamo e lo vedevamo, fra un viaggio e l’altro, fra una pausa e l’altra del suo lavoro, nella cerchia di quei fotografi con cui si era dato vita, a Savignano sul Rubicone, al progetto di “Portfolio in Piazza”, che si sarebbe poi evoluto in quello di “Savignano Immagini” e del festival di fotografia. Dal 2002, dodicesima edizione del festival, il premio - borsa di studio “Marco Pesaresi”, promosso dal Comune di Savignano sul Rubicone, dall’agenzia Contrasto e dai familiari a pochi mesi dalla scomparsa, è stato un modo di continuare a farlo vivere attraverso i progetti di giovani fotoreporter: ai book annualmente selezionati da una giuria specializzata viene attribuita una somma di 5000 euro con l’intento di proseguire e sviluppare un progetto di reportage. Quindici i premi conferiti in undici edizioni, a cui hanno concorso e che si sono aggiudicati – per fare qualche nome senza far torto ad alcuno – autori di spessore internazionale come Alex Majoli e Paolo Pellegrin, oggi rispettivamente presidente e membro di Magnum, esclusiva e autorevole agenzia fotografica a livello mondiale.2 Marco continua a vivere nell’iniziativa inesausta della mamma Isa, dell’agenzia Contrasto che detiene i numerosi reportage realizzati in varie parti del mondo, nell’attività di “Savignano Immagini”, che nel proprio archivio di fotografia d’autore conserva oltre settantamila suoi documenti tra negativi, diapositive, provini, stampe. Ci ha lasciato un grande patrimonio di immagini in cui si riflette quasi tutta la sua vita, e poco altro di sé, se non poesie, annotazioni e brani di racconti di viaggio contenuti in un paio di agende. “Più soffro e più mi affanno nella ricerca della poesia, più sento che dentro di me vivo situazioni difficili, più il mio sguardo si addolcisce e più cerca la serenità e l’armonia dell’immagine. E qualche volta la trova”. Che cosa unisce l’insaziabile e dolorosa 8 Biblioteche e archivi ricerca del viandante della fotografia ai ritorni malinconici alla sua terra, alla sua città, al suo mare, in un percorso parallelo, intimo e riservato, schivo e complice al tempo stesso, di situazioni colte e restituite con un significato sempre profondo e partecipato? La sua fotografia racconta circostanze estreme da un capo all’altro del mondo, fra gente e genti diverse, il cui esito esemplare è raccolto nel libro che lo ha consacrato alla fama internazionale: Underground è un reportage realizzato nelle metropolitane di dieci delle più grandi città del mondo, pubblicato in America da Aperture e in Italia da Contrasto nel 1998.3 Un viaggio durato due anni di infinite ore vissute nel sottosuolo, a contatto con una umanità fatta per molta parte di emarginati, di reietti, di disperati, di deformi, di gente perduta e senza speranza, attraverso la quale Marco dava “forma ai suoi demoni, andandogli incontro e guardandoli in faccia” (Renata Ferri). Immagini rapide, colori forti, ritmo vorticoso e straordinariamente moderno per raccontare dieci storie del sottosuolo che gli avevano procurato la celebrità e insinuato una sofferenza interiore tremenda, perdurante e irreversibile, non solo per ciò che aveva visto e subìto fisicamente, ma perché in qualche modo tutto il peso di quella umanità dolente gli era entrato dentro per non lasciarlo più. Dopo Underground “tutto sembrava niente”, come se quel viaggio gli avesse contato come mille vite. E invece il viaggio era continuato, alla ricerca di storie e avventure nuove. Come Transiberiana, o come il grande reportage fra Stati Uniti, Giappone e Russia sui Megastore che si ergevano come giganti nei paesi trainanti così come in quelli emergenti. Era penetrato nel tessuto sociale lacerato e contraddittorio della Berlino del dopo Muro, delle case occupate e della creatività artistica giovanile, negli anfratti di colossi decadenti come la Roma di Cinecittà. Era andato e ritornato più volte a catturare realtà e dimensioni sfuggenti che lo affascinavano, da Londra a New York, da Calcutta ad Amsterdam, seguendo anche percorsi marginali e inusuali come il tragitto del Po, i parchi acquatici, le Cinque Terre, o indagando macro e microcosmi come i raduni alpini, la solitudine degli anziani, il piccolo borgo di Cetona. Tutti percorsi intrapresi e incompiuti, uno dei più affascinanti e intriganti quello sul mondo notturno riminese. Marco “non era un fotografo adatto ai lavori su commissione” (Roberto Koch) e, malgrado l’universo che gli si era aperto con Underground, aveva bisogno di seguire un istinto naturale, di assecondare motivazioni intrinseche e profonde. Ho visto per la prima volta le immagini di Rimini nel 1998, o più probabilmente nel 1999, durante una delle migliori stagioni della fotografia a Savignano, quando Marco Pesaresi era venuto a sottoporre il suo book ancora in progress a Mario Cresci, allora nostro compagno di viaggio nel percorso di “Savignano Immagini” e direttore artistico di “Portfolio in Piazza”. Non entravo nel merito di valutazioni, anche se di progetti e di portfolio mi ero abituata a vederne tanti, e mentre Marco sfogliava le sue stampe in bianco e nero rigorose e perfette in un gruppo silenzioso e raccolto sono rimasta folgorata da quelle immagini. Immagini che nel 2003 sarebbero diventate il suo secondo e ultimo libro cult, edito da Contrasto un anno e mezzo dopo la sua morte.4 Ero rimasta folgorata perché nelle sequenze di Rimini gli aspri e complicati aspetti della marginalità, della droga, della prostituzione, della pornografia affioravano delicatamente, non con la drammaticità di altri reportage realizzati nelle tante circostanze estreme con cui si era confrontato e che aveva frequentato. C’era il mondo globale IBC 2013 della vita notturna giovanile, dei locali e delle discoteche, colti nel periodo della consacrazione di Rimini a capitale di una “movida” ante litteram, all’avanguardia di mode tanto audaci quanto anticipatrici e trasgressive. Una stagione di Rimini caput mundi che conviveva con la periferia e gli echi folkloristici delle balere ruspanti, del ballo di coppia, degli ultimi ruggiti del machismo e del gallismo, esautorati dalla ricorrente ostentazione del corpo femminile. Nulla di pornografico in quelle sfilate di fondoschiena emergenti da torsi insaccati, di seni pesanti di anonime incappucciate, nell’esibizione di membri virili, di prostitute, di gay e di trans che popolavano strade, feste e locali. Quelli che trasparivano erano ritratti di malinconia e solitudine interiore, di riti collettivi lontani da valori condivisi e comunitari eppure carichi di una valenza estrema e iniziatica. A Renata Ferri, sua collega nell’agenzia Contrasto, Marco era sembrato il fotografo giusto per un lavoro sul porno allora dilagante, nei siti e nel business. Lui ci aveva provato con una missione a Budapest e aveva dovuto rinunciare, disgustato dalla dissolutezza di potere e di denaro che alimentava quel mondo. Non c’è pornografia nelle sue immagini di una Rimini pur dissoluta e perversa; c’è piuttosto l’anima nera, notturna, oscura di una città suo malgrado metropolitana, in cui universi licenziosi e appariscenti convivono con le atmosfere pacate del mare d’inverno, di luminose feste di borgata, di una linea di costa che non ha ancora tagliato il cordone ombelicale con il territorio rurale che ne ha alimentato lo sviluppo, di un entroterra gravitante sull’universo balneare ma ancora legato a una fisionomia contadina. Il volto di quella Rimini che era la sua città e che aveva ritratto e interpretato, quella Rimini dell’ostentazione, della trasgressione, dell’esclusività e del sorprendente a tutti i costi, gli apparteneva di meno. “La mia fotografia nasce da tradizioni contadine e si accompagna alla poesia del mare d’inverno. Io amo questa terra, la amo con tutto il cuore, mi piace questa terra perché muta in continuazione, nulla è mai uguale all’anno precedente, tutto è in evoluzione continua. I miei occhi, la mia persona sono eccitati dalla sinuosità, dalla dolcezza e dal vissuto: nell’istantanea ci sono queste condizioni, ci sono questi attimi che convergono e tu li fermi”. C’è un altro grande progetto incompiuto di Marco, un progetto che, a differenza di altri, avrebbe voluto realizzare; lo chiamava “cultura popolare”. Non ne aveva parlato con nessuno, non ha lasciato un appunto, una traccia, ma su molte custodie delle strisce di negativi compare questa dicitura. Sono migliaia di negativi che ritraggono un paesaggio romagnolo variegato, trapuntato e scandito da avvicendamenti stagionali, calendari festivi, ritmi pacati e lenti, dove riti e comportamenti antichi (l’uccisione del maiale, il barco eretto a fine trebbiatura) si affiancano a consuetudini e appuntamenti collettivi di una tradizione più recente (feste dell’Unità, ballo liscio, fiere e sagre popolari) e dove il mare rappresenta uno scenario e un riferimento costante, anche per quegli aspetti tradizionali, poi banalizzati dalla propensione turistica, più connotati in alcune realtà dell’entroterra. È il caso della “cuccagna” di Cesenatico, che si svolge in estate lungo il portocanale, sullo sfondo del Museo della marineria all’aperto; è il caso dei falò di San Giuseppe, gli antichi lom a merz che si accendevano nelle campagne in coincidenza con il passaggio stagionale, 9 10 Biblioteche e archivi arcaici segnali di comunicazione nelle campagne che più di recente si sono trasferiti a illuminare il litorale costiero. Accanto a queste, le feste recenti, reinventate o inventate. Come “Gradisca”, la lunga tavolata che univa in un’unica spiaggia il litorale della costa romagnola, con le “rustide” di pesce sul porto. O le feste di borghi marinari come la “Borgata che danza”, dedicata alla musica popolare, che da oltre vent’anni ha luogo a Bellaria, durante la quale gruppi di suonatori provenienti da varie parti d’Italia si incontrano e si avvicendano nelle strade e nelle osterie del vecchio borgo marinaro. O come la “Festa de Borg”, che si svolge da quasi vent’anni nel borgo più antico, popolare e marinaro per eccellenza di Rimini, San Giuliano. Se considerato nella sua qualità di progetto in nuce, il repertorio variegato e apparentemente occasionale di questi reportage e di queste sequenze fotografiche risulta invece coerente con una tradizione popolare romagnola attraversata più di altre da innovazioni e mutamenti. Un repertorio in cui, non a caso, spiccano alcuni eventi rituali che, se non tipicamente romagnoli, sono da tempo connotati come tali dalle comunità locali e che sussistono tuttora, in una dimensione comunitaria, celebrativa e ideale profondamente cambiata. Rito di interpretazione complessa, il Carnevale di Cerreto di Saludecio, nella Valconca, è stato scoperto e studiato a cavallo degli anni Settanta e Ottanta, e si presenta ricco di riferimenti arcaici nonostante il periodo di interruzione nel secondo dopoguerra. Elementi e personaggi identificanti di questo carnevale sono le buffonate, le storie, la Vecchia, i Nirèt, il Pagliaccio, l’Uomo coperto di foglie. La Pasquella è un rituale che si svolge nel periodo dell’Epifania in molte località dell’Italia settentrionale e centrale. Molto diffuso in Romagna, consiste in un canto di questua in cui i pasquaroli si recano di casa in casa a portare l’augurio di buon anno, ricevendo in cambio offerte di beni alimentari. I “pasquaroli” sono accompagnati e preceduti dalla coppia mascherata del Vecchio e della Vecchia, tipiche figure carnevalesche. La processione del Venerdì santo a Montefiore Conca, piccolo borgo di confine tra Romagna e Marche, è una sacra rappresentazione di tradizione secolare. Intimamente legata alla comunità locale, rappresenta quasi un’anomalia in una Romagna, più che antireligiosa, anticattolica, e, se ha certo qualcosa da invidiare ad analoghe rappresentazioni del Sud-Italia, conserva come un gioiello una liturgia che ha mantenuto molti elementi della tradizione pur mutando ruoli e significati sociali originari. Della Pasquella, del Carnevale di Cerreto e del Venerdì santo di Montefiore Conca si sono occupati ricercatori e antropologi locali, ne esistono documentazioni orali, musicali, filmate e visive realizzate anche da fotografi professionisti, in una stagione in cui la fenomenologia popolare destava un interesse e un fermento che ora sono un labile ricordo anche per chi li ha vissuti.5 Di questa fervida stagione ci rimangono molte testimonianze, di documentazione e d’autore, e non pochi grandi fotografi hanno ritratto espressioni di ritualità popolare pur se in margine alla loro attività prevalente. Impossibile che Marco ignorasse le splendide immagini di Ferdinando Scianna, che proprio alla sua interpretazione delle IBC 2013 feste siciliane deve il suo ingresso quale primo italiano nell’agenzia Magnum; improbabile che non conoscesse le immagini realizzate rispettivamente per la Campania, la Puglia e la Basilicata da Franco Pinna, Ando Gilardi, Mimmo Jodice, Mario Cresci; forse è meno facile che avesse visto quelle di Marialba Russo, di Francesco Faeta, di Lello Mazzacane, di Annabella Rossi. Dubito che Marco Pesaresi avesse conoscenze di antropologia e delle dinamiche delle espressioni di ritualità popolare che fotografava, così come accade per la ridda di fotografi di strada o della domenica che da sempre le hanno prese d’assalto. Marco però era un professionista di genio e di talento, appassionato della sua terra, che senza saperlo e senza volerlo aveva lo sguardo dell’antropologo. Non sappiamo che cosa volesse fare, quale fosse la sua idea di cultura popolare, quale fosse la percezione di quella Romagna che aveva nel cuore; può darsi che intravedesse in questa scelta una alternativa al suo disagio o anche un ulteriore modo di essere sempre dalla parte della marginalità, dell’esclusione, in ogni caso dalla parte di un mondo non emergente e non protagonista. Da queste foto ci separano ormai vent’anni, vent’anni che sembrano una voragine e una distanza enormi. Forse vale la pena di ripensarci. Note (1) Fotografie e reportage di Marco Pesaresi sono apparsi più volte su testate internazionali come “L’Espresso”, “Panorama”, “Geo”, “Sette”, “El Pais”, “The Observer”, “The Indipendent”. (2) Le mostre relative al premio - borsa di studio “Marco Pesaresi” sono documentate, dal 2006, nei cataloghi annuali editi in occasione di “Portfolio in Piazza - Festivalfoto” e di “SI FEST - Savignano Immagini Festival”. In occasione del decimo anniversario della scomparsa del fotografo e dell’istituzione del premio, il “SI FEST” ha presentato il volume: M. Pesaresi, Qui e altrove, presentazione di R. Koch, Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena) - Verucchio (Rimini), Savignano Immagini - Pazzini Editore, 2011. (3) M. Pesaresi, Underground. Un viaggio metropolitano, introduzione di F.F. Coppola, Roma, Contrasto, 1998. (4) M. Pesaresi, Rimini, Roma, Contrasto, 2003. (5) Per approfondire si segnalano, tra gli altri contributi: M. Carli, Siamo qua da voi signori. La pasquella nel territorio cervese, contributi di E. Baldini e A. Sistri, Ravenna, Longo, 1996; G. Zaffagnini, Siamo qua con canti e suoni. I rituali dell’Epifania e di Calendimaggio in Romagna, introduzione di C. Ghirardini, Ravenna, Longo, 2010; A. Sistri, Strutture di festa, carnevale e cultura carnevalesca a Cerreto di Saludecio, “Romagna arte e storia”, IV, 1984, 10, pp. 75-94; G. Granaroli, Processioni e sacre rappresentazioni, San Marino, AIEP, 2002 (“Archivio della memoria”, 3); La processione del Venerdì santo a Montefiore Conca, Rimini, Raffaelli, 2009. [“IBC”, XXI, 1, gennaio/marzo 2013] 11 Nel secondo centenario bodoniano ripercorriamo una singolare vicenda tipografica del Novecento. Protagonisti: un grande editore italiano e un’agguerrita ditta bolognese. Un Garamond bolognese per Einaudi Elisa Rebellato Quest’anno ricorre il secondo centenario della morte di Giambattista Bodoni, un uomo che, nella Parma ducale prima e francese poi, seppe rinnovare la grafica del libro a stampa italiano, tanto nelle proporzioni della pagina, quanto nell’elaborazione di nuovi caratteri tipografici.1 È quindi interessante ripercorrere, ora, una vicenda novecentesca legata alla produzione di caratteri da stampa, vicenda che collega una ditta bolognese al grande editore torinese Giulio Einaudi, di cui nel 2012 si è ricordato il centenario della nascita. Nell’editoria italiana del Novecento le più importanti case editrici hanno posto molta attenzione alla cura grafica delle copertine, mentre un minore impegno è stato dedicato allo studio dell’impatto visivo offerto dal testo, composto di caratteri tipografici; eppure, l’approccio al libro da parte del lettore e la lettura stessa del volume sono condizionati da entrambi questi elementi grafici, che possono allo stesso modo attrarre o respingere chi posa lo sguardo sull’esterno o all’interno del libro. Alla disciplina della progettazione dei caratteri tipografici è evidentemente mancato, nel secondo dopoguerra, il sostegno di una committenza industriale ed editoriale disposta a credere nel valore del progetto globale del prodotto, che lo considerasse nelle varie componenti, materiali e contenutistiche. Una delle poche eccezioni è costituita dalle scelte editoriali di Giulio Einaudi. Prima di lui, tra i grandi editori italiani del Novecento, solo Arnoldo Mondadori aveva commissionato un carattere tipografico nuovo. Non si trattava di un’iniziativa personale dell’editore, dettata dal desiderio di innovare la propria produzione dal punto di vista grafico, ma Mondadori vi era stato in qualche modo costretto dal poeta e letterato Francesco Pastonchi, il quale, incaricato della direzione della “Raccolta Nuova dei Classici italiani”, aveva preteso che venisse approntato un nuovo carattere, il Pastonchi appunto, che connotasse anche sotto l’aspetto visivo la peculiarità della collana. L’entusiasmo del letterato si scontrò con le preoccupazioni economiche dell’editore, ma alla fine Pastonchi ebbe la meglio: la progettazione del carattere ebbe inizio nel 1924. La “Raccolta Nuova dei Classici italiani” non vide mai la luce, tuttavia il Pa- IBC 2013 stonchi venne impiegato per una collana che in qualche modo ne riprendeva le linee guida, quella dei “Classici italiani” diretta da Francesco Flora.2 Ben diversa fu la vicenda del Garamond realizzato per Giulio Einaudi alla metà degli anni Cinquanta.3 Il figlio di Luigi Einaudi, nel novembre del 1933, appena ventunenne, aveva fondato la propria casa editrice, in stretta collaborazione con Leone Ginzburg e il gruppo di amici che si era formato dalla frequentazione comune del liceo D’Azeglio, sotto il magistero di Augusto Monti. I primi anni furono piuttosto complessi, per la difficile convivenza con il fascismo: arresti e invii al confino dei principali collaboratori interruppero a più riprese l’attività del gruppo, e Giulio stesso fu arrestato e interrogato. La guerra, poi, portò devastazioni e bombardamenti che colpirono a più riprese le sedi della Einaudi, con gravi danni e ingenti perdite economiche. Superate le difficoltà della guerra, però, Giulio Einaudi volle dare una nuova veste grafica alle sue edizioni. È noto infatti il grande amore per l’aspetto estetico dei volumi che connotò il suo mestiere di editore, un amore risalente, secondo qualcuno, alla passione bibliofilica che aveva contraddistinto il padre Luigi e che in qualche modo gli era stata trasmessa. Come tutti i grandi editori prestò sempre massima attenzione alla grafica delle coperte e delle sovraccoperte, affidate a importanti artisti del Novecento, come Francesco Menzio, Renato Guttuso, Bruno Cassinari o Ennio Morlotti. L’ideazione della copertina non era però svincolata dalla progettazione totale dei volumi o dei periodici, come è evidente nel coordinamento grafico tra “Il Politecnico”, periodico, e “Politecnico biblioteca”, la collana, curati entrambi da Max Huber e Bruno Munari. Tuttavia Giulio Einaudi decise di rinnovare e connotare la propria immagine anche con un carattere tipografico nuovo ed esclusivo, che permettesse di riconoscere un libro einaudiano anche trovandolo aperto su un tavolo.4 L’editore fu coadiuvato nella scelta dal responsabile editoriale Oreste Molina, capo dell’ufficio grafico. Fino a quel momento i libri della casa Einaudi erano stati composti in Linotype utilizzando caratteri eterogenei (Bembo, Bodoni, Caledonia, Granjon), e l’editore propose di far realizzare un Garamond da impiegare sulla Monotype, una tecnica di stampa che avrebbe assicurato risultati più accurati, a dimostrazione dell’importanza che l’editore attribuiva a questo elemento nella realizzazione dei volumi; ma Molina, più addentro di Giulio nelle questioni tecniche, sconsigliò vivamente, ed efficacemente, la composizione in Monotype, perché più lenta e più costosa. La decisione di adottare un carattere Garamond è interessante. Con questo termine si indica una famiglia di caratteri, tutti derivanti in maniera più o meno fedele da quello inciso alla metà del Cinquecento da Claude Garamond, tipografo parigino famoso anche per aver creato il “Grec du roi”, il carattere con cui venivano impresse le edizioni di testi greci destinate al re di Francia. Si tratta di un carattere con grazie, estremamente leggibile, che rimandava alla tradizione umanistica. Per realizzare il nuovo carattere, Giulio Einaudi si rivolse a un’azienda bolognese, la Simoncini, che in quel momento era già alla seconda generazione, sotto la guida di Francesco. L’azienda era nata anni prima, per volontà del padre Vincenzo Simoncini che, formatosi come montatore e riparatore di macchine compositrici meccaniche, 13 14 Biblioteche e archivi nel 1931 avviò un’azienda per la produzione di ricambi per Linotype.5 I tre figli, Francesco, Cesarina e Gian Attilio, furono coinvolti nell’impresa, che iniziò a impiegare anche alcuni operai. Gli anni della guerra, come per Einaudi e per gran parte degli italiani, furono difficili anche per la Simoncini. Francesco fu richiamato sotto le armi e nel 1944 i bombardamenti colpirono per ben tre volte la fabbrica. L’anno successivo, terminate le ostilità, l’azienda riaprì nel centro cittadino, in via Carbonesi, nell’attesa che fosse approntato un nuovo capannone in via delle Fragole, nella periferia sudorientale di Bologna. La prima innovazione del dopoguerra fu la fabbricazione di matrici per macchine Linotype, voluta in particolare da Francesco, che diventò anche socio del padre al 50%. Negli anni Cinquanta l’azienda, che fino a quel momento era rimasta di piccole dimensioni, si espanse notevolmente: nel 1952 furono allargati gli edifici e l’anno successivo la Simoncini si trasformò in società per azioni. Alla morte del padre Vincenzo, tutti gli otto figli divennero soci, e Francesco, che deteneva il 51% delle azioni, divenne amministratore unico. La capacità di innovazione della Simoncini fu evidente quando la ditta aprì al proprio interno uno studio di progettazione di caratteri con ben dieci disegnatori, che la fece uscire da una dimensione locale e le fece raggiungere una clientela nazionale. A questo periodo va fatta risalire la creazione di numerosi tipi di caratteri, tra i quali il più famoso è l’Aster (1955), realizzato per assecondare le necessità della stampa dei quotidiani e caratterizzato quindi da aste verticali corte, per comprimere gli spazi. Francesco Simoncini poté quindi offrire a Giulio Einaudi matrici di ottima qualità a prezzi concorrenziali; da non sottovalutare era anche la possibilità di una fornitura continua e flessibile, capace di creare segni speciali in caso di necessità. L’azienda bolognese si appoggiò per la realizzazione della commessa Einaudi a una ditta tedesca, la fonderia Ludwig & Mayer di Francoforte, con la quale continuò a collaborare anche in seguito. Ci vollero due anni per realizzare il carattere, dal 1956 al 1958. I disegni di Bologna venivano inviati a Francoforte per confronti e modifiche, quindi tornavano in Italia e l’elaborazione proseguiva finché non si arrivava a un accordo. A quel punto si produceva il disegno esecutivo della lettera e si iniziava a studiarla in rapporto alle altre componenti dell’alfabeto. Infatti, particolarmente esemplificativo della meticolosità con cui Simoncini lavorò al suo Garamond fu lo studio riservato ai raggruppamenti di lettere, per evitare il rischio di creare addensamenti di colore sulla pagina. Da qui derivò anche l’attenzione dedicata alle trasformazioni subite dai caratteri in seguito all’inchiostrazione e alla pressione in corso di stampa, che portò a modificare i tipi cosicché, deformandosi, raggiungessero la forma ideale. Anche Oreste Molina partecipò al dibattito, soprattutto con indicazioni relative alla funzionalità dei caratteri e alle necessità della casa editrice. Il Garamond Simoncini fu uno dei pochi caratteri di quegli anni progettato esclusivamente con funzioni editoriali, insieme a quelli ideati da Giovanni Mardersteig e da Alberto Tallone, e ad alcune delle realizzazioni di Aldo Novarese. In questo carattere IBC 2013 tipografico si concretizzarono le esigenze di un editore ambizioso e desideroso di offrire al lettore un libro bello non solo nei contenuti ma anche nell’aspetto, e le capacità di un’azienda in grado di fornire un prodotto funzionale e di qualità. Note (1) G. Montecchi, Il rinnovamento grafico di Giambattista Bodoni, in Id., Itinerari bibliografici. Storie di libri, di tipografi e di editori, Milano, FrancoAngeli Edizioni, 2001, pp. 58-86. (2) Sulla vicenda mondadoriana si vedano: M. Rattin, M. Ricci, Questioni di carattere. La tipografia in Italia dall’Unità nazionale agli anni Settanta, prefazione di G. Anceschi, Roma, Stampa Alternativa / Graffiti, 1997, pp. 90-95 e il Quanto basta n. 8 dedicato a Francesco Flora sul sito www.fondazionemondadori.it. (3) Per la bibliografia aggiornata di e su Giulio Einaudi e la sua casa editrice, si rimanda a: Libri e scrittori di via Biancamano. Casi editoriali in 75 anni di Einaudi con illustrazioni e documenti, a cura di R. Cicala e V. La Mendola, presentazione di C. Carena, Milano, Educatt, 2009 (che non tiene ovviamente conto delle numerose pubblicazioni uscite in occasione del centenario). (4) M. Rattin, M. Ricci, Questioni di carattere, cit., pp. 144-148. (5) Le notizie sulla ditta sono reperibili nell’opuscolo: F. Simoncini, Panoramica sulla Società Simoncini, Bologna, Arti Grafiche Tamari, 1965. [“IBC”, XXI, 1, gennaio/marzo 2013] 15 Tre attori hanno portato il pubblico nelle stanze e tra le carte dell’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Reggio Emilia. Teatro in archivio Pierluigi Tedeschi, Lella Vinsani L’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Reggio Emilia (ISTORECO), nato nel 1965, fa parte di una rete nazionale di istituti costituiti al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio documentario e le memorie della guerra di Liberazione in Italia e dell’intero Novecento (www.istoreco.re.it). L’importanza che l’ISTORECO e il Polo archivistico del Comune rivestono per la città è davvero rilevante: va infatti ricordato che qui è conservato l’archivio della Resistenza e del movimento di liberazione a Reggio Emilia e i tanti cartellini dei partigiani iscritti all’ANPI (l’Associazione nazionale partigiani d’Italia), un patrimonio di grandissimo valore. Naturalmente sono presenti anche molti altri fondi rilevanti – gli archivi di alcuni partiti politici, quello della Camera del lavoro, quelli del Comune e della Provincia, dell’Azienda consorziale trasporti, della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, e diversi altri elencati nel sito del Polo archivistico (archivi.comune.re.it) – e questo ne fa una straordinaria risorsa non soltanto per la ricerca degli studiosi ma anche per il recupero della memoria da parte della città.1 Di questa opera di recupero fa parte la collaborazione tra l’ISTORECO e l’attore Pierluigi Tedeschi, già autore di Nebbia, uno spettacolo di cui la rivista “RS. Ricerche Storiche” ha proposto una sintesi nel suo numero 113. Tedeschi infatti, ben noto al pubblico e alla critica per il suo impegno civile e sociale, assai ben trasposto in pièces teatrali, ha dimostrato molto interesse per i materiali dell’archivio e ha cominciato a pensare a una lettura a più voci, costruita e adattata agli spazi della struttura, come un modo per interessare e coinvolgere chi ancora non conosce l’Istituto. È nato così “Teatro in Archivio vol. 1”, uno spettacolo tenutosi nei locali dell’ISTORECO e del Polo archivistico il 15 dicembre 2012, basato su testi scelti da Lella Vinsani e interpretati da Cinzia Pietribiasi, Silvia Scotti e Pierluigi Tedeschi.2 I brani letti sono stati scelti per comunicare al pubblico le varie tipologie di documenti conservati nell’Istituto, seguendo un ordine cronologico facilmente comprensibile. Sicuramente vincente è stata l’idea di consegnare a ogni presente, prima dell’inizio della rappresentazione, il cartellino di un partigiano, per favorire un’immersione empatica nel periodo storico raccontato dalle letture. IBC 2013 Lo spettacolo ha avuto inizio con il documento che sancisce la costituzione del Comitazione di liberazione nazionale (CNL) provinciale, che ebbe luogo in città il 28 settembre 1943 nella canonica della chiesa di San Francesco. E proprio in quella canonica si trovava la credenza conservata oggi nell’ingresso dell’ISTORECO, dove non a caso è cominciata l’azione teatrale. Nell’emeroteca si è potuta ascoltare la testimonianza “elettronica” di Annita Malavasi “Laila”, partigiana, interessante anche per il suo risvolto sociale. Annita, infatti, allora fidanzata e giudicata “troppo libera” per la sua attività politica dal promesso sposo, lo lasciò pur di rimanere fedele ai suoi ideali. Nella sala delle scrivanie erano esposti – per la prima volta – gli strumenti di tortura usati nelle carceri dei Servi, a Villa Cucchi e nel carcere di San Tommaso, resi in tutta la loro potenza di crudeltà dalla forte presenza scenica di Pierluigi Tedeschi. Nel corridoio che congiunge l’ISTORECO con il Polo archivistico, è stata rievocata la storia di una giovane staffetta che subì pesanti e ripetute torture: la sua vicenda, negli ambiti più nascosti e personali, è stata interpretata con passione e intensità da Cinzia Pietribiasi. Con la lettura dell’opera dedicata da Salvatore Quasimodo Ai Fratelli Cervi, alla loro Italia, il pubblico è stato accompagnato all’ultima tappa della rappresentazione, l’Archivio delle OMI (Officine meccaniche italiane) Reggiane sito nei locali del Polo archivistico, dove è stato letto un brano del libro Disegnava aerei di Annamaria Giustardi, riguardante l’eccidio del 28 luglio 1943. La canzone I morti di Reggio Emilia, in ricordo della strage del 7 luglio 1960, ha poi concluso simbolicamente il percorso storico. “Teatro in Archivio vol. 1” è nato dalla volontà di ricercare un nuovo modo di trasmettere i valori del passato, di rileggere i documenti che la patina del tempo sembrava aver cosparso di oblio, e il linguaggio teatrale si è rivelato uno strumento estremamente efficace per ripercorrere momenti, luoghi e volti che hanno fatto la storia della nostra città e del nostro Paese. Che la proposta di lettura scelta da Pierluigi Tedeschi, Cinzia Pietribiasi e Silvia Scotti sia la formula giusta lo si è visto chiaramente dal comportamento del pubblico: sguardi indirizzati a recuperare la memoria di immagini forse già viste ma dimenticate; orecchie dirette alle parole che si alternavano tra volti e oggetti; momenti passati che tornavano con i colori vividi della violenza che fu, dell’orrore, della paura; il silenzio, in certi momenti teso, a seguire quel che è stato; persone che si muovevano lente ma decise, in un pellegrinaggio scandito dalle tappe fondamentali del tragitto che ha portato alla democrazia; un coro sottile che si è levato alla fine del percorso sulle note di una canzone, e che tutti ci ha uniti nella memoria della tragedia e nella volontà di non dimenticare. Gli anni che stiamo attraversando non hanno certo contribuito a far sì che nelle giovani generazioni sia nata la voglia di sapere, di conoscere il passato da cui provengono e che oggi rende loro possibile anche “disinteressarsi” della storia; si rischia quindi di dare per scontata la forza della democrazia, conquistata a carissimo prezzo e con alto spirito di sacrificio. Ecco, dal punto di vista dell’ISTORECO riteniamo che fornire a tutti l’opportunità di visitare i luoghi della storia, dove si conserva la memoria, sia stata una iniziativa che ha dato buoni risultati. Merito di questo va soprattutto agli attori, che hanno for- 17 18 Biblioteche e archivi nito un nuovo modo di approcciarsi alla materia e ai documenti. L’utilizzo di nuovi linguaggi è essenziale in questo particolare momento storico, in cui tutto muta con grande velocità, e lo è particolarmente in un settore che, come il nostro, ha necessità di rendersi “interessante” per favorire una prima conoscenza e poi magari l’approfondimento che ne potrà seguire. [Lella Vinsani] Per raccontare cos’è stata l’esperienza di “Teatro in Archivio vol. 1” bisogna proprio partire dal luogo fisico in cui è avvenuta la rappresentazione: da un archivio. Un luogo che, situato nel centro storico della città di Reggio Emilia, ha avuto, come spesso accade, vari utilizzi nel corso del tempo: da edificio religioso a spazio adibito alle scuderie dell’esercito. Infine, destinato a ospitare il Polo archivistico del Comune e l’ISTORECO: istituti, per loro stesso statuto, tenuti in primo luogo a conservare e a proteggere documenti preziosi, la memoria storica di una comunità. Questa giusta azione di conservazione e protezione può far sì che, al di fuori della stretta cerchia di ricercatori e cultori della materia, questi spazi e questi edifici vengano vissuti come chiusi, inaccessibili: un corpo separato e difficilmente penetrabile. Il lavoro di divulgazione dei materiali contenuti, la rielaborazione e lo studio dei documenti possono subire o rischiare la stessa sorte. Rimanere anch’essi retaggio esclusivo e a volte autoreferenziale degli studiosi e degli archivisti di centri e poli conservativi analoghi, sparsi sul territorio nazionale. Con questa consapevolezza, l’ISTORECO, in particolare, dedica da anni molte delle sue energie a portare fuori dai suoi ambiti il proprio tesoro di memoria: basti ricordare, tra le tante iniziative, i periodici “viaggi della memoria” rivolti alle scolaresche, un’esperienza didattica e divulgativa che negli anni ha consentito a centinaia di studenti di visitare i campi di sterminio nazisti in Polonia e in Germania. “Teatro in Archivio vol. 1” tenta un approccio nuovo di divulgazione e manutenzione della memoria: aprire un archivio, un luogo di solito chiuso e per pochi addetti ai lavori, facendo entrare le persone nel luogo fisico in cui questa memoria è conservata, dove sono custoditi i documenti, e facendole camminare e spostare in tutte le direzioni. Una proposta che, con l’ennesima espressione anglosassone, si può a ragione definire site-specific, cioè nata in questo luogo, per questo luogo, dai materiali presenti sul posto. Non si tratta di un innesto di materiali, spettacoli o performance nati altrove e adatti a ogni situazione: le storie e le vicende che si dipanano, sala dopo sala, provengono dalle carte e dai materiali video dell’archivio. Il pubblico viene accolto all’ingresso, sulla “soglia della memoria”, e a ognuno dei partecipanti viene dato un cartellino di un partigiano o di una staffetta, proveniente dallo schedario dell’ANPI. È un invito a immedesimarsi in quelle persone, a prendere un nome di battaglia per il tempo del percorso. Un mobile massiccio di legno scuro è stato il testimone silenzioso della fondazione del CLN reggiano: nel corridoio d’entrata dell’ISTORECO, davanti a questo sobrio arredo, i tre attori raccontano la vicenda. Si prosegue nella “sala pinacoteca” e nella “sala delle bandiere” dove prima un video e poi un’attrice raccontano le “vite autentiche” di alcune staffette partigiane. IBC 2013 Nella “sala delle scrivanie”, una bacheca che contiene degli strumenti di tortura – efferati o apparentemente banali e innocui, come un ferro da stiro – cominciano a parlare, con la voce di un attore, delle torture e delle violenze commesse nella famigerata Villa Cucchi, la sede reggiana della polizia politica fascista. Di violenza che lascia un segno indelebile nella memoria di chi l’ha subìta si narra ancora nella “sala del restauro”, con la “Storia di Anna”, un’ex staffetta che per strada, a distanza di decenni, incrocia il suo ex torturatore. Salvatore Quasimodo ha scritto una poesia intensissima e misconosciuta dedicata Ai Fratelli Cervi. Un testo che conduce il pubblico emozionato dalla vicenda dolente della staffetta Anna, attraverso il lungo “corridoio degli archivi”, verso il deposito (prezioso e in gran parte in attesa di adeguati restauri) destinato all’archivio delle “Officine Reggiane”. Trattore R60, la canzone trasmessa da uno scricchiolante altoparlante, introduce all’ultima narrazione a tre voci: “Disegnava aerei”, storia di un giovane tecnico delle Reggiane, appassionato di meccanica e di aeroplani, morto il 28 luglio del 1943 durante uno scontro tra la polizia e gli scioperanti. Cosicché il brano che chiude questo viaggio tra sale e corridoi di un archivio aperto per la prima volta al pubblico, non può che essere Per i morti di Reggio Emilia. Quelli caduti il 7 luglio del 1960, nel centro storico della città, mentre scioperavano contro la legge “Tambroni”. “Teatro in Archivio vol. 1” è l’inizio di un percorso che ci auguriamo possa proseguire con successivi “volumi”, per portare ancora il teatro in luoghi non-teatrali. Tre attori in relazione, in dialogo, in conflitto con uno spazio adibito a sede di un archivio: nulla di nuovo in assoluto, se si pensa che già dal primo Novecento le avanguardie artistiche storiche sentirono il bisogno di uscire dai teatri per lasciarsi contaminare dal contesto quotidiano, urbanistico e architettonico, per ridefinire le funzioni e le convenzioni del fare teatro. Dopo un secolo, l’urgenza di sperimentare spazi non teatrali non ha più quelle implicazioni di provocazione, sovvertimento, manifesto politico. Rimane più che mai intatta e rafforzata l’eterna dialettica tra spazio, corpo dell’attore, forma dello spettacolo. In altri termini, un confronto tra il “contesto” dove si svolge un’azione performativa, lo “strumento” di questa azione, cioè l’attore-performer, e la “modalità di comunicazione”. Una dialettica che obbliga l’artista a riflettere sul processo comunicativo e sulla ricerca di una nuova relazione con lo spettatore. “Teatro in Archivio vol. 1” non ha portato qualcosa di estraneo all’interno del Polo archivistico e dell’ISTORECO di Reggio Emilia. In questo caso si può ben dire che il luogo e i ricercatori hanno generato teatro: con il desiderio e la necessità di trovare nuove strade per divulgare l’enorme patrimonio di memoria che conservano. Come ogni cosa, anche la memoria, se non viene usata, allenata, sottoposta a una corretta e continua manutenzione, corre il rischio di disperdersi, sfarinarsi, entrare in quell’enorme buco nero che risucchia tutto quello che sembra “già visto”, “già sentito”, “già conosciuto: saputo e risaputo”. Così per me ora appare chiaro cos’è accaduto con questa prima esperienza: un cortocircuito tra il senso contemporaneo di fare teatro (in quale “contesto”, con quali “strumenti”, con quali “modalità di comunicazione”) e il senso contemporaneo 19 20 Biblioteche e archivi di fare divulgazione e manutenzione della memoria (in quale “contesto”, con quali “strumenti”, con quali “modalità di comunicazione”). [Pierluigi Tedeschi] Note (1) Si veda in proposito: A. Ferraboschi, M. Storchi, Insieme in archivio, “IBC”, XIX, 2011, 4, pp. 12-16. (2) Cinzia Pietribiasi, attrice, danz’autrice e regista, dopo una formazione non accademica partecipa con progetti performativi originali alle semifinali del premio “Scenario” nel 2009 e nel 2011, e viene selezionata per la semifinale del premio “Gd’A Emilia Romagna” 2012. Parallelamente lavora con “La Baracca - Teatro Testoni Ragazzi” di Bologna. Collabora con la compagnia “Arte e Salute Onlus” (attori-utenti del Dipartimento di salute mentale di Bologna), realizza e conduce progetti di teatro per bambini e corsi di formazione per insegnanti nelle scuole di primo e secondo grado. Silvia Scotti, attrice e formatrice, ha incrociato l’ambito teatrale e quello educativo. Dal 2003 al 2006 ha recitato nella “compagnia Giolli” con cui ha partecipato al convegno internazionale “I Teatri delle diversità”; ha approfondito lo studio del movimento a l’École Internationale de Théâtre Lassaade di Bruxelles; collabora come attrice con “Istarion Teatro” (Reggio Emilia) e “Laboratorio 41” (Bologna). È referente teatrale del progetto “FEI 2013” del Comune di Parma (settore adolescenti), collabora con enti di formazione per adulti e realizza progetti di teatro per bambini e adolescenti. Pierluigi Tedeschi, performer, autore teatrale e scrittore, fin dai primi anni Ottanta ha partecipato e organizzato letture ed eventi poetici in varie città d’Italia. Nel 2010 ha pubblicato Il profilo delle parole, antologia poetica ispirata al fotografo Luigi Ghirri (Edizioni Baobab), nel 2012 Luoghi Comuni con il fotografo Riccardo Varini (Edizioni AbaoAqu). Ha debuttato in teatro nel 2011 con il suo monologo multimediale Nebbia. Un’orazione civile, e collabora come attore con “Lenz Rifrazioni” (Parma). [“IBC”, XXI, 1, gennaio/marzo 2013] A Bologna pubblico e privato si uniscono per rendere fruibili i documenti che raccontano la storia della comunità tra Otto e Novecento. Una città per gli archivi Alessandro Alfier Ancora oggi la sussidiarietà orizzontale, declinata sul versante della valorizzazione dei beni culturali, muove passi incerti, invocata più che praticata, fors’anche per l’assenza di una giurisprudenza significativa e per la diversità di approcci tra il legislatore nazionale e i legislatori regionali. Da tempo però il nostro ordinamento si è arricchito di questa fattispecie: dapprima facendola assurgere al rango di dovere costituzionale sull’onda della riscrittura che nel 2001 ha interessato l’articolo 118 delle Costituzione, per poi dettagliarla con le disposizioni contenute nel “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (Decreto legislativo 22 gennaio 2004 numero 42). S’impone così il principio per cui “la Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale” (articolo 6, comma 3 del Decreto legislativo 42-2004), che pone in capo agli attori pubblici l’obbligo – non il semplice intento od obbiettivo programmatico – di collaborare con il settore privato per promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e per assicurarne le migliori condizioni di pubblica fruizione. Questo quadro normativo è stato concretamente introiettato dall’Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBC) che, al sorgere del progetto bolognese a iniziativa privata “Una città per gli archivi”, ha consapevolmente perseguito – come in altre occasioni – l’attuazione dei principi di sussidiarietà orizzontale. E nel quadro di questa collaborazione pubblico-privata per la valorizzazione degli archivi storici sono state raggiunte delle mete che forse in altro modo non sarebbero state a portata di mano: come il riuso di risorse umane, informative e tecnologiche, che l’attore pubblico ha messo a disposizione dei privati animatori del progetto per massimizzare gli effetti prodotti dagli investimenti pubblici nel settore dei beni culturali; o come l’avvio dell’integrazione tra diversi sistemi che sul web descrivono i beni culturali, per fornire così alla comunità degli utenti servizi integrati a più alto valore aggiunto.1 Il progetto “Una città per gli archivi” muove i primi passi nel 2006, quando la Fondazione Cassa di risparmio in Bologna e la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna avviano un insieme strutturato e coordinato di attività per preservare e rendere 22 Biblioteche e archivi pubblicamente fruibili gli archivi più significativi per la storia della comunità cittadina nell’Ottocento e nel Novecento. L’intento progettuale delle due fondazioni mette radici su un terreno che è già di per sé fertile. In quegli stessi anni si assiste infatti a una “riscoperta” delle fonti per la storia bolognese sull’onda di contributi diversi: le iniziative organizzate a livello locale per ricordare la figura di Giosue Carducci, i preparativi per commemorare in città i 150 anni dell’Unità d’Italia, la pubblicazione in più volumi della Storia di Bologna realizzata sotto la direzione di Renato Zangheri con il contributo della Fondazione Cassa di risparmio, e il recupero di monumenti documentari per l’identità della comunità felsinea come Il Liber Paradisus, opera data alle stampe per iniziativa della Fondazione del Monte, che nello stesso periodo promuove anche il riordino e l’inventariazione dell’archivio della Commissione per i testi di lingua in Bologna e dell’archivio di Riccardo Bacchelli. È questo il clima culturale che fa da sfondo all’avvio del progetto, i cui esordi sono già il risultato di un’intraprendenza dei privati utilmente orientata sulla base delle competenze tecniche messe in campo dal pubblico: nel 2007 infatti, di fronte alla necessità di censire gli archivi cittadini a maggiore rischio conservativo e più bisognosi di attività di ordinamento e inventariazione, l’IBC mette a disposizione del progetto nascente il proprio patrimonio di conoscenze ed esperienze, per costruire così con le fondazioni un orizzonte operativo che sia sinergico con la politica di valorizzazione degli archivi storici bolognesi perseguita già da decenni dall’attore pubblico. L’apporto al progetto, ai suoi esordi, va però ben oltre. L’IBC infatti fa valere i positivi riscontri che è andato raccogliendo sulle performance della piattaforma di gestione documentale xDams, sempre più utilizzata negli interventi archivistici intrapresi sul territorio regionale: si tratta di un’esperienza preziosa che fornisce un apporto di grande rilievo alle fondazioni. E così, ancora una volta, i privati fanno tesoro delle competenze maturate nel tempo dal pubblico, in una sorta di disseminazione delle conoscenze: l’applicativo della softwarehouse Regesta.com viene infatti prescelto anche da “Una città per gli archivi” come lo strumento più idoneo per l’inventariazione informatizzata dei fondi e delle raccolte selezionati con il censimento, così da poter produrre un patrimonio informativo da restituire, in ultima istanza, agli utenti della rete. Negli anni successivi l’iniziativa delle fondazioni ha assunto una forma prettamente operativa, definita su tre lati: dalle linee di politica generale impresse al progetto da un comitato di esperti, dalle metodologie e dalle decisioni tecniche elaborate da un coordinamento scientifico in attuazione delle linee d’indirizzo generale, dall’intensa collaborazione con la Soprintendenza archivistica per l’Emilia-Romagna per quanto attiene alle competenze di tutela che lo Stato esercita su gran parte degli archivi interessati dal progetto.2 Attraverso questa articolata struttura, “Una città per gli archivi” ha acquisito quel carattere di duplice “trasversalità” che lo contraddistingue. Il progetto, infatti, si fa carico delle molte problematiche che sottraggono le fonti primarie al loro naturale destino di fruizione da parte della comunità, da quelle legate al riordino e all’inven- IBC 2013 tariazione, a quelle legate al restauro della documentazione e alla predisposizione di condizioni e di ambienti fisici idonei alla sua conservazione. Ma non dimentica che l’Ottocento e il Novecento sono secoli in cui l’atto del documentare, lungi dall’abbandonare la carta, si rivolge anche ad altri media: così l’intraprendenza delle fondazioni estende il proprio raggio d’azione anche ai fondi e alle raccolte di materiali grafici, fotografici, audiovisivi, sonori. Un approccio di questo tipo ha rilevanti ricadute metodologiche e operative: impone infatti che, all’interno della piattaforma gestionale xDams, i tracciati di inventariazione da un lato si pluralizzino – in rapporto alle diverse tipologie materiali di archivi – e dall’altro lato assumano una forma in cui l’impostazione archivistica consolidata dagli standard disciplinari internazionali sappia anche guardare alla tradizione catalografica di matrice bibliografica, che, soprattutto per la descrizione dei singoli items materializzati nei nuovi media, ha da tempo consolidato un patrimonio di data structure standard e di data content standard.3 Proprio sul fronte dell’inventariazione informatizzata la collaborazione con l’IBC si è fatta nel tempo sempre più stringente, tanto che nell’ottobre del 2010 è stata stipulata una convenzione con cui l’iniziativa delle fondazioni ha assunto l’impegno di adottare soluzioni per l’integrazione tra il proprio patrimonio di dati e i sistemi informativi regionali gestiti dallo stesso attore pubblico sui beni archivistici e librari; quest’ultimo, nel contempo, mette a disposizione le proprie competenze professionali per contribuire al consolidamento della banca dati gestionale in uso a “Una città per gli archivi” e allo sviluppo del futuro portale “archIVI”,4 su cui le fondazioni hanno avviato i lavori proprio in quegli stessi mesi, avvalendosi di un raggruppamento di imprese formato da Chialab, Expert System e ChannelWeb. Così, tra la fine del 2010 e il maggio del 2012, l’IBC, tramite un proprio collaboratore (colui che scrive) ha espresso una delle figure tecniche che operano in seno al coordinamento scientifico del progetto. Tale assetto organizzativo agevola il conseguimento di una serie di obiettivi. Sul piano dell’integrazione fra risorse web, è stata portata a termine la procedura di cooperazione applicativa tra il portale “archIVI” e l’OPAC del Polo bolognese del Servizio bibliotecario nazionale. Un esito che nasce dalla considerazione che diversi fondi e raccolte coinvolte nel progetto si richiamano a una parte del patrimonio bibliografico gestito dalle istituzioni bolognesi e catalogato nell’OPAC. La rilevanza di tali rimandi ha indotto a ricercare – con la collaborazione dell’IBC e dell’Area sistemi dipartimentali e documentali dell’Università di Bologna – una prima forma di restituzione di tali rimandi agli utenti web. Da qui lo sviluppo di una procedura software tramite cui il portale, grazie al protocollo di comunicazione Z39.50, è in grado di lanciare delle interrogazioni per codice identificativo d’autore sul server messo a disposizione da Sebina OpenLibrary (l’applicativo gestionale dell’OPAC), ottenendo come risposta un elenco di notizie bibliografiche che sono direttamente consultabili all’interno di “archIVI”. Così l’utente che decide di ricercare nel portale le descrizioni archivistiche riferite a un certo autore dei documenti inventariati ottiene simultaneamente, all’interno della stessa piattaforma, 23 24 Biblioteche e archivi le descrizioni bibliografiche di provenienza OPAC referenziate al medesimo autore, in una sorta di modalità di consultazione integrata. Sul piano del riuso delle risorse software, dopo aver predisposto con Regesta.com un authority record per la descrizione dei soggetti produttori conforme all’ultima versione del data structure standard EAC e integrato nella piattaforma xDams, l’IBC ha messo a disposizione del progetto delle fondazioni tale risorsa, evitando un inutile e dispendioso proliferare di soluzioni software a carico dei privati. Oggi, quindi, le banche dati gestionali, sia quelle che alimentano “IBC Archivi”,5 sia quelle che alimentano “archIVI”,6 condividono il medesimo authority record dei soggetti produttori. Tale riuso – reso agevole dal fatto che xDams è la piattaforma gestionale adottata sia dall’attore pubblico che da “Una città per gli archivi” – permette agli archivisti operanti nell’ambito del progetto di avviare un confronto in tema di prassi descrittive con i colleghi dell’ente regionale, anche a seguito di occasioni formative organizzate con lo stesso IBC. Sul piano della condivisione del patrimonio informativo delle banche dati, infine, è stata avviata un’ulteriore collaborazione. Da alcuni anni l’IBC gestisce CAStER, un sistema informativo per la rilevazione degli enti di conservazione presenti sul territorio regionale e dedicati agli archivi storici: una risorsa il cui impiego condiviso può giovare tanto alle fondazioni quanto al soggetto pubblico. Infatti il sistema informativo regionale si compone di una banca dati in cui risultano già descritti alcuni dei soggetti che a Bologna conservano i fondi e le raccolte inventariati dal progetto delle fondazioni, e dispone inoltre di un consolidato tracciato per descrivere i rimanenti istituti conservatori coinvolti in “Una città per gli archivi”. Nel contempo il riuso dell’applicativo CAStER da parte delle fondazioni può arricchire la banca dati regionale e fornire un contributo per un suo più diffuso impiego. Per queste indubbie utilità, i conservatori coinvolti nell’iniziativa delle fondazioni e non ancora censiti nel sistema informativo regionale vengono messi nelle condizioni di potersi descrivere all’interno dell’applicativo: a questo fine la parte pubblica e quella privata organizzano delle occasioni formative, mentre il coordinamento scientifico del progetto predispone un servizio di assistenza rivolto ai propri conservatori. In prospettiva, dunque, il sistema informativo regionale risulterà popolato dai dati relativi a tutti i soggetti bolognesi che detengono i fondi e le raccolte che fanno parte di “Una città per gli archivi”. Tale mole informativa sarà resa disponibile su più nodi della rete: certamente sul portale “IBC Archivi”, che viene alimentato dalla banca dati CAStER, ma che attraverso dei web services esporrà i medesimi dati anche a favore del portale “archIVI”.7 Si delinea così una soluzione di sistema, che accentra sul sistema informativo regionale le funzioni descrittive dei conservatori d’archivio, in qualità di fonte informativa unica per distinte piattaforme web. Tali attività, oltre a conferire concretezza al rapporto di sussidiarietà orizzontale tra la parte pubblica e quella privata, si integrano nel più generale processo di sviluppo del portale “archIVI”, inaugurato nell’aprile del 2013. Un portale che si inscrive in un orizzonte programmatico ben definito: realizzare una risorsa web capace di risponde- IBC 2013 re alle domande che emergono nel momento in cui le forme dell’inventario analogico elaborato secondo il tradizionale modello di mediazione archivistica – in cui il tecnico della memoria, in sala di consultazione, media tra l’utente e lo strumento di accesso alle fonti primarie – siano acriticamente riproposte nel web, ovvero in un ambiente in cui, venendo meno il reference di sala dell’archivista, occorre che la risorsa di accesso all’archivio sia il più possibile autoesplicativa per poter essere realmente usabile dagli utenti della rete.8 Note (1) Sul fronte dell’ente regionale la collaborazione è concretamente attuata dalla Soprintendenza per i beni librari e documentari, servizio interno all’IBC. (2) Per un approfondimento sulla storia del progetto si vedano: Spigolature d’archivio: contributi di archivistica e storia del progetto “Una città per gli archivi”, a cura di A. Antonelli, Bologna, Bononia University Press, 2011, pp. 13-43; A. Antonelli, Istantanea “Una città per gli archivi”: istituzioni, fatti, persone, tempi, modi, prospettive e storia di un progetto archivistico locale, “Archivi & Computer”, XXII, 2012, 2, pp. 7-35; la risorsa all’indirizzo: www. cittadegliarchivi.it/footer/documenti-di-progetto-1/breve-storia-sul-progetto-una-citta-per-gli-archivi (come tutte le altre risorse web qui citate, è stata consultata l’8 maggio 2013). (3) Per un approfondimento delle tematiche relative all’inventariazione informatizzata dei fondi e delle raccolte coinvolti in “Una città per gli archivi” si veda: “Archivi & Computer”, XXII, 2012, 2 (numero monografico della rivista, dedicato al progetto). (4) www.cittadegliarchivi.it/. (5) archivi.ibc.regione.emilia-romagna.it/ibc-cms/. (6) Le descrizioni dei soggetti produttori generate con la piattaforma xDams e le descrizioni dei soggetti conservatori prodotte con l’applicativo CAStER saranno disponibili sul portale “archIVI” a partire dai primi mesi del 2014. (7) Si veda la nota precedente. (8) Le attività di sviluppo della piattaforma web hanno tra l’altro previsto l’esecuzione di alcuni user studies, per valutare l’usabilità di una sua versione prototipale da parte degli utenti; per un approfondimento si veda: P. Feliciati, Ask the users, il valore aggiunto della valutazione dei sistemi informativi culturali on line coinvolgendo gli utenti: il caso del progetto “Una città per gli archivi, “Il capitale culturale: studies on the value of cultural heritage”, 2012, 5, pp. 129-144 (www.cittadegliarchivi.it/footer/documenti-di-progetto-1/gli-user-studies-sul-portale-di-una-citta-per-gli-archivi). Sulle problematiche legate al passaggio dal tradizionale inventario analogico all’inventario pubblicato sul web si veda: A. Alfier e P. Feliciati, Cambio de paradigma en el próximo decenio: el desafío de la Web para los instrumentos de descriptión de los archivos, “Tabula”, 16, 2013, pp. 33-49. [“IBC”, XXI, 2, aprile/giugno 2013] 25 A Ravenna la Biblioteca Classense dedica una mostra ai libri d’artista realizzati esclusivamente da mani femminili. Fatti da donne Claudia Giuliani Dobbiamo a Mirella Bentivoglio, decana delle artiste del libro in Italia, l’aver coniato il felice termine di “libriste”, con il quale la Biblioteca Classense di Ravenna contrassegna una serie di iniziative dedicate al libro d’artista: nello scorso anno 2012, in occasione dell’8 marzo, l’esposizione “Libriste. Dalla collezione di libri d’artista di Marco Carminati”, concernente i libri d’artista di questa ricca collezione privata, e quest’anno, di nuovo nella ricorrenza della Festa della donna, “Libriste alla Classense”, in cui si sono potuti esporre libri d’artista appartenenti alle collezioni classensi, o per dono o grazie a una intelligente politica di acquisizioni datata agli anni Settanta e Ottanta del Novecento, che volle prestare attenzione alle case editrici maggiormente attive nella produzione di libri d’artista, da Geiger a Scheiwiller.1 Ma “Libriste” si propone qualcosa di più rispetto all’esposizione di libri d’artista come creative forme di sconvolgimento, o di rigenerazione, del libro classico. I libri in questione sono infatti prodotti esclusivamente da donne. In questa operazione si vanno realizzando due istanze: da un lato, appunto, l’attenzione all’evolversi del percorso di destrutturazione del tradizionale codice del libro, e in particolare del libro tipografico, e dall’altro la messa a fuoco di scelte che le donne hanno operato in questo percorso. Lo scopo è comprendere il loro lavoro sul libro. Donne di varia nazionalità, età e pratica artistica, hanno prodotto libri polimaterici, devianti e innovativi rispetto alle forme dei paratesti tipografici tradizionali. Possiamo leggerne l’evoluzione e le innovazioni, che si declinano variamente, dall’impiego dei materiali al lavoro sugli elementi paratestuali (i titoli, la collocazione e la definizione dei contributi autoriali, la sequenza delle carte, la formulazione retoricamente elaborata delle note tipografiche, per dirne alcuni) fino ai testi, a partire dagli esperimenti di poesia visiva. Possiamo rintracciare in questi lavori i percorsi del libro d’artista senza specificità di genere, ma anche indagarne lo specifico femminile, forse non sempre leggibile, a volte ideologico, a volte persino espressamente rifiutato; in realtà l’aver messo a confronto i libri delle artiste fa giocoforza emergere delle specificità innegabili, come il ricorso ai lavori femminili, ai loro saperi, nella confezione del libro, la loro citazione IBC 2013 anche, e infine la presenza nei libri del corpo delle donne, inequivocabile segno di diversità. Da citare, in proposito, la sperimentazione in mostra della giovane Cristina Volpi, che col suo Pas de Mots ha condotto a termine un’operazione di sostituzione della parola con i segni del corpo, l’impronta delle ciglia riprodotte sulle pagine: immagine questa, scelta per il manifesto della mostra. Oltre cinquanta le artiste esposte, fra cui un nutrito gruppo di donne attive sul territorio ravennate. Alle origini della scelta di questa esposizione in una biblioteca storica c’è la sgomenta osservazione di un vuoto. Il vuoto lasciato dai libri delle donne, che sono libri non presenti. E non si vuole qui fare riferimento ai testi prodotti dalle donne, tema che pure consentirebbe di rilevare clamorose omissioni e assenze, quanto ai libri che, come oggetti, alle donne furono legati. Sono rare le memorie di donne che del libro hanno fatto oggetto di lavoro o di passione, dalla rilegatrice alla bibliofila. Sono rare persino le memorie delle lettrici. E una rimozione nella biblioteca di conservazione significa perdita, a volte irreversibile. Per questa ragione, all’interno di questa grande biblioteca di tradizione che è la Classense, emergono con particolare risalto le poche figure di donne che ai libri si legano: “libriste”, se vogliamo, esse stesse, anche se lontane da quella creativa opera di decostruzione ed espressione artistica personale che vediamo rappresentata nei libri d’artista. Si allude a Maria Pasolini Ponti, la “creatrice” di biblioteche popolari nella Romagna del tardo Ottocento e primo Novecento, luogo di lettura d’elezione per le donne, vere fucine di lettori, i cui effetti ancora oggi si colgono nelle realtà di pubblica lettura a Ravenna; a lei l’edizione 2013 di “Libriste” ha dedicato il lavoro di Roberto Gianinetti, un’installazione appositamente realizzata, comprendente fra l’altro il libro d’artista Abbecediario popolare e un inedito ex libris di Maria Ponti. Si allude alla contessa ravennate Teresa Gamba Guiccioli, raccoglitrice di memorie amorose su carta, con il suo vero e proprio libro-oggetto La Corinna o l’Italia di Madame de Staël, su cui l’amato Byron vergò una delle prime lettere, rilegato in velluto rosa e conservato in un improbabile e struggente scrigno di pesante metallo. Più lontana ancora, e incerta, Maria Stuarda, con il libro d’ore che forse accompagnò le sue devozioni attraverso tragiche vicende biografiche, e che ora si trova fra i manoscritti della Classense. Infine, le poche memorie di monache-lettrici, o più spesso oranti, sopravvissute solo nelle scarne note di possesso femminili dei libri della Classense. Questo è quanto rimane dei libri delle donne di una conventuale e papalina Ravenna, dall’antico regime all’Unità d’Italia. Ma anche il secolo appena trascorso non si è sottratto a questa rimozione di genere. È in questa desolante cornice di annullamento e perdita di memoria che si sono andate collocando le opere delle “libriste”, queste vive espressioni del percorso realizzato da donne che hanno voluto essere lavorando sul libro, attraverso il libro, che sia di poesia visiva o grafica d’arte, unico o seriale. La loro riflessione di genere, la memoria di sé stesse e la costante ricerca, divengono tanto più significative nella contiguità con i libri “eccellenti” della Classense, a segnalare forse un estremo esito, e sicuramente una rivalsa. 27 28 Biblioteche e archivi Certo in biblioteca regna sovrano l’ordine sequenziale: dei caratteri sulle pagine, manoscritte o a stampa, delle pagine nel libro, dei libri sugli scaffali, e poi degli armadi e delle sale, dove, sopra tutto, l’ordine del bibliotecario allinea e numerizza, per “materia”, per “formato”. In questo poderoso sistema, in questa langue bibliotecaria, anche il libro d’artista ha un suo luogo: 702.81 nella classificazione decimale Dewey. Il sistema classificatorio dei libri ha già previsto la collocazione della destrutturazione dei libri, all’interno delle “arti decorative”. In ossequio a questo “dover essere” biblioteconomico – ma non senza auspicare un creativo sovvertimento dell’“ordine dei libri” analogo al sovvertimento che il libro d’artista realizza – in Classense si sono voluti affrontare, con maggiore consapevolezza, i problemi legati alla conservazione e al trattamento catalografico del libro d’artista: un passaggio di testimone, questo, da altre e maggiori biblioteche, ormai costrette ad abbandonare il trattamento di queste collezioni “di nicchia”. Il tema è stato pertanto proposto l’8 marzo 2013, in una giornata di studio dedicata alla catalogazione del libro d’artista, in cui sono intervenuti Rosaria Campioni, Claudia Giuliani, Annalisa Rimmaudo, Carla Barbieri, Mara Sorrentino, Melania Gazzotto, Fausta Squatriti, Fernanda Fedi e Gino Gini. Al di là della definizione del libro d’artista – tema caro agli artisti stessi e vivacemente dibattuto anche in questa sede – gli intervenuti hanno riproposto l’urgenza di “riconoscere” il libro d’artista nelle collezioni storiche, per ottenerne la salvaguardia e la valorizzazione, che è quanto in questa mostra si è riusciti a fare con il recupero e l’esposizione delle storiche antologie Geiger e della rivista “Tam Tam”. Ed è in questa chiave che oggi procedono anche la riflessione sulla catalogazione informatica e l’attivazione, nel Servizio bibliotecario nazionale, di un codice di genere per il riconoscimento del libro d’artista. Nota (1) “Libriste alla Classense”, Ravenna, Biblioteca Classense, 9 marzo - 27 aprile 2013. Catalogo: Libriste alla Classense 2013, a cura di D. Silvestroni, M. Sorrentino, C. Giuliani, introduzione di A. De Pirro, Ravenna, Istituzione Biblioteca Classense, 2013, stampato in 150 esemplari. [“IBC”, XXI, 2, aprile/giugno 2013] Grazie all’accordo tra l’Archivio di Stato bolognese e la Regione Emilia-Romagna, è on line una prima consistente tranche dei fascicoli processuali relativi alle stragi del treno Italicus e della stazione di Bologna. Accedere per ricordare Elisabetta Arioti, Gabriele Bezzi La documentazione giudiziaria è sempre stata oggetto di grande interesse da parte dei ricercatori, non solo perché documenta con dovizia di particolari vicende processuali che ebbero nel passato grande risonanza, ma perché costituisce una fonte rilevante per comprendere aspetti fondamentali, sia sociali che politici, dell’evoluzione storica di una comunità. A Bologna la documentazione delle diverse magistrature giudicanti succedutesi nei secoli si trova raccolta presso l’Archivio di Stato, in quanto esso è l’istituto culturale che svolge il compito di conservare la documentazione prodotta dagli uffici statali presenti in città, e quindi anche quella giudiziaria. Quest’ultima raggiunge dimensioni davvero imponenti, in quanto per una serie di felici circostanze l’Archivio di Stato, istituito nel 1874, ha potuto concentrare presso di sé gli atti prodotti dai tribunali cittadini fin dall’età medioevale, con una continuità quasi ininterrotta, il che lo rende, sotto questo profilo, uno dei più interessanti nel panorama nazionale. Purtroppo, però, con il passare del tempo, a causa di problemi di spazio dei depositi, il regolare flusso di documentazione dagli uffici giudiziari all’Archivio si è rallentato e quindi la documentazione del Tribunale si arresta ai primi anni del Novecento, mentre quella della Corte di assise arriva fino al 1971. Ciò ha dato origine a molti inconvenienti, venuti alla luce in occasione del recente trasferimento del Tribunale dalla vecchia alla nuova sede di Palazzo Pizzardi. La necessità di riorganizzare la grande mole di documentazione che si era venuta disordinatamente accumulando negli anni ha reso necessario l’avvio di un complesso intervento di censimento, di scarto e di trasferimento, che ha consentito di concentrare la documentazione più antica presso un deposito ben attrezzato messo a disposizione dal Comune di Bologna. In questo contesto è maturata la convinzione della necessità di trasferire presso l’Archivio di Stato, per meglio tutelarli e renderli maggiormente fruibili in attesa di poter effettuare l’intero trasferimento della documentazione destinata a conservazione permanente, almeno gli atti dei processi di sicura e intensa valenza storica, come 30 Biblioteche e archivi quelli relativi a stragi e a episodi di terrorismo che si sono celebrati innanzi alla Corte di assise di Bologna negli ultimi 40 anni. L’idea è stata sviluppata anche sull’esempio dell’attività del Centro di documentazione “Archivio Flamigni”, che a partire dal 2005 ha promosso la costituzione della “Rete degli archivi per non dimenticare”. Questa rete coinvolge, da una parte, numerosi centri di documentazione, associazioni e archivi privati che hanno lavorato e stanno lavorando per conservare e tramandare la memoria storica sugli episodi di terrorismo, violenza politica e criminalità organizzata che hanno tristemente connotato il nostro paese nel secondo dopoguerra, dall’altra gli istituti archivistici statali, centrali e periferici, destinatari della documentazione giudiziaria che riguarda questi episodi. Il primo Archivio di Stato a essere coinvolto dalla Rete è stato quello di Viterbo, dove si conservano gli atti del processo sulla strage di Portella della Ginestra. In seguito se ne sono aggiunti altri, prima singolarmente e poi sotto il coordinamento della Direzione generale per gli archivi, la quale, nel dicembre del 2010, ufficializzava l’avvio di una collaborazione con il Centro di documentazione “Archivio Flamigni”. Il primo risultato di questa intesa ha portato a realizzare, all’interno del Sistema archivistico nazionale (SAN), il portale “Rete degli archivi per non dimenticare”, inaugurato il 9 maggio 2011, nel corso della cerimonia del Giorno della memoria svoltasi al Quirinale (www.memoria.san.beniculturali.it/web/memoria/home.). Sollecitati da questa iniziativa e dall’esempio di altri archivi di Stato, in particolare quello di Milano, che ha accolto in versamento anticipato i fascicoli processuali relativi ai processi sulla strage di Piazza Fontana e sull’attentato alla Questura di Milano del 1973, il Tribunale, la Corte di assise e l’Archivio di Stato di Bologna hanno sottoscritto, il 6 dicembre 2011, un accordo per il versamento anticipato di 18 fascicoli processuali posteriori al 1971, per un totale di 1018 faldoni, riguardanti alcuni dei più noti e gravi episodi di terrorismo degli ultimi decenni del secolo scorso. Particolarmente significativi, sia per dimensione che per rilevanza storica, sono quelli relativi all’attentato al treno Italicus del 4 agosto 1974 e alla strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Questo materiale verrà quindi anticipatamente trasferito presso l’Archivio di Stato di Bologna e reso consultabile, nel rispetto delle particolari procedure concordate con il Tribunale e la Corte di assise, necessarie per la protezione dei dati sensibili e sensibilissimi contenuti nelle carte processuali. Al versamento anticipato si associa quello che costituisce uno dei punti qualificanti delle iniziative promosse dalla “Rete degli archivi per non dimenticare”: la riproduzione digitale. Il primo esperimento di digitalizzazione integrale, in questo ambito, ha interessato nel 2006 il fascicolo processuale relativo alla strage di Piazza della Loggia di Brescia ed è stato effettuato in occasione dell’avvio di una nuova istruttoria, su iniziativa dell’Associazione dei familiari delle vittime di quell’episodio di terrorismo, insieme alla “Casa della memoria” di Brescia e grazie al finanziamento degli enti locali. I risultati ottenuti in quella sede hanno reso auspicabile che ogni versamento anticipato IBC 2013 sia accompagnato da un intervento di digitalizzazione, quello che Benedetta Tobagi definisce una buona pratica di “democrazia digitale”.1 L’esperienza, di grande importanza culturale, è stata quindi ripetuta per gli atti dei processi per le stragi di Piazza Fontana celebrati sia a Milano che a Catanzaro, e per l’attentato alla Questura di Milano del 1973. In questi casi la digitalizzazione può effettivamente ottenere il duplice risultato di una migliore conservazione e di un migliore accesso alle fonti. Anche a Bologna questa buona pratica si sta ora realizzando grazie all’intervento di numerosi soggetti pubblici e privati. In modo particolare è risultato determinante, in questo contesto, l’intervento della Regione Emilia-Romagna, attraverso l’Assessorato alla cultura e l’Istituto per i beni culturali, tramite la sua struttura dedicata alla conservazione degli oggetti digitali prodotti dalla pubblica amministrazione: il Polo archivistico regionale (ParER).2 Il ParER ha affiancato l’Archivio di Stato nella supervisione tecnica dei lavori e si è impegnato non soltanto a fornire gli strumenti per velocizzare l’attività di digitalizzazione e assicurare successivamente la corretta conservazione dei file digitali presso le sue strutture, ma anche a far predisporre un sistema di accesso per la consultazione della documentazione digitalizzata, che sarà reso disponibile presso l’Archivio di Stato di Bologna. Alla buona riuscita del progetto collaborano inoltre l’Associazione vittime della strage di Bologna, l’Archivio “Casa della Memoria”, il Centro documentazione “Archivio Flamigni”, mentre le attività di digitalizzazione sono compiute da volontari dell’AUSER, l’associazione di volontariato da sempre vicina e attiva sui progetti di miglioramento del servizio reso dagli uffici giudiziari. Si tratta di un intervento notevolmente lungo e complesso, a causa dell’estrema varietà dei formati cartacei presenti nei voluminosi fascicoli penali e della necessità di una scrupolosa conservazione e fedele riproduzione di tutti gli atti originali. A poco più di un anno e mezzo dalla sottoscrizione della relativa convenzione, sono stati comunque completati la digitalizzazione e il versamento di uno dei fascicoli più consistenti dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo, quello del processo cosiddetto “Italicus bis”, frutto dell’unificazione delle inchieste sulle stragi del 2 agosto alla stazione di Bologna e dell’Italicus per azioni di depistaggio. La consistenza complessiva del fascicolo è infatti di 291 unità archivistiche di conservazione: precisamente 290 faldoni, denominati “volumi”, e 1 registro, corrispondenti a circa duecentocinquantamila immagini di pagine digitalizzate. Gli atti del processo, che si svolge presso la Prima sezione della Corte di assise di Bologna ed è iscritto al Registro generale (vecchio rito) con il numero 1 del 1996, comprendono a partire dal 1982 le indagini del Pubblico ministero (iscritto al Registro generale del Pubblico ministero numero 1251 del 1982), dal 1984 al 1998 gli atti della fase istruttoria (iscritto al Registro generale del Giudice istruttore numero 1329 del 1984), e terminano con il dibattimento che si protrasse dal 24 novembre 1998 al 9 giugno 2000. Infine, negli ultimi due volumi (273 e 273 bis) sono compresi anche atti del processo d’appello, iscritto alla Corte di assise di appello di Bologna con il numero 18 31 32 Biblioteche e archivi del 2001. Parte della documentazione è in copia: copie di atti dei processi sulla strage di Bologna (dal 1980) e sull’attentato al treno Italicus (dal 1974). Per ogni unità archivistica di conservazione è stato prodotto un file in formato PDF, opportunamente processato con tecniche di Optical character recognition, costituito dalle immagini digitali di tutti gli elementi del faldone a partire dal dorso dello stesso, che riporta la denominazione del processo, un titolo sommario relativo al contenuto e il numero di sequenza del “volume”, per poi proseguire con tutti i documenti contenuti, riprodotti in ogni parte all’interno delle loro aggregazioni originarie. Questi file sono stati formalmente consegnati all’Archivio di Stato a corredo delle unità archivistiche di conservazione progressivamente trasferite, e successivamente acquisiti da parte del ParER, che provvede a garantirne la corretta conservazione nel suo sistema di conservazione e all’inserimento nel sistema di consultazione appositamente predisposto per fornire funzionalità di ricerca e riproduzione dei documenti digitalizzati. Il sistema di consultazione permette infatti di effettuare sia una navigazione nelle unità archivistiche digitalizzate, sia ricerche testuali sulla totalità delle immagini, consentendo quindi con un’unica ricerca di ottenere risultati provenienti da diverse unità archivistiche di conservazione, o meglio dai diversi file PDF di immagini digitali.3 Dal settembre del 2013, quindi, il fascicolo processuale sarà consultabile presso l’Archivio di Stato secondo la procedura prevista dall’articolo 122 comma 2 del Decreto legislativo 42/2004, ossia in base a singole istanze di accesso valutate dal presidente della Corte di assise di Bologna. La consultazione avverrà in primo luogo sulla riproduzione digitale, scorrendo direttamente i singoli file oppure utilizzando il sistema di ricerca, che all’interno di una così ampia base documentale (stimabile, a fine progetto, in oltre un milione di singole immagini) consentirà un approccio facilitato al reperimento di informazioni. Questa soluzione tecnologica potrebbe inoltre essere estesa ad altre fonti all’interno della Rete nazionale degli archivi per non dimenticare, in quanto il sistema di ricerca elaborato a Bologna, già in parte discusso con altri soggetti aderenti alla Rete, soprattutto la “Casa della memoria” di Brescia e l’Associazione vittime della strage di Bologna, si pone l’obiettivo di rendere accessibile in tempi ragionevoli una mole di documentazione estremamente ingente, senza però trascurare la corretta contestualizzazione archivistica, in mancanza della quale le informazioni che si presume di ottenere rischiano di diventare manchevoli se non addirittura fuorvianti. Anche se per ragioni di speditezza si è preferito non ricorrere per la descrizione archivistica ai normali applicativi, che avrebbero comportato un impegno troppo lungo e gravoso, ma si è scelto di puntare direttamente alle immagini del materiale documentario riprodotto attraverso un sistema di ricerca full text, non si è però rinunciato a riprodurre i nessi che legano fra loro le singole carte, e in questo sicuramente sta il maggiore interesse dell’esperimento in corso. Si tratta insomma di un approccio innovativo alla documentazione contemporanea, in grado di produrre strumenti di ricerca che non possono definirsi veri e propri inventari ma che nello stesso tempo non si limitano a riprodurre in modo piatto e mo- IBC 2013 nodimensionale una sequenza di immagini, ma garantiscono la corretta collocazione delle stesse all’interno della specifica sedimentazione della documentazione. Il progetto di completa digitalizzazione dei fascicoli processuali concernenti i fatti di terrorismo e stragismo giudicati dalla Corte di assise di Bologna è stato sviluppato nella consapevolezza che, come è scritto nella “Dichiarazione universale sugli Archivi” approvata dall’UNESCO: “L’accesso agli archivi arricchisce la nostra conoscenza della società umana, promuove la democrazia, tutela i diritti dei cittadini e migliora la qualità della vita”. Soprattutto di fronte a documentazione di tale rilevanza bisogna impegnarsi, come sottolinea la stessa “Dichiarazione universale”, affinché gli archivi siano resi accessibili a tutti, nel rispetto delle leggi in vigore e dei diritti degli individui, e siano utilizzati per contribuire alla crescita di una cittadinanza responsabile. Note (1) Rete degli archivi per non dimenticare. Guida alle fonti per una storia ancora da scrivere, a cura di I. Moroni, Roma, ICPAL, 2010, p. 28. (2) Per informazioni sul ParER: ibc.regione.emilia-romagna.it/istituto/chi-siamo/polo-archivistico-regionale-parer; parer.ibc.regione.emilia-romagna.it. (3) Il sistema di consultazione si basa sull’applicazione xPDFindER, sviluppata per conto dell’IBC da 3D Informatica, che si basa anzitutto sulla scelta di uitilizzare l’XML come formato per contenere le informazioni testuali riconosciute nei documenti digitalizzati. [“IBC”, XXI, 3, luglio/settembre 2013] 33 Gli archivi raccontano come e perché, durante il ventennio fascista, la scuola italiana propagandò l’idea che la guerra fosse una condizione naturale, inevitabile, persino positiva, della vita nazionale e dei rapporti tra nazioni. Una cattiva educazione Gianluca Gabrielli Il 9 maggio 2013, a Bologna, nell’ambito di “Quante storie nella Storia - XII Settimana della didattica in archivio”, si è tenuto un seminario di studio sulla funzione propagandistica svolta dalla scuola italiana a favore della guerra durante il ventennio fascista. Il seminario, “Echi di guerre a scuola”, è stato promosso dalla Soprintendenza archivistica per l’Emilia-Romagna, dalla Soprintendenza per i beni librari e documentari della Regione Emilia-Romagna e dalla sezione regionale dell’Associazione nazionale archivistica italiana, in collaborazione con il Centro italiano di documentazione sulla cooperazione e l’economia sociale. Pubblichiamo una sintesi dell’intervento di Gianluca Gabrielli, dottorando in Storia dell’educazione all’Università di Macerata. Enzo Traverso ha definito gli anni che vanno dal 1914 al 1945 come l’epoca di una “guerra civile europea” che ha “profondamente modellato le mentalità, le idee, le rappresentazioni e le pratiche dei suoi protagonisti”. Non si fa fatica a cercare la conferma di questa affermazione; infatti le dimensioni inedite e drammatiche assunte dalle due guerre mondiali presero alla sprovvista le stesse gerarchie politiche e militari preposte alla preparazione e conduzione del conflitto. La partecipazione alla guerra, che fino ad allora era rimasta in gran parte appannaggio degli “specialisti” militari e confinata alla linea del fronte, si estese come mai in precedenza, arrivando a coinvolgere le intere popolazioni dei paesi belligeranti (i civili oltre ai combattenti, la produzione oltre alle forze armate), rendendo così di importanza strategica anche la mobilitazione del fronte interno. Le nuove tecnologie impiegate, dotate di potenza distruttiva incomparabilmente superiore rispetto al passato, produssero laceranti sconvolgimenti nella vita degli individui e delle società europee e trasformarono potentemente le modalità della partecipazione degli uomini al conflitto, convertiti sempre più in appendici dei sistemi d’arma e sempre più annullati nella manifestazione del valore individuale. In questo contesto in Italia, nel 1922, prese il potere il fascismo, che si affermò presto come una dittatura liberticida e proiettata verso una politica di espansionismo imperialista. Il regime considerava l’esperienza della Prima guerra mondiale come parte fon- IBC 2013 dante della propria identità e si impose presentandosi come movimento rigeneratore della nazione anche attraverso l’esaltazione del bellicismo e tramite la militarizzazione di settori importanti della vita pubblica. In Italia, quindi, questa prima parte del secolo dalle forti accentuazioni belliciste trovò un interprete politico che, giunto al potere, ne incarnò in gran parte le istanze e fece di tutto per accentuarne i toni. Durante il ventennio fascista, così, numerosi elementi del contesto politico contribuirono a rafforzare in Italia l’idea che la guerra rappresentasse una condizione naturale, fondamentalmente positiva, o comunque inevitabile, della vita nazionale e dei rapporti tra le nazioni. Già l’affermazione del regime era stata tributaria dell’uso sistematico della violenza delle squadre fasciste contro gli avversari politici; l’organizzazione dello squadrismo sulle suggestioni del corpo d’assalto degli “Arditi” attivo durante la Prima guerra mondiale trasferì le modalità di combattimento spietato dalle trincee alle vie cittadine, rivolgendole contro i “nemici interni” incarnati dagli avversari politici e sindacali e dagli oppositori del regime, facendo della violenza politica il caposaldo dell’idea di rigenerazione patriottica. Esauritasi la fase squadrista, intervenne poi la costituzione stessa del regime a esaltare e finalizzare alla guerra gran parte della politica nazionale; basti pensare alla campagna di crescita demografica e di sostegno alla maternità condotta non per tutelare madri e bambini, bensì in funzione di un accrescimento della potenza militare e imperialistica della nazione (nel 1927 Mussolini afferma: “Pregiudiziale della potenza politica, e quindi economica e morale delle Nazioni, è la loro potenza demografica”). A conferma di questo progetto inoltre, fin dalle operazioni militari in Libia negli anni Venti e poi soprattutto dalla conquista dell’Etiopia nel 1935-1936, la politica estera bellicista e revisionista contribuì fortemente a sconvolgere i fragili equilibri internazionali e a condurre l’Europa alla catastrofe della Seconda guerra mondiale. Su questo sfondo il regime operò per riorganizzare il sistema educativo nazionale al fine di renderlo funzionale ai nuovi “destini imperiali”. Non si trattava cioè semplicemente di potenziare l’esaltazione patriottica di matrice risorgimentale che aveva accompagnato la prima fase di costruzione dell’identità nazionale, tra l’Unità e la Prima guerra mondiale. In questo nuovo contesto, per il regime si trattava di costruire un “italiano nuovo”, curandone e controllandone l’educazione fin dalla tenera età, in modo che maturasse in sé un’immagine positiva della guerra come affermazione non degli individui ma della collettività subordinata al duce, realizzando i destini della nazione e coltivando la potenza fisica, morale e in un certo senso biologica della stirpe. Per raggiungere questi fini non era più possibile operare la trasformazione solamente all’interno dei canali tradizionali – che pure furono usati – come la riscrittura dei programmi e dei libri di testo. Si trattava di una trasformazione più ampia, che non poteva che coinvolgere la stessa struttura organizzativa dell’educazione nazionale al fine di ottenere una piena militarizzazione dell’infanzia. L’intervento in questa direzione fu particolarmente precoce. Già all’indomani della marcia su Roma fu nominato sottosegretario all’Istruzione Dario Lupi, fascista militante, che, attraverso un fitto e oculato lavoro di circolari, promosse numerosi interventi di cam- 35 36 Biblioteche e archivi biamento nella vita quotidiana della scuola, molti dei quali orientati proprio al rafforzamento delle ritualità relative al ricordo della Grande guerra e alla sua fascistizzazione. Fu lui che istituì i “parchi della rimembranza”, giardini cittadini in cui piantare alberi destinati ognuno a ricordare un caduto del primo conflitto mondiale; Lupi riuscì a innestare un culto sacralizzante sull’enorme quantità di lutti che attraversavano tante famiglie italiane; questa nuova forma di religiosità politica coinvolgeva le scolaresche di tutta Italia, attraverso la gara a essere nominati a far parte della guardia d’onore, riservata agli alunni maschi più meritevoli. In breve tempo questa commemorazione incluse tra i nomi dei martiri celebrati anche i “caduti della rivoluzione fascista”, cioè gli squadristi morti nel contesto degli scontri del periodo 1919-1922. Le scuole, quindi, divenivano le custodi del culto dei martiri della Grande guerra e della rivoluzione fascista, e inauguravano una ventennale presenza organizzata nelle piazze, reiterata secondo il calendario politico del fascismo e volta a mostrare l’obbedienza disciplinata dei corpi degli scolari al progetto totalitario. Un secondo elemento cruciale fu l’istituzione dell’organizzazione giovanile del regime, l’“ONB - Opera Nazionale Balilla” (poi “GIL - Gioventù Italiana del Littorio”), che affiancò e allargò l’ambito di competenze della scuola costituendone allo stesso tempo la palestra e la caserma. Se la scuola tout court non poteva venire trasformata in caserma, era però possibile, mutando di segno le esperienze laiche e religiose dei boy scout, istituire una “caserma” collegata all’istituzione scolastica e finalizzata alla gestione del tempo libero e dell’attività fisica delle giovani generazioni: all’ONB fu infatti affidata l’educazione fisica degli alunni, fortemente orientata verso le forme della preparazione premilitare. Le esercitazioni sportive si alternavano agli schieramenti e alle marce coreografiche in cui i bambini e le bambine dovevano dare prova della propria obbedienza disciplinata agli ordini degli educatori o dei capisquadra. Le iniziative pubbliche del regime erano il momento in cui questa preparazione trovava la propria realizzazione pubblica. La divisa, tipica dell’istituzione militare, era uno dei cardini della frequentazione dell’Opera Nazionale Balilla, codificata e obbligatoria nelle pubbliche celebrazioni. L’altro oggetto fondamentale di questa appendice della vita scolastica era il moschetto, fucile in dotazione ai fanti della Prima guerra mondiale, che costituiva lo strumento per eccellenza della preparazione degli allievi più grandi; per i piccoli esistevano le riproduzioni in legno, quasi un’istituzionalizzazione del gioco della guerra all’interno di una grande caserma parascolastica gestita direttamente dal regime. A queste attività partecipavano anche le bambine, le cosiddette “piccole italiane”; anch’esse erano dotate di una divisa e prendevano parte alle medesime coreografie, ma il modello educativo a cui erano indirizzate era quello ritenuto tipico del genere femminile, in funzione non certo militare, semmai materna e di supporto dei ruoli maschili: come madri e infermiere. Comune ai maschi e alle femmine era il contenuto educativo fondamentale dell’organizzazione balillistica: lo spirito gerarchico e l’esaltazione dell’obbedienza cieca ai superiori. Se la caserma, infatti, storicamente assolveva il ruolo di agenzia specializzata all’“obbedir tacendo”, solamente l’ONB, con i suoi capi selezionati tra i militanti fascisti più convinti, poteva trasmettere alle giovani generazioni l’esaltazione di questo annulla- IBC 2013 mento individuale nel gruppo e nella subordinazione gerarchica verso un capo (e, per successive mediazioni, verso Mussolini, capo supremo). Mentre la “caserma” dell’Opera Nazionale Balilla operava parallelamente alla scuola, con finalità più dirette ed esplicite, la scuola stessa a sua volta si sarebbe trasformata integrando progressivamente, nei propri testi e programmi didattici, gli elementi dell’ideologia fascista, e tra essi coltivando il militarismo e il bellicismo. Nell’anno scolastico 1934-1935, per esempio, prima della guerra di invasione dell’Etiopia, fu introdotta una nuova materia di studio, la “Cultura militare”, per l’ultimo anno delle scuole medie inferiori e per i primi due delle superiori. Veniva insegnata per 20-30 ore annuali da ufficiali attivi o della riserva e costituiva il curricolo di formazione teorica su temi come le forze armate, la cartografia, le armi e il tiro, le caratteristiche della guerra antica e moderna. Riservata esclusivamente ai maschi, era finalizzata a elevare la preparazione del cittadino-soldato e a diffondere una disposizione morale alla vita militare e al combattimento. Oltre alla materia specifica, però, la cultura bellica penetrò anche in modo indiretto nei curricoli delle più disparate materie di studio. Non solo l’italiano, le letture, la storia, ma addirittura la matematica. Per esempio, nel sussidiario di Bonomi del 1941, tra i numeri che si invitano i bambini a trascrivere in cifre si trova: “milleundici, furono le mitragliatrici catturate al nemico durante la vittoriosa guerra italo-etiopica”; tra gli oggetti da misurare troviamo il “moschetto Balilla”; tra i problemi inclusi nel sussidiario di Armando dello stesso anno troviamo: “un proiettile tra i più piccoli per cannoni di medio calibro ha il raggio della base di millimetri 105. Quanti centimetri è la circonferenza?”. Non si trattava quindi solamente di “insegnare” la perizia bellica, aspetto pure ritenuto importante, ma di infondere uno spirito generale, in modo che la guerra e i suoi strumenti fossero percepiti come naturali attività dell’uomo. Proprio in questo senso vanno lette le esemplificazioni matematiche di questo spirito bellicista: non solo forzature ideologiche, ma espressioni ormai ordinarie di una quotidianità scolastica che andava introiettando la naturalezza della guerra. Si trattò di un caso unico in Europa nella sua pervasività e nella potenza dispiegata, paragonabile solamente a quello espresso dalla Germania nazista. Solo analizzando approfonditamente la dimensione educativa di questa trasformazione antropologica degli italiani si può comprendere la “disponibilità” della popolazione alla mobilitazione bellica senza precedenti che coinvolse la popolazione italiana dal 1935, senza interruzione, fino alla catastrofe della Seconda guerra mondiale. Bibliografia E. Traverso, A ferro e fuoco. La guerra civile europea 1914-1945, Bologna, il Mulino, 2007. A. Gibelli, Il popolo bambino. Infanzia e nazione dalla Grande Guerra a Salò, Torino, Einaudi, 2005. La scuola fascista. Istituzioni, parole d’ordine e luoghi dell’immaginario, a cura di G. Gabrielli e D. Montino, Verona, Ombre corte, 2009. [“IBC”, XXI, 3, luglio/settembre 2013] 37 C ultura popolare Fotografie di Marco Pesaresi Il primo numero di “IBC” pubblicato on line nel 2013 ha proposto una piccola selezione del vastissimo fondo che raccoglie le fotografie di Marco Pesaresi conservate dall’ICS - Istituzione Cultura Savignano di Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena). Grazie alla generosità di Isa Perazzini, madre del fotografo, e alla collaborazione di Giuseppe Pazzaglia nella ricerca d’archivio e nella contestualizzazione delle immagini, è stato possibile rendere omaggio al lavoro di un autore di grande talento, scomparso troppo presto. Nato a Rimini nel 1964, all’inizio degli anni Novanta Pesaresi entra a far parte della prestigiosa agenzia fotografica Contrasto. Viaggia per il mondo, concentrando il suo sguardo sui fenomeni più drammatici della vita sociale: immigrazione, tossicodipendenza, emarginazione. Tra i suoi progetti editoriali più importanti vanno citati Underground, una ricognizione sulla vita delle metropolitane in dieci città del mondo, e Megastores, realizzato tra Giappone, Stati Uniti e Russia per documentare i riti del consumismo. L’ultimo reportage, Rimini, uno struggente ritratto in bianco e nero della sua città natale, è stato pubblicato nel 2003, due anni dopo la sua morte. Le sue fotografie sono state pubblicate sulle principali testate nazionali e internazionali, tra cui “Panorama”, “Espresso”, “Geo”, “El País”, “The Independent”, “The Observer”. Le immagini proposte su “IBC” fanno parte di un grande progetto incompiuto, che Marco Pesaresi aveva provvisoriamente intitolato Cultura popolare. Migliaia di negativi ritraggono le feste, i riti e gli appuntamenti collettivi che costellano la vita della gente romagnola, facendo convivere insieme le tradizioni antiche e le consuetudini recenti, la devozione e la trasgressione, il sacro e il profano. Per approfondire si veda, nelle pagine di questo volume, l’articolo di Paola Sobrero pubblicato nel numero 1-2013 della rivista “IBC”. 40 Cultura popolare Processione del Venerdì Santo a Montefiore Conca (Rimini) fotografia di Marco Pesaresi IBC 2013 Processione del Venerdì Santo a Montefiore Conca (Rimini) fotografia di Marco Pesaresi 41 42 Cultura popolare Processione del Venerdì Santo a Montefiore Conca (Rimini) fotografia di Marco Pesaresi IBC 2013 Benedizione del mare e processione per la Madonna del Carmine a Torre Pedrera (Rimini) fotografia di Marco Pesaresi 43 44 Cultura popolare Benedizione del mare e processione per la Madonna del Carmine a Torre Pedrera (Rimini) fotografia di Marco Pesaresi IBC 2013 I Pasquaroli, il Vecchio e la Vecchia a Igea Marina (Rimini) fotografia di Marco Pesaresi 45 46 Cultura popolare I Pasquaroli e la Vecchia a Igea Marina (Rimini) fotografia di Marco Pesaresi IBC 2013 I Pasquaroli a Igea Marina (Rimini) fotografia di Marco Pesaresi 47 48 Cultura popolare Fuochi di San Giuseppe a Torre Pedrera (Rimini) fotografia di Marco Pesaresi IBC 2013 Fuochi di San Giuseppe a Torre Pedrera (Rimini) fotografia di Marco Pesaresi 49 50 Cultura popolare Fuochi di San Giuseppe a Torre Pedrera (Rimini) fotografia di Marco Pesaresi IBC 2013 Carnevale a Cerreto, Saludecio (Rimini) fotografia di Marco Pesaresi 51 52 Cultura popolare Carnevale a Cerreto, Saludecio (Rimini) fotografia di Marco Pesaresi IBC 2013 Festa popolare nel Riminese fotografia di Marco Pesaresi 53 M usei e beni culturali Dai “volti dell’ospite” ai 2200 anni della Via Emilia: l’edizione 2013 del “Festival del Mondo antico” di Rimini prosegue nell’esplorazione del presente con lo sguardo sull’antichità. Siamo tutti ospiti Valeria Cicala Nel 2012, a Rimini, per la quattordicesima edizione di “Antico/Presente. Festival del Mondo antico”, il tema individuato è stato “Hospes-Hostis: i volti dell’ospite”, un argomento dalle più svariate chiavi di lettura, perché, muovendo da una parola che ha la stessa radice, si giunge a significati e concezioni opposti: l’ospite diviene il nemico, l’ospitalità trascolora in ostilità. Un’ambivalenza delle situazioni e degli stati d’animo, un capovolgimento totale di sentimenti e rapporti su cui si possono articolare i percorsi più svariati, dalla letteratura alla storia, dalla filosofia alla psicoanalisi, dalla sociologia alla religione. L’Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-Romagna (IBC) è da sempre parte di questo progetto riminese, oramai radicato sul territorio. Nel 2007 aveva commissionato a Peppino Ortoleva, docente di Teoria e storia dei media all’Università di Torino, un’indagine per verificare che tipo di partecipazione suscitasse il festival, quali fossero le sue ricadute sul territorio e le potenzialità ancora inespresse.1 L’anno scorso, durante i tre giorni di incontri e dibattiti – che richiamano artisti e studiosi di differenti discipline, e comprendono una sezione dedicata ai bambini: “Piccolo mondo antico” – l’Istituto ha proposto una tavola rotonda dal titolo “Ospitiamo la cultura” per trattare il tema del patrimonio culturale quale risorsa e opportunità di incontro e di conoscenza, ma anche di sviluppo e di crescita economica. A Rimini l’ospitalità, la buona ospitalità, è alla base di un turismo prevalentemente balneare, nonostante la poliversa realtà storico-artistica che la connota e che si sta accreditando di anno in anno, grazie al sistematico impegno di chi opera nelle istituzioni pubbliche. Ci è sembrato opportuno proporre in questo contesto alcune riflessioni sul tema complessivo del turismo culturale, mettendole in relazione concreta con esempi di azioni realizzate sul territorio regionale. La finalità era quella di offrire delle esemplificazioni che, in qualche misura, ribadissero un messaggio che sta alla base stessa del lavoro quotidianamente svolto da chi opera nello straordinario e contraddittorio universo dei beni culturali. Creare eventi e potenziare luoghi di aggregazione nel segno della conoscenza, della ricerca scientifica, di un’educazione sistematica, è un modo per vivere meglio la propria realtà, ma 56 musei e beni culturali anche per riflettere sui possibili nuovi modelli di sviluppo che proprio un tempo di crisi e di recessione richiede. Si tratta di un percorso che può coniugarsi con una prospettiva di economia etica, attenta ai valori, improntata a quella di cui da sempre parla uno studioso come Amartya Sen. Non bastano gli slogan efficaci e le parole d’ordine. Certamente mantengono viva l’attenzione iniziative come il “Manifesto” del “Sole 24 Ore” e i tanti dibattiti dove si ascoltano esperti e c’è un pubblico qualificato. Forse troppo, forse è la trasversalità che manca! Guardando stuoli di turisti muniti di macchine e cineprese digitali, infatti, succede di avere la sensazione che la maggiore opportunità di viaggiare, di andare in vacanza, non corrisponda sempre alla capacità di gustare un paesaggio fisico e umano. La vertigine creata dalla bellezza sembra essere meno frequente e si riduce sempre più a una reminiscenza letteraria. Restando nell’orizzonte regionale, si avverte poca curiosità per le storie urbane e per le loro a volte spericolate mutazioni, per il profumo della costa, per un crinale o una via d’acqua. Luoghi e percorsi sorprendenti si snodano lungo la Via Emilia, lungo le valli o risalendo gli Appennini, mete tanto vicine e mai esplorate, anche nella pigra convinzione che ci si può sempre andare. È possibile in questa stagione così globalizzata avere una discreta conoscenza, magari, dei musei dell’Austria o di quelli della Catalogna, ma ciò non implica che si siano visti i quadri di Guido Reni o di Guercino che si trovano nei musei o nelle basiliche delle nostre città. Degli stessi autori è probabile che si siano apprezzate, piuttosto, le opere conservate nelle collezioni inglesi. Proprio per restare su Rimini, sono tanti coloro che da anni frequentano la sua spiaggia, ma non hanno mai messo piede al Tempio Malatestiano, con buona pace di Sigismondo e di Leon Battista Alberti! Poi, però, ci pensa un grande graphic designer come Leonardo Sonnoli a portare in tour a Rimini, dove ha scelto di vivere, studenti e professori inglesi e americani, perché osservino le lettere incise sull’Arco di Augusto, sul Ponte di Tiberio e, in pieno Rinascimento, sull’epidermide del Tempio, per giungere infine, tenendo presente quei caratteri che in gergo tipografico si definiscono “capitale quadrata”, alla cartellonistica della pubblicità, alle insegne dei locali e degli stabilimenti balneari. A queste persone Sonnoli spiega l’evoluzione del tratto, dell’alfabeto; e come il segno interpreta il suo tempo e si riscrive, si rielabora. Dall’antichità al postmoderno la linea è continua e lo si scopre proprio mettendo in relazione, contestualizzando le esperienze. C’è un effettivo bisogno di educazione al patrimonio; e in questo senso il 2012 è stato un anno in cui, almeno sulle pagine dei giornali e sui siti web, l’attenzione scritta nei confronti dell’importanza di salvaguardare e valorizzare il patrimonio ha sempre avuto firme e voci autorevoli. Di fatto, però, in tempi di spending review, è proprio il tema delle risorse economiche a essere prepotentemente attuale: lo scorso 6 marzo, sulle pagine della “Repubblica”, Dario Pappalardo tracciava un quadro preoccupante della situazione economica della maggior parte dei musei di arte contemporanea: c’è una drastica riduzione di budget, diviene difficoltoso organizzare mostre e attività IBC 2013 didattiche, è indispensabile creare sinergie, ottimizzare la gestione dei servizi.2 In questo senso il Comune di Bologna si è già mosso con la creazione dell’Istituzione Bologna Musei; si tratta di una struttura di coordinamento che, pur nell’autonomia dei tredici istituti che ne fanno parte, razionalizza l’impiego delle risorse. Come scriveva già parecchio tempo fa Salvatore Settis, “dovremmo giocare ‘contesto’ e ‘museo’ sullo stesso tavolo, quello di un’Italia in cui il patrimonio nel suo insieme è assai più grande della somma delle sue parti. Manca però un ingrediente: un’idea dell’Italia, un progetto per la sua cultura”.3 E tali riflessioni restano sinistramente attuali. Gli interventi della giornata riminese che qui si propongono, e che l’IBC presenterà al pubblico in occasione dell’edizione 2013 del “Festival del Mondo antico”, costituiscono uno spaccato regionale confortante. A fronte di finanziamenti pubblici azzerati e di risorse private in continua contrazione, i progetti e le esperienze di cui si è parlato esprimono la consapevolezza che di crescita culturale non si può fare a meno. Una convinzione che emergeva nelle parole introduttive dell’assessore regionale alla cultura, Massimo Mezzetti, ed era ribadita dalle osservazioni di Massimo Pulini, assessore alla cultura del Comune di Rimini. Sebbene fosse trascorso meno di un mese dal terremoto che ha colpito soprattutto la parte occidentale del territorio regionale, pur nell’emergenza di interventi da destinare a chi aveva perso tutto o quasi, c’era grande apprensione anche per gli ingenti danni subìti dal patrimonio storicoartistico. Per le biblioteche e per i musei inaccessibili si esprimeva la convinzione che la ripresa non avrebbe potuto prescindere anche dal ripristino e dalla fruizione di quegli spazi e di quei luoghi. “Museums as meeting places” ben si attaglia come auspicio, non solo come slogan, alle esperienze che in queste pagine ci racconta Massimo Negri, riferendo del progetto “Genus Bononiae. Musei nella città”, che inanella in un unico percorso il nuovo Museo della storia di Bologna con altri palazzi e strade, ritrovando un linguaggio comune. Lo stesso accade con l’esperienza che propone Gianfranco Brunelli, il quale, negli straordinari spazi del San Domenico di Forlì, coniuga le grandi mostre con l’identità del territorio e delle sue istituzioni culturali; mentre Alberto Cassani scandisce i passaggi di un ambizioso progetto per fare di Ravenna la capitale europea della cultura per il 2019. Sottese a queste realtà in progress, le considerazioni di chi studia i fenomeni della storia del turismo, come fa Annunziata Berrino. A questo scenario di riflessioni era necessario abbinare immagini altrettanto eloquenti e significative della realtà in cui viviamo. Il luogo in cui si è svolto l’incontro e l’attenzione a date e anniversari significativi per la storia, in particolare quella della regione, hanno portato l’attenzione sul repertorio fotografico che Matteo Sauli ha dedicato ad alcune strade della costa, in particolare quello che propone l’attualità della Via Emilia.4 Nel 2013 si compiono i 2200 anni dalla nascita di questa strada; correva l’anno 187 avanti Cristo quando il console da cui prese il nome, Marco Emilio Lepido, la fece tracciare partendo da Rimini per giungere a Piacenza, e la prossima edizione del Festival, dal 21 al 23 giugno, sarà dedicata a questa ricorrenza. 57 58 musei e beni culturali Una strada, una regione, da sempre in un crescendo di eventi, di finalità, di suggestioni. Tutto è successo e continua a succedere su questo percorso non sempre riconoscibile, in una ballata perenne che non è solo letteratura e musica, ma soprattutto fatica e determinazione. Anche brutture paesaggistiche, cemento mal utilizzato, abbandono degradante. Le nette fotografie di Sauli si compenetrano in un libro edito nel 2012 e fatto per accomodarsi bene in un’ampia tasca o in una piccola borsa, con i caratteri della scrittura misurata e profonda, tersa e reale, di Vittorio Ferorelli.5 Nei brevi racconti, come nelle immagini, si mostra ciò che oggi è la Statale 9. Con sensibilità e ironia differente, lo sguardo dello scrittore si ferma anche sulle stesse cose che l’altro fotografa, ma poi i racconti, i resti di questa storia millenaria, possono essere proficuamente diversi. I fasti dei 2200 anni di una delle più importanti consolari d’Italia si celebra anche così, sottolineando la distanza, non solo cronologica, dalla sua primaria funzione, in quella temperie di eventi e progetti alla cui pregnanza si arrendevano anche i Monty Python del film Brian di Nazareth ammettendo che in fondo, poi, i Romani cosa mai avevano fatto? Le strade, i ponti, gli acquedotti... Note (1) Si veda in proposito il dossier: Dentro l’evento. Anatomia di una manifestazione culturale, a cura di V. Cicala e V. Ferorelli, “IBC”, XVI, 2008, 2/3, pp. 57-80. (2) D. Pappalardo, Musei in default, “la Repubblica”, 6 marzo 2013, pp. 54-55. (3) S. Settis, Perché i nostri capolavori meritano un progetto, “la Repubblica”, 22 agosto 2011, pp. 25-27. (4) Matteo Sauli, nato nel 1982, si è formato affiancando i fotografi professionisti Daniele Casadio ed Ettore Malanca e frequentando l’Accademia di belle arti. Dal 2004, anno della sua prima esposizione, ha realizzato diversi progetti fotografici, tra cui quello condotto sulla Strada Romea (“SS309”), quello sul backstage della mostra sul pittore rinascimentale Garofalo al Castello Estense di Ferrara, e la partecipazione alla campagna di rilevamento “Ritornando in Appennino”. Per questi ultimi due progetti ha collaborato con l’Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-Romagna, che nel 2008 ha dedicato alle sue immagini il fascicolo 2/3 della rivista “IBC”. Nel 2011 la Fondazione FORMA per la fotografia gli ha assegnato il primo premio nel concorso “Eccezionalità dell’ordinario” in memoria dello scrittore Giuseppe Pontiggia. (5) V. Ferorelli, M. Sauli, Al bordo della strada. Diario di viaggio sulla Statale 9 - Via Emilia, Bologna, Bononia University Press, 2012; si veda la recensione: E. Pirazzoli, La dorsale d’Emilia, “I Martedì”, 306, 2012, p. 64. Questo libro può essere considerato anche un omaggio a un grande della fotografia, Nino Migliori, e al suo straordinario volume fotografico: Crossroads. Via Emilia, Bologna, Damiani Editore, 2006. [“IBC”, XXI, 1, gennaio/marzo 2013; dossier “Ospitiamo la cultura”, a cura di Valeria Cicala] Musei e giovani: in Italia, ancora un appuntamento mancato. In Europa, invece, si affermano forme stabili di collaborazione e di dialogo. Tre casi in Olanda, Danimarca e Galles. Al prossimo incontro Sara Maccioni Chiunque si trovi a frequentare i musei, o abbia fatto del museo la propria professione, non potrà non constatare che i giovani italiani ancora oggi sono i grandi assenti fra i pubblici. Eppure hanno alle spalle una ricca esperienza dentro le sale del museo, vissuta da bambini, con la scuola o insieme alla propria famiglia: in molti conoscono questa istituzione e hanno avuto tempo per instaurare con essa un rapporto. Ci si aspetterebbe, insomma, che essa accompagni in modo naturale il piccolo visitatore in una nuova fase della sua vita, l’età giovanile. È questo invece il momento che segna il punto di rottura, l’incontro mancato. Mancato perché, potenzialmente, quell’incontro potrebbe avvenire: il museo racchiude in sé la possibilità di soddisfare le esigenze di questo che, tuttora, risulta un “non pubblico”. Ancora oggi esso può essere luogo di formazione personale, di confronto con la memoria, di ispirazione per apprendere valori civili e nuovi modi di guardare alla realtà. Un luogo che oggi può essere fonte di identificazione ma anche di svago. Un giro per i musei italiani rivela in effetti quanto l’Italia si interroghi e avanzi proposte per una didattica museale a misura di giovane, realizzando esperienze di grande qualità, che spesso però sono sporadiche, quasi mai continuative nel tempo.1 Lavorare con questo pubblico, d’altro canto, rappresenta una sfida: il museo deve saperla cogliere se intende realmente diventare inclusivo e accogliente, ma per farlo deve essere capace di riunire in sé la natura del tempio, per non dimenticare la sacralità del luogo di memoria e di bellezza, e quella del forum, immagine quanto mai attuale di uno spazio che dà voce al visitatore, alle sue esperienze e ai suoi valori, un luogo in cui creare e condividere conoscenza attraverso il confronto. Ma in che modo dar voce ai giovani dentro al museo? Il dibattito intorno alle esigenze del così ribattezzato “pubblico invisibile” si è sviluppato da tempo e, mentre in Italia si moltiplicano una pluralità di voci – che arricchiscono le riflessioni ma non danno concretezza e continuità alla strada intrapresa – il contesto internazionale si arricchisce invece di esperienze, strategie e buone pratiche che sembrano conquistare i giovani utenti, trasformandoli in pubblico museale. 60 musei e beni culturali Tre realtà meritano l’attenzione di chi intende ringiovanire l’Italia dei musei: la Galleria nazionale della Danimarca, lo Stedelijk Museum in Olanda, i Musei nazionali del Galles. Tre grandi istituzioni così diverse fra loro ma accomunate da una didattica forte e ben radicata, che ha saputo osare, raggiungendo risultati di ottima qualità. A Copenaghen, dal 2007, viene rinnovato di anno in anno lo “Unges Laboratorier For Kunst (ULK)”, letteralmente “Laboratori d’arte per i giovani”. L’idea e dunque il nome nascono dagli spazi dedicati ai laboratori didattici nei musei, di solito destinati alle attività con i bambini: “ULK” individua allora, tra le sale del museo, un luogo di cui i giovani si possano impossessare e in cui si possano riconoscere. Il progetto è rivolto ai giovani dai 15 ai 25 anni, provenienti da Copenaghen, e prevede la formazione di una comunità, di solito 15 membri, che si riunisce una volta alla settimana insieme al personale del museo per organizzare iniziative di vario tipo (www.smk.dk/ udforsk-kunsten/unges-laboratorier-ulk/). Ad Amsterdam l’idea di dar voce ai giovani dentro al museo nasce dalla tesi di laurea di Marlous Van Gastel, storica dell’arte che nel 2006 ha discusso una tesi sulla rilevanza sociale del museo oggi, in particolare nel mondo dei giovani. Prendeva vita così, a partire dal 2008, il progetto “Blikopeners”, parola traducibile come “apriscatole”. La parola blik indica la vista o la prospettiva, mentre openers letteralmente significa “coloro che aprono”: i “Blikopeners” sono allora un gruppo di giovani capaci di aprire i propri occhi e la propria mente a nuove idee e a nuovi modi di vedere e vivere il museo e l’arte, e di trasmettere all’esterno quello che hanno compreso. Il gruppo – età dai 15 ai 20 anni, proveniente da tutta Amsterdam – vive un’esperienza di circa un anno a stretto contatto con il museo, ricevendo un rimborso spese. I ragazzi riflettono su come attirare il pubblico dei loro coetanei, attraverso la formazione e l’azione sul campo, con workshop, visite guidate, eventi, progetti di comunicazione. I Musei nazionali del Galles hanno gettato le basi per la creazione di un pubblico giovanile agendo, in questo caso, sui contesti periferici, con un ambizioso progetto a cui hanno dato il nome di “On Common Ground”, “Su un terreno comune”. L’obiettivo, infatti, è far sentire i ragazzi e le ragazze coinvolti (dai 16 ai 24 anni) uniti da una stessa identità e una stessa provenienza, al di là dell’origine etnica, dello status sociale o del contesto di appartenenza. A differenza dei progetti sviluppati in Danimarca e Olanda, l’iniziativa gallese è un outreach che opera in contesti periferici e spesso disagiati ed è maggiormente articolato, suddividendosi territorialmente in 55 progetti diversi, che i gruppi di lavoro locali plasmano strada facendo in relazione alle realtà culturali presenti in loco (www.oncommonground.co.uk/home.htm). Tre realtà museali e tre proposte decisamente diverse sono la concreta dimostrazione che è il museo a poter fare la differenza nel difficile rapporto con gli adulti di domani. E mentre in Italia ancora ci si domanda dove si possano trovare i giovani e quali siano le strategie di coinvolgimento più appropriate, l’Europa dimostra che raggiungere i giovani è possibile e non è nient’affatto difficile. La Galleria nazionale della Danimarca ha agito su due fronti: il tramite della scuola e un sito web, utilizzati per informare i giovani della possibilità di entrare a far parte di “ULK” e per incrementare l’affluenza di questo pubblico nelle sale del museo. Il pro- IBC 2013 getto è stato quindi pubblicizzato durante le visite scolastiche al museo e attraverso gli insegnanti, presentandone le attività e gli eventi e invitando gli interessati a candidarsi per diventare membri del gruppo dei giovani volontari. Il sito web (che ora è in fase di riallestimento) è stato inaugurato nel 2007 parallelamente al lancio del gruppo e si proponeva di far vivere le proposte anche virtualmente, attraverso un continuo aggiornamento sulle attività svolte al museo; alla comunità reale in loco, inoltre, il sito tenta di aggiungere, attraverso un blog, una comunità virtuale: gli utenti si possono iscrivere e creare un proprio profilo in cui evidenziare i propri interessi personali per ogni forma d’arte e condividerli con altri utenti (sul modello dei social networks come Facebook o MySpace). Il gruppo dei “Blikopeners” si forma invece a partire dagli annunci che lo staff del museo espone nelle scuole, nelle associazioni culturali, sul sito del museo, e nei centri culturali giovanili. La selezione del gruppo segue il criterio della diversità: di sesso (vengono selezionati in equa misura ragazzi e ragazze), origine etnica, provenienza di quartiere, interessi, retaggio culturale ed età. L’intento è creare una comunità di giovani interna al museo, con opinioni e voci diverse, potenzialmente in grado di attirare a loro volta target diversi di pubblico. Particolarmente strutturata è stata la campagna pubblicitaria e di reclutamento dei giovani prevista per il progetto “On Common Ground”, che è stato presentato con mezzi alquanto differenziati e con un vero e proprio “bombardamento pubblicitario”: dal sito web alla distribuzione di volantini, dai manifesti pubblicitari agli annunci sulle radio locali, dalla stampa alla televisione, dalle scuole alle organizzazioni locali operanti con giovani svantaggiati. Tre approcci diversi per un obiettivo comune: parlare il linguaggio giovanile. Se pur caratterizzati in modo differente e con note di vera originalità, questi progetti adottano un analogo approccio costruttivo, che appare sempre più la chiave perché si apra il dialogo fra pubblici e museo. Un dialogo arricchito, dato il tipo di pubblico, dal metodo educativo della peer education. A Copenaghen il gruppo dei giovani volontari realizza, insieme allo staff del museo, la progettazione di visite guidate, workshop ed eventi, preceduti da un periodo di formazione: i giovani vivono così “dietro le quinte” del museo e comprendono come soddisfare le esigenze di altri giovani, oltre che le proprie. Prende vita, così, l’esperienza dell’“ULK”, in cui ogni piccolo particolare è ideato e realizzato dai giovani volontari: dalle tante attività “tecnologiche” (ai visitatori, per esempio, viene chiesto di trovare la colonna sonora di un’opera d’arte attraverso il proprio lettore MP3, o di immortalare con la propria macchina fotografica un dettaglio) a un luogo dedicato in cui incontrarsi, il “Lab00”, la sala strutturata a misura di giovane. Allo Stedelijk Museum il gruppo dei “Blikopeners” ha fatto dell’identità il suo baluardo: hanno progettato la sala per i giovani interna al museo, hanno scritto un proprio manifesto e disegnato il marchio con cui “firmano” le iniziative da essi ideate. Anche per loro è prevista una serie di incontri di formazione con lo staff interno del museo e professionisti esterni, attraverso i quali imparano le tecniche di lettura di un’opera d’arte e che cosa significhi apprendere attraverso un’esperienza museale 61 62 musei e beni culturali soddisfacente. Da sessioni di brainstorming e dai post-it su cui i membri del gruppo scrivono le proprie idee e al contempo le votano utilizzando colori diversi (un metodo ormai abituale per i frequentatori dei “Blikopeners”) hanno origine le visite animate e i laboratori, gli art talks e gli speed datings sull’arte. Come pure gli eventi serali, che non sono nient’affatto svincolati dai contenuti e dall’identità del museo ma anzi diventano un’occasione per sentirsi accolti finalmente in qualità di pubblico. Infine incontriamo quel gruppo di 500 giovani gallesi, di adozione o di nascita, che “On Common Ground” catapulta nel mondo della cultura locale e museale. Obiettivo del progetto è sensibilizzare e far conoscere ai giovani la cultura del proprio territorio, per costruire responsabilità e identità. E il progetto trova un metodo vincente scegliendo la via del contesto informale per eccellenza: sono le organizzazioni giovanili locali e gli artisti emergenti a guidare altri giovani in questa esperienza. Un’esperienza basata sulla formazione di una comunità locale, che ne rende protagonisti i membri: sono i giovani coinvolti a decidere i temi da trattare e le attività artistiche attraverso cui avvicinarsi al mondo della cultura. Sono ancora loro a progettare, sulla base delle proprie competenze e dei propri gusti, il proprio percorso di apprendimento, che si concretizza in visite nei luoghi della cultura, o nella realizzazione di laboratori artistici e di mostre aperte al pubblico. E se si osservano più da vicino queste tre proposte si vedono tanti giovani che hanno messo da parte l’immagine tradizionale del museo come relitto impolverato, per scoprirlo come luogo accogliente, da vivere in pieno. Si incontrano giovani che il museo è andato a conquistare fuori dalle sue sale, per proporsi come una realtà che ha un legame con la contemporaneità. E si scopre un museo che guarda ai giovani come risorsa e non come problema su cui intervenire, mettendosi in ascolto delle loro voci ed entrando in contatto con il loro mondo. Le buone pratiche nel lavoro con i giovani esistono, così come esiste da parte loro la voglia di mettersi in gioco. Conosciamo i loro gusti, le loro necessità educative e culturali, la loro identità. Al museo italiano non resta altro da fare se non agire sul campo con continuità, affinché diventi un’abitudine pensare ai giovani come a un tipo di pubblico particolarmente stimolante. Nota (1) Il dibattito italiano è vivo da diversi anni e dimostra quanto nel tempo sia maturata una grande sensibilità nei confronti dei giovani e delle loro esigenze; il confronto individua i limiti della didattica museale italiana e riconosce le risorse e le potenzialità a cui fare riferimento perché si crei un pubblico più giovane. Tante sono state le occasioni di confronto, da cui sono scaturite importanti pubblicazioni di riferimento per i professionisti del settore: Il museo verso una nuova identità. I. Esperienze museali di nuova concezione in Italia e nel mondo; II. Musei e comunità. Strategie comunicative e pratiche educative, atti del convegno internazionale di studi (I, 2007; II, 2008), coordinamento scientifico di M. Dalai Emiliani, Roma, Gangemi Editore, 2011; C. Da Milano, I. Del Gaudio, M. De Luca, G. Franchi, V. Galloni, I giovani e i musei d’arte contemporanea, Ferrara, EDISAI, 2011; IBC 2013 A. Cicerchia, I giovani fra creatività e consumi culturali, “Economia della Cultura”, 2008, 1, pp. 7-14; A. Bollo, I pubblici dei musei. Conoscenza e politiche, Milano, FrancoAngeli Edizioni, 2008; Musei giovani. Idee, progetti e passioni, atti del convegno (Modena, 24 novembre 2006), Modena, Provincia di Modena, 2007; M. Sani, A. Trombini, La qualità nella pratica educativa al museo, Bologna, Editrice Compositori, 2003. [“IBC”, XXI, 1, gennaio/marzo 2013] 63 In aprile, con il fine settimana dedicato ai teatri storici dell’Emilia-Romagna, sono tornati “I luoghi del bel canto”. Pensando anche a quelli colpiti dal terremoto. Musica per ricostruire Lidia Bortolotti Il 13 e il 14 aprile 2013 si è rinnovato l’appuntamento con i teatri storici dell’EmiliaRomagna: 24 dei 101 teatri censiti sono stati protagonisti di un fine settimana di aperture straordinarie, visite guidate gratuite, spettacoli musicali, opere e concerti. La prima volta è stata in autunno. L’iniziativa forse era partita un po’ in sordina, con diciassette teatri che avevano aderito raccogliendo dal pubblico un positivo riscontro. Così, a distanza di pochi mesi, c’è stata la replica. La risposta dei teatri che hanno aderito è stata nella maggioranza dei casi entusiastica, corrisposta da un ottimo esito quanto alla partecipazione del pubblico. Ventiquattro teatri storici, dal Piacentino al Riminese, hanno dato vita nel fine settimana di metà aprile a manifestazioni diversificate, con finalità molteplici e convergenti. Da un lato c’era l’intento di richiamare l’attenzione dei cittadini verso quella straordinaria macchina che è la sala teatrale, dando modo di osservarla anche da una prospettiva diversa rispetto a quella fruita da semplice spettatore, come all’Arena del Sole di Bologna. Ma è stata anche l’occasione per celebrare Giuseppe Verdi nel bicentenario della nascita. L’anno in corso è peraltro ricco di spunti celebrativi importanti, ricorrendo anche il bicentenario della nascita di Richard Wagner e i 150 anni della nascita di Pietro Mascagni. E, passando dai musicisti celebri ai teatri storici, a Bologna ricorre il duecentocinquantesimo dell’apertura del Teatro Comunale e del teatrino di Villa Aldrovandi Mazzacorati, entrambi presenti nella manifestazione, il primo aperto alle semplici visite guidate, il secondo anche con lo spettacolo Solo, un monologo dell’attore Alessandro Tampieri, in cui le parole di Dante, Pirandello, Fo e Baricco guidano lo spettatore attraverso diversi generi e periodi della drammaturgia italiana con personaggi accomunati dal senso di solitudine estrema: la lucida follia di Enrico IV, l’affabulazione del Giulàr, la famelica condanna del Conte Ugolino. Un percorso molto apprezzato dal pubblico. Ma il fil rouge della manifestazione, oltre al tema verdiano (risultato prevalente), è stato dipanato dall’attenzione rivolta ai teatri colpiti dal terremoto nel maggio del 2012. IBC 2013 Un proposito ben esplicitato dal Teatro Socjale di Piangipane, presso Ravenna, che ha presentato un ricco programma musicale finalizzato alla raccolta di fondi destinati a due circoli no profit dell’area modenese colpita, per sostenere iniziative culturali e musicali. La banda “Città di Ravenna” e il soprano Federica Balucani, molto apprezzati dal numeroso pubblico intervenuto, hanno proposto un repertorio concentrato su Verdi per oltre la metà del programma, dall’immancabile marcia trionfale dell’Aida alle arie più conosciute della Traviata, proseguendo con l’esecuzione di celebri colonne sonore arrangiate per la banda, e concludendo con un allegro e giocoso pot-pourri di arie romagnole. Dalla parte opposta della regione, nel Piacentino, un folto pubblico ha popolato l’antico borgo medievale di Vigoleno, dove all’interno del castello si trova un piccolissimo teatro fatto realizzare negli anni Venti dall’allora proprietaria Maria Ruspoli Gramont, che ne affidò la decorazione al pittore russo Alexandre Jacovleff (Pietroburgo, 1887 - Parigi, 1938). Alle visite guidate ha fatto seguito un apprezzato concerto nel cortile del castello, con il Trio Verdi e la presenza straordinaria di Azusa Kinashi, soprano solista della Corale “Giuseppe Verdi” di Parma; nel programma: brani tratti da Nabucco, Trovatore, Traviata, Rigoletto, Forza del destino, Lombardi alla prima crociata, Aida, Otello, ma anche dalla Turandot di Puccini e dalla Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, arie e canzoni di Tosti, di Gastaldon, Cherubini, Yradier e Marchetti; e, per concludere, pezzi tratti da operette e canzoni napoletane per rivivere le vecchie atmosfere dei cafè chantant del primo Novecento. Anche a Fiorenzuola il weekend di apertura dei teatri è andato bene: non sono mancati né i visitatori curiosi di conoscere questo bel teatro ottocentesco, restaurato pochi anni fa, né gli spettatori alle performance in programma. Si è registrato il tutto esaurito anche a Fidenza, nel teatro intitolato a Girolamo Magnani, lo scenografo prediletto da Verdi. Qui si sono avvicendati diversi gruppi corali locali con un programma verdiano intitolato Cori in festa per un amico. Nella vicina Fontanellato, poi, si sono esibiti “Grandi e Piccoli insieme in coro”. Le proposte sono state estremamente diversificate. Se, giustamente, la musica è stata l’indiscussa protagonista, non sono mancate le possibilità di osservare da diverse angolature questi spazi così particolari: non solo le sale teatrali e il luogo della scena, ma anche i vani adiacenti, destinati a tutti quei momenti di socialità che il teatro induce naturalmente. Come è successo a Bagnacavallo, al Comunale di Ferrara e all’Alighieri di Ravenna, o come a Cesena, in cui le visite guidate al Teatro Bonci erano finalizzate a far conoscere l’allestimento dello spettacolo Chi ha letto il Decamerone?, drammaturgia e regia di Gabriele Marchesini, con gli studenti del corso per allievi attori selezionati nelle scuole superiori e nelle università cittadine (lo spettacolo, promosso dal Comune di Cesena e dal Teatro Perché di Bologna, è stato realizzato nel 700° anniversario della nascita di Giovanni Boccaccio). Taluni teatri hanno proposto anche mostre: a Correggio, con “Le stagioni dell’Asioli (2009-2013)” nelle fotografie di Tiziano Ghidorsi, e a Novellara, dove oltre alla visita a questo pregevole spazio, riproposizione in scala ridotta del Municipale di Reggio Emilia, è stato possibile visitare una mostra documentaria allestita nel locale Museo 65 66 musei e beni culturali civico per far conoscere i momenti significativi della storia teatrale della cittadina, un tempo sede della corte dei Gonzaga, dal Rinascimento fino al 1868, anno di inaugurazione del teatro, recentemente dedicato al tenore Franco Tagliavini. A Portomaggiore, invece, il Teatro Sociale della Concordia si è svelato in una veste inconsueta, essendo la sala teatrale vera e propria in attesa di restauro. Il Comune, dopo aver acquisito la struttura e proceduto con una serie di interventi urgenti per scongiurare la definitiva rovina dell’edificio, ne ha potuto restaurare la sola facciata e recuperare il ridotto, restituendo in parte dignità al teatro e rendendo fruibili tutti gli ambienti posti nella parte anteriore dell’edificio. Nel foyer è stata allestita una piccola pinacoteca. Una sala del primo piano, utilizzata anche per conferenze, concerti e presentazioni, ospita dieci ritratti di ferraresi illustri dipinti da Remo Brindisi; in un’altra sala adiacente sono state esposte una serie di opere del pittore Federico Bernagozzi, mentre dipinti di altri autori contemporanei sono posti negli spazi attigui. Nell’atrio del piano terra trovano sede le mostre temporanee, dedicate in particolare a pittura e fotografia, organizzate dai Servizi culturali del Comune in primavera e in autunno. In questa occasione i visitatori hanno potuto osservare dal piano terra la sala del Teatro Sociale della Concordia nello stato attuale, in attesa dei necessari restauri, senza potervi accedere per evidenti motivi di sicurezza. Chi si è recato allo Stignani ha potuto visitare, oltre al teatro, la mostra “200 anni di teatro a Imola”, allestita nelle sale adiacenti al Ridotto in occasione del bicentenario di questo contenitore, realizzato nel 1812 nella soppressa chiesa di San Francesco. L’esposizione, curata dall’Archivio storico comunale di Imola in collaborazione con il Teatro comunale, ha ripercorso le particolari vicende di questa struttura attraverso tavole di progetto, disegni per decorazioni e affreschi, manifesti per spettacoli e intrattenimenti, libretti di sala. Nel Ridotto, con la proiezione del video in alta definizione dell’Otello di Giuseppe Verdi (con Placido Domingo, Barbara Frittoli, Leo Nucci; direttore, Riccardo Muti; produzione, Teatro alla Scala di Milano), il Maestro è stato celebrato con la magia del grande spettacolo lirico, che attualmente non è quasi più possibile realizzare nei teatri medi e piccoli. In altri teatri le visite erano intervallate da momenti musicali, come al Teatro comunale “Luciano Pavarotti” di Modena, o come a Busseto, che ha presentato La Peppina a Teatro, una visita animata in compagnia di Giuseppina Strepponi che intrattiene amabilmente gli ospiti cantando per loro al termine della visita (soprano, Virginia Barchi). E ancora al Comunale di San Giovanni in Persiceto, dove le visite guidate con Miriam Fornì erano precedute da un’introduzione musicale dedicata a Giuseppe Verdi a cura dell’Associazione musicale “Leonard Bernstein” (Barbara Favali, soprano, e Donatella Scagliarini al pianoforte, in: Caro nome da Rigoletto; La Vergine degli Angeli da La forza del destino; Ave Maria da Otello; Saper vorreste da Un ballo in maschera). A Sant’Agata Bolognese la visita al teatro a cura di Romeo Grosso è stata seguita da uno spettacolo-conferenza, W Verdi, con Umberto Fiorelli voce recitante, musiche dal vivo eseguite dall’Ensemble Bibiena, e immagini di Federico Zuntini. Ampio e vario il programma proposto a Gambettola nel piccolo teatro da poco riaperto. Il sabato è stato possibile assistere alla presentazione in anteprima nazionale dello spettacolo di narrazione Etna, storie popolari alle pendici del vulcano del cunta- IBC 2013 storie siciliano Alessio Di Modica. Mentre alla domenica il mezzosoprano Francesca Bagli e la pianista Fabiola Crudeli si sono esibite in un programma di arie e di musiche verdiane. Chiuso nei primi anni Cinquanta, il Comunale di Gambettola è rimasto a lungo inutilizzato e destinato a usi impropri; solo di recente la struttura è stata completamente recuperata e ha ripreso con rinnovata energia l’attività teatrale e culturale. Considerate le piccole dimensioni (100 posti a sedere), l’amministrazione ha voluto destinarlo al perseguimento di ben determinate finalità: come il progetto “La Baracca dei Talenti”, un laboratorio permanente che, in collaborazione con l’Azienda sanitaria di Cesena, intende sperimentare e sviluppare pratiche del teatro in diversi ambiti del disagio psicofisico, realizzando attività volte all’integrazione e all’inserimento sociale di persone con disabilità. Al contempo viene proposto un calendario di eventi culturali aperti a tutto il pubblico. A Longiano, dove durante le due giornate è stato possibile visitare il Teatro “Errico Petrella”, al sabato si sono esibiti coristi e musicisti della classe di canto del Conservatorio “Bruno Maderna”, con un programma di arie e di musiche verdiane realizzato e diretto da Gabriella Morigi e l’accompagnamento al pianoforte di Pia Zanca. La domenica si è esibita in un analogo programma verdiano una giovane e valente pianista: Sara Castiglia. A San Giovanni in Marignano il “Teatro dei Cinquequattrini”, con la complicità di “Incontramusica” e la collaborazione dell’Assessorato alla cultura del Comune, ha realizzato il programma di apertura al Teatro “Augusto Massari” proponendo Letture arie e cori dedicate a Giuseppe Verdi. Il delizioso Teatro “Angelo Mariani” di Sant’Agata Feltria è stato aperto alle visite del pubblico per l’intero fine settimana; nella serata domenicale il numeroso pubblico è stato intrattenuto dal duo Sergio Zampetti e Luigi Verrini con il concerto per flauto e chitarra Melodie dall’Ottocento, che comprendeva le immancabili arie verdiane ma anche musiche di Schubert, Chopin, Rossini. Il pubblico entusiasta è stato coinvolto nel canto corale del Va, pensiero, rispondendo con un lunghissimo applauso finale. Ancora una volta questi luoghi simbolo del sapere attivo, spazi dell’incontro e della socializzazione in cui le comunità rinascono e crescono, interpretando con formule diversificate un’amicizia antica hanno confermato la loro vitalità. La stessa vitalità che si vuole riportare nei teatri duramente colpiti dal terremoto di un anno fa. Per raggiungere questo obiettivo è stata promossa una raccolta di fondi a cui si può partecipare con un versamento sul conto corrente “Pro Teatri” (IBAN: IT 87 H 0200802450 000102267869). [“IBC”, XXI, 2, aprile/giugno 2013] 67 Il Museo civico medievale di Bologna mette in mostra il recupero di una preziosa collezione di tessuti antichi. Frammenti di moda Marta Cuoghi Costantini “Sete fruscianti, sete dipinte”: questo è l’accattivante titolo di una piccola mostra ospitata fino al 29 settembre 2013 negli spazi del Lapidario del Museo civico medievale di Bologna, interamente dedicata al tema desueto e poco frequentato dei tessuti antichi. La rassegna – curata da Silvia Battistini e Massimo Medica, oltre che da chi scrive – si sviluppa in un breve ma denso percorso di visita dove trovano spazio preziosi e inediti manufatti tessili, a cui si alternano dipinti di raffronto e un completo maschile da gala della fine del XVIII secolo, appartenuto a una nota famiglia bolognese. Un sintetico ed essenziale corredo esplicativo, puntualmente ripreso in una piccola guida a stampa, presenta al pubblico i diversi manufatti ma anche e soprattutto i primi importanti risultati di un articolato progetto di lavoro avviato già da qualche anno proprio su questi beni. La visita alla mostra sollecita alcune considerazioni preliminari, relative alla peculiarità delle opere esposte, che comprendono tessuti di seta, ma anche ricami, pizzi, galloni, sotto forma di frammenti, alcuni di grande formato ma per lo più di piccola taglia, quindi oggetti incompleti e per molti aspetti misteriosi, avanzi o sopravvivenze di mondi ormai molto lontani nel tempo. La comprensione di questi materiali non è dunque immediata ma implica immaginazione e fantasia, oltre a un mix di conoscenze che spaziano tra la storia della tecnica e dell’economia, dell’artigianato e del commercio, richiamando anche aspetti non trascurabili della storia sociale. I tessuti, infatti, rappresentano la materia prima di abiti e arredi, svolgendo da sempre e in tutti i contesti culturali un ruolo rilevante nella definizione dell’immagine personale e quindi nell’indicazione di censo, ruolo, condizione sociale. Privilegiando questa chiave di lettura, la mostra bolognese accosta ai frammenti tessili una serie di importanti testi pittorici siglati da protagonisti di primo piano della vita artistica cittadina. Ciascuno di loro declina in modo personale il tema del ritratto; tutti, però, accordano grande attenzione alle vesti dei personaggi, riproducendone con straordinaria abilità non solo le fogge sartoriali ma anche le caratteristiche materiali delle stoffe. La loro abilità è tanta e tale da consentirci di riconoscere le diverse IBC 2013 tecniche di lavorazione e le loro caratteristiche tipologie decorative, alcune delle quali trovano riscontro nei reperti che ci sono pervenuti. Ce ne offrono esempi significativi il ritratto di Bianca Cappello eseguito verosimilmente da Lavinia Fontana intorno al 1585, e quello di Pietro di Annibale Bargellini siglato da Bartolomeo Passarotti nel 1576, i cui abiti documentano rispettivamente un “velluto cesellato” e un “raso sforbiciato”, entrambi di gran moda nel XVI secolo. La perizia degli artisti diventa vero e proprio virtuosismo quando si tratta di riprodurre i diafani pizzi e i preziosi ricami che di norma completavano l’abbigliamento signorile, come quelli molto discreti che rifiniscono la candida camicia della misteriosa dama ritratta tra il 1565 e il 1570 da Prospero Fontana sullo sfondo di un suggestivo scorcio di vita domestica, o quelli di gusto marcatamente barocco che arricchiscono la camicia di Ippolita Obizzi Campeggi, fedelmente riprodotti da Benedetto Gennari il Giovane tra il 1680 e il 1690. Seppur circoscritta numericamente, la selezione dei tessuti esposti comprende un arco cronologico molto ampio, esteso tra XVI e XVIII secolo, e si riferisce a un contesto geografico che spazia in Europa, tra i più importanti centri di produzione. Questi prodotti però, seppure indirettamente, richiamano la città di Bologna, la cui storia, come quella di molti altri centri italiani, fu fortemente segnata dalla presenza di un importante distretto tessile, che incise profondamente sulla vita della città e sulla sua economia, condizionandone persino l’assetto urbano con l’insediamento di imponenti filatoi idraulici e di numerose botteghe artigianali. Complementare all’attività del setificio – rinomato soprattutto per la lavorazione degli “organzini” e dei “veli di seta”, ovvero dei prodotti che resero celebre Bologna sulle principali piazze europee – era quella dei laboratori di ricamo, la cui antica tradizione fu poi rilanciata sul finire del XIX secolo dall’“Aemilia Ars”, fenomeno tutto locale anche se ispirato alle teorie delle inglesi “Arts & Crafts”, con cui condivise, pur con qualche decennio di scarto, la volontà di contrastare la qualità mediocre del prodotto industriale attraverso il rilancio del lavoro artigianale. Il rinato interesse per le arti del ricamo propugnato dall’associazione bolognese ricevette indubbiamente impulso dal fenomeno del collezionismo tessile, che negli ultimi decenni dell’Ottocento era praticato in città da due principali esponenti: Leopoldo Enrico Lambertini e Francesco Silvestrini. A questi due personaggi, che certamente intrattennero rapporti con altri noti collezionisti dell’epoca (ma la cui biografia è passibile di ulteriori approfondimenti), sono intitolati gli importanti nuclei tessili conservati presso il Museo civico medievale, di cui la mostra presenta una ristrettissima selezione. Conservato nei depositi del museo per decenni, solo di recente questo prezioso patrimonio, composto complessivamente da oltre 750 reperti, è divenuto oggetto di un articolato programma di valorizzazione che ha preso avvio nel 2008 con la schedatura informatizzata dei tessuti. I parametri catalografici predisposti dal Centre international d’etude des textiles anciens, il CIETA di Lione, centro accreditato su scala mondiale per lo studio e la classificazione dei tessili antichi, sono stati adattati al tracciato mini- 69 70 musei e beni culturali steriale della scheda OA: accanto all’individuazione dei filati e dei loro colori, delle tipologie tecniche e dei motivi decorativi, vi trovano posto anche le informazioni per così dire d’archivio, desunte dalla documentazione allegata ai tessuti stessi e dai vecchi inventari di museo. Le schede dei tessuti andranno a incrementare il Catalogo del patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna, dove sarà possibile effettuare ricerche incrociate per epoca, provenienza, tipologia (www.ibc.regione.emilia-romagna. it/servizi-online/catalogo-del-patrimonio-culturale). In parallelo alle operazioni di schedatura è stato realizzato un importante intervento di manutenzione straordinaria che ha riguardato la totalità dei manufatti. Si è trattato di operazioni indispensabili per ovviare ai rischi di degrado derivanti dalla consistente presenza di polvere, sporco e microrganismi, conseguente alla lunga permanenza dei materiali nei depositi. Le operazioni conservative hanno rispettato l’ordinamento storico dei materiali, parte dei quali erano stati sistemati su fogli di carta comune, come si trattasse di un vero e proprio album di campioni. Per facilitare lo stoccaggio di teli e frammenti, e consentirne la movimentazione senza conseguenze dannose per la loro conservazione, sono state realizzate carpette in cartoncino a ph neutro in quattro misure standard e spessore variabile. L’articolato programma di lavoro avviato sulla collezione tessile bolognese approderà all’allestimento di una nuova sezione espositiva, collocata al primo piano del percorso di visita del museo, in uno spazio contiguo a quello che ospita la collezione dei vetri e improntata agli stessi caratteri di sobrietà. La Sala Tessuti, la cui realizzazione è ancora in corso, sarà tuttavia dotata di arredi e soluzioni tecniche innovative, indispensabili per garantire un giusto punto di equilibrio tra le istanze irrinunciabili della conservazione dei manufatti e quelle altrettanto importanti della comunicazione, diretta non solo a specialisti e addetti ai lavori ma anche a studenti, operatori del mondo produttivo e della moda, e in generale al vasto pubblico dei visitatori del museo. Sono state ovviamente numerose le competenze in campo necessarie per svolgere questo progetto, dallo studio analitico dei singoli reperti, condotto da Barbara Corradi e Francesca Ghiggini con il supporto di Raffaella Gattiani di Data Management per l’informatizzazione della scheda, alle operazioni conservative effettuate dalla ditta Restauro e Studio Tessili snc di Digiglio e Cambini di Lucca con la collaborazione di Cepac di Forlì, alla progettazione museografica curata da Cesare Mari (PANSTUDIO architetti associati) affiancato per la grafica di sala da Monica Nannini (Spa Design) e Simonetta Scala (Lizart Comunicazione Visiva). Resta da fare un’ultima considerazione relativa ai promotori dell’iniziativa: innanzitutto il Museo civico medievale di Bologna, titolare e custode attento dell’importante collezione tessile, e poi l’Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-Romagna, che è stato partner fin dall’inizio del progetto di valorizzazione di questo patrimonio, a cui ha partecipato attivamente attraverso il Servizio musei e beni culturali, con un ragguardevole impegno finanziario oltre che con la concreta e fattiva collaborazione di diversi funzionari. IBC 2013 Quest’ultimo aspetto attribuisce per così dire un “valore aggiunto” al lavoro realizzato in questi anni, poiché in tempi di pesanti ristrettezze economiche come quelli attuali la collaborazione fattiva tra enti e istituzioni rappresenta forse l’unica via praticabile per condurre in porto iniziative complesse come il recupero e la valorizzazione di beni museali. Al di là dei contenuti storici relativi agli antichi tessuti, al loro collezionismo e alle loro possibili chiavi di lettura, la piccola mostra bolognese documenta dunque una operazione di carattere museografico e un modello di gestione per così dire “virtuoso”, che si auspica pertanto possa trovare riscontri concreti anche in futuro. [“IBC”, XXI, 2, aprile/giugno 2013] 71 Con il progetto “AdriaMuse” l’Unione Europea promuove il turismo culturale fra le due sponde dell’Adriatico, facendo uscire i musei dalle proprie mura. Le Muse si divertono Laura Carlini, Giulia Pretto Le Muse escono dai musei, dove sono abitualmente di casa, per tuffarsi nel mare Adriatico. Nuotano dalla riviera romagnola e pesarese alle coste istriane, montenegrine e albanesi, alle lagune venete. S’inoltrano nelle verdi valli della Bosnia e salgono sulle colline del Molise, coinvolgendo nei loro felici giochi quanti hanno voglia di vivere la cultura in modo allegro e non convenzionale. Questo è lo spirito di “AdriaMuse”, un progetto di cooperazione transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013 cofinanziato dall’Unione Europea, per promuovere il turismo culturale fra le due sponde dell’Adriatico grazie a eventi innovativi sul tema del mare, dell’archeologia, delle tradizioni locali (www.adriamuse.org/). Nel progetto sono coinvolti 11 partner provenienti da cinque paesi: la Provincia di Rimini, partner capofila, l’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBC), la Regione Veneto, l’Università di Venezia IUAV, la Provincia di Pesaro e Urbino, la Provincia di Campobasso, Skupa (Italia), il Museo nazionale del Montenegro, il Comune di Scutari (Albania), il Cantone di Zenica e Doboj (Bosnia ed Erzegovina) e la Regione Istriana (Croazia). Per concorrere alla valorizzazione turistica del patrimonio culturale i partner hanno condiviso un itinerario legato soprattutto al mare, che collega musei, siti archeologici, porti, antiche pescherie, ristoranti e tutto ciò che si riferisce alla cultura marinaresca, sperimentando idee da mettere a disposizione delle amministrazioni e degli operatori economici e culturali. “AdriaMuse” ha già dato vita a una serie di manifestazioni in cui i musei escono letteralmente dalle proprie mura con attività curiose e originali, pensate per intercettare il pubblico che tradizionalmente non li frequenta: per il successo di queste manifestazioni il personale dei musei gioca un ruolo fondamentale, in virtù della capacità di interpretare e di raccontare l’identità storico-culturale delle popolazioni legate al mare. Il museo fuori dalle proprie mura La definizione “museo al di fuori delle proprie mura” comprende tutte le attività che il museo organizza all’esterno della propria sede per appassionare pubblici sempre più eterogenei ed esigenti: festival, rievocazioni storiche, mostre itineranti, installazioni IBC 2013 nella città, flash mob, laboratori, attività didattiche, conferenze, letture animate, proiezioni, degustazioni, visite guidate, realtà aumentata, app per dispositivi mobili. Uscire dalle proprie mura significa comunicare la propria identità, interagire con la città e con la comunità, costruire nuove relazioni e consentire la partecipazione, farsi conoscere e apprezzare da persone potenzialmente interessate, che così potranno essere invogliate a fare una visita “all’interno delle mura”, dove i musei conservano collezioni che, se adeguatamente raccontate con narrazioni emozionanti, possono dispiegare il massimo potenziale di coinvolgimento. Per rispondere alle aspettative che si creano “fuori dalle mura” occorre presentare contenuti semplici e accattivanti ma non per questo banali, cercando di allettare il visitatore a ritornare al museo per una visita più approfondita. Gli eventi “fuori dalle mura” rappresentano un’occasione importante per divulgare i contenuti culturali dei musei ubicati nelle località turistiche e per rendere nel contempo più attraente l’offerta complessiva dell’area, favorendo in alcuni casi la destagionalizzazione dei flussi turistici. L’IBC, con la collaborazione dei partner e dei musei dell’Emilia-Romagna, ha raccolto 25 casi di buone pratiche che illustrano possibili modalità per portare i musei nella città e nelle comunità. Il repertorio di casi, raccolto nella pubblicazione Museum Beyond Its Walls,1 ha fornito lo spunto per fare alcune riflessioni sugli attori e i luoghi privilegiati dei musei al di fuori delle proprie mura, nonché per realizzare un’analisi di queste attività, evidenziandone i punti di forza e di debolezza, le opportunità e le minacce. Il repertorio illustra festival di vario genere, corsi di formazione, attività ludico-didattiche per bambini e ragazzi, rievocazioni storiche, fiere e seminari, mostre itineranti, percorsi turistici reali e virtuali, letture e degustazioni enogastronomiche. Citiamo, a titolo di esempio, le diverse edizioni del “Festival del Mondo Antico” di Rimini, che da quindici anni contribuisce alla diffusione della cultura dell’antichità attraverso commenti magistrali, happening, giochi, laboratori, seminari, proiezioni e iniziative gastronomiche. Dall’epicentro costituito dal Museo della città e dalla Domus del chirurgo, il festival si estende a tutta la città di Rimini (strade, piazze, monumenti, librerie e ristoranti) fino a inglobare i comuni della provincia. Un altro caso virtuoso è rappresentato dal MUSA, il Museo del sale di Cervia. La Salina Camillone, sezione all’aperto del museo, resta l’unico esempio in Italia di salina a lavorazione artigianale a raccolta multipla. Qui i visitatori sono accolti dai volontari del gruppo culturale “Civiltà Salinara” e hanno l’opportunità di vedere le modalità di lavorazione e raccolta del sale. Con il percorso “Salinaro per un giorno”, i partecipanti collaborano alle attività di raccolta e trasporto del sale in compagnia dei salinari, per comprenderne il lavoro e sperimentare in prima persona le attività della vecchia salina. Le iniziative dell’IBC per la formazione L’attività di formazione nell’ambito di “AdriaMuse” si è concentrata su contenuti a forte valenza sociale (in particolare gli ecomusei) e sul tema della comunicazione del patrimonio culturale supportata dalle nuove tecnologie. Nel settembre del 2012 Argenta e Cervia hanno ospitato il workshop rivolto agli operatori ecomuseali “Patrimonio e 73 74 musei e beni culturali Innovazione”, incentrato sul rapporto tra patrimonio e cambiamenti sociali e sulla costruzione delle mappe di comunità, che ha visto la partecipazione attiva di circa cinquanta soggetti, tra cui una delegazione della Regione Istriana e della Città di Rovigno con l’ecomuseo “La Casa della Batana”. L’esperienza dedicata agli ecomusei prosegue anche nel 2013 con un workshop dal titolo “Ecomusei - soggetti e protagonisti locali. Cosa fanno e cosa vogliono”, programmato ad Argenta e a Villanova di Bagnacavallo nei giorni 7 e 8 settembre. Per favorire l’apprendimento di forme di comunicazione efficace da parte dei musei, dopo l’esito positivo della prima edizione, è stato riproposto in chiave europea “Comunicare il Museo*”, un percorso di sviluppo di tecniche e pratiche di comunicazione museale 2.0 promosso e sostenuto dall’IBC e progettato da “BAM! Strategie Culturali”. La giornata di presentazione (Bologna, 8 febbraio 2013) ha avuto come ospite di eccezione Chiara Bernasconi del Digital Media Department del MoMA - Museum of Modern Art di New York, che ha raccontato l’esperienza di digital strategy del MoMA, anche attraverso alcuni esempi di progetti di partecipazione low budget replicabili da piccole realtà museali. Hanno partecipato alla giornata gli operatori museali dell’Emilia-Romagna e dei territori interessati dal progetto “AdriaMuse”. L’iniziativa è stata resa disponibile anche in streaming ed è stata seguita da circa quattrocento persone.2 Il 24 giugno 2013, presso Casa Artusi a Forlimpopoli, si è svolto “Il gusto del Museo 2.0”, un workshop di formazione destinato agli operatori museali e turistici e ai food & travel bloggers, in cui sono state presentate esperienze nazionali e internazionali di marketing territoriale imperniato sui musei. Alla giornata hanno partecipato esperti provenienti da diversi paesi tra i quali: Marino Budicin, vicesindaco di Rovigno (Croa zia), per l’ecomuseo “La Casa della Batana”, Jasmin Mandzukic, direttore del Museo civico di Tesanj (Bosnia Erzegovina) e Laila Tentoni, vicepresidente di Casa Artusi. Le iniziative dell’IBC per la promozione Nel luglio del 2012 è salpata da Cattolica la prima regata “AdriaMuse”, con destinazione Pola, in Istria: un incontro ideale fra le due sponde dell’Adriatico svoltosi in concomitanza con la “Notte Rosa”. I regatanti hanno sostato a Pola, dove la Regione Istriana li ha accolti con una visita speciale all’Anfiteatro romano e al Museo storico e navale, per poi ripartire alla volta di Cattolica, dove sono stati festeggiati nella cerimonia ufficiale di premiazione presso il Museo della Regina. Gli eventi culturali – organizzati in collaborazione tra IBC, Museo della Regina, Associazione “Mariegola delle vele al terzo e delle barche da lavoro delle Romagne” e Regione Istriana – si sono conclusi con la parata delle imbarcazioni tradizionali con vele al terzo radunatesi nel porto di Cattolica. Le attività di promozione e la collaborazione con l’ecomuseo di Rovigno si sono ulteriormente sviluppate nel 2012 nel corso della “Fiera degli Ecomusei” di Argenta e durante le iniziative di “Sapore di Sale” a Cervia. A coronamento di questo gemellaggio, la Batana Adriatica è stata messa in acqua a Campotto, nelle Valli di Argenta. Nelle serate della fiera argentana, l’ecomuseo di Rovigno ha proposto la lavorazione e la degustazione di “salà sardoni” e “sardelle fresche alla griglia” con l’animazione del gruppo folk “Batana”, che ha suonato musica popolare istriana. A Cervia gli ospiti di IBC 2013 Rovigno hanno dato vita a una disfida con i pescatori locali con l’iniziativa “Salature a confronto” con l’impiego del sale di Cervia: “salà sardoni”, a cura dell’ecomuseo “La Casa della Batana”, contro “saraghina al sale di Cervia”, a cura del circolo dei pescatori “La Pantofla”. L’evento è stato ospitato dal MUSA - Museo del sale di Cervia. Nel 2013, nella cornice delle “Feste Artusiane” a Forlimpopoli, l’ecomuseo “La Casa della Batana” di Rovigno ha animato lo stand “Sapori d’Europa” con le proprie specialità gastronomiche, accompagnate dalle musiche tradizionali rovignesi. Contemporaneamente, nella Scuola di cucina di Casa Artusi, Jasmin Mandzukic, direttore del Museo civico di Tesanj, si è cimentato nella preparazione di alcune ricette tradizionali del cantone di Zenica Doboj utilizzando terrecotte tipiche della cucina domestica bosniaca: un momento di condivisione e convivialità che ha unito Forlimpopoli, la Croazia e la Bosnia Erzegovina. Infine, per promuovere i musei dell’Emilia-Romagna e la cooperazione transfrontaliera, l’IBC ha ideato “Il Gusto del Museo”, un tour attraverso i musei dell’Emilia-Romagna che operano al di fuori delle proprie mura sul tema del mare e dell’enogastronomia. Protagonisti del viaggio di studio sono stati i partner del progetto, gli operatori museali della regione e i food & travel bloggers di fama internazionale, invitati a tenere un diario di viaggio digitale della loro esperienza. Il tour si è snodato in un percorso di 14 tappe, dedicate ad altrettanti musei e luoghi di cultura: il MIC - Museo internazionale della ceramica di Faenza, il Museo della Rocca di Dozza con l’Enoteca regionale, il Museo dell’aceto balsamico tradizionale di Spilamberto con la Consorteria, Casa Artusi, MUSA - Museo del sale di Cervia, il Museo della marineria di Cesenatico, il Museo del gelato di Anzola dell’Emilia, l’Academia Barilla di Parma, i Musei del cibo della Provincia di Parma (Museo del salame di Felino, Museo del prosciutto di Langhirano, Museo del pomodoro di Collecchio, Museo del parmigiano reggiano di Soragna), il Museo Guatelli di Ozzano Taro e l’Antica Corte Pallavicina, futura sede del Museo del culatello. L’intero progetto-pilota “Il Gusto del Museo” è documentato da articoli su blog internazionali qualificati, da un video, da centinaia di immagini fotografiche e dai disegni realizzati dagli urban sketchers Clelia La Gioia e Angelo Di Nunzio, grazie alla partnership con “Can’t Forget Italy” e il progetto “Digital Diary”. “AdriaMuse” ha in programma ulteriori azioni di disseminazione e rafforzamento della collaborazione transadriatica, che si sta positivamente consolidando e che potrà proseguire anche dopo la fine del progetto, prevista per il febbraio del 2014. Note (1) Museum Beyond Its Walls, a cura di L. Carlini e G. Pretto, Bologna, Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, 2013 (per scaricare la versione elettronica del libro: online.ibc.regione.emilia-romagna.it/h3/h3.exe/apubblicazioni/t?NRECORD=0000113853). (2) Il video è visibile on line: ibc.regione.emilia-romagna.it/multimedia/ video/comunicare-il-museo-collezioni-comunita-pubblici. [“IBC”, XXI, 3, luglio/settembre 2013] 75 Il progetto “MuMu - Musei Multiverso” sperimenta un software per creare e collegare universi culturali. Primo test: un’app dedicata al vasto mondo verdiano. “VersoVerdi”: i musei e i percorsi da esplorare Isabella Fabbri, Micaela Guarino Quando si è trattato di decidere quali sarebbero stati i contenuti della prima applicazione sperimentale del progetto “MuMu - Musei Multiverso” nell’ambito dei musei dell’Emilia-Romagna abbiamo ragionato su varie ipotesi. L’impostazione della app, basata su un certo numero di pianeti da scoprire e visitare attraverso un viaggio virtuale, non rendeva immediatamente percepibili le possibili soluzioni. I pianeti andavano collegati tra loro e avrebbero potuto a loro volta generare nuovi possibili collegamenti. Lo strumento da utilizzare per poter fruire di questo nuovo universo poneva inoltre alcune precise condizioni: numero contenuto e brevità di testi, spazio privilegiato per immagini, video, audio; necessità di costruire due tipi di percorsi per ogni pianeta. Bisognava quindi ragionare su temi che valorizzassero i patrimoni e, al tempo stesso, esaltassero le caratteristiche tecniche dell’applicazione. Più o meno nello stesso periodo, l’Istituto per i beni culturali della Regione stava valutando le iniziative da intraprendere per celebrare il bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi. È venuto a quel punto naturale scegliere proprio la figura del grande compositore per inaugurare questo nuovo approccio. Oltre a essere stato un grandissimo musicista, Verdi è stato infatti anche uomo dei suoi tempi, ricco proprietario terriero, interprete musicale del Risorgimento italiano, filantropo riservato, politico riluttante, contadino delle Roncole. Una figura quindi ideale, vista la sua poliedricità, per costruire un itinerario tra musei e luoghi dell’Emilia-Romagna secondo legami di senso e rimandi non troppo ovvii. D’altra parte la realtà dei musei emiliano-romagnoli, ricca e articolata, consente di leggere il territorio regionale ripercorrendone di volta in volta e in modo documentato la storia, le vicende artistiche e culturali, la cultura materiale, gli aspetti del paesaggio, i beni naturali, gli aspetti tecnico-scientifici e produttivi. L’intreccio tra questa varietà di situazioni e le caratteristiche e gli interessi della figura di Giuseppe Verdi si è concretizzato nell’individuazione di 4 possibili percorsi tematici di visita: musica, territorio, Ottocento (inteso come società, arte e storia di quel periodo) e cultura del cibo. Percorsi che, a loro volta, si incontrano e si intersecano componendo una sorta di griglia percorribile in direzioni diverse, a seconda delle curiosità e degli interessi. IBC 2013 I musei e i luoghi coinvolti in questa prima “esplorazione planetaria” sono stati 24: una soglia dettata, oltreché da ragioni tipologiche, anche dal tipo di opere e di materiali conservati e dalla necessità di non eccedere nel numero di luoghi rappresentati, anche per meglio testare l’applicazione e il suo funzionamento. Con il coinvolgimento dei responsabili dei musei e degli altri luoghi rappresentati – e con la consulenza e la collaborazione dell’Istituto nazionale di studi verdiani che, insieme alla Fondazione Toscanini e al Castello della musica di Noceto, ha messo a disposizione le registrazioni musicali – sono così stati costruiti i quattro percorsi, alla scoperta dei quali si viene introdotti dal Preludio della Traviata. Le tappe del viaggio sono anch’esse connotate da brani musicali (la maggior parte dei quali verdiani e tratti da alcune delle opere più note, come Otello, Aida, I Lombardi alla prima Crociata, Don Carlo, Falstaff), da immagini delle sedi museali, dipinti, sculture, disegni, fotografie, strumenti musicali, erbari, orti botanici, strumentazioni scientifiche, porzioni di territorio, pompe idrauliche, da brani video e audio che raccontano vicende e persone. Punto di partenza, e non poteva essere altrimenti, è la casa natale di Giuseppe Verdi a Roncole di Busseto, un luogo evocativo che ricorda le umili origini del Maestro, che nel 1863 scriveva: “Sono stato, sono e sarò sempre un paesano delle Roncole”. Un Verdi giovane e un Verdi affermato sono illustrati da altre due case-museo: Casa Barezzi a Busseto e Villa Verdi a Sant’Agata di Villanova sull’Arda. Tra i materiali utilizzati per raccontare Villa Verdi, tra l’altro, si può ascoltare la lettura della famosa lettera di Giuseppina Strepponi che descrive con accenti comici l’impegno del marito nella progettazione e realizzazione degli spazi della casa e del parco e i continui cambi di letto da una stanza all’altra mentre fervevano i lavori. Verdi si occupava personalmente anche della gestione dei suoi terreni e ne apprezzava i prodotti. Per questo abbiamo connesso i luoghi verdiani al museo di San Martino in Rio con immagini e un filmato che raccontano la vita dei contadini e dei proprietari nelle campagne padane tra Ottocento e primi anni del Novecento. Verdi imprenditore agricolo si preoccupa di far arrivare l’acqua nei suoi terreni disponendo lo scavo di canali di derivazione dai torrenti vicini. Una pratica che ci rimanda al millenario rapporto che coinvolge uomini, acque e bonifica delle terre prima sommerse e poi rese coltivabili: ad Argenta il Museo della bonifica ne racconta lo sviluppo nel corso del Novecento in Emilia-Romagna. Allo stesso modo i paesaggi, la storia e la società dell’Ottocento e dei primi anni del Novecento rivivono nelle opere d’arte della bella collezione del nobile piacentino Giuseppe Ricci Oddi, conservata nella Galleria omonima che annovera tra i suoi artisti Antonio Fontanesi, Antonio Mancini, Giovanni Fattori, Giuseppe De Nittis. Il percorso legato all’Ottocento artistico prosegue con Giovanni Boldini, che ha rappresentato con grande efficacia e raffinata eleganza l’alta società europea di fine secolo e inizi Novecento, ma anche la vita nelle grandi città e i segnali di modernità che la caratterizzano. In questo caso la connessione tra i luoghi verdiani e il Museo Boldini si fa più stretta e coinvolgente: il pittore ferrarese è l’autore di uno dei più 77 78 musei e beni culturali celebri ritratti di Verdi, mentre il compositore rinnova a sua volta l’amicizia reciproca con il dono di dediche e spartiti. La musica verdiana è, con tutta evidenza, la colonna sonora del Risorgimento italiano e Va, pensiero una sorta di secondo inno nazionale, anche se Verdi non partecipa in prima persona alle battaglie risorgimentali. Nel 1861 accetta l’invito di Cavour a far parte del primo Parlamento del Regno d’Italia, ma la politica non gli interessa. Il tema è comunque imprescindibile e per questo il nostro percorso fa tappa anche al Museo del Risorgimento di Bologna, che conserva cimeli, materiali e documenti resi ancora più interessanti e “vivi” dalla passione degli attuali curatori, e si sposta poi alla periferia di Forlì, nel cuore di una bella casa padronale, Villa Saffi, già sede di riunioni carbonare, che dal 1861 ha ospitato il leader mazziniano e democratico Aurelio Saffi e sua moglie Giorgina Craufurd. Inglese di origine, ma patriota italiana per passione politica, amica e collaboratrice di Mazzini, Giorgina partecipa con slancio alle vicende del Risorgimento e organizza le prime società di mutuo soccorso per le donne lavoratrici. Abbiamo scelto di parlare di lei in omaggio alle tante donne protagoniste dimenticate delle battaglie risorgimentali e degli albori delle lotte emancipazionistiche. Risorgimento e melodramma rivivono in un prodotto solo apparentemente minore, ma in realtà potente ed estremamente comunicativo: la figurina, gioco dell’infanzia, magica icona della cultura divenuta seriale e popolare, concentrato di storia nazionale. Lo straordinario museo modenese dedicato appunto alle figurine ne raccoglie centinaia di migliaia. Per il nostro viaggio abbiamo ovviamente privilegiato quelle dedicate alle opere verdiane e ai protagonisti dell’unità d’Italia. Abbiamo deciso di concludere il “lungo” Ottocento nel segno della rivoluzione tecnologica e quindi della modernità: Villa Griffone, sulle colline bolognesi, è il teatro del primo riuscito esperimento di radiocomunicazione compiuto nel 1895 da un giovane e appassionato autodidatta, Guglielmo Marconi. Un piccolo, emozionante filmato ce lo mostra all’opera. Pioniere del wireless, Marconi riceverà il premio Nobel nel 1909. La musica, in Emilia-Romagna, non si identifica solo con Giuseppe Verdi. L’itinerario tematico è in questo caso particolarmente denso di snodi e punti di sosta. La prima tappa, che funge anche da centro propulsivo per successive esplorazioni, è il Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna, il cui nume tutelare è il padre francescano Giovanni Battista Martini, una delle personalità più illustri del Settecento musicale europeo, che ebbe anche Mozart tra i suoi allievi. Un allievo particolarmente apprezzato, visto che padre Martini non esitò a correggergli il compito con cui altrimenti non sarebbe forse riuscito a superare la prova di ingresso nella prestigiosa Accademia Filarmonica bolognese. Il museo bolognese conserva, tra l’altro, una splendida raccolta di strumenti musicali. Collezioni di strumenti sono conservate in molti altri musei. Tra questi abbiamo scelto il Castello della musica ospitato nell’antica Rocca Sanvitale di Noceto, che affianca due diverse raccolte: gli strumenti del maestro liutaio Renato Scrollavezza e gli oltre duemila dischi in vinile a 78 e a 33 giri di musica lirica e sinfonica appartenuti al IBC 2013 giornalista sportivo e melomane Bruno Slawitz. Le registrazioni che proponiamo sono imperfette, ma le voci dei cantanti decisamente affascinanti. Quanto agli strumenti musicali, accanto a quelli di più nobili tradizioni, non potevamo dimenticare strumenti popolari e curiosi come le ocarine di Budrio, ben rappresentate nel museo a loro dedicato, con le quali si suona di tutto, e ovviamente anche Verdi. Se l’Emilia-Romagna rimane, come è stata definita, la terra del melodramma, l’epicentro tellurico è sicuramente nell’antico ducato governato da Maria Luigia d’Austria. A Parma, nel 1867, nel quartiere operaio e popolare di Oltretorrente (quello che il trasvolatore fascista Italo Balbo non riuscì a espugnare), è nato Arturo Toscanini, tra i più celebri direttori d’orchestra del mondo, che ha conquistato le platee internazionali con la forza irresistibile delle sue interpretazioni sia operistiche che sinfoniche. La sua casa è un museo ricco di oggetti, documenti, immagini e riproduzioni sonore originali. Pietro Mascagni era livornese, ma i casi della vita lo hanno portato spesso in terra di Romagna: la chiesa parrocchiale di Bagnara di Romagna ospita infatti un piccolo museo a lui dedicato, traboccante di spartiti, dipinti, fotografie, dediche. Merito della bella Anna Lolli, la cantante con cui Mascagni visse una lunga e romantica storia d’amore, testimoniata dalle oltre quattromila lettere qui conservate. Era invece pesarese di nascita, ma legato a Lugo e a Bologna, dove visse in fasi diverse della sua vita, Gioachino Rossini. L’autore del Barbiere di Siviglia e del Guglielmo Tell è stato anche un raffinato buongustaio, amante della buona tavola e del buon vino. Alle prese una volta con una composizione musicale, sembra abbia confessato: “Sto cercando buoni motivi, ma non mi vengono in mente che pasticci, tartufi e cose simili”. La duplice passione rossiniana per la musica e per il cibo ci permette di introdurre un breve percorso gastronomico, quasi d’obbligo viste le caratteristiche peculiari del nostro territorio. Così, per scoprire i segreti della nobile arte della norcineria, si visita il Museo del prosciutto di Langhirano, che fa autorevolmente parte della confraternita dei musei del gusto emiliano-romagnoli, e ci si reca poi in rispettoso pellegrinaggio nella Casa Artusi di Forlimpopoli, che insieme al museo ospita una biblioteca, un ristorante e una scuola di cucina. Secondo molti autorevoli critici, a Pellegrino Artusi – autore, nel 1871, del famoso manuale La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene – va il merito di aver collaborato a una seconda importante Unità d’Italia: quella degli italiani a tavola. Questi sono alcuni dei nodi e dei punti di sosta della nostra esplorazione sotto l’ala protettrice di Verdi. Come è evidente, si tratta di scelte motivate, che non esauriscono però le possibilità di connessione dei musei tra loro. Altri potrebbero privilegiare fili conduttori diversi e produrre così – come è nell’intenzione degli ideatori della piattaforma – universi sempre nuovi, veri e propri moltiplicatori di storie e narrazioni. [“IBC”, XXI, 3, luglio/settembre 2013; dossier Musei Multiverso. Un software per creare e collegare universi culturali, a cura di Vittorio Ferorelli] 79 La Galleria comunale “Villa Franceschi” fa rincontrare, a due passi dal mare, il talento pittorico di Antonio Ligabue e quello artistico e narrativo di Cesare Zavattini. Toni e Za, insieme a Riccione Orlando Piraccini Dicono a Riccione che una mostra così non s’era mai vista. Che non s’erano mai contati tanti turisti “giornalieri”, arrivati qui da ogni parte proprio per incontrare lui, Toni; e poi, magari, anche per un po’ di mare e un raggio di sole e una “vasca” nel rinomato viale Ceccarini. Secondo alcuni, è tornata a brillare l’adriatica “perla” da quando si è cominciato a propagandare meno il divertimentificio e si fa un po’ più cultura. Stan tornando i tempi belli? Quelli della mondanità balneare che nel dopoguerra fu perfino colorata ad arte? Qualcuno ricorda quando il “Savioli” faceva feste e chiamava a sé i celebri artisti a dipingere dal vero; e quando potevi vedere Guttuso e altri protagonisti della rinascente pittura italiana alle esposizioni del Palazzo del Turismo. Intanto, apposta per presentare Ligabue (Toni), a Riccione è tornato Za (Zavattini), che nella “fascinosa” era venuto già nel ’47: e quella volta per tributare onore (e consegnare premio) a un artista di talento della parola come Italo Calvino. Durante quest’estate, migliaia son stati i visitatori che si son fatti guidare dallo scrittore di Luzzara nell’universo fantastico di Ligabue. E sotto l’ombrellone, intanto, ci si interrogava: ma cos’è questa mostra di Ligabue: una specie (Cesare ci perdoni!) di “miracolo a Riccione”?; oppure (più realisticamente, a nostro parere) c’entra un po’ di “buon governo”? o è in atto (più verosimilmente, sempre secondo noi) un “effetto museo” di Villa Franceschi che prima non c’era? Prodigi e politiche culturali a parte, nel villino che fu luogo di vacanza della famiglia imolese dei Franceschi, due fatti sono accaduti: che un’istituzione culturale ancora “bambina” (con i suoi appena otto anni di vita) è arrivata a far di Riccione un caposaldo nel sistema regionale dell’arte moderna e contemporanea, e che il successo (sperato certo, ma non così clamoroso) ha segnato una mostra promossa – è vero – nel nome sempre attraente (e di sicuro richiamo) di Ligabue, ma che certo il “fantasmone” zavattiniano ha finito per rendere preziosamente unica e per questo ancor più mirabile. IBC 2013 Una casa per l’arte Questa, in formato ristretto, la “carta d’identità” di Villa Franceschi, che è stata offerta ai visitatori della mostra “Ligabue: ‘Toni’ e la sua arte nel racconto di Cesare Zavattini” (11 luglio - 6 ottobre 2013).1 –– Nome: Galleria d’arte moderna e contemporanea; –– Proprietà: Comune di Riccione; –– Anno di nascita: 2005; –– Luogo: via Gorizia, adiacenze Grand Hotel; –– Tipologia edificio: villino residenziale; –– Ideatori: Lorenzo Campioni, Nazareno Pisauri; –– Progettisti del restauro architettonico: Pier Luigi Foschi, Stefano Guidi, Luciano Zavatta; –– Caratteristiche e impianti: secondo i più aggiornati standard museali; –– Servizi al pubblico: visite guidate, supporti informativi, cataloghi, archivio; –– Attività collaterali: cicli di conferenze, incontri, laboratori didattici; –– Direzione: Daniela Grossi; –– Organo consultivo: comitato tecnico-scientifico; –– Partner: Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBC), Provincia di Rimini; –– Organismi di supporto: associazione “Amici dei Musei di Riccione”; –– Ordinamento espositivo: Claudio Spadoni; –– Esposizione permanente: opere della collezione comunale d’arte e della “Raccolta Arcangeli” (deposito dalla Regione Emilia-Romagna); –– Principali mostre temporanee: “Nicolosa Rastelli Leziroli” (2006), “Virgilio Guidi” (2007), “Aldo Borgonzoni, testimone del tempo” (2009), “Lucio Saffaro” (2009), “60 - sessanta e dintorni” (2010), “Sogni di carta” (2011), “Filippo de Pisis” (2012), “Ligabue” (2013). È museo – “Certo che siamo museo!”, dicono a Villa Franceschi – ma questa era una casa per le vacanze e oggi è una casa per l’arte. E non per caso: qui si punta molto sull’accoglienza, sull’essere “musealisticamente” ospitali. Ma l’alto gradimento sembrerebbe dipendere assai dalla formula: ovvero, il frequente “cambiar faccia” della galleria, con opere che entrano ed escono dal deposito secondo ben studiati schemi espositivi, e, specialmente con l’innesto di mostre temporanee di notevole presa sulla comunità riccionese, ma anche di forte richiamo per l’utenza turistica. Non mancano poi i segni di un lavoro faticoso ma redditizio, che riguarda la costruzione di una rete di rapporti con altre istituzioni culturali “consorelle” in ambito territoriale sia locale che nazionale. Qui è stato ben inteso il richiamo autorevole di Ezio Raimondi, quando era presidente dell’IBC, a far del museo un laboratorio dell’“intesa negoziata”: capace, cioè, di dar luogo davvero a un sistema relazionale tra soggetti ed enti diversi tra loro, ma tale da favorire anche aperture, scambi, confronti tra comunità troppo spesso chiuse in sé stesse e alle prese con i loro interessi di campanile. Si dicono sicuri, a Villa Franceschi, che grandi mostre recenti – come quelle di Borgonzoni e di Guidi e di de Pisis e, oggi, quella stessa di un Toni “introdotto” da 81 82 musei e beni culturali Za – non sarebbero state possibili senza un’adeguata “rete”, protettiva e propositiva al tempo stesso. È evidente, infatti, che nel “valore aggiunto” della presenza zavattiniana alla straordinaria rassegna su Ligabue non può proprio esservi stata casualità. L’idea – la “trovata”, come da qualcuno a Riccione è stata definita – di affidarsi a Zavattini (lui artista della parola e, come ben si sa, anche del colore) per fare la conoscenza di Ligabue e della sua opera, è scaturita dal “prorompente” archivio che di Cesare porta il nome. Archivio che gli eredi hanno donato alla Biblioteca “Antonio Panizzi” di Reggio Emilia e che la Soprintendenza regionale per i beni librari e documentari ha giustamente posto sotto la propria osservazione. Proprio le carte hanno rivelato il gran lavoro di Za “su Ligabue”: dal testo in forma poetica del ’67 (ripubblicato nel 1974 dall’editore Scheiwiller nella collana “All’Insegna del pesce d’oro” e poi, dieci anni più tardi, nei “Tascabili Bompiani”) fino al soggetto e alla sceneggiatura per il film di Salvatore Nocita che la televisione italiana ha mandato in onda nel 1978; e poi gli appunti, i preziosissimi “echi della stampa”; e poi ancora, e verrebbe da dire specialmente, certi ricordi del “Toni” in forma di disegni e incisioni. Così, dunque, Cesare Zavattini è ritornato a Riccione per raccontarci di un artista delle sue parti, da tutti chiamato “Toni”: un tipo po’ strano, ma che, in fondo in fondo, “era uno di noi”. Il ritorno di Za “Ho attraversato la piazza di Luzzara fingendo di essere Antonio Ligabue”. Così parlando, Cesare Zavattini si è ripresentato a Riccione, esattamente come aveva scritto quasi in apertura del memorabile poemetto dato alle stampe da Franco Maria Ricci nel ’67. Come il lettore di allora, Za è sembrato avvertire il visitatore di oggi: che sì, lui, insomma, ha provato a essere un “biografo serio”, magari anche riuscendovi, ma le sue parole, di nuovo pronunciate, dovevano essere intese come una dedica al “Toni”, venute da dentro, da un sentire forte, da uno stato di immedesimazione, appunto. Si può dire oggi, stando agli indici di gradimento espressi dal pubblico, che quella storia, che Zavattini aveva cominciato a raccontare nel “caldo antico” di ferragosto, a due anni appena dalla scomparsa di Ligabue, è stata ancora capace di stimolare un contatto più diretto e ravvicinato con l’autore di una pittura tanto speciale, nata come nelle favole. Certo, sul fenomeno Ligabue non sono mancati, specialmente in quest’ultimo periodo, importanti studi e ricerche; e giustamente sono stati anch’essi richiamati nella mostra riccionese per una più agevole esplorazione del fantastico mondo del pittore di Gualtieri. Ma l’approccio zavattianiano a Ligabue è stato davvero altra cosa, perché scaturito proprio da quella fatale attrazione per la pittura che così gran breccia ha fatto nella poliedrica creatività del maestro luzzarese. È un aspetto che abbiamo avuto personalmente modo di indagare (bella impresa davvero!): non semplicemente sulle questioni del fare arte, ma sul modo – teorizzato da Za, appunto – di intendere l’arte entro la cornice sociale del suo tempo. E su questo punto sono ancora tanti i codici da decifrare per stabilire una giusta connessione, per esempio, fra lo Zavattini artista dell’immagine e quello artista della parola, fra lo Zavattini che dipinge, insomma, e quello che parla e scrive di pittura. È ancora im- IBC 2013 perscrutabile, infatti, la sfera nella quale si proiettano certi giudizi sibillini rivolti a sé stesso, del tipo: “Ho messo in giro la voce che sono un pittore che non sa dipingere. Ma è certo che sono un pittore?”; e come non tenere in buon conto certi frequenti gridi d’allarme, per esempio per le manipolazioni commerciali di un’arte senza più autenticità e originalità, del tipo: “Si può anche non fare pittura. Anzi, qualche volta il non farla può diventare un atto creativo. Mi sono spiegato?”. Ma se è vero che Zavattini ha intravisto nella pittura da lui identificata come autenticamente naïve la giusta via per una rottura clamorosa con il reale, con i conformismi degli stili correnti, nella vita come nell’arte, non è allora scandaloso affermare che il colloquio del nostro con quel tipo di creatività, a quel punto, è andato oltre le parole, investendo direttamente, forse, le ragioni fondanti del suo far pittura. Il dialogo del pittore con l’uomo Ligabue appare allora veramente ravvicinato: perché proprio i selvaggi visionari padani della naïveté hanno “rotto il fronte ‘angelico’” o spezzato i canoni dominanti di una rimembranza involuta e retorica, svuotata di ogni viva memoria, come anche dell’esotico più improbabile, bamboleggiante o zoofilo, e perfino da tanta arcadia pervaso. È stata, questa di Riccione, una buona occasione per rileggere certe riflessioni di Za sull’improbabilità del proprio operare in rapporto all’“arte ufficiale”, riflessioni intese talora dalla critica come vezzosi autocompiacimenti, ma che meglio sarebbe considerare come autentici esercizi di ironia. Per rileggerle alla luce della personale esperienza di pittore nella sfera di una creatività sostanzialmente esercitata per diletto, sorretta dalla fantasia, ma ravvivata da una speranza tenace sulle infinite possibilità della pittura, pur ammettendo che “un giorno non si dipingerà più, qualora il dipingere venga inteso come un modo di essere e di capire, e l’iter del pennello troppo lento per partecipare non soltanto ideologicamente agli eventi”. È casuale il fatto che nel 1975 (quando Za ancora scriveva su Ligabue per il catalogo della grande mostra di Gualtieri e in più occasioni aveva polemizzato contro certa visione idealistica dell’arte, biasimando “le deteriori conseguenze dell’ammirazione per il pittore, per l’‘artista geniale’”, dato che “non è l’individuo pittore che dobbiamo ammirare, ma l’uomo, l’uomo come specie, che è capace di dipingere, e di fare mille altre cose”), è casuale che proprio in quell’anno sia nata una serie infinita di autoritratti, con le loro condense colorate di riflessioni, umori, sensazioni, stupori? È come se Zavattini avesse voluto farsi direttamente carico di risposte concrete alla questione assolutamente etica di un’arte intesa “come patrimonio e strumento comune e quotidiano: non più fatta ‘da altri’ e in fondo ‘per altri’”. Una questione che era stata stimolata dall’esperienza naïve, ma di fatto era rimasta sostanzialmente irrisolta. Nota (1) Ligabue: “Toni” e la sua arte nel racconto di Cesare Zavattini, a cura di D. Grossi e C. Spadoni, Torino, Umberto Allemandi & C., 2013, 144 pagine, 25,00 euro. [“IBC”, XXI, 3, luglio/settembre 2013] 83 Chi realizza una mostra documentaria è chiamato a dare forma visiva ed evocativa a processi creativi che, di per sé, non si vedono e non si sentono. Da Bellaria a Lubecca e Zurigo, ecco due esempi ben riusciti. Allestire l’invisibile Maria Gregorio L’estate 2013 ci ha regalato due bellissime mostre letterarie. Due mostre esemplari, non soltanto perché allestite alla perfezione, ma anche perché illustrano in modo esemplare, appunto, due vie molto diverse ma altrettanto valide per realizzare un’esposizione letteraria: si tratti di mettere in scena un’opera o un personaggio. In questo caso: Thomas Mann e il racconto La morte a Venezia, al Buddenbrookhaus di Lubecca e allo Strauhof Museum di Zurigo; Alfredo Panzini e le donne, nella Casa Rossa di Bellaria Igea Marina (Rimini), il museo dedicato allo scrittore. Vale la pena di osservarle da vicino, accostandole. Raramente, infatti, è possibile capire con tanta chiarezza quali intendimenti e quali strumenti possano raggiungere per vie diverse il comune obiettivo: dare forma visiva ai processi che, nel tempo, disegnano e modificano l’immagine di un autore e della sua opera. Perno di tutto è l’allestimento, ossia la costruzione del percorso espositivo ideato dal curatore regista o dall’artista allestitore per offrire una rappresentazione visiva della “cosa” letteraria. Ho, così, citato i due artefici all’opera. Da un lato, un curatore che, coadiuvato da chi realizza l’allestimento, stabilisce una precisa regia espositiva; dall’altro, un artista che, attento alle indicazioni del curatore, crea, ordinandoli nello spazio, gli oggetti necessari a rappresentare il tema prescelto. Entrambi partono, com’è indispensabile, dall’interpretazione. Nel primo caso, il curatore regista delinea, quale forma visiva della sua interpretazione, il percorso della mostra, invitando il visitatore a confrontarsi razionalmente ed emotivamente con il nuovo che scaturisce da ogni rappresentazione espositiva. Nel secondo, l’artista dà forma all’interpretazione attraverso un dialogo fatto di consonanze e dissonanze, da lui stesso innescato, tra gli oggetti di nuova creazione, i materiali preesistenti, lo spazio: giocando sulla sorpresa e sullo spaesamento, sfida il visitatore a prendere atto dello “scarto” rivelato dal suo gesto creativo. IBC 2013 Varchiamo, ora, la soglia dei due musei. La mostra che ha per titolo “Voluttà della decadenza. ‘La morte a Venezia’ di Thomas Mann” è stata originariamente allestita al Buddenbrookhaus di Lubecca nella primavera del 2012, a cento anni dalla pubblicazione del racconto. Il Museum Strauhof di Zurigo, l’ha ospitata nell’estate del 2013, aggiungendovi una nuova sezione dedicata a Richard Wagner, a duecento anni dalla nascita del musicista. Molto stretto è infatti il rapporto di Thomas Mann con la musica e la figura di Wagner, che a Venezia, dove compose il duetto d’amore del Tristano, morì. Al centro della mostra è il testo del racconto, messo in scena seguendo le tracce del protagonista, Gustav von Aschenbach, durante il suo soggiorno lagunare, fino a quando la morte pone fine al suo “decadere”. Il visitatore è sollecitato ad accompagnarlo per così dire fisicamente, muovendosi con lui passo dopo passo (scortato, ove lo desideri, da un’ottima audioguida), scoprendo per via i temi che innervano il racconto e la struttura narrativa che vi è sottesa. Nella mostra, come nel “romanzo percorribile” costruito da Hans Wißkirchen nel Buddenbrookhaus di Lubecca, il visitatore cammina nel testo, lo legge e lo guarda, lo vive in prossimità e a distanza. E anche in questo nuovo allestimento si avverte, con forza, la mano salda del curatore regista. Un modulo allestitivo segna più di ogni altro e in modo estremamente efficace l’intero percorso espositivo: il susseguirsi di pannelli quadrati, inclinati su un sostegno che li regge a circa settanta centimetri da terra. Ogni pannello reca scritto un passo saliente del racconto, che sembra così “svolgersi” dinnanzi ai nostri occhi durante il tempo della visita. I caratteri a stampa sono studiati per far sì che il visitatore non debba chinarsi per leggere, riuscendo a seguire agevolmente il testo e, nella stessa posizione, a guardare gli oggetti e le immagini intorno. Aggiungerei: riuscendo a percepirsi e a viversi nello spazio creato da testo, oggetti e immagini. È uno spazio che muta di “stazione” in “stazione”: partendo da Monaco, dove sono vissuti Thomas Mann e il suo alter ego Gustav von Aschenbach, fino a Venezia, dove il visitatore arriva oltrepassando una pozza di laguna creata sul pavimento da un proiettore, a segnare la soglia. Pertanto, non si attraversano “sale” bensì, appunto, “stazioni narrative”, reali e mentali, costruite mediante banner illustrativi, videoproiezioni e gigantografie fotografiche, usate per ricreare sullo sfondo l’atmosfera della città, dei canali, dell’albergo, del Lido. Mentre oggetti, quadri, statue, fotografie, vetrine con libri, documenti e periodici (sempre disposti in modo da poterli leggere con agio) rendono visivamente e sensorialmente presenti sia i temi e i personaggi del racconto, sia quelli che aleggiano sul fondo: la figura problematica dell’artista, la mitologia greca, la filosofia di Nietzsche, l’omosessualità, per citarne alcuni. Il legame tra gli avvenimenti narrati e quelli vissuti dall’autore è qui strettissimo. Immersi in questa atmosfera, sollecitati da queste presenze, si cammina attraverso la mostra sempre seguendo il testo con gli occhi e con la mente che, in un certo modo, rimane quasi più vigile di quanto non sia quando leggiamo nel silenzio di una stanza. Ciò avviene perché la “ricreazione” del testo in forma espositiva sollecita la reazione del visitatore, insieme emotiva e attivamente critica, grazie alla sequenza delle citazioni sui pannelli, veri e propri segnavia che ordinano il percorso in un fitto dialogare con gli oggetti e le immagini. Come a dire che, per capire, è necessario 85 86 musei e beni culturali abbandonarsi alla “voluttà” della lingua e della visione, ma rimanendo vigili entro i confini e ben saldi sulle gambe, per decifrare – osservando, leggendo, ragionando – la lettura nuova del testo che la regia offre all’intelligenza dei sensi e della mente. Nella Casa Rossa dello scrittore Alfredo Panzini, che riapre le porte ogni primavera a Bellaria Igea Marina per concludere la stagione con l’autunno, si è inaugurata nel giugno 2013 la nuova mostra: “Alfredo Panzini e lo stile delle donne”. Come di consueto, la cura scientifica è firmata dal direttore, Marco Antonio Bazzocchi, l’allestimento è stato realizzato dall’artista Claudio Ballestracci. La solidità scientifica, guizzante di ironica fantasia, e l’impronta artistica, saldamente ancorata alla conoscenza di tecniche e materiali, contrassegnano fin dall’inizio questo straordinario unicum nel panorama museale italiano. Qui, infatti, non vediamo interventi d’artista aggiunti o integrati in un allestimento dato: qui, l’intero allestimento è ogni volta ricreato come opera d’arte a sé stante. Così potremmo forse sintetizzare il modo in cui Ballestracci lavora all’allestimento del museo: rimane in paziente ascolto della vita che ha impregnato le stanze e, quand’essa si svela, egli crea oggetti che di quella vita recano una traccia visibile ma, senza lasciarsene imprigionare, vivono di vita propria, dando corpo a un’intensa relazione di scambio tra ciò che è stato e ciò che è. Approfittando della libertà offertagli da una casa pressoché priva di arredi e oggetti originali, l’artista studia con sapienza e amore i pochi rimasti per trarne ispirazione e mandare “in luce al mondo” i nuovi oggetti, portatori della sua poetica, fedeli all’anima della casa. Questo significa interpretare tenendo viva la memoria. Per nostro diletto, molti di questi oggetti creati in occasione delle mostre che si sono susseguite nel tempo continuano a vivere anche in quella nuova. Di fatto, in quest’ultima esposizione ci sono tre mostre in una. La prima vede protagoniste le donne di cultura dell’epoca: Sibilla Aleramo, Margherita Sarfatti, Ada Negri. Protagoniste della seconda sono Clelia, la moglie pittrice, presente in tutte le sale con le sue opere, e la figlia Matilde, fervente ammiratrice del padre. Al centro della terza è invece lo stesso scrittore, appassionato cultore di moda. Le quattro “vele” poste nella sala d’ingresso sono ovviamente ispirate al tema e la prima reca un testo dattiloscritto di Panzini sull’abbigliamento femminile: volutamente “bianca”, su di essa vengono proiettate immagini di figure tratte da riviste di moda conservate nell’archivio. Alle pareti, i primi quattro dipinti di Clelia: ritratti familiari scelti per introdurre il visitatore, accolto da canzoni d’epoca, tra gli abitanti della casa. Si entra nel “Soggiorno delle carte”, dove dominano sette faldoni d’archivio che contengono sette riviste di moda dell’epoca. Ricreati in materiale “trasparente”, illuminati da una striscia a luce calda, i faldoni poggiano su due tavoli in lamiera zincata ossidata, ponendosi così in relazione con le pareti della sala, dipinte a tempera detta polverosa. Tra i due tavoli ecco la base di lamiera su cui è appoggiata la bicicletta (l’ultima usata da Panzini), illuminata da una lampada costruita ad hoc usando i tubi per l’irrigazione dei campi: un riferimento alla passione dello scrittore per la vita povera, di campagna, come lo sono la lamiera zincata, usata in tutto l’allestimento, e così pure i cartellini “volanti”, sostenuti da un filo di ferro. A una parete il comò, il IBC 2013 cui lungo cassetto illuminato mostra cinque disegni caricaturali dello scrittore. Sulla parete di fronte, il mobile a vetrina originale, illuminato all’interno, ospita i ritagli di stampa amorevolmente raccolti dalla figlia, accompagnati da alcuni oggetti: forbici, un pennino, un calamaio, una cartolina. “Objets à vocation poétique”, li avrebbe definiti Le Corbusier. Al primo piano, la “Stanza di Alfredo”, interamente dedicata a Clelia, offre due novità emozionanti. A ciascuno dei dodici aerei leggii (che ora portano disegni di lei, ma sono presenti fin dalla mostra inaugurale) è stata aggiunta una lampada: il braccio che la sostiene, fissato nella parte alta dello stelo, è di tubo in rame ossidato, mentre la testa è in tubo di ferro zincato. Forma e colore riprendono elementi figurativi del soffitto. È uno dei “paesaggi” della casa più fiabeschi. La grande scrivania, dove sono esposti documenti che illustrano la vita professionale di Clelia, è stata “elettrificata” con un sistema che prevede l’inserimento di contenitori trasparenti luminosi, alloggiati nei cassetti: l’“antico” che racchiude il contemporaneo dell’alta tecnologia. Non è infatti mancato, tra i visitatori, chi evocasse Tron, un film di fantascienza. Nella stanza da letto è adagiato sulle lenzuola il telo che porta impressa la copertina di una rivista di moda, mentre nell’armadio rimane la divisa che Panzini indossava come “accademico d’Italia”, schermata dal velo che riproduce il lemma “accademico”, tratto dal suo Dizionario. Di fronte, la magica teca-lanterna sormontata dalla piuma (metafora della scrittura), che racchiude gli occhiali e un ritratto di Panzini. Dal comodino, elettrificato, occhieggiano due fotografie di Matilde, bambina e giovinetta. Ma, ancorché piccola, a dominare la stanza e forse l’intero allestimento di quest’anno è la nuova teca dedicata proprio alla figlia Matilde. “Micromondo teatrale” la definisce Claudio Ballestracci, che spiega: “Ho avvertito il bisogno di introdurre un elemento drammaturgico: le immagini in movimento, l’attrice che ascoltiamo leggere la lettera della figlia mentre guardiamo nella teca le scarpette e la foto di lei bambina, la musica di Janáček che risuona nella stanza... Come se volessi far vivere ai visitatori un’emozione, una sensazione in miniatura. Così anche nell’allestimento di Casa Finotti, dove ho esposto il manoscritto di un quaderno in cui Piero, figlio di Panzini, descrive il fattore. E anche in questo caso ho voluto una voce di attrice a leggere il testo e l’accompagnamento di una canzone di Charles Trenet, Je chante”. “Essere immerso in un mondo di totale felicità in cui ogni cosa insignificante si impregna di significato”: in queste parole di Joseph Cornell c’è forse la chiave dell’arte posta al servizio dell’allestimento. [“IBC”, XXI, 4, ottobre/dicembre 2013] 87 100 case popolari Fotografie di Fabio Mantovani 100 case popolari è un racconto itinerante di Fabio Mantovani, incentrato sul progetto residenziale collettivo che dagli anni Sessanta del Novecento ha cambiato il volto di buona parte del territorio urbano italiano. Una stagione dell’architettura apparentemente indifferente alle coordinate geografiche dei luoghi. Otto le realtà presentate in queste pagine: Pilastro+Virgolone e Barca a Bologna, Gallaratese a Milano, Forte Quezzi a Genova, Rozzol Melara a Trieste, Villaggio Matteotti a Terni, Corviale a Roma, Zona Espansione Nord a Palermo. Lo sguardo di Mantovani insiste sul rapporto tra corpi e spazi, cogliendo insieme il persistere delle architetture e l’attraversamento quotidiano delle persone. Dopo la prima esposizione nel marzo del 2013 all’interno dello Spazio Lavì di Sarnano, il progetto, curato da Sara Marini, è stato presentato al pubblico nella sede dell’associazione “duepuntilab” di Bologna dal 25 ottobre al 10 novembre 2013. Bolognese, classe 1970, Fabio Mantovani è fotografo professionista dal 1996 (www.fabiomantovani.com). I suoi campi di azione sono l’architettura, l’immagine aziendale e il reportage sociale. Ha pubblicato servizi su varie riviste italiane, tra cui “D Repubblica delle donne”, “Style - Corriere della Sera”, “Private”, e internazionali: “Monocle”, “Japan Times”, “Le Monde”, “Ojo de Pez”. Le sue foto sono apparse su testate di architettura italiane e europee come “Ottagono”, “D-Casa”, “Il Magazine dell’Architettura”, “Progetti”, “AW-Archiworld”, “Modulor”. Per approfondire si veda, nelle pagine di questo volume, l’articolo di Sara Marini pubblicato nel numero 2-2013 della rivista “IBC”. 90 100 case popolari “Cento case popolari”: Bologna, Quartiere Pilastro, 2012 fotografia di Fabio Mantovani IBC 2013 “Cento case popolari”: Bologna, Quartiere Pilastro, 2012 fotografia di Fabio Mantovani 91 92 100 case popolari “Cento case popolari”: Bologna, Quartiere Barca, 2012 fotografia di Fabio Mantovani IBC 2013 “Cento case popolari”: Bologna, Quartiere Barca, 2012 fotografia di Fabio Mantovani 93 94 100 case popolari “Cento case popolari”: Milano, Quartiere Monte Amiata al Gallaratese, 2012 fotografia di Fabio Mantovani IBC 2013 “Cento case popolari”: Milano, Quartiere Monte Amiata al Gallaratese, 2012 fotografia di Fabio Mantovani 95 96 100 case popolari “Cento case popolari”: Milano, Quartiere Monte Amiata al Gallaratese, 2012 fotografia di Fabio Mantovani IBC 2013 “Cento case popolari”: Milano, Quartiere Monte Amiata al Gallaratese, 2012 fotografia di Fabio Mantovani 97 98 100 case popolari “Cento case popolari”: Trieste, Rozzol Melara, 2012 fotografia di Fabio Mantovani IBC 2013 “Cento case popolari”: Trieste, Rozzol Melara, 2012 fotografia di Fabio Mantovani 99 100 100 case popolari “Cento case popolari”: Trieste, Rozzol Melara, 2012 fotografia di Fabio Mantovani IBC 2013 “Cento case popolari”: Genova, Forte Quezzi, 2012 fotografia di Fabio Mantovani 101 102 100 case popolari “Cento case popolari”: Genova, Forte Quezzi, 2012 fotografia di Fabio Mantovani IBC 2013 “Cento case popolari”: Genova, Forte Quezzi, 2012 fotografia di Fabio Mantovani 103 104 100 case popolari “Cento case popolari”: Terni, Villaggio Matteotti, 2013 fotografia di Fabio Mantovani IBC 2013 “Cento case popolari”: Terni, Villaggio Matteotti, 2013 fotografia di Fabio Mantovani Alle pagine seguenti “Cento case popolari”: Terni, Villaggio Matteotti, 2013 fotografia di Fabio Mantovani 105 106 100 case popolari IBC 2013 107 108 100 case popolari “Cento case popolari”: Roma, Corviale, 2012 fotografia di Fabio Mantovani IBC 2013 “Cento case popolari”: Roma, Corviale, 2012 fotografia di Fabio Mantovani 109 110 100 case popolari “Cento case popolari”: Roma, Corviale, 2012 fotografia di Fabio Mantovani IBC 2013 “Cento case popolari”: Palermo, ZEN, 2013 fotografia di Fabio Mantovani 111 112 100 case popolari “Cento case popolari”: Palermo, ZEN, 2013 fotografia di Fabio Mantovani IBC 2013 “Cento case popolari”: Palermo, ZEN, 2013 fotografia di Fabio Mantovani 113 Confotografia Fotografie di Iolanda Di Bonaventura, Evelina Favaro, Sara Sagui, Giorgio Serri Dal 20 al 26 settembre 2013 più di cinquanta fotografi provenienti da tutta l’Italia si sono dati appuntamento a L’Aquila per confrontarsi, discutere e osservare il territorio, mettendosi al fianco degli aquilani che ogni giorno, da quattro anni, lottano per riportare in vita la loro città martoriata dal terremoto. Il progetto, intitolato Confotografia (www.confotografia.net), è stato completamente autofinanziato dai partecipanti, che sono partiti a proprie spese e si sono messi al lavoro senza una committenza esterna, invitati dalle due associazioni promotrici, “Segni” e “Fuorivista” (www.fuorivista.org). Ogni partecipante è stato associato a una “guida” locale: un cittadino disponibile a introdurre il fotografo alla sua conoscenza quotidiana e ravvicinata del territorio. Tra i risultati più importanti c’è proprio questa esperienza di condivisione, possibile grazie a un atteggiamento di fiducia da parte di tutti: molti dei fotografi sono intenzionati a ritornare in città e i partecipanti aquilani hanno promesso di redigere una lista di cittadini che intendono rinnovare la propria disponibilità a ospitare e guidare i fotografi nel prosieguo del loro lavoro. In questo inserto presentiamo una selezione delle immagini realizzate dietro le quinte della manifestazione e nel corso delle varie iniziative realizzate per riflettere, per camminare e per guardare insieme. Per approfondire si veda, nelle pagine di questo volume, l’articolo di Alessandra Chemollo pubblicato nel numero 4-2013 della rivista “IBC”. 116 confotografia “Confotografia”, L’Aquila, 20-26 settembre 2013 fotografia di Evelina Favaro IBC 2013 “Confotografia”, L’Aquila, 20-26 settembre 2013 fotografia di Evelina Favaro 117 118 confotografia “Confotografia”, L’Aquila, 20-26 settembre 2013 fotografia di Evelina Favaro IBC 2013 “Confotografia”, L’Aquila, 20-26 settembre 2013 fotografia di Evelina Favaro 119 120 confotografia “Confotografia”, L’Aquila, 20-26 settembre 2013 fotografia di Evelina Favaro IBC 2013 “Confotografia”, L’Aquila, 20-26 settembre 2013 fotografia di Evelina Favaro 121 122 confotografia “Confotografia”, L’Aquila, 20-26 settembre 2013 fotografia di Evelina Favaro IBC 2013 “Confotografia”, L’Aquila, 20-26 settembre 2013 fotografia di Evelina Favaro 123 124 confotografia “Confotografia”, L’Aquila, 20-26 settembre 2013 fotografia di Iolanda Bonaventura IBC 2013 “Confotografia”, L’Aquila, 20-26 settembre 2013 fotografia di Sara Sagui 125 126 confotografia “Confotografia”, L’Aquila, 20-26 settembre 2013 fotografia di Sara Sagui IBC 2013 “Confotografia”, L’Aquila, 20-26 settembre 2013 fotografia di Sara Sagui 127 128 confotografia “Confotografia”, L’Aquila, 20-26 settembre 2013 fotografia di Sara Sagui IBC 2013 “Confotografia”, L’Aquila, 20-26 settembre 2013 fotografia di Sara Sagui 129 130 confotografia “Confotografia”, L’Aquila, 20-26 settembre 2013 fotografia di Sara Sagui IBC 2013 “Confotografia”, L’Aquila, 20-26 settembre 2013 fotografia di Sara Sagui Alle pagine seguenti “Confotografia”, L’Aquila, 20-26 settembre 2013 fotografia di Sara Sagui 131 132 confotografia IBC 2013 133 134 confotografia “Confotografia”, L’Aquila, 20-26 settembre 2013 fotografia di Sara Sagui IBC 2013 “Confotografia”, L’Aquila, 20-26 settembre 2013 fotografia di Giorgio Serri 135 T erritorio e beni architettonici -ambientali Un progetto fotografico di Fabio Mantovani racconta otto grandi agglomerati architettonici di edilizia popolare italiana, da Bologna in su e in giù. Cento case e un affresco Sara Marini “Cento case popolari”, il racconto fotografico realizzato da Fabio Mantovani, di cui “IBC” presenta qui alcuni frammenti, esplora otto grandi sistemi abitativi: Rozzol Melara a Trieste, Gallaratese a Milano, Forte Quezzi a Genova, Pilastro+Virgolone e Barca a Bologna, Corviale a Roma, Villaggio Matteotti a Terni, ZEN a Palermo.1 O forse, più precisamente, registra, attraverso cento scene, come le persone attraversano e abitano, oggi, architetture costruite quarant’anni fa per essere pezzi di città. Le otto grandi “case” collettive sono interrogate quali esempi in cui verificare il rapporto tra progetto e vissuto, e lette attraverso uno sguardo che non costruisce risposte a priori ma che cerca, nel e oltre il pensiero architettonico, le tracce di un possibile elogio dell’ordinario. L’obiettivo coglie gesti quotidiani che convivono pacificamente, loro malgrado, con architetture-simbolo della storia del nostro paese, e non solo. Le architetture, se guardate da vicino, sembrano silenziose testimoni di storie anonime, di necessarie storie di vita. Storia di un affresco Il progetto “Cento case popolari” è stato allestito nel marzo del 2013 all’interno dello Spazio Lavì,2 in forma di affresco: veniva ribadita così la necessità non di documentare le architetture ma di ritornare su un’idea di architettura, ormai lontana ma tuttora abitata. Cento scatti compongono un quadro atopico e relazionale: la posizione delle fotografie non è tesa a raccontare i singoli luoghi, ma una stagione precisa del progetto – in buona parte dettata dal Piano Fanfani del 1949 – apparentemente indifferente alle posizioni geografiche. All’osservatore è stato chiesto, prima, di perdersi nella grande scena, d’immergersi in un’idea comune, propria di un tempo preciso, e, solo in un secondo momento, di ricomporre l’immagine dei quartieri attraverso i singoli frammenti. I cento scatti erano disposti quali tasselli di un’unica rappresentazione e senza rispettare il racconto delle singole architetture: era possibile ritrovare le giuste appartenenze abbinando numeri e lettere, scritti per dettare colonne e righe, a una legenda esplicativa, seguendo la logica di una battaglia navale. 138 Territorio e beni architettonici -ambientali Così come Fabio Mantovani ha fissato alcuni dei momenti in cui architettura e abitanti decidono le reciproche posizioni, così l’affresco in mostra invitava a una partecipazione attiva. Al visitatore era data la possibilità sia di cogliere le assonanze di un tempo, gli echi di un pensiero che rimbalzano tra distanti città italiane, sia di trovare le differenti interpretazioni del senso dell’architettura che gli autori cercano di marcare con forza in occasioni che appaiono oggi accomunate da una fiera fiducia nel progetto, fiducia che sfocia in alcuni casi in cieca autonomia del segno. Il visitatore poteva quindi decidere consapevolmente di accogliere lo spaesamento, la moltiplicazione degli sguardi oppure ritrovare attinenze, ricostruire appartenenze, rintracciare il disegno della singola struttura. La ricerca di Fabio Mantovani è un viaggio che muterà “contenuto” nel suo farsi: le cento case trovate ora diventeranno, nel tempo, ancora cento sguardi, ma su un numero sempre maggiore di architetture. Il prossimo allestimento di “Cento case popolari” – che si terrà nello spazio duepuntilab a Bologna nell’autunno del 2013 – vedrà riproposto l’affresco ma a commento di questo e dello stesso spazio espositivo verranno affissi una serie di scatti relativi allo ZEN di Palermo, opera di Vittorio Gregotti,3 stampati come manifesti da strada. Le scene della grande “casa” siciliana entreranno così successivamente nella rosa delle cento fotografie scalzandone altre delle architetture più rappresentate. Il progetto procederà e si modificherà progressivamente attraverso altri nuovi ingressi, altri sguardi su architetture popolari, fino a far coincidere ogni singola immagine con un unico singolo luogo. In un gioco di specchi, sia l’allestimento, che il progetto fotografico, che l’oggetto raccontato insistono sulla moltiplicazione delle situazioni e sul loro contemporaneo riecheggiare altrove, sul movimento cercato nella stasi o nella regola del numero fisso. In estrema sintesi si tratta del senso stesso di un affresco: ovvero quello spazio in cui complessità e trasformazione sono imprigionati in un’unica grande scena. Ambiguamente: un pezzo di città e un’architettura Nel momento in cui la diffusione orizzontale del sistema urbano è arrestata dalla crisi e, al contempo, non si producono idee di città, il progetto,4 la letteratura,5 e con questi anche chi costruisce narrazioni a partire dal reale, “ritornano” sulle grandi “case” collettive costruite tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo precedente. Si tratta di architetture legate tra loro da una visione di città, da una politica, soprattutto da un pensiero moderno comune e al tempo stesso sfaccettato; e poi ci sono gli ospiti di queste strutture, chi si è trovato per scelta o suo malgrado a viverle e abitarle. Diverse direzioni sostengono questa attenzione in tutta Europa: un rinnovato interesse verso la densificazione e i modelli dell’abitare condiviso (sempre a fronte di ridotte possibilità economiche), un inarrestabile problema sociale che caratterizza la cattiva fama dei cosiddetti grandi “mostri” (come testimoniano le cronache delle banlieues parigine), l’aver raggiunto quella distanza temporale necessaria per rileggere criticamente un’eredità che in modo sempre più insistente chiede una presa di posizione se non un’azione (come, per esempio, la demolizione per le Vele di Scampia, o agognati recuperi, restauri, riutilizzi o riciclaggi). IBC 2013 Tale “ritorno” assume, nello sguardo di Mantovani, la lucidità della ricerca, senza indecisioni, di un possibile rapporto tra corpo e spazio: non ci sono protagonisti, ci sono relazioni a distanza. Gli abitanti intrappolati negli scatti sono i veri eredi, i veri interpreti di quella tensione verso la modernità, di quell’aspirazione dell’architettura, non sempre concretizzata, a partecipare al disegno urbano. La possibilità di trovare cento case dentro un numero anche variabile di edifici, tutti appartenenti però al momento in cui le città italiane hanno costruito i propri monumenti all’abitare ensemble, sostiene il valore dello spazio, delle situazioni dell’oggi, oltre la testimonianza storica delle opere raccontate. Fabio Mantovani esplora quella che a distanza di quarant’anni possiamo definire una stagione eroica dell’edilizia pubblica o dell’edilizia per tanti (visto che non tutti gli interventi raccontati sono pubblici). È possibile affermarlo guardando a quello che in seguito è stato il destino progettuale e costruttivo delle case: se si supera appunto la distinzione tra investimento pubblico e privato, il tema dell’abitare, dopo questa vicenda, ha accolto o la via del buonsenso o quella della speculazione edilizia, perdendo tensione verso la ricerca di una traiettoria, di un sogno, di un ideale. Non c’è moralismo però negli scatti: l’architettura è lì a raccontarsi per quello che è oggi, colta nel suo essere nostalgicamente e ambiguamente epica, nel suo voler essere brano di città. I progetti sono carichi di pensiero, un pensiero introverso, attestato sulle questioni dell’architettura e per questo poco interessato ai luoghi. Un pensiero volto a sancire posizioni che, se lette a posteriori e oltre alcuni distinguo evidenti, fanno di queste esperienze un’unica esperienza protagonista di una storia. Una storia incentrata su un’interpretazione del mestiere dell’architetto volonterosamente atto a dettare direzioni, spesso dimentico di accogliere complessità e contraddizioni. Una pacifica convivenza Se l’architettura è sorpresa nel suo attestare un’assoluta fiducia in sé stessa, nelle regole della razionalità, ma anche nella forza dell’invenzione, le persone che commentano la scena normalizzano ogni tensione: argomentano una pacifica convivenza. Oltre le polemiche che hanno reso note queste architetture al grande pubblico quali condensatori di problemi sociali – con attacchi spesso inconsapevoli del peso impresso dalla collocazione urbana periferica della maggior parte di questi manufatti che nascevano quasi come nuove porte della città, o dimentichi dell’incompletezza dell’opera o ancora della “forzata” omogeneità sociale che li connota – Fabio Mantovani ritrova una vita “normale” costruendo un elogio dell’ordinario capace di addomesticare i cosiddetti “edifici-mostri” nostrani. La vita scorre tra le pieghe dell’architettura in un copione in cui si intrecciano la storia del progetto e la sua quotidiana occupazione. Gli spazi più metafisici sono accolti quali rifugi per la solitudine, l’intreccio dei percorsi disegna modi d’incedere diversi, gli spazi verdi sembrano riflettere la personalità di chi li cura. Siamo di fronte a una scoperta: quell’architettura che, nel suo ripetersi su grandi estensioni, voleva tutti uguali, anche perché fondata su un’idea di corpo astratto, solo da misurare (non tutta sicuramente: fa eccezione per esempio il Villaggio Matteotti, frutto di un processo di partecipazione), guardata così si trasforma nella misura della 139 140 Territorio e beni architettonici -ambientali diversità umana. Emergono le diverse sfumature degli abiti, le imprecisioni del corpo, il suo movimento, contrapposti ad architetture fondate sulla ripetizione, sul colore come codice per definire l’uso degli spazi, sulla regola geometrica figlia degli strumenti della rappresentazione, sulla staticità del segno. Non è possibile parlare di sfondo e figura, non si tratta nemmeno di un set per mettere in mostra i diversi mode d’emploi de la vie, come decretava Perec. I cento scatti hanno tutti due protagonisti: l’architettura colta nel suo persistere, sia come manufatto sia come pensiero, e le persone fissate nell’immagine mentre sono in viaggio, cariche di una storia che ne disegna i volti, desiderose di attraversare la scena con le proprie cangianti diversità. Note (1) Più precisamente: Carlo Celli, quartiere Rozzol Melara, Trieste 19691982; Carlo Aymonino, Aldo Rossi, quartiere Monte Amiata al Gallaratese, Milano, 1967-1972; Luigi Carlo Daneri, Eugenio Fuselli, quartiere Forte Quezzi, Genova, 1956-1968; Giuseppe Vaccaro, quartiere Barca, Bologna, 1957-1962; Francesco Santini con Giorgio Trebbi, Glauco Gresleri, Giorgio Brighetti, quartiere Pilastro, Bologna, 1963-1968 + Franco Morelli, Giuseppe Manacorda, completamento del quartiere Pilastro detto “Virgolone”, 1974-1976; Mario Fiorentino con Federico Gorio, Piero Maria Lugli, Giulio Sterbini e Michele Valori, Corviale, Roma, 1972-1982; Giancarlo De Carlo, villaggio Matteotti, Terni, 1970-1976. (2) Lo Spazio Lavì si trova a Sarnano (Macerata) ed è gestito dall’omonima fondazione progettata e diretta da Monica e Piero Orlandi. (3) Vittorio Gregotti con Franco Amoroso, Salvatore Bisogni, Vittorio Gregotti, Hiromichi Matsui, Franco Purini, quartiere ZEN (Zona Espansione Nord), Palermo, 1969-1973. (4) Si veda per esempio la ricerca di Durot, Lacaton e Vassal sui grandi complessi residenziali costruiti tra gli anni Sessanta e Settanta, sviluppata su incarico del governo francese e riportata in: F. Durot, A. Lacaton, J.-P. Vassal, Plus. Large scale housing development. An exceptional case, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2007. Un’ulteriore testimonianza dell’interesse rivolto al tema è l’attenzione posta nel bando di concorso “Europan 2013” a diverse aree caratterizzate proprio dalla presenza di grandi strutture residenziali appartenenti alla stessa stagione progettuale che ha partorito i progetti letti in “Cento case popolari”. (5) Si veda per esempio: G. Corbellini, Housing is back in town. Breve guida all’abitazione collettiva, Siracusa, LetteraVentidue Edizioni, 2012. [“IBC”, XXI, 2, aprile/giugno 2013] In tempo di crisi, le strategie architettoniche propongono sempre più spesso di riutilizzare gli spazi esistenti e gli scarti urbani. Riciclare la città Renato Bocchi, Fabrizia Ippolito Presentiamo i testi degli interventi dei due autori al convegno “Disegnare la città del futuro. Tra riuso dell’esistente e nuovi modelli urbanistici”, organizzato dall’Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-Romagna (IBC) il 22 marzo 2013 all’interno del “Salone del restauro” di Ferrara. Il convegno rientra nell’iniziative realizzate dall’IBC nell’ambito di “Re-Cycle Italy. Nuovi cicli di vita per architetture e infrastrutture della città e del paesaggio”, un programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (PRIN) a cui partecipano anche diverse università italiane. Le brevi note che seguono introducono alcuni punti-chiave della ricerca PRIN avviata da poco più di un mese, dal titolo “Re-cycle Italy”, ricerca di cui sono coordinatore e che vede coinvolte ben 11 facoltà di architettura di università italiane, con oltre 100 ricercatori. Essa prende spunto direttamente dalla rassegna proposta nella mostra “Re-cycle” al MAXXI, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma, nel 2012, a cura di Pippo Ciorra (anch’egli parte integrante del nostro gruppo di ricerca). L’adozione del termine “riciclo” nell’intervento sull’esistente – rispetto a termini come recupero, riqualificazione o riuso – sposta di fatto il centro dell’attenzione dal predominio dei valori dell’esistente (assunto invece come materia in qualche modo inerte, che ha concluso o sta per concludere il suo ciclo di vita) ai valori di nuovi principi progettuali capaci di manipolare l’esistente per istituire nuovi cicli di vita: un processo, quindi, in cui l’esistente è assunto di fatto come materiale utile per un progetto completamente rinnovato: per questo preferisco parlare di principi rifondativi. In tal senso il nostro ragionamento è certamente più vicino alla tradizione della pratica del progetto di architettura dentro l’esistente di maestri dell’architettura italiana come Carlo Scarpa o di architetti contemporanei che si innestano su questa stessa linea (in Emilia penso per esempio a Guido Canali) o per altro verso a esperienze della cosiddetta “architettura parassita”, come l’ha definita Sara Marini nel suo fortunato studio pubblicato da Quodlibet. E nell’ambito del progetto urbano è più vicino a progetti di re-invenzione, piuttosto che alla tradizione di intervento del recupero di 142 Territorio e beni architettonici -ambientali ripristino, completamento o ampliamento in continuità con i tessuti esistenti su cui proprio l’Emilia-Romagna è stata in Italia a lungo il punto di riferimento principale. Il riciclo dei materiali in architettura Un primo capitolo della nostra ricerca riguarda quindi tutte quelle esperienze che utilizzano gli scarti, le macerie, o i materiali riciclabili come materia stessa per la costruzione di nuovi prodotti architettonici, tendendo a eliminare o ridurre al minimo lo spreco delle risorse. Esperienze che attivano procedure di assemblaggio o montaggio, le quali prevedono lo spostamento e la ricomposizione di materia per definire nuove configurazioni, sia attraverso la rottamazione e la nuova ricomposizione, sia attraverso la rigenerazione completa di oggetti e spazi senza una previa distruzione. Esperienze di frontiera in questo campo si sono ormai largamente imposte all’attenzione dell’opinione pubblica. Per fare degli esempi, si possono citare in rapida sequenza: il geniale lavoro fondato prevalentemente sull’uso di materiali di riciclo inusuali nel campo della costruzione edilizia (soprattutto il cartone) di un architetto come il giapponese Shigeru Ban, ben noto al pubblico emiliano; oppure alcuni lavori di Peter Zumthor, fondati su materiali di recupero industriale quali i pallet; forse un po’ meno nota in Italia l’eccezionale esperienza didattica e sociale, a sfondo etico, del gruppo di architetti e docenti dell’Alabama denominato “Rural Studio”, fondata sui principi dell’autocostruzione attraverso materiali di riciclo; o la produzione di Alejandro Aravena, del quale è interessante qui ricordare il caso della casa Combeau, costruita con le pietre e con il legno ricavati dal disboscamento e dallo scavo del sito medesimo su cui è sorta; o, ancora più esplicito, l’esperimento del giovane gruppo olandese “2012 Architecten”, autori di una casa costruita interamente con materiali di recupero quali profilati di acciaio provenienti da una vicina fabbrica tessile o assi di legno provenienti dallo smontaggio di grandi bobine di avvolgimento dei cavi. In tutti questi casi, l’esperienza dell’architettura si fonda su un approccio etico dichiarato (attenzione al sociale, alla produzione low cost, all’autocostruzione) e su un uso programmatico di materiali riciclati (dai container portuali a materiali di scarto delle lavorazioni industriali). Un’esperienza singolare e molto interessante è quella di Maria Giuseppina Grasso Cannizzo: mi riferisco soprattutto alla sua casa Parisi-Sortino, analizzata da Sara Marini nella mostra “Re-cycle” del Maxxi. “L’operazione” – spiega l’autrice – “viene verificata sul modello dell’edificio: è la simulazione di un processo di riduzione attraverso la demolizione progressiva della forma pre-esistente. Dalla simulazione del processo viene suggerita la soluzione: tutti i ritagli, casualmente accumulati su un lato, vengono spostati sotto il fronte principale. Con i cumuli di macerie si guadagna la continuità di quota tra il primo piano e l’esterno: sulle macerie si impianta il nuovo giardino. L’inserimento del programma funzionale determina il posizionamento e le dimensioni delle nuove bucature, la definizione del piano quotato del giardino, il posizionamento dei muri di contenimento delle macerie”.1 IBC 2013 Il riciclo nei tessuti urbani Ma il riciclo a cui pensiamo è anche e soprattutto un riciclo degli spazi e dei tessuti urbani, attraverso un’opera di infiltrazione nel costruito che possa essere rigeneratrice, nel senso di mettere a frutto le energie incorporate negli stessi processi di costruzione delle città, e delle periferie urbane in particolare, o addirittura della cosiddetta città diffusa. Si tratta, in questo caso, di una procedura capace di attivare più cicli di vita contemporanei e di sfruttare così le energie incorporate nell’esistente e di esaltarne il metabolismo in un maggiore equilibrio fra ambiente e sviluppo sociale. Con l’ovvia differenza di valore che si lega a un’esperienza a sfondo didattico, mi permetto qui di mostrare, a esemplificazione metodologica, alcune prime sperimentazioni in tema di riciclo urbano avviate di recente nei nostri laboratori IUAV e applicate ad aree produttive parzialmente dismesse. Sia nel caso dell’area in dismissione della grande fabbrica Mira Lanza a Mira, con un gruppo di laureandi, sia nel caso dell’area della latteria sociale di Soligo, nei colli trevigiani, proposta come tema del nostro Laboratorio integrato di progettazione del paesaggio, abbiamo voluto sperimentare differenti principi di reinsediamento per la trasformazione e il nuovo utilizzo delle fabbriche oggi in disuso, riconsiderando i caratteri geografici e urbani dei siti. Il progetto di riciclo riposa in entrambi i casi sull’innesco di principi insediativi completamente nuovi, che siano in grado però di reintegrare, manipolandoli, i resti fisici, o in alcuni casi le semplici tracce di impianto del sedime edilizio, delle fabbriche preesistenti. Il progetto non parte tuttavia dal concetto primario di recupero/riuso dell’esistente, ma da un generale ripensamento dei principi insediativi stessi, che si fonda su una rinnovata volontà di integrazione con i caratteri salienti del paesaggio, assunti quali elementi primari (originari) dell’identità del luogo, sia in senso fisico sia in senso percettivo: i fiumi adiacenti, la tessitura dei superstiti appezzamenti agricoli, nel caso di Soligo la linea delle colline sullo sfondo, nel caso di Mira il rapporto con le geometrie dei tracciati infrastrutturali (canali e strade) e l’integrazione con le maglie e i tessuti del centro abitato. Nel caso di Mira si è dato luogo a un esercizio astratto di valore metodologico che ha indagato le capacità di reazione della forma dei luoghi e delle singole preesistenze edilizie in seguito all’introduzione di differenti principi di riorganizzazione dell’intera area. I modelli insediativi “testati” vanno dalla rinaturalizzazione dell’area alla densificazione del costruito, passando per l’applicazione di regole ordinatrici a telaio, o di volumi neutri e virtuali, o di piastre a più livelli: i modelli di riferimento sono stati desunti dal lavoro di grandi architetti contemporanei (da Eisenman a Ito e Sejima a Koolhaas) o di paesaggisti come Soerensen o Martha Schwartz. Si è cercato di verificare soprattutto come reagivano all’imposizione del modello astratto alcuni aspetti ritenuti salienti del luogo: innanzitutto la ricomposizione o riconfigurazione del fronte e dello skyline lungo la Riviera del Brenta, l’affogamento o meno dei grandi volumi recuperati della fabbrica in un tessuto connettivo più unitario e denso, l’eventuale formazione di landmark a scala territoriale, la riformulazione di 143 144 Territorio e beni architettonici -ambientali spazi pubblici o semipubblici aggreganti il nuovo tessuto, la possibile azione di rinaturalizzazione (vegetale) di almeno parte dell’area, eccetera. Allo stesso modo, nel caso di Soligo, gli studenti sono stati invitati a sondare ipotesi trasformative anche molto diverse fra loro, da un massimo di ri-naturalizzazione (assumendo il paesaggio vegetale come conduttore del gioco) a un massimo di estensione e densificazione delle maglie geometriche astratte con cui si è impiantata la zona industriale più recente, passando per livelli intermedi di ibridazione dei due modellilimite, che considerassero un parziale riutilizzo delle strutture edilizie esistenti insieme a un più intenso rapporto con gli elementi geografici (il fiume in particolare). I progetti più interessanti sono risultati quelli che intervengono con un sistema di aggiunte puntuali, “parassite”, di contaminazione e rigenerazione dell’esistente o quelli che assumono l’esistente non tanto in quanto volume costruito quanto come sistema modulare di setti murari e pilastri su cui impiantare un organismo totalmente rinnovato. Il riciclo nel paesaggio Ma il tema del riciclo può applicarsi, in forme più generali e “strategiche”, anche a temi di rigenerazione a larga scala della città e del paesaggio, e persino delle infrastrutture territoriali, avvicinandosi alla procedura che esalta la ciclicità del passaggio da un ciclo all’altro, eliminando al massimo lo scarto, fondandosi soprattutto sulle risorse ambientali persistenti e sulla loro rimessa in uso “sociale”. Prendo a esempio un caso su cui ho avuto modo di operare in prima persona una decina di anni fa nell’ambito di una consulenza urbanistica per il Comune di Trento.2 Si trattava di ripensare l’intera fascia urbana in via di progressiva dismissione lungo l’asta del fiume Adige, con la previsione di una serie di interventi a carattere collettivo che dovevano interessare le aree industriali e militari in via di dismissione. L’ipotesi principale su cui si è lavorato prevedeva di riciclare o meglio ripensare, nel ruolo di protagonista, il fiume stesso, da lungo tempo emarginato ed escluso dai destini della città, e a partire da questo rifondare la nuova fascia urbana non più sulla base di principi insediativi da città compatta e densa ma piuttosto come città-paesaggio, ossia con un insediamento multipolare che trovasse però una forte coesione attraverso il tessuto connettivo dei caratteri paesaggistici, ricomposti in forma di segmentato lungo parco fluviale. All’interno di tale operazione, che implicava anche un chiaro ripensamento della rete infrastrutturale di sostegno, poteva allora avviarsi l’opera di autentica ricostruzione urbana, che è in parte effettivamente avvenuta con la trasformazione dell’area ex Michelin da parte di Renzo Piano e la costruzione del nuovo MUSE, con il progetto della nuova Biblioteca Universitaria di Mario Botta a conclusione dell’asse storico del duomo, con la trasformazione in corso delle aree militari a favore del nuovo Ospedale provinciale, con la futura opera di riciclo prevista per l’ex Italcementi in riva destra, fino al sorprendente riuscito riciclo delle gallerie dell’ex strada tangenziale per usi espositivi, su progetto di Elisabetta Terragni. In tutti questi casi, alle varie scale, il principio del riciclo ha il valore di introdurre nell’opera di trasformazione edilizia, urbana e paesaggistica un autentico processo IBC 2013 di rigenerazione, proponendo un ripensamento e una riconfigurazione radicale – sia pure in termini di processi graduali e progressivi – delle forme insediative e dei loro modi d’uso, tenendo conto delle necessità di questi nostri tempi di crisi. [Renato Bocchi] In un momento nel quale i nostri territori si riscoprono consumati da anni di espansione, in un paesaggio nel quale la crisi rivela spazi di dismissione e ritrazione, in un tempo nel quale urgenze ambientali economiche e sociali spingono a fare tesoro di tutte le risorse, il confronto con l’esistente assume caratteri di intensità e di necessità, e il riciclo entra nel dibattito sull’architettura e la città. Piuttosto che chiederci cosa fare di nuovo, chiediamoci cosa fare con quello che ci ritroviamo. Se da una parte l’arte, dall’altra le teorie sul quotidiano, da tempo guardano a questo tema, interpretando l’uso come pratica creativa, il dibattito attuale sull’architettura si rivolge alla manipolazione dell’esistente muovendosi tra il riconoscimento di necessità e la ricerca di possibilità espressive, tra il riuso e il riciclo, tra le tattiche e le strategie, in un confronto serrato con un paesaggio i cui residui riemergono da un’epoca di rimozioni: scarti edilizi e urbani sono i materiali di una riflessione progettuale che, diffusa in ambito internazionale, può trovare in Italia una sua specificità e in alcuni suoi territori alcune attitudini latenti. Tre atlanti – un atlante di progetti, un atlante di cifre, un atlante di fenomeni – possono essere il punto di partenza per una riflessione su dispositivi, materiali e attitudini relativi al riciclo di architetture, città e paesaggi. Re-cycle. Progetti di riciclo Nel 2011 il MAXXI di Roma mette in mostra progetti di riciclo. L’esposizione passa in rassegna progetti di architettura, di città e di paesaggio che lavorano sull’esistente attraverso interventi di adattamento, sovvertimento, reinvenzione, in un’interpretazione di riciclo che riguarda le molte dimensioni e accezioni del progetto. Dall’architettura alla città al pianeta, un’ottica orientata al riciclo rimette in gioco i materiali della realtà e gli strumenti di intervento.3 In una collezione di esempi, che dalla mostra del MAXXI può espandersi in un archivio aperto, che attraversa altre mostre e altri progetti, e intercetta riflessioni sullo scarto e il riciclo di altre discipline,4 si possono rintracciare alcuni dispositivi ricorrenti, alcuni materiali e alcuni temi. Tra i dispositivi la riparazione, il parassitismo, la trasposizione, l’opera aperta, la bassa definizione, che esprimono un atteggiamento adattativo, approfittando di circostanze e occasioni, assorbendo errori e imperfezioni; che usano il tempo come materiale del progetto, intervenendo per progressione, incarnando ritmi e cicli temporali nello spazio; che intrecciano le scale agendo puntualmente e diffondendosi per propagazione, ripetizione, moltiplicazione; che approfittano della sospensione, progettando l’incompiuto, intervenendo nei vuoti, creando interruzioni. Tra i materiali, ruderi e rovine; edifici porosi o abbandonati, in ampliamento, in trasformazione; suoli in attesa di costruzione, in abbandono, contaminati; edifici tecnici, strutture produttive e infrastrutture in disuso o in obsolescenza; città metropolitane e suburba- 145 146 Territorio e beni architettonici -ambientali ne in ritrazione; centri storici svuotati. Tra i temi, che hanno a che fare con la città e il paesaggio, le questioni del consumo del suolo, del rischio, della marginalizzazione, della crisi. Attraverso questi dispositivi, materiali e temi, alcuni autori, ma anche alcune opere e alcuni luoghi, diventano emblemi del riciclo (Lacaton e Vassal, con il Palais de Tokyo e la Tour Bois le Prêtre; James Corner Field Operation, con l’High Line, condivisa con Diller e Scofidio e Renfro, e la discarica di Fresh Kills a New York; Detroit e Monaco, con i progetti sulla ritrazione, “Cloudspotting Detroit”, e sull’agricoltura temporanea, “Agropolis Munchen”). E, al di là di emblemi, il riciclo assurge a paradigma dell’architettura.5 Se la manipolazione dell’esistente è da sempre una pratica connaturata alla vita delle città e degli edifici – esemplificata da Spalato o da Lucca nella storia urbana, in questi anni elevata da lingua parlata a grammatica, assunta nel dibattito disciplinare sull’architettura sulla città e sul paesaggio – radicata nell’attualità dei territori e orientata a una visione attuale, essa assume un nuovo rilievo. In un momento in cui i paesaggi si risvegliano da decenni di torpore alterati, consumati, saccheggiati, cosparsi da manufatti senza più ragioni, lo sguardo sull’esistente acquista una nuova utilità e un senso nuovo. Caduta la fiducia nello sviluppo e nel progresso del Moderno, archiviato il Novecento, ma archiviato anche il lassismo con cui sui territori è stato interpretato il Postmoderno, un atteggiamento laico verso quello che rimane (di infrastrutture e megastrutture, come di frammenti di urbanizzazione dispersa) conduce a ripensare gli strumenti del progetto. Prima che il paradigma del riciclo si cristallizzi in nuovo salvifico modello, la sua apparizione può indurre cambiamenti: tra città e architettura, tra etica ed estetica, tra domande dell’abitare e risposte del progetto, un nuovo modo di vedere le cose può aprire nuovi spazi di intervento. Rumore di fondo. Paesaggi di riciclo In occasione della Biennale di architettura di Venezia del 2010, nel Padiglione italiano, curato da Luca Molinari, una voce forniva un bollettino in numeri del territorio italiano. I numeri facevano da rumore di fondo a una rassegna sul presente dell’architettura italiana.6 Dalla grande quantità di cemento consumato (813 chilogrammi per abitante all’anno) e di materiale scavato (quasi 300 milioni di metri cubi all’anno), di cave attive (5725) e in dismissione (10.000); alla grande quantità di case (27 milioni), di case abusive (il 10%), di case vuote (il 20%); alla carenza di case popolari (il 4,5%); alla crescente quantità di boschi (100.000 ettari all’anno) e di potenziali deserti (il 30% del territorio); alle grandi quantità di territori (il 45%), di edifici (il 68% di quelli privati, il 75% di quelli pubblici, il 60% dei beni culturali) e di popolazioni (il 40%) a rischio sismico, e ad altro rischio; all’entità degli investimenti per opere pubbliche e grandi opere (più di 30 miliardi di euro all’anno) e, per contro, delle opere interrotte (almeno 300); ai numeri delle strutture dismesse (5 milioni di case; 2791 miniere; 9.000 ettari di industrie; 150.000 ettari di territorio contaminati; 1.800.000 ettari di campi agricoli in 10 anni; 804 edifici militari), dei paesi abbandonati (5.838), delle IBC 2013 ferrovie in disuso (5.800 chilometri), delle autostrade in concessione (più della metà), dei piccoli porti e aeroporti (800 porti, 122 aeroporti e 224 aviosuperfici), dei luoghi turistici (300 milioni di visitatori all’anno), dei beni culturali (47 siti UNESCO), della superficie protetta (il 19%), del territorio vincolato (il 50%), delle leggi, delle regole, delle deroghe e delle eccezioni; degli architetti (1 ogni 470 abitanti)... Si può dire che alcune quantità stanno facendo la qualità dei paesaggi italiani. Quantità di soggetti, di interessi, di regole, di progetti, di politiche e di pratiche, compongono il ritratto di un paese in costruzione e in movimento, di un paesaggio frammentato e plurale, dove la moltitudine assume un rilievo speciale. Sono quantità variabili, che richiederebbero un bollettino quotidiano. Ma indicano alcune delle direzioni verso le quali si muovono i paesaggi italiani. Vent’anni dopo i viaggi in Italia degli anni Ottanta e Novanta, quando c’era entusiasmo e ansia di descrizione di un nuovo paesaggio, libero dagli stereotipi del Bel Paese, guardare cosa ne è stato dei nostri territori non implica necessariamente il quadro di un disastro, ma sicuramente la presa di coscienza di condizioni cambiate, di aspettative disattese, di effetti collaterali o connaturati alle direzioni intraprese: un quadro dei residui materiali dell’urbanizzazione di questi anni, ma anche un quadro dei residui delle idee di città e di paesaggio che l’hanno determinata. Se quello che scartiamo dice qualcosa su quello che scegliamo, gli scarti di questi anni di costruzione del territorio parlano di rincorse fallite alla modernizzazione, di discese a valle o sulle coste dell’urbano, di ambizioni di cubatura non commisurate agli usi, di un passaggio affrettato dall’industria al terziario, di un’avanzata dell’urbano sull’agricoltura, di una vittoria della mobilità individuale su quella collettiva, di una prevalenza delle grandi opere sulle opere pubbliche diffuse, di un predominio del privato sul pubblico, del consumo sulla conservazione, dell’espansione sulla riduzione, di una diffusa rimozione per il perturbante della città. E se le condizioni sono cambiate, è cambiato anche lo sguardo che le osserva, sollevato dalla necessità di ribadire il suo rinnovamento, di contrapporre qualità a quantità, visione laterale a visione zenitale, fenomeni a materiali e forme della città. Così i numeri, svincolati da obblighi di obiettività, esaminati nelle loro relazioni e contraddizioni, possono essere elementi di un’indagine indiziaria, che restituisce dinamiche e qualità dei paesaggi, fuori da rimozioni, ma anche fuori da visioni univoche, il Bel Paese come il paese disastrato. Se alcuni fenomeni e alcuni materiali sono significativi per quantità, è nella quantità che risiede l’urgenza di una loro riconsiderazione e la potenziale efficacia di un intervento che li rimetta in gioco. Tattiche. Laboratorio di riciclo Una collezione di ricerche sul territorio napoletano propone le tattiche dell’abitare come punto di vista sulla città e Napoli come manifesto dell’adattamento e dell’eccezione. Se i modi di abitare intervengono nelle pieghe della città modificandola per cumulazione, a Napoli esprimono una particolare creatività e agiscono con particolare pervasività; mentre le pratiche quotidiane avanzano nei territori e negli studi urbani, Napoli può essere l’emblema di una città dove l’eccezione è la regola, l’adattamento è una consuetudine e le tattiche sono sovrane.7 147 148 Territorio e beni architettonici -ambientali La città delle tattiche è individualista, temporale, precaria, oscura, rimossa, esplosa, straordinaria, ordinaria – e spesso abusiva. Si può rintracciarla sul litorale flegreo, sul litorale domitio, nell’area vesuviana, nell’entroterra tra Napoli e Caserta, nella corona di periferie pubbliche, nella zona industriale e nelle porosità del centro, dove alcuni fenomeni fanno per quantità la sua qualità. Nell’area vesuviana seicentomila persone abitano nella zona a rischio eruzione, rispondendo alla precarietà con l’ostinazione a stare sul territorio; nella periferia urbana i quartieri della ricostruzione post-terremoto dell’80 rappresentano il più grande intervento di edilizia pubblica d’Europa negli ultimi 50 anni, un intervento oggi trasformato dalla prova dell’abitare; nella terra tra Napoli e Caserta, oggetti, materiali e popolazioni di scarto ricadono su un territorio a sua volta scartato e la criminalità organizzata influisce sulle regole per la sua costruzione; tutto intorno, sui litorali e nell’entroterra, una moltitudine di interventi individuali agisce sui paesaggi agricoli e costieri, sui siti archeologici e naturali, modificando la città. Le tattiche dell’abitare cercano la via più facile, utilizzano i materiali esistenti, scendono a compromessi con il territorio, applicano tecniche note, rielaborano tradizioni e suggestioni, approfittano delle occasioni, procedono per imitazione, per reinterpretazione, per contaminazione, raggiungendo a volte risultati innovativi mentre lavorano per risolvere emergenze, per acquisire vantaggi, o per assecondare necessità. Intervenendo sull’esistente, procedono per adattamenti e correzioni, interpretando la riparazione come dotazione di un nuovo senso e di nuove prestazioni, e la città (dove le cose cominciano a funzionare quando sono rotte)8 come un laboratorio permanente di riciclo. Lavorare sul riciclo vuol dire confrontarsi con le situazioni specifiche, evitare le generalizzazioni per entrare nella realtà dei territori, nelle loro forme, nelle loro vicende e nei loro materiali; significa adottare una visione piuttosto che un modello o un protocollo d’azione. Non si tratta di opporre il localismo alla globalizzazione, ma di intercettare gli effetti diversi della globalizzazione nei diversi luoghi; non cristallizzare l’identità di una città, ma assumerne la specialità. E Napoli è speciale per l’evidenza e l’intensità che qui assumono i fenomeni, le urgenze e le emergenze, per la pregnanza con cui i comportamenti intervengono a conformarla. Inchiodata a questa specialità, può rimanerne prigioniera, restando ai margini dei discorsi sulla contemporaneità; considerata come un laboratorio, può essere un luogo dove sperimentare modi di fare e rifare la città. Napoli, con le sue contraddizioni e i suoi conflitti, non offre consolazioni, come non offre consolazioni il riciclo, se, piuttosto che come ricetta, viene interpretato come chiave di ingresso nelle pieghe della città. [Fabrizia Ippolito] Note (1) Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, a cura di C. Rizzica, Melfi, Libria, 2006. (2) Si veda: R. Bocchi, Il paesaggio come palinsesto, Rovereto, Nicolodi, 2006. IBC 2013 (3) Re-cycle. Strategie per l’architettura, la città e il pianeta, a cura di P. Ciorra e S. Marini, Milano, Electa, 2011. (4) Tra le mostre si segnala la Biennale di Venezia del 2012, con i padiglioni tedesco, giapponese e americano; tra le riflessioni su riuso e riciclo: N. Bourriaud, Postproduction. Come l’arte riprogramma il mondo, Milano, Postmedia book, 2004 (edizione originale 2001); W. Mc Donough, M. Braungart, Cradle to Cradle. Remaking the Way We Make Things, San Francisco, North Point Press, 2002. (5) Si veda: M. Ricci, Nuovi paradigmi, Trento, LISt Lab,, 2012. (6) Si veda: F. Ippolito, Rumore di fondo, in Ailati. Riflessi dal futuro, a cura di L. Molinari, Milano, Skira, 2010. “Rumore di fondo”: cura F. Ippolito; responsabili di ricerca: M. Cerreta, C. Piscopo, V. Santangelo; gruppo di ricerca: D. Cannatella, M. C. Fanelli, R. Giannoccaro, S. Sposito; consulenti: F. Lancio, E. Micelli, F. Zanfi; ricerca in corso di aggiornamento. (7) F. Ippolito, Tattiche, Genova, Il nuovo melangolo, 2012. (8) A. Sohn-Rethel, in Adorno, Benjamin, Bloch, Krakauer, Sohn-Rethel. Napoli, a cura di E. Donnaggio, Napoli, L’ancora del Mediterraneo, 2000. [“IBC”, XXI, 2, aprile/giugno 2013] 149 Il progetto “ATRIUM” disegna una rotta culturale europea per collegare le testimonianze architettoniche lasciate dai totalitarismi nel corso del Novecento. Strutture di regime Claudia Castellucci Il XX secolo ha lasciato in Europa, tra le altre cose, la scomoda eredità storica dei regimi totalitari e autoritari che ne hanno condizionato lo svolgersi. Il territorio europeo è punteggiato dai segni tangibili di questa storia. Si tratta di architetture a volte di pregio, ascrivibili al razionalismo, altre volte eclettiche o addirittura banali, che hanno tuttavia un forte valore simbolico, realizzate dentro il design di nuove funzioni urbane e accompagnate da un preciso intento propagandistico, finalizzato al consolidamento dei regimi che le produssero. Sono edifici nati per assolvere a bisogni pratici (uffici postali, stazioni ferroviarie) o monumenti e palazzi costruiti per la rappresentazione e celebrazione del potere. In alcuni casi si tratta di interi quartieri o di città costruite ex novo per motivi vari: è il caso degli insediamenti abitativi nati intorno a zone di sfruttamento minerario, o dei quartieri fieristici. Si pensi all’EUR, acronimo di Esposizione Universale Roma, che fu fatto costruire da Mussolini per un’esposizione che in effetti non ci fu mai, ma che avrebbe dovuto celebrare, con i fasti di una moderna fiera internazionale, il ventesimo anniversario della marcia fascista su Roma, proiettando il regime nella modernità e nel futuro. Benché rifiutiamo le ideologie dei regimi che hanno prodotto tali edifici, monumenti, quartieri o città, si tratta di lasciti di un periodo della storia europea che non può semplicemente essere cancellato con un tratto di penna. Per questo motivo è nato il progetto “ATRIUM - Architecture of Totalitarian Regimes of the XXth Century in Urban Management”, che, a dispetto del lascito scomodo a cui sono legate e dello stato di degrado che a volte le connota, considera queste testimonianze come un “bene culturale”. Beni che ci ricordano che dalle macerie della Seconda guerra mondiale e dal crollo di quei regimi nasce l’idea stessa di Europa che abbiamo oggi. Perché Forlì? Prima di descrivere seppur sommariamente “ATRIUM”, vale la pena svolgere alcune considerazioni per spiegare perché Forlì ha promosso e coordina questo progetto. L’origine forlivese del dittatore Benito Mussolini costituisce, sin dalla presa del potere IBC 2013 da parte del fascismo, un fattore determinante nello sviluppo complessivo della città. Come ricorda Ferruccio Canali, a partire dagli anni Trenta, grazie a una macchina propagandistica ben funzionante, verso la “Città del Duce” si dirigeranno carovane di torpedoni promosse dalle organizzazioni legate al turismo politico, mentre la mitografia fascista esalterà, parallelamente, l’esemplare laboriosità romagnola, l’ospitalità, eccetera.1 Si tratta di una vera e propria mitizzazione delle origini, a dispetto di un inizio non proprio esaltante nel processo di fascistizzazione della Romagna e di Forlì, che anche successivamente si manterrà una delle province italiane con il minor numero di iscritti al partito fascista. Non a caso, come ricorda Vittorio Emiliani, a Forlì, fra il 1939 e il 1943, per iniziativa di un gruppo di giovani del Gruppo universitario fascista, nascono tre riviste alle quali collaborano alcuni dei futuri esponenti della classe dirigente e del mondo artistico e letterario, prima di fronda e poi decisamente antifascisti, tra cui Giorgio Napolitano, Paolo Grassi, Giorgio Strehler, Carlo Lizzani, Giovanni Testori e Giorgio Caproni.2 Roberto Balzani e Mario Proli hanno sottolineato come l’assegnazione di un nuovo ruolo nell’immaginario collettivo abbia riguardato non solo Forlì e Predappio (località, quest’ultima, che ha dato i natali al dittatore) ma tutte le altre città contigue.3 Ravenna viene legata alla figura di Dante, presentato come precursore del fascismo; Rimini e la costa romagnola vengono promosse a capitali dell’industria balneare, fenomeno ancora d’élite ma avviato sulla strada del turismo di massa, imperniato sulle famiglie e sulle colonie marine; Imola viene epurata della sua immagine ottocentesca legata ai padri del socialismo; Faenza è qualificata per la tradizione della ceramica; Castrocaro diventa un centro termale importante, dotato di più di cento camere magnificamente arredate, di spazi per la socialità, di un padiglione per le feste, mentre Fratta Terme si connota per un altro padiglione termale, più modesto, adatto a far godere i benefici delle acque anche alle classi lavoratrici più modeste e al ceto impiegatizio attraverso il sistema delle previdenze sociali. Ma è soprattutto su Forlì che si concentrò l’intervento statale: il dittatore impose alla sua provincia di origine, ancora politicamente inaffidabile ma di “buon ceppo”, di assurgere a modello e guida esemplare per le restanti province italiane, paradigma per lo sviluppo di tutta la nazione, al di là del ristretto orizzonte localistico. Imponenti furono le opere realizzate dal regime: rimboschimento, regimazione dei fiumi, nuove arterie stradali, gli aeroporti di Forlì e Rimini. Ma è soprattutto all’architettura che venne affidato il ruolo trainante di motore per il consenso, sia per il risvolto occupazionale connesso con un’intensa attività edilizia, sia per la rilevante valenza simbolica che venivano ad assumere le nuove realizzazioni. Il progressivo “svecchiamento” della città venne presentato come un’azione che si compiva grazie all’interessamento diretto del duce, e che “raschiava dal volto della città le incrostazioni del tempo”. Come racconta Ulisse Tramonti, la città antica fu sopraffatta da un consistente e progressivo numero di edifici che si sostituirono a tessuti edilizi ritenuti sommariamente fatiscenti, senza percepire il centro antico nella sua interezza di stratificazione storica di elementi unici e irripetibili.4 151 152 Territorio e beni architettonici -ambientali Per quest’opera di rinnovamento vennero incaricati i progettisti più famosi del momento, ai quali fu imposto di radicare, in un contesto locale estremamente provinciale, le tendenze che andavano percorrendo l’ambiente romano e milanese, luoghi in cui si creavano le mode, le tendenze di gusto e i confronti architettonici dell’epoca. È ancora Tramonti a sottolineare che, per la vastità degli interventi realizzati, nonostante la mancanza di un programma estetico unitario e la presenza di contraddizioni e ambiguità, tale architettura ha finito per costituire la prima immagine di modernità dell’architettura italiana. A maggior ragione, questo vale per Forlì. Non a caso Giorgio Bocca in un reportage compreso, nel 1962, all’interno del suo Miracolo all’italiana, osservava che questa città non chiedeva più niente a Roma, “quasi temesse di resuscitare il ricordo della piccola Roma...”. Insomma: Forlì aveva avuto troppo, o per lo meno così si riteneva durante il ventennio fascista nelle altre regioni italiane, perché in verità la città non divenne mai un grande centro industriale o terziario, e la sua situazione economica rimase tutt’altro che rosea. La Seconda guerra mondiale, poi, pose fine a questa fervida attività edilizia e cancellò il sogno di fare di Forlì una “piccola Roma”. Sono ancora oggi evidenti i danni che questo patrimonio architettonico ha subìto successivamente, non solo a causa della guerra, ma anche per restauri sbagliati, rifacimenti e ampliamenti impropri, demolizioni selvagge, operate nel segno di una damnatio memoriae che si è tradotta in demolizione o, molto più spesso, in trasformazione sbagliata. Solo verso la fine degli anni Sessanta del Novecento sono stati prodotti studi su personaggi e opere di questo periodo dimenticato. Caduti alcuni ostacoli ideologici, passato molto tempo, si è potuto cominciare a riflettere a mente sgombra su quegli anni in cui tante contraddizioni si sono agitate, intrecciate, spente nell’ordine, ma poi riaffiorate. L’attenzione, oggi, è posta sulla modernità delle opere architettoniche prodotte dal regime fascista, per lo meno di alcune di esse, ovvero sulla loro capacità di interpretare il proprio tempo, elaborandolo con specifiche originalità. “ATRIUM”: la dimensione europea Il progetto “ATRIUM” rappresenta il punto di arrivo di tale recuperata attenzione nei confronti di questo patrimonio architettonico di cui si colgono, a un tempo, gli aspetti di pregio e la storia che li ha prodotti, con i suoi drammi (www.atrium-see.eu/ita). Dopo il crollo del muro di Berlino è inoltre diventato possibile ripensare non solo le architetture e la storia occidentale, ma anche quella dei paesi usciti dal comunismo, e dunque l’intera storia europea del XX secolo. Anche in quei paesi la sfida che le nuove istituzioni democratiche hanno dovuto e devono affrontare è quella di mantenere un legame con la propria storia e il proprio patrimonio architettonico nonostante le memorie recenti e spesso tragiche a cui tale storia e tale patrimonio sono associati. Si è quindi profilata l’opportunità di sfruttare l’allargamento a est dell’Unione Europea per dar luogo a una riflessione congiunta e localmente ancorata sulla storia europea, secondo una prospettiva parziale ma feconda, quella delle architetture prodotte dai regimi. Si tratta di una scelta che evidenzia la limitatezza delle interpretazioni storiche prevalenti nell’ultimo secolo, principalmente basate su di un approccio dualistico che IBC 2013 ha pensato e descritto Est e Ovest come entità separate e totalmente distinte. In realtà vi sono state numerose influenze reciproche e significative durante tutta la guerra fredda, per non parlare delle analogie fra i regimi e dunque dei punti di contatto sia sul piano storico sia su quello architettonico. L’integrazione europea offre la possibilità di riconciliare queste due entità all’interno di tendenze comuni, e di un clima socioculturale e politico che ha permeato l’Europa del XX secolo. Il programma europeo “South East Europe” ha permesso di avviare un confronto che ha l’obiettivo di costruire una rotta culturale europea delle architetture dei regimi dittatoriali del XX secolo. Si tratta di una sfida, poiché tra i 18 partner attuali di “ATRIUM”, che stanno lavorando insieme in 11 stati, alcuni provengono da paesi ex comunisti nei quali la caduta dei regimi è recente e le ferite sono ancora dolorose: questi paesi sono inevitabilmente posti di fronte alla necessità di fare i conti con la storia scegliendo di non cancellarne la memoria per quanto difficile possa essere. Il progetto è ormai in dirittura di arrivo, ma è appena iniziata la seconda fase del percorso, che mira a dare sostenibilità nel tempo al partenariato, per far sì che diventi spazio vivo di ricerca, luogo duraturo di studio, alimentato e tenuto insieme dall’esistenza di una rotta culturale europea certificata. È questa la ragione che ci ha portato a dare vita, il 15 giugno, all’associazione transnazionale “ATRIUM”, titolare e soggetto gestore della “Rotta ATRIUM”, incaricata di espletare gli aspetti amministrativi, di tenere i rapporti con il Consiglio d’Europa, di promuovere e diffondere la conoscenza intorno alle tematiche inerenti le architetture dei regimi dittatoriali europei del XX secolo. Intorno all’associazione sta nascendo un network di università e centri di ricerca interessati alla tematica. L’associazione, composta da enti locali, conta già 10 aderenti di 5 paesi europei, mentre il network accademico, benché ancora in via di costruzione, ha già acquisito adesioni significative di 14 realtà di 6 paesi europei. Le parole-chiave I concetti-guida che il partenariato ha messo al centro del proprio confronto e della scelta di operare insieme in modo continuativo sono i seguenti: –– Consapevolezza. Ovvero: la coscienza comune che “ATRIUM” può concorrere a determinare; –– Memoria e comprensione. Nel guardare a questi beni architettonici occorre ricordare che: •quel bene appartiene a un contesto, è tipico (o è un modello) della cultura architettonica di un periodo, rientra in un piano urbanistico di espansione della città e riorganizzazione dello spazio, è testimone a volte di un’architettura di avanguardia che presentava soluzioni avanzate per l’epoca; •la nostra rotta si confronta con temi di natura culturale e urbanistica, con la storia dell’architettura, con la storia politica e con la storia tout court. Non può essere altrimenti, perché il Novecento è il secolo che ha visto nascere le dittature, cioè l’illusione della democrazia fuori dal liberalismo, ma anche la modernizzazione, con i suoi caratteri pervasivi e comuni a più contesti; è un’epoca che ha pensato il mondo tutto proiettato nel futuro, che ha visto la nascita della società di massa 153 154 Territorio e beni architettonici -ambientali e della propaganda, mettendo alla prova la democrazia. È anche il secolo della nascita dell’Europa come soggetto politico e istituzionale sovranazionale, auspicabile confederazione di stati disposti a cedere parte delle proprie competenze per mettere in comune la prospettiva del continente. –– Responsabilità. Come dichiarato, ci confrontiamo con beni scomodi, che non di meno devono essere considerati patrimonio culturale e tutelati. Questo impegno ha delle conseguenze, per esempio, rispetto al riuso e al restauro, che non possono prescindere dalla conoscenza degli elementi storici, politici e culturali prima richiamati. Il Manuale per la gestione, conservazione, riuso e valorizzazione delle architetture dei regimi totalitari del XX secolo in Europa prodotto da “ATRIUM” è stato occasione di una complessa, a volte difficile, discussione fra partner provenienti da paesi e storie diverse. Rappresenta certamente un punto di arrivo importante e non scontato l’assunto su cui si basa, ovvero che nel contesto attuale la conservazione di questa importante parte della storia architettonica del XX secolo sembra auspicabile e necessaria, senza che ciò implichi rimuovere la memoria di ciò che essa ha significato. –– Sapere organizzato. Vista la necessità di far crescere la conoscenza della relazione fra edificio, aspetti architettonici e memoria, il punto di forza di “ATRIUM” consiste nel mettere a disposizione, nelle sedi locali dell’associazione, un sapere teorico e scientifico, ma anche pratico, adatto a differenti target: turisti, scuole e giovani, ma anche professionisti che si trovano alle prese con il problema del restauro di tali manufatti, amministrazioni pubbliche incaricate di definirne la sorte nei piani regolatori, eccetera. Un esempio in tal senso è rappresentato dal “Tavolo per il restauro del moderno” di Forlì, nel quale comuni, università e centri di ricerca sull’architettura, soprintendenze, ordini professionali, insieme all’Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-Romagna, si stanno confrontando per la messa a punto di una lista di argomenti di cui tenere conto quando ci si confronta con la ridefinizione d’uso e con il restauro di manufatti moderni. –– Turismo. Diventare un itinerario culturale riconosciuto dal Consiglio d’Europa rappresenta anche un’opportunità di sviluppo turistico ed economico, che guarda ai giovani e alle gite scolastiche come primi potenziali fruitori, anche se non unici. Il disegno della rotta, la messa a punto del prodotto turistico, l’individuazione degli operatori economici con cui collaborare sulla base di carte etiche appositamente definite saranno pertanto uno dei campi di azione dell’associazione “ATRIUM”. I prodotti Il progetto ha sin qui realizzato un censimento dei beni architettonici legati ai regimi presenti nelle città aderenti, e un manuale contenente linee guida per il restauro degli edifici moderni. È inoltre in corso una catalogazione digitale di documenti cartacei, libri e pubblicazioni, fotografie, video e altri materiali documentari e archivistici collegati agli edifici censiti, incluse testimonianze di storia orale, per ricostruire pezzi di vita sociale e familiare quotidiana, descrizioni degli edifici, ricordi. Siamo infatti convinti che gli edifici della nostra rotta rappresentano un’opportunità per capire IBC 2013 il Novecento, e che conoscere la vita reale dei luoghi e delle persone che li hanno abitati e li abitano sia una chiave in più per capire meglio il patrimonio architettonico. Nel giugno del 2013, a Forlì, abbiamo realizzato un evento internazionale, il “Piloting ATRIUM”, che ha rappresentato una sorta di prova tecnica per verificare il consenso sul percorso e sulla proposta turistica messi a punto. In occasione del piloting, cittadini, tour operator, media, turisti sono stati condotti a scoprire il territorio nelle sue varie dimensioni (architettonica e culturale, naturalistica, termale, culinaria) e tra iniziative scientifiche, spettacoli ed eventi vari sono stati invitati a suggerire aggiustamenti e migliorie per il lavoro futuro. L’evento ha dimostrato la validità del progetto e il carattere germinativo che lo connota: decine di associazioni e realtà varie hanno dato vita, a Forlì e nei comuni limitrofi, a 15 mostre, 30 convegni ed eventi, 14 spettacoli e migliaia di forlivesi vi hanno preso parte. Le prospettive Nel settembre 2013 l’associazione ha depositato il dossier di candidatura al Consiglio d’Europa: la risposta sul riconoscimento è attesa per la primavera del 2014. Intanto è necessario avviare un piano di lavoro per il consolidamento e l’ampliamento della rotta, per la ricerca scientifica, per la messa a punto della dimensione turistica. Di recente si sono anche aperte nuove piste di possibile sviluppo, come quella destinata a far nascere una rotta specificamente dedicata ai siti industriali dismessi, realizzati in periodo totalitario. Molte città partner di “ATRIUM”, infatti, sono nate intorno a una funzione economica: è il caso di Labin, in Istria, sorta per volontà del fascismo italiano di sfruttare le miniere di carbone (scelta poi confermata dal comunismo); di Dimitrovgrad, in Bulgaria, nata intorno a un sito industriale chimico; di Doboj, in Serbia, votata alla lavorazione dell’acciaio; di Velenje, in Slovenja, destinata allo sfruttamento minerario; della stessa Predappio, con l’industria aeronautica Caproni. In altri casi, come a Tirana con il kombinat tessile, interi quartieri sono stati dedicati a una produzione specifica. Ogni ulteriore sviluppo dovrà essere valutato con attenzione e nel tempo. Per ora ci concentriamo sulla predisposizione di un buon dossier di candidatura per diventare davvero, al primo tentativo, una “rotta culturale europea”. Note (1) F. Canali, Architetti romani nella “città del Duce”, Cesena, Società editrice “Il Ponte Vecchio”, 1995, estratto da “Memoria e Ricerca”, 1995, 6. (2) V. Emiliani, Prefazione, in La città progettata: Forlì, Predappio, Castrocaro. Urbanistica e architettura fra le due guerre, a cura di L. Prati e U. Tramonti, Forlì, Comune di Forlì, 1999, p. 14. (3) La Romagna del Duce in cartolina. Il territorio romagnolo e la costruzione di una politica autoritaria, a cura di R. Balzani e M. Proli, Forlì, Sapim, 2003. (4) U. Tramonti, Le radici del razionalismo in Romagna. Itinerari nel comprensorio forlivese, Forlì, Edizioni Menabò, 2005. [“IBC”, XXI, 3, luglio/settembre 2013] 155 In settembre più di cinquanta fotografi di tutta l’Italia si sono dati appuntamento a L’Aquila per partecipare a una sei giorni di confronti, dibattiti e osservazione del territorio a fianco dei cittadini. Confotografia Alessandra Chemollo Camminando per la strada si incontrano ogni giorno persone di cui non si conosce nulla. Guardandole con attenzione può risultare evidente come ci siano gesti, portamenti e segni che ognuno, spesso inconsapevolmente, conserva quale eredità di quanto ha vissuto, dell’atteggiamento con cui ha affrontato ciò che gli è capitato in sorte, delle conseguenze che ne ha tratto. Ci sono eventi traumatici che trasformano il corpo e i gesti delle persone, e a qualcuno di noi è capitato di conoscere fino a che punto alcuni fatti della vita sono in grado di trasformarci. Normalmente le cose più importanti, quelle di cui portiamo le tracce nel corpo e nei gesti, ci colpiscono individualmente, sono successe solo a noi in quel preciso istante. A L’Aquila invece, è successo a tutti qualcosa di terribile contemporaneamente: un terremoto ha inciso nei destini di tutti gli abitanti di un vasto territorio, nello stesso medesimo istante: alcuni di loro abitavano in centro, altri in periferia, altri ancora in piccoli centri più o meno distanti dalla città. La notte del 6 aprile 2009 ha reso tutte queste persone partecipi di un unico lutto: chi ha perso la casa, chi le persone a cui voleva più bene, chi è sceso correndo nel buio inciampando in pezzi di muro che cadevano alla rinfusa, per ritrovarsi spaventato in un mondo reso irriconoscibile da pochi minuti di rabbia della terra. Che cosa ha comportato l’aver condiviso tutto questo? Se ognuno di noi è solo ad affrontare le avversità che il destino gli serba, cosa accade a una comunità che deve misurarsi con un “dopo” di questa portata, quali sono le dinamiche di confronto tra le persone che si ritrovano a cercare risposte e soluzioni a un problema che, in diversa misura, le coinvolge tutte? Chi ha il vizio di guardare il prossimo che incontra per la strada, molto spesso osserva con un’attenzione simile anche i luoghi che percorre. Chi poi utilizza una macchina fotografica per approfondire questa osservazione, lavora in fondo in modo simile a chi, munito di registratore, seleziona frammenti di pensiero da rielaborare in seguito, grazie a una presa di distanza dal momento che li ha generati. Si raccolgono tracce, IBC 2013 cercando di identificare un percorso, si individuano analogie, dissonanze ed elementi capaci di entrare in sinergia con qualcosa che abbiamo già visto. Ma, all’interno delle ricerche che ognuno di noi conduce, stabilendo regole proprie, raccogliendo immagini che diventano o meno parti di un progetto, che cos’è che attrae la nostra attenzione? Ha qualcosa a che fare con il nostro metabolismo, c’entra in qualche misura con ciò di cui la nutriamo, questa attenzione? E ha ancora un senso, nell’era di Instagram, fare della fotografia il proprio mestiere, raccogliere immagini o meglio lasciarle dietro sé come i sassi di Pollicino, registrare quanto siamo in grado di vedere, e provare a costruire un ordine che renda possibile ad altri avventurarsi nel processo del pensiero che le ha generate? Dal 20 al 26 settembre 2013 più di cinquanta fotografi, provenendo da tutta l’Italia, si sono dati appuntamento a L’Aquila per partecipare a “Confotografia” (www.confotografia.net). Sono arrivati senza avere un incarico, ognuno a proprie spese, per partecipare a un progetto completamente autofinanziato, organizzato da due associazioni di fotografi. Il programma che li ha convinti a partire prevedeva un laboratorio residenziale, per la “sperimentazione di un metodo di indagine del territorio basato sullo scambio di conoscenze tra fotografi e cittadini”.1 Un primo sopralluogo collettivo, un seminario con esperti di varie discipline per offrire spunti di lettura a partire da punti di vista eterogenei, e poi ogni partecipante è stato associato a una “guida” locale: un cittadino aquilano disponibile a introdurre il fotografo alla sua conoscenza quotidiana e ravvicinata del territorio. Una fotografia “al servizio”, dunque, che cerca radici di consapevolezza nella naturale capacità di osservazione, che vuole nutrire di elementi di conoscenza le proprie scelte interpretative . È a partire dall’intuizione di Goethe per cui “l’occhio vede quel che la mente conosce” che è nata l’idea di creare questa liaison tra fotografi e “guide” locali, e di coinvolgere alcuni esperti capaci di sezionare un territorio in cui la rapida stratificazione dei segni ostruisce la lettura, tracciando dei percorsi accessibili anche a chi arriva da lontano. “Confotografia” nasce come esigenza di confronto tra fotografi che trovano nei limiti dello sviluppo professionale – i limiti di una crisi culturale che coinvolge molti settori, e che viene accelerata dai mutamenti di “supporto” – lo stimolo a mettere in discussione gli ambiti in cui operano. Fotografi abituati a considerare il proprio lavoro come parte di un processo interpretativo; professionisti che nelle loro rappresentazioni degli spazi cercano un ordine che ne consenta la lettura, che registrano pieni e vuoti all’interno di frammenti bidimensionali, collocati nel tempo. Che guardano al lavoro di chi esplora il visibile a partire dalle storie individuali come un complemento necessario, la ri-connessione imprescindibile tra un contenitore e un contenuto che ha subìto una frattura di senso. Fotografi a cui da molto tempo manca l’apporto significativo di una committenza pubblica capace di mettere in sinergia il loro contributo, e che troppo spesso vedono indebolita la propria qualità di “autori” nell’ambito di manifestazioni che, in assenza di esiti progettuali, disperdono il senso della loro qualità visiva. 157 158 Territorio e beni architettonici -ambientali Ogni nascita ha alla sua origine una cellula, capace di dar vita a un processo generativo che per aggregazione moltiplica le potenzialità insite in un piccolo nucleo. “Fuorivista”, l’associazione che nel 2010 ha prodotto “SisMyCity” – un’esposizione che è stata evento collaterale di “Biennale Architettura”, poi “adottata” da “Triennale” e da “Festarch” (www.sismycity.com) – ha coinvolto “Segni”, l’associazione di fotografi aquilani che nel 2012 ha inaugurato la “Casa della fotografia” (www.casadellafotografia.net). Insieme hanno poi chiamato a raccolta un gruppo più allargato di fotografi per costituire il comitato promotore di “Confotografia”, che a sua volta ha nominato un comitato scientifico per scegliere i fotografi da coinvolgere nel progetto. Progetto che, disatteso dalle istituzioni, è stato, va ribadito, completamente autofinanziato. Tutto in economia, quindi: le due associazioni, grazie alla collaborazione della Casa dello studente “San Carlo Borromeo” e di molti aquilani che hanno accolto i fotografi, sono riuscite ad assicurare a tutti i partecipanti il pernottamento gratuito per l’intera esperienza residenziale. Grazie al contributo del Dipartimento di scienze umane dell’Università dell’Aquila è stato organizzato un seminario introduttivo, concertato con gli stessi criteri: geografi, urbanisti, architetti, antropologi, psicologi ed esperti di fotografia (anche loro aquilani e non) riuniti per sezionare il territorio a partire dai presupposti che ne articolano la lettura.2 E poi i dibattiti, collettivi e per gruppi, facilitati da un clima conviviale e dalla forza di un luogo che pare aver trasmesso l’energia della terra al pensiero delle persone che l’hanno subìta, un luogo in cui il tempo contratto del postsisma ha prodotto dei processi ipertrofici di trasformazione dei luoghi. Ma se il tema principale di “Confotografia” si può riassumere nell’esigenza di mettere in discussione le modalità di approccio e di utilizzo della fotografia di territorio, qual è il metodo che è stato proposto, e quali effettive novità ha introdotto? Innanzitutto cinquanta fotografi sono proprio tanti. Se poi ognuno di loro ha una “guida” locale, parliamo già di un centinaio di persone coinvolte. Con la partecipazione degli studenti dei licei scientifico, classico e artistico, di quanti hanno preso parte ai molti workshop e delle associazioni locali,3 allora ecco che il dibattito si allarga e le cose che si guardano si possono misurare a partire da punti di vista davvero differenti. Non c’è solo lo sguardo ravvicinato o distante di chi guarda tutti i giorni o per la prima volta qualcosa, c’è anche un’attenzione che si sposta in virtù di conoscenze e attitudini diverse. I risultati del progetto sono ancora da sviluppare, gli esiti saranno il frutto della vivace discussione che ha visto cittadini, studenti e fotografi lavorare nel fitto programma del laboratorio, e del “caso” che ne accompagnerà l’elaborazione. Ciò che è avvenuto, tuttavia, marca già il segno di qualcosa di nuovo: un processo di reale condivisione, possibile grazie a un atteggiamento di fiducia da parte di tutti. I partecipanti aquilani hanno promesso di redigere una lista di cittadini che intendono rinnovare la propria disponibilità a ospitare e guidare i fotografi che intendono sviluppare ulteriormente il loro lavoro; tra i fotografi, molti hanno in programma di tornare. Si sta definendo la costituzione di un archivio che raccolga tutti i materiali prodotti da fotografi e cittadini (fotografie, video, audio, disegni, testi), nucleo di riferimento per ulteriori IBC 2013 sviluppi del progetto; gli organizzatori stanno discutendo le modalità di diffusione dei risultati e del processo (pubblicazioni, esposizioni, diffusione on line). Ma perché si possa dire che “Confotografia” abbia davvero funzionato, occorre che le conseguenze degli intensi giorni di laboratorio possano maturare dentro la città che lo ha ospitato, offrendo la moltitudine degli approcci visivi quale strumento di lettura del territorio. Occorre che i cittadini si approprino di quanto hanno potuto vedere grazie all’esperienza di condivisione con chi, venendo da lontano, ha offerto delle chiavi di lettura di quello che, per una sorta di assuefazione dello sguardo, rischiava di divenire illeggibile. E occorre inoltre che quanto seminato abbia il tempo per dare i suoi frutti nel terreno della fotografia, isterilito da un momento storico che rende particolarmente difficile la sopravvivenza di coloro che fanno della ricerca la propria scelta professionale. Ci auguriamo che questo impegno condiviso possa incontrare l’interesse di qualche istituzione, che intenda le potenzialità insite in un nuovo “contenitore”, capace di accogliere le istanze di indagine e di analisi che, come stabilito dalla Convenzione europea del paesaggio, dovrebbero precedere qualsiasi importante progetto sul territorio, offrendosi quale interfaccia per la partecipazione dei cittadini. Potremo allora dire di aver imparato qualcosa dall’esperienza aquilana, e che subire in molti qualcosa di terribile nello stesso momento porta con sé almeno un’opportunità, una prima pietra di rifondazione di un processo democratico. Note (1) Le associazioni promotrici sono: “Fuorivista” (www.fuorivista.org) e “Segni”. I fotografi partecipanti: Daniele Ansidei, Gianpaolo Arena, Giulia Baczynski, Pablo Balbontin, Danilo Balducci, Isabella Balena, Ivana Barbarito, Fabio Barile, Aniello Barone, Nunzio Battaglia, Enrico Benevenuti, Roberto Boccaccino, Andrea Bosio, Giulia Bruno, Michele Buda, Eleonora Calvelli, Sergio Camplone, Laura Cantarella, Claudio Cerasoli, Daniele Cinciripini, Alessandra Chemollo, Alfonso Chianese, Dario Coletti, Ezio D’Agostino, Marco D’Antonio, Marco Dapino, Paola Di Bello, Antonio Di Cecco, Giorgio Di Noto, Giuseppe Fanizza, Laura Fiorio, Gianfranco Gallucci, Stefano Graziani, Marco Introini, Cosmo Laera, Pierangelo Laterza, Marianna Leone, Peppe Maisto, Sergio Maritato, Allegra Martin, Luca Massaro, Massimo Mastrorillo, Stefania Mattu, Antonello Mazzei, Luca Mattia Minciotti, Simone Mizzotti, Maurizio Montagna, Francesco Neri, Fulvio Orsenigo, Antonio Ottomanelli, Nadia Pugliese, Sabrina Ragucci, Gabriele Rossi, Claudio Sabatino, Daniele Sambo, Massimo Sordi, Luca Spano, Davide Virdis, Giovanni Vio. (2) Tra i relatori del seminario: Fabio Pelini, assessore alla Partecipazione del Comune di L’Aquila; Luciano Marchetti, già vicecommissario per la Ricostruzione; Guido Incerti, architetto; Franco Arminio, scrittore “paesologo”; Piero Orlandi, Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna; Chiara Capodici e Fiorenza Pinna, “3/3 Studio”; Lina Calandra, geografa; Pierluigi Properzi, urbanista; Marco Morante, architetto, 159 160 Territorio e beni architettonici -ambientali “Collettivo 99”; Antonello Ciccozzi, antropologo; Sara Vegni; Alessandro Sirolli, psicologo; Antonella Marrocchi, “Policentrica”. (3) Le associazioni partecipanti: “Appello per L’Aquila”; “Arti e spettacolo”; “Bibliobus”; “Hatha Ciudad”; “Piazza d’Arti”; “Circolo Arci Querencia”; “Terremutate”; “MUSPAC”; “180 amici”; “La fiaccola”; “Territori”. [“IBC”, XXI, 4, ottobre/dicembre 2013] A Bologna, in un quartiere periferico affacciato sul Reno, ha aperto la nuova “Manifattura di arti, sperimentazione e tecnologia”, un edificio polifunzionale che salda il legame tra un’azienda e la città in cui si è sviluppata. Questo è un MAST! Piero Orlandi A Bologna, all’inizio del mese di ottobre del 2013, ha aperto i battenti “MAST - Manifattura di arti, sperimentazione e tecnologia”, un grande complesso polifunzionale composto da una gallery, una academy, un auditorium, oltre a caffetteria, nido, ristorante aziendale e centro benessere. La città e il quartiere Reno acquistano un’architettura prestigiosa e una serie di servizi sociali, culturali e ricreativi di grande qualità. È questo l’esito di un percorso durato alcuni anni. Nel 2006 G.D, la nota azienda bolognese leader del settore delle macchine per la produzione e il confezionamento delle sigarette, e la sua presidente Isabella Seràgnoli, bandirono un concorso di architettura a inviti per la realizzazione dell’ampliamento della propria sede tra le vie Battindarno, Vittoria e Speranza, su un’area confinante con quella già occupata dall’azienda. Il fatto stesso che un’impresa privata decidesse di ricorrere a una procedura di tipo concorsuale per selezionare il progetto di un intervento di grande rilievo simbolico e funzionale per la città costituiva un fatto culturale assai significativo, particolarmente apprezzato da tutti coloro che, a Bologna e in regione, lavorano per uno sviluppo urbano connesso con la qualificazione dell’architettura contemporanea. La giuria, composta tra gli altri dal sindaco Sergio Cofferati, da Francesco Dal Co, docente allo IUAV di Venezia e direttore di “Casabella”, dall’ex direttore della Galleria d’arte moderna della città, Danilo Eccher, e dall’architetto paesaggista Paolo Pejrone, scelse il progetto proposto dallo studio “Labics” dei giovani architetti romani Maria Claudia Clemente e Francesco Isidori. Il proposito fondante del progetto consisteva nell’idea di migliorare la funzionalità e l’efficienza degli spazi, a beneficio del personale impiegato nell’azienda, comunicando al tempo stesso alla città un’immagine nuova e qualificata di G.D. Il disegno, proprio per questo, prevedeva una sorta di edificio unico e multifunzionale, capace di assumere forme diverse accogliendo un asilo nido e un ristorante, pensati sia per i dipendenti che per le necessità del quartiere e della città, un auditorium di 400 posti e un museo aziendale. Questo segmento del quartiere Santa Viola ha un tessuto particolarmente frazionato, fatto di piccoli edifici mono o bifamiliari: nel progetto è 162 Territorio e beni architettonici -ambientali molto evidente l’intento di relazionarsi con il contesto urbano attraverso una grande scalinata che rende permeabile e aperta la nuova architettura verso il parco pubblico che giunge fino alle rive del fiume Reno. La presenza del sindaco ai lavori della giuria testimoniava dell’interesse vivo della città a una struttura che avrebbe contribuito in modo decisivo a dotare di servizi quel comparto urbano. Servizi anche di una certa dimensione – come l’auditorium – difficilmente pensabili per una pubblica amministrazione già a quei tempi alla ricerca di partnership con i privati: tanto è vero che in quegli stessi anni si costruiva in project financing la nuova sede istituzionale del Comune alla Bolognina. Avviata la fase di costruzione del nuovo complesso, Isabella Seràgnoli diede impulso anche alla riflessione sul tipo di museo da realizzare, che doveva dar conto al pubblico della storia dell’azienda, ma più in generale del significato e del ruolo dell’industria e del comparto metalmeccanico nella realtà bolognese, nazionale e internazionale. Considerata anche la presenza in città di un’importante collezione pubblica come il Museo del patrimonio industriale (che conserva anche pezzi riguardanti la produzione industriale di G.D), Seràgnoli preferì pensare a una struttura che, anziché rischiare di essere una replica di altre analoghe dove si conservano reperti e testimonianze della storia dell’industria, si facesse centro di promozione della ricerca artistica contemporanea sui luoghi del lavoro, e sulle relazioni complesse tra lavoro, persone, società, paesaggio. Decise che la fotografia poteva essere il linguaggio più consono a rappresentare queste relazioni, e che dunque il nascente museo di G.D doveva intendersi come collezione di opere di fotografia contemporanea dedicate all’industria, in questa accezione larga. Ed è per questo che oggi l’inaugurazione del nuovo complesso è stata accompagnata da “Foto/Industria, Biennale 01 di impresa, lavoro”. Si tratta di una serie di diciassette mostre in undici sedi, arricchita da incontri e dibattiti con fotografi e critici, svoltasi dal 3 al 20 ottobre. Curata da François Hébel, con l’équipe de “Les Rencontres de la photographie d’Arles”, la rassegna ha avuto luogo in diverse sedi espositive, tutte nel centro storico: dalla Pinacoteca nazionale al Museo civico archeologico, all’ex Ospedale degli Innocenti in via d’Azeglio. Lo si può leggere come un ritorno – almeno per immagini – dell’industria nel centro della città, un centro un tempo ricco di opifici che fecero di Bologna una delle capitali europee della produzione della seta, nei mulini mossi dalla forza idraulica. Per l’occasione l’editore Contrasto ha pubblicato un cofanetto con diciassette minicataloghi dei lavori degli artisti, fra cui Robert Doisneau, Henri Cartier-Bresson, Elliott Herwitt, Gabriele Basilico, Cesare Colombo. Nella mostra, i profondi e ormai storici rapporti tra fotografia e industria vengono mostrati nella loro molteplicità: le foto aziendali con i dipendenti messi in posa in gruppo, le stanze dei consigli di amministrazione, la fatica degli operai alle prese con le macchine, i processi produttivi nelle loro varie fasi, i luoghi diversi del lavoro, la comunicazione del prodotto, e così via. Le esposizioni temporanee sono integrate e completate dalla galleria permanente allestita nel MAST e intitolata “I mondi dell’industria”, curata da Urs Stahel, direttore del Fotomuseum di Winterthur. Qui la collezione di fotografia industriale – che comprende opere di grandi autori come IBC 2013 Bernd e Hilla Becher, Bill Brandt, Berenice Abbott, Lewis Hine, Guido Guidi, Thomas Ruff – è suddivisa secondo temi che mettono in risalto l’evoluzione del mondo della produzione dal fuoco, dalla polvere, dal grande numero degli operai dell’industria manifatturiera ed estrattiva, agli ambienti asettici dell’era digitale. Fin qui i fatti, che disegnano un’esperienza di cultura d’impresa ai massimi livelli. Nei giorni subito successivi alla inaugurazione, la città è stata scossa da una polemica innescata dall’interpretazione data ad alcune parole di Seràgnoli, che molti hanno letto come una critica per la scarsa partecipazione delle istituzioni al progetto del MAST. Forse non è inutile in proposito relazionare i tempi dello sviluppo di questa idea progettuale, sia architettonica che culturale, al contesto ideologico e operativo che la città e la regione hanno vissuto in questi anni. Si è discusso più volte sul ritardo che il capoluogo regionale ha accumulato per decenni nei confronti della cultura architettonica e urbanistica contemporanea, evidenziato anche dal fatto che le maggiori imprese culturali del periodo – pensiamo al MAMbo e alla Manifattura delle Arti – continuavano una tradizione tracciata negli anni Settanta, dove i “contenitori” del centro storico erano gli unici protagonisti architettonici. Solo nell’ultimo decennio, anche attraverso la riqualificazione di comparti ex industriali nelle zone di via Larga e della Bolognina, per iniziativa sia pubblica che privata sono sorti nuovi spazi comuni e nuove architetture in grado di costituire un’alternativa al paesaggio urbano consolidato nei decenni precedenti. Anche per forzare questa inerzia, nel 2001, la Regione e l’Istituto regionale per i beni culturali (IBC) sentirono la necessità di sfruttare pienamente la forza espressiva e comunicativa della fotografia di paesaggio per sottolineare il senso delle azioni che l’amministrazione regionale svolgeva con le proprie leggi in materia di gestione e sviluppo delle aree urbane. Nel 2001 Gabriele Basilico, che non aveva mai ricevuto grandi committenze né a Bologna né in regione, fu chiamato a commentare visivamente, con un imponente lavoro di circa settecento immagini, lo stato delle aree da riqualificare per impulso di una legge regionale del 1998; poi nel 2002 un’altra norma regionale sulla qualità architettonica diede impulso a ricerche fotografiche sulle incongruità del paesaggio e sull’architettura del secondo Novecento. In questo quadro, nell’aprile del 2006, si tenne alla ex chiesa di San Mattia, a Bologna, una rassegna di lavori fotografici commissionati negli anni precedenti dalla Regione e dall’IBC sul tema delle relazioni tra architettura e paesaggio. Erano esposte opere di Gabriele Basilico, Nunzio Battaglia, Michele Buda, Alessandra Chemollo, Paola De Pietri, Guido Guidi, Riccardo Vlahov, Giovanni Zaffagnini, eseguite nel corso delle campagne fotografiche sulla riqualificazione urbana nel 2001, sui paesaggi incongrui nel 2003, sull’architettura del secondo Novecento nel 2005. Chi scrive accompagnò Seràgnoli a visitare questa mostra, lieto di contribuire a sostenere la sua intenzione di comporre una storia contemporanea dell’industria e del lavoro attraverso la fotografia: un’intuizione molto acuta e pertinente, in una città come Bologna che era al tempo stesso capoluogo di una regione dalla grande tradizione fotografica – pensiamo alla attività di organismi come “Linea di Confine per la fotografia contemporanea” a Rubiera, come il “SI Fest” di Savignano, come la Fototeca Panizzi 163 164 Territorio e beni architettonici -ambientali a Reggio Emilia – ma priva di una solida tradizione di produzione e comunicazione della fotografia d’autore. Proprio nel 2006 si era aperta a Genova, curata da Germano Celant, una mostra sul lavoro nelle arti per celebrare i cento anni della CGIL. Il lavoro umano nel Novecento è stato trasformato dalla grande fabbrica, e gli artisti di quel secolo hanno dedicato molte opere a questo tema, da Picasso a Sironi, a Boccioni, a Léger, fino a Gabriele Basilico. Appunto nello studio di Basilico si svolse un incontro, nell’estate del 2006, per riunire alcune delle persone che avrebbero potuto supportare l’intenzione di G.D verso la fotografia: oltre al maestro milanese, a Isabella Seràgnoli e a chi scrive, c’erano Giovanna Calvenzi, critica e photo editor, Roberta Valtorta, direttrice del MuFoCo di Cinisello Balsamo, unico museo italiano dedicato alla fotografia, e Laura Gasparini, responsabile della Fototeca Panizzi, custode tra le altre di molte immagini di Luigi Ghirri. Si pensò subito a un concorso internazionale per giovani artisti fotografi, fu costituita con i presenti la giuria, poi integrata con Daniela Facchinato e con Pippo Ciorra, attuale curatore del museo MAXXI Architettura e instancabile organizzatore e propugnatore di ogni iniziativa atta a rimettere al centro dell’attenzione istituzionale l’architettura. Solo due anni prima era uscito, con l’intento di surriscaldare un poco l’atmosfera bolognese, un numero di “Gomorra”, rivista edita da Meltemi, dedicato a Bologna, la metropoli rimossa, con una serie di fotografie graffianti di Nunzio Battaglia, poi esposte all’Urban Center in una delle sue prime mostre fotografiche. In copertina campeggiava un’immagine delle famose Gocce, l’accesso all’Urban Center comunale progettato da Mario Cucinella. Non bisogna dimenticare che la sua demolizione fu una delle prime azioni della nuova giunta Cofferati, non esattamente un atto di affettuosità nei confronti del progetto contemporaneo. Nella prima riunione bolognese della giuria del premio fotografico di G.D, Ciorra propose di intitolare il concorso “GD4PhotoArt”, e questo è rimasto il titolo delle tre edizioni sin qui svolte. Alla prima, nel 2007-2008, parteciparono 36 fotografi, indicati da 12 selezionatori (direttori di musei, gallerie, agenzie fotografiche, curatori, critici) di altrettanti paesi europei, e invitati a presentare i propri curricula e i progetti fotografici. La giuria assegnò tre borse di studio a Dita Pepe, Rob Hornstra, Léa Crespi, che consentirono la realizzazione dei loro lavori, poi esposti nella mostra “Photography meets industry”, a Palazzo Pepoli Campogrande, dal 7 al 23 novembre 2008. Il catalogo, come i successivi, era curato da Giovanna Calvenzi e fu edito da Damiani. Dalla seconda edizione la giuria si è poi arricchita con la presenza e le competenze di Quentin Bajac (già responsabile delle collezioni fotografiche del Centro Pompidou di Parigi, poi direttore del dipartimento fotografico del MoMA di New York) e del gallerista londinese Michael Hoppen. I selezionatori e i paesi rappresentati nell’edizione 2009-2010 furono 17, 30 i fotografi che inviarono progetti e quattro i vincitori: la francese Olivia Gay, il britannico Justin Jin, l’italiano Alessandro Sambini e l’olandese Niels Stomps. Alla terza edizione 2011-2012 hanno partecipato 39 concorrenti, per la prima volta anche di paesi extraeuropei (Cina, Giappone, Sudafrica, Brasile). E tra i finalisti infatti c’era la giapponese Tomoko Sawada, oltre a Jiang Jun (Cina), Txema Salvans IBC 2013 (Spagna), Andrea Stultiëns (Olanda). La mostra è stata aperta dal 22 novembre al 30 dicembre 2012 presso la Pinacoteca nazionale di Bologna. Naturalmente la progressiva realizzazione di questo concorso ha consentito di creare i presupposti di contenuti e relazioni che hanno portato quest’anno, con l’inaugurazione del MAST, alla prima edizione della Biennale di fotografia bolognese. Nota L’autore ringrazia Mariella Criscuolo e Simona Poli per le notizie gentilmente fornite. [“IBC”, XXI, 4, ottobre/dicembre 2013] 165 Gli edifici realizzati negli anni del boom raccontano sequenze di adattamenti, modificazioni, valorizzazioni e successioni. Prima di interrogarci sul loro futuro, è il momento di iniziare a ricostruirne le vicende. Storie di case, in prospettiva Federico Zanfi L’invito di Piero Orlandi a stendere queste note costituisce l’occasione per iniziare a condividere alcune riflessioni sul senso di un’esperienza di ricerca che mi ha coinvolto recentemente – riflessioni che finora erano state scambiate solo entro una cerchia piuttosto ristretta di amici e colleghi – oltre che per iniziare a interrogarmi su quali siano le prospettive di un percorso di ricerca che verso tale esperienza è molto debitore. Storie di case è un’opera collettiva, che raccoglie 23 biografie di edifici e complessi residenziali costruiti tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta del Novecento in tre grandi città italiane: Milano, Torino e Roma.1 Nasce all’interno di un programma di ricerca universitario per giovani ricercatori, dedicato allo studio delle architetture costruite dai – e per i – ceti medi nelle città italiane durante il boom edilizio del secondo dopoguerra.2 Quello che nel volume viene posto sotto osservazione è un patrimonio di edifici ordinari, molto rilevante sia sotto l’aspetto quantitativo (lo stock edificato in quegli anni costituisce ancora oggi circa la metà dell’edificato complessivo di molte città italiane) sia sotto l’aspetto sociale (a quella fase di esplosione edilizia e al raggiungimento della proprietà dell’abitazione è intimamente legata l’affermazione dei ceti medi nel nostro paese), un patrimonio tuttavia poco esplorato, se non del tutto trascurato, dagli studi sulla storia dell’architettura e della città. Senza soffermarmi qui sulle ragioni di questa rimozione,3 vorrei provare a riflettere sulla scelta metodologica attraverso la quale Storie di case ha proposto ai suoi lettori di iniziare ad avventurarsi all’interno dell’immenso patrimonio edilizio del boom. O, detto in altre parole, vorrei provare a riflettere sul perché valga la pena di ricostruire, oggi, storie di edifici. Una domanda a cui, a mio avviso, si possono far seguire due considerazioni. In primo luogo, la ricostruzione della storia di un edificio richiede di tenere insieme uno sguardo retrospettivo, che cerca di far luce su elementi collocati nel passato (come la fase di progettazione o il cantiere) con un’attenzione rivolta al presente o al passato recente, che va a osservare le pratiche abitative e le trasformazioni a noi IBC 2013 contemporanee o cronologicamente più vicine. Due tipi di sguardo che, volendo semplificare un poco, sono stati spesso esercitati in modo disgiunto: da un lato il canonico approccio mantenuto dallo storico dell’architettura, che racconta un edificio attraverso il suo progetto, e raramente si interessa a ciò che accade dopo che la costruzione è stata ultimata; dall’altro lato l’indagine sul campo praticata da architetti e urbanisti, attenti a una fenomenologia di pratiche d’uso e di trasformazioni spaziali tutta collocata nel presente. Scrivere la storia di un edificio non soltanto richiede di non separare questi due registri, ma di praticarli insieme. Richiede di riflettere sull’esito, misurato all’oggi, di certe scelte progettuali o di certe soluzioni costruttive adottate quando l’edificio è stato concepito e costruito; di leggere e interpretare alcune pratiche abitative emergenti alla luce dei processi di cambiamento sociale e urbano che si sono dispiegati in un arco temporale più lungo; soprattutto richiede di non ridurre un oggetto dinamico, quale è un edificio, a una descrizione riferita a un’unica soglia temporale – o a una serie di soglie – ma piuttosto di restituire un processo, di restituire il farsi di un frammento di città, comprendendo tanto la sua costruzione materiale quanto una sua continua evoluzione sotto l’influenza degli abitanti e delle più ampie dinamiche di trasformazione urbana, sociale, culturale. Lungo questa linea di evoluzione, ci si potrà poi domandare cosa ne potrebbe essere, in un futuro prossimo, di questo frammento di città, scoprendo allora di avere a disposizione qualche elemento in più rispetto sia allo storico, sia a chi si è arrestato all’indagine della sua condizione presente (ma su questo punto ritorneremo più avanti). In secondo luogo, la ricostruzione della storia di un edificio permette di ragionare sui molteplici soggetti che hanno avuto un ruolo nella sua costruzione e nella sua trasformazione, e di rileggerne insieme i diversi tipi di lascito. Implicita, in questo approccio, è un’idea dell’architettura quale oggetto sociale complesso, oggetto il cui racconto dovrebbe essere non solo un racconto di spazi, ma anche un racconto delle forze che stanno dietro la loro edificazione e la loro modificazione nel tempo. In questa prospettiva, Storie di case ha tentato di mettere al lavoro un gruppo multidisciplinare, e ha proposto un registro narrativo a più piani, tessendo parole e immagini, voci d’individui e documenti d’archivio, frammenti di cronaca e letteratura disciplinare, fotografie d’autore e istantanee amatoriali. Che esperienza ci consente, tenendolo tra le mani, il prodotto di questa articolata operazione di montaggio? I disegni tecnici provenienti dagli archivi pubblici e professionali ci mostrano gli spazi costruiti: planimetrie generali di complessi residenziali, piante e sezioni di ambienti abitabili. Con i loro timbri, le loro annotazioni e correzioni a margine delle eliografie, questi disegni ci parlano anche di un percorso burocratico e di un ruolo d’indirizzo e negoziale svolto dai tecnici comunali, un ruolo che è stato tanto decisivo per la definizione di questi manufatti quanto del tutto trascurato dagli studiosi della città. Le voci delle persone, raccolte attraverso interviste, ci permettono poi di incrociare le storie degli edifici con le parabole imprenditoriali e le vite individuali: sono voci di costruttori, venditori, abitanti vecchi e nuovi, frequentatori assidui o occasionali 167 168 Territorio e beni architettonici -ambientali delle case, appartenenti a diverse generazioni, ciascuno col proprio tono colloquiale. Ci raccontano di quanto sia stato centrale il tema della casa – la sua costruzione, la sua proprietà, la sua valorizzazione – nelle vite della generazione che ha ricostruito e abitato l’Italia dopo il secondo conflitto mondiale. Gli opuscoli pubblicitari, le brochure promozionali e gli annunci commerciali usciti dagli archivi privati ci consentono poi di osservare l’edificio studiato in rapporto agli stili di vita e ai modelli di consumo che andavano affermandosi in quegli anni. Stili di vita fissati anche da alcune fotografie provenienti dagli album di famiglia, che ci mostrano come quelle stesse pareti domestiche fossero la scena dei momenti di tempo libero, le feste, le riunioni famigliari. Uno sguardo fotografico contemporaneo, infine, ritrae le case dall’esterno e dall’interno, ne mostra la materialità, lo stato di conservazione.4 Ma soprattutto registra come i loro spazi siano oggi occupati da una serie di oggetti e di pratiche certamente non prevedibili al momento della costruzione. Ci parlano quindi di un diffuso ma non sempre semplice processo di adattamento, che tenta di ottenere il massimo dallo sfruttamento dell’esistente, e di far accomodare nuove esigenze in spazi ereditati. Nel lavorare a questa operazione di montaggio, ma soprattutto nell’entrare dentro le case a fianco di Stefano Graziani – fotografo con cui avevo già una consuetudine di collaborazione, e che nell’ambito di Storie di case si è occupato degli edifici milanesi, che a me è toccato seguire più da vicino – maturavo un pensiero riflessivo e andavo paragonando il lavoro che stavamo conducendo ad altre esperienze di ricerca, nel cui solco mi ero formato e che avevano costituito per me dei modelli di riferimento. In particolare, paragonavo il nostro lavoro alle ricerche sull’urbanizzazione diffusa, che negli anni Novanta avevano visto numerosi studiosi produrre altrettante letture di diversi contesti insediativi italiani, e che avevano in un certo senso codificato uno stile narrativo ben riconoscibile. Quelle esperienze avevano proposto un abbinamento stretto tra il testo e l’immagine, tra la parola e la fotografia. Alla base di tale abbinamento vi era una ragione precisa, ben nota e dichiarata: a spingere ad adottare altri tipi di sguardo era l’insufficienza delle tradizionali modalità di rappresentazione dell’urbanistica – come del suo punto di vista zenitale e distante – all’atto di descrivere i materiali edilizi e le regole insediative che caratterizzavano le nuove forme di urbanizzazione. In quel particolare contesto, la fotografia funzionava molto bene (talvolta gli autori delle immagini erano gli stessi ricercatori, talvolta erano fotografi che affiancavano gli urbanisti nell’indagine sul campo), poiché consentiva di registrare praticamente in tempo reale l’apparire dei “nuovi fatti urbani”, di campionarli, di dargli un’evidenza visiva che con l’utilizzo della sola carta tecnica non si sarebbe potuta ottenere. Così fa per esempio Edoardo Marini nelle fotografie che illustrano il volume Il Territorio che cambia sulla regione urbana milanese. Così fa Gabriele Basilico nelle Sezioni di paesaggio italiano che presenta insieme a Stefano Boeri alla Biennale di Venezia. Così fanno Sisto Giriodi, nel suo Atlante sul territorio del Piemonte, Guido Guidi, accompagnando lo studio sull’area centrale veneta di Stefano Munarin e IBC 2013 Maria Chiara Tosi, e Chiara Merlini, nel suo studio Cose/viste sull’urbanizzazione nelle valli marchigiane. Al netto delle flessioni stilistiche che gli autori conferiscono di volta in volta alle immagini, a me sembra che in buona sostanza, durante quella stagione di ricerche, al fotografo, o all’urbanista fotografo, bastasse dire che quegli edifici stavano lì dove lui li rappresentava. È la loro presenza, la loro posizione e la loro forma architettonica, la novità che merita di essere registrata, ciò che in quel momento – in una fase di forte crescita di quelle nuove forme urbane – è importante testimoniare. Se torniamo a visitare oggi gli stessi territori, se torniamo a passeggiare tra i filamenti urbanizzati di case di famiglia e di capannoni industriali (ed è quello che Stefano Graziani e io abbiamo iniziato a fare negli ultimi anni, dapprima in alcuni ambienti insediativi costieri nel Mezzogiorno, poi in diversi distretti al Centro-Nord)5 il paesaggio apparentemente non è cambiato. Tutti quei manufatti stanno ancora al loro posto. Certo, qualche insegna è stata sostituita, l’intonaco è talvolta sbiadito, si nota un po’ d’erba non tagliata nei giardinetti di alcune villette o palazzine di uffici, ma sostanzialmente quello che ci raccontavano le fotografie delle ricerche che abbiamo richiamato è quasi esattamente quello che potremmo raccontare noi, se scattassimo le stesse immagini oggi, negli stessi luoghi. Il fatto significativo, però, è quel paesaggio sta cambiando, ma non dal di fuori. Sta cambiando dal di dentro. Sta cambiando nelle preferenze e nelle pratiche abitative della società che lo ha costruito, nelle sue risorse individuali e nei modelli di consumo, nei modi e nei luoghi del produrre. Sono – per riportare soltanto due esempi banali – i due coniugi anziani che ormai abitano la loro casa isolata solo al piano terra, per risparmiare sul riscaldamento, e non prendono più neppure in considerazione l’idea di fare manutenzione all’edificio. È la piccola o media azienda che ha portato la produzione in qualche paese a basso costo del lavoro – o che ha chiuso i battenti, per la concorrenza di qualche paese a basso costo del lavoro – e non riesce a valorizzare il suo capannone, una banale scatola prefabbricata con un’accessibilità non ottimale, perché non c’è più alcuna domanda per questo genere di spazi.6 Come lo colgo questo cambiamento? Certamente non soltanto rimanendo all’esterno dell’edificio e scattando una fotografia, ma forse neppure attraverso il ridisegno più analitico dei volumi costruiti. Oggi, a mio avviso, per capire come stanno cambiando i territori dell’urbanizzazione diffusa – ma il discorso potrebbe valere per tutti quei settori della città contemporanea che si trovano ormai a fare i conti con trasformazioni non più appartenenti alla stagione della crescita, non più additive – è richiesta una strategia descrittiva diversa, una strategia che probabilmente richiede uno sforzo maggiore. Oggi a mio avviso è necessario entrare dentro gli edifici e osservarli dall’interno, ascoltare le storie individuali, ricostruire le vicende richiamando e mettendo al lavoro una molteplicità di fonti, di immagini, di voci, di oggetti. Se rimango all’esterno, la dimensione del cambiamento non la colgo più. Ecco, dunque, che torniamo alle storie. È attraverso la ricostruzione delle storie degli edifici che, a valle della stagione della crescita, possiamo forse tornare a cogliere un 169 170 Territorio e beni architettonici -ambientali mutamento che non ha quasi più una dimensione quantitativa, e che pervade tutti quegli oggetti che proprio la lunga stagione della crescita aveva lasciato sul territorio. Un mutamento che oggi riguarda modi d’uso, valori immobiliari, modelli culturali e di consumo, dinamiche di avvicendamento e trasmissione ereditaria tra generazioni. Se questo è l’orizzonte della trasformazione, forse è proprio attraverso la ricostruzione di biografie di edifici che diventa possibile non solo accendere una luce sulla loro condizione presente (cosa che già molti di noi hanno imparato a fare) ma soprattutto rimettere questo presente in tensione con le dinamiche di medio e lungo periodo che lo hanno generato, e da qui immaginare plausibili traiettorie di trasformazione. Le storie delle case costruite negli anni del boom, con la loro parabola lunga ormai cinque decenni, ci raccontano di un’articolata sequenza di adattamenti, modificazioni, valorizzazioni, successioni. La descrizione prospettica di questi processi è a mio avviso il primo e imprescindibile passo per riuscire a formulare progetti e politiche che su questo patrimonio edilizio possano innestarsi in modo fertile: incontrando le predisposizioni diffuse nei proprietari e attivando le risorse residue in una direzione sensata. Lo stesso vorremmo poter dire – e questo è un campo ancora tutto da esplorare – di quella moltitudine di oggetti, suoli e tessuti edificati che oggi nel nostro paese si mostrano in una condizione incerta, senza più un uso e apparentemente senza una prospettiva. Prima di interrogarci sul loro futuro, prima di formulare strategie di riuso, è forse il momento di iniziare a ricostruire le loro storie. Note (1) Storie di case. Abitare l’Italia del boom, a cura di F. De Pieri, B. Bonomo, G. Caramellino e F. Zanfi, Roma, Donzelli, 2013. (2) Il programma Firb-Futuro in Ricerca “Architetture per i ceti medi nell’Italia del boom. Per una storia sociale dell’abitare a Torino, Milano e Roma” ha coinvolto ricercatori dei politecnici di Torino e Milano e dell’Università La Sapienza di Roma. Per informazioni sulle diverse attività svolte nell’ambito del progetto: www.middleclasshomes.net. (3) Lo fa Filippo De Pieri nel suo testo Storie di case: le ragioni di una ricerca, che introduce il volume. (4) I fotografi che hanno collaborato alla ricerca Storie di case sono Michela Pace, Fabio Severo e Stefano Graziani; quest’ultimo è anche l’autore del saggio fotografico che apre il volume, oltre che delle immagini che accompagnano queste note. (5) Alcuni primi esiti di queste perlustrazioni si trovano in: F. Zanfi, Città latenti. Un progetto per l’Italia abusiva, Milano, Bruno Mondadori, 2008; F. Zanfi, Dopo la crescita: per una diversa agenda di ricerca, “Territorio”, 2010, 53, pp. 110-116; F. Zanfi e S. Graziani, Un adeguarsi difficile. Appunti sul cambiamento degli spazi produttivi in Brianza, in A. Lanzani, A. Alì, D. Gambino, A. Longo, A. Moro, C. Novak e F. Zanfi, Quando l’autostrada non basta. Infrastrutture, paesaggio e urbanistica nel territorio pedemontano, Macerata, Quodlibet, 2013, pp. 206-215. (6) Alcune prime riflessioni su questi fenomeni si trovano in: A. Lanzani e F. Zanfi, Piano Casa. E se la domanda fosse quella di ridurre gli spazi?, “Dia- IBC 2013 loghi internazionali – Città nel Mondo”, 2010, 13, pp. 126-145; F. Zanfi, I nuovi orizzonti della città diffusa. Dinamiche emergenti e prospettive per il progetto urbanistico, “Urbanistica”, 147, 2011, 147, pp. 100-107. [“IBC”, XXI, 4, ottobre/dicembre 2013] 171 Al bordo della strada Fotografie di Matteo Sauli Nell’anno in cui cadono i ventidue secoli dalla sua creazione, la Via Emilia è stata percorsa e ritratta lungo i suoi 262 chilometri da Matteo Sauli, fotografo già sperimentatosi “on the road” con una serie dedicata alla Statale Romea. Da Rimini a Piacenza, le immagini fermate sulla consolare, così antica e così contemporanea, raccontano i volti e le cose che si incontrano al bordo di questa strada, ma anche quelli che si possono incontrare lungo i margini di una strada qualsiasi del mondo, se si ha ancora il tempo e il desiderio di guardare al di là degli stereotipi. Nato nel 1982, Sauli si è formato affiancando fotografi professionisti come Daniele Casadio ed Ettore Malanca, e frequentando l’Accademia di belle arti. Dal 2004, anno della sua prima esposizione, ha realizzato diversi progetti, tra cui la campagna di rilevamento “Ritornando in Appennino” e il reportage sul backstage della mostra sul pittore rinascimentale Garofalo al Castello Estense di Ferrara, progetti per i quali ha collaborato con l’Istituto regionale per i beni culturali, che nel 2008 ha dedicato alle sue immagini il fascicolo 2/3 della rivista “IBC”. Nel 2011 la Fondazione “Forma per la fotografia” gli ha assegnato il primo premio nel concorso “Eccezionalità dell’ordinario” in memoria dello scrittore Giuseppe Pontiggia (www.matteosauli.com). Questo diario di viaggio sulla strada che ha dato metà del suo nome all’Emilia-Romagna nasce da una collaborazione con lo scrittore Vittorio Ferorelli, da cui sono scaturiti un libro edito dalla Bononia University Press e una mostra che nel 2013, dopo la prima edizione al Museo della città di Rimini nell’ambito del “Festival del Mondo Antico”, è stata allestita nella Casa di Ariosto a Ferrara. Per approfondire si veda, nelle pagine di questo volume, l’articolo di Valeria Cicala pubblicato nel dossier del n. 1 - 2013 della rivista “IBC”. 174 Al bordo della strada “Al bordo della strada. Diario di viaggio sulla Statale 9 - Via Emilia” Còsina, Faenza (Ravenna), 2011 fotografia di Matteo Sauli IBC 2013 “Al bordo della strada. Diario di viaggio sulla Statale 9 - Via Emilia” Osteria Grande, Castel San Pietro Terme (Bologna), 2012 fotografia di Matteo Sauli 175 176 Al bordo della strada “Al bordo della strada. Diario di viaggio sulla Statale 9 - Via Emilia” Idice, San Lazzaro di Savena (Bologna), 2011 fotografia di Matteo Sauli IBC 2013 “Al bordo della strada. Diario di viaggio sulla Statale 9 - Via Emilia” Castel San Pietro Terme (Bologna), 2012 fotografia di Matteo Sauli 177 178 Al bordo della strada “Al bordo della strada. Diario di viaggio sulla Statale 9 - Via Emilia” Borgo Panigale, Bologna, 2011 fotografia di Matteo Sauli IBC 2013 “Al bordo della strada. Diario di viaggio sulla Statale 9 - Via Emilia” Faenza (Ravenna), 2012 fotografia di Matteo Sauli 179 180 Al bordo della strada “Al bordo della strada. Diario di viaggio sulla Statale 9 - Via Emilia” Piacenza, 2011 fotografia di Matteo Sauli IBC 2013 “Al bordo della strada. Diario di viaggio sulla Statale 9 - Via Emilia” Ozzano dell’Emilia (Bologna), 2011 fotografia di Matteo Sauli 181 182 Al bordo della strada “Al bordo della strada. Diario di viaggio sulla Statale 9 - Via Emilia” Santarcangelo di Romagna (Rimini), 2011 fotografia di Matteo Sauli IBC 2013 “Al bordo della strada. Diario di viaggio sulla Statale 9 - Via Emilia” Idice, San Lazzaro di Savena (Bologna), 2012 fotografia di Matteo Sauli 183 184 Al bordo della strada “Al bordo della strada. Diario di viaggio sulla Statale 9 - Via Emilia” Gallo Bolognese, Castel San Pietro Terme (Bologna), 2012 fotografia di Matteo Sauli IBC 2013 “Al bordo della strada. Diario di viaggio sulla Statale 9 - Via Emilia” Il Moro, Parma, 2011 fotografia di Matteo Sauli 185 186 Al bordo della strada “Al bordo della strada. Diario di viaggio sulla Statale 9 - Via Emilia” Cesena, 2012 fotografia di Matteo Sauli IBC 2013 “Al bordo della strada. Diario di viaggio sulla Statale 9 - Via Emilia” Forlì, 2012 fotografia di Matteo Sauli 187 188 Al bordo della strada “Al bordo della strada. Diario di viaggio sulla Statale 9 - Via Emilia” Ponte Gambino, Noceto (Parma), 2011 fotografia di Matteo Sauli IBC 2013 “Al bordo della strada. Diario di viaggio sulla Statale 9 - Via Emilia” Faenza (Ravenna), 2011 fotografia di Matteo Sauli 189 S torie e personaggi Tra i mestieri della cultura, anche quello del giornalista ha una forte responsabilità sociale. Il direttore di un grande quotidiano nazionale racconta la sua esperienza dalla carta al web. Il mestiere di scrivere Ezio Mauro Pubblichiamo una parte dell’intervento pronunciato dal direttore del quotidiano “la Repubblica” nel corso dell’incontro pubblico tenutosi l’8 novembre 2012 nella Biblioteca “Giuseppe Guglielmi” dell’Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del ciclo “I mestieri della cultura” (per guardare il video completo: www.ibc.regione.emilia-romagna.it/multimedia/video/i-mestieri-della-cultura). Quando si parla del proprio mestiere, e lo si ama, credo non sia giusto ripararsi dietro uno schermo, fingendo che non ci appassioni. La prima ragione per cui ho accettato volentieri l’invito a venire qui oggi è proprio questa: mi date l’occasione per parlare del mio lavoro, che è la cosa che mi appassiona di più e che continua a provocarmi e a ingaggiarmi come quando ho iniziato, nonostante tutti i cambiamenti che ci sono stati. Qualche giorno fa siamo stati al giornale fino alle quattro del mattino per seguire le elezioni del presidente degli Stati Uniti. Mentre noi andavamo via è montato il turno che avrebbe preparato l’edizione straordinaria di “Repubblica Sera”, una versione digitale e totalmente autonoma del nostro giornale, che è in piedi da un anno e che normalmente esce alle sette di sera, l’ora in cui, secondo gli algoritmi di Google, si è tornati a casa dal lavoro, si prende il tablet, ci si siede sul divano e magari si dà un’occhiata a quello che è successo nel mondo. Quel giorno abbiamo deciso di fare uscire un’edizione straordinaria, come si faceva con i giornali di carta, ma abbiamo puntato tutto sulla versione digitale. Il quotidiano tradizionale non sarebbe riuscito a dare la notizia, il gioco dei fusi orari e il meccanismo dello scrutinio americano non lo permettevano. Certo, la vittoria di Obama si era andata delineando nel corso della nottata, ma alle quattro meno un quarto, quando le rotative si mettono in movimento, i sondaggi dell’Ohio, lo stato chiave, davano risultati altalenanti e, soprattutto, c’erano molte schede ancora da scrutinare. Quindi abbiamo passato il testimone a “Repubblica Sera”, che è uscita alle otto con il risultato finale, e prima che uscisse ci siamo affidati al nastro di notizie che scorre 24 ore su 24 sul nostro sito web. 192 Storie e personaggi Quella mattina, qualche ora dopo, quando sono tornato al giornale per fare la prima riunione giornaliera, ho acceso il computer e c’era una email di Obama. Come tutti quelli che hanno dato un qualche contributo alla sua campagna, sono stato raggiunto più volte dai messaggi di posta elettronica inviati dallo staff elettorale, e ognuno di essi era firmato. Il giorno prima Michelle Obama mi aveva scritto: “Mio caro Ezio, sono certo che tu hai votato però passa in rassegna i tuoi amici più fragili: qualcuno potrebbe non aver votato. Vallo a prendere e accompagnalo a votare, o comunque dagli un colpo di telefono...”. Quella mattina l’email era firmata da Barack “in persona”. Stava per fare quel discorso meraviglioso che abbiamo pubblicato su “Repubblica” oggi [l’8 novembre 2012, ndr] ma prima di uscire mi ha mandato questa email: “Ezio, sto uscendo, là fuori c’è la folla che mi aspetta, vado a parlare, ma prima volevo dirti che nulla di quello che io sto per dire per celebrare il risultato che abbiamo raggiunto sarebbe stato possibile senza di te. Perché senza di te, e quelli come te, che hanno camminato viottolo dopo viottolo, isolato dopo isolato, in tutto il paese...”. Ecco fin dove arrivano questi strumenti. Per qualche frazione di secondo mi è venuta persino la tentazione di rispondere, poi naturalmente mi sono accorto che avrei scritto a un risponditore automatico. Però, dentro di me, ho pensato quanto sono duttili questi strumenti, quante potenzialità ancora nascondono, ma anche quanto sono antichi. Perché quel messaggio era la ricreazione moderna di qualcosa di antichissimo: la politica che fa verso i militanti e che li ringrazia del sostegno, come accadeva nelle vecchie società di mutuo soccorso operaio che ho avuto modo di conoscere quando facevo il cronista. Tornando a casa, quel giorno, ho accompagnato un collega che non aveva l’auto e, ripensando alle elezioni americane, gli ho detto: “Ma che grande fortuna vivere questi tempi”, e lui mi ha risposto: “Sì, e in questi casi la più grande fortuna è avere un giornale”. Torniamo, quindi, al tema del nostro incontro. Mentre venivo qui pensavo come avrei passato questa giornata se non avessi avuto tra le mani un giornale, questo strumento che ti dà la sensazione di afferrare un lembo della storia mentre ti passa davanti, di fermarla per un attimo e di farle qualche domanda. Per quanto si tenti di minare il diritto dei cittadini a sapere, questo è il vero fondamento della democrazia, che nella parte del mondo in cui per fortuna ci tocca vivere è fondata su un soggetto decisivo: la pubblica opinione. Un’opinione che si forma ogni giorno nella testa dei cittadini informati e consapevoli. Naturalmente i cittadini sono tutti uguali davanti alla legge e, quando vanno a votare, contano ognuno nello stesso modo: sia il cittadino informato, sia quello ignorante. Però non c’è dubbio: se la democrazia potesse scegliersi il suo cittadino ideale, ne sceglierebbe uno informato, che conosce i problemi su cui deve pronunciarsi e gli elementi su cui deve basare il giudizio supremo del voto. La democrazia, ha scritto il sociologo americano Neil Postman, ha una mentalità tipografica, perché, se potesse sognare, sognerebbe dei cittadini che leggono i giornali. Soltanto nel nostro paese si continua ancora a chiedere a un giornale “con chi stai?”, mentre le domande che una democrazia liberale dovrebbe fare a un giornale sono altre. Chi sei? Qual è la tua identità? Di che mondi sei composto? Qual è la tua IBC 2013 cultura di riferimento, la tua anima? Perché soltanto se io, lettore, so davvero chi sei tu, giornale, e come sei fatto, come è composta la tua redazione, che tipo di relazione culturale hai con i lettori, soltanto se so tutto questo, capisco perché su certe questioni prendi determinate posizioni, perché conduci certe battaglie e non altre. Per un giornale, poi, non dovrebbe avere alcuna importanza se il lettore quando legge un articolo la pensi come lui, perché il suo compito non è fare proseliti né convertire, ma semplicemente dare delle informazioni. Io ti ho messo tutti gli elementi sul tavolo: tu, con questi elementi, puoi costruire la tua idea della vicenda. In più, alla fine, come uno dei vari elementi, ti dico anche come la penso io; ma per chiarezza, non per convertirti. Noi non siamo né dei preti né dei partiti: dobbiamo dare qualche strumento per capire. C’è una differenza tra conoscere e capire, così come tra guardare e vedere. Davvero, allora, è come se il giornale dicesse al lettore: fai il giro, vieni qua vicino a me, questa notizia tu credi di saperla già perché l’hai sentita alla radio mentre ti facevi la barba o l’hai sbirciata sul computer di tuo figlio, ma adesso fermati e proviamo ad aprirla insieme. Il giornale fa questo: prende una notizia dal flusso di informazioni che circonda il lettore da ogni parte, la apre e ne tira fuori i pezzi. E questi pezzi sono sempre tantissimi, molti più di quanto sembrerebbe da fuori. È vero: nell’offrire un flusso di notizie, internet è imbattibile. Ma la rete è appunto come un fiume, dove a contare di più sono la capacità di portata e la velocità di scorrimento. E dentro al fiume scorre di tutto, dalle barche ai detriti pericolosi. In rete il saggio di un filosofo viaggia incollato alla pernacchia di un blogger, e senza un segno distinguibile di gerarchia rimarranno incollati per l’eternità. Il giornale non è il flusso, il giornale sta dentro il flusso e cerca in qualche modo di dominarlo, lasciando scorrere molte più cose di quelle che trattiene. Si tratta certamente di una scelta discrezionale, ma, con i pezzi che raccoglie, il giornale può costruire qualcosa di ambiziosissimo, una vera e propria cattedrale di notizie. Un luogo in cui chi vi entra può vedere rappresentati i fatti della giornata. In questa ricerca di senso c’è la vera ragione morale di questo mestiere, la sua vera garanzia di perennità. Quando dopo le 10 di sera sei lì che stai scrivendo e non rispondi più al telefono perché sai che aspettano solo il tuo pezzo per chiudere, quando a un certo punto finisci quelle cento righe e prima di mandarle via le rileggi, a volte succede che ti dici: “Ce l’ho fatta, sono riuscito a restituire almeno una parte della complessità di questa storia”. Se attraverso quella consapevolezza aiutiamo il lettore a fare qualche metro in più nel cammino della conoscenza, nella padronanza dei fenomeni su cui come cittadino si dovrebbe pure pronunciare, è un risultato meraviglioso. Una volta ho fatto i complimenti a Giorgio Bocca per un articolo e lui mi ha detto: “Non sapevo di sapere le cose che ho scritto”, e credo di aver capito cosa voleva dire. Esiste una dimensione orizzontale della realtà, quella in cui il mondo ti viene incontro, ti urta, ti provoca, e poi c’è quella verticale delle cose in cui credi, della tua cultura, del mondo che abiti, magari quella del giornale in cui lavori. C’è di continuo un urto tra queste due dimensioni, tra ciò che siamo e ciò che incontriamo, e ogni volta va tutto in pezzi. Se questi pezzi li riprendi al volo come un giocoliere e poi li rimetti insieme, può venir fuori qualcosa che fino a un momento prima non c’era. Qualcosa 193 194 Storie e personaggi di inedito, che prima non sapevi. Questo è ciò che intendeva Bocca: il pezzo che aveva scritto, evidentemente, era già dentro la macchina da scrivere. [trascrizione: Gabriella Sino; redazione: Vittorio Ferorelli] [“IBC”, XXI, 1, gennaio/marzo 2013] L’indagine di un detective della memoria riporta alla luce la storia di Arpad Weisz, l’allenatore amato da un’intera città, poi dimenticato e mandato a morte perché non era di “razza ariana”. Silenzio in campo Vittorio Ferorelli 3 gennaio 2013, in uno stadio del Nord Italia. Nel bel mezzo di un incontro amichevole di calcio, dopo mezz’ora di insulti di una parte del pubblico ai giocatori di origine africana, uno di loro si ferma, scaglia il pallone in tribuna, si toglie di dosso la maglia e decide che la partita è finita. Il nome del calciatore, quello della sua squadra, e altri dettagli, qui poco importano. Conta di più il senso dell’accaduto. A volte, semplicemente, non si può fare finta di niente. Poche settimane, dopo, a Bologna, un altro stadio ha onorato il Giorno della Memoria ricordando la storia di un uomo, Arpad Weisz, l’allenatore ungherese grazie al quale, negli anni Trenta, lo squadrone che “tremare il mondo fa” vinse ben due scudetti. Poi, quando Mussolini emanò le leggi razziali e costrinse quell’uomo ad andarsene, e poi a morire nell’inferno di un lager, la città fece finta di niente. Non ci furono cori umilianti, quella volta, ma un unico silenzio compatto. E a nessuno venne in mente di fermare il gioco. Nei mesi scorsi la vicenda di Arpad Weisz è stata ricordata in diverse occasioni. Se ne è parlato a margine della mostra su “Lo sport europeo sotto il nazionalsocialismo”, curata dal Mémorial de la Shoah di Parigi e giunta in Italia grazie all’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna.1 La Soprintendenza archivistica ha promosso a Bologna una serie di incontri scolastici con giornalisti, storici e archivisti, concludendo il ciclo con l’apposizione di una targa per ricordare il figlio di Weisz che qui, finché le leggi fasciste lo permisero, aveva frequentato le elementari.2 Persino una nota televisione commerciale si è interessata al caso, dedicandogli un’appassionata ricostruzione.3 Ma se oggi conosciamo questa storia, il merito è di qualcuno che, di fronte a un delitto di oblio, ha deciso di farsi, come s’è definito lui stesso, “detective della memoria”. Matteo Marani, giornalista sportivo, quasi dieci anni fa è partito dalle labili voci su quanto accadde a Weisz dopo che ebbe lasciato Bologna e, un giorno dopo l’altro, con gli strumenti che ogni indagatore della memoria ha a disposizione – documenti, libri, archivi, biblioteche e testimonianze dirette dei viventi – ha ricostruito i suoi ultimi anni di vita.4 Il libro che riassume questo percorso, oltre al valore civile di un recupero postumo, ha qualcosa da dire anche a quanti credono che, in fondo, i luoghi e gli strumenti con 196 Storie e personaggi cui la memoria si trasmette sono solo una spesa inutile, la prima da tagliare in caso di crisi. Senza quei luoghi e quegli strumenti, infatti, la storia di Arpad Weisz sarebbe rimasta nel buio. E lui, come i membri della sua famiglia, sarebbe morto tre volte: la prima per mano degli indifferenti, la seconda dei nazisti, la terza di tutti gli smemorati venuti in seguito. Nel 1999, introducendo il volume pubblicato per commemorare i novant’anni del Bologna, Enzo Biagi scrisse: “Si chiamava Arpad Weisz, era molto bravo, ma anche ebreo e chi sa come è finito”.5 Da questa coltre di nebbia è partito Marani per cercare di capire, innanzitutto, dove fosse finito quell’uomo, che non era esattamente un signor Nessuno. Nato a Solt, in Ungheria, nel 1896, calciatore di ottimo livello, gioca per la propria nazionale alle Olimpiadi del 1924, trasferendosi poi in Cecoslovacchia, in Uruguay e in Italia. Divenuto allenatore, nel 1930 porta allo scudetto la squadra dell’Inter (allora Ambrosiana), dove mette a frutto per primo il talento eccezionale di Giuseppe Meazza. Quello stesso anno, con il nome italianizzato in Veisz, dà alle stampe, insieme ad Aldo Molinari, un modernissimo manuale sul gioco del calcio, in cui propugna il sistema “Chapman” che poi fu utilizzato nel dopoguerra da quasi tutte le squadre italiane.6 Arrivato nel 1935 a Bologna, porta i suoi metodi innovativi anche tra i rossoblu, guidandoli alla conquista del campionato l’anno dopo e quello successivo. A Parigi, nel ’37, il suo squadrone (Schiavio, Monzeglio, Sansone, Fiorini, Biavati, Puricelli...) batte i maestri inglesi del Chelsea per 4 a 1, vincendo il “Trofeo dell’Esposizione Universale”.7 È questo l’uomo che da un giorno all’altro viene dimenticato da tutti, come se non fosse mai esistito: Bologna, 26 [ottobre 1938, ndr] Si apprende da fonte autorizzata che le superiori Gerarchie sportive hanno concesso il nulla osta nella giornata di oggi per il mutamento nella direzione tecnica del Bologna. A sostituire Arpad Veisz, la cui permanenza nella nostra città datava da tre anni e mezzo, è stato chiamato il dottor Ermanno Felsner già del Milan, il quale ritorna ad allenare la squadra rosso-blu dopo esserne stato il primo istruttore. Il dott. Felsner assumerà senz’altro l’incarico giovedì, in occasione della consueta partita settimanale fra titolari e riserva.8 Piccolo saggio di giornalismo ai tempi del regime, questo trafiletto del “Littoriale” merita la citazione per il tono burocratico con cui liquida la “permanenza” dell’allenatore, per la fretta di tornare alla vita “consueta”, per l’impassibilità con cui “senz’altro” chiude il discorso. Il “Resto del Carlino” negli stessi giorni farà anche di meglio, riuscendo a dare la notizia ancora più in breve e senza nominare Weisz neanche una volta. IBC 2013 L’indagine di Matteo Marani comincia dagli archivi dello Yad Vashem, il centro di documentazione mondiale sulla Shoah. Nella banca dati che raccoglie i nomi delle vittime trova la scheda che conferma il luogo e la data della morte di Arpad: Auschwitz, 31 gennaio 1944.9 Il passo successivo consiste nel dare un nome ai componenti del suo nucleo familiare, di cui naturalmente gli annali del calcio non facevano parola. Rivoltosi all’anagrafe storica del Comune di Bologna, l’investigatore riceve il certificato di residenza e lo stato di famiglia, scoprendo che il nostro, con la moglie Elena e i figli Roberto e Clara, viveva in via Valeriani 39, a poca distanza dallo stadio. Proseguendo le sue ricerche, Marani si rende conto di quanto sia difficile il compito di indagare il passato e di quanto sia a rischio la vita dei documenti; quelli conservati nella Casa del Fascio, dove aveva sede il Bologna, furono in gran parte bruciati da chi aveva interesse a cancellare la storia, così come accadde per i fascicoli della Prefettura relativi a quegli anni. Anche le testimonianze dei viventi, a più di mezzo secolo di distanza, sono difficili da recuperare: il più longevo dei rossoblu, Ettore Puricelli (detto “testina d’oro”), era morto nel 2001. Ma è a questo punto che entra in gioco la creatività del detective. Presumendo che il primogenito di Weisz, nato nel 1930, avesse frequentato una scuola elementare nel ’36 e nel ’37, si mette alla ricerca dei registri delle “Bombicci”, l’istituto che allora, come oggi, è più vicino a via Valeriani. Quando li trova, sepolti in un vecchio deposito, trascrive i nomi di tutti i compagni di classe del piccolo Weisz e li incrocia con quelli ancora presenti nell’elenco telefonico. Dopo alcune chiamate a vuoto, finalmente gli risponde qualcuno: “Roberto, io, lo conoscevo bene. Era il mio migliore amico. È una vita che cerco di sapere cosa gli è successo”. La voce di Giovanni Savigni trema, e non è per via dei suoi settant’anni. “Venga a trovarmi. Ho qualcosa da farle vedere”. A casa di Savigni, Marani scopre alcuni tesori inaspettati. Le vecchie fotografie che ritraggono Roberto e la sorellina Clara danno finalmente un volto a quelli che, fino a quel momento, erano solo due nomi. Ma sono altri oggetti a rivelarsi ancora più preziosi per le ricerche successive: sono le lettere scritte alla madre di Giovanni Savigni da Elena Rechnitzer, la moglie di Arpad. Lettere inviate da Parigi e poi da Dordrecht, in Olanda. Gli ultimi documenti ufficiali sulla vita italiana dei Weisz, le lettere inviate dalla Prefettura di Bologna al Ministero degli Interni (conservate nell’Archivio centrale dello Stato, a Roma), dicevano solo che il 10 gennaio 1939 i coniugi erano usciti dal Regno diretti in Francia. Finalmente si veniva a sapere dove erano andati. Dopo il breve soggiorno parigino, nella primavera del ’39 Arpad e la sua famiglia si spostano nei Paesi Bassi, dove l’allenatore prende le redini del Dordrechtschte Football Club. Manco a dirlo, dopo il suo arrivo la piccola squadra si salva dalla retrocessione e l’anno seguente si piazza nella parte alta della classifica. Ma il confine con la Germania è terribilmente vicino. Nel raccontare i suoi incontri con i giocatori e gli sportivi olandesi che conobbero Weisz, le parole di Marani si fanno scure di presagi. Nessuno di loro sapeva che era ebreo. E lui, nonostante le vittorie in campo, sembrava sempre spaventato. Evitava di farsi fotografare. Poi, quando parlava dell’Italia, all’improvviso diventava triste. 197 198 Storie e personaggi Ai primi di agosto del 1942 la Gestapo bussa a casa dei Weisz e li porta via tutti. Vengono deportati nel campo di smistamento di Westerbork, dove due anni dopo passerà anche Anne Frank; quindi, insieme a centinaia di altri ebrei, vengono stipati come bestie sui treni merci diretti verso la Polonia. Durante il viaggio, probabilmente, l’allenatore viene dirottato con altri uomini verso i micidiali campi di lavoro dell’Alta Slesia; ma è solo un’ipotesi, perché il suo nome non figura tra quelli di coloro che, alla fine di quel viaggio, scesero dai treni. Anche questo dato può essere ricavato da una fonte documentaria, il Kalendarium che riporta gli avvenimenti del campo di Auschwitz.10 Qui, il 5 ottobre, appena giunti, Elena e i piccoli Roberto e Clara vengono subito avviati alla morte nelle camere a gas. Arpad sopravviverà poco più di un anno. Nel gennaio del 2009, allo Stadio “Dall’Ara”, il Comune di Bologna ha posto una targa in memoria di Weisz sotto la torre Maratona, la stessa torre che negli anni Trenta era dominata dalla statua di Mussolini a cavallo. Una targa analoga è stata inaugurata nel gennaio 2012 allo stadio “Meazza” di Milano. Ma gli effetti della ricerca di Matteo Marani non sono ancora finiti. Di recente, infatti, è nato il “Club internazionale Arpad Weisz”, che nel primo articolo del suo statuto ripudia l’antisemitismo e ogni forma di razzismo. Il club, animato dallo storico Stefano Salmi, unisce con un ponte culturale l’università di Bologna, quella di Budapest e quella di Lisbona, città da cui l’allenatore passò da giovane per andare in Uruguay. Su quel viaggio di formazione calcistica e sulla prima parte della sua vita verte il libro che Salmi sta preparando in questi mesi, forte anche di una memoria familiare: suo padre Guerrino, calciatore nella squadra giovanile del Budrio, ebbe modo di conoscere Weisz. Conoscere. Sembra questo l’antidoto migliore alla stupidità che deriva dalla perdita della memoria. Conoscere e poi raccontarlo, perché questo è ciò che possiamo fare noi che viviamo a distanza dal passato. Nel libro intitolato Gli scomparsi Daniel Mendelhson racconta la storia delle sue ricerche per scoprire qualcosa di preciso su ciò che era successo al fratello maggiore di suo nonno, lo “zio Schmiel”, di cui in famiglia si ricordava solo che un giorno, chissà quando, chissà dove, era stato ucciso dai nazisti con la moglie e le quattro figlie. Anche lui, come Matteo Marani, ha molto viaggiato. Anche lui ha interrogato le carte e i sopravvissuti. Alla fine, quel che di preciso è successo allo zio Schmiel, non riuscirà a scoprirlo, ma si accorgerà di avere in mano, forse, qualcosa di ancora più prezioso, “un dato che non può essere trascritto su un diagramma: chi erano, com’erano vissuti”.11 Note (1) La mostra è stata allestita a Bologna dal 6 novembre al 21 dicembre 2012 presso Casa Saraceni: www.assemblea.emr.it/cittadinanza/attivita-e-servizi/ percorsi-sulla-memoria/lo-sport-europeo-sotto-il-nazionalsocialismo/. (2) Il ciclo di incontri si è tenuto nelle scuole elementari “Bombicci” e “Manzolini” tra l’1 ottobre 2012 e il 27 gennaio 2013: www.sa-ero.archivi.beniculturali.it/index.php?id=926. IBC 2013 (3) La trasmissione, “Federico Buffa racconta Arpad Weisz”, trasmessa da Sky Sport, può essere vista su YouTube. (4) M. Marani, Dallo scudetto ad Auschwitz. Vita e morte di Arpad Weisz, allenatore ebreo, Roma, Aliberti editore, 2007. (5) 1909. Novant’anni di emozioni. La rivista che racconta la storia del Bologna calcio, Bologna, Press club, 1999. (6) A. Veisz, A. Molinari, Il giuoco del calcio, Milano, Alberto Corticelli Editore, 1930. (7) Per ripercorrere la storia del Bologna Football Club la Biblioteca comunale dell’Archiginnasio ha allestito una mostra in occasione dei cento anni della squadra (“Quattro matti dietro un pallone”, 20 maggio - 26 settembre 2009). (8) “Il Littoriale”, 27 ottobre 1938. (9) La scheda cita come fonte la “Lista degli ebrei uccisi provenienti dall’Olanda” della Dutch War Victims Authority: db.yadvashem.org/names/nameDetails.html?itemId=4308844&language=en. (10) Kalendarium. Gli avvenimenti nel campo di concentramento di Auschwitz 1939-1945, a cura di D. Czech, Milano, Mimesis, 2007 (esiste una versione italiana online: www.deportati.it/librionline/Kalendarium.html). (11) D. Mendelhson, Gli scomparsi, traduzione italiana di G. Costigliola, Vicenza, Neri Pozza Editore, 2007, p. 614. [“IBC”, XXI, 1, gennaio/marzo 2013] 199 Un’articolata retrospettiva e una serie di eventi collaterali per rendere omaggio, finalmente nella sua città, a Nino Migliori, maestro della fotografia. Spazio ai Migliori Valeria Cicala Nel novembre del 2011, a Parigi, visitando al Grand Palais “Paris Photo”, e trovandoci di fronte alle foto di Nino Migliori, ci si chiedeva con altri amici quando la sua città, Bologna, avrebbe trovato modo di dedicare a questo straordinario, esuberante artista, di fama internazionale, una mostra che desse spazio a tutta la storia di un fotografo che, con solare curiosità, continua a sperimentare, a contaminare, a mischiare sogni e paure, a reinventare oggetti. Arrivò poco dopo la mostra alla Fondazione “Forma per la fotografia” a Milano, la prima grande retrospettiva dedicata a Migliori. E nell’inverno del 2013 ci ha pensato “Genus Bononiae. Musei nella città” a regalare ai suoi concittadini e a un folto, entusiasta pubblico, tutt’altro che locale, negli spazi attentamente predisposti a Palazzo Fava, un evento espositivo davvero complesso, labirintico, non esaustivo. Ma in grado di offrire, attraverso la selezione delle opere mirabilmente condotta, un tentativo, un filo di Arianna che avvicinasse il più possibile ai molteplici guizzi della sua creatività. Pensato e curato in ogni dettaglio, il percorso parte dalla fine degli anni Quaranta per giungere all’oggi. Più di trecento opere, nove installazioni, un documentario realizzato senza compiacimenti, ma come narrazione puntuale. Come pure pienamente efficace è stata la serie di incontri dedicati alla fotografia, proposti settimanalmente nel corso dell’esposizione. Ma, nel frattempo, Migliori ha già realizzato sia a Bologna, sia altrove, nuove mostre, nuove opere. Febbrile ed energico, carico di vitalità e di approcci diversi con la materia, con il paesaggio, con la realtà. Esce dagli schemi, deciso a non annoiarsi, a catturare l’occhio del pubblico e a scatenare sensazioni e riflessioni. Coerente con la frase del Mahatma Gandhi che si legge aprendo l’ottimo catalogo (“La vita non è che una serie incessante di esperimenti”) e che accompagna l’esposizione, dal titolo “La materia dei sogni”, di per sé indicativo del rapporto che l’artista ha con la fotografia.1 Migliori non andrebbe presentato con parole e con articoli. Andrebbero guardate le sue immagini, la sperimentazione e la capacità di intervenire sulle foto, di materializzarle. Ma la più proficua opportunità per comprendere i percorsi mentali, la profon- IBC 2013 dità e il rigore del suo lavoro, a cui non manca mai il desiderio di giocare e inventare, è incontrare lui. Ci si stupisce di fronte alla freschezza, al sorriso di una persona che ha varcato gli ottanta, già da qualche anno, e che ti accoglie negli spazi luminosi del suo studio, felice di raccontarti non il passato, non malinconiche riflessioni o acidi disappunti, bensì l’ultima idea a cui sta lavorando e i progetti per i prossimi anni. Invece di mostrarti un freddo rendering al computer, ti svela la maquette con la miniatura del percorso espositivo che sta realizzando, nello specifico quello della mostra in Palazzo Fava, attorniato dalle due uniche, insostituibili, infaticabili e straordinarie collaboratrici: sua moglie Marina e Antonella che, sempre nel catalogo, alla voce “ringraziamenti”, sono citate come “le streghette che condividono i miei sogni”. Osserva la tua reazione quando ti propone il reimpiego di una bottiglietta di plastica vuota che ricorda una figura umana inginocchiata; ne capirai a pieno la finalità solo quando, visitando la mostra, resterai inchiodato di fronte all’installazione intitolata Orantes, una composizione in bilico tra esigenza di assoluta spiritualità e un inquietante atteggiamento di totale sottomissione: un messaggio multiplo. Sorbendo una tazza di caffè accompagnata da biscotti al cioccolato e zenzero, davvero sublimi, con Nino si conversa di viaggi, di incontri, di fatiche divertenti, di lavori da consegnare, che propone in anteprima ai suoi ospiti raccontando i particolari di una scelta, il modo tutto suo di modificare, di intuire, ancor prima di fotografare, oggetti e materiali che dialogheranno con altre immagini, con altri suoni; che avranno una seconda vita attraverso la sua sensibilità creativa. Nella tranquillità animata dello studio, sotto le travi degli alti soffitti, tra ripiani che accolgono contenitori e cataloghi, non si respira un clima di memoria, ma di officina, di lavoro continuo. Le “stagioni” della fotografia di Nino Migliori sono tante e tutte costruite su una assoluta indipendenza e autonomia, anche perché la passione e il suo talento dovevano esprimersi compatibilmente con un’attività lavorativa, con l’esigenza di mantenere una famiglia. I suoi primi interessi sono focalizzati sulla sua terra, l’Emilia, sull’Italia del Sud, sui luoghi e le persone di un dopoguerra che ha voglia di costruire, che è carico di progetti e speranze; la sua fortuna, come quella di tanti suoi coetanei, è la straordinaria ricchezza di fermenti che gli anni Cinquanta propongono, sono le sollecitazioni che una mente fertile può ricevere ed elaborare. Migliori lavora e fotografa. Memoria e nuove alchimie si intrecciano presto nel suo percorso, con una forte attenzione per la contemporaneità, per la storia dell’arte, per i segni del quotidiano, per i linguaggi. Si pensi alla serie di fotografie dedicate ai Muri: un racconto della realtà, delle insofferenze, delle piccole grandi aspirazioni, urlate, incise in un graffio, rappresentate in un ingenuo o goffo disegno. Un percorso che precede di molto l’attenzione e gli studi che Francesca Alinovi, ricercatrice dell’ateneo bolognese, avrebbe dedicato, nei primi anni Ottanta, a quello che si definisce “graffitismo”, fenomeno nato in America alla metà del Novecento, ormai sviscerato in tutti i suoi risvolti sociali e culturali. Ma allora le stratificazioni e i fermenti che quei muri comunicavano, e su cui il fotografo ritornerà negli anni Settanta, costituiscono 201 202 Storie e personaggi un modo differente di affrontare la città, il paesaggio urbano. Come sostiene Arturo Carlo Quintavalle, “è certamente un procedimento informale e Migliori veramente dovrebbe essere situato tra i primi che hanno operato nell’ambito dell’informale in Italia”. Sono anche gli anni degli Idrogrammi, come pure il tempo nel quale instaura un costante dialogo con i personaggi del mondo della cultura, con artisti italiani e stranieri. Frequentazioni importanti, che muovono dalla richiesta di fotografare il personaggio, il suo studio ma, come ha raccontato lo stesso Migliori a Michele Smargiassi nella rivelante intervista che fa da preambolo al catalogo, “in realtà sbirciavo, carpivo, volevo capire cosa facevano, come si esprimevano, che tipi erano, se erano autentici, alcuni li ho ingigantiti altri cancellati, perché vivendo con loro capivi chi era l’opportunista, lo sgomitatore, il poeta, il disinteressato, il perfezionista che non si curava di vendere...”. Indubbiamente, incrociare e stabilire contatti con Peggy Guggenheim, scoprire artisti come Pollock, apriva nuove prospettive! Straordinario ragazzo, il nostro, che sente affinità con questa avanguardia, e prova a sperimentarla nella camera oscura. Continua a fotografare il suo mondo, ma usa acidi, realizza le ossidazioni, i pirogrammi e molti altri esperimenti inediti. Dopo tante interviste e tanti articoli, queste righe non vogliono certo raccontare né la mostra, né il catalogo, che davvero costituisce una lettura assai lucida e mai difficile dell’opera di Migliori; è piuttosto un modo per rendere omaggio a un amico che con noi ha generosamente collaborato anche in tempi recenti: è stato lui ad aprire lo scorso autunno gli incontri di Villa Franceschi a Riccione, in cui fotografi di grande fama si confrontavano con giovani, ma già sperimentati colleghi.2 Forse è anche un modo per manifestare le preferenze di chi scrive rispetto al suo universo di luce, al suo modo di usare e ricreare la fotografia, senza mai svuotare, ma piuttosto aggiungendo all’immagine un valore, una sollecitazione. Si pensi ai suoi paesaggi, così intrisi di reminiscenze morandiane, eppure rimpastati sull’epidermide delle sue foto. Come non apprezzare l’omaggio ai Carracci o la sua via Emilia bifronte? Ed è ancora l’amore per la fotografia che lo porta a creare collages con gli scarti fotografici, che lo entusiasmano come possibilità di memoria, di reimpiego, quasi un modo alternativo di proporre frammenti di vita, mosaici in cui inventare nuove storie e ridare dignità a un gesto mai casuale, mai fine a sé stesso: scattare una foto. Migliori è persona in costante viaggio, cittadino di luoghi diversi, seppure profondamente emiliano, o meglio italiano. Le sue immagini di città del nostro paese, come gli scatti di New York, che sembrano attingere alle tele di Hopper, mostrano approcci mai scontati. Altrettanto pungenti e ironiche, tornando sulle installazioni, le serie di Herbarium o di Frutta e verdura, una riflessione sul degrado della natura, sulla violenza che si adombra nel cellophane come nel vetro che mummifica e “snatura” la vita. Ma se poi dovessi scegliere una sola immagine, la sintesi del lavoro di questo straordinario personaggio, c’è una foto che mi sembra racchiuda il rapporto di questo maestro con la fotografia, uno scatto che contiene passato e futuro mentre contempla l’attimo, quel millesimo di secondo sospeso, fermo e già diverso: è Il tuffatore. Una IBC 2013 straordinaria reminiscenza classica, un messaggio di solare potenza, un lanciarsi nella scommessa di un futuro, di un sogno. Note (1) N. Migliori, La materia dei sogni, Milano, Contrasto, 2013. (2) Si vedano i video del dialogo tra Nino Migliori e Matteo Sauli, svoltosi il 18 novembre 2012: www.ibc.regione.emilia-romagna.it/multimedia/video/nino-migliori-e-matteo-sauli/dialogo-fra-nino-migliori-e-matteo-sauli-18-11-2012/. [“IBC”, XXI, 2, aprile/giugno 2013] 203 A San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna, la “Compagnia del Teatro dell’Argine” interpreta da vent’anni, in modo creativo, un’essenziale funzione democratica. Agire, raccontare, resistere, testimoniare: il ruolo del teatro Micaela Casalboni Micaela Casalboni è tra i fondatori della “Compagnia del Teatro dell’Argine”, nata nel 1994. Dal 1998 la Compagnia ha la direzione artistica dell’ITC Teatro, il teatro comunale di San Lazzaro di Savena (Bologna). Attualmente è composta da circa 30 fra registi, drammaturghi, attori, tecnici, organizzatori e amministratori. La direzione artistica è affidata a Nicola Bonazzi, Pietro Floridia e Andrea Paolucci. Nel gennaio 2012 John Mpaliza Balagizi, 40 anni, esule della diaspora congolese, ci dice che di lì a pochi mesi lascerà il lavoro di ingegnere informatico che ha presso il Comune di Reggio Emilia e partirà per un viaggio incredibile: percorrerà a piedi 1600 chilometri, farà tappa in alcuni dei luoghi simbolo della memoria, della fondazione e della cittadinanza d’Europa (la Torino di Primo Levi, la Ginevra dell’Alto Commissariato ONU per i Rifugiati, la Strasburgo delle istituzioni, la Maastricht dell’omonimo Patto), per arrivare infine a Bruxelles, sede del Parlamento Europeo. Qui, nella capitale d’Europa, John ci dice che si farà testimone della condizione di estrema violenza, sfruttamento, ingiustizia, silenzio, che, dopo aver fatto oltre sei milioni di morti, sta ancora dilaniando il suo paese, la Repubblica Democratica del Congo. Ci dice che sarà portavoce di tutti coloro che voce non hanno per farsi sentire, né trovano orecchie che vogliano intendere. Ci dice anche, più o meno testualmente: “Non ho soldi, non ho potere, non ho influenza. Una sola cosa ho della quale posso disporre liberamente: il mio corpo. E quello userò per farmi sentire”. La notizia di questo gesto, queste parole, questi numeri ci sconvolgono. Come esseri umani, come europei, come cittadini del mondo. Come artisti che nel 1994 decidono di dar vita a una compagnia teatrale che non si limiti a creare spettacoli, ma che lavori a stretto contatto con le persone, le associazioni, le istituzioni del territorio sul quale opera; che apra le porte del suo teatro non solo agli artisti o agli spettatori teatrali tipo, ma anche alle scuole, ai bambini, agli anziani, insomma ai cittadini, e poi, andando oltre, anche ai non-cittadini, a coloro che tutti i giorni lottano per i loro diritti, agli abitanti delle periferie, ai migranti, agli esclusi. IBC 2013 Prima di tutto quel gesto, così forte, così archetipico, così da eroe greco, che subito ci viene voglia di diventare il coro di quell’Oreste, di aiutare quel messaggio a emergere e a diffondersi grazie agli strumenti che ci sono propri: laboratori, letture, spettacoli da realizzare nei piccoli paesi e nelle grandi città lungo il cammino congolese. Attività che non hanno certo la risonanza della televisione, ma in compenso sono dal vivo e sono corali, dunque esercitano sulle persone che vi prendono parte una forza molto grande, quella del coinvolgimento diretto, del venire, letteralmente, toccati e attraversati da quelle testimonianze e da quelle memorie. Inoltre, cosa non secondaria, la mediazione dell’arte, che trasfigura in un’opera una storia, è un mezzo straordinario per guardare dentro queste e altre storie, spesso terribili, senza venirne sopraffatti, in modo indiretto e mediato ma non compromissorio ed eufemistico, un modo che non sminuisce l’orrore né l’importanza di quella testimonianza, ma che, elevandola all’universale attraverso il riconoscimento, l’adesione emotiva e il respiro fisico dell’azione, ce la porta vicina, ce la fa sentire nostra, ci fa sentire che tutto questo ci riguarda, non è solo l’ennesima triste storia sull’Africa che qualche telegiornale (pochi, per la verità) passa. Il teatro è come lo specchio attraverso il quale soltanto Perseo può guardare la Medusa senza timore di rimanerne impietrito. Secondo elemento che ci colpisce nel racconto di John: le parole. Una in particolare: corpo. Anche il teatro mette al centro del suo fare il corpo, il corpo dell’attore, il suo respiro, la sua voce, il corpo nel quale si traducono i significati, le parole, le storie. Infine, i numeri fanno scattare nella nostra memoria risonanze da brivido: oltre sei milioni di morti nella guerra in Congo. Sei milioni. Un numero che non può non rimandare a quell’altro numero, il numero di quegli altri poveri morti, gli ebrei “terminati” negli ingranaggi della soluzione finale senza che nessuno sapesse, credesse, vedesse. Fino all’ultimo. Dei morti congolesi invece si sa tutto. Solo che non se ne parla. Con il risultato che non esistono, questi sei milioni, e non esistendo sono condannati a moltiplicarsi perché nulla interviene a fermare quella guerra, che va avanti inesorabilmente, anche se ora non si chiama più guerra. Il Teatro dell’Argine, fin dalla sua fondazione, ha sentito l’esigenza di tenere gli occhi aperti sul mondo, di indagarlo per cercare di capirlo usando gli strumenti del teatro, oltre a quelli più ovvi della ricerca sul campo, della lettura, dell’informazione. Niente di nuovo sotto il sole: Aristofane nelle sue commedie non solo raccontava la sua epoca, faceva addirittura nomi e cognomi dei protagonisti che metteva alla berlina e che erano viventi e spesso presenti nei teatri dove la loro storia era raccontata. Questo raccontare tipico del teatro non solo ha la forza di rendere vivo e corporeo qualcosa che sui libri di storia e in televisione è lontano e freddo, è un raccontare che accade qui e ora e che si fa in coro: il coro degli spettatori che vivono tutti insieme contemporaneamente quel racconto, quella conoscenza mediata dall’arte eppure viva, respirante e sudata; il coro degli artisti che, in sala prove prima e sul palco poi, studiano e sudano per trasformare quel racconto in un pezzo di teatro e non in una conferenza; il coro degli uni e degli altri messi insieme, che insieme conoscono e si emozionano e, forse, saranno un po’ cambiati quando usciranno da quel teatro. Magari uno solo su cento. È una magia che si realizza quando gli artisti non pensano solo all’opera d’arte ma si preoccupano anche del pubblico al quale sarà rivolta e il 205 206 Storie e personaggi pubblico è assetato e pronto ad ascoltare e a dialogare con certe storie – il che non è per nulla scontato che accada, ma quando accade è atto supremo di cittadinanza e di comunità. Noi l’abbiamo visto accadere, per questo crediamo che il teatro (l’arte, la cultura) sia tra i bisogni primari dell’uomo, come il cibo, l’acqua, la voglia/necessità di socialità, l’educazione. Qualcosa di molto concreto, di essenziale, di primordiale, come gli elementi che ci hanno colpito nel racconto di John e che costituiscono il nucleo del nostro fare teatro: i gesti, le parole, i numeri, il corpo, il coro, il farsi qui e ora, l’essere (dal) vivo e vibrante, essere testimoni e portavoce, essere dentro la città, la comunità. Questi elementi sono il motore anche dei nostri lavori sulla memoria. Non si tratta di raccontare in modo per dir così compilativo un pezzo di Storia, quanto piuttosto di comprendere ciò che è accaduto percorrendo un cammino alternativo a quello dei libri di storia, per poi farsi testimoni di quel cammino, condividerlo con il coro degli spettatori, in modo che acquisti significato non come memoria d’archivio ma come segno e senso per il nostro presente. Si tratta di raccontare le persone, di entrare in relazione con esse e le loro storie: “Il teatro non è mai così commovente come quando ribalta il grande nel piccolo, e fa del frammento il prisma in cui l’intero si rilegge” (Attilio Scarpellini, “Diario”, dalla recensione di Tiergartenstrasse 4). Proprio da qui, dalle persone, nasce il nostro ultimo lavoro Se non sarò me stesso. Diari e volti dalla Shoah (2012), uno spettacolo che prende i suoi testi da quel forziere di tesori della memoria personale e privata che è l’Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano e prova a incarnarli in sei attrici sulla scena, sei donne di oggi che prendono sul loro corpo e dentro di sé i destini narrati in prima persona da sei donne ebree italiane degli anni Quaranta, che hanno vissuto i bombardamenti e le leggi razziali, la resistenza e il lager, la privazione e la clandestinità. Allo stesso modo nasce uno dei nostri più vecchi spettacoli, Tiergartenstrasse 4 - Un giardino per Ofelia (2003). In seguito a una ricerca sui meccanismi di nascita dei totalitarismi per creare lo spettacolo interattivo Cronache da un mondo perfetto, emerge dai libri di storia quella parentesi nera, a noi allora poco nota, dell’Aktion T4, il progetto nazista di sterilizzazione e sterminio dei disabili, il cosiddetto “Olocausto minore”. Cominciamo a leggere saggi, interviste a medici e infermiere del tempo, atti di processi come quello di Norimberga, poi visioniamo i film di propaganda e qualche documentario. Non vogliamo a nostra volta realizzare un documentario, non è il nostro mestiere. Nostro mestiere è trovare degli universali in cui tutti si possano riconoscere (esattamente come per le vittime congolesi); tradurre la Storia in piccole storie; creare personaggi che abbiano la credibilità delle persone realmente esistite alle quali si ispirano e al contempo la forza della verità poetica che solo la creazione teatrale può dare loro. Conoscere e inventare: così nascono i personaggi di Ofelia e Gertrud. Ofelia è la ragazza disabile che la Storia tenta di distruggere e che incarna la purezza e l’innocenza insieme alla “dolce follia” del personaggio shakespeariano di cui porta il nome; Gertrud è l’infermiera che prima tenta di salvarla, conquistata dalla simpatia travolgente di quella donna rimasta bambina, ma che poi diventa ingranaggio di quella stessa macchina di distruzione che cercava di contrastare, divenendo IBC 2013 così il simbolo della complicità con il potere, esattamente come la regina Gertrude dell’Amleto a cui si ispira. Al di là delle riflessioni e delle stratificazioni di senso da cui nasce, lo spettacolo è molto semplice, molto umano, ha fatto più di cento repliche nei teatri di tutta Italia, davanti al pubblico normale ma anche a tanti ragazzi delle scuole; una casa editrice napoletana lo ha voluto pubblicare e una spettatrice di Udine sta realizzando la traduzione in lingua tedesca perché vuole che la storia giri anche in Germania. Di voce in voce, di portavoce in portavoce. Infine, lo spettacolo Mamsèr – Bastardo racconta un’altra piccola storia, quella dell’editore modenese Angelo Fortunato Formiggini. Ebreo, umorista, uomo di cultura e poeta dialettale, Formiggini fu uno dei maggiori editori del Novecento, prolifico e impegnato a far conoscere la cultura italiana nel mondo. Ma se era il più importante editore italiano, perché nessuno lo ricorda più? È troppo facile dare la colpa al velo di silenzio che il tempo fa cadere sulle cose: se uno è importante – il più importante – il tempo non è in grado di stendere alcun velo. E allora vediamo... Formiggini era ebreo, Formiggini si è suicidato, il fascismo ha imposto la rimozione di una memoria scomoda. Tutto qui. Non è molto, ma è tantissimo. Basta questo per decidere di raccontare la storia di una vita. E se poi quella vita è piena di un entusiasmo quasi ingenuo per il proprio mestiere, sentito come missione di cultura e di affratellamento, allora costruire uno spettacolo per rinnovare la memoria di quella vita, farsi portavoce, non solo è auspicabile, ma diventa addirittura necessario. Come necessario abbiamo avvertito far recitare questo copione non solo agli attori professionisti della compagnia, ma anche a diversi gruppi di allievi dai 18 anni in su, per moltiplicare le voci e i testimoni. La lotta al silenzio e all’oblio, la necessità di dire e di resistere, fare di questa memoria qualcosa che ci riguarda oggi: è questo il filo che da Formiggini ci riporta a John Mpaliza. Formiggini, subito dopo la promulgazione delle leggi razziali nel ’38, decide di buttarsi dalla Torre della Ghirlandina come atto supremo e ultimo di protesta. Ma prima scrive a tutti, ai suoi, al Papa, al Re, al Duce, scrive poesie, lettere, epigrammi, scrive istruzioni alla moglie per la perpetuazione della sua memoria. John è stato ricevuto al Parlamento Europeo, sia a Strasburgo sia a Bruxelles, dove, alla fine del viaggio, gli è stato comunicato che finalmente, dopo quasi vent’anni, aveva ottenuto la cittadinanza italiana. La guerra in Congo continua ancora, la Resistenza, che Formiggini non fece in tempo a vedere, pure. Spetta a noi, con costanza, un giorno dopo l’altro, dentro e fuori i teatri di tutto il mondo, costruire faticosamente il nostro ruolo attivo di cittadini d’Italia, d’Europa, del mondo. [“IBC”, XXI, 2, aprile/giugno 2013; dossier Un racconto che si rinnova. Verso il 70° della Resistenza e della Liberazione, a cura di Orlando Piraccini e Patrizia Tamassia] 207 usei, delle musei, biblioteche, delle biblioteche, degli archivi degliearchivi del territorio e del territorio da da usei, delle biblioteche, degli archivi e del territorio da na prospettiva una prospettiva unica in unica Italia: in quella Italia:offerta quelladall’Istituto offerta dall’Istituto na prospettiva unica in Italia: quella offerta dall’Istituto per i beniper culturali i beni culturali della Regione della Regione Emilia-Romagna. Emilia-Romagna. per i beni culturali della Regione Emilia-Romagna. La nuovaLaversione nuova versione annuale annuale su carta, su che carta, sostituisce che sostituisce le le La nuova versione annuale su carta, che sostituisce le recedenti precedenti uscite periodiche, uscite periodiche, offre ai lettori offre ai l’occasione lettori l’occasione recedenti uscite periodiche, offre ai lettori l’occasione riflettere di riflettere su alcunisudei alcuni temi,dei delle temi, storie delle e dei storie progetti e dei progetti riflettere su alcuni dei temi, delle storie e dei progetti ffrontatiaffrontati nell’annonell’anno trascorso,trascorso, affiancando affiancando alla versione alla versione ffrontati nell’anno trascorso, affiancando alla versione on line un onsupporto line un supporto su cui sfogliare, su cui sfogliare, insieme ai insieme testi, ai testi, on line un supporto su cui sfogliare, insieme ai testi, le immagini le immagini d’autored’autore a colori ea in colori bianco e inebianco nero che e nero che le immagini d’autore a colori e in bianco e nero che appartengono appartengono alla tradizione alla tradizione della testata. della testata. appartengono alla tradizione della testata. IBC IBC2013 2013 oltre Da trent’anni oltre trent’anni la rivista la “IBC” rivista racconta “IBC” racconta il mondoil dei mondo dei oltre trent’anni la rivista “IBC” racconta il mondo dei
Scaricare