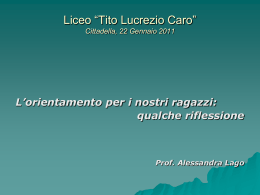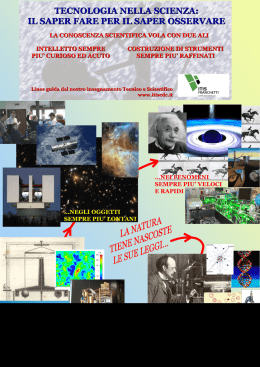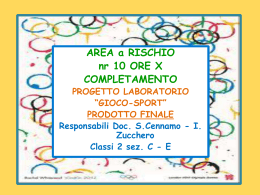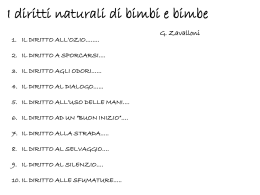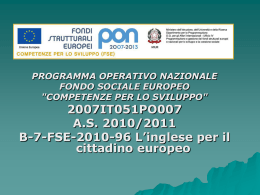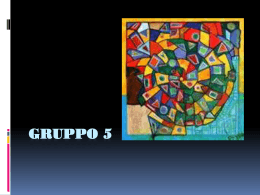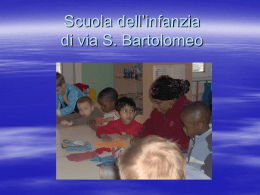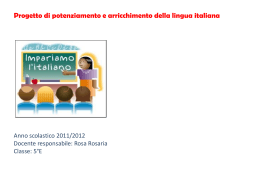Evoluzione della classe nel triennio I.T.C. "E. TOSI" – BUSTO ARSIZIO Nel corso del triennio la classe ha così mutato la sua composizione. A.sc . 2000-2001: 24 alunni. A.sc. 2001-2002 : 21 alunni. A.sc. 2001-2002 : 20 alunni Anno scolastico 2002-2003 Documento finale di programmazione del Consiglio di Classe La classe ha conservato le caratteristiche che l’hanno contraddistinta sin dall’inizio: è formata per lo più da alunni responsabili e diligenti, con spiccato senso del dovere, desiderosi di migliorare e consolidare la propria preparazione, disponibili al dialogo didattico ed educativo. Tali caratteristiche hanno permesso generalmente di superare le difficoltà incontrate- a livello dei singoli alunni e di dinamiche interne alla classe- ed hanno favorito un percorso positivo in termini non solo di conoscenze e di acquisizione di competenze, ma anche di crescita personale. Tale crescita è stata sicuramente incentivata dalle molteplici attività integrative offerte dalla scuola ed a cui la classe ha aderito ( scambi, progetti, alternanza, teatro, laboratorio teatrale…) e dall’atmosfera serena e costruttiva in cui si sono svolte le lezioni. E’ evidente che non tutti hanno compiuto lo stesso percorso: gli alunni con maggiori capacità critiche e rielaborative sono pervenuti a risultati spesso brillanti, gli altri hanno dato, comunque, prova di raggiungere con pienezza gli obiettivi fissati dal consiglio di classe. Tutti, nel complesso, hanno acquistato maggiore sicurezza e fiducia nei loro mezzi. classe QUINTA sez. CL indirizzo: ERICA Composizione del consiglio di classe Materia RELIGIONE ITALIANO E STORIA STORIA DELL’ARTE INGLESE TEDESCO SPAGNOLO MATEMATICA DIR/EC DELL’ AZIENDA GEOGRAFIA ED. FISICA docente Basaglia Cecilia D’Amico Antonella Bottini Elisa Reina Rita; Ricupero Giselle Bianchini Tiziana; Winzenburg Cecilia Agueci Monica; Arciniega M. Josè Falcetta Luisella Impiccicchè Giuseppe Florenzano Elena Pellai Alessandra Permanenza del corpo docente Nel corso del triennio il c. di cl. è rimasto invariato per quanto concerne l’insegnamento di:Religione, Italiano, Storia,Inglese, Spagnolo, Matematica, Ed.fisica. Mancanza di continuità didattica ha, invece, caratterizzato le altre materie . In modo particolare Storia dell’arte ha cambiato insegnante ogni anno, Tedesco e Diritto ed economia per l’azienda hanno avuto un insegnante in terza ed un altro in quarta e quinta; Geografia ha avuto lo stesso insegnante in terza e in quarta, mentre nel corso della quinta si è verificato l’avvicendarsi di più insegnanti. Specificità dell’indirizzo di studio In una società in rapida trasformazione (che richiede non solo conoscenza del nuovo, ma anche l’acquisizione di strumenti adeguati per leggere ed affrontare la dinamicità dei cambiamenti), il progetto ERICA (Educazione alla relazione interculturale nella comunicazione aziendale) si propone di formare una professionalità allargata, che abbia come base una vasta dimensione culturale e tenda all’acquisizione di competenze comunicative, di familiarità con quegli strumenti procedurali che caratterizzano, oggi, il mondo del lavoro. Finalità del progetto formativo è lo sviluppo di un atteggiamento interculturale basata su una visione del mondo non schematica, armonica ed ampia. Il contatto con modi di agire e di comunicare, con lingue e letterature, mentalità e sensibilità, sistemi di valori e tradizioni diversi offre allo studente un campo di osservazione ampio e privilegiato al quale può accedere, oltre che tramite l’apporto diretto della cultura di paesi stranieri, anche mediante l’uso di strumenti di analisi e di interpretazione che gli provengono dall’area delle scienze umane presenti nel curriculum. Lo studio di queste discipline permette di evidenziare le radici comuni della cultura europea sulle quali si innestano le diverse realtà nazionali. La formazione interculturale si fonda su un impianto curricolare integrato che prevede trasversalmente nei programmi delle varie discipline l’indicazione di un’impostazione non italocentrica e la possibilità dell’integrazione degli apporti formativi. Finalità non secondaria del progetto è l’apprendimento dell’autonomia come capacità di gestire il processo di apprendimento come attitudine all’autoformazione, abilità che permette, anche con l’impatto nel mondo del lavoro una costante capacità di aggiornamento. Me todo di lavoro Il consiglio di classe ha considerato lo studente soggetto attivo del processo di apprendimento. La metodologia attuata ha privilegiato l'operatività, partendo, ove possibile, da situazioni reali e concrete con successive rielaborazione dei dati per giungere a sintesi e valutazioni. A tale scopo è stato necessario sollecitare e guidare gli studenti, richiedendo loro una partecipazione più propositiva e coinvolgendoli sistematicamente nel processo formativo, al fine di fare acquisire un metodo di lavoro all'insegna dell'autonomia. La programmazione didattica è stata sistematicamente perseguita dal consiglio di classe attraverso il confronto e la discussione dei piani di lavoro delle singole discipline, che hanno costituito il punto di partenza per la stesura del piano di lavoro annuale della classe, in cui sono stati definiti la tipologia delle prove di verifica, i fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale, la corrispondenza tra voti e livelli, la definizione dei carichi di lavoro domestico settimanale e l’obiettivo trasversale. Particolare attenzione il C.di cl. ha rivolto alla valutazione, la quale è sempre avvenuta per obiettivi e, all'interno di questi, per livelli allo scopo di assicurare maggiore omogeneità al processo didattico di apprendimento-insegnamento. Per le valutazioni finali si è fatto comune riferimento alla scala di valutazione adottata dall'Istituto e relativa all'esplicitazione dei livelli conseguiti all'interno dei singoli obiettivi. 1 2 Di seguito si riporta la tabella di riferimento . LIVELLO 1 2 3 4 5 VOTO 2 4 6 8 10 Nella valutazione finale vengono presi in considerazione altri elementi importanti, quali metodo di studio, partecipazione, impegno e progressione. Attraverso riunioni periodiche il c.di cl. si è confrontato ed ha verificato il percorso formativo e didattico che si era prefissato. Momenti particolarmente significativi sono risultate le riunioni di interperiodo, durante le quali sono stati indicati i livelli raggiunti dagli alunni, per poi comunicarli alle famiglie in un effettivo rapporto di interazione. Gli studenti hanno potuto fruire della rete di recupero, sostegno e approfondimento che l'Istituto ha assicurato durante tutto l'anno scolastico. In vista poi del nuovo esame di Stato, il c.di cl. si è attivato per elaborare esempi, esercitazioni di terze prove che abituassero gli allievi ad un lavoro interdisciplinare il più concreto possibile. Una prima prova ha coinvolto le seguenti discipline: storia, spagnolo, tedesco, matematica. Una seconda esercitazione ha interessato: inglese, diritto ed ec. per l’azienda, arte, matematica. Esse hanno previsto risposte aperte, strutturate e in lingua. I giorni 22 e 23 maggio si svolgeranno le prove simulate dei primi due scritti stabiliti dall'esame di stato. ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO L'esperienza dell'Alternanza Scuola-lavoro, svolta ormai da più di dieci anni dal nostro istituto, è considerata un'attività valida per far partecipare il tessuto produttivo locale alla crescita culturale e professionale dei nostri allievi. L'impegno e l'interesse crescente manifestato dagli operatori della zona ha permesso di consolidare la nostra iniziativa e di sviluppare un dialogo quasi continuo con i rappresentanti delle categorie interessate. Il coinvolgimento del mondo esterno si è sempre più diversificato, infatti le aziende interessate vanno dal settore industriale a quello dei servizi, comprendendo da alcuni anni anche gli enti pubblici locali. Nel corso del 2002 sono state coinvolti nell'esperienza 80 alunni delle classi QUARTE che hanno svolto la loro attività di lavoro presso aziende di settori diversi (industriale, assicurativo, bancario, turistico), di dimensioni diverse, private e pubbliche e presso professionisti; anche la zona geografica si è ampliata, comprendendo oltre Busto e la Valle Olona, Legnano, Gallarate, Varese ed il Milanese. 3 E' importante evidenziare come questa attività abbia coinvolto solo gli studenti che hanno richiesto espressamente di poter svolgere questa esperienza, rinunciando ad un mese delle loro vacanze. Fra tutte le richieste pervenute, una apposita Commissione ha elaborato una graduatoria di merito, in base alla qua le sono state assegnate le aziende agli studenti. Presso ogni azienda gli studenti hanno svolto un tirocinio di quattro settimane, seguendo un percorso predisposto dall’insegnante responsabile in cooperazione con il tutor aziendale. Obiettivo essenziale del progetto è stato quello di mettere finalmente in contatto due realtà diverse, ma certo non contrapposte, offrendo la possibilità alle aziende di meglio comprendere e conoscere il mondo della scuola e agli studenti e ai docenti di verificare in che misura il lavoro scolastico sia collegato alla realtà aziendale. Gli studenti hanno saputo affrontare, con serietà e responsabilità, ambienti e situazioni nuove, adattandosi perfettamente ai tempi ed ai ritmi dell'attività lavorativa. Al termine dell'attività è stato proposto agli studenti un questionario strutturato in tre parti: SEZ. 1 – PRESENTAZIONE SEZ. 2 – L’ESPERIENZA SEZ. 3 – ATTESE PER IL FUTURO Il questionario ha dato agli studenti la possibilità di esprimere giudizi e valutazioni personali sull'attività svolta in azienda. Dalla sua analisi, sono emersi apprezzamenti sui rapporti interpersonali, sulle attività teoricopratiche, nonché sull'autonomia operativa e di giudizio che ogni ente ha liberamente concesso. Gli studenti indicano inoltre che, durante il tirocinio, hanno saputo adattarsi sia all’orario loro imposto sia al disagio derivante dalla distanza del luogo di lavoro rispetto alla loro abitazione. Particolare rilievo viene attribuito dai ragazzi alle diverse competenze necessarie per lo svolgimento della mansione loro affidata. Riconoscono anche di avere avuto maggiori sollecitazioni e motivazioni allo studio e dichiarano la loro disponibilità a ripetere l’esperienza come diplomati anche per un periodo più lungo. I ragazzi esprimono un giudizio positivo sull’utilità dello stage perché permette loro di verificare capacità e attitudini per il futuro, acquisire nuove conoscenze sia sul lavoro che nell’organizzazione, rapportarsi con persone che operano nel mondo del lavoro. Anche le aziende, nel completare la loro scheda di valutazione, evidenziano apprezzamenti sull'iniziativa, sui programmi didattici formulati e sulla preparazione scolastica degli alunni. L'esperienza ha ampiamente dimostrato che il nostro insegnamento non è solamente improntato alle conoscenze, ma è rivolto all'acquisizione di capacità operative e abilità pratiche. La validità dell'esperienza è avvalorata dal fatto che l'attività viene ripetuta anche nel presente anno scolastico. Per gli alunni l'esperienza non si esaurisce con la loro permanenza in azienda, ma culmina con una breve relazione individuale che mette in evidenza soprattutto gli stati d’animo, le paure e i sentimenti provati durante l’esperienza, le aspettative ed i risultati ottenuti. Alcuni studenti hanno poi deciso di approfondire alcune delle tematiche affrontate durante lo stage, con una relazione che sarà presentata agli esami di maturità. 4 Nel corso dell’estate 2002 un gruppo di 2 alunni ha svolto l’attività di alternanza scuola-lavoro presso le aziende indicate nella tabella seguente: COGNOME LUALDI MASIELLO NOME ELISA SARA DITTA CAYO COCO VIAGGI JET HOTEL S.r.l. CITTÀ BUSTO ARSIZIO GALLARATE CLASSE 4CL 4CL ORIENTAMENTO L’attività prevista dal DM 487/97 si è sviluppata nel corso degli ultimi sei anni scolastici con l’obiettivo di costruire un percorso di attività che renda lo studente maggiormente consapevole delle proprie attitudini, delle possibilità offerte dal contesto in cui vive in funzione della scelta postdiploma e capace di acquisire in formazioni sulla tipologia degli studi universitari, sulla formazione professionale superiore e sul mondo del lavoro. La Commissione Orientamento si è costituita come gruppo di progetto ed ha elaborato il piano delle attività e gli strumenti per realizzarlo. I moduli di orientamento, realizzati nel corso dell’anno scolastico, hanno permesso agli studenti: ?? di assumere informazioni dirette sul contesto (mercato del lavoro, opportunità di proseguire gli studi, riforma universitaria, offerta formativa dei diversi Atenei, investimento nella formazione di capitale umano: analisi costi/benefici ) ?? di acquisire metodica di ricerca ?? di acquisire consapevolezza riguardo alle attitudini (simulazione test di ammissione all’Università, colloqui attitudinali ) ?? di saper stilare domande di lavoro , curriculum vitae e lettere di accompagnamento ?? di simulare colloqui di assunzione. Inoltre durante tutto l’anno è rimasto operativo lo sportello di orientamento per garantire colloqui individuali con il responsabile del progetto ed il Centro di Autoorientamento dove gli studenti hanno potuto reperire materiale informativo sia cartaceo che multimediale e dove sono presenti postazioni dotate di PC collegati con Internet. In modo più analitico, l’attuazione dell’area di progetto, oltre agli obiettivi specifici delle materie direttamente coinvolte, consente di perseguire, e di verificare importanti obiettivi trasversali, quali: ?? individuare e rappresentare modelli o procedure ?? verificare progressivamente la validità degli esiti ed eventualmente correggere in itinere l’impostazione ?? documentare il lavoro in modo corretto ed esauriente ?? comunicare efficacemente i risultati conseguiti La realizzazione dell’area di progetto per l’anno scolastico 2000-01 ha visto coinvolte le classi quarte, in quanto gli studenti dovrebbero aver acquisito adeguate conoscenze procedurali, capacità operative e sufficiente autonomia, indispensabili per affrontare un’attività incentrata su una produttività spontanea. Il ruolo del docente, infatti è stato quello di osservatore attento e di eventuale risorsa a disposizione degli studenti, proprio perché finalità principale del progetto deve essere quella della crescita e dello sviluppo nell’allievo di una autonoma capacità critica e progettuale. L’attività è stata svolta in prevalenza durante le ore curriculari sulla base del calendario programmato dal consiglio di classe. I ragazzi hanno provveduto a riorganizzare il lavoro svolto in modo organico e funzionale; al termine dell’attività, come documentazione per il Consiglio di Classe, è stato predisposto un quaderno a fascicoli, in cui è stato raccolto buona parte del materiale prodotto. Ciascuna classe ha inoltre provveduto a presentare il lavoro attraverso sintesi realizzata con Power Point. L’attività è stata, alla fine, oggetto di una duplice valutazione ?? la prima, riguardante il prodotto in quanto tale, è stata effettuata in base a parametri quali: la completezza, la complessità, la correttezza e l’organicità delle soluzioni, la ricchezza della documentazione ?? la seconda, riguardante i comportamenti degli allievi che hanno partecipato al progetto, è stata di competenza del consiglio di classe attraverso griglie d'osservazione sistematica appositamente predisposte. Gli studenti stessi hanno sentito l’esigenza di autovalutarsi, predisponendo griglie differenziate, allegate alla documentazione delle singole aree di progetto. Il consiglio di classe ha fatto proprie le valutazioni elaborate dal docente referente, che hanno formato parte integrante della valutazione finale del singolo allievo. AREA DI PROGETTO Gli indicatori utilizzati sono stati i seguenti: ?? Responsabilità nel mantenere gli impegni e nel portare a termine il proprio compito 1. tende a sfuggire alle responsabilità 2. è responsabile, ma bisognoso di essere sollecitato 3. è responsabile in ogni situazione 4. è responsabile e disponibile L’area di progetto, intesa come simulazione di situazioni reali, costituisce un valido strumento didattico non solo perché favorisce l’interiorizzazione delle conoscenze attraverso la loro applicazione, ma anche per l’alta valenza formativa che deriva dall’imparare ad assolvere un compito complesso, verificabile e finalizzato. Costituisce inoltre un momento estremamente formativo nel quale possono emergere capacità che gli studenti non riescono ad esprimere in situazioni di apprendimento normale. L’introduzione dell’area di progetto nel processo formativo può quindi consentire allo studente di: ?? cogliere l’unità del sapere ?? riflettere sulle proprie capacità operative e organizzative ?? favorire il confronto tra istituzione scolastica e realtà lavorativa ?? contribuire a sviluppare senso di responsabilità e rispetto degli impegni, ma anche quella particolare disposizione mentale che induce a cercare nuove soluzioni, a modificare i propri comportamenti, a rivedere i propri giudizi. ?? 1. 2. 3. 4. 5 Capacità di proporre nuove soluzioni e di adattarsi a nuove scelte scarsa si adatta alle nuove scelte si adatta e tenta di proporre nuove soluzioni propone nuove soluzioni 6 ?? 1. 2. 3. 4. ??Obiettivi: Capacità di documentare il proprio lavoro e relazionare documenta e relaziona in modo superficiale e impreciso documenta e relaziona in modo diligente e corretto documenta e relaziona in modo accurato e appropriato documenta e relaziona in modo completo e originale 1) Possedere le conoscenze di base degli elementi di un pacchetto turistico e delle relazioni fra domanda e offerta del settore 2) Saper valorizzare le risorse locali e quelle delle nazioni di cui si studia la lingua 3) Suscitare interesse verso il mondo del turismo 4) Dimostrare capacità nella gestione e conduzione di una piccola attività imprenditoriale 5) Poter utilizzare le lingue straniere apprese Relazione del docente referente Il Consiglio di classe ha indicato come referente la prof.ssa Bianchini Tiziana. La classe ha aderito alla proposta del referente, prof.ssa Bianchini Tiziana, di gestire virtualmente un Tour operator con sede a Busto A. (Va). Il Tour operator portava il nome di “Le palette”. Poiché gli studenti non avevano nozioni di turismo sufficienti ad affrontare un lavoro, anche se virtuale , di questo tipo, sono state impartite loro otto ore di lezione informative dal Prof.Torrente Gianluca, esperto nel settore. ??Finalità: ?? Suscitare interesse verso il mondo del turismo ?? Dimostrare capacità nella conduzione e gestione di una piccola attività imprenditoriale ?? Poter utilizzare le lingue straniere apprese ??L’attività: 1. Introduzione: ?? ?? ?? ?? Nozione di pacchetto turistico Tour operator e agenzia viaggi: “grossisti” e “dettaglianti” di pacchetti turistici Il catalogo: contenuti, termini e condizioni contrattuali di un pacchetto turistico Il programma La partecipazione a questo breve corso non è sempre stata attiva e produttiva. Ciononostante il prodotto finale si può definire buono perché: ??Le ragazze hanno saputo sfruttare diversi dei suggerimenti forniti nella stesura, ad es., di un pacchetto-viaggi; ??Hanno saputo relazionarsi con un pubblico curioso durante la “Giornata aperta”, momento in cui è stato presentato il prodotto; ??Hanno a raccogliere materiale idoneo e rielaborarlo; ??Hanno incominciato a saper lavorare in “gruppo”; ??Hanno acquisito nozioni di turismo nuove; ??Hanno imparato, seppur in misura minima, a saper leggere in maniera intelligente un depliant e le proposte ivi contenute. I livelli di partecipazione e di interesse mostrato sono diversi poiché taluni hanno lavorato in modo molto produttivo, altri più superficiale. 2. Incoming: ?? Nozione e commento di dati statistici settoriali ?? Come si “costruisce” un pacchetto turistico di incoming: programma, comportamenti di turisti di diverse nazionalità, contenuti (le strutture ricettive, i mezzi di trasporto, le guide), costi e ricavi ?? Consulente di un operatore turistico locale: esempio di un pacchetto turistico di incoming ?? Pubblicità: fiere, riviste di settore, Internet, strumenti “alternativi” 3. Outgoing: ?? Nozione di commento di dati statistici settoriali ?? Come si “costruisce” un pacchetto turist ico di outgoing: la scelta della destinazione e della tipologia del prodotto, programma, contenuti (il vettore aereo, l’operatore turistico locale, l’accompagnatore), costi e ricavi ?? Responsabile della programmazione di un piccolo tour operator di nicchia; esempio di un pacchetto turistico di outgoing ?? Pubblicità: fiere, riviste di settore, Internet, strumenti “alternativi” 7 Sono state coinvolte in particolare le lingue straniere (Inglese, Tedesco, Spagnolo), mentre le altre materie hanno contribuito con il 10% del loro monte ore dell’orario scolastico e con attività di assistenza. ??Presentazione del progetto: ?? Giornata aperta a. sc. 2002/2003: sabato 11 gennaio ?? Presentazione di un CD-Rom 8 ATTIVITA’ INTERNAZIONALI E DI SCAMBIO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE Gli scambi all’estero si sono dimostrati un valido strumento per la realizzazione degli obiettivi didattici ed educativi delineati dai singoli progetti. Dal punto di vista linguistico gli allievi hanno potuto rafforzare le abilità di comprensione e di esposizione, attraverso la pratica quotidiana della lingua straniera in famiglia, a scuola e durante le visite. Pratica che continua tuttora mediante scambi epistolari. Gli scambi hanno permesso inoltre una presa di contatto con una realtà e con abitudini diverse dalle proprie, favorendo così un’educazione interculturale volta al superamento di pregiudizi. Grazie agli scambi è stata offerta infine agli allievi l’opportunità di effettuare il confronto tra sistemi scolastici diversi e di approfondire le loro conoscenze in campo sociale, storico, geografico e politico del paese partner. Nell’ambito del Progetto Lingua 2000, l’Istituto ha offerto la possibilità di conseguire una serie di certificazioni linguistiche in collaborazione con University of Cambridge e Goethe-Institut di Milano. Hanno aderito al progetto i seguenti alunni: Inglese: PET: Etossi, Guccione, Lualdi, Masiello, Restivo, Rogora, Gagnolato, Lardo, Direnzo, Formenti, Caldarella, Venturin, Mocchetti FIRST: Rogora, Restivo, Dei Negri, Etossi, Guccione, Lualdi, Masiello Tedesco: ZD: Rogora, Guccione, Etossi, Masiello, Lualdi, Restivo, Lardo, Rimoldi, Gagnolato. Anno Sc.1999-2000 : sette alunne (Etossi, Guccione, Lualdi, Masiello, Restivo e Rogora ) hanno partecipato allo scambio effettuato con l’Istituto Het Assink di Haaksbergen (Olanda) nove alunne (Direnzo, Lardo, Milani, Mocchetti, Provasi, Rimordi, Paganini, Provasi,Venturin,Zocchi) hanno partecipato allo scambio effettuato con l’Istituto IES “Juan da la Cerva” di Velez (Spagna) Anno sc. 2000-2001: tutta la classe ha partecipato allo scambio effettuato con l'Istituto Bundeshandelsakademie Feldkirchen (Austria) Nello scambio è stato di importante significato didattico l’uso delle lingue veicolari tedesco e inglese, utilizzate sia per comunicare che per la produzione di tutti i materiali. Si segnala il comportamento corretto delle alunne che hanno partecipato sia alle attività didattiche che culturali con impegno ed entusiasmo, confermato anche dagli insegnanti e dalle famiglie che le hanno ospitate. LABORATORIO TEATRALE Hanno partecipato alle attività di laboratorio teatrale, organizzate dall’Istituto, le alunne Lardo (nel corso della classe terza) , Etossi e Direnzo (nel corso del triennio). FORUM INTERNAZIONALE ANNO SC. 2001-2002 In occasione del cinquantesimo dell’Istitut o, i seguenti alunni : Caldarella, Dei Negri, Demolli, Direnzo, Lardo, Etossi, Masiello, Gagnolato, Zocchi, hanno partecipato attivamente all’organizzazione del Forum. La partecipazione agli scambi è stata sentita e motivata e gli alunni hanno dimostrato entusiasmo, correttezza e senso di responsabilità. ATTIVITÀ INTERNAZIONALI Durante lo scorso anno scolastico, alcuni studenti hanno avuto la significativa opportunità di recarsi a Mesa in Arizona per frequentare un corso estivo di lingua inglese presso il MESA COMMUNITY COLLEGE. Hanno partecipato all’attività le alunne Annalisa Formenti e Tania Lardo. Nel corso del presente anno scolastico, le alunne Elisa Lualdi e Sara Masiello hanno inoltre partecipato all’International School Forum ad Harrogate (Tennessee) – USA, durante il quale hanno collaborato con studenti provenienti da tutto il mondo, confrontandosi con culture diverse sul tema dello sviluppo personale e sociale nel curriculum scolastico. PROGETTI EUROPEI Anno Sc. 2000-2001: le alunne Etossi, Guccione, Lualdi, Masiello e Rogora hanno partecipato al Convegno “Netdays Europe” che si è tenuto a Varese Le alunne Gagnolato e Mocchetti hanno partecipato alla manifestazione Euroscola presso il Parlamento Europeo di Strasburgo Anno Sc. 2001-2002: l’alunna Etossi ha partecipato al Convegno Internazionale Exposcuola, tenutosi a Salerno. 9 10 Come metodologia didattica è stato utilizzato, innanzi tutto, il metodo della provocazione, ponendo domande e offrendo sollecitazioni di vario tipo, avvalendosi di scritti e citazioni di autori e intellettuali contemporanei. Conseguentemente la classe è stata guidata, per mezzo del dialogo e del confronto, a prendere in seria considerazione quanto le veniva offerto, a porlo in relazione con l’e sperienza personale e a comprendere e valutare, infine, gli insegnamenti specifici della disciplina. Come modalità di verifica sono stati considerati gli interventi spontanei degli alunni operati nell’ambito delle lezioni, le risposte da loro date a domande flash, l’effettiva comprensione e rielaborazione dei temi svolti ed è stata particolarmente apprezzata l’eventuale seria considerazione critica espressa dagli studenti durante il dialogo educativo. E’ stato considerato, inoltre, l’atteggiamento globale dell’alunno inteso come interesse, capacità di ascolto, partecipazione, responsabilità e rispetto. PIANI LAVORO DELLE SINGOLE DISCIPLINE Religione Prof.ssa Basaglia Cecilia OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO E LIVELLO MEDIO DI PRESTAZIONE DELLA CLASSE Gli obiettivi formativi perseguiti nell’ambito della attività didattica sono i seguenti ?? Conoscere il problema dell’esistenza di Dio nella ricerca dell’uomo e nella rivel azione divina. ?? Saper analizzare fatti attuali inerenti la vita della Chiesa locale ed universale, esponendo il proprio giudizio critico e personale. ?? Saper cogliere le valenze religiose presenti nella storia e nelle culture contemporanee. ?? Saper cogliere le implicazioni etiche dell’adesione al cristianesimo. ?? Saper utilizzare in modo corretto documenti del Magistero e fonti varie inerenti gli argomenti trattati. Obiettivi trasversali e ruolo specifico della disciplina Consolidare negli allievi l’acquisizione degli atteggiamenti giusti per la ricerca personale: lealtà nei confronti della verità, capacità di ascolto, di riflessione personale e di confronto, acquisizione del senso del limite, rispetto e tolleranza. Portare gli allievi ad una conoscenza critica del fatto religioso nella sua globalità, per renderli autonomi e consapevoli delle proprie scelte di vita. Livello medio di prestazione della classe Nell’arco del triennio circa il 50% degli alunni si è avvalso dell’ora di istruzione religiosa cattolica mantenendo il medesimo insegnante. Gli alunni hanno dimostrato seria e appropriata considerazione degli argomenti svolti, solo alcuni, però, hanno partecipato anche attivamente alle lezioni e con apporti personali, altri hanno mantenuto una recettività seria e riservata, secondo la diversità delle loro realtà personali e relazionali. Hanno rivelato, altresì, di possedere discrete capacità critiche e di aver rielaborato le tematiche offerte in modo adeguato. Il livello di prestazione degli alunni è pertanto ottimo. Metodologia di insegnamento Il criterio didattico di fondo adottato è quello della prospettiva antropologica/storica, scelto tra quelli indicati dai nuovi programmi per l’insegnamento dell’Istruzione Religiosa Cattolica, redatti dall’Ufficio Catechistico Nazionale. Si è cercato, cioè, di risvegliare negli alunni i grandi interrogativi che suscitano la domanda religiosa per poi svolgere la tematica della rivelazione cristiana, in relazione con i suoi sviluppi storico/culturali, sociali ed etici. Gli obiettivi disciplinari hanno teso, quindi, a far sì che gli alunni potessero passare dal…"piano delle conoscenze a quello della consapevolezza e dell’approfondimento dei principi e dei valori del cattolicesimo…". (programmi Ufficio Catechistico Nazionale), in relazione con la cultura contemporanea e in quanto inseriti nella loro valenza formativa globale dell’alunno. 11 DESCRITTORI VALUTAZIONE CORRISPONDENZA LIVELLI/VOTI ARTICOLAZIONE DEI LIVELLI E ?? Conosce il problema dell’esistenza di Dio nella cultura contemporanea in modo: 1. lacunoso 2. parziale 3. adeguato 4. preciso 5. completo ?? Comprende il valore delle proposte etiche e le loro implicazioni antropologiche in modo: 1. parziale 2. impreciso 3. essenziale 4. preciso 5. completo ?? Analizza i fatti della storia e della cultura contemporanea sapendoli rapportare ad un messaggio religioso in modo: 1 inadeguato 2 parziale 3 adeguato 4 preciso 5 completo ?? Corrispondenza livello/voto Livello 1 voto scarso livello 2 voto insufficiente livello 3 voto sufficiente livello 4 voto buono livello 5 voto ottimo STRUMENTI DIDATTICI Libro di testo in adozione: “Il nuovo Religione”, per il triennio, Flavio Pajer, edizioni SEI. Videocassette e brani di autori contemporanei. La Bibbia di Gerusalemme, ed. Dehoniane Bologna. Documenti del Magistero Catechismo della Chiesa Cattolica, Libreria Editrice Vaticana-1993. Articoli di quotidiani e settimanali. 12 ITALIANO PROGRAMMA La maggior parte degli argomenti svolti hanno trovato riscontro nell’ambito dei moduli “Vocazione all’amore: rapporto di coppia, sacramento del matrimonio e famiglia” e “La responsabilità dell’uomo verso se stesso, gli altri, il mondo” con la seguente scansione. Aspetti di etica relazionale/sociale e la relativa morale cristiana/cattolica. L’amore consapevole e responsabile secondo il Catechismo della Chiesa Cattolica. Il santo: un uomo vero. La nostra appartenenza culturale all’occidente cristiano, sviluppo di un articolo della pagina culturale del Corriere della Sera del 8/11/02: “Quando l’Italia uscì dalla selva oscura” di J. Le Goff. In seguito alla visita del papa Giovanni Paolo II a Monte Citorio sono stati svolti i seguenti argomenti: articolo da “Il Giorno”, “siate uniti e solidali”; visione di parte di videoregistrazione dell’evento stesso; l’origine culturale della nostra società a partire dai discorsi di accoglienza degli onorevoli Casini e Pera. Commenti inerenti l’incontro con il neo-Vescovo Tettamanzi della nostra diocesi, un espressione del cristianesimo. Aspetti di etica/solidale per l’uomo e per il cristiano. “Sono nato, dice Dio perché “ analisi di un componimento inerente l’annuncio del Natale. Saper utilizzare le categorie del “cuore e della ragione” nell’esporre le proprie affermazioni e opinioni. Lettura e analisi dell’introduzione a “Ipotesi su Gesù” di Vittorio Messori con conseguente sviluppo del tema dell’esistenza di Dio e di alcuni aspetti di fondo del cristianesimo. Don Isidoro Meschi: la sua dedizione per i giovani e la sua comunità di recupero per tossicodipendenti “Marco Riva”. La pace del Papa: giustizia e pace, essere operatori di pace(Angelus del 23/02/03). Mons. Albacete, il fatto cristiano punto di incontro fra un americano e una irachena, articolo del settimanale Tempi del 26/03/03. I gesti culturali e attuali del Papa: l’incontro con i giovani a Roma e l’enciclica del 17/04/03. Il dialogo con le altre religioni: islam e induismo. Prof.ssa D’Amico Antonella Obiettivi di apprendimento Gli obiettivi d'apprendimento concordati nelle riunioni di coordinamento disciplinare sono i seguenti: · · · · · · · · · · conoscere le problematiche trattate, i testi letti e analizzati, i profili degli autori, le caratteristiche specifiche dei generi letterari, gli aspetti essenziali dei movimenti culturali; compiere analisi differenziate secondo i testi e individuare la funzione comunicativa; riconoscere i modelli culturali caratterizzanti le epoche prese in considerazione; riconoscere elementi di continuità e di innovazione nella storia delle idee; confrontare prodotti di uno stesso genere distanti nel tempo e riconoscere persist enze e variazioni; ricostruire attraverso analisi, confronti e sintesi, l'evoluzione diacronica dei movimenti e delle epoche; ricostruire l'iter evolutivo sia stilistico sia ideologico di un autore in rapporto alla sua formazione e alla tradizione; produrre elaborati di diverso argomento secondo modelli di scrittura diversi, tema,analisi testuale, saggio breve articolo di giornale operare collegamenti interdisciplinari motivare correttamente i propri giudizi Livello medio di prestazione della classe Interesse per la materia, serietà di impegno e continuità di studio hanno nel complesso caratterizzato la classe, nella quale le lezioni si sono svolte in un’atmosfera serena e costruttiva. La piena disponibilità al dialogo didattico-educativo ha permesso a tutti un’apprezzabile progressione rispetto ai livelli iniziali, sia sotto l’aspetto delle conoscenze e competenze che dal punto di vista della crescita personale, che per molti si è soprattutto tradotta in una maggiore sicurezza nelle proprie capacità e disinvoltura nel relazionarsi con gli altri. In particolare, gli alunni con maggiori capacità critiche e rielaborative sono pervenuti a risultati decisamente apprezzabili e hanno dato prova di autonomia di lavoro e di saper effettuare collegamenti interdisciplinari; gli altri hanno raggiunto in maniera sicuramente adeguata gli obiettivi prefissati. Nel suo insieme, la classe dimostra di avere un orientamento storico - letterario generale, che consente di inquadrare autori e movimenti; è in grado di leggere ed analizzare, effettuando i necessari collegamenti, i testi esaminati; per lo più chiara, corretta e logica è l’esposizione, tanto orale che scritta. Metodologia di insegnamento Attraverso percorsi didattici mirati, si è teso al raggiungimento di obiettivi specifici e trasversali, quali la conoscenza di autori e movimenti, di testi , letti, analizzati ed inseriti nel giusto contesto culturale e storico, allo sviluppo delle capacità di comunicazione e logico - operative, al potenziamento del piacere della lettura. Il metodo di lavoro ha avuto come punto di partenza l’analisi e l’interpretazione dei testi: brani letterari, poesie, documenti, pagine critiche. L’esame dei testi è stato occasione di discussioni e confronti, ed ha permesso di ricostruire movimenti e poetiche. 13 14 La lezione di tipo tradizionale ha avuto la funzione di introduzione alla lettura, sollecitazione di interessi, commento al testo qualora non sia risultato sufficiente l’apporto guidato degli alunni, integrazione e raccordo informativo, aiuto a costruire una sintesi conclusiva dell’unità didattica. Si è sempre cercato di stimolare negli studenti l’autonomia di lavoro, la ricerca personale, l’attitudine alla curiosità intellettuale, indirizzando gli interessi anche verso altre espressioni culturali, quali il teatro. Significativa a questo proposito è stata la risposta di un numero elevato di studenti che hanno assistito con piacere agli spettacoli teatrali proposti dalla scuola. Valutazione Le varie fasi di lavoro sono state accompagnate da un ’ attenta e continua valutazione, finalizzata alla verifica del percorso di apprendimento e a rendere lo studente consapevole delle proprie difficoltà e dei progressi compiuti. La valutazione ha assunto forme diverse: interrogazioni brevi e lunghe, relazioni orali e scritte, testi argomentativi su tematiche di storia letteraria o di varia attualità, saggi, analisi testuale, articoli di giornale. E’ stato valutato il raggiungimento degli obiettivi prefissati e si è dato peso, in un giudizio complessivo, alla partecipazione, impegno e progressione rispetto al livello iniziale. Gli obiettivi a cui si e' fatto riferimento con la relativa articolazione dei livelli, sono i seguenti: PRODUZIONE ORALE: Saper comunicare in modo coerente dimostrando padronanza degli strumenti letterari CONOSCENZA Livelli 1. Non conosce i testi letti e analizzati, i profili degli autori, gli aspetti essenziali dei movimenti culturali; non conosce le strutture metriche e le principali figure retoriche 2. Conosce in modo frammentario e confuso testi e autori, movimenti culturali, strutture metriche e principali figure retoriche 3. Conosce i fondamentali caratteri di opere e autori e i modelli letterari e retorici nelle loro linee essenziali 4. Conosce con ampiezza di riferimenti i testi e gl i autori , che sa collocare con precisione nel contesto socio culturale 5. Conosce con sicurezza e in modo approfondito modelli culturali, elementi di continuità e di sviluppo nella storia delle idee e dei generi letterari 4. Sa compiere con una certa autonomia analisi differenziate secondo i testi, collocare autori e opere nel loro contesto socio culturale 5. Sa organizzare con autonomia e senso critico analisi approfondite di autori e movimenti; sa sviluppare valutazioni personali con efficacia e coerenza ESPOSIZIONE Livelli 1. Si esprime in modo disorganico e scorretto; non ha la minima competenza del linguaggio letterario 2. Si esprime in modo frammentario e improprio 3. Sa esporre in modo corretto, ma non sempre con proprietà terminologica 4. Sa esporre con fluidità e competenza 5. Sa padroneggiare gli elementi della comunicazione letteraria, esprimendosi in modo organico e personale PRODUZIONE SCRITTA Saper comunicare producendo testi scritti in modo pertinente e organizzato Livelli 1. Produrre testi poco coerenti e disorganici, mostrando conoscenze scarse e confuse espresse in forma scorretta 2. Produce testi utilizzando conoscenze abbastanza pertinenti, ma limitate ed esposte in modo elementare e scorretto 3. Produce testi mostrando nel complesso conoscenze pertinenti e organizzate; si esprime con correttezza, anche se non sempre con proprietà 4. Produce testi ampiamente articolati, sostenuti da argomentazioni coerenti esposte in forma scorrevole e appropriata 5. Produce testi elaborati in modo personale, con ricchezza di documentazione e validi contributi critici; utilizza con sicurezza linguaggi specifici Per la valutazione della prova d’esame simulata di fine anno sono state predisposte griglie di valutazione, con una definizione più analitica dei descrittori e con il punteggio in quindicesimi, così come previsto dalla normativa sull’Esame di Stato. Libri di testo AA.VV. Letteratura italiana, Edizioni scolastiche Bruno Mondatori ,ed. rossa, vol. II e III Attività integrative COMPETENZA LETTERARIA Livelli 1. Non sa riconoscere elementi costitutivi dei testi letterari, non è in grado di compiere analisi differenziate secondo i testi; non sa collocare testi e autori nel loro contesto socio – culturale 2. Anche guidato, sa riconoscere solo gli elementi più semplici di un testo o di un problema letterario, ma non è in grado di collocarli nel contesto socio – culturale 3. Se guidato, sa riconoscere elementi essenziali di un testo o di un problema letterario, ricostruire con coerenza il messaggio dell’opera e dell’autore, cogliere analogie e differenze tra opere e autori 15 Visita guidata al Vittoriale Programma svolto UD1 L'ETA' DEL ROMANTICISMO: L’ESEMPIO DI A. MANZONI. Caratteri del Romanticismo in Europa . Romanticismo italiano e Risorgimento Discussioni e polemiche tra romantici e classicisti 16 ALESSANDRO MANZONI "Lettera a monsieur Chauvet" : "Che cosa distingue il poeta dallo storico" UD4 Estetismo e simbolismo Una poesia di impegno civile: ”Marzo 1821” Giovanni Pascoli. Il Fanciullino: “Il nuovo Adamo” “Il poeta è poeta” L’Adelchi: Coro dell’atto quarto la morte di Ermengarda Atto V: la morte di Adelchi I promessi sposi e il romanzo storico Un diverso esempio di romanzo storico:S. Vassalli, La Chimera (lettura integrale) UD2 Myricae: " Il lampo" “Il tuono” ‘’ L’assiuolo" " Novembre" " Arano" “Lavandare” “X Agosto” Canti di Caselvecchio “La mia sera” RITRATTO D'AUTORE: GIACOMO LEOPARDI Dalle Lettere "Lettera al padre" “Lettera a Pietro Giordano” Dallo Zibaldone Indefinito e fascino dell’antico Dai Pensieri Una “commedia umana in frammenti” Gabriele D’Annunzio. Le vicende, strettamente intrecciate della vita e della scrittura L’eroe decadente: Da “Il piacere”: Ritratto d’esteta Il verso è tutto Alcyone: La pioggia nel pineto Operette morali: " Dialogo della natura e di un islandese" “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere” I canti: "L’infinito" "A Silvia" “Il passero solitario” “Il sabato del villaggio” "Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” “ La quiete dopo la tempesta” “La ginestra”,versi 1-145; 297-317 UD3 IL DECADENTISMO: SIMBOLISMO ED ESTETISMO Oscar Wilde Il ritratto di Dorian Gray (lettura integrale) UD5 LA CRISI DELL’UOMO MODERNO: PIRANDELLO E SVEVO Luigi Pirandello. “ Il fu Mattia Pascal" (lettura integrale) L’ETA’ DEL REALISMO Novelle per un anno : " La carriola" " La signora Frola e il signor Ponza, suo genero" Naturalismo e verismo. Giovanni Verga Vita dei campi: Fantasticheria La prefazione a: L’amante di Gramigna Il teatro: la rottura con la tradizione “Così è (se vi pare)”, lettura integrale “Enrico IV”,atto III Il ciclo dei vinti Malavoglia (lettura integrale) Italo Svevo. Caratteri del romanzo del Novecento: La coscienza di Zeno (lettura integrale) Novelle rusticane: " La roba" 17 18 UD6 Il fenomeno delle avanguardie: i futuristi F.T Marinetti: Il Manifesto del Futurismo C.Govoni: Il Palombaro STORIA PROF.ssa ANTONELLA D’AMICO Obiettivi d'apprendimento. Gli obiettivi d'apprendimento concordati nelle riunioni di coordinamento disciplinare sono i seguenti: I Crepuscolari G.Gozzano: Totò Merumeni UD7 MATERIA: LA ROTTURA DELLA TRADIZIONE: FUTURISTI E CREPUSCOLARI ?? conoscere gli elementi fondamentali dell'evoluzione politica, economica, sociale e culturale della seconda meta' dell'Ottocento e della prima meta' del Novecento; ?? leggere testi specialistici e acquisire lessico e concetti significativi; ?? osservare le dinamiche storiche attraverso le fonti; ?? classificare e organizzare dati, leggere e strutturare tabelle e grafici; ?? contestualizzare un evento; ?? costruire sequenze temporali cronologiche e se quenze causali; ?? identificare somiglianze e differenze, continuità e rotture; ?? fare collegamenti interdisciplinari; ?? confrontare giudizi critici; ?? esporre, argomentando, le problematiche trattate nelle varie unità didattiche. IL RUOLO DELL’INTELLETTUALE TRA IMPEGNO ED EVASIONE: E.MONTALE Ossi di seppia : I limoni Non chiederci la parola Meriggiare pallido e assorto Sulla poesia: "Gli avvenimenti che fra le due guerre mondiali hanno straziato l'umanità li ho vissuti standomene seduto e osservandoli" Livello medio di prestazione dell a classe. Lettura integrale di uno dei seguenti romanzi: Italo Calvino, I sentieri dei nidi di ragno Alberto Moravia, La ciociara Le lezioni si sono svolte in un’atmosfera serena, che ha favorito un percorso didattico regolare. La classe, motivata e responsabile, si è mostrata attenta ed interessata agli argomenti trattati, che spesso è stata in grado di approfondire attraverso lavori di ricerca e collegamenti interdisciplinari. I risultati raggiunti, ovviamente diversi a seconda della sistematicità ed organicità dello studio e delle capacità logiche ed espressive, testimoniano un grado di preparazione complessivamente buono. Il cinema del neorealismo Metodologia di insegnamento. Roberto Rossellini, Roma città aperta L’insegnamento e lo studio della storia sono stati finalizzati ad una ricostruzione critica del passato per meglio comprendere e valutare i rapidi cambiamenti del nostro tempo e a favorire una partecipazione responsabile alla vita collettiva e un sereno confronto di idee. Gli studenti sono stati guidati in modo da poter pervenire ad una conoscenza degli elementi fondamentali dell’evoluzione politica, economica e culturale dei periodi trattati, essere in grado di valutare le dinamiche storiche attraverso le fonti, contestualizzare un evento, costruire sequenze cronologiche e causali. Si è fatto ricorso al manuale e alla lezione tradizionale per fornire la necessaria visione d’insieme dei fenomeni storici per collocarli in una linea diacronica o sincronica, cercando, comunque, sempre di proporre le varie problematiche fornendo ipotesi interpretative diverse, così da incentivare la partecipazione degli alunni. Si sono favorite le ricerche personali ed i lavori di gruppo e di approfondimento in un’ottica di interdisciplinarietà. L’uso del giornale un’ora alla settimana (la classe ha, infatti, aderito all’iniziativa del Corriere della Sera “il quotidiano in classe”) ha favorito un’opera di aggiornamento e di confronti critici fra opinioni diverse. UD8 LA STAGIONE DEL NEOREALISMO Vittorio De Sica, Ladri di bicicletta 19 20 PROGRAMMA Valutazione UD1 L’EUROPA DELLE NAZIONALITA’ La valutazione del raggiungimento degli obiettivi è avvenuta con molta regolarità, in modo da fornire agli studenti le indicazioni necessarie al percorso di apprendimento. Le forme della valutazione sono state molteplici: interrogazioni brevi e lunghi, relazioni, testi argomentativi, saggi brevi, questionari. Gli obiettivi a cui si e' fatto riferimento con la relativa articolazione dei livelli, sono i seguenti: Il processo di unificazione dell’Italia L’operato della Destra storica I problemi del nuovo Regno CONOSCENZA Il processo di unificazione della Germania Livelli 1. Non conosce gli avvenimenti e non è in grado di orientarsi né cronologicamente né nella dimensione spaziale 2. Conosce i fatti essenziali senza inquadrarli nelle strutture economico - sociali e istituzionali 3. Se guidato, descrive gli avvenimenti, orientandosi nelle strutture spazio – temporali 4. Conosce con sicurezza gli avvenimenti e la loro collocazione spazio - temporale, inquadrandoli nelle strutture economico - sociali e istituzionali 5. Conosce in modo esauriente e approfondito le strutture economico - sociali e politico istituzionali in ordine al tempo e allo spazio UD2 L’ITALIA LIBERALE La Sinistra al governo La società italiana La questione meridionale L’Italia di Crispi COMPETENZA STORICA Livelli 1. Non è in grado di comprendere, definire e usare in modo appropriato i macroconcetti della storia generale e i concetti ordinatori e classificatori 2. E’ in grado di usare solo in modo approssimativo e incomplet o i macroconcetti e i concetti ordinatori e classificatori; non è in grado di riconoscere la relazione e la distinzione tra fatti e problemi né di collocare i diversi avvenimenti sul piano sincronico e/o diacronico 3. Dimostra di avere un’idea sufficientemente chiara dei macroconcetti e dei concetti ordinatori e classificatori; se guidato sa distinguere tra fatti e problemi e operare nessi tra analisi diacronica e analisi sincronica 4. Comprende in modo esauriente i macroconcetti e i concetti ordinatori e classificatori ed effettua analisi complete dei diversi fenomeni storici 5. Effettua analisi complete dei diversi fenomeni storici, cogliendo in particolare i fattori di mutamento e di persistenza; sa argomentare in modo problematico Il colonialismo italiano La crisi di fine secolo L’età giolittiana UD3 L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO Imperialismo e imperialismi Interpretazioni dell’imperialismo L’imperialismo americano ESPOSIZIONE Livelli 1. Si esprime in modo disorganico e contraddittorio; non usa la terminologia specifica della disciplina 2. Si esprime in modo poco chiaro, con scarsa proprietà terminologica 3. Si esprime in modo coerente e corretto, ma non sempre con proprietà terminologica 4. Conosce e usa la terminologia specifica esponendo con fluidità ed organicità 5. Sa padroneggiare con sicurezza la terminologia specifica, esprimendosi in modo organico e personale Le potenze europee nell’età dell’imperialismo Verso nuovi equilibri e alleanze UD4 IL MONDO IN GUERRA L’Europa alla vigilia della guerra Lo scoppio del conflitto Libri di testo L’Italia dal neutralismo all’interventismo M: MANZONI, F. OCCHIPINTI, I TERRITORI DELLA STORIA, VOLIII, EINAUDI SCUOLA Un mondo in armi I soldati e la vita di trincea 21 22 La rivoluzione russa UD7 IL DOPOGUERRA Verso la pace Il dopoguerra in Italia La vittoria mutilata La guerra fredda e la divisione del mondo in due blocchi. L’integrazione europea UD5 FRA LE DUE GUERRE La decolonizzazione Il quadro geopolitica I problemi del dopoguerra La crisi delle istituzioni liberali in Italia La crisi del 1929 I totalitarismi IL fascismo Il nazismo La guerra civile in Spagna L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin Lo stalinismo Lettura integrale del romanzo di G Orwell “La fattoria degli animali” Verso la guerra UD6 LA SECONDA GUERRA MONDIALE Lo scoppio della guerra La guerra parallela dell’Italia Il predomino tedesco L’intervento degli Stati Uniti Il genocidio degli Ebrei La svolta del 1942-1943 Il crollo del fascismo La Resistenza L’ultima fase del conflitto Gli esiti della guerra 23 24 MATERIA: STORIA DELL’ARTE Prof.ssa ELISA BOTTINI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ?? ?? ?? ?? saper analizzare i caratteri formali dell’opera d’arte secondo il suo specifico linguaggio riconoscere tipi, generi, materiali e tecniche della produzione artistica individuare in un’opera i tratti caratteristici dell’artista e gli eventuali modelli di riferimento collocare l’opera d’arte nel contesto culturale in cui è stata prodotta individuandone le caratteristiche e la cronologia ?? esprimersi con linguaggio appropriato utilizzando il lessico specifico inerente agli argomenti trattati ?? formulare autonomamente valutazioni storico-critiche L’attività di insegnamento-apprendimento della Storia dell’arte è rivolta anche al raggiungimento dei seguenti obiettivi trasversali: ?? sviluppare una lettura metodologicamente corretta e articolata dell’opera d’arte, inserita in un consequenziale percorso stilistico ?? educare alla percezione della dimensione storico-culturale di un ambiente urbano ?? promuovere la conoscenza e il conseguente rispetto del patrimonio storico-artistico e ambientale ?? comunicare correttamente con esposizione organica e proprietà terminologica. LIVELLO MEDIO DI PRESTAZIONE DELLA CLASSE La classe ha seguito con interesse gli argomenti svolti, dando prova di un progressivo coinvolgimento nel dialogo educativo. L’impegno è stato generalmente costante e responsabile ed ha consentito a tutti gli allievi di acquisire le conoscenze fondamentali in modo corretto. Alcune allieve, dotate di un metodo di lavoro più efficace e sostenute da un interesse costante, hanno raggiunto una preparazione apprezzabile a livello di conoscenza e comprensione ed una maggiore autonomia nella rielaborazione personale. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO Soprattutto inizialmente, per evitare dispersioni e per poter introdurre gli argomenti anche in assenza di conoscenze pregresse, si è fatto ricorso alla lezione tradizionale, senza peraltro rinunciare a proporsi in maniera problematica e coinvolgente. In seguito si è cercato di favorire un approccio più personale ai contenuti, utilizzando metodi attivooperativi (dalla lettura e discussione dell'opera, all’autore, alla individuazione del contesto storicoculturale) fondati sulla partecipazione attiva dell’alunno. Si è inoltre integrato il testo con l’uso di fotocopie di approfondimento e la visione di audiovisivi. VALUTAZIONE La valutazione sommativa è il risultato di verifiche periodiche, orali e semistrutturate, condotte sulla base dei livelli e degli indicatori previsti dalla programmazione d’Istituto . Alla valutazione finale concorrono, oltre ai risultati ottenuti, la progressione nell’apprendimento e la realizzazione degli obiettivi non cognitivi Descrizione dei livelli di valutazione: 25 CONOSCENZA 1. Non conosce le opere trattate e gli artisti che le hanno prodotte, non è in grado di orientarsi cronologic amente; 2. Descrive solo superficialmente le opere senza inquadrarle storicamente e stilisticamente; 3. Conosce i fondamentali caratteri delle opere collocandole nella giusta dimensione storica o nel percorso dell’artista 4. Individua correttamente gli elementi espressivi fondamentali delle opere analizzate superandone l’aspetto puramente descrittivo e ponendo le in relazione con il contesto storico e con lo sviluppo stilistico dell’artista; 5. Conosce in modo esauriente ed approfondito tanto i molteplici aspetti espressivi presenti nelle opere considerate quanto l’intera attività degli artisti in relazione al contesto storico COMPRENSIONE STORICO - ARTISTICA 1. Non sa riconoscere gli elementi costitutivi dei "manufatti" artistici e non è in grado di compiere analisi differenziate. 2. Anche guidato, sa riconoscere solo gli elementi più semplici di un "manufatto artistico" limitandosi alla descrizione superficiale. 3. Se guidato, sa riconoscere gli elementi essenziali di un "manufatto artistico", ricostruire con coerenza il messaggio dell’opera e dell’autore, cogliere analogie e differenze. 4. Sa riconoscere gli elementi fondamentali dei "manufatti artistici" mettendoli in relazione con il significato e il messaggio dell’opera, sa compiere con una certa autonomia analisi differenziate, collocando autori e opere nel loro contesto socio-culturale. 5. Sa organizzare con autonomia e senso critico analisi approfondite di autori e movimenti; si orienta con sicurezza e competenza nell’ambito storico-artistico relazionando gli aspetti stilistici, tecnici, culturali all’interno dell’opera d’arte. ESPOSIZIONE 1. Si esprime in modo disorganico e scorretto, non ha la minima competenza del linguaggio storico artistico 2. Si esprime in modo frammentario e improprio. 3. Sa esporre in modo corretto, ma non sempre con proprietà terminologica e fluidità 4. Sa esporre con fluidità e competenza 5. Sa padroneggiare tutti gli elementi della comunicazione artistica, esprimendosi in modo organico e personale. CORRISPONDENZA LIVELLO/VOTO LIVELLO 1 2 3 4 5 VOTO 2 4 6 8 10 26 La biografia artistica di Picasso. Il futurismo: caratteri fondamentali del movimento attraverso l’analisi di alcuni passi dei manifesti La figura di Boccioni LIBRI DI TESTO Lezioni di arte - Dal Neoclassicismo alle avanguardie. Rielaborazioni di testi a cura di Clara Calz a-Edoardo Varini da Bertelli-Briganti-Giuliano Storia dell’arte italiana, ELECTA-BRUNO MONDADORI Kandinsky e l'arte astratta "Der blaue Reiter : obiettivi e programma Il dadaismo: l’arte come libertà e provocazione I centri del Dadaismo tra Europa e Stati Uniti. M. Duchamp, tra giochi di parole e sperimentazione di nuove tecniche PROGRAMMA TESTIMONIANZE DI PITTURA ROMANTICA E DI REALISMO IN EUROPEA L’arte dell’inconscio : il surrealismo André Breton: la poetica, la ricerca Max Ernst: sperimentazione e analisi del profondo René Magritte L’artista romantico La nuova filoso fia della natura: la pittura di paesaggio in Inghilterra e Germania La pittura di storia in Francia: Gericault, De La Croix. Il romanticismo in Italia: Hayez Il Realismo in Francia : Courbet, Millet Il fenomeno dei Macchiaioli : Fattori, Lega La Metafisica: Giorgio De Chirico ARTE TRA LE DUE GUERRE : IL RITORNO ALL’ORDINE L'IMPRESSIONISMO L a “ nuova oggettività ” in Germania La pittura murale messicana Il fascismo e le arti Sironi e il Manifesto della pittura murale Arte e propaganda politica: nazismo e stalinismon t Motivi dominanti della ricerca ed esame di alcune opere di: Manet, Monet, Renoir, Degas. PROBLEMI E FIGURE DEL POSTIMPRESSIONISMO Cèzanne: lo studio della forma Seurat : la pittura come scienza Van Gogh : tra simbolismo ed espressionismo Gauguin : simbolismo ed esotismo TENDENZE ARTISTICHE DEL SECONDO DOPOGUERRA L’espressionismo astratto americano La pittura informale in Europa La pop art: Roy Lichtenstein, Andy Warhol SIMBOLISMO E ART NOUVEAU Il Simbolismo in Europa: caratteri generali ed accenni ad alcune figure significative dell'area simbolista, con particolare attenzione ad Odillon Redon. Klimt e la Secessione viennese Il divisionismo italiano L'Art Nouveau e le sue manifestazioni in Europa Antoni Gaudì e il Modernismo spagnolo LE AVANGUARDIE DEL NOVECENTO I principi estetici dell’espressionismo Un precursore: Munch L’espressionismo tedesco: il gruppo "Die Brücke” I "fauves" francesi e Matisse. IL CUBISMO: CARATTERI DEL MOVIMENTO. Esame di alcune opere di Picasso e Bra que 27 28 PREMESSA COMUNE PER L’APPRENDIMENTO DELLA PRIMA LINGUA (INGLESE) E DELLA SECONDA LINGUA (TEDESCO) Internet. Si è lavorato in modo interdisciplinare quando i contenuti l’hanno reso possibile e utile. Le discipline linguistiche condividono gli obiettivi di apprendimento, i criteri di valutazione e le tipologie di VALUTAZIONE verifica elencati di seguito: Per valutare le abilità conseguite al termine di ogni modulo, sono state effettuate prove orali e scritte OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO differenziate in funzione degli obiettivi prefissati, attenendosi ai criteri concordati con il consiglio di classe. STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZA E ABILITA’ Sono state utilizzate diverse tipologie di verifiche: esercizi di comprensione, brevi composizioni, Al termine del percorso lo studente dovrà conoscere gli aspetti lessicali e morfosintattici più significativi interpretazione di grafici, redazione di lettere commerciali, brevi relazioni, riassunti orali, conversazioni. della lingua, la microlingua e alcuni aspetti di civiltà e di attualità. Dovrà inoltre essere in grado di: Nella valutazione si è privilegiato una comunicazione efficace anche in presenza di errori formali. - cogliere il significato globale di dialoghi e di interventi su argomenti di carattere professionale; cogliere le informazioni specifiche e i dati contenuti in brevi interventi in ambito professionale; comprendere il senso globale di pagine di testi specialistici del settore, di articoli di giornale e di pagine Web; individuare informazioni specifiche relative all’ambito professionale in documenti autentici; comprendere in modo dettagliato messaggi pubblicitari, corrispondenza relativa al settore professionale, opuscoli e modulistica; presentare argomenti diversi relativi al proprio ambito professionale utilizzando anche tracce o schemi; riassumere testi e articoli di carattere generale e professionale; analizzare grafici, tabelle e listini; interagire su argomenti noti di carattere professionale, utilizzando il registro adeguato; intervenire in modo appropriato all’interno di un gruppo di lavoro, esprimendo e motivando le proprie opinioni; sostenere conversazioni telefoniche di carattere professionale; riassumere testi di tipologie diverse; redigere lettere relative al settore professionale. OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA NEL LORO RAGGIUNGIMENTO Acquisizione di una competenza comunicativa, che permetta di servirsi della lingua in modo adeguato al contesto e di entrare in contatto con una realtà diversa dalla propria, favorendo così un’educazione interculturale che porti al superamento di pregiudizi ed immagini stereotipe. Riflessione sulla lingua straniera ai diversi livelli, che permetta di cogliere comparativamente con l’italiano, gli elementi specifici della stessa. Capacità di operare collegamenti interdisciplinari, inserendosi con prontezza e flessibilità nelle dinamiche del dialogo. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO Sono stati predisposti percorsi educativo-didattici atti a potenziare le competenze linguistiche ed il linguaggio specifico. Nel lavoro di analisi, sintesi e confronto sono state privilegiate la scoperta guidata e le attività di tipo comunicativo, integrate dall’uso della lezione frontale e del lavoro di gruppo. Sono stati utilizzati testi autentici quali lettere, documenti, giornali, grafici; materiale aggiornato è stato attinto da 29 30 PROGRAMMA SVOLTO INGLESE Prof.ssa Reina Rita MODULO N.1: The Romantic Age PROFILO DELLA CLASSE Durante il corso di studi la classe ha sempre dimostrato , complessivamente, una discreta partecipazione alle attività proposte. Apprezzabile è stato l’interesse per la disciplina evidenziato, soprattutto, quando gli argomenti trattati hanno offerto l’opportunità di discussioni, durante le quali gli studenti hanno cercato di confrontare se stessi, la propria cultura con quella che è espressione della lingua inglese. L’impegno è stato mediamente costante e continuo, serio nelle attività domestiche e preciso in quelle in classe. La maggior parte degli studenti ha conseguito un metodo di studio consolidato. Essi, infatti, sono complessivamente in grado di organizzare le conoscenze acquisite e di motivare le proprie scelte. Mediamente discreta è la conoscenza delle strutture morfosintattiche, delle funzioni, del lessico specifico e dei contenuti. Sono in grado di comprendere comunicazioni orali e testi scritti in modo per lo più dettagliato, cogliendo il senso della comunicazione. Per quanto riguarda la produzione sono in grado di argomentare su argomenti generali e specifici, utilizzando registri linguistici adeguati. Soltanto un esiguo numero di studenti incontra qualche difficoltà soprattutto nell’esposizione scritta. ORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO Gli argomenti in programma sono stati affrontati in modi diversi; per questo motivo ritengo utile suddividerli per meglio chiarire le modalità didattiche. Letteratura: gli argomenti di letteratura sono stati trattati sia con lezioni frontali che con interventi di tipo individuale, di coppia o di gruppo, anche con il supporto di fotocopie, lucidi, video, registratore. A volte l’autore o l’opera sono stati presentati attraverso film, con il monitoraggio ed il commento dell’insegnante e degli studenti stessi. Uno spazio abbastanza rilevante è stato dato all’ “historical and social background”, inteso non come studio nozionistico di fatti ed avvenimenti, ma come base di partenza (o di arrivo) per la comprensione degli autori e delle opere trattate, come valido supporto per gli argomenti di civiltà e come connessione con le altre materie dell’area linguistica. Geografia e Turismo: in questo campo gli studenti hanno agito spesso in modo autonomo, preparando la lezione o l’approfondimento da esporre alla classe, abituandosi così a relazionare in pubblico. Questo lavoro è stato attuato avvalendosi anche di fotocopie, materiale informativo autentico (brochures, booklets, opuscoli e cataloghi turistici) o trovato su Internet. Civiltà e articoli di attualità: gli argomenti sono stati introdotti essenzialmente dalla Conversatrice con la collaborazione dell’insegnante, poi sviluppati in modo autonomo; si è cercato inoltre di stimolare interventi e dibattiti nella classe riguardo alle varie tematiche affrontate. Commercio: si è data importanza esclusivamente alla comprensione di lettere e alla trattazione di alcuni argomenti legati al turismo. Nel corso dell’anno, per quanto possibile, si è cercato di stabilire collegamenti con le altre materie di studio. Per quanto riguarda la misurazione e la valutazione, mi sono attenuta alle scelte concordate nel Consiglio di Classe. Aggiungo, per la mia disciplina, una considerazione legata alla tipologia del corso: la correttezza formale è stata puntualmente perseguita come suggeriscono i programmi, ma non è stata intesa in senso punitivo. L’errore, punto di partenza per l’analisi e la comprensione dello stesso, deve essere rimosso, non è però l’unico parametro di misurazione; più rilevante mi è parso di dover intendere la capacità di trasmettere il messaggio comunicativo. 31 OBIETTIVI Conoscenza: conosce la realtà socio-culturale dell’età del Romanticismo. Comprensione: comprende testi letterari relativi all’età romantica, testi di attualità, articoli di quotidiani e riviste. Produzione: sa relazionare testi letterari e di attualità, esprimendo considerazioni e facendo paragoni CONTENUTI The Industrial Revolution – Changes in society Reality and Vision: W. Wordsworth’s ‘Daffodils’ S. T. Coleridge’s ‘The Rime of the Ancient Mariner’ W. Blake’s ‘London” Fantasy, Gothic and the Double: ‘Frankenstein’ by M. Shelley (film) MODULO N. 2: Marketing and promotion OBIETTIVI Saper descrivere luoghi , attrattive turistiche, hotels; saper scrivere un volantino pubblicitario; persuadere e promuovere; analizzare ed usare il linguaggio promozionale. CONTENUTI Marketing and Promoting in leisure and tourism Alternative Accommodation Circular letters to promote tours, packages and various types of hotels MODULO N.3: The Victorian Age OBIETTIVI Conoscenza: conosce gli avvenimenti principali dell’età vittoriana. Comprensione: comprende brani letterari. Produzione: sa descrivere in modo appropriato la realtà socio -culturale de ll’età vittoriana e riassumere articoli di attualità. CONTENUTI The Age of Reforms: Victorian values – Faith in Progress Realism: Excerpts from ‘Hard Times’ by C. Dickens Aestheticism: Excerpts from ‘The Picture of Dorian Gray’ by O. Wilde Colonialism: the British Empire A passage to India by Foster (film) MODULO N. 4: Travelling around the world OBIETTIVI Presentare e promuovere tours, itinerari, città…nel mondo Descrivere un’offerta Scrivere una brochure 32 TEDESCO Prof.ssa BIANCHINI TIZIANA CONTENUTI Tours and itineraries Worldwide cities and destinations Circular letters to present itineraries Activity and special interest holidays Obiettivi d’ apprendimento MODULO N.5 OBIETTIVI Conoscenza: conosce gli aspetti socio-letterari dell’età moderna. (XX sec.) Comprensione: comprende il messaggio dei brani proposti . Produzione: sa relazionare, con riferimenti testuali, sulle nuove sperimentazioni linguistiche e sulle problematiche poste dallo sviluppo della scienza e della tecnologia. CONTENUTI The XX th century: social, political and literary features The experimentation in fiction: Ulysses – Dubliners by James Joyce Mrs. Dalloway – To the lighthouse by V.Wolf Utopia and Dystopia: Excerpts from ‘Animal Farm’ by G. Orwel Excerpts from ‘Brave New World’ by A Huxley Waiting for Godot by Beckett ??Capire messaggi orali di carattere quotidiano, cogliendo la situazione, l’ argomento e gli elementi significativi del discorso; ??Esprimersi con pronuncia ed intonazione accettabili su argomenti di carattere quotidiano, pur con qualche errore formale; ??Comprendere testi scritti per usi diversi, cogliendo il senso e lo scopo del messaggio, anche in presenza di elementi non ancora noti; ??Produrre in modo comprensibile semplici testi scritti di carattere personale e quotidiano, anche se con errori. Livello medio di prestazione della classe Gli allievi hanno consolidato le loro competenze comunicative in maniera soddisfacente. Taluni sanno comunicare in modo quasi perfetto, dimostrando di possedere un notevole bagaglio lessicale e sintattico, sia in lingua parlata che scritta; altri sanno comunicare in maniera comprensibile, talaltri si esprimono in maniera molto semplice e lineare. Le difficoltà maggiori che ho incontrato con una classe nella quale insegno solo dalla quarta, sono state quelle connesse alla “libera espressione in lingua straniera” perché sono molto legate alla votazione e facevano fatica a presentare produzioni libere spontanee perché timorose di una votazione mediocre o negativa. La classe ha raggiunto un livello medio complessivamente discreto e, in taluni casi ,ottimo. MODULO N.6 OBIETTIVI Saper stendere una lettera formale per domande di lavoro e C.V. Saper sostenere un colloquio di lavoro Conoscere-descrivere argomenti di attualità Metodologia d’ insegnamento La metodologia d’ insegnamento adottata è stata varia. Gli studenti sono stati impegnati in simulazioni di colloqui in ambiti diversi; hanno letto e riprodotto sia scritto che oralmente molti brani autentici tratti da giornali in lingua o da Internet; hanno dovuto imparare ad operare collegamenti guidati con altre discipline; hanno imparato a produrre testi di tipologia diversa: brevi commenti, descrizioni di situazioni particolari, analisi di dati statistici. CONTENUTI Jobs and career: job application and CV Identifying suitable jobs Employment and unemployment Articles about economy Molti allievi, inoltre, hanno approfondito con letture personali o ricerche di gruppo, un argomento a scelta tra quelli svolti, utilizzando materiali forniti dall’insegnante o Internet. 33 Valutazione Le verifiche scritta hanno interessato i diversi campi del loro sapere: ??Lettere commerciali a schema libero e/o guidate ??Domande aperte e chiuse di argomento letterario ??Programma di viaggi ??Pacchetti turistici Le verifiche orali erano mirate all’ utilizzo dei diversi registri linguistici e consistevano in: ??Colloqui di lavoro ??Spiegazione gi grafici ??Commenti di brani letterali ??Analisi di brevi testi letterari ??Situazioni tipiche di albergo 34 Libri di testo ed altri strumenti didattici SPAGNOLO PROFF. AGUECI MONICA; ARCINIEGA MARÍA JOSÉ C. Colin, Unternehmen, CIDEB M. Raimondi -A. Frassinetti, Literaturstunde, Principato Internet Giornali in lingua Depliants turistici in lingua Opere letterarie in versione semplificata Films in lingua Computer e video proiettore Lavagna luminosa Obiettivi di apprendimento - Conoscere gli aspetti lessicali e morfo-sintattici più significativi della lingua, aspetti di civiltà e cultura dei paesi di lingua spagnola; - Comprendere testi orali di diversa tipologia cogliendo il messaggio, le informazioni e il registro utilizzato; - Comprendere ed analizzare testi scritti descrittivi, narrativi e turistici, tratti da diverse fonti, individuando, oltre le informazioni in essi contenute, il tipo di testo; - Esprimere opinioni personali sulle tematiche affrontate, illustrare e commentare immagini - Produrre semplici testi scritti quali lettere, riassunti e brevi relazioni su argomenti affrontati, esperienze fatte, testi analizzati. Programma svolto Commercio: ??Auf der Suche nach Arbeit ??Messen und Ausstellung ??Reiselust ??Anfrage, Angebot, Bestellung, Beschwerde Livello medio di prestazione della classe La classe ha dimostrato nel corso del triennio un vivo interesse per la disciplina in generale, accogliendo sempre con entusiasmo ogni attività proposta. L’attenzione è sempre risultata ineccepibile e la partecipazione in generale attiva. L’impegno domestico è risultato puntuale ad ogni compito assegnato. Il livello medio della classe è per tanto da considerarsi buono, non tanto in considerazione del mero voto, quanto soprattutto in virtù della costanza, partecipazione e interesse dimostato nei tre anni. Letteratura: ??Der Romantik: Friederich Schlegel Novalis J. Von Eichendortff ??Die Jahrhundertwende: Th. Mann Metodologia Sebbene l’obiettivo primario della terza lingua sia quello di favorire la competenza comunicativa soprattutto orale, tenuta in considerazione la bontà della classe si è lavorato anche sulla conoscenza delle strutture grammaticali di livello avanzato, nonché sulla produzione sia scritta che orale. Si è cercato di promuovere il coinvolgimento degli alunni, sollecitandone gli interventi e la discussione. Anche le lezioni svolte con la collaborazione dell'insegnante di madrelingua hanno favorito il potenziamento della comprensione, l'arricchimento del lessico, l'uso sciolto ed idiomatico sia della lingua parlata sia dei linguaggi specifici. Oltre al programma di base, sono stati approfonditi alcuni aspetti in ambito turistico ed in ambito storico, delineando l’evoluzione della storia e della cultura spagnola. Trattandosi di una terza lingua, affrontata solo a partire dal terzo anno di corso, non si sono potuti trattare in modo approfondito aspetti di letteratura, ma sono stati presentati i testi più significativi dall’ottocento ad oggi. . ??Expressionismus: G. Heym G. Trakl Kafka ??Der Nationalismus und die Judenverfolgung: P. Celan B. Brecht Aktuelles: ??Die Wehrpflicht ??Krieg und Frieden Valutazione Le diverse prove di verifica hanno mirato all'accertamento delle abilità di comprensione e di produzione sia scritte che orali e, come previsto espressamente dal progetto ERICA, è stata valutata positivamente soprattutto la capacità degli alunni di esprimersi con spontaneità, anche in presenza di alcuni errori formali. Alla valutazione finale hanno concorso oltre agli obiettivi cognitivi an che quelli comportamentali. 35 36 CONOSCENZA: conoscere gli aspetti lessicali e morfosintattici più significativi della lingua, aspetti di civiltà e di vita sociale, di letteratura e turismo Livello 1: Livello 2: Livello 3: Livello 4: Livello 5: lacunosa frammentaria e/o confusa limitata agli elementi essenziali ampia completa e approfondita COMPRENSIONE ORALE: comprendere messaggi orali di varia tipologia, riconoscendo l’intenzione comunicativa del parlante. COMPRENSIONE SCRITTA: comprendere articoli e testi di varia tipologia Livello 1: non comprende il messaggio Livello 2: comprende solo alcuni elementi del messaggio Livello 3: comprende globalmente il messaggio Livello 4: comprende nei dettagli il messaggio Livello 5: comprende il messaggio nei dettagli e in modo articolato Modulo 3: Queremos reclamar Quejas y reclamaciones Literatura: siglo XX; Modernismo: Rubén Darío; Arte: Gaudí Modulo 4: Busco trabajo Dar consejos Curriculum y anuncio de trabajo Literatura: La Generación del ’98: l’esistenzialismo di Unamuno El Esperpento: Valle-Inclán Modulo 5: Publicidad, ¡qué gran invento! La publicidad El eslógan Literatura: La Generación del ’17: Federico García Lorca PRODUZIONE ORALE: interagire e relazionare su argomenti trattati, supportando la propria opinione con considerazioni personali e stabilendo collegamenti interdisciplinari Livello 1: non è in grado di trasmettere il messaggio Live llo 2: trasmette il messaggio in modo parziale e/o confuso Livello 3: trasmette il messaggio in modo semplice Livello 4: trasmette il messaggio in modo efficace Livello 5: trasmette il messaggio in modo personale e corretto PRODUZIONE SCRITTA: redigere semplici testi scritti quali lettere, riassunti e brevi relazioni su argomenti trattati, esperienze personali, testi analizzati Livello 1: non è in grado di trasmettere il messaggio Livello 2: trasmette il messaggio in modo parziale e/o confuso Livello 3: trasmette il messaggio in modo lineare e semplice Livello 4: trasmette il messaggio in modo efficace e corretto Livello 5: trasmette il messaggio in modo personale e fluido Modulo 6: Podría hablar con… Conversaciones telefónicas con empresas Historia: Guerra Civil y Franquismo Literatura Hispano-Americana: La literatura mágica de Isabel Allende Arte: Picasso y “Guernica” Strumenti didattici Libri di testo ed altri materiali Testo in adozione: F.Castro, Uso de la gramática española, Nivel avanzado, Madrid, Edelsa, 2001. Giovannetti Muñoz, Bermejo, Manual de literatura española e hispanoamericana, Torino, Petrini, 2001. Sono state inoltre usati altri testi per approfondimenti, materiale autentico, audio- e videocassette per le varie attività. PROGRAMMA Modulo 1: Yendo de viaje Comprensión y producción oral sobre el verano pasado Dejar y referir mensajes y recados Hoteles, alojamiento, transportes Presentar y resolver problemas por teléfono Literatura: siglo XIX: Romanticismo: Espronceda, Larra, Bécquer Modulo 2: ¿Qué nos cuenta el periódico? Noticias: titulares y artículos Los periódicos Propuestas de viaje Literatura : Realismo/Naturalismo:Clarín 37 38 nella società moderna che nelle discipline di modelli matematici, statistici , informatici ed economiche. Si è tentato in ultima analisi di non far apparire la matematica come una rigorosa struttura a sé stante e un insieme vuoto di formule, ma come un linguaggio, pur simbolico, volto a descrivere la realtà e a ricercare le soluzioni dei problemi che questa ci pone. Per meglio centrare tali obbiettivi sono state usate sia le lezioni che le discussioni e le esercitazioni in cui si è cercato di suscitare un atteggiamento attivo e critico da parte della classe e di stimolare lo spirito di indagine di ogni alunno, di costruire e risolvere modelli e a valutare e verificare i risultati ottenuti, pretendendo rigore e chiarezza. Tutti gli argomenti sono stati trattati partendo da problematiche il più possibili reali; la teoria utilizzata è stata quella del “ Problem solving “ e la soluzione è stata affrontata con il metodo del top-down. MATEMATICA Prof.ssa Falcetta Luisella OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO. Conoscenze: ?? Le leggi della domanda e dell’offerta; le funzioni di costo, ricavo e profitto ?? Le caratteristiche di una funzione lineare in due variabili reali. ?? Gli scopi e i metodi della ricerca operativa. ?? Le fasi di un’indagine statistica. Competenze: ?? Studiare l’andamento di funzioni razionali intere e fratte e rappresentare graficamente ?? Risolvere problemi economici mediante l’uso di funzioni in una variabile. ?? Calcolare massimi e minimi liberi e vincolati di funzioni lineari in due variabili sia con il metodo grafico che con l’uso delle derivate. ?? Scrivere il modello dei problemi di scelta in condizioni di certezza e problemi di programmazione lineare. ?? Rappresentare dati statistici e calcolare gli indici di sintesi e di variabilità. VALUTAZIONE In seguito all’introduzione della didattica modulare, la valutazione si è basata sulla misurazione dei descrittori relativi ai diversi moduli. Le verifiche sommative scritte ed orali sono state valutate tenendo conto dei livelli raggiunti nei descrittori misurati di volta in volta e l’accettabilità è stata fissata con la media dei livelli sufficiente. Per ciascun descrittore, inoltre, il livello di accettabilità è stato fissato al 60% del punteggio grezzo totale. LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE. La classe è composta da 20 alunni tutti provenienti dalla classe 4 CL. Alla luce delle valutazioni ottenute devo sottolineare che la classe, nella maggior parte, ha risposto alle aspettative in modo positivo, dimostrandosi interessata, desiderosa di apprendere nuovi contenuti e disponibile al lavoro sia scolastico che domestico. Ha dimostrato di possedere capacità rielaborative e di saper analizzare situazioni reali e ha compiuto discreti e positivi sforzi per arricchire il proprio vocabolario scientifico, pertanto si esprime in modo semplice ma corretto. I risultati ottenuti sono stati nel complesso discreti. Solo pochissimi alunni hanno lievi difficoltà nell’applicazione delle regole, nell’analisi dei problemi e nella rielaborazione; bisogna però sottolineare che, con opportuni interventi di tipo personalizzato, si sono ottenuti notevoli progressi. La classe ha sempre partecipato attivamente allo svolgimento delle lezioni e ha raggiunto gli obiettivi disciplinari minimi fissati in sede di programmazione in modo discreto. Bisogna comunque sottolineare che all’interno della classe ci sono alcuni alunni di spicco che hanno dimostrato interesse, impegno costante e una partecipazione attiva e a volte rielaborativa. I risultati ottenuti da questo gruppo di alunni sono stati sempre più che buoni e a volte anche brillanti . LIBRO DI TESTO Trovato “La Matematica” Vol.2 e Vol. 3 Ghisetti e Corvi Appunti insegnante. PROGRAMMA MODULO 1: STATISTICA DESCRITTIVA DESCRITTORI 1 Organizza e rappresenta i dati di un’indagine statistica 2 Determina i valori sintetici di una distribuzione di frequenze 3 Calcola ed interpreta gli indici di variabilità 4 Calcola i valori sintetici di una variabile casuale. Contenuti METODOLOGIA L’elemento conduttore, che ha caratterizzato, pertanto tutto l’anno scolastico è stata la costante preoccupazione di sviluppare negli alunni la capacità di pensiero logico, di costruire un discorso induttivo, di esprimersi in forma chiara e corretta e di avviare ad un processo di matematizzazione della realtà nella convinzione che la singola nozione può essere qualcosa di più duraturo ed importante. A tal fine si è sempre cercato un collegamento con l’esperienza di vita pratica mettendo in particolare rilievo l’importanza generale della matematica, considerando l’influenza crescente sia 39 ?? ?? ?? ?? Le fasi di un’indagine statistica. Organizzazione e rappresentazione di dati. Gli indici di posizione: le medie, la moda, la mediana. La variabilità: campo di variazione, scarto quadratico medio, varianza. Variabili casuali e distribuzioni di probabilità. Valor medio e scarto quadratico medio. 40 Contenuti MODULO 2A: MODELLI MATEMATICI PER L’ECONOMIA 1 2 3 4 ?? Definizione di funzione reale in due variabili reali. Dominio di funzioni lineari e linee di livello. ?? Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili. ?? Massimi e minimi liberi e vincolati sia con l’uso delle derivate che con le linee di livello. DESCRITTORI Riconosce semplici modelli relativi alla domanda e all’offerta di un bene Rappresenta la funzione di domanda e di offerta di un bene Determina il prezzo di equilibrio tra domanda e offerta Risolve problemi di ottimizzazione relativi ai costi e/o ai profitti MODULO 4:APPLICAZIONI ECONOMICHE IN DUE VARIABILI Contenuti ?? Funzione della domanda e sue caratteristiche. Elasticità d’arco e puntuale. Coefficiente di elasticità della domanda. Domanda elastica, anelastica e rigida. Funzione dell’offerta e sue caratteristiche. ?? Rappresentazione grafica delle funzioni di domanda e di offerta nel piano cartesiano. ?? Equilibrio tra domanda e offerta nel caso di concorrenza perfetta. Trasposizione della domanda e/o dell’offerta. ?? Costo totale, costo medio, costo marginale. Ricerca del minimo costo unitario. Ricavo totale. Utile e ricerca del massimo utile. Diagramma di redditività. 1 2 DESCRITTORI Risolve problemi di programmazione lineare in due variabili. Risolve problemi di ottimo in due variabili Contenuti ?? Programmazione lineare in due variabili metodo grafico. ?? Massimo dell’utilità di un consumatore con il vincolo del bilancio. MODULO 2B: PROBLEMI DI SCELTA 1 2 3 DESCRITTORI Risolve problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati Risolve problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti Risolve problemi di scelta in condizioni di incertezza con effetti immediati Contenuti ?? Scopi e fasi della Ricerca Operativa. Costruzione del modello matematico. ?? Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati: scelta tra più alternative, problema delle scorte, anche con sconti sulle quantità. ?? Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti.Investimenti commerciali ed investimenti industriali: criterio dell’attualizzazione e criterio del tasso effettivo di rendimento. ?? Problemi di scelta in condizioni di incertezza con effetti immediati: criterio del valor medio, del pessimista e dell’ottimista. Calcolo del rischio. MODULO 3: GEOMETRIA ANALITICA DELLO SPAZIO 1 2 3 DESCRITTORI Descrive le caratteristiche di una funzione lineare in due variabili, utilizzando le linee di livello Rappresenta la soluzione di una disequazione o di un sistema di disequazioni in due variabili Determina massimi e minimi liberi e vincolati di funzioni in due variabili. 41 42 DIRITTO ED ECONOMIA PER L’AZIENDA PROF. IMPICCICHE’ GIUSEPPE Livello medio di prestazione della classe OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO In armonia con le FINALITA' FORMATIVE GENERALI del progetto, questa disciplina, particolare in quanto formata da differenti discipline (diritto, economia politica, economia aziendale) ha il compito di far acquisire una preparazione rivolta a svolgere compiti non tanto di gestione amministrativa, quanto di tipo comunicativo - relazionale. Gli OBIETTIVI GENERALI dell'intero triennio sono stati quindi quelli di far acquisire buone conoscenze relativamente a: - il contesto giuridico ed economico in cui opera l'azienda - il sistema aziendale e i suoi sottosistemi - le principali problematiche connesse con le diverse funzioni aziendali - le fondamentali caratteristiche organizzative ed amministrative delle aziende operanti nei diversi settori economici, anche per quanto riguarda le emergenti prospettive di rapporti con l'estero. OBIETTIVI DELLA CLASSE QUINTA STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI SAPERE E DI SAPER FARE, CONCORDATI NELLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO DISCIPLINARE, DA RAGGIUNGERE AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO ?? Utilizzare, in modo corretto anche se non completo, le conoscenze, le informazioni e i documenti ?? Analizzare i caratteri strutturali fondamentali delle aziende nei vari settori economici ?? Interpretare con sufficiente coerenza le dinamiche aziendali ?? Esaminare in modo corretto gli strumenti e le politiche della pubblica amministrazione in una visione macroeconomica ?? Documentare in modo ordinato e completo la sequenza logica dei propri elaborati scritti e orali La classe ha partecipato in modo attivo e propositivo all’attività didattica. Gli obiettivi generali e quelli specifici della disciplina sono stati raggiunti. Gli alunni riconoscono e rappresentano correttamente le dinamiche quantitative dei fenomeni aziendali, sanno utilizzare informazioni e documenti commettendo solo qualche imprecisione, analizzano ed interpretano le caratteristiche fondamentali delle aziende operanti nei diversi settori economici ed espongono in modo appropriato e pertinente le conoscenze acquisite. Pertanto il livello di profitto mediamente raggiunto può dirsi quasi buono. METODOLOGIA Il traguardo formativo non è consistito solo nel far acquisire conoscenze, ma anche competenze ed abilità così da sviluppare abitudini mentali orientate alla risoluzione di problemi ed alla gestione di informazioni. Si è dovuto adottare quindi un metodo operativo coerente con gli obiettivi del progetto. I vari moduli sono stati svolti utilizzando, dove possibile, le tecniche di analisi, a gruppi ed intergruppo, di testi, documenti e situazioni problematiche, pervenendo successivamente a momenti di sintesi e valutazione. La lezione frontale ha trovato spazio nei momenti introduttivi e di raccordo fra le varie Unità didattiche e, quando è stato giudicato opportuno, in relazione alla peculiarità degli argomenti del programma. Analizzando in modo specifico il progetto, si deve non considerare significativa la parte contabile di ogni azienda, ma importante ed essenziale l'analisi economico-patrimoniale e giuridica. L'impegno del docente è stato quello di affrontare la trattazione delle varie aziende di servizi, decidendo quale approfondire, tenuto conto delle caratteristiche economiche della zona e degli interessi degli studenti. Si è cercato di abituare gli studenti alla produzione di parti operative con dati opportunamente scelti e all’analisi critica degl i elaborati prodotti, all’effettuazione di collegamenti disciplinari e, dove possibile, interdisciplinari. LABORATORI OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA NEL LORO RAGGIUNGIMENTO Il laboratorio di informatica è stato utilizzato, secondo le indicazioni del Progetto, come contributo allo svolgimento dell'attività educativa. Nel corso della classe quinta, è stato di supporto per l’approfondimento in Internet di alcuni moduli. COGNITIVI: - Comunicare con esposizione fluida e proprietà terminologica - Anal izzare le situazioni e rappresentarle in modo sistematico - Operare scelte razionali e opportunamente motivate - Formulare ipotesi funzionali alla creazione di modelli concreti - Affrontare alcune realtà diverse per contenuti e situazioni VALUTAZIONE Per ogni Unità si sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione, gli strumenti e le verifiche. Le verifiche sommative sono state effettuate al termine o durante i vari moduli, finalizzate alla classificazione degli alunni attraverso il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Gli strumenti utilizzati sono stati prove scritte non strutturate e prove orali. COMPORTAMENTALI: - Organizzare il lavoro a livello individuale in modo razionale e autonomo - Partecipare al lavoro di gruppo accettando ed esercitando il coordinamento - Padroneggiare alcune realtà diverse per contenuti e situazioni Al fine di perseguire tali obiettivi trasversali all'interno della disciplina si pongono in essere i seguenti comportamenti: controllo sistematico dei lavori assegnati in classe e a casa; sollecitazione al dialogo ed al confronto durante le lezioni; abitudine alla presentazione di relazioni scritte, correggendone l'esposizione; presentazione di situazioni nuove suscettibili di discussione in classe. OBIETTIVI DISCIPLINARI conoscenza * Riconoscere realtà economiche note 1 - non riconosce realtà e fenomeni 2 - li riconosce in modo confuso o parziale 3 - riconosce gli elementi essenziali 4 - riconosce altri elementi oltre agli essenziali 5 – riconosce compiutamente 43 44 comprensione * Rappresentare le dinamiche quantitative dei fenomeni aziendali 1 - rappresenta in modo scorretto e/o incoerente 2 - rappresenta in modo parzialmente corretto 3 - rappresenta correttamente solo le situazioni semplici o gli elementi fondamentali di quelle complesse 4 - rappresenta correttamente ma con qualche imprecisione 5 - rappresenta in modo corretto e preciso applicazione * Utilizzare conoscenze, informazioni e documenti 1 - utilizza in modo scorretto o non appropriato 2 - utilizza in modo parziale e impreciso 3 - utilizza in modo corretto ma non completo 4 - utilizza in modo completo e corretto 5 - utilizza in modo completo e corretto con apporti personali analisi * Analizzare i caratteri strutturali delle aziende nei vari settori economici 1 - non analizza 2 - analizza in modo molto superficiale 3 - analizza le caratteristiche fondamentali 4 - analizza in modo completo 5 - analizza in modo completo e approfondito sintesi * Interpretare le dinamiche aziendali 1 - non interpreta 2 - interpreta in modo confuso e/o parziale 3 - interpreta in modo corretto le dinamiche essenziali 4 - interpreta in modo corretto e completo 5 - interpreta in modo completo e approfondito esposizione * Esporre quanto appreso 1- espone in modo involuto e/o scorretto 2 - espone in modo poco organico 3 - espone in modo semplice e corretto 4 - espone in modo appropriato e pertinente 5 - espone in modo fluido e personale STRUMENTI DIDATTICI LIBRI DI TESTO ED ALTRI MATERIALI - Percorsi di diritto ed economia per l’azienda – AA. VV. – Paolo Della Valentina – Casa Ed. Tramontana - FOTOCOPIE e LUCIDI per l’approfondimenti di alcuni moduli - CODICE CIVILE PROGRAMMA MODULO 1 - IL BILANCIO D’ESERCIZIO ?? Il bilancio d’esercizio e le sue finalità ?? I principi di bilancio ?? Il bilancio civilistico ?? Lo Stato Patrimoniale e il suo contenuto ?? Il Conto Economico e il suo contenuto ?? L’Analisi di bilancio per margini e indici MODULO 2 - LE AZIENDE DI CREDITO ?? Il mercato finanziario e l'ìntermediazione creditizia ?? Le funzioni e gli obiettivi dell'azienda di credito ?? L'organizzazione della banca ?? La legislazione bancaria ?? Le operazioni bancarie di raccolta: i depositi a risparmio, il conto corrente di corrispondenza passivo, i certificati di deposito, i pronti contro termine ?? La concessione del fido bancario ?? Le operazioni di impiego fondi: aperture di credito, sconto di effetti, anticipi su ricevute bancarie, anticipi su fatture ?? Le operazioni bancarie di servizi: i servizi complementari e i servizi collaterali ?? Il bilancio della banca MODULO 3 - LE AZIENDE TURISTICHE ?? Il mercato turistico: domanda ed offerta ?? La normativa giuridica: Legge Quadro in materia turistica ?? Il tour operator ?? L'agenzia viaggi ?? L’imprenditore turistico ?? I documenti emessi dall’agenzia viaggi ?? L’albergo: gestione e documentazione ?? Il bilancio dell’azienda turistica CORRISPONDENZA LIVELLO/VOT0 LIVELLO VOTO 1 2 2 4 3 6 4 8 5 10 MODULO 4 - LE AZIENDE DI TRASPORTO ?? Il sistema dei trasporti ?? Il contratto di trasporto ?? Il trasporto delle merci e la logistica aziendale ?? Il trasporto intermodale ?? Il trasporto di merci via terra ?? Il trasporto di merci via mare 45 46 ?? Il trasporto di merci via aerea ?? I problemi di gestione delle aziende di trasporto ?? Il bilancio dell’azienda di trasporti GEOGRAFIA ANTROPICA Prof.ssa ELENA FLORENZANO Obiettivi di apprendimento MODULO 5 LE AZIENDE ASSICURATIVE ?? La ricerca della sicurezza ?? Il contratto di assicurazione ?? L’impresa di assicurazione ?? Le caratteristiche delle aziende di assicurazione ?? La struttura patrimoniale ed economica delle aziende di assicurazione ?? Il premio ?? Le assicurazioni ramo danni ?? Le assicurazioni a primo rischio assoluto e a primo rischio relativo ?? Le assicurazioni a valore intero ?? Il risarcimento del danno ?? Le assicurazioni sul trasporto di merci ?? Il capitolato nazionale ?? La polizza italiana di assicurazione Standard minimi di apprendimento in termini di sapere e di saper fare, indicati dal progetto assistito ERICA e assunti dal coordinamento disciplinare, da raggiungere al termine dell'anno scolastico ?? Riconoscere ed usare correttamente termini e concetti fondamentali del linguaggio geografico ?? Leggere, costruire ed interpretare carte, grafici ed indicatori socioeconomici ?? Comunicare informazioni geografiche con strumenti più idonei (relazioni, grafici, carte, immagini) ?? Analizzare ed interpretare un sistema territoriale individuandone i principali elementi costitutivi fisici ed antropici e le loro più evidenti interdipendenze ?? Formulare ipotesi interpretative di semplici fenomeni economico-territoriali attraverso l’osservazione diretta e indiretta ?? Applicare le abilità strumentali e metodologiche all’analisi di un territorio non conosciuto ?? Analizzare e interpretare flussi interregionali e internazionali di persone, merci, capitali ed informazioni ?? Individuare e valutare diverse possibili interpretazioni della disparità di sviluppo economico sia su scala locale sia su scala planetaria ?? Leggere attraverso strumenti geografici-economici eventi storici, fatti e problemi del mondo contemporaneo continuamente proposti dai media MODULO 6 –IL SISTEMA ECONOMICO ITALIANO E L’ATTIVITA’ ECONOMICA ?? ?? ?? ?? - Il PIL e il Reddito Nazionale in Italia Indici economici Gli obiettivi dello Stato Gli strumenti di politica economica politica monetaria politica fiscale politica dei redditi politica di bilancio OBIETTIVI DISCIPLINARI E ARTICOLAZIONE DEI LIVELLI CONOSCENZA saper individuare gli elementi fondamentali degli argomenti studiati COMPRENSION saper collegare gli elementi di conoscenza tra loro E saper individuare i rapporti di causa - effetto APPLICAZIONE ricavare informazioni da strumenti cartografici classificare e schematizzare gli elementi di conoscenza ANALISI operare confronti e collegamenti tra le realtà studiate saper operare collegamenti interdisciplinari SINTESI realizzare mappe concettuali attraverso un linguaggio simbolico consolidare e ampliare le proprie conoscenze attraverso informazioni acquisite in modo autonomo OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA NEL LORO RAGGIUNGIMENTO ?? Comunicare in modo pertinente attraverso il potenziamento delle capacità espressive ?? Consolidare le capacità d’analisi ?? Consolidare le capacità d’osservazione ed assicurare una comprensione critica ed aggiornata della complessa realtà del mondo d’oggi ?? Educare allo sviluppo sostenibile attraverso l’acquisizione di comportamenti rispettosi delle compatibilità ambientali 47 48 Libri di testo ed altri strumenti didattici Livello medio di prestazione della classe Annunziata, Deaglio, Emiliani, Foa, Sofri La classe è costituita da alunne e da un alunno ed è nel complesso dotata di buone capacità e abilità che hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento nonostante alcune difficoltà oggettive descritte di seguito. L'impegno non si è rivelato costante ma ciò è in buona parte imputabile agli eventi che si sono succeduti a partire dall’inizio dell’anno scolastico fino alla metà di Febbraio rispetto alla disciplina e che hanno instaurato clima di incertezza e precarietà nei confronti della materia. Attraverso il dialogo educativo si è riusciti a ripristinare stabilità e fiducia. Gli alunni hanno mostrato personale interesse e spesso hanno espresso le proprie idee ed opinioni. Il dialogo educativo è stato sempre improntato ad un confronto aperto di idee che ha consentito di analizzare la complessità del mondo contemporaneo attraverso gli strumenti della geografia. Il metodo di studio è razionale e autonomo per un buon gruppo di alunne, per altre sufficientemente organizzato e solo per pochi permane meccanico e ripetitivo. Metodologia di insegnamento Suscitare interesse per gli aspetti disciplinari e interdisciplinari della materia, stimolare uno spirito critico nell'analisi delle problematiche geografiche e socioeconomiche, apprendere tecniche di osservazione e rilevazione dei fenomeni geografici, comprendere i problemi dell'organizzazione sociale dello spazio sono stati gli obiettivi di fondo del corso. Attenendosi al Piano di Lavoro della classe è stato fatto un recupero in termini di obiettivi di apprendimento adoperando come strumento didattico principalmente il libro di testo. A causa dei problemi oggettivi legati alla disponibilità di tempo sono stati utilizzati solo in minima parte strumenti didattici alternativi quali articoli e informazioni attinte da Internet. I contenuti proposti sono stati trattati per consentire un approfondimento degli stessi in relazione a fatti ed avvenimenti contemporanei. Gli studenti sono stati guidati ad impostare lo studio in chiave problematica e interpretativa, non fermandosi alla semplice descrizione dei fenomeni studiati. Valutazione Il percorso di apprendimento è stato verificato ricorrendo a interrogazioni individuali e sommative al termine di U.D.e ad esercizi di applicazione e di analisi. Nella valutazione finale si è tenuto con to del livello di raggiungimento degli obiettivi didattici, dei progressi compiuti nel processo di apprendimento, dell'impegno, della partecipazione al dialogo educativo. Nell’attribuzione dei voti alle singole prove è stata utilizzata la seguente griglia di corrispondenza livello/voto: LIVELLO 1 2 3 4 5 DEFINIZIONE NON SA SA PARZIALMENTE SA IN MODO ACCETTABILE SA CON SICUREZZA SA IN MODO COMPLETO E ARTICOLATO GLI ALTRI CONTINENTI Zanichelli Programma svolto Unità 1 Medio Oriente e Nord Africa ?? Le terre del deserto, dell’Islam, del petrolio ?? Asia mediorientale e Nord Africa: Maghreb, Valle del Nilo, Mezzaluna fertile, Penisola Araba. ?? La nascita e lo sviluppo dell’Islam ?? Nascita dello stato di Israele ?? La Questione palestinese ?? Fondamentalismo e integralismo. ?? L’Importanza del petrolio nella geografia dell’area Unità 2. La Cina ?? Aspetto fisico climatico. ?? Cina propria e Cina esterna ?? I caratteri fondamentali della Cina imperiale ?? Profilo storico: dalla caduta dell’impero alla repubblica popolare. ?? Il maoismo e le tappe della politica cinese dall’isolamento all’apertura all’Occidente ?? Lo sviluppo attuale dell’economia cinese: una “strana” via al socialismo di mercato. Unità 3. ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? L’India Lo spazio del subcontinente indiano I climi, gli ambienti e le produzioni agricole Le religioni indiane e il sistema delle caste La dominazione coloniale L’indipendenza e la figura di Gandhi L’economia indiana contemporanea Il ruolo della donna nella realtà sociale indiana VOTO 2 4 6 8 10 49 50 EDUCAZIONE FISICA Prof.ssa: Pellai Alessandra Obiettivi d’apprendimento. 1. Rielaborazione, rieducazione e consolidamento degli schemi corporei e motori attraverso esercitazioni pratiche con l’utilizzo dei vari attrezzi e tecniche specifiche della materia per arrivare ad una conoscenza e ad un uso razionale del proprio corpo (ricerca dell’equilibrio emotivo). 2. Socializzazione con sviluppo dei concetti di autocontrollo, accettazione delle regole e del giudizio finale. 3. Autonomia operativa: sviluppo delle capacità organizzative e la loro attuazione pratica. 4. Avviamento allo sport come abitudine di vita. 3. Fondamentali individuali di squadra con relativa applicazione nel gioco vero e proprio di pallavolo, basket, madball e hunyhockey. 4. Orientamento e sviluppo di particolari attività scaturite dagli interessi degli alunni. 5. Teoria. Gli argomenti trattati sono stati i seguenti: - Storia delle Olimpiadi - Educazione alimentare: concetti di alimenti e problemi relativi all’alimentazione. - Doping: dal concetto di “sport” a quello di “frode sportiva” e sostanze dopanti. - Elementi di primo soccorso inerenti all’attività sportiva. Livello medio di presentazione della classe. La classe ha evidenziato un interesse accettabile per la disciplina lavorando con impegno e partecipando in modo non sempre attivo al dialogo educativo. Ha conseguito un’adeguata autonomia operativa e maturato abilità specifiche nel complesso discrete. Metodologia d’insegnamento. Agli alunni è stata ch iesta una partecipazione attiva nel provare, praticare e sperimentare in prima persona quanto proposto , spiegato e dimostrato attraverso l’attività costante, opportunamente guidata e controllata. Hanno potuto esprimersi con una elaborazione personale del lavoro svolto, ottenendo così dei miglioramenti significativi: Le diverse tecniche proprie della materia e le strutture scolastiche a disposizione sono state utilizzate in relazione alle esigenze del momento e a quelle degli alunni tenendo in considerazione le risposte date dagli stessi argomenti trattati. Valutazione. 1. Verifica continua durante lo svolgimento delle lezioni. 2. Prove periodiche di riepilogo su specifici argomenti con attrezzi codificati e non, percorsi, staffette, partite a tema. La valutazione individuale è stata la somma dei progressi ottenuti da ciascun alunno tenendo soprattutto conto della partecipazione attiva e dell’impegno dimostrato durante le ore di lezione. Attività integrativa. Attività sportive comprendenti discipline della pallavolo, pallacanestro, calcetto ed atletica leggera (corsa campestre). Programma 1. Esercizi a corpo libero, esercizi individuali ed a copie con l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi per lo sviluppo, il miglioramento e il mantenimento delle qualità psicofisiche di base quali la mobilità articolare, l’equilibrio, la coordinazione, la velocità, la forza, la destrezza, la resistenza. 2. Lo stretching sia come riscaldamento sia come compensazione al termine di particolari esercitazioni utilizzandolo per il mantenimento di una buona elasticità muscolare e come tecnica di rilassamento fisiologico. 51 52
Scarica