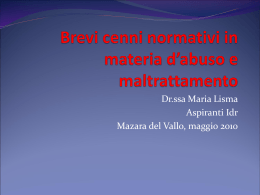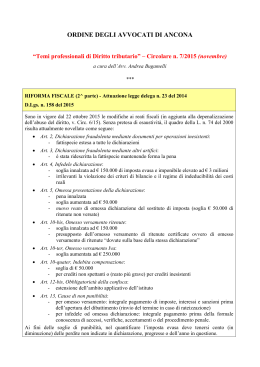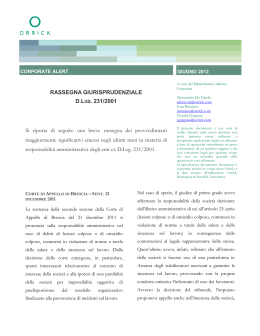www.ildirittoamministrativo.it OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA PENALE AGGIORNATO AL 31 dicembre 2012 A cura di DILETTA PIAZZESE Corte di Cassazione, Sez. III, 4 ottobre 2012, n. 38719: la violenza sessuale si distingue dalla molestia a sfondo sessuale per la coartazione della volontà altrui attraverso l'intento dell'agente di appagare il proprio desiderio sessuale violando al contempo la sfera dell'autodeterminazione sessuale della vittima. Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione torna a focalizzarsi sulla differenza tra la condotta integrante il reato di violenza sessuale ex art. 609, c.p. e quella integrante il reato di molestia sessuale, ex art. 660, c.p. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, confermato con la sentenza in commento, nel primo caso la condotta sanzionata comprende qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, per se fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, ovvero in un coinvolgimento della sfera fisica di quest'ultimo, pone in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sfera sessuale (Cass. Pen. n. 2742/2010; Cass. Pen. n. 7369/2006). Il reato di molestia sessuale ex art. 660, c.p. è invece integrato solo in presenza di espressioni volgari a sfondo sessuale ovvero di atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi dall'abuso sessuale (Cass. n. 2742/2010). La giurisprudenza ha, altresì, ritenuto configurabile il tentativo del delitto di violenza sessuale quando, anche in mancanza di contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta dell'agente lasci emergere, dal punto di vista soggettivo, l'intenzione dell'agente di raggiungere l'appagamento dei propri istinti sessuali, nonché il requisito oggettivo dell'idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale (Cass., Sez. III, 26/10/2011, n. 45698). 1 www.ildirittoamministrativo.it Corte di Cassazione, Sez. V n. 44824 del 15 novembre 2012: il fallimento della società non è equiparabile alla morte del reo e quindi non determina l'estinzione della sanzione amministrativa prevista dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 Con la sentenza in esame, la Suprema Corte di Cassazione è giunta a confermare l'orientamento giurisprudenziale, già emerso in precedenti pronunce, affermando l'importante principio di diritto riportato in epigrafe, in base al quale il fallimento di una società non estingue la sanzione amministrativa prevista dal D.lgs. n. 231/2001 in quanto evento non equiparabile alla morte del reo. Il caso giunge all'esame della Cassazione a seguito di ricorso immediato dei Pubblici Ministeri del Tribunale di Roma avverso la sentenza del Gup dello stesso Tribunale che ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti della società imputata dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5 e 25-ter lett s) del D.Lgs. n. 231/2001, in relazione alla commissione del delitto di cui agli artt. 81, 110, c.p. e 2638, co. 2, c.c., nonchè dell'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5 e 25-sexies del D.Lgs. n. 231/2001 in relazione alla commissione del delitto di cui agli artt. 110, 81 c.p. e 135, D.Lgs. n. 58/1998, in quanto tale illecito sarebbe estinto per sopravvenuto fallimento della società. Il Gup di Roma aveva, infatti, equiparato il fallimento della società alla morte del reo, che ai sensi dell'art. 150, c.p. determina l'estinzione del reato. Tale scelta si è basata sulla presunzione di definitiva inattività della società, essendo stato giudicato impossibile un ritorno in bonis della stessa, equiparabile per effetti alla morte della persona fisica; sulla terzietà della posizione della curatela fallimentare rispetto alla società e, dunque, sulla irragionevolezza della scelta contraria di addebitare la sanzione amministrativa per l'illecito della società al curatore, che è terzo incolpevole e che si troverebbe in una posizione incompatibile in quanto, da un lato, legittimato a costituirsi parte civile in un ipotetico processo per bancarotta collegato ad atti di corruzione e, dall'altro, sarebbe chiamato a rispondere dell'illecito amministrativo commesso dall'amministratore; infine, sulla antieconomicità dell'eventuale rinvio a giudizio della società, che esporrebbe la stessa a spese processuali a danno della massa dei creditori. In merito alla questione in esame si registrano precedenti pronunce, in occasione delle quali si è affermato che il fallimento della società non figura nel D.Lgs. n. 231/2001 quale causa di estinzione dell'illecito contestato, ipotesi che si verificherebbe solo a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese. 2 www.ildirittoamministrativo.it Le Sezioni Unite hanno a tal proposito sottolineato che il fallimento priva la società fallita dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti a quella data, assoggettandoli alla procedura esecutiva concorsuale finalizzata al soddisfacimento dei creditori, ma tale effetto di spossessamento non si traduce in una perdita della proprietà, in quanto la società resta titolare dei beni fino al momento della vendita fallimentare (SU, n. 29951 del 24/5/2004). Il ragionamento giuridico alla base della pronuncia di primo grado è viziato, a giudizio della Corte, dall'irragionevole convincimento della irreversibilità dello stato di quiescenza in cui si trova la società che pertanto viene, dai giudici di merito, assimilato alla morte della persona fisica ed equiparato, in applicazione analogica delle norme in materia di estinzione del reato, alla morte del reo. In realtà, il fallimento della società non determina una modificazione soggettiva della stessa, che si trova soltanto sottoposa ad una liquidazione concorsuale ad opera di un pubblico ufficiale e sotto il controllo dell'autorità giudiziaria. Solo l'estinzione formale dell'ente produce, come sottolineato dalla Corte, eventualmente l'estinzione dell'illecito contestato e perchè ciò avvenga non è sufficiente né l'apertura né la chiusura della procedura fallimentare, bensì un formale atto di cancellazione della società dal registro delle imprese. Fino a quel momento, infatti, la società pur se malata rimane in vita e può, comunque, ritornare in bonis, con conseguente riespansione dei poteri gestionali ed amministrativi degli organi sociali. Solo la morte effettiva della persona fisica comporta l'estinzione del reato e dunque solo l'estinzione definitiva dell'ente può eventualmente determinare gli stessi effetti sulla sanzione per cui è giudizio. Il giudizio prognostico sullo stato di salute della società reso dai giudici di merito non può, per le ragioni sopra evidenziate, fondare l'estinzione dell'illecito amministrativo contestato, in quanto, tra l'altro, anche ove l'ente non abbia fondate chances di tornare in bonis, ciò non consentirà di escludere la possibilità per lo Stato di recuperare il credito attraverso lo strumento della insinuazione al passivo del fallimento. Peraltro, tale tipo di credito è assistito da privilegio che, solo se si giunge ad una siffatta e ragionevole conclusione, è in grado di svolgere la sua funzione pratica. Ove, infatti, si accogliesse il ragionamento del Gup di Roma secondo cui, come nel caso di morte della persona fisica, il fallimento della società determina non solo l'estinzione dell'illecito amministrativo ma anche della pena, la sanzione irrogata prima della dichiarazione di fallimento non consentirebbe per tale ragione l'insinuazione al passivo del fallimento. E' evidente che una simile soluzione priverebbe del tutto di efficacia la disposizione normativa contenuta nell'art. 27, D.Lgs. n. 231/2001. L'eventuale e oggettiva difficoltà di eseguire la pena non deve, quindi, condizionare la procedibilità del processo, considerando tra l'altro che il nostro sistema giuridico è slegato da principi di 3 www.ildirittoamministrativo.it eseguibilità delle pronunce giurisdizionali. Né l'eventuale posizione di incompatibilità della curatela fallimentare nel processo ex D.Lgs. n. 231/2001, può costituire argomentazione per ritenere sussistente una ipotesi non codificata di estinzione del reato, ma è questione processuale da risolvere nel processo. Le censure di parte ricorrente si fondano, inoltre, sull'eccezione della mancata trasmissibilità agli eredi dell'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 7 della L. 689/81. Ciò si verifica in quanto il fallimento non determina successione dell'ente collettivo, né a titolo universale, né a titolo particolare e non per la natura della sanzione irrogata ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (che, per la verità, rimane ancora incerta). A tal proposito, si ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che in materia di sanzioni amministrative per pregresse violazioni dell'imprenditore fallito, fermo il potere dell'ente impositore di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, il relativo credito è soggetto alle regole concorsuali e deve essere fatto valere con insinuazione al passivo fallimentare (Cass. Civ., Sez. 1, n. 18729 del 6/9/2007). In ultimo, la Corte si sofferma in breve sulla scelta di natura legislativa, di applicare una sanzione pecuniaria o interdittiva nei confronti di una società non più operativa: si tratta di un problema di politica legislativa che non può certo legittimare l'interprete a superare il dato normativo. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei pubblici ministeri del Tribunale di Roma, ha annullato la sentenza impugnata rinviando al giudice di primo grado per una nuova valutazione in ordine al rinvio a giudizio che dovrà attenersi al principio di diritto riportato in epigrafe. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 7 dicembre 2012, n. 47604: l'offerta in vendita di semi di piante dalle quali è ricavabile una sostanza drogante, correlata da precise indicazioni botaniche sulla coltivazione delle stesse, non integra il reato dell'art. 82 T.U. stup., salva la possibilità di sussistenza dei presupposti per configurare il delitto previsto dall'art. 414, c.p con riferimento alla condotta di istigazione alla coltivazione di sostanze stupefacenti. La questione giunge al vaglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a seguito del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze per l'annullamento della sentenza emessa dallo stesso Tribunale che, in esito a giudizio abbreviato, ha assolto gli imputati con la formula perché il fatto non sussiste, ritenendo che la vendita di semi di cannabis o marijuana 4 www.ildirittoamministrativo.it su un sito internet liberamente accessibile, unitamente ad opuscolo recante precise indicazioni per la coltivazione delle specie offerte in vendita, non integra il reato di cui all'art. 82 T.U. stup. (chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni) né quello previsto dall'art. 414, c.p. (essendo più specifico quello ex art. 82 T.U. stup.), bensì l'illecito amministrativo di cui all'art. 84, T.U. stup (la propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall'articolo 14, anche se effettuata in modo indiretto, e' vietata. Il contravventore e' punito con una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 82). Sull'interrogativo se la pubblicazione e la messa in vendita di semi di piante idonee a produrre sostanze droganti, con l'indicazione delle modalità di coltivazione e della resa, integri o meno il reato di istigazione all'uso di stupefacenti, si è registrato negli ultimi anni un nutrito contrasto giurisprudenziale che ha visto contrapporsi due diversi orientamenti. Parte della giurisprudenza di legittimità, muovendo dal convincimento della costante interconnessione tra pubblicizzazione di semi, coltivazione degli stessi e utilizzo di sostanze stupefacenti, ha ritenuto che, anche nell'ipotesi in cui la pubblicità non sia finalizzata strettamente ad esaltare le qualità droganti del prodotto e ad istigare il pubblico all'uso dello stesso, la normale finalità della coltivazione sia l'ottenimento e l'utilizzo della droga (Cass., Sez. 4, n. 26430 del 20/5/2009; Cass., Sez. 4, n. 23903 del 20/5/2009; Cass., Sez. 4, n. 2291 del 23/3/2004; Cass. Sez. 4, n. 15083 dell'8/4/2010). Pertanto una simile condotta integrerebbe di certo il reato di cui all'art. 82, T.U. stup. Altrettanto rigorosa è l'interpretazione di altra parte della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6, n. 38633 del 24/9/2009) che giunge a riconoscere alla condotta descritta rilevanza penale ai sensi del citato articolo del Testo Unico sugli Stupefacenti, ammettendo che l'istigazione possa astrattamente consistere nel fornire agli acquirenti dettagliate notizie sulla modalità di coltivazione di piante dalle quali sono ricavabili sostanze stupefacenti. Un diverso orientamento della stessa Corte (Cass. Sez. 4, n. 6972 del 17/1/2012) ha risolto la questione in senso opposto ai precedenti, sostenendo che la vendita di semi di piante dai quali sono ricavabili sostanze stupefacenti non costituisce reato perché riconducibile agli atti preparatori privi di potenzialità causale rispetto alle attività vietate. In particolare, la citata sentenza, operando un'attenta analisi delle diverse condotte descritte dagli artt. 82 e 84, T.U. stup., ha sottolineato che la propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni 5 www.ildirittoamministrativo.it comprese nelle tabelle previste dall'art. 14, T.U. stup e punita con sanzione amministrativa, non comprende necessariamente la propaganda finalizzata alla vendita. Pertanto la semplice indicazione dei metodi di coltivazione e delle caratteristiche delle piante non determina induzione all'uso di sostanze stupefacenti né provoca il concreto pericolo del loro uso da parte dei destinatari del messaggio. L'analisi delle Sezioni Unite prende le mosse dalle prescrizioni sovrannazionali in tema di pubblicità di sostanze droganti (art. 10, comma 2 della Convenzione di Vienna del 1971, ratificata e resa esecutiva in Italia con la Legge del 25 marzo 1981, n. 385, che stabilisce: ciascuna parte, tenendo debito conto delle norme sulla sua Costituzione, proibirà le inserzioni pubblicitarie riguardanti le sostanze psicotrope e destinate al grosso pubblico), giungendo, poi, a sottolineare che il nostro ordinamento contrasta ogni forma di propaganda attraverso, tra l'altro, una forte anticipazione della tutela penale. Le Sezioni Unite, al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale sull'argomento, hanno ritenuto opportuno soffermarsi, in principio, sulla distinzione tra le due tipologie di condotte descritte dagli artt. 82 e 84, T.U. stup. e sui loro diversi ambiti di applicazione, giungendo a sostenere l'inconciliabilità della nozione di proselitismo e quella di induzione al reato (annoverate dall'art. 82) con le caratteristiche tipiche del messaggio pubblicitario, che non mira a suggerire scelte basate su specifiche ragioni ideologiche, e non implica un rapporto personale tra il propagandista ed il destinatario con opera di diretto influenzamento dell'uno sull'altro. Maggiore sforzo si richiede, invece, all'interprete chiamato a focalizzarsi sulla distinzione tra la nozione di istigazione effettuata pubblicamente e quella di propaganda. A giudizio delle Sezioni Unite, infatti, tale distinzione non può essere trascurata o negata se si vuole giustificare correttamente la differente risposta punitiva alle due condotte data dal legislatore che, non a caso, all'interno di uno stesso contesto normativo, ha scelto di usare termini differenti (propaganda pubblicitaria e istigazione). La Corte condivide quanto precedentemente sostenuto dagli stessi giudici di legittimità che hanno posto l'accento sulle caratteristiche del messaggio pubblicitario che, nell'art. 84, deve essere asettico e non deve indurre i destinatari all'acquisto o all'uso del prodotto stesso. In applicazione di tale criterio, ritenuto dalla Corte l'unico idoneo ad operare l'opportuna diversificazione delle condotte di cui si tratta, si ritiene che rientri nella propaganda pubblicitaria la condotta di chi si limita in modo asettico e neutro a rendere noto al pubblico la esistenza della 6 www.ildirittoamministrativo.it sostanza veicolando un messaggio non persuasivo e privo dello scopo immediato di determinare all'uso di stupefacenti. D'altronde, è lo stesso legislatore che nel formulare il secondo comma dell'art. 84 specifica che la sanzione amministrativa deve trovare applicazione, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 82, e, mostrando in questo modo di inquadrare il rapporto tra le condotte descritte negli articoli in esame in termini di gravità crescente, fornisce così la soluzione per risolvere l'eventuale e supposto conflitto apparente di norme. La Corte risolve il caso di specie ritenendo di non inquadrare la condotta contestata nell'ipotesi di reato ex art. 82 in quanto la nozione di stupefacente non è in alcun modo coincidente o sovrapponibile con quella di pianta dalla quale, attraverso opportuni procedimenti chimici non descritti nel messaggio pubblicitario, sia ricavabile una sostanza stupefacente. La Corte giunge a tale conclusione in quanto avverte l'esigenza che l'interpretazione degli articoli in esame rimanga fedele al dato letterale, che si riferisce alle sostanze stupefacenti e non alla naturale fonte da cui le stesse derivano. Un'interpretazione differente rischierebbe, al contrario, di dilatare il fatto tipico previsto dalla norma con palese violazione del principio di tassatività. Purtuttavia, la Corte esclude la qualificazione della condotta contestata ai sensi dell'art. 84 T.U. stup. in quanto il messaggio pubblicitario non era neutro ed asettico, ma indicava i metodi botanici per la miglior resa dei semi e invitava i destinatari all'acquisto come attività prodromica al successivo comportamento, consistente nella coltivazione di piante dalle quali è estraibile una sostanza stupefacente. Tale condotta è invece punita dall'art. 26 T.U. stup. e prevista come delitto dal successivo art. 73, comma 3. Più calzante, ad avviso della Corte, appare invece il richiamo all'art. 414, c.p., che prevede il delitto di istigazione a delinquere, dovendosi precisare che esso non si pone rispetto al citato art. 82 in rapporto di genere a specie in cui il primo sarebbe norma generale e il secondo norma speciale. Ciò in quanto l'art. 82 non annovera tra le condotte punibili la illegale coltivazione di stupefacenti. Occorre a questo punto una valutazione ex ante del magistrato di merito circa la reale efficienza dell'azione stimolatrice a spronare le persone con modalità tali da persuaderle a passare all'azione e da porsi come antecedente adeguato per indurle a commettere il fatto illecito. Per la configurabilità del delitto ex art. 414, c.p. non è richiesta la punibilità in concreto della condotta istigata, ma è necessario che la stessa sia prevista dalla legge come reato. Nel caso di specie ciò si verifica in quanto l'art. 73, T.U. stup. punisce con la reclusione la mera coltivazione. Ulteriore e necessaria valutazione, non eseguibile in sede di legittimità, è quella diretta alla verifica che la condotta contestata all'agente ed accertata sia inidonea a mettere a repentaglio il bene 7 www.ildirittoamministrativo.it giuridico protetto, risultando in concreto inoffensiva (ciò si verifica quando la sostanza non produca un effetto drogante rilevabile). Per tali ragioni, non emergendo in modo palese che la pubblicità degli imputati fosse inoffensiva, le Sezioni Unite hanno annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze. Corte di Cassazione, Sez. I, 10 dicembre 2012, n. 47859: la legge, n. 199 del 26/11/2010 non può essere intesa come una seconda possibilità, oltre quella prevista dall'art. 656, c.p.p., di ottenere la sospensione dell'esecuzione al fine di scontare la pena con la speciale misura alternativa prevista dalla suddetta legge. La questione di cui si è occupata la Corte di Cassazione nella sentenza in commento riguarda i rapporti tra la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva ex art. 656 co. 5 c.p.p. e la sospensione dell'ordine di esecuzione di cui all'art. 1 l. 199/2010, c.d. legge Svuota Carceri. La L. n. 199/2010, recante disposizioni sull'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno, è stata emanata con l'obiettivo di risolvere, attraverso la predisposizione di una misura emergenziale temporanea, il problema del sovraffollamento delle carceri. La norma, infatti, prevede la possibilità di ottenere la detenzione domiciliare per le categorie di condannati che, ai sensi dell'art. 656, c.p.p., non avrebbero potuto goderne e, in particolare, per coloro ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, c.p.p. La Cassazione, nella pronuncia in commento, ha operato il raffronto tra le due norme (art. 656, c.p.p. E art. 1, L. n. 199/2010), affermando il principio di diritto in base al quale la norma di cui alla L. 199/2010 non può essere considerata una seconda chance per il condannato di ottenere la sospensione dell'esecuzione della pena. L'art. 656, c.p.p. prevede, infatti, che se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta; qualora l'istanza sia stata respinta, il Pubblico Ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. 8 www.ildirittoamministrativo.it L'art. 1 della L. n. 199/2010 dispone la sospensione delle pene detentive non superiori a dodici mesi (ora diciotto mesi) solo nel caso in cui il condannato non possa beneficiare di una delle misure alternative alla detenzione in carcere che possono essere concesse attraverso la procedura prevista dall'art. 656, c.p.p. Il comma 3 del citato articolo 1 della L. 199/2010, inoltre, prevede espressamente che la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione possa essere disposta dal pubblico ministero solo quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi e salvo che lo stesso debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 dell'art. 656, c.p.p. Dalle norme sin qui riportate e sottoposte all'esame della Corte di Cassazione, emerge con chiarezza che se il condannato può beneficiare delle misure alternative alla detenzione in carcere prevista dall'Ordinamento Penitenziario, avrà diritto solo alla sospensione ex art. 656, c.p.p. Ove il beneficio richiesto gli sia stato negato dal Tribunale di Sorveglianza in ragione della pericolosità o per altra causa, il condannato non potrà usufruire di una seconda sospensione, in attesa che questa volta il Magistrato di sorveglianza valuti se si tratti di un soggetto pericolo o che comunque sussistano le condizioni per l'esecuzione della pena presso il domicilio. E' quest'ultima la fattispecie concreta sottoposta all'attenzione dei giudici di legittimità, che si sono pronunciati per la non ammissibilità di una seconda sospensione dell'ordine di esecuzione in quanto il condannato, nel caso di specie, ha già attivato il meccanismo previsto dall'art. 656, c.p.p. Corte di Cassazione, Sez. IV, del 13 dicembre 2012, n. 48243: ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe stato ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. In materia di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, i giudici della Suprema Corte confermano l'ordinamento ormai consolidato della stessa giurisprudenza di legittimità secondo il quale la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto risiede nella diversa condotta posta in essere dall'agente che, nel primo caso si estrinseca in un comportamento meramente passivo e privo di efficacia causale, mentre nel secondo si caratterizza per il contributo positivo, morale o materiale, all'altrui condotta criminosa, assicurando quindi, al 9 www.ildirittoamministrativo.it concorrente, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare (Cass., Sez. 4, n. 24895 del 22/5/2007). Il compito del giudicante è dunque quello di valutare se e in che misura il contributo del concorrente ha assunto rilevanza in termini di agevolazione nella commissione dell'illecito e se, quest'ultimo, in assenza di tale condotta, sarebbe stato ugualmente commesso, anche se con più scarse possibilità di riuscita. Nel caso di specie, la condotta dell'imputata sottoposta a giudizio della Suprema Corte e condannata in secondo grado in ordine al reato di cui agli artt. 81 e 110 c.p.p. e 73, co. 1 bis, D.P.R. 9 ottobre 1999, n. 309, consisteva nell'aver costantemente assisto alla vendita di stupefacenti da parte del marito convivente, attività di cui quest'ultima era a conoscenza dal momento che lo stupefacente era detenuto in vari luoghi all'interno dell'abitazione e in particolar modo in camera da letto. Sulla base di tali accertamenti in fatto, i giudici della Corte di Cassazione hanno confermato le conclusioni già formulate dai giudici di merito, giungendo ad affermare che la condotta agevolativa dell'imputata andava ben al di là della connivenza e si configurava invece come complicità sia nella detenzione della droga nel suo complesso, sia nella vendita ripetuta di singole dosi. 10
Scaricare