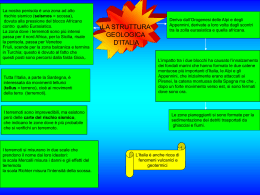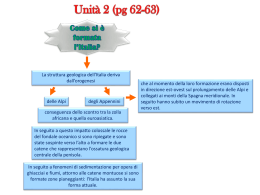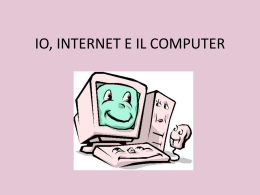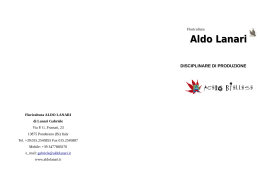Elémire Zolla
Il conoscitore
di segreti
Una biografìa intellettuale
di Grazia Marchianò
Rizzoli
Quando un uomo se n'è andato per sempre, porta
un segreto con sé: come a lui, proprio a lui — sia
stato possibile, in senso spirituale, vivere.
Hugo von Hofmannsthal
Due parole preliminari
Poco dopo la morte di Elémire Zolla, occorsa a Montepulciano il 29
maggio 2002, la Encyclopedia ofReligion pubblicata da Macmillan
m'invitò ad allestire per la seconda edizione, in programma nel
2004, un profilo dello scrittore in 1200 parole, oltre allo spazio per
la bibliografia ragionata e la ricezione critica. Nella lettera che mi
conferiva l'incarico, mi si invitava a illustrare «le vite» di Elémire
Zolla: una richiesta che mi colpi per la sua strana esattezza, come se
chi scriveva fosse perfettamente al corrente di quello che tante volte
qui, in Italia, era parso un vezzo dello scrittore la confessione, cioè,
di aver vissuto svariate vite in una, morendo alla vecchia identità
ogni volta che se ne foggiava una nuova. Fu l'inaspettato uso al plurale della parola «vita» che mi diede il coraggio necessario a «raccontare» Zolla in 1200 parole.*
Seppure lo spazio qui a disposizione sia molto maggiore, non
per questo è stato più agevole il compito di scavare la personalità
dello scrittore per chi ha avuto la ventura di condividere almeno
un paio di quelle sue vite e un fascio di esperienze intellettuali incancellabili. Dopo aver montato e smontato svariate versioni del
manoscritto nel tentativo di adeguarlo a un modello di biografia
standard, se mai ne esiste uno, mi sono persuasa che la sola via percorribile nel mio caso era di immergere lo sguardo quanto più a
fondo nei mondi mentali di Zolla, nelle idee ripide e, in più d'un
* Encyclopedia ofReligion, a cura di Lindsay Jones, Macmillan, New York, voi. 1 4 ,
pp. 9984-9987.
9
caso estreme, che hanno tramato i suoi scritti e deciso in gran parte
degli andamenti scoscesi della sua vita unica e multipla.
Nelle stanze in cui, da una stagione all'altra del dopo Zolla,
prendeva forma II conoscitore di segreti in un affastellio vertiginoso
di carte, cartelle, fascicoli, raccoglitori d'archivio e materiali di
corrispondenza provenienti da ogni dove, venivano a lambirsi
due maree cartacee, due fiotti distinti di attenzione a quel che
Zolla scrisse, pensò, dichiarò pubblicamente o confidò a bassa
voce in privato. Da una parte le recensioni, gli articoli di giornalisti, intervistatori, studiosi e autori che, a loro volta, hanno commentato i suoi libri, criticato le sue idee, dialogato con lui in
modo diretto e indiretto in una gamma assai ampia di atteggiamenti e posizioni, costruttive e distruttive, osannanti e ingiuriose
ma tiepide quasi mai, competenti e attente più o meno, a seconda
di un insieme di fattori legati all'aria del momento, alle convinzioni personali, alla preparazione culturale e alla correttezza di chi
si firmava, come accade in tutti i casi nei quali le idee di un autore
e la sua opera non passano inosservate e suscitano sentimenti e
reazioni che blande e concilianti non possono essere. Dall'altra
parte le lettere, talune di molte pagine, dattiloscritte o vergate a
mano accanto a un numero incalcolabile di messaggi, biglietti,
cartoncini e cartoline provenienti da gente di ogni tipo, età e condizione sociale, che ha acquistato i libri di Zolla o li ha presi in
prestito da un amico, li ha letti, è tornata a rileggerli consumandoci gli occhi, ne è stato provocata, scombussolata, toccata nell'intimo, costretta a fare i conti con una parte di sé che l'indifferenza, la pigrizia mentale, la disattenzione, la negligenza hanno
tenuto in ombra e che un pensiero, una battuta dello scrittore,
una parola scambiata fortuitamente con lui hanno istigato a snidare. Molte di queste persone e le schiere di studenti nella cui vita
si è materializzato, a un certo punto, un contatto con ciò che ha
detto, pensato e insegnato Elémire Zolla, quante volte scavalcando reticenze, timidezze e una palese soggezione, hanno preso
la penna in mano per confessare che le idee espresse nei suoi libri,
gli orizzonti straniami dischiusi lì dentro o a viva voce li hanno
toccati nel profondo. Di qui l'onda schietta di gratitudine auten-
tica, l'ansia spontanea di riconoscere quanto le parole dello scrittore siano state una fonte di consapevolezza, una guida e una luce
nel labirinto della vita.
Dare un conto minuzioso di questi fiotti di attenzione all'opera di Zolla, distinti e non mescolabili, scaturiti da esigenze e
motivi senza rapporto o vicinanza gli uni con gli altri era un'impresa che sebbene avessi preso inizialmente in considerazione,
non è stata affrontata riconoscendo che in fin dei conti è rinviabile e probabilmente può attuarla meglio una persona diversa da
chi ha condiviso gli ultimi venticinque anni della vita di Zolla,
avendone segnata la propria in maniera incancellabile.
Il libro si compone di due parti. La prima, Sprazzi di una biografia scancellata * percorre quattro successive stagioni della vicenda intellettuale di Zolla. In inglese una esposizione di questo
tipo, intesa a cogliere lo spirito del vissuto dello scrittore piuttosto che attenersi ai fatti minuti, sarebbe una story, non una history.
La seconda pane, Scritti di quattro stagioni, aduna una scelta di
testi zolliani antichi, intermedi e recenti raggruppati in sei sezioni:
Saggi letterari, Scritti sulfurei, Nuove terre cieli nuovi, Scritti zodiacali, Appunti sulfuturo, Epifanie. La sezione antologica è dunque
opera esclusiva dell'ingegno di Zolla, il frutto del suo formidabile
talento e di un grande spirito messi a dimora in un'opera postuma.
Una parola ancora sul titolo. Perché intitolare questo libro II conoscitore di segreti ì Forse che Elémire Zolla ebbe conoscenze riservate, esoteriche di nome e di fatto, così speciali e pericolose da tenerle per sé o sussurrare, eccezionalmente, a pochissimi? Può darsi,
ma allora a che prò far luce su di esse se già non lo ha fatto lui? Il
motivo del titolo è un altro, e la spiegazione è addirittura banale. I
segreti, di cui Zolla scrisse e parlò sono sotto la vista di tutti, nitidi
e squadernati come un libro aperto. Senonché gli occhi della maggioranza di noi divagano, sono disattenti, guardano senza vedere,
ricorrono volentieri a lenti altrui da indossare e gettar via per infor* Il saggio che pubblicavo su «Viator», anno VI, 2002 (pp. 11-22), s'intitola Elémire
Zolla: Sprazzi di una biografia interiore. Si trattò di un intervento a ridosso della
morte di Zolla dove la mia commozione era palpabile. A distanza di tempo vi scorgo
prefigurato il profilo intelletuale tracciato nella Parte prima del presente volume.
carne subito altre. In certi casi le stesse lenti ci restano appiccicate
l'intera vita, e con la nebbia o il buio conviviamo senza problemi.
Allenarci con le sole nostre forze a scrutare il visibile al punto da rasentare qualche volta l'invisibile - come Zolla ha fatto ininterrottamente, senza risparmio, nelle più sbrigliate direzioni, non è da
tutti e, in fin dei conti, è meglio così.
Quanto a lui, molti dei suoi segreti, è vero, li ha carpiti leggendo,
e s'è trattato a volte di libri scovati chissà dove, composti in lingue
poco note ai più; altri di quei segreti li ha catturati viaggiando in
luoghi magari distanti da quelli che si bazzicano abitualmente,
ascoltando persone che forse è raro incontrare sotto casa, nella redazione di un giornale o nei corridoi universitari. D'altra parte di
libri, viaggi e incontri è piena oramai la vita di ciascuno e tanto più
si avvia a esserlo in quel futuro alle soglie di cui Zolla ragionava lietamente negli ultimi anni. Sicché, viene di pensare, non sono tanto
gli spostamenti nello spazio fisico, le letture sulla carta o sul video
del computer, gli incontri prevedibili o imprevisti a dispensare occasioni di conoscenza, ma il modo nel quale ci si rapporta ad essi, si
fanno filtrare e lievitare dentro di noi, suscitano connessioni, dischiudono orizzonti al di là dell'ovvio, istigano a dubitare e ad accendere nuove domande, senza porre limite alcuno alla fame e alla
sete di cercare, indagare, apprendere, ricordare, dedurre, analizzare,
argomentare, immaginare ma anche contemplare, meditare, coltivare il silenzio, espandere la consapevolezza, crescere dentro - quali
che siano le circostanze in cui ci si trovi a vivere, nella buona e nella
mala sorte come si diceva un tempo. I segreti conosciuti da Zolla e
disseminati nei suoi libri attingono a questa crescita, alla somma di
dolore e gioia che gli è costata, all'intima persuasione che il bene
della conoscenza non sta nella capacità di rispondere a un quesito
ma nello sforzo di affrontarlo fino in fondo. Questo è stato il presupposto e la ragion d'essere del mestiere di scrivere in cui si identificò la sua vita.*
* Nel saggio su Pinocchio riportato in Epifanie (Parte seconda), a un certo punto
scriveva: «In vernacolo, ridendo, conviene esporre le cose più inaccessibili».
Parte prima
Sprazzi di una biografìa scancellata
Una vita per la scrittura
Le aure via via incontrate [...] col tempo formano
tra loro strane costellazioni e le intreccia un filo
invisibile: la biografìa di un uomo.
Dai Quaderni
Ci sono persone che nascono, si direbbe, per lasciare una traccia,
una testimonianza viva del loro passaggio. Essa può consistere
nelle azioni compiute, quando l'energia s'è tutta concentrata nel
fare e nell'agire, ma può anche imprimersi in ciò che quelle persone hanno pensato e, quando si tratta di scrittori, nelle pagine
che hanno scritto. I pensieri, infatti, vivono e si imprimono secondo leggi proprie, e anche la loro sparizione obbedisce a un
destino autonomo. Per evitare che essi vengano dimenticati si
può dar loro una spinta a restare presenti, a influire in quella
parte del mondo della vita che si chiama cultura. Questo libro
postumo di Elémire Zolla (1926-2002) vuole essere una porta
di accesso al suo pensiero rivisitato negli scritti di una vita abbastanza lunga da affacciarsi sul ventunesimo secolo. Un pensiero
notoriamente non facile da assimilare perché colmo di conoscenze in cosi tanti campi (storia, letteratura, mitologia, simbologia, filosofia, religioni, esoterismo e altro ancora), da paralizzare chi è sprovvisto degli strumenti intelletuali necessari ad accostare opere erudite come le sue.
Uno degli argomenti ricorrenti dei critici di Zolla, sia in vita,
sia in morte, fu il carattere altezzoso dei suoi scritti, difficili da
masticare se non a piccole dosi aiutandosi con un dizionario e una
enciclopedia a portata di mano. Un'obiezione che Zolla liquidava
in quattro e quattr'otto affermando che la difficoltà è inversamente proporzionale alla volontà e alla tenacia con cui ci si applica a capire. Una risposta che suonava un tantino minacciosa a
chi non è abituato ad associare la nozione di proporzionalità all'impegno personale, né ha mai pensato che comprendere per
davvero comporta una trasformazione interiore. Altre volte si era
limitato a sorridere, senza dir nulla, e anche in quel caso si restava
interdetti. Cosa c'era dietro quel muto sorriso?
In una delle ultime interviste rilasciata a Doriano Fasoli nel salotto di casa a Montepulciano,1 Zolla volge al suo interlocutore lo
sguardo remoto e cortese di chi sorride alla vita con distacco. Oramai i giochi sono conclusi e tutto è chiaro: le forze che agiscono
in noi e ci rendono succubi o padroni (molto di rado) del nostro
destino sono le stesse che intrecciano gli eventi storici, che scatenano lutti e tripudi, che spingono alla santità e all'abiezione, che
s'incanalano in quello che si chiama correntemente il bene e il
male. Forze gigantesche, terrificanti, misteriose: da dove scaturiscono infatti odio e amore, bellezza e turpitudine, luce e tenebra
dentro di noi? Forze tuttavia che si possono ammansire non appena ci si applichi a scrutarle indefessamente alla loro radice.
Chiunque coi mezzi che può, con le occasioni che la vita gli offre,
può farlo e intanto impara a guardarsi d'attorno con attenzione, e
quanto maggiore è l'attenzione, tanto più aumenta la sorpresa di
trovarsi catapultati proprio qui, di essere proprio «noi» con questa faccia, con questi modi, con questi ricordi, aspettative, rimpianti e paure che ci prendono alla gola. Nella conversazione con
Fasoli lo sguardo di Zolla abbracciava tutto questo e lo scavalcava:
dell'atteggiamento sprezzante, protervo, vagamente tenebroso
che era stato il suo nell'età delle battaglie ideologiche quando il
suo impegno d'intellettuale in rotta con l'industria culturale e il
sistema che la regge si era arroventato nella disputa, l'invettiva, il
sarcasmo, non restava traccia. Parlò di svariati argomenti: il significato del martirio cristiano, la statura di Nietzsche nel pensiero
del Novecento, gli incontri determinanti con lo storico delle religioni rumeno Ioan Petru Culianu (1950-1991) e l'etnomusicologo tedesco Marius Schneider (1903-1982). Poi la conversazione virò sul tema dell'aura, che era stato al centro di uno dei libri
più popolari di Zolla negli anni Ottanta, Aure? sullo sciamanesimo al quale s'era accostato dal tempo del primo viaggio di ricerca tra gli indiani d'America;3 sulla realtà virtuale e gli effetti
prodotti sulla gente da tecnologie capaci di alterare il quadro ordinario del mondo; infine sulla lettura, sul ruolo che la pratica indefessa del leggere ebbe nella sua vita e nella costruzione di se
stesso come scrittore. Intanto, nella stanza dove avveniva l'intervista, l'occhio della telecamera indugiava sulle tracce visibili dei
viaggi da un capo all'altro compiuti dallo scrittore: statuine cinesi
di immortali, un suonatore di liuto indiano con il capo sormontato da un grazioso baldacchino azzurro, piccole vasche colme di
ciottolini secchi come minuscoli giardini zen, un koto' per bambini accanto a una fotografìa che ci ritrae in Thailandia, stoffe
sgargianti drappeggiate attorno a diagrammi buddhisti del
cosmo. Sul cielo a volta del salotto, le figure affrescate dei quattro
venti nell'atto di scoccare la freccia nelle quattro direzioni e al vertice del soffitto Borea che rapisce Orizia, traendola al mondo
degli dèi. Nel suo neutro sguardo circolare sull'antica sala la telecamera carpiva lembi e memorie della vicenda di un uomo indecifrabile, una vicenda nella quale il principio e la fine, culla e
tomba venivano, ora, mitemente a coincidere.
Questo libro aspira a far luce sulla coincidenza degli opposti
nella vita, nel pensiero e nell'opera saggistica5 di Elémire Zolla. Se
molti dei suoi scritti, soprattutto quelli che videro la luce tra la
fine degli anni Cinquanta e gli anni Settanta del Novecento, sono
stati bollati come elitari per l'erudizione di cui sono farciti e pericolosi per le tesi controcorrente sostenute dall'autore in maniere
recise e accanite, qui si portano argomenti che aiutano a rettificare questo giudizio e l'idea, in parte sbagliata, che un cibo di sapore raffinato spiaccia a palati rozzi, a stomaci che digeriscono
pietre. Ciò non è del tutto vero o almeno ha cessato di esserlo da
quando molta gente ha sentito l'anelito a camminare nella vita in
un modo più accorto e consapevole proprio come fece Zolla seppure, rispetto a lui, con una lucidità e un accanimento presumibilmente meno feroci. Dare un nome a questo anelito non è semplice visto che non si identifica nei vecchi concetti di «verità»,
«fede», «armonia» o «bellezza» — sebbene in ognuno di essi quell'anelito che viene dal profondo si rispecchi in parte. Certamente
comporta una crescita interiore, una ricerca genuina di equilibrio
e quiete, il risveglio di quello che un tempo si chiamò «intelletto
d'amore». In questo caso una lettura non preconcetta dell'opera
di Elémire Zolla può essere d'immenso aiuto. Occorre però prima
liberarla delle concrezioni che l'hanno ossificata facendole dire
quel che non ha detto, con l'aggravante che lo scrittore non si
prese mai seriamente la briga di contestare i fraintendimenti. Sapeva che sarebbe stato uno spreco di tempo a vuoto. E per lui, il
tempo era un capitale che doveva rendere il massimo. Se lo si sciupava correndo appresso a fisime, a rettifiche inconcludenti, era
davvero un peccato mortale, una auto-condanna senza appello
visto che la vita è un prestito provvisorio e dipende solo da noi che
.cosa farne. I critici che si erano occupati dei suoi libri, i giornalisti che lo avevano via via intervistato disponevano di un repertorio di etichette prêt-à-porter, appiccicate al nome e al cognome
come ritornelli: «filosofo strano e inquietante», «maestro scomodo», «turista metafìsico», «chierico vagante e cercatore di
aure», «glossatore di archetipi», «psicopompo», «intellettuale eterodosso», «alchimista della felicità», «Zolla degli spiriti» e via dicendo. Quanto agli eventi e agli accidenti della vita privata, poiché era persuaso che ricordarli senza distorcerli fosse impossibile,
evitò di stendere memorie, anzi con ogni cura si allenò a cancellare l'identificazione con l'io personale. «Da sempre m'è apparso
una menzogna l'io» scriveva nel 1994 ne Lo stupore infantile. «A
guardare con attenzione, quell'ammasso d'impressioni casuali si
sbriciolava e molte, diverse persone potevano essere addebitate,
in parte vere, in parte no.» Un'indole disciplinata ma ribelle a
qualsiasi intimidazione, una inflessibilità intellettuale che fu pagata a caro prezzo, una mente sistematica incline all'esoterico, un
senso spiccato della bellezza e una febbre divorante di conoscenza
sono tratti preliminari a un ragguaglio di necessità frammentario
sulle stagioni di una vita nella quale sofferenza e gaudio, indigenza e benessere, solitudine e affiatamento con pochi affini, si allacciano dal principio alla fine. Un profilo stilato da lui stesso per
la scheda contenuta nell'edizione originale del 1963 de I mistici
dell'Occidente, cattura in dieci righe quel che lo scrittore volle raccontare di sé al tempo in cui la malattia polmonare - che lo assillerà per il resto dei suoi giorni - l'aveva riacciuffato a trentasei
anni, immobilizzandolo a letto per mesi.
«Elémire Zolla» si legge «è nato nel 1926 aTorino, i nonni avevano
avuto per patria la Cornovaglia, il Kent, la Lombardia e l'Alsazia.
La sua vita non annovera avvenimenti degni di nota; ora vive a
Roma. Il suo romanzo Minuetto all'inferno uscì nel 1956, ed ebbe
il premio Strega opera prima. Ha scritto un libro di saggi L'eclissi
dell'intellettuale, uscito nel 1959, insieme a due antologie {Imoralisti moderni t La psicanalisi, edizione Garzanti). Ha scritto anche
molti saggi letterari sparsi su riviste (i più recenti trattano lo stile di
Melville e la filosofia di Kafka).»
Tre anni prima, nel 1960, la rivista «Il Paradosso»6 aveva condotto
un'inchiesta sulla generazione dei nati negli «anni difficili» del
Ventennio: che cosa leggevano e che ne pensavano della politica
intellettuali e scrittori cresciuti sotto il Regime come Italo Calvino, Rossana Rossanda, Antonio Banfi, Giovanni Baget Bozzo,
Franco Fortini, Ruggero Zangrandi, Mario Rossi e, tra loro, il
controverso autore di L'eclissi dell'intellettuale, preso di mira per le
sue tesi ferocemente antimoderne. Le parole di Zolla in quell'occasione trasudavano il fastidio di chi si trovi costretto a rimestare
tra cianfrusaglie abbandonate in una cantina malsana e buia.
«Non posso rispondere alla domanda sulla vita politica» aveva
detto «perché non ne ho esperienza di sorta. Dinanzi agli apparati
politici provo i sentimenti di cui parla Pasolini nella poesia sulla
festa dell'"Unità".»
Qualche concessione in più l'aveva fatta sulle letture della sua
adolescenza. «Nel 1939 avevo tredici anni; anche se si fanno mo-
strc di pittura infantile e si pratica da qualche parte l'educazione
progressiva, non so se convenga portarvi a visitare una nursery»
aveva dichiarato spazientito.
Frequentavo la scuola fascista con l'animo di Alice fra le bestie e le
cane da gioco. Il mio bagaglio? Dovrei copiare l'elenco della biblioteca di casa e di quella d'un circolo di Torino. Le preferenze
che avevo da ragazzino? La storia d'Europa di Croce e Eanima dell'uomo sotto il socialismo di Oscar Wilde. L'abitudine di confinare
le letture dei fanciulli ai libri per l'infànzia è nevrotica, ha la stessa
funzione della fasciatura del cranio presso ceni africani. Non mi
fu imposta.
In un altro autoritratto che risale allo stesso anno, l'infanzia è rievocata come un piccolo paradiso:
Dove non pendevano minacce, dove liberamente m'aggiravo fra
mobili dignitosi e persone che s'ingegnavano a esserlo. Ero curato
e quasi ignorato, a interessarmi erano i quadri (mio padre era pittore), i discorsi (la mia presenza non imponeva censure), le musiche (mia madre era pianista), i libri che presto cominciai, se non a
capire, a leggere. Quel paradiso terrestre si spostava, secondo i capricci di mio padre, da Londra a Parigi, sicché la noia non poteva,
nemmeno essa, insinuarsi, e di quando in quando tutto allegramente mutava, la lingua del mondo «di fuori» diventando quella
di mia madre (inglese) o di mia nonna (francese) o di mio padre
(italiano).
Poi di colpo, un giorno orrendo, fui cacciato dal paradiso, anche
se in apparenza tutto restava intatto. Mi portarono a vivere, stavolta definitivamente, a Torino, un giorno della guerra d'Etiopia.
Ricordo l'uscita dalla stazione, mi trovavo in una città dove tutto
procedeva tetramente a rilento, dove a ogni passo s'incrociavano
uomini in divise stravaganti e per giunta armati, e infine dove una
frotta di marmocchi vestiti da soldati, muniti di moschetti camminavano indrappellati, al comando d'un uomo pallido, isterico,
bestemmiarne. Ne fui mosso a riso, senonché, domandato a mio
padre se quello fosse uno dei fascisti dei quali avevo udito più volte
parlare, mi fu risposto che ormai ero in Italia e ci conveniva non
fare discorsi politici in pubblico. Allora mi scese addosso una
nube nera che non s'è più dissipata, e le cose presero ad andare di
male in peggio né accennano a migliorare. Inutile raccontare ciò
che mi avvenne dopo i dieci anni (la scuola pubblica già conuene
tutti i mostri di cui la vita sarà prodiga), poiché la sciagura è
noiosa, anche se cambia aspetto, ora presentandosi come penuria,
ora come idiozia imperante, ora come malattia. Perché questo racconto? Perché spiega come mai almeno alla penuria ed all'idiozia
sovrana io stenti ad acconciarmi, restandomi fitto in mente il ricordo di uno stato indenne da quelle maledizioni. Spiega anche
perché io scriva: non credo che il male sia tutto inevitabile. Questo è quanto posso fornire come «contributo alla critica di me
stesso». Inutile stare a narrare altri episodi biografici, tanto più che
i fatti di per se stessi, specie quelli occorsi a me, non hanno interesse e procuro di non farne provvista. Inoltre mi pare sconveniente parlare di sé medesimi salvo che questo sia un modo abbreviato di discorrere di altra cosa. E allora perché quell'inizio biografico? Per dire che se i rapporti umani fossero sciolti dal bisogno
nonché dagli idoli economici e resi leggeri, attenti, intatti, indifferenti, la dolcezza di vivere non sarebbe impensabile.7
Trentanni più tardi, in un brano dedicato a un torinese sui generis quanto lui, Guido Ceronetti, l'evocazione di se stesso acquistava toni sognanti quasi da «C'era una volta...»:
Vivevo isolato, sbrigando in fretta le scuole, ignorando compagni
e professori per quanto potevo, adagiato a leggere per ore e ore, vagando a lungo attraverso le strade miserelle di Torino, sempre in
cerca d'un tratto di vita memorabile, nel quale alla fin fine nemmeno speravo. Sentimento costante era il vago incantesimo per il
semplice fluire del tempo, che di quando in quando riusciva a
comprimersi e a fermarsi in una sfera raggiante, dorata. Osservavo
con curiosità non troppo intensa l'abitudine che gli altri avevano
di considerarsi un punto d'imputazione, un carico di responsabi-
lità e di doveri, una persona. Io non m'ero mai visto altro che come
un convegno temporaneo, fluttuante, trasognato di impressioni.
Ciò che davvero mi costituiva era l'entusiasmo che provavo per
certe opere. Le leggevo e rileggevo: Tao-te Ching, Alice, la vita del
Buddha. Altre letture viceversa le tenevo a distanza, mi infastidivano quasi quanto il mondo circostante (come i romanzi di
Dickens cosi carichi di odiosa compassione).
Qualche rara volta parlai di ciò che provavo e vivevo, a qualche
donna che mi piaceva, per i profumi, la pelle morbida, gli occhi
scintillanti, per una sua parvenza d'attenzione amorosa.8
Infine soccorre il profilo che Zolla allestì per XAutodizionario
degli scrittori italiani nel 1989. S'era alle soglie di un decennio,
l'ultimo della sua vita, colmo di viaggi e nuovi libri, e l'occasione
servì a rattoppare un'immagine passabilmente estesa di se stesso,
in modo da non doverci tornare più sopra se non conversando a
tu per tu con qualcuno, abbandonandosi al piacere di raccontare
come fu che toccando l'età matura si stupisse di esserci ancora, e
remando nelle acque della vecchiaia avesse gioito come mai
prima.
Nacque aTorino il 9 luglio 1926. Suo padre, Venanzio, era nato in
Inghilterra da padre lombardo e madre alsaziana; aveva studiato
pittura, dedicandosi alla maniera di Whistler, dipingendo dame
in kimono, venendo quindi in Italia, con la moglie inglese e stabilendosi a Torino, dove aveva un gruppo di allievi (fra loro era
anche Argan). La madre, Bianche Smith, sapeva suonare ogni
strumento, ma preferì l'organo.
Zolla crebbe isolato nella casa paterna, parlando naturalmente inglese, francese e italiano, studiando in seguito il tedesco e lo spagnolo. Dipingeva e suonava il pianoforte. Messo a scuola, imparò
l'arte di fingere, di occultare i sentimenti, disprezzò quanti gli stavano d'attorno. Non incontrò se non fascisti in Italia; lo sollevava
l'espatrio frequente, il soggiorno in Inghilterra o a Parigi. Cominciò a leggere fitto; a scuola riuscì facilmente.
Fu in Italia durante la guerra, uno dei rari periodi di quieta ricchezza
per suo padre; notò che a poco a poco la gente diventava meno fascista. Ricorda l'arrivo degli alleati a Torino, esattamente come l'aveva immaginato da dieci anni. Segui la facoltà di Legge a Torino,
che aveva qualche professore capace, e anche qualche sperimentatore di sciocchezze strutturalistiche. A ventidue anni si ammalò di
tisi e fu per morire; durante la malattia scrisse un romanzo, che usci
nel 1956: Minuetto all'inferno (Einaudi) ed ebbe il premio Strega
opera prima. Aveva parecchio stampato negli anni precedenti, sulla
rivista «Letterature moderne» di Flora e «Il pensiero critico» di Cantoni, in seguito sullo «Spettatore italiano» e infine a partire dal
1957, su «Tempo Presente». Erano saggi sui maggiori autori del Novecento, che egli tentava di riunire in una specie di luogo ideale, distante dalle contaminazioni politiche; escluse la presenza, fra loro,
di Joyce.9 Gli scrissero Eliot e Thomas Mann, per consentire.
Nel 1957 si trasferì a Roma, dove per breve tempo ebbe parte nella
redazione di «Tempo Presente». È di allora un nuovo romanzo,
Cecilia o la disattenzione (Garzanti).
La raccolta dei suoi saggi, in parte ispirati alla Scuola di Francoforte, L'eclissi dell'intellettuale (Bompiani 1959, premio Crotone), ebbe parecchie riedizioni e traduzioni. Era una negazione,
destinata a non poter essere generalmente accettata, di tutto il sistema dell'industria culturale, nel quale si rifletteva la tendenza
del pensiero nato dopo il capovolgimento hegeliano. L'opera formulava il sottinteso invito ad abbandonare il mondo quale è stato
conformato dal potere di questo pensiero: i maggiori autori degli
ultimi due secoli sono stati capaci di questo esodo.
L'anno dell'uscita di quel libro era cruciale: Zolla fu anche chiamato a insegnare all'Università di Roma, specie per intervento di
Mario Praz, e incontrò Cristina Campo, con la quale visse fino alla
mone di lei nel 1977.
Uscirono varie opere negli anni successivi, specie un'antologia, Imistici dell'Occidente (Garzanti 1963). La tradizione mistica era qui
documentata come il luogo segreto dove si era affermata nei millenni l'uniformità permanente di una metafisica immutevole, negazione radicale del mondo in quanto tale, ancor prima che esso assumesse l'aspetto moderno. Presso Bompiani uscirono i saggi succes-
sivi: Storia del fantasticare e Le potenze dell'anima. Nel 1966 Zolla
vinse il concorso a cattedra e andò nel 1967 a insegnare a Catania,
per passare quindi a Genova, dove rimasefinoal 1974, insegnando
oltre a letteratura angloamericana anchefilologiagermanica.
Nel 1968 da un viaggio nel Sudovest degli Stati Uniti ricavò una storia dell'immagine dell'Indiano, I letterati e lo sciamano (Bompiani
1969). L'opera ebbe una risonanza notevole negli Stau Uniu.10
Il periodo che andò dal 1968 al 1980 vide Zolla isolato e aborrito
in Italia dalla classe che aveva afferrato il potere; egli si dedicò a
viaggi in India, in Indonesia, in Corea e soprattutto in Iran. A poco
a poco, dopo la pubblicazione di Che cos'è la tradizione (1971) e
della vasta dissertazione alchemica Le meraviglie della natura
(1975), cessarono i rapporti con Bompiani. Rimase viva però, in
qualche modo, la collaborazione al «Corriere della Sera».11
Zolla tornò con notevoli opposizioni a insegnare all'Università di
Roma nel 1974.12 Cominciò a scrivere in inglese. Uscì in Inghilterra e in America Archetypes (1981), seguito da TheAndrogyne
(1981). Dopo il 1980 in Italia mutò la situazione politica, l'opposizione a Zolla parve in gran parte dissolversi. Egli sposò nel 1980
Grazia Marchianò. Riprese a scrivere in italiano e uscirono presso
Marsilio Aure (quattro edizioni, 1985), L'amante invisibile (premio Ascoli Piceno, 1987), Archetipi (Premi Isola d'Elba e Mircea
Eliade, 1988), Verità segrete esposte in evidenza (1990).
Aveva diretto dal 1969 al 1983 una rivista, cui fece collaborare gli
autori che gli parvero in qualche modo salvarsi dalla generale decadenza, «Conoscenza religiosa» (La Nuova Italia),13 e in quel periodo formulò la metafisica esposta in Archetipi-, essa gli parve il
dono che poteva lasciare, soluzione rigorosa e pacificante d'ogni
questionefilosofica,capace di salvare dall'influsso delle ideologie
moderne e di far partecipare alla gioia che dalla maturità in poi
egli sentì pervadere la sua vita.14
Un uomo che ha vissuto nei libri che ha scritto non può che essere
incontrato lì dentro, con la trepidazione di chi si prepara a un
cammino di cui ignora il punto d'arrivo, curioso di quel che potrà
accadere. Un viaggio dentro i pensieri e il destino di un uomo che
alla domanda «Perché scrivi?» un giorno aveva risposto: «Lo scrittore vero scrive perché scrive, ha il fine in ciò che fa come lo fa, in
modo che non può tollerare di rifare, senza nessun rapporto con
le finalità generali dell'esistenza, con le convenienze dell'economia, della politica, della moralità o dell'immoralità».15
«Scrivere» aveva aggiunto «è un atto che si profila sul nulla, un
modo di affermare, descrivere, meditare che si è sempre associato
all'ispirazione e sempre gli si è unita una pretesa infinita o nessuna
pretesa. Naturalmente esistono altre attività, retoriche calcolate,
che con lo scrivere spesso non hanno rapporto, anche se ne hanno
tutti i caratteri materiali.»16
Nel Conoscitore di segreti sì è tentato di offrire i filtri occorrenti
a scrutare il singolare edificio a più piani che fu la mente zolliana,
una mente sfaccettata come un cristallo, porosa come una spugna, così incurante del limite da riuscire a spostare i confini della
coscienza sempre più addentro, molto, molto al di là dei recinti
dell'io-persona, fino a rasentare lo stato di consapevolezza imperturbata che lo scrittore non smise di inseguire fino all'ultimo
istante. Dice la tradizione lamaista che se il morto, udendo scrosci, ululati, sussurri, «sarà preso da sgomento, paura, attrazione,
rimarrà loro vittima, loro larva martoriata, brandello di psiche infetta e contagiosa. Chi fin da vivo seppe che tutto ciò era illusione,
ne uscirà viceversa indenne [...]» si legge in un presàgo passo di Le
meraviglie della natura. Introduzione all'alchimia.17
Negli scritti dell'altro ieri così come in quelli più recenti, l'immagine di questa vasta casa mentale - «terra-cielo» come si usa
dire in Toscana di dimore indipendenti - si delinea nitida nei caratteri generali, e ne affiorano anche i tratti scoscesi di un'indole
attratta dagli antipodi: bellicosità e mansuetudine, fervore e impassibilità, freddezza glaciale e caritatevolezza, ossequio alla
norma e spirito di ribellione, cautela nei rapporti umani ordinari
e ardimento nella cognizione degli estremi, amore dell'immobilità e invincibile richiamo all'esodo, acutissimo senso storico e
consapevolezza della forza del destino, attrazione all'arcaico e voglia gioiosa di sondare il futuro.
Ognuno dei libri di Zolla, quali ne siano l'occasione estrinseca e
il tema dominante, è una ricerca e una dissertazione sui rapporti intimi e fondanti tra l'essoterico (l'appariscente tangibile) e l'esoterico
che lo anima, lo muove e ne costituisce il fiderò nascosto. «In ogni
società» scriveva negli anni Novanta «esiste uno strato esoterico. È
lì che negli ultimi secoli si sono celate, elaborate e preparate per la
conquista del mondo essoterico le varie dottrine.» E portava l'esempio del liberalismo, che fu covato dai Rosacroce, del socialismo
e del comunismo costruiti in certe logge fin dal diciottesimo secolo;
«e il fascismo ugualmente si celò in certe logge dalla fine del secolo
XIX».18 D'altra parte l'esoterico (alla lettera il «più interno») è
anche semplicemente la zona in ombra di noi stessi; la si rasenta
ogni momento e quando affiora, un'esperienza più piena della vita
ci fa trasalire.
Di queste zone d'ombra Zolla si è occupato caparbiamente, scrutandole anzitutto in se stesso e poi nei testi letterari e poetici di
Oriente e Occidente, nelle credenze e nei riti delle civiltà indigene, nei meandri della follia e nei recessi dello stato mistico, nelle
idee religiose e nei sistemi di pensiero antichi e moderni. Con padronanza enciclopedica lo ha fatto inforcando lenti specialistiche
a seconda del contesto storico e culturale osservato, e ciò non facilita certo la navigazione attraverso i suoi scritti. Qui si propone
una tra le svariate rotte possibili adottando la procedura, tutta
zolliana, di comprimere il ragguaglio biografico, con qualche
concessione in più sul periodo formativo a Torino, ed espandere
l'esame della personalità interiore dello scrittore sullo sfondo di
alcuni temi che innervano la sua opera attraverso sette decenni
del Novecento. I primi due sono l'antropologia dell'uomo infelice formulata al tempo della battaglia anti-moderna negli anni
Sessanta, e l'individuazione, che risale allo stesso periodo, della
mistica come vertice e norma dell'esperienza umana. Il terzo tema
ha il suo epicentro nel trattato sull'alchimia composto alla metà
degli anni Settanta. La poetica dell'esodo, del viaggio vissuto
come una rivelazione di archetipi domina gli scritti, anche inglesi,
degli anni Ottanta, e in quelli del decennio successivo sono nevralgici i temi del sincretismo e della realtà virtuale. Infine l'approdo al concetto di mente naturale apre la strada alla rievoca-
zione di un mito universale: la discesa e l'ascesa dell'anima attraverso i piani dell'essere in Catabasi e anastasi, l'ultima opera pubblicata in vita.19
Come fiaccole in un campo di notte questi temi lampeggiano
tutti insieme negli scritti sul destino e lo zodiaco che solcano obliquamente l'opera zolliana. La loro parziale raccolta è posta nella
sezione antologica accanto a: Saggi letterari, Scritti sulfurei, Nuove
terre cieli nuovi, Appunti sulfuturo e Epifanie.
Ogni gruppo di testi è preceduto da una nota introduttiva, ma
a proposito di Scritti sulfurei e Epifanie una parola va spesa subito.
Sono titoli che vorrebbero stenografare due tratti marcatamente
agli antipodi della prosa zolliana: la carica urticante, intimidatoria degli scritti anti-moderni e lo scorrere placido, illimpidito dei
testi sgravati dall'intento polemico. Sono timbri discordanti che
nell'opera dello scrittore cosi come nella sua vicenda personale a
un certo punto hanno cessato di stridere. Nell'ultima parte di
questa biografia si è tentato di metterlo in luce.
Nella dialettica intellettuale tra «apocalittici» e «integrati», di
cui ragionava il giovane Umberto Eco nei primi anni Sessanta,20
l'opera di Zolla, che un critico nel 1967 si compiaceva di definire
«una macchia necessaria nel nostro panorama d'idee e di scritture»,21 costituisce un «caso» senza precedenti, tutto da studiare.
I primi trent'anni a Torino
1926-1956
Nel teatro Kabuki sovente, all'aprirsi del sipario, si
è abbagliati da uno sventolio di stoffe dai colori
smaglianti, crudi. Gli attori entrano, vestiti di
panni color pastello e proprio lo sfondo sgargiante,
che s'annulla, dà un risalto a ogni sfumatura.
Volgarità e dolore
Il 1926, anno dellaTigre nel calendario zodiacale cinese, fu teatro
in Italia di avvenimenti abbaglianti come lo sventolio di stoffe nei
drammi giapponesi di cui scriveva Zolla in Volgarità e dolore nel
1962. Curiosamente nell'una e nell'altra data le ultime due cifre
sono invertite e chi è portato a notarlo può liberamente immaginare che anche i numeri nell'immensa distesa da zero a infinito si
accostino tra loro come attori sulla scena, recitando però ruoli
difficili da decifrare nella commedia umana.
Nel 1926 Benito Mussolini subisce tre attentati; vengono approvati provvedimenti per la sicurezza del regime che decretano
lo scioglimento dei partiti e di ogni associazione ostile al fascismo;
l'annullamento dei passaporti; la soppressione della stampa contraria al regime; l'istituzione del Tribunale speciale che, in via amministrativa, giudicava sui reati di spionaggio, incitamento alla
guerra civile, ricostituzione e propaganda di partiti disciolti. Il
confino di polizia diviene operante e Antonio Gramsci è spedito
a Ustica. Espatriano in Svizzera Treves e Saragat; Nenni e Turati
fuggono, rispettivamente, a Parigi e in Corsica. Per attentati ai
membri della famiglia reale e al capo del governo è stabilita la
pena di morte. Piero Gobetti e Giovanni Amendola muoiono in
seguito alle ferite causate dagli squadristi. Il fascio littorio è dichiarato emblema di Stato. L'Opera nazionale Balilla inquadra
obbligatoriamente i ragazzi tra gli otto e i dodici anni, e dai dodici
ai diciotto nelle fila degli avanguardisti. Tra quelle fila è lecito immaginare taluno abbastanza sconsolato da immedesimarsi nel
protagonista del dramma futurista citato su «Minerva. Rivista
delle riviste», il quindicinale romano di cui il giovane Zolla farà
golosa incetta molti anni dopo. La scena è occupata da un solo attore che in un crescendo, lapidariamente, grida: «Spero!» (Atto I);
«Sparo!» (Atto II); «Spiro!» (Atto III).
Fuori d'Italia eventi di pari spicco si annoverano nel 1926: in
Polonia il colpo militare del generale Pifeudski; l'ascesa al trono
imperiale di Hirohito in Giappone; la formazione di leghe comuniste in Cina orchestrate da Mao Tse-tung tra i contadini dello
Hunan; la guerra civile in Nicaragua innescata dalla rivolta liberale e l'immediato intervento degli Stati Uniti. Ma il 1926 è anche
l'anno in cui è stampata a Leningrado Biosfera di Vladimir Vernadskij, l'opera che annuncia e precorre la teoria ecologica nota
come Ipotesi Gaya. Sempre nel 1926 viene compiuto il primo esperimento di trasmissione televisiva, il comandante Nobile sorvola il
Polo Nord, e un pastore svizzero, Felix Grosser, in una sua memoria su una rivista di storia delle religioni1 dà il via a una querelle che
coinvolgerà il fior fiore dei classicisti europei quando gli scavi
nella villa di Paquino Proculo a Pompei porteranno alla luce un'iscrizione latina in cinque parole: SATOR AREPO TENET
OPERA ROTAS.
Quelle cinque parole inscritte in un quadrato, possono essere
lette indifferentemente dall'alto in basso, dal basso in alto, da sinistra a destra e viceversa. Il motivo è che quattro di esse - «sator»,
«rotas», «Arepo» e «opera» - sono a specchio, e la quinta situata al
centro, «tenet», è palindroma, cioè speculare di se stessa. Sicché la
scritta: «Il contadino Arepo governa con fatica le ruote (dell'aratro)» si prestava a congetture che vanno molto al di là del signifi-
cato letterale. Nel modo in cui era costruito, il blocco faceva pensare a un quadrato magico e Grosser nel 1926 vi scorse «l'anagramma del Pater noster ripetuto due volte o di due A O (alfa e
omega)». Così scriveva Elémire Zolla in un articolo sotto pseudonimo quarantanni dopo.2 E mentre segnalava che esemplari
identici del quadrato magico erano stati rinvenuti in Mesopotamia, in Inghilterra e in Cappadocia, avanzava l'ipotesi che la formula latina potesse nascostamente riferirsi alla visione del profeta
Ezechiele tratto al cielo su un carro di fuoco le cui ruote «potevano muoversi in quattro direzioni, senza aver bisogno di voltare
nel muoversi» {Ezechiele I, 15-16).
Si tornerà più avanti sull'ipotesi avanzata in quella occasione
da Bernardo Trevisano, pseudonimo che Zolla adottò nei primi
anni del periodo romano firmando con quel nome un fascio di articoli sul «Giornale d'Italia». L'ombra del quattrocentesco Bernardo Trevisano, conoscitore di segreti metallurgici, continuò ad
aleggiare sugli scritti zolliani di alchimia pubblicati in seguito
seppure il vero motivo dell'identificazione con l'alchimista del
Quattrocento non venne mai esplicitato.
Fu dunque durante il quinto anno del Regime che a Vincenzo Venanzio Zolla ( 1880-1961 ), pittore di radici vigevanesi, nato a Colchester (Inghilterra), e a Bianche Smith (1885-1951), un'inglese
del Kent, nacque un secondo figlio, Venanzio Elémire, sedici anni
dopo la primogenita Eda Doris. Il parto, il 9 luglio 1926 avvenne
a casa in via Massena 85, alle 10,15 del mattino mentre un eclissi
parziale di sole offuscava il cielo a Torino.3 Il primo ritratto a carboncino di Elémire, così chiamato dal padre in omaggio al romanziere francese Elémir Bourges,4 è datato 13 luglio, quattro giorni
dopo la nascita. Il piccolo, visto di profilo, se ne sta ad occhi chiusi
raggomitolato su se stesso. Venanzio Zolla, diplomatosi all'Accademia Albertina di Belle Arti a Torino e allievo di Vincenzo
Grosso, in quegli anni ha uno studio avviato di maestro d'arte. Dipinge ritratti, paesaggi e nature morte alla maniera degli impressionisti e le avanguardie non lo interessano. Frequenta pittori,
come Domenico Buratti, di tempra forte e riservata quanto la sua
ed è sempre sul punto di piantare tutto e correre per mostre a Londra o Parigi. Uno dei libri più annotati della sua biblioteca privata,
L'arte cortese di crearsi nemici5 fece epoca a Londra a fine Ottocento
per la spregiudicatezza con cui un pittore eccentrico e spavaldo
come James Abbott McNeil Whisder aveva impugnato le dichiarazioni diffamatorie sul suo scarso talento artistico da parte di Ruskin, il pittore e celebre critico, durante un chiacchieratissimo processo a Londra senza risparmio di colpi dall'una e dall'altra parte. Il
libro che aduna gli atti della gustosa controversia nell'edizione originale Heinemann del 1908, fittamente annotato e colmo di disegnini in punta di penna di Venanzio Zolla, non deve essere sfuggito
all'occhio penetrante del figlio Elémire negli anni in cui prendeva
coscienza del sistema di mosse alla base della partita della vita.
Venanzio Zolla, a quanto risulta, fu un marito e un padre
quanto meno distratto. Di natura indocile, protervo, agnostico,
meticoloso e bohémien, non s'illudeva su ciò che può concedere
un'esistenza ancorata al capriccio dei mercanti d'arte e all'uggia
dei doveri familiari, e ai suoi congiunti badava il minimo necessario. Bianche, sua moglie, era una donna impettita, orgogliosa, incline, nelle situazioni sgradevoli, a barricarsi in un tetro silenzio
piuttosto che dar sfogo ai suoi sentimenti (pare che da bambina
fosse stata sonnambula). Adattarsi a parlare una lingua non sua in
una città che non le andò mai a genio, e trovarsi a quarantanni a
mettere al mondo un secondo figlio, per di più gracile e di salute
cagionevole, forse non era il massimo delle sue aspirazioni. Per
fortuna, suonava bene l'organo e il pianoforte. Dava lezioni nel
salotto di casa e la sera, in qualche cinema cittadino, accompagnava al pianoforte le proiezioni dei film muti. Talvolta portava
con sé Elémire. Acquattato nella sala in penombra, le vicende
sullo schermo sottolineate dai passaggi al piano lo ammaliavano
ma un istinto suggeriva al bambino di non farsi catturare, di prendere le distanze. Lo studio di Venanzio Zolla, al piano superiore
dell'appartamento di via Pesaro dove la famiglia era andata ad abitare, è un via vai di modelle, acquirenti, mercanti e la parlata torinese dai toni melliflui e aspri s'incide nell'orecchio del piccolo
Elémire. Il padre ritto al cavalletto, la pipa spenta di traverso in
bocca, asseconda i movimenti della mano con ogni muscolo del
corpo, ma è dal polso a scatti impercettibili che germogliano le
pennellate e a poco a poco nasce il quadro.
Giù da basso le allieve della mamma incespicano con le dita
sugli esercizi di Czerny al pianoforte; il bambino, cheto cheto,
ama sedersi non visto dietro la porta: verrà il momento in cui
l'onda dei suoni lo avvolgerà in un abbraccio trepido, colmo di lacrime, ma lui imparerà a essere il guardiano piuttosto che lo
schiavo della propria commozione.
L' Omaggio a Chopin - avrebbe poi ricordato - sembra parlare
della tenebra che pervade il corridoio. Una tenebra che la luce, pur
penetrando fin 11, non dissipa. [...] In qualche modo capisco che
devo prestarmi a patire gli esitando, le note puntate del tempo rubato, non devo oppormi alle lacrime, soltanto così potrò gettarmi
nello scintillante tripudio di accordi che scandisce la marcia dei
seguaci di Davide, simile a quella dei puttini danzanti sotto l'orologio dorato sul camino.
Sul tavolo del salotto, sotto le rose, accanto alle ciambelle, la teiera
mostra un argento spento, appannato dal tempo. Mentre mia
madre sta suonando, il tè intride l'acqua e le toglie la crudezza.
Tutto si sacrifica, le foglie di tè, la luce, le superfici brillanti, i suoni
che debbono reggersi come uccelli sospesi, isolati fuor del tempo
[...] Delle foglie di tè resta l'essenza, della voce il nucleo; il pedale
è usato appena appena [...] la luce non deve erompere [...] il mio
cuore è libero di espandersi nello spazio enorme che così si apre,
può diventare fiero, incurante. Inoltre, poiché tutto attorno a me
si ritrae, imparo a compormi.6
Alle elementari nell'Istituto Ferrante Aporti, il ritegno instillato
in casa fa di lui uno scolaro modello. L'unica intemperanza sarebbe stata il lancio di una lavagna sulla testa di un compagno sospettato di averlo tradito preferendogli al gioco qualcun altro.
Quando Elémire ha nove anni, Venanzio Zolla, con una decisione repentina che scombussola la famiglia, liquida i suoi affari a
Torino e s'installa a Londra. A cinquantacinque anni la Royal
Academy gli apre le porte, dipinge, espone e vende fitto, ma l'inverno 1936 è duro e insieme alla polmonite si becca un'anemia
perniciosa. All'arrivo della primavera la soluzione più ovvia sarà
fare marcia indietro. Prosciugati i risparmi fino all'ultima goccia,
come nulla fosse rimetterà su casa e studio a Torino.
A Maidstone, nel Kent, i genitori di Bianche hanno una casa
con un piccolo frutteto. Elémire vi trascorre qualche mese e accanto al nonno si trova bene. Non ha niente da fare e al vecchio si
accompagna volentieri. I silenzi e le parole del nonno ritmano le
ore della giornata e il bambino le assapora momento per momento in una ronda senza strappi, uniforme. Una di queste trasognate memorie affiorerà in un elzeviro sul «Corriere della Sera» intitolato Lezione di verità nella stagione in cui il Premio Strega attribuito al primo romanzo e il rumore suscitato dalla prima opera
saggistica di critica sociale, avevano fatto di Zolla lo scrittore più
in vista, corteggiato e poco dopo detestato, nei circoli intellettuali
della capitale. Senonché quell'elzeviro pare scritto da tutt'altra
persora rispetto al saggista che aveva sfidato l'establishment dichiarando una guerra senza quartiere all'industria culturale e al
progressismo moderno. Lezione di verità, nel contenuto e nel
tono, è la cronaca della giornata trascorsa da un bambino che impara a riconoscere i sapori delle mele che il nonno gli porge. La
maschera del narratore cinico, del moralista invelenito, in questo
brano è deposta, e ne affiora una creatura imbozzolata nella quiete,
docile all'insegnamento impartito con naturalezza dal vecchio, decisa a respingere tutto ciò che di brutale e sgangherato filtra dal
mondo di fuori. È un brano letterario di squisita bellezza che introduce, meglio di qualunque descrizione, nello spazio interiore
del protagonista immerso nel ricordo di sé bambino.
Il vecchio coglie una mela grassa, la mostra al fanciullo, aiutando
l'occhio a posarsi sulla superfìcie, tracciandone la forma col dito.
Proprio l'imbarazzo per la lentezza del gesto è una forza che costringe il fanciullo a seguire il tocco del dito sulla scorza, ruvida
quasi al punto di raggrinzirsi.
Mentre il fanciullo mangia la fetta tagliata dalla mela che con tanta
meticolosità era stata prima considerata, il vecchio gli dice: «È una
mela cotogna», e s'incammina verso un altro albero, spiccandone
un altro frutto, mostrandolo dopo averlo lustrato sulla manica affinché restituisca limpidamente tutta la luce che può; dice: «Una
mela limoncella», invitando a paragonare i sapori, la cui diversità
appare straordinaria al fanciullo perché non s'aspettava di scoprirla, avendolo il vecchio preparato all'esercizio del gusto con
quello degli occhi, usando cioè d'una finta, tanto che insensibilmente il palato si apprestava a emulare l'attenzione della vista, nella
misura in cui non era chiamato con un ordine a prodigarsi. La differenza appare ancora più vasta, come fra due case o due ore della
giornata, perché nulla ha distratto il fanciullo, non una parola superflua né un sorriso di ingiunzione o esortazione, e neanche un
soffio d'aria, essendo molto silenzioso il tramonto alla villa.
Il vecchio procede nel verde diventato, col progredire della sera,
un grigio granuloso, ripetendo i gesti di prima a spiegare la varietà
di altri meli. Passare nello stesso attimo dall'agra e rossa lazzcruola
alla renetta, il cui sugo è più serrato che aspro, dà una sorpresa
come piegare per una strada e vedere un paesaggio insospettato, o
come volgersi dalla conversazione con una persona ad altra di qualità opposta e della stessa natura. È come oltrepassare un confine
ignorato fino a prima, a prova che l'avventura promessa da una
qualsiasi frontiera non è che la ripetizione grossolana di avventure
possibili all'interno del limite (dentro la villa, dentro di noi), tanto
che per laricchezzadi ciò che può presentarsi nella aiuola dove ci
si trova (quando siano favorevoli il silenzio e una voce amica, vecchia, indifferente a ogni effetto) si trascurano le provocazioni del
mondo di fuori, cessa la curiosità fredda e tetra per ciò che avviene
nei tratti della vicina campagna dove cresce il luppolo e dove vagano, alla raccolta, sguaiati cittadini venuti apposta, la domenica,
pagati dai birrai (dicono che l'odore del luppolo, soave quand'è
disperso per l'aria, sia forte come un fermento quando si raccoglie
nelfittodelle piante e dia la confusione e demenza della ebbrezza).
Ma se il fanciullo rientrando nell'aria un poco più fresca e severa
della casa dopo il tepore dell'orto dove il sole ristagna, seguendo il
vecchio verso la poltrona, [...] si sente di una potenza sconosciuta
dianzi, di una potenza che stringe in fascio le facoltà acquistate nel
breve passeggio serale, ciò avviene perché egli ha, in questo momento, ereditato dal vecchio, e proprio la gioia più rara che quegli
abbia acquisito nella sua vita.
Il fanciullo è tornato a sdraiarsi sul tappeto come a leggere, e presto legge davvero, poiché avrà l'intera vita per assortire le varie
cose apprese in quest'ora che il vecchio ha innestato con cosi capricciosa apparenza nella giornata, quasi a renderla insieme singolare e quotidiana. Nella memoria il fanciullo comincia, senza avvedersene (per il suo bene, poiché a esserne coscienti si impedisce
un'opera cosi tortuosamente delicata), a comprendere che soltanto facendo leva si agisce virilmente. [...] Più tardi questo insegnamento si ramificherà, ma forse soltanto quando la pelle comincerà a ispessirsi come quella del vecchio; si esprimerà anche a
questo modo: «Non è facendo leva su ciò che ti proponi principalmente che otterrai un effetto, come il pittore non ribadisce
quest'ombra, ma schiarisce quella luce, non incupisce questo
verde, ma stempra quel giallo all'angolo opposto del quadro. Così
non t'illuderai che quando provi disagio, insofferenza d'un
aspetto della tua o dell'altrui vita, basti modificare quel sintomo,
ma saprai di dover spezzare tutta una costellazione occultamente
maligna, poiché non sarà un lavoro che ti attedierà, ma tutto l'insieme della tua esistenza che ti ha orientato ad accettare quel lavoro, non sarà mai quella donna o quell'amico che ti riusciranno
dannosi e che basterà allontanare, ma l'errore, la falsa persuasione
con cui hai giustificato l'accostarti a loro [...]».
La cosa più semplice e più difficilmente esprimibile che il vecchio
aveva comunicata al fanciullo era un'altra. I raccoglitori di luppolo, le cui voci s'udivano portate dal vento, erano pervasi dalla
stessa vita che animava, come un fuoco covato da braci, la dimora
del vecchio e del fanciullo, ma in quelli il fuoco era aspro, come
chiuso efischiarnein un ceppo ancora bagnato. [...] Se mai li si accostava e li si ascoltava, si sorprendeva che erano senza gioia, tanto
più quanto atrocemente ridanciani, tetramente privi di riguardi
l'uno per l'altro, sicché mai avrebbero neanche potuto indugiare
ad assaporare una mela per coglierne la natura singolare, ma soltanto per divorarla, incorporarla, né avrebbero posto attenzione
ad una mela se non per comprarla o venderla con vantaggio. [...]
La loro vita era più triste della mone, senza quiete perché priva di
quella facoltà assai affine all'amore che distingue con cura l'anima
di una mela da quella di una diversa mela. Senza volere essi mentivano, cioè non erano capaci di denominare con pazienza, nulla aggiungendo o non dando alcun colore; dovevano infatti, come allettati da un turpe piacere, ingrandire, rimpicciolire, come specchi
deformanti, ogni cosa di cui dessero ragguaglio.
Così attraverso il paragone del vecchio con quegli altri anziani immodesti, che raccoglievano il luppolo, il fanciullo, come lui stesso
avrebbe saputo di lì a qualche decennio, scopriva che il vecchio,
portandolo sotto i meli, gli aveva insegnato a dire la verità.7
Ai raccoglitori di luppolo evocati in quella pagina si sarebbero sostituite in seguito, nella percezione adulta della vita, entità più
complesse e minacciose: il sistema coi suoi ingranaggi, la società
con le sue trappole, le sue ipocrisie ben mascherate e occorrerà
escogitare tattiche di aggiramento, evasioni strategiche. Il saggio
Invito all'esodo, di poco posteriore all'elzeviro sul «Corriere della
Sera»,8 mette in chiaro i motivi di una decisione che, a Roma,
verso i trentacinque anni diverrà irrevocabile: uscire «dal giro
della ruota», balzare contro corrente, saltar via.
Torniamo intanto a Torino. Tra la prima infanzia e i vent'anni
quando la tubercolosi minacciò di condurlo rapidamente a morte,
Elémire Zolla (d'ora in poi sarà indicato spesso con le iniziali) ebbe
modo di aprire gli occhi quanto basta sulle afflizioni della vita per
decidere di prendere misure radicali al riguardo. L'ingresso nelle
configurazioni del mondo era una faccenda delicata. Comportava rischi, tormenti, azzardi e una preparazione meticolosa era
necessaria su tutti i fronti. All'origine delle smisurate conoscenze
di EZ ci fu la percezione nitida, inappellabile che senza il sostegno
di un ingente sapere la battaglia personale della vita, ingaggiata in
circostanze sfavorevoli, aveva scarse probabilità di essere vinta.
Negli anni della scuola dell'obbligo,9 è uno studente deciso a
trarre il massimo dalle ore spese sui libri. L'inglese e il francese,
parlati in casa come l'italiano, lo spingevano a tuffarsi in altre lingue, lo spagnolo e il tedesco saranno le prime. In certi periodi,
ogni mese dell'anno scandiva l'affondo in una distinta letteratura.
Gennaio: portoghese; febbraio: turca; marzo: spagnola; aprile e
maggio: scandinava e via di seguito. Due, tre volte alla settimana
c'erano le soste in certi caffè frequentati dal padre dove una saletta
apposita offriva un assortimento di periodici non italiani. Alla
radio le voci bene impostate degli speaker della BBC lo proiettavano fuori delle strade mortalmente rettilinee di Torino, delle
aule impettite e grigie dell'ateneo sabaudo dove s'era iscritto alla
facoltà di Legge.
All'inizio l'entusiasmo per quella scelta non era stato straripante. Però ci si trovava e in men che non si dica la decisione salomonica fu presa: avrebbe frequentato tutti i corsi che gli fossero
garbati nell'intero ateneo. Incominciò da Lettere e Filosofia e le
lezioni delle materie filosofiche furono le più seguite, nessuna
esclusa. Anni dopo, con gusto, ricorderà certe private conversazioni con un eminente professore di teoretica preoccupato che
quel giovanotto, dietro l'abituale sarcasmo, nascondesse la reticenza di chi non osa affrontare i turbamenti di un forte peccare.
«Beva!», «Vada a ballare!» lo aveva incitato tra un rinvio a Novalis
e una citazione di Schelling.10
I corsi di storia e letteratura lo catturavano blandamente. Infatti fin da bambino, con un puntiglio che persino al padre, notoriamente indifferente a quanto il figlio pensasse o facesse, non
era sfuggito, si era passato a tappeto la storia mondiale di popoli,
epoche e Paesi, e lo stesso era accaduto per le letterature dei cui
testi si era pasciuto direttamente. Senonché l'ingresso negli studi
giuridici fece scattare nella sua mente connessioni alle quali difficilmente avrebbe badato senza la lettura di talune dispense e
un tirocinio piuttosto speciale assieme agli studenti di psichiatria. Sul tavolino della stanza in via Pesaro, accanto ai testi di storia e fenomenologia del diritto, presero posto le dispense di medicina legale di Mario Carrara e di psichiatria forense di Carlo
Ferrio. Queste ultime (ridotte oggi a larve di carta) iniziano dalla
definizione, in corso allora, di amenza: «sconvolgimento tumultuario dei processi ideativi e della percezione, capace di disorientare la personalità e ottenebrare la coscienza anche fino a
spegnerla».
Gli studenti prendevano appunti sulla dinamica di ogni caso
illustrato dal professore, e lo stesso avveniva nel corso delle visite
ai reparti dell'Opera Pia Ospedali Psichiatrici e della Piccola Casa
del Cottolengo dove, accanto a pazienti affetti da gravi malformazioni fìsiche, erano ricoverati oligofrenici, epilettici, dementi
dei tipi più disparati.
Molte delle sue osservazioni EZ le annotava in margine alle dispense, e chi si trovi a sfogliarle sessantanni dopo è come se piombasse di punto in bianco in un girone infernale dove echeggiano
urla, si biascicano monologhi a voce atona, rimbombano «passi
musicali», stormiscono «alberi parlanti», spuntano dalle pareti
«fiori animati» ed eserciti di gendarmi, mostri, pigmei ammiccano
dal soffitto a testa in giù.
L'ideorrea (flusso verbale incontrollato) di un paziente incline
a esprimersi in francese, era stata annotata parola per parola:
«"Che cosa c'è? Hm!" guarda un angolo buio. "Les dieuxencage!
Ily a des Dieux là dedans!Ils ont lespieds dans les espaces. Qu'est-ce
qu'ils ont diti Une peau d'hippopotamepour la Tsarineì Va' a farti
monaca! Les capucins! Mia moglie è trattata come una schiava,
anzi come un tritone [...]"».11
«In momenti di occasionale lucidità» annotava EZ «certi pazienti tendono ad attribuire i loro deliri a una coercizione misteriosa. Una frase come: "Satana mi tormenta ma io niente" può essere mormorata senza intermissione per giorni, mesi, a volte anni.
«Un ricoverato rimugina: "Angelo Nosso dubita o meglio crede
che l'uomo sia provvisto d'anima deducendo la sua teoria dagli
esperimenti sulle Alpi. Baccelli al contrario ammette la vita come
produzione della forza muscolare. Preferisco il secondo".»
In margine a un vecchio articolo della «Rivista sperimentale di
freniatria e di medicina legale» del 1889 EZ, evidentemente at-
tratto dall'aspetto linguistico della malattia mentale, trascriveva: «Il 30% dei paranoici fabbrica neologismi, e al 90% si
tratta di sostantivi. Alcuni esempi: "Ape di coscienza", "Calabrone salvatore", "Alveatico". A proposito di quest'ultimo termine un degente nel manicomio di Imola aveva fornito il seguente ragguaglio: "C'è una nube che avvolge la testa del malato
e lo trasforma in un altro mercé la conquitescenza mirtica dell'alveari«)".»12
La retrocopertina delle Lezioni di psichiatrìa forense è lacerata
in più punti ma la trascrizione della lettera ai genitori di un'ebefrenica si legge ancora:
Torino, 12 maggio 1950
Nella riunione di costì possiamo avere sul saggio di questi mesi la
conclusione, su questo fermato incosciente da voi genitori, se avrò risposta in proposito mi unirò alle vostre riconoscenze, che vi premono e così saremo sugli affari nostri senza disturbi continuamente.
Certa che la più degna vi sarà da guida per la mia conoscenza vi
aspetto.
Un'altra annotazione riguarda un malato che «si tratteneva dal distribuire elemosine temendo di diffondere veleno». Costui era
persuaso che «zappando squarciasse il seno alla Madonna;
quando gettava la fiocina nel fiume gli pareva di sollevare dal
fondo le sue creature e di veder galleggiare le loro viscere».
Negli anni in cui lo psichiatra Mario Tobino stilava il diario poi
rielaborato ne Le libere donne di Magliano (1953) il problema se
la follia - per citare le sue parole: «sia solo un misfatto della società, frutto di storte leggi e non invece una solenne misteriosa
tragedia» - si affacciava titubante, svestito della prepotenza che
avrebbe assunto decenni dopo con la crociata Basaglia. Tra le storie narrate con mano felice in Per le antiche scale una, in particolare, illustra in maniera perfetta le atmosfere dell'epoca in cui EZ
assorto negli studi giuridici, bazzicava con gusto Psichiatria. Riguarda il caso del Federale A.
Nel bel mezzo di una solenne adunata — racconta Tobino — il Federale A. di punto in bianco aveva scoperto il vuoto universale, il
nulla assoluto e in perfetta conseguenza, l'irrealtà del Duce.
In maniera sommessa il Federale era stato accolto nel manicomio
circondariale sotto la diretta sorveglianza del direttore, il Dottor
Anselmo. Nel suo diario quotidiano il dottore registrava le condizioni, peraltro tranquillissime, di quel paziente speciale, il tenore
dei dialoghi con chi, clandestinamente, lo andava a visitare, una
volta il suo Vice, un'altra volta la moglie. Un giorno che costei
andò a trovarlo: «Il federale appena la scorse immediatamente si
animò apostrofandola: "Figurati se esisti, tu! Non ci sono i grandi,
sono meno che foglie secche, non esiste il Duce e tu ti presenti che
non sei nemmeno una larva"».
«Ma, Riccardo!?» e sul volto le si impietrì il ghiaccio della delusione.13
L'impassibilità che nemmeno i santi, i liberati in vita, possiedono
stabilmente, per molti psicopatici - EZ si convinceva - è la norma,
e nella botte di ferro di silenzi o discorsi senza capo né coda, stanno
al sicuro. In un appunto in margine alle dispense di medicina legale annotava: «La psichiatria tratta le difese dal male mentale formulate dalla diagnosi, quindi il gioco linguistico sovrammesso ai
gesti o alle parole [...] pietrificati, sottratti al loro fluire e assunti nel
sistema, nel complesso di distinzioni del diagnostico».
L'interesse per la malattia mentale faceva presagire che l'argomento
della tesi di laurea sarebbe rientrato in quella materia. Ma così non
fu per due ragioni. La prima, coercitiva, era stata la tubercolosi. Dei
lunghi, stremanti, reiterati soggiorni in ospedale14 sopravvive una
traccia nella vicenda di ricovero, delirio e coma vissuta da Lotario
Copardo, il protagonista di Minuetto all'inferno.
Per oltre tre anni la ferocia della tisi scombussolò la vita di EZ
e gli studi universitari subirono un arresto. Solo quando le sue
condizioni migliorarono, la tesi di laurea fu portata a termine in
una materia però estranea alla medicina legale. Nella sessione
straordinaria dell'anno accademico 1952-1953, la matricola di
giurisprudenza n. 15077 discuteva una tesi dal titolo: Le compensazioni private egli affari di reciprocità nel diritto commerciale (relatore il prof. Paolo Greco).15
Come mai la scelta dell'argomento, presumibilmente affrettata, cadde sul diritto commerciale? Sebbene non sia dato accertarlo con precisione, un episodio ricordato in famiglia può offrire
un curioso indizio. Viene qui riferito con un accenno di affabulazione.
Un giorno Venanzio Zolla trova Elémire alle prese con gli scartafàcci giuridici nella sua stanza. Per una volta la curiosità lo arresta sulla soglia e in inglese, com'era solito fare in particolari occasioni domestiche, domanda al figlio: «Ragazzo mio t'inzeppi la
testa di questa roba, che utile te ne aspetti? Per quanto mi riguarda, so una cosa sola: perdi, vinci, mercanteggi, tiri sul prezzo,
è la vita. Un pittore ci fa l'abitudine. Tu, è evidente, sei portato all'astrazione, ti pasci di teorie... Vuoi sapere la teoria mia? Eccola:
la convenienza. E che vantaggio si trae ad applicarla? Tenere a
bada le truffe».
EZ, come d'abitudine, l'aveva ascoltato in silenzio, appuntandosi a mente le battute. Un pomeriggio di tre anni dopo padre e
figlio s'incrociano in casa di nuovo.
«Mi sono laureato stamattina» dice Elémire distrattamente.
«Ah sì, e in che?» replica il padre con lo stesso tono distratto.
«Diritto commerciale.»
«Vale a dire?»
«Oh! Niente di speciale» minimizza lui. «Immagina Tizio che
incarica Caio di far credito a Mevio e resta truffato. Quali sono le
implicazioni in materia di diritto commerciale. Tutto qui, un'amenità.»
Nessuno saprà mai se la scelta di quell'argomento per la tesi di
laurea fu influenzata dalla lezioncina sulla convenienza e la truffa
ammannitagli dal padre quella volta. È pur vero che, almeno
prima di cadere malato, i corsi del professor Greco erano stati frequentati con assiduità, e al giudizio del docente erano state sottoposte alcune tesine. Una di esse, sul tema della censura, battuta in
tre pagine su una portatile, sopravvive tra le carte di allora. In
margine al primo foglio a sinistra, l'annotazione a matita del professore è ancora nitida: «Molto bene. Specialmente la seconda
parte. Il principio è formalmente un po' involuto, a differenza
della seconda parte, cha ha la immediatezza che l'argomento e il
tono richiedono».
Qui e là il lavoretto anticipa posizioni che acquisteranno spiccato
rilievo nel ciclo saggistico di critica sociale nel periodo compreso
tra il 1959 e il 1971.1 passi della tesina che prefigurano temi di
punta di L'eclissi dell'intellettuale sono stati evidenziati in corsivo.
È pensabile un'abolizione della censura o della persecuzione dell'oscenità? È difficile rispondere di si: le offese alla sensibilità sono
cocenti quanto le offese al corpo, assai più, anzi.
Già è scarsa l'efficacia delle leggi poste a difesa del civile decoro, poiché bisognerebbe essere vissuti imbozzolati in riguardose famiglie e
convivenze eccezionali per non essere stati lesi infinite volte dall'oscenità, dal turpiloquio di prammatica nelle convivenze di massa.
Riesce difficile immaginare che oggi negli eserciti, nelle fabbriche,
negli uffici si sia liberi dall'oppressione del turpiloquio di cui parlò
con cosi sublime accoramento il colonnello Lawrence in The Mint.
Guai se almeno molto di lontano non soccorresse il pallido appoggio della legge, per cui almeno in certi luoghi si è garantiti dal
dilagare del linguaggio e dei modi teppistici.
Ma la sensibilità sociale è unfantasma, difficile da definire, pretesto
d'ogni arbitrio, specie in ragione del vizio borghese diritenereche
certe cose siano lecite o meno a seconda del momento (lecito inveire
contro una recluta, illecitoripeterele stesse parole dinanzi alla propria madre). [...] Ciò che desta sgomento è l'applicazione della
censura o del sequestro a opere d'arte o che si propongono di esserlo. È chiaro che soltanto in una società migliore si potrebbe sperare di fare a meno dell'opera dei tutori della legge, già oggi non si
può restare non offesi da certi cartelloni pubblicitari, specie di film.
Ma ciò che indigna è che la censura non ha mai perseguitato la volgarità offensiva con il fervore con cui s'accanisce contro le opere d'arte.
Ifilmpiù abietti circolano senza difficoltà, i bambini vengono abi-
tuati a lazzi ripugnanti, a violenze oscene senza che alcuno li difenda purché lo spettacolo non minacci di farli ragionare, criticare,
giudicare. È ilgiudizio dunque che si vuole estirpare, non l'oscenità.
Quest'ultima questione avrà ampio sviluppo nell'ultima parte di
Volgarità e dobre dove a proposito della «critica come gesto»,
Zolla scriveva:
Principio della critica è il gesto di gioia, di orrore, di riverenza che
l'opera suscita.
Critica è rispondenza, antifona, cioè pane dell'opera stessa, sua prosecuzione, pertanto crescita del testo originario. Critica negativa è
l'indifferenza, il silenzio, e tanto è negativa la critica che prodiga
elogi ma non manifesta passione quanto quella che freddamente
mostra le mende dell'opera. Critica positiva è tanto quella fetta di
improperi e denigrazioni, che sono gesti d'allarme e scongiuro,
quanto quella che appassionatamente riverisce a mani giunte sotto
specie di lodi (p. 161 dell'edizione originale Bompiani 1962).
Gli studi giuridici erano andati di pari passo con imperterriti,
straripanti esercizi letterari, e il motivo è semplice: in assenza di
alternative alla vita che conduceva, abbandonarsi ai piaceri della
scrittura in camera sua era l'unico modo di evadere da fermo.
Ogni altro piacere al confronto gli appariva scialbo, un analogo
in perdita.
L'esordio ufficiale a ventun anni era stato con un libro filosofico di 200 pagine, Saggi di etica e di estetica, pubblicato nel 1947.
La tipografìa delle Edizioni Spaziani si trovava proprio accanto all'abitazione di via Pesaro. Lo stile cincischiato, un tantino pedante, evocava arti intorpiditi, ali che stentano ad aprirsi, occhi
disawezzi a bagni di luce ma presto uno stile letterario sarebbe
emerso in un romanzo «satanico» non solo nel titolo, concepito a
ridosso dell'attacco di tisi mentre la madre, anch'essa malata, si
avviava a morire.16 Di Minuetto all'inferno, dell'inspiegabile fortuna che arrise a quel romanzo, e dei racconti di poco posteriori,
si dirà fra poco. Intanto vale la pena riferire l'occasione che fece
venire a galla un tema tra i più indigesti e spinosi del pensiero di
Zolla: l'idea di persona. Un'idea che elaborata, riconfigurata in
mille maniere rimase centrale fino agli ultimi anni. In un testo del
1995, L'inganno del nome, si legge: «La persona è "fatta" del nome
proprio, sorge originariamente come trovata stregonesca».17
Un'affermazione che gli studi antropologici confermano in
pieno, senonché si stenta a farla propria e soprattutto da parte cattolica suscita accanite obiezioni: è mai possibile smentire che «io»
sono e resto me stesso da quando nasco fino all'ultimo respiro?
Ma EZ lo sconfessava: quante volte aveva scorto d'attorno
«corpi che mutavano facilmente di padrone, che nascondevano
una parte segreta a loro stessi: un cibo bastava ad alterarli o un
goccio di liquore».
Nel corso della vita svariate «persone» si erano avvicendate
dentro di lui. «Chi ero io?» si domandava ne Lo stupore infantile:
Potevo dar ordine alle lacrime di accalcarsi alle palpebre, alle risate
di scuotermi il petto e tuttavia rimanere indifferente, lontano. Una
passione sembrava a tratti dominante, ma dentro di me sapevo che
mai lo era. Così sentivo piene di sentimenti ascoltando la musica,
vibravo come un fuscello al trepido vento dei tempi rubati, piangevo calde lacrime, eppure non ero propriamente io a ferio. Era
una mia parvenza. Ma era anche una parvenza l'osservatore freddo
e distante. Osservava in me lo scorrere di una coscienza che non ero
io, era anzi nitidamente distinta da me quale mi conoscevo e quale
apparivo. Non era né me né fuori di me [...]. E quanto ai sentimenti e ai pensieri che mi si facevano incontro, che via via affioravano, fino a qual punto erano veramente miei? [...] M'accorsi ben
presto che potevo appassionarmi a una compagna o anche a una
persona adulta o a un gioco. Potevo perderci la testa e ritornare in
me dopo un certo tempo. Ma chi ero io? L'entusiasta o l'osservatore? Lo stregato o colui che notava il rapimento e l'ebbrezza?18
In seguito la meditazione su questo arcano s'era estesa al rapporto
tra la persona e il suo nome, un nome che, una volta ricevuto, le
aderisce come un sigillo.
«Nelle civiltà d'Occidente il battesimo» rifletteva «accompagna il conferimento del nome; l'immersione più o meno metaforica nelle acque in condizioni di nudità è una riconvocazione
della prima fase cosmogonica: ci si reimmerge nel puro suono di
acque correnti, frusciami, nell'origine sonora dell'universo visibile e contemporaneamente si riceve la denominazione: si nasce
nella parola che ci denoterà.» D'altra parte, fuori dell'Occidente
cristiano l'annuncio che la persona è una maschera del vuoto era
attecchito in una terra, l'India, predisposta ad accoglierlo. E dall'India drappelli di monaci buddhisti si erano irradiati «a divulgare la notizia nell'Asia centrale, in Cina, in Giappone e ancor
oggi una vasta parte dell'umanità riceve il loro insegnamento».19
Se la convinzione che l'io-persona sia una parvenza aveva preso
radici fin dalla fanciullezza, curiosamente erano stati gli studi di
giurisprudenza a mettere lo scrittore su quella strada molto prima
d'incrociare la teoria buddhista.
Il primo indizio documentato di un esplicito interesse alla teoria della persona risale al 1948, esattamente un mese e mezzo
prima del ricovero all'ospedale San Giovanni Battista Città di Torino per tubercolosi bilaterale diffusa.
Nella primavera di quell'anno il «Times Literary Supplement»
aveva pubblicato un esteso articolo sul concetto di «persona»,
quasi una monografìa, del teorico del diritto H. C. Dowdall.20
Poco dopo al giornale era pervenuta una lettera da Torino firmata
Elémire Zolla. Attraverso una ricognizione storica dello sviluppo
dell'idea di persona, con tanto di riferimenti che spaziavano da
Plotino a Hume a Pufendorf a Vico, lo studente di giurisprudenza sosteneva che «persona» lungi dall'essere una realtà ontologica, è piuttosto una contingentpractical construction: an institution («un costrutto contingente che risponde a fini pratici: una
istituzione»).
Colpito dal tenore della lettera che il giornale inglese pubblicava il 23 ottobre, Dowdall replicava con una disquisizione imperniata sui nessi tra il concetto di persona nel diritto arcaico e il
dramma greco-romano dove gli attori indossavano maschere.
Questo ragionamento non solo accoglieva la tesi di EZ ma in so-
stanza la rafforzava. Intanto un altro storico del diritto, P. W. Duff,
interveniva sulle pagine del «Times Literary Supplement» con
proprie argomentazioni e il risultato fu che tutti quegli interventi
(di Dowdall, Duff, Zolla e la replica di Dowdall a costui) furono
riuniti e pubblicati in un libriccino che Dowdall ebbe la gentilezza
di inviare al giovane torinese con una dedica.21
C'è poi dell'altro. Un mucchio di annotazioni rinvenute in un
vecchio quaderno toccano un punto specifico del trattato di
Hans Kelsen, Lineamenti di dottrina pura del diritto, un'opera
fondamentale pubblicata in Germania nel 1934,22 uscita in italiano da Einaudi nel 1952. Poiché EZ si era laureato quell'anno,
è fortemente probabile che il testo l'avesse letto tempo addietro
nell'edizione originale.
Gli appunti riguardano in particolare il paragrafo 25 della
parte IV che contiene una minuta analisi delle nozioni di persona
«fisica» e «giuridica».
Un esame a fronte del testo di Kelsen e degli appunti aiuta a ricostruire la genesi della posizione zolliana sull'argomento. Kelsen
sostiene che mentre per la teoria tradizionale del diritto «persona
fisica» è l'uomo, secondo la dottrina da lui elaborata la persona fisica non è che «l'espressione unitaria personificata delle norme
che regolano il comportamento di un essere umano». In questo
senso la «persona» è un artificio. Nella misura in cui la «persona
fisica» è il punto centrale d'imputazione di ciò che si definisce
uomo, l'uomo è una realtà naturale e di conseguenza la «persona
fisica» viene a essere «una rappresentazione ausiliare della conoscenza giuridica».
Quanto alla «persona giuridica» Kelsen la vede come
l'espressione unitaria di un complesso di norme [...] che regola il
comportamento d'una pluralità di uomini. A volte essa è personificazione di un ordinamento parziale come sarebbe lo statuto
d'una società [...] altre volte è la personificazione d'un ordinamento giuridico totale che costituisce una comunità giuridica
comprensiva di tutte le comunità parziali e che di solito è rappresentata dalla persona dello stato.
Riguardo poi al significato ideologico dell'antinomia tra individuo e comunità, Kelsen ragiona così: «Se la "persona" intesa come
personificazione di un complesso di norme [...] crea un'unità organica [...] allora viene anche risolta l'apparente antinomia fra individuo e comunità; un'antinomia che intrappola la filosofia sociale tradizionale quando afferma che l'individuo è un tutto e
nello stesso tempo una parte della comunità. [...] Col dissolvere il
così detto diritto soggettivo squarciando il velo della personificazione nelle sue tante forme di manifestazione, la dottrina pura del
diritto» conclude «viene ad essere liberata da ogni giudizio di valore etico-politico diventando così, nei limiti del possibile, "un'analisi esatta della struttura del diritto positivo"».23
In un saggio del 1960 dove esaminava alcune posizioni della
scuola scettica del diritto americano Zolla era lapidario: «La
norma nasce con la pietrificazione della vita [...]. Jus scriptum è
maledizione, ma una volta che si sia affermato, ineluttabile».24 E
poco oltre sentenziava: «Non basta togliere le grucce al malato
perché cammini, tuttavia le grucce restano il segno della sua malattia e perciò da aborrire».
Il tema della malattia come mortificazione sarà ripreso in Volgarità e dolore in forma di domanda: «Che cosa si può dire dal
letto di morte d'un ospedale? Solo un moribondo di pessimo
gusto potrebbe fingersi nel raccoglimento d'un intérieur quando
in realtà si trova in un immondezzaio o in una macchina per selezionare i rifiuti della società disinfettata».25
Nelle sue fasi d'assalto e latenza la tisi era stata un'esperienza di
trasformazione, l'adito a una percezione acuita dell'esistenza.
Guardarsi da fuori come se quel corpo madido, ansimante fosse
di un altro aveva prodotto su di lui l'effetto di una catarsi:
A taluno - avrebbe annotato anni dopo - capita un giorno dell'esistenza di accorgersi che tutto è una farsa, specie gli onori, la
stima di cui si gode, l'opinione che gli altri hanno di noi, e anche
noi di loro, e di noi stessi. Tutto ciò che solitamente esalta e fa tremare è precario, ridicolo. Che liberazione, scoprirlo!
Di colpo si buttano via le grucce a cui ci appoggiamo: il rispetto al-
trui, il rispetto di noi stessi. Tutto il miserabile amor proprio ci
scrolliamo di dosso. Da ora in poi nessuno ci ricatterà più, andiamo
sciolti, leggeri ormai. Vorremmo andare da tutti a rivelare la buona
novella: «Puoi vivere senza la stima altrui e la tua. Lascia stare l'immagine di te stesso!». Ma se, ingenui, lo facciamo, avremo delle
sgradevoli sorprese. Ci verrà domandato: «Cioè posso rubare, uccidere?». È dunque questo il desiderio che si agita nel cuore comune?
Allora si sta zitti. Meglio che tutti camminino curvi sotto il peso
della propria immagine, del rispetto di sé, se quel peso li trattiene
dal delitto. Ma sarà vero che li trattiene?
C'era stato poi il secondo passo. Per il giocatore in erba - e di
fronte alla vita quale giovane non lo è? - un certo numero di giocate preliminari simulate è una tentazione incoercibile, e poiché
nelle vene di EZ scorreva inchiostro da scrittore, quelle giocate di
prova furono narrazioni. I primi racconti, ambientati a Torino e
Venezia, le città più familiari della sua giovinezza, esalano atmosfere surreali, e tetri, gonfi di malinconia sono gli orizzonti in cui
si muovono i personaggi: la misera portiera dello stabile in via dei
Martiri in attesa di un evento memorabile che poi le accadrà davvero; Ignazio, il ragazzetto attratto in un villino dove consumerà
una fine senza scampo accanto a una derelitta uscita di testa;
Marco, lo speziale veneziano che dopo aver addestrato il suo gatto
a «scrivere» con gli zampini anneriti di polvere di carbone, un
giorno nei segni tracciati dall'animale legge il presagio dell'imminente sciagura.
Visita angelica in via dei Martiri, L'Africa nel cortile e. Marco e
il gatto Mammoni sono esercizi narrativi che Zolla da giovane
praticò per sondare il limbo che si stende tra l'inferno e il purgatorio della commedia umana. Basta affacciarsi alla soglia di quel
trittico di storie, e la sensazione di apnea prende alla gola:
Volge all'argento il grigio delle nuove case in via dei Martiri di
queste giornate di primo inverno e ancor più paiono esse deserte
d'ogni vita. Vita non è ceno il rapido saluto o lo squallido discorrere dei vicini quando accada d'incontrarsi, quando saranno, le
loro parole, tediosi elenchi d'informazioni quanto costa riscaldare
nei vari modi, con nafta o con carbone, con legna o con gas, come
s'installa questa stufa o s'impiantano intercapedini, oppure, e peggio, rimestano i brandelli d'impressione che sulle retine stampò la
televisione la sera dianzi, o fra uomini accertano sorti di partite di
calcio, variazioni di paga o contributi, oppure, a modo di facezia
ripetono, al caso di una parola pronunciata, le pubblicità rimate
dei prodotti.
Incipit di Visita angelica in via dei Martiri
***
Tre scalini menavano alla porticella del villino, coronata da una
vecchia insegna rossa: Reale Società Assicurazioni. Qui Ignazio sedeva, aspettando Isidoro, Genesio, Apollonia che a uno a uno
scendevano dalle umide ventose mansarde.
Ignazio aveva nove anni e come più anziano li capeggiava, ed attorno a lui si sentivano stretti a difesa dalla banda dei ragazzi che
dominavano i giardini del rione armati difiondee cerbottane, ma
soprattutto temibili perché portavano un fazzoletto stretto al ginocchio o attorno alla testa, come a significare che erano i feriti
che potevano ferire, anzi dovevano [...].
Incipit di L'Africa nel cortile
Dapprima le braccia e le gambe di Marco si dimenarono, tentando di spingerlo a galla, poi da qualche recesso della sua mente
che il panico non aveva toccato fu impartito, serafico e perentorio,
un ordine: si abbandonò tutto all'acqua fredda. E in quell'attimo
vasto, in cui la mente raccoglie in un baleno tutti i pensieri prima
di svanire, si consolò di aver tratto Mammone in salvo dai marinai
sicché anche Marco poteva diventare l'uno. Ma prima che il verde
gelo dell'acqua si chiudesse su di lui un baleno svelò l'occhio nero
del frate o della Mora,figliadi Turco [...].
Chiusa di Marco e il gatto Mammone
Disposte cronologicamente tra Minuetto all'inferno e il secondo
romanzo Cecilia o la disattenzione, quelle calligrafie narrative servirono Il per lì a svelenire certi dèmoni uggiosi di cui disfarsi al più
presto. Scopertamente sono gli esiti di lucidi, spietati affondo in
certi abissi torinesi di normale abiezione nascosti agli occhi della
gente dabbene per il semplice fatto che gli occhi della gente dabbene, a differenza di quelli di uno scrittore, non s'attardano su
megere che d'inverno si corazzano il petto con fogli di giornale, su
cartomanti che alla porta del proprio miserabile alloggio inalberano la scritta: «Sonnambula autorizzata» (sic!) ; su fanciulli intisichiti che succhiano la minestra da un coppo di cartone; su portinaie allenate a captare variazioni impercettibili nei manierismi
quotidiani della squallida turba che popola il caseggiato. Nel caso
di Minuetto all'inferno, i personaggi agiscono come ostaggi di sbadati umori, e così basso all'orizzonte è il sole della vita da far pensare a un esorcismo: per liberarsi del male accumulato il narratore
evoca un succubo e lo delega a compiere un rito. I suoi officianti,
in un cielo surreale che incombe su Torino al tempo finale del Regime, sono il (un) Dittatore, attorniato da insolenti scherani, e il
suo complice, Satana, circondato a sua volta da una corte di diavolacci proni ai suoi ordini.
A un livello ulteriore di lettura il romanzo, al pari dei racconti
di quel periodo, è un'iniziazione al senso occulto dell'esistenza.
Che la sua vita, e la vita in generale, fosse un gioco di dadi retto
dal destino, Zolla lo aveva creduto da sempre, ma era anche persuaso che il giocatore non è un burattino, uno zimbello del fato
purché la sua arte di vivere si affini al punto da piegare la sorte all'intensità dell'intento, rettificandola. «La sorso fortuna» scriveva
nel 1963 «è l'elemento che collega fato umano e divinità superiore, perché critica oggettivamente il destino, mette in continuo
subbuglio, è simboleggiata dal sistro, invita a non riposare nel
mondo.»27
Un giorno, mentre era intento a limare certi dialoghi di Minuetto
all'inferno, una strana sensazione lo prese alla gola. S'era visto catapultato in un luogo senza contatto con gli spazi abituali, però riconoscibile e paradossalmente familiare. Aveva valicato i ventìcinque
anni, la madre era appena morta e la spossatezza polmonare, questa
volta, c'entrava in parte. Stava leggendo Jean Santeuil, il romanzo
incompiuto del giovane Proust e il senso di straniamento avvertito poc'anzi divenne tangibile non appena gli occhi gli caddero
su un giro di frase: «In quanto al regno dello spirito, egli lo immaginava come sovrapposto alla terra, ma senza che dalla terra vi
penetrasse mai nulla, eccetto i profumi, la pietà, la corruzione, la
malinconia e i gatti».28
Trasalì come se lo spirito del personaggio proustiano si fosse
immedesimato nel suo. Quel passo figura in calce alla Parte seconda di Minuetto all'inferno.
Esattamente tre anni prima che L'eclissi dell'intellettuale facesse di
Zolla il saggista più scomodo sàia page del periodo precedente il
Sessantotto, nell'estate 1956 Minuetto all'inferno, del tutto inaspettatamente, ottenne il Premio Strega per l'opera prima.
Esumare dagli archivi dello scrittore certi documenti sul «caso»
Minuetto può valere la pena trattandosi di una pagina di storia
della letteratura italiana del tempo, tra le più sapide e amene.
Quando il dattiloscritto atterrò sui tavoli dell'Einaudi in via Biancamano a Torino, passò e ripassò per le mani di lettori eccellenti
come Italo Calvino, Carlo Frutterò, Carlo Fenoglio e in primis Elio
Vittorini, direttore della collana per la narrativa «I gettoni».29 A
parer suo Minuetto all'inferno non solo abbondava delle pecche tipiche di un romanzo d'esordio ma era l'espressione intollerabilmente insana di una poetica decadente, arcaica e presuntuosa.
«Non so, francamente» dichiarava nel risvolto di copertina «che
cosa valga questo romanzo "satanico" di Elémire Zolla. Mi ricorda da un lato il Pavese più torbido, e da un altro la narrativa
"mitteleuropea" del patriota triestino Silvio Benco.»
Nel carteggio tra Frutterò e Vittorini, lo scrittore siciliano
confessava che al contatto con una sottospecie di letteratura
che ama sataneggiare «io precipito in uno stato di allergia e non
so nemmeno distinguere tra creature e aborti nella sua proliferazione».
Nella sua replica a Vittorini, Frutterò ammetteva:
[Il romanzo] non convince neanche me, ma insisto nel non ritenerlo indegno dei Gettoni [...] Ha diversi capitoli buoni, e le sue
numerose ingenuità e falle non sono quelle di un dilettante da
giornaletto di provincia. [...] Sia ben chiaro io non faccio il paladino di Zolla per ragioni personali; ma, a pane il fatto certissimo
che ci farà causa (è un esperto in materia) e che la perderemo, non
vedo la ragione di trattarlo cosi male, quando pubblicargli il romanzo non costerebbe, riconoscilo, neanche a te, un terribile sacrificio ideologico. Ti prego con tutte le forze - concludeva - di ripensarci.
La risposta di Vittorini fu categorica:
Non sono d'accordo. Trovo lo Zolla decisamente inferiore a tutti i
libri che tu citi [...] sono degli effettivi «gettoni». Mentre lo Zolla
è solo cupamente fantasticante: un incubo puramente libresco
[...]. In ogni modo non dico che non lo voglia pubblicare. Ho
detto e ripeto che vorrei scrivere all'autore per dirgli della brutta
impressione che mi ha fatto rileggere il suo manoscritto e per cercare di convincerlo a ritirarlo, a non commettere l'errore di rendersene responsabile in pubblico. Questo è tutto.
Doppiato il solstizio dell'inverno 1955, le posizioni dei pianeti
sulle sorti di Minuetto sono mutate. Vengono allestiti i dati biografici su Zolla e il 24 gennaio Vittorini scrive a Calvino: «Nel risvolto per lo Zolla non farò che dir male di me. Niente di lui».
Passa la primavera e il 5 giugno una nota a mano, frettolosa, annuncia: «Usciti Guerra e Zolla, la tipografìa è in riposo e non bisogna lasciargliela».30
Si arriva all'estate, e ciò che accadde a Roma la sera della premiazione, lo rievocava Maria Bellonci, madrina dello Strega, tredici anni dopo: «Quel 1956 [...] con Guido Alberti, sempre sollecito verso i giovani, pensammo di dare un premio anche ad un'opera prima che ebbe questo carattere originale: la giuria era composta dai vincitori dello Strega. Vinse Elémire Zolla col suo primo
romanzo Minuetto all'inferno, libro che sorprese tutti, oscillante
fra una specie di realismo magico e un moderno razionalismo; e
cosi proponemmo un nome che ha oggi un suo singolare colore
nel saggismo italiano.»31
Quella sera la ruota della fortuna, ciecamente, girò a favore del
giovane «in abito scuro, timido, ma che si assicura intelligentissimo»,32 e il Premio Strega, arrivatogli tra capo e collo, diede una
sterzata fatidica all'asse della sua vita.
Il periodo romano
1957-1991
Il coraggio che davvero difende è quello conforme
all'etimo: un grande cuore, una psiche ordinata e
forte perché sottomessa allo spirito.
Il satanismo1
1. Bozzetti di vita quotidiana
Lasciata Torino con immenso sollievo, EZ s'immerse nel mondo
culturale della capitale: era il 1957. Nella società letteraria e accademica romana strinse amicizie senza legarsi a gruppi di nessun
tipo. Era un chierico vagante, un intellettuale senza portafoglio,
un uomo deciso a giocarsi la vita con un capitale costituito dalla
sua sola mente, «la più svanente, esasperante delle crete», avrebbe
annotato nei Quaderni.
Abitudinario, meticoloso e frugale nella vita quotidiana, si piegava alle cose solo in base a un ordine interiore ma anche secondo
l'estro del momento, consapevole che un'occasione lasciata andare è persa per sempre.
Chi volesse immaginare il giovane Zolla all'inizio del periodo
romano, che durò trentaquattro anni, è agevolato dall'articolo di
un saggista napoletano, all'epoca collaboratore de «Il Mattino»,
Luigi Compagnone, che ritrasse lo scrittore nel suo rifugio a un
passo dal Tevere dove aveva abitato per qualche anno dopo la separazione dalla prima moglie. Il matrimonio nel 1958 con la scrit-
trice Maria Luisa Spaziarli conosciuta molti anni prima a Torino,
s'era logorato e sciolto dopo pochi mesi.2
L'articolo s'intitola Esclusi dalgiro ed è colmo di una delicatezza
insolita nel mondo di chi scrive in pubblico. Nel quartiere Prati
venne incontro a Compagnone
l'alta e opaca facciata di un caseggiato costruito — scriveva — come si
usa oggi: tale, da farti disperare che dentro vi abitino e vivano uomini
non ancora ridotti a larve e bruchi ammassati, nelle loro catalessi serali, dinanzi a schermi televisivi [...]. Ma come di 11 a poco fui entrato
nella casa, subito m'accorsi d'essere venuto in un territorio a sé
stante, in uno spazio dove qualcosa impediva alla volgarità la pur minima intrusione. Una casa di poche stanze [...] povera, si, ma come si
può dirlo della cella di un monaco [...] il tavolo e il mobile, il letto e
qualche quadro alla parete, i libri sul comodino, le carte con gli appunti [...] la profonda grazia spirituale del padrone di casa aveva trasformato gli oggetti, le pareti, la casa, a sua immagine e somiglianza.3
Negli appartamenti romani in cui EZ abitò dopo quello di via
Pannini, l'impronta sarebbe rimasta identica. Penombra, silenzio,
un aleggiare d'essenze profumate, il brontolio dell'acqua in bollore per il tè, alle pareti riproduzioni di icone senza valore commerciale ma di straordinaria forza iconografica. Talune stavano
poggiate sui ripiani di mobiletti che lo scrittore, con un moto improvviso di alacrità manuale, si buttava a laccare di squillanti rossi
di Cina finché la tetraggine dell'aspetto iniziale non era fiaccata.
Poi i gatti: una buffonesca, contegnosa banda di cinque o più felini, imperterrita nella ricerca di un piacere sottile condiviso col
padrone a graffietti e moine, sbadigli sontuosi, scorribande in
spalla, sonni indisturbati sulla pancia di lui sdraiato a scrivere. Ore
che gocciavano lente senza che il suono del telefono forasse il silenzio, dialoghi a voce smorzata, i vasetti di miele sul vassoio accanto alle tazze da tè, scatoline di cibo lambite da linguette troppo
appagate per mordicchiare più di tanto 11 dentro.
Da quando s'era installato a Roma lavorando nella redazione di
«Tempo Presente» e poi docente di prima nomina all'Università
La Sapienza,4 EZ aveva avuto l'accortezza di stendere una cortina
invisibile tra il suo mondo e il mondo di fuori. Le cautele di un
funzionario dei servizi segreti, lui le aveva adottate spontaneamente all'unico scopo di sigillare la vita privata, eppure non c'era
nulla di più esposto alla luce del sole del suo tran tran quotidiano.
Incapace di condurre automobili, si muoveva volentieri a piedi
a un ritmo che non tollerava soste fuorché davanti a vetrine di erboristerie, mobilia asiatica e delicatezze esotiche. Nelle passeggiate verso sera amava attardarsi nelle librerie. Le rastrellava periodicamente anche nei posti più fuori mano e di richiamarlo ai
limiti dell'orario di chiusura non c'era verso.
Spesso le catture più ghiotte avvenivano all'ultimo minuto con
la saracinesca calata a metà: a braccia colme, a passo veloce riguadagnava la via di casa. Nelle sue camminate era fortunato: quante
volte una sorte imperscrutabilmente benigna aveva provveduto a
sventare incontri sgraditi!
Negli anni la rete di strade percorse ogni giorno aveva incluso
Piazza Sant'Anselmo sui fianchi dell'Aventino, dove s'era acquartierato accosto alla casa di Cristina Campo, la scrittrice (al secolo
Vittoria Guerrini) cui fu legato fino alla morte di lei avvenuta nel
gennaio 1977.5 L'appartamento in via Merulana dove andammo
a vivere nel 1979 aveva il vantaggio di essere vicino a La Sapienza
dove Zolla teneva lezione regolarmente alle tre del pomeriggio.
Gli studenti, gli assistenti e chi andava a visitarlo erano ricevuti in
una stanzetta in via Magenta; successivamente in uno studio più
ampio in viale Castro Pretorio, colmo di libri e cimeli dei viaggi
tra gli indiani d'America. Prima che io gli facessi da autista sulla
vecchia Ford, lo scarrozzavano in facoltà allieve devotissime, alla
guida di automobiline che a strattoni e sussulti fendevano impavide il traffico romano.
Alle testate cui aveva collaborato nei primi anni, 6 gli articoli
battuti a macchina erano consegnati con una puntualità ineccepibile. Se li scriveva a mano, non c'era interpunzione, tratto di
lettera che non fosse precisato con minuzia da calligrafo e l'occhio che scorreva la pagina indugiava volentieri su quel nome e
cognome allacciati nella firma in un arpeggio elegante e deciso.7
Gli inviti a cena in casa di letterati amici erano stati inizialmente un'abitudine concessa a se stesso e a chi l'accompagnava,
con distaccato piacere. In quegli interni romani di trasandata bellezza, una vena salottiera, il gusto tutto inglese della conversazione sono tono spumeggiava in battute fulminee, e non c'era argomento sul quale le posizioni degli interlocutori non venissero
arpionate con una consumatissima destrezza dialettica. Sapeva
vincere con la noncuranza di chi avrebbe trovato sommamente
triviale approfittare del disagio altrui, e i toni di una voce bellissima temprata nel sussurro e nella declamazione erano dosati
come quelli di un cantore provetto. Vestito solitamente di scuro,
indossava capi modesti non potendosi permettere niente più di
una bella cravatta, ma la minima trasandatezza o un minuto di ritardo agli appuntamenti erano aborriti quanto l'incostanza nelle
relazioni di amicizia alle quali teneva moltissimo.8
Ai dati estrinseci sugli anni romani che inclusero la stagione dei
viaggi fuori d'Europa ripercorsa nel capitolo 4, e sul periodo finale a Montepulciano dove ci trasferimmo non appena Zolla, al
compimento dei sessantacinque anni, lasciò l'insegnamento universitario, c'è poco da aggiungere rispetto ai ragguagli diretti dello
scrittore citati nel primo capitolo. Da una biografìa che EZ volle
scancellata è lecito però far affiorare circostanze ed elementi che
aiutino a scrutare la sua personalità, la cifra di un uomo che verso
la fine della vita lietamente confessava:
Sono stato sempre alieno dalle imposizioni marxiste o fasciste, la
mia mente ha spaziato senza impedimenti. Perciò da sempre sono
vissuto nell'orizzonte che oggigiorno ci circonda in maniera nitida e visibile. Dice René Clair: il chiavistello del futuro garantito
dal marxismo è saltato, il tempo ci è restituito, profondo e profuso, senza segnaletica coatta. L'immersione nel passato, l'amore
dell'arcaico non sono più l'obbrobrio che sembrarono, bensì occasione di libertà. Il futuro si dilata in enigma, in possibilità sconfinate. La vita torna perciò alle sue dimensioni proprie, che sono
enormi, esplorabili senza posa e tuttavia, aggiungo, strutturate da
archetipi eterni.9
2. La mediazione intellettuale
In un articolo sul teatro di Bertolt Brecht apparso nel 1956, Zolla
osservava che nei drammi brechtiani è raggiunta la fusione totale
del sistema critico e della passione umana. Quando il momento
storico è tale che «il personaggio non si raggiunge più attraverso
la partecipazione affettiva, soltanto rischiosamente rivivendone
la malattia è dato di plasmarlo».10 Sopra al titolo dell'articolo
campeggia la riproduzione della leggendaria carretta di Madre
Coraggio nell'allestimento del Berliner Ensemble, la compagnia
di teatro diretta da Bertolt Brecht. Sia l'incedere dolente del carro
su ruote che paiono di pietra, sia il passo appena citato squarciano
la vista sulla tempestosa stagione che Zolla si accingeva a traversare poco dopo i trent'anni. Anche nel caso del momento storico
che indovinava di piombo sentiva che soltanto «rischiosamente
rivivendone la malattia» avrebbe potuto comprenderlo fino in
fondo.
Che si trattasse di una battaglia intellettuale da combattersi
senza alleati su cui contare, gli fu chiaro da subito. Occorreva utilizzare le più affinate risorse dell'ingegno critico per riconoscere
gli impulsi che determinano i cambi di rotta negli andamenti del
sistema, i fermenti in grado di minarlo dall'interno in una miscela
di parossismo e scaltrezza, caso e causalità.
«Alla mia parete» recita il Liederóxzto nell'articolo sul dramma
brechtiano «è appeso un intaglio giapponese / maschera d'un cattivo dèmone; coperto di lacca dorata. / Compassionevole vedo /
le gonfie vene della fronte, che dicono / quanto sia faticoso essere
cattivo.»11
Forse non è sbagliato congetturare che la «cattiveria» profusa
da Zolla negli scritti di critica sociale del primo periodo romano
fosse una tattica attinta al metodo che Theodor Wiesengrund
Adorno (1903-1969) propugnava ne La dialettica negativadopo
averlo messo in pratica nelle opere precedenti. Opere che Zolla
conobbe e commentò assai prima che divenissero testi di culto in
Italia.12 Quel che Horkheimer e Adorno dal loro esilio in America avevano stigmatizzato nel maggio del 1944, cioè che esiste
un totalitarismo nascosto sia nel fascismo sia nel capitalismo,13
fu per il giovane Zolla una istigazione a battere la strada della dialettica negativa, in vista però di raggiungere un obiettivo che
dalla filosofia della scuola di Francoforte si allontanava a perdita
d'occhio. In un saggio sulla rivista romana «Elsinore» uscito nella
primavera 1964, EZ denunciava il carattere parassitario della filosofìa di Adorno in termini che non lasciano dubbi sulla propria
presa di distanza dalla dialettica negativa pur essendo persuaso
che una critica radicale della società di massa e, a monte di essa,
dell'ideologia illuminista, fosse l'unica tattica efficace date le circostanze. L'idolatria progressista, l'industria culturale, la mistificazione, l'interesse smodato per il corpo, l'abbassamento del soggetto sociale a una stupidità impudente e intontita sono temi che
innervano la Dialettica dell'illuminismo quanto gli scritti zolliani
di critica sociale tra il 1959 e il 1971, e sviluppi convergenti assumono gli excursus di Adorno e Zolla sull'opera di Sade e il sadismo.14
C'è però una differenza di fondo nella visione dei due pensatori,
e una lettura attenta del saggio su «Elsinore» aiuta a coglierla.
Adorno - scriveva Zolla - adotta un metodo invincibile [...] non
prospetta un punto di vista di contro a un altro, ma critica il porsi
d'un punto di vista in genere. La sua forza sta nel non concedersi
mai punto di vista, nello sfruttare bensì quello dell'avversario, nell'adottare il sistema che ne promana dimostrandone o l'interna
contraddittorietà o l'inconciliabilità con la concretezza. [...] Questo metodo della negatività assoluta si potrebbe chiamare parassitismofilosofico,né il termine ha di necessità un tono deprecatorio, essendo noto che il mondo vegetale è parassita della terra,
come l'animale del vegetale, come l'uomo degli altri parassiti
(d'altra parte la macchina, parassita dell'uomo, sta vendicando
piante e bestie).15
Deprecabile piuttosto è il fatto che vietandosi di ammettere una
filosofìa che non sia esclusivamente demolitrice, Adorno è come
«un guerriero che rifiutasse di considerare la guerra in funzione
della pace». Persuaso che la spiritualità non sia altro che un tipo di
merce e dunque un'arma di intontimento e dominio, Adorno disconosce l'anelito a scavalcare la contingenza storica, il bisogno
nell'uomo di darsi un fine soprannaturale, esclude che ci siano
istanze che si sottraggono a patteggiamenti e compromessi suggeriti dalla ragione calcolante.
Per intendere il senso della solitaria battaglia intellettuale che
rese a EZ una moneta ancipite: su una faccia la fama letteraria e
un'istantanea fortuna critica, sull'altra l'ostinata avversione dell'establishment culturale fino ai primi anni Ottanta - come riconosceva lui stesso nell'Autodizionario degli scrittori italiani- occorre
meditare a fondo sulla coesistenza nel pensiero di Zolla di due
istanze parimenti imperiose. L'istanza eretica, di colui che sceglie
di stare dalla parte contraria, di andare controcorrente, consapevole del prezzo che tale scelta comporta. E l'istanza metafisica, che
però condusse Zolla su sponde lontane da una metafìsica intesa
alla maniera occidentale.
Nel senso più vasto - scriveva negli anni Ottanta - la metafisica
è ben più che un linguaggio, è un'esperienza che trasforma [...].
È proprio questa metamorfosi intima e totale che definisce il metafisico [...]. Egli estirpa ogni identificazione con la sua persona
sociale e storica, non si riconosce nell'individuo che sembra essere, nato da certi genitori in certa data, con un suo carico di ricordi. Il metafisico si identifica con l'essere come tale. Lo esprimerà talvolta nei secoli dicendo «Sono figlio del cielo e della
terra» o, come affermava Guerin Meschino, «sonofigliodel sole
e della luna».
L'istanza eretica spinse il giovane Zolla a collocarsi fuori del giro
allo scopo - inconcepibile per chi unicamente «nel giro» si sente
al sicuro - di serbarsi libero di indignarsi, di «individuare le cause
di una rovina abbastanza prossima di una società basata sulla distruzione della natura», dichiarava in Che cos'è la tradizione.
Il passo di San Nilo Abate messo in calce a L'eclissi dell'intellettuale - «Colui che si disperde nella moltitudine ne torna crivel-
lato di ferite» - la dice lunga sulla disposizione dello scrittore alla
vigilia della sua battaglia anti-moderna. 16 D'ora in avanti la sua
parola si sarebbe caricata di furia, avrebbe provocato, suscitato
sdegno, attizzato avversione quanto più impassibile si sarebbe
conservato nell'intimo. Era un programma che aveva preso forma
tempo addietro sui banchi della facoltà di Legge a Torino quando
s'era affacciato sui paradossi del diritto, sui labirinti della malattia
mentale. Certe somiglianze tra la struttura della norma giuridica
e la patologia mentale avevano dissuaso i suoi studi dal prendere
stabile residenza in quei distretti, ma l'impronta causídica, la percezione abbagliante dell'assurdo erano rimasti, e l'apparato di
fondo degli interventi a voce e degli articoli, pubblicati a raffica su
riviste e quotidiani, resta quello di una requisitoria allestita con
una pars destruens e una pars construens.
L'eclissi dell'intellettuale, il capofila degli scritti polemici, prese
forma sullo schema di un ciclo di trasmissioni radiofoniche al
terzo programma della RAI incentrato sui temi: «Industria e letteratura», «Erotica di massa», «Le regressioni della droga», «La decadenza della persuasione».
Ridar vita ai clamori che quel libro, ristampato nel giro dei
primi mesi quattro volte, suscitò all'epoca è manifestamente impossibile. Una vicenda che scosse, impermalì, esasperò una compagine intellettuale avvezza a passare ogni questione, atteggiamento o punto di vista al filtro di un'insindacabile polarizzazione
politica. Che il pensiero sia il «padrone» piuttosto che il «servo»
che esegue la polarizzazione era (e rimane) una considerazione del
tutto estranea al codice in uso. Zolla lo denunciò e con una delle
sue caratteristiche torsioni dialettiche ricorse una volta, si era nel
1963, alla figura hegeliana del «figlio del padrone»17 per additare
un uomo la cui libertà interiore gli ingiunge di resistere alla forza
e stravolgerne le abiette regole. «Il guerriero» aveva scritto ne L'eclissi dell'intellettuale «deve temprarsi, respingere la paura, e se veramente vuol essere forte, anche l'odio. Il giocatore, una volta calcolata la situazione agisce meccanicamente, con un gesto stereotipo, e può permettersi di vivere una vita interiore tutta abbandonata a se stessa.»
Tempo dopo gli era capitato di occuparsi di una nuova edizione
del Bhagavadgttà, il poema epico indiano dove Arjuna, in procinto di combattere, si macera nel dubbio se sottomettersi alla logica implacabile della battaglia. Il cocchiere accanto a lui lo esorta
a «osservare le alterne vicissitudini come se non ci riguardassero (o
addirittura come se fossimo noi a divinamente volerle!). [...] Se
mai si acquista un tale distacco» rifletteva EZ «si diventa partecipi
di ciò che è immutevole, eterno, e le nostre vicende, anzi la nostra
stessa persona, ci appariranno come vesti, che indossiamo o buttiamo. Le cose visibili manifestano delle essenze che si ritrarranno
un giorno nell'infinita possibilità, per svanirci o per ridiscenderne
sul piano della manifestazione visibile: impariamo a vedere questo
manifestarsi e riassorbirsi senza giudicare, senza commuoversi,
senza che s'increspi la nostra mente».
«L'eclissi dell'intellettuale entusiasmò e indispettì come mai
prima era capitato nel nostro mondo culturale per un libro di
saggi» scriveva Giuseppe Tedeschi in un ragguaglio sull'opera di
Zolla fino al 1969.18
Il primo a occuparsi autorevolmente àt\YEclissi dell'intellettuale era stato Eugenio Montale dalle pagine del «Corriere della
Sera». Egli intravedeva in Zolla la tempra di «uno stoico che
onora la ragione umana e che sente la dignità della vita come un
supremo bene. È un uomo che non si mette "al di sopra" della mischia, ma che vuol restare ad occhi aperti. E finché esisteranno
uomini così fatti la partita non sarà del tutto perduta».19
A sua volta, Guido Piovene, recensendo Volgarità e dolore, la
seconda opera zolliana del ciclo anti-moderno, osservava che:
«Vi sono libri che devono la loro forza alla maniera con la quale
è condotta l'analisi, al suo movimento, alle luci che accende sul
proprio cammino. Qualunque sintesi li falsa».20 Due anni dopo,
nel 1964, era la volta di Storia delfantasticare, un libro costruito
come un trittico sulle origini dello stato fantastico e i suoi esiti
nelle letterature moderne, nel surrealismo e nelle avanguardie.
L'esizialità della fantasticheria era posta in evidenza soprattutto
nell'opera di Kafka, dove si esprime una poetica agli antipodi di
quella di Joyce. Se in Kafka - commentava Elena Croce recen-
sendo Storia delfantasticare - Zolla coglie «colui che di fatto ci
ha aiutato come nessuno a individuare i moderni travestimenti
di Satana», Joyce al contrario rappresenta per Zolla «l'apoteosi
del fantasticare».21 L'avversione per l'autore di Ulisse, manifestata da EZ in svariate occasioni,22 ha una sostanza etica ed estetica insistentemente messa a nudo nel componimento giovanile
Joyce e la moderna apocalisse, qui riportato tra i Saggi letterari,
Parte seconda.
Tra il 1959 e il 1971 lo scrittore licenziò quattordici volumi 23 e
cinque di essi, nel giro dei primi quattro anni, erano stati delle
antologie: Imoralisti moderni (co-curata con Alberto Moravia),
La psicanalisi-, l'edizione commentata delle Opere di Sade e di
una scelta di scritti di Emily Dickinson {Selected Poems and Letteria. Infine Imistici dell'Occidente, una monumentale raccolta
di testi di contemplativi pagani e cristiani, di cui ci occuperemo
fra poco.
Le prefazioni a Confessioni e immaginiti Franz Kafka, a L'età del
jazz di Fitzgerald,24 innumerevoli lavori di americanistica tra i
quali spiccano i volumi Le origini del trascendentalismo e l'edizione
di ClarelÒi Herman Melville,25 oltre a uno sciame di interventi e
articoli pubblicati dalle più varie parti, compongono una bibliografia a tal punto ingente e diversificata che si stenta a ricondurre
alla penna di un unico autore. Una sola spiegazione rimane plausibile: la vita di Zolla si svolgeva su due piani. Quanto più turbinosa era la ridda degli impegni quotidiani, tanto più sigillato e assorto era il tempo trascorso al tavolo di scrittura.
Da quando a ventidue anni, a tu per tu con la tisi, aveva deciso
di «non» credere alla propria morte imminente sulla base di un
semplice ragionamento: se muoio per davvero non ci sarà più un
io a esaminare la questione, intanto vedo fin dove posso spingermi al di là di me stesso e può darsi che ce la faccia, a trentasei
anni la ricaduta nella malattia polmonare l'aveva posto al medesimo bivio. Però questa volta il nemico non era più solo la tisi, e fu
la spinta incontenibile ad affrontare quella più dura sfida a rianimarlo dal profondo.
3. La svolta silenziosa
Nel 1962 un ampio saggio concepito come introduzione a un'antologia di testi di contemplativi pagani e cristiani, I mistici dell'Occidente, documenta una svolta senza ritorno nella prospettiva intellettuale e spirituale dello scrittore. La ricaduta della malattia polmonare lo sequestra a letto per mesi, e la visione interiore si allarga:
«Ascendiamo il monte Ventoso della storia e guardiamo il disegno
da quella grande altezza: i particolari non si discernono più, vediamo alternarsi ciclicamente l'una all'altra civiltà fondate sul commento d'un testo sacro tremendo e fascinoso, che non tanto è letto
e giudicato quanto legge e giudica chi lo accosti, e civiltà prive d'un
testo, apparentemente fondate sul culto della critica».26
I mistici dell'Occidente che raduna e traduce in un tomo di settecento pagine lo giudicano nel nudo silenzio di un soave rigore,
e la sua persona intellettuale è messa in questione radicalmente.
Lo stato mistico come norma dell'uomo è riconosciuto come la
pietra di volta di un sistema che d'ora in poi si richiamerà ai valori
perenni della tradizione; prescriverà la liberazione dal sonnambulismo coatto dell'industria culturale e della società di massa; definirà Yanatomia spirituale dell'uomo nell'insieme delle civiltà religiose della terra. Circolò inizialmente l'Introduzione a I mistici
anche in un fascicoletto autonomo di una novantina di pagine
dalla copertina in cartoncino grigio. Una rarità editoriale assieme
al volantino contenuto nell'edizione originale Garzanti dove
Zolla esponeva un profilo di sé perfino più smunto di quelli che
abbiamo letto in precedenza.27
Per niente laconica era invece la descrizione dell'antologia. E se
le ristampe Rizzoli 1976 (in sette piccoli volumi) e Adelphi 1997
(in due volumi di circa 2000 pagine), la riprofilano in modi diversi, qui è trascritta nella versione originale:
È probabile che questa antologia, nella quale Elémire Zolla ha
raccolto testi religiosi di tutti i tempi e di tutte le letterature, sia
unica al mondo. Dai testi orfici al biblico-platonico Filone, da Seneca a Plutarco, dai testi ermetici a Giamblico, sulla fine della ci-
viltà classica: i Padri della Chiesa, Clemente d'Alessandria, Tertulliano, Origene, Evagrio, Agostino; il medioevo occidentale e
bizantino; e la grande rinascita del pensiero religioso nel secolo XI
e XII, Pier Damiani, S. Bonaventura, Gioacchino da Fiore, Hildegarde von Bingen, Mathilde von Magdeburg, S. Francesco e i
Manichei. Poi, mentre si avvicina l'età moderna, le diverse tradizioni nazionali: la mistica tedesca, da Boehme fino a Lutero, Silesius e Athanasius Kircher; i puritani inglesi, John Donne e Fludd;
la quasi ignota fioritura italiana, da S. Caterina da Genova alle
correnti neoplatoniche, a S. Veronica Giuliani e Bartolomeo
Cambi; Calvino, S. Francesco di Sales, Pascal, Bossuet e Pierre de
Caussade; S. Ignazio, S. Teresa e S. Giovanni della Croce. Verso la
metà del secolo XIII questa grande tradizione si esaurisce e si spegne: un mondo sembra morire di colpo.
Taumaturghi greci e Padri della Chiesa, cabbalisti e francescani,
gesuiti e protestanti sono vicini e solidali nelle pagine di questa antologia. Il lettore moderno può leggerla a frammenti e brani, cercandovi la sparsa quintessenza intellettuale e morale dell'Occidente; ma può anche leggerla come un unico, immenso libro,
scritto dall'umanità in un solo respiro. Accanto a testi famosissimi, pagine di grandi scrittori ignoti, neppure registrati nelle enciclopedie. Un'ampia introduzione precede la scelta: notizie e
commenti agevolano la lettura.
Quell'«ampia introduzione» in otto paragrafi è un trattatello capitale non tanto per spicco di dottrina visto che l'erudizione è un
sale scialato ovunque negli scritti zolliani, e neppure perché
un'antologia così concepita ha forse un unico precedente ne Le
confessioni estatiche raccolte da Martin Buber e pubblicate in Germania nel 1921.
Il punto è un altro. In quelle pagine meditate allo spasimo ma
che paiono scritte di getto, sono prefigurate le vie maestre dell'opera futura. Esse fanno capo ad almeno quattro temi di fondo che
innervano gli scritti zolliani tra il 1968 e l'anno della morte, e indicarli uno per uno è un passo necessario per inquadrare il pensiero dello scrittore alla luce di quanto verrà esposto nei prossimi
capitoli. Il primo tema riguarda la ricostruzione di una morfologia
spirituale unitaria nelle culture del mondo antico, i cui tratti extrastorici e metafisici saranno delineati in una sequenza di opere
che da Lepotenze dell'anima e Che cos'è la tradizione culmina ne La
filosofia perenne: l'incontro tra le tradizioni d'Oriente e d'Occidente.
Su questa stessa traiettoria vanno situate le indagini sulla «diversità» (otherness) indigena, sciamanica e orientale, riconoscibile
quest'ultima nel pensiero e nelle pratiche estatiche e religiose sufi,
induiste, buddhiste e taoiste esplorate dallo scrittore nella stagione
degli esodi fuori dell'Occidente (capitolo 4). L'esito complessivo
di queste indagini a partire da Iletterati e b sciamano e nell'insieme
degli scritti apparsi sulla rivista «Conoscenza religiosa», è stato la
revisione radicale dell'idea superbamente etnocentrica della minorità spirituale delle civiltà indigene, e l'avvio di una riflessione sistematica sul lascito spirituale dell'Oriente non cristiano al mondo
moderno. Opere erudite come Le tre vie, e divulgative come Aure
e La nube del telaio. Ragione e irrazionalità, tra Oriente e Occidente,
per non parlare delle ricerche promosse dallo scrittore nell'ambito
accademico dei cultural studies («studi culturali») sono una pietra
miliare nel faticoso, osteggiato acquisto di una visione unificata
della spiritualità umana che scavalca barriere e pregiudizi etnici,
ideologici e religiosi. Il terzo tema di fondo, perfino più temerario
dei due precedenti, che Zolla impostò nella lontana introduzione
a I mistici dell'Occidente con sviluppi ininterrotti fino alle ultime
opere, è il recupero di una visione della natura e del mondo vivente
- la biosfera secondo Vernadskij, il mondo zodiacale secondo
Zolla—anteriore alla rivoluzione scientifica; e la riscoperta gioiosa
di una conoscenza nutrita degli apporti dei saperi tradizionali,
astrologia, alchimia, botanica, musica, giacché «ogni tratto dell'alchimia — scriveva nel taccuino preparatorio a Le meraviglie della
natura. Introduzione all'alchimia-corrisponde a un tratto analogo
in ognuna delle altre scienze e qui nasce l'interpretazione alchemica dei miti e delle Scritture». Il quarto tema di fondo, non meno
ripido dei precedenti, è al centro del trattato sugli Archetipi, dove
gli intrecci nelle vicende della storia e della politica, e gli stessi fattori che scatenano l'immaginazione artistica e poetica sono situati
e interpretati in una griglia di modelli o «schemi unificanti, carichi
di energia emotiva e simbolica». Gli influssi di questi modelli primari, che Zolla solo in parte ammise di ricondurre alle idee platoniche e agli archetipi junghiani, sono pienamente riconoscibili
nelle dinamiche storiche e nei processi dell'immaginazione creativa. L'intramontata presenza dell'archetipo impersonato da Dioniso, emblema nel mito greco della mania erotica e bacchica, era
messa in luce dallo scrittore nella vasta introduzione a II dio dell'ebbrezza. Antologia dei moderni dionisiaci.
Ci si domanderà: com'è possibile che una serqua così fitta di temi
sia già prefigurata nella Introduzione a I mistici dell'OccicUnteì
Per trascendere il mondo - affermava nel testo a un certo punto bisogna che il mondo ci sia, per attingere il sovrannaturale è necessario che ci si rappresenti il naturale. Perciò le due mediazioni attualmente preliminari a ogni conoscenza mistica saranno prima la
critica del bisogno falso, del consumo coatto, della repressione
della natura, poi la configurazione della propria vita nell'ordine anteriore alla modernità.
28
È un «programma» al quale lo scrittore si attenne con scrupolo
scandendo l'Introduzione a I mistici in due parti. La prima, assai
breve, che nella versione originale occupava il primo di otto paragrafi, verte sulle «cattive definizioni» dello stato mistico. Poiché
essa non figura nell'edizione Adelphi riveduta del 1997, la si è collocata in questo volume, nella Parte seconda, tra gli Scritti sulfurei,
il luogo più adatto ad accogliere una critica corrosiva del «falso»
misticismo.
La seconda parte, che nella riedizione Adelphi ammonta a una
novantina di pagine, fornisce una mappa dei fattori e delle condizioni che propiziano secondo Zolla l'unico tipo di esperienza interiore, appunto la contemplazione, capace di schiudere alla
mente i piccoli e i grandi segreti dell'esistenza sui quali una filosofia non sorretta dall'ardore contemplativo non può che stazionare alle periferie.
In un crescendo dialettico l'argomentazione culmina nel com-
mento a ventiquattro immagini di antiche mappe celesti e di
una strepitosa carta del cielo raffigurata su un tamburo sciamanico.
Se per ipotesi I mistici dell'Occidente fosse stata l'ultima opera
curata dallo scrittore sopraffatto dalla tisi a trentasei anni, non c'è
dubbio che nelle pagine di avvio all'antologia è racchiusa in nuce
la circolarità di un pensiero completo fin dall'inizio accordato ai
temi di fondo sommariamente sopra enunciati.
In un elzeviro pubblicato una trentina d'anni dopo, quella cifra
di completezza si compendiava in un semplice giro di frase:
Ciò che ha vita e cade, ciò che dà vita e sale [...]. L'uomo parte da
un oggetto campito nello spazio, la cui immagine [...] provoca un
movimento nell'interiorità; questo via via si trasforma nell'immagine fantastica, nella valutazione, nella ragione, che si eleva in intelletto e quindi in mente (il noùsàei Greci) per trasfondersi infine
nella «luce che illumina e rapisce», divinizzando, in quanto è Dio.
Il Salmo 82 proclama: «Io ho detto: voi siete dèi».
29
Sostenere che il misticismo è «un ritorno della tradizione in
senso proprio, ricordo involontario di cosa sepolta», e che il fatto
stesso di raccoglierne le esili tracce è la prova che ciò avviene nel
momento in cui una civiltà accecata dalla propaganda e dalla libido dei consumi ha indotto nel soggetto storico l'oblio dei beni
spirituali, tutto ciò negli anni Sessanta suonò a tal punto allarmante e molesto da spingere a giudicare Zolla non più solo una
«macchia» nel panorama culturale italiano secondo il critico
menzionato nel primo capitolo, ma «un satana, l'Avversario» come riportava Guido Ceronetti in un articolo apparso su «L'espresso» nel 1971.30
Prima di compiere una ricognizione, seppure veloce, delle imprese avviate da Zolla nel periodo che precede gli esodi fuori dell'Occidente, è opportuno toccare un punto lasciato in sospeso a
proposito del «nemico» dal profondo con cui lo scrittore si misurò dalla prima giovinezza.
Tra gli scritti letterari dei primi anni Cinquanta spicca una
monografìa apparsa su «Letterature moderne», la rivista diretta
da Francesco Flora che aveva accolto svariati saggi letterari di
Zolla della prima stagione. Si intitola Thomas Mann e consiste in
un profilo accurato della personalità dello scrittore austriaco
scrutata attraverso il dramma interiore di Leverkùhn nel Doktor
Faustus.
Il patire di Leverkiihn secondo Zolla proviene da un eccesso
d'intelligenza. Un'intelligenza di portata estrema, osservava, «è
tutt'altro dall'intelligenza mezzana, piegata al servizio della potenza, desiderosa solo di trovare un porto sicuro, di risolvere il
mondo in un sia pur faticato acquisto». D'altra parte un'intelligenza estrema
porta con sé una maledizione. Essa significa distacco, impossibilità di porsi in comunione: Leverkiihn emanava quasi una fisica
sensazione di gelo, la sua presenza recava una ventata di freddo.
Sarebbero agevoli — proseguiva — i confronti con il Faust
goethiano (anche in esso si trattava di rappresentare un punto
d'arrivo dell'intelligenza), e colmo di sapienza goethiana è tutto il
libro. Ma il Fausti Mann ha un carattere nuovissimo, egli è si saturo di disciplina morale, da non essere più se non prontezza
fredda, gusto della costruzione fine a se stessa, della parodia. Un
uomo simile - si domandava EZ nei suoi trent'anni — ha delle vie
dischiudibili alla sua opera?31
A Torino e nel primo periodo romano, quel quesito era stato
anche un quesito personale. Se l'era posto e riposto mentre si dava
alla narrativa, alla critica sociale, alla denuncia dei vizi nazionali,
alla fustigazione del progressismo moderno. Poi, a grado a grado,
i rovelli, il ricorso all'invettiva, la pratica del sarcasmo coatto
erano cessati, e il dramma del Doktor Faustus che. aveva paventato
e in parte vissuto, si era sbiadito come un sogno scacciato dal soffio di un sentimento nuovo. Quando fu pronto a nominarlo, non
lo chiamò spiritualità o fede - giacché «spesso s'invocano i valori
dello spirito per opprimere coloro che dovrebbero portare lo spi-
rito»; e neppure struggimento amoroso. Infatti: «Solo chi creda di
dover ricevere mercede per i propri sospiri può addolorarsi vedendoli ignorati o respinti; allora la ripulsa sarà giusta punizione
della stortura» ( Volgarità e dolore). «Quiete» sarebbe parola più
adatta però: «le parole sono sempre ostaggi; appena concesse al
mondo profano, subito questo ne fa reti, gabbie» scriverà in Verità
segrete esposte in evidenza. Piuttosto, se ci si convince che: «Chi
perde ciò che possiede acquista un nuovo tipo di possesso, quello
della sua perdita»,32 una parola diversa affiorerà alle labbra, il
nome di un senumento che nel cuore di un uomo d'intelligenza
estrema stenta a fiorire. Quella parola è affetto, l'affetto che «tramuta e redime»: un'epifania.33
4. Verso un «nuovo» illuminismo
«Si è responsabili del potere che ci è assegnato, il quale è inevitabilmente trascurabile quanto a efficacia storica, ma immenso in
se stesso, tanto da non potersi nemmeno sperare di esercitarlo interamente, poiché si estende su tutti i pensieri e le immagini che
affiorino alla nostra mente.»
Questo brano ricorre nel saggio che vide la luce nel 1964 sulla rivista romana «Elsinore».34 S'intitolava Per un nuovo illuminismo ed
era il fulcro della prima di due lezioni che EZ tenne l'anno dopo a
Venezia, alla Fondazione Cini, nell'ambito del ciclo «Arte e cultura
nella civiltà contemporanea». Il tema della seconda lezione era stato
«Le macchine e il fantasticare», argomento al centro dell'opera Storia delfantasticare pubblicata quello stesso anno.
Dal 1959 ogni settembre all'isola di Saii Giorgio i Corsi Internazionali di Alta Cultura diretti da Vittore Branca (m. 2004) richiamavano studiosi, studenti e gente comune disponibile a intendere
la cultura come una georgica dell'animo (l'espressione è di EZ), e la
mediazione intellettuale come una sua insostituibile prerogativa.
Il dibattito sulle «due» culture, l'umanistica e la scientifica, animato da Charles P. Snow nei primi anni Cinquanta, esigeva un lifting meno ambiguo di quello timbrato McLuhan quando il so-
ciologo canadese aveva espresso sulla società mediatica il seguente
giudizio: il nostro è un mondo nel quale «non ci si domanda più
se venga prima l'uovo o la gallina perché sembra che la gallina sia
un'idea dell'uovo per ottenere più uova».35
Se si è disposti ad ammettere che la gallina sia un ¿¿¿»dell'uovo,
questo, aveva detto EZ, è un ragionamento a occhio e croce platonico col quale il «mondo» di cui parlava McLuhan non può esimersi dal fare i conti. E, a proposito della smisurata fascinazione
esercitata dagli idoli moderni, il progresso, la scienza, l'azzeramento dei valori spirituali, ammoniva con un piglio da predicatore, attingendo a un passo dell'Antico Testamento, un sorso del
profeta Geremia: «Gl'idoli sono simili ad uno spauracchio in un
campo di cocomeri: non possono parlare [...]. Gl'idolatri con una
cosa accendono il fuoco ed in quella stessa cosa hanno fiducia,
dottrina di vanità! [...]. Io so, o Signore, che la via dell'uomo non
è in suo potere, né è dato all'uomo che cammina di dirigere i propri passi (GeremiaX, 5-23)».
«Per religione costituita» aveva aggiunto «s'intende un edificio
sociale fondato sulla riverenza interiore collettiva verso un oggetto non esauribile mediante discorsi dialettici; tale oggetto si
denomina diabolico se il suo culto ha come effetto turbamenti e
rovine, divino se viceversa procura la pace, l'accettazione e la trasformazione del dolore, l'adeguamento a forme esteticamente armoniose.»36
Impercettibilmente il pubblico in ascolto s'era diviso in due
schiere. La prima, risentita per le bordate contro la scienza (e lo
scientismo) accusati di dispensare una moneta il cui luccichio
da una faccia, il progresso visibile, impedisce di scorgere il regresso sull'altra. La seconda schiera s'era astenuta dal prendere
posizione. La percezione che l'oratore facesse intravedere orizzonti sorgivi, liberi dai dogmi del progressismo moderno, fu avvertita di netto e uno spiraglio a un ascolto senza pregiudizio si
apri.
Riletti dopo tanto tempo certi passaggi della lezione veneziana
vibrano ancora della forza trascinante che li aveva pervasi:
Esiste un assurdo alla radice della scienza moderna: come può lo
spirito umano porsi a giudice di un processo cosmico di cui si ritiene il prodotto?
Si spezzò con Cartesio la possibilità d'una educazione simbolica
diretta dell'uomo: dopo di lui tocca prima criticare l'imperio delle
scienze moderne, quantitative, cioè ridurle ai loro limiti se ci si
vuole disporre a riacquistare le nozioni tradizionali.
La scienza moderna è fondata su un sacrificio che la religiosità tradizionale non può non giudicare satanico: l'ablazione della spiritualità, cioè della capacità di leggere come simboli di verità trascendenti tutte lefigurestoricamente visibili o udibili.
37
Oggi è stato impiantato in tutti il riflesso condizionato onde ci si
domanda, dinanzi ad ogni problema, se esso abbia un aspetto sociale, divulgativo [...], ovvero se esso non sia «condannabile» in
quanto riservato a pochi e solerti, se non sia «d'élite», e vengono in
malafede confusi i giusti e i dotti con i satrapi o con i liberti ambiziosi di distinzioni sociali.
38
Nell'ultima parte della conferenza EZ aveva citato lo storico della
scienza Giorgio de Santillana, uno studioso «agli antipodi di Bertrand Russell e, in genere, dell'epistemologia moderna». «Fintanto che la scienza sarà viva e non sterile» aveva detto de Santillana «dovrà presentare ciò che presentava la metafisica.» E aggiungeva: «Fermi sapeva troppo del neutrino per considerarlo un
mero accorgimento contabile».39
In precedenza Zolla aveva chiamato in causa Marius Schneider,
specialista di un campo, l'etnomusicologia, lontano da quello di
de Santillana. Eppure ambedue gli studiosi invocavano una rieducazione simbolica dell'uomo moderno, una scienza capace di metaforeggiare. C'erano altri a sostenerlo? - s'era domandato lo scrittore guardandosi attorno. Perché non radunarli?
Scoccava il 1966 e l'incarico conferito a Zolla da un istituto di
cultura romano gli offrì l'occasione per tentare l'impresa.
5. Il convegno sui valori permanenti nel divenire storico
Nel cuore antico della capitale un palazzo patrizio attorno al 1966
si era animato di un fervore insolito. Una targa segnalava all'ingresso la sede dell'Istituto Accademico di Roma,40 e le iniziative
che l'Istituto promosse nel giro di un triennio furono avviate in
una sala al primo piano, su un tavolo ingombro di carte ma ordinarissimo al quale sedeva un signore sui quarantanni, intento a
fare e raccogliere telefonate, a ricevere i visitatori facendo loro capire con garbo che ogni parola da spendere nei minuti a disposizione doveva andare a segno senza spreco.
Nel ruolo che l'Istituto Accademico conferì allo scrittore tra il
1966 e il 1968, egli non perse tempo. Progettò l'allestimento di un
Dizionario dei simboli inesistente in Italia. Un'impresa erudita che
si sarebbe detta inadatta a incidere sugli andamenti culturali del
momento. Ma Zolla illustrando il progetto, mostrava che non era
così. Dopo aver menzionato i precedenti più autorevoli di dizionari del genere nelle principali lingue europee41 e delle maggiori riviste e collezioni di simbologia fuori d'Italia,42 scriveva:
È indubbiamente ancora un fenomeno di avanguardia culturale la
netta percezione di una fase remota della civiltà umana, per nulla
inferiore alla civiltà scientifica moderna quanto a capacità di organizzazione metodica dei dati dell'esperienza, intendendo per
«esperienza» non solo i fenomeni esteriori dell'uomo ma anche
quelli interiori, gerarchicamente organizzabili attorno a una percezione dei piani sovratemporali dell'essere. Questa conoscenza
del mondo arcaico è certamente agevolata dalla nuova antropologia di Lévi-Strauss e dalla conseguente confutazione del mito d'un
universo prelogico primitivo. Ma è anche l'apporto di calcoli
astronomici come quelli di un Hoyle ad avviarci verso una prova
inoppugnabile della fioritura d'un pensiero scientifico almeno databile al 7000 a.C., al tempo delle grandi costruzioni megalitiche
ed è singolare che siano stati i calcolatori elettronici ad aiutare tali
ricostruzioni di archeologia culturale. [...] Il linguaggio della
scienza arcaica fu un linguaggio simbolico, e il simbolo in tale con-
testo ha la duplice funzione di indicare operazioni scientifiche e
stati interiori di minore o maggiore vicinanza all'intuizione dell'essere assoluto.43
Nel progettare il Dizionario dei simboli e un ciclo di conferenze
preparatorie a un convegno internazionale in programma nell'ottobre del 1968, Zolla non agiva da solo. Lo affiancavano i
membri del comitato scientifico dell'Istituto Accademico, e non
si trattava di persone qualsiasi ma di un gruppo di intellettuali e
docenti universitari decisi a offrire un'alternativa al lassismo e
allo scollamento dei valori cristiani in atto nel tessuto sociale italiano di quegli anni. Tra loro spiccavano storici come Paolo
Brezzi, esperti di etica e scienze politiche come Sergio Cotta e
Augusto Del Noce, filosofi come Michele F. Sciacca, drammaturghi come Diego Fabbri, linguisti come Giacomo Devoto. Nel
fascicolo di presentazione toccò a Sergio Cotta illustrare gli scopi
e le attività dell'Istituto Accademico per il triennio 1966-1968.
Nelle sue 68 pagine, quel fascicolo, ora introvabile, documenta
un momento delicato nella vita culturale del Paese, forse poco
noto alla generazione dei nati negli anni Ottanta, nipoti di quella
cui Zolla appartenne. E non è meno diffìcile mettere oggi le mani
sul trio di vecchi volumi, due a cura dell'Istituto Accademico e
uno pubblicato da Vallecchi, che contengono gli Atti del convegno sui valori permanenti nel divenire storico, e i testi delle conferenze preparatorie tenute a Palazzo Torlonia sotto la sommessa
supervisione di EZ. Quei testi sono raccolti in un volume rilegato
in tela avorio di circa 200 pagine. Sul dorso un'etichetta in cuoio
a lettere dorate reca tra la cima e la base, con le iniziali dell'Istituto
e le date 1967-1968, i nomi dei sette conferenzieri: Giorgio Diaz
de Santillana, Jean Servier, Mircea Eliade, Hans Sedlmayr, Michele F. Sciacca, Paolo Brezzi, Giacomo Devoto.44
La diffusione in Italia delle opere di questi studiosi avvenne in
gran parte per iniziativa di Zolla nelle collane di Boria, Rusconi,
La Nuova Italia, in ampio anticipo su linee editoriali che molti
anni dopo consacrarono autori come John Ronald Reuel Tolkien,
Giorgio Diaz de Santillana e Herta von Dechend, Marius Schnei-
der, Joshua A. Heschel, John Epes Brown, Seyyed Hossein Nasr,
Amadu-Hampàté Bà per non parlare di Pavel Florenskij. Se La
colonna e ilfondamento della verità usci in prima edizione mondiale da Rusconi nel 1974, lo si deve a Zolla che non appena intercettò un testo di Florenskij su un vecchio numero della rivista
del Patriarcato di Mosca e ne fu conquistato, convinse Alfredo
Cattabiani (m. 2003), allora direttore dei Saggi Rusconi, a pubblicare l'opera maggiore di Padre Florenskij. Altri suoi testi furono pubblicati su «Conoscenza religiosa» nel fascicolo 2,1977, e
lo stesso anno EZ curò per Adelphi il magnifico saggio sull'icona
Le porte regali traducendolo dal russo.
I motivi che ispirarono il convegno internazionale del 1968 erano
illustrati da Sergio Cotta nella prima parte del fascicolo dell'Istituto Accademico.
Una visione dell'uomo soffocata dallo storicismo, dall'evoluzionismo e da uno scientismo indifferenti a una filosofia dei valori, scriveva Cotta, era smentita dai recenti studi antropologici
che rintracciavano «la presenza nell'uomo di caratteri e di strutture costanti sotto il variare delle forme e dei simboli. Da questo
fervore di studi emerge una rappresentazione dell'uomo che non
è né tutto realizzato dall'origine, né tutto costruito (e costruibile)
dalla storia, ma un uomo che è initium creaturae nel pieno e ricco
senso di questa espressione scritturale».
Gli intellettuali che alle soglie del Sessantotto gravitarono attorno all'Istituto Accademico furono d'accordo nell'individuare
quel dato fondante in una originarietà dell'essere che si manifesta
nel farsi della storia. Il tema del convegno: «I valori permanenti nel
divenire storico» era dunque un appello a esplorare la permanenza
e la trasformazione dei valori umani non come un dilemma tragico
ma come una relazione carica di fiducia e potenzialità positiva.
L'inaugurazione in Campidoglio il 3 ottobre 1968 avvenne
sotto la presidenza di Eugenio Montale. Luigi Pareyson nella prolusione di apertura denunciò lo svuotamento di una cultura impedita di riconoscere valori nei quali affiori una presenza originaria e profonda: «Il problema è di distinguere [...] fra ciò la cui na-
tura e il cui valore si esauriscono nella storicità, e ciò la cui storicità è apertura e tramite all'essere, e quindi sua sede e apparizione».45 La seconda parte della relazione di Pareyson toccava in
esteso il concetto di tradizione, vista come «l'opposto della rivoluzione perché la rigenerazione ch'essa richiede è di tutt'altra natura di quella propugnata dalla rivoluzione, avendo un carattere
originario e ontologico mentre quest'ultima ha solo un carattere
secondario e temporale».
Tra il 3 e il 5 ottobre46 presero la parola John Epes Brown, Germaine Dieterlen, Gilbert Durand, Jean Servier, Marius Schneider,
Eric Voegelin, Cyrill von Korvin Krasinski tra vari altri. Studiosi
che nei rispettivi campi avevano dischiuso aspetti della cathédrale
engloutie evocata da Giorgio de Santillana nella sua relazione, un
mondo di conoscenze sommerse che Zolla si avviava a portare alla
luce nella rivista «Conoscenza religiosa» fondata alla Nuova Italia
nel 1969.
Gli Atti del convegno romano ebbero due edizioni: la prima, a
cura dell'Istituto Accademico, è un volume di 497 pagine. Ai testi
nelle lingue originali segue la versione italiana.47 L'altra edizione,
Eternità e storia, fu pubblicata da Vallecchi nel 1970.
6. «Lume non è se non vien dal sereno»: la quarta parte dell'uomo
Lepotenze dell'anima - l'opera in cui Zolla, allora quarantaduenne,
gettava le basi dell'antropologia spirituale cementata nell'insieme
degli scritti avvenire—vedeva la luce poco prima dei lavori del convegno per il quale aveva profuso tante energie dietro le quinte del
suo ufficio di segretario generale dell'Istituto Accademico.
La bandella originale dell'edizione Bompiani enunciava in
modo chiaro la materia e gli intenti dell'autore. Poiché è quasi impossibile recuperarla, scorriamola con diligenza.
Zolla offre in questo libro una «anatomia spirituale» dell'uomo:
egli mostra cioè come le diverse culture e religioni hanno risposto
alla domanda: quali sono le facoltà spirituali dell'uomo? Ma poi-
ché il suo interesse non è puramente storico bensì metafisico le
varie civiltà (classica, ebraica, egiziana, indiana, buddhista, oltre al
cristianesimo) vengono esaminate con metodo morfologico, extrastorico, giungendo a riconoscere una fondamentale unità del
genere umano, dai primitivi al cristianesimo. Da questa indagine
dipendono però anche conseguenze di ordine più immediato e
quasi pratico: infatti la consapevolezza della complessità umana,
delle «potenze dell'anima», è condizione per definire ciò che costituisce l'unità degli uomini, è possibilità di parlare in senso rigoroso di concetti come «spirito» o «destino», ed è infine avviamento
a una vita felice.
Un pensiero di Simone Weil citato in calce («Non c'è niente di
più importante che il concetto dei piani sovrapposti della coscienza, di cui l'ultimo è superiore alla psicologia»)48 conduce il
lettore al cuore del problema esaminato nella prima parte del
libro: l'antropologia dell'uomo infelice.
Secondo Zolla l'infelicità del soggetto moderno ha alla sua radice una penuria spirituale cresciuta a mano a mano che una credenza e un culto si sono imposti tacitamente. La credenza è che
l'uomo consista esclusivamente di tre parti: corpo, ragione e
anima, alle quali sono stati tributati culti distinti. Il materialismo
rispetto al corpo; lo scientismo rispetto alla ragione, e l'irrazionalismo rispetto all'anima o psiche. I riflessi dell'uomo moderno sono
stati condizionati al punto «da trasformare la sua interiorità in una
replica fedele di quel triangolo carcerario»: una condanna a vita.
Zolla cosi argomentava:
Il corpo, la psiche e la ragione si nutrono soltanto di parvenze in
divenire, di storia, ma la ragione, adoprando le mere regole della
coerenza, dovrebbe pur concludere che è insensato asserire:
«Tutto è contingente» (con le varianti: «Tutto è nella storia»,
«Tutto diviene»), perché nel tutto si dovrebbe includere anche
questa proposizione che, non potendo essere assoluta né eterna,
impone la smentita di se stessa. Inoltre la ragione deve riconoscere
di rifarsi a dei princìpi di coerenza di per sé evidenti, per esempio
che una cosa non può essere esistente e inesistente nel contempo.
Tali princìpi o assiomi non sono dimostrabili, essendo la fonte
delle dimostrazioni, ma non sono nemmeno irrazionali, perché,
se lo fossero, non potrebbero impartire una razionalità di cui sarebbero privi; saranno perciò a dirsi sovrarazionali.
Occorre dunque postulare l'esistenza di un piano più elevato
della ragione e dell'anima, il piano dell'intuizione intellettuale: la
«quarta» parte dell'uomo. Quando Dante dice: «Lume non è, se
non vien dal sereno / che non si turba mai» (ParadisoYJX., 64-65),
intende il piano sovrarazionale che la ripartizione moderna ha disinvoltamente obliterato.
Con una concordia che non può essere casuale «le quattro parti»
precisava «si ritrovano in tutte le tradizioni che non postulino la
preminenza dello stato bestiale».
Nella storia della filosofia cristiana basterà retrocedere all'età
della Scolastica per avvedersi che la triade moderna è stata amputata di una quarta parte: l'intelletto. Denominazioni alternative di
intelletto- ricordava EZ - sono: spirito nel senso di atto del respirare, giacché «esso sta alla ragione come il respiro agli esseri viventi»; lume della ragione, nel senso che la ragione è messa al suo
servizio; oppure anche sapienza perché «come assaporando (latino
sapere) essa afferra il suo oggetto in modo immediato». Inoltre non
sfugge alla mente tradizionale che l'uomo, come sosteneva Platone, può solo ricordare i princìpi dell'intelletto, non crearli.
Non appena affiori il ricordo che esiste una quarta parte dell'uomo, questa presa di coscienza è sufficiente a far riemergere l'idea sopita e modernamente perseguitata, di «intelletto d'amore».
Da quel punto in poi ridiventa possibile prefigurare e configurare
un'antropologia dell'uomo felice, felice nel senso di orientare deliberatamente la sua vita al conseguimento dei fini nei quali consiste il valore non caduco di vivere.
Simili ragionamenti erano un palese invito a intendere il risveglio all'intelletto d'amore come una prerogativa intrinseca alla
natura spirituale dell'uomo, non un privilegio riservato a un'élite
arroccata su una «torre d'avorio». E sulla torre d'avorio come
luogo eletto dell'interiorità invece che immagine di selezione sociale, lo scrittore in più di un'occasione si era soffermato. Inutilmente, giacché i suoi interlocutori non erano affatto disposti a riconoscere una differenza così sottile.49
Proprio agli inizi del 1968 il «Corriere della Sera» aveva invitato due
intellettuali «fuori del coro» a dare un giudizio sull'ora presente. Un
filo diretto era intercorso tra Giorgio Vigolo e EZ,50 e la lettera che
i due scrittori si erano scambiata apparve in Terza pagina il 25 febbraio sotto il titolo interrogativo: Disprezzare il nostro tempo?
C'è un limite, senza dubbio — ragionava Vigolo - entro cui si deve
accettare il nostro tempo, se non altro per viverci e, meglio ancora,
per capirlo, per esprimerlo in ciò che ha di più segretamente sofferto e soffocato, in ciò cui aspira dal profondo e che né gli scienziati né ifilosofiné i politici possono dargli [...]. Ci vuole — proseguiva — un coraggioso anticonformismo o diciamo anche una
scintilla prometeica di ribellione per contrapporre alla stasi del
tempo attuale «soluzioni inattuali, oggi appena intraviste, forse
ancora impensabili distintamente, come sono impensabili i fiori
in una notte polare».
Zolla rispondeva:
Caro Vigolo, accettare non è approvare. Accettare il proprio tempo
(ma il proprio destino, non il tempo di tutti e di nessuno) è un
ovvio dovere; approvare consuetudini, ideologie, istituzioni soltanto perché del proprio tempo è del narcisista («se ci vivo io!») o
dell'atterrito («forse se lo approvo non mi farà troppo male») e comunque dello stolto (non si comprende perché l'essere nostre contemporanee le nobiliti). L'avvenire «buono» sarà imprevedibile? La
tua metafora delfioreinconcepibile tra i ghiacci è certamente bella
ma parzialmente veritiera, poiché le stesse norme che reggono i cristalli delle nevi dispongono i petali attorno alla corolla [...], dunque anche su una banchisa si possono conoscere le uniche forme
possibili che qualunque realtà futura dovrà assumere, se sarà armo-
nica e non cancerosa. Cosi è dell'uomo: che potrà essere ogni suo
concepibile futuro se non una distanza minore o maggiore dal
punto di perfezione, che non è nel tempo né del tempo? [...]
L'assolutamente nuovo, staccato dall'idea permanente della perfezione, quale tutti i tempi hanno coltivato o represso, è il puro inferno. Ed è anche una premessa di molte truffe: «Signori il futuro
non è forse una cambiale in bianco? Eccovela, firmate» è il discorso di tutte le avanguardie e dei progressisti. I «tempi», il «progresso» non sono concetti chiaramente definibili e nella misura
della loro incertezza, se ne appropriano, proclamandosene i rappresentanti, le canaglie. Rammenti Goethe? A proposito di ciò
che chiamava «quello schifoso fantasma, lo spirito dei tempi»,
scrisse: «Ciò che per lo più si chiama spirito dei tempi, il più delle
volte non è che lo spirito di lorsignori».
Chi come te - concludeva - conosce i dileni reali e tradizionali
non fantasticherà certo di ipotetici futuri ma accetterà il suo individuato destino senza esitare a disprezzare il suo tempo. La prima
cosa con la delicatezza del tuo Hölderlin, la seconda col vigore divertito del Belli.
Il (tuo anche lui)
Elémire Zolla.
La lettera scambiata tra i due scrittori è un piccolo documento
d'epoca. Rispecchia due diversi modi d'intendere e giudicare quel
cruciale momento storico: pervasa d'inquietudine ma non chiusa
alla speranza la presa di posizione di Vigolo, recisa e tassativa
quella di Zolla.
Nel 1998 EZ confessava: «Ero a quel tempo sfiorato, impensierito dalla depravazione circostante, tanto da volerla fugare; raccattai ciò che nella storia dell'Occidente poteva apparire limpido
e fermo e ne feci il centro d'un mandala, nel quale tutto si rischiarasse e il disordine allentasse la presa».
Questo brano ricorre nelle pagine d'avvio alla riedizione
Adelphi 1998 di Che cos'è la tradizione, l'opera che nel 1971 chiudeva il ciclo degli scritti anti-moderni con un'indagine nitida e
appassionata sul concetto più preso di mira dall'ideologia pro-
gressista in quegli anni: la Tradizione. Quanti fiumi di parole
sono corsi contro e a favore di essa - come se la persistenza o la
sparizione della «memoria» (questo, e non altro, realmente significa «tradizione») fosse appesa al filo del vilipendio o dell'ossequio
nei confronti di ciò che si vuole atavico o immerso nel divenire
storico. In India l'adesione o il ripudio della tradizione assunse
una virulenza persino maggiore che nell'Occidente ebraico-cristiano, tuttavia senza mai mettere in discussione il volto della memoria tradizionale, che 11 è duplice. Intesa come éruti (alla lettera:
ciò che è stato udito), la tradizione è il lascito di verità incorruttibili affidate alle formule sacre (mantra) di cui i maestri spirituali
posseggono la chiave di esperienza interiore. Intesa come smrti
(alla lettera: ciò che viene trasmesso), la tradizione è sottoposta
alla stessa legge di contraddizione, tradimento e falsificazione che
vale per le cose di questo mondo. In ultima analisi le due anime
della tradizione, l'incorruttibile e la caduca, esprimono gradi diversi del manifestarsi del dharma (la legge cosmica) negli smisurati cicli del tempo.51
Zolla percepì con chiarezza la differenza, e la formulazione che
ne diede in Che cos'è la tradizioneè conforme alla nozione indiana,
seppure il tono adottato allora nel contrapporre a una civiltà custode delle verità tradizionali (la civiltà del «commento») una civiltà immersa nel gioco delle forze mondane (la civiltà «della critica») sia carico di un'esasperazione indubbiamente manichea di
cui egli stesso si sarebbe in seguito pentito. Infatti nel 1998 confessava: «Pagai un prezzo, oggi me ne dispiace; l'orrore fu maggiore della volontà di ignorare i dualismi».
Questi accenni aiutano a percepire il travaglio vissuto dallo scrittore negli anni che precedono la stesura in inglese del trattato sugli
Archetipi, l'opera, s'è detto, che accanto a Le potenze dell'anima e
Che cos'è la tradizione costituisce una pietra di volta nell'edificio
speculativo di Zolla.
Quando nel 1998 Che cos'è la tradizione veniva ristampato da
Adelphi, una domanda era stata posta all'autore: «Che cos'è la tradizione inizia con la citazione petrarchesca dell'ascesa al monte
Ventoso della storia. Cosa vediamo da lassù?».
Aveva risposto: «Dipende. C'è il momento in cui dall'alto di un
monte si contempla la campagna circostante in modo perfetto
perché la distanza si fa enorme e quindi ci si vede legati a tutto ciò
che ci circonda. C'è anche il momento in cui le nebbie offuscano
tutto e forse è il momento più perfetto, perché tutto sta al di là
della nebbia».
«E le nebbie possono essere identificate con le epoche storiche?»
«Sono il momento in cui si va al di là dell'epoca storica, in cui
l'epoca storica può essere una qualunque, non importa. Quando
all'improvviso io mi trovo in mezzo a una campagna, e la nebbia
mi circonda e mi separa... potrei essere al momento in cui si scontrano le truppe di Annibale con quelle dei romani, posso essere
l'altro ieri... vado oltre la segmentazione storica, oltre la divisione
fra presente passato e futuro.»
«È un velo che si apre?»
«Eh si, un velo provvidenziale, che copre le illusioni della
storia.»52
7. Una conoscenza «religiosa»
Verso la fine del 1968 Federico Codignola, figlio del proprietario
della Nuova Italia a Firenze, il senatore Tristano, andò a trovare
EZ all'Aventino, e inaspettatamente gli propose: «Vuoi fare una
rivista? Te la pubblica mio padre».
Fu un'avventura eccitante ma faticosissima. Per cominciare, i
testi degli autori non italiani - ed erano la maggior parte - bisognava tradurseli da sé; ogni fascicolo di oltre cento pagine,
quando non si trattava di numeri doppi, andava costruito dall'a
alla zeta, e la cadenza trimestrale non lasciava margini. Le ore che
lo scrittore trascorreva in treno tra Roma e Genova, dove aveva
sulle spalle la direzione dell'Istituto di Lingue e Letterature straniere alla facoltà di Magistero,53 erano utilizzate fino all'ultimo
minuto per le traduzioni. La corrispondenza con gli autori, la stesura dei propri testi,54 gli editoriali e tutto il resto, avvenivano in
un tempo che suppliva alla brevità con la condensazione, e c'era
da scommettere che l'ora in cui i materiali dovevano essere consegnati al corriere romano della Nuova Italia, era raggiunta con
ampio anticipo.
L'editoriale del primo numero di «Conoscenza religiosa» contiene una vibrata denuncia del turbamento e della sete di autentica spiritualità in quello specifico momento storico. È un testo
programmatico che merita di essere conosciuto al di là della cerchia dei lettori dell'indimenticabile rivista.
È noto — affermava Zolla — che Dio ci si presenta sotto la maschera
del povero. È meno noto che questo povero è assai difficile a riconoscere essendo povero colui dal quale istintivamente si distoglie lo
sguardo oppure sul quale sifissauno sguardo che non vede nella
misura stessa in cui si finge o crede umanitario [...]. Il povero di
oggi non è fàcile a riconoscersi perché è colui che disturba i nostri
pregiudizi più radicali. Il sapiente Dogon, Alce Nero erano certamente poveri fra i poveri, la loro sapienza chi poteva non deriderla
0 compatirla o non volerla preservare sono la vetrina di un museo?
Soltanto uno sguardo religioso poteva vedere quella povera sapienza come un raggio dello Splendore. E soltanto una straordinaria attenzione può vedere dietro la maschera del giovine dagli occhi
vitrei e dalle mani tremanti, dalle vesti che cupamente simulano
uno spirito di libertà e che ripete i vecchi motti del libertinismo europeo [...] può vedere, si dice, la vera faccia, che è supplichevole e
miserabile e sta chiedendo qualcosa di inimmaginabile, per lui e
per la torma che lo circonda [...]. Per quanto paia incredibile, egli
sta chiedendo un lembo di quella sapienza che tutto nella civiltà
moderna cospira a reprimere. Egli sta mostrando a che cosa conduce la repressione dell'essenza religiosa dell'uomo [...].
La rivista che si presenta si propone di [...] offrire i testi che aiutino
a uscire da una cultura che non osa nemmeno affrontare la dialettica dell'illuminismo. Gli strumenti stessi della cultura dominante, di qualsiasi posizione od obbedienza essa sia, sono virtualmente distrutti: le alme madri sono diventate le «vecchie da segare», le lugubri Befane dei carnevali tecnocratici [...]. È certo che
1 loro figli avevano appreso soprattutto il disprezzo della cono-
scenza sapienziale che pure era custodita sotto il logoro mantello
dei selvaggi. E verso quei selvaggi tutt'al più guardavano con l'occhio del libertino settecentesco. E come sempre chi reprime si reprime. Chi ferisce sta amputando la propria sensibilità. Chi rifiuta
di vedere si sta accecando. L'Occidentale potrà ritrovare nella nozione dell'Essere che egli ha represso, il momento di stupore, di
estasi intellettuale, di libertà e di conoscenza col quale qualcuno
come lui udì una frase come «sono chi sono» in un passato che la
repressione ha reso leggendario?
Forse si è spiegato - concludeva - perché sarebbe buffo dire che
questa rivista è dedicata all'etnologia, anche se pubblicherà testi
etnologici; che è dedicata alla teologia, visto che non avrà motivo
di pubblicare pagine teologiche che siano disgiunte dall'esperienza del divino e rispondano al puro e degno bisogno di ordine
razionale entro un sistema; dire che è dedicata all'ecumenismo, essendo i suoi fini distinti da un'amabile amministrazione dei rapporti di buon vicinato tra le confessioni.
55
Il primo dei testi ospitato nel fascicolo inaugurale, La meraviglia,
era di Abraham Joshua Heschel, il cabbalista e teologo ebreo che
dedicò a Zolla l'edizione italiana di Passione di verità. Seguivano
La simbologia della danza di Marius Schneider; Conoscenza dell'uomo negro dell'etnologo Marcel Griaule; Prolegomena allo studio del testo biblico di Heinrich W. Guggenheimer; una silloge di
poesie di indiani d'America; l'Ode a Terminus di W. H. Auden a
cura di Carlo Izzo; Galerie religieuse di Djuna Barnes, e il poema
Missa romana di Cristina Campo. 56
Di ogni autore il cui testo compariva per la prima volta, erano
forniti un profilo e una scheda bibliografica. La messe di informazioni era più doviziosa quando si trattava di un autore sconosciuto in Italia e ciò accadde spesso. Il sodalizio tra i collaboratori
della rivista durò quattordici anni e se con l'uscita dal mondo di
«Conoscenza religiosa» nell'annata 1983, gli studiosi e i poeti che
le diedero vita, dileguarono, le idee instillate nelle 7000 pagine
dei suoi sessantasette fascicoli hanno resistito ben oltre l'età delle
battaglie intellettuali di Zolla e la sua stessa vita.
Non erano stati in pochi a chiedersi e a chiedergli: se la conoscenza impartita nella rivista non è confessionale, in che senso allora è religiosa?.
In quegli anni e da allora in poi, Zolla non risparmiò occasione
per stigmatizzare la distanza tra un'adesione confessionale e l'apertura a una dimensione e a un'esperienza del sacro che si pone
al di là delle barriere tra i singoli credo. In questo senso è necessario chiarire che Zolla fu e rimase un intellettuale laico. Laico nel
senso che il fenomeno religioso, la presenza di un senso del divino
impresso come uno stampo nella mente umana, fu indagato
come un problema epistemologico prima che esistenziale, e il
perno attorno al quale ruotò fu la natura profonda del credere,
quali che siano le individuazioni dell'atto di fede nella storia dei
processi culturali. Questo per Zolla era stato un problema urgente non perché lo riguardasse in persona, dato lo scarso rilievo
che era disposto a concedere alle urgenze «personali», ma perché
la situazione storica all'epoca lo imponeva. La critica radicale che
lo scrittore formulò negli anni Sessanta alla resa deliberata della
Chiesa di Roma alla svolta progressista statuita dal Concilio Vaticano II, va letta in questa luce.57
8. Uno pseudonimo colmo di segreti
Torniamo indietro di qualche anno. Nel triennio 1965-1967 sul
quotidiano di Roma «Il Giornale d'Italia» prese a comparire una
firma mai vista prima. Era di un articolista che una volta su dieci,
inaspettatamente, intingeva la penna nel miele al posto del fiele.
Gli habitué del quotidiano curiosavano ogni volta in Terza pagina
se gli toccava la purga o l'elisir, e risulta che dietro la firma di Bernardo Trevisano, o le iniziali B. T., si nascondesse anche un'autrice assai prossima allo scrittore, come segnalava lo stesso Zolla
nel 1987 recensendo l'opera di Cristina Campo Gli imperdonabili,58 Ma gli articoli schedati nell'archivio di Zolla e appresso
elencati sono opera sua.
Tra l'I gennaio e il 28 settembre 1966 c'era stata una serie di el-
zeviri sui segni dello zodiaco da Capricorno a Scorpione. L'affondo
nello spirito astrologico avveniva dalla parte di una compiuta filosofia del destino che pareva beffarsi allegramente degli argomentucci «ci credi?», «non ci credi?» che la lettura o l'ascolto alla radio
dell'oroscopo quotidiano suscitano immancabilmente.
Che l'astrologia sia un sapere con un sostrato matematico antichissimo e velato non ha nulla a vedere con la trivialità degli oroscopi ordinari. La mente di Zolla, incoercibilmente attratta dal velame, con la scienza velata per eccellenza s'era trovata a casa, e gli
scritti astrologici attraverso le stagioni della vita si erano infìttiti fino
a comporre un corpo di prose a sé stanti, esaminate nel capitolo
Esodi nell'altrove: il destino e lo zodiaco e in parte raccolte negli Scritti
zodiacali. Prima però di arrivarci, un paio di dilemmi chiedono di
essere sciolti. Il primo riguarda l'identità di Bernardo Trevisano.
Chi era costui?
Alla luce delle scarne notizie storiche, si fronteggiano due ipotesi: che il Trevisano fosse un patrizio così chiamato perché originario della marca trevigiana o che venisse da Treviri in Germania.
Senonché i trattati di alchimia annoverano Bernardo tra i maestri
dei segreti del primo Rinascimento. Nato nel 1406, avrebbe
avuto facoltose sostanze di cui a un certo punto si sarebbe sbarazzato, non prima di aver svolto transazioni finanziarie in quel di
Rodi dove visse per qualche tempo. Seguace del pensiero di Aristotele ed esperto di medicina galenica, in tarda età sarebbe divenuto padrone dell'Arte lasciando, tra altri scritti, un'opera sulla
«filosofia naturale dei metalli», e un trattato di filosofia ermetica
nel quale campeggia la favola di un re rigenerato alla fonte della
Vita, trasparente allegoria dei procedimenti mercuriali di trasformazione e «redenzione» alchemica della materia.
Amico di Tommaso da Bologna, che fu medico personale di
Carlo Vili re di Francia, Bernardo gli indirizzò una epistola dove
esprimeva gratitudine per il dono «grandissimo» di una pietra da
lui ricevuta (la pietra filosofale?), che lo ripagava degli erculei tentativi compiuti nelle segrete operazioni dell'arte.59
Perché nel periodo in cui collaborò a «Il Giornale d'Italia» EZ
si firmasse Bernardo Trevisano rimane senza una chiara risposta.
Più di un indizio fa pensare alla forte attrazione dello scrittore per
uno dei protagonisti della «letteratura dei segreti» fiorita in Europa in età pre-moderna. Il nome dell'alchimista del primo Quattrocento può essere stato lo schermo dietro il quale, un po' per
celia un po' sul serio, lo scrittore riparò la sua vocazione all'esoterico in un tempo tra i più negati a tollerarla.60
9. Cronologia ragionata degli articoli zolliani a firma di Bernard
Trevisano o siglati B. T. su «Il Giornale d'Italia»
La serie inizia con il pezzo su due colonne Le opere di Guénon (8
novembre 1965), a proposito di alcune edizioni italiane a cura
della «Rivista di studi tradizionali» cui faceva capo a Torino la casa
editrice omonima. 61
L'I 1-12 novembre era la volta di L'urlo delprofeta e il sorriso dell'ex ufficiale inglese sulla versione italiana presso Guanda di una
raccolta di poesie di uno tra i maggiori letterati del nostro tempo,
«il migliore, senz'altro in Inghilterra», Robert Graves.
Egli si fece conoscere da noi prima della guerra quando Bompiani
stampò le sue biografie dell'imperatore Claudio, ma non ha mai
riscosso una gran fortuna [...]. Purtroppo - segnalava - Longanesi stampò col titolo La dea bianca una raccolta di scritti vari,
assai divertenti ma per lo più frivoli, usurpando il titolo del
grande trattato The White Goddess, il monumento cui forse più
saldamente s'affida la fama di Robert Graves: si tratta di una decifrazione delle antichissime scritture celtiche del popolo gallese,
note come Mabinogium, dove l'autore mette a frutto un'erudizione che copre tutto il campo delle mitologie e delle letterature.
Da quell'opera erano citati brani ai quali Zolla si sarebbe richiamato vent'anni dopo ne L'amante invisibile, cesellando il tema
della dama di sogno nelle religioni, nella letteratura e nella legittimazione politica.
Il 2-3 dicembre era la volta del pezzo Un'arte per camminare a
proposito del libro di Karlfried von Durckheim Hara, centro vitale dell'uomo, pubblicato in Francia da La Colombe. Risale a quel
tempo, se non a prima, l'abitudine di EZ di raccogliere con cura
tutto quanto nella tradizione dello zen giapponese concerne l'arte
di «conoscere la Fonte».
Colui che abbia spostato nel ventre il suo baricentro - osservava
nell'articolo - ha una capacità di prendere decisioni all'istante,
fulmineamente, perché tale facoltà è sempre legata ad uno stato di
apparente abbandono. L'unico che in Occidente abbia lasciato
una trattazione perfetta di questo tema è Heinrich von Kleist nel
suo teatro di marionette (ne usci anni addietro - segnalava - una
versione nelle edizionifiorentineFussi).
E dopo aver elencato gli errori fondamentali che si possono commettere durante gli esercizi per acquistare hara concludeva: «La
respirazione diventerà perfetta quando [...] tutto il corpo sarà imperniato sul suo centro addominale; allora finalmente l'uomo
[...] non ondeggerà più fra la passività e un controllo volontaristico delle proprie emozioni. Lascerà affiorare in se stesso ciò che
è impersonalmente naturale».
Proseguivano nell'ordine: Le delusioni d'un utopista sul discepolo ribelle di Darwin Samuel Butler (16-17 dicembre), e La via
antica dei fiori sull'opera omonima di Gusty L. Herrigel, appena
tradotta presso Scheiwiller.
A chi scrive - confessava Trevisano a un ceno punto - capitò un
giorno, a un congressofilosofico,di accostare un invitato giapponese, domandandogli, dato il tenore del suo intervento, se non fosse
per caso un seguace di Heidegger. Il giapponese sorrise e rispose evasivamente. E soltanto dopo qualche tempo, quando il discorso si fu
orientato su tutt'altro binario, avvertì che il suofilosofareera fondato sulla lingua giapponese. In quell'intervallo fra domanda e risposta egli aveva lasciato ramingare il mio pensiero e Io aveva interrotto al momento giusto: sì, il metodo heideggeriano si sprofondava
nella radice linguistica, ma il senso era tratto dalla struttura del giapponese e non del tedesco. Poi egli mi annunciò che se volevo saperne
di più m'avrebbe parlato alla presenza del suo maestro. L'indomani
ebbi una lezione di filosofia tradizionale in un caffè, con il maestro
seduto immobile e silenzioso al vertice d'un triangolo che egli formava con due discepoli intenti a impartirmi l'insegnamento, consultandosi con lui prima d'ogni frase, con rapidi inchini del capo,
come a sapere se il loro tono era giusto, se stavano dicendo troppo,
se io sembravo all'immobile osservatore abbastanza attento. Guastai tutto con occidentale malagrazia, ponendo delle domande. Era
un'offesa: come dire che essi non intendevano benissimo i miei bisogni, le mie capacità e la giusta gradazione. Mi sovvenni di Mosé e
Aronne nel racconto biblico: il primo faceva tenere dal secondo i
rapporti col popolo, per osservare meglio e non distruggere la propria immagine contemplativa e ieratica, per agire senza agire.
Il 3-4 gennaio 1966 era la volta di un fondo su sei colonne dal titolo La cattiva coscienza delle parole attorno al predominio moderno dell'orizzontalità nella concezione dello spazio e nella scelta
delle metafore linguistiche. Quelli erano gli anni in cui il filosofo
Hans Blumenberg veniva coniando il nome di una nuova scienza,
la metaforologia, e Zolla, alias B. T., nel riportare con ampiezza le
indagini raccolte sull'ultimo numero della rivista parigina «Triades», sottolineava l'abuso di metafore celebranti l'orizzontalità: si
parla - notava - di «ampi» scambi di pareri, di «vasti» poteri, di
«estese» consultazioni, si «allargano» i campi d'indagine, si «ampliano» i problemi, gli orizzonti eccetera e non si parla mai o di
rado di «alte» o «sublimi» o «elevate» concezioni. In un altro articolo, Ilpalazzo difumo pubblicato col suo nome su «La fiera letteraria» (17 marzo 1966), EZ si diffondeva sull'argomento anticipando quelli che, due anni dopo, sarebbero stati i temi al centro
di Le potenze dell'anima: il corpo come fonte di metafore e l'albero lessicale dell'interiorità.
Vediamo di che si tratta. Per indicare l'anima-scriveva in quel
testo - esiste in tutte le lingue una catena o albero lessicale dell'interiorità il cui primo anello è il respiro. Sia il tedesco Geist (spi-
rito) che l'inglese ghost provengono dal sanscrito heda-s, l'ira divina, «e l'ira è designata come un gonfiarsi anch'esso del respiro».
Di qui il dipanarsi di «una raggiera di cose o atti connessi: i polmoni, gli strumenti a fiato, il mantice, il gonfiarsi, l'otre, il cuscino, il guanciale, la vescica, il tumore, il mucchio, l'eccesso, il
pieno e il troppo, l'orgoglio, il bioccolo, la polvere, la nuvola, il
vapore, il calore (dilatante), la nebbia, la pioggia e la rugiada, il
fumo, l'oscurità, la fuliggine, il vento, il freddo, l'eccitazione irosa
0 addirittura folle, la fretta e l'avidità e infine, ultimo anello della
catena o ultima foglia dell'albero, a seconda della similitudine che
si elegga, l'anima o vita o ragione».62
1 pezzi apparsi nelle settimane successive trattavano del pensiero di
Frithjof Schuon, il discepolo di René Guénon ( 13-14 e 24-25 gennaio), e del ritmo magico nella poesia di Pound (27-28 gennaio).
Tra febbraio e marzo l'ermetico Bernardo si occupava del diritto all'opposizione sancito in taluni ordini monastici, della salvaguardia della liturgia tradizionale intrapresa da «Una voce»,
l'associazione di ferventi cattolici anti-modernisti per la quale
s'era strenuamente impegnata Cristina Campo; dei segreti dello
zen e del taoismo, della poesia di Montale, del metodo strutturalista di V. J. Propp applicato ai racconti di magia e altro ancora.
Via via che di settimana in settimana si snodava il rosario degli
articoli, un mutamento sottile si poteva percepire, come se l'attenzione dell'autore inizialmente focalizzata sul presente si dirigesse sempre più indietro nel tempo e sempre più lontano nello
spazio, ad esempio nell'esame delle pitture rupestri nelle grotte
paleolitiche e dei cardini celesti nelle architetture tradizionali in
India, in Egitto, in Cina. E non è casuale che nello stesso periodo,
dietro lo schermo del Trevisano, Zolla ponesse mano a un fascio
di articoli di astrologia tracciando i caratteri dei dodici segni dello
zodiaco. Per offrirne un assaggio, l'analisi di sei di essi incluso il
Cancro, il suo segno natale,63 è riportata negli Scritti zodiacali
(Parte seconda).
Nel frattempo un altro articolo firmato Trevisano usciva l'8
settembre 1966. Era una corrispondenza da Pompei e Ercolano
sulle tracce di tre misteriosi «oggetti»: il segno di croce dissepolto
da una casa a Ercolano, che aveva suggerito a Amedeo Maiuri la
congettura della presenza di ebrei convertiti al tempo dell'eruzione; l'enigmatica scritta «Sodom Gomor» rinvenuta su un
muro a Pompei, e il cosiddetto quadrato magico graffito sullo
stucco di una colonna della palestra e nel portico della casa di Paquino Proculo. Se ne fece cenno nel capitolo 1 a proposito della
struttura della formula latina Sator /Arepo / Tenet I Opera / Rotas,
che si può leggere al contrario: Rotasi Opera / Tenet!Arepo /Sator.
L'ipotesi di Zolla era che le rotas dell'aratro del contadino
Arepo fossero una metafora delle ruote del carro di fuoco su cui fu
tratto al cielo il profeta Ezechiele (Ezechiele I, 4-28). La congettura era così esposta nell'articolo: «Arepo sarebbe l'uomo incaricato da Dio di spargere carboni ardenti su tutti coloro i quali non
abbiano in fronte il segno che li distingue per "coloro che soffrono
dell'abominazione'' (il segno della T, che nell'alfabeto ebraico più
antico era una croce). Il carro di Ezechiele potrebbe essere dunque
una specie di ruota della fortuna che appone laT sulla fronte dei
giusti e colpisce gli empi. Sarebbe dunque un'iscrizione ebraica o
cristiana, adatta alla Pompei flagellata».
EZ riportava poi le interpretazioni ufficiali del quadrato magico, quella del pastore Grosser, che risale - s'è detto - al 1926, e
del Carcopino, ritenuta la più attendibile in una ridda di ipotesi
senza soluzione.64
Poco dopo l'incontro con l'enigma del quadrato magico, Bernardo Trevisano usciva di scena, riacquattandosi negli incunaboli
donde lo scrittore l'aveva esumato in un tempo di svolta della sua
vicenda intellettuale.
10. Il salto del salmone
Verso la metà degli anni Settanta la svolta era segnata da un'opera che fa da spartiacque tra il ciclo di scritti anti-moderni
dove domina il sarcasmo, la perorazione indignata, e quello nel
quale il difensore della Tradizione, eretico nell'intimo ma anche
per il gusto squisito di provocare, scopre le sue carte confessando i veri amori - l'alchimia, la conoscenza dei segreti, gli archetipi, il sincretismo, l'Oriente e le vie di accesso all'esperienza
metafìsica - in un crescendo di ricerche, esperienze e incontri
filtrati nelle corrispondenze di viaggio, nella serie di ricerche pilotate alla Sapienza dove aveva preso servizio alla fine del 1974,65
nelle conversazioni in pubblico e nei libri via via usciti dagli editori Marsilio, Adelphi, Mondadori, Einaudi e Tallone alle soglie
della vecchiaia.
Il testo che fa da spartiacque tra il primo e il secondo periodo
romano è Le meraviglie della natura. Introduzione all'alchimia, ristampato più volte da Marsilio fino all'edizione riveduta postuma
del 2005. In quest'opera dottissima ma priva di cipiglio erudito
dove lo stile canta, lo sciamano e il metafìsico, il maestro dei poteri e l'illuminato s'incontrano nella figura del vecchio alchimista
ritratto al vivo nella Prefazione.
Un giorno a Isfahan un vegliardo dall'aspettofreschissimo(disse di
avere novantacinque anni), scrutando lo scrittore con occhi arguti,
gli aveva domandato:
«Che se ne fa delle erbe?»
«Voglio mettermi a studiare alchimia.»
«Ma, allora provi a modificare il suo corpo, per cominciare. Rinunci alla carne. Si cibi dei latticini della sua mucca o della sua
capra. Deve prenderne cura lei stesso e così la sua essenza le sarà restituita come quintessenza.»
66
«Essenza», «quintessenza»: parole impegnative ormai fuori uso.
Ma non facciamoci intimorire solo per questo!
Immaginiamo di trovarci nei panni di un sempliciotto, una
persona di scarsa istruzione, ad esempio la massaia descritta con
garbo da Pavel Florenskij in una delle Lettere di La colonna e il
fondamento della verità: la sua domestica.
Un giorno, mentre la donna sfaccenda per casa, lui a bruciapelo le
domanda: «Che cos'è il sole?».
Lei: «Il solicello».
Lui: «Suvvia che cosa è?».
Lei: «Ma per l'appunto, il sole!».
Lui: «E perché risplende?».
Lei: «Così: il sole è il sole e cosi risplende. Guarda un po', cosi è, il
solicello...».
Lui: «Ma perché?».
Lei: «Dio mio, Pavel Alexandrovic! Come faccio a saperlo, io? Lei
è istruito, sapiente, e io sono ignorante».
67
È un esempio calzante. Accostare il pensiero di Zolla, lo s'è detto,
non è facile; ci vogliono una buona dose di medcolosa attenzione,
tenacia, docilità e il gusto di affidarsi al ritmo suadente delle parole.
Tra il suono e il senso si aprono varchi, scorciatoie che portano a catturare immagini esalate dalle zone profonde della coscienza dello
scrittore. L'incontro con quelle immagini più trasparenti di altre,
non lascia dubbi: vibra 11 dentro una nota diversa come se l'anima e
il destino di chi scrive affiorassero senza veli in un nodo che solo la
morte può sciogliere. Un paio di metafore, entrambe acquatiche,
carpite in due opere distanti vent'anni l'una dall'altra, offrono una
scorciatoia per cogliere in un sol colpo un aspetto centrale dell'indole di Zolla e un tratto inconfondibile della sua biografia.
La prima metafora s'incontra in un passo di Che cos'è la tradizione.
«L'uomo» affermava «ha bisogno di certezze, di un centro su
cui ruotare come un pianeta intorno al sole. Egli è assai simile alle
carpe che godono e s'irrobustiscono ad avere una pietra posata al
centro del loro specchio d'acqua, intorno a cui volgere giri su giri
armoniosi.»68
La pietra metaforica attorno alla quale il pensiero di Zolla ha
ruotato è un prisma a molte facce e ognuna di esse, nel corso del
tempo, ha inalberato, per così dire, una diversa parola-chiave.
Negli anni dello sgretolamento sistematico dei valori, deflagrato
nel Sessantotto, la parola-chiave era stata «tradizione»: l'unico
punto d'appoggio, dichiarava, per chi voglia sottrarsi all'inquinamento morale e alla pianificazione totalitaria, comportati dal progressismo moderno. Dieci anni dopo, la parola-chiave campita al-
l'inizio del trattato sugli Archetipi era «esperienza metafisica»,
espressione di uno stato unificato della mente e della coscienza, il
più prossimo immaginabile a una liberazione in vita. Avvertiva tuttavia che «esperienza metafìsica», al pari del termine equivalente
indiano samàdhi, «è soltanto un nome, che va periodicamente verificato, subito sostituito per poco che l'uso lo alteri, che la forza denotativa si spenga». Infatti, verso fine secolo, la pietra di certezza
acquistava una terza denominazione, quella di «mente naturale».
Nel primo capitolo de Lafilosofiaperenne è definito «mente naturale» lo stato di una mente che ha recuperato la spontaneità originaria, alleviata del proprio peso, percettiva al massimo, capace di
comunicare, come si dice in Giappone, col «gioco della pancia»,
una mente in cui «tutti i fenomeni si presentano non nati», e si ridesta il bodhicitta, lo spirito del risveglio. Una mente siffatta è l'antenata della mente dominata dalla ragione strumentale, calcolante
e dualistica, centrata sull'Io avido e solipsistico. Una filosofia fondata sul concetto di mente naturale fu formulata, sosteneva, «sin
dai primordi [...]; in Occidente nel pitagorismo e via via nei secoli
(è) affiorata in modo compiuto o parziale, sempre comunque costretta a mascherarsi dietro le persuasioni dominanti».69
Nella fase conclusiva del pensiero zolliano i concetti di tradizione, esperienza metafisica e mente naturale trovarono stabile
terreno di accoglienza nel contesto del sincretismo, visto da EZ
come l'orizzonte filosofico nel quale s'annodano e al quale affluiscono tutti quegli insegnamenti e quelle correnti di pensiero
che nonostante le diversità culturali intrinseche a una civiltà
planetaria fanno capo a una soggiacente e unanime metafisica
unitaria. 70
La seconda trasparente metafora ricorre in Verità segrete esposte in evidenza, e non c'è immagine più adatta a rispecchiare l'indole dello scrittore e l'andamento solitario del suo cammino intellettuale.
Ogni vita — scriveva in quel libro — comporta una invisibile interiorità, che ne è la sostanza. Per coglierla, occorre un aggiramento
delle apparenze sensibili, un balzo controcorrente quale fa il sal-
mone, simbolo vivente della conoscenza nelle Scritture norrene.
L'aggiramento, il salto porta dal piano dei participi passati a quello
dei presenti, dall'esperienza vissuta alla creazione vivente. Rispetto
al mondo della natura si sviluppa in noi una sensibilità alle cause
formali plasmatrici. Rispetto al mondo morale passiamo dallo
stato di sudditi o di ribelli alle prese con norme, alla libera, ironica,
giocosa, esoterica possibilità di norme; dal mondo animato all'animante, dall'attuato all'attuante e possibile.
71
72
Ciò che rende sui generisi orma, di Zolla nel pensiero del secondo
Novecento non può essere messo in più limpida evidenza che nella
metafora della carpa attratta da una pietra al centro di uno specchio d'acqua, e del salmone che balza contro la corrente. Coi mezzi
che il suo tempo gli rese disponibili, scrivendo, insegnando e parlando a gola spiegata, Zolla indicò nella tradizione, nell'esperienza
metafisica e nella mente ritornata alla naturalezza spontanea la pietra che incardina valori umani universali, espressione di una filosofia perenne nel flusso del divenire storico. Una linea di pensiero
e di azione che non potè che situarsi contro corrente, ponendosi
agli antipodi degl'idoli e delle voghe dominanti nell'epoca. La
adottò deliberatamente e serenamente, plasmandosi attorno una
vita simile a quella di certi contemplativi zen, catafratti al mondo
nonostante l'inosservanza di voti o regole, e l'energia cui attinse fu
di tipo taoista, costruita sul non-fare: «le cose, andava ripetendo,
non si fanno, accadono a partire da certi movimenti del cuore».73
Ma facciamo un passo indietro.
Nell'anno in cui uscivano I mistici dell'Occidente, la «Rivista di
Estetica» pubblicava un ampio saggio zolliano, Invito all'esodo, alcuni brani del quale sono riportati negli Scritti sulfurei. In una nota
di suo pugno sulla copertina del fascicolo, lo scrittore annotava:
saggio rifiutato da «Nuovi Argomenti», «il Mondo» e «Paragone».
Evidentemente le argomentazioni porte in Invito all'esodo,
erano state ritenute inaccoglibili dai responsabili delle tre testate
che pur in altre occasioni avevano ospitato scritti di Zolla.
Taluni di quegli argomenti venivano esaminati una decina di
anni dopo dal critico Elio Lombardo in una recensione dal titolo
esplicito: Elémire Zolla e la fuga perfetta.
A volo d'uccello ma in modo tutt'altro che superficiale Lombardo scrutava l'opera zolliana fino a Che cos'è la tradizione, al culmine del primo periodo romano.
Una singolare immagine campeggia all'inizio del pezzo di
Lombardo. Questa volta non si tratta di pesci ma di bruchi di una
certa specie di tarma (Cnethocampa processionea). Quando di
notte escono dal nido in cerca di cibo, i brucolini descrivono una
strana giostra simile a una collana rotante: «Vanno in fila indiana»
scriveva Lombardo «e ciascuno tocca con il proprio capo il retro
dell'animale che lo precede [...]. Ogni insetto subito secerne un
filo setoso che, unito a quello prodotto dai compagni, tesse un
sottile nastro, cui tutta la schiera in cammino aderisce».
Il cerchio intrecciato dai bruchi è un'immagine altrettanto eloquente delle metafore pescate in Che cos'è la tradizione e. Verità segrete esposte in evidenza. E se nell'esame degli scritti zolliani nel
complesso si può tacitamente ricorrere a un criterio cronologico,
come s'è fatto finora per un'utilità immediata di esposizione, si
compie però un torto verso un pensiero strutturato come un
mandala le cui linee di fuga confluiscono al centro, rastremandosi
nel punto più interno. Questo centro intimo e segreto, grembo e
tomba dove il frastuono della vita è inawertibile, la filosofia indiana equipara al luogo nel quale il pensiero argomentante, non
più arrovellato, approda a una riconciliata visione unitiva. Dal
principio alla fine l'opera zolliana traccia e ritraccia questo andamento mandalico. A Zolla - sottolineava Lombardo - molto
preme insistere su una «vita radicata nell'essere e resa spaziosa da
quel canto di lode che l'antica filosofia indiana afferma capace di
liberare tutte le creature, facendole crescere ed espandere».74
11 .Le ajfinità elettive
In uno dei tanti volumi editi da Rusconi nei primi anni Settanta
che recano la sua introduzione, EZ tratteggiava con un semplice
paragone il dono della quiete costante alla quale si applicò a
conformare l'intera sua vita. «Rettamente vede» aveva scritto «soltanto colui che sappia rendersi impersonale e quieto, cosi l'acqua
può rispecchiare soltanto se è immobile, senza turbamento.»75
Due áspera dell'indole dello scrittore, in apparente contrasto
l'uno con l'altro, gettano luce sulla sua biografia intellettuale. Da
qualche rara ammissione diretta risulta che EZ ebbe cara l'immobilità, la condizione più adatta alla creatività del pensiero, all'impianto
della quiete interiore, alla lucida penetrazione dei segreti. Una coscienza immota sviluppa l'arte del distacco e nel suo caso il primo
personaggio da cui staccarsi, ora lo sappiamo, era stato lui stesso.
Fin da bambino aveva appreso a osservare i movimenti della
coscienza, a non identificarsi con quell'«ammasso di impressioni
casuali» in cui scopri consistere l'io. Aveva visto che nel flusso
della coscienza ci sono delle brecce, bastava infilarle e viaggi strepitosi si potevano compiere senza spostarsi d'un millimetro.
C'era poi la volontà tetragona di andare al fondo delle cose, l'ansia sconfinata di apprendere, la ricerca di un gaudio, una quieta
ebbrezza in cui incerchiare la vita. Questo, forse, era il primo segreto attinto ai mistici, da tenersi ben stretto. Ma non perdeva di
vista che la conquista della quiete costante era una battaglia da
combattersi a tu per tu con nemici assai più insidiosi di quelli riconoscibili nel mondo là fuori dove i giochi della vita obbediscono a regole alla fin fine poco complicate. Quella deducibile
dal comportamento di un cane da guardia quando si accosta la
proprietà del padrone era una di esse. Dopo tutto, abbaiando, il
cane è leale e se levi le tende non ha motivo di attaccarti, ma
quanto subdolo, ingannevole, pieno di trabocchetti è il confronto con un pensiero molesto o di bassa lega. L'ordine di sloggiare può andare a effetto, ma scorie si accumulano nei paraggi e
il sistema per ridurle in cenere non funziona a dovere quasi mai.
L'altro tratto caratteristico della sua indole era stato in parte favorito dal sentirsi per nascita ed educazione non del tutto inglese,
accidentalmente italiano, un intellettuale di diaspora in un
tempo al quale aveva sentito di appartenere solo per certe affinità
di mente e di cuore con spiriti come il suo, attratti dagli antipodi,
vetta e abisso, roccia e onda. E indubbiamente un capitolo a parte
della vita di Zolla riguarda gli incontri con uomini e donne di conoscenza che senti intimi e affini indipendentemente dal fatto di
averli incontrati di persona, nel caso di Marius Schneider, Heschel o I. P. Culianu; di aver navigato nei loro scritti come accadde
con Melville, Yeats o Pasternak, o ancora per averli riconosciuti
quali speciali fratelli d'anima, incomparabilmente più amici che
amici di carne, come fra poco vedremo.
Tra gli affini del secondo gruppo un posto a sé lo hanno Herman Melville (1819-1891) e Pavel A. Florenskij (1882-1937?).
A proposito dell'autore di Moby Dick, il romanzo cui Zolla dedicò nel I960 il memorabile saggio Melville e l'abbandono dello
zodiaco, qui accolto tra gli Scritti zodiacali (Parte seconda), una
volta aveva confessato:
Fra i grandi mi tiene inesorabilmente avvinto Herman Melville. Lo
capii all'improvviso, per un'illuminazione subitanea, che avevo
vent'anni. Da allora lo rileggo quasi completamente ogni due o tre
anni e ogni volta mi trovo di fronte a un testo inatteso, con rinvìi
ad autori sempre nuovi [...].
Quando egli incominciò a scrivere, già aveva imparato tutto della
vita, era stato a bordo di mercantili, baleniere, navi da guerra, aveva
soggiornato fra indigeni ancora intatti nelle isole Marquesas. Conosceva tutta la torva umanità delle navi. Era svezzato, sapeva parare ogni colpo, era stato ferito nell'intimo. Frammezzo alle nefandezze, aveva conosciuto l'amicizia più blanda, aveva tenuto colloqui
profondi con marinai conoscitori verso per verso di Shakespeare e
quei dialoghi erano valsi più d'ogni insegnamento [...].
Per pagine e pagine dopo il brano citato, il volto umano di Melville acquistava rilievo via via che i suoi romanzi erano descritti ad
uno ad uno, da Typee{ 1846) a Mardi (1849) a Moby Dick{ 1851)
a Pierre (1852), a The Confidence Man (1857) e il poema Clarel
(1876), versato da EZ in italiano nel 1965, infine il postumo
Billy Budd, stampato due anni prima che Zolla nascesse, quando
Melville cominciò ad essere letto. «È uno studio» scriveva «sulla
regalità nella sua essenza; come esibizione di innocenza e maestà
[...] cui deve seguire il sacrificio rituale. L'ufficiale infame che accusa d'insubordinazione Billy ha l'occhio velato di lacrime: egli è
necessario al rito. E tutto avviene con pochissime parole. Superflui i vocaboli, quando si tocca l'archetipo.»76
Nel caso di Pavel Florenskij, l'archetipo che nel cuore di EZ
fece scoccare la scintilla dell'amore fraterno fu la Sapienza dissimulata sotto un manto di mansueta carità. In Uscite dal mondo lo
confessava alla fine del brano dedicato a Florenskij nella sezione
che accoglieva i profili di altri tre russi straordinari: Grigorij Rasputin, Nikolaj Roerich e Georges Gurdjieff.
«Non so» scriveva EZ «se ho fatto bene a divulgare le mie annotazioni su Florenskij. Incontrarlo forse fu un evento da tacere?
In lui le stesse idee erano apparse, riunendosi, svolgendosi in steli
e foglie di pensieri, come in me oggigiorno. Va da sé [...] dentro di
lui s'era incastonato ciò che in me aveva lasciato una tenuissima
impronta, ma tanto più l'essenziale identità mi sbalordì, specie
nel semibuio davanti a certe iconostasi lambite da vaghi riflessi
d'oro [...] mentre i noti corali mi staccavano dall'anima, gettandola in lacrime, come un cencio, lontano.»77
Le affinità elettive di EZ furono d'altronde anche di un terzo tipo,
e il momento in cui ci si avvia ad accompagnare lo scrittore nei
suoi viaggi lontano da Roma, è il più appropriato a evocarle.
In una di quelle sue confessioni in pubblico che tante volte avevano fatto trasalire i lettori della Terza pagina del «Corriere della
Sera», per quanto erano disarmate e vibranti, una volta era affiorata la figura di un amico, uno col quale lo scrittore aveva condiviso ore perfette e immobili, stagliate nella memoria al punto che
«in seguito non ebbe più motivo di domandarsi quale fosse il senso
della vita». Era accaduto un giorno, sotto la canicola, durante un
viaggio nel Nuovo Messico e questa ne è la fuggitiva immagine:
Il mio amico sommerso nel materno vapore della pianura come
un'alga spugnosa in una tenera laguna [...] s'era sentito investire
dalle secche folate cariche dell'odore dipinon esalato dal legno d'al-
tare di una chiesina a San Antonio [...] L'attimo di sbucare nella
piazza non trascorre [...] tutto è simultaneo fuor del tempo.
78
Chi era l'amico? Non altri che il suo doppio di sogno, un gemello
la cui esistenza interiore - confessava - «è una perpetua danza di
ore elette, vissute si nel passato, però mai trascorse».
E rammentava che un'altra volta l'amico aveva evocato assiduamente certi sguardi, specie di animali. «Quello di una tartaruga che vidi rispondergli affettuosamente, col suo rauco soffio
raspante, la bocca spalancata e protesa.» Oppure un tramonto a
Mashad quando «la chiamata alla preghiera ondula nell'aria [...] e
fra le colonnine d'un alto loggiato sporgono i lunghi corni ricurvi
a lanciare il loro barrito di poche note al sole calante. Mashad-. "visione"; shahidr. "testimone"».79
Immedesimarsi nel «diverso», sia esso una persona, un animale, un personaggio d'invenzione o una figura di sogno, ed essere al tempo stesso il testimone imperturbato dell'emozione che
attanaglia il cuore, tutto questo, che è cosi difficile da esprimere
in parole, fa trapelare un terzo tratto caratteristico dell'indole di
EZ, l'incoercibile spinta all'esodo conoscitivo, all'esplorazione di
orizzonti mentali e geografie culturali ai margini dell'ecumene, di
tutto quanto esorbita il «sistema» e lo contesta nel profondo.
La ribellione al culto della forza, di qualsiasi segno, lo aveva
messo inconfondibilmente, sempre dall'altra parte, e l'epoca in
cui visse gli procurò occasioni a non finire di meditare sui segreti
della forza - sia essa esercitata da un regime totalitario, un clero,
una corporazione accademica, una cerchia iniziatica, un potentato nutrito del mito di una superiorità qualsivoglia, succube di
una tirannia foss'anche solo di conformismo mondano. Lui nei
salotti, a tavola, in mezzo alla gente ci stava benissimo, però era
fulmineo nel far perdere le tracce. Aveva il garbo distaccato di
chi si concede a dosi minime, irremovibile nel vietare che l'armonia, la compattezza del suo essere venissero scioccamente
violate. Era troppo preso a pedinare i princìpi che reggono le
cose, a scrutare il fondo dell'anima, a intercettare nel limo germinante le spinte verso la luce, e le risorse di una consumata pe-
rizia letteraria erano mobilitate affinché quei doni abbondanti si
posassero sulla pagina.
Nei suoi peripli della mistica pagana e cristiana, delle pratiche
estatiche nelle culture sciamaniche dell'America indigena e in
Asia, dell'alchimia vista come metafora del processo spirituale di
morte e resurrezione, della gnosi, della cabbala, degli esoterismi
di Oriente e Occidente Elémire Zolla era stato ardito come solo
uno che ha visto in faccia la propria morte sa esserlo in pieno. Domandandosi perché il Talmud accosti teschio e fallo, aveva compreso che la cognizione degli antipodi si ottiene al prezzo di traversare la notte dell'anima, e se la sete di sapere sconfigge la paura,
l'accesso alla camera segreta dove gli antipodi si toccano non è negato. Ma ci sono segreti che nemmeno la cognizione degli antipodi può largire a meno che non si sprigioni un fervore dal cuore,
il calore dell'affetto che tramuta e redime. Quell'ardore effuso dal
cuore Dante e i poeti stilnovisti l'avevano chiamato «foco», «intelletto d'amore», «lume» di ragione nel senso che la ragione senza
quel lume è cieca, invidiosa e trista come una donna sterile. Lui
l'aveva intuito da bambino che la casa della vita ha la sua pietra di
volta nell'intelletto d'amore. La lezione impartitagli dal nonno a
Maidstone racchiudeva una sottile verità: le piantine nell'orto,
soprattutto le più stenterelle vanno assecondate a nutrirsi di luce.
Cresceranno, e quando viene il tempo daranno mele di ogni tipo.
Penetrandone i distinti sapori il bambino apprenderà a riconoscerle. Così per tutto il resto nel corso della vita: dolori, piaceri,
rovesci, fortune, onde che si abbattono sulla chiglia. La mente
calcolante si abbarbica al passato. Il cuore pulsa nell'attimo e non
ha domani su cui contare.
Esodi
Il viaggio che mai si pensi d'intraprendere si vorrà
soltanto se si vuole con esso tutte le condizioni e
conseguenze che comporta [...]: così si è fuori del
capriccio insulso, del mondo informe dei desideri.
Volgarità e dolore
1. Esodi di vari tipi
Esodo è una parola che Zolla ebbe sulle labbra costantemente, non
solo quando il costo di esistere era stato più esoso. Il vantaggio di
essere scrittore, non era cosa da poco. Con penna e quaderno, poteva imbastire esodi di ogni sorta, e i racconti giovanili, ai quali s'è
accennato all'inizio, erano stati il primo banco di prova. È un tale
miracolo inventare storie, scolpire caratteri, iniettare velleità, ricordi, passioni in personaggi cui dare un nome, un aspetto, un
destino, il potere di dannarsi o redimersi: meraviglia dell'esodo
narrativo!
C'era stato poi l'esodo linguistico. Una lingua sconosciuta è
come una muraglia altissima. Senza appigli vai giù e per risalire
occorre un sistema. Alle prese con l'italiano mentre frequentava le
elementari, Elémire da bambino si era costruito in un quaderno
un repertorio completo di verbi, avverbi, aggettivi e modi di dire.
Una memoria prodigiosa e la ripetizione tenace ad alta voce gli
avevano fatto espugnare in men che non si dica la cittadella lin-
guistica. Adulto, l'esodo in lingue remote lo aveva spronato a
scrutare che cosa si cela dietro geroglifici, ideogrammi, sillabe effuse dalla gola profonda come il mantra OM, radici nei cui significati originari riconobbe lo jato ancestrale tra il fausto e l'infausto, il puro e l'impuro, la lode e la deprecazione.1
Le rune e lo zodiaco, un vasto saggio pubblicato nel secondo numero di «Conoscenza religiosa»,2 aveva accolto i risultati di ricerche pronte a dirigersi dalla filologia germanica, la disciplina che
aveva insegnato all'Università di Genova, nelle mitologie scandinave tanto familiari a Tolkien.
Quando s'era inerpicato dall'inglese all'anglosassone s'era accorto che la serie canonica delle ventiquattro rune {«runa» aveva
spiegato «vuol dire mistero, segno, mormorio, scongiuro») corrispondono a due a due, quali poli positivi e negativi, alle stazioni
dello zodiaco.
Tutt'insieme una runa - scriveva in quel saggio - era un mistero e
una conoscenza, un segno e un effetto, una lettera alfabetica e un
numero, un aspetto del cosmo e una divinità. Le rune erano la segnatura degli oggetti, la loro forma essenziale e sintetica, la formula della loro energia specifica: del loro ritmo. Ritmo identico e
dunque medesima runa hanno tutti gli svariati oggetti d'una serie
o catena dall'uguale vibrazione; una particolare stella, un minerale, una bestia, una divinità, una pianta, una parte dell'uomo,
partecipando a una certa forma ritmica, vengono designati, evocati da una figura runica corrispondente.
Il sistema era stato interpretato traducendo la serie canonica delle
ventiquattro rune del poema norreno e le ultime cinque che sono
soprannumerarie ma «possono rientrare nell'ordine se si fanno
coincidere con una runa canonica».
Dopo le antiche lingue nordiche s'era accostato al sanscrito, e
quattordici trattati estratti dal corpo delle Yoga Upanisad erano
stati raccolti e commentati in un fascicolo speciale di «Conoscenza religiosa».3 Quei testi esponevano una fisiologia sottile
del corpo umano paragonabile a quello che in botanica è la fo-
glia «vista» da Goethe quando visitò il giardino botanico di Palermo e da quella visione restò folgorato. La foglia conteneva «i
princìpi plasmatori, le cause esemplari, finali e formali di ogni
pianta materiale».
Più avanti lo studio delle etimologie era stato una pratica ininterrotta, e nella sua biblioteca allestita con estro eclettico la zona
riservata ai dizionari e ai trattati di linguistica è tra le più ingenti e
preziose.4
La disposizione allo studio delle lingue l'aveva reso padrone
anche di quelle apprese in età adulta, come nel caso del russo
quando s'era cimentato col saggio sull'icona di Pavel Florenskij
Le porte regali. A chi gli domandava come avesse preso forma la
traduzione di Ikonostas confessava di non saperlo: la sua mente e
il suo cuore si erano affiatati al punto che quel testo per lui non
aveva avuto più segreti.
In Iran dove s'era recato annualmente prima della caduta di
Reza Pahlavi nel 1978, gli era stato facile esprimersi in persiano
adeguandosi ai modi, perfino ai motti di spirito che fioccavano
nelle conversazioni con l'autista di piazza o le sue guide improvvisate nei quartieri, nelle case di preghiera di Isfahan e Shlraz. La
felicità di abbandonarsi al diverso, assorbirlo da tutti i pori, affratellarselo, lo inebriava.
Forare Io spazio che su di noi hanno incurvato secoli e secoli avrebbe poi confessato in Uscite dal mondo — è l'atto più bello
che si possa compiere. Quasi nemmeno ci rendiamo conto delle
nostre tacite obbedienze e automatiche sottomissioni, ma ce le
possono scoprire, dandoci un orrore salutare, i momenti di spassionata osservazione, quando scatta il dono di chiaroveggenza e
libertà, e per l'istante si è padroni, il destino sta svelato allo
sguardo.
Per mantenersi in questo stato occorre non avere interessi da
difendere, paure da sedare, bisogni da soddisfare; si raccolgono
i dati, si dispongono nell'ordine opportuno e, al di là dei recinti dove si sta rinchiusi, si spalanca l'immensa distesa del
possibile.
Gli articoli di viaggio pubblicati sul «Corriere della Sera» per oltre
trent'anni e sul Domenicale del «Sole 24 ore» tra il 2000 e la primavera del 2002 (un fascio di essi è raccolto nella sezione Nuove
terre cieli nuovi della Parte seconda), provano senza bisogno d'altri riscontri che nella otherness, la «diversità» culturale dai mille
volti, EZ s'era trovato a casa più che a casa sua.
L'esodo geografico aveva fatto di lui un antropologo sui generis,
assiduo a convegni - dalla Finlandia all'Ungheria agli Stati Uniti
al Canada - dove indigenisti, etnologi, esperti di culture sciamaniche scoprivano che le discipline da loro insegnate nelle università e nelle accademie assumevano nelle indagini di quell'italiano
dal perfetto accento britannico uno spessore inaudito. L'ammirazione e il desiderio sincero di strappargli notizie sui campi che
avevano creduto di conoscere a menadito erano palpabili, e raramente un'ombra d'invidia si frapponeva fra loro e lui. Lo stesso
era avvenuto ai simposi di filosofia, religioni comparate, medicina tradizionale e filosofia — dall'Iran a Sri Lanka all'India alla
Corea a Taiwan al Giappone. Nel 1989 un invito della Japan
Foundation lo aveva immerso testa, braccia e mani in certi esperimenti di realtà virtuale poi descritti in Uscite dal mondo, scoprendo che la plasticità della mente nipponica, pronta a svuotarsi
e ricolmarsi ogni volta con efficiente leggerezza, permette allo
slancio nel futuro delle tecnologie giapponesi di convivere con la
persistenza di valori atavici nel corpo sociale. Bastava inoltrarsi di
pochi metri nei ridotti di certi templi fuori mano, di giardinetti
ritagliati nel bel mezzo del frastuono urbano e l'esodo dall'uno all'altro antipodo aveva luogo di schianto.
Il viaggio accompagnato da un sentimento di abbandono
colmo di meraviglia fugava dal corpo ogni senso di fatica rendendolo vigoroso e scattante. Una colazione di primo mattino accompagnata da laute tazze di forte tè nero era la sferza sufficiente
a resistere fino a sera senza bisogno d'altro cibo o bevanda.
Svuotata la mente di ogni abituale legame o affetto, munito di
una valigetta contenente scarsissimi effetti personali, la stagione
degli esodi geografici era iniziata nel 1968 quando un invito del
Dipartimento di Stato americano gli aveva consentito di ritagliarsi un itinerario ad hoc nelle riserve indiane del Sud-Ovest. Lì
nell'abbaglio di un sole implacabile aveva visto vecchie bocche
versare in giovani orecchi i segreti di una civiltà sciamanica e di
una religione della terra estesa all'intero mondo vivente. I documenti consultati in biblioteca gli avevano squadernato la vista sul
volto nascosto di una letteratura che negli ultimi tre secoli era
stata imperniata senza scampo sull'uomo bianco. S'era accorto
che le fattezze di quel volto nascosto erano indiane, e lui non
aveva fatto che ridisegnarle con l'intensità trepida del pittore che
sa di avere il tempo contato per catturare un lampo, un chiaroscuro presto svaniti. Il frutto di quel viaggio, I letterati e lo sciamano segnò una svolta negli studi di americanistica, e nei corsi di
varie università degli Stati Uniti l'opera fu adottata per molti
anni.5 Quali furono i motivi di tanta fortuna critica?
I più cospicui li aveva colti lo storico delle religioni rumeno I. P.
Culianu in un articolo su «History of Religions», la rivista fondata
da Mircea Eliade all'Università di Chicago dove il 21 maggio 1991,
lo stesso giorno dell'assassinio di Rajiv Gandhi, una mano ignota
feriva mortalmente l'appena quarantenne Culianu (1950-1991).
La recensione si basava sul testo della riedizione Marsilio de I letterati e lo sciamano, arricchita di un nuovo capitolo dove Zolla aggiornava la materia con un'indagine sull'opera controversa dello
scrittore-antropologo Carlos Castañeda e di nuovi emergenti autori indiani. Senonché per un utile avvio ai ragionamenti dello studioso rumeno, è bene calarsi nella materia del libro al modo in cui
prese forma in quel primo viaggio americano sulla scia dell'incontro fortuito con due indiani incrociati in una strada di Santa Fe nel
Nuovo Messico. La schietta confessione delle loro esperienze di «diversi», oggetto di ordinario disprezzo da pane dei Bianchi, era stato
per EZ il punto di partenza di un affondo nei documenti consultati
in svariate biblioteche locali sui rapporti tra il bianco e l'indigeno
nella storia americana e la sua letteratura negli ultimi tre secoli.
Era una ricerca, si commentò in America,6 che poneva in discussione i fondamenti stessi di una parte della nostra storia, e che
raggiungeva la massima evidenza nel ricchissimo materiale di no-
tizie rare, di autori ignoti, di citazioni straordinarie, che EZ introduceva nel suo discorso. Un discorso che culminava nel capitolo sui ragguagli indiani forniti da indiani, ove per la prima volta
emergeva una sorprendente letteratura, più sacra che profana,
con cui le vittime consegnavano agli oppressori le loro verità e i
loro ritmi. La conclusione, per l'autore, aveva il profondo sapore
di una parabola; con gli indiani, infatti, i falsi progressisti «bianchi» mostravano di aver sterminato la parte migliore di se stessi.
La prefazione zolliana alla prima edizione trasuda l'asprezza caratteristica della sua prosa negli anni del primo periodo romano:
«L'idea del progresso» affermava senza mezzi termini «ha giustificato, promosso (e rimosso dalla coscienza) l'eccidio, che fu ora fisico ora spirituale, a seconda dell'occasione. Ha anche riatteggiato come le conveniva l'immagine dell'Indiano, quando non ne
ha inibito la visione». Sicché la ricostruzione di questa immagine
è stata non tanto «una storia quanto una morfologia». Infatti «la
materia è rimutata e svariata dai tempi, ma le sue forme persistono [...] eclissandosi spesso soltanto per riemergere». Ad esempio, se l'ideologia del libertinismo filosofico ha impresso oggi alle
cose la sua forma certamente più diffusa «essa non plasma forse
già certe visioni secentesche del mondo aborigeno?». E non è
forse vetusta «la tradizione d'una ipocrita benevolenza illuministica che atteggia in particolari forme gli Indiani?». C'è stata però
- riconosceva poco dopo - una scoperta straordinaria negli ultimi
tempi: «gli oppressi medesimi parlano, sia pure ancora attraverso
mediatori; si forma una letteratura indiana».
Nell'interpretazione di Culianu,7 la «scoperta» che Zolla menziona era stata in gran parte proprio opera sua. Infatti ne I letterati
e lo sciamano il dominio della materia storico-letteraria viene a sposarsi secondo lo studioso rumeno con un tipo di interpretazione e
intelligenza critica ignoto ai metodi dell'antropologia culturale
corrente. La curva ermeneutica del disprezzo, della tolleranza,
della benevolenza, del rispetto, dell'attenzione, infine della reverenza verso le civiltà indigene d'America - che aveva scandito in
questa precisa sequenza l'atteggiamento dei ricercatori americani
- per la prima volta nel libro di Zolla era scavalcata di netto, e un
approccio inedito alla «diversità» indigena era compiuto dall'autore. Nella «nuova» ermeneutica zolliana Culianu scorgeva operante un approccio illuminato dal cuore: in inglese intelligence out
oflove, un'espressione del tutto equivalente a quello che la Scolastica cristiana definisce «intelletto d'amore», la facoltà spirituale
che Zolla ne Le potenze dell'anima aveva denunciato rimossa nella
coscienza moderna. Era stata non l'arida ragione critica ma il lume
di cui Dante dice che non si turba mai (Paradiso XIX, 64-65) a pilotare lo scrittore nelle zone sommerse della letteratura americana
portando alla luce l'integra bellezza e la portata spirituale del filone
indigeno. Una tesi ardita, quella di Culianu, che ha avuto scarso riscontro nella pur attenta ricezione de Iletterati e lo sciamano in Italia, sia al tempo della prima edizione che della successiva.8 Ma la
fortuna del libro in America dipese da fattori più contingenti. Il
progressismo a oltranza che negli inquieti anni Sessanta spadroneggiava negli ambienti intellettuali radicali della costa adantica,
aveva colto nel filone imbroccato da Zolla l'anticipazione di un
proficuo cambio di rotta, tutto pro-indigeno negli studi letterari e
in quella che di 11 a poco sarebbe diventata una disciplina di gran
seguito, l'etnopoetica. In Italia le ricerche accademiche promosse
da Zolla in ambito americanistico dagli anni Settanta in poi aprivano la strada a un terreno vergine dal forte taglio antropologico,
comparativo e interdisciplinare.9 Ma il «caso» che all'inizio della
stagione degli esodi costituì I letterati e lo sciamano, suggerisce di
andare un po' più a fondo nell'approccio col mondo indigeno
dello scrittore, un approccio notevolmente distante, come ora vedremo, da quello del principe indiscusso della ricerca etnologica
nel Novecento: Claude Lévi-Strauss.
2. Tristi tropici perché?
Risale agli articoli giovanili, pubblicati aTorino, l'apertura vivacissima di Zolla sul portato simbolico delle culture indigene e del
folklore popolare.10 Credenze, miti, riti e cerimonie dei popoli che
Lévi-Strauss, in una celebre battuta, aveva definito «assenti alla
storia», esprimevano agli occhi di Zolla idee raffinate e complesse,
certamente formalizzabili in un'algebra strutturale secondo il metodo lévi-straussiano, a scapito tuttavia, ritenne Zolla, di un intendimento che destasse l'osservatore a riconoscere nell'osservato
concezioni di portata universale cui non occorre una presenza
nella «storia», l'uso della scrittura o una consuetudine dialettica
per filtrare nei pensieri e negli atti della vita quotidiana.
Vediamo ad esempio in che modo Bernardo Trevisano descriveva la forma e la funzione del calumet, la pipa sacra indiana in un
articolo dell'aprile 1966 uscito sul «Giornale d'Italia».
Il calumet ha quattro nastri pendenti a significare le quattro pard
dell'universo, uno nero designa l'Occidente dove vivono le forze
che concedono la pioggia, uno bianco il Settentrione donde spira
il vento purificatore, uno rosso per l'Oriente dal quale sprigiona la
luce, e dove si leva la stella del mattino, uno giallo per il Sud,
donde giunge la primavera e la forza delle crescite. Ma i nastri
stringono una piuma d'aquila, la quale sta a mostrare come essi
formino una sol cosa: l'Uno, il Padre verso il quale i pensieri dovrebbero salire con volo d'aquila. All'imbocco della pipa sta un
lembo di pelle di bisonte, simbolo della terra. Prima di cominciare
il rito della sacra fumata l'Indiano saluta cielo, terra, i punti cardinali, e poi medita sul tabacco, il quale rappresenta lo spirito
umano che si deve elevare e disperdere fuggevole nel cielo, sacrificando; quindi egli medita sul fuoco che divora il tabacco, emblema di Dio, sul tabacco stesso che è l'uomo e sulla pipa che è lo
spazio cosmico.
La circolarità — sottolineava B. T. — era la forma cui l'Indiano riconduceva ogni cosa: la propria tenda, la cerchia delle tende, a
imitazione e celebrazione dei venti che vorticano a tromba, della
terra che è tonda, del cielo che s'incurva come una sfera, dei nidi
degli uccelli. In tal modo, tutte le forme statiche dell'esistenza si
trovano determinate da un archetipo concentrico materiale o
mentale; centrato sul suo io qualitativo o totemico, quasi impersonale, l'Indiano tende all'indipendenza e perciò all'indifferenza
nei confronti del mondo esterno; egli si circonda di silenzio come
entro un cerchio magico, e questo silenzio è sacro perché trasmette influssi celesti [...]. Di qui una indifferenza dell'Indiano
nomade verso le strutture stabili dello spazio: egli rifugge da dimorefisse,di pietra, e perfino dalla scrittura, la quale condenserebbe, pietrificherebbe il fluire silenzioso dello spirito.
«La civiltà europea, nelle sue forme sia dinamiche che statiche»
osservava ancora «è invece fondamentalmente sedentaria e cittadina, sta ancorata nello spazio e vi si stende quantitativamente,
laddove l'Indiano d'America rappresenta un Abele ucciso dal
Caino europeo fabbricatore di città», e citava in proposito le parole di Benjamin Franklin:
Li chiamiamo selvaggi perché i loro costumi divergono dai nostri
che ci illudiamo essere la perfezione della civiltà, ed essi pensano
altrettanto dei loro [...]. Avendo pochi bisogni artificiali, hanno
molto agio di coltivar l'anima in vista della conversazione. Il nostro modo di vivere laborioso essi lo stimano basso e servile al paragone, e l'istruzione in base alla quale noi ci valutiamo essi la considerano frivola e vana.11
Quattro anni dopo, la Terza pagina del «Corriere della Sera»,
sotto l'immagine di un ridente ragazzino nambikwara, la narice
adorna di un bastoncino piumato, accoglieva l'elzeviro zolliano:
Parenti ai tropici, dal sottotitolo: «L'algebra mitologica di LéviStrauss applicata ai costumi di una tribù del Mato Grosso».12
Una pagina importante perché mette in luce la distanza tra la
prospettiva alla base dell'antropologia spirituale zolliana e quella
dell'etnologia ufficiale che ha in Lévi-Strauss uno dei suoi indiscussi maestri.
Nel 1938 Lévi-Strauss aveva dimorato tra i Nambikwara amazzonici per parecchi anni documentando la sua ricerca nella Vita
familiare degli Indiani Nambikwara (trad. it. Einaudi 1970). I
complicati rapporti di parentela erano stati formalizzati in diagrammi di un'algebra «forse più pomposa che necessaria», cornilo
meritava EZ, riconoscendo d'altra parte all'etnologo di aver sottolineato in maniera impeccabile gli equilibri di forze, le formule
di autorità, le più minute consuetudini, tanto che si esce dalla lettura perfettamente informati di tutto, salvo - rilevava - «dell'essenza della vita dei Nambikwara, del loro segreto religioso: della
loro intimità».
Un'osservazione che la maggior parte dei ricercatori sul campo
troverebbe illecita non rientrando minimamente nello statuto
dell'indagine etnologica la ricerca di un'essenza nell'identità culturale di un gruppo o di un singolo individuo. Senonché Zolla era
e rimase convinto che l'essenza di un individuo o di un gruppo, la
maniera inconfondibile di rapportarsi alle proprie radici e concezioni ataviche esemplate nei riti e nei miti, è un dato reale, concreto e pienamente documentabile, solo se lo si accosti con un atteggiamento di profonda apertura e simpatia umane, ponendo
domande che in molti casi esorbitano dai repertori etnologici
consueti ma che vanno tuttavia al cuore delle credenze indigene,
di un'idea del mondo nella quale il singolo individuo situa se
stesso e il gruppo al quale appartiene. L'esempio porto da EZ nel
suo articolo era il seguente:
I Nambikwara concepiscono tre tipi di forze soprannaturali: in
primo luogo la potenza del nande, astratta si ma calata in oggetti e
in sostanze; poi spiriti attivi sotto forma di animali soprannaturali
o seminaturali, infine il fulmine, con il quale è possibile, in certe
condizioni, avere rapporti personali [...].
Questo - affermava - è il lato della mentalità nambikwara che
Lévi-Strauss chiama metafìsico e irrazionale contrapponendolo
all'altro «razionale e positivo». Senonché, e qui sta l'obiezione di
Zolla, «basta l'aggettivazione ("razionale", "irrazionale"), per capire come mai i capitoli dedicati da Lévi-Strauss alla vita religiosa
dei Nambikwara sono così smunti e insignificanti». Se la struttura in cui egli ha deciso di incastellare i fatti rituali e le confidenze degli indigeni intorno ai rapporti con l'invisibile è vista
come qualcosa di «irrazionale» e perciò trascurabile, è chiaro «che
i fatti tenderanno a eclissarsi e le confidenze ad arrestarsi di fronte
all'etnologo nella stessa misura in cui invece sciamarono attorno
a Griaule o alla Dieterlen alle prese con le forme del pensiero mitico, dei riti e dei costumi dei Dogon del Mali africano».13
Secondo Zolla, che la metafisica sia «irrazionale» non solo è
una contraddizione in termini ma un pregiudizio del tutto dannoso ai fini dell'indagine, sia essa etnologica, storica o d'altro genere. E nell'articolo immaginava che se Lévi-Strauss avesse accostato la vita di Bisanzio o d'una città medievale d'Europa «ignorandone quasi del tutto la vita mistica e il pensiero metafìsico, costruendosi soltanto modellini algebrici della struttura corporativa, delle attività economiche, dei rapporti fra i membri delle famiglie», ebbene, «il suo stupore non sarebbe stato diverso».
All'autore di Tristi tropicie di tante altre opere che hanno avuto
il merito «di gettare tra le anticaglie i boriosi storicismi», non si
può tuttavia chiedere, concludeva EZ, di corredare il suo sistema
di idee con una metafìsica. «Troppe resistenze dovrebbe superare
in se stesso, troppo solo si ritroverebbe [...]. E poi per fare quest'ultimo passo gli ci vorrebbe un animo molto più asciutto, diafano, robusto.»14
Riscandire gli aggettivi: asciutto, diafano, robusto riferiti all'atteggiamento dell'etnologo chino sui Nambikwara con l'apertura
dell'osservatore illuminista, aiuta a comprendere meglio quel
che sostenne Culianu quando, a proposito dell'approccio di
Zolla alla diversità indigena, parlò del risveglio in lui dell'intelletto d'amore.
Una digressione si rende a questo punto necessaria.
3. Una otherness dai tanti volti
Nella personalità del «conoscitore di segreti» la polarità del «diverso» illuminata dall'intelletto d'amore, occupa un posto peculiare e centrale. Esso andrebbe valutato non solo attraverso l'esame degli scritti antropologici, ma ripercorrendo passo passo l'itinerario che condusse lo scrittore a misurarsi con la natura del
«diverso» in un insieme enciclopedico di discipline e saperi depositato nell'intera opera.
Nella prima fase di militanza critica, marcatamente influenzata
dai pensatori della Scuola di Francoforte, otherness per Zolla fu il
mondo dei valori tradizionali che al culmine del ciclo storico moderno l'industria culturale, la società di massa, le stesse gerarchie
della Chiesa romana prone alla sirena modernista, confissero in
una esautorata clandestinità. Otherness, ancora, nello scavo della
vita contemplativa tra i mistici pagani e cristiani fii il luogo nel
quale il solitario, l'ebbro di Dio prendono scandaloso rifugio.
Nelle opere posteriori a Che cos'è la tradizione, otherness sì fece immagine dell'orientamento più bistrattato della filosofia occidentale, il sincretismo che il saggio omonimo del 1990 prospettava
come l'apertura del pensiero senza pregiudizio sull'unità profonda
tra sistemi di pensiero e fedi storicamente e culturalmente separati
ma non inconciliabili.15
Otherness, nondimeno, significò per Zolla la tradizione del segreto custodita dagli alchimisti, dai cultori della medicina tradizionale, dai cabbalisti e i maestri di trafile esoteriche — trafile alle
quali peraltro non si associò mai.
Per chiarire meglio questo punto, aggiungeva: «Non voglio
certo staccare dai maestri ai quali ci si sia legati: desidero togliere
di mezzo una condizione giuridica: l'accettazione da parte di un
maestro dalla prospettiva: quella esoterica, dove non può spadroneggiare alcun sistema giuridico».16 Come a dire, la normatività
giuridica vista come un vincolo e un obbligo ineliminabili nella
vita essoterica, sia almeno risparmiata a chi veleggia nella otherness esoterica.
Infine, negli scritti a partire da Uscite dal mondo, otherness significò lo slancio verso esperienze di realtà virtuale col sollievo di
scorgervi la possibilità di una liberazione dalla tirannia della materia e dal culto dell'io-persona. In una corrispondenza con
Giampiero Comolli, di cui ci occuperemo più avanti, Zolla affermava che la realtà virtuale è una tale rivoluzione «perché non esiste una sola esperienza per noi fondamentale e perfino sacra che
non si possa trasporre in un programma di realtà virtuale». Molto
si discusse negli anni Novanta sul plauso zolliano per le tecnologie informatiche e gli esperimenti di realtà virtuale. Un plauso ritenuto non solo incoerente in colui che negli anni Sessanta aveva
infierito contro la macchina, il cinematografico, le avanguardie e
l'abuso dei media, ma eticamente sventato. Si tornerà più avanti
sul famigerato argomento.17 Intanto ulteriori, sorprendenti
aspetti della otherness inseguita da Zolla vanno messi in luce.
Esodi nelXaltrove-, il destino e lo zodiaco
Bisogna abbandonare ogni concetto noto [...]
ignorare ogni conoscenza morta per trovare ciò
che vive e dà vita. Bisogna che si muoia per
rinascere, che si sia divinità solari. Cioè che si viva
come il sole attraverso lo zodiaco.
Melville e l'abbandono dello zodiaco
Quando il richiamo di un altrove perfino più eccentrico degli
orienti geografici, guadagnò terreno nella sua mente, un'idea gli
si configurò come pietra angolare della casa della vita, la pietra attorno alla quale ruotano le singole esistenze: l'idea di destino. Ne
sortirono pagine intarsiate nel corpo dell'opera ma nel contenuto
e nel tono inconfondibilmente a parte rispetto agli altri scritti zolliani. Quelle pagine emanano una luce diversa, tenue come il
cielo al crepuscolo, simile al mite bagliore della Via Lattea.
L'erudizione che rende scoraggiante l'incontro con l'opera di
Zolla, negli scritti sul destino e lo zodiaco, si stempera e, se non
tutto se ne afferra, resta una traccia, un'eco che ritorna; dietro il
peso del sapere s'intravede la nostalgia di un'innocenza che solo gli
occhi di un bimbo possono riflettere o quelli di un vecchio nei quali
il film della vita scorre a ritroso e le prove che un tempo l'avevano
sopraffatto, ora, nelle acque del ricordo, fluttuano disancorate. Chi
ha letto il fulgido racconto di un narratore giapponese morto
quando Zolla era bambino, Miyazawa Kenji (1896-1933), Una
notte sul treno della via lattea, ha assaporato l'atmosfera straniarne
che impregna gli Scrìtti zodiacali raccolti nella Parte seconda.
***
Deve esserci stata una prima volta in cui lo scrittore aveva puntato
«lo sguardo appassionato al nereggiare della notte, spiccando dai
puntini luminosi le figure tradizionali, leggendo nella loro disposizione celeste la realtà che ci circonda sulla terra». Senza fallo
quella volta ci fu se un giorno aveva confessato: «Cosi mi lasciai
trasportare nel mondo delle metafore che sonnecchiano nel nostro inconscio: la scintilla di Venere vespertina corrisponde al tremito amoroso, quella di Venere mattutina o Lucifero all'audacia
che si paga col sacrificio e via elencando i barlumi celesti e i modelli della sorte».
Al tempo degli esodi dall'Occidente, l'incontro forse più memorabile lo aveva avuto coi sacerdoti astrologi zoroastriani:
Essi amano ricordare nella loro storia l'apparizione nel 603 a.C. di
Saturno, Giove e Marte nello stesso segno zodiacale, che doveva
provocare la nascita di Cosroe, mentre riproponendosi nel 543 a.C.
annunciava la caduta di Babilonia. E citano Avicenna, che in un
poemetto a noi pervenuto predice con nitore l'invasione mongola,
il sacco di Bagdad, l'assassinio del Califfo e infine la vittoria degli
Egiziani sui Mongoli nel 1260, in base alla congiunzione di Giove e
Saturno in Capricorno mentre io - precisava EZ - potrei citare il De
coincidentia astronomica di Pierre d'Ailly, sorbonardo del secolo
XV che dalla congiunzione di Saturno e Giove prevista per il 1789
deduceva la Rivoluzione francese e il crollo della monarchia.1
Che il destino decida dei nostri passi, assegni di nascere e morire a
un dato momento, impartisca diseguali gioie e dolori gli era stato
chiaro da sempre pur sapendo, evidentemente, che il sistema in cui
stiamo prevede che si facciano scelte, si prendano decisioni, si dica
si, no o si resti incerti in un raggio di autonomia simile a quello dell'attore che nel dramma ha il ruolo assegnato, non uno diverso.
Si pensi a che cosa fu il romanzo in antico: «I romanzi dell'epoca alessandrina» annotava in una lontana pagina «sono narrazioni di viaggi, di natali occultati, espongono traversie e accidenti
che alla fine vengono inevitabilmente corretti dal destino o fato, il
quale celebra la sua vittoria con il riconoscimento dei personaggi
separati per caso ma fatalmente uniti. Il romanzo antico, assai
poco sollecito della verosimiglianza, è in realtà una sorta di consolazione, con cui si rassicurava l'uomo (esposto dal crollo delle comunità alla perdita del suo destino) che questo avrebbe trionfato,
che l'essenza era permanente e l'accidente temporaneo. Consolazione non fraudolenta, perché in fondo la vita non ha comunque
senso se resa priva di forma, se non trova un punto di fuga prospettica rispetto al quale ogni avvenimento diventi significativo.
Di qui l'importanza delle coincidenze (l'ultimo a scoprirla fu Pasternak) nonché della morte: l'ultimo attimo concesso per ravvisare la propria forma predestinata e trovar pace [,..]».2
«Un'altra fonte di consolazione» aveva aggiunto «erano stati i ritratti degli antenati: volti dipinti, non migliorati, non alterati in
modo alcuno, visti da un estraneo attentissimo, costretto dalla
natura stessa della sua opera alla purezza di sguardo: il pittore. Il
bambino che contemplava quei volti dipinti e, perché morti, innocenti, d'una potenza fatta di mera saggezza, imparava a trattare
con i suoi impulsi più radicali e con le persone alle quali quegli
impulsi l'avrebbero legato, con la stessa pace che vigeva in quei
suoi dialoghi impossibili con le figure primordiali, i cui tratti
erano carichi di tutti i significati che potevano nascondersi nei
dialoghi con persone vive.»
Passi come quelli citati, risalgono a epoche e occasioni diverse
della vita di Zolla ma per quello che dicono e il modo in cui lo dicono, appaiono simultanei come se i lembi dei primi e degli ultimi, sottratti al dazio del tempo, finissero col congiungersi. Se si
insiste a volerli situare in un ordine cronologico, il momento giusto è attorno al 1960. Nell'agosto di quell'anno usciva su «Paragone», la rivista diretta da Roberto Longhi, un saggio corposo
come un romanzo sul capolavoro di Melville Moby Dick-. Melville
e l'abbandono dello zodiaco.
Il 27 marzo 1962 e il 16 aprile 1963 era la volta di due articoli:
Il destino e la fortuna e II destino, pubblicati rispettivamente sulla
«Gazzetta del Popolo» e il «Corriere della Sera».
Nella Introduzione a I mistici dell'Occidenteì paragrafi quarto e
settimo e il brano sui colori, trattano diffusamente dello zodiaco.3
Proseguendo negli anni, toccò ali 'alter ego letterario di EZ,
Bernardo Trevisano, firmare sul «Giornale d'Italia» la serie dei
segni zodiacali da Capricorno a Sagittario. E dileguato che fu Bernardo sullo spartiacque del periodo romano, la voce narrante di
Le meraviglie della natura. Introduzione all'alchimia subentrava a
illustrare le fasi del processo alchemico secondo la disposizione
per sette o dodici dello zodiaco filosofale.
Il saggio Le rune e lo zodiaco che si è citato nel capitolo precedente, riportava a sua volta ricerche di archeoastronomia condivise da Margarete Riemschneider e Margarete Lochbrunner, le
due studiose tedesche assidue collaboratrici della rivista fino al
1980. Quell'anno, in un articolo su «Sette», il supplemento del
«Corriere della Sera», Zolla esordiva con una noterella biografica
e un presagio:
Un giorno del 1968 a New York, entrai da Mason's, una libreria
dalle pani di Madison Avenue. Il libraio mi squadrò duramente,
fece capire che il tipo di libri che cercavo non gli garbava. Dopo un
po' capii che gli garbava fin troppo: stava soltanto inscenando la
farsa cui nessuno buon newyorkese rinuncia, la scenataccia che
prelude alla confidenza. Prima che uscissi, con l'aria di chi mette a
parte d'una congiura, mi spifferò: «Si segni quel che le dico. Gliela
dò al cento per cento. Fra dieci anni, di psicanalisi si parlerà sì e no.
Ci sarà soltanto A - S T R O - L O - G I A » . Dalla soglia sussurrai:
«Anche le mie fonti lo confermano».4
Non stava scherzando. Tutte le volte in cui s'era imbattuto in qualcosa che l'aveva interessato, di 11 a dieci anni, quel qualcosa finiva
sulla bocca di tutti. Era accaduto con le opere di Adorno, Horkhei-
mer, Marcuse, McLuhan, Lévi-Strauss, commentate da Zolla assai
prima che la loro fama toccasse lo zenit negli anni Sessanta.
Ma nel caso dell'astrologia la previsione che sarebbe dilagata in
forma epidemica era altrettanto facile quanto prevedere lo scotto
che avrebbe pagato, visto che «i concetti più rari divulgandosi,
prendono un'aria balorda», sentenziava.
Nel trattato sugli archetipi, c'è poco nei temi che ruotano attorno al concetto indiano di samadhi o esperienza metafisica che
non rinvii a una teoria del destino coronata, in capo al libro, dalla
visione della rosa.
L'anno dopo, il 1982, era la volta del saggio II cielo scritto pubblicato su «FMR», la rivista diretta da Franco Maria Ricci,5 e un
analogo sfolgorio di immagini siderali guarniva la Introduzione a
Le dimore del cielo. Archeologia e mito delle costellazioni di Giuseppe
Maria Sesti.6 E mentre il rosario dei segni zodiacali si riscandiva in
Uscite dal mondo, un fastoso volume di Allemandi, Cercare il cielo
accoglieva il saggio introduttivo Osservazioni del cielo?
Rinvii svariati al tema del destino si scaglionano da un decennio
all'altro. Nel capitolo iniziale de La nube del telaio accenni al nesso
tra ordo, l'ordine-che-lega e ordior, l'atto-che-abbindola, introducono il tema della tessitura che la concezione arcaica descrive come
un sortilegio. Senonché le sorprese nell'opera di Zolla non finiscono
mai. Si suole associare il culmine del tormento all'istante in cui il filo
della vita è reciso? Ebbene lui invitava piuttosto a riflettere «sulla
botta spietata che ci fu sferrata alla nascita, quando subimmo il contraccolpo terrificante dell'aria che ci gonfiava i polmoni, del latte che
scorreva per la prima volta nella gola e ci fecero ressa d'attorno i pollini della stagione, l'atmosfera invernale, primaverile, estiva o autunnale. Questo trauma primario non è forse un sigillo fetale?».8
1. Definizioni del destino
All'astrologia inizialmente Zolla aveva prestato scarsa attenzione. In
seguito, aveva preso a interessarsi al dottor Ernst Bernhard, lo psicanalista tedesco (1896-1965) che era stato discepolo di C. G. Jung.
Nel suo studio romano - ricordava EZ - si rifugiavano a farsi modellare personaggi che stimavo, e la prima mossa nell'accostare un
cliente, era di cavarne l'oroscopo. La cura si serviva di quello
schema per orientarsi, trovare soluzioni, indirizzare. Si può dire
che tutta la terapia era già implicita in quel disegno del carattere,
delle capacità, del destino. Il metodo di Bernhard ricalcava puntualmente quello junghiano. Non serviva a stabilire dei fatti, ma a
individuare una conformazione del destino e che cosa è più consono al destino del variare di stagioni in cielo da un capo all'altro
dell'anno? Se poi alle 12 costellazioni si combinano i 7 pianeti, si
riesce a definire con precisione ogni sorte. Almeno, cosi pareva a
Bernhard e ai suoi clienti.9
Jung aveva intuito che gli archetipi si possono esprimere in modo
adeguato mercé le combinazioni astrologiche. Studiando il gruppo
dei clienti di Bernhard, EZ si era persuaso che senza un'idea di destino poco o nulla vale la vita e di essa, senza il sistema astrologico
«non posso nemmeno cominciare a parlare in maniera articolata».
Ne era scoccata una definizione secca come lo schiocco di una pallina da ping pong: «Il destino è il nesso misteriosamente necessario
tra il carattere d'un uomo e gli eventi che gli si costellano intorno».
Ricamandoci sopra aveva aggiunto:
L'idea di un destino sbalestra fuori delle nostre categorie ordinarie, implica una connessione fra il mondo interiore e gli accadimenti esteriori, trascende la semplice morale, perché comprende
anche l'inconscio, si rivela in tutta la sua sconcertante realtà
quando ci accadono sincronismi. È qualcosa di ceno e di concreto, ma si può cogliere ed esprimere soltanto poeticamente, o in
musica o dipingendo un ritratto.10
A proposito delle ricerche statistiche sulla validità dell'astrologia, si
era documentato sul caso dei coniugi Michelle e François Gauquelin:
Cominciarono a raccogliere dati, proponendosi di fornire la
smentita decisiva dell'astrologia, di dimostrare statisticamente
che a uguale oroscopo non corrisponde uguale sorte. I loro numeri cominciarono però a ballare davanti ai loro occhi, prendendosi gioco di loro; invece di smentite, venivano fuori conferme dell'astrologia. Risultò ben probabile la presenza di Marte
e Saturno nell'ascendente o in medio coeli tra medici, di Giove
fra attori e soldati, della Luna fra scrittori e politici. Ma i dati
più sconcertanti concernevano i campioni sportivi; invece della
rata probabile del 12% per i nati con Marte in ascendente, fu accertato il 22%, che ha una probabilità su 5 milioni di prodursi.
Naturalmente le polemiche prò e contro l'accertamento sono
state interminabili. Ma anche futili, perché si scambia la categoria sociale e sociologica «campione sportivo» per l'essenza di
un destino.11
In altre parole, un oroscopo non procura informazioni su fatti socialmente, esteriormente definibili. Gli oroscopi di Dante o
Goethe, che erano nati ambedue sotto i Gemelli, sono come
«carte geografiche, cieli squadernati su cui cogliere il segreto della
loro sorte [...]. L'occhio poetico può scorgere verità che non si svelano all'uomo legato alla lettera dei fatti».12
E fin dove arriva la gittata dell'occhio clinico?
Se n'era occupato in un articolo che risale al 1962 riferendo il
caso che aveva incoraggiato lo psicologo Lipot Szondi a formulare
una propria, empirica teoria del destino.
Una coppia si presenta da Szondi, la giovane donna è inquieta,
tormentata da dolori alla testa, di notte non piglia sonno, di
giorno è intimidita. Poi, la serie di sintomi particolari: non riesce,
scrivendo, a formare la «k», è tentata di buttarsi in una fontana.
Una prima cura allevia i mali, ma per poco; lo squilibrio non è
stato corretto, ella comincia a sospettare di aver avvelenato il bambino, il marito, gli ospiti e piangendo dice di ricevere di quando in
quando le visite di una vecchia afflitta dalle medesime ossessioni.
Il marito svela che la vecchia è sua madre, che suo padre e uno
zio della moglie erano cugini, e quello zio s'era invano proposto di
farli incontrare e sposare quando erano adolescenti. La moglie
s'era sposata la prima volta a diciotto anni per interesse, divor-
ziando quasi subito; dopo aveva incontrato lui e questa volta le
nozze erano state ispirate dall'amore. Però l'amore, a distanza di
cinque anni, stava riscuotendo il suo prezzo: le ossessioni che denunciavano la natura segreta del vincolo. Secondo Szondi è una
stessa tendenza ereditaria, dalle manifestazioni diverse a seconda
dell'occasione, che ora annoda vincoli d'amore, ora isola nell'ossessione. Due persone — spiega - possono appartenere alla stessa
costellazione psicologica di tipo epilettoide e l'uno diventa un
Caino brutale, attaccabrighe, assassino, mentre l'altro reprime in
sé Caino e diventa Abele che vive i suoi parossismi come fantino,
ferroviere, spazzacamino, pompiere, fornaio e spesso homo sacer.
Così il destino d'un uomo che appartiene alla costellazione schizoide può pigliare forme differenti, l'uno riducendosi ad un mero
schizofrenico, l'altro soffrendo di una nevrosi ossessiva, il terzo
diventando un fanfarone paranoico o un inventore. Taluni si
comportano per tutta la vita come degli eccentrici o come intellettuali che riflettono soltanto su sistemi, la logica pura e le matematiche. Altri diventano vagabondi e abbandonano la famiglia e
la comunità errando laceri e sporchi per anni interi, finché un
giorno muoiono di fame e di freddo in un fossato o di tisi in un
ospedale.
Scavando negli archivi parrocchiali Szondi si era reso conto che
persone i cui antenati s'incontrarono (nell'amore, nel delitto, nel
lavoro) tendono a riunirsi molto più di quanto richiederebbe la
legge di probabilità. Se si porta nel sangue la propensione a scegliere le persone con cui avere rapporti per attrazione o per opposizione, «grazie ad un acconcio sistema di perforazione di schedine - osservava EZ in margine al rapporto su Szondi e la sua
scuola — non dovrebbe essere impossibile escogitare una macchina per impostare il proprio destino, da nutrirsi con una dieta
mista di informazioni, cioè combinando quelle stanate dagli uffici di ricerche araldiche con i risultati delle analisi chimiche e dei
test psicologici».13
E a proposito del capitano Ahab che nel capolavoro di Melville, Moby Dick, «voleva costruire una carta delle migrazioni dei
capodogli con precisione statistica, sì da poter finalmente andare
diritto allo scopo, ammazzare la balena inconfondibile, distruggere ogni traccia di natura», rifletteva che «poche imprese di oggi
sono dissimili».14
Dieci anni dopo, in un commento al Goethe di Pietro Citati,
osservava che nel cielo natale dello scrittore tedesco è dominante
Mercurio: il dio delle premonizioni e del destino:
Mercurio trasvola, non si sofferma ed è questa una delle grandi
qualità del libro: non cede ai ricatti di Saturno, dio cosi potente
oggigiorno. Non si lascia mai imprigionare, Mercurio, e anzi riesce perfino a trovare un accomodamento con Saturno e un'intesa
con tutti gli dèi planetari. Che sia d'accordo con Venere, è evidente dallo stile, tuttavia non si lascia mai trascinare nelle vertigini
di Venere. Con Venere allestisce i suoi corteggiamenti e della dèa
osserva tutte le astuzie: infatti una delle parti più gustose del libro
è la descrizione degli abbigliamenti: congiunzioni di Venere e
Mercurio.15
Passi come quest'ultimo e i precedenti, attivano nel lettore un dinamismo psichico, spronano a domandare: se il cielo che squaderna oggi la scienza non ha nulla a vedere col cielo zodiacale, c'è
un piano di realtà nel quale situare un cielo del genere?
Quante volte parlando in pubblico, lo scrittore era stato messo
di fronte a domande simili e spesso la resistenza, l'ostilità erano
state palpabili. Come la volta in cui aTorino, al termine della conferenza per l'Associazione Culturale Italiana nel 1990, un padano
inviperito lo aveva affrontato con queste parole: «Professor Zolla,
ci vuol dire di grazia che cosa sono gli archetipi?».
Come nulla fosse, sprizzante allegria per l'occasione che veniva
a taglio, aveva risposto:
Archivuol dire origine e «tipo» viene dal greco typtein = battere,
coniare. Quindi «archetipo» è la forma impressa sulla materia
delle cose come un sigillo. Archetipi sono anche i punti dell'orizzonte, da due: Oriente-Occidente, in sufinoalle 24 ore, ossia i 24
punti toccati dal sole nel suo giro, che possono essere ancor più
ravvicinati pareggiando i giorni del giorno più lungo ovvero
l'Anno. Questo, a sua volta, si restringe a trentasei o a dodici, e se
l'uomo si distende come una ruota toccando la testa coi piedi, le
stazioni solari equivarranno alle membra umane: la testa-Ariete
toccherà i piedi-Pesci, e via via arretrando. Laflora,la fauna, le singole minime cose sono cellule di organismi più vasti. Per capire la
forma specifica, il tipo, bisogna risalire all'archetipo che l'ha tipizzata. E vuol sapere qual è l'archetipo del viaggio? Ma è l'esodo, l'egira. Quando ci si muove viaggiando sulla terra l'archetipo è il pellegrinaggio, e l'archetipo del pellegrinaggio è l'estasi.16
Scrosciarono applausi in teatro quella sera. Acquattata nel via
vai della folla mi divertivo a catturare battute, lembi di commenti in un registro esteso tra la giubilante approvazione e l'astio più protervo. A un certo punto riconobbi la voce padana:
«Toccare coi piedi la testa: testa-coda! Uhm! Il troppo è troppo!»
sentii il tizio brontolare tra sé e sé mentre a passo dignitoso guadagnava l'uscita.
Torniamo allo zodiaco.
L'occhio nudo, al quale un tempo si schiudevano gli zodiaci, è
uno strumento ormai angusto e impedito, sosteneva EZ, e se ci si
porta entro la scienza odierna occorre scordarsene.
Non stava esortando a obliare le ricchezze favolose del passato
astrologico, ma ad acquisire le cognizioni tutte nuove che «oramai ci si offrono e ci conducono tra altri misteri».
E incitava a riprendere la questione basilare:
si contempla il cielo, ma che cosa si scorge? Le onde luminose o fotoni i quali colpiscono la retina sono una frazione cosi esigua delle
vibrazioni oscillanti tutt'attorno, che rivelazioni cruciali si sottraggono alla nostra attenzione. In genere la nostra vista è minima
rispetto a quella degli animali. Che cosa mai vediamo, rispetto a
un'aquila sospesa sopra il paese?
Non soltanto le sue diottrie svergognano le nostre, miserande al
paragone, ma nel suo tessuto oculare si schiudono anse, fovee che
permettono la selezione d'un campicello e la discesa dell'attenzione su di esso fino alla massima prossimità. In tempi arcaici ci si
avvedeva delle capacità eccezionali che spettavano alle specie animali e il proposito umano primario era di immedesimarsi trasfondendosi nella loro identità; si invocava questa metamorfosi osservando con cura, agognando con intensità, fino a cadere in deliquio e ricevere l'allucinazione di essere uniformi a loro. Lo sciamano volava allora come un'aquila, spingeva lo sguardo arditamente all'intorno, con furia aquilina. Ma non è soltanto questione di appurare il raggio del visibile. Ormai si sa che la parte sostanziale dell'universo ci elude. Non si tratta dei raggi ultravioletti
da una banda, e di quelli che si succedono fino alle onde radio,
dall'altra. Esiste una materia oscura, che si sottrae a qualsiasi sondaggio, e già nel 1933 Fritz Zwicky la scopriva osservando il complesso di galassie della Vergine, misurando la velocità del moto di
ciascuna per un verso, valutando la luce che ne emanava per l'altro. Risultò che la massa dell'insieme era maggiore di quella delle
componenti: una forza di gravità straordinaria, nata da una materia oscura invisibile ma presente, tratteneva nel suo spazio l'insieme di galassie.17
Di nuovo se il padano l'avesse sentito parlare così, avrebbe borbottato: «Questo qui non sta al tema: aquile, diottrie, sciamani,
materia oscura, galassie. Il troppo è troppo!».
Nella Introduzione a Le dimore del cielo di G. Maria Sesti lo scrittore confessava:
Più e più volte ho fatto l'esperienza di culture ritrose e segrete che
luminosamente si palesavano, non appena mi impadronivo del
loro sistema zodiacale.
Per anni mi aggirai, irrimediabilmente estraneo, nel mondo delle
saghe nordiche. Per quanto leggessi, la prosa islandese arcaica e
l'anglosassone continuavano a rimanermi inaccessibili, enigmatiche e brutali. Non mi parlavano che di gesta bieche, di dure e monotone fùrie; nel ricordo ne echeggiavano soltanto torve canzoni
di guerrieri ubriachi rimbombanti per desolate aule di pietra, ululati di venti e di lupi su grigi ghiacci interminabili.
Una lugubre, opaca terribilità: una povera cosa;finchéincominciai
a riflettere un giorno sulle rune, le lettere dell'alfabeto nordico, che
non sono semplici segni, ma simboli, ciascuna, d'un aspetto della
vita. Provai a disporle sul cerchio dello zodiaco, e risultò che ogni
paio di rune esprimeva esattamente i significati di un segno zodiacale. Allora tutta l'arcaica letteratura islandese e anglosassone mi si
dischiuse, le molteplici anime dei personaggi svelarono le loro
profondità. Le saghe mi offrivano ormai cammini percorribili,
luoghi ospitali, semplicemente perché mi era adesso familiare il
loro zodiaco, cui potevo riferire i miti e le cosmogonie, le opere
quotidiane, le esperienze interiori, gli dèi. Lo stesso m'accadde con
le letterature celtiche d'Irlanda, del Galles, di Bretagna, tutt'altro
che lugubri, anzi meravigliosamente deliranti, ma proprio perciò
d'una irriducibile lontananza: esotiche; le leggevo divertito ma impartecipe. Tuttavia anche queste letterature mi diventarono familiarmente intellegibili allorché imparai da Robert Graves a situare
sullo zodiaco gli ogam, le rune celtiche. Allora le più folli e arruffate
fiabe si svelarono per limpidi racconti simbolici, per trasposizioni
di esperienze interiori in narrazioni fantastiche.18
2. Giochi cosmici
In certi raccoglitori dell'archivio, plasticati in verde cupo e rosso,
blocchi di appunti e disegni autografi giacciono in custodie trasparenti, ordinate per anno. In una cartella datata 1970 mi ero
imbattuta in una serie di schizzi di giochi infantili accanto ai quali
erano accuratamente trascritte cantilene e ninnenanne, e la sensazione che i giochi dei bambini e le ninnenanne entrassero alla
grande nel tema zodiacale era stata nettissima. Sono giochi tradizionali dell'area mediterranea europea, noti un po' a tutti per
avervi partecipato da piccoli sulla ghiaia che sfrigolava sotto i piedini. Forse non sapevamo e non abbiamo insegnato ai nostri figli
che quei giochi hanno squadrature cosmiche. La mano di Zolla le
aveva tracciate disponendo accanto a ogni gioco la sua filastrocca:
l'albero di cuccagna, il nascondarello, il salto della corda, la mosca
cieca, il saltaranocchia, i quattro cantoni, le belle statuine: «son
d'oro e d'argento, costano cinquecento, uno due tre». Oppure
Maria Giulia in mezzo alle bambine in cerchio: «Maria Giulia, di
dove sei venuta? Alza gli occhi al cielo. Fa' un salto. Fanne un
altro. Fa' la riverenza. Fa' la penitenza. Ora in su ora in giù. Dài un
bacio a chi vuoi tu».
Non ebbe dubbi: nei rimari del buon tempo antico, c'era una
chiave per accedere ai territori del Grande Paesaggio. Marius
Schneider che per un periodo si era dedicato allo studio delle ninnenanne iberiche, aveva compreso di trovarsi dinanzi a «una specie di Antologia Palatina o un repertorio di haiku, che comprende
distici fulminei, come questa turpiloqua apocalissi delle mamme
di Galizia: " Garrotati in culo creperanno i vecchi, /E noi due, bambino, si resterà soli!". E canzonette allegre dall'eros franco e spicciativo, come questa della mamme asturiane: "Ho Giovannino
mio nel letto, / Oggi, bel galante, non si può. / Dormi, bambinello
dell'anima mia, IE tu torna domani alle tre"».19
Nelle loro conversazioni romane Zolla e Schneider20 erano tornati di frequente su un punto cruciale: quelle ninnenanne servivano a iniziare i bambini ai misteri dell'anno, davano lezioni di
geografìa zodiacale, erano sacre cantilene, scongiuri contro i
morti maligni perambulantes in tenebris, composizioni mitologiche solenni «scadute a svenevoli blaterazioni soltanto con l'evo
moderno».
In una ninnanna si culla il bambino invitandolo a identificarsi
con Lucifero:
Luciferìno dell'alba, dormi
Se il bambino dormisse
Nella sua culla lo scaglierei
Coi piedini al Sole
E lafaccina alla Luna.
Uccellin che sull'ulivo canti
Non mi destare il bambolino!
Ha sonno il bambinello.
Che cosagli daremo?
Calor di lumachina, che mette corni.
Verrà la Lupa, la Regina Mora
A cercare ipiagnucolosi!
La ninnananna, insegnava EZ, descrive il periplo dall'uno all'altro segno, nella notte, sotto la luna nuova, attraverso l'inverno.
Brilla in cielo Venere vespertina: la ninnananna ne fa una controfigura della Vergine zodiacale, e dice al pargolo che Lei gli sta
dando la buona notte di lassù, affinché con tal viatico le forze del
giorno e della notte si pareggino ed egli slitti nel sonno.
Ora il bambino addormentato scenderà nella parte infera del
Grande Paesaggio, buia landa palustre, canneto lungo il mare di
tenebra. Fa la traversata nella culla che è una bara che è un pesce:
sul mare egli salpa, scorre, vola.
La ninnananna descrive la navigazione proponendo i simboli del
vortice, della spirale, del nicchio, della conca. L'immagine d'un uccellino che canta da un ulivo o da un mandorlofioritosegna il termine del tragitto. Si entra nel purgatoriale mare di fuoco, fretum
febris avanti l'alba, tempo onirico di carnevale. A questo punto la
ninnananna parla d'un «calor di lumachina» che fa crescere le
corna. E in forma di Lumachina fa la sua prima carnevalesca apparizione, Madre Natura. La cantilena prepara il Luciferino dell'alba
alle apparizioni successive, e lo mette in guardia: se non fa la nanna
da bravo, se la vedrà piombare addosso come Lupa o feroce Regina
Mora scortata dal suo losco manutengolo, El Coco. Ma se il bimbo
si cala buonino nel sonno e fa i sogni che deve, metterà cornetti luciferini e un bel di sarà lui, lassù sulla Montagna meridiana e solstiziale, il cocco di Madre Natura.21
Le madri del vecchio Occidente - era stato il suo commento non avevano fatto altro che insegnare ai pargoli in culla l'arte di librarsi in quei paesaggi onirici.
3. L'abbandono e lo zodiaco: a proposito di Moby Dick
«Nell'abbandono l'unica regola è il momento presente. L'anima
vi è leggera come una piuma, fluida come l'acqua, semplice come
un fanciullo.»
Nel memorabile saggio sul capolavoro di Melville del 1960, la
parola chiave «abbandono» ricorre otto volte in quaranta pagine.
Pare il rintocco di campana che affiori da un mondo sommerso,
l'immenso mare d'acqua nel quale la nave maledetta del capitano
Ahab s'inabissò sfracellandosi contro la balena bianca.
Nel romanzo marino di Melville Zolla raccolse lo stesso segnale captato nel capolavoro di Pasternak, Il dottor Zivago, un segnale simile alla luce intermittente di un faro nella notte. Quel
faro illumina due dimensioni del tempo agli antipodi: il tempo
diurno della storia nella tregenda di Zivago e Lara Fèdorovna
quando in Russia anche le betulle sanguinavano, e il tempo notturno del mito nell'epopea melvilliana della baleniera suicida. Nei
due romanzi EZ aveva scorto versioni cozzanti dell'abbandono:
y
nel Dottor Zivago l'abbandono dei due amanti ¿/destino - in una
resa che però più lucida, intemerata e mansueta non poteva essere; in Moby Dick l'abbandono dello zodiaco - cosi recita il titolo
del saggio zolliano - ossia il distacco da una concezione della vita
affidata al volere del cielo una volta riconosciuta l'impotenza dei
piani fondati sul «libero» arbitrio umano.
In un articolo pubblicato lo stesso anno in cui uscivano i saggi
sui capolavori di Melville e Pasternak, EZ citava un passo di
Nietzsche: «Poiché fui stanco del cercare / Imparai il trovare. /
Poiché un vento mi avversò / Navigo ad ogni vento».22
Una mente abbandonata è agli antipodi del fatalismo. La vigilanza e l'attenzione la rendono fluida e quieta mercé la chiarezza.
Una mente siffatta - scriveva nella Introduzione a I mistici dell'Occidente— assomiglia al vellum Gedeonis, il vello che nel deserto
si conserva umido e nella palude secco, simbolo di creatività e distacco dal mondo, di una critica intesa come opposizione feconda. È una mente immersa nel proprio cielo. I taoisti lo chia-
mano il «cielo interiore», invisibile e sottile, anteriore alla nascita,
prossimo all'uno. Sta di casa «a due pollici e quattro decimi sotto
l'ombelico», assicurava Pao-p'u tzu (283-343).23
Melville e l'abbandono dello zodiaco e gli altri scritti zodiacali,
sono solchi tracciati nel pensiero profondo dello scrittore di cui
è futile sondare la genesi, un «come» e un «quando» legati a occasioni di lettura - come l'incontro coi romanzi d'avventura di
Melville, o circostanze estrinseche della vita quali quelle offerte
dagli esodi in un altrove fisico o mitico incastrato in una mente
immersa nel proprio cielo. Si può tentare beninteso di passare in
rassegna alcune di queste idee configgendo la punta del compasso proprio sul saggio sul Moby Dick. Il lucido abbandono è
una di esse. Un'altra è l'innocenza, l'innocenza straziata. La balena arpionata dal capitano Ahab, dal marinaio Stubb e il resto
della ciurma nelle gelide, remote acque dell'oceano, è il simbolo
vivente di quella che per Zolla è la massima fonte d'orrore: l'innocenza straziata, «la dimostrazione dell'impossibilità di vivere,
della assoluta disumanità della vita; ma è anche la dimostrazione della necessità di vivere di là dalla catena di colpe, addossandosele tutte, consumandole col proprio sacrificio sì da infrangere in un punto la catena del male invece di propagarlo ritorcendolo». Un altro simbolo dell'innocenza straziata, che è
tutt'uno con la disgrazia senza peccato è l'agnello: esso «sta completamente fuori della forza perché la subisce senza partecipare
alle sue leggi».
Una contemplazione senza turbamento della disgrazia incolpevole, dell'oltraggio smisurato inflitto al mondo della vita dai
balenieri a caccia nell'oceano o dai macellatori di agnelli diviene una fonte inesauribile di pensieri sulla forza immane che
cavalca persecutori e perseguitati. La si chiama destino, ma assegnarle questo nome piuttosto che un altro, non scioglie l'enigma che alla mente arrovellata si presenta senza soluzione, a
meno di sciogliere lo spasmo che deforma il pensiero giacché di
uno spasmo, di un'orrida smorfia si tratta fino a quando non ci
si risolve a fare come il marinaio dell'altro romanzo d'awen-
tura di Melville, Mardi: «Ho viaggiato senza carta, con il compasso e con lo scandaglio non avremmo trovato queste isole di
Mardi. Chi si butta con coraggio getta tutte le gómene e allontanandosi dalla brezza comune, che vale per tutti, gonfia le vele
con il suo fiato».24
È il lucido, intemerato abbandono, lontano anni luce da una
resa supina, la soluzione additata da Zolla negli scritti sul destino
e lo zodiaco. «La ricerca della verità come scoperta» scriveva nel
saggio sul Moby Dick «vuole che si sia soli dinanzi al mondo, l'illuminazione non è collettiva, per sua natura. Bisogna abbandonare ogni concetto noto, bisogna ignorare ogni conoscenza
morta per trovare ciò che vive e dà vita. Bisogna che si muoia per
rinascere [...], cioè che si viva come il sole attraverso lo zodiaco.»25
***
I brani che si sono riportati offrono un'immagine inedita del conoscitore di segreti: un conoscitore eretico giacché nei suoi scritti
contravvenne all'antica norma di tacere di ciò su cui è azzardato e
talora devastante aprire gli occhi sebbene si tratti di segreti coi
quali ognuno di noi convive, arrivando, qualche volta, perfino ad
accorgersene sotto una sollecitazione qualsiasi. Può essere la vista
di un cane che trotterella sigillato in un mondo di cui così poco
filtra all'esterno; di un ippocastano fasciato di nebbia o squassato
dal vento; degli occhi di un cucciolo che ancora non sanno guardare; di un cero che arde nella penombra; di una vecchia che incespicando su un viottolo in salita pare allungare di chilometri i
pochi passi dall'uscio di casa. In simili situazioni la scopertura dei
segreti avviene senza patente alcuna di conoscenza o pedaggio di
studi avanzati. Tra un conoscitore di segreti e io che «non so», la
differenza in quei frangenti s'azzera, e una festevolezza commossa
si fa strada dentro di me per scordarmene però quasi subito, non
appena il ritmo di un vivere non più percepito come un dono, è
ripristinato.
Non così era stato per lui. Che la festa della vita non finisse
mai, Zolla lo aveva creduto, vissuto e affermato tenacemente,
nella buona e nella cattiva sorte, in stato di benessere e in malattia, e quando sorella Morte gli si mise al fianco alle prime luci di
quel mattino, nessuno spasimo, non un'ombra di resistenza l'avevano accolta.
L'approdo: i lembi si congiungono
La vocazione al segreto non ha niente a vedere
con la vita sociale, eppure è aggiogata alla vita
sociale: è lo scotto che deve versare per potersi
divulgare. Talvolta si sottrae: gli anacoreti, gli
uomini del biasimo, i pazzi di Dio, i manichei. I
mistici - ci sono pattuizioni d'ogni genere. Ma
proprio ciò che li rende accetti è il germe della
loro rovina.
Dai Quaderni
Nell'India tradizionale gli stadi della vita di un uomo sono regolati su un modello metafìsico: la rescissione dei legami mondani e il perfezionamento della propria natura intrinseca sono la
mèta verso la quale in età avanzata tutto deve convergere. È un
principio acquisito nei secoli e non è un segreto per nessuno. La
segretezza sta nel processo di effettivo distacco. Tra un'esotericità
cullata come un privilegio settario, corporativo, e un'immersione in ciò che è «più interno» - nel senso letterale del termine
«esoterico» — la differenza è la stessa del proverbio: «tra il dire e
il fare c'è di mezzo il mare». Attaccarsi alla giacca il distintivo:
«iniziato patentato» o atteggiarsi come se quel distintivo ci fosse
davvero, è un vezzo puerile che ha poco a spartire con l'approdo
all'esoterico che Zolla visse effettivamente dopo averne esplorato
le dinamiche scrutandole dentro di sé, incontrando persone che
della conoscenza esoterica ebbero fondata esperienza, incrociando anche a un passo da casa luoghi colmi d'aura, inebrianti
come un elisir.
Sull'elisir c'è un testo breve del 2001, e chi lo ha letto ha potuto
accostare, una volta ancora, la concezione zolliana sul fulcro esoterico dell'esistenza.
Elisir - scriveva - proviene dall'arabo al-iksir, a sua volta tratto
dal greco xerón, «secco», e designò la pietra filosofale, ovvero
mondata di ogni liquidità, vertice della materia, che si concentra in essa sopra la natura, offrendosi come raccolta massima di
vitalità, terapeuticità, quindi fulcro d'ogni guarigione, da sanare ogni malanno e redimere qualsiasi colpa. Ma a parte i procedimenti di laboratorio alchemico cosi evocati, la parola rappresenta il fulcro dove si congiungono alto e basso, cieli e terra.
Anzi dove si stabilisce alla perfezione il loro rapporto. Senonché: che cosa è la relazione fra l'uomo ed il cosmo, fra l'io e la
natura?
Talmente importante è questa domandina perché ne dipende la
fusione tra i due estremi, che alla fin fine è l'estasi o sommo
bene, la loro confusione inestricabile, in cui si avvincono e distruggono a vicenda in un meraviglioso trionfo di morte e resurrezione. Ha tanti sinonimi questa sintesi suprema o elisir, è
il sommo nepente, il sangue del Graal, il gioiello che elargisce
ogni desiderio: sorso di paradiso, cibo soprannaturale.1
Nella limpida calma di una visione alla quale nulla è più da aggiungere, la domanda sulla relazione uomo-cosmo, io-natura era
colmata in pagine il cui andamento non assomiglia certo a quello
di una lezione accademica. Da tempo il professor Zolla era sceso
di cattedra, o forse non c'era mai salito nel senso consueto, e a chi
s'informava sulla sua carriera accademica, soleva rispondere: «Ho
fatto il docente universitario per quarantanni e lo Stato mi ha pagato per questo. Qualche centinaio di studenti si è laureato e addottorato con me. Tutto qui».
Proviamo a immaginare che un giorno dicesse a lezione:
Il tutto vede le parti con un solo sguardo, mentre la parte non vede
il tutto se non per aspetti diversi e successivi. Per questo la divinità
è la simultanea totalità degli aspetti successivi. Onde la sua visione
è unica, e non si attua in successione.2
La classe, normalmente distratta, s'era fatta attenta. Qualcuno
voltandosi al compagno seduto dietro, aveva lanciato uno
sguardo interrogativo: «Che sta dicendo?».
Intanto il professore aveva proseguito a parlare, e quasi nulla
restava tra le pareti dell'aula, dell'eco di quella sentenza: «Il tutto
vede le parti con un solo sguardo, mentre la parte non vede il
tutto».
Che Zolla parlasse per sé, è vero e falso allo stesso tempo. Falso
- perché citava e argomentava dentro lo schema di una meditata
lezione accademica. Vero - perché l'origine e la mèta del suo parlare scavalcavano il tema della lezione. Chi s'era voltato a domandare: «Che sta dicendo?» aveva ragione, sebbene spiegare perché
non avesse tono non sia poi cosi facile.
***
Cronologicamente il distacco dallo stile di vita che dai trenta
anni in poi era stato il suo, avviene nel 1991 quando Zolla lascia l'insegnamento universitario, l'abitazione romana e l'oramai assottigliata compagnia di gatti in via Merulana e ci si ritira, lui e io, tra vecchie mura fasciate di nebbia nel borgo di
Montepulciano (il toponimo, curiosamente, ha la rarità di contenere tutte e cinque le vocali dell'alfabeto italiano e, quanto
alla cittadina, ci sono in realtà due Montepulciano e quella sotterranea è un tracciato di cunicoli, noto a pochissimi e quasi
inaccessibile).
In una visita allo scrittore riportata nel «Sole 24 ore» al valico
del 2000, Giovanni Santambrogio compiva senza saperlo un atto
simmetrico a quello di Luigi Compagnone quarantadue anni
prima, quando aveva incontrato EZ nel piccolo appartamento
romano dove allora abitava.
La casa di Zolla a Montepulciano in cima alla collina - Santambrogio annotava - è al centro di un fino reticolo di ripide viuzze
e di portici ad altezza d'uomo. Ogni stanza dell'abitazione reca
segni d'Oriente, luoghi in cui ha viaggiato e dove ha dialogato
con il buddhismo, l'induismo, il taoismo. Un delicato profumo
di essenze accentua la diversità della vecchia abitazione da quelle
adiacenti, tutte con i tetti in cotto, lefinestrepiccole e le porte in
legno. Dentro, l'Oriente scandisce le ore; fuori, si erge maestosa
la facciata manierista della chiesa di Santa Lucia, opera di Flaminio del Turco. Il colore della pietra s'infiamma ai raggi del sole
per sfumare in un bianco sensibile alle minime rarefazioni della
luce. È questo spettacolo che tiene compagnia a ogni lavoro di
Zolla. La piccola scrivania sta proprio di fronte alla «finestra-palcoscenico». Poco distante e poco sopra si apre la piazza di San
Francesco con il suo portale gotico. Dal pulpito ricavato nella
facciata avrebbe predicato San Bernardino da Siena, l'infaticabile
oratore degli inizi del '400 che attraeva le folle e convertiva anche
i cuori di pietra.3
Quasi ogni giorno che non fosse nevoso si svolgeva, immancabile, la passeggiata di Zolla su per gli erti vicoli o giù, verso il prato
di San Biagio, accosto al piccolo cimitero storico che nell'abbraccio dei cipressi a Montorio avrebbe poi accolto le sue spoglie. I
poliziani che incrociavano l'anziano signore che a passo cadenzato, basco e impermeabile bianco, faceva la sua passeggiata accanto alla moglie, lo salutavano col cenno di riguardo riservato a
uno straniero di passaggio. In effetti, da bambino fino all'ultimo
giorno, lui non smise di considerarsi un outsider, un ospite tollerato, uno che aveva accolto il disagio di esistere in un secolo
empio come una scommessa, e scavando nei segreti della storia e
dell'animo umano, infaticabilmente, aveva cercato di restare
senza macchia dichiarandolo anche, indifferente alle prevedibili,
velenose reazioni a destra e a manca. Sui versanti della critica sia
laica sia cattolica l'attenzione al pensiero e all'opera dello scrittore
conobbe picchi di estremo favore agli inizi della carriera letteraria
e di tendenziosa avversione fino agli anni Ottanta. Nell'ultimo
decennio della vita, mentre gli piovevano addosso riconoscimenti di vario genere,4 il pendolo fra i due estremi aveva finito
con lo stabilizzarsi su posizioni di intimidito rispetto nonostante
isolati tentativi di affibbiare comunque a EZ un'etichetta di
parte: secondo alcuni, sarebbe stato membro di una non meglio
precisata banda di neognostici assieme al rumeno Emile Cioran e
a Guido Ceronetti. In quel caso semmai, l'anatema gli aveva fatto
perfino piacere. E in un servizio del «Corriere della Sera» sui
Nuovi eretici: lafede trasversale, dopo un prologo sulla denominazione antica di gnosi, era intervenuto affermando: «Sotto l'episcopato del cardinale Siri si pubblicò per qualche anno a Genova
una rivista diretta da Baget Bozzo dove erano colpiti dell'accusa
di gnosi quasi tutti gli scrittori moderni, dal Leopardi in poi. Una
particolare furia vi dettava anatemi antignostici contro di me; mi
confesso lusingato».5
E, sempre nello stesso articolo, più avanti scriveva:
Chi voglia divertirsi a scorrere tutti coloro che con un briciolo di
ragione si possono denominare gnostici, dai primi secoli cristiani
a oggi, potrà leggere la cronaca fedele che ne tracciò Culianu [...].
In una noterella apparsa su L'umana avventura (Jaca Book, inverno primavera 1990-91), lo studioso rumeno prendeva lo
spunto da un esilarante articolo di Ceronetti che elencava gli gnostici nuovi: oltre a me, Cioran e lui stesso. Quindi rammentava
che nell'800 Eugen H. Schmitt e il femminista Ottfried Eberz salutavano la gnosi come verità suprema; seguì, discepolo di Heidegger e di Bultmann, Hans Jonas, che improvvisò un attacco alla
gnosi come rifiuto del mondo. Voegelin individuò nella gnosi il
sostrato micidiale del marxismo. Un discepolo di Heidegger, Taubes, idolo dei sessantottini tedeschi, riconobbe nella gnosi la dottrina distruttiva della storia, da salutare con amore. Per Luciano
Pellicani infine gnostici sarebbero i rivoluzionari [...]. In breve, a
compendio di migliaia di pagine, Culianu concludeva: «O si rinuncia all'etichetta di "gnosticismo moderno" o tutto può sembrarci gnostico». Sia un marxista che me - terminava EZ liquidando così l'argomento.6
Tra il 1990 e il 2002, quattordici nuove opere avevano visto la luce,
e Discesa all'Ade e resurrezione nell'autunno del 2002, era stata l'ultima. In quella dozzina d'anni gli editori Adelphi e Marsilio avevano provveduto alla ristampa dei libri zolliani che erano stati una
pietra miliare nella saggistica italiana del secondo Novecento: la
monumentale antologia I mistici dell'Occidente, I letterati e lo sciamano, Che cos'è la tradizione, Le meraviglie della natura. Introduzione all'alchimia e le due opere in inglese Archetipi e L'androgino,
tradotte anche in spagnolo e giapponese.7 Tra i nuovi titoli: una
monografìa su Ioan Petru Culianu e il dittico La luce e La scoperta
del sacro in America; il trattato Le tre vie sul tantrismo indù e
buddhista; lidio dell'ebbrezza, dotta antologia sulle tracce del Dionisismo nelle letterature moderne. E ancora La nube del telaio. Ragione e irrazionalità tra Oriente e Occidente, La filosofia perenne,
Uscite dal mondo e Lo stupore infantile-, infine Un destino itinerante
dove sono raccolte quelle conversazioni tra Oriente e Occidente
con Doriano Fasoli menzionate all'inizio. Va detto che nei primi
anni Ottanta era stato Marsilio il primo editore a infrangere il
tabù sugli scritti di Zolla avviando la pubblicazione di una serie di
libri che oggi si ricordano tra i suoi più belli: Aure? L'amante invisibile, Verità segrete esposte in evidenza, e la versione dall'inglese di
Archetipi, ristampati più volte in edizione economica.
Negli anni Novanta, la ristampa delle vecchie opere in contemporanea all'uscita delle nuove, offriva una visione globale
delle tappe e degli snodi di un itinerario intellettuale troppo esuberante per venire incasellato alla maniera solita. L'itinerario di
uno studioso di stampo antico, temprato a un'autodisciplina che
lo rendeva incurante ai richiami del mondo esterno, teso alla conquista di un sapere dal quale traeva il piacere più elevato e sottile
per lui concepibile. Dei temi che lo seducevano diventava temporaneamente lo schiavo, docile a qualsiasi servizio per umile e meccanico che fosse. I suoi quaderni sono colmi di trascrizioni dei
passi degli autori studiati, di schizzi che inchiodano dettagli essenziali all'interpretazione di un'immagine. Si prenda il caso della
doppia stesura, inglese e italiana, de L'amante invisibile? Il tema
della sposa-di-sogno presente nelle più diverse tradizioni dall'A-
frica all'Estremo Oriente: un partner femminile o maschile a seconda del sesso di chi sogna, le cui visite ricorrenti, i cui doni inaspettati, i cui messaggi entrano alla grande nella vita intima di un
uomo o di una donna senza apportare disagi al ménage quotidiano (o al contrario suscitando incidenti di vario tenore!), lo
aveva incapricciato al punto da sfociare in un'indagine a tutto
campo, e il primo brogliaccio intitolato Spose esposi celesti è 11 a testimoniarlo. Consiste in un dattiloscritto di 137 pagine più due
di indice non numerate. Un tocco di bellezza sul frontespizio lo
procura una striscia di carta di riso incollata al fondo, dove una
ciotola votiva con otto grossi pomi è fiancheggiata dalle silhouette
di due dàkinì (creature semidivine del pantheon indù) danzanti.
Siamo nella fucina del fabbro-scrittore. Lì il tema, questo tema
(ossia l'erotica sciamanica nelle religioni, nella letteratura e nella
legittimazione politica), si coagula in associazioni fulminee d'idee
che scavalcano le comuni frontiere disciplinari. S'immagini un
clown imprigionato in un sacco senza aperture da cima a fondo.
Tenta di divincolarsi come può, ora sbattendo il capo contro l'apice superiore, ora scalciando e perdendo l'equilibrio coi piedi
impediti, ora sferrando pugni vani nella stretta che lo soffoca.
Zolla sapeva che il sapere è come il sacco del clown: va lacerato affinché la scrittura, anche la più erudita, ruscelli come una melodia. Cesellare il tema della Dama di sogno nei suoi risvolti letterari, mitologici, estetici, erotici, onirici, etnologici, mistici, religiosi comportava una mobilitazione a tutto campo giacché un andamento per pure astrazioni sarebbe stato come per il pittore di
icone limitarsi alla campitura di fondo, vietando alle immagini di
assumere forma. Sul retro di quasi ogni pagina dattiloscritta, incollato sul lembo superiore sinistro sta un foglio di carta velina
dove schizzi sapienti e veloci tratteggiano parvenze della Dama in
una griglia immaginale globale. Sfilano accenni di statuine baulé,
sagome di madonne protocristiane, veneri sireniformi a cavallo di
leoni marini, la Dama erta sul Pesce, issata sul Cigno mentre la
freccia scoccata da un Eros infante sta per raggiungerla. Sotto allo
schizzo, preciso, immancabile - il riferimento alla fonte iconografica. In questo caso: «Revue belge d'archéologie et de l'histoire
de l'art» (tomo XXIII, 1954, pp. 3-20), cui si accompagna l'appunto: «Amore ferisce la Dama che bagnandosi nelle acque scosta
il velo della terrestrità "ovvero mangia il cuore del suo fedele all'equinozio di primavera"».
Uno sguardo a volo d'uccello nella fucina del fabbro-scrittore,
rende la sposa-di-sogno una figura un tantino più prossima, quasi
scaturita dal nostro stesso sognare, e l'erudizione dispiegata nel
testo a man salva, ci paralizza di meno. D'accordo, non molto si
fisserà nella memoria della baldanzosa scorreria attraverso miti e
credenze tramandati nella letteratura mondiale, ma il tuffo a capofitto ci ha procurato la gioia di lambire una gestazione colma,
vibrante e arcana. Zolla mobilitava scrivendo molteplici e cospiranti funzioni mentali. Da scenografo del pensiero, pensava per
immagini, suoni, odori e impronte tattili: nella sua scrittura l'ascesi intellettuale si accompagnava a un pieno sentire.10
#*#
Per approssimarci almeno un poco all'identità autentica del conoscitore di segreti, bisognerebbe riappropriarsi di un'accezione del
termine «letteratura» ormai dismessa ma che, nel suo caso, è la più
appropriata. Zolla è stato uomo di lettere al modo in cui lo furono
i calligrafi della Cina T'ang cultori del taoismo esoterico, gli studenti di logica buddhista allenati alle più sofisticate argomentazioni dialettiche,11 gli affiliati di una tariqa persiana, i pii talmudisti dediti in segreto all'estasi contemplativa, i pensatori sincretisti
del Rinascimento italiano, gli eruditi del Seicento europeo esperti
di alchimia ed esoterismo, i protagonisti dei Grand Tours oltre il
Mediterraneo che tra il diciottesimo e il ventesimo secolo diedero
una spallata decisiva all'etnocentrismo europeo. Zolla fu un letterato in tutte queste accezioni, un esploratore di orienti mentali, che
è qualcosa di diverso da un orientalista nel senso corrente del termine. Nei suoi viaggi, le cui mète privilegiate - a parte gli Stati
Uniti che visitò molte volte - erano state l'Iran pre-Khomeini, l'India del tempo di Indirà Gandhi, Bali e l'Indonesia, l'Egitto e Israele,
Sri Lanka e la Corea, la Birmania, Taiwan, il Giappone e Hawaii, la
singolarità di una mente ecumenica e un'erudizione sterminata suscitavano invariabilmente nei suoi interlocutori associazioni mentali con umanisti d'altri tempi, una curiosa mescolanza di anacoreta
e dotto nei panni di un forbito gendeman dal perfetto accento oxoniense che per nessuna ragione al mondo avrebbe rinunciato a una
prima colazione molto britannica e al tè pomeridiano.
I primi a riconoscerlo per un disertore penetrato nel bush accademico da terre incognite erano stati gli assistenti alle cattedre di
Letteratura angloamericana e Filologia germanica di cui Zolla era
stato titolare all'Università La Sapienza di Roma, a Catania, a Genova e di nuovo a Roma 1, dove negli anni Ottanta aveva avviato
un prestigioso dottorato in letterature comparate.12 La seconda categoria di perplessi sull'identità di EZ furono gli editori di cui negli
anni era stato un consigliere eccellente introducendo in Italia autori poi divenuti famosi da J. R. R. Tolkien a Ananda K. Coomaraswamy, a Nisargadatta Mahàràj per non parlare di Djuna Barnes, Carlos Castañeda, loan P. Culianu. E quanto ai lettori di «Conoscenza religiosa», la rivista che diresse nel periodo della contestazione sessantottesca e del brigatismo rosso, essi videro in Zolla
un maestro di conoscenza appartato e inflessibile nel reprimere
qualsiasi tentativo di affibbiargli un ruolo di guida spirituale.13
L'altra categoria di intellettuali in contatto con la natura ermetica dello scrittore, furono con Roberto Calasso, Federico Codignola, Susanna Bergamo, Bianca Tallone e gli altri editori dei suoi
libri, i redattori delle riviste e delle pagine culturali dei quotidiani
che per oltre mezzo secolo accolsero saggi, articoli e elzeviri di
Zolla: da «Tempo Presente», la rivista romana diretta da Ignazio
Silone e Nicola Chiaromonte, a «Elsinore», che ebbe tra i suoi direttori Gaspare Barbiellini-Amidei, a «il Mondo» diretto da Mario
Pannunzio, al «Corriere della Sera» dove tra gli interlocutori più
assidui c'era stato Cesare Médail, autore di uno schietto profilo di
EZ ne Le piccole porte, il libro pubblicato da Médail poco prima
della morte (2005); infine, a partire dall'anno 2000, il Domenicale de «Il Sole 24 ore» dove la prima domenica di giugno del
2002 Riccardo Chiaberge disponeva che uscisse, oramai postumo, l'ultimo articolo firmato dallo scrittore.14
S p r a z z i di u n a b i o g r a f i a s c a n c e l l a t a
***
Quando aveva compiuto sessantacinque anni un dono cartaceo
inaspettato gli era piovuto in mano La religione della terra. Quell'opera era stata il frutto della mia amabile cospirazione con
amici studiosi di vari Paesi e tra loro I. P. Culianu, decisi a festeggiare il compleanno di Elémire quel 9 luglio 1991. In casa, nei
mesi precedenti, non era trapelato nulla e quando il libro si materializzò, lui ne fu visibilmente sorpreso. Si prese assieme un tè,
il modo consueto di dare il benvenuto a un nuovo libro. Accomodato in poltrona, lesse d'un fiato i dieci saggi e la mia introduzione vergando immediatamente altrettante cartoline di ringraziamento indirizzate ai coautori e l'undicesima a Maurizio
Rosenberg, l'editore del libro. L'assenza totale di commenti sulla
parte introduttiva mi lasciò un tantino perplessa. Un po' per
celia un po' sul serio azzardai: «Non scriveresti una cartolina
anche a me?».
«Ma via!» sbottò col tono di un nonno rivolto alla nipotina monella «ti sei scordata che la gioia sta tutta nel donare senza aspettarsi nulla?» E mi tornò alla mente il passo di Volgarità e dobre
dove, a proposito di due che si amano, aveva affermato:
Già è dubbio che mai possa esserci amore che non sia quello reciproco, di cui due persone s'accorgano insieme, che è venuto a insediarsi tra loro, apparizione miracolosa. Se non è reciproco sarà
da dirsi devozione, o trasalimento che spinga a sacrificio e assistenza. Ma pretendere che i propri rapimenti amorosi echeggino
con favore nell'amato è l'opposto dell'amore, non dedizione
gioiosa ma esazione calcolante. Solo chi creda di dover ricevere
mercede per i propri sospiri può addolorarsi vedendoli ignorati o
respinti, allora la ripulsa sarà la giusta punizione della stortura.
Quel passo, la prima volta che lo lessi senza ancora conoscere EZ,
mi era parso altero, di una durezza eccessiva e privo di carità.
Tempo dopo, studiando i testi dell'advaita Vedànta indiano m'ero
imbattuta in un dialogo filosofico delle più antiche Upanisad, la
Brhadàranyakà II, 4. È una conversazione tra un vecchio maestro, Yäjnavalkya e la moglie Maitreyl. Costei è una donna devota, avida di sapere ma il suo cuore è una gemma imperfetta, perciò scambia l'amore per una forma di possesso e teme la morte.
Un giorno che quei pensieri la assillano più del solito, si decide a
interrogare Yäjnavalkya e le sue risposte, se possibile, la turbano
ancora di più.
Trascrivo i passaggi essenziali del dialogo con qualche aggiustamento e una minima spiegazione sui termini àtman e Brahman che vi ricorrono spesso, dove per Brahman la scuola del
Vedänta advaita (non-duale) intende l'essere-che-è-tutti-gli-esseri, la realtà universale, e per àtman, l'individuazione del Sé cosmico nel sé che è (in) ognuno di noi, di cui la persona che ci costituisce è lo strato superficiale e accidentale.
- Maitreyl: «Che cosa ne sarà di me quando sarò scomparsa?
Per favore, mio caro, rispondi!».
-Yäjnavalkya: «O Maitreyl, Maitreyl che quesito è mai questo!
Se però tieni davvero a saperlo, ascolta ciò che dico e meditaci su:
sappi che non è per l'amore al marito che il marito è caro ma per
amore all 'dtman (l'essere) che è (in) lui; e non è per l'amore alla
sposa che la sposa è cara, ma per l'amore ali'àtman (l'essere) che è
(in) lei. [...] Ed è per l'amore al Brahman (il Sé universale) che
tutto è amato, ed è al Sé che tutto ritorna. Ricordalo bene!
«È l'àtman dentro di noi che bisogna contemplare, che bisogna
conoscere, su cui bisogna meditare. Vuoi davvero sapere come lo
si conquista?
«È con la mente illuminata che si conquista l'àtman. E come si
ottiene una mente illuminata? Ascolta... ciò che ti dico e non
scordarlo: "Cosi come non si sente il suono di una conchiglia a
meno di prenderla in mano e accostarla all'orecchio, cosi come
una presa di sale che si getta in acqua non c'è modo di riprenderla
e tuttavia, ovunque si raccolga dell'acqua, vi si trova il sale, egualmente avviene con questo Essere illimitato, infinito, disciolto
nell'oceano della coscienza, coscienza di se stesso a se stesso. Negli
elementi da cui emerge, in quegli stessi si riassorbe, giacché alla
morte, sappi, la coscienza cessa"».
- Maitreyl: «Sono molto turbata ad apprendere che la morte
porta via la coscienza!».
— Yàjnavalkya: «Maitreyl, non parlo per turbarti ma per
istruirti: là dove c'è dualità, l'uno odora l'altro, l'uno vede l'altro,
l'uno ode l'altro, l'uno parla, pensa all'altro, l'uno conosce l'altro;
ma allorché tutto rientra nel Grande Essere, che ne è più dell'uno
e dell'altro, dell'attore e dell'atto e della discriminazione tra l'uno
e l'altro?».15
Perché ho citato questo dialogo? Perché la teoria esposta da
Yàjnavalkya sull'amore che è vero amore quando trascende la soggettività degli amanti e nulla rivendica, sembra echeggiare quasi
alla lettera il passo di Zolla letto poc'anzi. Non l'alterigia o l'assenza di carità gli avevano suggerito i pensieri che m'erano parsi
spietati, ma una conoscenza adamantina del gioco di forze su cui
si regge il sentimento amoroso.
1. Uscire dal mondo
«Uscire dallo spazio che su di noi hanno incurvato secoli e secoli
è l'atto più bello che si possa compiere. Quasi nemmeno ci rendiamo conto delle nostre tacite obbedienze e automatiche sottomissioni, ma ce le possono scoprire, dandoci un orrore salutare, i
momenti di spassionata osservazione, quando scatta il dono di
chiaroveggenza e libertà e per l'istante si è padroni, il destino sta
svelato allo sguardo.»16 Cosi inizia l'opera che inaugura l'ultima
stagione creativa nella vita del conoscitore di segreti, il tempo in
cui la pietra di certezza inizialmente denominata tradizione e poi
esperienza metafisica, ora si chiama mente naturale, una mente
«annegata nella natura che è l'eterno presente», affermerà nel
1999.
Per l'immagine di copertina di Uscite dal mondo EZ aveva suggerito una pittura murale thailandese, un gioiellino di sincretismo all'acqua di loto! Vi si vedono infatti dei personaggini agghindati alla moda di un estenuato Settecento europeo accorrere
a mirare il prodigio di un gigantesco loto emerso da uno stagno.
Il fiore è cinto da una margherita di palustri erbette in un paesaggio che ricorda i fondali pointillisti di Bosch: un piccolo capolavoro di ibridismo pittorico d'età coloniale. Quando il libro prese
a circolare, le congetture sul significato del titolo furono più
d'una: «uscite» nel senso del femminile plurale o piuttosto
«uscite» all'imperativo? E ancora: si tratta di un vaticinio, un congedo annunciato o è la trascrizione di un sogno psichedelico? Per
di più è solo una coincidenza che il titolo originale dell'ultima
opera di I. P. Culianu pubblicata da Mondadori come I viaggi dell'anima. nel 1991, Out ofthis World, sia l'esatto corrispettivo di
«Uscite dal mondo»? Non è curioso che i due autori, quasi contemporaneamente, avessero pensato d'intitolare i loro libri in
modo identico?
Curioso si, ma non inspiegabile. Sia sul piano intellettuale che
della vita privata, la soglia dell'ultimo decennio del Novecento era
stata per entrambi un giro di boa. Dopo anni trascorsi tra l'Italia
e l'Olanda da chierico vagante, Culianu, professore all'Università
di Chicago e erede intellettuale di Mircea Eliade, nel 1990 si sentiva alle stelle. Nel cassetto, anzi nella memoria del computer (che
di lì a poco gli venne sottratto), gli appunti sui prossimi libri
erano una miniera, i suoi corsi alla Divinity School magnetizzavano assieme a frotte di studenti una fauna di gente bizzarra,
prontissima a farsi un'ora di aereo da chissà dove per ricevere insegnamenti trasversali su sètte gnostiche, Apocalissi, esoterismo e
stregoneria - gente che non saprai mai se rema contro il sistema o
a modo suo, lo sostiene alla maniera bizzarra, dissipata e mondana consueta in epoche da tardo Impero. A metà strada tra il
mago balcanico e una testa d'uovo, glaciale e accalorato Culianu,
a piccoli colpi bene assestati si stava facendo strada nelle zone alte
del mondo accademico, aveva appena fondato «Incognita», una
prestigiosa rivista di studi interdisciplinari pubblicata da Brill,17
era a un passo dall'ottenere la cittadinanza americana e stava per
risposarsi, felicemente, una seconda volta.
Un episodio premonitore accadde nell'agosto 1989 a Montepulciano, prima che Zolla e io andassimo ad abitarci. Culianu, la
fidanzata americana Hillary Wiesner, EZ e io, si era seduti a un
tavolino del caffè di Piazza Grande. E mentre Giovanni affondava
i denti con gusto in una pizza fumante, gli venne di rovesciare le
pupille all'indietro come faceva tutte le volte in cui voleva per
pochi istanti ritrarsi in se stesso. Lo sentimmo esclamare: «Chissà
fin dove riuscirò ad affacciarmi nel prossimo secolo!». E prendendo tra le sue le mani della fidanzata, aggiunse: «È così bizzarro
immaginarmi vecchio!».
Zolla lo riguardò sorridendo, si strinse nelle spalle e disse a sua
volta: «Devo ricordare proprio a te la battuta di Cioran?».
«Come no, il mio compatriota!» rispose Culianu. «E qual è?»
«Padrone di tutti gli errori, posso finalmente esplorare un
mondo di apparenze, di enigmi leggeri!»
Con quella citazione a memoria, che faceva propria, EZ incoraggiava l'amico a saltar via dalla stretta del tempo lineare, a vivere
ogni istante come se il futuro non esistesse, al modo che era stato
esattamente il suo da quando aveva vent'anni. E Culianu, che al
valico dei quarantanni era vicino effettivamente a sparire, il salto
outofthis worldcome un postumo di se stesso, lo aveva fatto davvero nel suo ultimo libro. In che modo? Viaggiando nella mente,
accidentalmente la propria, scoprendo che la pluralità dei mondi
concepita da Giordano Bruno, il pensatore che tra gli italiani
aveva studiato più a fondo, 18 era cosmica e insieme mentale o
piuttosto cosmica in quanto mentale. I lettori de I viaggi dell'anima hanno potuto constatare che out ofthis wor¿/significa contestualmente molte cose riferite all'esplorazione di quelli che Culianu chiamò gli iper-spazi mentali dopo aver esaminato un immenso repertorio di stati alterati di coscienza ed esperienze estatiche nella storia antica e moderna e nelle tradizioni indigene esperienze di limite che riteneva non a torto alla radice dell'affabulazione religiosa, mitica e poetica o, in parole zolliane, della
«fede in un sistema di metafore».
Là dentro, nella nostra testa ininterrottamente si configurano i
costrutti che puntellano l'idea, il lògos del mondo - idea di cui è
parte la credenza che una realtà «oggettiva» esista davvero. Senonché la nuda, intimante presa di coscienza che il senso del
mondo è pane anch'esso dell'affabulazione mentale condusse
Culianu, alle soglie della morte, a una disincantata percezione
dell'assurdo, affine a quella che aveva suggerito a J. L. Borges le
sue mirabolanti storie di eternidad. In una di esse si legge:
Rimasi a guardare quella semplicità. Pensai, probabilmente ad
alta voce: Questo è lo stesso di trent'anni fa [...]. Immaginai quella
data: epoca recente in altri paesi, ma ormai remota da queste mutevoli pani. Forse un uccello cantava e provai per lui un affetto
piccolo, della grandezza di un uccello; ma è più probabile che in
quel vertiginoso silenzio non ci fosse altro rumore che quello, anch'esso intemporale, dei grilli. [...] Mi sentii morto, mi sentii percettore astratto del mondo: confuso timore imbevuto di scienza
che è la massima chiarezza della metafisica. Non supposi, no, di
aver risalito le presuntive acque del tempo; piuttosto mi sospettai
in possesso del reticente o assente senso dell'inconcepibile parola
eternità [...].19
Essere postumo di se stesso è un'esperienza che nelle circostanze
della vita ordinaria non accade lucidamente quasi a nessuno, ma
nell'invenzione borgesiana di storie di eternidad dove qualunque
delle maschere dell'io può essere indossata a piacere, tutto è possibile: provenire dal futuro, morire una o più volte e ritrovarsi
nella stessa pelle, ricordare quel che s'ignorava di sapere o fingersi
l'inimmaginabile fino a convincersi che la «mente» forse è qualcosa di più di un congegno dalle prestazioni in fin dei conti prevedibili.
Uno dei primi libri pubblicati da Culianu in Italia, una raccolta di saggi sulla gnosi che uscì a Messina nel 1981, aveva il titolo latino di Iter in silvis (itinerari nella selva).20 Alla luce di
quanto sarebbe successo, quel titolo conteneva la previsione che il
suo cammino, stroncato a quarantanni, sarebbe stato non una
serie di balzi contro-corrente aña maniera del conoscitore di segreti, ma un vagabondaggio tortuoso nel fìtto di un bosco, colmo
di incognite. Infatti dieci anni dopo, il «dentro» di iter in silvis si
capovolgeva nel «fuori» di out ofthis ivorld. In entrambi i casi la
metafora era stata azzeccata.
***
Zolla, da parte sua, una volta sgusciato via dagli obblighi accademici, si sentiva, nonostante l'ispessirsi delle malattie, come rigenerato sia dentro che fuori. Gli esperimenti computeristici passati
sotto il nome di realtà virtuale lo avevano galvanizzato, e in una
memorabile conferenza alla Società Scientifica Socrea a Milano,
nel marzo 1990, confluita in Uscite dal mondo (nel capitolo Lo
scopo della vita), aveva sondato gli orizzonti di un «futuro alle
porte» congetturabile attorno al 2030-2040. L'aveva fatto baldamente, sondando ipotesi scientifiche, consultando ingegneri
esperti di informatica dagli Stati Uniti al Giappone, indossando
anche il buffo elmetto e i sensori in uso nei primi esperimenti di
realtà virtuale - se ne trova traccia negli Appunti sul futuro raccolti
nella Parte seconda. Esperienze dal vivo, congetture, riflessioni su
aspetti e questioni dalle quali, secondo il fisiologo Ruggero Pierantoni, autore di un articolo-stroncatura pubblicato su «Leggere» nell'ottobre 1994,21 un conoscitore di mistici segreti, per
eclettico che sia, avrebbe dovuto assennatamente tenersi alla
larga, per non rischiare di bruciarsi le alucce inadatte a incauti
sorvoli sui grevi terreni di scienze che non barano. Sta di fatto che
EZ ribelle come al solito, non aveva obbedito all'ingiunzione di
tacere su ciò che aveva attinto a fonti, peraltro, coralmente riverite, e sull'onda dei ragguagli dagli USA e dal Giappone s'era sbrigliato in inseguimenti di visioni e trasvolate virtuali «fin dove il
computer potrà allestire e la fantasia condurre».
«Credo si sia all'inizio di una storia meravigliosa - annunciava
entusiasta nel 1991 - Yadvaita Vedànta e la liberazione sono prossime a diventare esperienze disponibili. Questo capovolgerà la
condizione umana, farà accostare al fine supremo della vita numeri sempre più ampi di uomini». E alla domanda, che cosa era
mutato dagli anni in cui componeva le dolenti note di avvio ai
Mistici dell'Occidente, rispondeva che rispetto ad allora: «Le condizioni si sono modificate in modo sconvolgente e per molta
parte stupendo: è liquidata la follia marxista e perciò l'inimicizia
per principio verso la mistica e l'intenzione di eliminarla». E ag-
giungeva: «Mi pare che se oggi ci si apre alla verità mistica ed esoterica (lascio da parte se si debba dire e oppure ó), l'orizzonte non
sia più una singola fede, ma l'insieme delle fedi, cioè la possibilità
stessa di avere fede in un sistema di metafore».22
«Un sistema di metafore?» gli era stato domandato con qualche
apprensione: «Che cosa intende quando definisce le fedi delle
metafore?».
Zolla aveva sorriso mitemente con l'aria di volersi esimere da
una risposta. Ma chi lo interrogava, aveva insistito e lui allora s'era
deciso a un chiarimento che qui tento di riassumere in poche parole, poiché aiuta a capire un tantino meglio l'itinerario intellettuale dello scrittore in certi snodi che apparvero sconcertanti e indecifrabili ai critici attenti del suo pensiero, il cui numero, col
passare del tempo, si va assottigliando.
«Siamo avvezzi» aveva detto EZ «ad associare la fede alla credenza religiosa, e "credo", "non credo" sono dichiarazioni che ci
impegnano nel profondo. Tuttavia la questione della fede andrebbe esaminata in una prospettiva più vasta indagando a
monte delle specificazioni che assume l'atto di fede, e che sono
dei più vari generi, etici, estetici, politici e appunto religiosi. La
fonte del credere, del credere in sé e per sé è un'energia d'intensità straordinaria, e una delle sue maggiori caratteristiche è che
la si può orientare a volontà in ogni direzione: verso noi stessi, la
nostra stirpe, la società, lo Stato, gli interessi, gli affari, gli affetti
oppure verso le sfere astratte, le teorie filosofiche, i sistemi di
pensiero che ci confezionano un'idea di realtà con tutti i significati spesso contradditori di cui viene vestita o svestita.
«Ho passato la vita» aveva aggiunto «a esplorare le credenze radicate nelle più svariate culture e civiltà, ed è stato inevitabile che le
concezioni che ho sentito più affini e convincenti siano state quelle,
come le indiane, che aprono la mente a interrogarsi sulle proprie dinamiche e suscitano la coscienza a rispecchiarsi in se stessa. Gli effetti di una ininterrotta pratica mentale di questo genere sono grandiosi: si cessa di essere gli ostaggi dei nostri pensieri, credenze e sentimenti, la nostra automatica identificazione è cessata, siamo saltati
al di là del credere e del non credere, liberi, imperturbabili e sereni.
Questa per me» aveva concluso «è l'unica esperienza di libertà in vita
che ci venga accordata dal sistema che ci regge.»
Il plauso di Zolla per gli orizzonti dischiusi dagli sviluppi dell'intelligenza artificiale e l'accesso a esperienze di realtà virtuale va inquadrato nella prospettiva indicata poc'anzi nella sua risposta alla
domanda su che cosa mai intendesse con l'espressione abbastanza
sibillina, del sistema di metafore che ci abita e di cui saremmo gli
ostaggi.
Nel momento in cui l'intelligenza robotica diventerà prevalente al punto da dirigere in futuro l'intelligenza umana, come sosteneva Hans Moravec nei primi anni Novanta,23 l'intera prospettiva dell'uomo muterà: con adeguate manipolazioni sul cervello, essa potrà addirittura spostarsi «ad un corpo nuovo» affermava entusiasta EZ «dello stile, del colore, del materiale che ti
sarai scelto» (L'argomento è sviluppato nel brano II reale illusorio:
una diversa recita nella sezione Appunti sulfuturo, Parte seconda).
E aggiungeva:
C'è chi sostiene come fece il Pomponazzi, che senza un corpo
l'uomo cessa di essere individuato; ma il pensiero, virtù organica
della fantasia e dei sensi, nel caso della nostra operazione si salva
interamente e riceve in seguito informazioni sensibili a volontà.
Ci sarà piuttosto da domandarsi quanti potrebbero guardare alla
trasposizione in macchina della propria mente come a un fine auspicabile. Credo che il loro numero sia più alto di quanto possa
sembrare: non è un isolato Moravec quando contempla con gusto
quella prospettiva. Resta una questione più seria: si è certi che sia
eccelsa la parte ineffabile e non verbalizzabile della mente? Io
sento — concludeva — che gli amori più fervidi, le risoluzioni più
tragiche rifiutano le nomenclature e le opere più eminenti si compiono in silenzio, ineffabilmente. Ma la mia sensazione non è condivisa da tutti e molti si sbarazzerebbero volentieri della parte tacita alla quale dò tanto spicco. Oso aggiungere: credo che molti
non possiedano questo angolo indicibile della persona.24
Tra coloro che sono privi di questo «angolo indicibile della persona» e ne vanno fieri, si possono tranquillamente annoverare uomini di scienza, onesti e appassionati del loro mestiere, come il citato Pierantoni, confusi tra milioni e milioni di uomini e donne
toccati dalla grazia di una concreta aderenza alle «cose come
stanno»: che si battano a volerle cambiare per il meglio o coltivino
il proprio campicello in perfetta buona fede, la differenza non è
poi così grande. Non coltivano una «mente eroica» alla maniera
superbamente arrischiata da Zolla secondo taluni dei suoi critici
malevoli;25 non compiono né commissionano arcigni studi sul
Superuomo nelle letterature moderne nell'inconfessa«) tentativo, chissà, di approssimarcisi;26 sono indenni dal delirio «Fermate il mondo, voglio scendere», pennellato nel titolo dell'articolo di Pierantoni; si guardano bene dal pensare l'infanzia «luogo
ideale dove si cela l'Unità ed estasi da cui ogni sentimento promana» e tanto meno si domandano se l'incanto della puerizia
possa per caso assaporarsi nella conoscenza senza dualità, nella
rievocazione della natura vista da Goethe, oppure alla maniera indicata all'esordio de Lo stupore infantile, il libro che reca in copertina l'immagine della coppia di amanti celesti in volo verso il sole
e, all'interno, quella di Kukai fanciullo,27 adagiato in preghiera su
un vezzoso flore di loto - immagini inequivocabilmente agli antipodi di una concreta aderenza alle «cose come stanno».
Ora però che il conoscitore di segreti è sceso dal treno della
vita, vale la pena domandarsi in che cosa consista quell'angolo indicibile della persona di cui s'incaponì a fornire indizi e prove,
con conseguenze curiosamente duplici, come notavo all'inizio.
Da una parte, suscitando stizze, moti di scherno, ironie e talvolta
vere e proprie ondate di avversione sulle pagine di influenti giornali e in certi circoli che contano nel Paese; e d'altra parte annoverando migliaia di lettori che i suoi libri hanno arricchito interiormente, nei quali hanno intravisto mondi conoscitivi più vasti
e mondi che sono stati aiutati a scoprire dentro di sé, ci si sono
specchiati e hanno compreso che «spiritualità è la capacità di leggere come simboli di verità trascendenti tutte le figure storicamente visibili o udibili»; che la conoscenza tende all'amore ma
«finché resti conoscenza non vissuta interiormente, legata alle
sole parole, è un acquisto sterile, che non giova a portare la mente
nel cuore».
Per aiutare a riconoscere Xangolo indicibile della persona, Zolla
esaminò ogni sorta di fonti e testimonianze mistiche, religiose, filosofiche, mitologiche, etnologiche, esegetiche, artistiche e poetiche, commentandole, mettendo in luce l'esistenza di una planimetria simbolica e spirituale unitaria, propria della costituzione
umana e dunque universale.
Ogni sistema religioso, incluso l'ebraismo e il cristianesimo
nel suo nocciolo mistico ed esoterico, affermava nel 1999, possiede un impulso unitivo ineffabile, e questa è la premessa di un
intendimento unificante. Egualmente filosofie sorte e formulate in Paesi diversi additano la medesima visione unitaria della
mente e del cosmo cui Leibniz, Bacone e prima di loro Agostino
Steuco diedero il nome di «filosofia perenne». «Tuttavia» precisava poco dopo, «unificare Israele, Cristianità e Islam col mondo
antico, significa chiuderci in confini angusti: India, Cina, Giappone e tutto lo stuolo di coloro che fino al Novecento si credeva
di poter denominare "primitivi" debbono entrare nell'orbita e
permearci.» E se l'attenzione si estende all'«intreccio di tutte le
migrazioni di popoli che si sono intersecate per le varie pianure, "l'arte dell'universo, lentamente, acquisterà un profilo
•
"
unitario
.» 2 8
Nel 1977 l'uscita del primo volume della magnifica trilogia di
Giorgio Colli La sapienza greca101 aveva sollecitato lo scrittore a riflettere sul tema centrale di quell'opera.
La sapienza - osservava - non è la capacità di rispondere a ogni
quesito, ma è lo sforzo di affrontare un quesito fino in fondo. Ad
esempio: Come è nato il tutto? Come posso vederlo come un'unità, abbracciarlo, identificarmici?
Queste domande sono il presupposto della conoscenza sapienziale,
la quale ad esse possa rispondere, e non necessariamente a parole
(se mai parla, lo fa in versi, cantando), bensì con gesti, sguardi, urla,
scatenando un vortice di danza. Al culmine non si esprime neanche più visibilmente: allucina, fa sfolgorare luci e risuonare voci nel
segreto dell'interiorità, oppure neanche questo fa, ma lascia dilagare nel cuore la pace profonda della beatitudine.30
Nei Detti e fatti dei Padri del deserto che Cristina Campo aveva curato con l'amico fiorentino Piero Draghi, si legge che un giorno
era stato domandato all'abate Agatone: «Che cosa è meglio: l'ascesi corporale o la custodia della mente?». Il sant'uomo aveva risposto: «Gli uomini sono come gli alberi; il lavoro del corpo ne è
il fogliame e la custodia della mente ne è il frutto: ora, tutti gli alberi che non danno frutto, sta scritto saranno tagliati e gettati nel
fuoco. In vista dei frutti, dunque, bisogna sorvegliare quello che
accade in noi, vale a dire, custodire la nostra mente».31 E questo,
Zolla aveva compreso, è il primo passo per aprirsi all'esperienza
metafisica.
In Archetipi l'aveva paragonata al mare in cui dolcemente naufraga
il Leopardi dell' Infinito e della Vita solitaria, senonché, osservava,
«Leopardi non trasse da quei momenti tutto ciò che avrebbe potuto, non li seppe porre al centro dell'esistenza come rivelazioni
dell'essere rispetto alle apparenze semplici e illusorie».32
Nell'India tradizionale, qualcun altro l'aveva fatto e in un
brano dell'Editoriale per il decennale di «Conoscenza religiosa»,
l'esperienza metafisica era descritta nei termini di uno che l'ha
vissuta e vuole condividerne una stilla seppure in forma di inadeguate parole.
Una dopo l'altra—scriveva - si susseguono le percezioni, le immagini, le riflessioni, ora in un tumulto affannoso ora distesamente,
ma la vita non è tutta qui, può non essere così angusta: si può osservare questa diversa molteplicità senza identificarsi, senza dire
che quei movimenti sono «miei», fino a non partecipare più, diventando puri testimoni; questa è l'esperienza metafisica. [...]
La parola — aggiungeva — è un tramite imperfetto, una danza può
essere più propizia, o un mandala, o un diagramma, un'icona, uno
sguardo. Tutto ciò è dato per scontato da molti. Come è dato per
scontato che l'esperienza metafìsica sia superiore ai dilemmi del
bene e del male: chi in essa si installa vede notte e giorno, male e
bene come chi sta su un cocchio e guardi le ruote vorticanti, i loro
mozzi fusi in uno. [...] La pura luce di questa verità — aveva concluso — ha lambito negli ultimi anni molti cuori come nel cupo
passato non avveniva.33
Scorrendo questi enunciati viene di pensare a una mente pervenuta alla radice; non è un placebo di comodo la quiete che la avvolge ma l'esito di un cimento durato l'intera vita.
Ne Le tre vie, un libro che alla metà degli anni Novanta, quando
uscì, non fu meditato quanto meritava, quel cimento che era stato
intimo e personale, era descritto nei termini di un testo canonico,
lo Yogavasistharàmàyana, di cui Zolla riportava il seguente passo
capitale:
Quando la liberazione è turbata e si disperde negli oggetti molteplici, si chiama mente; quando è persuasa d'una sua intuizione, si
chiama intelligenza; quando, stoltamente, si identifica con una
persona, si chiama io; quando, invece d'indagare in maniera coerente, si frammenta in una miriade di pensieri vaganti, si chiama
coscienza individuale; quando il movimento della coscienza, trascurando l'agente si protende al frutto dell'azione, si chiama fatalità; quando si attiene all'idea «L'ho già visto prima» in rapporto a
qualcosa di veduto o non veduto, si chiama memoria; quando gli
affetti di cose godute in passato persistono nel campo della coscienza anche se non si scorgono, si chiama latenza inconscia;
quando è consapevole che la molteplicità è illusoria, si chiama sapienza; quando, in direzione opposta, si oblia nelle fantasie, si
chiama impura; quando si trattiene nell'io con le sensazioni, si
chiama sensibilità; quando rimane non manifestata entro l'essere
cosmico, si chiama natura; quando suscita confusioni fra realtà e
apparenza, si chiama illusione; quando si discioglie nell'infinito,
si chiama liberazione: pensa «sono legato» e c'è l'asservimento,
pensa «sono libero» e c'è la libertà.34
Meditare questo passo non è privo di effetti nel profondo della
coscienza. Affacciati sul bordo di noi stessi, ci avvediamo che la
domanda «chi sono?» rimbalza su di noi come un'eco e si trasforma nella constatazione: «sono quello che penso». Se penso:
«sono legato», c'è l'asservimento; se penso «sono libero», c'è la libertà. Ciò vale per ogni altro oggetto mentale: la persona, la società, la natura, il mondo, la vita o l'aldilà.
La mente, andava ripetendo EZ, è una cera plasmabile, un organo le cui prestazioni si possono contrarre o espandere a volontà
fino a raggiungere una pienezza inaudita, la pienezza di una
«mente naturale».
2. Una mente naturale
Nell'ultima stagione del suo itinerario intellettuale la pietra di
certezza attorno alla quale il pensiero di Zolla ha ruotato prendeva il nome di «mente naturale». Di che mente si tratti l'aveva
intuito almeno da quando a proposito della percezione del cielo
dell'uomo arcaico (esaminata ne II destino e lo zodiaco), aveva affermato che essa doveva provenire da una mente simile a quella
che i taoisti e i buddhisti descrivono come mente spontanea,
mente genuina, mente in equilibrio, mente originaria, nonmente, mente imperturbata - sulla base del significato duplice e
coincidente dei termini cinesi benxin, zixin = «mente-cuore»
(giapponese kokoró).
Parrà un paradosso ma in una mente del genere non c'è niente
di metafisico! Zolla ne scrive come di una condizione di pienezza
totale, nei sensi, nelle emozioni, nello scatto vigile e vitale di un'intelligenza adunata alle cose e in questo senso, poco o più che
umana. Eppure una pienezza siffatta è a tal punto religiosa da fargli esclamare a un certo punto: «Siamo tutti enti passivi, l'animazione è Dio!».
Era accaduto nell'agosto 1990, all'indomani di una memorabile dichiarazione del pontefice Giovanni Paolo II, e non c'è luogo
più adatto di questo a rievocarlo:
All'inizio di quest'anno — Zolla scriveva — Giovanni Paolo II dichiarò che nell'uomo freme un alito di Dio e poi stupì tutti aggiungendo che esso vibra anche negli animali. «Tu gli mandi il tuo
soffio ed essi sono creati» dice il Salmo 104, aggiungendo: «E
torna nuova la faccia del mondo». È un salmo tra i più incantevoli:
raffigura il Dio d'Israele che si veste della natura. «Natura» non
esiste nel pensiero ebraico, la parola stessa è un imprestito arabo.
Dio è la natura, essendone la forza attiva.
Ravvolto di luce come in un manto
I cieli srotola come un tappeto
Fabbrica con l'acqua i suoi terrazzi
Per suo carro piglia le nubi
Remiga alato di vento
Fa suoi angeli le burrasche
Suoi corrieri i bagliori difuoco.
Così la stupenda versione di Ceronetti - commentava EZ - ci restituisce la respirazione ampia e poi sconvolta e poi rasserenata di
chi contempla l'azione di Dio tutt'intorno. Lo sgomento per l'ordine miracoloso, per le incredibili regolarità. E per la presenza
degli animali: i passeri, la cicogna appollaiata in cima all'edificio,
gli stambecchi in cima alle montagne, le lepri fra i sassi, i leoni ruggenti, la balena con cui Dio gioca nel mare. Tutti respirano con la
stessa forza con cui respira l'uomo, a imitazione di Dio.
II Salmo 104 — e così terminava - invita a estendere la fratellanza, la
vera sensibilità al di là di noi stessi, agli animali più vari della terra,
del cielo e delle acque e allo spirare dei venti e alfioriredei campi.35
I taccuini preparatori di Uscite dal mondo traboccano di esultanza
e stupore per l'intelligenza misteriosa e impeccabile che regge il
mondo vivente.
Chi ha insegnato alle api a costruire con tanta sapienza — si domandava - chi orienta gli uccelli migranti sul quadrante dei cieli,
chi incastra le orbite stellari l'una nell'altra? Non sarà forse la
stessa intelligenza che splende lassù a portare vigore nei campi?
Ogni pianeta non corrisponde forse a una pianta? Al sole il «gira-
sole», alla luna la lunaria - i nomi stessi ci parlano ancora di queste corrispondenze. Un tempo si sentiva che dietro, dentro a queste cose materiali operava una mente sola.36
Forse lo yoga - rifletteva - le arti marziali, l'allenamento meditativo all'attenzione spassionata e ininterrotta, lo stesso impulso che
ci spinge a mormorare una preghiera sono tracce residue di una
pienezza venuta meno; la pienezza di chi si riconosce parte intrinseca del mondo vivente, suo complice e alleato dalla roccia all'ameba, dall'oceano al cielo.37
«Tutta la civiltà sciamanica» si legge in Uscite dal mondo «è un tentativo di assimilarsi al mondo animale, e quando Bodhidharma introdusse il ch'an (o zen) a Shao Lin nel 527, insegnò ai discepoli l'imitazione fedele delle fiere, fino all'identificazione con le gru trasformandoli in campioni di lotta. In Occidente Orfeo è il capostipite di chi s'accosta alle bestie e ne trae profitto, osservando le loro
menti libere dal nostro scoppiettio d'immagini e pensieri, i loro ingegni schietti. Dioniso, e in India Siva, sono emblemi di ciò che
muore e rinasce dalla terra che è "tutti i semi"(panspermid).»
«Sciamano», «sciamanesimo» sono termini che fino a qualche
tempo fa suonavano ostici e nebbiosi, le esperienze estatiche del
guaritore indigeno appartenendo al mondo sigillato di una «diversità» etnico-religiosa del tutto estranea alla cultura del soggetto
storico occidentale moderno.
Senza essere un etnologo di professione e con criteri di approccio
al mondo indigeno ben diversi, come s'è visto, da quelli dell'etnologia corrente, Zolla studiò lo sciamanesimo, in specie la tradizione
estatica femminile in Corea, e da storico delle idee inquadrò il fenomeno sciamanico nel contesto della fenomenologia religiosa in un
modo, in questo senso, non dissimile da Mircea Eliade. Nell'ultimo
decennio della vita, mentre tesseva l'elogio della mente naturale, accordata ai ritmi del mondo vivente come quella dello sciamano, EZ
sentì l'esigenza di rivisitare vaste zone della letteratura moderna scorgendovi all'opera lo spirito tutto sciamanico di Dioniso, il dio trace
dell'invasamento estatico, dell'ebbrezza panica e bacchica.
Nella introduzione a lidio dell'ebbrezza è rievocato un incontro con Dioniso nella campagna greca:
Camminavo per i campi, m'ero inoltrato in un boschetto ed ero
felice come quando ci s'inoltra in un contado leggiadro, ma a distanza di tempo nemmeno me ne ricordo, dei caratteri di quel
contado. In Grecia, specie nell'Attica, sono i profumi che riempiono l'attenzione, la sfidano con la loro varietà che nemmeno si
riesce a fermare con parole. Sono i sentori di quei fiori e quelle
erbe che soltanto su suolo greco allignano e giungono nuovissimi
alle narici, appena si sia usciti da Atene, sull'Imetto. Arrivai a una
casetta davanti alla quale un gruppo d'uomini stava degustando il
vino nuovo e mi osservarono con attenzione. Finalmente il più
anziano mi pregò di partecipare, con un tono dove mi parve di
sentire la forza, di cosi remote origini, dell'ospitalità. Infatti, i
volti seri e benevoli mi diedero la sensazione di quel rito arcaico. Il
mio greco miserello bastò, ci si senti accomunati. Prima che me
n'andassi, quattro si alzarono a danzare dignitosamente la lenta
danza greca in tondo. Ci salutammo in silenzio.38
3. Comesi concilia una mente naturale con la realtà virtuale.
Note su un carteggio Zolla-Comolli
Nel 1992, poco dopo la pubblicazione di Uscite dal mondo, la rivista «Aut Aut» accoglieva una lettera scambiata tra EZ e Giampiero Comolli, lo scrittore e gran viaggiatore che nei decenni è
stato tra i più assidui a registrare l'evoluzione del pensiero di Zolla
fino agli ultimi enunciati oltre il 2000. 39
Nella sua lettera, Comolli esponeva in semplici, schiette parole
quel che la lettura di quel libro aveva smosso in lui sullo sfondo
dell'intera opera dell'anziano scrittore. Un'amabile, confidenziale resa dei conti attraverso pensieri, domande, dubbi affiorati
dal profondo e che di «personale» hanno solo il veicolo verbale,
non l'essenza.
Nella prima parte della lettera, Comolli individuava le tesi por-
tanti di Uscite dal mondo in tre punti nevralgici. Li riassumo in parole mie, trascrivendo le righe iniziali, letterariamente assai belle:
Caro Zolla,
una benefica sensazione di limpida euforia, di sottile, eterea ebbrezza, ha accompagnato pagina dopo pagina la mia lettura di
Uscite dal mondo. Sicuramente questa particolare gioia del testo —
per cui sembra di respirare a ogni passo un'aria di ultraterrena libertà — è dovuta anzitutto al tema del libro: un «pellegrinaggio» di
epoca in epoca, di luogo in luogo, alla ricerca delle più disparate
vie d'uscita dalle sottomissioni che il mondo ci impone, per raggiungere invece un'estatica purezza.
Ma il singolare sentimento, diciamo cosi, di «felicità celeste» che
il libro ci dona, non deriva soltanto dal fatto che qui ci si occupa
dei vari e molteplici itinerari verso la beatitudine suprema. È la
scrittura stessa di questo libro infatti, il suo stile «cosmico» - per
dirlo in una parola - a costituire di per sé uno strumento di liberazione: c'è in Uscite dal mondo (ancor più che in opere precedenti) una trasmutazione della lingua in canto sospeso fra questo
e l'«altro» mondo, un uso della scrittura, come se questa fosse un
rito di passaggio per affacciarsi sull'aldilà.
Il lettore avverte che il ritmo della frase adombra un inaudibile
ritmo dell'Infinito, e così avvertendo intrasente la presenza dell'Infinito proprio attraverso il libro, che quindi si rivela essere una
nuova, ulteriore porta di uscita dal mondo.40
A questo preambolo che è un ottimo avvio alla lettura del libro,
segue l'individuazione dei punti nevralgici nella tesi di Zolla che,
a mia volta, semplifico. Il primo è che proprio qui, in questa vita,
si possa raggiungere una liberazione o elevazione spirituale che ci
tramuti e ci rinnovi talmente nel profondo che le traversie e le
gioie incontrate sul nostro cammino siano accolte, le une e le
altre, come opportunità preziose egualmente accidentali e transitorie. Infatti ogni cosa è legata a tutte le altre, e la configurazione
specifica e generale del quadro del mondo dipende in ultima analisi dalla nostra mente.
Il quesito di Comolli, in realtà duplice, era dunque il seguente:
posto che lo scopo precipuo della vita consista in una simile liberazione o elevazione spirituale, dobbiamo pensare che i mezzi efficaci a raggiungerla dipendano interamente da noi, dalla nostra
volontà e capacità di svilupparla, o sono da intendersi piuttosto
come «strumenti angelici» che qualcuno venuto in nostro soccorso ci dispensi amorevolmente «come una grazia»? Ma allora:
che c'entra col cimento di elevarsi con le proprie forze o mercé un
aiuto «esterno», la realtà virtuale?
L'intreccio tra i due quesiti è talmente importante sia in rapporto al pensiero di Zolla, sia in sé e per sé, che si rende necessario un piccolo sforzo di attenzione in più.
Senza fare riferimenti espliciti alla teoria buddhista del risveglio e dei mezzi efficaci per accedervi, che alcune scuole fanno dipendere da aiuti «esterni», altre dallo sforzo individuale, e che talune ritengono ottenibile in modo graduale e altre istantaneo,
Comolli sollecitava Zolla a pronunciarsi su questo punto non
solo per comprendere quale delle due strade EZ ritenesse a suo
giudizio più percorribile, ma anche per venire a capo del plauso
incondizionato dello scrittore per gli esperimenti di realtà virtuale. C'è dunque un legame tra la concezione zolliana e quella
buddhista dell'insostanzialità dell'io, cosi tanto in linea con la
teoria emergente della non-differenza tra reale e virtuale?
«Per favore risponda!» - domandava Comolli e la sua insistenza
pareva echeggiare quella di Maitreyl, l'interlocutrice nel dialogo
upanisadico prima esaminato.
Nella sua risposta, Zolla riaffermava la natura rivoluzionaria
della realtà virtuale «perché non esiste una sola esperienza per noi
fondamentale e perfino sacra che non si possa trasporre in un programma di realtà virtuale»; e quanto alla liberazione in vita, riteneva che «il dischiudersi di una realtà esoterica è possibile anche
senza la figura del maestro», propendendo, implicitamente, per la
via «solitaria» piuttosto che per la via «amorevole» avvicinabile
alla concezione della Grazia cristiana.
Leggendo e rileggendo questo carteggio, ho l'impressione che
le risposte di Zolla abbiano sedato solo in parte i quesiti di Co-
molli, quesiti che possono essere urgenti non solo per lui. E la circostanza che lo scrittore non possa più prenderli in esame mi sollecita, sulla fine di questo itinerario introspettivo, a tentare un'interpretazione alla luce di quel che ho intimamente appreso e compreso del suo pensiero e non certo per addossarmi un compito palesemente improprio. Non posso che farlo alla maniera che mi è
divenuta congeniale da quando per le vie dell'Asia mi è accaduto
d'incontrare sui libri e dal vivo certi conoscitori di segreti, simili a
EZ, stupefacenti e indecifrabili da quanto erano rocciosi e fluidi
al tempo stesso, in costante intimità con gli antipodi. Lo svariare
dei toni dallo sferzante al soave, dall'apocalittico all'irenico, dal
plumbeo al gaudioso negli scritti zolliani collocati nella Parte seconda, esalta questa intimità con gli antipodi in maniera direi
inequivocabile.
Una volta, sfogliando un libro di Anagarika Govinda La via delle
nuvole bianche: un buddhista in Tibet, tradotto in italiano lo stesso
anno, il 1981, in cui Archetipi usciva a Londra e in contemporanea
a New York,41 m'imbattei in un passo che mi fece riflettere:
«Ci sono montagne» scrive Lama Govinda42 «che sono soltanto
montagne e ci sono montagne che hanno personalità. La personalità di una montagna non è soltanto una strana forma che la
rende diversa dalle altre, proprio come un viso con una strana sagoma o azioni strane non fanno di un individuo una personalità.
La personalità consiste nelpotere di influenzare gli altri, e questo potere è dovuto alla risolutezza, all'armonia e allafocalizzazione su un
punto delcarattere»{coisìvo mio).
Ecco un paragone adeguato — mi sorpresi a pensare. Nella personalità di EZ tutti e tre quegli aspetti: la risolutezza, l'armonia e
la focalizzazione su un punto del carattere sono presenti a un
grado spiccato, e la domanda del tutto pertinente posta da Comolli se uno stato di «liberazione in vita» sia pensabile come un risveglio solitario, ottenuto con le proprie forze, senza soccorso di
guide spirituali o per grazia divina, non poteva che suscitare la risposta effettivamente ottenuta, e ribadita da Zolla altre volte:
«Credo che immergendosi nello studio della concezione buddhista della pietà si emerga guariti dal bisogno di porre antitesi».43
L'antitesi: ciò che si oppone, che è antinomico e inconciliabile.
Zolla nel suo percorso intellettuale ha affrontato l'antitesi senza
risparmio occupandosi di problemi di critica sociale, di dialettica
storica, di etica ed estetica ma anche sfidando l'antitesi sul suo
proprio terreno negli ambiti della logica classica, aristotelica,
buddhista e talmudica (un minimo assaggio di un botta e risposta
talmudico è riportato nel brano Israele: Sfat e cento cancelli in
Nuove terre cieli nuovi, Parte seconda).
Si rese conto che l'affondo buddhista nelle figure, negli intrichi
e nei trabocchetti della logica, poteva diventare, come di fatto è
avvenuto nelle celebri scuole dialettiche mahàyàna, un metodo
che nel conseguire la padronanza dell'antitesi sfociava nel suo superamento, rimodellando una mente imperniata sulla vacuità, liberata dalla sudditanza al cozzo degli antipodi, una mente per la
quale la differenza tra natura e artificio, reale e virtuale è letteralmente inconsistente in quanto vuota, priva di realtà ontologica.
Un ragionamento di Nàgarjuna, uno dei massimi pensatori indiani e sistematore del buddhismo mahàyàna (II secolo d.C.), illustra questo punto in termini perfettamente aderenti alle discussioni di fine secolo sulle prospettive dischiuse dagli esperimenti di
realtà virtuale: «Come un uomo artificiale - afferma Nàgarjuna dice di no ad un altro uomo artificiale occupato in qualcosa (impedendogli di farla), e un uomo magico, creato da un mago, dice
di no ad un altro uomo magico, creato dalla sua stessa magia, il
quale è occupato in qualcosa (impedendogli appunto di farla) [...]
- cosi appunto la mia enunciazione, seppure vuota, può logicamente negare la natura propria di tutte le cose».44
Tornando al quesito di Comolli: «che c'entra la via di liberazione con la realtà virtuale», pare evidente che il punto di contatto per Zolla sia la nozione buddhista di «vacuità» e il conseguente azzeramento di una differenza logica e ontologica tra
«reale» e «virtuale». Ciò che Zolla sostiene in Uscite dal mondo e
nel primo capitolo de La filosofia perenne implica, ribadisco, un
metodo radicale di trasformazione interiore del tipo di quelli impartiti nelle trafile esoteriche buddhiste, taoiste e anche cristiane, come nel caso della pratica ortodossa di sincopare la pre-
ghiera sulla ininterrotta ripetizione del Nome divino. Sia la disciplina meditativa che una prolungata esperienza di cocente dolore vissuta come una sfida, costituiscono per se stesse uno degli
«accorti mezzi» grazie al quale la mente arrovellata si spiana, si arrende lucidamente alla quiete, e poco importa se la fonte che la
largisce è chiamata fede, sapienza, grazia o è piuttosto il soccorso
compassionevole («amoroso» nelle parole di Comolli) di una
guida spirituale.
Nel saggio Esoterismo e fede, pubblicato su «Conoscenza religiosa», che ora si può rileggere,45 Zolla definiva la fede: «una capacità di autoallucinarsi o di sostanziare in certo modo la percezione», e la annoverava tra gli «accorti mezzi» accanto all'arte, alla
ginnastica sacra, all'etica e alla filosofia. Per la seconda volta, in
poche righe, incontriamo questa espressione. Di quali «accorti
mezzi» si tratta?
L'uomo, ritiene Zolla, è una creatura duttile, e quando la capacità di credere è coltivata e sviluppata a dovere, è come esercitare
e irrobustire un arto fisico: chi vi si sarà allenato otterrà di disporre della fede invece che trovarsi nella situazione in cui è la fede
a disporre di lui.
Un ragionamento indubbiamente scabroso giacché mette in
discussione concezioni inveterate sia per il credente sia per colui
che non si riconosce tale, sfidati entrambi a pensare la fede come
un'energia che, attivamente o in potenza, dispone di noi a meno
di non riuscire a disporne noi stessi. Anche la premessa, formulata
nel paragrafo iniziale di Esoterismo efede e la conclusione cui Zolla
perviene, non sono facili da accogliere. La premessa è che «ogni
vita ha un nucleo esoterico» nella misura in cui «ogni essere vivente fa supporre un'intelligenza che lo plasma. Le sue molecole
ne recano la formula in codice, e questa rinvia a una forma formante e informante. Gli antichi parlavano della causa formale
che informa di sé ogni essere vivente; a noi càpita di poterne leggere la scrittura. Ma mentre decifriamo il codice biologico, non
osiamo più immaginare l'interna intelligenza codificatrice; essa è
come divenuta irraggiungibilmente interna, nota a pochi e diffamata: esoterica. [...]»
In altre parole: sia le scienze che le vie della conoscenza metafisica
hanno un nucleo esoterico, senonché mentre nel primo caso l'esotericità è un addentramene non solo ammesso ma coltivato e
incentivato, nel secondo caso è categoricamente sbandita, sospettata di ogni pericolosa nequizia. Zolla inoltre non esitava a sostenere che «l'oggettività in sé e per sé è un'ubbia. La fede dell'osservatore seleziona e conforma il reale. La fede non è soltanto la sostanza di ciò che siamo ma anche della natura quale ci appare.
Non è dato dimostrare una differenza tra la percezione della realtà
e un'allucinazione collettiva costante e durevole: sono infatti la
stessa cosa».46
Che la fede sia allo stesso tempo «la sostanza di ciò che siamo»
e una deliberata allucinazione, è un assunto che sconcerta fino a
quando non si venga scalfiti dal pensiero che la vita, nella fortuna
e nella sciagura, è una palestra nella quale allenarci alla cognizione
e al superamento degli antipodi.
4. Congedi
È venuto il momento di accennare a taluni accorgimenti praticati
da Zolla negli scritti dell'ultimo decennio della sua vita. Forse
«accorgimenti» non è la parola giusta ma per il momento non ne
trovo una migliore. Sta di fatto che dagli anni Novanta in poi non
c'è opera che all'epilogo non accenni a un commiato, una presa di
congedo lasciata cadere con noncuranza come una goccia d'inchiostro sbavata su un calligramma. Ogni volta, in quelle sommesse parole, è presagita un'uscita dal tempo.
In Uscite dal mondo, la cornice del commiato è il padiglione erboso di un monaco birmano presso il quale il capo della polizia locale si è recato in visita con la sua famigliola.
«Il tempo» scrive EZ «subisce un arresto. La mente liberata comincia a rimbalzare tutt'attorno al trono centrale e sfavillante tra
le colonne, al divampare delle luci variegate, allo sfilio di vecchie
fotografìe sopra il colonnato: ricordi del monaco, nel 1943 pilota
di spitfire nel Nevada.»
Il monaco mostra allo scrittore la camminata meditativa e lui
commenta: «Basterà che tutta la mia attenzione scenda di
schianto nel piede e avverta con sgomento la terra [...]. Mi si
mette a lato e posa lentamente per terra un piede appena deviato,
quindi l'altro, simmetrico, accompagnandoli via via con le necessarie parole: Scende. Si posa. S'alza.
«Il monaco adesso torna dove stava e da un fascio ben composto estrae un libro stampato nel 1979 a Santa Cruz: Joseph Goldstein, The Experience oflnsight. A naturai unfolding. Mentre trascrivo rioccupa il suo posto accanto alla famigliola. Dopo un
cenno, chiusi gli occhi, recita ad alta voce un canto, mentre i tre
tengono la fronte poggiata per terra. Adesso tutt'e quattro salutano, restituisco il libro, mi accomiato».
A sua volta Le tre vie si chiude sull'aspetto più prezioso del lascito
spirituale indiano al mondo, il combattimento meditativo: «Il
patrimonio intellettuale indù» scrive EZ «negli ultimi tre secoli,
s'è giusto sfiorato; danze, dottrine tantriche sono appena appena
riemerse. Per ottenebrare ogni cosa, hanno svolto la loro parte il
regime del silenzio che ha sempre imperato su ogni insegnamento
nonché le guerre di sterminio. La storia dell'India infine per tanta
parte rimane congettura e le sue date sono supposizioni. Eppure,
ramingando per foreste, indagando angoli dimenticati di templi,
percorrendo torridi, umidi, tenebrosi vicolacci, raccogliendo
confidenze, Il ancora può capitare l'incontro con un qualche barbaglio del passato remoto, che si tramuta».
Il capitolo finale de La nube del telaio s'intitola esplicitamente:
Congedo, e un paio di passi da Robert Frost rinviano alle immagini del ruscello di luce e della ruota del tempo: «Tu ti puoi spingere indietro per un ruscello di luce al cielo»; «E questa rapidità ti
fu data non per affrettarti né soprattutto per andartene dove vuoi.
Ma perché nella smania di spendersi del tutto a te spetti invece il
potere di fermarti».
Egualmente con un congedo prende avvio l'ultimo paragrafo
de Lafilosofia perenne, dove Zolla, dopo oltre un trentennio, torna
a esaminare il pensiero di Sade e il sadismo. Se nei primi anni Sessanta, la lucida, glaciale follia del Marchese era stata scrutata nell'edizione delle Opere47 e Zolla vi aveva scorto i prodromi dei totalitarismi moderni - una congettura che nel contesto della battaglia anti-moderna dello scrittore era apparsa, all'epoca, provocatoria e tendenziosa - sulla fine del secolo aveva sentito l'esigenza di «svelare il tema effettivo» di quelle riflessioni iniziali su
Sade. Ne risultò un riesame decantato dei fattori che avevano innescato gli eventi nel decennio 1968-1978.
L'impulso nacque in Cina e vi portò la massima rovina, avventandosi su tutto ciò che rimanesse di civile in quel paese. Qualche
scrittore è emerso a raccontarlo, Jung Chang e Acheng fra loro.
Questo scatenamento puramente sadico fu ricevuto con simpatia
e lode in America e in Europa. Esse ne ricevettero ben presto l'urto
in casa, che produsse, almeno in Germania e in Italia, una guerra
civile [...]. Con rigore sadico fu esclusa ogni pretesa morale di famiglia o Stato, per non dire ogni ricordo d'un universo etico.
Questo denudamento paradossalmente accomuna i due opposti,
sadismo e quietismo mistico. Ma come, incalzava, poterono scendere tra le folle i pensieri abbastanza rari di Sade?
La risposta era fornita alle pagine 281 e seguenti:
L'arma che consenti di scaraventare torme nel Sessantotto - scandiva EZ — fu una scoperta dei medici di guerra americani, che durante il secondo conflitto mondiale si trovarono alle prese con il
trauma della battaglia, da risanare mercé la terapia di gruppo, alla
quale si può allenare un animatore [...]. L'animatore deve eccitare
l'emergenza della psiche di gruppo e dovrà farla riaffiorare ad
ogni incontro [...]. Dovrà aspettarsi, in un convegno terapeutico
psicanalitico, correnti aggressive dirette contro di sé (i transfert
negativi), ma per lo più le spinte aggressive insorgono fra i componenti del gruppo e danno forza alla discussione, a lui toccherà
soltanto incanalarle o smorzarle [...]. Dovrà incitare sempre all'intervento (al goingaround), non si stancherà di ricordare che è
11 per aiutare e che tutti sono presenti per fare uno «scambio di
esperienze», senza imporre nessuna opinione [...]. Una volta stabilito il clima propizio, doserà l'uso della seconda persona plurale, che elimina ogni angoscia e quello della prima persona singolare (come a dire: «Non sei più noi, sei semplicemente tu»)
[...]. La gente — osservava - tende a partecipare perché l'impegno
allevia il senso di colpa e l'ansia sempre presenti, mentre la sensazione di appartenere al gruppo dà conforto e tepore, vi si è tutti
uguali e le piccole frustrazioni non tolgono di mezzo questa
unione. Uno dei primi trattati sull'arte usci dalla Free Press di
Glencoe nel 1962: Group Psychotherapy. Il manipolo di animatori addestrati che si formò in tutte le città del mondo, specie
nelle università, potè scatenare — cosi concludeva — l'immensa
deflagrazione.48
Pochi sanno che della raccolta di saggi Discesa all'Ade e resurrezione uscita da Adelphi a pochi mesi dalla morte, esiste una versione succinta, Catabasi e anastasi, pubblicata da Tallone nel
2001. Nei mesi successivi, l'imminenza dell'edizione milanese
aveva spinto Zolla ad aggiungere nuove parti e su quelle bozze si
chinò fino all'ultimo. Nella Nota al testo osservavo che «i temi
che avevano stregato la sua mente nel corso della vita, all'epilogo
vengono a esigere anche dal cuore la quota dovuta». Catabasi e
anastasi descrive ed esorcizza il dramma della sparizione della coscienza in una sequela di tradizioni misteriche dall'estremo Occidente all'estremo Oriente, dalla celtica alla taoista. Ma in questa
occasione i segreti che in esse s'annidano sono squadernati senza
veli da chi sa di non avere oramai tempo davanti. Nell'orizzonte
del libro si staglia il tema di un esodo d'altra specie, il «viaggio» intrapreso dall'anima una volta sciolta dal corpo fisico. La direzione
del cammino è duplice: all'ingiù, in greco katàbasis, e all'insu,
anàstasiso anàbasis. Nel suo insieme il cammino equivale a un periplo completo dei regni cosmici: inferi, terra, atmosfera, cielo, e
il periplo sigilla e riscatta la vicenda terrena, fugace ma decisiva,
della creatura di carne.
Se l'anastasi nella prospettiva cristiana è vista come una resur-
rezione del corpo e dal corpo, il taoismo vi scorge piuttosto la fase
in cui la creatura mortale, trasumanando, porta a compimento il
proprio destino celeste. Il punto nel quale i retaggi di Oriente e
Occidente s'incontrano è esplorato nel capitolo: Sapienza celtica
di Merlino. Attraverso la mitobiografia del druida Merlino ricostruita alle fonti, Zolla dimostrava che fili invisibili annodano il
Santo Graal, incardinato al cuore esoterico dell'Occidente a temi
analoghi dell'esoterismo taoista, indigeno e sciamanico dove vasi,
zucche, coppe, recipienti di forma uterina, svolgono un ruolo di
spiccata magnitudine simbolica.
L'edizione Adelphi di Discesa all'Ade e resurrezione, arricchita
degli ultimi scritti, ha un andamento ansante, concitato, all'ultimo respiro. Adesso, ciò che resta da dire non ammette rifacimenti, non tollera dilazioni o rinvìi, e una cavalcata di immagini
attraverso la storia e i miti di Oriente e Occidente s'abbatte fulminea all'epilogo:
I Magi dei Medi erano stati paralleli ai brahmani indù, ai leviti d'Israele, avevano praticato il culto del fuoco e venerato Zoroastro;
dalle loro meditazioni doveva emergere Zurvan, Tempo-Destino
supremi. Da esso originò il bòn e si stabili in Tibet, sostituendo il
culto dei re; insegnò il culto dell'Uomo bianco e dell'Uomo nero,
fonte delle costellazioni, dei poteri infernali, di peste e tribolazione, da cui doveva forse evolversi in un seguito di secoli l'idea
evangelica del Signore del secolo, dio di quest'epoca di transito
{Seconda lettera ai Corinti IV, 4).
Mentre il fiume sterminato delle parole contenute nei libri zolliani si avviava alla foce, un piccolo manipolo di parole, come obbedendo a un ordine silenzioso, si radunava a pennellare una figura esalata dal nucleo intimo e segreto della mente dello scrittore, la figura dell'«uomo celeste alto come la stella polare, aperto
a tutte le forze del cosmo, svuotato, amputato della testa, diventa
puro specchio dell'universo [...]. Conoscente e conosciuto allora
si fondono, infine non hanno più nome né forma, si stringono e
si esprimono nell'uno che è tutti i numeri».49
5 . 1 lembi si congiungono
Se il racconto di questa biografìa scancellata prese avvio a Torino
nell'altro secolo quel 9 luglio 1926 quando il sole nel cielo del
mattino si eclissò per un poco, non è fuori luogo immaginare che
all'epilogo lo scrittore ripercorra le vecchie strade dell'infanzia
l'anno in cui il padre moriva: il 1961.50
Da questo colle dove è stata distrutta la vecchia chiesa chiara e modesta si ode Torino: un rombo che, affinandosi, s'incupisce. La cupola di vapore sopra la fungaia delle case grandina un riverbero
lattiginoso; quand'ero bambino queste afe ferme erano più rare.
In città da poche ore, già mi mortifica una patina di fuliggine sui
polsini, il torace intorpidito pesca con cautela l'aria greve di detriti
industriali. Non è cresciuta in bellezza, la città, da quando ero
bambino; non è più dato di contemplare la facciata medievale di
Palazzo Madama, laggiù, senza essere offesi dal bronzo delle statue
e se la facciata barocca si leva ancora gioiosa accanto al vicino
trionfo del duomo, le incombe addosso un grattacielo fascista, il
lacchè tiene a briglia il suo antico signore. Che vado mai cercando
nell'intreccio della veduta?
Laggiù non sono ormai quei caffè, misteriosi vestiboli affacciati a
via Po, adorni di soffitti dipinti, di velluti rossi, di specchi incorniciati [...]. Poco resta oltre a blocchi di cemento irti di antenne televisive come le baite di corni di bue, a negozi nichelati: una scacchiera di bare metalliche. Né, spingendo lo sguardo alla periferia
avvolta di bruma calda, posso riconoscere con l'usata letizia due
punti, le case, a me care, di due pittori oggi morti, mio padre, Venanzio Zolla e il suo amico Domenico Buratti.
Alla minuta descrizione della casa di Buratti e della vista dal balcone al quale l'anziano pittore si affacciava notando con mestizia
i cambiamenti di toni e atmosfere tutt'attorno, via via che il
tempo passava, seguiva l'evocazione della figura paterna nella casa
di via Pesaro in cui EZ aveva vissuto fino al 1956 assieme agli altri
membri della famiglia.
Mio padre abitava una casa così squallida da non potersi dire, né
triste, né tetra, né torva, era di qua d'ogni sentimento. La strada
che vi conduceva, un acciottolato fra nudi muri scorticati sui quali
si indovinava la traccia dello stampino con cui i fascisti incatramavano la faccia del loro padrone, e accanto si vedevano sgorbi di
bambini desolati, cerchi con due croci e un taglio di bocca sopra
corpi quadrati, e, attorno, stelle o nomi o ingiurie o oscenità. DubufFet, Mirò. Dal suo balcone, d'estate, mio padre dipingeva
quella strada, ed era tutta un dilagare di luce cremosa rotta da accese vampe; d'inverno la dipingeva da dietro i vetri: muri marroni,
celesti o bruni, coltri di neve affioranti dalla nebbia pervasa di
fumo, come vellutate gobbe di bestie affogate nella mota.
Non aveva avuto agi, aveva dovuto dipingere per denaro. Passi per
via San Pietro in Vincoli e odi salire dalle grate del Cottolengo un
concertato di voci agoniche e fatue; così udivi nello studio i committenti: «Perché mai così grigi i suoi quadri? Viviamo in un'epoca
solare, in Italia». «Vorrei che si distinguesse la faccia delle figure
nello sfondo», «Ci metta una pecorella», «Perché ha la faccia triste e
pallida questa donna? Di tristezza ce n'è già abbastanza», «Mi piacciono i nudini, ma con un velo qui e la faccina un po' vergognosa».
Mio padre si celava dietro il fumo della sigaretta, aveva imparato a
non tentare di spiegare che quanto è calcolato è laido, a coloro che
vivevano calcolando. Per distrarsi dai loro discorsi talvolta li disegnava in fretta, tenendo nascosto il foglio in grembo, fermandoli
nella smorfia con cui chiedevano allegria. Come spiegare a costoro
che il pittore distrugge la natura guardandola, la risolve in un reticolo di rapporti fra intensità di luce, fra forme? Poi risorgerà, se la
grazia assiste, se si è immersi in completo silenzio, la stessa natura.
Talvolta, per ritrovare l'oasi, sempre più remota del mondo circostante, egli tentava scorciatoie: le scomposizioni di piani di cui parlava Buratti, le geometrie, ma tosto gettava via i puntelli, tornava
alla verità; alla mezzatinta accennata nell'angolo destro in alto che
trasforma tutto l'angolo sinistro in basso. Sia lui che Buratti avevano studiato all'Accademia Albertina, ai primi del secolo. La bottega del maestro è per il giovane apprendista simile a ciò che sono,
per l'uomo in genere, la famiglia, la classe sociale, qualcosa che
tocca viverefinoall'estremo, svolgerefinoalle conseguenze che distruggono ogni forma creata. Quando cessa l'apprendistato si
forma il vuoto, guai a chi allora rabbrividisce e si afferra ad una
qualsiasi immagine di se stesso che gli venga offerta dalla società o
dalla pigrizia o dalla tradizione. Soltanto accettandolo il vuoto tenebroso (avete mai pensato al buio?) si ottiene l'invenzione, e ci si
accorge che questa altro non è se non il ritorno al centro immobile
d'ogni pittura della nostra civiltà in estinzione: ai classici. Spontaneità e tradizione non esistono divise l'una dall'altra.
Per vie così opposte — EZ rifletteva — i due pittori erano giunti in
cene opere allo stesso centro, cercando la purezza antica o accettando la lotta estenuante con gli artifici moderni, poco importa;
l'essenziale era la fede non discorsiva in certe velature, in certi baffi
di fuliggine dei grandi, inattingibili maestri. Raro viaggio a ritroso
nei secoli, testimoniato da pochi quadri, a cogliere qualcosa di
quelle precisioni imponderabili.
Tali improvvisi lampi si erano manifestati, in due punti di questa
città. Se ne serberà qualche ricordo? Non è una domanda che
abbia importanza.
51
***
Quarantanni dopo la visita a Torino sul filo della memoria, Zolla
riesponeva l'idea confittagli dal padre e mai abbandonata, della
pittura come arte che vince la morte. Il testo è il penultimo della
sezione Epifanie nella Parte seconda.
6. Oro incenso e mirra
Il 28 maggio 2002, il primo pomeriggio assolato e tiepido aveva
incoraggiato una breve passeggiata. Da Montepulciano a Pienza
undici chilometri di curve ondulate che accompagnano con dolcezza lo sguardo tra colli e filari, e anche se la distanza è scarsa, si
entra in un'aura diversa.
Posteggiai l'automobile al fontanile accanto alla Pieve di Cor-
signano, sotto Pienza. Un luogo incantevole, tufaceo e arcano,
imbozzolato in una solitudine che i rari visitatori increspano appena nel pigro svolìo dei colombi padroni ai piani alti della torre.
Elémire amava di tanto in tanto riosservare le figure scolpite
sull'architrave a fronte e sulla porticina laterale. La loro danza
nella pietra l'aveva descritta minutamente in Verità segrete esposte
in evidenza, e tanto bene gli s'era impressa nella memoria che a riguardarla gli occhi erano quasi superflui.
Al centro dell'architrave una sirena impugna le proprie pinne divaricate, ostentando l'inguine bene inciso, come dicesse che varcando la soglia del tempio, si entra, si torna nel suo grembo.
Figure di donna che mostrano il sesso sono comuni nelle chiese arcaiche d'Irlanda, una sovrasta l'ingresso della chiesa di Leighmore.
Lo stesso spirito fece scolpire una ragazza che ostentava l'inguine
sopra Porta Tosa a Milano. Buttava in faccia ai pellegrini la sua promessa, il suo vanto di fertilità e in mano stringeva una daga e una
serpe: minacciava di punta i fantasmi della morte e della sterilità,
teneva in pugno il simbolo del rinnovamento e della medicina [...].
A Corsignano [...] la sirena bifida non è sola sull'architrave. Alla
sua sinistra un'altra sirena suona una ribeca mentre un drago le
pigia le fauci aperte sull'orecchio, come dardeggiandovi la lingua.
Alla destra invece una danzatrice dalla gonna pieghettata poggia
una mano sulfiancoe l'altra protende in alto, come nel flamenco;
una compagna le stringe l'avambraccio sollevato, e intanto afferra
con l'altra mano un drago che le preme le fauci sull'orecchio [...]. Il
sistema di metafore degli antichi dava per scontato che i vortici
della danza evocassero i genii delle acque. Nonno nelle Dionisiache
descrive Sileno (si amò giocare su «sileni» e «sirene») che diventa
una fiumana nell'empito del ballo [...].
Le cosmogonie arcaiche, presenti ai costruttori romanici, pongono
all'inizio del tempo la pura sonorità, narrano che dall'abisso del nulla
emersero iritmipossenti e fondamentali: affiorarono i draghi. Grazie
alla mediazione del desiderio, alla forza inesorabile che avvince a un
grembo di sirena, quei puriritmisonori assunsero una veste di carne,
crearonofiguredi danza. I due versanti del nostro architrave deno-
tano dunque, rispettivamente, l'invisibile e il visibile. [...]. Nella cosmogonia l'invisibile precede il visibile, nella conoscenza religiosa il
processo si rovescia. Il desiderio, doloroso o estadco, congiunge i due
opposti, suscita l'illusione cosmica. La sirena romanica non è dunque,
come si è spesso creduto, un ammonimento a schivare gl'inganni
delle maliarde; non per lezioncine di morale si sprecò il tufo [...].
52
Cosi aveva scritto tredici anni prima, e per imbeversi ancora della
danza di pietra s'era mosso quel 28 maggio lentamente da casa, e
si dirigeva ora alla soglia sul fianco della Pieve, affacciata sulla vai
d'Orda ebbra di luce.
Rientrando da quella passeggiata, aveva annotato un commento su un foglietto che trovai poi deposto nella pagina di Verità
segrete in cui è descritta la Pieve di Corsignano. Quel commento
è il seguente: «A lato una porticella introduce al luogo dove si celebravano le messe. Su di esso si stende una pietra che offre tre nicchie introduttive. Mostrano i re magi recanti l'oro, l'argento e la
mirra. Il sole è l'oro, la luna l'argento, la mirra olezzante sarà Venere dalla quale si partiva per calcolare i cicli del tempo.
«I tre fondamenti dell'esistenza sono protesi alla stella che sfolgora a destra su un altro terzetto di nicchie: la prima mostra un
angelo che tutela l'annuncio ai pastori, la seconda un consimile
angelo che ingloba il pargolo sotto il soffio dell'asino e del bove;
infine appare, senza tutela angelica, l'enorme Risorto. La stella
che dardeggia sulle nicchie ricapitola la triade metafìsica di annuncio, nascita e resurrezione.
«A sinistra la colonna mostra una serie di circoli all'incontro di
due linee che s'intersecano, in cima sta un animale, cavallo o
bove. A riscontro, a destra, c'è invece soltanto l'arricciarsi di una
pianta dopo una scena di scontri tra fiere. Un leone risponde al
cavallo della sinistra, sulla base a destra figura una partoriente».
L'occhio allenato dello scrittore aveva colto ancora una volta lo
sfolgorare del simbolo nel simboleggiato, e le parole erano rifluite
ad affermarlo poco prima che i fattori che avevano costituito
tutto il suo essere: respiro, pensieri, memorie, immagini si dissolvessero nell'immensa marea che stava montando.
***
A chi mi ha seguito sin qui nell'evocazione distaccata e al tempo
stesso partecipe (un paradosso, per me, difficile da evitare!) di una
vita in cui lo spirito di ribellione e una carica formidabile di spiritualità affrancata dall'osservanza religiosa si sono congiunti in un
nodo indissolubile, vorrei partecipare una riflessione tutta personale.
L'opera di Zolla scrittore e pensatore trae il suo più originale
valore dall'idea da lui arditamente ribadita che le antiche vie di
conoscenza di Oriente e Occidente e la sapienza indigena possiedano le chiavi di accesso per l'uomo di ogni latitudine a una realizzazione piena e completa di se stesso all'interno di una società
planetaria fruitrice di sempre maggiori e unificanti benefìci tecnologici. Questo è l'aspetto secondo me più fecondo del lascito
intellettuale zolliano per coloro che si sentono pronti a riceverlo e
a condividerlo coi loro compagni di strada.
Postilla
Esistono, com'è fàcile immaginare, dei cartoni preparatori a
Sprazzi di una biografia scancellata. «Cartoni» è parola che si addice
a un dipinto realizzato alla vecchia maniera piuttosto che a uno
scritto digitato al computer. Ma in questo caso è il termine adatto
giacché le pagine stipate a centinaia nella camera di scrittura sono
l'embrione della creatura di carta che è ora in mano, un embrione
colmo di tutte le sostanze vitali che hanno irrorato il futuro libro.
Barlumano ogni tanto in quei cartoni pagliuzze d'oro, frasi pescate
dagli scritti editi e inediti di Zolla, e dispiace non dare l'occasione
di condividerle a chi è giunto sin qui. Ad esempio questa:
Come una pianta cresce secondo le leggi della vegetazione così cresce
un uomo, obbediente alla vocazione del suo organico destino (ofato
o stella), mentre le singole occasioni, i rovesci o contrattempi, le avversità sono opera dellafortuna. Questa corrisponde alle disarmonie
nel volgersi celeste delle stagioni, alle tempeste, alle eclissi. Essa rien-
tra nella provvidenza generale, perché la sua funzione è di richiamare l'uomo alla precarietà insegnandogli l'indifferenza verso le
venture, gli accidenti della vita, instillandogli la consapevolezza
della possibile sciagura nella prosperità e viceversa, perciò essa è strumento divino [...].
O questa, che coglie in essenza che cos'è lo stile:
Lo stile: quel sale chepreserva dalla corruzione i concetti, l'unica loro
difesa dalla trasformazione in motti, in un vaniloquio gergale [...].
Oppure quest'altra, vibrante di rimprovero:
Piuttosto che uscire dalla tua gabbietta colma di cianfrusaglie, rivedi i conti! Credi che si possa giungere a un saldo? Aggiungi, togli
alla lista? Aspetta, ti faccio una mancanza e la dovrai aggiungere,
non sarai mai alla fine.
Un giorno,farse,a pochi, capita che capiscano: la gabbietta è
aperta, i conti sono numeri immaginati e scribacchiati a caso, i
saldi sifanno sulle tombe e si buttan dentro e chi lifa è una creaturina misera misera, che l'esistenza soffia via, l'inesistenzarivelaper
il niente che è.
0 l'appunto su un foglietto a mano inserito nei Quaderni all'ultima ora:
Il tempo è... quest'essere immaginario proteso a inghiottire le varietà
di cibo, delle pupille, delle orecchie, delle narici, dei polpastrelli,
della pelle, della gola... Rammento ciò che avvenne, mi prospetto
l'avvenire... e questo mi offre ilperno su cui avvolgere passato efuturo... il senzatempo, l'eterno presente.
1 cartoni preparatori del Conoscitore di segreti compongono un affresco di gran lunga più esteso e stratificato di questo. A leggerlo
come un racconto occorrerebbero molte notti passate a veglia accanto alla fiamma crepitante d'un focolare in pieno inverno.
Note
1. Una vita per la scrittura
1. E. Zolla e D. Fasoli, Un destino itinerante. Conversazioni tra Oriente e
Occidente, Marsilio, Venezia 1995.
2. E. Zolla, Aure: i luoghi, i riti, Marsilio, Venezia 1985 e successive edizioni.
3. E. Zolla, I letterati e lo sciamano, Bompiani, Milano 1969; Marsilio,
Venezia 1989 e successive edizioni.
4. Strumento tradizionale giapponese a tredici corde.
5. L'opera narrativa consiste nei romanzi Minuetto all'inferno (Einaudi,
Torino 1956, Aragno, Racconigi 2004 a cura di G. Marchiani)) e Cecilia o la disattenzione (il cui primo capitolo usciva su «Tempo Presente»,
n. 2, febbraio 1959 retrodatando dunque la stesura del romanzo pubblicato da Garzanti nel 1961), nonché qualche decina di racconti
sparsi tra le riviste dell'epoca. Marco e il gatto Mammone (che apparve
sul quotidiano di Torino «Gazzetta del Popolo», 7 gennaio 1962, ma
che in realtàrisalea vari anni prima) è ripubblicato per gli ottantanni
dalla nascita dello scrittore in Elémire Zolla dalla morte alla vita, a cura
di G. Marchianò, «Viator», nuova serie, 2005-2006.
6. «Il Paradosso», n. 23-24,1960.
7. Ritratti su misura, a cura di E. F. Accrocca, Sodalizio del Libro, Venezia
1960, pp. 442 s.
8. Unti con Guido Ceronetti, «Bloc notes», 28-29 novembre 1993.
9. Si veda il saggio Joyce o l'apoteosi del fantasticare, «Elsinore», n. 4, marzo
1964. Risale invece al 1952 Joyce e la moderna apocalisse, accolto tra i
Saggi letterari nella Parte seconda del presente volume.
177
10. The Writerandthe Shaman. A Morphology ofthe American Indian, trad.
di R. Rosenthal, Harcourt Brace Jovanovich, New York 1973; esistono
anche una traduzione francese e spagnola. Sulla ricezione critica negli
USA si veda Nota 5 del capitolo 4.
11. La collaborazione di Zolla al «Corriere della Sera», durata dal 1958 al
2000, era rievocata da Cesare Médail in Zolla e il «Corriere», «Caffè
Michelangelo», Firenze, n. 3,2003, nella sezione del fascicolo dedicata
a Elémire Zolla, a cura di E. Gatta.
12. Il provvedimento di trasferimento dalla facoltà di Magistero dell'Università di Genova all'Università La Sapienza di Roma quale titolare
della seconda cattedra di Letteratura angloamericana è in data 30 ottobre 1974. Le opposizioni più accanite vennero da ordinari sia laici sia
cattolici alleati nell'impedire la chiamata di un accademico le cui idee
notoriamente anti-moderne ne facevano il «nemico» per una volta
comune. Il francesista Giovanni Macchia fu nel novero di risicata maggioranza che votò a favore.
13. Tutti gli scritti zolliani apparsi sulla rivista sono raccolti e commentad
in E. Zolla, Conoscenza religiosa. Scritti 1969-1983, a cura di G. Marchianò, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2006.
14. Autodizionario degli scrittori italiani, a cura di E Piemontese, Leonardo, Milano 1989. La bibliografia zolliana indicata alle pp. 439 s.
che cessava col 1990, era aggiornata al 2002 nell'Omaggio allo scrittore a cura di G. Marchianò, «Viator», anno VI, 2002, pp. 24-35, e
«Idea Viva», Buenos Aires, n. 14,2002, pp. 52-54.
15. Domande rivolte a 109 scrittori, a cura di F. Camon, «Nord-Est»,
Padova, n. 6,1989.
16. Ibidem.
17. L'opera segna il commiato di Zolla dalla fase «negativa» di critica antimoderna. Ristampata da Marsilio tre volte durante la vita dello scrittore, è stata ripubblicata dall'editore veneziano nel 2005, a cura e con
un'introduzione di G. Marchianò. Trad. sp. Paidós, Barcelona 2003.
18. Nella Presentazione de II Bosco sacro, percorsi iniziatici nell'immaginario artistico e letterario, a cura di E. Zolla e M. Maymone Siniscalchi,
Bastogi, Lecce 1992. Si veda nello stesso volume «In principio era l'esoterismo» intervista rilasciata a D. Crocco.
19. Nelle edizioni Alberto Tallone, Alpignano 2001. Arricchita degli
ultimi saggi e intitolata Discesa all'Ade e resurrezione, l'opera usciva
postuma presso Adelphi, Milano 2002.
U. Eco, Opera aperta, Bompiani, Milano 1962.
21. Nell'articolo non iìrmato Due saggisti, a proposito di E. Zolla e U. Eco,
in «Letteratura italiana», n. 79, anno II, 11 aprile 1967, Fratelli Fabbri
Editori, Milano.
20.
2.1 primi trent'anni a Torino
1. L'articolo s'intitolava Ein neuer Vorschlagzur Deutungder Satorformele
usci in «Archiv fur Religionswissenschaft», n. 29, 1926, pp. 165-169.
Del quadrato magico si occuparono da allora con rinnovate ipotesi
archeologi e studiosi eminenti come A. Maiuri e J. Carcopino. Un
vaglio accurato delle interpretazioni è in SatorArepo Palindrome criptografica cristiana, a cura di M. C. Sacchi ZafFarana, Premessa di Gianfranco Ravasi, Tallone, Pinerolo 1998.
2. Intitolato Custodita in un «qttadrato magico» una parte del mistero di
Pompei? A firma di Bernardo Trevisano, pseudonimo di EZ, «Il Giornale d'Italia», 8-9 settembre 1966.
3. Il cielo natale di Elémire Zolla è esaminato da F. Frigerio, lo studioso
esperto di astrologia genetliaca in Elémire Zolla dalla morte alla vita,
cit., sezione Analisi.
4. Nato a Manosque in Provenza nel 1852, muore presso Parigi nel 1925,
un anno prima della nascita a Venanzio Zolla del figlio Elémire. Giornalista, fondatore della «Revue des chefs-d'oeuvre» (1881-1886), è
autore di vari romanzi tra i quali Les oiseaux s'envolent et lesfleurs tombent{Gli uccelli volano via e ifioricadono), e La nrf(Lz nave, pubblicato in due parti tra il 1904 e il 1922).
5. The Gentle Art of Making Enemies, Heinemann, London 1890, fu
ristampato tre volte nel giro di pochi anni. Il volume nella biblioteca di
casa Zolla è dell'edizione del 1906. Fu un dono al pittore della moglie
Bianche nel Natale 1908, come si legge nella dedica a penna: To VenanziofromBianche, Christmas 1908. L'arte cortese di crearsi nemici, a cura
di E. Bilardello, è pubblicato nelle Edizioni Novecento, Palermo 1988.
6. Il brano ricorre ne Lo stupore infantile, Adelphi, Milano 1994, capitolo
L'infanzia assassinata.
7. Lezione di verità, «Corriere della Sera», 30 marzo 1962. Sul melo e i
suoi caratteri nel capitolo II settenario di Le meraviglie della natura.
Introduzione all'alchimia (Bompiani, Milano 1975) Zolla annota:
«Gioviale è il melo: ha la corteccia macchiata di giallo, dalla stessa tintura amara degli acini d'uva e delle foglie di primula; i suoi corimbi ver-
deggiano a primavera, in estate spargendosi di petali rosei prima e poi
bianchi [...]. Il melo e i suoi pomi sono simboli di giovinezza e imperio;
segnato dagli acini è il pentagramma, lafigurastessa che Venere disegna nelle suerivoluzionicelesti, e la mela è anche un simbolo erotico:
Venere abbinata a Giove». In nota EZ rinvia a G. Ruhtenberg, Der
Apfelals Chiffreccc. in DieDrei, Stuttgart, settembre 1970.
8. Invito all'esodo usciva su «La rivista di Estetica», anno II, maggio-agosto 1963. I primi sette paragrafi sono riportati negli Scritti sulfurei,
Parte seconda.
9. Le pagelle negli anni di corso al Regio Ginnasio Cesare Balbo documentano i risultati di un adolescente disciplinato, versatissimo nelle
materie umanistiche, poco incline all'eserciziofisicoe piuttosto indifferente alle lezioni di religione.
10. Si tratta delfilosofoLuigi Pareyson (1918-1991), professore di Teoretica all'Università di Torino, uno dei maestri della Scuola Italiana di
Estetica.
11. Verso lafinedel saggio Joyce e la moderna apocalisse (in Scritti sulfurei,
Parte seconda), EZ sovrappone quasi alla lettera la logorrea dello psicopatico ai bisticci verbali ricorrenti in Finnegan's Wake mostrandone
l'inconsistente differenza.
12. Pubblicata a Reggio Emilia. Fascicoli XV, 1889, pp. 352-393 e XVI,
1890, pp. 1-35.
13. M. Tobino, Per le antiche scale. Una storia, Mondadori, Milano 1972.
Il passo citato è a p. 131 della ristampa Rizzoli, Milano 2003.
14. Dopo una polmonite contratta all'età di sei anni, la tubercolosi esplode
nell'inverno 1948 dopo che EZ, al compimento dei vent'anni, è riconosciuto inabile al servizio militare per deficienza toracica. Una benefattrice si accolla le spese di trasporto in automobile del malato all'ospedale Le Molinette per i trattamenti di pneumotorace. La TBC si
rimanifesta in maniera virulenta nell'autunno del 1950.
15. Rilegata in tela rossa e dattiloscritta su fogli di velina, la tesi si compone
di 135 pagine suddivise in tredici capitoli, corredati di schemi e diagrammi, quattro appendici e la bibliografia. Sullo sfondo della trattatistica di diritto amministrativo, sono esaminati «i problemi complessi
che sorgono intorno alla natura giuridica degli affari di reciprocità e
delle compensazioni private». Nella Premessa EZ spiega che il criterio
adottato è di far precedere «la parte costruttiva» dell'esposizione da
«una critica delle diverse soluzioni» alle questioni in materia di regime
vincolistico, e conclude: «Confidiamo che questo procedimento giovi
a snellire una trattazione che altrimenti verrebbe di continuo sviata
dall'insorgere di problemi incidentali, dalla necessità via via di eliminare costruzioni diverse che possano proporsi, dall'opportunità di esaminare lo stato della dottrina sui singoli problemi dogmatici». Un
metodo argomentativo che lo scrittore metterà costantemente in pratica nelle opere di critica sociale del primo periodo romano e al quale
continuerà ad attenersi in futuro.
16. Bianche Smith Zolla, sofferente da anni di malattia coronarica (al
tempo chiamata coronante), muore al San Giovanni Battista Città di
Torino il 24 luglio 1951. Nella Introduzione alla ristampa di Minuetto
all'inferno la cui iniziale stesura precede di quattro anni la pubblicazione nel 1956 (1951-52 è la data posta dall'autore in fondo al testo),
mi soffermo sull'indole di Bianche e il probabile influsso del suo temperamento malinconico e schivo sul secondogenito Elémire. A proposito di un cartone da lui dipinto della madre anziana scrivevo: «Le labbra si stringono in una piega dura, di riluttante sopportazione, e s'indovina tra le sopracciglia il solco della malinconia che Elémire sulla
fronte delle donne, di tutte le donne via via incontrate, avrebbe aborrito» (p. 11, Aragno 2004). Nei primi anni Cinquanta lo scrittore prese
gusto a dipingere, e all'Esposizione Nazionale d'arte al Valentino nella
primavera del 1953, accanto a svariate opere del padre figura una sua
tela: Composizione di ellissi.
17. L'inganno del nome, «Anterem», n. 50, giugno 1995, pp. 42 s.
18. Lo stupore infantile, Adelphi, Milano 1994, pp. 23 s.
19. L'inganno del nome, cit.
20. H.C. Dowdall, The Word «Person», «The Times Literary Supplemento,
8 maggio 1948.
21. A penna sulla copertina: To Dr. E. V. Zolla with complimentsfromH. C.
DowdalL II libriccino di 20 pagine: SpecialArticle and Correspondence
on the Word «Person» also Correspondence on the Words «Community»
and «Society», The Shenval Press, London, è custodito nell'archivio
dello scrittore.
22. Hans Kelsen, nato a Praga nel 1881, redasse nel 1920 il progetto della
costituzione austriaca. Dopo aver insegnato all'Università di Vienna
riparò a Ginevra e successivamente negli Stati Uniti. Gli elementi principali della teoria giuridica kelseniana sono esposti da Renato Treves
nella Introduzione all'edizione italiana dei Lineamenti di dottrina pura
del diritto (Einaudi, Torino 1952).
23. Ivi, p. 94. Il capitolo si intitola La dissoluzione dell'idea dipersona.
24. Lo scetticismo giuridico, «Rassegna Italiana di Sociologia», anno I, n. 4,
ottobre-dicembre 1960.
25.
26.
Bompiani, Milano 1966, III ed., p. 150.
Visita angelica in via dei Martiri usci su «Tempo Presente», anno II, n. 2,
febbraio 1957, e fu pubblicato in inglese nel semestrale diretto da Saul
Bellow «The Noble Savage», n. 4,1961 ; LAfrica nel cortile era accolto nell'antologia L'amore in Italia, Sugar, Milano 1961, pp. 273-337. In una
versione accorciata dal titolo Giuditta era stato pubblicato su «il Mondo»,
30 settembre 1958; Marco e ilgatto Mammone era comparso il 7 gennaio
1962 sul quotidiano di Torino «Gazzetta del Popolo», si veda anche Nota
5 del capitolo 1. La versione integrale è nella sezione dei tesd zolliani del
fascicolo speciale Elémire Zolla dalla morte alla vita, «Vìator», cit.
Un altro racconto, Veio, un cane, La minestra, usci su «Paragone», n. 154,
1962.
27. Nella Introduzione a I mistici dell'Occidenteripubblicatoda Adelphi,
Milano 1997.
28. EZ lesse il Jean Santeuilnell'edizione in tre volumi di Gallimard 1952
(Collection «Bianche»), con la prefazione di André Maurois.
29. Nell'archivio di Zolla il carteggio tra i lettori eccellenti all'Einaudi che
giudicarono il romanzo consiste di otto fogli spillati e li precede il testo
delrisvoltovittoriniano. Si veda in proposito la mia Introduzione alla
ristampa di Minuetto all'inferno (Aragno 2004), pp. 16-18 e la Nota 14.
30. Gli stralci delle lettere intercorse sono tratti dal carteggio citato alla
nota precedente.
31. M. Bellonci, Come un racconto gli anni del premio Strega, Club degli
Editori, Milano 1969.
32. Ivi, p. 47.
Volgarità e dolore,
3. Il periodo romano
1. E. Zolla, Il satanismo, «Conoscenza religiosa», n. 4,1970, p. 397.
2. La separazione avviene a pochi mesi dal matrimonio celebrato con rito
civile in Campidoglio. Zolla otterrà il divorzio dopo un'estenuante
vertenza giudiziaria durata oltre un ventennio.
3. L. Compagnone, Esclusi dal giro, «Il Mattino», anno LXXII, n. 1.
4. Dopo la libera docenza ottenne l'incarico di Lingua e Letteratura
angloamericana nel 1960 per intervento di Mario Praz. L'ordinariato
fu conseguito nel 1967 e la prima destinazione fu l'Università di Catania dove insegnò per un anno, per poi passare all'Università di Genova.
5. Il sodalizio della scrittrice con Elémire Zolla profilato da Cristina De
Stefano in Belinda e il mostro. Vita segreta di Cristina Campo (Adelphi,
Milano 2002), è una ricostruzione attinta a testimonianze di persone
dell' entourage di Vittoria Guerrini. Ne risulta un'immagine della
vicenda e dello stesso Zolla molto alterata, di cui lo scrittore silenziosamente si rammaricò. Dopo questo spiacevole episodio, un tacito
accordo con mio marito mi fece astenere dal far parola delle confidenze
da lui ricevute sui risvolti umani e letterari della vicenda Zolla-Guerrini.
6. Le principali erano state «Nuova Antologia», «Il pensiero critico», «Lo
Spettatore italiano», «Studi Americani», «Elsinore», «Il Punto», «La
Fiera letteraria», «il Mondo» e svariati quotidiani tra cui i romani «Telesera», «Il Giornale d'Italia», «Il Messaggero», e «La Nazione» a Firenze.
7. La calligrafìa dello scrittore è analizzata da E. Bracci Testasecca in Elémire Zolla dalla morte alla vita, cit., sezione Analisi.
8. Più di una volta una certa facilità all'abbaglio lo indusse a scambiare
per schietti sentimenti che nei suoi confronti non erano tali. Sarebbe
fùtile, e non conforme allo spirito di questo ragguaglio, esplicitare
nomi e circostanze.
9. Da un appunto autografo.
10. L'emancipazione della commedia, «Notiziario», Einaudi, anno V, n. 9,
settembre 1956.
11. Ivi, p. 5.
12. Come documenta Stefano Cochetti in Mythos und «Dialektik der
Aufklärung», Haim Verlag, Königsberg 1985.
13. Come si evince dalla Premessa degli autori alla I edizione dell'opera
(trad. it., Einaudi, Torino 1966): «Nelle condizioni attuali anche i beni
materiali diventano elementi di sventura. Se la loro massa, per mancanza del soggetto sociale, dava origine, nel periodo precedente, in
forma di sovrapproduzione, a crisi dell'economia interna, essa produce
oggi, che gruppi di potere hanno preso il posto e la funzione di quel
soggetto sociale, la minaccia internazionale del fascismo: il progresso si
capovolge in regresso».
14. Si vedano a raffronto l'Excursus II: Juliette, o illuminismo e morale in
Dialettica dell'illuminismo, e i testi zolliani: Sade («Aut Aut», n. 41, settembre 1957) e II sadismo (in II Marchese di Sade, Le Opere, scelte e
presentate da E. Zolla, Longanesi, Milano 1961).
l'i. Adorno fra metacritica e metafìsica, «Elsinore», n. 5, aprile 1964,
ristampato in «Ethica», vol. IX, 1970. All'analisi de La musicologia di T.
W. Adomo, è dedicato il saggio omonimo, «La rivista di Estetica», anno
II, settembre-dicembre 1957.
16. Strali variamente acuminati si abbatterono sull'autore di L'eclissi dell'intellettuale ad ogni occasione per oltre un ventennio sulla stampa
nazionale. Nel novero degli arcieri accanto a Ennio Flaiano cui si deve
la battuta: «E sia ben chiaro che tra Elémire Zolla e la folla preferisco la
folla», spiccano nella persistenza Valerio Riva (m. 2004) e Beniamino
Placido. Unafilippicadi quest'ultimo su «Civiltà delle Macchine», n.
1-2, gennaio-aprile 1977, pp. 62-70, s'intitolava, concordemente alla
frase di Flaiano, Gli intellettuali e le masse. Preferisco la falla.
17. Nella Introduzione il mistici dell'Occidente, Garzanti, Milano 1963.
18. «Dette l'avvio a lunghe serie di indagini e teorizzazioni [...] stimolò i
più disparati interventi di letterati, sociologhi, uomini di cultura [...]
sul torpore e l'incubo dell'uomo-massa; il suo vitalismo nevrotico e
insensato, automatico e truce; il rapporto tra uomo e collettività, tra
uomo e cultura, tra uomo e avvenire.» G. Tedeschi, Gli itinerari spirituali di Elémire Zolla, «Vita e pensiero», anno LII, n. 1, gennaio 1969.
19. E. Montale, Odradek, «Corriere della Sera», 7 agosto 1959.
20. G. Piovene, Giudicano la civiltà d'oggi un inferno senzafinestre,«La
Stampa», 12 febbraio 1962.
21. E. Croce, Storia del fantasticare, «il Mondo», 1 settembre 1964.
22. Valga per tutte le risposte a F. Giordano nell'intervista: Joyce? Io lo
stronco, «Mondo Operaio», 3 marzo 1991, pp. 107- 111.
23. I loro titoli sono: L'eclissi dell'intellettuale, Bompiani, Milano 1959; La
psicanalisi, Garzanti, Milano 1960; Imoralisti moderni (co-curato da A.
Moravia), Garzanti, Milano 1960; Il Marchese di Sade, Le Opere, scelte
e presentate da E. Zolla, Longanesi, Milano 1961; Emily Dickinson,
SelectedPoems andLetters, a cura di E. Zolla, Mursia, Milano 1961; Volgarità e dolore, Bompiani, Milano 1962; I mistici dell'Occidente, Garzanti, Milano 1963; Le origini del trascendentalismo, Edizioni di Storia e
Letteratura, Roma 1963; Storia del fantasticare, Bompiani, Milano
1964; Herman Melville, Clarel, Prefazione e traduzione di E. Zolla,
Einaudi, Torino 1965; Nathaniel Hawthorne, Settimio Felton o l'elisir
di lunga vita, a cura di E. Zolla, Neri Pozza, Vicenza 1966; Le potenze
dell'anima, Bompiani, Milano 1968; Iletterati e lo sciamano, Bompiani,
Milano 1969; Che cos'è la tradizione, Bompiani, Milano 1971.
24. F. Kafka, Confessioni e immagini, Prefazione di E. Zolla, Mondadori,
Milano 1960; F. Scott Fitzgerald, L'età del jazz, Prefazione di E. Zolla, Il
Saggiatore, Milano 1960.
25. Cit. nella Nota 23.
Il passo ricorre in Che cos'è la tradizione, Bompiani, Milano 1971
(Adelphi 1998 e 2003), l'opera che chiude il ciclo degli scritti sociali
anti-moderni del primo periodo romano.
27. Introduzione a Imistici dell'Occidente, cit., pp. 1-96.
28. Nel paragrafo La mistica come iniziazione della Introduzione, Adelphi,
2 voli., Milano 1997, p. 26.
29. Dieci gradini verso la luce, «Corriere della Sera», 20 gennaio 1996.
30. In Com'era bello ilpeccato pagano, in occasione dell'uscita di Che cos'i la
tradizione, Bompiani, Milano 1971.
31. Thomas Mann, «Letterature moderne», n. 2, marzo-aprile 1953, II
paragrafo, pp. 149 s.
32. Invito all'esoeio, «La rivista di Estetica», anno II, maggio-agosto 1963.
33. Epifanie^. il titolo sotto il quale è raccolto l'ultimo gruppo di prose zolliane nella sezione omonima, Parte seconda. Si vedano in proposito la
Premessa e la Nota introduttiva alla detta sezione.
34. Per un nuovo illuminismo, «Elsinore», n. 8-9, settembre-ottobre 1964.
35. MNotal,p. 19.
26.
3 6 . Per un nuovo illuminismo, Arte e cultura nella civiltà contemporanea,
Quaderni di San Giorgio, 29, Sansoni, Firenze 1966.
37. Ivi, pp. 307 s. dove ricorrono i due passi precedenti a questo.
38. Ivi, p. 316.
39. Ivi, p. 324.
40. L'Istituto Accademico di Roma era sorto nel 1965 sotto la presidenza
dell'onorevole Pietro Campilli. Nel 1966 d'intesa con le Fondazioni
Olivetti e Giorgio Cini promosse il convegno internazionale sulle Fondazioni culturali che creò le premesse a una prima revisione delle norme
fiscali relative agli enti di cultura in Italia. Confinianaloghi a quelli dell'Istituto Accademico, era stata fondata in quegli anni l'Unione Italiana
per il Progresso della Cultura (U.I.P.C.) con sede in Piazza Campitelli.
41. Il Diccionario de símbolos tradicionales ¿i). E. Cirlot, l'Introduction au
monde des Symboles di G. de Champeaux e D. S. Sterckx o. s. b., Die
Welt der Symbole di D. Forstner e Inbild des Kosmos di P. Rech, ancora
inediti in Italia nel 1966.
42. «Antaios» diretta da Mircea Eliade e Ernst Jiinger, «Symbolon» diretta
da Benno Schwabe, e la serie dei XXXIV volumi degli «Eranos Jahrbücher» di C. G. Jung pubblicatifinoad allora.
43. Le circostanze favorevoli a realizzare l'allestimento del Dizionario dei
simboli non furono immediate e dovettero passare anni prima che il
progetto prendesse forma: in «Conoscenza religiosa», n. 2, 1977; nel
testo della voce Simbologia firmata da Zolla sull'Enciclopedia Italiana
Treccani nel 1982 (voi. VI), e nei lavori del Convegno «Numeri e
figure geometriche come base della simbologia», promosso da Zolla a
Roma al Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel giugno 1978. Gli Atti
sono nel fascicolo omonimo di «Conoscenza religiosa», n. 1-2, 1979.
44. Giorgio Diaz de Santillana: «Per un incontro tra umanesimo e scienza»
(30 giugno 1966); Jean Servier: «Aldilà dello scientismo» (26 maggio
1967); Hans Sedlmayr: «Architettura, semantica e simbolo» (1 luglio
1967) ; Mircea Eliade: «L'iniziazione ed il mondo moderno» (30 settembre 1967). Accanto a loro il linguista Giacomo Devoto sul tema «La
parola italiana» (17 marzo 1967); il filosofo Michele E Sciacca su:
«Verità e storia in Vico» (26 gennaio 1968) e lo storico Paolo Brezzi su:
«Il fatto storico cristiano nell'interpretazione di Vico» (8 maggio 1968).
45. Nella sezionefilosoficaintervennero Michele F. Sciacca: «Storicismo o
storicità dei valori?»; Sergio Cotta: «L'esperienza giuridica e i valori permanenti» e Augusto Del Noce: «Contestazione e valori». Nelle sezioni
scientifica e di scienze religiose, Giuseppe Moruzzi e Paolo Brezzi sui
temi: «Percezione visiva e simbologia» e «I valori religiosi nel divenire
storico»; e nella sezione estetica, Carlo Cassola e Diego Fabbri, rispettivamente su: «Cultura e poesia» e «Spirito creativo e simboli».
46. L'elenco completo dei relatori annovera Henri Baruk, John Epes
Brown, Herta von Dechend, Giorgio Diaz de Santillana, Germaine
Dieterlen, Gilbert Durand, Cari Philip Hentze, Marie E. P. Kònig,
Padre Cyrill von Korvin Krasinski, Thomas Molnar, Hector Alvarez
Murena, Seyyed Hossein Nasr, Marius Schneider, Christian Norbert
Schulz, Hans Sedlmayr, Jean Servier, Théophile Spoerri, Eric Voegelin, Wladimir Weidlé, Dominique Zahan.
47. I valori permanenti nel divenire storico, Istituto Accademico di Roma,
1969.
48. S.Weil, La connaissancesurnaturelle, Gallimard, Paris 1952.
49. Divenuta stigma di superbo isolamento, turris eburnea nel contesto
devozionale cristiano riferito a Maria Vergine, è all'origine immagine
di spontaneità e gioiosa accettazione del destino. Zolla lo precisa nel
dialogo con un giornalista collocato nella Parte seconda tra i brani di
Scritti sulfurei col titolo appunto La torre d'avorio. In Verità segrete esposte in evidenza (Marsilio, Venezia 1990), capitolo Esoterismo e fede,
Turris eburnea è «simbolo di scampata socialità, emblema di conoscenza religiosa che non subisce ma illumina ogni fede, massimo peri-
colo per ogni forza politica che miri alla Totalità». Si veda la voce omonima nel Lessico zolliano.
5 0 . Disprezzare il nostro tempo? Rispondono Elémire Zolla e Giorgio Vigolo,
«Corriere della Sera», 25 febbraio 1968. All'indomani della morte di
Giorgio Vigolo, eccellente traduttore di F. Hòlderlin (si veda il volume
delle Poesie con un saggio introduttivo, Einaudi, Torino 1958), Zolla
dedicava un articolo: La donna soprannaturale («Corriere della Sera»,
16 gennaio 1983) a La Virgilio, il romanzo di Vigolo che risale al 1921
(pubblicato dall'Editoriale Nuova nel 1983). Nella protagonista EZ
scorgeva i caratteri della donna-di-sogno che si accingeva a tratteggiare
ne L'amante invisibile (Marsilio, Venezia 1986).
51. Sono grata all'indologo Gian Giuseppe Filippi dell'Università Ca'
Foscari per l'utile scambio di vedute sull'argomento.
52. M. Perilli, Dialogo con Elémire Zolla, «AIUEO», n. 6,1998.
53. Titolare della cattedra di Letteratura angloamericana, tenne contemporaneamente l'insegnamento di Filologia germanica, avviando allo studio approfondito dei testi primari dell'antica letteratura scandinava laureandi che poi si rivelarono studiosi di grande talento, come nel caso
della scandinavista Gianna Chiesa Isnardi. In quattro anni di intensissima attività didattica e diricerca,Zolla costruì da zero una scuola di
giovani specialisti in letterature comparate e culturalstudies mettendoli
in grado di affrontare con rigorefilologicoe intelligenza ermeneutica
temi unificanti e complessi come quello del «Superuomo e i suoi simboli nelle letterature moderne» su cui Zolla scriveva in L'equivocazione
deliberata e l'idea di superuomo, «Settanta», anno V, settembre-dicembre
1974. Il progetto fece capo a sei volumi pubblicati da La Nuova Italia,
Firenze, tra il 1971 e il 1979. Sul magistero zolliano all'Università di
Genova si veda il saggio di Angelica Palumbo, Elémire Zolla: l'iniziazione allaricerca,«Studi Europei». Annali del Dipartimento di Studi
sulla Storia del Pensiero Europeo «Michele Federico Sciacca», Università di Genova, Leo S. Olschki, Firenze, X, 2002. Anche le riflessioni di
Pier P. Ottonello in La realtà dei simboli, «Nuova Antologia», n. 2016,
dicembre 1968 e nell'opera Ontologia e mistica, Marsilio, Venezia 2002.
54. I testifirmatie siglati da Zolla su «Conoscenza religiosa» tornano ad
essere disponibili nel volume E. Zolla, Conoscenza religiosa. Scritti 19691983, cit.
55. Sullaricezionecritica della rivista nella stampa nazionale, si veda la mia
Introduzione al volume citato alla Nota precedente.
56. Negli anni successivi altri testi di Cristina Campo impreziosirono i
fascicoli della rivista. Nel n. 1,1977, in mone di lei, EZ pubblicava lo
stupendo Diario bizantino e altre poesie.
57. Tra gli intellettuali cattolici che misero in guardia sui pericoli di sincretismo, gnosticismo e aristocraticismo insiti nella visione religiosa zolliana, è da annoverare accanto a Sergio Quinzio, Vittorio Messori. Si
veda l'intervista a EZ: Più che il Gesù della storia mi interessa il Cristo del
mito, «Jesus», maggio 1984 e nel volume Inchiesta sul Cristianesimo,
Mondadori, Milano 1987.
Tra il 1966 e il 1967 Zolla fu in prima linea nel contestare lo spirito e la lettera delleriformedeliberate dal Concilio Ecumenico Vaticano II in materia di liturgia e soppressione del latino (si vedano gli articoli ne «La Fiera
letteraria», 10 febbraio e 31 marzo 1966), e l'«adeguamento» della Chiesa
ai nuovi tempi (nei componimenti La visione dello storico delfuturo e II
neolassismo conciliare collocati negli Scritti sulfurei, Parte seconda).
Una infuocata polemica in materia, sulla quale nel giugno 1966 intervenne a favore delle posizioni conservatrici di Zolla Monsignor Domenico Celada, allora direttore della rivista della Cappella Musicale Pontificia, fu quella che oppose Zolla a Adriana Zarri, ampiamente riferita
su «La Fiera letteraria». Il 16 febbraio 1967 una tavola rotonda sulla
«Cultura dopo il Concilio» promossa dall'Unione Italiana per il Progresso della Cultura metteva a confronto l'intransigenza di Zolla con le
posizioni più morbide di Arturo Carlo Jemolo e Sergio Cotta. Ne riferiva ampiamente Gino de Sanctis in Pluralismo culturale, Quaderni
dell'U.I.P.C., 17,1967. Le interfacce del problema «Zolla e la materia
religiosa» andrebbero affrontate separatamente col concorso collegiale
di storici, teologi ed esperti di cristianesimo e religioni non cristiane.
58. Ne La verità in uno stile, «Corriere della Sera», 15 novembre 1987,
Zolla menzionava due pezzi di Cristina Campo apparsi su «Il Giornale
d'Italia» con lo pseudonimo di Trevisano nel corso del 1966, ossia La
silenziosa isola della Trappa e l'elzeviro sul Martyr de Saint Sébastien di
G. D'Annunzio, di cui era pubblicato uno stralcio a fianco della recensione a Gli imperdonabili, Adelphi, Milano 1987.
59. Un'edizione abbastanza recente dell' Opera chimica di Bernardo Trevisano è pubblicata a Parigi da Guy Trédaniel, Editions de la Maisnie,
1976. Minute notizie su Bernardo, qui semplificate allo stremo, erano
fornite dal compianto amico Paolo Lucarelli, l'alchimista e storico dell'alchimia improvvisamente deceduto nel 2005.
60. Il sincretismofiorentinodel Quattrocento, il saggio pubblicato su
«Nuova Antologia», n. 2188, ottobre-dicembre 1993, è uno dei testi
fondamentali per accostare la dimensione sincretista e metafisica del
pensiero di EZ.
61. A René Guénon era dedicato Benvenuti nell'arca dell'inconscio, l'ultimo
articolo di Zolla pubblicato sul Domenicale de «Il Sole 24 ore» il 2 giugno 2002 nella stessa pagina in cui era annunciata la morte dello scrittore e ne scriveva, brevemente, Giulio Busi.
62. Le potenze dell'anima, Bompiani, Milano 1968, p. 53.
63. Si veda Nota 3 relativa al capitolo 2.
64. Si veda Nota 2 relativa al capitolo 2.
65. I due maggiori progetti di ricerca nei quali, come a Genova, Zolla coinvolse un gruppo di giovani studiosi attivi presso la sua cattedra dal
1975, furono un'enciclopedia sulla letteratura del Novecento Americano: I Contemporanei, 3 voli., Lucarini, Roma 1981 -1983, e una vasta
ricerca di taglio comparativo sul tema: L'esotismo nella letteratura
angloamericana, di cui l'editore Lucarini a Roma pubblicò tre volumi
( 1981 -1982) e Liguori a Napoli il quarto, nel 1987.
66. Dalla Prefazione, pp. 9 s. della ristampa Marsilio, Venezia 2005.
67. P. Florenskij, La colonna e ilfondamentodella verità, II Lettera: Il dubbio, trad. it, Rusconi, Milano 1974.
68. Il passo ricorre alla p. 21 (Adelphi 2002). Nel 1998, la prima ristampa
Adelphi sollecitava Umberto Galimberti a riflettere negativamente sulla
sua utilità in La tradizione inutile di Elémire Zolla, «La Repubblica», 26
marzo 1986. A proposito della metafora dell'uomo-carpa il filosofo
scriveva: «[...] La storia non è una faccenda di carpe, è una faccenda di
uomini. Gliela vogliamo lasciare agli uomini la storia invece che alla
"pietra posata al centro dello specchio d'acqua" intorno a cui girano le
carpe?». E proseguiva sostenendo che se oggi la civiltà della critica «pare
estinta», ciò non è accaduto «per merito della Tradizione e neppure per
colpa degli intellettuali, ma perché nella storia prepotente si è affacciato
quello che Emanuele Severino chiama "il convitato di pietra", che non è
la pietra intorno a cui girano le carpe, ma la tecnica [...]». «Ripubblicare
nel 1998 Che cos'è La tradizione— concludeva il professor Galimberti significa allora rieditare un libro non solo inutile per le ragioni che
abbiamo cercato di esporre, ma un libro che non coglie neppure lontanamente nel segno il senso del nostro tempo che è sempre meno tempo
dell'uomo.» Sarebbe fàcile replicare, utilizzando gli stessi argomenti del
recensore, che la metafora della carpa si addice proprio a illustrare il caso
dell'attrazione irresistibile dell'uomo novecentesco per il «convitato di
pietra»: la tecnica; e quanto al concetto di «uomo», anche senza spingersi a definirlo alla maniera di EZ (si veda la voce nel Lessico zolliano),
esso si prospetta assai meno granitico di quanto Galimberti sembra dare
per scontato, se non «prematuro» addirittura!
69. Lafilosofiaperenne, Mondadori, Milano 1999, p. 10.
70. Il sincretismo è ripubblicato nel volume E. Zolla, Conoscenza religiosa.
Scritti 1969-1983, cit. Sullo stesso tema si veda il primo capitolo di
Verità segrete esposte in evidenza, cit.
71. Gli antichi testi delle mitologie e cosmogonie islandesi e norvegesi.
72.
Verità segrete esposte in evidenza, nel capitolo Esoterismo efede a p. 154
della ristampa Marsilio 2003.
73. Si veda G. Marchiani», a cura di, La religione della terra, Introduzione,
Red, Como 1991.
74. E. Lombardo, Elémire Zolla e la fuga perfetta, «La Nuova critica», I-II,
1972.
75. Introduzione a W. I. Thompson, All'orlo della storia, trad. it., Rusconi,
Milano 1972.
76. Noi stregatiper sempre dall'incubo ¿#Moby Dick, «Corriere della Sera»,
27 settembre 1991.
77. Uscite dal mondo, Adelphi, Milano 1992, sezione Dalla Russia.
78. Ore elette, «Corriere della Sera», 29 novembre 1975.
79. Dai Taccuini di viaggio: Iran, 1976. Il passo è tratto dal secondo brano
citato in In Iran tra isufi (Nuove terre cieli nuovi, Parte seconda).
4. Esodi
1. La linguistica e il sacro, fascicolo speciale, «Conoscenza religiosa», n. 1-2,
1972. Disponibile in E. Zolla, Conoscenza religiosa. Scritti 1969-1983,
cit. Gli esiti della ricerca sulla linguistica e il sacro erano illustrati altresì
ne II sacro e il linguaggio, «Incontri culturali», Roma, n. 17,1972.
2. La prima versione di Le rune e lo zodiaco, rielaborata in Uscite dal
mondo, uscì in «Conoscenza religiosa», n. 2,1969 e si può ora rileggere
in E. Zolla, Conoscenza religiosa. Scritti 1969-1983, cit. La versione
inglese, The Runes and the Zodiac era pubblicata in «Sophia Perennis»,
II, 2, Teheran 1976, Kraus-Nedeln, Liechtenstein, e successivamente
in «Celtic Dawn», nn. 3,4,1989, Thame, Oxford.
3. Yoga Upanisad, fascicolo speciale, «Conoscenza religiosa», n. 1, 1973.
In E. Zolla, Conoscenza religiosa. Scritti 1969-1983, cit.
4. La biblioteca zolliana a Montepulciano consiste in qualche migliaio di
volumi che abbracciano tutti i campi di studio dello scrittore. Vi si scorgono le sue predilezioni per la linguistica, l'etnologia, la mistica, le religioni mondiali: la cristiana e l'ebraica in particolare, le letterature e le
filosofie di Oriente e Occidente, l'iconografia artistica e la simbologia,
l'esoterismo, l'alchimia, la medicina e la farmacopea tradizionali e un
gran numero di trattati di patologia e psichiatria. Rari i pezzi d'antiquariato non rappresentando per lui oggetti da collezione.
5. The Writer and the Shaman. A Morphology of the American Indian
usciva da Harcourt Brace Jovanovich, New York 1973 per la traduzione di R Rosenthal (già autore della versione dell 'Eclissi dell'intellettuale, Funk & Wagnalls, New York 1968). Nel 1974 il Book Review
Digest dava conto dell'ingente numero di recensioni tra le quali quella
di Vine Deloria Jr. sul «Boston Sunday Herald Advertiser» (2 marzo
1974); di A. H. De Rosier, «Annual of American Academies», luglio
1974; di Guy Davenport nell'opera The Geography of Imagination,
1981; di Peter Nabokov, «New York Review of Books», 27 settembre
1984. Si veda in proposito la voce «Elémire Zolla» a cura di G. Marchianò, in Encyclopedia of Religion, a cura di Lindsay Jones, Macmillan,
New York, voi. 14, pp. 9984-9987.
6. Si veda Nota precedente.
7. I. P. Culianu, The Construction of the Other, «History of Religions», vol.
30, n. 3, 1991. Ulteriori osservazioni su I letterati e lo sciamano ricorrono nella recensione di Culianu a Verità segrete esposte in evidenza,
«Incognita», vol. 1,2 1990.
8. Per non risalire a quanto se ne scrisse al tempo della prima edizione,
basta limitarsi alle riflessioni dell'americanista Fernanda Pivano sulla
ristampa dell'opera, Indiani d'America, cultura respinta, «Corriere della
Sera», 30 aprile 1989. Esse toccano la condanna di Zolla dell'atteggiamento del Bianco americano verso l'indigeno e l'apologia dell'opera di
Castañeda ma non i motivi di fondo che suggerivano a Culianu di
vedere giustamente all'opera, nell'approccio di Zolla con la otherness,
l'intelletto d'amore. Sull'apertura all'intelletto d'amore il rinvio
opportuno è al capitolo omonimo di La nube del telaio, Mondadori,
Milano 1996. Più vicino alla chiave interpretativa di Culianu si
mostrava Hervé Cavallera nell'articolo su I letterati e lo sciamano, in
«Problemi della pedagogia», nn. 4-5,1989.
9. Di questo aspetto del lascito zolliano, oltre a quanto indicato alla Nota
53 relativa al capitolo 3, tratta in esteso Fedora Giordano dell'Università di Torino in: Zolla e gli Indiani d'America, Atti del Convegno Gli
orienti del pensiero di Elémire Zolla: 1926-2002, Centro Pannunzio,
Torino, 16 novembre 2002, pubblicati in Elémire Zolla dalla morte alla
vita, «Viator», cit. Sull'edizione aggiornata de Iletterati e lo sciamano, F.
Giordano riferiva in La vittoria dello stregone, «L'informatore librario»,
n. 3, marzo 1979.
10. Vale la pena di citare: Arte popolare, uscito in «Itinerari», Genova, n. 13,
giugno 1955, dove sono prefigurati alcuni temi di fondo dell' Eclissi dell'intellettuale, allora vicino a vedere la luce, e Cantipopolaripiemontesi, in
«Letteratura», Roma, n. 29, settembre-ottobre 1957. Nel recensire la
raccolta omonima pubblicata da Einaudi e introdotta da G. Cocchiaia,
il giovane Zolla si concedeva sull'indole piemontese annotazioni deliziose. Ad esempio: «La rassegnazione è certamente l'operazione psicologica repressiva fondamentale che sta dietro al cantore popolare piemontese, una rassegnazione cupa, di stampo quasi germanico, che scorge dietro ogni manifestazione di vita l'ombra del patibolo, che vive sotto l'incubo dellagiustissia [...]. Un popolo sempre oppresso dalle guerre, dalla
coscrizione, non sa incantarsi allo spettacolo della vita, e i suoi radi
incanti subiscono una deformazione, saranno sentimentalistici (così
tutta contaminata da un senso di doveroso vincolo coniugale, non disperata veramente, ma lacrimosa è la chiusa della Bela Cecilia che datasi
invano al capitano per salvare il marito condannato, rifiuta l'offerta di
matrimonio del boja d'Imi mari)». E più oltre: «Nelle lezioni piemontesi è insistita la scena quasi gioiosa della fucilazione ed è aggiunto il
tratto cannibalico che anche in altri canti militari si fa sentire [...]: l'assurdità di una condizione disumana viene vinta regredendo alle immagini antichissime dei sacrifìci cannibalici che davano un valore sovrannaturale all'olocausto [...]». «La fantasia piemontese quando s'accende» si
legge poco dopo «non ha limiti di verosimiglianza (basti pensare al più
popolare romanzo dell'Ottocento piemontese, Don Pipita l'asilé, che
s'impernia su questa folle trovata: l'osteria di don Pipéta viene chiusa perché vi si tengono discorsi poco devoti; don Pipéta torna dopo anni e anni
dalla Francia, e intanto nella sua bottega il vino è diventato aceto, sicché
egli si mette a far l'acetaio).» E conclude: «Quando il Piemonte fu investito dai lumi, non a caso la sua più lucida mente, il conte Radicati di Passerano ne fu. abbacinato e nell'esilio londinese scrisse la Philosophical Dissertation upon Death, dove conduceva la sua critica liberatrice addirittura
all'esaltazione del suicidio; lumeggiava il cuore segreto del suo popolo».
11. Il calumet, «Il Giornale d'Italia», 18 aprile 1966. Il passo di Benjamin
Franklin è tratto dall'opera di F. Schuon Hehaka Sapa (Payot, Paris
1954) alla quale Trevisano rinvia.
12. Parenti ai tropici, «Corriere della Sera», 29 marzo 1970.
13. Il testo fondamentale sulla cosmogonia dogon di M. Griaule è Dio d'acqua, uscito a Parigi nel 1966, capofila delle ricerche sul campo di G. Dieterlen, G. Calame-Griaule e altri africanisti della scuola griauliana. Fu
tradotto da Garzanti nel 1972. Su «Conoscenza religiosa», n. 1, 1969
Zolla pubblicava il saggio di Griaule: Conoscenza dell'uomo negro.
1 4 . Parenti ai tropici, cit.
15. Il saggio era pubblicato con lievi modifiche nel capitolo 1 di
segrete esposte in evidenza, cit.
Verità
16. Nella corrispondenza intercorsa con Giampiero Comolli: A proposito
¿/'Uscite dal mondo, «Aut Aut», n. 250, luglio-agosto 1992, esaminata
più avand nel capitolo La mente naturale.
17. Si veda capitolo 6, paragrafo 3.
5. Esodi nell' altrove: il destino e lo zodiaco
1. Un'altra Persia, «Corriere della Sera», 5 marzo 1975.
2. Salvo casi specificamente indicati, i passi di EZ citati in questo capitolo, attingono al fondo dei taccuini manoscritti dai quali lo scrittore
trasse materia per articoli e pubblicazioni.
3. Nota 2 del paragrafo La mediazione deve essere impossibile, p. 55 della
riedizione Adelphi 1997, voi. I.
4. Leggi l'anima nel cielo, «Sette», 4 ottobre 1980. Si veda La nube del
telaio, Mondadori 1996, capitolo IV.
5. Il cielo scrìtto, «FMR», n. 19,1982.
6. Introduzione a G. Maria Sesti, Le dimore del cielo. Archeologia e mito
delle costellazioni, Novecento, Palermo 1987.
7. Cercare il cielo, Allemandi, Torino 1994. Testi di P. L. Bassignana, C.
Frugoni, Plinio, G. Ravasi, E. Zolla.
8. Leggi l'anima nel cielo, cit.
9. Mitobiografia, a cura di H. Erba-Tissot (trad. it., Adelphi, Milano
1969), ricostruisce l'opera clinica di E. Bernhard attraverso i quaderni
e gli appunti da lui dettati ad amici e allievi.
10. Terapia perpsiche, «Corriere della Sera», 5 novembre 1969.
11. Tarocchi, specchio magico del mondo, «Corriere della Sera», s.d.
12. Il destino e lafortuna, «Gazzetta del Popolo», 27 marzo 1962.
13. Ibidem.
14. Melville e l'abbandono dello zodiaco, in Scritti zodiacali, Parte seconda.
15. In «Il Dramma», 9 settembre 1970.
16. Dai Taccuini preparatori ad Archetipi, trad. it., Marsilio, Venezia 1988.
1 7 . Leggi l'anima nel cielo, cit.
18. Introduzione a G. M. Sesti, Le dimore del cielo, cit.
19. Dai Taccuini.
20. L'attenzione di Zolla all'opera di Marius Schneider (1903-1982) è
stata ininterrotta e colma di frutti. Nel recensire sul «Corriere della
Sera» (23 agosto 1976) Pietre che cantano (trad. it., Arché, 1976), un
testo fondamentale accanto a II significato della musica (Rusconi
1970), che Zolla introdusse e in parte tradusse sotto lo pseudonimo di
Bernardo Trevisano, lo scrittore affermava: «Rari sono i libri che possono cambiare la vita di chi li legge, questo è uno di essi. Chi sappia
cavarne tutte le deduzioni, vede in modo nuovo la storia, ascolta altrimenti i suoni della natura e la musica, guarda diversamente le cose.
Intanto le guarda con l'orecchio: impara a coglierne il ritmo, la vibrazione essenziale [...]». Alla morte dell'etnomusicologo tedesco, Zolla
accoglieva nel n. 1, 1983 di «Conoscenza religiosa» limito del mondo
primordiale e l'armonia delle sfere, ultimo dellafittaserie di saggi ospitati sulla rivista dai primi anni Settanta. Il loro elenco è negli Indici a
cura di M. Canale di E. Zolla, Conoscenza religiosa. Scritti 1969-1983,
cit. Gli studi di Schneider sulle ninnenanne iberiche risalgono al
periodo delle ricerche folkloriche in Spagna negli anni Quaranta
donde sorti il trattato fondamentale El origen musical de los animales
simbolos en la mitologiay la escultura antiguas (tiad. it., Adelphi 1986).
21. Dai Taccuini.
22. Virtù dell'attenzione, «Gazzetta del Popolo», Torino, 20 luglio 1960.
23. Introduzione a Imistici dell'Occidente, cit.
24. Noi stregati per sempre dall'incubo di Moby Dick, cit.
2 5 . Melville e l'abbandono dello zodiaco, cit.
6. L'approdo: i lembi si congiungono
1. L'elisir i n II fenomeno religioso oggi: Tradizione, mutamento, negazione, a
cura di R. Cipriani e G. Mura, Urbaniana University Press, 2002.
Anche in «Euntes Docete», LIV/2, nuova serie 2001.
2. Si veda Solo ilpittore vince la morte in Epifanie, Parte seconda.
3. G. Santambrogio, A chi porre le domande ultime, «II Sole 24 ore», Speciale 2000, p. VIII.
4. I premi Città di Roma, Ascoli Piceno, Isola d'Elba e Mircea Eliade alla
fine degli anni Ottanta; e con sua sorpresa il titolo di Grande Ufficiale
al merito della Repubblica sotto la presidenza di Luigi Scalfaro nel giugno del 1996.
5.
Un anatema che mifa onore, «Corriere della Sera», 30 aprile 1993.
6. Ibidem.
7. Archetypes, Alien & Unwin, London, Harcourt Brace Jovanovich, New
York 1981; trad. sp. Monte Avila, Caracas 1983; trad. giapp. Hosei
University Press, Tokyo 1985. La Prefazione di Zolla all'edizione giapponese compare nella ristampa Marsilio del 1988. The Androgyne,
Thames & Hudson, London 1981, Cross Road, New York 1982; trad.
giapp. Heibonsha Publishers, Tokyo 1988; trad. sp. Debate, Madrid
1990.
8. Una recensione di Aure afirmadi Masolino d'Amico, compariva su
«The Times Literary Supplement», 13 marzo 1987. Trad. sp. a cura di
V. Gomez i Oliver, Paidós, Barcelona 1997.
9. Due capitoli della versione originale inglese sono rispettivamente pubblicati in «New Observations», New York, n. 64, gennaio-febbraio
1989, e in «Seshat», Studies in memory ofElémire Zolla, London, n. 6,
Spring 2003.
10. G. Marchianò, Nota al testo, L'amante invisibile, Marsilio, Venezia
2003.
11. In un appunto a mano si legge: «Nella logica indiana l'analogia è esplicita perché essa si propone la liberazione dall'errore teoretico come premessa dell'esperienza metafisica, e in tal caso è piti prossima alla logica
stoica che all'aristotelica».
12. Si trattò del primo dottorato in Scienze letterarie (Letterature comparate) avviato in Italia, e Zolla ne fu uno degli ideatori. Tra i giovani
addottorati sotto la sua diretta guida si distinsero la sanscritista Vincenzina Mazzarino e la germanista Eleonora La Velia. Le loro memorie
sull'insegnamento ricevuto da EZ sono in Elémire Zolla dalla morte
alla vita, cit., sezione Testimonianze accanto a quelle di Lidia Valli, laureatasi con Zolla, e dei professori Nuccio d'Anna e Fabrizio Frigerio,
che seguirono i corsi diretti da EZ all'Istituto Ticinese di Alti Studi a
Lugano (1970-1973).
13. Si veda la mia Introduzione a E. Zolla, Conoscenza religiosa. Scritti 19691983, cit.
14. Si intitola Benvenuti nell'arca dell'inconscio, e Zolla vi recensiva la raccolta di appunti di René Guénon, a cura di A. Grossato, «Il Sole 24
ore», 2 giugno 2002.
15. Brhadàranyakà Upanisad, Seconda lettura, IV, in Upanisad antiche e
medie, a cura di P. Filippani-Ronconi, Boringheri, Torino 1960.
16. Lafilosofiaperenne, Mondadori, Milano 1999.
17. Di «Incognita. International Journal for Cognitive Studies in the
Humanities», pubblicata da Brill, Leida, uscirono quattro fascicoli: 1,
e I, 1 1990, e II, 1 e II, 2, 1991, prima dell'assassinio del professor
Culianu all'Università di Chicago il 21 maggio 1991. Tra i membri del
Comitato d'onore della rivista accanto a Elémire Zolla, Moshe Idei,
Edgar Morin, Alien G. Debus, Jacques Le Goff, Michel Meslin e tra i
membri del Comitato scientifico di cui mi onoro di aver fatto parte,
Lawrence E. Sullivan, Gherardo Gnoli, Elizabeth Fox Genovese e Ithamar Grunewald.
18. Si rinvia a Eros e magia nel Rinascimento, l'opera che usciva in italiano
nel 1987 con una prefazione di Mircea Eliade (Il Saggiatore, Milano).
Tra gli specialisti in Italia dell'opera di Culianu si annovera Roberta
Moretti alla quale si devono indagini che inquadrano le concezioni sul
mito e la storia dello studioso rumeno e la sua produzione narrativa. Si
veda R Moretti, I. P. Culianu e il «Linguaggio della creazione», «Viator», anno VII, 2003; La conferenza di Assisi su Mircea Eliade, Progetto
editoriale sulla vita e l'opera dil. P, Culianu, «Viator», anno Vili, 2004;
e il saggio I. P. Culianu storico delle idee: esempi di metodologia ermeneutica i n Religion, Fiction, and History: Essays in Memory ofIoan Petru
Culianu, voli. 2, Nemira, Bucarest 2001, l'opera a cura dello storico
rumeno Sorin Antohi che contiene un rendiconto mondiale di culianistica con i contributi degli italiani Casadio, Eco, Filoramo, Marchiani)
e Zolla.
19. Storia dell'eternità'm]. L. Borges, Tutte le opere, a cura di D. Porzio, voi.
I, Mondadori, Milano 1984.
20.1. P. Culianu, Iter in silvis. Saggi sulla gnosi e altri studi, acura di G. Sfameni Gasparro, Edizioni Sfameni, Messina 1981.
21. R Pierantoni, Fermate il mondo, voglio scendere, «Leggere», n. 64, ottobre 1994. Nel prendere di mira l'opera zolliana Lo stupore infantile,
uscita da Adelphi quell'anno, ilfisiologosi produce in una beffarda
filippica contro lo scrittore, colma di facezie e di scoperti attacchi perfino alla sua attendibilità di studioso.
22. Nel corso di una conversazione con Giorgio Israel su mito e razionalità,
a cura di G. Lelli sulla rivista «Prometeo».
2 3 . I n Fanciulli della mente: l'avvenire dell'intelligenza robotica e umana,
Harvard University Press 1991. Lo scienziato era allora responsabile
del Mobile Robot Laboratory della Carnegie Mellon University, USA.
2 4 . Uscite dal mondo, cit.
25. Nell'articolo Come si fabbrica una mente eroica: Amosov, Aristotele e i
cervelli artificiali {«Corriere della Sera», 30 ottobre 1979), EZ rifletteva
sugli orizzonti dischiusi dalla robotica in anni ancora lontani dalle diatribe sulla realtà virtuale.
26. Il riferimento è al progetto di ricerca diretto da Zolla all'Università di
Genova (si veda la Nota 53 relativa al capitolo 3). Sull'opera in sei
volumi riferiva Claudio Gorlier in II superuomo non ha tempo, <La
Stampa», 6 luglio 1977.
27. K5bò Daishi, il fondatore della linea shingon del buddhismo giapponese nell'VIII secolo.
28. La filosofia perenne, Mondadori, Milano 1999, capitolo Fib^ofia
perenne, stato naturale della mente.
29. La sapienza greca, a cura di G. Colli, 3 voli., Adelphi, Milano 1977-78 80.
30. Verso la sapienza negata ai moderni, «Corriere della Sera», 20 novembre
1977.
31. Detti e fatti dei Padri del deserto, a cura di C. Campo e P. Draghi,
Rusconi, Milano 1975.
32. Archetipi, trad. it., Marsilio, Venezia 1988 e successive edizioni.
33. Il brano si può ora rileggere in E. Zolla, Conoscenza religiosa. Scritti 19691983, cit
34. Le tre vie, Adelphi, Milano 1995, pp. 26 s.
35. Dio vestito della natura, «Corriere della Sera», 26 agosto 1990. Ccnfluito nel capitolo L'ideale religioso, Uscite dal mondo, cit.
36. Dai taccuini preparatori a Uscite dal mondo.
37. Introduzione a Mircea Eliade, Lo Yoga. Immortalità e libertà, RC.S.
Sansoni, Milanol995. Si veda anche Lafilosofìaperenne, cit., p. 140.
38. Lafiguramitica di Dioniso dall'antichità a oggr. Introduzione a lidio
dell'ebbrezza. Antologia dei moderni dionisiaci, Einaudi, Torino 1998.
39. Ricordo in particolare il suo intervento: In memoria di Elémire Zolla
alla trasmissione Uomini e profeti condotta da Gabriella Caramore,
Radio 3,1 giugno 2002.
40. G. Comolli, A proposito di Uscite dal mondo, «Aut Aut», n. 250,
luglio-agosto 1992, pp. 87-92. Alle pp. 92-96 seguiva la risposta di
Zolla.
41. Presso Thames & Hudson e Harcourt Brace Jovanovich rispettivamente.
42. Divenuto monaco buddhista nella linea del «Piccolo Veicolo» col
nome di Anagarika Govinda, lo studioso tedesco peregrinò nei luoghi
spirituali himalayani svolgendo importanti ricerche sull'iconografìa
templare di cui riferiva ne La via delle nuvole bianche: un buddhista in
Tibet; trad. it., Ubaldini, Romal981.
43. L'affermazione ricorre nella risposta di Zolla a G. Comolli. Si veda Nota
40.
44. Nagàrjuna, Lo sterminio degli errori, a cura di A. Sironi, Introduzione di
R. Gnoli, Rizzoli, Milano 1992. Attilia Sironi, che ha tradotto le stanze
del Màdhyamakakàrikà da cui è tratto il passo citato, osserva che
Nagàrjuna, dialogando con un oppositore, risponde alle sue obiezioni
sostenendo la vacuità della propria enunciazione ma facendo salva l'efficacia logica di negare che una cosa vuota (l'uomo artificiale) ne nega
un'altra ugualmente vuota (il secondo uomo artificiale o magico).
45. In E. Zolla, Conoscenza religiosa. Scritti 1969-1983, cit.
4 6 . Ibidem.
47. Il Marchese di Sade, Le Opere, cit.
48. Il caso è illustrato ne Lafilosofiaperenne, cit., pp. 60 s.
49. Il passo ricorre in Che cos'è la tradizione, ristampa Adelphi, Milano
2003.
50. Pittori a Torino, «Gazzetta del Popolo», 4 ottobre 1961. In un articolo
precedente: La pittura e il nulla (28 maggio 1960) a proposito del saggio del pittore spagnolo Ramón Gaya pubblicato nei Quaderni dipensiero e di poesia diretti da Elena Croce e Maria Zambrano (Editore De
Luca, Roma), Zolla affermava: «Pittore è colui che si dispone a cogliere
rapporti esatti su una tela, e nuli'altro si propone se non di non essere
personale [...]. L'arte è destino, e il giorno che si arriverà a comprenderlo [...] ci si renderà conto che in quanto destino non possiamo
costruirla, e neppure farla, ma soltanto ascoltarla e compierla [...]».
5 1 . Ibidem.
52.
Verità segrete esposte in evidenza,
tismo, cit.
capitolo Monumenti italiani al sincre-
Parte seconda
Scritti di quattro stagioni
Premessa
Non condivido, osservo.
Postfazione a Kadri Karaosmano|lu, NurBaba
Questa antologia di scritti solca quattro stagioni della vita di Elémire Zolla, stagioni che approssimativamente coincidono con i
periodi presi in esame in Sprazzi di una biografia scancellata-, gli
anni di formazione a Torino, le battaglie intellettuali nel primo
periodo romano e gli esodi fuori dell'Occidente, la partenza da
Roma nel 1991 e l'approdo a Montepulciano.
Di un'opera sistematica e occasionale foltissima che si stende
dagli anni Quaranta del Novecento fino al 2002, e annovera due
romanzi: Minuetto all'inferno e Cecilia o la disattenzione e una dozzina di racconti, una selezione come questa - attinta a saggi, articoli, elzeviri, interventi in pubblico, prefazioni e commenti a
opere di altri autori - non può che offrire un'immagine incompleta, non però inattendibile. Infatti è nel modulo del testo breve
o di media lunghezza, levigato con cura ma scritto a volte di getto,
da giornalista, mentre il tempo sta per scadere, che trapelano i
tratti di un letterato immerso nel proprio tempo, però perfettamente in grado di estraniarsene, di un uomo che, morendo, si è
portato con sé il segreto di cui ragionava von Hofmannsthal nell'esergo citato all'inizio di questo libro: «come a lui, proprio a lui sia stato possibile, in senso spirituale vivere».
201
I testi sono distribuiti in sei gruppi tematici e li precede una
breve illustrazione.
La prima sezione accoglie cinque saggi letterari composti tra
il 1947 e il 1960. Una scelta calcolata giacché mette in evidenza
dello scrittore immerso nel pelago della letteratura moderna
europea attrazioni e ripulse estetiche ed etiche, categoriche, in
una oscillazione inquieta tra la padronanza dell'esercizio critico
e l'immersione stregata nei mondi mentali degli autori accostati — in questo caso la triade Kafka, Joyce, Pasternak - con l'atteggiamento del giovane meditabondo descritto in una pagina
di Volgarità e dolore: «siede sul ciglio d'un fosso, guarda dei colli
sotto la volta del cielo. Nella sua stanza gli accade poi di ricordare ciò che ha visto e le parole gli si formano secondo un ritmo
cosi imperioso da chiedere di essere trascritte».
La seconda sezione raduna saggi e articoli in ordine sparso del
primo e del secondo periodo romano, volendo porre uno spartiacque tra l'età delle battaglie intellettuali e quella degli esodi
fuori dell'Occidente all'epoca della stesura dell'ultima delle sette
opere pubblicate da Bompiani: Le meraviglie della natura. Introduzione all'alchimia. La Nota introduttiva spiega perché questi
scritti sono definiti «sulfurei» e se occorressero chiarimenti ulteriori li dispensa a piene mani l'apologo attinto a una storiella di G.
I. Gurdjieff, citata da EZ recensendo l'autobiografìa del maestro
armeno:
C'era una volta un mago che possedeva un gregge di pecorelle. Gli
piaceva la carne d'agnello e ogni tanto ne macellava una. Per impedire le fughe, decise di ipnotizzare il gregge e immergendolo nel
sonno ipnotico inculcò tre convinzioni: che le pecore sono immortali, sicché non debbono temere la macellazione, che è anzi un modo
di andare difilatonell'eternità; che egli era un buon pastore che sopra
ogni cosa amava le sue pecorelle; che esse inoltre non erano pecore
ma quali leoni, quali aquile, quali uomini, quali addirittura maghi.
II gregge aspettò tranquillo la macellazione da allora in poi.*
* Una vita d'incontri straordinari, «Corriere della Sera», 29 giugno 1977.
202
Il terzo gruppo: Nuove terre cieli nuovi documenta l'apertura di
orizzonti conoscitivi, l'incontro amoroso di Zolla col «diverso»
etnologico e religioso nei suoi viaggi in quattro continenti tra il
1968 e il 2000. Sono articoli, porzioni di saggi e componimenti
che si assaporano di pari passo alla lettura di Esodi (Parte prima).
Lo stesso vale per il gruppo di Scritti zodiacali che è simmetrico a
Esodi
altrove: il destino e lo zodiaco. Al vasto saggio sul Moby
Dick di Melville, che risale al 1960, sono accostati articoli posteriori firmati o siglati da Bernardo Trevisano, il doppio ermeticoletterario di EZ nel periodo in cui collaborò al quotidiano romano «Il Giornale d'Italia».
Gli Appunti sul futuro risalgono agli anni Novanta e ruotano attorno al tema che provocò al tempo infuocati dibattiti: le implicazioni, temibili o desiderabili, di una corporeità sostituibile nella
realtà virtuale.
L'ultima sezione, Epifanie, accoglie prose che nei contenuti e
soprattutto nel timbro suonano agli antipodi degli Scritti sulfurei,
tanto da far pensare a due autori senza rapporto l'uno con l'altro.
Ma se si scava nel profondo di ciò che è detto, ci si accorge che i
due fanno capo a una sola mente inerpicata verso la luce.
Saggi letterari
In una mente meditativa e curiosa le tante
letture non ricadono inerti e ammucchiate,
ma si connettono orchestrandosi, creando a
poco a poco: la letteratura.
D a i Taccuini
Nota introduttiva
Le pagine riunite nel primo saggio II vero se stesso sono tratte dalla
Parte seconda della prima opera in volume di Zolla ventunenne,
quei Saggi di etica e di estetica pubblicati nelle Edizioni Spaziani a
Torino nel 1947, commentati con favore da lettori eccellenti
come Francesco Flora e Benedetto Croce ma passati inosservati al
vasto pubblico.
Joyce e la moderna apocalisse, che è del 1952, è il primo articolato documento della condanna dell'autore di Ulysses da parte del
giovane Zolla, molto prima che il romanzo venisse tradotto in Italia (Mondadori, 1960). La ripulsa era ribadita quarantanni dopo
in un'intervista a Fedora Giordano: Joyce? Io lo stronco.*
Il saggio La maschera e il volto di Franz Kafka, usciva su «Letterature moderne», la rivista diretta da Francesco Flora, nella primavera del 1954. «I documenti» scrive EZ nel primo paragrafo
* «Mondo operaio», 3 marzo 1991.
205
qui non riportato «ci permettono di rivedere (Kafka) come uomo
fra uomini, ma la ricostruzione della sua persona deve costituire
solo un primo gradino nella lenta comprensione [...] del complesso pensiero che la sua persona-maschera cela dietro di sé [...].»
Ne emerge il quadro di un Kafka «indubbiamente mistico» che
«trasse forza dalla tradizione ebraica e dalla cabbala nel creare la
sua visione nichilistica del mondo [...]».
Il quarto componimento è di fatto un dittico su Boris Pasternak: accoglie Cinque tesi sul Dottor Zivago formulate da EZ al
tempo della sua collaborazione a «Tempo Presente», e l'articolo
Intrìso di pietà in un'epoca empia, pubblicato sul quotidiano romano «Telesera», all'indomani della morte di Pasternak l'I giugno 1960.
Un utile avvio alla lettura dei due componimenti lo fornisce un
precedente saggio zolliano: Il passaggio di Pasternak dall'avanguardia alla tradizione pubblicato su «L'approdo letterario» nel
1958,* di seguito a un commento di Mario Luzi, l'anno in cui lo
scrittore russo riceveva il Premio Nobel.
La tesi centrale di Zolla è che il procedimento tenuto dallo
scrittore nelle novelle e nelle liriche dell'iniziale fase avanguardistica era stato il «rispecchiamento incontrollato (o meglio, controllato soltanto in sede ritmica e melodica) [...]». La prosa della
Infanzia diZenja Ljuverso del P o i c h é con questo titolo era apparso su «Esprit», rispecchia una «visione di tipo cinematografico
che sposta di continuo il suo angolo di visuale con una frenesia,
una lucidità frastornante nella quale è soprattutto il disordine ad
affiorare». «Ma nel Dottor Zivago» sostiene EZ «il rispecchiamento, la lucidità frastornante sono trascesi, e un principio ordinatore più profondo, che è formale e sostanziale insieme, si apre
un varco. A dirla in breve questo principio è la fede nella natura
provvidenziale del destino. Pasternak costruisce il Dottor Zivago
come una rete di corrispondenze meticolose. Già all'inizio sono
presentate come virtualmente intrecciate le sorti dei vari perso* Ilpassaggio di Pasternak dall'avanguardia alla tradizione, «L'approdo letterario», n. 4,
ottobre-dicembre 1958.
naggi; essi stanno tuttora a una grande distanza l'uno dall'altro
ma la poesia è quella conoscenza provvidenziale che ravvisa nel disegno dei loro destini ancora informi il boccio destinato a fiorire»
(corsivo mio).
Che cosa significa, si era domandato Zolla, «questa reverenza
verso i segni sparsi sul decorso della vita, destinati a conferire mistero e significato [...] alle vicende quotidiane?».
«Yuryi Zivago» rispondeva «riesce a educarsi non al modo degli
autotormentatori che si piegano ad astratte leggi, ma plasmando
grazie agli affetti e all'arte, grazie all'incoerenza del cuore, le esperienze che gli toccano in un tutto significativo.»*
Negli anni arroventati della sua mobilitazione intellettuale, EZ
aveva sviscerato la tregenda di Zivago, con un acume assai prossimo all'immedesimazione. Le Cinque tesi e l'articolo in morte di
Pasternak su «Telesera», fanno intravedere, con gli ovvi confronti,
la possibilità di una trasposta somiglianza tra la visione disillusa
della storia di Zivago/Pastemak e quella zolliana. La stessa resistenza allo spirito dell'epoca che aveva spinto Zolla a esclamare
con rabbia: «Chi oserebbe ormai porre in dubbio che il bene della
vita debba sprigionare dalla distruzione», che l'eversione delle
forme venga «salutata come opera giusta e buona [...]», diviene
mite accettazione quando si riconosce un principio più profondo
che ordisce e modella i destini singoli e collettivi.
Il quinto pezzo, l'elzeviro Contro ifantasmi della decadenza: il
testamento etico di Benedetto Croce, usciva nel 1966 sulla pagina
che il «Corriere della Sera» dedicava al filosofo nel centenario
della nascita (1866-1952),** accanto agli articoli di Emilio Cecchi, Rosario Romeo, Giovanni Russo e Elena Croce.
* Ivi, p. 67.
** «Corriere della Sera», 25 febbraio 1966.
Il vero se stesso
La symphoniepastorale di Gide è un dramma tremendo che pur si
giace fra le velature e gli smorzamenti di una parola casta: un pastore protestante ha raccolto una fanciulla cieca, illudendo se
stesso col motivo della doverosa carità: fasciata dalle sue cure, essa
s'è fatta smagliante in bellezza, si che il figlio del pastore se ne innamora: ma il padre lo dissuade e respinge, nascondendo a sé la
propria gelosia sotto il velame dello scrupolo moralistico. A suscitare in vita codesto scrupolo egli lo investe delle tinte e dell'enfasi
delle scritture, ma codesto esorcismo protratto e procacciato si
smuore, e prorompe d'un tratto l'urlo di Eros con veemenza di
scatto, di follia. Il gioco complesso e mai portato in superficie ha
però intristito e avvizzito il cuore dell'uomo; quando la tragedia
di desideri è versata in una tragedia palese delle vicende, egli sente
con lo stupore deserto (che anche esprimono il punto finale e il
bianco dell'ultima pagina) che s'è trasformato in aridità senza
uscita e ha smarrito ogni possibilità di fervore, di vita: «Volli piangere, ma il mio cuore era arido come un deserto».
Per l'etica romantica (e non solo romantica) si son composte
innumerevoli sacre rappresentazioni dell'«Uomo che ha tradito il
vero se stesso», per correre dietro a un falso sé, ordito dall'ingegno
e insufflato dalla delusione. Nel commercio morbido e sotterraneo che s'istituisce tra il vero, sotteso, e il falso, che usurpa le apparenze, il vero io perde le sue fattezze e si fa sterile; sottratto alla
tonica e violenta atmosfera della realtà intisichisce, e, appena alfine si trae in luce, appare larva svanente, colorita di rimpianto
forse. Di queste «rappresentazioni» ho posto in cima l'offerta gidiana per la sua perfezione gemmea: ma vi si svaria all'infinito:
cito secondo il caso delle reminiscenze, l'uomo ibseniano, il fiabesco Dorian Gray, la convolta perplessità delle affinità elettive,
lo sfarzo troppo rombante della Taide di Anatole France, e l'elegante-velata Education sentimentale. Il bovarismo, teorizzato da
Jules de Gaultier, è appunto la trasposizione su d'un piano più generico, di questi dissidi di romanzi: l'uomo per maledizione si
sforza verso una costruzione che non è lui.
Le storie letterarie sono infestate di traditori di questa sorta, e
uno dei temi attorno ai quali si piacque la gnomica tedesca, fu il
diritto conseguimento delle aspirazioni giovanili; beato chi non
depose dal pensiero il sogno giovanile!, cantano Goethe e Humboldt
(sottintesa l'illusione della giovinezza inambigua, rousseauiana: è
stato necessario Freud a disperderla e a illuminare sulla smisurata
ipocrisia del bambino).
Il vero io è destinato a trionfare nelle sacre rappresentazioni ma
il pericolo è che, apparso sulle scene, sia ormai svuotato e ombra,
il personaggio che ha un destino definitivo è invece il falso io, la
sovrastruttura, l'anima veste, che (forse inconsapevole) conculca,
se non convelle l'anima inconfessata: il falso io deve perire e perisce al comparire dell'eroe effettuale della vicenda. La «morale»
che si dovrebbe udire sulle labbra dell'attore preferito, se le rappresentazioni fossero allestimenti scenici elisabettiani, suonerebbe come quelle parole kierkegaardiane: «Pure per amor tuo voglio rispondere: non sai che giungerà l'ora della mezzanotte in cui
ognuno dovrà smascherarsi? Credi che si possa sempre scherzare
con la vita? Credi che si possa di nascosto sgattaiolar via un po'
prima della mezzanotte, per sfuggirla? Non inorridisci a questo
pensiero? Nella vita ho visto persone che tradirono tanto a lungo
gli altri che alla fine in essi la pazzia ributtantemente mostrava agli
altri quei segreti pensieri che essi, fino allora, avevano orgogliosamente tenuti celati». Prima di assentire come torna spontaneo, a
questo discorso ci si dovrebbe salutarmente rattenere e rientrare:
non è esso un poco lo stesso dilemma che Platone presentava al timorato Protarco, inghirlandato per l'opposto corno: «Vorresti tu
vivere come un'ostrica, con addosso il peso che affonda della tua
concupiscenza?». Il posticcio viso può anche sfidare i rintocchi
della mezzanotte e sostenere la parte trionfante giacché, se l'evocazione del desiderio fosse per sé un bene, parrebbe invero che
ogni ordinamento debba scomporsi e sparire per il fatto stesso che
ogni cosa è in verità promossa dalla molla del suo contrario, dall'anarchismo.
Saggi di etica e di estetica, Editrice Spaziani, Torino 1947, pp. 57-60.
La maschera e il volto dì Franz Kafka
Il volto*
Il retroscena spirituale della tortuosa psicologia di Kafka, è tutto
racchiuso in una dichiarazione del suo diario: «La solitudine che,
nella sostanza, mi fu imposta da sempre fu anche in parte ricercata
da me a proposito — ma non vi ero costretto, forse?... a che cosa mi
conduce essa? Può anche condurre alla follia... Tutta questa letteratura non è che un assalto alle frontiere, e se nel frattempo non
fosse intervenuto il sionismo, avrebbe potuto ben sviluppare una
dottrina occulta, una nuova cabbala» (16 febbraio 1922).
L'opera di Kafka era destinata a formare un corpo di dottrine
esoteriche che si collocasse al di fuori dell'antica cabbala (era questa
la speranza segreta dell'ebraismo, il rifugio dalla persecuzione, l'evasione nel misticismo e nel nichilismo), e Kafka aggiunge: «è vero
che questo esige un genio non si sa quanto incomprensibile, che
spinga le sue radici in seno ai secoli antichi e che ricrei i secoli antichi». La ventilata cabbala kafkiana riprendeva i modi, il linguaggio
e i miti dell'antica, racchiusa nel medievale libro dello Zohar.
Il linguaggio della conoscenza per la cabbala non può essere
che l'allegoria e il simbolo: «per lo Zohar non esiste un segno artificiale, irreale e una cosa significata, reale, ma "l'uno e l'altro sono
nel contempo delle realtà e dei segni"». Perciò «i fenomeni e i testi
non sono soltanto l'espressione, il riflesso di un mondo sovrasensibile, ma sono entrambi una realtà duplice: realtà esteriore e sensibile; realtà interiore e astratta. Le parole della Scrittura, le leggende sul passato hanno una verità storica, ma sono altresì il simbolo di una verità più alta».3
* Nella Parte prima del saggio qui omessa, ci sono rinvii alle note 1 e 2. La numerazione inizia pertanto dalla nota 3.
3. Alla p. 201 di La Cabbale, Henri Serouya, Grasset. Le parole fra virgolette sono citazioni dello Zohar. Si mettano in rapporto con ciò che dice Kafka (considerazioni
sul peccato): «il linguaggio, per esprimere tutto ciò che esorbita dal mondo sensibile,
può sempre essere usato in modo allusivo, ma mai in modo analogico, poiché, confacendosi al mondo sensibile, non concerne se non la proprietà e i suoi rapporti».
Questo principio linguistico che rifiuta di staccare realtà e simbolo è accettato in pieno da Kafka, ed egli rinuncia in partenza a
cercare una realtà che non sia linguaggio: metafora, simbolo, allegoria, rinvio, allusione - come variamente egli dice. Nulla ha
reale sostanzialità sensibile, nulla si coglie per intuizione diretta
(per tactus intrìnsecus), ma ogni oggetto si disegna inevitabilmente come un geroglifico, tutto è segno. [...]
La creazione del mondo per opera di Dio rinvia al problema
dell'esistenza di Dio. Se l'universo è un tessuto di segni (il velo
dietro il quale si nasconde lo splendore, nel gergo cabbalistico),
esso deve in ultima istanza rinviare alla «gran cosa significata».
Soltanto l'indagine di questa potrà spiegare l'universo che ad essa
addita. Se si deve concepire il termine di tutti i rinvìi, di tutte le
allusioni, si dovrà concepire l'infinito, giacché i segni finiti non
possono, rinviando a un altro da sé, che additare l'infinità: «ma
l'infinito è una volontà superiore più misteriosa di tutti i misteri.
È il nulla» ( Tosefìa, II, 239 b, Zohar). La gran cosa significata, Dio
in sé e per sé è il nulla, il nulla del nulla. Il nome più segreto di Dio
è ayin, nulla; anzi, i cabbalisti rifiutavano perfino di fermarsi al
termine della negazione assoluta - forse esperti dei pericoli della
parola che aveva suscitato le dispute del platonico Parmenide - e
giunsero alla conclusione che il concetto di Dio non può essere
pienamente reso che dall'interrogazione: miì\ chi?L'ultima realtà
è un interrogativo puro. Nel suo immaginoso linguaggio lo Zohar
afferma: «la testa suprema, l'antico dei giorni sacro e misterioso è
la testa che non è testa perché è sconosciuta e non si saprà mai che
cosa contenga. Nessuna saggezza e nessuna intelligenza può coglierla. È di essa che parla la Scrittura: "rifugiati nel tuo paese" e
"le bestie andavano e venivano". È perciò che il sacro antico dei
giorni porta il nome di nulla» (III, 292 b).
Si rifrangono le stesse parole sulle labbra del pittore Titorelli
nel Processo: «il tribunale supremo è irraggiungibile per lei, per me
e per tutti quanti. Come stanno le cose là noi non sappiamo e, sia
detto fra parentesi, non vogliamo nemmeno saperlo».
Il fatto però che la cabbala riconosca in Dio il nulla non significa che essa con ciò rinunci a sviscerare il mito del Dio creatore al
fine di meglio illustrare per allegoria la situazione umana, anzi il
SepherJezirah afferma: «Dio provò la prigione che voleva dare agli
spiriti creati. Dio si fece uomo per essere amato e compreso dagli
uomini; e noi non conosciamo di Lui che questa immagine segnata sul velo che ci nasconde il suo splendore. Questa immagine
è la nostra ed Egli vuole che per noi sia la Sua. Così noi lo conosciamo senza conoscerlo. Egli ci mostra una forma, ma non ne
ha». «Prima della creazione del mondo non c'era alcun rapporto
per cui Dio potesse essere chiamato misericordioso o giusto. Tutti
questi nomi sono irreali, e non gli sono dati che nello spirito delle
creature [...] nessun attributo reale, nessun nome gli può essere
applicato.» (Zohar, III, 257 b)
Una simile visione della realtà, così profondamente nichilistica, non poteva che portare all'angoscia e alla disperazione: l'antica leggenda ebraica narrava di tre dottori che erano giunti fino
in fondo alla cabbala: uno era impazzito, l'altro era diventato
empio, il terzo si era salvato. Kafka avverte il giovane Janouch di
non tentare di penetrarlo a fondo: «la mia severità potrebbe agire
come un veleno, lei è giovane» {Janouch, Gespraeche mit Kafka).
Forse perciò Kafka desiderò che le sue opere venissero bruciate.
La sua candida ultima amante Dora Dymant sostenne che egli
volesse distruggerle perché non era ancora pervenuto a trovare la
via, la sua salvezza,4 ma non sembra che egli si facesse simili illusioni sulla possibilità di liberarsi della menzogna (Dora Dymant
dichiara esplicitamente, a confusione dei Candides che vorrebbero scorgere una speranza nel nichilismo kafkiano, che Kafka
non aveva fede).
La seconda mashalo allegoria che Kafka s'impegnò a decifrare
è il mito del peccato originale. «Mi pare che nessuno come me
abbia compreso il peccato» scriveva a Milena. Per intendere in
pieno l'affermazione bisogna rifarsi al concetto di peccato nella
teologia medievale ebraica: Maimonide escludeva che l'albero
della conoscenza del peccato significhi il sesso che è connaturato
ed essenziale all'uomo (Kafka spiegava al giovane Janouch che
4. Si veda «Evidences», Parigi, novembre 1952.
sesso è senso: Sinnlichkeit deriva da Sinn, esso non è il peccato).
Maimonide, nella sua Guida dei perplessi (1,2), nega altresì che la
«conoscenza del peccato» indichi l'intelligenza, che è anzi, come
facoltà discriminatrice del bene e del male, presupposta dall'ordine di non mangiare il frutto proibito.
Peccato: conoscenza del «buono e del cattivo», come va reso il
testo della Genesi, significa sensibilità raffinata che sente disagio
dinanzi al brutto, vergogna e pudore. 5 Ciò che Kafka chiama
Schmutzigekeit e Scham (che cosa sopravvive a K. del Processai
« es war ab solite ihm die Scham ueberlebem) : è l'angoscia dinanzi
alla banalità, non il peccato nel senso cristiano, ma la nausea.
Dal peccato originale non ci si può liberare. Kafka narra a Milena un suo dolce ricordo d'amore: in esso «non c'è sporcizia
(Schmutè) ma tutto ciò che apporta la vita dall'interiorità dell'uomo, in breve, qualcosa dell'aria che si è respirata nel paradiso terrestre prima della caduta. Ma qualcosa di quell'aria,
touha, manca, di qui nasce l'angoscia». E in un altro passo:
«Sporco sono, ecco perché faccio un tal strepito per la purezza.
Nessuno canta così puramente come coloro che si trovano nel
più profondo inferno; è loro il canto che scambiano per canto
degli angeli». L'accidia e lo squallore: ecco il risultato del peccato. Solo i bambini ne sono esenti: «non sanno rigettare le cose
disgustose e scegliere le buone». Nelle parole di Isaia, e forse se
ne salva l'estrema decrepitezza {II Sam. XIX, 36). Questo spieghi la particolare attenzione che Kafka rivolge ai due estremi
della vita, l'accorato rimpianto del giorno in cui al bambino si fa
perdere l'innocenza (discorrendo con Janouch egli indica nella
tonalità sporca e disgustosa in cui viene fatta dal bambino la
scoperta del sesso una delle massime radici dell'infelicità, è
ovvio il rapporto con il protagonista di Amerika), l'attenzione
per i vecchi del Castello.
Kafka dava alla caduta il valore di mito metafisico come Martin Buber:
5. Per queste e altre questioni di teologia ebraica, si veda Aspetti e problemi dell'ebraismo, Roma, 1952.
Il peccato originale non è accaduto una volta per diventare poi destino, ma nella sua realtà accade ora e qui. Ogni uomo, nonostante tutta la storia accaduta, nonostante tutta la sostanza ereditaria trasmessagli, si trova nella nuda e cruda situazione di Adamo;
a ogni uomo spetta di decidersi (M. Buber, Kampfum Israel. Der
Glaubedes Judentums).
«L'espulsione dal paradiso non fu un atto ma un avvenimento
perpetuo» (Kafka, Meditazioni), «l'espulsione dal paradiso è definitiva, la vita in questo mondo è ineluttabile, l'eternità dell'avvenimento (ovvero, l'eterna ripetizione dell'avvenimento, per esprimerlo temporalmente)» {Considerazioni sulpeccato).
La conoscenza del peccato è per Kafka {ibid.): «un gradino
verso la vita eterna e nello stesso tempo un ostacolo. Quando
dopo aver acquistata la conoscenza vorrai ottenere la vita eterna
(e non potrai non volerlo, perché la conoscenza è questo) dovrai
distruggerti, tu che sei l'ostacolo, per costruire il gradino che è
la distruzione». «Se ciò che si dice andasse distrutto nel paradiso, fosse stato indistruttibile non si tratterebbe di qualcosa di
definitivo; se invece è distruttibile, viviamo dunque su una falsa
fede.»
Non si mangiò dell'albero della vita: «siamo stati cacciati dal
paradiso perché non ne mangiassimo» {ibid). L'albero della vita
nel mito ebraico avrebbe dovuto dare l'immortalità, rendere
l'uomo chaj lé olàm, eternamente vivente. Tale immortalità andò
variamente intesa dall'ebraismo, ora come vita eterna individuale, ora, e più spesso, come trasmissione della vita nella stirpe.
Kafka rifiutò di riconoscere l'eternità, appunto a causa della conoscenza, dell'angoscia: la lettera al padre è il suo scritto chiave.
Egli non potè mangiare dall'albero della vita: non volle sposarsi,
per le ragioni stesse di Kierkegaard.
Altro mito ebraico che Kafka svolse nelle sue considerazioni
è quello della torre di Babele, e della condanna divina a vivere
nella discordia {riv), nel disordine. Anche questa situazione è
eterna, l'uomo tenterà invano di apportare ordine nel suo
mondo. [...]
Nel Golem di Gustav Meyrink, scritto sotto l'influsso delle dottrine cabbalistiche, troviamo gli stessi temi kafkiani della distruttibilità del mondo visibile: «Il mondo esiste appunto per darci
modo di pensarlo distrutto» afferma in esso la cabbalista Miriam,
e Kafka scriveva: «con la vista più potente si può dissipare il
mondo. Davanti agli occhi deboli esso si consolida, agli occhi più
deboli mostra il pugno, davanti ai più deboli ancora non ha vergogna, uccide chi osi guardarlo».6
Il mondo visibile è il velo dello splendore. Chi ha distrutto il
mondo con la preghiera (e per Kafka la letteratura era la preghiera, dichiara nel diario), vedrà un fascio di fiamme che non
svela - secondo la metafora della cabbala - nulla della sostanza
che brucia: «la realtà è un lampeggiamento supremo, davanti al
quale si devono chiudere gli occhi» (Zohar; Mistero della Thora,
97); «il fatto che esiste solo il mondo spirituale ci toglie la speranza per darci la certezza. La nostra arte consiste nell'essere accecati dalla verità: la luce sulla smorfia del volto che indietreggia,
ecco l'unica verità» (Kafka, ibid.).
Si deve concludere che Kafka ebbe delle visioni mistiche? Non
pare possibile metterlo in dubbio, se si ripensa alle dichiarazioni
che fece a Rudolf Steiner e riportò nel diario: «ho provato degli
stati di illuminazione da lei descritti... nei quali sentivo di aver raggiunto non solo le mie frontiere, ma le frontiere di ciò che è universalmente umano». Del resto non pare che Kafka pervenisse a
degli stati di illuminazione liberatori; il passo fondamentale: «la
verità più vicina è questa: che tu premi la testa contro il muro di
una cella senza porte néfinestre», va messo in rapporto con la dottrina cabbalistica dell'io vero dell'Habal Garnim (di cui il cabbalista Hillel del Golem dice: «egli abita alto sopra la terra in una cella
senza porte e con un'unicafinestraài cui nessuna intesa con gli uomini riesce possibile»), a quel miraggio mistico egli non pervenne.
6. Nella sezione Idra Rabba Kadisha dello Zohar è detto: «Il mondo sussiste solo grazie al segreto», al segreto sulla verità ultima, cioè.
Minuti sarebbero i riscontri possibili delle favole di Kafka con le
favole talmudiche: la figura di Alessandro Magno cui la leggenda
talmudica attribuiva la scoperta della rotondità della terra è una
delle predilette da Kafka, come simbolo dell'uomo che «ha raggiunto i confini».
Anche l'attenzione ai sogni che si svela nelle lettere a Milena, è
tipica della religiosità ebraica, e ben si può iscrivere a epigrafe
delle disquisizioni kafkiane sui sogni la massima talmudica: «non
i sogni si avverano, ma la loro interpretazione».
Perfino l'abitudine cabbalistica della combinatoria letterale
(aspetto che disgustò Spinoza) fu sentita da Kafka: nel diario, in
un passo citato da Brod nella biografia, Kafka dà un esempio della
combinatoria con cui studiava i nomi dei personaggi, per la novella II Giudizio: «Georg ha tante lettere quanto Franz. In Bendemann, non è che un rafforzativo di Bende, in vista di tutti gli sviluppi inattesi della storia. Ora Bende ha altrettante lettere di
Kafka e l'è vi si ripete come la a in Kafka».
***
Kafka riatteggiò a suo modo i romanzi classici che gli vennero fra
le mani: egli confessò che Amerika era ricalcata sul David Copperfield, e II castello fu ricalcato su La nonna di Bozena Némcovà,
uno dei libri di testo su cui studiò al Liceo di Praga il boemo (vi è
narrata la vita di un piccolo villaggio ceco dominato da una signora feudale insediata in un quasi irraggiungibile castello, contornata da uno stuolo di funzionari. La figura di Christl, insidiata
da un funzionario italiano del castello — che diverrà il Sortini - ,
precorre l'Amalia kafkiana. Ma poi il romanzo si conclude con illuministico ottimismo facendo intervenire una nonna della feudataria a raddrizzare i torti).
L'unico materiale che Kafka potè usare adottandone anche le
movenze narrative fu la letteratura cabbalistica del movimento
cassidico (raccolto da Martin Buber nei Chassidische Buecher). Le
novelle degli scrittori cassidici e gli aforismi - specie quelli di
Rabbi Nahman — influirono notevolmente sulle prime opere,
specie sulle novelle d'intonazione surrealistica.7
Kafka avrebbe voluto seguire l'emigrazione palestinese, e non a
caso tentava di imparare un mestiere, la falegnameria o il giardinaggio, per trovare salvezza in quello stato di particolare innocenza che dà il lavoro manuale. Ma se ne ritrasse in seguito, come
dal matrimonio, poiché ebbe acquistata coscienza di dover «scavare la fossa di Babele».
«Letterature moderne», anno V, n. 2, marzo-aprile 1954, pp. 151-159.
7. Il movimento fu fondato da Baal Shem e il suo motivo fondamentale è che Dio è
prigioniero della sua creazione e che il fervore mistico dei «pii» (chassidim) debba liberarlo.
Joyce e la moderna apocalisse
Alla soglia dell'intimità dell'anima si apre un bivio: da un verso si
spicca l'itinerario verso l'estasi dall'altro si stende la terra desolata
della delectatio morosa, del dormiveglia, della coscienza crepuscolare, brulicante di tetre banalità e rimasticature, di desideri o ambizioni conculcati che tentano la rivincita sul piano della fantasticheria, di ricordi sconnessi, di lugubri lussurie. È il mondo dei
precordi che, fin tanto che irraggi e domini la saggezza intellettuale della mente o la volontà serrata del plesso solare (come
amava chiamare Lawrence il platonico thymós), giace nell'oscurità
della trascuranza; ma nell'uomo volgare (e anche nell'uomo intelligente e di carattere sonnecchia un uomo volgare, che lo segue
come un Doppelgänger, come una trista ombra, pronta a balzar
fuori, verso la luce non appena l'inibizione si allenti) la vita è tutta
fatta di triti frantumi, di rifiuti: mozziconi di canzonette, puzze,
giochi di parole, rimasugli insensati di ricordi, avanzi di dialoghi,
facezie insulse e frasi fatte: un universo di amebe che si rincorrono, intrecciano, combinano. È il vero e presente inferno che
l'uomo si reca dentro, voragine che inghiotte e rimugina le scorie
della vita svolta sul piano superiore del pensiero e della scelta volitiva. Ognuno ha dentro di sé questa cloaca dove incessantemente si raccoglie e rimescola il brìcà brac dell'esistenza.
L'uomo normale sente ripugnanza dinanzi all'immondo e al
purulento eppure, avverte la psicologia del profondo, questa ripugnanza dev'essere, come ogni sentimento, ambivalente; il disgusto è la risultante di molte componenti, non esclusa l'attrazione, e tale attrazione viene sentita allo stato puro appunto al livello della coscienza inferiore. L'animo basso ha null'altro da
esprimere che questa attrazione del torbido, e ama esprimere questa colluvie:* eccola venirci incontro come il marchio caprigno
del demonio, nel rozzo graffito sessuale sul muro — eterno ricalco
delle oscenità graffiate sui muri di Pompei - nella logorrea della
* Il dizionario definisce colluvie: adunamento di materie putride e immonde. Termine obsoleto, ricorre nel testo due volte.
donnetta, nel gergo delle caserme e dei lupanari, nel turpiloquio
della plebe. Ecco che perfino dalle labbra di un amico di cuore e
d'ingegno esce in un momento di turpe abbandono la zaffata fetida dei racconti lubrichi, dei truismi idioti - come uno stridulo e
grottesco motivo d'organetto che irrompa in un andante mozartiano, e con raccapriccio ci accorgiamo del miasma infernale che
anch'egli nasconde dentro di sé. Per lo più questo inferno è coperto dalla vergogna, ma può anche schiudersi con tracotanza e
urlare il suo motto di raccolta: tousfrères et cochons, negli eserciti,
nei falansteri, dovunque i valori della saggezza e del decoro perdano il loro dominio a favore di quella che Valéry Larbaud chiamava la profonda serietà del borborigmo, della laidezza mentale,
del crasso calembour, della bestialità scurrile.
I mistici, volendo trascendere il piano della razionalità e del volere, temono in particolare di cadere preda dei tentacoli di questa
coscienza inferiore, di trovarsi in balìa della loro anima belluina e
tentano di combatterne l'insidia con la contemplazione fissa, con
la giaculatoria, onde pervenire al perfetto vuoto e buio interiori, a
scongiurare l'opera dei demoni il cui nome è legione, volta a evocare i frastagli assurdi dei ricordi, il fluire dell'osceno, dello scatologico, del banale.
Quelli che i casisti chiamano i piaceri dell'immaginazione,
quel flusso ecolalico insomma di cui siam venuti discorrendo
non coincide con il subconscio, in quanto è sempre avvertibile
mentre la struttura dei complessi individuali e degli archetipi ancestrali onde è tessuto il subconscio è sempre nascosta. Essa affiora attraverso questa coscienza inferiore, per lo più, ma può
anche esprimersi incidendo sul comportamento concreto, provocando movimenti involontari, amnesie, lapsi. È cioè ricostruibile ma non esplorabile in modo diretto. La coscienza inferiore
sia essa quella di veglia o quella onirica è il terreno da sondare al
fine di desumere la geografìa dell'inconscio, ma non l'inconscio
tout court.
Nei canti XXI e XXII dell' Inferno è ben delineato in chiave di
aspro e ferito disdegno il mondo della coscienza inferiore, mentre
nel Gargantua esso vien reso in un diverso registro, quello dell'i-
lare ebrietà. Comunque in codesti classici esempi esso resta in
certi limiti, è tutt'intorno cinto da una fondamentale serietà di
vita, ancorata a una Weltanschauung che tutto permea di significato. Anche nel caso più vistoso di Rabelais che si sfrena all'impazzata, diluviando la sua colluvie di canzonette oscene, delle sue
deformazioni linguistiche, dei suoi vaniloqui da allegra brigata
gauloise, l'evocazione della coscienza inferiore è in funzione di
qualcosa di profondamente sentito e pensato, che si traduceva
giocosamente nel vagheggiato ordine monastico che avesse per
insegna «Fais ce que voudras». Insomma tutto si svolgeva fra argini, il sorriso che poteva suscitare questo ambito deteriore dell'uomo, in chi non si sentisse di aborrirne con ascetica indignazione, era pur sempre un sorriso tollerante.
Rotti i compartimenti stagni della vita spirituale, forzati gli argini della logica e dell'etica, la modernità s'è curvata su codesto
molteplice mondo della nausea fino a compiacersene, fino a indugiare con gusto nel proprio disgusto. E rifiutato il silenzio e la
trascuranza onde la nauseosità era coperta. Nei sistemi filosofici
essa è considerata fra i fenomeni basilari ed essenziali dell'esistenza (il disgusto della purulenza dev'essere rovesciato, «il faut
renverser les termes: ce n'estpoint de tout cela quej'ai dégoût. Mais la
nausée est tout cela comme existé non-thématiquement... c'est autrui
qui saisit ma nausée, comme chair, précisément et dans le caractère
nauséeux de toute chair» precisa Sartre (L'être et le néant).
Il romanzo non vuole più razionalizzare l'uomo proiettandolo
entro le coordinate di un'etica o almeno di una caratteriologia,
bensì staccarne amorfi frantumi, riprodurne senza filtrarli i balbettii, le rêveries più gelose. Si profilano i primi tentativi in Fraillein Else dello Schnitzler, in Les lauriers sont coupés del Dujardin;
nel primo è denudata la delectatio morosa d'una ragazza che progetta di uccidersi, nell'altro sono registrati i desideri, le associazioni gratuite più triviali del protagonista. Il gusto di grottesche
sbavature della fantasticheria già s'afferma nell' Ubu roi del precursore dei surrealisti, Jarry. Poi venne Joyce a comporre quella
che Cecchi ha denominato la «bieca telogia» della coscienza inferiore, l'apoteosi della nausea.
Joyce si trovò al bivio d'estasi e nausea multiforme allorché
spinse i primi passi nel suo scavo interiore. Nella giovinezza provò
ad abbandonarsi secondo le regole gesuitiche all'azione della grazia virtuale, ma questa non divenne mai attuale, quello che egli
chiamò l'iniquo abbandono lo lasciò nelle secche dell'accidia
dove s'arrestò lo slancio del suo fervore; un'indolenza spirituale
(piuttosto che uno scetticismo) lo impregnò tutto. E la sua introversione invece di anelare alla «luce sovressenziale» affondò nella
nausea.
Joyce intravide chiaramente l'altra soluzione, quella dell'estasi
- non l'estasi della mistica religiosa preclusagli dall'incredulità ma sì l'estasi profana del piacere artistico, il rapimento dell'ipervisione alla Proust. Infatti la ricerca in interiore homine che addusse Proust a sorprendere l'anima di un albero nell'attimo arcano dell'intuizione panica fu ben conosciuta da Joyce: « thesoul
the whatness leaps to usfront the vestment of appearance. The soul of
the commonest object achieves structure of which is so adjusted, seems
to us radiant. The object achieves its epiphany.» (Stephen Heró)}
La visione esaltata in codesto passo teoricamente descritta fu
non di rado, con certi tratti eleganti e tenuissimi, raggiunta da
Joyce.
Ecco un attimo di finezza verbale evocatrice ed esaltata su un
volo d'uccelli nella versione di Pavese del Aportrait of the artist as
ayoung man, volto in Dedalus:2 «i gridi erano acuti e limpidi e sottili e cadevano come fili di serica luce dipanati da rocchetti turbinosi» (p. 336), o ancora: «la livida mano accartocciata e bruciante
sussultava come una foglia staccata nell'aria» (ivi, p. 68). Più
avanti si citeranno le acute e allucinate deformazioni della scena
di sabba che segna l'apice di Ulysses. In codesti tratti avviene ciò
che Joyce amava chiamare, con un'espressione del secentista Morgagni «l'incanto del cuore». Risplende una claritas, tomistica connotazione dell'arte di cui Joyce fornì una sottile interpretazione.
1. L'anima, l'essere ci investe sciogliendosi dal velo dell'apparenza. L'anima dell'oggetto più comune, la cui struttura sia così conformata, ci sembra raggiare. L'oggetto
celebra la sua epifania.
2. Frassinelli, Torino 1933.
Eppure, come s'è detto, lo scandaglio di Joyce fu puntato in
tutt'altra direzione; il tetro reame della nausea gli parve più vero
di quest'altro. Ecco come nell' Ulyssese$i pone i termini della sua
scelta: «Vi sono peccati... o cattivi ricordi che sono nascosti dall'uomo nei recessi più scuri del cuore, eppure là rimangono in attesa. Egli può lasciar appannare il loro ricordo, lasciarli stare come
se non fossero mai esistiti e quasi convincersi che non furono o
che almeno furono altrimenti. Eppure una fortuita parola d'un
tratto li chiamerà ed essi sorgeranno dinanzi a lui nelle circostanze
più varie, in visione o in sogno o mentre l'arpa e il tamburello gli
leniscono i sensi o nella fresca argentata calma vespertina o alla
festa di mezzanotte quando egli è appena sazio di vino. Non per
insultarlo verrà la visione, come a chi soggiaccia alla sua ira, non
per maligna volontà di rescinderlo dai viventi ma avvolta del pietoso manto del passato, silenziosa, remota, rimproverante. Lo
straniero osservò sul volto che aveva dinanzi recedere lentamente
la falsa tranquillità imposta, si sarebbe detto, dall'abitudine o da
qualche trucco studiato, di fronte a parole cosi amareggiate da rivelare in chi parlava una morbosità, un fiuto attratto dagli aspetti
più crudi della vita» (traduco da Ulysess, The Bodley Head, Londra 1947, p. 403).
È l'abbrivo stesso di Proust. Ma altro il risultato. Proust evoca
per il diletto della preziosità, tesse con ampie involute e ben architettate frasi una rete in cui raccogliere la magnifica preda d'una
sensazione raffinata che gli faccia sentire quella sua specialissima
estasi, quel suo particolare sfinimento di cuore; mentre Joyce per
acre piacere di degradazione (già nel passo citato c'è una tonalità
di abiezione nell'esercizio della reminiscenza) e per coraggiosa
ambizione di cruda verità, sconnette le maglie della sua sintassi
(che già negli scritti giovanili non era fittamente ordita, tanto che
è raro scoprirvi delle subordinate: la semplice coordinazione è l'unica materia connettiva) al fine di lasciarsi invadere dalla nauseosa molteplicità del conscience stream. Non contento di obliterare la subordinazione sintattica, distrugge la stessa interezza degli
atomi del discorso, delle parole. Ed ecco che, adottando questo
suo nuovo linguaggio, attua la sua metamorfosi, si disossa, si af-
floscia in un essere gelatinoso (Spitzer parlò del Molluskenhajte
desStil di Joyce), ammasso viscerale duttile, lubrico, scivoloso che
affonda e si mimetizza nel gran mare della nausea. Il paragone con
Proust data l'analogia delle premesse e la nettissima divaricazione
dei risultati ha sempre colpito (la hanno sviscerata nei particolari
Henry Miller e Bernhard Fehr); Spitzer (Stilstudien) ha prospettato una triade di scrittori congeneri, affiancando a Joyce e Proust
lo Schaeffer. Oltre all'iniziale avvio introspettivo e teso a captare
la reminiscenza, sono comuni a Proust e Joyce le callidae iuncturae di sapor grottesco, l'arte del pastiche. C'è perfino in Proust Spitzer omise di ricordarlo - un esempio di ruminazione interna
del personaggio nel famoso passo: «cerf, Francis Jammes, fourchette», ma d'altronde: «einen Fall ivie: Jingle a tinkle touted
wobei Joyce Glocklein und Haufichlag in die iennere Rumination,
wurdeProustdurchtandis que Parenthesen wiedergeben... erunirde
nicht zu Augenblicksbildungen wie ^Aoomusalem... greifen».3 La
metamorfosi in verme spappoloso non potè compiersi senza un
iniziale moto di disgusto a una tale identificazione con la nausea
mediante la creazione del linguaggio della nausea, e l'artista da
giovane dirà: «le fantasticherie mostruose erano balzate innanzi
improvvise e furibonde, da semplici parole, ed egli aveva presto
ceduto e se le era lasciate imperversare attorno» (Dedalus). Eppure non tennero gli argini del cuore e dell'intelletto. Il cuore infatti è bacato: sempre in Dedalus afferma, «nulla si muoveva nella
sua anima, tranne una libidine fredda crudele e senza amore». La
mente è indifferente: non importa sapere se si crede o no, afferma
Stephen, con l'imbelle scetticismo dell'accidia; «non voglio servire né Dio né l'uomo», proclama, e almeno di questo è ben certo.
Che gli resta? Soltanto, di «tollerare cinico i particolari vergognosi
delle sue orge segrete, in cui esultava a deturpare pazientemente
qualunque cosa lo avesse colpito». E allora si lascerà invadere da
questa sua moderna versione della possessione diabolica, dalla
3. «Nel caso di Jingle a tinkle touted, in cui Joyce lascia riecheggiare nella "ruminazione" interiore tanto lo scalpiccio come lo scampanellare, Proust si varrebbe di parentesi basate sul tandis que... né giungerebbe a folgorazioni immaginifiche come
fi/oorausalem.»
«presenza sottile come un mare... come una moltitudine che
dorma», dal «grido contro un iniquo abbandono, un grido che
non era l'eco di un osceno scarabocchio letto sulla parete grondante di una latrina».
Ma prima dell'abbandono totale e irrimediabile alla torbida attrazione del viscido e del mucillaginoso, prima della metamorfosi, Joyce tentò un altro esito, con Esuli. Il dramma delinea
la situazione morale di due uomini e d'una donna affrancati dai
«ceppi della morale borghese», affaticati a trovare un criterio d'azione nell'ideale dell'azione schietta, irriflessa, sincera (Roberto
proclama la nuova direttiva: «il momento vertiginoso della passione, della passione libera, senza vergognab la sola via di scampo»).4
Situazione alla Ibsen, salvo che qui non c'è più lotta anticonvenzionale, siamo già entrati nel regno promesso della sincerità senza
ostacoli; i personaggi son pertanto disorientati, vogliono rispettare ciascuno i sacri moti istintivi dell'altro ma finiscono col rimanere paralizzati e ridicoli e paradossali, irretiti in un'inestricabile confusione sentimentale. Paiono ignorare l'elementare fatto
che la mia azione - per quel tanto poco o poco imperio che possiede - concorre a formare la «schietta» decisione di chi mi attornia, che la tolleranza illimitata toglie l'energia senza dar la pace.
Le situazioni sono ben girate, spesso ammalia ancora Joyce l'ideale della clarìtas, dell'epifania dell'oggetto, come in questa descrizione-per-metafora-vissuta d'una donna che s'aggira in un
giardino: «in quel vestito, col vostro agile e sottil corpo, camminando a piccoli passi uguali, vidi proprio la luna quando veleggia
nel crepuscolo».
È una breve parentesi; in Ulysess]oyct optò decisamente per la
terribile metamorfosi, che sola era sua; per quel suo, a dirla machiavellicamente, ingaglioffarsi. Miller chiamò la soluzione di
Joyce il «deterioramento dell'anima [...] in Joyce assistiamo all'intero processo di decomposizione» (L'universo della morte). E fu soprattutto un atto di franca ammissione, di denudamento; perfino
in Esuli il protagonista doveva ammettere: «se vedessi il mio mi4. Versione di Linati, in II Dramma, n. 353.
gliore amico disteso là, entro una cassa da morto, e la sua faccia
avesse una comica espressione, non potrei trattenermi dal ridere».
E la risata funambolesca esplode disumana e immane in Ulysess, j
su tutto, sulla cultura come sulla maternità, sulla religione come
sull'amore, sottoposti non già alla critica analitica di Proust ma aj
quella immediata del furfante che li sgonfia con uno sberleffo. Sr
tratta del nichilismo dei giovani russi che si uccidevano lasciando
infisso al loro abito il biglietto: «Sputo su tutto», e di quello ben
più radicale del teppista che risponde con un gesto osceno. In
Ulysess Joyce non si confessa, non si giustifica, ma si spande, straripa, si celebra. Dalla limacciosa piena esce l'immagine di Joyce nel quale compositamente si fondono i due protagonisti, Stephen
e Bloom. Da quel caos si enuclea una persona. Non già una persona chiusa in una curvatura metafisica, animata da un principio
della volontà, ma pure, nel volgere delle sue sensazioni, si stagliano alcune costanti. Il fatto centrale della sua vita è il rifiuto di
pregare al letto della madre agonizzante, nonostante ella lo impetrasse. Già in Esuli egli lamenta «morì sola senza avermi perdonato», «io lottai contro il suo spirito e ancora adesso il suo spirito
lotta contro il mio». La storia era stata riferita minutamente in
Dedalus. Ora in Ulysess con un rigurgito di sconcezze Joyce se ne
libera, venga pure lo spettro della madre a cercarlo nel quartiere
dei postriboli, Stephen le griderà: «Demone mangiatore di uomini! Jena!».
La scuola freudiana identifica nel mare un simbolo della
madre, nella simbologia onirica. E contro il fascino del mare si accanisce in particolare Joyce, accentuandone i caratteri schifosi:
«l'untume rancido delle alghe» di Dedalus (cit., p. 90) si rifrange
in Ulysessfindalle prime pagine {ivi, p. 3): «Isn't the sea whatAlgy»
- ormai Joyce ha fatto il salto nell'irrazionale, Algernon Swinburne e le alghe, in grazia del suono non riescono più a staccarsi
l'uno dall'altro - «.calls it: a grey sweet mother? The snotgreen sea.
The scrotumtightening sea. Epi ofnopa pónton». Il maremuco nasale, il mare che irrigidisce lo scroto. Joyce avventa contro ciò che
minaccia di affascinarlo un profluvio di immondezze.
Il mondo di sensazioni è prevalentemente olfattivo, però ca-
gnescamente, non al modo umano e sottile di Proust. «Non ho
mai provato ripugnanza per gli odori» dice già Dedalus, e in Ulysess gli ambienti hanno tutti il loro puzzo particolare, la loro commistione di odori, da quello della madre: «her graveclothes giving
offan odour ofwax and rosewood her breath... a faint odour ofwettedashes» (ivi, p. 3);5 a quello dei vari cibi: «grìlled mutton kidneys
which gave to his palate a fine tang offaintly scented urine» (ivi, p.
48)6, via via fino alla ridda di puzze immonde del sabba centrale:
«from drains, clefts, cesspools, middens, arise on ali sides stagnant
fumes» (ivi, p. 414). 7 C'è un autentico culto degli odori, non già
di buccheri o altra galanteria, ma di traspirazione, di mucosa, di
fiati fetidi alitati attraverso denti dorati.
La genesi di tanta accanita ed esaltata compiacenza di orrori è indubbiamente in quei macabri esercizi spirituali del Loyola descritti
in Dedalus, dove al penitente si fa immaginare nitido e minuto l'inferno con particolar riguardo alle puzze. Vista la dichiarazione di
Stephen, che nessun odore lo disgustasse, lo sforzo immaginativo
cui lo piegavano i padri gesuiti doveva riuscirgli graditissimo.
Oltre che saturo di odori, l'inferno del Loyola risuona di bestemmie, e così pure Ulysses, e non solo di bestemmie ma di elaborati sacrilegi verbali. Le litanie alla Vergine, già rimasticate e aggrovigliate nella fantasia del piccolo Dedalus, in Ulysses vengono
rievocate attraverso la parodia che se ne inscena durante il sabba
(«Kidney ofBloomprayfiorus...»). La bestemmia a volte riesce spiritosa, come nel pensiero che la partoriente rivolge allo «universal
Husband» che sta nei cieli. Le funzioni sacre sono parodiate quasi
a ogni pagina, fin dall'inizio, nella presentazione di Buck Mulligan
che viene paragonato a un officiante mentre fa la toeletta del mattino. Nel sabba, dove tutte queste tendenze arrivano al loro fiore si
celebra anche la messa nera (« On an eminence, the centre of the
5. «Il suo sudario emanava un odore di cera e palissandro, il suo fiato un odore lieve
di cenere bagnata.»
6. «Rognone arrosto che infondeva al suo palato un fine sapore di orina lievemente
odorosa.»
7. «Dalle fogne, dalle crepe, dalle latrine, dai letamai si levano, su ogni lato, dei vapori stagnanti.»
earth, rises thefield altar of Saint Barbara. Black candles risefrom its
gospel and epistle horn. From the high barbicans of the tower two
shafts of light fall on the smokepalled altarstone. On the altarstone
Mrs Mina Purefoy, goddess of unreason, lies naked, fettered, a chalice
resting on her swollen belly. Father Malachi OFlynn, in a longpetticoat and reversed chasuble, his two leftfeet back to thefront,celebrates camp mass»)8 e la cerimonia, allegramente descritta con la tecnica della sceneggiatura cinematografica, come tutta la parte centrale è un poco il compendio di tutta l'opera. Si osservi nei dettagli
il passo riportato: la giocosa invenzione dei nomi, il particolare significativo e tipico (il ventre del «corpo divino» è enfiato). Il sesso
occupa pressoché costantemente l'autore, ed è una visuale rivoltante della vita sessuale, impregnata di feticismo (già presente in
Esuli nel particolare della giarrettiera e in Dedalus), feticismo che
trova il suo culmine e trionfo nella scena di Bloom e della zoppa;
snaturata dal masochismo (già in Dedalus c'è una punta di masochismo quando Stephen, vilmente tormentato dai compagni s'accorge di non provare astio, anche se egli cerca di camuffare il suo
sentire come pura indifferenza: «tutte le descrizioni d'amore e d'odio violento che aveva trovato nei libri gli erano parse irreali»), masochismo che prorompe durante il sabba, quando una delle baldracche muta sesso come l'Orlando di Virginia Woolf, da Bella diventa il lenone Bello, che sottopone Bloom a ogni sorta di luride
sevizie. Si mescola un certo inconsapevole satanismo alla vita sessuale di Bloom; il bacio di rito al re del sabba vien dato da lui alla
moglie coricata. Ma l'orrido sessuale tocca il punto più nauseante
nel discorso di Stephen durante la notte di Walpurga: «Entergentlemen to see... bestial butcher's boy pollutes in war veal liver or omelette on the belly (ivi, p. 539).9
8. «Su una prominenza, al centro della terra, sorge l'altare da campo di Santa Barbara. Candele nere si alzano dal vangelo e dai corni dell'epistola. Dagli alti contrafforti della torre due fasci di luce cadono sull'altare ammantato di fumo. Sull'altare la signora Mina Purefoy, dea dell'irrazionale giace nuda e incatenata, con un calice sul ventre enfiato. Il padre Malachi O'Flynn, con lunga sottana e casula rovesciata, i due piedi sinistri girati all'indietro, celebra la messa da campo.»
9. «Entrino signori a vedere... la polluzione di un bestiale garzone di macellaio nel
fegato di vitello caldo o con una frittata sul ventre.»
Infine, a completare la mistura, a ogni cosa viene congiunta la
parodia dell'erudizione, spinta a eccessi noiosi. La resa è tutt'altro
che realistica, non si potrà certo affermare che sia una oggettiva
registrazione di franche de vie interiore far sfilare nella mente di
Bloom i nomi «Nasiodoro, Goldfinger, Chrysostom, Maindoré,
Silversmile, Vifargent, Panargyros». Un critico, il Wilson, rimediò in questo caso supponendo che Joyce con queste parole più
che alla fedeltà badasse a dare la traduzione di un processo che
nella mente di Bloom si dovette svolgere assai più convolto, ma a
ragione Toynbee obietta, «Joyce non sta traducendo il relativamente semplice processo di Bloom in termini più letterari: ha trasformato Bloom in simbolo poetico».
Non si può essere del tutto consenzienti al termine «simbolo
poetico», tuttavia l'istanza serve a disperdere l'illusione di un realismo naturalistico in Joyce. L'unica volta che egli è veramente
realista, e con una resa immediata veramente maggiore di alcuna
cosa mai prima tentata, è nel monologo interiore di Marion
Bloom alla fine di Ulysses. Ma nel corpo del libro lo è raramente.
Semmai è espressionistico, specie nel sabba. Qui la gioia del raccapriccio tocca l'apice — la poetica della claritas, dell'epifania
degli oggetti viene applicata non al fine di farne irraggiare qualche qualità luminosa o elegiaca, come nei tratti di Dedaluspñma.
citati, ma per spremerne all'estremo tutta la carica di schifo, di
nausea. E tanto è lo sforzo, che la resa diventa grottesca, grandiosa. Perfino la nebbia che si protende verso i budelli delle strade
assume forme animali viscide, vischiose («snakes of riverfog creep
sloivly»). Come la nebbia si muta in serpente così una donna con
lo scialle sulla testa si trasforma in pipistrello: «ivith a squeak she
flaps her batshaivlandruns» (ivi, p. 422); le impressioni fisiologiche sono condensate e rapprese entro immagini crasse e dense:
«greyhorrorsearedhisflesh... coldoilsslidalonghisveins, chillinghis
blood: age cristing him with a salt cloak»;10 ogni aggettivo è scelto
col proposito di ridurre a orrore la sostanza aggettivata: il cane
10. «Un grigio orrore indurì la sua carne... olii freddi scivolarono nelle sue vene, agghiacciandone il sangue: la vecchiaia lo incrostava d'un manto salino.»
che segue Bloom - forse reminiscenza del cane che segue Faust «sprawls on his back, wriggling obscenely with begging paws, his
black tongue lollingout».u Le scene sono scelte tra i manichini di
un museo degli orrori, come i mutilati del sabba: «an armlesspair
ofthemflop restling, growlingin maimedsodden fighi»12 (magnifica alchimia verbale!). Questi sono i momenti culminanti, dove
un lucore sinistro e verdastro impregna ogni cosa (l'entrata nella
città notturna è un'incomparabile mistura di segni mortuari e di
oggetti naturali: nell'aria brillano «willo'the wisps and danger signals»). Il simbolo impregna cosi strettamente il reale che i termini di comparazione (poiché sono come fuochi fatui) non vengono agganciati da un «come», ma da un «e». Fuochi fatui e segnali di pericolo. Si può vedere in codesto stile una reviviscenza
di mentalità primitiva, poiché per il primitivo un oggetto è se
stesso e qualcosa d'altro, l'uomo che ha per totem il leopardo è un
uomo e un leopardo.
Lo stile joyciano, s'è detto, è una formula incantatoria per farci
tornare al primitivo, se non addirittura per convertirci in bruchi.
Come nella chamber ofhorrors di Madame Tussaud's, mèta di domenicali viaggi verso l'orrore dei londinesi, cosi nel sabba di Ulysses ci si fanno incontro volti contraffatti, segnati da Dio: «un
idiota sordomuto con occhi stravolti, la bocca informe e sbavazzante, passa a balzi, scosso dal ballo di San Vito. Viene imprigionato da una catena di braccia infantili... un nano si issa in spalla
un sacco di cenci e di ossa... una vecchia che assiste con una lampada a olio affumicata aiuta a ficcar roba nel sacco... in una stanza
illuminata da una candela, infissa nel collo d'una bottiglia una
brindaccola pettina un bambino scrofoloso». Risuonano richiami sconci, canzonette oscene. E ben si chiude la scena lunghissima con la melodrammatica perorazione della madre (nella
versione di Linati).
11. «Si mette a pancia all'aria, agitando oscenamente le zampe imploranti, con la
lingua nera penzoloni.»
12. «Una coppia senza braccia lotta a tonfi, borbogliando nel combattimento mutilo e pesante.»
La Madre:
(Ilsuo viso sifa sempre più vicino a lui esalando unfiatodi cenere).
Guardati. (Leva verso di lui un braccio secco e annerito, colle dita
distese). Guardati. La mano di Dio (Un verde granchio con occhi
rossi maligni affonda le sue branchie nel cuore di Stephen).
Siamo in chiave Rimbaud. Ma lo stile delle altre parti non si mantiene su questo livello strenuo ed espressionistico. A capriccio precisa fino alla noia dei particolari insignificanti - e il tedio è accresciuto dal faticoso stile a coordinazioni, tutto sorretto da «e». Un
esempio di indugio scelto a caso: «Haines helpedhimselfandsnapped
the case to. He put it back in his sidepocket and took from his waistepocketa nikeltinderbox, sprangitopen too, and havinglithiscigarette,
heldtheflamingspark towards Stephen in theshellofhishands» (ivi, p.
17); da questo tono minuzioso si trapassa a capriccio in un tono telegrafico, futuristico. Su tutto plana l'uggia dell'indifferenza, l'artista, dice Joyce, non deve prender pane con il cuore alla vicenda, ma
deve starsene a guardare «nettandosi le unghie». Gli aggettivi tematici (notò uno dei traduttori di Ulysses, Alberto Rossi) sono «quieto,
grigio, soffice»; è da aggiungere un aggettivo che spesso s'accompagna a «grigio»: lebbroso (si parla spesso di «color lebbroso»).
Se Ulysses era un puzzle risolvibile, insolubile appare Finnegan's
Wake, che segna, nelle intenzioni di Joyce, la rappresentazione della
notte, come Ulysses del giorno. Esso è un costante bisticcio verbale,
una storpiatura ininterrotta dei suoni, ma assai dubbio è il suo umorismo. L'ingenuità dei critici ha cercato dietro la pagina di entrambi
i libri un edificio intellettuale che per il vero non esiste. Tale candore
è soltanto superato dalla volontà di mistificazione degli artisti moderni. Il collegiale lavoro di due critici americani, Campbell e Robinson, A Skeleton key to Finnegan's Wake, spiega ad esempio il passo
« Tea tea too oo» in questo modo: «And here too is the motherly cup of
tea (As the teaplantadds to water a delicious stain, so does thegocUess of
lifeaddthestain of nature to abstractpurity ofthe waters ofheaven)»,xì
13. «Anche qui abbiamo la materna tazza di tè (come la pianta del tè dà all'acqua
una tinta deliziosa, cosi la dea della vita aggiunge la macchia della natura all'astratta
purezza delle acque celesti).»
e un recensore («Times Literary Supplement», n. 2832) divertitamente suggerì:
« One can so easily suggestan alternative: "Also there is an intimate malefemale contactofteafòrtwo, ivhich leadsalltoo easilytothesurpriseand
dismay conveyed in the expression Ho!"».14 L'epopea del borborigmo
non è un testo esoterico dove tesori di sapienza siano celati dietro il velame. C'è sì unarimuginaturadi varia erudizione e pedanteria, ma al
livello di pretesti per giochi di parole, ditiritereora aristofanesche ora
gratuite. Come ci si possa estasiare, come taluni pretendono, dinanzi
afrigidissimescomposizioni ericomposizionidi parole, è davvero un
problema. Tanto più che spesso non raggiungono quell'elementare
divertimento che c'è in certe creazioni di Laforgue (come il famoso aggettivo sangsuel). Se davvero ci fosse di che provare un piacere estetico
in pagine composte di meteorismi verbali, sarà tempo che degli enti
culturali installino dittafoni nei manicomi a eternarci le logorree dei
maniaci. A quanti si ostinano a mandar grida d'entusiasmo dinanzi a
tali frigide invenzioni sarà bene sottoporre questo impareggiabile
brano: «Che cosa c'è HM! Les Dieux en cage!Ily a des Dieux là dedans
ils ontlespieds dans les espaces. Qu'est-ce qu'Hs ontdit? Unepeau d'hyppopotamepourla tsarine?Và' a farti monaca. Les capucinsì Mia moglie
è trattata come una schiava, anzi come un tritone. On a fait des distances,jevousdisensilence, quilnefautpasdissiperlesdistances, ilfaut
les tenirpardesanneatixoupardesgrossessphères. Si fa una sigla con la
piegata scomposta, non mi piace ma ha dell'espressione. Bisogna
proibire la forza siderea, Jehovah. Nelritmosi vedono tutte le azioni
piccole con piccola tensione. Ho tre amanti gigantesche, hanno dimensioni nettuniche, sono meridiani della terra, bionde con gli occhi
elettrici e ifianchidi cristallo di rocca poliedrici a sistema rotante».
No, non è un passo di Joyce o di un joyciano, ma un classico esempio,
che recano i trattati di psichiatria, di idonea amenziale.*
14. «È cosi focile suggerire l'alternativa: c'è anche il contatto intimo maschile-femminile del tè per due, che può fàcilmente concludersi nella sorpresa e nella costernazione riprodotte dall'esclamazione Oo!»
* Il discorso demenziale è tratto dalla dispensa di psichiatria consultata da EZ negli
anni universitari. Si veda in proposito Nota 11 relativa al capitolo 2 della Pane
prima.
Del resto con ciò non si desidera sminuire l'importanza che tali ricerche hanno, in quanto bahnbrechend, dissodatrici di terreni
fino a oggi mai osati. E sono comunque il parallelo letterario di
certi discepoli di Schoenberg o dello Hàba, nonché, in pittura di
Braque e Picasso. L'opera di Joyce, in questo aspetto vistoso
quanto discutibile ha l'importanza di un gesto di coraggio.
A persuadere di una valutazione restrittiva, che riduca Joyce al
rango alto ma non altissimo (che attenui l'iperbolica dichiarazione di Priesdey: «nobody can deny him, not merely talent, but
sheer genius») basta un raffronto con un suo contemporaneo impegnato in analoghi esperimenti: Kafka. Ho già illustrato la fase
joyciana (non nel senso di un'eco di Joyce, ma nel senso di un parallelismo inconsapevole di ricerca) di Kafka in «Letterature moderne», dicembre 1950. Pure Kafka subì l'ossessione dell'idiozia
che riesce a intridere del suo miasma ogni momento della vita
umana, forza immane e paralizzante, e la eternò nelle figure degli
aiutanti di K nel Castello-, ma prima di stendere i grandi romanzi
della maturità egli scrisse, con Betrachtungeines Kampfes, 1' Ulysses
della letteratura tedesca. Qui veglia e sonno sono compenetrati in
una registrazione attentissima del conscience stream, un oggetto
qualsiasi vale a impegnare la mente dei personaggi in interminabili variazioni gratuite (Max Brod ricorda che tutto l'episodio del
cinese fu originato da fantasticherie sopra un'incisione orientale
che Kafka teneva appesa in casa). Ma il respiro armonico di
Kafka, la presenza di una curvatura metafìsica che dà spicco e
forza alla rappresentazione, ci fanno per contrasto sentire la fragilità di Joyce. A epigrafe dell'opera joyciana non stonerebbero le
parole àe\['Apocalisse-, poiché non ti ho trovato né freddo né
caldo, ma tiepido, ti ho vomitato fuor della mia bocca.
«Il pensiero cridco», 6 novembre 1952.
Cinque tesi sul Dottor
Zivago
1. La crìtica del reale diventa natura
Pasternak, in quanto lirico, proclama il messaggio latente di ogni
lirico: «Come io sto (di casa) nel linguaggio, che non è mio strumento ma mia voce, cosi si stia con la natura e con il prossimo».
La lirica è sempre implicito rifiuto d'una società oppressiva (ancorché la societas in interiore homine) attraverso la purezza della
parola. Pasternak ha sentito il bisogno di rendere da implicito
esplicito questo messaggio: il Dottor Zivago, oltre ad essere un romanzo, è quindi un commento narrativo-saggistico ad un serto di
poemi.
Per ottenere questa trasformazione, questa crescita della sua lirica su se stessa, Pasternak ha dovuto doppiare la punta di Finisterre dell'arte moderna, superare l'avanguardia senza sacrificarla.
Se l'avanguardia era la coscienza dell'angoscia espressa attraverso
la distruzione dei mezzi espressivi, l'asserragliarsi del soggetto
nella nevrosi e nell'arbitrio (questo dramma dell'avanguardia ancora non degenerata in sistema accademico fu il tema del Doktor
Faustus), con il Dottor Zivago si trapassa in un momento superiore, nel quale la coscienza dell'orrore e la critica della società diventano abito, natura: non più elementi di distruzione della
forma, bensì elementi del contenuto. La forma viene ripresa là
dove era stata abbandonata, al punto dove l'avevano lasciata
Óechov e Tolstoj.
Ma meglio che a tali autori si può accostare Pasternak ad Alessandro Scriabin. Nei suoi Ricordi (pubblicati sulla rivista uruguayana «La licorne») Pasternak individua i caratteri dello stile di
Scriabin e, insieme, del proprio: «Andrea Belyi, Chlebnikov e
altri andarono alla ricerca di nuovi mezzi espressivi, mirarono al
sogno d'una lingua nuova, lustrando e sondando le sillabe, le vocali, le consonanti. Mai potei capire tali ricerche. Le scoperte più
sorprendenti si producono quando, colmo del suo contenuto,
l'artista, senza aver tempo di troppo riflettere, dice precipitosa-
mente la sua parola nuova nella vecchia lingua, senza sapere se è
nuova o vecchia. Così parlò Chopin nel vecchio linguaggio mozartiano-beethoveniano, tanto stranamente nuovo da sembrare
un secondo inizio. Così fece Scriabin, quasi soltanto con i mezzi
dei suoi predecessori, rinnovando la sensazione musicale fino alle
radici negli studi dell'opera otto o nei preludi dell'opera undici
[...]».
Per poter rendere natura la critica del reale Pasternak ha scelto
la strada non del sottinteso, ma della semplicità.
2. Il massimamente differenziato è espresso attraverso il massimamente semplice
v
Il dottor Zivago è costruito secondo le norme di attica trasparenza,
della determinazione chiara e distinta ma non analitica degli oggetti e dei sentimenti: sta al semplice, equidistante dal semplicistico e dall'arrovellato, sta al limpido senza cadere nell'ovvio; rappresenta l'uomo senza mutilarlo né del gesto oggettivo né del
pensiero e del sentimento interiori; raffigura la società senza parare nell'unanimismo e senza spappolarsi nel caos. E tuttavia non
fornisce un'immagine «consolante», idillica del reale, quasi che
questo fosse oggi quel che era in passato, non ancora corroso dalla
«malattia» denunciata dall'avanguardia. Pasternak continua la
festa del narrare fin dove gli è consentito, ovvero fino all'inesprimibile, all'orrore della illibertà assoluta del soggetto; in concreto:
fino alla soglia dei campi di sterminio e fino al momento in cui
l'uomo a furia di persecuzioni cede, si dà per morto come l'opossum braccato. Quest'ultimo è il caso del personaggio di Vasjia, il
giovane bellissimo simile agli scudieri che i pittori dipingevano a
fianco degli zar, il discepolo di Zivago; Pasternak lo segue fino al
momento in cui «si adatta», abbandonando Zivago. Quanto alla
fase dei campi staliniani, Pasternak si limita a osservare per bocca
d'uno dei personaggi che la guerra era una benedizione al confronto, accolta con gioia suicida, e a far intravedere la soglia d'un
campo. Il dolore, la crudeltà, la sofferenza possono essere placati
dal canto di Orfeo, l'assenza di vita non si può esorcizzare. Fin
dove può, la metafora gareggia con il factum brutum atque nefastum. Ma fin dove può la metafora gareggiare con il reale? Karl
Kraus rispose: fin dove la realtà non diventi metafora.
Si rilegga questa pagina della Dritte Walpurgisnacht:
Quale rivelazione, per colui che si è accostato al linguaggio, sarebbe più sorprendente, quale visione più fulminante di quella di
un involucro verbale che si riempia di nuovo del sangue che era,
un tempo, il suo contenuto? Mirabile visione, se questo sangue
fosse soltanto metaforico: il sangue del pensiero che attesta la genuinità della parola. Visione gorgonica poiché è invece l'erompere
del sangue fisico, che comincia a sgorgare dalla crosta del linguaggio. Nessuna variante, per raffinata che fosse si è potuta sottrarre a
questo processo; nemmeno il terribile «versar sale sulle ferite
aperte». Una volta deve essere accaduto, ma si era dimenticato,
fino a rinunciare a ogni rappresentazione di alcunché di effettivo,
fino all'assoluta incapacità di rendersene conto. L'espressione era
usata per designare il ricordo crudele di una perdita, la manomissione di un dolore psichico: questo esiste sempre, mentre l'azione
da cui si attingeva rimaneva impensata. Eccola [...]
E Kraus narra di un vecchio costretto in un campo nazista a immergere una mano ferita dentro un sacco di sale, e soggiunge:
Rimane irrapresentabile; ma siccome è accaduto, la locuzione non
si può più utilizzare.
v
Ecco la stessa osservazione tornare nel Dottor Zivagcr.
Quello che era stato concepito in modo nobile e alto è diventato
rozza materia. Cosi la Grecia diventò Roma, cosi l'illuminismo
russo divenne la rivoluzione russa. Se pensi all'espressione di Blok:
«Noi ifiglidegli anni terribili della Russia» vedrai subito la differenza delle epoche. Quando Blok diceva questo, bisognava intenderlo in senso metaforico, figurato. Ifigliallora non erano i figli,
ma le creazioni, i prodotti, l'intelligencija, e i terrori non erano
terribili, ma provvidenziali, apocalittici; tutt'altra cosa. Ma adesso
tutto quel che era metaforico è diventato letterale; ifiglisono veramente ifigli,e i terrori sono terribili, ecco la differenza.
Pastemak esprime frammezzo alla conversazione di due combattenti dell'ultima guerra una diagnosi altamente complessa della
realtà storica, che interpreta ciò che stava accadendo come un trasformarsi della realtà stessa in metafora o ideologia. Ma questa coscienza critica non corrode la forma che anzi classicamente plasma la scena placida e dolorosa, non coartata da un commento
astratto esterno né deformata da registrazioni del pensiero o bloccata nella descrizione del comportamento. Quale il segreto di
questa genuinità della parola tesa nello sforzo di esprimere una
complessità che sembra esigere la deflagrazione della forma?
3. La rappresentazione dell'amore coincide con la critica della
realtà
v
v
Il «cuore» del Dottor Zivago è la storia d'amore di Zivago e Lara
Fèdorovna. Commovente, di classica freschezza: rivivono gli
amori del passato, illustri, nel loro, ed il loro fa da specchio a ogni
nuovo amore. Ma oggi un siffatto amore non potrebbe esaurirsi
nella natura meramente privata dell'uomo, nell'ingenuità chiusa
su se stessa della vita individuale. La semplicità antica di Pasternak è riottenuta solo perché egli ha trasformato in elemento naturale del contenuto la consapevolezza del rapporto fra l'individuo e la società:
Ancor più dell'affinità delle loro anime li univa l'abisso che li divideva dal resto del mondo. Ad entrambi era nello stesso modo
ostile tutto quanto è fatalmente tipico dell'uomo d'oggi, la sua voluta esaltazione, le sue isteriche velleità, e quell'inerzia della fantasia che innumerevoli lavoratori dell'arte e della scienza si preoccupano di alimentare perché la genialità rimanga un'eccezione. Il
loro era un grande amore. Tutti amano senza accorgersi della
straordinarietà del loro sentimento. Per loro invece, e questa era la
loro straordinarietà, gli istanti in cui, come una vampata d'eterno
nella loro condannata esistenza umana, sopravveniva il fremito
della passione, costituivano momenti di rivelazione e di un nuovo
approfondimento di se stessi e della vita.
Il loro amore è critica incarnata del male della società, e proprio
grazie a questo acido che deterge da ogni impurità sentimentale
acquistano verità i vari successivi tocchi e velature con cui esso
viene dipinto da Pasternak. Tocchi da impressionista: non fisicamente insistiti (di Lara amante rimane l'immagine d'un lungo
corpo in vestaglia che stende le braccia, leukólenos)-, s'è detto che
la forma è stata ripresa là dove aveva cominciato a essere sgretolata
dall'avanguardia.
Pasternak precisa, insieme alle morbide tinte del quadro, la situazione morale. Zivago e Lara si amano in pienezza perché lo
esige la natura che li circonda, perché lo esigono i volti compiaciuti che essi suscitano all'intorno; ma questo avviene perché
sono indifferenti al dominio dell'uomo sulla natura e alla «falsa
socialità».
Pasternak attira nel cerchio della «felicità» di Lara e Zivago gli
elementi sinistri dell'esistenza: la loro primavera è anche inferno
e decomposizione (cosi egli informa nel commento alla lirica
Smarrimento). Eppure non si potrebbe asserire che aleggi un'aura
morbosa attorno all'episodio, ovvero una misura di compiacimento per la carne diabolica e mortale. La stessa seduzione dalla
quale in gioventù Lara afferma di essere stata macchiata per sempre non è oscena, non ci offende o sgomenta. Non esistono tabù
che possano essere violati: Komorovskij non è una figura diabolica, e se Lara venne sedotta non fu oltraggiata da una violazione
dell'onestà, bensì da una diminuzione della sua libertà. Perché
quest'atmosfera di innocenza, di indifferenza dinanzi al tabù del
costume, che esclude tanto l'orrore come il gusto della violazione?
La realtà ha superato il mondo dove il bene temeva la sua immagine riflessa nel male e questo la propria riflessa nel bene; ormai
v
non è più tempo di indugiare sul momento mortifero, negativo,
dell'amore, sul tristanismo, perché la realtà nega senso tanto alla
salute come al morbo; i due poli siano dunque entrambi benedetti in un mondo dove la vita stessa è per essere estirpata, con il
suo dolore e la sua gioia, la sua sanità e la sua malattia. Prossimo
all'estinzione, l'uomo impara infine ad applicare la ricetta di Paracelso: la salute deve inserire nel suo circolo la malattia.
4. Il cristianesimo come orfismo
Pasternak si richiama costantemente al cristianesimo. Egli giustifica codesto «ritorno» attraverso l'interpretazione di Cristo come
liberatore dell'individuo dal popolo, profeta disarmato o eroe orfico che, come tale, è la vera incarnazione dell'umano e si contrappone all'immagine dell'uomo tiranno di sé e degli altri, domatore da circo; e infine di Cristo come eroe festivo che invita a
riconoscere come la vera vita sia festiva e non feriale.
Non è il «ritorno» di uno storicista, e neanche una reviviscenza
alla Eliot o alla Tate (questa è essenzialmente una deliberazione,
una volontà di credere): Pasternak non si atteggia come se fosse
cristiano onde opporre un principio d'ordine alla terra desolata: la
sua fede è insieme più complessa e più semplice. Ecco come se ne
può ricostruire il processo formativo.
Zivago sa che «il male peggiore, la radice del male futuro fu la
perdita della fiducia nel valore della propria opinione [...], si credette che bisognasse cantare in coro»; sa pure che tale male è indotto da un'impazienza verso le opinioni e da un disprezzo feroce
verso i loro portatori, i profeti disarmati, onde si esige che le opinioni divengano subito prescrizioni, che rispondano alla domanda «Che fare?» o addirittura che abbiano a disposizione eserciti che le servano, le certezze ultime di Zivago, se pure sono mai
esprimibili, non sono pragmatiche. Egli trova un momento di felicità nel lavorare la terra, ma aggiunge: «Non predico la semplicità e il ritorno alla terra che furono di Tolstoj, non ho intenzione
di apportare una correzione al socialismo per quel che riguarda la
questione agraria. Attesto semplicemente un fatto e non erigo a
sistema il mio destino». E all'epoca che gl'impone: «Se dici a devi
dire b» risponde: «Io dico a e non dico b».
Zivago è l'uomo che ha compreso come per non essere sommersi nella coralità ci si debba svincolare dall'atti aut, rifiutandosi
di diventare i servitori della prassi e cosi mantenendo intatta la
nostra umanità festiva, attribuendoci il diritto di aborrire dai macelli senza predicare il vegetarianismo, dall'industria senza esaltare l'arcolaio, dal potere senza invocare il caos.
Ecco che cosa gli consente di schivare il dominio della «non verità che venne sulla terra russa», la «malattia del secolo», che ha
ghermito il marito di Lara, il fiero comandante rosso, figura etica
ammirevole, secondo l'etica come coazione della propria natura
piegata a servire un'idea o addirittura, al limite, semplicemente
l'immagine della propria efficienza dura e aspra.
Proprio perciò il marito di Lara cade nella dialettica tremenda
per cui «ognuno con se stesso è diverso che nelle manifestazioni
esteriori: ciascuno ha la coscienza macchiata e può a ragione sentirsi colpevole di tutto, sentirsi un ignorato malfattore, un bugiardo non smascherato» e quindi è potenzialmente vittima docile di un processo staliniano dove si accuserebbe d'ogni torto.
Quale figura mitica può simboleggiare questo rifiuto della ragione della forza che anima Zivago e lo distanzia dal marito di
Lara? Il Cristo delle sètte russe o quello evocato dalla visionaria
Sima, il Cristo che nasce dal rituale orientale, e già si era reincarnato in una figura del romanzo russo, nel principe Myskin.
Myskin affrontava disarmato il male e lo scioglieva in quello
che i manuali devozionali ortodossi chiamano «il fiotto rinfrescante delle lacrime», nella confessione, provocando il malfattore
con osservazioni che mettevano a nudo la tristezza desolata, lo
sforzo immane necessari a compiere il male. Zivago vive in tempi
nei quali è ben diverso il Nemico, quando esso non è più il solo
male della vita, ma la non-vita; quindi guarda alla vita nella sua
complessità, dove male e bene s'intrecciano, come a ciò che
preme custodire nella sua interezza. In un mondo dove l'apatia e
l'inerzia per cui «tutti si foggiano su qualcuno... o semplicemente
si imitano a vicenda», spengono la vivezza del sentire o la seppelliscono sotto la soglia della coscienza, la vita, viluppo di serpi e tubare di colombi, diventa benedetta in sé. Perciò in Zivago rivive,
ma oltrepassato, diventato naturalezza, Myskin.
Zivago e Lara sono invero scandalosi rispetto alla società in cui
si trovano a vivere, appunto perché è loro propria «una certa estasi
dell'anima fuor della realtà immediata» come scriveva Chiaromonte. Come si spiega codesto loro stato d'estasi? Dall'analisi
delle poesie in fondo al volume, una spiegazione è fornita: essi indossano le maschere rituali di Cristo e di Maria Maddalena nell'interpretare il dramma sacro che consente di stare nel tempo mitico e verticale del loro amore fuor del tempo reale.
Zivago si sente Cristo scrivendo della notte del Getsemani:
Lo spazio della notte ora pareva
ilpaese dell'annientamento e dell'inesistenza.
La distesa dell'universo disabitata,
e soltanto l'orto un luogo capace di vita.
E interpreterà come Maddalena Lara, corrotta da Komorovskij;
sarà lei a gridargli, nel poema:
Oh, dove mai sarei adesso,
Maestro mio e mio Salvatore,
se durante le notti accanto al tavolo
non mi aspettasse l'eternità
come un nuovo cliente, adescato,
da me nella rete del mestiere.
Ma spiega che cosa vuol dire peccato
e morte e inferno, efiamma e zolfo
quando sotto gli occhi di tutti,
con te, come un pollone ad un tronco,
mi sono conpunta nella mia angoscia senza fine.
Ciò che appare nel corpo del romanzo come realtà visibile mediata dalla società ostile è, al livello della poesia, interpretato nella
sua vita mitica sotterranea, semicosciente: i fiotti di felicità tragica
che investono Zivago e Lara provengono appunto dal fatto che
essi rivivono dei miti, recitano parti antichissime, tradizionali
(nel senso che Freud diede al termine di tradizione: ciò che è stato
perfettamente dimenticato e ritorna irriconoscibile). Il mito cristiano che essi interpretano non è quello consueto, ecclesiastico
(così come Pastemak non è cristiano tolstojano, ovvero non è tale
perché debba pure alla fin fine riallacciarsi a ciò che è vivo nel popolo), ma un mito riatteggiato, con un margine di invenzione ed
arbitrio che lo rende adeguato all'esigenza individuale, e porta in
sé anche tutte le successive correzioni del decadentismo che lo
andò riatteggiando.
v
5. La moralità di Zivago non conosce le buone azioni
Che Zivago sia un uomo morale, che abbia un alone di tal quale
santità è impressione netta quanto imbarazzante, perché non si sa
bene definire di quale sorta sia la sua santità. Zivago non si adatta
a un sistema casistico, ma di certo ha in ogni momento della sua
vita un atteggiamento esemplare. Infatti non sacrifica mai a
schemi generali, a «parole» vaghe il valore unico, irripetibile dell'esperienza singola. Di fronte ai dilemmi morali che lo costringono
a una scelta (stare con la moglie o vivere con Lara), egli temporeggia, differisce, sogna di risolvere tutto nella confessione bruciante,
non per ipocrisia e indecisione (per quanto anche questo appaia in
lui e sia un momento della situazione interiore), sibbene per timore di oltraggiare la vita operando un taglio netto e crudo, sacrificando qualcosa. Quando sente crescere in sé l'amore per Lara,
teme di «essere come un delinquente» con la moglie Tonj a, che egli
«ama fino alla venerazione». Eppure, nel fitto del tormento riesce
a mantenere una zona di calma, di serenità dentro di sé, non con
l'ironia, arma volgare di difesa, ma con l'attenzione implacabile:
Aveva forse tradito Tonja, preferendole un'altra? No, egli non
aveva scelto, non faceva paragoni. L'idea del «libero amore»,
espressioni come «i diritti e le esigenze del sentimento» gli erano
estranee. Parlare e pensare così gli sembrava indegno. Nella vita
non aveva colto «ifioridel piacere», non si era mai accomunato a
superuomini o semidei, né aveva chiesto per sé privilegi e vantaggi, e sotto il peso della coscienza inquieta si sentiva esausto.
La vita, egli proclamerà, non è un materiale che si possa «trattare»
secondo certe regole. Dovrà egli preferire Tonja a Lara, rispettando ciò che ha maturato i propri diritti? No, salvo cadere nella
grettezza, nel mortuario dominio del passato e della lettera morta
sulla vita. Ciò che rende drammatica la sua situazione è l'amore
per Tonja, non i diritti e i doveri che li legano. Deve preferire dunque Lara in quanto ha il diritto di accogliere i nuovi sentimenti e
la nuova esperienza? No, salvo cadere nello svilimento d'un esercito di diritti, in un livellamento dell'irripetibile a «una delle tante
esperienze possibili e permesse». Come uscire dal dilemma? Rendendosi conto che non è possibile uscirne, che non esistono vie
tracciate fuorché nelle terre già battute da tutti, mai in quelle che
a noi tocchi scoprire e percorrere. Una paradossale uscita che è
anche chiusura nell'angustia e nella rottura della particolarità irripetibile è appunto quella di Zivago: rendersi conto che la fedeltà
non è servitù ma senso della particolarità irripetibile dell'amore,
che appunto in quanto irripetibile, non può essere tradita.
Del resto, a trarlo fuori dalle secche della casistica provvedono
i tempi, o il loro spirito, sotto specie di tre cavalleggeri che lo sequestrano per il servizio nel distaccamento partigiano. Nell'esilio
forzato gli accadrà di domandarsi quale sia la particolarità irripetibile che lo avvince a Lara. Lo farà, quasi senza avvedersene, nella
scena più alta del romanzo, là dove egli assiste ammaliato ai sortilegi d'una maga siberiana per liberare una mucca da un foruncolo. La maga evoca nel suo vaniloquio antiche cronache, testi
sacri, leggende, fatti presenti, e osservandone la singolarità-coralità popolana-dialettale di colpo Zivago ha anche lui una visione:
con un giro di spada è divelta a Lara una scapola, e se ne sviluppano a nastro le città, le strade, le case, gli spazi stranieri da lei abitati. Che cosa di tutto ciò ama Zivago?
«Come l'amava? Per quale aspetto? Qualcosa forse che poteva
essere identificato, distinto in una scelta? Oh, no, no! Per quella
linea inimitabile, semplice e netta con cui in un unico tratto l'aveva tracciata dall'alto in basso il creatore.»
Ancora una volta siamo al motivo fondamentale: la vita, la
creatura umana sono da accogliere nella loro interezza. Felicità è
ormai essere in contatto con la vita tal qual è, miscuglio di esaltazione e sofferenza. Grazie all'attenzione verso la vita Zivago riesce
a compiere i suoi miracoli; grazie alla sua attenzione verso Lara
egli la trasfigura e la fa vivere in perfetta consapevolezza e intensità; grazie all'attenzione verso la natura la sua esistenza è animata
da una vibrazione particolare, da «qualcosa di diafano, di bianco
e nero, di odoroso», da una sensibilità che lo avverte della presenza nella campagna del ciliegio selvatico, che gli consente di riprendere contatto con il particolare incanto della terra odorosa,
inumidita da fiocchi di neve stemprati a mezz'aria a maggio.
Tale orfismo è l'unica proprietà dell'uomo che lo solleva sopra
gli agglomerati perfetti di termiti e api, alle cui meraviglie egli biecamente agogna. Orrendo a pensare è lo smarrimento dell'uomo
d'oggi, che considera l'orfismo un fiore del male, e non esita a reciderlo. Uno di tali fiori è Lara Fèdorovna, che un giorno usci di
casa e spari, forse in un campo di sterminio per donne.
«Tempo Presente», anno III, n. 2, febbraio 1958.
Intrìso di pietà in un'epoca empia
Che cosa avverrebbe se una pianta dirigesse consapevolmente, pianificasse la sua crescita? Svilupperebbe soltanto lefoglieo i rami o il
tronco, non potrebbe mai attingere l'armonia naturale. Cosi
l'uomo che penetrasse le leggi del suo destino e volesse regolarlo,
lui, in luogo delle filatrici eterne, si convertirebbe in mostro: il segreto della vita è l'abbandono. Cosi dichiarava la sua particolare
fede Pastemak all'inizio del racconto giovanile L'infanzia di Zenja
Ljuvers(tà. Einaudi, 1959). È questa l'intuizione centrale di Pasternak, e il suo stesso stile è frutto di abbandono allo spirito geniale del
linguaggio, piuttosto che applicazione di principi poetici. È un'intuizione tremenda, non certo un invito all'idillio: legge della natura
è il mutamento costante, quindi il sacrificio, la morte e la rinascita
perpetue. Zivago è l'eroe, l'eletto perché accetta di morire e rinascere, ed è un uomo conciliato con la natura, cioè felice (a dispetto
dei dolori che lo colpiscono) perché in un mondo d'uomini costretti al sacrificio dalla dura necessità, egli sacrifica volontariamente, accoglie lo strazio come la gioia. Zivago vive una vita senza
illusioni, eppure ardente, non crede che l'uomo possa dominare la
storia più di quanto non possa dominare la natura e pure partecipa
intensamente alla storia. Pasternak e la sua proiezione, Zivago,
sono intrisi di pietà verso l'uomo e la natura, come l'antico Enea,
perciò riescono pressoché incomprensibili in un'epoca empia.
Portato sulla ribalta della vita collettiva nel modo più violento,
Pasternak si comportò con perfetto abbandono, con costante ingenuità, e la parola va intesa nel suo doppio senso: egli fu ingenuus,
ossia libero. Quando dovette affrontare sotto gli occhi di tutti il
dialogo con le autorità politiche del suo paese, riuscì a non lasciarsi turbare, a serbare la spontaneità dei gesti: non trasparve in
quel momento né umiltà né orgoglio, né paura né sfida. Le sue risposte pubbliche, le sue lettere, i suoi telegrammi avevano un
suono di cui s'era perduta la traccia in un mondo diviso fra la rettorica e la freddezza scientifica, si udiva l'accento quasi dimenticato di un uomo intero, che parlava con l'abbandono, insieme, di
un familiare e di un principe. Era come un uomo nudo fra guer-
rieri in cotta e celata, che sgomentava tutti. Si sentiva che le sue
dichiarazioni non erano state meditate o calcolate, che l'unica
preparazione che si poteva essere concessa era l'esortazione: «Non
siate solleciti di ciò che direte».
Salutarmente delusi furono i suoi ammiratori spurii, coloro
che avrebbero voluto si attenesse ad un ruolo prevedibile, egli non
diede soddisfazione ai padroni politici né concesse ai loro avversari lo spettacolo di un ribelle inflessibile. Patetico, incurante e armonioso, apparve durante i mesi di strane tentazioni, persecuzioni minacciate, ricatti.
Fu miracolosamente se stesso, e nuli'altro, talché non poterono
capirlo né i politici né gli artisti, gli uni e gli altri irritati da un
uomo che non può e non vuole lasciarsi imporre il marchio d'una
dottrina politica o poetica.
Verrà forse il tempo in cui la particolare mitezza e pateticità,
l'eroica noncuranza e la serietà mortale di Pasternak saranno pressoché incomprensibili, come a noi oggi le pagine degli antichi rituali. Verso la fine dell'era borghese visse in certi interni borghesi
un'umanità delicata e forte, di cui Proust e Rilke e Pasternak
hanno serbato l'essenza.
La casa paterna di Pasternak fu un'oasi di quella fatta: il padre
pittore preso dalla sua opera calma e franca, gli ospiti seduti al pianoforte, la figura leggiadra della madre; erano come piante di serra,
fresche anche se di fuori dominava il terrore. Poiché Pasternak fanciullo conobbe quel privilegio e quella dignitosa umanità (quelle
note, quei sentori, quei bisbigli amorosi, quelle conversazioni), e
ne serbò il ricordo e la fede, i difensori dello squallore e dell'ottusità
lo censurarono e tentarono d'accantonarlo. Ma l'unica speranza di
bene dovrà cercare la sua forma nel ricordo di quel mondo sciolto
dall'ombra del privilegio e non nel risentimento degli oppressi. E
se verrà cancellato perfino il ricordo di quell'agio e di quella grazia?
Si affronterà lo squallore, disposti alla metamorfosi tragica, rispose
Pasternak, affermando che di là dalle apparenze gli accadeva di
udire crescere l'erba dove tutto pareva brullo.
«Telesera», 31 maggio/1 giugno 1960.
Contro i fantasmi della decadenza:
il testamento etico di Benedetto Croce
Una invincibile decadenza sfibra le istituzioni e gli uomini dopo
il Novecento, ormai tocca a pochi sparsi spiriti ravvivare con quotidiana solerzia e fede in se stessi e, possibilmente, anche fra di
loro l'idea della sanità spirituale. Tale, in breve, è il testamento lasciato da Benedetto Croce dopo aver quietamente combattuto
per una lunga vita i potenti fantasmi della decadenza, ora con il
più grazioso degli esorcismi, la facezia, ora con la vibrazione addolorata dell'orazione pedagogica.
Ma preme rammentare soprattutto come egli rifiutasse l'anima
della modernità non in nome delle verità metafìsiche e della filosofia perenne, ma della libertà fine a se stessa. L'anima del mondo
moderno è stata pesata e trovata mancante sulla bilancia del soprannaturale, ma anche su quella puramente umana e umanistica: non solo essa risulta priva di valori eterni, ma anche di stimoli vitali e di giustificazione storica. Croce infatti era d'opinione
che «la storia s'incarica di confutare il dualismo fra Dio e il diavolo; e in verità lo supera come non poterono le escatologie né del
parsismo e neppure del cristianesimo coi loro assunti della vittoria finale di Ormuzd e del regno di Dio, che annunciavano la
chiusura del processo della storia ossia la fine del mondo»; egli vagheggiava una saggezza goethiana, ricusante ogni ascetica, disposta perfino a divertirsi con Mefistofele, intrattenendolo nel suo
spazio distinto e ineliminabile, dato che comunque a subirlo si sarebbe in ogni modo costretti dalla pressione stessa della storia,
ossia dalla mutevolezza d'ogni valore e cosa.
Che le escatologie sieno, come afferma il passo crociano citato,
in qualche modo superabili è dubbio, ma non è argomento da potersi affrontare qui e ora; interessa piuttosto la coincidenza dei
giudizi che il superando senso escatologico ed il suo superatore
concordemente danno di un male del mondo moderno perfino
peggiore della carne e del vizio: l'inaridimento dell'esistenza
stessa, anche della più grezza e puramente vitale, il suo ridursi a
imitatio instrumentorum, ad imitazione dei mezzi meccanici. Tali
sono i caratteri dell'èra attuale, da far inorridire anche chi come
Croce non riverisca affatto il diritto divino e il diritto di natura e
non condivida le antiche condanne della carne.
L'idiozia attiva del mondo moderno non è una tempesta di empiti carnali e di furori ambiziosi, tutte cose che Croce, con
Goethe, riteneva legittimabili, ma la necrosi d'ogni inventiva spirituale ed il ridursi dei palpiti del cuore, feroci o soavi, brutali o civili, mondani o ascetici che sieno, al secco rintocco d'un metronomo collettivo. Più che di un'infezione si soffre d'una degenerazione e d'una sterilità.
Lo si avverte per mille sintomi, che Croce elencò mirabilmente. L'uomo moderno, innanzitutto, separa i fini dai mezzi,
inibendosi così la spontaneità, condannandosi ad una meccanicità senza vita: infatti «è da abbandonare l'idea che si suole avere
della finalità, secondo la quale si porrebbe il fine come qualcosa di
fisso, come un disegno che si vada poi eseguendo. L'uomo opera
caso per caso e d'istante in istante, attuando la sua volontà di ogni
istante e non già quel disegno astratto che si dice fine. Da ciò
anche la conferma che non è possibile fissare modelli o tipi fissi di
azioni: colui che cerca e aspetta codesti modelli e tipi è un individuo che non sa volere, privo di quell'iniziativa e di quella creatività, di quella genialità che non è meno indispensabile all'attività
pratica di quanto sia all'arte o alla filosofia». L'uomo d'oggi è paralizzato dalla sterilizzante suddivisione, perfino in arte egli
scinde il contenuto dalla forma, il fine e il mezzo. Ritornare alla
libertà vorrebbe dire obliare queste divisioni dissennate.
Inoltre delle due «scienze laiche», l'economia e l'estetica, la
prima viene nel mondo moderno sempre più assoggettata a una
sua parte, la ricerca scientifica empirica, oro maledetto che converrebbe riseppellire sotto il Reno: l'uomo ormai idolatra le
scienze empiriche e si trastulla con le «visioni dell'universo» che se
ne estraggono a furia di fantasticherie (Croce confutò avanti la
lettera il futurismo cosmologico di Teilhard de Chardin: a pagina
114 di Teoria e storia della storiografia). D'altro canto la sfera estetica, si è andata contraendo come pelle di zigrino: si scambiano
per arte balbettii, rantoli, scarabocchi.
Con pazienza ammirevole quel senso del dovere quotidiano
che rende l'uomo minuzioso e solenne come un calcare in lento
accrescimento, o un'onda che erode la roccia, una pianta di lentissima crescita, Croce insegnò a deridere e disprezzare l'arte moderna, aggiungendo di giorno in giorno nota a nota, appunto ad
appunto.
Spesso, è vero, egli contrappose ai moderni non già i sommi
classici, ma certi borghesi maestri della sua gioventù; questi comunque erano pur stati uomini (un po' miseri ahimè) e non viziosi fanciulli. Domestico e faceto, Croce riuscì a fugare, per sé e
per i molti che lo seguirono, gli effetti della suggestione collettiva,
le grandi operazioni di magia nera cui venivano via via soccombendo i suoi contemporanei: il culto della scienza positiva, quello
del quarto stato, quello della nazione (e quanta veemenza, dietro
l'aria tutta domestica, ci voleva per respingere l'ubriacatura della
prima guerra mondiale e la tentazione di diventar disumani a
causa della seconda) e infine e non ultimo, il culto dell'arte moderna.
La difesa crociana contro i sortilegi che riducono l'uomo a un
infante suggestionabile, placato da giochetti, intimidito da futili
minacce («bisogna stare col proprio tempo!»), inebriato da cigolìi, incapace di distinguere fra oggetti degni e immondizie, è tra le
migliori garanzie, a tutt'oggi, della nostra indipendenza. Ed era
necessario un coraggio civile quale oggi è pressoché scomparso
per reggere durante tanti anni senza cedere, quel coraggio che è
condizione della retta conoscenza, simile al baluardo di monti
che difende dai venti la superficie d'un lago, nella cui calma è dato
a ogni oggetto di specchiarsi.
«Corriere della Sera», 25 febbraio 1966.
Scritti sulfurei
Ormai pochi sentono ripugnanza per l'ovvio, e
soltanto una tale ripugnanza distingue la cultura
dalla divulgazione. L'ovvio dovrebbe permettere il
silenzio, che è la terra donde germogliano fiori e
frutti; quando si comincia a divorarla, l'ovvio, la
terra è segno che Nabucodònosor è impazzito.
Mezzacultura*
Nota introduttiva
Sotto l'etichetta di «sulfurei» o semplicemente «polemici» sono
raccolti scritti zolliani apparsi su quotidiani e riviste nel periodo
che precede, coincide e scavalca gli anni della contestazione sessantottesca. In una vena caustica, irridente, rabbiosa affrontano i
temi allora scottanti di critica sociale e di costume, denunciando
vizi nazionali come nella rubrica La fissa dei serpenti del settimanale «Il Punto», sparando sarcasmi sulle avanguardie, lamenti sul
neolassismo conciliare e la soppressione del latino nei programmi
scolastici; duettando col cibernetico Silvio Ceccato sul tema allora
chiacchieratissimo dell'alienazione, scontrandosi con chi contestava a Zolla gli attacchi al cinematografo, gli affondo contro l'erotismo di massa; mettendo a fuoco sulle pagine di «Elsinore» (la
* «Il Punto», 25 febbraio 1961.
249
rivista romana diretta da Giuseppe Barillà, Luigi Piredda e Gaspare Barbiellini-Amidei), i guasti del culto della scienza prodotti
dall'idolatria illuminista, e sul «Corriere della Sera» certi vizi dei
sociologi di Toronto, in primis Marshall McLuhan: «costoro» dichiarava nel 1962 «non sanno limitarsi a interrogare la realtà per
discernere il vero dal falso, ma vogliono anche rassicurarsi assumendo atteggiamenti ottimistici, positivi, costruttivi e la preoccupazione per l'atteggiamento dovrebbe essere lasciato alle mannequins». In un elzeviro di poco posteriore, dove il bersaglio erano i
prodotti adulterati dell'industria culturale, «gli avanzi di cultura»
asseriva «sono persuasi di avere un potere immenso, pari alla dignità dei testi da loro coltivati da ragazzi, e nella misura della loro
alterigia distribuiscono esortazioni all'umiltà oppure si propongono di entrare nella macchina del potere per impadronirsene [...].
Il maccartismo e il poujadismo furono le ultime manifestazioni
dell'odio di massa per gli intellettuali. Ormai i furori che ancora
covassero non avrebbero un bersaglio vivo ma soltanto il ricordo di
una grazia antica, scambiata per privilegio e calpestata. La pace è
firmata, anche perché gli intellettuali hanno tutti la faccia dei loro
persecutori e possono, anodini quali sono ridotti, indrappellarsi
con i personaggi dell'industria culturale [...]».*
In quegli anni tuttavia Zolla non si limitò a gettare l'anatema
su quelli che ritenne i mali irreparabili della mentalità progressista, ma prescrisse antidoti, indicò vie d'uscita attraverso una predicazione tanto più tartassante quanto più filtrata da un interno
impassibile.
Se talvolta quelle prose suonano stridule per una petulanza di
troppo, i temi del contendere rimangono attuali nel senso che
oggi si vivono in maniera per lo più acritica e passiva, gli effetti di
ciò che egli denunciò e in certi casi previde prima che i fatti avvenissero.
* Avanzi di cultura, «Corriere della Sera», 13 maggio 1963.
L'alienazione
A parte la storia della parola, il suo uso attuale è talmente fluttuante che essa è diventata uno di quei recipienti che proprio per
essere vuoti o di contenuto mutevolissimo si prestano a una particolare forma di frode: un motto, un vocabolo ripetuto nella misura della sua perdita di significato diventa un polo d'attrazione
per tutto ciò che si agiti confusamente, inconsciamente, stoltamente nell'uomo; tanto più attira quanto meno è salda la psiche
o attenta la ragione. «Il rinnovamento dell'Uomo», «l'Uomo
nuovo», «la liberazione dell'Uomo», «l'emancipazione della Persona» (e via raccattando quest'immondizia verbale) sono tutti
magneti per gli animi fluidi i quali s'indurranno a credere che la
loro personale ossessione, quasi inconfessabile smania e persistente fantasticheria formino la sostanza di quegli effetti. Di qui
la funzione sociale formidabile delle frasi vuote, delle indicazioni
indeterminate, che sono in realtà un appello a tutte le persone variamente malate a riunirsi, se non altro per spegnere la loro inquietudine in un'azione purchessia, nella quale hanno magicamente proiettato i loro poveri, privatissimi deliri. La massima socialità si nutre della massima privatezza attraverso la mediazione
dei motti insignificanti. Lo si vede allorquando mai un utopista
voglia concretare in un programma legislativo qualcuno di quei
motti: nascono opere non già di sogno bensì di incubo, quali
sono all'occhio di un uomo esperto di vita pratica e tuttavia non
disonesto le varie utopie; eppure è un'utopia che gli storici della
letteratura spesso attribuiscono al genere comico e d'umor nero a
nutrire nascostamente di sé le dottrine politiche oggi più potenti:
il Falansterio di Fourier (e non è certo a caso che il maggior umorista del Rinascimento italiano come il Doni fosse altresì un facitore di utopie). Nei Ragguagli di Parnaso Traiano Boccalini già
smantellò nel secolo XVII (e, per chi rispetti la mente umana, in
modo conclusivo) le formule «rinnovatrici» dell'utopia. Oggi gli
utopisti tacciono, la massima concretezza che raggiungano è
l'urlo o la lagna, la reiterazione delle parole dianzi menzionate,
con preferenza particolare negli ultimi anni per uno spauracchio
o (per gli animi malcerti) attraente fantoccio, un relitto delle utopie dei tempi artigianali: l'Autogestione, angelica parvenza destinata a liberare da un indeterminatissimo mostro, l'Alienazione.
L'uomo soffrirebbe (cosi tutti garantiscono) perché alienato. I
fraudolenti si guardano bene dall'aggiungere da che cosa lo sarebbe, anche se amano dissertare sulla causa per cui lo sarebbe. Le
utopie ottocentesche, eredi dell'illuminismo, pretendevano che
ogni sofferenza avesse per origine un'alienazione dal mondo dei
desideri e degli scopi puramente umani, cagionata da quello
schermo deformante che a loro avviso era il sacro o il soprannaturale o la trascendenza. Il fatto che i luoghi dove si è estirpata fino
all'ultima traccia questo schermo siano colmi di sofferenze nuove
oltre che delle antiche, non indurrà certamente i seguaci di questa scuola a mutare avviso; l'allucinogeno, i vari deliri delle società
pagane (i circensi, l'erotismo, il culto dell'imperatore o dell'impero) hanno usurpato il posto dei riti e delle orazioni e dei pellegrinaggi, ma costoro continueranno a proclamare che «la decima
del prete è più intelligibile della sua benedizione». Continueranno a balbettarlo anche sprofondando nei viaggi psichedelici,
ricevendo cioè i sacramenti di una religione che per essere satanica essi non considerano alienante.
Da un intervento a due voci con Silvio Ceccato dei primi anni Sessanta.
Da parte sua l'ingegnere Ceccato rispondeva al quesito come «costruirei una macchina che dovesse riuscire alienata». I due testi su tre colonne
comparivano su «Tempo libero», un foglio di contro-tendenza costellato di schizzi, caricature e slogan incitanti a: «fare alla guerra, correre
come un cane matto, fare all'amore, essere un amico dei fiori o un fior
d'altro, fare all'amore ma non la guerra, essere Op, fare un tubo, do it
yourself, sparare a chi ti pare, leggere ciò che ti piace, scrivere le cose mai
scritte, dire le cose mai dette, bere a più non posso, dire di si a tutto di
no a tutti, ma guardare in faccia a chi so io e sa anche lui» (il tutto digitato in maiuscolo sull'apice della pagina a stampa).
Come nasce l'antisemitismo
Quante volte capita di illudersi di parlare con una persona assennata e decente e d'un tratto scoprire che cova il vizio segreto dell'antisemitismo? La malattia è rara fra gli operai, ma diffusa in
varie forme fra quasi tutti gli altri ceti: fra piccoli imprenditori,
impiegati, professionisti più o meno frustrati, borghesi e perfino
intellettuali malriusciti. Si va dall'antisemitismo di certe cerchie
mondane tradizionaliste che sembra inoffensivo perché allegro e
simile ad altri tratti di pari idiozia (come il discorrere di jettatura
con la stessa faccia melensamente ironica d'obbligo per il giocoso
vilipendio degli ebrei), all'antisemitismo virulento, organizzato
in forme ossessive, che non rifiuta alcuna contraddizione pur di
ritrovare in ogni fatto l'opera del Nemico: nel bolscevismo come
nel capitalismo, nella guerra come nel pacifismo, nell'arte astratta
come nella difficoltà di far carriera in un giornale o in una clinica
o in una cerchia di operatori di borsa. La forma ossessiva e delirante si trova fra artisti misconosciuti, giornalisti che non riescono a scrivere articoli vendibili, imprenditori ostacolati nelle
operazioni di credito bancario. Fra i due estremi dell'infezione
mondana e della forsennata, c'è un trapasso graduale come in
altre forme di aberrazione. C'è chi accetta di osservare con interesse che si giocano certe partite di calcio e c'è chi a causa d'una
partita non s'accorge che un dittatore sale al governo, oppure
muore d'un collasso cardiaco sugli spalti d'uno stadio; c'è chi accetta senza difficoltà di ascoltare una canzonetta e c'è chi tende la
mano trepida ad accendere la radio appena desto per tema di sentire il silenzio.
Il male dell'epoca sta nel non mostrare mai sdegno verso le malattie dello spirito, onde queste nei più fragili possono allignare
senza che all'inizio vengano curate, sicché quando diventano epidemiche non esistono più difese di sorta, ma tutti inclinano senza
avvedersene alle forme più acri. Cosi può capitare di udirsi replicare, se si mostra naturale ribrezzo dinanzi ad una battuta antisemita: «Ma via, si scherzava soltanto», oppure addirittura: «Ma lei
è ebreo? No? E allora?».
Del resto non è nemmeno dato di reagire con argomenti all'antisemitismo, perché esso è simile al turpiloquio, alle smanie
sportive: salvo nelle forme esacerbate, sa già benissimo d'essere
cosa ridicola e abietta [...]. Eppure non resta se non tentare di
chiarire quale sia la genesi del male fra i tanti il più orrido, che
proprio in questi giorni torna a turbare, non solo nelle miti (e in
apparenza inoffensive) forme quotidiane ma in quelle più mostruose. «A chi la colpa del male?» soleva domandare Hitler, e generava angoscia fra i suoi ascoltatori, per tosto scioglierla additando loro qualche vittima sacrificale gratuita. Quell'angoscia
non bisogna anestetizzarla, ma sentirla fino in fondo; le folle hitleriane provavano angoscia perché sapevano che esse erano le
colpevoli. Cosi siamo colpevoli noi, singolarmente, per ogni tolleranza dinanzi all'espressione anche mite e scherzosa del male.
Ma come sorse questo male?
Con la nascita di un'economia mercantile e manifatturiera nei
secoli XVII e XVIII la separazione delle comunità ebraiche dalle
cristiane comincia a perdere senso, e si procura di conciliare l'antico col nuovo mediante l'istituzione di uno stato intermedio fra
l'ebreo confinato nel ghetto e il libero cristiano: le comunità privilegiate in Francia, gli ebrei di corte o i GeneralprivilegierteJtulen
prussiani. Si formò una classe di banchieri ebrei legati all'aristocrazia, favoriti dalla facilità di trovare corrispondenti in ogni
paese, strumenti commerciali essenziali alla vita economica internazionale e alla finanza statale. La loro utilità fu riconosciuta nell'età mercantilistica, elogiata da Colbert come anche dall'articolo
«Juifi» attribuito a Diderot, nella Grande Enciclopedia, e di conseguenza si ebbero ebrei titolati e socialmente capaci di ottenere
protezione dai sovrani. Questa classe di banchieri, se da un verso
trovava nel seno delle comunità religiose i propri corrispondenti
nei vari paesi, non aveva d'altro canto coscienza politica di sorta e
non favorì certamente la soppressione delle discriminazioni giuridiche, anzi Mirabeau proclamava che si dovevano emancipare
gli ebrei a dispetto della loro resistenza (i ricchi ebrei di Bayonne
e Bordeaux erano emancipati assai prima della Rivoluzione).
La rivoluzione industriale non vede gli ebrei impegnati come im-
prenditori, e l'antica potenza economica degli ebrei di corte viene a
frazionarsi in singole famiglie di finanzieri, come i Rotschild, che
stroncarono tanto la concorrenza di correligionari come di cristiani, imponendo quasi un monopolio finanziario in Europa
dalle guerre napoleoniche alla fine del secolo, con un'indifferenza
politica che era condizione essenziale della potenza finanziaria.
Anche nel caso dei Rotschild il legame religioso poteva essere tramite per stabilire corrispondenze e ottenere una facile rete
d'informazioni, ma non divenne un'ideologia, anche se di fatto i
maschi della famiglia erano tenuti a sposare correligionarie. La
potenza dei Rotschild declina con l'èra imperialistica e insieme
s'allentano nella temperie positivista i legami religiosi delle comunità ebraiche. Dell'antisemitismo religioso antico, con il suo
corteggio di leggende sull'omicidio rituale di fanciulli e sul furto
di ostie consacrate, si perdono le tracce nell'Europa dell'èra manufatturiera e poi capitalistica: i grandi illuministi scartano e irritano entrambi i contendenti, Voltaire non fu attaccato soltanto
dai cattolici ma anche dagli ebrei. Così pure le ideologie rivoluzionarie ottocentesche miravano a escludere l'ebraismo come religione e comunità: il libello antiebraico di Marx era stato preceduto dalle dichiarazioni di Charles Fourier, nel suo Nouveau
monde industriel, contro il sistema di vita antindustriale e ancora
patriarcale degli ebrei.
L'antisemitismo ottocentesco ha tratti diversi dall'antico e cristiano: si nutre di libelli contro la potenza dei Rotschild. Come osservava Engels, esso partiva dall'aristocrazia, ma i suoi partigiani
erano soprattutto piccoli borghesi. La patina era data dal disprezzo
degli aristocratici per i loro tradizionali banchieri, la sostanza era il
risentimento sociale dei piccoli borghesi verso uno strato dell'alta
borghesia. Il pensiero politico ed economico serio non poteva evidentemente fare discriminazioni tra finanza ebraica e finanza cristiana. Nell'epoca dello sviluppo industriale crescente, fino alla
fine del secolo, il problema di codesti sentimenti compete alla patologia del costume; è durante la crisi dell'economia industriale tedesca nel 1873 che l'antisemitismo diventa materia di manipolazione politica, cioè nasce l'antisemitismo moderno.
Il crollo in borsa che colpiva gli interessi della borghesia in ascesa
rinfocolò l'opposizione conservatrice e antiliberale; Wilhelm
Marr fu. il primo a sfruttare la congiuntura con il suo libello Vittoria del giudaismo sul germanismo, considerata da un punto di vista
non confessionale (Cfr. Paul W. Massing, Vorgeschichte des politischen Antisemitismus, pubblicato dalla Europäische Verlagsanstalt,
Frankfurt 1959. Ci si riferisca a questo studio anche per le altre citazioni di fatti e di autori, dell'antisemitismo del periodo bismarckiano). Marr scarta le obiezioni religiose all'ebraismo e perfino le recriminazioni conservatrici sulla parte avuta dagli ebrei
nel movimento di libertà ottocentesco. Egli comincia a delineare
una visione nuova dell'ebraismo, che unisce a spunti di osservazione concreta tratti paranoici: l'ebraismo è una potenza che minaccia di schiacciare ogni altra. Ma se non è provato un nesso
ideologico evidente fra comunità religiosa e imprese finanziarie?
Marr risponde che esiste una solidarietà di razza; inutile opporre
che la libera concorrenza ferve tra ditte ebraiche e che quindi non
solo non esiste prova alcuna che siano legate in cartello quelle tenute da ebrei, ma si ha la dimostrazione del contrario.
Marr usa un argomento che sarà poi tipico: un giornalista non
può scrivere sulla stampa importante perché essa è tutta in mano
a ebrei, e il loro operato è segnato dalla mancanza di principi. È
evidente il risentimento dell'uomo sconfitto nella libera concorrenza, che cerca un imputato per la sua inefficienza o sfortuna:
Marr fa appello non già a strati tradizionali, come i cattolici o gli
aristocratici, ma a una massa di frustrati che il crollo economico
ha accresciuto a dismisura, offre una spiegazione confusa (ebraismo è mancanza di princìpi sani e saldi, un'affermazione che rifiuta di determinare che cosa si intenda per ebraismo e che cosa si
intenda per princìpi sani) e lo slogan di «Nuova Palestina» a denigrare l'opera di unificazione nazionale e di incremento industriale
del cancelliere Bismarck.
A Marr segue Otto Glogau, con un libro nel quale dà una spiegazione dei disastri in borsa sostenendo che le leggi dalle quali
vengono lesi i piccoli borghesi investitori e altre categorie economiche minori sono opera di ebrei, e accusa gli ebrei come entità
ideologica di essere i rappresentanti del commercio, sfruttatori
delle classi produttrici. L'ideologia nazista e le blaterazioni di Ezra
Pound sono così già enunciate da Glogau: «Marx e Lassalle hanno
cercato di risolvere il problema a partire non dalla borsa ma dall'industria, rendendo responsabili gli industriali per tutte le calamità dei lavoratori fomentando l'odio di costoro. Noi li correggiamo: il nostro movimento addita al popolo le radici del suo bisogno nella forza del denaro, nello spirito di Mammona della
borsa».
L'antisemitismo s'afferra a una distinzione degli economisti
cattolici e di Proudhon fra capitale produttivo e improduttivo.
Poiché le forze economiche delle famiglie degli ebrei di corte per
forza di tradizione commerciale si sono indirizzate per lo più alla
finanza e non all'industria, l'equazione fra capitale improduttivo
e ebraismo viene avallata con una parvenza di giustificazione.
Che alla Camera prussiana il capo liberale Lasker dimostrasse durante le sedute di gennaio e febbraio del 1873 come proprio i deputati conservatori e alcuni patrocinatori del movimento antisemita e «produttivistico» avessero parte nelle ditte più losche e speculatrici, occasioni se non cause del crollo disastroso dei titoli,
non poteva bastare. Statistiche non controllate sulla percentuale
di ebrei implicati nella speculazione erano sufficienti a persuadere
i colpiti. Inoltre comincia a manifestarsi la mentalità paranoica
dell'antisemitismo moderno già in questa sua prima apparizione:
lo stesso Lasker è ebreo o finanziato da ebrei, si contesta.
Nel decennio successivo, Stoecker riuscì a promuovere un movimento sempre più forte, dove si mischiavano richiami alla tradizione religiosa, allo spirito nazionale e alla lotta contro la finanza ebraica. A Bismarck esso riuscì utile come pedina contro i
liberali, sicché non esitò a servirsene fino a quando non si impose
una coalizione del centro e dei conservatori, per cui questi lasciarono cadere Stoecker e la demagogia antisemita. La paranoia di
Stoecker doveva incolpare la potenza ebraica della propria sfortuna: non già la politica coloniale e il rafforzamento dell'esercito
sostenuto dall'interesse dell'industria pesante. La politica coloniale e militaristica non aveva bisogno delle ideologie cristianosociali antisemitiche e produttivistiche, e questa verità non poteva essere accolta se non a prezzo del riconoscimento della funzione subordinata dei residui religiosi, dei fossili feudali, della mistica della produzione sana e del capitale pulito.
L'antisemitismo servi durante il decennio 1880-'90 a sfruttare il malcontento delle masse contadine: i nuovi partiti antisemiti, dopo la caduta di Stoecker, irregimentavano le masse agricole che risentivano dell'industrializzazione unendo a programmi antisemiti propositi anticonservatori: Moritz Busch si
incaricò di formulare la nuova dottrina. L'antisemitismo serviva
ormai come ingrediente di due movimenti opposti: il conservatore e il rivoluzionario contadino o popolare radicale. Che cosa
era rispecchiato dalle due tendenze se non il conflitto fra produzione di massa e produzione familiare nelle campagne, la
prima in mano ai nobili latifondisti, l'altra affidata alla classe dei
piccoli proprietari, entrambi alla mercé del grande capitale? Il
nuovo movimento chiedeva la revoca dell'emancipazione degli
ebrei e la nazionalizzazione delle industrie; i conservatori e i latifondisti preferirono a tal punto rinunciare a sfruttare l'antisemitismo, caduto in mano ai loro nemici. Di chi la colpa dell'incomprensibilità del sistema giuridico e burocratico?, si domandava l'agitatore Ahlwart, e incolpava la congiura ebraica di aver
corrotto l'amministrazione dello Stato. Di chi la colpa della
scarsità di mangime nelle piccole fattorie? Dei latifondisti e
degli speculatori ebrei.
***
Perché proprio in Germania doveva prendere forme così vistose
l'antisemitismo? Massing risponde: le altre nazioni avevano
avuto una rivoluzione democratica, mentre in Germania «l'industrializzazione ebbe luogo senza che la borghesia avesse un
forte potere politico. Il piccolo borghese procurò di compensare
la mancanza di potere politico ribadendo penosamente le sue
prerogative sociali» e le ideologie razziste servono assai bene a
dare uno status sociale a chi se ne sente privo; «l'idea popolare
(völkisch) dava sicurezza e orgoglio a classi decadute [...]. Se la
purezza di sangue era l'attributo più importante, allora coloro
che aspiravano a una funzione politica direttiva non avevano bisogno di preoccuparsi di avere beni di fortuna o predicati nobiliari». Inoltre l'attacco contro gli ebrei era poco rischioso tanto
per la sicurezza materiale come per l'equilibrio psichico, meno
pericoloso delle critiche radicali al sistema capitalistico, alla monarchia o al militarismo.
Ma nella competizione politica dell'èra imperialistica guglielmina dal 1895 al 1914 questi elementi psicologici non potevano
essere d'utilità: la competizione per il loro sfruttamento tra i conservatori e i radical-popolari aveva cagionato una svalutazione del
gettone antisemita sulla tavola da gioco delle forze politiche. Allora, senza il conforto di far parte del Leviatano, l'antisemita si
mostra nella sua nudità. Ha dovuto cercare con disperazione di
afferrare un fantasma: la dissoluzione delle comunità religiose,
che colpisce anche le ebraiche, l'ha costretto a scovare qualche definizione di ebraismo che inchiodi in qualche modo la sua ossessione, ha dovuto inventare un legame di qualche sorta fra la casa
Rotschild (che dopo la guerra del '700 perde importanza) e i banchieri, i professionisti, gli uomini politici di cognome ebraico e le
organizzazioni religiose e assistenziali israelitiche, tra rabbini tradizionalisti, cabbalisti orientali e Karl Marx e Disraeli e altre cose
non addizionabili, finché alla fine ha trovato il fattore biologico,
addirittura, di omogeneità: la razza semita in contrapposizione
all'ariana.
Ma proprio quando ha trovato il modo di fingere a se stesso
d'aver abbracciato il suo incubo (sul quale proietta la sete di potenza e di prestigio in lui frustrati, nonché i suoi sogni di rivincita che fantasticano di mene tenebrose da romanzo popolare),
l'antisemitismo s'accorge che la sua malattia è una merce, per
congiuntura politica ed economica, invendibile sia ai conservatori come ai radical-popolari. Tornerà a valere dopo la guerra del
'14, ripresentandosi tal quale. I vecchi patrocinatori del movi-
mento tentarono nel periodo di eclissi di contaminare, se non lo
Stato tedesco, la società tedesca, di vendere al minuto ciò che
non riuscivano a esitare all'ingrosso sul mercato dei partiti.
Ormai a corto di finanziamenti (di chi la colpa? Della finanza
ebraica; come se questa avesse potuto impedire che al tempo propizio le loro casse fossero colme), lanciano campagne per vietare
agli ebrei l'accesso a ritrovi pubblici e alberghi, e ci riescono soltanto per qualche tempo alla spiaggia di Bokum. Alcuni fondano
in Paraguay una colonia che dovrebbe essere paradisiaca perché
pura d'ogni infiltrazione ebraica; ma presto il gruppo si sbanda.
L'antisemitismo diventa appannaggio di sètte agli orli dei manicomi come quella che pubblica i Quaderni di Ostara, capeggiata
da un ex monaco spiritista Lanz von Liebenfels, il quale afferma
essere massimo peccato sulla terra l'inquinamento della fulgida
razza bionda ad opera di Ciandali, ovvero di meridionali nerastri; fra tali settari si cita il Bhagavadgìtà, testo che ha la sfortuna
di essere accetto ai lunatici delle piccole sètte in genere e che condanna la contaminazione della razza ariana. In questo caso, oltre
agli ebrei si protesta anche contro i gesuiti e gli zingari. Hitler da
giovane andò da Lanz von Liebenfels a farsi rassicurare sulla sua
bellezza a dispetto della chioma bruna di Ciandali (Wilfried
Daim, Der Mann der Hitler die Ideen gab, pubblicato dall'Isar
Verlag, Miinchen 1958: è uno studio psichiatrico sui predecessori ideologici del nazismo).
Ma come questa predicazione doveva trovare se non un seguace almeno un ascoltatore benevolo perfino in Strindberg, cosi
non va dimenticato che il delirio di persecuzione proprio di giornalisti falliti, di piccoli imprenditori privati e altrettali poteva allignare anche in un Wagner, il quale incolpava gli ebrei d'aver cospirato contro la sua musica, capeggiati da Meyerbeer; ma in lui
l'odio antisemita giunge a chiara coscienza negativa: «Se la nostra
cultura si sfascia, poco male; guai invece se si sfascia a opera degli
ebrei» egli scrisse, e tentava di dire che voleva l'annientamento del
suo mondo in un'apoteosi ex contrario, e non osando proclamarlo
doveva inventare un incubo di congiure oscure, voleva essere aiutato nel suicidio.
***
Mentre in Germania l'antisemitismo fermenta al limite delle cliniche psichiatriche, in Francia esso vigoreggia con l'affare Dreyfus, e con una particolare sfumatura: nell'odio generale delle
classi militare e aristocratica (che si vedono sfuggire non solo il
potere economico ma la possibilità stessa di capire un mondo
retto da complesse forze industriali e finanziarie) vengono accomunati, come già nella Germania conservatrice del 1848, ebrei e
intellettuali, due tipi di senza patria che i collegi giudicanti e i circoli patriottici vorrebbero far sparire per tornare a filtrar linfa
dalle radici confitte nel dolce suolo di Lorena. Cominciano a infittirsi le leggende: i conservatori francesi accusano gli ebrei di cospirare con la Germania, mentre in Germania li si accusa di non
avere più lo spirito germanico. Più tardi doveva riproporsi lo
stesso assurdo: l'antisemita taccia gli ebrei di essere alleati del comunismo sovietico e nel contempo li accusa di manovrare da padroni la finanza capitalistica.
Come ridurre a una parvenza di senso tali contraddizioni? La
polizia zarista fornisce i Protocolli dei savi anziani di Sion, ovvero
la relazione di un convegno non si sa bene se di alti rabbini o di finanzieri o di ideologi impazziti o di rivoluzionari anarchici con
tendenze al Götterdämmerung, comunque di esseri assai poco realistici, che mescolerebbero infantilmente proponimenti politici e
filosofìa apocalittica. Il falso è troppo evidente, ma già comincia
ad affermarsi in Europa il principio che sarà alla base del sistema
nazista: non importa che si dia prova di un'affermazione, non importa neanche che essa sia plausibile a una mente educata; le persone capaci di criticare sono poche, fra esse molte troveranno il
loro tornaconto a credere; quanto alle persone di tempra mezzana, finirano col dire: «Non sarà vero del tutto, ma qualcosa ci
sarà pur sotto» e il gioco sarà fatto, come nella pubblicità idiota
dei prodotti inutili [...].
Poco è mutato del «materiale umano» che si presta alla manipolazione dell'antisemitismo da allora in poi. Come non fu difficile
persuadere milioni di tedeschi e italiani che la loro incompletezza
umana era dovuta allo strapotere ebraico, così non fu diffìcile far
credere che tanto Trockij come Stalin erano manovrati dalla congiura ebraica capitalistica, e si giunse a far pronunciare da italiani
la parola demoplutogiudocrazia comunista: come dire quadratorotondotriangolare. Che masse inebetite non notino l'incongruenza e siano disposte a prestarsi docilmente a manovrare le
macchine per l'eccidio di massa al fine di evitare incredibili combinazioni internazionali di finanzieri è scontato; gravi restano i
casi degl'intellettuali che si sono prestati al gioco. Jean Girodoux
che nel 1939 al pari di un John Ford monopolista di costruzioni
d'automobili protestava contro gl'immigrati ebrei dei ghetti
orientali che avrebbero «eliminato i nostri concittadini e i loro costumi tradizionali e le loro professioni... sfidando ogni indagine
del censimento, delle imposte...?». E con la stessa irritazione d'un
bottegaio che disperatamente si guardi attorno a cercare la faccia
delle forze economiche oggettive che con l'apertura dei grandi magazzini minacciano di togliergli l'illusione di essere indispensabile,
forse che Cari Gustav Jung, dal 1933 al 1939, non si riprometteva
e non prometteva di eliminare il «giudaismo» dalla psicologia?
La recrudescenza dell'antisemitismo forse si può porre in rapporto con il bisogno di trovare una spiegazione politica ad ogni propria ansia, che in molti viene a non potersi più sfogare nella guerra
fredda; forse in mene di cancellerie. Ma né la spiegazione della psicologia politica né quella della tattica diplomatica sono esaurienti;
l'antisemitismo moderno è sempre stato latente e disponibile per
chi abbia voluto servirsene, dalla crisi economica seguita alla guerra
francoprussiana del 1870; né giova escogitare teorie di archetipi
eterni, poiché è una realtà strettamente condizionata da un certo assetto produttivo e dalle sue conseguenze psicologiche.
L'unica terapia efficace sarebbe di indurre un abito di rifiuto, di
vigilanza contro i sintomi più modesti della malattia, fin dai suoi
prodromi ameni, inoffensivi così come per le altre facce dell'idra,
alla quale si è dato vari nomi, come mentalità autoritaria, spersonalizzazione, massificazione.
«Tempo Presente», anno V, n. 1, gennaio 1960.
La bonarietà
La bonarietà è in Italia la maschera con cui vengono inflitte le più
atroci ferite; non la tensione aspra e goffa dei tedeschi, il dileggio
molto casual e perfido degl'inglesi, la maniera tagliente e inviperita dei francesi, e neanche la brutalità spiccia americana hanno
mai attecchito nel costume repressivo e autoritario italiano; perfino la mistura di turpiloquio paesano e di grinta prussiana che
costituiva lo «stile» fascista fu una divagazione temporanea, un
tratto tollerato, appunto, bonariamente, dai custodi del conformismo. Quando infieriva qualche fascista dèdito alla rappresentazione più coerente della sua parte, i moti di ribellione venivano
sedati dal coro, dai buoni padri di famiglia, che sorridevano benigni, tolleranti: «È fatto così», «Ha i suoi lati buoni, sempre meglio
degli scioperi», «C'è sempre modo di cavarsela, senza fare tante
storie», «In fondo sono bravi ragazzi, la gioventù... », «Se l'ha fatto
avrà le sue ragioni», «Non ci si può opporre ai tempi».
La bonarietà è un'arma molto efficace, chi la combatte cade subito in una luce sgradevole: opporre ad un sorriso saputo la fierezza o lo sdegno rende ostici, per le vittime del tiranno bonario è
difficile suscitare consensi. L'aggressione bonaria non ha bisogno
di concetti difensivi, non deve giustificarsi, ha già nel suo fare
mansueto la propria difesa. La bonarietà riduce tutto a ripetizione
del passato, cita la storia per ammorbare il presente («Ci sono sempre state fazioni», «Noi abbiamo una civiltà vecchia, queste cose
non ci fanno paura»). Essa permea il costume generale al punto
che, qualsiasi cosa accada, ci si sente dire: «Non s'impressioni»,
«Niente di grave», «Non se la prenda», che riduce tutto a paura infantile da dissipare con paterna bonarietà. Chiunque infranga la
regola, chiedendo al bonario di spiegare le sue parole rassicuranti
e insulse, viene condannato da altre parole ancora più rassicuranti
e insulse («Scocciatore», «Pessimista», «Menagramo»), e se mai la
nascosta ferocia si manifesti, non sarà a danno dei violenti (si sa, la
violenza sbollisce, è perfino pittoresca, dura poco e il bonario sorride con chi ghigna, perciò torbidi di studenti, efferatezze di squadracce sono cose da sorriderne e dimenticare subito), ma a danno
dei raziocinanti, che chiedono conto del senso delle parole, mettono a confronto teorie e realtà, osano pensare invece di bonariamente ridere con chi ride e voltar le spalle a chi piange.
Serie sui Difetti nazionali, Rubrica Chiacchiere, «Il Punto», 1961.
La torre d'avorio
D: Vuolparlarci del suo nuovo libro?
R: Che il libro parli da solo.
D : Non crede che vi sia contraddizione tra il rifiuto della cultura di massa e l'impiego, da parte sua, di tipici strumenti di
comunicazione di massa, come la radio, i settimanali, le antologie volgarizzatrici (sulla psicanalisi, moralisti contemporanei, Sade...)?
R: Non scrivo testi per le aziende, ma testi che aziende distratte comprano come fossero scritti per loro. Un giorno
ebbi questo per me lusinghiero dialogo con un dirigente
d'industria:
Dirigente: Ormai vogliamo cose che non siano gergali.
Io: Mi fa piacere.
Dirigente: Lo so, lei non usa un gergo. Ma, come dire...
lei ha un'impostazione mentale gergale.
Uno scrittore è immorale (o molto bisognoso) il giorno in
cui permette che qualcuno gli modifichi gli scritti; finché
vende scritti che non sono destinati per necessità intrinseca
alla vendita, dimostrerà non già la sua contraddittorietà,
ma soltanto la sua mancanza di rendite.
D: Non crede che certa negazione della cultura di massa faccia parte della stessa cultura di massa, non rappresentando un
superamento della medesima, ma soltanto il puro momento
della negatività? Per esempio: certa musica d'avanguardia,
che pretende di negare la musica accademica o facilmente
commerciabile, rientra quasi totalmente nel quadro della
musica industrializzata.
R: Se è d'avanguardia, va da sé che è la faccia uguale e contraria della musica commerciale. Il puro momento della negatività è lo spauracchio col quale si vorrebbe arrestare
chiunque osi pensare: «In fondo, anche nell'uomo più laido
c'è una scintilla divina». «È impossibile che tutto un popolo
sbagli», se volessi potrei anch'io recitarvi questa filastrocca,
ma lo fanno già così bene tutti gli altri che forse è superfluo.
Non conosco esempi di pura negatività assunti dall'industria culturale: sempre c'è nei suoi autori un barlume di consolazione, «la Casina illuminata in fondo al bosco», se non
altro nello stile bonario, come è il caso di certi critici della civiltà di massa che scrivono per il «New Yorker». Ciò che stupisce è che, per la prima volta nella storia, si pretenda in
modo cosi unanime di essere consolati, rassicurati, si voglia
a ogni costo essere confortati dalla «positività». Non credete
che sia un brutto segno? Perché non c'è libro o trasmissione
che non consoli, eppure non basta, coloro che vorrebbero
fare qualcosa di meno doveroso, vengono invitati anche
loro a spendere una parola di incoraggiamento.
D: Nonsiamo inclini apensare con Piovene che lei sia uno scrittore condizionato dai suoi stessi strumenti d'analisi, tanto che
«giungerebbe a conclusioni identiche di fronte a ogni altra civiltà passata, presente ofutura» («La Stampa», 3 marzo 1962).
Ma la soluzione della torre d'avorio non le sembra che possa essere considerata inadeguata alla dinamica contemporanea?
Rj Henry James, soltanto perché aveva raggiunto il culmine dello snobismo, riteneva di poter usare senza ripugnanza l'espressione «torre d'avorio». Non volendo fare
esercizi di snobismo, credo che l'unico modo di usare l'espressione sia quello liturgico. Turris eburnea è Maria
madre di Dio, immagine di verginità, cioè di spontaneità e
gioiosa acccttazione del destino.
D: Cosa pensa degli scrittori italiani contemporanei? Crede
che il livello dell'attuale civiltà letteraria italiana sia superiore a quello degli anni intorno al 1940?
R: Ho letto un poeta, Wilcock; un romanziere, Monicelli;
un saggista, don Milani.
Incontro e scontro con Elémire Zolla, a cura di A. Chiesa, «La Fiera letteraria», 4 marzo 1962.
Invito all'esodo*
L'anima che è legata a qualche attuale o abituale
affetto, a idee o apprensioni particolari, non può
giungere a godere i diletti dello spirito di libertà,
come la volontà desidera.
San Giovanni della Croce, Notte oscura, II, EX, 2
«... M.me Verdurin à M.me de Cambremer, II,
IX, 2.
—... En art, vous savez les fidèles de mes mercredis,
mes enfants comme je les appelle, c'est effrayant ce
qu'ils sont avancés... Tous les ans ça va un peu plus
loin; je vois bientôt le jour où ils ne marcheront
plus pour Wagner et d'Indy.
— Mais c'est très bien d'être avancé, on ne l'est
jamais assez — dit M.me de Cambremer».
Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe
Il tedio è conveniente
L'industria culturale offre un movimento perpetuo entro un sistema di combinazioni fisse, somigliando al caleidoscopio e
anche a certi giochi, come quelli di carte, dove la monotonia fondamentale è tanto ovvia a chi osservi di fuori quanto celata a chi
ci si annulli. Si potrebbe dire che il tedio per la staticità della partita e l'eccitazione per la sua variabilità sono dunque impressioni
nate dal punto di vista, e così si guadagnerebbe il favore di tutti i
conformisti, impegnati a dimostrare che l'unica cosa vera è l'universale relatività, forse con la speranza di persuadere che sia relativa la loro assoluta miseria di esseri che si privano dell'essere. Ma
esistono prove della natura oggettiva di una partita di carte; essa
non può essere narrata, cioè trasfigurata, salvo come pretesto, di
per se stessa si concede soltanto al crudo ragguaglio, come la vi* Sono qui riportati i primi sette dei quindici paragrafi del saggio e le due relative
note. La Nota 9 a p. 200, riferita a Pietro Citati, costituisce il secondo brano delle
Litanie citatiane, pp. 337 s.
cenda degli scambi agl'ingorghi di binari fuori delle stazioni ferroviarie. Anche il comportamento dei giocatori dimostra che il
tedio conduce la partita; essi non riescono a pronunciare durante
il gioco o intorno ad esso se non interiezioni, banalità, fischi, borbottìi, nulla che superi le comunicazioni fra scimmie. Beninteso,
all'origine il gioco di carte fu un'interrogazione di religiosi archetipi, cioè un esperimento sulle varie disposizioni che la sorte o fortuna poteva dare agli elementi eterni del destino; del pari le corse
e gli agoni furono cerimonie sacre, il pallone fu il sole conteso
dalle fratrie zodiacali, ma ormai la lontananza storica da quei significati si è talmente allungata che le loro radiazioni sono, se pur
ci sono, omeopatiche; i cani scalciano sull'asfalto di città come un
tempo raspavano la terra delle selve dove occorreva occultare ai
nemici ogni traccia.
La stessa dominazione del tedio che imperversa per eccellenza nella partita a carte impregna l'industria culturale, matrice di ogni gioco nel quale l'uomo imprigioni il suo tempo. Ci
si potrebbe domandare: se il tedio esala come un banco di vapore dal pantano, perché uomini liberi ci stanno immersi? Non
è forse segno che l'industria culturale appaga un loro bisogno?
Che dunque offre qualcosa di diverso dal tedio. È una riflessione falsa, perché l'uomo che consuma cultura industriale, cioè
concetti e immagini fabbricati da aziende, sarebbe libero soltanto se riuscisse ad astrarsi dal gioco della convenienza economica, ed egli ha viceversa interesse a ostentarsi istericamente interessato ai prodotti. La dimostrazione di questo tortuoso e curioso meccanismo deve partire da certe riflessioni economiche
generali.
Oggi l'uomo è diventato, come usa dire Bertrand de Jouvenel, spostabile; il suo ambiente è fungibile, sicché egli è disposto ad un ascetismo capovolto: per natura, ormai, egli rinuncia
ai massimi beni profani, la propria terra come ente inconfondibile, la salubrità dell'aria, un ruolo sociale nitido, un lavoro sensato, costumi e oggetti d'uso che abbiano uno stile, cibi schietti.
A compenso dell'ascesi, della rinuncia a questi conforti egli
però non riceve beni spirituali, sibbene i materiali che si pos-
sano per caso produrre in serie; all'ascesi egli deve comunque
adeguarsi mediante una varia anestesia. Così i fanciulli oggi
non possono comunque aggirarsi imparando e sbrigando faccende nella bottega o nel campo, non possono giocare ripetendo culti immemorabili per la strada sorvegliati dalla comunità, né bagnarsi nel torrente, né allevare gli ultimi nati, poiché
il padre deve lavorare in fabbrica o in ufficio, abitare in un alveare (meglio se tale resta in modo patente, guai se un regime lo
nomina comunità per decreto), rinunciare alle acque che non
siano piscine pubbliche, limitare le nascite; il padre che ravvisi
nel nido d'infanzia o nel collegio o nella banda di estranei coetanei forme di esilio o nella solitudine una forma di carcerazione per i suoi figli, soffre; se invece giudiziosamente si acceca,
vivrà soddisfatto nell'infelicità.
Gli unici a poter trarre un vantaggio dall'ascesi sono i perfettamente spostabii, che riescono a crearsi falsi bisogni che verranno
soddisfatti. L'allenamento a questo nuovo ordine crea istinti repressi, fiacchi; l'uomo spostabile regredisce di qua dalle passioni.
Il mistico le trascendeva. C'è una somiglianza fra i due, proprio
perché sono i contrari l'uno dell'altro: non sono asserviti ai beni
naturali della terra né l'uno né l'altro.
L'industria culturale è organizzata in modo che questo intorpidimento o malessere rimanga nascosto e insieme si perpetui poiché ad esso conferisce il carattere di una seconda natura. A tal
segno è riuscita nel suo intento che dopo qualche anno di assuefazione sembra di non poter più vivere senza futili servizi. Nessuno è ignaro dell'uggia di questo assetto: così quando si domandi a coloro che hanno acquistato da un anno il televisore se si
sentano più felici di prima, la domanda susciterà soprattutto imbarazzo, perché il motivo dell'acquisto non fu un miraggio di felicità, ma il desiderio di adeguarsi ad un uso sociale; di gettar zavorra nelle ore che figli, moglie, amici, voci del passato colmano
evidentemente soltanto di desolazione inconfessabile. Un antico
peccato spadroneggia in modi nuovissimi; disse Iacopone: «L'Accidia una freddura, / ce reca senza mesura, / posta'n estrema
paura, / co la mente alienata».
Un'anima in due corpi
Ma l'industria culturale è duplice, essa smercia due prodotti adulterati: l'imitazione degli effetti e l'imitazione dei procedimenti di
ciò che fu l'arte, secondo la definizione perfetta che Clement
Greenberg fornì rispettivamente del Kitsch e dell'avanguardia. Il
sentore della musicalità che si coglie nella canzonetta dove la
blandizia melodica è affinata fino al suo più vomitevole distillato,
è corrispettivo all'esercizio musicale delle opere «da leggere più
che da ascoltare». Chi abbia in dono la contemplazione non tollera l'oltraggiosa facilità del commestibile Kitsch, come rifiuta la
simulazione delle difficoltà seriali o elettroniche, le burchiellesche letterarie, le scomposizioni e triangolazioni di spazi.
Virginia Woolf non sopportava un romanzo Kitsch o le ostentazioni della difficile e perpetua adolescenza di Joyce, per uguali
motivi..
Si potrebbe anche dire che l'industria ha una parte maschile, inventiva, ed una femminile, conservatrice: l'avanguardia ed il consumo generale. Nelle fabbriche che debbono reggere alla concorrenza si crea presto o tardi un «ufficio studi», per ricerche, progettazioni, destinato a prevedere i cambiamenti necessari per essere
sempre «in prima fila»; così nel settore culturale della produzione
non basta gettare sul mercato i beni destinati all'immediato consumo, film ovviamente ridicoli, utensili francamente brutti, romanzi furiosamente melensi, trasmissioni crudamente pargoleggianti, bisogna pensare al ricambio, al marketing settoriale, cioè
virilmente innovare.
Ma come le donne possono fare a meno degli uomini, talché nacquero secondo la leggenda regni di Amazzoni che si facevano fecondare una volta e poi respingevano i maschi come superflui parassiti,
così ci può essere un'industria culturale esclusivamente dedicata a
soddisfare il consumo, senza l'avventura delle novità, il dinamismo
delle trovate. È il caso dell'industria culturale sovietica, femminilmente conservatrice, che rimase pietrificata dopo il tentativo di conquista compiuto ai tempi di Lenin dai tecnici di una innovazione
avanguardistica perpetua (Eisenstein, Majakovskij, i «costruttivisti»).
Ma nei casi come il sovietico, d'eliminazione delle avanguardie, nasce una minoranza impotente e irritante, che cova il suo
malessere coltivando tenui stravaganze. In Italia, sotto il fascismo,
molti ragazzi agognavano dischi di jazz, libri proibiti di Hemingway, balli «degenerati e negroidi»; in Russia oggi i loro analoghi riescono altrettanto amabili, purché non si ricordi come saranno sgradevoli quando avranno piena licenza di dedicarsi ai
loro feticci. È una minoranza con la quale in un regime non del
tutto poliziesco (nel quale aumentino gl'impiegati e scemi il numero degl'inurbamenti) bisogna venire a patti, che l'industria è in
grado di soddisfare mediante il suo settore sperimentale, il quale
obbedisce alla moda, figlia della morte. Il suo nutrimento è quello
delle iene: una salma, cioè la nobile cultura dei tempi passati, che
essa nascostamente detesta perché desidera staccarsi soltanto in
parte dal mondo di massa e perciò si volge alla cultura autentica
solo per quel che le basti, per poi straziarla, come a esorcizzarne il
fascino. Ogni nuova generazione deve reagire all'anziana e lo fa
per lo più con la rievocazione parodistica, anche se inconsapevolmente tale, di un dato momento dell'arte antica (sta dicendo, che
lo sappia o no, «quanto peggio tanto meglio», in odio alla falsità
dominante). Un esempio musicale: Stravinskij rifece il verso a
Pergolesi come Picasso alle Meninas di Velizquez come dicendo:
«Questa bellezza insulta la nostra miseria», offrendone una parodia atroce e greve, e tale fu il loro modo di applicare, a quanto li
circondava, il «quanto peggio tanto meglio».1
Dopo qualche decennio l'avanguardia musicale fu a tal punto
di rozzezza, richiamandosi non più a Pergolesi, sibbene magari, a
Gesualdo da Venosa, che ai vecchi. Stravinskij sembrò rappresentare addirittura l'età dell'oro, la serietà, il mondo dove saldi criteri
di bene e di male consentivano equilibrati giudizi, impossibili nel
frastuono di effetti d'altoparlante e di macchine elettroniche, fra
1 • Puskin intuì ciò che si preparava: nel suo dramma su Salteri questi è l'ottimo musicista, zelante muratore del duomo mai compiuto della musica universale, che
Proprio perciò decide di avvelenare Mozart: «Egli ha portato come un cherubino, /
alcune melodie dal paradiso, / per volar via di nuovo, dopo avere / svegliato in noi,
Progenie della polvere, / il desiderio ch'è senz'ali. Vola / via, dunque. Quanto
prima, tanto meglio» (trad. di Rinaldo Kiifferle).
i quadrati dileggi della tecnica corale che divennero norma nelle
sale da concerto. Sempre di nuovo si replica la vicenda del
dramma di Pusikin, Mozart e Salieri, o l'Invidia.
Ma l'uso dell'orchestra per segnare ritmi tambureggiami, i
motteggi che Stravinskij ordiva per medicare in sé il trauma della
compresenza nel suo cuore del circo e del conservatorio, erano già
soprusi, facinorosi più che faceti, dopo i quali, «tanto valeva» andare fino all'ultima feccia, secondo la logica immanente del progresso nel decadimento. Lo stesso avviene in pittura, dove qualche
decennio fa pareva gran coraggio squadrare in modo eroicomico
le figure (operai sironiani, contadini careniani) per rappresentare
la nuova austerità, la cupezza del premio Cremona, oppure, alla
rovescia, accennare a quarti di tono cromatici monotoni, sbiaditissimi a spregio del consumo borghese, oppure appastare omini
disegnati con mano infantile. Coloro che furono avanguardisti a
quell'epoca, dopo aver invano tentato di fermare il movimento
inesorabile, automatico dell'avanguardia, si trovano a rimpiangere come tempi di saldi costumi i loro, oggimai che si confezionano teche con sotto il vetro una mucillagine che appasta forcelle,
vetri rotti, cordoncini, un'unghia. Cominciata la corsa, meglio
farcela fino alla morte, pensano i più abiettamente astuti: e allora,
incapaci di trovare argomenti, ma con fùtile buona volontà, ecco
i vecchi avanguardisti salutare l'avanguardia nuova, da questa
forse un poco corteggiati, disprezzati senza rimedio.
Mesta la sorte dei «superati» volonterosi, pronti a riconoscere il
nuovo, ma non meno triste quella dei «superati» cocciuti, che invocano il braccio secolare, gridano, inascoltati per prove che rechino, alla congiura dei mercanti. Essi debbono infatti dimostrare che l'arte buona si ferma a X, che in seguito c'è stato uno
strano malanno dovuto alla imprecisabile tendenza che muove
l'uomo al vizio, dopo il quale soltanto pochi giovani attardati restano buoni, osservanti di quel tanto di grammatica e sintassi che
loro, ai loro tempi, ancora conservavano, che non avevano cioè
osato buttare all'aria.
Intanto i «nuovissimi» debbono dimostrare come da Giotto si
giunga per un piano, dolce cammino fino all'americana che un
anno fa a Spoleto esponeva pezzi di celluloide, le bambole rotte
dalla sua figlioletta, con la presentazione di un critico assai ingegnoso (Falzone, il quale spiegava come in tal guisa si dimostrassero ormai «sgonfiati gli Zeppelin dell'angoscia»).
Che fine avrà questa fatica dei fabbricanti d'ideologie? Forse
quella prevista da un visitatore d'una mostra italiana a Mosca, il
quale diceva inevitabile l'arte astratta perché quando tutti avranno
la casa non ci saranno pittori a sufficienza, e allora ci vorrà un'arte
che tutti possono farsi da soli. Talvolta il nano con la testa ciondolante, seduto a ridere sul sagrato di paese, dice la verità meglio dei
loquaci incantatori all'osteria.
I bave heard hysterical women say they are sick of the palette and
fiddle-bow (W. B. Yeats, Lapis Lazuli)
Ma come uscire dal giro della ruota? Come non cadere vittime di
queste frivole reazioni automatiche? Come evitare di infierire,
con l'avanguardia, su ciò che è debole e indifeso: il ricordo di
un'arte non asservita alla moda? Di una sintassi e d'un antico decoro linguistico? Il primo passo dev'essere una rinuncia a volere, e
presupporre, che esista un'arte di oggi; di fatto è più facile dimostrare che essa oggi non può esistere, se proprio si vuole restare in
questa cerchia di problemi fatui per la loro stessa enormità. I più
rifiuteranno di fare questo passo, aggrappandosi a professioni di
fede bolse quanto interessate.
Leslie Fiedler, che pure è stato il più intelligente critico della
letteratura americana asservita all'industria culturale, dopo avere
ammesso che un'opera narrativa ha dignità nella misura e nelle
parti in cui non è riducibile al cinematografo (giungendo a capire
che questo è un nuovissimo e grato criterio estetico), ha sentito il
bisogno di presagire un'èra nuova in cui Hollywood perderà il suo
monopolio, in cui i giovani drogati e osceni avranno piena libertà
dall'industria si da creare una narrazione non più di parole ma di
fotografìe in moto. Un ragionamento simile a quell'altro: che
l'uomo morto è una modalità dell'uomo.
Invidiabile fede, si potrebbe dire, se la smania di unirsi al coro
sgangherato che canta nel buio, superstiziosamente, la filastrocca
Tout va très bien, non fosse da supporre forte come la fede.
Rinunciato a dare per certo che oggi ci sia un'arte, che l'èra industriale abbia la sua come qualsiasi altra; riconosciuto che l'ultimo stile in Europa risale addirittura al primo tiranno moderno
(cioè appoggiato al sistema delle manifatture) e fu ahimè il neoclassico; riconosciuta nel romanticismo la rinuncia al gusto, la
perversione che sommerse l'Europa, non a caso, insieme ai primi
prodotti confezionati a macchina, forse si sarà compiuta una purificazione bastevole a vedere ciò che è, senza essere accecati da ciò
che si vuol vedere. Anzi si avrà perfino un canone che mancò agli
antichi: quanto è avanguardia è cultura di massa, una forma volontaristica e calcolata del brutto. Proprio il massimo sostegno
verrà dato a chi abbia l'animo di lasciare i sostegni, e buttandosi a
nuoto, vincendo paura e pigrizia, rischi di affogare.
Si passi di colpo non si dice dalle sale d'un qualche intatto castello ma dalle stanze rustiche conservate in un museo d'arti e tradizioni popolari, alle case dove si acconciano oggi a dimorare: lo
sgomento alla vista di una cosi abissale caduta sarà comune a quasi
chiunque. Ma i più si nascondono il sentimento provato o almeno
lo sciolgono nel modo più spiccio: col saccheggio. Una forma di
utensile, di mobile, di ornamento non ancora sfruttata viene tolta
dal suo ambiente e aggiunta, a riempire di altra paccottiglia la casa
desolante, già cosparsa degli oggetti via via imposti dall'industria
dell'arredamento, dal Mobilerà. Calder al pupo siciliano.
Se dopo il neoclassico non esiste più uno stile europeo, già
quell'ultimo fu opportunamente funereo, e cercò spesso nell'archeologia greca, egizia, o assira il surrogato dell'invenzione.
Tuttavia, con tutte le sue stonature, era uno stile, che echeggiava armoniosamente nelle diverse arti, nella musica compassata
di Spontini e Cherubini; nella pittura marmorea di David, nell'architettura dei quartieri napoleonici; nella poesia aggrappata al
decoro ed ai vezzi mitologici e declamante contro la massificazione dei sepolcri, foriera d'altre peggiori, nelle memorie dove il
personaggio appariva in pose plastiche; nelle ceramiche, nei tendaggi, negli abiti, fino all'ultima delle arti minori.
Il nesso di quest'ultimo stile europeo con Napoleone, di cui
madame de Staèl diceva «è un sistema, non un uomo», cioè con
quel compromesso ch'egli rappresentò tra antico e moderno, tra
la società composita unificata della corte regale e la società
uniforme retta dalla burocrazia imperiale, è chiaro. Le manifatture però non sono ancora le industrie, lo Stato napoleonico è or
ora sciolto dall'idea patrimoniale dell'impero: il neoclassico è ancora uno stile. Si potrà chiamare stile il liberty soltanto a patto di
riconoscere che le sue sinuosità non sono desunte dalla botanica
quanto dalla figura dello scorpione, sotto il quale segno si commemorano i defunti.
Il meglio che si possa fare dopo quel tempo è compiere imitazioni il più possibile discrete del passato meno caratteristico, ogni
tentativo di non firmare la propria figura, il proprio gusto, la propria casa, riesce deleterio. Naturalmente, a mano a mano che ci si
allontana dal passato, diventa più penoso questo ricalco, insidiato
dal sentimentalismo o dalla giustificazione stentorea, ma o si è il
proprio stile, cosa rarissima o non c'è che il contrario: la Modernità, la quale, sotto colore d'essere il non ornato, è il non stile.
Alla dottrina hegeliana dell'estinzione dell'arte per effetto dell'Ironia romantica si è sempre opposto un bonario e becero:
«Tant'è: vedi se dopo è morta». All'esame necroscopico fatto da
Tolstoj in Che cos'è l'arte? sì è replicato che l'opera sua testimonia
contro le sue teorie.
Ma quando si dice che l'aristocrazia tramontò nell'età assolutistica, o nell'età dei liberi comuni, a seconda dei luoghi, a chi verrebbe in mente di contestare additando qualche contemporaneo
proprietario di fondi (o gestore di fattoria comunista) munito di
patenti araldiche? Il ghignetto con cui si accompagnerebbe la replica: «Eccone un esemplare, e voi affermate che la specie si
estinse secoli fa» non sarebbe forse compassionevole? E cosi non
vale la congiura dei Pisoni a refutare la morte dello spirito repubblicano romano avvenuta al tempo delle ultime lotte dei tribuni.
Tolstoj dileggiò nel suo libello la vacua farsa di un'arte che lo Stato
di tipo napoleonico aveva incorporato nella burocrazia con l'istituzione dei Conservatori e delle Accademie di belle Arti, che la
borghesia soffocava coi suoi letali abbracci esigendo «quadri, musiche, poesie, che facciano pensare», cioè sbavature per le fantasticherie untuosamente licenziose o patriottiche o moralistiche. E
denunciò quanto v'era di volgare e ipnotico in quel che sembrava
reazione alla volgarità, in Bayreuth. Dileggio e denuncia che non
sono profezie da cartomante ma definizione di una vita sociale
contaminata dalla rèverie quanto l'anima di Anna Karenina, e
quella vita nutre dei propri veleni la propria arte, talché non può
sviluppare altro che male.
Una tesi già dimostrata
Hegel nell'Estetica osservò a uno a uno i segni fatali.
Lo Stato, dopo la codificazione e l'istituzione dell'anagrafe, toglie la sostanza agli individui perché nello Stato si «suddivide il lavoro per l'universale, come nella società si fraziona l'attività mercantile»; ora, meglio o peggio che ciò sia, esso toglie possibilità all'arte, che poggia sull'identità dell'universale e dell'individuo, quale
esisteva nei tempi antichi, quando il legame sociale non era una «relazione legalefissae precedente che costringesse a necessità», talché
l'uomo, anche se vassallo, formava una totalità con i suoi atti. Noi
esigiamo la consapevolezza e deliberazione per imputare un atto a
chi lo compie, ma Edipo non distingueva fra sé e il proprio destino,
fra mire soggettive e fatto oggettivo. Nello sviluppo di un'azione
moderna «ciascuno incrimina tutti gli altri e rigetta da sé quant'è
possibile la colpa» e così ancora si procura di scansare la colpa degli
avi che gravava naturalmente sui nipoti. Questo distacco dell'individuo dal suo destino non può procedere oltre un certo segno senza
levar la terra di sotto i piedi all'artista, che viene defraudato perfino
di quel genere che sembrerebbe dover restare immune, non avendo
rapporto con la società, l'idillio, poiché «oggi quella semplicità domestica e campestre nel sentimento dell'amore o nel gustare alla libera un buon caffè, è di pochissimo interesse», talché Goethe dovette collegare il suo Hermann undDorothea alle vicende storiche
per evitare che si sciogliesse nella scipitaggine.
Quanto alle altre forme di racconto, in tutte le arti, il protagonista dev'essere un uomo regale «e non per amor dell'aristocrazia
o delle distinzioni, ma a causa della perfetta libertà di volere e
agire che si trova attuata nel concetto di monarca» salvo nel caso
del genere comico che si attaglia a gente impedita. Se in Shakespeare vi sono personaggi di rango basso è perché grazie allo stato
di rivolta sono affrancati, principeschi di fatto. E se ci si delizia di
quadretti di genere olandesi o di ragazzotti mendichi del Murillo
è perché nei primi c'è una «risvegliata libertà spirituale e vitalità»
tenuta nei giusti limiti dalle dimensioni stesse dei quadri i quali
non pretendono di appagarci interamente; i secondi «seggono al
suolo calmi e beati, quasi Dei dell'Olimpo: non parlano, non agiscono, sono uomini di un pezzo, senza noia o inquietudine: e su
questo fondamento di ogni abilità si ha il concetto che di questi
fanciulli si possa far tutto». Ma guai a chi voglia inscenare le «storie domestiche quotidiane», i «lamenti del padre con la signora, la
dipendenza dai ministri e gli intrighi dei camerieri e segretari,
come pure la bisogna della signora con le serve della cucina e le
care, delicate cosucce delle signorine nelle stanze intime», tutto
ciò fa provare ribrezzo come leziosa «voluta naturalezza».
Nei tempi moderni un magistrato è una macchina e «ciò che i
magistrati aggiungono di loro, dolcezza di maniere, avvedutezza
e via dicendo, non è cosa principale e contenuto sostanziale, ma
indifferente e accessoria e gli stessi capi di Stato e generali non
hanno mai potere sostanziale; l'interesse per la figura del soggetto
moderno "si riduce sempre a vedere come gli vanno le cose" senza
rapporto con le potenze oggettive, il diritto, il costume; e la stessa
rivolta o vendetta contro la società "racchiude l'ingiustizia che
vuol reprimere"».
L'ironia nasce da questa condizione. Ironicamente si eleva a
personaggio la miseria del cuore che desidera senza volere, che
fantastica o si compiace delle minime cose quotidiane ed insulse,
e poi si ironizza su ciò che trascende questo covo di suppurazione.
Federico Schlegel, emanando le norme di questo atteggiamento,
ch'egli chiamò poesia della poesia, pose la base dell'avanguardia,
che è la finzione di far arte con l'impossibilità dell'arte, con le
«velleità e le irrisolte contraddizioni del cuore»; egli fu il primo a
promuovere la dissoluzione delle arti, essendo, nell'epigrafica
sentenza di Hegel, «la poesia della poesia nient'altro che la più liscia prosa».
Federico Schlegel infatti fu il primo avanguardista, ovvero, per
usare i termini suoi, fautore della «poesia universale progressiva».
Cominciò dall'opposto, vagheggiando l'ideale classicità contro la
roboante letteratura che «desidera in modo tremendo e sterile,
espandersi all'infinito, assetata di penetrare fin dentro l'individuo». Ma col saggio Ueber das Studium der griechischen Poesie del
1797 egli rovesciò le sue idee secondo quella che doveva essere
una caratteristica dei teorici dell'avanguardia: partire dall'arte e
dalla condanna degli esperimenti e della Sehnsucht per invertire
bruscamente il cammino; forse è il solo modo per aver l'aria di dir
cose che non sembrino mostruose e banali a favore della morte,
perché qualcosa della ragione passata persiste allorché si entra nel
torto, i modi affabili lasciano traccia anche quando si decide di
tralasciarli per entrare nella Suburra e son poi quelli che hanno un
certo pregio per i teppisti. «Moderno, interessante» furono per il
nuovo Federico Schlegel le lodi da sostituirsi a «bello»; egli patrocinò la combinazione di vari generi e la mescolanza della poesia
con la prosa, affermò che l'essenza dell'arte moderna è il suo divenire, il suo rinvio al futuro, precedendo Heidegger e osò scrivere:
«Il filosofo deve parlare di se stesso al pari del poeta lirico»; nel
1800 egli già elogia l'arte come gioco e ironia o, francamente,
cóme buffonata 2 o come coscienza del caos che si unisce alla coscienza di averne coscienza e infine, con parola decisiva: come
manipolazione.
In lui trovi l'elogio della «poesia informale» e «inconscia»
sparsa nell'alma natura, della immaginazione malata, della «len2. Egli parlò di transzendentale Bouffonerie e del buffo come modo di spezzare
senza tregua l'illusione dell'arte. (Questi passi di Schlegel sono in parte raccolti d a
Reni Wellek in History ofModem Criticism, II voi.) . E un accostamento giudizioso di Lukacs quello fra la delusione per lo svanire del citoyen dopo il Direttorio
e la rivolta dell'individualismo sull'«Athenäum», la rivista degli Schlegel; sua intuizione perfetta è la teoria del Biedermeier come diffusione dello schlegelismo f ì a l e
masse dei filistei, primo suggello della fraternità nascosta di avanguardia e Kitsch.
rissima dissezione di voluttà innaturali... di impotenze sensuali o
spirituali», della critica d'impressione; trovi la fede nella critica
come polemica e, in breve, l'intelaiatura dell'avanguardia. Egli affermava nel Discorso sulla mitologia di aspettare che dal caos accettato nascesse una nuova mitologia, sorta non dal mondo sensibile ma dall'arte stessa.
Invano Hegel doveva confutare questo coacervo di parole d'ordine micidiali, di ostentazioni funerarie; con Hegel per l'ultima
volta si osserva il panorama delle varie arti secondo uno spirito
oggettivo, secondo un gusto. Egli dà l'ultimo addio alla pittura ed
all'architettura con parole indimenticabili, e solfato Hermann
Melville saprà comporre con altrettale chiaroveggenza l'epicedio
della pittura italiana ed europea la cui estinzione egli collegò ai
trionfi di Garibaldi (nel poema At the Hosterly).
Anche quando in seguito si osi ribellarsi alle asserzioni provocatorie e narcotiche di Federico Schlegel, il gioco è fatto, qualcosa
sarà ormai inafferrabile, la totalità smarrita. Eppure soltanto tenendo fede alla totalità ed al gusto impossibili si riesce a superare
la soggezione alla moda ed alla madre sua, talché i fedeli riescono
a celebrare ancora i riti estinti ricorrendo ai vari stratagemmi imposti dal rapporto inestricabile di industria e letteratura al tempo
dell'eclissi del tutto (quando perfino la sintesi di fantasia e dottrina, che definiva il poeta, fu sciolta e apparve il livido spettro
dell'incolto ispirato, del brutto veggente). In tale tenebra usurpa
l'ufficio di criterio dell'arte la sua negazione: l'uomo entra nello
stato crepuscolare, fantastica invece di plasmare. Anche l'operaio
alla catena di montaggio, una volta che compia automaticamente
i suoi gesti, fantastica nel vuoto.
Chi perde ciò che possiede acquista un nuovo tipo di possesso,
quello della sua perdita
E lo spirito dell'avanguardia sussurra all'orecchio dell'uomo cosi
conciato, con la voce di un qualche nipote di Federico Schlegel:
«Vi pare necessario che l'uomo abbia due occhi? Uno basta. A che
prò due gambe, quando ci sono delle carrozzine da mandare
avanti a palmate, o, poiché le braccia sono amputabili, a colpi di
fronte in terra, dati di striscio? E due reni, quando ne basta uno e
si salva l'essenziale, cioè l'anima? E due polmoni quando uno si
può estrarre e l'altro tagliare per tre quarti?».
Proposizioni analoghe hanno trovato credito, quando si sono
applicate via via ai varii elementi dell'arte. Va da sé che il tirocinio
artistico può essere superfluo (come braccia e gambe, e perfino
buona parte del cranio), e può esserlo anche la distinzione fra ani
maggiori e minori. La critica d'arte degli ultimi tempi è come la
medicina messa al servizio dei campi di concentramento: fa esperimenti per vedere fino a qual punto l'uomo possa continuare a
vivere in mancanza di questa o quella sua parte, come se l'uomo
non fosse già cancellato dalla terra al momento stesso in sui si sottomette a queste prove senza ribellarsi, al momento stesso in cui
si decide che si possono tentare.
Infatti, dopo di esse, forse che si potrà rieducare a vivere? È a
dubitarne, nelle arti figurative certe tradizioni essendo ormai perdute, sicché non c'è speranza la risurrezione essendo ciò che avviene di là d'ogni speranza.
Gli apologeti dell'avanguardia, che comincia al momento
stesso in cui non si vogliano chiamare caricature involontarie i
quadri di Van Gogh o goffamente disegnati i quadri di Cézanne
(chi non si ribella? Si vorrebbe estirpare il cancro, ma senza scoprirne le tenere radici) non discutono: insultano, fingendo di credere che si giudichi brutto un quadro (almeno: ciò che viene issato
su una parete in un luogo deputato ad accogliere quadri) soltanto
perché non vi si riconoscono certi oggetti, o brutto un pezzo di
musica (almeno: l'insieme di suoni che vengono fatti ascoltare in
sale deputate all'ascolto di concerti) soltanto perché non vi si riconosce una melodia. Anche un uomo assai mutilato è un uomo,
magari tanto più tale perché mutilato, se la prova lo affina; gli apologeti dimostrano questa ovvietà con intollerabile insolenza.
Che la melodia sia usurata dall'abuso dell'industria culturale o
che l'effigie sia usurpata dalla fotografìa e dal cartellone è evidente, ma non ne segue affatto che l'arte sopravviva necessaria-
mente alla contaminazione. Semmai essa può vivere in un'oasi incontaminata (se si riesca a non vedere per qualche miracolo le immagini fotografiche, se si riesca a non udire le associazioni legate
ormai alle melodie tonali).
Quando Robbe-Grillet critica la narrativa tradizionale può
dire ogni sorta di verità, ma non c'è alcun legame fra l'assennatezza delle sue affermazioni critiche e i suoi romanzi.
Quando poi si parli di ascesi dell'avanguardia si cade in un ricatto ancor peggiore dell'insolenza. Intanto è da dimostrare che
di ascesi si tratti e non di mera incapacità; chi ha un braccio paralizzato non sacrifica niente lasciandoselo tagliare (i personaggi di
Beckett sono certamente emblematici). Picasso non ebbe mai capacità di pittore, egli fin dai primi quadri traccia linee di contorno
e poi ci ficca dentro spalmate di colore, sicché poco importa se
alla fine non traccia più contorni equivalenti a quelli che racchiudono, secondo l'occhio dell'uomo volgare, le figure degli oggetti.
Mondrian disegna con tale goffa applicazione di allievo d'accademia i suoi alberi, che tanto vale vederli ridotti a disegnini geometrici per stoffe. Kandinskij figurativo è un cartellonista per turismo in Russia o per esposizione di artigianato baltico. Ma anche
se essi avessero dato prova di buona esecuzione e si fossero poi votati all'ascesi, la questione riguarderebbe la loro personale velleità
di spoliazione e ricerca di santità, non già la storia dell'arte.
Nel 1854 Kierkegaard udì una commemorazione funebre del
pastore Mynster in cui si osò dire che il morto «faceva parte di una
catena che andava dagli apostoli ai nostri giorni», e proruppe nella
sua accusa alla Chiesa gridando all'impostura di un'amministrazione di benefici ecclesiastici senza ombra di fede, sorretta dalla finzione di un'ininterrotta trasmissione della vita cristiana; egli affermò che, quando lo Stato creasse benefici ecclesiastici per una religione il cui dogma fosse che la luna è fatta di cacio, dopo qualche
anno la nuova fede sarebbe stabilita, sulla stessa indifferenza su cui
poggia il cristianesimo «moderno». Che il sacro sia eclissato dovrebbe essere chiaro adesso alquanto più che ai tempi di Kierkegaard, e il caso di un dogma folle e infantile non è più ipotetico, se
si pensa alla scuola di mistica fascista a Milano o alla chiesa germa-
nica neopagana. Ma Kierkegaard trovò un intoppo: quale la data
della morte della religiosità? A furia di cercare, prese a individuare
quanto di esiziale era in Lutero; ma sbagliava, perché non è necessario, nel regno dei concetti, il certificato di morte con la data esatta
o presunta, per attestare che un cadavere è un cadavere. Ora, se si
vuole una data presunta della morte dell'arte, è proprio il momento
in cui non ci si accorge che sono stolte e comiche proposizioni
come queste di Van Gogh, che cosi bene descrivono il volontarismo e la sua compagna impotenza: «vorrei fere il ritratto di un
amico artista, che fa sogni grandiosi e lavora come l'usignolo canta.
Egli è biondo, e vorrei infondere nel quadro l'amore e la stima che
sento per lui. Comincerò dunque con il dipingerlo tale e quale,
quanto più fedelmente mi sarà possibile. Ma il quadro non è completo così. Per completarlo mi trasformo in un colorista arbitrario:
esaspero il biondo dei capelli, mi spingo verso l'arancione, il cromo,
il limone pallido. Dietro la testa al posto del muro banale del povero appartamento ci metto come sfondo l'infinito; uno sfondo
semplice del più carico e intenso turchino che riuscirò a confezionare»: velleità, fantasticherie, prevaricazioni, quali possono sorgere
soltanto se la prima operazione, quella della fedeltà, è negata ormai
alla mano (i primitivi? Erano anteriori alla Rinascenza e religiosi in
modo non soltanto soggettivo: usarne come di giustificazione fu
segno di cattiva coscienza nella prima avanguardia).
L'apologeta afferma poi che le dolorose rinunce riguardano
cose superflue, ma non pensa di dover dimostrare anzitutto la necessità della rinuncia.
Altro ricatto: «Preferite dunque all'avanguardia l'accademia?
Preferite i quadretti di genere e le oleografie dei salons del primo
Novecento?».
Come porre al bivio tra mangiare oggetti di plastica o detriti e
cibi decomposti. Il metro stesso che fa respingere come insulse e
sentimentali le opere degli ultimi figurativi o tonali fa scartare
tutto quanto l'avanguardia ha imposto al mercato dai suoi primordi a oggi. D'altra parte l'avanguardia è protesta e in questo
senso è provocazione salutare.
Ma purtroppo più nessuno la prende alla lettera: quando si
espongono stracci nei musei, quando si emettono rumori nei
conservatorii, si sta deridendo istituzioni che ormai sono diventate arcaiche. Nessuno si avvede che si tratta di amabili o insulsi
dileggi, e allora l'artista d'avanguardia rincara: appende tele graffiate, tele vuote, strappa le corde d'un pianoforte; ma imperterrita
la Gran Madre dell'Abiezione, la società di massa, incorona. Invece di redimersi, colui che ha subito i giusti dileggi, offre uno stipendio al burlone.
Poi il beffeggiatore viene beffato da colui che sarà beffato e la
catena si perpetua senza fine. O fino al giorno in cui si imparerà
di nuovo a prendere tutto alla lettera.
Le grosse rivoluzioni storiche sono spesso inavvertite; lo scetticismo europeo nel secolo XVIII dissipò nel modo più discreto le
persecuzioni delle streghe; non ci fu una polemica furiosa, non
scontri palesi tra fautori della vecchia teologia e critici irridenti, e
questi ultimi mai osarono affrontare tutto intero l'edificio teologico che giustificava la persecuzione.
Come si può non accorgersi di morire
Gl'inquisitori furono derubati della loro potestà senza violenza: a
distanza di una generazione, ai primi del '700, il ricordo dei roghi
di Salem in America era affievolito, pareva un sogno sul quale non
valesse la pena di indagare, e nessuno veramente si vergognava di
aver creduto comunque alle fatture, tutt'al più ci si incolpava di
uno sbaglio giuridico; l'aver prestato fede alla cosiddetta testimonianza spettrale. L'opuscolo di un certo Brattle, che verso la fine
delle persecuzioni di Salem aveva osato protestare contro gli eccidi, era stato clandestino e imperniato su argomentazioni procedurali, su disquisizioni intorno alle possibilità di fornire prova del
reato. La stregoneria dileguò senza che alcuno la uccidesse, nemmeno per veleno, si estinse di morte lentamente naturale, senza
suscitare né cordoglio né sghignazzate.
I preti vennero tuttavia sempre ancora chiamati esorcisti e serbarono per diritto canonico la potestà di cacciare i dèmoni e gua-
rire i posseduti, il tribunale ecclesiastico dovrebbe ancora oggi occuparsi di stregoneria e di patti col demonio.
Ma chi penserebbe di portare in chiesa invece che al manicomio provinciale una donna schiumante e ululante? La Chiesa si è
lasciata svestire dei suoi poteri, cedendo proprio il più vistoso, il
terapeutico, a funzionari dello Stato, i più confusi e disarmati fra
i medici: gli psichiatri; la parte meramente persecutoria fu ereditata dai politici, e invece di streghe furono variamente taglieggiati, verso la fine del secolo XIX e nel pieno del XX, artisti, ebrei,
zingari, pensatori rivoluzionari.
La sparizione della stregoneria, cioè dell'isteria e paranoia e
oscenità contagiose, nonché del potere ecclesiastico di correggerla o coltivarla, è il modello di estinzione a cui si può guardare
per sapere cosa stia accadendo, in questa seconda metà del secolo
XX, alle arti. Infatti l'ironia romantica che Hegel già riteneva malanno letale, si è moltiplicata per mille forme, inconsapevolmente
ironiche e antiromanticamente romantiche. Il fondamento romantico resta inalterato in ogni caso, anche nel cubismo; verso il
1912 la reazione alla volgarità sociale, che fino ad allora aveva indotto a cercare riparo nell'interiorità drogata, piglia una forma
ancor più disperata in quanto «la forma del mondo si astraeva dai
suoi particolari, talché nel cubistico Nudo che scende la scala non
importa se la persona è bella o brutta, morale o immorale, analfabeta o colta, uomo o donna» (cosi scrive in un'inconsulta ma preziosa apologia Jacques Barzun).
Questa è ironia romantica al suo punto estremo: oggettiva
senza umore di sorta, senza divertimento né disperazione.
Naturalmente il sofisma del progresso impedisce di capire la
stortura del sistema: oggi è l'action paintinge. l'informale ciò che
s'è estratto dall'abisso della frivolezza e che si proclama diverso,
nuovo incomparabile proprio nella proporzione della sua invarianza rispetto a ogni precedente avanguardia.
L'aumentare dell'ironia romantica, fin di là d'ogni soggettivo
spirito di beffa, conferma la morte dell'arte, come il miasma crescente sempre meglio denuncia il cadavere.
«L'arte non può morire, perché sempre c'è stata», si dice.
Cosi la stregoneria: sempre fii menato a giustizia chi esercitasse
magia nera; nel secolo XVIII questa sempiternità si mostrò precaria.
«L'arte muterà volto e sopravvivrà.» Al pari del rapporto fra
strega e persecutore; eppure solo per similitudine possiamo dire
che un gerarca sovietico o nazista che va in traccia di «elementi antisociali» è erede degl'inquisitori, solo per similitudine possiamo
affermare che Oscar Wilde o Dreyfus si accollano la parte eterna
della povera vecchia accusata di far deperire il bestiame, trascinata
alla gogna, buttata in galera.
Come la strega si estinse ai primi del '700 cosi l'arte si spegne
agli ultimi del '900; dopo una malattia cominciata ai primi
dell'800. In particolare nel decennio 1960-1970 tutto precipita,
quanto completamente, tanto più inavvertitamente.
La Sparizione delle classi e il Regno dell'Illibertà
Oggi la bassa cultura, com'è stata chiamata la gamma di merci
fornita dall'industria culturale, si è sollevata a un grado di «sofisticazione» finora proprio della «media cultura», mentre gli ultimi artisti sono morti o si sono acconciati alla mediocrità richiesta per l'ammissione all'industria.
Gli spareggi sono quasi appianati dopo il bradisismo, tocca ridisegnare la carta geografica, cancellando montagne e depressioni, mostrando la tetra spianata.
Certo, i cosiddetti artisti s'illudono di continuare la loro opera,
e se sono persone mediocri, come i più torpidi osservanti continuarono a ritenere efficace l'esorcistato ridotto a cerimonia, non
più irrigato da fede. La potestà di esorcizzare era passata a psichiatri o a politici, e i preti difendevano la loro ultima forza,
quella secolare; cosi gli artisti credono di dover ancora difendere
la loro opera quando la pubblicità, il cinematografo e altrettali
branche dell'industria hanno inglobato ogni sostanza.
Si vuole allestire l'inventario delle perdite? Stranamente a nessuno tornano in mente, forse per vergogna. Il ritratto, ancora praticato sia artigianalmente sia, per sporadico miracolo, artisticamente,
fino alla prima guerra mondiale, era già stato spiantato assai prima,
dalla fotografìa. Questa distrugge, rendendolo superfluo, il corpo
del ritratto, perché offre modo di ritrarre, in senso materiale, senza
concorso di uomo (oppure con concorso del tutto fatuo, come
quando fotografi vanitosi impasticciano gli acidi per simulare effetti pittorici, esercizio simile a quello di camminare sui gomiti,
potendosi ottenere effetti pittorici con mezzi pittorici). Morto il
corpo, dell'anima che resta? Lo spettro che disturba gli assassini
oppure il ricordo che immalinconisce gli amici.
La tradizione del ritratto è ormai irrecuperabile, perfino quella
frigida di un Lenbach o Sargent, e coloro che ancora si industriano
di ritrarre o eseguono orride imitazioni a mano di fotografie colorate o caricature, più o meno squadrate, più o meno sbavate. Non
esiste un ritrattista vivente, l'agonia è conclusa. E fu una nobile
arte, e così necessaria alla salute dell'uomo, che quasi non si sa parlarne ora che nessuna speranza di rinascita rimane. Né è chiaro chi
più impietosamente l'affossi, il becchino motteggiarne che sarebbe il pittore astratto o il figlio tabetico, il figurativo.
Col ritratto sono morti il paesaggio e in ultimo anche la natura
morta; la sonata, la sinfonia, l'opera lirica, l'arte di comporre per
pianoforte; la lista potrebbe continuare, ma qualche guizzo simile
a quelli che scuotono i cadaveri dei colerosi fa reputare tuttora
vivo il romanzo, il poema, e altri generi.
Il tirocinio che dava modo di esercitare le varie arti e scienze
non era soltanto una misura utilitaria, ma aveva anche della cerimonia religiosa perché il tirocinio è anche un sacrificio e patimento, che i chiamati soffrono senza esitazione, con gioia, tanto
li occupa e trascina il fine dell'arte, mentre i fiacchi subiscono con
strazio, nella misura della purificazione di cui abbisognano. Chi
avesse oltrepassato gli anni di tirocinio era anche un uomo purificato dalle fanciullaggini, dall'abitudine di perdersi in fantasticherie, di trastullarsi con progetti inattuabili, avendo ormai trovato il
punto d'equilibrio della sua vita nella sua opera e soprattutto
avendo coscienza di dover mostrare soltanto opere perfettamente
finite «a regola d'arte» o «come Dio comanda», e di dover tacere
dei suoi esperimenti, tentativi, generici progetti.
È proprio questo punto delicato che i distruttori della civiltà
hanno saputo erodere: oggi il tirocinio sussiste per le attività strettamente scientifiche o meccaniche, ma sono stati colpiti i lavori
più augusti, ormai, per la loro parte meccanica, eseguibili a macchina. Dipingere, narrare, amministrare, suonare: queste attività
nessuno saprebbe più insegnare e sopravvivono, mere fonti di
corruzione, gl'istituti dove un tempo si apprendevano. A che prò
le accademie d'arte e i conservatorii? A che prò l'anatomia pittorica, la prospettiva? E perché insegnare lettere, quando si può fissare sulla macchina da presa ciò che si vuol raccontare? Le sopravvivenze s'ammantano di tristezza, intrise come sono della loro
morte prossima; l'istruttore di cavalleria, il maestro di figura, il
professore di filosofia, il maestro di contrappunto sono ridotti a
far compagnia alla zingara che dice la ventura, all'uomo che gira
con la pertica a spegnere i lumi a gas, al copista calligrafo.
Pensieri sgradevoli e non rimunerabili
Dinanzi a questo inventario catastrofico la reazione dei più è la
stessa che scatta quando si mostrino le montagne di ceneri
estratte dai forni crematori, dalle fosse comuni dell'ultima guerra.
Beninteso, si deve mostrare i corpi dei campi sovietici a sinistra,
quelli dei campi nazisti a destra, quelli di Hiroshima al centro, e
non perché si voglia una compensazione trilaterale delle colpe,
che sarebbe obbrobrio aggiunto ad obbrobrio (anche perché la
demonicità specifica del fascismo, il motivo della sua identità col
male fu, come individuò Simone Weil, la sua invenzione del minimo ideologico); se si invita a contemplare un drago a tre fauci è
perché la burocraticità forma l'essenza dei tre esperimenti di sterminio massificato, l'accidentalità di un animo crudele o di un'esaltazione fanatica negli esecutori costituisce il tratto più agghiacciante e comune. L'ingiustificabilità cresce d'altra parte con la
perfezione degli strumenti usati: un gruppo di scienziati che lavorava attorno alla bomba atomica riuscì dopo molti sforzi a
«inoltrare» un suggerimento di far scoppiare l'ordigno in una pia-
nura desertica alla presenza di rappresentanti giapponesi oppure
di esibirne prova su una landa spopolata del Giappone; non si sa
quale fine, quale percorso facesse questa proposta nella «trafila»,
talché Hiroshima fu distrutta per uno «scherzo» burocratico dei
più inevitabili; chi se ne indigna guardi a ciò che egli tollera nel
suo ufficio, alla ridicola colletta cui non osa rifiutarsi, alla compera rateale cui consente «perché così non si nota la spesa».
Si addita da tre parti perché la più salutare vergogna è quella
che si prova di se stessi e perché l'apparato in sé, lo strumento che
ha affossato i borghesi polacchi è lo stesso che ha inumato gli ebrei
e incenerito «più giapponesi del massimo necessario».
I più dicono o pensano che, dopo tutto, si vive come prima nonostante qualche carneficina; altri asseriscono che nulla sarebbe
avvenuto se si fosse stati tutti simili ai carnefici d'una delle tre
parti, invece di stare a intralciarli, costringendoli a trucidare; altri
ancora garantiscono che bisogna accettare i tempi come sono e
dimenticarne i mali, quasi fosse naturale fare altro.
Pochi intendono che i mucchi di salme sono la conclusione di
una dimostrazione per assurdo, che addita il termine di ogni burocrazia col suo gergo disinfettante e letale, di ogni lavoro divorziato dal suo fine, di ogni imbottimento dei crani, in breve, d'ogni alienazione. C'è anche chi ribatte: a che prò la vergogna? Essa
non è una rivoluzione. Marx replicò in una lettera giovanile a
Ruge: «la vergogna è già la rivoluzione, una nazione che la provasse sarebbe il leone che si stringe tutto in se stesso per balzare innanzi». Così, se davvero assalisse vergogna alla distesa di arti sfiorite o infrollite, all'idea che non c'è più pittore capace di insegnare
a ritrarre, fra poco non più un musicista capace d'insegnare a
comporre, non più uno scrittore che preservi ogni possibile ricchezza del suo linguaggio ma solo guitti dell'industria che disintegrano il linguaggio o lo riducono al punto di chi lo parla nelle
strade, se davvero assalisse vergogna, chissà di quali impeti si sarebbe capaci; invece nulla potrà nemmeno afferrare il pugno che
rifiuti di sciogliersi. A voler continuare, viceversa, la finzione della
sopravvivenza dell'arte, quasi che la Storia avesse stipulato a nostro favore l'obbligo di fornirci arte comunque e dovunque, si
cade nelle situazioni eterne del teatro buffo o del repertorio della
truffa. Gli intellettuali somigliano alle povere madri dei dispersi
in guerra, incapaci di accogliere come figlio il vagabondo che ha
deciso per qualche tempo di sfamarsi a loro spese. Nei primi
tempi esse esigono delle lagrime, dei nèi, dei falsi ricordi d'infanzia; con l'andar degli anni non curano nemmeno se il vagabondo
è di pelo rosso anziché moro.
Così qualsiasi fatto un tempo confinato nell'asilo infantile, nel
cortile di fabbrica durante la refezione, nella camerata di caserma
all'ora vespertina delle confidenze vomitevoli, negli alberati cortili dei manicomi, ormai sembra idoneo a spingere avanti la farsa
della sopravvivenza o del ritorno delle arti disperse durante la
guerra, dal '40 al '45. Non ci vuole più di un confuso accenno per
provocare il riconoscimento, basta nei produttori dei fatti «artistici» un'aria disordinata che ricordi ad un osservatore inetto la
bohème, basta il fatto materiale di modellare o spalmare di pigmenti una superficie, per dedurne la simiglianza a ciò che un
tempo si chiamava scultura o pittura [...].
«La rivista di Estetica», anno II, maggio-agosto 1963, pp. 169-214.
Le cattive definizioni dello stato mistico*
Le definizioni dello stato mistico sono elencate dai dizionari filosofici e dalle enciclopedie, dai trattati teologici; la più stringata è:
«Conoscenza sperimentale di Dio». L'uso del termine è invece affidato a regole segrete e semplicistiche. Come campo di gravitazione di sentimenti ottusi la parola attrae una serie di significati
diversi a seconda delle varie faglie della cultura pietrificata.
Nella cultura di massa, al livello minimo, esso è sinonimo di
sentimenti confusi benché gradevoli, di un compiaciuto e lezioso
accostarsi alle istituzioni ecclesiastiche; comporta due ordini di
gesti: occhi bassi lagrimosi, labbra dischiuse, banalità sussurrate
oppure sorriso smaccato, testa inclinata, occhi scintillanti. Nostalgie, sdilinquimenti, compunzioni, l'inserimento più o meno
facile, sempre recitato, in un'istituzione ecclesiastica: ecco ciò che
il termine può stenografare per i consumatori delle merci culturali di qualità ovviamente più triviale.
Nella mezzacultura il termine è considerato elogiativo da un
certo strato di consumatori: donne borghesi che alternano viaggi
ad Assisi e letture di mistici a love affairs accompagnati da declamazione interiore, omosessuali analoghi, frequentatori di sètte
superstiziose, seguaci di partiti di destra con tendenze sanguinarie. Nella stessa mezzacultura il termine viene considerato marchio d'obbrobrio dai consumatori di ideologie legate ai sindacati
0 alle imprese neocapitalistiche.
Il termine è considerato imbarazzante, da confinare a certi fenomeni ormai accolti e neutralizzati nel canone storico ecclesia* Sulle «cattive definizioni dello stato mistico» verte il primo degli otto paragrafi
della Introduzione all'antologia I mistici dell'Occidente (Garzanti 1963). Poiché
nella edizione riveduta Adelpni 1997 questo paragrafo d'esordio non compare, a
differenza che nella ristampa Rizzoli in sette volumetti oramai difficilmente accessibili (1976-1978), è un testo in pratica sconosciuto. Zolla non vi lesina i toni aspri
connaturati alla sua prosa in quegli anni. D'altra parte in margine alla riedizione
Rizzoli 1976 precisava: «Rispetto al 1963 la cultura di massa è mutata in modo cosi
vasto da alterare molti dei dati di questo paragrafo».
1 titoli degli altri paragrafi della Introduzione sono: La mistica come norma delr
l'uomo-. La mistica come iniziazione, Il mondo zodiacale, Perdita della naturai Perdita
dei simboli. Principi zodiacali; La mistica come matematica.
stico, da parte della mezzacultura dei protestanti «demitologizzati», dei cattolici che hanno bisogno di presentarsi ad un elettorato o pubblico di imprenditori o di impiegati alieni da attriti con
l'ideologia del loro lavoro.
La cosiddetta alta cultura è strettamente legata agli strati inferiori, l'apice pesa sulla base che lo regge. Nella storia della cultura
italiana recente l'accezione favorevole del misticismo è il segno di
riconoscimento di una sua parte ormai sparita, nazionalistica, e
designa: orgoglio per l'incapacità di analisi concettuale, ornato
stucchevole con pezzi di antiquariato linguistico strappato alle
chiese, piacere di conformarsi alla vita militare. Presso gli ermetici c'è il pudore del termine stesso a causa dell'abuso precedente,
ma l'incapacità di organizzazione del pensiero e di analisi chiara
e distinta delle idee, il piacere tratto dal suono puro delle parole
indicano che il termine non è da loro respinto ma solo accantonato, che non provoca ripugnanza ma soltanto astensione dall'uso diretto.
Il riflesso condizionato d'un voto sfavorevole è comune a coloro
che invece d'un nome portano il distintivo di «storicisti» o «marxisti» o «neopositivisti» (se non seguono Wittgenstein); presso costoro il termine è sinonimo di irrazionalità, che può voler dire: non
verificabilità per esperimento o per testimonianza sociale, difetto
di documentazione adeguata, appello abusivo ai sentimenti, rifiuto di prova, rivendicazione di facoltà intuitive in contraddizione con i processi concettuali, appello di concetti e molte altre
cose ancora; nei casi più sinceri è addirittura mera indicazione dei
propri avversari politici o accademici.
Per buona parte dei significati attribuiti alla parola c'è una
straordinaria concordia di tutti nel definirla male, quale che sia il
voto, di condanna o di approvazione, che segua alla definizione.
Per i marxisti il misticismo è o anarchica incapacità di incanalare la rivolta nell'unico solco che la storia offre, pertanto considerazione di contraggenio con la società da modificare, oppure
semplice appendice di un'istituzione ecclesiastica; essi danno definizioni false ma mirano giusto, poiché il mistico potrebbe es-
sere tollerato soltanto nel Regno della Libertà, dove anzi sarebbe
l'abitante naturale, laddove chiaramente riesce fastidioso nel
tempo dell'edificazione della libertà mediante esasperazione
della servitù. Peraltro un certo rapporto fra mistica ebraica e
marxismo fu cercato da Walter Benjamin; una valutazione della
mistica giansenista come unica rivoluzione concessa in difetto di
un proletariato con partito (pertanto figura paterna per il comunista) fu proposta da Lucien Goldmann, uniche eccezioni insieme a Bloch, rispetto alla condanna del misticismo come ideologia. Per i pensatori «progressivi» d'altra sorta, mistica è ogni fiducia magica in istituzioni o capi di istituzioni, tanto che essi
parlano addirittura di devozione mistica dei militanti comunisti.
Riconducendo l'avversione che cosi si esprime a maggior chiarezza, si ricava questa loro strana definizione: mistico è ogni atteggiamento che impedisca la critica. Mistico talaltra volta è, per
costoro, l'atteggiamento di disprezzo verso la carne, il corpo in
quanto tali, la tendenza a idealizzare e decorare con le parvenze
rettoriche della sublimità cose incongrue: altri modi di evitare la
critica.
Se si osservano le associazioni inconsce della parola nei diffamatori come negli apologeti, si vede che mistico corrisponde a
femminile. Perciò i femminei seguaci di ideologie autoritarie la
amano in quanto possono sentirsi senza contraddizione apparentemente virili e mistici insieme: non osando pigliare coscienza della loro femminilità verso l'istituzione o il suo capo, la
esaltano inconsciamente con questa trasposizione terminologica. Come passività femminea intendono inconsciamente il termine anche i progressisti, e perciò ritengono che il misticismo,
contro ogni ragione, porti alla acquiescenza verso i capi magici
della folla o verso la falsa tradizione (la resistenza al nazismo fu
alimentata, nel gruppo della Rosa bianca, da letture di mistici,
per dire un solo caso, di un ambiente che scoraggiava efficacemente le rivolte).
Per leggere i mistici occorre avere non solo la mente sgombra
da queste ubbie coagulate in stereotipi ma anche libera dalle associazioni inconsce.
Il feticcio dell'esperienza
Volete rendervi accetti, essere amati da ogni spirito gregario?
Basta che pronunciate una frase come: «Conta di più una esperienza viva e sofferta che non una sterile conoscenza intellettuale», o come: «Preferisco un documento sincero e palpitante ad
uno sterile virtuosismo estetizzante».
Il consenso commosso che susciterete se avrete lo stomaco di
profferire tali proposizioni, vi avverta che oramai tutti considerano
oltraggioso l'esercizio dell'intelletto o del gusto, cui preferiscono la
sciattezza, primo passo verso l'ebetudine. La forza dei sentimenti
d'odio contro l'intelletto e il gusto è tale che gli uomini politici accorti non hanno esitato a servirsene. Nessuno statista oserebbe restaurare l'antica severità delle scuole, imporre nuovamente un ordine di studi simile a quello anteriore alle guerre mondiali. Ogni regime che s'è succeduto ha procurato di demolire un tratto del vetusto edifìcio dei nostri padri; si cominciò abolendo l'insegnamento
della rettorica e della logica, sostituite da una delirante educazione
alla lettura sentimentale o alla storia del pensiero, si prosegue oggi
eliminando il calco da cui rettorica e logica di preferenza si traggono, la lingua latina. Gli argomenti sono tali che soltanto il previo
bando alla logica poteva consentirne l'uso; il primo suona: «Il latino
è un privilegio di classe», cui buon senso vorrebbe che seguisse la
conclusione: «Dobbiamo perciò concederlo a tutti», e da cui invece
si deduce: «Dunque verrà tolto ai pochi che l'hanno». Il secondo argomento suona: «Visto che ormai non s'impara più bene il latino,
lo toglieremo del tutto», che equivale a: «Visto che i braccianti cinesi s'accontentano d'una ciotola di riso, tanto vale toglier loro
anche quella». Il terzo, e più buffo suona: «Riserviamo il latino agli
specialisti di lingue morte», che equivale ad affermare che soltanto
i facchini debbano curare la salute, soltanto i camerieri imparare la
discrezione, soltanto gli attori pronunciare con chiarezza.
Poiché è buona politica uccidere i sicari dopo che hanno fatto il
loro servizio, fra poco lo storicismo, cui fu demandato di assassinare la rettorica e la logica imponendo invece loro la storia letteraria e la storia della filosofia, verrà distrutto anch'esso, e le scienze
storiche si sacrificheranno a favore di un qualche coacervo di materie che si potrà intitolare «educazione civica». E poi sarà la volta
della storia letteraria, cui si sostituirà «comunicazioni umane», in
modo da far cessare il privilegio che la letteratura ancora per poco
detiene, e si smetterà infine di considerare il fischio men degno
d'un eloquio chiaro e distinto.
***
Lo sfruttamento politico dei sentimenti d'odio verso l'istruzione
è generale, ma bisogna riconoscere ai nazisti il primato, poiché
nel Mein KampfW disprezzo per gli «sterili» letterati è la nota dominante e dovette contribuire assai a ingrossare le file delle camicie brune, come attesta questo brano del discorso di Goering alla
Dieta prussiana del 18 maggio 1933: «Le idee della rivoluzione
tedesca sono state comprese dalle masse popolari viventi nella miseria prima che dalla gente istruita ( Vivi e prolungati applausi).
Ecco come si spiega che la nuova generazione, nonostante e forse
proprio perché ha una formazione intellettuale incompleta, abbia
capito d'istinto le idee della rivoluzione tedesca».
I nazisti hanno il primato ma non l'esclusiva, poiché non c'è
partito che non abbia contribuito a sgretolare un poco il duomo
che i secoli avevano lentamente levato.
I sentimenti generali sono sottili, impalpabili, invincibili: siamo
al punto che soltanto un uomo di straordinaria indipendenza è
ormai capace di non accettare la tonalità deprecatoria da cui è aionata la parola «letterario», di rifiutare il vezzo demagogico di opporre l'uomo completo al letterato, l'umanità alla limpidezza stilistica, l'esperienza al sapere, ovvero ciò che tutti presumono di
avere e di cui comunque esistono prove oggettive a ciò che soltanto
pochi possono ricevere in dono dopo un lungo tirocinio.
Il feticcio della esperienza umana, come ogni idolo, esige vittime,
più di quante non si creda. Può capitare in un'aula di medicina di
assistere ad una lezione in cui il professore spiega come mai ad un
certo tipo di elettroshock se ne sia sostituito un altro, migliore, e,
affinché gli studenti abbiano non solo conoscenza di questo fatto,
ma anche la taumaturgica esperienza, darà una dimostrazione,
applicherà ad una paziente il metodo antiquato e nocivo, ed a
un'altra quello nuovo e privo di inconvenienti.
***
Un tempo non ci voleva troppo per convincere un povero villico
che avrebbe potuto liberare il bestiame dalle malattie torturando
un rospo, procurandosi midollo d'impiccato, rimescolando piante
fetide. Oggi ci vuole ancor meno a persuadere l'uomo-massa che
ogni male sulla terra proviene dallo studio del latino, dalla coltivazione delle lettere, dall'esercizio del gusto, che la prosperità sarà garantita soltanto il giorno in cui la terra verrà liberata dall'ultima
traccia di logica e rettorica, dalle vestigia del mostro «Estetismo» o
della belva «Intellettualismo».
In queste asserzioni c'è anche un briciolo di verità, perché in effetti, quando l'ultimo relitto di tali capacità sarà svanito, allora
nessuno avrà più modo di esprimere né consenso né dissenso, di
distinguere fra un borbottio esalato da teste ciondolanti e l'antico
linguaggio degli uomini.
L'esperienza, «Corriere della Sera», 12 marzo 1964.
La visione dello storico del futuro
La storia dissipa gli equivoci che formarono il labirinto dei contemporanei, a lei si demandano le sentenze diffìcili. E si può congetturare l'opera d'uno storico del remoto futuro, che voglia scrivere la Storia della decadenza del rito in Occidente. Ecco che, allestite le sue schede, comincia il mirabile gioco di disporle secondo
un disegno che emerge a poco a poco: thefigure in the carpet [...].
Dalla Costituzione del Concilio (Vaticano II), lo storico scoprirà che venne si permessa una liturgia volgare là dove fosse stimata opportuna, ma anche conservata l'antica con la massima
cura. Leggerà all'articolo 116 della Costituzione liturgica: Ecclesia cantum gregorianum agnoscit ut liturgiae romanae proprium
[...]. Inoltre appurerà da un'allocuzione di Paolo VI, del 24 ottobre 1964, che quel pontefice, continuando l'opera dei predecessori, deputava un Ordine monastico precisamente alla custodia
della liturgia tradizionale. [...] E infine leggerà un ammirevole
documento che riassunse tutta la dottrina accumulata nei secoli,
in completa conformità alla Costituzione liturgica, della quale
forni invero un'implicita esegesi autentica [...] la Instructio de sacrorum alumnorum liturgica institutione della Congregazione dei
seminari e degli studi del Natale 1965, la quale definì la liturgia,
fra l'altro, conformemente alla dottrina consueta, come schola
contemplationissupernaturalis [...].
Ma a questo punto lo storico rimarrà sbalordito, trovandosi fra
mano schede che parleranno d'una realtà agli antipodi di tali solenni dichiarazioni: se gli capiterà di avere una collezione di riviste musicali (come quella romana, «Cappella Sistina») ne estrarrà
una serie di notizie di celebri cori gregoriani e polifonici dispersi,
di tradizioni spezzate. [...] Scoprirà che in Francia, Norvegia, Belgio, Inghilterra, Austria, Germania, Scozia, Italia vennero formandosi associazioni per la preservazione del rito latino e gregoriano chiamate «Una voce». Né potrà pensare che il loro fine fosse
provocatoriamente superfluo, se leggerà sui loro bollettini che
l'associazione madre, la francese, ebbe la benedizione del Pontefice regnante, Paolo VI. Forse fra le carte preservate dal tempo, ci
sarà anche una copia dell'appello rivolto al Pontefice dagli scrittori e dai musicisti, implorante, addirittura, che fosse soltanto, almeno, conservata nelle chiese conventuali la liturgia gregoriana.
E in calce all'appello scorgerà i nomi di Maritain o di Mauriac,
ispiratori del movimento che aveva portato al Concilio [...].
Dio faccia cessare la visione di questo storico del futuro! Lo vediamo registrare come, seguendo fino alle conclusioni ineluttabili
le teorie dei distruttori del gregoriano, i loro prosecutori abbattessero le cattedrali perché la maggioranza non sapeva enunciarne
i pregi architettonici, risolvessero di gettare in cantina le icone
perché soltanto pochi erano in grado di individuarne i princìpi di
stilizzazione. Ecco che sul luogo dove Chartres gettava ombra con
la sua «estetizzante» pretesa di trascendenza e solennità, essi allestirono un parco di divertimenti con mostre di cartelloni religiosi
e esibizioni di chitarre elettriche. Gli ultimi cultori del gregoriano
vennero impiegati dal Museo di storia delle antiche superstizioni
occidentali di Pechino.
La visione delb storico, «La Fiera letteraria», 9 giugno 1966, e in «Quaderni di informazione della Consociatio Internationalis Musicae Sacrae», n. 4, inverno 1966.
Il neolassismo conciliare
[...] Oggi sono diventati rari gli onesti teologi che ricalchino con
diligenza le dottrine tradizionali ed è introvabile chi le faccia rivivere in modi abbaglianti e vertiginosi come seppe fare Kierkegaard. È frequente un tutt'altro tipo di teologo, privo dell'umiltà
dei primi come dell'empito kierkegaardiano, diluitore dei concetti
e aridamente declamatorio, quale nel suo ultimo libro Jacques
Maritain ha dileggiato con garbo sferzante.
Se un provinciale pascaliano girasse il mondo interrogando costoro (che talvolta parlano anche della morte di Dio), coglierebbe
uno spettacolo ahimè privo dell'avvocatesco splendore dei loro
predecessori parigini del '600.1 nuovi lassisti infatti non si curano
di scardinare ingegnósamente la lettera delle norme, occupandosi
invece di produrre una declamazione dove le parole perdono il
loro peso, il significato esatto. Essi si proclamano custodi del
Concilio (se cattolici), ma affermano spesso cose introvabili nei
testi conciliari perché è loro prerogativa lo Spirito del Concilio (o
lo Spirito dei Tempi e lo Spirito di pastoralità), Spirito che li guiderebbe, aleggiando al di sopra d'ogni lettera contaminante. Essi
evitano l'esattezza delle definizioni come un gentiluomo l'insistenza, perciò è inutile voler cavare da loro che cosa s'intenda di
preciso per Pastorale (un buon numero di conversioni?) o per Spirito dei Tempi (l'obbedienza ai taste-makerà) o per Esigenze dell'Uomo Moderno.
Ecco come si presenta una celebre rivista teologica: «suo scopo
non è la ricerca speculativa, ma quello di offrire a tutti coloro che
sono impegnati nell'azione apostolica una teologia ripensata secondo le esigenze dell'uomo moderno». Il tono è quello di chi
non ha tempo da perdere, che deve correre a confessare dei moribondi; e così nessuno si accorge di quanto sia assurda la frase, con
quella pretesa di creare una «teologia non speculativa», che equivale al quadrato rotondo.
Se poi si passa al vaglio la smisurata massa di vaghi libri, si scopre che... essa nulla offre se non due sole asserzioni.
La prima: «Il Concilio (o, se si tratta di acattolici, lo Spirito dei
Tempi o altro ente difficilmente catturabile) ha promosso una
concezione religiosa priva di sovrastrutture magiche».
Che intendono i nuovi lassisti allorché parlano di «magia»?
La frase piglia un significato diverso a seconda di chi la pronunci: se si tratta di un nemico delle religioni fondate sui sacramenti, essa è una previsione della loro prossima estinzione e dunque un'esclamazione di trionfo. Se viceversa risuona sulle labbra
di un credente o almeno di un amico della religiosità o almeno di
un uomo tollerante, c'è da rivolgergli la domanda (simile a quella
che fece San Francesco di Sales a Teodoro Beza): «Si poteva raggiungere la salvezza con quei mezzi sacramentali?». Se non si è mai
potuto, tanto vale chiudere una storia che, magica o no, risulterebbe cosi vana e fallimentare; se viceversa si ammette che qualcuno pure si salvò, che qualche misura di salvezza, di letizia, ne
venne: perché impedire che essa continui ad essere largita, che
altri ancora per quella via si salvino? Soltanto perché la parola
«magia» suggestiona sfavorevolmente?
Nella comune parlata «magico» è qualsiasi sguardo che accenda simpatia o avversione, qualsiasi parola stranamente ossessionante o gesto fortemente fascinoso, in breve, tutto ciò che
abbia un'efficacia non perfettamente calcolabile. Se tale è l'accezione che alla parola attribuiscono i neolassisti, perché mai negare
ai rapporti col divino questa qualità avvincente che pure pervade
e vivifica quelli umani?
Il secondo luogo comune dei neolassisti è a un dipresso questo:
«Il Concilio (o lo Spirito dei Tempi, eccetera) ha parificato il sacro
ed il profano, ovvero ha assorbito il sacro nel profano; ciò deriva
dal fatto che esso ha approfondito l'idea dell'Incarnazione, dopo
la quale le due sfere non sono più divise l'una dall'altra».
Così l'Incarnazione avrebbe (e la scoperta sarebbe di questi
anni) reso accessibile a tutti ogni parte del Tempio, il cui velo,
come è noto, fu rescisso. Se si attribuisse un significato preciso alla
frase, bisognerebbe concludere che oramai sono leciti tutti gli obbrobri, visto che commetterli non esclude nemmeno dal tempio.
In realtà questa confusa declamazione è il punto di partenza per
una serie di demolizioni: tutto ciò che è ieratico, disumo dalla mi-
seria umana, viene distrutto in nome di una terribile parificazione; e la serie dovrebbe proseguire fino all'estremo termine, fino
a scalzare l'ultimo mattone dell'ultima chiesa che in qualche
modo si distingua da un circolo di beneficenza dove si allestiscano
conferenze sull'amabilità della materia.
Certo, pochi confessano a se stessi di desiderare una così radicale rovina e pochi saprebbero sopportare la visione di tutte le demolizioni, inevitabili una volta che si sia cominciata la «purificazione del sacro». Il n'y a que lepremierpas qui coûte-, ma i neolassisti, con procurata miopia, non vogliono scorgere se non una piccola parte della trafila. Tengono l'occhio sulla particella del sacro
che si accingono all'istante a colpire: il recinto dell'altare, le decorazioni cultuali, la veste e la castità sacerdotali, gli atti d'ossequio
sacrale, gli oggetti religiosi, la lingua e la monodia sacre [...].
I neolassisti hanno abbandonato e proscritto il criterio del bene
e del male, sostituendolo con l'alternativa fra progresso e regresso,
come se delicate questioni spirituali si potessero ridurre al metro
che serve a misurare l'incremento delle risorse tecniche. E come se
il progresso incontenibile verso pantani o fossati non fosse uno
dei numeri preferiti della tradizione comica.
Ahimè, questa loro proposta, di risolvere ogni questione in una
scelta fra progresso e regresso è un ottimo affare per le menti torpide e superbe, che evitano così quello che Hegel chiamava lo
«sforzo del concetto». I neolassisti per lo più ignorano che per loro
in particolare si tratta però di un affare in perdita, data l'irresistibile tendenza che mostrano ad abbracciare sempre le mode di
avantieri [...].
Le nuove Provinciali, «Corriere della Sera», 23 marzo 1967.
Il buffone, Buster Keaton e l'avanguardia
In Guerra e pace i Rostov tengono ancora il buffone di famiglia e
Natasa si svaga con lui allorquando il marito è lontano, come una
eroina shakesperiana.
Forse la povera Anna Karenina, vissuta a circa un secolo di distanza, se un pagliaccio domestico l'avesse intrattenuta con capitomboli e tiritere, avrebbe saputo evitare il suo orrido famoso
dormiveglia a occhi aperti durante la passeggiata in carrozza a San
Pietroburgo: il pagliaccio avrebbe impersonato professionalmente quella parte di lei, ed ella se ne sarebbe quindi affrancata
con un sorriso compassionevole. Seneca diceva di fere a meno del
buffone perché gli bastava osservarsi: ma questo è privilegio degli
uomini d'orazione.
Un tempo il popolo intero lucrava i benefici lievemente vergognosi della buffonata alle fiere ed in certe ricorrenze: Capodanno,
Carnevale, Calendimaggio. Questo sistema calendariale era già in
declino nel secolo scorso e vederlo in rovina fa ricordare come la
palude ricoprì la terra dianzi nettamente distinta dall'acqua allorché gli scoli furono distrutti dai barbari; infatti ormai la buffonata
non è più ristretta e arginata dal rango nonché dal luogo e dal
tempo dell'anno, avendo essa intriso quasi ogni tratto della vita.
Questa estinzione del comico non è evidente perché se pur
sono morte le feste popolari e declinanti i teatri e i circhi, i buffoni
paiono aver trovato ricetto nei mezzi di massa dopo aver rinunciato a scambiare con gli spettatori i loro lazzi e motteggi. Ma non
li salverà a lungo nemmeno questa simbiosi e questo isolamento.
Le masse paiono sì smaniare di sollazzarsi ma il loro riso è venato
d'ansia, come contraffatto, e ad ascoltarlo bene, si avverte che va
amalgamandosi con quello funereo delle platee affittate dalla
radio o dalla televisione per emettere la loro scarica di applausi a
ogni battuta.
L'arte della buffoneria non è meno inconciliabile con lo spirito
moderno del suo antico opposto: il sacerdozio ieratico. La sua
morte però ha di particolare che avviene non per soppressione ma
Per diffusione in tutte le fibre della vita. Ciò che viene chiamato
modernamente poesia o romanzo appartiene in realtà al genere
delle burchiellate ovvero «mattane», toltone però ogni spunto che
muova all'ilarità. Così la pittura di grottesche ovvero la bambocciata divenne l'unico genere del Novecento, ma uno stravagante
galateo condannava chi avesse riso, come natura voleva, delle
deformazioni (di un Roualt) spacciate per tragedie. Del resto
qualsiasi facezia ripetuta con faccia seria dopo un certo tempo diventa sinistra. La buffa architettura che prescrive tetti a sghimbescio, diventando onnipresente, cessa di suscitare il riso. Le filastrocche di Joyce come i silenzi o gli stridori della musica nuovissima sono tutti numeri del repertorio comico reiterati però fino a
che i muscoli facciali hanno cominciato a non piegarsi più. Del
resto il Benayoun ha dimostrato come dai lazzi di Buster Keaton
sia derivato l'armamentario dell'avanguardia, senonché questa
non fa ridere.
Già i romantici tedeschi avevano cominciato a servirsi dell'a
parte, del bisticcio, della divagazione con una sistematicità che
escludeva la celia. Hanno perduto nella società addomesticata
dall'avanguardia il loro carattere socialmente buffo due fra i più
celebri numeri del buffone: la vendita di fumo e il re nudo.
In certi quartieri di Amsterdam e Londra quasi tutti i giovani
vestono e ciondolano da buffoni e d'un genere sinistro, e dopo un
poco si cessa di riderne; ottenevano lo stesso effetto certe lugubri
milizie totalitarie. Attraverso a costoro si perpetuerà tutto del
buffone salvo la sua virtù esilarante: la quantità distrugge la qualità comica.
Gli ultimi carnevali che racimoliamo nella memoria erano
d'una volgarità mortuaria; e si prova disgusto a leggere le vicende
degli ultimi buffoni di corte del Settecento, allorché in Prussia Federico Guglielmo I ne teneva che erano altresì dei sommi eruditi
(e già in casa di Richelieu aveva folleggiato l'accademico Boisrobert). C'è da domandarsi se la buffoneria nell'èra cristiana non
abbia sempre portato un marchio di degradazione. Fin dagli inizi
la Chiesa proscrisse con gli spettacoli del circo anche i carnevali,
ma nel Medioevo era costretta a vietare le feste degli asini nei
duomi e le parodie della liturgia alle feste degli stolti. Il cristianesimo infatti esigeva da tutti la capacità senechiana di scoprire dentro di sé il buffone spregevole. Eppure la buffonata talvolta fu un
ottimo ammanto delle verità ineffabili o difficilmente comunicabili. Come l'Amlothi o Amleto delle saghe nordiche si finse pazzo
per celare i suoi segreti politici, cosi i misteri della fede più ardenti
furono spesso camuffati ottimamente da pagliacciate; San Simeone il Semplice fu maestro di quest'arte e per le strade di Bisanzio offriva spettacolo di sé Sant'Andrea di Sali, e in Occidente
fra' Ginepro e San Filippo Neri li emularono spontaneamente; re
Davide per primo s'era dimenato nudo come un saltimbanco davanti all'arca santa e a chi lo biasimava aveva risposto «ero humilis
in oculis meis». Sappiamo che gli antichi usavano perfino l'oscenità, sorella della buffonata, come velo di significati religiosi, e
credere che gli Indiani devoti sieno mossi a lussuria dalle figure
simbolicamente erotiche scolpite sui loro templi è come immaginarsi che la croce attizzi nei cristiani il sadismo. Plutarco narra addirittura che a certe feste egizie si usava il turpiloquio al fine di
provare vergogna e sentirsi così spinti a maggior devozione.
Buffonate e oscenità accompagnavano il cordoglio funebre antico secondo l'archetipo di Baubo, che alzò la gonna per far ridere
Demetra afflitta. Come possiamo sperare di interpretare i sentimenti arcaici alla stregua dei nostri? Il buffone nell'Irlanda arcaica
era un lunatico ed un sommo poeta, come indicò mirabilmente
Enid Welsford; nelle costumanze di Scozia ma anche di Spagna e
d'Italia, egli compare nella danza delle spade come medico che
cura la malattia invertendola, come indicò Marius Schneider.
In Come vi piace Shakespeare mette ancora sulle labbra del
buffone pretese medicinali: «Investitemi col costume d'Arlecchino, / Lasciatemi dire quel che penso / E ripulirò lo sconcio
corpo dell'appestato mondo / Solo che si voglia bere con pazienza
la mia pozione».
Tutto queste materiale che ci affluisce via via che caliamo nel
pozzo del passato si compone infine nella figura primordiale del
buffone sacro il quale esprime l'idea della mediazione e inversione
fra tutti gli opposti e così addita alle menti dei primitivi, innamo-
rate dell'analogia, la mediazione fra i più radicali opposti: il regno
della perfezione e la terra preda del male, ovvero fra lo spirito che
contempla e la carne suggestionabile. «Perché il contrario di tali
sfere non dovrebbe anche essere ironico o sarcastico oltre che tragico e doloroso o estatico e solenne?», pensa uno spirito del tutto
innocente. Di fatto tutte le mosse buffonesche che suscitano ancora oggi la risata per magia irresistibile si collegano a questa funzione primordiale e sacra, sono cose dell'altro mondo. Il buffone
costringe a ridere perché è mezza bestia, mezza donna, mezzo infante, mezzo malato, mezzo morto: perciò striscerà, avrà la camminata leziosa, incespicherà o sbatterà nei muri, sarà gibbuto e
tentennante, catalettico, infarinato, farà salti mortali: il tutto
però a metà, perciò altresì darà balzi, camminerà all'indietro, bercerà, farà il gradasso, indosserà un vestito pezzato, a scacchi, rivoltato, atteggerà la faccia come una maschera o spastica o pietrificata dal rigor mortis. Userà un metro giambico e sincopato, un
tono piagnucoloso e aggressivo. Un nano o un malato con disfunzioni del sistema spinale, con encefalo e muscolatura, fra loro
divisi, sarà adattissimo alla parte, e una coppia di gemelli, di coniugi battaglieri magari l'uno allampanato l'altro tozzo e altrimenti contrastati costituirà l'Arcibuffone diviso di fatto oltre che
psichicamente: il colmo dell'ilarità. La voce del buffone varierà di
registro come quella dell'Asino, che sarà dunque il suo totem (in
America potrà essere il coyote). Mercurio e la mutevole Luna oppure la stella duplice Vespero-Lucifero saranno i suoi dèi; la mediazione spinta fino al tradimento e alla frode (Arlecchino servo
di due padroni) sarà fra i suoi numeri; gabbato e truffatore formeranno una delle coppie dell'Arcibuffone.
Un uso squisito del buffone faceva a Lhasa il clero lamaista. Una
volta all'anno un buffone gettava la sfida materialista al rappresentante del Dalai Lama, gridando: «Ciò che percepiamo coi cinque sensi non è illusione», aggiungendo sarcasmi e ingiurie contro i religiosi. Un lancio di dadi, truccati a prò della verità, decideva la partita ed il buffone veniva cacciato nelle montagne, carico della malasorte, dell'incredulità di tutti.
Si potrebbe narrare ai bambini che un giorno all'inizio dei
tempi nostri, il buffone sostituì i dadi e vinse lui. Ma ha forse cessato di essere un buffone?
«La Fiera letteraria», 27 ottobre 1966.
Lamento e consolazione
Chi guardi alle prossime rovine e sventure con occhio umano,
come può non rabbrividire? Trascorsa la generazione nostra, il
greco e il latino saranno noti quanto oggi il gotico. Metà delle allusioni che vivificano le letterature volgari, appariranno incomprensibili; la letteratura erudita d'Europa fino al secolo XVIII sarà
inaccessibile (la filosofia fino a Spinoza, la botanica fino a Linneo); i concetti chiari e distinti (e tuttavia d'una chiarezza di tipo
non matematico), l'ordine armonioso e agguerrito del diritto romano e della teologia cattolica saranno un ricordo di pochissimi.
E lo spirito religioso, privato del suo scheletro scolastico, si appiattirà allora in una poltiglia o pietistica o demagogica, diverrà
fluttuante, sentimentale, effeminata svenevolezza; la giurisprudenza, immemore delle sue forme romane, offrirà ancor minore
certezza, i suoi termini non avranno più definizioni ben scolpite
nella lingua più consona, ma svarieranno evanescenti, sfumati,
alla mercé di momentanee e ingiuste suggestioni. Ciò che ancora
per noi è nitido si farà labile; come la penombra è propizia alle
opere losche, cosi sarà conveniente al tiranno che nessuno sappia
leggere le sue gesta tutte già previste nel fermo laconismo di Tacito, al truffatore che nessuno possa inchiodarlo nella secca e
splendida esattezza insegnata dalla prosa di Cesare. Nessun maestro di turpitudini ammantate di devozione dovrà temere l'accusa
di chi, nutrito di Patristica, vede in trasparenza attraverso le sue
oneste sembianze, già descritte da Attanasio nel suo ritratto di
Ario.
Le Università saranno ridotte a licei in attesa di diventare doposcuola elementari, i corsi monografici degradati a istituzionali
e infine a divagazioni più o meno propedeutiche, gli insegnanti
ad ausiliari dell'industria culturale o della propaganda politica,
vessati, spauriti istrioni o burocrati al servizio di pochi manipolatori che si celeranno dietro la finzione di rappresentare le masse.
Non c'è cosa più sinistra di una buffonata reiterata e quotidiana, quale sarà lo spettacolo di maestri istruiti dai discepoli. Già
in Francia è palese come Saint-Simon, il vinto dell'Ottocento, sia
il vincitore ideologico del nostro secolo, il saintsimonismo, ovvero la deificazione dell'industria e dei tecnocrati, soppianta
senza troppo dar nell'occhio il marxismo ed i suoi avversari; tutti
oggi sono saintsimoniani senza saperlo, perciò si parla di scuole
che educhino a due sole cose: il servizio nell'industria e la collaborazione ad un tempo libero pianificato, quanto a dire ad una
schiavitù che diversamente dall'antica non avrà nemmeno la giustificazione del bisogno di manodopera. Si salveranno così soltanto le professioni reputate proficue cioè che contribuiscano o
agli stermini o ai consumi o ai divertimenti di massa, soppresse
come asociali le umanistiche.
Si infierisce contro la cultura umanistica in nome dell'abolizione d'ogni privilegio di classe proprio allorquando a tutte le
classi sociali dovrebbe poter diventare accessibile. Così si svela un
fondo d'incredibile perversione. A tutti verrà elargita l'istruzione,
ma alla vigilia di concederla la si sarà spogliata d'ogni sua ricchezza e indipendenza, affinché le masse tali restino. La proposizione che con una concordia scellerata tutti ripetono oggigiorno
è: «Il latino è privilegio di classe, dunque si neghi alle masse ora
che lo si potrebbe elargire». L'incongruità mostri ai candidi come
l'odio e il disprezzo del popolo sia il movente di chi più istericamente se ne proclama difensore; infatti, chi avverte Otello di mostrarsi dal mostro occhiverdi, la gelosia, chi se non Iago? Chi grida
«popolo popolo» se non il tiranno più accorto? Perché non distribuire a quel tal popolo gli unici tesori che si possono moltiplicare
senza sminuirlo, la possibilità di ripetersi le melodie di Virgilio, di
cogliere le distinzioni di Agostino? I distruttori oggi dominanti,
se in loro la perversità per un attimo fosse alleviata dalla franchezza, risponderebbero: «Affinché il tempo libero del popolo rimanga un tempo sprecato e ignobile, che lo lasci inerte e malleabile nelle nostre mani».
Così si sdegna contro l'ipocrisia dei perversi l'uomo che guardi
con occhio umano al tempo e alle sue tribolazioni. Ma si rasserena
chi sia adusato a staccarsi dal tempo non materialmente e stabilmente, che questo non è concesso, ma spiritualmente, negli attimi liberi, di interiore sovranità (questi ultimi liberi sono pur
concessi a tutti coloro che fermamente li bramino, finché i seguaci del totalitarismo maestro di despoti, non mettano in atto il
suggerimento di Teilhard de Chardin d'intervenire con la chirurgia a modificare il cervello umano; però in quel momento stesso
l'uomo sarà sparito e la storia dell' Homunculus suo successore non
sarà congiunta a quella che finora ha legato i figli ai padri, e ci interessa appena, quanto la vita dei microbi che sopravvivessero
dopo la sparizione dell'uomo da una terra inaridita).
Sollevandoci dunque al di sopra della mischia domandiamoci:
i disegni abominevoli dei malvagi (e le confusioni, le illusioni degl'ingannati) otterranno davvero mai il loro scopo?
A parte le difficoltà impreviste che ostacolano il male non
meno del bene, forse che gli uomini privati della cultura avita saranno davvero assai più suggestionabili dei loro padri? Poiché la
libertà è il bene più caro (e si dice quella spirituale), ed essa viene
derubata mediante suggestioni, contradditorie ideologie e utopie, e dinanzi a queste l'uomo colto non è affatto, di norma, più
libero dell'incolto. Nemmeno un'abitudine ai classici dell'arte e
della speculazione fa necessariamente liberi, anzi talvolta rende
ancora più fragili e servili. Gli sciocchi girondini si beavano di
vaghe «riforme» senza indicarne né lo scopo né il prezzo, di declamazioni su un Bene che non dicevano mai per chi e come e a qual
fine fosse da stimarsi tale, di un progresso che non si curavano
nemmeno se fosse volto al bene o al male (e bene per chi, poi?); la
ghigliottina dei coerenti giacobini mozzò quei deliri in una piazza
con giusto sarcasmo intitolata alla Concordia. Codesti gabbati
per antonomasia, progressisti «senza esagerazione», non erano
forse pervasi di cultura umanistica, educati in collegi gesuitici,
nutriti di Plutarco, classicisti da riuscir stucchevoli?
Invero i colti sono suggestionabili quanto gli ignoranti. Un
pubblico di dotti si manovra con la stessa facilità di una folla di incolti; forse che «quello schifoso fantasma, lo spirito dei tempi»»
come lo chiamava Goethe, non seduce l'intellettuale quanto la
trepida femminella obbediente alle mode? Forse che le parole progresso dal secolo XVIII in qua, riforma nell'Inghilterra del '500 e
'600, non hanno fatto piegare il servile ginocchio ai colti (pur
adusati nella loro specialità a vagliare e pesare ogni termine) almeno quanto hanno eccitato i rudi avvinazzati declamanti e barcollanti per le strade notturne? Piega spesso il ginocchio al progresso anche chi pur sappia assaporare le pagine dei Salons di Baudelaire intorno a «quest'idea grottesca fiorita nella putredine della
fatuità moderna, che ha esonerato ognuno dal suo dovere, liberato ogni anima dalla sua responsabilità, svincolato la volontà di
tutti i legami che le imponeva l'amore del bello [...]». Pagine analoghe si potrebbero stralciare da Balzac o Proust, da Gogol' o Dostoevskij o Leskov, da Poe, Hawthorne o Melville, in genere dagli
autori geniali; i mediocri sofisti, insuperbiti dal loro talento,
amano l'incredibile volgarità della retorica progressista.
E dunque, pur privi di cultura umanistica, i nostri nipoti saranno aperti alla libertà spirituale né più né meno di noi. E la santità non viene irradiata sui miseri e ignoranti quanto sugli eruditi?
E che altro veramente conta? E forse che gli studi stessi non hanno
tendenza a vigoreggiare nell'oscurità e nei patimenti? Non riuscì
Roma a schiantare i cristiani, né la cristianità a estirpare lo spirito
pagano. Ciò che nella storia persiste emerge da una natura che
sempre riproduce i suoi esemplari, ridisegna i suoi corsi e ricorsi
in perpetuo. Invero la sapienza, la quale può essere «senza lettere»,
sa che nulla è mai tutto nuovo (cosi come tutto è sempre nuovo),
mentre un erudito spesso si illude superbamente d'essere chiamato a far l'araldo di nuovi cieli e nuove terre. In una sfilata di
quadri viventi indetta da Lorenzo il Magnifico uno, ideato dal
Pontano, mostrava il nuovo secolo d'oro emergente dal triste passato: sopra un guerriero morto stava tutto allegro un puttino
ignudo e dorato. Tale la stoltezza dei sommi umanisti alla vigilia
delle invasioni straniere, e del crollo dell'Italia. E alla vigilia dei
tempi moderni, sommi giuristi e teologi spagnoli giustificavano
in termini cattolici e romani il terribile spirito coloniale e mercantile europeo destinato a volgersi contro quanto v'era di bucolico e religioso in Europa e non solo a cancellare in Africa e in
America ogni traccia di indigena spontaneità. A che valse la loro
dottrina se non a farli errare in modo addottrinato?
Molte ricchezze, molti evangelici talenti, di cui oggi dispo-
niamo verranno ritirati per nostra viltà (chi difende il latino?) ai
nostri figli. Ma quel che conta è far fruttare i talenti che si hanno,
pochi o molti che siano, e Dio non toglie mai interamente fino all'ultimo talento.
Dicevano i cristiani dei primi tempi, affrontando un dovere
destinato forse soltanto ad accumulare sulle loro teste odio e vendetta: ho parlato per non macchiarmi, tacendo, dell'ignominia
commessa sotto i miei occhi, liberavi animarti meam.
«Corriere della Sera», 11 marzo 1968.
I precursori
A che paragoneremo il progressismo che si dice cattolico se non a
certi fantocci compositi in uso presso le fattucchiere nordiche e
descritti da Sheridan Le Fanu, nei quali una coda di volpe era cucita a un tronco di marmotta e ne pendevano, con sutura invisibile, due zampette di gallo e una testolina di civetta? La contraddizione voluta, l'ibridazione di cose incompatibili e orribili a vedersi l'una all'altra congiunte: tale il primo carattere del progressismo «cattolico». Il progressista invoca senza tregua libertà da
ogni autoritarismo, chiede con mille smanie la spontaneità e nello
stesso momento s'avventa con fare tra militaresco e burocratico
sui poveri cattolici fedeli alle loro tradizioni, accusandoli di sfida
all'autorità, brandendo decreti o circolari (o, più spesso, lo «spirito» di decreti e circolari).
Come il furfante è tra i primi a urlare «Al ladro», il progressista
non fa che ripetere «Pace, carità, pace, carità» per meglio perseguitare, intimidire, ingiuriare i fedeli colpevoli di amare i riti latini nella loro forma intatta, riluttanti all'inquieta, spasmodica,
infernale volontà di innovazioni (innovazioni senza estro, senza
necessità, senza frutto né di dottrina né di conversioni). Cosi chi
riconosca il carattere brutto e vecchio della liturgia volgare (risale
al concilio di Pistoia in Italia, al regno di Luigi XV in Francia e
venne scartata per sano, popolare disgusto), è tacciato di essere
ciecamente abbarbicato alle sue abitudini (anche l'amore dei genitori è solo un'abitudine?), di essere anziano (ma chi escogita le
novità non è quasi sempre vecchio?), di essere incolto o di essere
intellettuale.
Chi sarà così stolto da dubitare della malafede di coloro che
giudicano la bontà di argomentazioni e di tesi in base all'età o alla
classe sociale di chi le enunci?
«Amore, amore» delirano i progressisti; ma dai loro abbracci saranno accuratamente esclusi coloro che non paiano sul punto di accostarsi alle leve del potere politico. Non a caso quando il fascismo
era potente Teilhard de Chardin ne faceva elogi che vengono oggi
giudiziosamente dimenticati; si preferisce insultare chi li rammenti.
Proclami serafici e persecuzioni, tale il programma della chimera progressista, che si compone, quanto a concetti, d'un rappezzo di mode culturali smaltite dalla cultura laica almeno mezzo
secolo prima. Un ibrido, la cui principale origine è rimasta finora
sconosciuta. Vale la pena di estrarla da una parte di storia della
Belle époque rimasta nell'ombra o nel ridicolo.
Tutte le parole d'ordine diffuse durante e dopo il Concilio Vaticano II le ritrovi, a una a una nelle pagine d'una rivista che prese a
uscire nel 1909 a Parigi: «La Gnose», organo ufficiale della «Chiesa
gnostica». Era questo il titolo che avevano conferito alle loro adunate alcuni burbanzosi amici, i quali s'erano investiti di cariche
come «Patriarca» o «Vescovo», inventando altresì certe cerimonie
che, stando alle descrizioni, riuscivano a officiare impettiti, senza
ridere, indice dei loro caratteri atroci. «Gnosi» può significare parecchie cose diverse efraloro perfino contrastanti (nella Chiesa dei
primi secoli c'era una gnosi ortodossa e una ereticale). La Chiesa
gnostica parigina (che ebbe una filiale anche in Boemia) era semplicemente ciò che oggi è il progressismo cattolico. Si rimane abbastanza trasecolati scoprendo che uno dei compunti (o pincesans-rireT) vescovi era, sotto lo pseudonimo di Palingenio, René
Guénon giovinetto (chi non ha avuto una giovinezza suggestionata, compassionevole, salvo pochi invidiabili santi?).
La rivista pubblicava un Corso di controversia dove s'insegnava che il papa doveva diventare «un buon babbo» e nulla più.
Essa s'indirizzava ai cattolici «che si sentono virtualmente fuori
dei dogmi immutevoli e dell'intransigenza della loro Chiesa».
Esempio di bravo prete era considerato certo Hyacinthe Loyson,
il quale negava l'inferno, la confessione e l'infallibilità papale, e cui
giunse proprio in sulle fatte di tali negazioni «la dolce predestinata»,
certa madame Meriman. Loyson, dice la rivista, non è riuscito a
riformare la Chiesa, no, «ma dal suo tentativo è nato il modernismo;
i Loisy e iTyrrel ne derivano». Intanto, dopo il parto dell'eresia, Loyson celebrava infrancesee esibiva all'ammirazione della Chiesa gnostica, con la sua «predestinata» un esempio di «Coppia-Prete». Il
padre Teilhard avrebbe coniato una parola adeguatamente buffe che
si attaglia a queste smancerie pubbliche: «amorizzazione».
Il Male per la Chiesa gnostica era soltanto «l'istinto di separatività», ovvero «l'Egoismo, il desiderio di esistenza individuale»,
esattamente come oggi per i progressisti comunitari. E fa sgomento vedere la firma di Palingenio sono quella orribile semplificazione (il Male è separazione da Dio, non dalla società). Da tale
tradimento dell'etica, discende pari pari la dottrina liturgica, di
cui discorre una certa Esclarmonda (la saccente che non manca
mai nelle conventicole progressiste), proclamando che occorre
evitare sia il fasto cattolico che la nudità protestante (insegnava il
Manzoni nel Dialogo dell'invenzione cine, l'errante tenta sempre di
evitare le esagerazioni, per non fare i conti con le conseguenze) e
invitando, sulle orme di Giuda che voleva vendere per i poveri gli
unguenti rituali, a distribuire il prezzo dei paramenti e dei calici ai
diseredati.
La Chiesuola gnostica doveva presto scindersi e sciogliersi, coloro che ne fecero parte preferirono lasciar obliare l'avventura in
cui con gesti da Don Chisciotte avevano promulgato una teologia
da Sancho Panza. Eppure altri avrebbero accolto il boccio mostruoso, e riecco nelle pagine di Teilhard de Chardin, di lì a
trent'anni, riproporsi, nel medesimo stile fra parrocchiale e involontariamente Ubu alla Jarry, il catechismo della «Gnose» («Che
cosa ci fu all'inizio? - Il fuoco... ; Che cos'è la materia? - La manifestazione interiore del fuoco primordiale»), ecco che l'elogio dell'arte astratta, tema della «Gnose», diventava l'imbonimento commerciale dei mercanti parigini. I progressisti hanno tentato di
soffocare il cattolicesimo nel grottesco già sperimentato a Parigi
nel 1909 (Julien Green ha notato nel suo diario che con le liturgie volgari non è il senso del mistero che si perde ma il senso del
ridicolo), aggiungendo, di proprio, certe accortezze: l'arte di evitare chiarezza e semplicità, di attenersi al vago, di bandire le definizioni precise, e di usare sistematicamente, la riserva mentale.
Così, quando vogliono distruggere il culto dei santi e della Vergine Maria, dicono: «Il culto dev'essere cristocentrico»; se desiderano liquidare la tradizione ingiungono: «Bisogna essere scritturistici»; qualora sperino di ridurre le liturgie a riunioni di assemblea
affermano: «La partecipazione del popolo dev'essere attiva»; al-
lorché si accingono a negare il carattere sacrificale della Messa ripetono: «Mensa, pasto eucaristico». Perfino la loro gioia di scagliar l'altare ai piedi dell'assemblea figurava tra i dadà della
«Gnose».
Il male è monotono, tutte le chimere d'oggi risalgono a una
sola matrice, anche questa disintegrazione dell'ordo catholicus
non è se non il frutto d'un errore che ha mille forme e che vano sarebbe respingere in una delle sue incarnazioni per poi accoglierlo
in un'altra. L'unica strategia possibile della verità è l'estirpazione
dell'idea stessa di progresso. E come suscitati da una voce imperiosa, che pure promette soltanto persecuzioni e lacrime, vendette
tortuose, altri e meglio di chi scrive osano rovesciare il detestabile
idolo del Progresso. Due volumetti sono comparsi presso Edizioni di Ethica (Forlì), i Catechismi giansenisti e Sociologia e antropologia di un giovane filosofo, Gianfranco Morra, dove l'ideologia progressista non viene soltanto vanificata nella sua forma più
triviale, che è il travestimento cattolico, ma anche nelle vesti più
ammalianti, nel suo aspetto tecnocratico, «che si fonda su di un
sostanziale disordine del linguaggio, il quale risulta tanto più
strano in quanto viene compiuto proprio da chi vanta una rigorosa metodologia e una specializzazione critica». Morra cita due
passi di Heidegger che splendono per la loro forza logica intrinseca (pur facendo parte di un'opera spesso inquinata): «Quando è
attenta alla sua essenza, la filosofia non progredisce. Essa segna il
passo in un luogo per pensare costantemente la stessa cosa. Progredire significa allontanarsi da questo luogo: è un errore che
segue il pensiero come un'ombra. [...] La filosofia è storica soltanto nella misura in cui come ogni altra opera dello spirito, si
attua nello svolgersi del tempo. In questo senso tuttavia affermare
che la metafisica ha un carattere storico non la caratterizza affatto,
ma dichiara semplicemente qualcosa di ovvio».
«Corriere della Sera», 13 maggio 1968.
L'attesa come frode
Nella cultura del Novecento corre assai spesso una strana promessa di speranza: si sarebbe alla vigilia di un mutamento radicale; ancora un istante, un altro istante, ed ecco, ci si ritroverà su
una terra vergine. Quel che enigmaticamente appare sulle tele,
sulle carte, sui pentagrammi sarebbe già il vagito delle creature
nuove, il gesto degli innocenti che schiudono gli occhi sul paesaggio inesplorato dove il male è ormai soltanto il ricordo del vecchio mondo lasciato alle spalle, come per Lot e i suoi, fuggenti da
Sodoma. Come per Lot e le sue figlie le vecchie leggi sono abrogate; tutto è lecito in terra nuovissima. I veggenti, i poeti già vivrebbero sotto quel cielo sconosciuto, balbettando la lingua
inimmaginabile, abbozzando i primi atti della storia inedita, del
ciclo nuovo.
Questo sentimento offre agli animi notevoli vantaggi: è una
sorta di anno giubilare, i manipolatori di sentimenti lo somministrano al modo stesso che i demagoghi offrono alle masse la cancellazione dei debiti e l'uguaglianza.
Terre nuove e cieli nuovi sono in verità dati a compenso di un'ascesi che affranchi dalla servitù al peccato: certamente chi sappia
sciogliersi dalle catene della superbia, dell'avarizia, dell'ira, della
libidine, dell'accidia, dell'avidità di cibi e narcotici, dell'invidia, si
ritrova sciolto, incredibilmente rinnovato, con una mente capace
di straordinarie scoperte, tutt'insieme simile a un fanciullo e sapiente come Salomone, poiché non gli fanno più velo gl'inganni
intessuti dai suoi stessi vizi. Ride ora di chi tenti di truffarlo facendo leva sull'avarizia, di chi procuri di inebriarlo eccitandogli la
gola, di chi lo stimoli all'ira mostrandogli la forza e la fortuna altrui e aspettandosi che le invidii, di chi gli faccia balenare le solite
immagini della lussuria, di chi, infine, ignorando che egli fra sé e
sé è occupato a sollevare il cuore verso le realtà nuovissime che
viene scoprendo, speri di instillargli la noia. Terre nuove e cieli
nuovi gli sono dati e se egli rammenta ora il suo passato, quando
era alla mercé di chiunque sapesse con accorte parole e immagini
sedurlo, ne prova orrore e pietà; ormai è entrato in un tempo dove
il futuro non lo tiranneggia più con le sue ansie, né il passato con
le sue abitudini, né il presente con le sue mollezze, vive in uno spazio dove sono diventate trasparenti, dileguate le quinte ingannevoli dei desideri, delle nostalgie, delle speranze.
Anche i più scellerati sanno che esso esiste, poiché neanche loro
ignorano del tutto che cosa sia la quiete, la pacificazione, la letizia
sobria, ma allorché li si avverta che per arrivare a tanto occorre
una purificazione, un abbandono dei loro vizi prediletti, uno
smascheramento dei truffatori cui sono affezionati (i venditori di
speranze, gli ammiratori delle loro ire, gli aizzatori delle loro invidie, gli adulatori e i ruffiani), allora si ribellano, gridano al Dio
crudele, ai tiranni spirituali che vorrebbero tali rinunce. E poiché
si vergognerebbero di essere del tutto sinceri, eccoli ammantarsi
della veste inconfondibile d'ogni laidezza: l'umanitarismo; dicono di voler salvi tutti quanti e non i pochi beati, mercé una rivoluzione della società, del cosmo stesso. Ecco che a questo punto
sopraggiunge a sfruttare quest'animo rivoltato, umanitario, violento e smanioso, l'annunciatore di apocalissi: «Tutto sta per capovolgersi! Siamo alla vigilia! Ecco il Regno della Libertà. Ancora
più a fondo nello sconvolgimento, esasperiamo le contraddizioni, i dolori, distruggiamo tutto; affretteremo la catastrofe che
precede l'Avvento!».
Siccome non da oggi l'uomo desidera rinnovarsi ma rilutta a
purificarsi, non da oggi si sfrutta questa sua debolezza. Per tutto il
Medio Evo i predicatori d'apocalissi imminenti fecero buoni affari suggestionando ora conventicole ora folle intere, e fra gli umanisti ci furono ottimi rivenditori di una vaghissima Renovatio, per
non parlare degli estremisti fra i riformati. Nei tempi moderni gli
apocalittici spesso hanno smesso la maschera religiosa, ed è l'unica differenza.
Rivenditori di attese apocalittiche non sono soltanto i demagoghi, ma anche ispirati poeti. Yeats non parla forse con tono misterico di un nuovo cielo nel quale tutto sarà rivoluzionato? Non
predice forse nuove forme destinate a profilarsi di tra le fiamme
che consumeranno l'antico mondo putrefatto? Non è soltanto
l'incolta e confusa vittima dei demagoghi dozzinali a farsi alluci-
nare da questo specchietto, ma anche l'amante di poesie squisite.
Non sarà certo la cultura o la poesia a salvare l'uomo connaturatamente servile e suggestionabile. Quanti giovani delicati si avviarono alle battaglie della seconda guerra mondiale con un libretto di Rilke come conforto? E chi più di lui eccitò vergognosamente questa aspettativa trepida e stolta?
È un'attesa che dura da sempre: da quando l'uomo ha desiderato i benefici della purezza interiore senza volerne pagare il
prezzo in ascesi: dal tempo degli apocalittici antichi fino alle versioni secolari del Rinnovamento Ciclico (Robert Southey, che
con i giovani letterati inglesi giacobini aveva previsto, secondo
calcoli laici, non meno superstiziosi dei computi astrologici dei
millenaristi medievali, il Rinnovamento per mezzo della Rivoluzione francese, scriveva dopo essersi ravveduto: «un mondo visionario parve dischiudersi a coloro che erano alle soglie. Le cose
vecchie parevano sul punto di dileguare e si sognava soltanto più
la rigenerazione della razza umana»).
Le chiromanti da sempre hanno saputo sfruttare questa attesa
indeterminata: la «svolta nel destino» figura nel loro repertorio al
pari del «viaggio per mare» del «militare», della «donna bruna invidiosa». Stimolare l'Attesa apocalittica è un buon affare non solo
per le chiromanti ma per tutti coloro che si dedicano alla frode
pubblica. L'Attesa è una cassa di risonanza che dà vibrazioni
profonde a suoni striduli e ridicoli come «Progresso», «Sviluppo»,
«Promozione», «Autogestione». L'Attesa rende fluidi i concetti, i
sentimenti che un motto qualsiasi coagulerà formandone una
massa. La somma delle nevrosi individuali dà il motto socializzante e rinnovatore, che dev'essere generico, insignificante, sotto
pena di non funzionare. Un buon progetto legislativo non fùnge
da specchio magico, ripugna ai sacerdoti dell'Attesa apocalittica,
non serve ai nevrotici come schermo dove proiettare il loro inconfessabile delirio, non socializza l'intimità vergognosa. Se mai
dal motto qualcuno estrarrà un progetto di legge, il miglior affare
sarà di quanti protesteranno che esso è una delusione, un tradimento della santa Attesa.
L'ideologia ormai universale è tecnocratica, fondata sul culto
dell'Industria e della sovrapproduzione, ed essa deve provvedere
ad amministrare anche questa escrescenza fatale: l'Attesa apocalittica, la rivolta al sistema stesso. Non è un problema arduo: l'unico
pericolo per il sistema tecnocratico sarebbe una diffusione della libertà interiore, un ritorno di pochi o molti ad una vita ascetica che
piegasse i vizi capitali e rendesse perciò liberi dalle suggestioni
ideologiche. È un pericolo che nulla fa credere prossimo, le istituzioni religiose provvedono, ormai, per lo più a distogliere da simili
purificazioni, eccitando invece all'Attesa ed al Progresso. È viceversa un alimento alla Tecnocrazia la diffusione della droga, della
libidine, il consumo di motti imprecisi. Anzi, soltanto mercé questa combustione più rapida delle merci culturali e ideologiche il
sistema riuscirà a sopravvivere, perciò esso avrà bisogno sempre di
«parchi nazionali» dove una popolazione selvatica, drogata, offra
l'unica alternativa alla disciplina aziendale.
L'ideologo della tecnocrazia fu nell'800 il visconte di SaintSimon, l'ideologo dello sfrenamento istintivo fu il Fourier. La formula del sistema attuale è un saint-simonismo che include isole fòurieriste nutrendole e nutrendosene. Come nelle simbiosi del regno
animale i due sono parassiti e sfruttatori insieme l'uno dell'altro.
Il sistema attuale pone un aut aut fra ordine industriale da un
lato e violenta, distruttiva, collettiva degradazione dall'altro. L'Impero pagano non si resse su analoghe spinte contrarie, come una
pietra di volta tra gli archi opposti? La burocrazia imperiale che
reggeva la vita economica in ogni suo tratto sotto Diocleziano e la
plebe ipnotizzata dal sangue e dal sesso erano le due colonne d'un
edificio che aveva bisogno di entrambe per durare.
Chi avrebbe potuto immaginare che tutto sarebbe crollato a
causa di uomini che si staccavano senza violenza dalle seduzioni e
dall'ordine e dal disordine sociali, mirando soltanto a raggiungere
nuovi cieli e nuove terre dentro di sé, al di fuori dei templi e dei
sacerdozi veneranti l'Impero, la Società?
«Corriere della Sera», 25 maggio 1968.
La canzone del male
Da quando il Cristianesimo sorse, ad ogni nuova generazione di
cristiani è toccato immancabilmente di subire una identica, lugubre tentazione; una voce cupa e leziosa si leva, a una svolta della
loro vita, per sedurli. Ad ascoltarla attentamente, ci si accorge che
è in realtà un lamento d'idiota, consta di poche proposizioni, mai
variate. Eppure fa strage di cuori; è come se i giovani che s'aprono
alla vita non vedano l'ora di precipitarsi in antichissimi tranelli,
afferrati da morti invidiosi che vogliono vederli ripetere le proprie
passate, vergognose pantomime.
La prima nota della vecchia canzone può variare fra i due estremi
della gamma, può essere una nota di orrore: «Siamo caduti, noi
puri spiriti, in un mondo sozzo e ripugnante, siamo nati immondamente» oppure può essere una nota di isterica euforia: «Siamo
in un mondo stupendo, avviato a diventarlo sempre più, alla vigilia di una esplosione di bellezza e di carnale felicità». Poco importa da quale folle estremo cominci il canto del Seduttore, il suo
svolgimento è sempre eguale, porta all'ingiunzione: «Bisogna fare
tutte le possibili esperienze» o perché soltanto così ci si libera della
sozza materia, esaurendone tutte le possibilità, o perché, tutto essendo sacro, non c'è niente che non sia doveroso attraversare (magari: per comprendere ogni fratello). Come si vede, poco importa
la premessa, che essa si trovi all'una o all'altra estremità della
gamma. Chi oggi non ripete docilmente, stregato: «Devo fare
esperienze?». E così ai primordi del Cristianesimo i seguaci di Basilide ritenevano di dover compiere tutti i peccati, e ne contavano
365, quanti i giorni dell'anno, e si convincevano che un angelo
presiedesse a ciascuno, intento a spingervi i mortali, e che nel
compierlo convenisse rivolgersi a costui dicendo: «O angelo,
compio la tua opera, o Potenza, eseguo la tua azione». E facendo
esperienza d'ogni abominio dicevano di liberarsene e di volare
quindi nel puro Spirito.
E non soltanto i seguaci di Basilide seguirono questi precetti
perversi. Sant'Ireneo di Lione ammoniva: se volete davvero tutte
le esperienze, perché non imparare intanto tutte le arti e i mestieri? Ma sarà la trafila delle iniquità ad attrarre lo stuolo dei seguaci di questa tradizione satanica, che ritornerà, sempre identica, tra Fratelli e Sorelle del Libero Spirito, tra beghine e begardi
nel secolo XIV. Tra gli Alumbrados o «illuminati» di Spagna, tra
certi quietisti infami nel secolo XVII, la si indovina assai facilmente, e non c'è bisogno di indovinarla, è tutta allo scoperto fia
le sètte sinistre della Russia. Sempre in nome dello Spirito che è
opposto alla Natura, come presso i basilidiani e nicolaiti, rieccola
in Hegel, che raccomanda di liberarsi delle passioni appagandole.
E, nel campo stesso della Chiesa, riappare tra i falsi mistici dell'Ottocento abbordati da Huysmans. E non occorre proseguire.
La vecchia monotona canzone, nella sua seconda strofa, proclama
che finora sì vigevano certe leggi, sussistevano certi istituti, ma
ormai tutto dev'essere nuovo, incomparabile, rinnovato, lavato
col fuoco, perché cieli nuovi e terre nuove si schiudono, si è divenuti adulti, usciti una buona volta di minorità. La nuova dispensazione, già proclamata dai malprofetanti eresiarchi dei primi secoli, è riproclamata dagli Amauriciani medievali («Ormai si è
adulti, si è al ciclo dello Spirito!») per essere condannata dal secondo Concilio Lateranense, e riemerge con certi minoriti del secolo XIII i quali ripetono (oh terribile monotonia!) (testo latino):
«Venne un uomo chiamato Giovanni e ciò che vigeva prima di lui
fu ritenuto superato [...] e così adesso, in questo tempo in cui
spira lo Spirito [...]». Rieccolo, il misero ritornello, condannato
ancora nel secolo XV, quando lo ripetono gli homines intelligentiae, dicendo che le dottrine degli antichi santi e dottori cessano e
ne sopravvengono di nuove: cessabunt et supervenient novae. È
comprensibile: a chi deve smerciare un antichissimo ciarpame
conviene gridare al rinnovamento, l'adeguamento dei tempi.
Ora segue, di solito, un'altra strofetta della triste canzone: il richiamo demagogico alla povertà ed al servizio sociale. La intonò
per primo Giuda Iscariota per rimproverare la Maddalena di versare il nardo sul Cristo invece di darne il prezzo ai poveri.
Quale settario medievale non insistette che occorreva tornare
all'evangelica povertà, al mero servizio, superando il sacro? La tradizione d'iniquità detesta tutto ciò che nutre la quiete e l'abbandono al divino, specie i riti immutevoli e reitera perciò nei secoli
le accuse dei Piccardi al fasto cerimoniale (ornamenta ecclesiarum
omnia derident), ripetono con gli Alumbrados che è preferibile la
virtù all'eleganza di culto (è una frode stantia: si finge che si debba
scegliere fra due cose che non sono mai state in contrasto; chi ha
mai costretto a optare fra virtù e bellezza del rito? Incredibilmente
nei secoli questo trucco da nulla si dimostra sempre efficace); giù
fino ai segreti del Concilio di Pistoia, capolavoro dell'odio satanico verso la bellezza rituale.
Se è incredibile che una cosi prevedibile e monotona iterazione
sempre ancora trovi vittime, è miracoloso che si sia pur salvata respingendo un assalto dopo l'altro di queste vittime impazzite, la
tradizione opposta, che di secolo in secolo ha ripetuto le sue distinzioni rigorose, celebrato ne varienturì suoi riti austeri, preservando intatti i suoi canti, i suoi gesti benedicenti e impetranti.
Anch'essa offre un rinnovamento, ma è quello dell'uomo che si
pente e rinnega se stesso, e perciò emerge tutto imprevisto e
nuovo. Anch'essa offre un'ebbrezza, ma accompagnata da una serafica, guerriera severità. Oggi ci si ricorda ancora in molti di quest'altra tradizione, benché tutto sia messo in opera dai potenti di
oggi per cancellarne le tracce; e ciò che ci si ricorda facilmente
riaffiora. E se ci si dovesse scordare della sua esistenza, rieromperebbe improvviso con un contraccolpo violentissimo, poiché
scancellarla del tutto è inpossibile; infine, la canzone del male vive
solo come ribellione, offesa e sacrilegio. Di ciò che odia e perseguita ha bisogno.
«Corriere della Sera», 7 luglio 1969.
Un fatale incontro
Stupiva tutta Parigi il marchesino di Condorcet, così dotto, cosi
precoce, matematico e letterato trascinante; i padroni dell'opinione pubblica, D'Alembert, Turgot, Voltaire lo vezzeggiavano
ed egli li ricambiava generosamente, divulgando con stile focoso
le loro idee così progressiste, le loro violente irrisioni. A comporre
un quadretto squisito, gli stava al fianco, bellissima, letterata e,
come lui, tutta dedita alle idee progressiste, la moglie. Quanta filantropia, che belle e buone intenzioni, quali umanitari ardori si
spandevano come rosea nube dai due coniugi esemplarmente
moderni! E che ammirevoli indignazioni mostravano contro ogni
altrui ingiustizia o arretratezza!
Ecco finalmente la rivoluzione: la coppia Condorcet si prodiga
con doveroso entusiasmo. Vedilo, lui, membro del consiglio municipale interprete dei voti del Popolo, così svisceratamente
amato! Vedilo, ancor più intimamente interprete dell'Amato,
membro all'Assemblea. Quanti mai proclami non modella in
prosa nitida ed elegantissima l'ex allievo dei gesuiti, quanti progetti legislativi non compila con scrupolo di matematico, pianificando l'educazione nazionale! E circola la voce che non gli tremi
il cuore tutto avvampante di novità e razionalità allorché fa bruciare gli antichi codici dei monasteri. Non è forse - la vecchia cultura — il ferro con cui l'anima popolare è stata incatenata dai preti
e tiranni al suo triste servaggio? Nessuna pietà per chi non venera
la fonte d'ogni bene, l'anima del Popolo.
Ma passando di esaltazione in virtuosa indignazione, il marchese s'era scordato (forse perché in matematica, la scienza per eccellenza razionale, il problema non si pone) di domandarsi perché
mai proprio lui debba rappresentare il Popolo più di un altro. Lo
ama? Certo. Ma chi non ama il Popolo, salvo certi inimmaginabili mostri? I deputati detti della Montagna ritengono che Condorcet e i suoi amici siano indegni di parlare a nome del Popolo
Sovrano, incapaci di coglierne i sottili movimenti di volontà indiscutibile. Dalle chiacchiere, regno dei Condorcet, si passa alla
lotta spietata, e la Montagna è la favorita degli dèi del Popolo.
Condorcet, minacciato dalla ghigliottina, scampa in casa di un'amica, che lo accoglie con le belle frasi umanitarie che egli ama.
Nel nascondiglio continua a inebriarsi di parole, parole, parole
traboccanti d'amore per il Popolo, la Giustizia, la Razionalità. E
ne vien fuori un trattato sul Progresso dove si favoleggia che
l'uomo dalla bestialità primigenia sarebbe passato attraverso varie
ère lentamente progredendo, fino al Futuro Radioso che è per
scoppiare, in cui cesserà l'orrida Disuguaglianza, tanto fra le nazioni quanto fra le classi, e tutti avanzeranno senza fine sia intellettualmente che moralmente e fisicamente. Avanti! Avanti! Sgombrata la via dalla religione, dalle disuguaglianze, un anelito fecondo, incessante, verso più e più e più luce!
Un giorno Condorcet esce di soppiatto dal rifugio, ma coloro
che sono più progressisti di lui (il peggio non è mai morto) sono
all'erta. Egli fugge. Lungi da Parigi, in una foresta. Erra straziato
dai triboli, illanguidito dalla fame, una gamba offesa, ma finalmente scorge il borgo di Clamart. Osa, sotto il pungolo della disperazione, avventurarsi in un'osteria. «Una frittata» implora.
«Quante uova» domanda l'oste. «Dodici.» Il numero perfetto, rispondente ai mesi dell'anno, alle ore del giorno, alle tribù d'Israele ed agli Apostoli, è infausto per il marchese. Forse «dodici
uova» era la formula con cui si ravvivano le forze del marchese
dopo le uniche fatiche fisiche a lui note. Un'abitudine al Popolo
sconosciuta. L'oste gli domanda: «Che mestiere fai?». Il marchese
mente: «Il falegname». Non osa dichiararsi filantropo, demagogo,
progressista; del suo vero mestiere, sente dunque finalmente, vergogna. L'oste replica: «I falegnami non hanno mani come le tue e
non chiedono frittate di dodici uova». Come non bastasse, gli trovano in tasca un volume di Orazio.
Per arrivare alla lontana prigione deve trascinarsi sulle dure pietre con piedi sanguinanti, e gli spintoni del Popolo lo sorreggono
quando incespica. Alla fine sviene e si ritrova in un'umida segreta.
Di che morì quella notte? Di sofferenza o di veleno? Posso ora
svelare il segreto. Perché fili io a visitarlo. Lanciai un sacchetto di
monete al secondino, ebbi accesso allo stambugio stillante un gelido umore dalle pareti di pietra. Tremava di febbre, buttato sul
pavimento, nel fioco chiarore lunare. Volse lentamente la testa
alla mia figura ammantellata e tentò di fermare lo sguardo che di
continuo gli si velava. Mormorò: « Citoyen...».
«Bando alle ingiurie» dissi «non ho patria quaggiù e i potenti li
disprezzo abbastanza da potermene senza fastidio chiamare suddito.» «Forse indovino, lei è di quei bizzarri inglesi che salvano le
vittime della Montagna.» «Preferisco semmai, fra gli esecrabili, gli
estremisti, che almeno sono coerenti, a voialtri, sovvertitori a
metà.» «E allora che vuole da me?» «Comprendere. Comprendere
come un uomo di non scarso ingegno quale Dio l'ha creato, e
marchese, possa operare per la distruzione di ciò che rende degna
la nostra povera, breve esistenza sulla terra. Come può ella aver
approvato la distruzione di Cluny, di Marly, della più rara arte
francese? E dico il meno, poiché più non s'alzano dagli stalli dei
monasteri le devote melodie e perfino la semplice creanza è sparita dal suolo di Francia. Voglio ben sperare che ella non sia stato
in buona fede, come le canaglie; fra sé e sé, illustre marchese, avrà
ben tenuto per chiacchiere le parole d'ordine: cittadini, nazione;
contratto sociale, volontà generale.»
La mia destra istintivamente tracciò un segno di croce per l'orrore.
«Ella mi vuole far fuggire? SI certo, immagino che La Fayette
abbia intese con gli esuli, e sono disposto a...»
«Non mi fraintenda. Non sono qui per opera mondana. Della
dinastia che accumulò tanti peccati, non m'importa niente e La
Fayette mi disgusta.»
«Ah, vorrebbe farmi confessare da un prete? Perché no? Oh
dolci illusioni... Oh memorie... »
«Che prete! Quello di qui è colui che le sferrava or ora i calci più
violenti. Già sotto Luigi XV aveva smesso di dir messa in latino e
insegna ora che Gesù fu il primo Sanculotto.»
«E allora...»
«Già ho detto: voglio comprendere. Non ho altro fine. Ora che
hai subito ciò che subirono i martiri cristiani da te derisi, sai
quanto fosse futile il tuo sogno di eliminare l'ascesi e il dolore dal
mondo e forse ti avvedi della stoltezza di chi vuole imporre i propri confusi desideri al cosmo e alla storia.»
«Eppure la Costituzione del Novantatré è buona, moderata;
viene incontro al giusto bisogno di riforma...»
«No, nemmeno da un inerme posso tollerare tali ciance! La Costituzione che garantisce la libertà di fare ciò che non lede i diritti
altrui! I diritti dell'uomo! L'uomo ha semmai diritto alla verità, alla
realtà e alla moralità, ma questi sono anzitutto doveri! Tu intendevi
la libertà di essere corrotto e di corrompere, di sradicare la fede, di
eccitare, con l'idea dell'Uguaglianza. Gl'ignoranti sentono invidia
dei colti, e gli stolti degl'intelligenti, perciò l'arma micidiale è destinata a colpire anche i Condorcet. Tu e i tuoi avete aizzato l'invidia e la lussuria, e avete tolto di mezzo quell'esile difesa, il pudore,
ed ecco il vostro regno che dilaga sulla terra: ogni bellezza, ogni
dolcezza per colpa vostra sono scovate e punite! Il livore dell'inquieto orgoglioso scoprirà nel volto del più umile asceta la luce
della quiete e l'invidierà, e in nome della Società, del Progresso,
torturerà l'innocente. In tutta la Francia i paramenti sono strappati agli altari, e stupisci che anche tu, l'istigatore, sia aggredito
dalla belva che hai eccitato? Nulla di umano ti è alieno, ripeti col
tuo Orazio? Ebbene, l'uomo senza sacralità, senza pensieri divini,
senza pudori, è una belva che gode della distruzione. Il divenire, la
storia, l'incessante modificazione: questi gli dèi che hai voluto sostituire al Dio che ispirò le cattedrali. In India essi si venerano sotto
il nome di Kall, che ride brandendo una testa mozzata.»
«Forse il popolo non è ancora educato alla libertà.»
«Oh, quale superbia! Un mio fischio e il guardiano accorrerà a
punirti! Come oseresti educare il tuo Sovrano! Già ci pensano a
educarlo, alla strage e all'uguaglianza assoluta, i distruttori, coloro che perseguono il Male fine a se stesso. I veri seguaci di Kall,
non i timidi, i moderati acciarponi.»
«Ma che cosa proponi tu?»
«Ecco la domanda perversa. Non ho il dovere di proporre
niente.»
«Siamo nati per operare, per migliorare il mondo, per trasformarlo. Se non c'è niente da fare, tanto vale morire.»
«Morire alla tua ambizione, alla tua superbia, alla tua inquietudine.»
«Ma queste sono la vita, la vita, la vita!»
L'urlo del marchese fu si veemente, sì convulso, che egli rimase
strozzato.
«L'Europa», 9 marzo 1970. Ripubblicato ne La nube del telaio, Mondadori, Milano 1996, capitolo XI.
La persuasione occulta
[...] Il mondo moderno ha in realtà un suo testo sacro nascosto, e
nascosto in modo straordinariamente accorto; cioè, non è necessario chiuderlo in scrigni, non occorre vincolare nessuno al segreto;
è un testo sacro nascosto, semplicemente perché tutte le sue parole
si possono sostituire con altre, e raramente vengono allineate l'una
dopo l'altra. È un testo sacro per rubare l'espressione a certi teorici
della musica contemporanea, aleatorio, perché se ne possono rimescolare i vari elementi a caso, e il risultato non cambia.
Si può anche fare un test, giacché parliamo di manipolazioni
psichiche, una prova delle reazioni che si suscitano allorché si allineino tutte le frasi del «testo sacro» oggi prevalente.
Chi sarà colpito dal loro grottesco aspetto ha speranza di salvezza. Ma pongo una premessa, prima di dar lettura di questo
testo sacro occulto. Le parole che seguono possono essere utilizzate a qualsiasi scopo, ma è sempre «il potente» che se ne avvale,
perché esse non fanno che istradare chiunque nella direzione in
cui tutti vanno, la direzione generale prestabilita dal potere.
Questo «testo sacro» è tale non perché sia mai stato proclamato
tale, ma perché di fatto agisce come tale. Infatti nessuno oggi si
sognerebbe di mettere in dubbio le sue proposizioni.
Qualunque uomo politico stralcia, da questo testo sacro, le
frasi con le quali galvanizza il suo pubblico, qualunque industriale ne ricava i motti che convincano a comprare il suo prodotto, qualunque giornalista disonesto ne rimescola i concetti.
Ne farò dunque esposizione, unirò le varie frasi che lo compongono. Beninteso potrei cominciare da qualsiasi parte, andare
a ritroso o utilizzare questi elementi come un musicista.
Ecco il testo sacro che ci è inculcato, senza tregua, ogni giorno:
Occorre proporsi un rinnovamento costante per giungere a un'apertura spregiudicata a tutte le istanze, accettando una situazione
precaria e feconda in un'incessante ricerca collettiva delle possibilità di sviluppo e di crescita sociale, spezzando le remore, rovesciando le strutture acquisite e rivoluzionando le forme accettate
per aprire nuovi orizzonti d'indagine, sollecitando i contributi costruttivi e un ridimensionamento che mena in crisi le categorie e
le strutture, proponendo esperienze sociali sempre nuove in
un'accettazione consapevole dell'inquietudine e dei rischi di una
rimessa in questione dei principi statici sì da superare le preclusioni aprioristiche, le chiusure sterili, allargando la partecipazione
a tutti i livelli in vista di una revisione basilare degli schemi in uno
slancio generoso e con impegno incessante e sofferto, volto a distruggere le barriere, le vischiosità antistoriche che impediscono la
libera crescita, e l'innovazione sociale, educando a un ripensamento critico che travolga le cristallizzazioni Assiste e i residui formalistici con una rivoluzione radicale secondo nuovi moduli tecnici che permettano di uscire dall'immobilismo per riprendere lo
slancio in avanti in un clima di lavoro comune per liberare dalle
istituzioni ormai superate [...].
Ognuna delle parole di questo orrido «testo sacro» si può sostituire con un suo sinonimo. Le frasi possono essere sovvertite nel
loro ordine, e il risultato sarà sempre uguale. Questa tensione violenta quanto vaga, questa idea di movimento che non si sa dove
conduca, di dove parta, sarà riempita appunto dalle proiezioni
personalissime di ciascuno. L'insieme delle proiezioni privatissime sarà «socializzato».
Si può anche allestire un gioco delle parole d'ordine, con il seguente sistema, escogitato da un celebre clinico spagnolo:1 disponete tre filze di parole su tre colonne. Nella prima potete scrivere
parole tecnologicamente adorabili: programmazione, strategia,
mobilità, pianificazione, dinamicità, flessibilità, incremento, strumentazione, proiezione. Nella seconda colonna potete dispone
una serie di parole lievemente diverse, che diano un suono propiziatorio e dinamico, e infondano un tal senso di incoraggiamento
e di mobilità: funzionale, operativo, dimensionale, transazionale,
strutturale, globale, direzionale, opzionale, centrale. Mentre nella
1. Garcia Miranda in una conferenza il cui testo è apparso in «Noticias médicas»
(Madrid, 24 aprile 1969).
terza colonna possono trovar posto parole ed aggettivi che, dopo
questi, dinamizzanti, appaiono rappacificanti, tranquillanti, come:
sistematico, equilibrato, integrato, rilanciato, coordinato, combinato, stabilizzato, parallelo. Poi fatevi dire un numero qualsiasi di
tre cifre, componete assieme a caso le parole risultanti nelle tre colonne ed eccovi combinazioni come: «programmazione funzionale
sistematica», «strategia frazionale integrata», «flessibilità globale
equilibrata», «strumentazione opzionale coordinata» — e potete azzeccare un numero di combinazioni che la legge di probabilità vi
dice quasi infinito.
Il testo sacro della nevrosi moderna ha anche questo carattere
cancerigno, di proliferabilità all'infinito.
Questo è il sistema, il turpe gioco, quotidianamente, seriamente praticato; ma c'è anche un altro accorgimento dei persuasori occulti: quello di mai pronunciare la parola «tematica».2
Si mette in moto un sistema di parole sradicate, attenendosi
alla regola che vieta di pronunciare l'unica parola chiarificatrice,
cioè di svelare lo scopo occulto al quale si tende.
Certe riviste eleganti sono volte a infondere il piacevole senso
di appartenenza a una élite dalle ciglia inarcate e dalle labbra sempre increspate in un sorriso di sufficienza, e sono le scuole perfette
di questa tecnica di occultamento.
Valga un esempio. In America va emergendo una nuova coscienza tribale, dei Pellerossa. Diventa clamoroso il loro desiderio
di vivere secondo le costumanze ataviche, di non essere intruppati
nella massa produttiva, e naturalmente la rivista aggiornata deve
pubblicare dei «servizi» sull'argomento. Ora, il massimo fra i problemi che affiorano col movimento di riscossa degli Indiani, è che
essi non agitano problemi economici; non chiedono che il governo stanzi fondi per la costruzione di strade che fendano le riserve, di scuole e di ospizi. Altro fatto allarmante, per chi ami l'assetto sociale moderno: i Pellerossa frequentano le Università, imparano a comportarsi come perfetti ricercatori, per poi riaccettare
2. Walter Benjamin insegna che anche nelle grandi opere d'arte questo nascondimento della parola «tematica» è un proficuo artificio rettorico.
l'autorità degli anziani e della Tradizione, risoluti a vivere una vita
improntata ai valori religiosi rivelati.
Ora per la rivista ben patinata, per la slick-magazine, tutto ciò è
oltraggioso, e infrange alcuni dei più fermi tabù. Certo, la religiosità si può ammettere, ma purché non significhi una modificazione
del pensiero vigente, e sia un atteggiamento sociale fra tanti altri.
I Pellerossa minacciano questo dogma nascosto, e per ovviare
alla minaccia Edmund Wilson, un maestro dei servizi ben patinati, ha dato una dimostrazione di virtuosismo sul «New Yorker».
Ha trattato i Pellerossa con simpatia; è ovvio che una slick-magazine sta sempre con chi protesta. Ma egli è riuscito a nascondere
completamente il centro e il fine delle loro proteste: la volontà di
vivere secondo i valori religiosi della loro tradizione.
Vediamo con quale tecnica ci sia riuscito. Ha evitato di ammettere che le esperienze religiose possano, per ipotesi (perché è
un principio di questo tipo di riviste illuministiche che in ipotesi
si debba ammettere tutto e non ci si irrigidisca contro nessuna
prospettiva possibile) avere mai un carattere oggettivo; quindi saranno sempre la proiezione di qualche interesse materiale. Questo, che è il presupposto di tutta l'indagine di Wilson, non è mai
dichiarato. È la base tematica occulta, oculatamente nascosta per
tutto il servizio. Tutt'al più, dovendovi accennare, se ne parla con
un certo qual tono ironico, lievemente ironico, per far capire che
non sarebbe nemmeno bene immaginarsi di poter proporre seriamente, come ipotesi, che la vita mistica non sia un'allucinazione
compensatoria.3
La parola d'ordine e l'occultamento del tema sono dunque i
cardini della persuasione occulta.
Ma di recente è stata elaborata e messa in opera un'arma nuova, e
più pericolosa della precedente: la «tecnica di gruppo».
Si sperimentavano tali tecniche durante la guerra, per guarire i
traumatizzati dalla battaglia: parlando, sentendosi in un gruppo,
che a poco a poco sprigionava un certo calore di appartenenza, i
3. Cfr. E. Zolla, Iletterati e lo sciamano, Bompiani, Milano 1969.
soldati colpiti si scioglievano dalla loro pietrificazione. È stato
questo il primo impiego di massa della «tecnica di gruppo».
Un altro esempio. Nei manicomi spesso il problema più importante è posto dalla psiche logorata degli infermieri. Non si può
dire loro di passare una visita dallo psichiatra, ma si può invitarli
a discutere, tutti insieme, dei problemi del manicomio. E allora,
ignari, si incolonneranno, ben docili, a dire la loro sui mirabolanti «problemi generali» e lo psichiatra, che organizza i convegni,
riuscirà forse a modificare certe loro reazioni mediante la «tecnica
di gruppo». Dire: «Fatevi curare» desterebbe irritazione; ma «Venite, e discutiamo insieme» è assai lusinghiero. Ora il fine, in questo caso, può essere molto amabile: modificare il carattere, renderli più funzionali al loro lavoro; ma può anche essere un altro,
meno confessabile. La tecnica rimane: i fini mutano. In queste
tecniche di gruppo si palesa uno dei motivi per cui è venuta dissolvendosi la scienza dei fini. Se un gruppo si riunisce a discutere
di un argomento senza dichiarare preliminarmente il fine (non la
parola d'ordine) a cui si tende, e senza accertare i presupposti assiomatici della discussione, fatalmente vi si insinua un principio
opposto, cioè che la verità si possa raggiungere senza partire da
certi assiomi; che la verità nasca dalla discussione, e non dalla intuizione degli assiomi.
Nessuno si rende conto che gli è stata fatta violenza preliminarmente, obbligandolo ad accettare l'idea che dal dibattito, dal
confronto di esperienze, senza una ricerca e statuizione preliminare dei principi e delle procedure possa nascere la verità.
Naturalmente la tecnica di gruppo crea un ambiente «idealistico», utopistico, in quanto non si definisce mai il fine a cui tende
il gruppo. Lo si sostituisce con un animo collettivo; meglio ancora: con un'animosità collettiva. Gli infermieri, in quel tal manicomio, chiamati per la prima volta a discutere i problemi della
gestione dell'istituto, erano stati invitati da uno psichiatra. Ma
perché la tecnica riuscisse, bisognava che l'autorità ci fosse, e
ferma; occorreva tuttavia non si svelasse per tale, anzi doveva poggiare sulla critica dell'autorità.
Ci sono tanti piccoli accorgimenti per convincere che l'anima-
tore non è il padrone: egli può dire agli infermieri di riunirsi tutti
i giorni in una saletta per discutere dei problemi del manicomio,
ed anche intendersi con l'amministrazione a ché un bel giorno gli
venga sbattuta in faccia la porta della saletta, in modo che possa
rivolgersi agli infermieri esclamando: «Vedete con quali soprusi ci
viene impedito di riunirci a discutere». Egli avrà così fatto avallare
la convinzione di essere uno come loro, senza nessun mandato. E
a questo punto sarà cosa da nulla modificare le loro persuasioni,
ben più facile che con i consueti metodi dell'autorità, o dell'intimidazione o di una palese terapia. L'animatore sa che in qualsiasi
gruppo basta sradicare i partecipanti dalle inconsapevoli, non
meditate, ma non perciò necessariamente errate convinzioni assiomatiche ricevute dall'ambiente, e si riuscirà a farne ciò che si
vuole; diventeranno perfettamente manipolabili.
In un gruppo si forma un circuito psichico, un fenomeno simile a quello dell'induzione in elettricità, e l'animatore dovrà
semplicemente curare che questo circuito psichico sia sempre in
atto mediante una tecnica che nel gergo psichiatrico d'oggi si
chiama going around: egli sradica ognuno dei partecipanti dalla
sua natura sociale acquisita, facendo circolare, come una centrifuga, questa energia psichica.
L'animatore è potente, essendo l'unico che sa ciò che vuole, e sa
che le chiacchiere tali restano; sa che le varie opinioni che verranno formulate non avranno mai un valore perché partono dal
principio falso che la verità sia prodotta non occasionalmente ma
fondamentalmente dalla discussione di gruppo. All'inizio egli si
mostrerà preoccupato di aiutare i partecipanti, e sa che qualunque riunione, all'inizio, è dominata soprattutto dall'ansia che in
alcuni si esprime in impaccio, in altri col silenzio. Alcuni però,
egli li noterà subito, non si possono manipolare. Certi schizofrenici, o certi malinconici che ricattano minacciando il suicidio oppure, episodio rarissimo, un essere pienamente maturo, abituato
a porsi dei fini chiari in tutto ciò che fa.
Bisogna quindi eliminare, se del caso, queste rarissime eccezioni. Si tratterà poi di incoraggiare tutti gli altri a dire la loro intorno ai problemi che si susciteranno.
L'animatore è, in un certo senso, un uomo esemplare perché
del tutto privo di narcisismo; egli ha abolito completamente il suo
desiderio di primeggiare, e se mai l'ha trasferito nel gusto che si ha
nel vedere delle cavie che si comportano esattamente come si prevedeva. Egli dovrà indagare ciò che spinge ciascuno dei partecipanti o al silenzio o alla loquacità, a difendere questa o quella tesi,
e riuscirà a poco a poco a incanalarli come vuole, senza mai esercitare un potere, una diretta suggestione, perché basterà, quando
qualcuno emetta una tesi che potrebbe deviare verso l'unica cosa
proibita: la ricerca del fine preciso o degli assiomi logici, coalizzargli contro il gruppo intero.
I vari metodi per riuscirci fanno leva sul bisogno ben strano di
fare «bella figura». Strano, perché finché l'uomo viveva in una
piccola comunità, era abbastanza ragionevole ed economico che
desiderasse di «figurare» dinanzi al suo prossimo; ma in una società di massa in cui nessuno si conosce a fondo - essendo i rapporti fungibili, casuali e frammentati, questo desiderio diventa
arcaico. Ma forse proprio perciò è tanto violento.
Quando ci si ritrova insieme ad altri a caso, ecco il sogno dell'antica comunità che si dipana, tutti agiscono come se fossero di
nuovo nell'antico villaggio degli avi. Vi sono alcuni tipi di persone (una galleria teofrastica compone questi gruppi) e occorre,
per manipolare ciascuno, impratichirsi di un certo repertorio di
accorgimenti.
Compare spesso colui che vorrebbe, con quesiti continui, imbarazzare l'animatore. Tutte le volte che costui faccia una domanda, non gli si risponda direttamente, ma si inviti qualcun
altro del gruppo a rispondergli, badando a non risolvere mai personalmente un problema, ma a far emergere la risposta dal collettivo. A questo modo il querulo interrogante, che procura di mettere in imbarazzo l'animatore, non avrà più un bersaglio su cui dirigere i suoi moti aggressivi, e avrà paura di dirigerlo al gruppo intero. Il gruppo intero infatti fa paura: sta per la società intera, il
Dio dell'uomo moderno.
II litigioso invece è colui che ama «chiarire»; può anche avere dei
motivi sensati di valutazione e di critica. Bisogna che l'animatore
resti impassibile, e cerchi di farlo isolare dal gruppo. Gli proporrà
di trattare l'argomento in privato, oppure gli farà notare che manca
il tempo di approfondire: mai bisognerà impegnarsi con lui.
Il sofista, invece, ama discutere all'infinito. Bisogna sempre
dargli atto che c'è del buono nella sua obiezione; bisogna sempre
blandirlo, assicurandolo che la sua obiezione ha molti elementi
degni di attenzione per subito parlare di qualcosa d'altro; oppure
si dovrà lasciarlo parlare a lungo, sì che finisca in qualche tesi sofistica, la quale lo stacchi dal gruppo.
L'ostinato, viceversa, non vuole lasciarsi trascinare nel circuito
del gruppo, rifiuta di amalgamarsi. Bisognerà coalizzare il gruppo
contro di lui. Anche a lui si dirà che è opportuno studiare la questione separatamente, e lo si inviterà ad accettare, per un momento, l'opinione del gruppo intero. Se rifiuta, si troverà automaticamente isolato.
C'è l'uomo ben informato, che minaccia con le nozioni esatte
che possiede di intralciare la formazione della vaga anima collettiva di gruppo, ma basterà arrestarlo con questo semplicissimo argomento. «È un punto di vista molto interessante il suo - gli dice
- vediamo che cosa ne pensa il gruppo.» Ed ecco che la sua migliore informazione è derubata d'ogni autorità rispetto alle semplici opinioni di tutti gli altri. Non potrà rivendicare maggiore diritto per essere di fatto meglio informato, perché coalizzerebbe
contro di sé il collettivo.
C'è anche il muto; colui che si chiude nel silenzio, per disinteresse o per un eccesso d'ansia. Bisogna cercare qualche punto che
egli conosca, e indurlo a parlare. Ad esempio si potrà dirgli: «Noi
abbiamo bisogno della sua esperienza (cosa che tutti hanno), abbiamo quindi bisogno di lei». Difficilmente rinuncerà a mormorare qualche cosa; lo si loderà, ed eccolo inserito nel gruppo, grato
per giunta.
Con il ciarliero bisogna aspettare che egli prenda fiato, e fargli
qualche domanda che lo squilibri come: «Non le sembra che ci
siamo allontanati un po' troppo dall'argomento?». Invece il distratto lo si riporterà nel gruppo ponendogli delle domande, facendogli sentire l'imbarazzo della sua distrazione.
Infine c'è l'orgoglioso, il quale non si integra. Con costui conviene stare attenti a non urtarlo; bisogna, a ogni sua altera battuta,
dire: «Sì, indubbiamente, però...» e ricominciare a far circolare il
tema di discussione fra tutti i membri del gruppo. Questa, banale
ed efficace, la tecnica di gruppo.
L'animatore è l'unico, fra tutti, che sa ciò che vuole, ma non
formula questa sua volontà; se la formulasse, tutto il suo potere
crollerebbe. Egli dosa soprattutto l'uso della seconda persona plurale del verbo. Offre a tutti di integrarsi nel tessuto sociale; e naturalmente, quando qualcuno disubbidisce, non lo rimprovera;
gli toglie l'appartenenza al «noi». Quel tale si sentirà colpito da un
«tu non sei più noi, sei tu». Sarà ributtato nell'isolamento, nelle
tenebre esteriori, nella solitudine dell'io.
I partecipanti al gruppo, rivedendosi spesso, sentiranno di formare una società dove il senso di colpa viene attenuato, dove la
loro persona acquista un certo rilievo, dove c'è un certo conforto,
un certo tepore, grazie all'indistinto senso di appartenenza a un
gruppo in cui tutti si è uguali. Ed è un'uguaglianza, fra tutte, fraudolenta, perché di rado c'è stata una sudditanza così piena ad una
persona: l'animatore.4
Con questo gioco psicologico si diffondono le persuasioni che
si desiderano, dando a ciascuno l'illusione di essere lui ad esprimerle attraverso un «libero confronto sociale».
Ma in realtà lo si è sradicato da ciò che costituisce la sua vera
essenza sociale, dal suo passato atavico; lo si è persuaso, a poco a
poco, che non esiste una verità oggettiva, ma soltanto una verità
che si forma attraverso il concorso di più persone, legate in società; lo si è persuaso, senza dirlo, che non esiste un bene oggettivo definibile che si riporti all'idea della beatitudine, che non esistono princìpi fissi, che non esiste un ordine di natura subordinato a un ordine soprannaturale, ma che si possono prospettare
soltanto valori pragmatici e sociali.
4. Una spiegazione di ciò che avviene in questi gruppi che vada di là dei limiti intrinseci all'idioma comune d'oggi e alla sua varietà cne è il gergo della psicologia, potrebbe
darne una idea più adeguata. Se si osasse riprendere un preciso linguaggio arcaico, si
potrebbe parlare di creazione d'un golem impastato delle «ombre» dei raggruppati.
E a questo punto, colui che impersona i valori pragmatici,
colui che di fatto domina la società, ha acquistato un potere ancora maggiore di quello che il nudo potere gli conferirebbe. Egli
ha spinto le vittime di queste tecniche in un mondo di sogno ad
occhi aperti, di fantasticherie condivise, di chiacchiere (nel senso
che Kierkegaard dava al termine). E così in nome dei valori dell'efficacia, dell'azione, della mondanità, si riesce a piombare
l'uomo in un mondo fantasticato e si forma un tipo di schiavitù
basato sull'utopia della liberazione da tutte le coazioni, da tutte le
forme di vita «strutturata» e «istituzionalizzata». Contraddizione
in termini, poiché la vita è appunto organicità, forma.
«Rivista internazionale di Filosofìa politica e sociale e di diritto comparato», 1, 1970. Con lievi modifiche il saggio ricorre in E. Zolla, «Il linguaggio politico, l'assiomatica e la semplicità», Intervento alla cerimonia per il decennale della Fondazione Carlo Erba, Milano, 11 dicembre
1969. La prima versione dellafilastroccainfernale è in E. Zolla, Civiltà
della critica e civiltà del commento, «Conoscenza religiosa», La Nuova
Italia, Firenze, n. 4, 1969. Si veda anche il capitolo omonimo di Che
cos'è la tradizione (ristampa Adelphi 2003).
Litanie citatiane*
Nel Settecento dove mai in Europa non s'incontrano Italiani?
Dall'Inghilterra alla Curlandia stipettai, parrucchieri, maestri
di cappella, pittori, architetti, profumieri e alchimisti sono all'opera, gl'incantatori; né si valgono soltanto delle loro opere belle,
ma anche del loro non so che studiato si bene da Goethe nel suo
ritrattino di Cagliostro. Avevano, quegl'Italiani vaganti, un
modo di buttare indietro la testa, di accendere con un sospetto di
pianto gli occhi, di gesticolare con libertà inaudita, ma, soprattutto, modulavano la voce con tali trapassi, osando il tremolo tenorile come il baritonale rimbombo, da recare, dove che fossero,
un'atmosfera da opera, appunto, all'italiana.
Da fini delibatori di cabalette, da fanatici dell'impostazione
giusta di coloriture e di appoggiature, avevano l'arte di cogliere altresì i caratteri che ciascuno parlando e muovendosi, con leggiadra o stenta musicalità, svelava (specie quegli sprovveduti stranieri, ignari d'avere nel timbro un arto invisibile, alienabile quanto
il polso dello spadaccino, incapace di atteggiarsi, poveretti, con
l'incredibile, imbarazzante agio del melodramma).
Nietzsche doveva dire: «Non si confuta un suono». Gl'Italiani
vaganti del Settecento erano irrefutabili allorché vibrassero di
quel loro pathos multiforme.
Pietro Citati fa tornare in mente quella diaspora. Forse perché
ha dimorato a lungo accanto a Goethe, abate confessore, sarto,
maestro di danza, aiuto botanico.
Quando Citati deponga un libro, finisca d'osservare un autore,
prima d'ogni altra cosa procura d'imbroccare una melodia che li
* Sono qui collocati l'uno dopo l'altro due componimenti ironici sulla scrittura di
Pietro Citati. Al primo, Citati invita alti, che è del 1972, seguono le osservazioni
formulate da Zolla in Invito all'esodo, «La rivista di Estetica», anni II, maggio-agosto 1963, alla fine del paragrafo Una fòrza artistica, e alla nota 9 a proposito delsignifìcato di «caso», «alea» e «aleatorio».
Un tempo amici, i due scrittori smisero di frequentarsi più o meno al tempo in cui
Zolla e io ci sposammo. L'articolo di Citati in morte di EZ, Zolla: Così hz sua mente
senza struttura divorava il mondo («La Repubblica», 11 agosto 2002), trasuda sentimenti ed esprime giudizi sul volto umano, intellettuale e letterario di Zolla quanto
meno sorprendenti da parte di chi si era detto suo estimatore e amico.
dipinga, dei tanti sentimenti accumulati leggendo si serve per incitare in sé la vena melodica. Il recitativo, anche se sarebbe l'unica
«risposta», lo annoia. Perciò s'industria, ci mette del suo e, come
che sia, melodizza, sempre. La battuta è quella d'una comparsa da
niente? A forza di enfasi egli la converte in qualcosa in tutto simile
alle allocuzioni di un Serse o di Ciro il Grande. Alla lungaggine
del valletto che svogliato porga pantofole e vestaglia, è capace di
attribuire le complessità della clemenza di Tito.
Cosi in questo suo nuovo libro II tè del cappellaio matto (1972),
i sacerdoti egizi maestri di Mosé e Platone, protagonisti del primo
saggio, son cantati con frasi vezzose, con giusti e bene sonanti aggettivi, da istradare il più distratto sulla via dei sacri Archetipi; ma
può capitare, subito dopo, di riudire certi giri di quelle modulazioni, certuni di quei motivi, e stavolta, ahi! Sta parlando di qualcuno la cui memoria non varcherà, sia pure imbalsamata in questi nardi, il tempo necessario a leggere il saggio che gli è dedicato
(anche in un'epoca, come la nostra, così calamitosa da far spuntare gente che, pur di smorzare le sue tremende malinconie, fa
collezione di tappi, rocchetti, chiodi).
Al tè di Citati ci sono invitati d'ogni rango e risma. In parte va
bene così, se l'autore vuol essere un Poseidone, che sparge sulla
rena con le conchiglie eleganti i tristi barattoli. Ma talvolta l'eccitazione che dà il rimescolio di cose disparate diventa lo stupore dinanzi a cose che si spacciano l'una per l'altra.
Ma non si farebbe questo discorso (tutto a prò di faraoni e
sommi Micenei) se il libro non fosse opera rara e se la voglia di celebrarlo con bel canto non fosse spenta dalla difficoltà di stare al paragone delle sue arie sì ben bene intonate. E allora si fa come nei capannelli dopo l'opera, si va immaginando quale potrebbe essere la
recita ideale (fuor di metafora: un'opera tutta dedita agli Archetipi).
Questo discorso, inoltre, è forse un abbaglio di cui ha colpa il
tremendo Arlecchino che è il tempo, il quale nel libro appare appiattito e mette l'una accanto all'altra cose fiorite in distinte e lontane estati. È probabile infatti che Citati abbia incominciato a
fere le sue prove di canoro chat botté quale araldo di re del circo,
per scoprire solo in seguito i Filone d'Alessandria e i Paolo di
Tarso che ora di preferenza annuncia, e con amabili squilli. Se così
è, oh mirabile Provvidenza! O romanzo di formazione che si cela
nel seguito delle tazze da tè assaporate via via da Alice-Minerva,
oppure dal cappellaio (cui il mercurio usato per curare i feltri ha
dato una follia-sapienza da Ermete), oppure rovesciate in testa a
mostruosi, impolverati, minuscoli ghiri. Si sente che Citati, il devoto delle cavatine, il quale da sempre ha saputo che bisogna badare al tono più che alle ingannevoli, scivolose parole, ha incontrato Marius Schneider, il maestro delle metafore germinanti a
grappoli, degli accordi armoniosi. E sul canto gregoriano di Schneider, sui difficili canoni di Borges, Citati adesso misurerà i suoi
cantabili, congruamente rivolti alle eterne idee, invisibili ma configurabili dietro il velo dei suoni ordinati.*
***
Il primo apostolo dell'Alea in Italia fu Pietro Citati in un saggio
intitolato La poesia e il caso, ed egli elencò fra le poesie casuali le litanie, osando accostarle al bla bla dei surrealisti; la religiosità antica era meditata e sistematica ma ciò non può (deve) apparire
quando si sia capaci di estrarre meditazioni o sistemi, o almeno
coreografìe, dagli arrivi quotidiani sul mercato letterario. Ancora
una volta l'avanguardia trae avalli da accostamenti a ciò ch'essa
sconsacra (a proposito dei bisticci di Joyce si è invocato come precedente quello fra Petrus e petrà).
Citati ritiene che le litanie lauretane siano un abbandono ai valori puramente fonici, cioè una regressione allo stato infantile o
una caduta nel balbettìo schizofrenico, e pertanto le paragona alle
composizioni d'avanguardia. In realtà le litanie di Loreto erano
spunti di emblemi per la meditazione religiosa sulla verginità spirituale e, nel contempo, citazioni di passi biblici che, come illuminazioni fulminee, ricordavano i momenti dell'annuncio del
Nuovo nel Vecchio Testamento. Perciò Kyrie eleison rinvia ad
Abacucò, 3; Christe eleison a üf III, 2,20; Kyrie eleison all' Epistola
* Citati invitaaltì, «Settanta», 23 aprile 1972.
agli Ebrei 4,16; Christe audinosz Croniche II7, 14; e via dicendo.
La litania ha una struttura concettuale nascosta, disegna un'orazione speculativamente architettata, e proprio l'apparenza trasognata, ritmata fino all'impersonalità rende vieppiù pura l'intellezione del significato, per chi sia ad esso iniziato. I moderni giudicano del passato dell'Occidente con il disdegno e la compassione
del barbaro che non intende più il senso delle rovine auguste fra
le quali s'è accampato. E cosi vanno favoleggiando del gusto dei
primitivi e di altri inganni, ignari come sono della natura d'un
rito, in cui i singoli elementi sono rinvìi e non opere in se stesse. E
sono capaci di strappare ad una liturgia i suoi elementi per farsene
futile ornamento.*
* Invito all'esodo, cit., p. 200.
Spersonalizzazione e civiltà di massa
[...] Giova riprendere certe diagnosi della società moderna, del
tardo industrialismo per giungere a una spiegazione più acconcia.
La spersonalizzazione è il riflesso individuale della civiltà di
massa; è su una spersonalizzazione del pubblico che fa assegnamento l'industria culturale. Una società ferreamente competitiva
produce un'ansia invincibile, la lotta per l'esistenza produce da un
lato un desiderio di conformità sociale, all'ansia si reagisce come
l'opossum braccato, dandosi per morti, diventando mera efficienza meccanica e conformità ai gusti imposti dall'industria culturale. Tale pietrificazione dettata dall'ansia produce, insieme alla
schizofrenia indotta dalla specializzazione, una psicosi generale
che passa per il carattere della sanità. È da tale pseudosanità schizoide che può nascere un effetto collaterale assai noto della schizofrenia: alla stuporosa pietrificazione succede una smania di ricostruire il mondo già vuoto e tedioso, di animarlo di significati
portentosi ed occulti, e profetici. L'esperienza potrà riuscire inebriante o paurosa; per padroneggiarla lo schizofrenico fa appello
a un «verbiage» incoerente, per lo più a sfondo mistico e religioso.
In tal quadro si situano le regressioni occultistiche moderne, nascenti da un'esperienza della realtà come ripetizione tediosa nella
quale l'unica novità è la trovata sensazionale e già usurata al momento del consumo. Le attrazioni della fiera occultistica sono appunto fatte per adescare lo schizoide e il narcisista: l'incapacità
dell'uomo alienato di creare opere nelle quali riconoscersi e versarsi è trascesa nella speranza di sopravvivere, di eternare il proprio diritto all'omaggio meccanico. Ma un incentivo più serio
quand'anche vada poi a parare nel grottesco, va estratto dal nodo
di sentimenti che sta alla radice di tali adesioni: la specializzazione
mortifera viene apparentemente vinta grazie a vaste prospettive di
facile assimilazione che paiono inquadrare in un universo spiegabile la gratuità della posizione sociale. E a questo punto si può vedere come lo «spiritual revival», la regressione nell'occultismo scaturisca dalle stesse forze psicologiche che generano il fascismo.
Negli stessi Moniti all'Europa dai quali si trasse il quadro della
Monaco anteguerra, Mann metteva in luce la stretta connessione,
ed in Mario e il Mago, volendo tradurre sul piano di una vicenda
privata il dramma sociale del fascismo, Mann scelse un episodio
di frode misteriosofica banale. Si potrebbe giungere all'affermazione che il fascismo non fu se non la setta misteriosofica, la conventicola occultistica ridotta a forme accessibili al consumo di
massa, la sua collettivizzazione.
La giaculatoria, la fiaccolata eleusina, l'ipnosi sotto Io sguardo
del mago, il ritmo narcotizzante, le rivelazioni irrazionali e la parola sciolta dalla semantica, i simboli, la fiducia nei riti e nei travestimenti, nei totem e nell'estasi (di natura pirrica in apparenza,
erotica nella sostanza): tali i caratteri della vita collettiva fascista.
E se «una» spiegazione del fascismo è data dalle interessate mene
di gruppi industriali, l'altra, che deve spiegare come mai il fascismo potè diventare movimento di massa pur non avendo nulla da
offrire che non fosse contrario all'interesse delle masse, è data
dalla psicologia sociale. L'uomo nella folla solitaria è obbligato a
tendere tutte le sue forze nella lotta per l'esistenza, sempre meno
sorretto dalla famiglia in via di sfaldamento, e sembrerebbe che,
dovendosi ansiosamente reggere fra i sinistri del mercato, egli celebri il trionfo dell'individualità pura; ma per reggere allo sforzo
deve ridursi a mera funzionalità e conformità sociale, deve spegnere l'individualità; non solo tutti gli altri diventano per lui oggetti utilitari e merce, ma anch'egli deve trasformarsi per se stesso
in merce, in meccanismo utilitario. Come osservava Fenichel, sviluppando certi motivi delle ultime opere di Freud: «in società stabili l'individuo può sentirsi veramente parte di un tutto, credere
di ricevere in parte la promessa protezione. In società instabili invece la tendenza alla rivolta deve essere padroneggiata con un mutamento della sua stessa struttura mentale, facendo ricorso alla regressione narcisistica e orale [...]».
L'uomo-massa è l'uomo sbarcato dai secoli oscuri in un'isola
che egli domina appieno. Lo si è scambiato per un Calibano indurito nell'idiozia, incapace di seguire le sollecitazioni della bellezza o di godere della verità, incapace di spontaneità ancor più
del suo progenitore borghese. Ma l'uomo-massa non è un Cali-
bano; se lo fosse sarebbe lecita la speranza di modificarlo, di insegnargli, con paziente abnegazione, ad apprezzare i valori ai quali
preferisce i suoi lugubri trastulli: è un Prospero che impiega i suoi
poteri per abbrutirsi. Il borghese sotto la maschera sentimentale
era uno scettico smascheratore, un cinico senza pudori, era l'autentico selvaggio hobbesiano non appena riuscisse a liberarsi dall'incubo della polizia, non conosceva nulla di sacro capace di resistere al principio del profitto e, tuttavia, per rendersi efficiente ed
entrare nella lizza quotidiana, doveva infliggersi delle ferite, che
restavano su di lui come i segni di speranza della libertà. La rinuncia al sogno di un universo di solidarietà doveva essere conquistata al prezzo di sofferenze, il ricordo della madre gratuitamente affettuosa poteva sorgergli davanti come uno spettro ad
ogni passo della sua carriera. Il borghese aveva momenti di vita,
pur nelle torture della coscienza infelice, anche se egli chiamava
malattia il sorgere della vita. L'uomo-massa è di là di tali tormenti,
perché è convertito in mera efficienza, ha imparato a schivare i pericoli del sentimento. L'uomo-massa ha ripartito la sua vita in settori separati, il lavoro e il tempo libero, li ha affidati a potenze oggettive, che lo controllano togliendogli il peso della decisione e
della scelta (tutt'al più l'uomo-massa dovrà optare, votare per
questa o quella alternativa preformata dalle potenze industriali
alle quali si è consegnato come un cadavere). Per parte sua egli affronta tanto il lavoro come il tempo libero con lo stesso spirito:
sportivo, scherzoso e repressivo. Per giungere a tanto si esige la
mente di un Prospero, che sola può mantenere in codesto limbo
di convulsa frenesia e, nel contempo, di silenzio, di assenza.
«Civiltà delle Macchine», nn. 5-6, settembre-dicembre 1973.
Nuove terre cieli nuovi
Eppure se si spinge lo sguardo oltremare, si vedono
le terre ancora ricche di costume e di cerimoniale
restringersi come pelle di zigrino di anno in anno.
Sul globo intero, l'ala fredda dell'idiozia, l'ombra
dell'Occidente è protesa.
Aure: i luoghi i riti
Nota introduttiva
Gli scritti e gli articoli adunati in questa sezione tracciano un itinerario attraverso gli esodi di Zolla in quattro continenti. Temporalmente il periplo si snoda dal 1968, all'epoca del primo viaggio nelle riserve indiane del Sudovest degli Stati Uniti, all'anno
2000 quando visitò le isole Hawai'i scrivendone in una serie di articoli pubblicati sul Domenicale de «Il Sole 24 ore».
La spinta a evadere, a «entrare in una nuova pelle», a immedesimarsi nel «diverso» è una delle componenti perspicue della sete di
conoscenza ma anche dello spirito di ribellione al gretto etnocentrismo che lo scrittore non smise di denunciare da critico caratteristico dell'Occidente moderno. Studioso impeccabile del fenomeno storico dell'esotismo in Europa e in Nord America, EZ tuttavia, nelle sue note di viaggio, mostra di non calcare le orme degli
esotisti ottocenteschi e del primo Novecento. L'incontro con la
«diversità» indigena, sciamanica e delle tradizioni non-cristiane è
344
vissuto col rigore dell'antropologo e l'entusiasmo dell'errante in
cerca delle fonti di una spiritualità cosi spesso violata nei solchi
delle religioni ufficiali e degli esoterismi conclamati a Oriente e
Occidente.
Indiani d'America
Nell'estate del 1968 fui per la prima volta in Arizona e poi nel
Nuovo Messico. Racconto la visita a Taos ne I letterati e lo sciamano, ed evoco la scoperta emozionante delle poesie indiane in
un fascicoletto che trovai per caso, stampato ad Albuquerque. Vìsita memorabile, ne fui travolto e esaltato. Innanzitutto il paesaggio mi strappò al mio tono malinconico: uno spettacolo esaltante,
rivelativo, metamorfico, una statua della natura naturante con
ritmi e proporzioni sommi, perfetti, aurei.
Nel deserto m'inoltrai subito, sbarcando dall'aereo a Phoenix:
mi inebriò di odori e di tinte. Trovai un compagno di viaggio già
all'aeroporto: aveva un'automobile colorita e vastissima, con una
sua segretaria autista, mi depose dopo qualche ora in una stradina
di Prescott. Era il tipo di agglomerato al quale ci hanno abituato i
film del West, ci trovai un alberguccio che pareva del primo Ottocento, lo amministrava un pingue Sloveno dell'area triestina,
che mi parlò subito in un suo greve italiano. Potei telefonare di 11
all'amico che m'avrebbe ospitato nella sua villetta inerpicata
sopra Prescott, in una delle foreste collinari che circondavano
quel villaggio per pensionati. L'amico era legato al Dalai Lama e
in una piccola Università locale raccoglieva giovani tibetani già
guerriglieri Cham. Promise di venirmi a prendere l'indomani.
Esplorai intanto Prescott, incontrando i suoi abitanti; avanzavano lenti lenti lungo i marciapiedi, abbigliati da cowboy, scostandosi con i loro gran gesti eloquenti e spagnoleschi a cedere il
passo. Al centro, nel giardinetto, adagiati e trasognati, i pensionati. Da tutta l'America convengono a godersi questa quiete e
questo clima coi suoi profumi desertici e boscherecci insieme,
ravvivato sempre da tiepidi, carezzevoli venti. Una delle scoperte
più esilaranti che si fanno nel Sudovest è il paesaggio. Fu oggetto
di una scuola pittorica speciale, una delle massime nella storia
della pittura statunitense. Fu collezionata soltanto, oserei dire,
daiThyssen, si possono ammirare al Museo Thyssen-Bornemisza
di Madrid enormi vedute americane. A New York alcuni pittori,
specie inglesi, invitavano nei loro studi a guardare quei loro pae-
saggi
dall'interno, immensi, nell'800. L'abitudine era nata nel
'700 a Londra e a Parigi. Le scoperte geografiche inglesi si erano
godute negli studi dei pittori. Hawai'i s'era ammirata subito dopo
la spedizione di Cook, cosi.
Intanto la popolazione spagnola parla tuttora come nel Siglo de
Oro e indossa i costumi degli emigranti secenteschi, le fanciulle
nei ristoranti spagnoli di Santa Fe o Albuquerque piroettano facendo ruotare le loro tante gonne di tavolo in tavolo, porgendo
sontuosi, pimentati, fumanti piatti della Castiglia barocca.
Accanto agli Spagnoli ma scisse da loro le tante tribù di agricoltori indiani, maghi dalle movenze tozze e tarde gli uomini, seduttrici tranquille le donne; deliziosi poi i bambini appostati ad
adocchiare la persona giusta fra i visitatori solitari, per porgere in
silenzio il loro regalo, la pietruzza preziosa raccattata nel deserto,
un diaspro o un turchese favolosi.
Infine gli Anglos, e qui convengono i più raffinati tra loro. In
questo Sudovest dove sono affluiti a tramutarsi tanti personaggi
d'ogni sangue; tra loro rammentiamo Nikolaij Konstantinovic
Roerich, il sommo pittore e antropologo russo che nel breve periodo degli anni Trenta venne a New York e sedusse Roosevelt.
Raccolse pitture. Venne a incettare quadri di Taosiani da esporre
a New York, accanto a Senesi o Fiorentini del '400 e a icone russe
medievali: sono figurazioni equivalenti. D. H. Lawrence scrisse
le sue pagine più rapinose nel 1921 sulle tribù cultrici di serpenti, Warburg qui studiò anche lui il trattamento mercé i serpenti e guarì dalle ossessioni che l'avevano sempre afflitto, preparandosi così a portare a compimento la sua stupenda, innovativa rivista di arte.
Qui infine scoprii la letteratura degli Indiani d'America come
spazio eccelso e separato nel corso della letteratura angloamericana. Infatti a Taos ebbi la fortuna eccezionale d'imbattermi in
due indigeni venditori d'artigianato locale. Mi si confidarono, si
offrirono di portarmi nel deserto in automobile. Avevano subito,
mi raccontarono, oltraggi tremendi; da ragazzi gli Anglos li avevano trattati come bestie sgradevoli, a pugni e calci. Ebbi difficoltà a crederlo, tale la finezza del loro conversare e la squisita gra-
zia dei loro rarissimi gesti ed eccelso l'incanto delle delicate vicende di vita che mi esponevano.
Avevano letto quasi tutti gli autori indiani, furono loro a segnalarmi i pochi che avevano capito a fondo la loro profonda e
complessa religione, che si rivela nei particolari in un D'Arcy McNickle. Mi ostentarono un mistero mai pienamente rivelato: che
cosa si rechino a vedere lassù nelle montagne i Taosiani una volta
all'anno, nel celebre pellegrinaggio al lago azzurro. Lenti calano
in cerchio dall'altissimo orlo della conca a dove il lago si stende e
i pesci li avvertono, in quell'istante componendo segni d'accoglienza e d'augurio sono l'acqua.
Cari Gustav Jung fu qui che venne a contatto con la filosofia
indigena semplicemente osservando i Taosiani seduti sui loro
tetti, ravvolti in una coperta, a contemplare il sole.
Qui vennero a imparare l'architetto Frank L. Wright e la pittrice Georgia O'Keeffe.*
***
Alonzo Lopez è un giovinetto della tribù Papago dell'Arizona.
Scrive una delicata cosmogonia con domestiche immagini:
«Vedo una stella / Benché sia giorno. / Le mani di mia madre / La
fanno crescere. / È una stella nera / Contro un cielo candido. / Oh
com'è gentile la stella. / Ora che ella intesse / Unghie di demonio
/ Per fare un canestro».
E compendia gli antichi insegnamenti nella sua seconda lingua:
«Fui diretto dal nonno / A Oriente / Affinché avessi il potere dell'orso; / A mezzogiorno / Affinché avessi il coraggio dell'aquila; /
All'Occidente / Affinché avessi la saggezza del gufo; / A Settentrione / Affinché avessi l'astuzia della volpe; A Terra / Affinché ne
cogliessi il frutto; / Al Cielo / Affinché vivessi una vita innocente».
Anche il Nez Percé Phil George mette in versi inglesi gl'insegnamenti atavici sulla simbologia sacra della capanna dove si
* Gli Indiani d'America e l'Italia, a cura di F. Giordano e A. Guaraldo, 2 voli., Edizioni dell'Orso, Alessandria 2002.
fanno i bagni di vapore: «Questo capanno è ora / Il grembo di nostra madre, la Terra, / Questa tenebra in cui sediamo, / L'ignoranza delle nostre menti impure. / Queste pietre ardenti sono / La
venuta di una vita nuova. / Queste parole accolgo nel cuore. /
Confessandomi rammento i miei atti malvagi. / Per ognuno
spargo acqua su pietre cocenti. / Il vapore sibilante è segno che / Il
luogo donde germogliano i semi della Terra / Ancora vive. / Egli
suda, / Anch'io sudo. / Ricordo, il Vecchio sana i malati. / Porta ai
meritevoli la buona ventura. / Il sacro vapore esala; / I miei pori
cedono le scorie. / Dopo canto inni a Dio /Apro la porta a Oriente
/ E ne sorge la saggezza. / Purificato mi tuffo nelle acque gelide. /
Puro lavo via tutto ciò che appartiene a ieri. / O figlio, cammina
in questa nuova vita. / Essa ti è largita. / Pensa giusto, senti giusto.
/ Sii felice! / Ti ringrazio o Vecchio, o Capanno».
Anche la Choktaw Marie Jacob, con una grazia di poetessa giapponese ricrea gl'incanti della vita tribale: «Silenziosa, premonitrice
luce di luna / Che entri fra gli alberi. / Una brezza leggera si leva. /
M'affretto ad un capanno dalle linee incerte. / La pallida luce lunare
si cela fra manti di fosco velluto / La fanghiglia mi sciaguatta sotto i
piedi. / Umidi, attaccaticci odori di bosco si levano. / Odo e ascolto
sgomenta. / Sussurri come raschi sorgono dalla mia infanzia. / Ricorda, o piccola, che bene e male dimorano nel vento. / Attenta alle
forme tenebrose. In guardia! potenze d'ombra / Spiriti astuti in veste
d'uccelli / Erompono in vita toccati dalla luna. / Ricorda: il male ti
circonda. / Spiriti lanciano incanti per recarti male / Dicendoti:
"vieni"; poi la cerchia si allarga per risucchiare, per / Raccogliere
tutto il male, assorbendoti dentro. / Perché non badai alle parole del
sapiente / E non rimasi in piena luce nel bene? / Il bene? / Chi vincerà?... Nulla. / Soltanto il vento sibilante rispose buttandosi / Nel
mio mantello e arruffandomi i capelli. / All'improvviso la voce di
mio padre risuonò fra i tonfi del polso: / "Non temere, piccola, poiché nella quiete un giorno / Osai sfidare la forma del male, sciogliendolo dai pensieri / Che la strana luna gli aveva gettato addosso.
/ La forma divenne reale e si mostrò amica. / Rammenta: quando il
Male è padrone siamo vive forme / Cadute nel fondo buio di stagni
silenziosi, / E facciamo mulinelli e scorriamo dove Egli vuole"».
Abbiamo qui le primizie di coloro che dovrebbero domani formare una nuova straordinaria letteratura indiana in lingua inglese,
e se la poesia è sempre presaga del futuro, già possiamo trovare nei
loro versi la garanzia d'un vigoreggiare nuovo dell'antica tradizione. Chi avrebbe potuto immaginare che tra queste pagine di
così misero aspetto, in un umile florilegio scolastico, si dovesse incontrare tali promesse? E chi potrebbe immaginare dietro agli
occhi di qualche giovinetta indigena un'esperienza mistica come
questa di cui parla Julie Wilson, una Chippewa: «Viaggiai verso
Occidente / Cavalcando un solitario grido di coyote. / Vidi ombre
di more selvatiche trasformarsi nella morte davanti a me. / Inciampai e caddi in combutta con le anime giacenti / In questo
fosso di marciume. / Tutto quel che toccai si volse in polvere. / Accettai la tenebra e mi domandai quanto sarebbe durato un milione
di anni. / Nelle lontananze di questa tenebra spiai una minuta
forma bianca. / La cibai e nutrii del mio corpo dandole tutta me
stessa. / Portandomi a Oriente fui grata, finché scopersi che non
riuscivo / A staccarmene perché ero io che andavo con me stessa».*
***
A uscire da una delle autostrade che tagliano il Nuovo Messico, a
seguire una delle carrarecce fra le distese deserte e i rari coltivi, avviene di ritrovarsi in uno dei villaggi Tewa sopravvissuti; le case di
fango e paglia tozze ed eleganti, con le travi del soffitto sporgenti,
si raccolgono attorno alla piazza e di questa stagione si ode, entrando nel dedalo di strade, un coro ora gutturale ora ruggente.
Le donne s'affrettano, uscendo dalle porte di casa con i bambini,
verso la piazza, recando piatti di cibi variopinti; hanno lo sguardo
celato, i manti ondeggiano, verdi e scarlatti, al loro passo veloce.
La piazza si svela all'improvviso, vasta, assolata; il canto cupo e
imperioso dei danzatori allineati al centro risuona come una successione di colpi battuti contro la terra arida. La bruna cerchia
delle case è interrotta dai colori violenti dei crocchi di donne che
* Tribù divenuteforza politica, «Corriere della Sera», 16 ottobre 1968.
assistono immobili, ritte sui terrazzi coi manti agitati dal vento
caldo e carico di aromi.
I danzatori stanno in fila, la pelle lustra scintillante al sole, avvolti di fronde verdi chiarissime, battendo il tempo con le caviglie
risuonanti di bubboli, agitando le piume, simbolo delle preghiere ascendenti al cielo. La danza non conosce enfasi e vasti
movimenti, anzi è tutta affidata a gesti minimi, come quella dei
Noh giapponesi, e l'impressione è d'una forza trattenuta, immensa, la stessa che dà il duro canto. Una forza sul punto di traboccare e una discrezione sottile che impongono un'inflessibile
attenzione, grazie alla quale lentamente si penetra di là dell'apparente monotonia.
La scena resta immutevole per un'intera mattina, sotto il sole.
Poi i danzatori in fila s'incamminano verso una delle case dove le
donne hanno allestito il pasto sacrale.
Di alcune di queste danze e dei loro canti si conoscono lunghi
commentari che sciolgono il mistero delle iterazioni dall'apparenza o troppo semplice o troppo enigmatica, di molti fra i simboli celati nell'abbigliamento si conoscono almeno alcuni significati. Ma l'ipnosi del sole, la scansione di petto delle voci, la tersa
luce di deserto e d'altopiano, i profumi d'incenso delle piante esalanti nella calura, i sapori dei cibi; tutto ciò forma il corpo vivente
che riveste ''invisibile verità di cui parlano i canti. Una verità più
antica ma non discorde da quella che proclamano le chiese spagnole dei villaggi di fango e paglia, intonacate di un bianco acceso, con le travi sporgenti, di forme assai simili a certo romanico
sardo, spesso adorne di gioiosi affreschi popolari.
I Tewa non hanno mai accettato di separare con violenza le loro
verità antiche e quelle portate loro dai francescani nel secolo XVI,
anzi hanno saputo certamente arricchire la loro nuova fede. Dove
si potrebbe altrove trovare qualcosa di simile alla sublime chiesetta di Chimayo? È un santuario di fango, con pale d'altare d'una
grazia rustica e patetica, dove i santi cristiani hanno tratti da maschere di spiriti indigeni; dietro l'altare è celata una stanzetta dominata da una figura di Bambino, dove la nuda terra del pavimento ha proprietà miracolose. Chi l'ha mangiata o, fattane della
mota, se ne è cosparso, ha talvolta potuto abbandonare in sacristía gli arti ortopedici, le grucce con cui vi si era trascinato. Le rastrelliere recano queste testimonianze di guarigione, un album
raccoglie frasi devote dei visitatori; nelle ultime pagine mani femminili hanno tracciato nel nobile spagnolo rinascimentale che ancora qui si parla o in inglese suppliche per i giovani dei villaggi
oggi in pericolo nel Vietnam.
Cosi l'alchimia di devozioni ha riprodotto in questo santuario
rustico la pratica rammentata dagli antichi trattati medici e da Paracelso, di mangiare certa terra di certi luoghi privilegiati (la si
chiamava in Europa terra sigillata) [...] .*
***
L'atto preliminare del rito Hako è un canto invitante alla contemplazione, alla rescissione del visibile e quotidiano; esso propizia uno spirito reverente verso le «potenze minori» o manifestazioni di Dio, o potestà angeliche rettrici che si voglia dire.
Le immagini visibili non formano più, se questo atto è compiuto adeguatamente, un seguito senza scopo, bensì diventano
maschere, emblemi di archetipi divini: i venti si trasformano in
forme sensibili di quella forza archetipica spirante nell'aria, animante il petto e la mente; il sole è la visibile forma d'ogni vigore;
la terra infine è la materializzazione della forza materna e nutrice.
Le strofe d'avvio dello Hako formano un Genesi. Come in
tutte le cosmogonie, ci si cala, dall'inimmaginabile, inconcepibile, irrapresentabile, giù fino ai celesti luminari e alle erbe della
terra, dall'Origine all'originario, e si loda nei beni presenti la loro
origine assoluta.
Questo Genesi e questo Cantico delle creature pawnee sono seguiti (dall'ottava strofa in poi) da un inno di fondazione, di delimitazione d'uno spazio sacro o centro templare del mondo {contemplare significava questo alle origini di Roma). Come non pensare allo spirito che edificò i templi indù: si è accolti da un sacro
* L'ultima America degli Indiani, «Corriere della Sera», 3 ottobre 1968.
elefante, quasi simbolo dell'Altissimo, ci si trova tra simboli delle
potenze rettrici, e infine si penetra nel buio del luogo più intimo,
nella stanza segreta dove il brahmano accenderà il fuoco, farà che
si sprigioni la figura di Agni, il dio animatore e bruciante.
La seconda parte del rituale può ora incominciare; ci si è portati del tutto fuori del mondo delle cause seconde, di là dalle apparenze, di là dalle immagini senza scopo e fini a se stesse, fuori
della miserabile vita profana. Qui tutto ha senso, tendendo allo
scopo ultimo: la conoscenza e la quiete divine.
Ora si può incominciare a consacrare gli oggetti sacri, a trasformare i bastoni dipinti, una spiga di grano in talismani.
Oggetto sacro è quello dove non c'è tratto, materia che non sia significante: la sua visibilità o odorabilità sono trasparenti, rivelative.
È un segno che è anche il proprio significato, un segno smaterializzato.
I canti intonati durante l'allestimento dei bastoni piumati e della
spiga hanno il compito di farli apparire come pure visioni, geroglifici delle verità invisibili: folgorazioni sintetiche di ciò che nei canti
è una poetica, ma ancora discorsiva, esplicativa meditazione.
Una volta così trasformati, come non affermare che gli oggetti
diventano di diversa sostanza pur mantenendo l'accidentale apparenza di legno, di piume, d'ariste vibranti su uno stelo? Tanto
più che ormai hanno tralasciato del tutto la funzione del legno,
delle piume, della spiga per un'altra, di incarnare ciò che è all'origine di tali oggetti, di ciò che li creò e li crea.
Magia?
Ma che cosa avviene fra l'uomo e l'uomo e che non sia un meccanico contatto, che non sia magia? Se è magia l'opera d'uno
sguardo capace di trasformare una pelle che insacca fetide budella
e vischiosi umori in una figura radiosa di donna amata; se è magia
l'eifetto che sprigiona dal suono di certe misere, astratte parole o
dallo sventolìo d'un comune drappo, onde l'uomo si precipita,
per motivi umani, profani, a combattere e a procombere; se tutto
ciò è a dirsi magia, si dovrebbe chiamare l'opera prescritta dallo
Hako in questa sua parte consacratoria, che pure è analoga alle
azioni magiche, con un nome più alto: sacramento.
Infatti non avviene solo fra uomini e per uomini, ma getta un
ponte fra l'uomo e la fonte dei suoi istanti di quiete divina.
Autosuggestione?
Se per uno smarrimento compassionevole dei termini più
esatti (come sarebbero: metamorfosi, rigenerazione), si smania di
chiamare cosi lo Hako, si sia almeno razionali, e si chiami cosi
anche quel moto che fa chinare la madre con soavità sul figlio appena procreato o che infonde nell'animo di chi sia assalito da una
malattia una volontà di risanare, un piglio che dall'animo si trasmette ai ritmi del respiro e del polso.
Ma scordiamo queste suggestionanti parole, questi latrati del
Cerbero che fa la guardia ai misteri. E seguiamo piuttosto con intelletto d'amore la preparazione della spiga che il canto appassionato farà salire a Dio per ridiscendere quindi come Madre Grano,
guida del rituale Hako, Proserpina spicam tenens uguale e vergine
nella tenda sciamanica eretta nella pianura d'America come sulle
coste del Mediterraneo.
«Ognuno dei presenti deve concentrarsi su di lei.»
È dall'approfondimento estatico di questa concentrazione che
si parte per il Secondo Rituale, il quale dura tutta una notte di veglia. Esso ha lo scopo di individuare in una tribù lontana l'uomo
col quale stabilire un vincolo di amicizia soprannaturale, il figlio
di Madre Grano.
Perché lo Hako è un rito per stringere un'alta amicizia.
Si segue con la mente, cantando, il viaggio di Madre Grano, la
Spiga, verso il villaggio dove quell'uomo dimora, ci si inoltra tra
le capanne a cercare la sua. I pensieri sono fissi, fermi, insistenti su
di lui, l'uomo lontano e assopito, ignaro d'essere cosi ricercato,
circuito, eletto. Egli vedrà in sogno ciò che gli si sta facendo.
Il giorno dopo (Terzo Rituale) messaggeri in carne e ossa partono, percorrono sulla dura terra i sentieri dianzi seguiti con la
forza dell 'immaginano vera (così la chiamavano gli alchimisti
d'Europa e i sufi della scuola iranica).
Giungono; il Figlio di Madre Grano (così sarà chiamato da ora
in poi l'uomo trascelto), sa chi sono questi stranieri, rammenta il
sogno e ora se lo spiega.
E adesso si schiuda allo stupore l'uomo bianco. Questo rituale
è stato più e più volte compiuto e ha stabilito più e più arcane
amicizie. Menti concordi e disciplinate hanno toccato una lontana, predestinata psiche sognante. I libri della letteratura indigena o bianca d'argomento indigeno ne parlano come d'un fatto
consueto.
Ma chi è così sventurato da non aver mai provato la felicità del
primo incontro d'un sodalizio mirabile? E a chi l'ha provata non
è parso forse d'aver conosciuto da sempre l'amico, quasi con lui
immemorabilmente abbia scambiato uguali parole e silenzi? E
non ha sentito come se tutto convergesse a quell'esito, ogni episodio, ogni minima decisione fossero disposti a quel fine che ne
appare anche la causa?
Ora, forse chi ha avuto questo dono, forse intende che un popolo
dedichi tutto il suo ingegno ad afferrare le forze che cosi ci animano
e giunga a definire mezzi, rituali, canali di tali grazie. Infine, una notazione musicale non è forse un mezzo, un canale per riavere, quasi
a volontà, la gioia misteriosa e irripetibile d'una melodia?
Segue il rituale di consacrazione della sacra amicizia: il figlio è
raggiunto da tutta la sacra compagnia in un pellegrinaggio che lo
porta nei luoghi dei suoi sogni. Qui giunta, celebra l'aggregazione
e nel corso di questa, durante una veglia, visioni soprannaturali
sono suscitate in ognuno.
Si è al culmine del rito, i partecipanti sono trasformati a segno che
imparano ormai direttamente, per contatto col mondo spirituale.
Al Dodicesimo Rituale essi apprendono che «i riti sono rilevati
dalle visioni»: giungono là dove i riti sono concepiti, all'origine
dei racconti sull'origine, al Genesi del Genesi.
E ora consacrano, nell'ultima, graziosa e sublime parte del rito,
un fanciullo o una fanciulla, di solito il figlioletto del figlio prescelto, trasformandolo cosi come furono all'inizio trasformati i
bastoni piumati e la spiga, in vivo simbolo [...] .*
* Introduzione a Alice C. Fletcher, Il rito Hako, trad. it., La Nuova Italia, Firenze
1970.
***
All'apertura de L'Isola del Tonai, siamo nel 1971, Carlos Castañeda è in viaggio verso l'altopiano messicano per ritrovare ancora
una volta il suo maestro sciamano don Juan (ma chi voglia approfittare al massimo delle sue avventure sarà bene che abbia letto
prima i precedenti volumi, che in Italia furono via via editi da
Ubaldini).
Castañeda attraversa, sul percorso, Sonora, dove don Juan ha
una casa; un istinto gli suggerisce di fermarsi, ed ecco, don Juan
gli compare dinanzi. Avrebbe dovuto trovarsi dall'altra parte del
Messico, donde una prima serie di lezioni-scherzi. Proviamo a
dire che questo è il doppio di don Juan? O proviamo a dire che il
potere sciamanico in boccio di Castañeda l'ha evocato? Basta
escludere l'idea del caso, per lo sciamano tutto è segno e coincidenza, tutto gli è tramato sotto gli occhi dal suo stesso potere che
lo custodisce e governa. Non dovremmo stupirci troppo di quesd
primi addottrinamenti sciamanici. Così pensava e così agiva
Enea. Così i pietisti tedeschi del '700, e il Wilhelm Meister di
Goethe, sulla loro traccia, si affidava anche lui alle coincidenze
come a ordini del destino. Cari Gustav Jung le teorizzava, chiamandole «sincronie» e diceva che si infittiscono quando un uomo
si aggira intorno a un archetipo.
Lo sciamano, insegna don Juan, non accetta nemmeno che si
dica che egli sta cercando conoscenze sciamaniche, sono queste
che cercano lui. Sembrerebbe un uomo che stia recidendo la sua
volontà. In parte così è, egli rinuncia a dirigersi, si fa guidare dal
destino. Ma d'altro lato egli sviluppa una volontà che l'uomo comune non saprebbe immaginarsi. Controlla perfino i propri
sogni (don Juan insegna un trucco per farlo; ci si sforzi di vedere
le proprie mani durante il sogno) e si domina interamente,
stringe le redini della sua fantasia e del suo intero discorrere con
se stesso, dandosi ordini lievi e astuti, insistenti ma senza violenza.
Donjuán ricomincia, come già ha fatto nei precedenti volumi,
a scalzare, nel suo alunno, la fede nella realtà; lo allucina, gli scombina le certezze: «Il mondo non si offre a noi direttamente; di
mezzo c'è la descrizione del mondo. Propriamente, quindi, noi
siamo sempre a un passo di distanza e la nostra esperienza del
mondo è sempre un ricordo dell'esperienza. Noi siamo perennemente in atto di ricordare l'istante appena accaduto». Bisogna
impadronirsi di quel cardine: la descrizione che diamo della
realtà. Piegarla alla nostra volontà, invece di lasciarcela imporre
così come ce la presenta la ragione. Perciò don Juan abitua il suo
allievo alle ore crepuscolari, nelle quali le forme si dissolvono e un
cespuglio pare muoversi, pare uscirne una farfalla notturna. Ed
ecco, in mezzo a questo esercizio, compare l'amico di don Juan, il
secondo istruttore di Castaneda, don Genaro. Emerge come dal
nulla. È il doppio del vero don Genaro? Era lui ad agitare le
fronde, d'accordo con don Juan, per ingannare Carlos?
Sono tutti pensieri inutili allo scopo. La volontà di Castaneda
impari piuttosto a descrivere ciò che ha visto come il risultato di
una sua evocazione di don Genaro. Don Juan confida che se non
si è capaci di troncare il flusso di immagini e di pensieri dentro di
noi, se si smette di parlare con noi stessi, si acquistano certi poteri,
come questo di imporre un'immagine e di fare che essa si presenti
esteriormente a noi; se un uomo è in grado di non parlare con se
stesso «e anche solo per un istante, di afferrare l'immagine o il
pensiero di cui vuole sognare, l'argomento desiderato verrà a lui».
Ma questa fluidificazione del reale non va senza sofferenze e nausee nell'alunno.
Nella seconda parte dell'opera Castaneda incontra (di nuovo
«per caso») don Juan, stavolta in un completo marrone spinato,
sul Paseo de la Reforma a Città del Messico. Incomincia la lezione:
per l'uomo comune gli eventi sono benedizioni o maledizioni,
per lo sciamano ogni cosa è una sfida, egli sempre sta all'erta per
cogliere segni, coincidenze. Queste sono la prova che egli si sta
sviluppando al modo giusto. Così egli deve credere. Quale segno
si presenta?
I due vedono un uomo moribondo in mezzo alla strada. Don
Juan insegna a vederlo con la volontà, secondo l'interesse dello
sviluppo sciamanico. Quella morte è un segno: bisogna vederla
come un atto deliberato del morente, che ha scelto di morire così
sotto i loro occhi al modo stesso che una poesia di César Vallejo
dice: «Morirò a Parigi un giorno di pioggia / in un giorno che già
ricordo. / Morirò a Parigi - non fuggirò».
La gente che si riunisce intorno al morente in quegli ultimi
istanti, vista in questa luce, è come un gruppo di cortigiani convocati per assistere maestosamente all'evento.
Spiega don Juan che il moribondo è un'occasione d'oro: «dopo
che ci siamo seduti qui in attesa di un segno, ci siamo accorti di
quell'uomo: ciascuno di noi due lo ha percepito a modo suo, voi
con la vostra ragione, io con la mia volontà». Come a dire: chi dei
due ci ha guadagnato di più? E se si vuole lucrare un beneficio ancora più alto, ci si dica che è stato il proprio potere sciamanico a
convocare tutto in quel luogo e in quell'istante. Si impari a trapassare dalla spiegazione della ragione a quella della volontà, agevolmente, come agili, accorti anfibi, capaci di muoversi in entrambi gli elementi.
Per imprimere queste nozioni nella mente di Carlos, don Juan
gli traccia un grafico dell'uomo: nella testa è la ragione, il «parlarsi», alla punta dello sterno è il sentire, sotto l'ombelico sta la volontà, mentre il sognare sta fra le costole a destra e il vedere sciamanico sul fianco sinistro.
Durante una successiva passeggiata per la città, all'Alameda,
don Juan introduce due nuovi termini nel suo discorso: tonale
nagual.
Come spesso capita, Io sciamano li interpreta ben diversamente da come imporrebbero i testi di etnografia. Il tonai è lo spirito custode in forma animale, dicono i testi. Può anche apparire
come un animale, corregge don Juan, in realtà - ecco il mio tonai
- egli esclama, mostrando la propria persona. Tutto ciò che facciamo e sappiamo è opera del tonai, esso sta di guardia a tutto ciò
che siamo stati e abbiamo fatto, giudica, descrive le cose.
Si passa ad un esercizio: don Juan insegna a guardare i passanti,
se hanno un tonai ben costituito oppure acciaccato, miserando.
Per valutarlo bisogna cessare di giudicarli, di giustificarli o condannarli, bisogna vedere sciamanicamente, intuire direttamente
lo stato del tonai
Ma nella presenza del tonalà sono lacune, esso è talvolta come
sospeso; sono questi i momenti in cui si può manifestare quell'altra possibilità dell'essere che è il nagual, che si comunica con una
vertigine (quella stessa che si dice dia il tocco di certi santi, come
Ramakrishna). È il nagual che combina le coincidenze, che dispone i segni.
Si passa ad un altro esercizio. Vediamo se il nagualó. fa incontrare un io/Wperfetto - incita don Juan, e spiega: una persona armoniosa, nella quale il comportamento sia intonato all'interna
polpa dell'essere, ai pensieri, ai sentimenti. Subito passa una giovane incantevole. Abbiamo avuto il segno - esclama don Juan,
perciò — via verso il naguall
Andare verso il «¿zgiWsignifìca restringere il tonai. Attenzione,
perché il momento in cui si manifesta pienamente il nagual è
quello della morte, quando il tonalsi estingue. D'altronde è sempre il nagual in noi che crea, quando siamo creativi. Le parole
però non servono, occorre l'esperienza. Don Juan dà un'improvvisa botta a Carlos, che rotea dentro un'agenzia di viaggio e si ritrova in un'altra strada. S'accorge che quest'altra strada è lontana
dal punto dove ricevette la botta. L'indomani s'accorgerà che non
è possibile nemmeno rintracciarla. Quando implora da don Juan
spiegazioni sulla botta e lo smarrimento in cui è stato lanciato, riceve l'istruzione capitale: non serve richiedere spiegazioni, in
questi frangenti occorre agire, essere pronti a morire, rinunciare
alle spiegazioni del tonai, stringere, vanificare, rendere fluido il
tonai. Bisogna imparare a lasciar emergere liberamente il nagual
Don Juan ha dato lo spintone perché era un momento propizio a
stringere il tonai.
Così si chiude la seconda parte dell'opera [...].*
* L'Isola del Tonai, «Corriere della Sera», 7 settembre 1975. L'opera di Castañeda
usciva in traduzione italiana presso Rizzoli nel 1975.
In Iran tra i sufi
Finalmente, dopo che m'ero aggirato a lungo per la polverosa periferia di Isfahan, una fanciulla armena mi seppe dire dove abitava
il sacerdote zoroastriano. Bussai, un uomo atticciato, dagli occhi
neri e veementi mi accolse con grazia, quasi neanche ascoltando
le parole di presentazione, come mi avesse aspettato, e fui nella
stanza dominata dall'immagine di Zoroastro, adorna di rose, ed
ero appena seduto che la moglie del sacerdote mi porgeva la prima
tazza di tè.
«Siamo pochi qui a Isfahan» mi disse l'ospite «non abbiamo un
tempio, ma eseguiamo riti millenari per le nascite, i matrimoni, le
morti, alle feste di due in due mesi, seguendo il corso del sole. Il sacerdozio è ereditario, io sono l'unico a officiare per questa piccola
comunità.» Ma volevo scoprire qualcosa che non fosse l'elenco
degli usi, dei costumi e dei dogmi. Un lama tibetano mi disse un
giorno che si può entrare nell'intimo di una religione con una domanda che ne spalanca i recessi: «Che cosa fate dei vostri sogni?».
La posi e anche stavolta il minuscolo grimaldello apri lo scrigno. La voce dei due coniugi divenne più morbida e confidenziale: «Fra noi non ci sono molti malati mentali, abbiamo un rito
speciale. Quattro o più sacerdoti cantano gl'inni sacri sul malato
mentre dorme. La mattina egli si sveglia e un sogno l'ha guarito».
La moglie mi porta un infuso di efedra, quello che si dà al malato
al risveglio e che si beve durante le cerimonie. L'efedra, colta in
alta montagna, è tritata e insieme a una specie di buglossa dà le
due bevande sacre. L'effetto è quello, a un dipresso, che si ottiene
da noi con l'efedrina e la coramina. Sono giunto dunque alla radice, forse, dei vari riti di incubazione: di guarigione mediante un
sonno consacrato. Da questo, zoroastriano, è probabile che derivi
l'uso di una confraternita sufi dell'Afghanistan, di cui non ho incontrato traccia in Iran: i malati, per lo più delle tribù nomadi, si
raccolgono in certi templi segreti, si addormentano in una sala e
gli officianti della confraternita passano la notte recitando incantesimi su di loro. Le scarse notizie che se ne hanno furono divulgate qualche anno fa sull'«American Journal of Hypnosis». Pro-
babile che dall'Iran venisse la consuetudine del sonno nei templi
di Esculapio - ancora oggi si scorgono le tracce del rito aggirandosi tra le rovine di Epidauro o, in Attica, fra i resti del santuario
di Anfiarao: il sacro fonte per le abluzioni, il teatro per le sacre
rappresentazioni, la sala per i sonni incubatori di sogni risanatori.
Qualche giorno dopo sono inginocchiato nella sala posteriore
del tempio del fuoco di Teheran a osservare gli strumenti della liturgia d'incubazione, due treppiedi terminanti a mezzelune, sulle
quali sono adagiati dei fili di rame o di argento, un mortaio e un
pestello, alcuni recipienti. Il capo dei sacerdoti mi spiega il rito.
«Nei tempi della pienezza del culto avevamo cinque generi di
medici: coloro che insegnavano a purificare gli elementi, coloro
che accertavano la morte prima di affidare il cadavere al fuoco o
agli avvoltoi o di adagiarli in giare nella terra, si da non contaminarla. Quindi coloro che operavano col ferro. Il Libro dei Re dice
che questi ultimi liberarono re Rustam dal grembo materno col
taglio che voi chiamate cesareo e che si potrebbe anche chiamare
rustamico.» Rise e riprese l'elenco: «Il quarto genere erano i conoscitori di erbe. Quinto i conoscitori di incantesimi, di ritmi: i
mantru baishazu. Quando eseguiamo il rito della guarigione nel
sonno siamo i loro eredi».
Chi desidera guarire mercé il rito deve astenersi dalla carne, cibarsi di verdure leggere, bere decotti delle due piante sacre, l'efedrina e la coramina. Quindi egli si reca in casa del sacerdote a dormire. Gli officianti debbono essere quattro o più, non cinque. A
mezzanotte incomincia il rito, sul paziente addormentato. Gli
strumenti liturgici sono disposti in ordine. I due treppiedi con i
fili di rame o d'argento sono accanto all'officiante maggiore, il
quale lega al cingolo che il paziente, come ogni zoroastriano, porta
alla vita per scioglierlo e riannodarlo durante le preghiere uno dei
fili di metallo, che egli impugnerà durante la cerimonia. Nel mortaio s'incomincia a pestare l'efedra e si approntano la coppa d'acqua e di latte per mescolarvi l'efedra quando essa sarà preparata.
Le due mani dell'officiante maggiore sono impegnate, l'una a
stringere il filo di metallo, l'altra a colpire col pestello nel mortaio;
intanto la sua voce guida nella salmodia gli altri sacerdoti.
Dopo sei ore la preparazione della bevanda sacra è terminata, la
recitazione degli inni è compiuta, il loro ritmo penetrato nel dormiveglia del paziente. Allora il pestello ruota vorticosamente nel
mortaio, che si trasforma in una campana. Già colpendolo appena, ne traggo un timbro che mi sembra trapassi agli ultrasuoni:
quella esasperazione deve catapultare il malato fuori di sé. Quando
egli è desto, gli si dà subito da bere l'infuso della sacra pianta. Ha
avuto il sogno liberatore, spesso sono stati i suoi morti ad apparirgli dandogli il retto consiglio.
Osservo gli strumenti di salute nella sala posteriore del tempio,
dove sono posati tra tavole di offerte: frutti e rami di mortella,
simbolo del corpo, incensi e mirre, simboli rispettivi dello spirito
e dell'anima, germogli, simboli d'eternità, simili, nell'umida
pianta alla fiamma viva che si agita davanti a noi, dietro a un cristallo. È isolata, la fiamma, affinché nessun fiato la contamini. I
fedeli salmodiami la osservano dalla parte opposta del tempio,
dalla sala anteriore, di là da un secondo cristallo. Il sacerdote commenta gli oggetti, a uno a uno: i legni di sandalo e i bastoncini
d'incenso, le resine d'alberi odorosi che sanno attrarre ciò che in
noi è puro. Egli evoca la benedizione del pane, della frutta, del
vino e del latte e il pasto rituale in cui li si consuma tra luci e resine ardenti, e soggiunge infine: «Nei tempi andati un magnetismo si trasmetteva dal sacerdote al malato durante la cerimonia
del sonno risanatore, e non soltanto si praticava liturgicamente la
terapia, ma si compiva ritualmente anche il processo penale, mediante ordalie, attraverso prove a cui soltanto il colpevole soccombeva». Sorrise: «Forse oggi non si può più perché non esistono più innocenti?».
Questa sapienza era dei re Magi, che inaugurarono la tradizione cristiana. Uno dei suoi testi maggiori, il Denkart, la descrizione del paradiso, del purgatorio e dell'inferno fatta da chi ne
ebbe la visione durante un sonno oppiato, è la fonte remota del
viaggio dantesco.
«Noi eseguiamo ancora i riti. Quei poteri sono scomparsi» mi
dice il sacerdote. Quante frasi del Cristo non ritrovo nel libro di
preghiere zoroastriano! Quanti versi dei Salmi!
Insisto a domandare: «Ma non c'è nessuno che si sforzi di riattingere a quei doni?».
«Non fra noi.»
Ma mi parla di una società vegetariana, a Bombay, che approfondisce la dottrina, ha il culto degli asceti. Nella biblioteca ne
sfoglio i testi. Essi insegnano a leggere i cieli, dove le stelle simboleggiano ogni cosa terrestre e ultraterrena, diventando il perfetto
alfabeto, il Libro.*
***
A Mashad tutte le sere il sole fa sprizzare scintille rossicce dai bulbi
d'oro della moschea dov'è sepolto il santo che salvava le gazzelle
dai cacciatori; la bandiera verde si divincola, la chiamata alla preghiera ondula nell'aria, il tramonto rileva gli arabeschi turchini
delle maioliche.
Un bambino di sette anni insaccato in una tunica, coi pantaloni lunghi e goffi, appare nel mezzo della piazza. Sta sull'attenti;
sol mi-sol, la sol-la, intona una melopea ad Ali, con voce opaca, un
po' incrinata, tesa dalla fede, che ferma i passanti, gli crea una cerchia d'intorno. Di quando in quando qualcuno percorre il raggio
dalla circonferenza al centro per fargli scivolare una monetina nel
palmo e torna indietro. Incessante è la voce, il braccio si alza e si
riabbassa. La gente si disperde e il bambino continua a cantare
nella piazza deserta. Si riforma il cerchio, di nuovo si disperde. Il
crepuscolo scivola sulla piazza, il cerchio si riforma, sempre all'identica distanza, come l'ondata si ritira e si rifrange sempre sull'identico perimetro d'uno scoglio.
Il bambino gira all'intorno lo sguardo, è cieco: a uno a uno si
accendono i lumini nelle botteghe all'ingresso del bazar, sui loggiati pensili della locanda dei pellegrini; il fumo dell'erba contro
il malocchio si arriccia sopra le stufette delle mendicanti che ne ripetono il nome, esfand, esfand[...].**
* Un'altra Persia, «Corriere della Sera», 5 marzo 1975.
" Taccuini di viaggio.
***
Nella folla d'una città persiana, indistinguibili nella moltitudine
sono sparsi i seguaci delle confraternite sufi. Li riconoscerete a un
cenno, a un lampo negli occhi quando citerete un verso, quando
userete una metafora. Conoscono i poeti, certi discorsi soltanto
in loro trovano eco; possono essere il bottegaio, la mendicante, il
medico, chiunque. Di quando in quando, alle feste dell'Ordine,
ai convegni periodici, dalle quattro direzioni convengono al loro
centro, che è quasi sempre cacciato nell'intrico della parte vecchia
e povera della città. In un pomeriggio in cui il disgelo fa frusciare
d'acqua i fossatelli che costeggiano le strade, quando il sole già
primaverile comincia a operare stranamente nel buio dei corpi,
come un vino, tornano alla mente i versi dei poeti sufi, le loro similitudini sempre ripetute del divino Coppiere, del Vino dell'ebbrezza sottile, che proviene da conoscenze ineffabili, della Taverna dove un Coppiere dispensa quel Vino. E si cerca quella Taverna, il ritiro dei sufi.
Si segue il vicolo tra le casupole, che gira, ondeggia, si spezza a
gomito, s'infila sotto le torri dei crocicchi, simili nella forma ai copricapi di lana a punta dei pastori, agli elmi conici dei guerrieri
medievali d'Oriente; nell'ombra dei crocicchi coperti si aprono le
variopinte botteghe ai quattro cantoni, scrosciano le acque dei rigagnoli scontrandosi contro l'antica volta, chiacchierano in crocchio le donne velate e, come a preannuncio della mèta vicina, piccole nicchie annerite dalle candeline accese si aprono nei muri,
con l'immaginetta di Ali, il cavaliere pieno di grazia che sposò la
figlia del Profeta. Infine all'uscio d'una casa dimessa qualsiasi si
dice una parola e si è dentro ad un cortiletto. Sul lato destro si delineano tracce d'una costruzione in corso, fra le quali s'aggira il
gatto color fuoco, l'amico degli spirituali, dice la poesia sufica.
Da un lato travi, impalcature, l'accenno d'un muro: i confratelli si danno il turno nell'erigere un'ala nuova nel ritiro, mattone
su mattone senza fretta; così altri filano i manti o i berretti a punta
per il maestro, spinti dal bisogno di esprimere tangibilmente la
gratitudine per le conoscenze ricevute, per il «Vino» dispensato.
La parte già edificata è una fila di stanze che ricevono luce dal cortile attraverso vetrate dipinte. La luce si effonde tenue nelle stanze
nelle quali gli spessi tappeti attutiscono ogni suono, si posa sui ritratti di santi della confraternita, sui saggi di calligrafìa incorniciati lungo le pareti: mani rapite hanno tracciato quelle lettere che
si divincolano, tremano, come incalzate dal desiderio di estinguersi, in varianti infinite del grido là Ali, là Ali. Ornano le vetrate
la rosa e le due asce incrociate sopra una borraccia.
(Le asce sono la forza attiva, la borraccia che può contenere le
elemosine, la passività, insieme formano l'emblema dell'uomo
perfetto.)
Passando attraverso le stanze si scambia un cenno silenzioso
con le figure raggomitolate negli angoli; c'è chi si prepara in silenzio fin dal primo pomeriggio alla serata, concentrandosi, meditando, facendo ribollire l'acqua del narghilè su cui galleggiano
petali di rosa. La poesia sufi dice che quel ribollio sta esalando la
parola haqq, haqq, «verità, verità», perché il Fuoco è la carbonella
in cima allo stelo del narghilè, lo stelo stesso, di terraglia è l'elemento Terra, mentre alla base ribolle l'Acqua purificatrice. Tutti
gli elementi sono attraversati e vivificati dall'Aria, esistono grazie
alle boccate del fumatore. Contemplando, immedesimandosi in
questi accostamenti, egli può sentirsi dalla parte di chi ricrea di attimo in attimo, col suo soffio, l'universo. Una delle mète del sufismo è di far sentire il mondo come qualcosa che muore e si ricompone di attimo in attimo.
Nell'ultima stanza siedono le donne. Fra esse e gli uomini è la
stanzetta dove il maestro giace fra cuscini, cataste di libri e di manoscritti, fumando e bevendo il tè.
Quando tutti si saranno riuniti, al calar delle tenebre, i cantori
cominceranno a passeggiare di stanza in stanza salmodiando i
poeti dell'Ordine o altri classici. I temi sono sempre uguali. Si
parla di vino, vietato dal Corano; la sua menzione dà il brivido del
proibito: potrà servire a immettere in un mondo di esperienze
sottili, che nulla ha a vedere col mondo comune. Che i profani
possano credere a reali, peccaminose bevute, accentua il senso di
distacco e di compassione per tutto ciò che si muove, preda di comuni passioni, fuori di queste pareti. La salmodia dei cantori è avvivata dai gesti ampi, dalle esitazioni, dai crescendo della recitazione tradizionale, cui si assiste talvolta anche nelle sale da tè della
città vecchia. Quando tutti saranno imbevuti delle idee e dei
ritmi dei poeti, il maestro darà inizio alle invocazioni corali e ritmate, e tutti vi si uniranno. Ogni confraternita ha le sue, speciali.
Si spegneranno le luci, ciascuno deve isolarsi e immergersi nell'onda collettiva, le due cose tutt'insieme, senza provare disagio,
timidezza, ritegno. C'è chi si sentirà risucchiare nella spirale dell'invocazione che via via cresce d'intensità, cosi inesorabilmente,
e uscirà da se stesso singhiozzando. C'è chi sentirà soltanto soavemente acquietarsi il cuore, dimenticando le cure d'ogni giorno.
Le donne invocheranno sottovoce, per non turbare con le loro
voci sottili, le cui vibrazioni sono troppo potenti nell'intimo dell'uomo.
Riaccesi i lumi, si serve il pasto. Per tutto il pomeriggio si è
cotto l'agnello, condito con salse complicate mescolate al succo
dei melograni. Basterà per tutti, numerosi che siano. «Oh come
sazia il festino sufi!» mi sospira un amico. Prima ci si è purificato
il palato con un pizzico di sale.
Ognuno infine si congederà dal maestro, chi ne ha bisogno riceverà qualche parola.
Qualche parola che sorprenderebbe chi sia abituato alla smanceria cui sembra condannato l'Occidentale quando entri nel
mondo religioso. Parole sarcastiche; le accompagna una risata cadenzata da colpi netti, come se ad ogni colpo si dovesse staccare
una parte inutile dell'io. Se un morbido legame avvince a qualcosa di profano, se ci si afferra a qualche lusinghiera (o, per reazione, condannata) immagine di se stessi, il maestro non risparmia. È qui per usare le asce del simbolo sufi, per vibrarle con forza
contro ciò che non sia brama di liberarsi e di estinguersi. Chi
chiede rispetto per la propria persona, non venga da lui. Chi vuol
restare com'è, non indugi nella sua stanza. I fendenti, le risate s'infittiranno specie su ogni devozione che non serva allo scopo massimo e unico: «Meglio barcollare e puzzar di Vino / Che pavo-
neggiarsi di pio orgoglio vendendo il Suo Nome» dice un distico
di 'Omar Khayyam.
Che cosa avrebbe mai da fare un Voltaire in una confraternita
sufi? Sembrerebbero ben timidi e timorati i suoi dileggi. Il maestro sufi sa che ognuno ha la sua inconfondibile strada da seguire,
che ognuno ha un diverso nemico da vincere e ogni fede vecchia
d'un giorno cade sotto i suoi fendenti d'ascia. Talvolta si assiste a
conversazioni nelle quali il maestro scalza ciò che è più caro a
ognuno degli interlocutori che gli fanno cerchio, ridendo. Uno
non fuma il narghilè? Il maestro domanda se per caso non abbia
tanta paura di perdere il suo corpo, visto che tanti hanno tentato
di sciogliersene fumando. Un altro parla di sofferenze, di certa
gente sventurata, con l'inevitabile punta di compiaciuta ammirazione per la propria sollecitudine pietosa? Il maestro si piegherà in
due dalle risate, dicendo che tanti hanno procurato di raggiungere l'estinzione del loro io e gli sventurati se la vedono offrire.
Non stupisce che i manoscritti della biblioteca parlino di tanti
maestri lapidati dalla fùria dei profani. Guai a turbare la melensa
superbia dei devoti! Tra le pietre che gli piovono addosso un maestro dell'Ordine sorride annusando una rosa in una deliziosa miniatura sulla quale indugiano i miei occhi a lungo. Oh come si lapida di gusto un maestro dalla libertà interiore sconfinata!
A che cosa paragonare l'ironia del sufi? Alle giocose, frementi
ingiurie della giovinetta che cimenti il ragazzo che ha deciso di
prendersi; lo implora a ingiurie, prova vera rabbia perché ancora
egli non l'afferra. E quando l'afferri infine, gli pianterà le unghie
nel bel volto. Così il sufi implora l'immersione nella Divina Potenza. Chi potrei mai immaginare, fra gli uomini dell'Occidente
in veste di maestro, in questa stanza felpata? Certamente Melville,
non saprei di altri. Ma Melville dovette avere contatti col sufismo
da come parlò del Vino e della Rosa [...] .*
* Un giorno tra i sufi, «Corriere della Sera», 15 marzo 1975.
Israele: Sfat e cento cancelli
Il borgo di Sfat (o Safed) è un labirinto di pietra luminosa aggrappato a un colle di Galilea. I crinali gli disegnano attorno un
anfiteatro enorme; le quinte di costoni, ora più o meno ombreggiati, scaglionano piani successivi nello spazio. A certe svolte dei
vicoli, quando il paesaggio circostante si oifre d'un subito alla
vista, l'occhio sprofonda tra quei fondali viola e gode della vastità,
dove si dovrebbe poter scorgere il Tabor e forse perfino il lago di
Tiberiade. Sono brulle e odorose campagne punteggiate di carrube, di ulivi contorti, chiazzate di cespugli; vi può apparire all'improvviso l'altea setosa, rosea attorno al suo cuore dorato, o vi
possono splendere i candidi fiori del cappero dai ciuffetti rossicci.
Nei silenzi dei sassosi cortili di Sfat spargono ombra i melograni. Qui vissero nel secolo XVI i maestri della cabbala, Isacco
Luria, il Cordovero, Alcabez, Josef Caro. Le loro vecchie sinagoghe sono salottini felpati, dove tuttora la gente giace studiando
sui tappeti, fra i cuscini.
Dalle volte a botte pendono ancora le vecchie coppe d'olio con
raggiera di lumini. Colonnine tortili svolgono cascate di grappoloni e di fiori spampanati dai colori squillanti. In uno di questi salotti si mostra perfino la cripta dove un angelo sarebbe apparso a
Josef Caro, il secco, razionale giurista che teneva un diario di visioni. Tutta la pleiade di Sfat univa al talmudismo scettico e analitico la pratica dell'estasi. La propiziavano con immersioni nelle
acque correnti accompagnate da recite e meditazioni. Modulavano probabilmente il respiro, espirando col murmurc della M,
inspirando col sibilo della S e trattenendo il fiato alla radice della
gola, dove si accenna, sospesa fra il nulla e l'essere, l'inizio della vibrazione sonora, la prima lettera alef.
Ogni combinazione di lettere era per loro una parola sacra, un
archetipo dell'esistenza, un cancello da spalancare sull'estasi. Lo
stesso vocabolo in ebraico designa la parola e la cosa. Già la pratica religiosa comune dell'ebraismo disciplina la respirazione
della psiche, fatta di benedizioni e scongiuri, benedicendo ogni
cibo, visione o profumo con una formula particolare: nei casi nei
quali questa manchi, si ringrazia Dio dicendo: «Chè tutto è mercé
la Sua parola». L'ebreo devoto ribadisce senza tregua il nesso fra
ogni evento e una data parola, una data combinazione di lettere.
I cabbalisti consacravano a combinazioni di lettere le singole parti
del corpo, fino a stabilire in se stessi un riflesso condizionato. Alla
sensazione di ogni singola parte del corpo scattava l'evocazione di
determinate lettere e viceversa: il corpo diventava così una tastiera
su cui essi potevano modulare a volontà, con la pronuncia di certe
lettere, esultanze, trasporti, possessioni. Sprofondando nei loro
deliqui, i cabbalisti di Sfat dicevano di assimilarsi all'albero della
morte ed in pericolosi sogni lucidi visitavano i paesaggi archetipici della fantasia, scendendo negli inferi a redimere le tracce gementi e sperdute dello Splendore o salendo fra gli spiriti beati a
imparare.
Il popolo li venerava con uno sgomento che echeggia tuttora.
Uno scosceso declivio sul fianco di Sfat è sparso, alla rinfusa, di sepolcreti. Quelli dei cabbalisti sono a cupola, verniciati d'azzurro.
Celano nicchie affumicate, colanti cera, dove ardono candele votive. Ragazzi devoti leggono accoccolati, concentrati, isolati in
questo camposanto ripido e ventoso, al cui limite si aprono le caverne sacre, dall'entrata verniciata d'azzurro. Una di esse è il
bagno di acqua viva e gelida della purificazione cabbalistica.
Di quando in quando sciamano giù nugoli di pellegrine, corrono nei loro camicioni marocchini frusciami verso le cupole azzurre, infittiscono di candele le nicchie, baciano le tombe e via,
agili come capre felici, rivolano su per l'erta verso il loro torpedone. Torna a stagliarsi nel silenzio il gracchiare dei corvi. I ragazzi meditabondi non hanno levato la testa. Fra loro scendono
anche dei chassidim, nelle loro palandrane di seta, alla moda nella
Polonia napoleonica, l'epoca a cui si aggrappano, quando i loro
avi impararono le gioie della cabbala, che essi non vogliono più
perdere, e temono che basterebbe mutar d'abito perché tutto quel
tesoro dilegui.
Ma s'impara a conoscerli meglio nel loro quartiere «Cento cancelli», dove sorge la «Yeshivah Chasidei Breslov», la loro sede, dedicata al maestro Nachman di Breslav. Di lui si può dire che altro
non fece che ¡messere variazioni su una frase del Talmudàìi Gerusalemme: «Renderai conto di tutto ciò che il tuo occhio ha visto e
da cui non hai tratto beneficio e piacere». Malinconia e peccato
sono una cosa sola. Alcuni consigli di Nachman, elencati nei libretti devozionali distribuiti alla «Yeshivah»: «Imparate dai profani, da come essi si aizzano all'ira, si montano, voi fate lo stesso
per la felicità; gridate d'ebbrezza, non su per i vasi che sollevano
l'urlo dai polmoni alle labbra, ma per quelli che dai polmoni
vanno al cervello; ad ogni battito del cuore allucinatevi a vedere
divincolarsi una fiamma, accompagnatela con la mano sussurrando "non mi lasciare, non mi lasciare"».
Intorno al sacrario di Nachman sono innumerevoli case di preghiera. Lessi da ragazzo dei chassidim che sbattevano contro i muri
durante i loro rapimenti, me ne riferiva l'elegante, liscio tedesco di
Buber. Me ne raccontò in seguito Heschel, a occhi socchiusi, nel
suo melodioso inglese. Me ne restano in mente immagini smorzate. Nulla m'aveva preparato agli stanzoni dove l'urlo ritmato
degli oranti cozza contro la volta come una marea furibonda. Il
tempo si squarcia, si piomba nella Polonia del Settecento. Centinaia di corpi si piegano, riscattano in su come coltelli a serramanico, taluno rotea la testa. C'è chi su una parola si sofferma, diventa quella parola, s'immedesima nella vibrazione, mentre la salmodia collettiva s'inarca e ricasca in un rimbombo incessante.
Perché tutto ciò molti disturba, taluni indigna? C'è chi pretende che la possessione cabbalistica o chassidica minacci la lucidità talmudica. Ma perché opporre l'una all'altra? Chi gettò per
primo questo gelo, questa avversione?
A chi meglio domandarlo che a Adin Steinsaltz? Ha curato l'enorme nuova edizione del Talmud, oltre a scrivere un delizioso libretto su Nachman. È appena comparsa nelle librerie la sua Rosa
dai tredici petali, sulla mistica ebraica.
Risponde che all'origine del rigetto della passione estatica non
ci fu Mosé Mendelssohn, il cui illuminismo era molto complesso.
Sospetta piuttosto che tutto risalga a Heinrich Graetz, lo storico
ottocentesco. Di sé Steinsaltz dice d'essere un fisico che ha gettato
la tonaca. Studiò fisica, ma s'è dedicato al Talmud, un sistema si-
mile ma forse più complesso. La translogica talmudica ignora del
tutto le astrazioni, usa dei fatti concreti come modelli per ragionare su fatti simili. Come tradurre parole come autorità, disciplina, contesti, spiritualità in lingua talmudica? — domanda
Steinsaltz nel suo volume sul Talmud, dove pianamente, di passo
in passo, mostra come il gioco translogico arrivi a dialoghi come:
«Perché ci vuole una p nella parola korahì»
«Ma non ci vuole affatto.»
«Immaginiamo di sì.»
«E perché ci dovrebbe essere?»
«È ciò che ti sto appunto domandando.»
Già nel mondo antico i talmudisti discutevano di torri sospese
per aria, di clonazioni, di trapianti di feti. Essi esplorano tutte le
possibilità della mente; ignorano il senso comune, a prò della
pura vertigine intellettuale; di tutto sistematicamente domandano: «Non sarà vero l'opposto?».
A leggere e ad ascoltare Steinsaltz si scorgono le affinità profonde
tra la vertigine intellettuale dei capovolgimenti talmudici e il trascorrere cabbalistico da un piano all'altro dell'essere, dal senso al
sovrassenso delle parole. Steinsaltz cita l'inno cabbalistico ormai
entrato nella liturgia.
«Vieni, caro», in cui si parla di una Sposa che può essere l'anima, la comunità sacra, l'aspetto femminile, prossimo (Shekinatì) del divino; via via che si trascorre dall'uno all'altro registro di
lettura, la mente si delizia, «perché l'uomo ama le iridescenze,
trova per natura piacere nella madreperla» egli sussurra. Cosi i
cabbalisti di Sfat trascorrevano senza difficoltà dal Talmud alla
cabbala, dalla vertigine intellettuale all'estasi totale.
Senza il loro rigore intellettuale e scettico, certo la cabbala sarebbe una fonte di disastrosi deliri.
La sera del sabato a Gerusalemme leggo la locandina: «Segni e meraviglie, serata cabbalistica di Oded Teomi, al teatro del Museo
d'Israele».
La sala è gremita, sul palcoscenico salta l'attore. Ha un accenno
di cerone, veste maglietta e calzoni, ma con la voce impone un'atmosfera grave e tesa. Dice che è sotto giuramento, di dire certe
cose e altre tacere. Ebbe un sogno: si trovò davanti a un cancello
fra banchi di foschia e dietro il cancello s'alzava un cumulo di
libri. Su di essi la testa di suo padre, che prese a roteare, pronunciando oscure parole. Al risveglio, turbato, apri a caso il libro
maggiore della cabbala, lo Zohar, e il passo rispose, spiegò le parole del padre. Tale l'inizio dell'avventura. Ora l'attore ha l'aria di
un consumato intrattenitore di Broadway, un po' troppo lepido.
Dopo un ulteriore consulto dello Zohar, aperto a caso, che lo ha
messo in guardia contro Lilith, la prima donna di Adamo, che potrebbe rovinarlo, egli racconta d'aver deciso di esplorare Sfat. Qui
il guardiano d'una delle vecchie sinagoghe gli dice che venendo a
Sfat ha sbagliato di secolo. Cabbalisti non ce n'è più, anche se in
città abita un piombalo, un mattacchione che crede di essere Elia.
Annoiato dalle antiche strade, l'attore sta per portarsi in albergo
una ragazza, ma la lascia tutto impaurito quando sente che si
chiama Lilith. S'imbatte quindi in un tale che armeggia attorno a
un'automobile e che gli chiede aiuto. È un matto un po' divertente un po' arrogante: è lui, il piombaio. Fra pagliacciate e ammicchi racconta d'essere stato per breve tecnicamente morto durante un'operazione. In quell'intervallo sarebbe andato oltre la
cortina di questo mondo e da allora gli sarebbe compagno invisibile Elia.
Il tutto è raccontato fra lazzi. L'attore si congeda per l'intervallo
e il pubblico si sogguarda incerto. Lo svariare di toni è stato calcolato a puntino. Quando salta di nuovo sul palcoscenico, l'attore
racconta la visita al camposanto di Sfat. Vede aggirarsi per le
tombe un vecchio cadente, che sparisce in una delle vicine grotte.
Breve premessa sulla possibilità di improvvise allucinazioni, e l'attore narra di essersi inoltrato nella grotta, dove il vecchio presiedeva a un consesso. Ma non era più il vecchio, era il piombaio.
Il consesso aveva fatto un'evocazione di morti. L'attore annuncia stentoreo che riprodurrà l'evocazione e chiede a tutti di darsi
la mano col vicino e di ripetere dopo di lui le parole «non è per-
messo». Il pubblico ripete con lui che «non è permesso» evocare
morti, fare magia, secondo la Torah, ma alla fine dice: «è permesso
evocare gli angeli di Dio». L'attore rotea la testa e annuncia di parlare con la voce d'un antico martire, gioca con combinazioni di
lettere e numeri, e nel gioco rientrano anche sgradevoli elucubrazioni sul 1989, che sarebbe fatidico. Finita l'evocazione, egli rifà
la voce del piombalo, il quale spiega che le rivelazioni si possono
interpretare al contrario.
Sabato a Israele: va in scena la «cabbala», «Corriere della Sera», 23 agosto
1981.
Roma: una ferita rimarginata. Il papa in sinagoga
Il nostro ciclo storico ebbe inizio a Roma, con un insolito «tumultuare» degli ebrei in città. Pietro e Paolo erano venuti ad annunciare che i versetti messianici erano stati adempiuti. Non
erano i primi e non sarebbero stati gli ultimi a lanciare quella notizia in una sinagoga.
Sui tumulti abbiamo poche notizie. La versione ebraica si può
ricostruire dalle leggende medievali che Riccardo Di Segni raccolse con rigore storico in un libro uscito un anno fa, II vangelo del
ghetto (Newton Compton, 1985). Si favoleggiò perfino che guide
di Israele avessero incaricato gli apostoli di creare una Chiesa dei
gentili per allontanare gli ebrei cristiani dalla comunità.
Poco importa la verosimiglianza, conta che la tesi fu. creduta:
essa comprova, osserva Di Segni, che, mentre era temuta ed esecrata la presenza di un'eresia interna, verso i cristiani come tali
l'atteggiamento naturale era di tolleranza. C'è una tradizione in
tal senso fra i pensatori ebrei, che ritengono provvidenziale il
diffondersi attraverso l'evangelizzazione delle due idee: la sacralità della Bibbia e la santità di Gerusalemme.
Si suggella un ciclo storico bimillenario quando un successore
degli apostoli «rientra» nella sinagoga di Roma per essere accolto
con singolari onori? Il gioco dei gesti e delle citazioni durante la
cerimonia potrebbe dar l'avvio a una futura pratica liturgica?
L'odierno incontro in sinagoga (14 aprile 1986) non si risolve
nel semplice accostamento estrinseco di due tradizioni sacre, proprio a causa della loro vicinanza che nella storia è stata quasi sempre tragica, salvo durante il breve idillio dei tolleranti papati rinascimentali.
Il Congresso dei rabbini d'Europa si augura, in occasione dell'evento, che il Vaticano accetti lo Stato di Israele come adempimento «dei millenari sogni ebraici». Le parole bibliche, interpretate in senso puramente traslato dalla Cristianità, furono ribadite
alla lettera nelle sinagoghe, finché nel 1948 da «sogni» fatalmente
si tramutarono in realtà. L'«adempimento» non imporrà ai cristiani di ammettere anche il senso letterale di ciò che invocano
nelle loro preghiere? A questo punto si potrà continuare a relegare
fra le bizzarrie marginali la teologia di Campanella, che fonde
messianismo ebraico e cristiano? Il ritorno cristiano alle radici
sarà come la «visita alle Madri» che compie il Faust di Goethe?
La lettera del Rabbinato europeo parla anche di «riconoscere il
legame speciale degli ebrei con Gerusalemme, città sacra di tre
fedi in quanto dapprima (because first) santificata dagli ebrei
come loro capitale tremila anni fa». Quell'«in quanto dapprima»
designa Gerusalemme come la causa nella quale sono latenti gli
effetti successivi, sia la Roma cristiana sia l'Islam.
La tesi ha dalla sua la storia, ma a £1 Aqsa mi fu detto: «Fu un
sogno del Profeta a consacrare questo luogo». Soltanto quel sogno?
Un giorno, che mi trovavo con Heschel, si incontrò un teologo
islamico di cui ci incantò l'intelligenza, la quiete. Heschel portò
la conversazione sulla successione dei profeti ebrei che introduce
all'Islam, ma l'interlocutore replicò che l'Islam nasceva soltanto
dal mandato del Profeta. Per una giornata Heschel volle discutere
la battuta, tutto per lui dipendeva dalla sua ammissibilità. Si può
negare la propria radice storica, pur rivendicandone le parole?
Avevo in mente Heschel durante la cerimonia romana. Che
cosa ne avrebbe detto? L'avevo visto reduce da un colloquio tormentato con Paolo VI, in cui avevano discusso la dizione del documento sugli ebrei, ma se potè restargliene un qualche turbamento, esso scomparve d'incanto quando si accinse al suo pasto
chassidico: allora, chi credeva di essere malevolo, diceva di lui: «Si
droga di liturgia». Fra i Salmi che più lo «drogavano» c'era il 133,
letto da Giovanni Paolo II in sinagoga. Esso celebra l'esultanza del
perfetto affiatamento fra uomo e uomo: «Com'è bello e dolce il ritrovarsi dei fratelli dispersi».
Cosi traduce Ceronetti nella memorabile nuova versione dei
Salmi, apparsa l'anno scorso.
Ritrovarsi è come se la rugiada di monti lontani scendesse miracolosamente a Gerusalemme, nei cortili del tempio. Questa
comparazione è, commenta Ceronetti, «immagine della vita ascetica, figura della paradisiaca». Eppure designa anche un luogo
concreto.
Ceronetti annota, infine, su questo salmo di fuga e salvezza:
«Non c'è vera fuga che dalla storia, vera libertà che dal mondo:
tuttavia ad ogni rompersi di rete, il salmo grida il suo tragico, ineludibile ringraziamento».
Rimarginata una «ferita» di duemila anni, «Corriere della Sera», 14
aprile 1986, in occasione della storica visita di Giovani Paolo II alla sinagoga di Roma.
Nubia: cercando gli amanti divini
Dopo che fu finito il Congresso per il quale m'ero recato al Cairo,
scesi nella Nubia, sperando di assistere a qualche seduta del culto
degli zar. È una religione marginale che si estende dall'Etiopia
cristiana al Sudan e all'Egitto islamici e che si può dire presente,
con certe varianti, anche nel Marocco.
È gestito da donne, le sceicche dello zar, che così esprimono
una loro altrimenti inibita vocazione sacerdotale. Il culto è retto
dall'idea che gli spiriti invisibili, i jinn o genii, possono diventare
degli amanti, possedendo le persone che li attraggono. Come
ogni amore, questo può essere una maledizione o una benedizione. Le sessioni del culto, con le loro danze, servono a rendere i
rapporti con lo spirito armoniosi e ben temperati.
Al Cairo mi fu detto: «Lo zar è per le classi infime o per i gran
signori, chi sta in mezzo lo disprezza e lo teme». Ne parlai anche
con esoteristi islamici: secondo loro l'unico esile ponte che si può
gettare fra l'ortodossia islamica e lo zarb l'uso che quest'ultimo fa
dello zikr, l'invocazione ritmata dei Nomi di Dio, accompagnata
dal roteare o dall'abbassarsi e rovesciarsi all'indietro della testa.
Così si ottiene di scivolare nell'estasi, che è fine a se stessa nello
zikr, ma che introduce alla possessione nello zar.
Tutti avevano dubitato che riuscissi ad assistere ad una seduta.
Avevo dato appuntamento ad un giovane nubiano, che aveva promesso di trovare la strada giusta per accedere allo zar, sul terrazzo
d'un caffè davanti al Nilo. Era scesa la sera, il vento secco e rovente
mi sventagliava senza tregua nel buio. Il tè verde alla menta consente di rimanere lucidi mentre il corpo sembra svanire nell'aria
calda e animata e il tempo cessa di scorrere. Vidi avvicinarsi il giovane nubiano e l'andatura un po' curva già diceva che non ce l'aveva fatta. Aveva la faccia sorridente ma mortificata. Dapprima
aveva creduto di farsi aiutare dalla moglie, che egli sospettava d'aver assistito a qualche sessione di zar, ma il suocero, avvertito
della cosa, gli aveva fatto una scenata: voleva rovinargli la figlia,
facendole accostare la gente dello zarì Sicché, disse, era andato da
solo al beit-e zar, la casa dello zar. un piccolo edificio di fango in-
tonacato di giallo. La saletta era dipinta di rosso e vi stava accoccolata la sceicca, che l'aveva impressionato. Una vecchia dalle dita
coperte di anelloni, con un orecchino enorme a un orecchio, tutta
vestita di bianco, con un turbante bianco in testa, che non gli rispose, anzi evitò perfino di incrociare lo sguardo col suo. All'uscita furono guai: la gente del vicolaccio l'aveva affrontato, uno
non voleva staccare le mani dalla sua motocicletta. «Che cosa sei
venuto a cercare?» insistevano. «Hai la moglie malata? Non ce la
fate ad avere figli?»
Mentre il giovane mi parlava, lanciava di quando in quando
occhiate deferenti ad un uomo dall'aria di notabile siciliano, seduto ad un tavolo vicino, che seguiva il discorso e che alla fine intervenne con naturalezza, dicendomi in un rifinito francese:
«Non credo che gli adepti potrebbero abbandonarsi al rito in sua
presenza. Tutt'al più rischia che qualcuno le organizzi uno spettacolo in cui la gente reciterebbe uno zar a pagamento». Lo pregai
di sedersi al mio tavolo, ed egli continuò: «Si eccitano col tamburo, via via che il ritmo accelera le donne si tolgono i vestiti e restano in camicioni dai colori sgargianti e quando il loro zar le cavalca, ululano e si dimenano. Neanch'io sarei ammesso, che pure
sono amico perfino degli zingari».
«Ma come mi possono accogliere gli sceicchi d'un circolo di
zikrì» tentai. Il ponte non funzionò. «Che cosa c'è in comune fra
zar e zikri Niente. È questione di ritmo, certo, nell'uno e nell'altro caso. Ma le regole sono differenti anche nel ritmo. Dopo tutto
lo zikr è soltanto basato su gruppi di trentatré invocazioni e su
multipli di trentatré. Per lo più trentatré invocazioni rispettivamente di Allah Akbar, Allah Haqq, Allah Hai e infine Allah Hu.»
Udii delle voci note dall'entrata del locale e riconobbi due uomini e una donna della Costa d'Avorio che avevo incontrato al
Cairo e che stavano facendo anch'essi un giro nella Nubia. Vennero al tavolo tutti festosi, la donna era in costume nazionale, la
testa avvolta in un fazzolettone piegato a torre, dalla cui cima
spuntava una ciocca, gli occhi pieni d'allegria. S'interessò alla
conversazione con entusiasmo e gridò: «Et bien? Moi j'ai mon
mari génie. Bien sûr quej'ai mon mari génie!».
«E vede il suo marito soprannaturale nei sogni?» domandai.
«Ma che sogni! La prima volta ero altro che sveglia. Me lo vidi
in casa, per un quarto d'ora, poi spari e non so come, me ne scordai. Più tardi una dirimpettaia mi domandò chi era l'uomo che
era venuto a trovarmi quella mattina. Me lo descrisse esattamente
come l'avevo visto! Aggiunse che mentre lui era dentro di me, il
gallo si era messo a cantare a squarciagola senza smetterla. Era
vero, me ne risowenni. Capii che avevo visto per la prima volta il
mio marito soprannaturale. Pas en rêve, dans la réalité, monsieur!
Cela n'empêche pas qu'il vienne aussi en rêve. Certo che mi fa visita
in sogno. Per fortuna il mio non è di quelli tirannici e gelosi, iracondi, che ti rovinano l'esistenza. Lui mi aiuta, me lo sento accanto che mi protegge. Per certe poverette invece è una cosa terribile. Quando viene loro addosso, cadono in convulsioni, devono
fare la danza di possessione fino a stramazzare stremate. Allora
non resta che accettare la fatalità. Si celebrano pubblicamente le
loro nozze con lo spirito. Da allora sono sempre e soltanto vestite
di bianco. Si riconoscono per la strada. Non possono più sposare
un uomo. Bien entendu, elles ne se passentpas des hommes, si fanno
un uomo quando ne hanno voglia, ma prendersi un marito non
possono più. Da loro si va per fare la divinazione. Lo sposo soprannaturale, com'è giusto, le assiste, dà loro dei poteri. Comunque si può dire che più o meno tutte abbiamo uno sposo soprannaturale.»
Uno dei suoi accompagnatori mi disse: «Per lo più la moglie riserva il venerdì ai rapporti con lo sposo soprannaturale e quel
giorno il marito la lascia in pace. C'est entendu».
«Questo fra i musulmani?» domandai.
«Per via del venerdì? Macché, non c'entra l'Islam. Noi abbiamo molti calendari, a seconda degli usi. Abbiamo periodi di
quattro oltre che di sette giorni. Nel nostro caso ça revient simplement à dire, il quinto giorno è riservato allo spirito se si periodizza per sette. Sugli altari privati, in casa, la moglie tiene la statua del suo sposo soprannaturale e il marito quella della sua sposa
soprannaturale.»
«Chi dà le indicazioni allo scultore?» domandai.
«Oh là là, se lei vuole sapere proprio tutto non ha che da venire
a stare con noi!»
Il secondo accompagnatore è meno sbrigativo, mi spiega che
talvolta è l'interessato che è in grado di descrivere l'essere soprannaturale allo scultore, mentre altre volte si chiedono informazioni
con la divinazione. Prima che i tre partano, soggiungo che l'idea
dello sposo o della sposa celesti si trova in varie forme in buona
parte del mondo, ma di rado è così data per scontata. La donna
conclude: « Oui, Us autres sontplus nébuleux».
Anche il giovane nubiano si congeda. Resto solo con il notabile
egiziano, che sotto la raffica di meravigliose notizie dalla Costa
d'Avorio è rimasto a fumare in silenzio. Gli domando che cosa
può dirmi di questi amori invisibili: « C'est peut-être superstitieux,
mais la credenza è che un alchimista o un mago è sempre aiutato
da una sposa soprannaturale».
«E come si chiama questa sposa?»
«Hajjah o sceicca.»
«Come la padrona d'un 'beit-ezarì»
«SI, è lo stesso nome. Ma non è forse noto che i poeti ricevono
l'ispirazione da jinnì C'è un distico famoso nella poesia araba,
che dice Li kulli sa'irin min albaqshar /Jinniyatum unthawajtnniyun zakar. Ogni poesia ha rapporti con uno spirito femminile e
con uno maschile, ha una sposa e un amico jinn. Ma sono soprattutto le donne che avvertono la presenza d'uno sposo soprannaturale, che chiamano ragelo hajjo sceicco. Da lui ricevono ordini,
che sono talvolta provvidenziali, ma altre volte disastrosi, e spesso
una donna tormentata dal suo jinn cade malata e deve allora ricorrere ai riti dello zar. Ma scusi, se le faccio una domanda, che mi
è rimasta dentro per tutta questa lunga serata: come mai lei s'interessa tanto di tutto ciò?»
Come rispondergli?
Stavo scrivendo la storia della Dama celeste nella poesia [L'amante
invisibili, ed ecco, ero capitato fra gente per la quale quell'archetipo
dell'amore visionario era una realtà quotidiana, non una nozione,
come aveva detto la donna poc'anzi, nebulosa.
Nell'iniziazione sciamanica è l'amante celeste che conferisce
conoscenza e poteri, sosteneva in un celebre saggio del 1929, La
chiamata divina, il russo Shtemberg. Nel suo trattato sullo sciamanesimo Eliade attenuava la portata delle tesi di Shternberg, ma
confermava la diffusione dell'archetipo. Altri esempi portava dei
culti di possessione africana Iain Lewis nel suo trattato sulla possessione e l'estasi.
L'esperienza sciamanica della sposa o dello sposo celesti diventa tema delle fiabe d'un popolo, con gli amori di ninfe, o
donne serpenti o sirene o fate. Dalla fiaba nasce il mito politico, i
capi di dinastie sono amanti di dèe: Anchise amante di Venere genera la stirpe augustea, dagli amori del capostipite con Melusina
nasce la schiatta dei Lusignan. Infine l'archetipo genera sia l'immagine della Sapienza come sposa celeste nei sistemi metafisici,
che la figura della Dama nella lirica cortese. In certe tradizioni
poetiche si può accertare il punto preciso del trapasso dall'esperienza sciamanica della sposa celeste alla lirica cortese; così in
Cina, con le Elegie di Ch'u (IV-III secolo a.C.), tradotte da Waley;
così anche in Etiopia, nella lirica del poeta visionario Tawani, del
secolo XVIII.
La poesia cortese europea provenne dalla Spagna mozarabica,
dove si erano incontrate e fuse la tradizione dell'amore impossibile della poesia beduina e quella dell'amore per la Sapienza incarnata in una fanciulla, propria della letteratura visionaria sufi.
Su Beatrice, Laura, Logistilla ancora stinge il ricordo della
sposa celeste. Ogni passione amorosa fa riemergere l'archetipo
degli sponsali con un essere soprannaturale: può nascerne, a seconda, il Paradiso, il Canzoniere, un Sogno d'una notte di mezzestate o le avventure di Don Chisciotte. Anche dove non ci sono
«case dello zar» o visioni sciamaniche, l'archetipo raccoglie tributi
di lacrime e sospiri ogni qualvolta esso accende della sua luce l'incontro di due sguardi e a una creatura umana sovrappone l'idea
della sposa o dello sposo celesti.
AJubia: cercando gli amanti divini, «Corriere della Sera», 30 settembre
1982.
Benares, Cochin: l'India che non muore
Giunse governatore inglese in India nel 1834 lo storico, grecista e
latinista Macaulay, e decise che andava proscritta, come inutile e
dannosa al Progresso, la locale cultura sanscrita. L'indignazione
indiana covò lungamente, lentamente ingigantì e a distanza d'un
secolo prese corpo nella fondazione, fra le due guerre, dell'Università indù di Benares. Si possono scordare ormai le polemiche
delle origini contemplandola, estesa in un vastissimo parco, con
le Facoltà e le dimore di docenti e discenti nascoste tra i folti d'alberi sui lati dei vialoni ombreggiati da fichi del Bengala. Si potrebbe scambiare per qualcosa di simile alle innumerevoli Università anglosassoni affondate nel verde, ma sarebbe un errore.
Siamo in un mondo antichissimo, dove ogni cosa cela significati
riposti, che s'imparano soltanto a grado a grado.
Ogni particolare può aprirsi su misteri. Ad esempio: i fichi del
Bengala che fiancheggiano i viali. I loro enormi tronchi sono
bendati da fili bianchi, perché questa è la ricorrenza in cui le
anime dei morti vagano per la terra, come nei manalia romani, ed
esse sono attratte dalle spioventi capigliature verdoline di questi
giganti arborei; la bendatura dovrebbe trattenerle dentro, lontano dai vivi. Il fico del Bengala è il ricetto naturale dei defunti
perché è simbolo di ascesi, di morte al mondo: alla sua ombra il
Buddha ebbe l'illuminazione. Qui tutto può essere simbolo, rinvio ad un altro ordine di realtà: guai se nel recinto domestico
spuntasse un rametto di quest'albero della rinuncia, perché la
casa è il simbolo della fecondità: se il virgulto vi facesse mai capolino, un indù neanche lo toccherebbe, chiamerebbe un musulmano a estirparlo.
Questo è anche un mondo di leggende e di novellini. Si racconta ad esempio come sorse il tempio dell'Università. Un miliardario agonizzava, ma non riusciva a esalare l'ultimo respiro. Finalmente capì: lasciò in legato la somma necessaria a dotare l'Università d'un santuario a Siva e allora il Dio lo liberò.
Sorse così, negli anni Sessanta, in margine al gran parco, il tempio: una torre panciuta che biancheggia maestosa sopra una cinta
rosata. Non è un posto per gli appassionati dei tradizionali interni
templari indù, che sono grotte, meandri di tenebra dove grottesche stralunate rosseggiano al tremolare delle fiaccole, fra rulli di
tamburi e stridere di conche. Questo sacrario nuovissimo è invece
una sequela di aule severe, marmi chiari, freddi, silenziosi. Gli elementi antichi sono tuttavia preservati: nella cella centrale da una
brocca sospesa goccia acqua del Gange sopra il fallo di pietra nera
cosparso di fiori fragranti e davanti si alza un torello di pietra,
simbolo dell'anima devota. Questo è il centro geometrico, ma
quello semiotico è a oriente: un altro fallo, nel quale sono incorporate cinque teste di Siva avvolte di serpenti e tempestate di
scorpioni; rispetto ad esso sono dislocate le altre statue dell'edificio, su un'ideale rosa dei venti, a mostrare la geografia degli archetipi nel cosmo.
Il piano superiore è un giro di spaziosi, ridenti corridoi dove si
passeggia nella limpida luce leggendo, centellinando i testi scalpellinati sulle pareti; testimoniando d'un ideale d'infinita tolleranza, questo libro di marmo vorrebbe comprendere ogni idea nel
suo abbraccio. Il muro che esalta il buddhismo proclama: «Induismo e buddhismo sono due propaggini dell'unica nobile Norma».
Alla glorificazione di forme religiose spesso opposte fra loro, dal
culto giaina al sikh, segue un'antologia di mistici. Di Ramakrishna
si legge il detto: «È un verme nello sterco, innamorato del suo rifugio, l'uomo mondano; se lo tiri fuori, non vive più».
Una parete mostra gli ostacoli che ci impediscono di accorgerci
di essere Dio: l'ira, la mollezza, l'avidità rappresentate rispettivamente da uno scorpione, da fiori, monili, una casa accogliente, da
un fuoco divampante.
Fra tutte mi ferma l'attenzione una parete di cui nulla è tradotto in inglese: una comunicazione riservata. È dedicata al
primo grande alchimista, Nàgàrjuna e narra un'altra storia da
Novellino. Nel 1947 un anonimo adepto si presentò al miliardario Birla e al preside della Facoltà di Medicina indù (ayurvedà) e
in loro presenza sparse su del comune mercurio una polvere. Ne
risultarono 18 chili di oro zecchino, che furono destinati alla società pia «Sanatana Dharma» del Punjab.
Dopo aver letto il racconto m'affretto per i viali alberati verso
la Facoltà di ayurveda. Vi trovo il professor L. V. Guru, appena reduce da un convegno indonesiano sulle arti mediche tradizionali,
e mi ripete, sulla scia dell'entusiasmo, le tesi della sua relazione.
L'ayurveda non è soltanto medicina, è la scienza complessiva della
felicità; peraltro già nel Mille a.C. era praticata la dissezione dei
cadaveri. La lettura dei molteplici polsi, l'uso dell'oppio e della
cannabis, di minerali e metalli, tutto fu codificato in modo definitivo, già nel secolo XII.
Purtroppo, dice Guru, i medicamenti ayurvedici sono soltanto
per i re, che soli possono permettersi di profondere metalli preziosi e gioielli, pagarsi lavorazioni che durano anni. Per le questioni alchemiche egli m'indirizza al dipartimento specifico di
rasa sàstra. Qui il direttore, D. Joshi, conferma l'iscrizione del
tempio: il suo predecessore testimoniava di aver visto la trasmutazione. Ma non è poi tanto interessante una trasmutazione, fin
dal Trecento l'alchimia è essenzialmente quella che qui tuttora
s'insegna: il ramo della farmacia che si occupa di purificare, «uccidere» e così svelenire minerali e metalli: «preferiamo mirare alla
trasmutazione delle cellule del corpo».
«Fino a largire l'estasi dello yoga?» domando. «A questo i preparati alchemici possono soltanto contribuire. Certi possono togliere l'ansia, come l'oro, una volta che sia ucciso.»
Un giovane esercitatore mi suggerisce: «Una volta ucciso, l'oro
acquista molte qualità dei cortisonici». Aggiunge: «Non c'è bisogno di ingerirlo, basta posarlo sulla lingua». Infatti i prodotti alchemici dovrebbero essere «proiettivi»; dicono i trattati classici
che le coliche si guariscono infilando un anello fatto metà d'oro
ucciso e metà di solfato di rame scaldato in crogiolo con cenere di
penne di pavone, burro e miele.
Per tutti i preparati, specie per il mercurio e per l'unione di
mercurio e zolfo, il massimo toccasana, vale l'avvertenza: si debbono prima uccidere. Come si fa?
Per il mercurio si deve innanzitutto «sfregarlo» in un mortaio con pelo di montone, curcuma, mattone in polvere, fuliggine e succo di cedro. Quindi si bolle, avvolto in un panno, con
radici, salgemme, zenzero e orina di capra. Alla terza fase della
lavorazione, si sublima: si converte in gas e si fa tornare solido.
Quindi gli si dà da «mangiare» rame, mica, oro e zolfo. Dopo
un anno e più d'operazioni è morto e si dice che «morto, risuscita i morti».
Con grande orgoglio il capo operaio del laboratorio della Facoltà mi mostra delle preziose ceneri di mercurio. Odorano come
un muro lungamente cotto al sole.
È fùtile applicare a queste manipolazioni la nomenclatura
della chimica nostra; occorre ambientarsi in un linguaggio del
tutto diverso, che aiuta a scorgere altre qualità. Voglio tuttavia
provocare il giovane esercitatore; gli domando: «Perché non
chiama ossidi queste polveri?». Replica: «Se durante le cotture
non si sono fatti sfuggire i fumi e i vapori, non risultano dei comuni ossidi, il metallo o il minerale è stato liberato delle parti
aeree e liquide».
Una studiosa americana Sarah M. Bekker, osserva: «In Birmania si vendono gli attrezzi alchemici sui banchetti all'entrata dei
templi, tanto è dato per scontato che l'alchimia sia essenzialmente
un modo di purificarsi interiormente».
Questo è tuttavia vero anche in India, forse non tra gli onesti
universitari che curano edizioni dei classici e praticano in comuni
laboratori le antiche operazioni, ma tra i praticanti éivaiti e tantrici, che non si manifestano in pubblico. I testi affermano che la
lavorazione del mercurio (che è Siva) è altresì un culto reso alla
dea che ne costituisce la forza immanente. Essi intrecciano la
combinazione di mercurio e zolfo nei crogioli con riti erotici: la
loro compagna impersona lo zolfo e di zolfo ucciso sarà saturato
il suo organismo: sarà d'un incarnato splendente come l'oro in fusione, avrà la pelle fresca d'estate, calda d'inverno e i suoi mestrui
coincideranno con la luna calante.
Le complicate operazioni diverranno una danza liturgica ed
estatica; nel laboratorio, che sorge, a norma dei trattati, al centro
d'un giardino di semplici, a sudest arderà il fuoco, a sud si triterà
e si sfregheranno le sostanze, che a ovest si laveranno e a nordovest
si seccheranno; a tramontana si effettueranno le trasmutazioni.
Se è vero che qualcuno, per scienza tramandata, ancora persegue tali pratiche, perché mai dovrebbe palesarsi, offrire a sguardi
profani la sua officina paradisiaca?*
***
A Cochin mi insegnava il particolare yoga del kathakali, la pantomima sacra del Kerala, P. K. Devan, che sta redigendo un ampio
trattato sugli aspetti più reconditi di questa danza narrativa (questo, in lingua malayam, vuol dire la parola kathakali), per esempio sulla farmacopea di erbe e di pietre triturate che servono al
trucco ma soprattutto sedano i nervi e ingagliardiscono i muscoli,
aiutando il danzatore cosi a identificarsi con gli spensierati dèi che
impersona. Da Devan imparai a diffidare degli spettacoli solid,
rabberciati; ci vuole una compagnia templare, gente che migri di
tempio in tempio, paga dell'ospitalità, e durante i monsoni si ritiri a studiare e meditare. Venne una sera in cui Devan mi potè garantire una veglia notturna di danze autentiche, nel villaggio di
Muthakunnan, e alla volta di Muthakunnan partii, credendo
d'andare ad assistere al kathakali, mentre era destino che laggiù
scoprissi, innanzitutto, la Città del Sole.
La strada, dopo Cochin, affonda nell'esuberante campagna,
sfiora lagune iridate nel crepuscolo di oro e di scarlatto, di pallido
verde e infine di viola, a mano a mano che i raggi radono sempre
più di striscio la melma perlacea, come oleosa. Poi è la foresta, che
ingolfa nel suo buio tempestato di luccichii, di villaggi trapelanti
nel folto.
È calda, immediata, ovvia qui la riconoscenza verso la terra verde
e ondulata, con le sue dense macchie di alberi antichi, con i suoi
piccoli stagni coperti di loti, che profonde erbe profumate, frutti
polposi come una mucca distratta, di quelle randage che offrono
le mammelle turgide a qualunque marmocchio.
* Così cura l'ansia l'alchimista indù, «Corriere della Sera», 7 gennaio 1985.
Una riconoscenza forte, vibrata verso la terra infonde una trasognata beatitudine a ogni atto, che si mangi, si dorma, si stringa,
si abbracci un essere vivo, o semplicemente si calchi a piedi nudi
la cedevole, viva terra. Sicché è naturale che si tesoreggi, si esterni,
si magnifichi questa spontanea commozione, così preziosa e gaia,
esaltante, facendo della terra una bambola a cui offrire luci, fiori,
canti, danze.
Delle danze la più complessa, di uomini tramutati in metafìsiche bambole, è il kathakali. Giungo infine nel villaggio dove sta
per essere eseguita. Gli abitanti sono tutti affluiti in una delle due
vaste cinte templari, quella della dèa, della bambola Putuvakkal
Bhagavati. In una capanna al lato del tempio gli attori si fanno
truccare: devono sentirsi tramutati a grado a grado in dèi e perciò
di quando in quando si ridestano dal dormiveglia meditativo per
rimirarsi, ritualmente, in uno specchietto, così aiutandosi nella
modificazione interiore con la vista di quella esterna.
La folla festosa entra ed esce dalla capanna-camerino, sciama
dentro e fuori del tempio, che è uno splendore di lumi, dove s'incensa la Bambola; sul prato circostante si addensano e diradano i
capannelli attorno ai pentoloni in cui le donne dagli sfavillanti
manti gettano pizzichi di spezie e sorvegliano la cottura al crepitare delle fiamme. Frotte di bambini dagli occhi enormi corrono
dietro a un vecchio burlone che lancia battute a questo e a quel
crocchio. A indugiare guardando intorno, ci si accorge che taluni
uomini partecipano alla festa e nel contempo la sorvegliano; con
attenzione pari a quella del truccatore o delle cuciniere, scivolano
lievi tra la calca, paternamente. Uno di loro mi osserva, che sto accoccolato nella capanna studiando l'impasto dei colori e le caute
spennellature; mi si accosta, si china e mi sussurra di seguirlo. In
attesa dello spettacolo, mi mostrerà il villaggio.
Visito con lui il tempio della dèa, quindi usciamo dall'area risonante e illuminata, entriamo in una seconda cinta templare, silenziosa questa e semibuia. Al centro si alza un tempio a Siva. A
oriente sorge un padiglione, con la statua del fondatore della Società a cui il mio accompagnatore appartiene, e che regge il villaggio. Al fianco una casa di due piani, con un porticato: la sede della
Società. Di qui si organizzano per il popolo le veglie come quella
di stasera, che echeggiano poi a lungo nella memoria di tutti: di
qui si guida e si governa tutta la vita comune, amministrando i
templi, le scuole, le aziende. La Società Hindu Mata Dharma Paripalana offre al villaggio previdenza e bellezza.
M'accoglie una stanza linda e disadorna dove sono accosciati o
sdraiati i dirigenti. Mi spiegano, parlando a turno, che l'accesso
alla Società è aperto, le cariche sono elettive; vasti palmeti ne formano il patrimonio e permettono di mantenere le scuole e un collegio universitario, una biblioteca, un dispensario oltre ai due
templi che ho visto. Da 88 anni dura la Società, e offre al villaggio
sussistenza, conoscenza e gioia. Il corpo dell'uomo vuole cibo, la
mente assiomi, l'anima estasi; l'estasi è data dagli spettacoli come
quello che sta per incominciare; gli assiomi sono ricavati dall'insegnamento del fondatore della Società, la cui statua si alza nel padiglione, laggiù, nel piazzale sottostante: Guru Nàràyana.
Egli nacque nel 1854 in un villaggio come questo, Chempazhandy, in una capanna dal tetto di fronde di palma, ornata del
pepe rampicante, in un folto di palmizi e di manghi accanto alle
risaie rallegrate dai bianchi voli delle gru. Suo padre era un contadino, ma anche un rustico praticante di ayurveda, conoscitore
d'un po' di sanscrito, espositore ai compaesani dell'epica, e astrologo. Assimilata la dottrina paterna, Nàràyana andò di scuola in
scuola imparando le scienze comuni e infine si ritirò in una caverna fra i monti per approfondire l'alchimia e lo yoga segreto.
Quando ridiscese a valle, un seguito di discepoli gli si mise alle
calcagna e con loro girò l'India del Sud, componendo poesie in
sanscrito e in malayalam, insegnando l'antica, sempre uguale, inesauribile dottrina, l'advaita Vedànta: ogni contrasto che possiamo
immaginare è illusorio, ogni antagonismo una trappola per chi voglia raggiungere l'Unità, senza la quale il molteplice, coi suoi mille
contrasti, non avrebbe neanche quella parvenza di esistenza che
ha. Così ripeteva trasognato: fine dell'uomo è l'Unità, la Quiete,
ogni cosa o serve a raggiungerla o è un inganno. Qualunque idea è
soltanto un appoggio (upàya), va usata per andare oltre, senza aggrapparsi ad essa. Nàràyana poteva perfino deriderla, trapassarla
con la lama glaciale di un Voltaire, come poteva altresì sciogliersi
in incendi d'amore per Dio come un San Francesco. Ogni atteggiamento era per lui un mezzo in vista della pace, dell'affrancamento da tutte le possibili contrapposizioni. Se l'ateo straccia le
devote formule perché gli paiono dei ceppi, se il devoto cerca la liberazione dai comuni sentimenti concentrandosi nell'amor di
Dio, ciascuno di loro, dal punto in cui si trova, tende al medesimo
fine, che gli appare per la diversa angolazione a distanza.
Da questo cielo metafisico in cui Nàràyana viveva, calavano
talvolta irrisioni, particolari dileggi, per esempio egli si faceva
beffe dell'opposizione fra le caste alte e gl'intoccabili, sicché i discepoli fondarono una Società, quella che ora regge Muthakunnan, appunto, la quale ha per motto il verso del maestro: «Una
casta, una fede, un Dio». Il maestro non poteva identificarsi con
qualcosa di profano, ma i discepoli sentivano di avere un destino
attivo e vollero organizzare fuori dalle caste certi villaggi, che a
poco a poco furono interamente retti da loro. E fra loro mi trovavo, mezzo secolo dalla morte del maestro, avvenuta nel 1928.
M'accorsi, via via che la serata trascorreva, che l'insegnamento
sopravvive intatto, anche nelle sue parti più ardue e riposte. Entrò
nella sala un giovane irsuto, dai movimenti bruschi, e mi pose alcune domande dottrinali. Le risposte gli parvero sufficienti, e di
punto in bianco prese a mostrarmi certe respirazioni alle quali
pochi, poco noti trattati di yoga fanno scarsamente cenno. Indovinò ciò che mi premeva e si addentrò in certi punti mal decifrati
dei classici dello yoga, specie sui rapporti fra yoga e alchimia. Via
via che parevo assimilare gli insegnamenti, gli altri, ridendo, mi
recavano frutti tropicali, dolci di riso, miele e cocco, mi arrotolavano foglie di bètel. Diventarono sempre più allegri, le risate si alzarono fragorose. Scherzano, i discepoli di Nàràyana, su tutto,
anche su ciò che altrove vuole visi compunti e devoti, scherzano
con la stessa interezza con cui consacrano.
L'ospitalità, la franchezza meravigliose mi soverchiarono. Volevo
tentare un gesto minimo qualsiasi, non per ringraziare, ma per
contribuire a ciò che essi facevano. Domandai a quei reggitori,
guardiani, per dirla con Platone, della tropicale Città del Sole, se
nel villaggio ci fosse qualche povero, se potevo affidare all'elemosiniere qualcosa. Senza cambiare espressione dissero ad un ragazzo di portarmi il libro dei conti. Il bilancio della Società era in
forte attivo, non c'era nessuno da soccorrere. Risposero così, con
aria distratta, con la noncuranza di chi fa tutto per gioco, come gli
dèi del kathakali danzano le figure fondamentali, gli archetipi
della vita.*
* Come ho trovato la Città del Sole, «Corriere della Sera», 3 marzo 1979.
Yoga balinese
Lo yoga balinese è diverso da quello indù; è inoltre di difficile accesso perché a Bali non esistono monaci itineranti, maestri come
in India (qui guru vuol dire soltanto professore, e ashram è soltanto il collegio universitario).
Nei testi scolastici di Agama hindu Bali («religione indù di
Bali») si offre una bella, chiara serie di concetti: lo yoga estatico
(yogasamàdhi) consiste nei seguenti momenti: il distacco da tutto
e il diritto totale in se stessi, la meditazione sull'origine di tutto
(,dhyàna, donde il giapponese zen), infine la concentrazione
prima sul respiro e poi sul battito cardiaco, in cui ci si perde.
Le opere degli studiosi olandesi come Zoetmoelder, basate
sulla lettura degli antichi testi, paiono tutte un po' sfocate. Perciò
si tenta di giungere alla viva fonte e incomincia un giro in un labirinto, perché lo yoga è studiato soltanto da bramini che si siano
fatti consacrare sacerdoti (pedanda). Ai profani il pedanda è pressocché inaccessibile: per l'intera giornata seduto sull'altare attende ai riti, mormora le formule, esegue la danza delle mani con
cui convoca gli dèi.
A chi sia largito il dono di incontrarlo toccherà una lenta attesa
nel cortile templare: mentre ilpedandaiz incessantemente tinnire
il campanellino a forma di triplice folgore, fra starnazzar di polli e
rovistar di cani tra le offerte sparse per terra, l'occhio a grado a
grado contempla le sfrecciami pagode circostanti, i piccoli altari,
gli alti troni, rigorosamente calcolati secondo orientamento sacro
e simbologia cosmica. E mentre si sta così dimentichi e trasognati, giunge il momento in cui il pedanda ci è accanto. Ha con sé
il quaderno di appunti che raccolse ai piedi del maestro, potrà
forse perfino concedere di trascriverne dei brani.
Prima, essenziale verità: lo yoga rende interiore ciò che è
esterno; fa scaturire dalla propria interiorità il mondo paradisiaco
di Bali. Questa interiorizzazione è ardua da quanto qui è dolce abbandonarsi al semplice fluire della vita, passeggiare per stradine
costeggiate ora da folti d'alberi, talvolta di fragrante cinnamomo,
ora da terrazze lunate di risaie in declivio donde si levano fitti pal-
meti. Ogni duecento metri agli innumerevoli verdi si sostituisce
il cotto delle cinte templari, guardate dai mostri guardiani cesellati nella pietra, con fiori scarlatti simili a passionarle infilati nell'orecchio, se sono divinità non del tutto celesti, cinti di grembiuli
a scacchi, equilibranti il basso e l'alto, la sinistra e la destra.
I villaggi si celano dietro mura, nell'acqua del ruscello di cinta
luccica l'innocenza smagliante dei nudi di giovinette e giovani, lo
scarlatto del fiore, sulla chioma nera gocciarne. È raro che si feccia molta strada senza che venga incontro una teoria di figure regali, e i colori della strada si moltiplicano: sono i corpetti vellutati,
le gonne damascate, le torri di banane e manghi, di foglie di cocco
e dolciumi di riso, in bilico sulle teste. Seguendo la processione si
arriva a una festa, l'annuncia da uno dei templi la musica ininterrotta di litofoni e xilòfoni, e tosto si è fra le are gremite, dentro la
nuvola d'incenso, si riceve l'acqua magnetizzata dal pedanda, ci si
sparge di essa: propizia l'estasi.
Quando si sarà posseduti, il sacerdote minore, non bramino,
domanderà allo spirito in noi chi sia, ed esso, per comprovare la
sua potenza, potrà dire di trafiggere il corpo posseduto: non spiccerà sangue. Oppure si spargerà di braci ardenti: non ci sarà
ustione. Dopo il battesimo d'acqua, quello di sangue o di fuoco.
Tutti gli spettacoli balinesi sono simbolici: a sinistra è il male, a
destra il bene, nei templi come nel teatro d'ombre, a sud è
Brahmà, fuoco, rosso; a nord è Visnu, acqua, nero; a oriente
Iéwara, bianco; a occidente Mahadewa, giallo; a sudovest Rudra,
rosato; a sudest Maheswara, il vento, zafferano; a nordovest
Sangkara, verde; a nordest Sambu, azzurro; al centro della rosa dei
venti colui che è tutti i colori, Siva. Lo yogin deve diventare il
cosmo, il tempio da cui tutto emana. È Visnu, Colui-che-sostenta:
la catena montana del nord dalle cui viscere sorgono le acque irrigue, corso dai fiumi del sangue, è anche lo yogin, sparso dei laghi di
adipe, con un suo segreto respiro, e Visnu s'incarna nella sua cistifellea. Ogni vessillo, nastro, drappo nero agli altari è lui.
Lo yogin è Brahmà, il fuoco che compagina ossa, carne, nervi e
si concentra nel fegato. Lo yogin è Rudra, il suo stesso stomaco. È
Maheswara, come punta del suo cuore. Lo yogin è Iswara lunare,
come suo cuore e sua narice destra. Lo yogin è Sambu nei suoi polmoni, è Sangkara nel suo sesso. Al centro delle direzioni egli è
Siva, la stanza più piccola del cuore, il lobo centrale del fegato.
Bisogna sentire, rappresentarsi nel corpo e nella psiche le correnti d'energia proprie di ciascun dio. A ogni sillaba corrisponde
un dio, ogni mattina si attribuisce la sillaba giusta alla giusta parte
del corpo e della psiche. Ma se si vuol fare sul serio, tutto ciò
dev'essere dato per scontato.
Si procede con la totale concentrazione della mente sul respiro,
che bisogna immaginare calante al suono di Ah fino all'ombelico,
dove accende il fuoco, Brahmà, e quindi lo sospinge in alto fin nel
cranio a bruciare ogni impurità sul percorso, e si esala Am.
Cosi purificati, incomincia l'opera massima.
Un digiuno di undici giorni è segnato dapprima da reiterate
riunificazioni e disgiunzioni di sole e luna, il femminile e il maschile, finché si entra in uno stato di sogno costante. Ora ciò che
si vuole vedere si vede, e ci si rappresenta il proprio corpo come
una Bali ancor più complessa di quella geografica. Ormai la fantasia è liberata, si lavora con essa come con un kriss sulla vittima
sacrificale. Se non è bastato il lungo tirocinio a porre in questo
stato di visione, si può anche aiutarsi bevendo, durante il digiuno,
dcWarak, tenendo gli occhi chiusi e lo sguardo deviato a sinistra;
la prima visione che emergerà della Bali visionaria ed estatica sarà
una pietra, situata tra gli occhi, sede della concentrazione.
Di 11 la fantasia ebbra e precisa partirà in ricognizione per
monti, fiumi, stagni, pianure. Il maestro già ne ha dato un rifinito
ragguaglio. Dopo questa esperienza lo yogin sarà in grado non soltanto di compiere questo viaggio in se stesso ma di farlo nel paesaggio interiore altrui. Quando vuole esaminare qualcuno lo
ubriacherà un poco, gli darà del tabacco forte e lo metterà accoccolato davanti a sé, ordinerà di chiudere tutti i sensi, ingiungerà:
«Vedi il fiume e l'albero! Bàgnati nel fiume». Cosi viene trasmessa
agli altri almeno una parte della conoscenza intimissima del proprio corpo, della propria psiche, del mondo degli dèi.*
* Yoga a Bali tra sogni e digiuno, «Corriere della Sera», 16 febbraio 1978.
***
Passavo parecchio tempo, a Bali, osservando i bramini recitare le
loro lunghe litanie. Di diverso, rispetto ai rituali quotidiani dei
bramini indiani, è il fine che si propongono. In India i riti si eseguono perché la tradizione lo vuole e perché essi rinsaldano la psiche e purificano l'officiante, ma si ritiene che la loro efficacia sia
autonoma da ciò che avviene nell'officiante o nello spettatore.
Come si diceva della Messa cristiana: essa agisce in forza di ciò che
si opera (ex opere operato).
A Bali sopravvive una teoria che credo anteriore, primigenia: il
rito è efficace se produce l'effetto di un raptus. Il dio deve scendere
nell'officiante, producendo in lui uno stato diverso dal normale:
una potenza diversa da quella ordinaria gli s'insedia nel corpo e
soltanto a questo patto si ritiene che il suo gesto di benedizione
tracciato sull'acqua la renda sacra, magnetizzata, battesimale, tale
che trasmetta a chi se ne bagna qualcosa dello stato «divino» dell'officiante. La religione balinese è chiamata «religione dell'acqua
consacrata».
Un giorno, mentre osservavo le varie fasi della preparazione, i
preliminari alla transe di un officiante, mi venne in mente la spiegazione di tutto.
Come insegnano i trattati yoga indiani, anche a Bali si dà un
valore simbolico alle singole sillabe. Quando la consonante è nasale, la sillaba si riferisce al vertice celeste del cosmo, e via via calando verso la materia i vari piani dell'essere sono rappresentati
dalle consonanti gutturali, palatali, dentali, labiali. Le fauci e la
bocca sono come la Sfera del cosmo, il suono che si forma in
quella o quella loro parte indica una gradazione della realtà, da
quella massima, potenziale, fino alla minima: materiale, transeunte. Quindi ogni sillaba corrisponde a una divinità, a un archetipo del reale.
L'officiante balinese attribuisce a ciascuna parte del corpo la
sua sillaba, perché il corpo è il modello dell'universo.
Ogni mattina l'officiante ripete l'attribuzione delle singole sillabe-divinità alle singole pani e funzioni del suo organismo e nello
stesso tempo si raffigura queste sue parti e funzioni come luoghi di
un paesaggio ideale che riassume tutte le realtà possibili.
Fin qui si tratta di una dilatazione psichica, che produce una
sua estasi, onde si cessa di essere chiusi in se stessi, per sentirsi
tutt'uno con il cosmo. Si diventa i singoli dèi con le singole parti
del proprio corpo (e della propria psiche, perché non si distingue
il corpo dalla percezione, dal sentimento che lo riflette). Compiuta la perlustrazione e l'attribuzione, addirittura ci si identifica
con il Dio supremo, in un totale oblio di se stessi.
Fin qui niente di nuovo, si è precisato il modo in cui si ottiene
l'effetto estatico, che è il fine del rito.
Ma mi avvenne di ricordare, una mattina che stavo osservando
il rituale, un noto esperimento sui riflessi condizionati.
Il riflesso condizionato può essere semplice: una funzione del
corpo si condiziona a un fenomeno esterno qualsiasi. La dilatazione o restrizione della pupilla, involontaria, è prodotta dall'intensità maggiore o minore della luce; se si fa coincidere per un numero sufficiente di volte il suono d'un campanello con l'accensione del lume, la pupilla si dilaterà o stringerà, anche al mero
suono del campanello. Ma il gioco si può complicare, se ci si abitua a dirsi: «dilata!» o «stringi!» ogni volta che suona il campanello, si finirà col poter dare ordini direttamente alle pupille, facendole dilatare o stringere a volontà. Lo stesso vale per le altre
funzioni involontarie del corpo.
Che altro compie il bramino, se non un allenamento a condizionare a certi suoni certi stati del corpo e della psiche? Dopo una
lunga pratica quotidiana viene il giorno in cui una certa condizione e sensazione di un organo corrisponde di fatto all'immagine
mentale e alla sillaba che vi si è ripetutamente associata. La sequenza dell'estasi diventa un processo controllato dall'emissione
dei suoni «sacri». Le formule magiche o mantra agiscono anche
sulla muscolatura involontaria, sull'equilibrio ormonale: mettono nello stato specifico a cui si mirava. Rispetto ai rapporti con
altri, una certa intensità ipnotica, una pienezza, un'euforia o suggestiva gravità si possono cosi indurre volontariamente pronunciando i mantra.
Ciò avviene con tanta maggiore facilità e forza perché il condizionamento non è un semplice atto meccanico, una cupa ginnastica, come sarebbe un allenamento freddo, di laboratorio. Il sistema dei suoni, delle sillabe sacre e delle immagini divine corrispondenti forma un modello del cosmo in cui tutto rientra, che
lega l'uomo all'universo, spezza la barriera tra l'io e il non io. C'è
di più: questo Quadro del Mondo in cui si entra accogliendo il sistema teologico indù-balinese, è bello, è il criterio infatti del
Bene, del Bello e del Vero. Queste classiche tre qualità supreme in
una civiltà come la balinese sono il fine massimo, non già da rinviare al futuro o da relegare fra gli aridi concetti, bensì qualcosa di
vivo, che si attinge ogni volta che si tocca l'estasi, e che si custodisce dentro di noi, nel cuore del cuore, allorché si dimora, come si
dovrebbe sempre, in uno stato di quiete contemplativa. La civiltà
balinese è tesa a rafforzare la quiete nel cuore e la possibilità di accedere all'estasi. Perciò, a differenza delle civiltà moderne è razionale: si dà un fine e fornisce i mezzi per raggiungerlo. Noi non abbiamo fini ma motti che non resistono a un attimo di riflessione
o di analisi logica o di attuazione immaginativa un po' realistica.
A Bali il fine estatico-contemplativo è l'esperienza più comune,
offre un centro. Ciò che a noi da secoli manca, disperatamente.
L'allenamento a evocare in sé la massima estasi, ad attuare il
fine supremo che tutto giustifica, ma attorno a cui tutto può e
deve ruotare, è lasciato a coloro che ne sono capaci, ai «consacrati», che rinunciano alla vita di minute distrazioni per attingere
questo vertice, ogni mattina confermando le associazioni che
fanno del loro corpo e della loro psiche una tastiera su cui il suono
delle sillabe sacre può intonare la sinfonia globale del cosmo.
Le povere preghiere, i poveri gridi magici delle civiltà dove quest'arte è scomparsa sono quello che sono: rottami, tentativi di
riattingere una completezza smarrita. Qui viceversa vige la razionalità perfetta: l'estasi è a disposizione, l'armonia col cosmo saldamente stabilita. Si può spiegare perfino in termini di laboratorio pavloviano.*
* Che beato quel bramino, «Corriere della Sera», 17 novembre 1978.
Nuove terre cieli nuovi
***
Un giorno a Bali la figlia d'un sacerdote pemangku, un maestro di
cerimonie non bramino e all'occorrenza esorcista, venne ad annunciarmi per la notte successiva una gran veglia cerimoniale in
uno sperduto tempietto oltre la risaia vicino alla quale abitavo.
Sorrideva e per invogliarmi disse:
«Forse danzerò.»
- Perché forse?
«È mio padre che officia. Puoddarsi che non voglia che sia sua figlia a danzare.»
- E quando cominceranno le danze?
«A mezzanotte. Forse.»
- Che danza sarà?
«Una danza seria. Non roba rozza come il ballo delle rane, a cui
l'ho vista assistere.»
- E qualcuno andrà in transe? - usai l'espressione krauhan dewa,
«possessione da pane degli dèi». Non rispondeva, guardava altrove. Provai le espressioni che conoscevo in indonesiano: — «Ci
saranno dei chajal chajal, dei muti suri («delle allucinazioni»,
«delle morti apparenti»), e si decise a dire:
«Forse.»
- A quale dio è dedicata la festa?
«È la festa del tempio.»
- Non ci sono mai entrato. Quali altari ci sono?
Tornò a sorridere con garbo: «Ce ne sono tanti. Ci sono quelli
degli dèi: Brahmà, Visnu, Siva. A sinistra, ma davanti a tutti gli
altri, c'è quello deipitra».
Quando se ne fu andata, provai a decifrare la conversazione.
Quando avevo domandato se ci sarebbero state possessioni da
parte di dèi, aveva taciuto. Quando l'avevo interrogata sul dio cui
era dedicata la liturgia, aveva deviato il discorso. Aveva insistito a
dire che stava in prima fila, sia pure dal lato sinistro, infausto, l'altare dei pitra\ i mani. Una cerimonia in onor loro mi attraeva
poco, non ci tenevo a frequentare quei morti ancora affamati di
carne di maiale e di cipolle, assetati di ruvido vino di riso, i morti
tuttora sottoterra a fermentare.
Andarci o no, alla veglia?
Feci una passeggiata per il villaggio e scoprii che nessuno era al
corrente di nulla, neanche i mercuriali ragazzi che gravitano, autisti, guide, ruffìanelli, attorno agli alberghi e alle boutiques. Forse
valeva la pena d'andare?
Calò la notte, se volevo recarmici spedito l'indomani, era meglio assicurarmi della strada. Sarebbe stata ancora una notte di
novilunio. In sanscrito si dice krsna pàksha: «l'ala nera» dell'uccello che è il tempo, il quale ha due ali, la nera appunto, e la
bianca, del plenilunio. Queste notti le stava covando l'ala nera.
Neanche la risaia attigua al sentiero scorgevo; la tenebra compatta
mi comprimeva, era come se la stessi fendendo.
Il viottolo prese a serpeggiare, avvertivo dei fogliami sopra il
capo. Fui finalmente a un bivio, alzai la torcia e sopra uno zoccolo
vidi la statua d'un dèmone nano, zannuto, con occhi sporgenti.
Gli avevano allacciato alla pancia un grembiulino a scacchi nuovo
di bucato. Il bianco e il nero promette l'equilibrio di sinistra e destra, di dèi e dèmoni. A sinistra un sentierino scosceso si diramava
verso una bassa, maleodorante sodaglia.
Il recinto templare era profilato dalle fiaccole che ardevano all'interno, ne luccicavano le pozzanghere vicine. Laggiù i cani mi avevano annusato e le loro ombre guaiolanti, abbaiami sfrecciavano
come impazzite all'ingresso del tempio. Vi si delineò, chiamato
dal loro strepito, il sacerdote, che si curvò per scrutare meglio nel
buio, e tornò subito indietro; doveva essere indaffarato a preparare la festa. Anch'io tornai sui miei passi. Le voci dei cani si estinsero, mi ritrovai nel completo silenzio, solo con il cerchiolino
della torcia avanzante nella polvere.
La sera seguente m'era passata la voglia di andare. Nel ricordo
mi appariva sinistro il lingueggiare di fiaccole dal recinto in fondo
al declivio, il loro riflesso rossiccio sulle pozzanghere, l'uggiolìo
doloroso, l'abbaiare feroce dei cani templari, cani dei morti, cibati di offerte ai dèmoni.
Stavo sdraiato sull'amaca, quando all'improvviso mi fu davanti
la figlia del sacerdote, slanciata nella lunga gonna rossa damascata
di fiorami e di steli attorcigliati, tutta altera nel suo corpetto smeraldino. Portava un fiore scarlatto all'orecchio, i capelli corvini le
cadevano sulle spalle brune, incorniciando il volto corrucciato.
Taceva piena di rimprovero. La curva del labbro era imperlata di
sudore, mi sembrò perfino che tremasse.
In disparte, lo sguardo a terra per discrezione, ma accigliato,
partecipe dell'offesa, un ragazzo da cui s'era fatta accompagnare,
anche lui agghindato a festa, con il turbante scuro, la camicia candida, la gonna di seta.
Cosi mi trovai a rifare dietro di loro la strada della notte precedente. Ma adesso dal tempio tutto sfavillante si alzava un fitto
vocio; due automobili s'erano cacciate addirittura in fondo al declivio e stavano parcheggiate di sghimbescio fra le pozzanghere.
Un crocchio d'uomini era accoccolato davanti all'entrata del tempio, alcuni si tenevano stretto al petto il loro gallo. Uno soffiava in
bocca al suo per irritarlo e fargli sbattere la coda fastosa, che sembrava una girandola. In piedi, con un goffo sorriso di disagio, due
coppie australiane.
Lafigliadel sacerdote s'accorse che distoglievo la faccia da quella
adunata e rimediò gettandomi un sorriso d'intesa, facendomi
cenno di seguirla. Si aggirò l'edificio di fianco, saltando sopra una
pozzanghera, si costeggiò il muro del tempio, finché apparve una
porticina laterale. Dentro ci accolse un barbaglio di torce, un mulinare di donne in vesti sfarzose, strette in corpetti dorati, turchini,
verdi, arancione. Ognuna aveva portato in bilico sulla testa torri
di pasticci di carne, di torte di riso, di frutta incastellati da foglie
di palma intrecciate. Dalla pedana dove benediceva l'una dopo
l'altra le offerte rovesciate ai suoi piedi dalle donne, il sacerdote
balzò giù reggendo uno scodellone d'acqua benedetta, che mi
versò ridendo sulle mani a coppa. Indugiai a lavarmele e quindi a
cingere la fascia rituale. Rispondevo ai benvenuti, rinfrancandomi dopo la ventata di brutalità che poc'anzi mi aveva sfiorato.
Erano belli gli altissimi pennoni sacri, gli ombrelloni dagli orli
sfrangiati eretti in onoranza degli altari, adorni di stoffe bianche e
/
rosse (Siva e Brahmà), bianche e nere (Siva e Visnu). Quando alitava un po' di vento, garriva dal pennone maggiore lo stendardo
di tutti gli dèi, fatto di nastri rossi, bianchi, gialli, verdi, azzurri.
Sedetti sotto la pedana sacerdotale, di fronte alla fila di altari.
Accanto a me un uomo stava sistemando un cembalo.
«Vede, arrivano i musicisti» mi disse la ragazza sedendomi accanto. «Forse suoneranno.» Traboccava di gioia. Mi disse perfino
una frase in inglese: «Later Ishall notbeableto keepyou company, because Ishall be sacreòr. Come mai sapeva cosi bene questa frase cosi
insolita? Aveva l'aria di essersela mandata a mente, di averla già adoperata: «Fra poco non potrò più farle compagnia, perché sarò
sacra». Quando si alzò mi misi a scrutare minutamente il turbinio
dei colori. Mi sfioravano i cani sfrecciami avanti e indietro; animali
inferi, sono loro tutte le offerte sparse per terra per tener buoni i dèmoni, i bhuta, le cui effigi bestiali guardano ingressi, trivi e bivi.
Percorse il tempio un uomo con un gallo magnifico in braccio.
Andò dritto all'altare dei pitra, estrasse dalla gonna un'ascia ricurva, troncò di netto la coda variopinta. Le piume volteggiano
prima di posarsi nella polvere; le stille di sangue la terra le assorbe
all'istante, piacciono ai dèmoni, sono sangue sensuale e rabbioso.
Con un sorriso spavaldo e maligno, con l'animale sgomento raggomitolato in braccio, l'uomo esce. Ha diffuso nel recinto come
un vapore freddo e appiccicoso, che sporca tutto. Ha compiuto il
sacrificio ai dèmoni, bhùtayajna. La dottrina insegna che i bhùta
sono faville sprigionate dall'essere universale (mahàbhùtah), e
l'uomo nella sua parte infima è tutto un intersecarsi di scintille.
C'è chi le riassorbe nel fuoco interno, nel cuore, grazie al raccoglimento, e vive cosi ardente e assorto. C'è chi viceversa cova uno
scoppiettio ininterrotto, disordinato come di brace, sprizza stizze,
brame, e sorride duro, protervo come quell'uomo.
Alcune donne fanno l'adorazione davanti agli altari celesti,
stanno inginocchiate, tendendo le mani aperte, facendosi irrorare
di acqua benedetta, bevendone dall'aspergillo di cocco a forma di
barca. Alcune ragazze si stringono l'una all'altra, prendono cosi
strette a ondeggiare avanti e indietro, quindi, guidate da una di
loro, intonano una polifonia lamentosa e infinita.
/
Sono preludi a ciò che stanno ora facendo un uomo e una
donna davanti all'altare dei pitra. Accendono un fuoco non di
legni profumati, non di erbe, ma di sterpi dall'aspro sentore. Le
volute di denso fumo si levano, si piegano e investono tutti, avvolgendo in una caligine fetida. Tutti paiono accettare di buon
grado: si deve essere affumicati dal fumo dei pitra.
L'omaggio agli dèi è terminato, i pitra sono ormai al centro
della festa. Una vecchia si appoggia al loro altare, ondeggia, gira
su se stessa, le si invetria l'occhio, si guarda attorno con insistenza
feroce. Mi è di nuovo accanto la figlia del sacerdote, le labbra sull'orecchio, umida, tiepida sussurra: «È lei che andrà in transe.
Forse».
Il fumo si è disteso uniforme ed è alimentato senza tregua, chi
attraversa l'area sacra lo fende e ricaccia in riccioli e mulinelli.
Scopro che si può anche respirare, se si è parchi nel tirar su l'aria.
Nessuno tossisce. Una donna aggiunge sterpi su sterpi all'altare
dei pitra. Un'altra vi sistema coppette di vino di riso. Lo sguardo
mi cade in basso, si fissa sulla polvere calpestata dai piedi nudi,
dalle zampette. Grida di scommettitori da fuori, il coro riprende
o cessa a caso, qualche colpo sul cembalo. Mi alzo di scatto, sono
oltre la porta nel buio, giro al largo del crocchio di uomini accoccolati, delle due coppie di australiani che adesso ridono familiarizzati, sgangherati, salto le pozzanghere e in pochi balzi sono in
cima all'erta. Finalmente imbrocco il sentiero del ritorno. I rumori si sono smorzati. Veloci corrono i passi sulla polvere invisibile, nella notte fonda. Guardo con improvviso amore gli astri incredibilmente sfavillanti.*
* Tra i demoni e le scintilli, «Corriere della Sera», 26 luglio 1978.
Spiriti belli e Buddha dorati in Birmania
Nel suo trattato sullo Sciamanesimo Eliade omise due tradizioni:
oltre alla coreana, anche la birmana. La prima mi riuscì di penetrare, ma la seconda ancora mi è preclusa. Il socialismo locale isola
il paese, ed è forse un bene: dà visti per una settimana, che appena
basta a una visita frettolosa, mentre per accedere ai rituali ci vuole
tutt'un'arte sorniona di digressioni e appostamenti.
Ma una via d'accesso ho trovato, diventare il fido uditore della
massima esperta, Sarah Bekker, che nel paese soggiornò a lungo
ed ora vive tra i suoi cimeli, coccodrilli-mandòle, arpe a barca,
tamburi a clessidra in pietra nera, statue di spiriti e Buddha dorati, nel suo quartierino, a New York, sull'East River scintillante
che via via s'abbruna con lo scorrere lieve delle ore; da lei ho fatto
paziente incetta di notizie e di aure ben conservate da un'amorevole memoria, storie di sciamane e di alchimisti in ciò che fu sino
al 1885 l'Impero Birmano.
Qui come in Corea lo sciamanesimo sopravvisse tollerato ma
disprezzato dal buddhismo. Alle anime belle (come si dice in birmano) continuarono e continuano ad essere tuttavia attratti gli
spiriti, e le mettono in transe per farne le loro amanti. «Sposa di
uno spirito» è il nome delle sciamane e dei più rari sciamani. Ad
un primo incontro, in transe o in sogno, con uno spirito, seguono
gli sponsali, quando in segno di fidanzamento si beve dell'acqua
pura, un atto solenne
che preserva dagli assalti troppo irruenti e sregolati del celeste
amante. Appena possibile si festeggeranno le nozze, che vogliono
un costoso corredo, costumi cerimoniali, offerte di cibo e incenso,
l'ingaggio d'un'orchestra esperta di musiche per spiriti, l'affitto
d'un «palazzo di spiriti» e infine l'opera di sciamani celebranti.
La cerimonia mira a legare al corpo l'anima-farfalla in modo che
non vada più errando, fantasticando, ma rimanga ferma a disposizione delle celesti visitazioni. Il celebrante maggiore avvince l'anima-farfalla, la sposa dello spirito, mostrandole uno specchio in
cui si vede riflessa, e strusciandole poi lo specchio su tutto il
corpo; le lega quindi i polsi e le caviglie, le incrocia sul petto una
cordicella e nella crocchia le infila un ago col refe incrunato. La
sposa consuma infine il matrimonio eseguendo una danza in
transe.
L'idea dominante della possessione erotica da parte d'uno spirito fa dello sciamanesimo, nell'opinione di molti, una prerogativa di donne leggere e di uomini effeminati; il ragguaglio del capitano Alexander Hamilton, nel 1710, parlava di balli frenetici di
«ermafroditi». Ma nella realtà osservata dalla Bekker tutto è
straordinariamente elastico e fluido. Valga il caso da lei raccolto di
Ko Maung, posseduto dalla «Madre» che abita il cono vulcanico
Popa.
Andò così: un giorno egli volle offrire dei fiori ad un'attrice che
stava girando un film sulla «Madre del Popa», ma come fece per
porgerli, cadde svenuto. A giudizio degli astanti l'attrice in quel
momento doveva essere ancora posseduta dalla «Madre». A questa Maung dedicò una statua e, durante la cerimonia indetta per
consacrarla, fu posseduto per la prima volta, eseguì in transe la
danza della «Madre». Tornò periodicamente a eseguirla, con impeccabili movenze: aveva «perduto la sua vita umana», e danzò
anche per altri spiriti che via via lo possedettero, sia maschili che
femminili. Sempre si fece un punto d'onore di non indossare mai
abiti da donna, di non confondersi con la gente di sesso ambiguo.
Eppure, soggiunge la Bekker, i suoi subitanei entusiasmi e affetti
non sono certo la regola virile birmana.
Gli spiriti che più di frequente possiedono le anime belle sono
i 37 nat\ coloro che nella storia del paese più ingiustamente soffrirono e trovarono morte violenta, sicché ancora vanno errando
nell'aria, forze convulse che scatenano danze, dettano oracoli,
ispirano musiche appassionate, a contrasto con la modestia e la
quiete buddhiste.
Spetta un rango al di sopra delle spose degli spiriti agli alchimisti, eredi d'una religione anteriore a quella attuale instaurata
nel 1066, e di stampo più affine al tantrismo. L'alchimia si chiama
aggiya, «lavoro col fuoco» e insegna, in un gergo immaginoso, a
trattare il mercurio e il ferro in modo da ottenere delle palline
d'un metallo alchemico, capaci di conferire poteri perché impregnate di «materia prima», la sostanza incorruttibile che sta al di
sotto degli elementi visibili e tangibili. Ma ottenere queste palline
o pietre filosofali è soltanto la prima fase dell'opera.
Segue la fabbricazione mediante le palline di composti che si
ingeriscono e provocano un coma di una settimana, durante il
quale l'alchimista deve essere sepolto senza contatto con l'aria.
Pericolosa settimana! Il suo corpo è fragrante, chi lo mangiasse
acquisterebbe i poteri, occorre perciò che un discepolo stia in
guardia, facendo invocazioni sulla sepoltura. Passato il periodo di
morte apparente, l'alchimista risorge, lascia in dono al fedele discepolo la pallina, di cui non ha più bisogno essendo lui stesso
ormai una pietra filosofale, e diventa un uomo dei boschi: godrà
d'una eterna giovinezza, vivrà senza cibo, i suoi desideri ardenti
non li potrà soddisfare con donne normali, dall'odore di carne,
perciò tramuterà in donna certi frutti dell'Himalaya. La sua vita
sarà un perpetuo incanto. Un drammaturgo del secolo scorso, U
Kyin U mise in scena un uomo dei boschi che canta le meraviglie
della natura. «Guarda i fiori, la cascata, il ruscello, lo stagno, i
ciottoli, la rena color dell'argento. Cresce il muschio verde sulla
rupe, scorre la verde acqua sul sasso. Non brucia il sole di mezzodì
fra questi alberi fitti, alcuni allacciati come amanti, altri solitari
[...]»•
Fra le leggende di alchimisti va ricordata quella del lavorante
che per la disperazione dei suoi fallimenti si cavò gli occhi e ordinò all'apprendista di gettare nel cesso la pietra incompiuta. Ma
nella notte il cesso diventò fulgido: glielo dissero ed egli capì d'aver letto male il trattato; non andavano usati gli acidi {chili) ma il
fimo {chu). Allora fece ritirare dal liquame la pietra, finalmente
giunta alla perfezione, e recuperò la vista mettendosi nelle orbite
vuote l'occhio d'un toro e quello d'un caprone, che all'applicazione della pietra divennero i suoi nuovi occhi, spaiati.
Fece fondere il piombo e il bronzo disponibili e mercé la pietra
ne cavò argento e oro, consentendo al re di erigere la selva di templi dorati a Pagan. Egli raccolse infine sul cono vulcanico di Popa
le erbe necessarie, le polverizzò con la pietra e le mangiò, trasformandosi in uomo dei boschi. Il discepolo non le potè mangiare,
perché a lui sembrarono brandelli di carne umana insanguinata.
Frutti dell'Himalaya tramutati in donne, «Corriere della Sera», 14 gennaio 1987.
«Libretti» per sciamani
Le arti che noi conosciamo e pratichiamo sono sfaldature di un'originaria unità dello spettacolo rituale complessivo nel quale lo
sciamano si assumeva tutti i ruoli. Egli concepiva un vasto affresco mitologico e cosmico ed in tale cornice recitava la propria discesa agli inferi e ascensione al cielo, cantando, suonando, danzando contro fondali da lui stesso confezionati, immolando di
persona le vittime sacrificali e suggestionando, guarendo gli afflitti. Via via nel tempo si scollarono i singoli aspetti di questa recita sacramentale e ne nacquero le varie funzioni astratte, separate
l'una dall'altra, spezzettate, del compositore e dell'esecutore, del
poeta e del musicista, del sacerdote-psichiatra e dell'attore, del
ballerino e dello scenografo, del macellatore e del sarto-pellicciaio. In tempi a noi prossimi nessuno ha mai più avuto la forza e
la competenza necessaria a investirsi dei ruoli dell'arte «totale».
Rimase esterrefatta una generazione, quando Wagner osò ripristinare l'unità del poeta, del musicista e del creatore di miti; ma che
cosa era mai il suo ardimento, che parve titanico, in confronto
allo sciamano capace di impersonare, ventriloquo e acrobata,
tutti i personaggi?
Della spettacolarità sciamanica rimangono sparse testimonianze, tracce: i costumi, gli strumenti istoriati, qualche brano
musicale e alcune trascrizioni delle parole, che potremmo chiamare «libretti» delle sessioni. Sono testi grezzi, inameni, ma contengono in potenza ogni forma di poesia: della poesia sono il
seme. Hanno il fascino delle tavolozze pennelleggiate, dei massi
sbozzati, dei brogliacci: sono poesia allo stato nascente.
Per capire e valutare questi «libretti», occorre ricreare l'atmosfera della recita, nella quale i loro stralunati anacoluti, le loro ossessive iterazioni ed enigmatiche metafore assunsero significati
grandiosi. Si è venuta di recente affinando una tecnica della trascrizione che mette a frutto tutte le astuzie della grafica, tutti gli
accorgimenti della lirica moderna per preservare l'incanto rude e
complesso dei «libretti». Due americani, Tedlock e Rothenberg,
ne hanno fornito esempi straordinari, trasferiti quasi intatti sulla
pagina stampata. Dal loro lavoro è venuta emergendo una nuova
disciplina, l'etnopoetica, cui è dedicata dal 1970 una rivista stampata presso l'Università di Boston, «Alcheringa: Ethnopoetics». I
coniugi Rothenberg hanno anche compilato un'antologia dei
precursori e degli attuali maestri di quest'arte nuova (Symposium
ofthe Whole, Berkeley, 1983), includendo Frobenius, Radin, Malinowski e anche il Garda Lorca dello stupendo saggio sul dèmone, Elduende*
Tra i maestri attuali spicca Ruth Finnegan, teorica delle letterature africane per tamburo. Nelle lingue tonali dell'Africa è possibile il gioco per cui il tamburino rulla l'intonazione delle parole e
cosi parla, letteralmente, col tamburo; a scanso di equivoci tra vocaboli di uguale intonazione, sono usate circonlocuzioni poetiche, e ne nasce un idioma arcano, sottilmente imperativo, fatto
per guidare le danze e ideale per recite sciamaniche.
Altra maestra di etnopoetica è la poetessa indiana pueblo Paula
Alien, che insegna a differenziare le frequenti iterazioni: la stessa
frase assume infatti significati diversi secondo la direzione dello
spazio a cui si indirizza. Anche le parole isolate, dette con una
certa appoggiatura, possono assumere un senso speciale; per
esempio chi ribadisse la parola «pentola» a un pubblico affiatato
di Indiani delle praterie, potrebbe far conto su una consuetudine
contemplativa per cui essi ravviserebbero nell'acqua ribollente
nella pentola i neri cumuli del cielo, nel fuoco che la scalda il sole
dardeggiarne, nel lesso che vi cuoce il mondo animale offerto in
olocausto, nel vapore che ne sale l'anima, l'energia vitale che si
trasmette dall'acqua alla nube.
Ancora un maestro di etnopoetica va rammentato. Robert
Thompson, studioso del rapporto fra gesti e icone tra i popoli a
sud del Sahara, specie fra gli Ejagham della Nigeria, i quali eseguono danzando i loro simboli grafici, cosi creando un linguaggio mimico corrispettivo a quello sonoro rullato sui tamburi.
Si è dunque ad un grado di eccezionale raffinamento nella raccolta, nella trascrizione e nell'apprezzamento dei «libretti» scia* Si veda il saggio zolliano sul duerni*fin Garda Lorca, nella sezione Epifanie.
manici di tutte le lingue (parlate, rullate, danzate) nell'area africana e americana. Si è fermi viceversa alle procedure sommarie ottocentesche nell'ambito siberiano e centroasiatico, che pure annovera alcuni dei documenti cruciali, commentati da Eliade e da
Nora Chadwick nei loro classici trattati. Essi si trovano raccolti
nel volume Testi dello sciamanesimo siberiano e centroasiatico (a
cura di U. Marazzi, Utet, Torino). Vi possiamo ad esempio leggere per esteso il capitale Sacrificio del cavallo degli sciamani dell'Aitai.
Dapprima lo sciamano allestisce una tenda dal cui camino
spunta una betulla, la sua scala al cielo, e cantando attira gli spiriti
nel tamburo. Agitando un ramo fronzuto di betulla egli estrae
quindi per magia dai loro corpi le anime del destriero prescelto e
del suo palafreniere, e le manda in alto, verso il cielo, inseguendole a cavalcioni d'un oca di cenci e di paglia. Quando si è rassicurato che le due anime volteggiano nell'etere, toma in terra e immola il corpo del destriero; comincia ora ad arrampicarsi sulla betulla per raggiungere i suoi tre compagni d'ascensione: l'oca, il destriero e il palafreniere; con loro varca le nove o più sfere dei cieli
su fino alla dimora del Signore Celeste.
Si legge a contrappunto un altro rito, la calata nel sottosuolo,
che conduce al dio infernale Erlik Khan (in cui taluno ha riconosciuto il prototipo di Arlecchino).
Questi e gli altri documenti dell'etnologia (mongoli, ugrofinni
e d'altri popoli) sono letture faticose e ingrate (e la versione italiana per giunta non è delle più sciolte), ma alla fine il lettore viene
comunque travolto dalla concitazione drammatica dell'allucinato e allucinante spettacolo.
Chiunque si sia mai interessato ai simboli archetipici, in questi
«libretti» potrà incontrarne la forma grezza e primigenia: lo sciamano «vede» la Vergine Madre della stirpe emergere come fiamma
dal ceppo domestico, ravvisa nel tamburo via via un cervo, un
orso, un cammello, una tigre da cavalcare, mentre il mazzuolo gli
diventa frusta, serpente, vampa; quando cade in transe è come se
s'immergesse sott'acqua, quando esplora le radici infere dell'esistenza sente di sprofondare nella terra come una talpa, quando in-
fine, immedesimandosi in un ritmo di tamburo, cavalcandolo,
s'innalza in cielo, correrà al Lago di Latte, la via Lattea dove ogni
sete si estingue.
Entriamo in un universo dove un'idea si rifrange in miriadi di
immagini e di similitudini e dove tutto, senza tregua, si trasmuta
oniricamente, eppure la struttura visionaria resta immutevole e
rigorosa. L'avventura sciamanica è nel contempo una vigile veglia
e un sogno scatenato, chi la vive prova una frenesia incontenibile,
è premuto dagli spiriti alle spalle, gli vibrano le scapole e la spina,
eppure resta incrollabilmente lucido.*
Dallo sciamano viene ogni forma di poesia, «Corriere della Sera», 24 dicembre 1984.
* Sulla fertilità e l'importanza etnologica degli studi zolliani sullo sciamanesimo testimoniava Romano Mastromattei in Sciamani e neo-sciamani delta Buriazia e della
Mmgolia: appunti di viaggio per Elémire Zolla al Convegno Gli orienti delpensiero di
Elémire Zolla: 1926-2002, Centro Pannunzio, Torino, novembre 2002. Gli Atti del
Convegno sono pubblicati nel fascicolo Elémire Zolla dalla morte alla vita, a cura di
G. Marchiani), «Viator», Rovereto, nuova serie 2005-2006.
Malattie divine in Corea
Seul - Prima di partecipare a una sessione sciamanica ne discorro
con un conoscitore, Dunyun Lee. Insegna letteratura coreana all'Università nazionale e la storia del teatro l'ha portato a scoprire
nel rito sciamanico l'embrione e forse il culmine di ogni rappresentazione scenica. Una conversazione appassionata conduce dove
non si sapeva d'andare: non le forme della recita diventano il nostro tema, ma la radice affascinante e terribile dello sciamanesimo,
il periodo di angoscia e di infermità che sono il preludio d'una vita
sciamanica, di ciò che in Corea si chiama «malattia divina». I predestinati sono costretti dal dolore a cercare l'iniziazione, salvo nel
Sud, dove spesso ereditano le funzioni sciamaniche dai parenti.
Gli sciamani ereditari sono per lo più plebei, i chiamati dalla malattia divina provengono talvolta anche da altra classe.
I patimenti sono intercalati da eventi straordinari. Cosi capita
che una sciamana che non abbia trovato a chi trasmettere i suoi
segreti, prima di morire nasconda i suoi attrezzi liturgici seppellendoli in una caverna. Poco dopo il male divino colpisce una giovane, che si sentirà spinta misteriosamente a scavare nella caverna
e ad adottare il tridente, la sciabola rituali e gli altri strumenti carichi di passato. Le famiglie nelle quali c'è stata una sciamana
sanno d'essere minacciate, fatalmente la vocazione riafferrerà
qualcuno in una generazione successiva. Dunyun Lee mi accenna
alla vita d'una sua confidente sciamana che mi vuole far incontrare: cominciò a patire la malattia a dodici anni e la famiglia temeva che in lei si rifacesse viva una nonna sciamana, che tutti
avrebbero voluto dimenticare. Fu subito combinato un matrimonio, ma il divorzio seguì a ruota. I tormenti crescevano, la giovinetta rifiutava il cibo e non dormiva, finché un giorno si trovò ad
una sessione e si buttò a ballare con l'officiante: era incominciata
la guarigione. La giovane si trovò una iniziatrice ed è oggi una
donna altera e riservata, felice.
Di biografìe sciamaniche mi parla a perdifiato Taegon Kim,
che dirige l'Istituto di tradizioni popolari all'Università Kyong
Hee. Non so, di queste vite, quale sia la più bella.
Quella di Pak Myong-sun? È di Seul, andò sposa a quindici
anni. Poco dopo cominciò a notare che stava vivendo su due
piani. Assisteva un giorno ai riti di un indovino cieco, quando
scorse se stessa, il suo doppio, che accendeva un cero. S'accorse
che se chiudeva gli occhi vedeva danze rituali o cerimonie funebri. A poco a poco i sogni divennero più vividi della veglia, specie
uno, nel quale irruppe nella sua camera una cavalcata di spiriti.
Nei sogni emerse un motivo dominante: un vecchio canuto le
offre del riso, ella ne assaggia e si solleva in volo, trascorre sopra un
oceano dorato o offre nelle aule celesti il cibo agli animali.
Cominciò a provar fastidio del marito, della vita quotidiana.
Durò così, sospesa fra due mondi, fino ai cinquantadue anni,
quando nel sonno si sentì invasata d'un'antenata sciamana, si alzò
dal letto e gridò alla notte dei nomi. I nomi degli spiriti che l'avrebbero visitata da allora in poi. Si mise a scuola da una sciamana.
Cho Yong-ja, figlia d'un austero gendarme, andò sposa a diciassette anni. La divina malattia la costrinse a divorziare. Fece la
cameriera in un ristorante per allevare i figli e farli studiare. Continuava a soffrire, finché ebbe un sogno: stava alla porta del cielo,
una voce le ingiunse di entrare e fu in una sala piena di icone sciamaniche. Giunse un vegliardo con un libro, seguito da un soldato. Il soldato comandò: «Mettiti sul sentiero della luce!». Nei
giorni successivi il soldato continuò a comparirle davanti anche
di giorno. Stava facendo una passeggiata, quando si sentì spinta
dentro a una casa sconosciuta. Si trovò in una stanza dove una
donna cullava un bambino. Al vederla la donna chiamò una vecchia. Questa non sembrò notarla e si diresse all'altare, che prese a
rassettare, per mettersi quindi a fare delle invocazioni. Stava pregando gli dèi di entrare nella visitatrice. Infine le si rivolse e disse
d'aver avuto un sogno, in cui era stata preavvertita dell'arrivo
d'una candidata.
In un tempietto in cui era entrata per caso, ebbe il primo deliquio, e cominciò a vaticinare il futuro dei presenti, finché non
giunse il vecchio padre ex gendarme, a far cessare quel disdoro e a
portarsela a casa di forza. Egli convocò persino uno sciamano che
l'esorcizzasse, ma non ci fu verso. Cominciavano intanto ad ac-
correre coloro che avevano visto avverarsi i vaticinii dati nel tempietto e venne anche per lei il giorno dell'iniziazione.
Le sciamane hanno degli aiutanti sciamani, che vestono da
donna durante i riti. Myong-hun è uno di loro. Era un fanciullo
distratto e vagabondo che preferiva giocare con le bambine.
Amava offrire bicchieri d'acqua pura agli dèi, salutava cerimoniosamente il sole e la luna. Andò a fare l'operaio in una fonderia, finché non ebbe il suo sogno. Una vecchia discesa dalle montagne gli
mostrava un libro, dicendogli che il suo tempo era venuto. Quindi
giungeva caracollando un cavallo che lo divorava. Si sentì maciullato nelle viscere del cavallo fino a essere tramutato e a ritrovarsi
in sella: era diventato uno spirito guerriero. Nel sogno gli fu impartito l'ordine di vestire sempre di bianco. Così fece, e fu un supplizio. La gente si accani contro di lui, gli gettava l'immondizia
addosso per dispetto. Gli toccava rilavare fin tre volte al giorno i
suoi abiti bianchi. Ma la prova lo temprò per i sogni che dovevano
venire.
In uno di essi un generale ballò per lui, dopo di che scesero dal
cielo due corde di seta. Una voce echeggiò: «Se ti mando una
scala, sali!». Salì, avvolgendosi via via attorno al corpo le corde e si
trovò in un'aula del regno dei cieli. Su tre troni sedevano tre re.
Gli gridarono: «Non sei che un uomo!» e lo fecero precipitare
sulla terra. Cadde su una spiaggia dove erano tracciati trenta ideogrammi. Erano i nomi degli spiriti che l'avrebbero visitato da allora in poi. Decise allora di mettersi a scuola da uno sciamano.
Spesso ricorre il motivo della scala al regno dei cieli o della colonna di fuoco, come anche la discesa di stelle in terra, che parlano e istruiscono. La dimestichezza coreana con le stelle sembra
persistere da arcaiche origini pastorili: una popolare canzonetta
d'amore dice: «Sono Vega, vuoi essere il mio Altair?».
A volte i sogni si trasfondono nella veglia e c'è come uno sdoppiarsi della percezione: si assiste al sogno e intanto si va per faccende. Talvolta invece sono gli oggetti più comuni che si caricano
di significato, come quando una donna afflitta dalla divina malattia, mentre traffica in cucina, scorge nella scopa il ventaglio
della danza sciamanica e nell'attizzatoio la bacchetta del tamburo.
L'iniziazione tramuta la povera malata afflitta da emicranie, da
feci sanguinolente, da tremiti e vertigini, in una guaritrice maestosa: della miserella sperduta e dileggiata fa una donna regale,
fiera del suo segreto mandato.
La sciamana sa manipolare la fantasia e l'allucinazione. Spesso
è esperta di erbe e minerali, ma opera essenzialmente con ciò che
noi denominiamo, con incredibile, grossolana vaghezza: «volontà
di guarire», «fiducia», «effetto placebo», «actus medicus». Suggestiona, froda? Provatevi voi a fare altrettanto, a utilizzare come lei
il delirio, le convulsioni, il deliquio. La sciamana dopo l'iniziazione cammina a piedi nudi su spade affilate. Balla e capitombola
con tre spade infilate nella gola. Dopo tre giorni e tre notti di
danze frenetiche è fresca e alacre, e non per un'eccitazione che
debba poi pagar cara. Provatevi voi a frodare le tossine, a strizzare
con frode i capillari della gola e della pianta dei piedi.
Spesso la sciamana dipinge le icone che ornano il suo santuario
domestico. I generali cinesi, gli eroi coreani, le Pleiadi e l'Orsa, il
Vecchio della Montagna, il Drago azzurro dell'est che attrae la
fortuna, la Tigre bianca dell'ovest che scaccia le sventure, l'Uccello di fuoco del sud, la Tartaruga nera del nord. Le icone sono
disposte alle pareti in modo da raffigurare tutte le possibilità, gli
archetipi del cosmo. L'altare invece rappresenta il cielo. C'è un'alzata di sette pesche, a segnare le stelle dell'Orsa, i dolci di riso sono
il sole e la luna: l'essenza dei cibi scesi dal cielo nella benefica pioggia e nella rugiada, questi cibi, incensati e infusi di ritmi dal tamburo che li fronteggia, ritornano, sotto le loro specie apparenti,
alla pura essenza celeste. La sciamana è anche la protoarredatrice
e la protomusicista. Oltre che danzatrice e coreografa, è la primordiale poetessa. Improvvisa liricamente sul copione tradizionale della salita in cielo.
In margine agli arcaici miti, la sciamana diventa narratrice.
Quando racconta la storia del Vento, col cappello a tricorno, gli
occhi da rapace, che scocca una freccia e compare un esercito a cavallo, ne scocca un'altra e tutto scompare. Un giorno il Vento ha
un'ispirazione, corre dalla bella dèa delle nebbie, che già l'ha sognato e la prende fra le braccia. Ma lei ha una sorellina ancor più
vezzosa e la sciamana non la finisce di descrivere i pallori, i tremiti, i sospiri fra il Vento e la sorella proibita. I due alla fine scappano e l'abbandonata nutrirà un rancore inestinguibile.
Oppure: all'inizio terra e cielo erano uniti, poi ci fu uno stacco
e sorsero anzitutto gli astri e poi, nel gran buio cominciarono ad
aggirarsi cani crestati, vacche chiomate, cavalli cornuti, uccelli
parlanti. Dopo molte vicende, si giunse al mondo che noi conosciamo, diviso fra due figli del cielo, è toccato a uno la disgrazia di
reggere il mondo visibile, all'altro la fortuna del regno degli spiriti.
L'epos preferito delle sciamane è la storia di Paridegi, la cadetta
cacciata dai genitori, che li salverà quando le figlie preferite li
avranno abbandonati. Per loro si spingerà, subendo angherie terribili, fino alla montagna sacra che custodisce l'acqua della vita.
Paridegi è la protosciamana, detta anche la «regina dei disprezzati» (o re, perché in coreano non si distinguono i generi).
«Quale religione, che invita a identificarsi con Paridegi!» esclama
Dunyun Lee.
Ilpotere della sciamana è una malattia, «Corriere della Sera», 11 gennaio
1982. Una successiva corrispondenza da Seul, Così si diventa sciamane,
usciva il 25 gennaio 1982.
Fanciulle-cigno e coralli mongoli
In Cina anni addietro m'imbattei in una compagnia di Campani
che andavano a curare i loro affari di coralli con Cinesi che se ne
trasmettevano ereditariamente l'importazione. Nel palazzo imperiale di Pechino figura un albero di corallo in vaso, tra i tesori
più amati.
Presso i Mongoli il desiderio di corallo è ancora più forte. Stranamente troviamo presente tra loro il mare, che soltanto al
tempo dell'Impero Yuan fu accessibile. I clan buriati vantano di
discendere dalla sciamana Asuyigandayan, che si rivolse al cielo e
ottenne di partorire i loro antenati, facendosi impregnare dalla
schiuma del mare. Il mare è legato all'origine dell'uomo. Nel
mare s'innalza l'albero di corallo, simbolo dell'asse terrestre e del
sangue che regge l'uomo. Nel mito greco che sopravvive da noi,
si narra che si raggrumò in corallo il sangue di Medusa, sommo
rimedio, protezione del malocchio che s'incarna nello sguardo
meduseo.
Tutti questi significati sono presenti in qualche maniera in
quella vasta conca al centro dell'Asia, verde e ondulata, patria dei
Mongoli nomadi. Ma se sono migranti i Mongoli, l'idea dell'asse
cosmico è in loro tuttavia insediata. Se si vuole entrare sull'istante
nella loro arte e nella loro mente, basta andare a Stoccolma, dove
al museo etnografico si conserva la tenda che portò in patria Sven
Hedin. L'impressione che emana sconvolge. La falda sollevata
mostra un ambiente chiuso su se stesso, un microcosmo. È circolare, una sfera e ogni mobile, ogni oggetto vi sta disposto tutt'attorno secondo la rosa dei venti, nella direzione che lo regge e simboleggia. La vita del nomade qui s'impianta, il divenire dei suoi
spostamenti porta con sé l'essere invariante. Tornano in mente,
lasciandosi incantare da questo interno statico, le parole di Alce
Nero sulla tragedia che fu per i Sioux dover rinunciare alle loro
tende rotonde per occupare rettangoli mortuari, angolosi.
Credo che da questo insediamento nel padiglione orientato sul
cielo sia partita l'esistenza dei nomadi mongoli. Erano mandriani
marziali e questa professione è sempre collegata a un brivido, a un
potere magico; basti elencare i bùtteri di Maremma, i cowboy
delle praterie, i gauchos argentini, i Valacchi di Macedonia, i
Tutsi del Burundi. I Mongoli, riuniti all'improvviso, si lanciarono su tutta l'Asia e conquistarono l'Europa fino al Danubio,
con una fortuna che sembra arcana.
All'inizio vissero in clan divisi tra loro, soggiogati da sciamane
o sciamani in vesti bianche, cavalcanti destrieri candidi. Erano
loro a vedere nitidamente le fanciulle-cigno e i padri-toro.
Sacrificavano sulla cima delle montagne abitate dagli antenati.
Adoravano il gufo, che i più disprezzavano e di piume di gufo si
ornavano. Sapevano andare a cercare le anime smarrite o già
morte nell'aldilà. Per accingersi a una vita sciamanica allucinatamente si spogliavano delle carni, riducendosi a scheletri.
Acquistavano il potere di ridar vita a un corpo defunto, camminandoci sopra. Per una sciamana l'atto era sbalorditivo, perché
dalla vulva sprigionava un potere nefasto.
Poi sferzavano il morto con le loro fruste o «serpenti di fuoco».
Tutta l'epica antica è ossessionata dalla risurrezione che lo sciamano agevola [...].
L'arte mongola classica è iconica, non mira a infiorare o aggraziare
le forme, ma vuole marcare con forza gli attributi della statua o
della pittura, stampa con nitore le capacità magiche dei personaggi. Come illustrava Ananda Coomaraswamy, addobbi o fregi
descrivono nitidamente determinate funzioni spirituali, ogni
fiore, ogni anello o monile o vezzo del personaggio informa sulle
sue potestà. L'arte dipendeva, come a Bisanzio dai repertori monastici, da trattati tibetani di simbologia ed esecuzione approvati
dal clero.
La libertà che, dopo le icone ancora arieggiami Bisanzio dipinte nella Siena medievale, da noi si impose come guida all'artista, in Mongolia, fu ignorata e tuttora lo è.
L'arte popolare mongola, inserita in questa regola iconica, presenta opere grandiose. Basta l'abbigliamento d'una dama, non
meno augusto di quello dell'ultima imperatrice cinese eternata in
tante fotografie.
I capelli raccolti in due bande ai lati della testa, impregnati di
grasso gelido diventano come corni di pecora selvaggia. Si estendono fino a 40 cm dalla testa, ornati da fermagli d'argento tempestati di coralli. Ai due termini sono infissi fermagli che sospendono ai lati della faccia due cilindri dove s'infila il resto della capigliatura. Anche i cilindri sono adorni di coralli, di broccati aurei
e spirali annodate con coralli e turchesi.
A fianco della faccia cosi incorniciata da due semicerchi pendono due file di coralline o perline a frangia, come accenno ad
una difesa dagli spiriti.
Tutto quest'apparato dipende dall'elmo sparso di coralli che
copre il cranio, lasciando un'apertura per la fontanella cranica,
che all'apice dello yoga diventa l'apertura al mondo superiore.
Due spalline altissime sollevano la stoffa rossa delle maniche,
perché tutto il corpo si deve concepire in atto di innalzarsi. Al
collo pende una gorgiera dorata, su cui si adagiano l'una sull'altra
collane di coralli e turchesi. Le mani stanno infilate sotto le maniche, come fu d'uso per le sciamane. Tutta la figura armata di
corna-ali è sollevata verso i cieli.
La vitalità è testimoniata dal profluvio di coralli.
Fra i pezzi di vestiario femminile attrae il corpetto ricamato in
filo di seta e corallini, con al centro il simbolo cinese della felicità
sempre ripetuto.
Fitti fili di corallini s'appendono all'acconciatura, coralli decorano i fili che reggono porta-amuleti o scritture o mantra, fermati
da un corallo tondo.
Fra gli attrezzi maschili il corallo tempesta custodie di acciarino, con ornati d'argento e coralli rettangolari; le trombe rituali
sono incastonate di coralli e di turchesi; le fodere di pugnali sono
parimenti tempestate. Sempre spicca un corallo a sigillo delle
placche pettorali, armature contro ogni minaccia psichica.
Anche le tonde fibbie d'argento con filigrane portano al centro
un corallo. Vibrano della luce corallina collane e orecchini da cui
spenzolano due bracci d'argento. Gli orecchini di turchesi terminano in coralli o ne sono sovrastati. Un orecchino portano anche
gli uomini: s'attacca al lobo sinistro e ha un turchese sormontato
da due coralli. Dovunque si raccolgono oggettini sacri, scritti, reliquie in scatoline d'argento sbalzato, queste recano, confitto al
centro, un tondo corallo. Negli anelli infine s'incastonano coralli.
In questo popolo devoto all'albero marino si spense ogni progetto imperiale a partire dal secolo XIV. Eppure i Gelugpa che
avevano impregnato il mondo mongolico vi trasmisero un mito
che spingeva a un futuro messianico, l'immagine di Shambhala,
alla cui idea si accede studiando il Kalacakra. Si racconta che fra
gli ascoltatori del Buddha Sakyamuni ci fu il re di Shambhala,
paese a nord del Tibet. Egli tornò in patria e applicò con rigore
gl'insegnamenti ricevuti.
Taranatha (1575-1634) tradusse una guida di Shambhala.
L'invocazione di quel regno che sarebbe stato redentore in un futuro sempre prossimo diventa costante per tutta l'Himalaya e nell'intera Mongolia.
Finché il buriato Agvan Dorjeff nel Novecento diventò tutore
del tredicesimo Lama. Dimorò presso di lui, e poi si recò in Russia, secondo lui la vera Shambhala, il cui zar avrebbe restaurato la
gloria del buddhismo. Fu accolto nella corte ossessionata dalla
minaccia cinese e gli fu concesso di edificare un tempio buddhista nella Novaja Derevnja di San Pietroburgo, esso dipendeva dal
Dalai Lama che doveva rifondare l'Impero Mongolo. Quando il
bolscevismo deflagrò, il tempio non fu toccato. C'era fra le gerarchie comuniste chi vagheggiava il patto coi buddhisti. Intanto
Sukhbalaat, che guidò le truppe mongole alleate ai sovietici,
aveva composto un inno nel 1921 che diceva: «Moriamo in questa guerra e rinasciamo guerrieri del regno di Shambhala!».
Con l'avvento di Stalin crollò il sogno di Dorjeff. Soltanto
Roerich insediato nella Kulu Valley in contatto con Cicerin, si accaniva a predicare il culto di Shambhala, ma verso la fine della sua
vita i suoi contatti con i sovietici s'erano estinti.
Nel 1980 scoprii che i buddhisti della Buriazia avevano fondato una rivista che mirava a diffondere nuovamente un messaggio affine a quello cui s'era dedicato Dorjeff.
In Mongolia nel 1930 i Russi avevano proscritto col buddhismo il culto di Gengis Khan. Nel 1990 l'uno e l'altro furono su-
bito ripresi, si sono riaperti i monasteri, si rimedita il miracolo
politico di Gengis Khan.
Un vincolo congiunge i sogni possenti di quel popolo immerso
nella verde conca centrale dell'Estremo Oriente con l'opera dei
raccoglitori e lavoratori di coralli a Torre del Greco.
Introduzione a II corallo nella gioielleria etnica della Mongolia, a cura di
C. Del Mare, Electa, Napoli 1997. Il testo della Introduzione è qui parzialmente ripubblicato con l'omissione delle otto note che corredano la
versione originale.
La forza del tuono entra nella mano a Taiwan
Lukang (Taiwan centrale) - Il maestro taoista s'accoccola a gambe
incrociate al centro della stanza, col gesto delinea la via che la sensazione dell'aria respirata deve percorrere, giù dalle narici fino all'addome, dove si concentra in un bolo immaginario, e poi su per
la spina fino alla cima del capo, di dove fiotta fuori come in due
aeree coma. Egli avverte che non si deve protendere il petto come
ginnasti, ma accogliere la sensazione dell'aria dentro l'addome
appena sollevato nell'inspirazione. Mostra il punto dove si deve
raccogliere, tre dita sotto l'ombelico. LI va trattenuta e condensata in una perla lucente. Quando questa è ottenuta con ferma
immaginazione, incomincia il difficile: bisogna lentamente sollevarla verso l'alto, fin tra le ciglia, e più in là fino a sopra il cranio.
Quella luce interiore è chiamata, in molti testi, embrione. «Occorre raffigurarsi un embrione?» domando. Egli spiega che l'embrione è il simbolo della pura essenza originaria del tutto. «La luce
deve risalire celermente?» domando, ed egli sorride: è tanto se
dopo un anno d'esercizi essa arriva al cuore.
Il corpo dell'uomo genera due «venti», che si devono cogliere,
immaginare nel respiro. Sono l'uno caldo, virile, l'altro fresco,
femminile, e la luce sale se essi sono perfettamente armonizzati.
Ecco come si procede: il maestro chiude gli occhi, e sotto le palpebre abbassate fa roteare le pupille, ora da destra a sinistra, ora
da sinistra a destra, via via toccando i punti cardinali. Intanto arriccia la lingua e ne spinge la punta sul palato, come fosse l'asse di
rotazione.
«E le donne, possono fare questi esercizi?» domando.
Sorride: «Le donne sono sangue. L'uomo è sangue e aria. Le
donne possono porsi in quiete, non hanno da trattare con l'aria,
attivamente, per armonizzarla col sangue». Mi domando se questa, come sembrerebbe d'acchito, sia un'esclusione sprezzante
della donna, o non piuttosto il riconoscimento della sua completezza magica, che non ha bisogno di armonizzazioni faticose. Ma
non pongo il quesito: quando un maestro insegna la pratica, non
ama le elucubrazioni.
M'accorgo, quando egli si ritira per prepararsi all'arrivo di alcuni ospiti, che i miei fedeli appunti non rendono niente della
sessione. Fiochi barlumi, brusche regole sono ciò che resta dell'insegnamento intenso, trasformatore, in cui le sfumature di
tono sono l'essenziale e le parole semplici gusci svuotati. Soltanto
l'occhio vigile del maestro può avvertire di errori fatali, del mento
che tenda in giù («guai: fatto così l'esercizio danneggia la vista e
l'udito»), della tensione eccessiva nell'immaginare («guai, l'esercizio malfatto fa sopravvenire ciò che il popolo chiama dèmoni.
La mente va calmata»). Mi ricordo ciò che raccomandano i maestri di t'ai chi chuan: non fare mai sforzi, stirarsi. Lo stesso tanto
più vale per esercizi d'immaginazione e di respirazione. «Lunga
vita e armonia è lo scopo di questo metodo cinese» ha detto il
maestro congedandosi.
Quando rientra nella stanza, incravattato, non parlerebbe più
nemmeno per cenni di ciò che è avvenuto poco fa, è tornato a
sembrare ciò che è nella vita profana, un professore di filologia. E
quando giungono gli ospiti, anche loro professori, egli è il più
cauto, non concede la minima deviazione dal più razionale gioco
glottologico. Ha scritto sulla trasformazione dei suoni e dei toni
nella storia della lingua cinese, e ora intrattiene sull'arcaicità del
taiwanese, con i suoi otto toni, a confronto del mandarino, che ne
conserva quattro appena. Ma alla fine della conversazione si viene
a toccare la singolare assenza di una grammatica e di una rigorosa
fonologia in Cina, prima che fossero importate dal sanscrito sotto
i T'ang, ed egli esclama: «Si riteneva prima che l'essenza del linguaggio fosse lo stile. Chi ha stile crea la lingua e gli altri lo imitano, e si forma la grammatica». Credo che qui qualcosa trapeli
della sua vita segreta, di osservatore delle origini mentali creative
d'ogni realtà.
Delle pratiche taoiste invano si cerca traccia per le vie comuni:
soltanto la grazia di un adepto può schiuderle.
Ho percorso l'isola di tempio in tempio, ho assistito ai riti, ma
da questo versante non uno spiraglio s'è aperto. I capi dei templi
taoisti largiscono inchini, s'affrettano a ricolmare la tazzina di tè,
ma se parlo di pratiche ascetiche e mistiche, fingono di non udire
o si accigliano addirittura. Insisto con dolcezza e rispianano il
volto, ma per ripetere: al tempio la gente viene per pregare e interrogare la sorte con le rosse mezzelune di bambù. D'accordo,
dico, ma una superficie delle mezzelune è tonda, femminea, l'altra piatta, virile, e soltanto se le due mezzelune cadono con superfici opposte è segno di sì, di equilibrio, di una divina risata: lo
stesso equilibrio che le pratiche di respirazione e di meditazione
cercano nell'interiorità. Qui, rispondono, si viene soltanto a bruciare incensi, qualche volta a porre domande ai medium; i monaci
e le addette al culto nelle tuniche celesti recitano i mantra, officiano per il popolo e basta.
Millenni di persecuzioni gravano sul taoismo, la reticenza è nel
sangue. Del resto per il popolo minuto basta il bello spettacolo
del pentolone di rame colmo di incensi bruciati, del pentolone
sull'ara, che vibra al rintocco delle bacchette, tutti godono a stare
immersi in onde e ricci di fumo fragrante, mentre le fanciulle salmodiano accanto ai monaci, a sinistra una donna rulla un tamburo, a destra un uomo suona l'armonium. Le mezzelune di
bambù gettate da tante mani crepitano sul pavimento davanti alle
statue degli dèi per conversare con loro. Appena fuori del sacrario,
nel cortile del tempio la gente fa la merenda, gli innamorati si tengono per mano, i bambini giocano.
È la festa del capodanno lunare, l'anno della scimmia d'oro (o
di etere). Anno fausto, equilibrato. Per le stradine di Lukang dove
si procede in fila, tanto sono strette, si sfiora l'intimità delle famiglie. Le case danno sulla strada, offrono al viandante altrettanti
tempietti, con l'altare e le statue degli dèi. Rivaleggiano nella bellezza e nello sfarzo. Di capodanno vi si entra liberamente. Ci si affaccia, si chiede una tazza di tè e i bambini corrono a colmare le
tazze, i vecchi invitano a sedere.
Quando queste devote famiglie sentono di averne bisogno,
chiamano un sacerdote taoista. È in esilio a Taiwan il 63° Patriarca, il pontefice che garantisce col suo sigillo le vocazioni. Alcuni sono semplici esorcisti e guaritori: le «teste rosse» ma ci sono
anche le «teste nere», che spingono a fondo con autoallucinazioni, le pratiche che mi ha mostrato il maestro. Taluni sono
«maestri del tuono», che incorporano in ogni organo del corpo la
forza del lampo e del tuono di primavera.
Il rito consiste nel far entrare immaginativamente quell'energia celeste in un punto della mano, e di 11 nell'organo. Essi si allucinano fino a sentire che toccando col pollice la base dell'anulare
vibra la cistifellea, e via via alla base del medio risponde il fegato,
a quella dell'indice i polmoni, alla falange dell'indice la milza, a
quella del medio il cuore, a quella dell'anulare l'intestino tenue, a
quella del mignolo la vescica. E alla sua falange reni e arterie, alla
sua base infine i dotti immaginari per i quali si fa circolare il respiro. Il tuono s'introduce via via nel cuore, nell'intestino tenue,
nel centro del petto sotto il cuore, nell'addome, nel fegato, nelle
arterie e vene. Per ogni entrata si mette una sillaba e la punta della
lingua ne disegna il carattere sul palato. Intanto si fa circolare nel
corpo la sensazione del respiro. Ci si crea una rete di riflessi condizionati, si fa del proprio corpo una tastiera, su cui lo spirito
potrà suonare. Spesso si combina l'esercizio dei sette punti della
mano e del corpo con la contemplazione delle sette stelle dell'Orsa. Ecco perché uno dei trucchi dell'Opera di Pechino prevede il disegno dell'Orsa Maggiore sulla fronte. Le poesie classiche di Lu Tung-pin accennano a tutto ciò con succinta discrezione:
L'elisir d'immortalità
non c'è bisogno d'implorarlo da altri.
Gli otto trigrammi
i nove colori
sono nel palmo della mano.
I cinque elementi,
le quattro figure
sono dentro di te.
Quando l'hai capito,
puoi parlare con gli spiriti.
Chiudi gli occhi... cerca la verità.
La verità viene con la naturalezza.
La perla del tao ribolle
gioca con essa notte e di,
non buttarla via,
che il dio di sotterra
non ti mandi i suoi scherani.
«Corriere della Sera», 15 aprile 1980.
Cinque miracoli nel Giappone esoterico
L'esplorazione del Giappone esoterico mette a dura prova la volontà di sfoggiare saputi e divertiti sorrisini. Percival Lowell osservò con cura quasi dispettosa i miracoli della liturgia delle due
sètte shinto.
Quello del calderone: si traccia innanzitutto un percorso labirintico di corde di lino svolazzanti {gohei), attaccate a quattro
bambù fronzuti piantati tutt'intorno a un calderone, per tener
lontani gli spiriti. Quando nel calderone l'acqua ribolle, i sacerdoti fanno circumambulazioni cantando e digitando, prima lanciando ai punti cardinali manciate di sale, quindi gragnuole di
scintille sprigionate da un acciarino.
Con il gohei l'acqua bollente è esorcizzata. Con due fronde di
bambù essa è spruzzata in direzione dei punti cardinali. Adesso
l'officiante è afferrato dalla fùria del rituale, sferza l'aria con le
fronde come impazzito e infine cade stremato e disfatto.
È posseduto dallo spirito lunare dell'acqua, da ora in poi sarà
insensibile all'acqua bollente che è, sul piano sottile, il fuoco.
I sacerdoti informano Lowell che, come il corpo è attraversato
da vene e la terra da meati, cosi l'aria è un intersecarsi di arterie
sottili e gli spiriti le percorrono - ora lo spirito dell'acqua, ora
quello del fuoco - transustanziando gli oggetti [...].
Altro miracolo è la camminata sui carboni ardenti. Le stesse «difese» del rito precedente sono erette, ma in più il capo dei sacerdoti
respira ritmicamente durante la purificazione. La traversata delle
braci è, dice Lowell, una messa, un martirio e, quando il popolo
imita i sacerdoti, una mascherata comica. Egli raccoglie dagli officianti la spiegazione dell'immunità alle bruciature: il fuoco è
stato spossessato del suo spirito, è presente soltanto in senso materiale: gli è calato dentro lo spirito dell'acqua, come quando il
dio della pace scende nel cuore d'un uomo dedito all'ira [...].
II terzo miracolo è l'arrampicata da scalzi per una scala di spade
che conduce a una piattaforma aerea, dove è sistemato un altare.
Quarto è il miracolo del tuono. Su un'urna poggia un bollitore
col coperchio appoggiato in modo da lasciare uno spiraglio aperto.
L'officiante, dopo un bagno nell'acqua gelida, accende il fuoco, vi
traccia sopra dei mudrà, sparge del sale e agita un gohei. Attira a sé
con gesti della mano, sibila inspirando - infine, mentre il dio lo
possiede, come sferrandogli un pugno al petto, il bollitore emette
un tuono.
Quinto è il miracolo dell'accensione psichica del fuoco. Il sacerdote diteggia salmodiando sotto una doccia gelida, quindi
prega e diteggia sopra una pipa. Il fuoco s'appiglia alla pipa mentre il sacerdote lancia un urlo parossistico.
Lowell scruta i particolari dell'ascesi, i bagni gelati, specie
quello che alle due di notte galvanizza il corpo assonnato, annota
la dieta, che esclude le carni, il pesce, ogni vivanda cotta, saporosa, odorosa, qualsiasi traccia di sale. Noci, bacche e ghiande devono bastare, insieme a ortaggi, uva e diosperi secchi. Lowell però
s'accorge che tutto ciò è soltanto una cornice, per comprendere a
fondo si deve scendere nell'interiorità dell'adepto [...]. Questo assopimento è il fine dell'ascesi: esso consente di captare premonizioni, di ricevere la visita degli dèi.
Ma accanto a questo acquietamento [...], l'esoterismo shintoAlena a esercizi immaginativi, durante le digitazioni fatte intrecciando le dita con veemenza maniacale in varie composizioni [...].
Lowell visita le scuole di possessione della sètta di Nichiren, in
cui ragazzi e ragazze sono gettati in transe mediante l'uso della
verga con il gohei, poggiata fra gli occhi. Essa dà il segno dell'arrivo d'un dio scuotendosi e trascinando nella sua danza estatica,
che diventa acrobatica; i posseduti corrono sui cornicioni, capitombolano e con l'andar del tempo ci si perfezionano sempre più:
il loro capitombolare è il simbolo del rivolgimento costante del
divenire. Quando sono posseduti dallo spirito d'un rampicante,
si issano su una mano e poggiano le gambe a una parete.
Lowell tenta spiegazioni fisiologiche, nota che nel pieno della
possessione il cuore batte lento e cessano di sbattere le palpebre:
due indici che non si possono simulare, a parte l'anestesia che
s'accompagna a ogni transe.
Ma la fisiologia non è la chiave unica e sufficiente. Lowell è costretto a scandagliare il concetto stesso di persona. Le idee che si
succedono nella mente sono legate fra loro quanto le combinazioni del caleidoscopio, e noi siamo nient'altro che questa sfilata;
esistono inoltre idee ossessive e nascoste [...]. Sulla scia di Schopenhauer, Lowell cerca di identificare il noumeno (la cosa in sé)
nell'atto di volontà, ma si trova in definitiva a cospetto di pure
idee [...]. Tuttavia Lowell non osa persistere all'altezza metafisica
che l'esoterismo giapponese l'ha costretto a sfiorare; a ritrascinarlo in basso è l'ossessione razzista: l'estasi shinto, egli conclude,
non farebbe che denudare «lo spirito della razza» [...].
Dopo l'esplorazione dell'esoterismo giapponese, Lowell desistette dalla letteratura, per dedicarsi all'astronomia. Calcolò la
presenza d'un pianeta al di là di Nettuno e sposò la causa dell'abitabilità di Marte. Mori nel 1916.
Il seme d'una specifica passione esotistica era stato gettato.
Lowell precedette la schiera dei successivi adoratori del Giappone. Calcò le sue orme Lafcadio Hearn, per assaporare la felicità
di sogno d'un Giappone vaporoso e fiabesco, reso etereo dal
buddhismo. Venne poi Ernest Fenollosa, che andò al di là della
grafica popolare di Hokusai e di Utamaro, calandosi nel nucleo di
conoscenze esoteriche che è simboleggiato dai fondi d'oro della
pittura di meditazione. L'esotismo trasognato di Hearn era trasceso, l'osservazione tenace ma indispettita e sprezzante di Lowell,
dimenticata. Fenollosa si immedesima nel giovane adepto giapponese iniziato alla creazione d'un dio personale. Insieme a lui,
Fenollosa alza le preghiere via via ai vari dèi, annusando l'incenso,
adagiando la mente nel ritmo della campanella, intrecciando simbolicamente le dita, fissando lo sguardo in uno specchio finché la
superficie ne sia dissolta e si spanda in una infinita sfera di cristallo; appariranno via via Kwannon, cosi bianca che arde via ogni
scoria, Jizò che scioglie nel torrente della sua pietà, Amida che depone come una goccia di fuoco nel sole, Aizen che attizza le passioni fino a che scoppino e mostrino d'essere non-passioni, Fèdo
che lega a un palo, accende la pira e cava il cuore, trasformando in
delizia il dolore.
Questo Giappone che Lowell s'illudeva ancora di esorcizzare
come un'alterità assoluta e materiale, di razza, diventa, con Fenol-
Iosa, la promessa di una possibile metamorfosi, una via percorribile. Whistler imita la pittura giapponese con una certa compassatezza borghese - che si adatta troppo bene alle sale neoclassiche del
Palazzo Frick sulla Quinta Strada a New York - ma in poesia
Pound saprà assimilare tutta la forza sciamanica del teatro Noh,
mercé lo studio delle carte di Fenollosa.
Quando a Pound le ragazze paiono emergere dal budello del
metrò parigino come petali bagnati adagiati su un ramo nero, la
sua metamorfosi in un poeta giapponese dell'istante assoluto è totale. Tutto l'impaccio, la reticenza, la cocciuta difesa di sé, che irrigidivano Lowell e gli impedivano di gridare la sua meraviglia,
erano ormai congedati, la via sincretica alla metamorfosi era spianata [...].
Lo sciamanesimo giapponese avrà lo strano destino d'essere «liberato» dalle leggi oppressive in virtù d'un decreto delle forze
d'occupazione americane, per cui il Giappone sciamanico scoperto da Lowell sarà rivisitato in anni recenti da un'antropologa
inglese, Carmen Blacker, l'autrice di The Catalpa Bow, in un momento di inattesa rinascenza. A Lowell va il merito singolare di
aver avviato una lettura della mitologia giapponese sulla scorta
dei dati sull'estasi sciamanica. Egli capi per primo l'episodio cosmogonico centrale, della semidea che scatena le risate della deadel-sole-corrucciata con un'esibizione oscena e così riporta la luce
nel mondo, come nel mito di Eleusi Baubo, scoprendosi, fa ridere
Demetra raggelata dal lutto. La semidea giapponese e Baubo sono
sciamane in transe.
L'esotismo americano: Il Giappone e PercivalLowell, in L'esotismo nella letteratura angloamericana, serie diretta da E. Zolla, voi. III, Lucarini,
Roma 1982.
Aborigeni d'alto grado
Evento meraviglioso, vertiginoso arricchimento per la nostra vita
fu la scoperta della letteratura spirituale tibetana nella prima metà
del secolo. La vita di Milarepa e lo yoga tibetano furono presentati dall'americano Evans-Wentz, magiche peregrinazioni nel
Tibet furono esposte da Alexandra David-Neel. Irruppe nelle nostre menti una civiltà complicata e secolare, taluno ne fu radicalmente trasformato. Così accadde all'australiano Adolphus Peter
Elkin, morto in tarda età nel 1979, di cui è tradotto anche fra noi
il trattato sugli Aborigeni. Nel 1945 uscì il suo AborìginalMen of
High Degree, «Aborigeni d'alto rango», una rivisitazione degli
sciamani australiani tutta esaltata e illuminata grazie alle notizie
giunte dal Tibet. Antropologo, era tuttavia disposto a riconoscere
i poteri degli uomini di alto grado, ammetteva che essi affrontassero i sommi problemi filosofici; per spiegare le loro opere parlava
di ipnosi e di allucinazioni collettive. Soprattutto riconosceva che
delle loro iniziazioni sappiamo pochissimo. Un'apertura altrettanto audace la ricordo in Giuseppe Tucci, specie nel quindicinale che diresse allorquando usciva il libro di Elkin, a Roma,
«Scienze del mistero».
Ottanta tribù australiane erano state osservate, con lingue distinte e consuetudini opposte. Alcune erano dèdite alla circoncisione, altre no, altre ancora praticavano addirittura la subincisione: il pene circonciso era forato alla base e fatto periodicamente sanguinare. Tuttavia le diverse tribù erano connesse da alcune istituzioni comuni: la presenza di uomini d'alto grado, il
culto ossessivo del sangue per cui un sanguinamene era l'espressione d'ogni emozione forte, il sistema dei matrimoni incrociati e
infine il gioco delle peregrinazioni che attraversavano il paese accompagnate da canti speciali che con il loro intreccio misterioso
infondevano vita al paesaggio, riportandolo alla sua condizione
«iniziale», mitica, interpretandolo. Questa tramatura dei canti di
viaggio è evocata con la sua secca abilità da Bruce Chatwin in The
Songlines (apparso qualche anno fa da Adelphi come Le vie dei
canti):
Dalla scoperta del mondo tibetano Elkin fu spinto a riassumere le
esperienze di Spencer e Gillen, di A. W. Howitt, ma soprattutto a
rievocare le proprie. Notò che in certe tribù tutti sanno presagire
e vedere a distanza, ma al di sopra di loro si pongono gli uomini di
alta qualità, telepatici, chiaroveggenti e all'occorrenza micidiali,
che sono stati chiamati da altri uomini di qualità a farsi uccidere e
resuscitare, ad assorbire in corpo dei cristalli di quarzo. Parve a
Elkin che questi rituali di aggregazione fossero ricalcati sulla
mummificazione, praticata da molte tribù. Nel Tibet Elkin ritrovava l'arte di produrre nel corpo energia e calore, di acquistare
l'immunità al fuoco, di suscitare il serpente annodato al coccige,
che in Australia è il ricovero in cui sono celate le corde magiche, la
consuetudine di fissare la punta del naso fino a rendersi insensibili
e infine traboccanti di beatitudine. Fra le qualità sia tibetane che
australiane Elkin annoverava anche il cannibalismo rituale, la
corsa a mezz'aria in transe, la telepatia.
L'operina di Elkin non fu vastamente diffusa, ma capitò in mano a
Eliade, che aveva avuto un'iniziazione nell'Himalaya e aveva esplorato quasi tutte le varianti dello sciamanesimo. Tenne un corso ispirato a quella lettura nel 1964 a Chicago e ne proviene l'opera edita
ora da Jaca Book, La creatività dello spirito. Una introduzione alle
religioni australiane. Peccato. Eliade non frequentò gli Aborigeni,
che proprio in quel giro d'anni parvero rinunciare al suicidio collettivo, riprendendo il filo della loro vita antichissima, mentre lentamente il popolo australiano rinunciava alla persecuzione.
Giova a favore di Eliade la sua vastità di conoscenze, egli riesce a
trovare subito i paralleli, le risonanze. Purtroppo tuttavia quella
vastità in qualche raro caso è soltanto apparente, come quando si
fida delle indicazioni di certi grossi dotti come padre Wilhelm
Schmidt, sicché interi gruppi di studiosi, come i seguaci di Hugo
Winkler, lo storico di Babilonia (E. Siecke, Bòklen, Egrenreich,
Fries), sono etichettati con le denigrazioni di Schmidt o del tutto
ignorati. Cosi ben poco Eliade dovette leggere Winthuis, che pure
è citato, al quale risale un'interpretazione brillante della vita aborigena, basata sull'ossessione dell'androginia. Winthuis scriveva in
modo banale e iterativo, ma scrutava a fondo. Eliade aveva comunque il vantaggio di conoscere in buona parte la vasta letteratura tedesca sugli Aborigeni; soprattutto aveva letto l'opera di Helmut Petri, che Elkin ignorava. Aveva anche la capacità di stornare
l'attenzione al momento opportuno dalle confabulazioni europee
intorno alla natura delle divinità aborigene, per dirigere lo sguardo
piuttosto al paesaggio australiano, dove «ogni roccia, ogni sorgente o ogni punto d'acqua rappresenta una traccia concreta di un
dramma sacro prodottosi nei tempi mitici. Per il lettore europeo,
le peregrinazioni senza fine e gl'incontri fortuiti degli Eroi del
tempo di sogno sembrano monotoni all'eccesso. Ma allora anche
il vagabondare di Leopold Bloom nell' Ulisse appare monotono ad
un appassionato di Balzac o di Tolstoj». È giusto questo scintillante accostamento? Sì, le trascrizioni dei canti sono tediose, ma
mi tornano alla mente certi cantori australiani che si esibirono
anni fa all'Università di Roma: le delicate mosse di danza, le voci
carezzevoli, assorte, trasognate li mostravano completamente
astratti dal mondo circostante; delicati si atteggiavano, come immersi in un mare, tesi a messaggi d'un altro mondo. Eliade suggerisce: stanno rammentando, come Platone insegna. A guardarli si
capiva che erano assorti nel mondo acustico dove si trova la vera
causa di ogni visione, sapevano risalire alla loro voce, contrarsi in
essa, scoprendo come dal suono provenga la realtà visibile.
Eliade rinarra la sublime storia iniziatica esposta da Howitt sul
ragazzino wiradjuri. Il padre lo conduce nella savana e gli posa sul
petto due grandi cristalli di quarzo. Egli se li sente penetrare dentro come un colore. Il padre gli versa ciò che appare come quarzo
nell'acqua, che diventa dolce e, una volta bevuta, rivela tutt'intorno figure di spettri. È il preludio a una lunga iniziazione che
culmina nell'incontro con il totem segreto, una tigre-serpente; legato ad essa da una corda il giovinetto la segue nel suolo e poi in
cielo, dove infine scorge il Vecchio seduto a gambe incrociate, con
alle spalle due quarzi enormi, alti fino alla volta celeste. Il Vecchio
è incastonato nel cristallo.
Canti aborigeni dall'era dei miti,« Corriere della Sera», I4settembre
1990.
Hawai'i, danzando tra i coralli
Che cos'era un Hawai'iano in antico? Uno dei tanti abitanti
lungo la linea del mare su una delle otto isole dell'arcipelago,
compreso entro i confini del «porcile», delimitato da pietre sormontate da teste porcine. La transe in porco inflitta da Circe era
l'operazione essenziale nella quale lo Hawai'iano si riconosceva, e
allora diventava straripante di energia, capace di assimilare cibi
strabocchevoli, di scavare la terra in maniera spasmodica, di
amare senza limiti, con una digestione possente, una volontà di
prodigarsi sovrumana. La carne di porco era tabù per le femmine.
Lungo la costa fiorivano le palme dei tropici, con grappoli di
datteri, più addentro i banani, che non erano propriamente alberi, ma foglie germinanti, tabù anch'essi per le femmine. Ma c'erano soprattutto i campi di fango dove si coltivavano i taro, i cui
tuberi sono immersi nelle «paludi di taro», insieme alle foglie acri,
che lessate perdono l'acredine. Se ne ricava una piadina acidula, il
po. La coltivazione è ardua. Gli Hawai'iani sapevano scavare canali per irrorare meticolosamente tutta la loro terra, accorgimento necessario per mantenere attiva la coltura del taro, che abbisognava di acque commosse dai venti sempre spiranti. Erano
un alimento per ambo i sessi e anche un farmaco. Ricco di fosfati,
di calcio e di ferro, si doveva mangiare in una condizione di estasi,
senza mai pronunciare parole di dissenso o di ostilità. Serviva a
curare punture, enfiagioni, costipazioni.
Il maiale si cuoceva in una stufetta vicino al luogo del pasto,
imu. Si cuocevano anche altre carni oltre ai pesci, ma separatamente, ì'imu solo spettava ai porci. C'erano budini di taro, i kulolo, o di cocco, gli haupia, anch'essi tabù per le femmine, insalate
con pomodoro e salmone o lomi lomi, di pollo e seppie e foglie di
taro cotte in riso o latte di cocco.
La vita, specie degli aristocratici o ali'i, si svolgeva praticando
tutti gli sport. Scontri con armi rintuzzate o sfoggi di robustezza
o di equilibrio, corse su slitte o su tavolacci che consentivano di
attraversare le onde slittando su di esse. Lo scivolìo sull'acqua accanto alla costa era praticato altresì su barchette minime, dalle
estremità curve all'insù per gli alti, tozze per i plebei. I sessi dimoravano in stanze separate, salvo gli sposati. Avevano anche ciascuno una propria cucina, per separare le vivande secondo i rigorosi tabù. Un plebeo poteva raramente, mercé il sogno, accedere
alla casta dei sacerdoti. Cosi avvenne per Maunaloa, o Molokai,
nel XVI o XVII secolo: s'era impegnato in un gioco di scommesse
su chi avrebbe meglio fatto rotolare da un versante di collina una
palla. Era disastrosamente fallito più volte, quando in sogno gli
apparve un dio, che gli suggerì di presentare la sua vita come in
pegno nel prossimo gioco. Stavolta infatti trionfò e offri un
maiale al dio ignoto, che nel successivo sogno ricomparve e gli
confidò il proprio nome: Kaneikaulana'ula e gli mostrò gli alberi
giusto allora spuntati, nei quali si erano incarnati altrettanti dèi,
che li rendevano velenosi. Il re di Molokai volle trarre dai loro
legni statue dei singoli dèi, ma i falegnami che osarono avvicinarsi
ad essi subirono l'avvelenamento. Il dio ricomparve per prescrivere le cerimonie necessarie per accostare gli alberi, il plebeo cosi
diventò kahunaài quegli alberi. Nell'Ottocento furono adoperati
per trarne fastelli di rami che spandevano disastri: si videro volare
in fiamme per l'atmosfera, come razzi incendiari. Pare che un loro
residuo permanga al Bishop Museum di Honolulu.
Ciò che incanta soprattutto negli Hawai'iani è la trepida sensibilità ai ritmi, specie ai più soavi. Il rullìo dell'aria ventosa, delle
correnti marine erano imitati con grazia impeccabile, il colpeggio
del sangue d'una giovane si percepiva naturalmente, di colpo, con
entusiasmo e ci si adeguava con gioia. Le mani sapevano atteggiarsi, le gambe si arcuavano schiettamente, la mimesi era pronta
e spontanea. Ciò che li colpiva in primo luogo era la ritmicità elegante: nella colata di lava questo appariva il carattere eminente,
sicché la dèa dei vulcani era Pele, una strega. Ma piena di grazia!
Gli sbuffi sulfùrei seducono. Pele stava addormentata nel cratere di Kìauea nell'isola grande di Hawai'i e sognava una dolce
melodia; ne cercò la fonte e giunse, con l'anima che le si era staccata, dal giovane re Lohi'au che cantava un hulao georgica. Per tre
giorni dimorarono l'uno incollato all'altra, in amore. Ma immateriale. Pele fu ridestata dal sonno dalla sorellina Hi'iaka e lei, per
prima cosa al risveglio, la mandò a cercare l'amante squisito.
Hi'ialca percorse tutte le isole, a una a una.
Era accompagnata da un'aiutante, la donna verde wahine
'oma'o, che provvide a rimuovere via gli ostacoli che si eressero a
ogni isola dell'arcipelago. Toccarono infine Kauai, per scoprire
che Lohi'au si era disperato al punto di uccidersi. Hi'iaka ne catturò allora l'anima vagante e la reinserì nel corpo attraverso una
ferituccia al piede. Ma subito egli s'innamorò di Hi'iaka, ricambiato, e quando infine rivide Pele s'accorse che aveva le orride fattezze di una strega. Lei allora, indispettita, lo immerse nella lava
ardente. Due suoi fratelli dovettero intervenire per risuscitarlo ed
egli così potè tornare a Kapa'a, dove Hi'iaka lo aspettava impaziente. Contemplare lo spettacolo delizioso e atroce della lava strisciante, ravvisando le ondulazioni di un racconto in versi o mele:
questo significava intuire l'anima divina del vulcano.
Dèi della danza erano una coppia di fratello e sorella, i due
Laka. Il fratello le scomparve e lei danzava levando poesie alla natura, seguendone via via le movenze. Ebbe un'allieva, che volle
imparare: una sorellina di Pele. I bambini che volessero danzare,
dovevano iscriversi alla scuola di ballo, halau, comandata da un
insegnante, il kamu, e in tre anni erano pronti. Il dio dell'agricoltura, del taro, era Lono, che s'incarnava in un albero antico, in un
misto d'uomo e maiale. Di qui propiziava la transe maggiore, in
maiale. Dio del mare era invece Kanaloa, incarnato nel polipo a
otto braccia e nell'uomo capace di trattenere a lungo il fiato
sott'acqua: era lui che spirava le correnti sottomarine. Dio della
guerra e della fertilità virile era invece Ku, i cui attributi coincidono con quelli del germanico Tyr. Sull'isola era noto come il
predone locale, Kukailimoki; nei cieli, invece, come Kuniakea e si
avvertiva nel sole nascente, da contemplare con la massima attenzione. La parte femminea della procreazione spettava invece alla
luna, Hina.
I kahuna badavano in primo luogo al mano, al prestigio soverchiarne, che sapevano suscitare o stornare. Cantavano genealogie
per confermarlo nei re, i mele. Erano liste di nomi d'antenati, che
risalivano al tempo primordiale, quando i maria si erano distri-
buiti e insediati. Da ottobre a febbraio durava la festa di conferma
del mano, in onore di Lono e Ku, quando tutti s'esibivano in gare,
specie gli ali'i, praticando duelli con armi spuntate. I kahuna recitavano i loro mele, e facevano le loro dichiarazioni, il popolo presentava le sue istanze. Si facevano danze e si recitavano buia. Era la
festa più laicale delle tante celebrate nelle stupende campagne di
piante, tutte autoctone, con fiori fra noi ignoti, bocci sfolgoranti,
campanule delicate, farfalle variopinte. La musica hawai'iana
quasi è irricostruibile: nacchere e flauti, tamburi e schiocchi di bastone accompagnavano i mele e le hula. I cieli erano quasi sempre
solcati da arcobaleni, che ripetevano la congerie di tinte delle
campagne, degli uccellini. Il clima per tutto l'anno rispondeva al
nostro luglio.
Che cosa accade nell'aria di Hawai'i? Farfalle color del legno
d'albero si appiattiscono, volano poi zigzagando nei folti fiammeggiando colori violenti, fantasmatici e cosi distraggono i nemici. Altre invece, color nero, accostato ad altri colori svariati, avvelenano chi osi sfiorarle. Spesso formano catene mimetiche, che
si travasano nel colore sfumato e trasparente dei vegetali all'intorno. Lungo il mare gli Hawai'iani allestivano pescaie sbarrate da
màhàkào paratie bucate da grosse aperture, che consentono ai pesciolini di entrare e uscire liberamente, però rinserrano triglie e
cefaloni. Ma lo Hawai'iano entrava naturalmente sotto le onde,
un vasto e affascinante teatro qui lo accoglieva e stupiva con girandole di tinte fresche e violente, con esplosioni di sciami ingenti di pesci farfalla o gunnelli dorati o giallo limone, qualche
volta strati di nero, dai guizzi spicci e inattesi, con istantanee inversioni di rotta. Questi nugoli si addensano sopra i coralli variopinti e difformi: rosati, cremisi, verdolini, violetti, bigi, a occhio
di gatto, a orecchio d'elefante, a corno di bue, a istrice nera oppure a pohaku huna, martellini verdi e lobati brulicanti di labbrucce arancione. Di coralli se ne osservano molti che diramano
in fili sottilissimi, sospirosi e finiscono spesso in medusine fatte
quasi soltanto di iodata e salina acqua di mare, con palpiti armoniosi, con cappuccetti sfrangiati che fanno da sifoni, sospingendole come ballerine per i fondali dell'oceano.
I ricci con l'elmetto, ha'ukeuke kaupali, assorbono golosamente le alghe e possono guidare alle conchiglie gibbute, dalla
carne deliziosa, del cui guscio ci si potrà servire per nettare i cocchi della loro polpetta candida, tabù per le femmine; ma compare
anche abbondante il pesce chirurgo a volte terminante in un
triangolino giallo, anche lui divoratore forsennato di alghe e, con
la sua bocchina, squamatore di rocce. Quasi tutti questi pesci si
dilatano o condensano in un battibaleno, come la triglia volante
0 lolouuipinau, in grado di estendere il corpicino dorato coi suoi
labbrucci inquietanti, o il vezzoso kikakapu, capace di scatenare il
vomito in chi osi leccarlo o addirittura morderlo. Guizzano
tutt'attorno labridi e zanchi, cavallucci marini e aragoste, talvolta
mostruose e locali, come le ula. Ma spicca fra tutti il polpo a otto
tentacoli, coi quali s'inserisce in anfratti minuziosi o se ne proietta
fuori in un balenìo furibondo. Passa l'intera giornata catturando
crostacei, quindi, dopo aver curato le proprie uova all'improvviso
scompare, garantisce il futuro della propria razza per sparire nella
morte individuale prontissima. All'inizio della vita si era servito
della meravigliosa conchiglia, sottile e vuota, che conferisce con la
sua cavità la mobilità scattante, ed è costruita attorno a un punto
di nascita che fa la ruota allargandosi con armonia esemplare, modello di crescita per tutta la natura. La conchiglia stupenda del
nautilo argonauta gli permette viaggi oceanici infiniti. In lui s'incarna il dio del mare Kanaloa.
Chi si spinga nei fondali discernerà l'epinéfelo solitario dalle
variegate tinte mimetiche, che intrappola crostacei e altri pesci, o
1 limpidi argentei lucci n'omilu, in sciami fittissimi. S'insinua nei
crepacci e dispone all'apertura le sue spine il pesce palla rigonfiabile o anche il baliste homuhumu-nuku nuku à-pua'a, pesce delle
Hawai'i. Si scorgono inoltre noihu, lo scorpione ingannatore,
puhipaka, la murena dalle narici tubolari e dall'aguzza dentatura.
Ma il pesce maggiore, capace di ossessionare un Hawai'iano, è
mano, lo squalo. Gravissimo ammazzarlo, come trucidare un familiare: può infatti diventare un invisibile assistente, assecondare
la vita marina, spianando le correnti. I suoi occhi accrescono la lucentezza della luce sott'acqua, coi forami della pelle assorbe dalle
acque l'ossigeno, con gli incavi della bocca avverte i fremiti elettrici d'una lontanissima preda, le pinne del petto gli servono
come ali d'aereo, mentre le pinne dorsali danno stabilità al suo
trasvolìo sottomarino; contemplarlo significa conoscere Ku, il
dio della guerra.
Domenicale, «Il Sole 24 ore», 23 aprile 2000. Il precedente articolo,
Hawaii, crocevia dell'anima è del 12 marzo 2000.
Scritti zodiacali
Gli oroscopi di Dante o di Goethe sono come carte
geografiche, cieli squadernati su cui cogliere il
segreto della loro sorte. L'occhio poetico può
scorgere peraltro verità che non si svelano all'uomo
legato alla lettera dei fatti. Cosi le predilezioni
astrologiche possono essere strabilianti...
Leggi l'anima nel cielo*
Nota introduttiva
Gli Esodi «f//altrove: il destino e lo zodiaco percorsi nel capitolo
5 hanno preparato il terreno a un'incursione corsara in un
gruppo di scritti zolliani mai raccolti prima d'ora. Il filo che li
unisce è una concezione del destino visto alla maniera di Schopenhauer (nei Parerga e Paralipòmena), come il solco inconfondibile del cammino dell'individuo nell'imperscrutabile rete cosmica di cui l'uomo e l'intero mondo vivente sono parte intrinseca e involontaria. Scambiare questa concezione per un fatalismo passivo e inerte è scorretto e fuorviarne ai fini di una proficua lettura degli Scritti zodiacali nell'insieme dell'opera zolliana.
Questa rassegna minima, non più che un assaggio dell'ingente
materiale edito e inedito sull'argomento, ha il suo testo premi* «Sene», settimanale del «Corriere della Sera», 4 ottobre 1980.
438
nente nel saggio sul capolavoro di Melville, il romanzo Moby
Dick{ 1851).
Pubblicato su «Paragone» nel 1960, Melville e l'abbandono dello
zodiaco, consiste di otto paragrafi e venti note. Sono qui riportati
stralci dai primi sette paragrafi e quasi integralmente l'ottavo con
l'omissione delle note, in attesa di una riedizione integrale del
testo.
Precedono Melville e l'abbandono dello zodiaco, due brevi componimenti: sul destino e l'orientamento stellare della prima architettura, e i profili di sei dei dodici segni dello zodiaco che Bernardo Trevisano alias EZ allestì su «Il Giornale d'Italia» nel corso
del 1966. Sono i sei segni primari riconosciuti in Egitto e a Babilonia: Toro, Cancro, Vergine, Scorpione, Capricorno, Pesci.
Il destino
Non manca, a osservare le comuni consuetudini, qualche relitto
o troncone ancora vivo di un comportamento rituale, religioso
anche negli agglomerati dove più gli uomini vengono appiattiti
come marciapiedi, battuti dalla convulsa monotonia fino a diventare làmine fragili, diafane, l'una all'altra uguali. Relitti e tronconi: ma simili al gallo sacrificato che continua a zampettare
anche quando gli è stata mozzata la testa.
Un rituale antico è ancora conservato abbastanza bene ed è
quello degli approcci, che regola lo stringersi dei rapporti umani
diversi da quelli inevitabili, familiari. Con chi ci si lega? Per lo più
vige la norma della doppia prova: debbono ricorrere due segni di
inevitabilità: può talvolta bastare uno solo ma allora deve ripetersi
0 presentarsi in modo straordinario. Ecco la tavola dei segni che
dimostrano inevitabile un incontro: che si sia soccorsi in un frangente pericoloso; che ci si trovi impegnati entrambi a discorrere
con un essere neutro, mercuriale, esposto al pubblico: fattorino,
gendarme, funzionario, cane, bambino; che cada all'uno un oggetto e l'altro lo raccatti; che ci si ritrovi in un luogo neutro e accomunante: landa, deserto, ballo, ospedale. Segno per eccellenza
è la presentazione da parte di amici significativi, oggigiorno diventata mero segno, neutro come i precedenti, perché privo di
impegno, laddove un tempo era una garanzia, fornita dal presentatore, che la persona presentata fosse quanto lui degna e di adeguata educazione.
Casisti esasperanti di questo regolamento sono gli innamorati,
1 deliranti, gli sventurati. «Non avrei mai incontrato l'amata (non
sarei mai incappato nel persecutore) se quel giorno non avessi
detto quelle parole a Tizio, e non fossi quindi uscito di casa, e se
l'altro per suo conto non si fosse recato a quel convegno» ecc.
L'osservanza dei segni è più tenue a mano a mano che crescono
bassezza e infelicità: nella Suburra, fra gente gettata insieme dall'orrore, fra colpiti da una comune ossessione e agli adescatoti
basta un accenno di intesa, cioè non ci si vergogna di volere e
combinare incontri. Quando ancora vigevano distinzioni sociali,
ci si mostrava sempre meno desiderosi di nuovi incontri, cioè
sempre più felici di come già si stava, a mano a mano che si saliva
in una società più preziosa, al punto che non valeva alcun segno
salvo la presentazione da parte di un proprio pari [...].
Coloro coi quali si è vincolati per volontà di un incontro deciso
da segni adeguati costituiscono il vero prossimo ed è come se esso
avesse acquistato il diritto di far sprecare il tempo, di infliggere
conversazioni uggiose magari perfino sui propri abominevoli malanni, di chiedere in caso di bisogno soccorso. Cioè si ripristina, tra
coloro che si sono incontrati secondo le regole, un poco di quella
comunità tutta affiatata che un tempo era l'aria naturale di ogni
uomo, salvo prigioniero, anacoreta o esule. E talmente si vagheggia il bene scomparso della comunità, che oggigiorno nessuno o
pochissimi sanno di avere almeno un vantaggio sugli avi, di poter
scegliere le loro frequentazioni, e si aggrappano a quel che hanno
avuto in sorte senza domandarsi se sia decente o no [...].
Nietzsche prevedeva un futuro di comunità non già naturali,
come la famiglia, ma spontanee e originali, nate da un comune
fervore: vaticinio allegramente imprevidente, perché manca ogni
fervore dove non esiste una comunità naturale che nutra l'ardore,
magari della sua stessa negazione [...].
Talvolta capiterà agli uomini d'oggi di soffermarsi e domandarsi: «Perché mai io debbo provare pietà, orrore, tenerezza proprio per costoro che la sorte mi ha situato attorno, fra tutte le
facce umane che, in vitro, sarebbero altrettanto più degne?». E
specie quando si trovano sotto l'ombrellone di una spiaggia, a un
tavolo di ristorante, ad un terrazzo di città, a gettarsi frasi uguali a
quelle che si stanno palleggiando altri gruppi sotto i prossimi ombrelloni, al tavolo accanto, sul terrazzo dirimpetto, talvolta agli
uomini-massa pensierosi capiterà di rimuginare: «Perché sto proprio qui e non altrove?». Infatti essi non trovano più nessuno che
spieghi loro perché mai obbediscano alla tavola dei segni d'inevitabilità. Eppure ad essa restano fedeli, e l'iniziativa di quel college
americano di installare un dating office, ovvero un ufficio per assortire appuntamenti tra gli studenti, e l'abitudine di trovar marito, compagnia, lavoro mediante annunci economici e imprese
di «avvicinamento», tuttora stentano a imporre le loro razionalità. Tuttora offendono qualcosa di vivo e sacro [...].
A voler determinare che mai sia questa cosa, facilmente si risponde che è la fede nel destino, forse superiore alla nostra volontà, che regge gli avvenimenti che ci interessano e dinanzi alla
quale dobbiamo mostrarci calmi, abbandonati, o pietosi come
Enea, non procaci come la gente facile, i vagabondi, i ruffiani, che
decidono senza pudore degli incontri che vogliono, attaccando
discorso 11 per 11, senza attenersi al limite che la provvidenza disegna intorno a ciascuno, come a ingiungere: «Questo "è il tuo orto,
qui lavorerai"». Tant'è: quanto più si prevaricherà, forzando il destino, tanto meno si saprà ciò che si vuole, o meglio: quello che
vuole la sorte, ciò che si è. Prevaricando si diventa gente da trivio,
da mercato, senza destino, affidata soltanto al caso, alla fortuna:
queste sono certezze modestamente religiose che sopravvivono.
«Esiste il destino?» è interrogazione malposta, che appassiona i
popolani e all'analisi si mostra vacua; ma è lecito invece affermare
che gli uomini ancora mostrano di voler seguire un destino.
Il destino si può definire un seguito di fatti tra loro connessi, la
vita di un uomo il quale abbia avuto una esperienza capitale è
sempre un destino cui egli ha saputo obbedire, perché tutti i casi
che gli sono occorsi si dispongono in ordine a quell'evento come
la limatura di ferro si orienta a formare una rosa attorno alla calamita. La vita di un santo, come Agostino, è tutta impregnata di
destino perché ogni suo episodio è una tappa verso la conversione
e la sua intera esistenza disegna un percorso, con ambagi e arresti
o cammini spediti, verso il fine predestinato. La conversione è il
modello più nitido di fatto che fornisce il destino, ma anche
meno eccelse vicende possono dar senso, cioè destino, a una vita.
Orrido e mero accumulo di fatti è la vita di fortuna, fortuita; e
poiché il destino si svela soltanto quand'è compiuto (il momento
di morire è l'ultimo in cui sia concesso di ravvisarlo), finché permanga incertezza sul suo profilo conviene porre in esso fede e speranza, come prescrivevano certi motti: «Ho il mio astro», «Non si
volge chi a stella è fisso».
Le metafore che designano il destino sono tratte dalla filatura,
dall'orditura dei tappeti; esse seguono appunto una trama che, a
osservare le singole manovre del filatore, può restare occulta, ma
si spiega alla fine o dall'alto, talché ne riceve un premio chi nel filatore ha posto subito fede, essendo stato in pace e quiete durante
l'attesa [...].
Quale fu la forma originaria e pura di tali residui religiosi? Bisogna tornare all'antica sede di tribù dove ognuno, nascendo in
una certa capanna da certa madre, inevitabilmente entrava in un
destino già tutto segnato, poiché appartenendo a quella capanna,
cosi orientata, egli corrispondeva a quell'astro in cielo, a quell'animale nella selva, a quella pianta, a quella occupazione di pace, a
quel ritmo e melodia da cantare nelle cerimonie, a quella arma e
funzione guerresca ed era destinato a sposare una certa vergine,
corrispettiva a lui nel cerchio delle capanne, e a formare comunione con certi compagni, fin dal suo primo vagito.
I segni di inevitabilità erano conosciuti e interpretati dagli anziani. Oggi se ne osservano strani frantumi, e sono pur essi che
preservano da un peggior disordine.
«Corriere della Sera», 16 aprile 1963.
Era legato alle stelle il segreto
della prima architettura
J. Norman Lockyer (1828-1920) fu uno dei massimi astronomi
inglesi, sommo studioso della cromosfera solare e scopritore di un
elemento presente nel sole (e solo in seguito riscontrato fra i gas
terrestri), l'elio. Nel 1894 pubblicò dalla MIT Press TheDawn of
Astronomy, risultato di una serie di analisi sull'orientamento dei
templi egizi. Egli nota preliminarmente che le osservazioni astronomiche degli antichi sicuramente datano da 7000 anni fa per
l'Egitto, da più di 5000 per Babilonia, da più di 4000 per l'India
e la Cina.
In Egitto il culto era dedicato eminentemente alle varie qualità
della luce solare: quella aurorale veniva adorata nella figura del
giovinetto Horo o Arpocrate, la meridiana in quella del dio Ra, la
vespertina in quella di Atmu, mentre il sole tramontato era adorato come Osiride. Altri nomi pigliava la luce solare in rapporto
al momento dell'anno: Amen-Ra era quella del solstizio d'estate.
Il culto era incentrato soprattutto sull'alba e sul tramonto, cioè
sui momenti in cui il sole toccava l'orizzonte. Ma anche le tenebre
avevano le loro immagini divine: Set, Anubis, Tifone, Bes. Anubis è spesso visto come sciacallo, Tifone come coccodrillo.
La luna è connessa a Tot e Khons, in forma di ibis. Iside è l'aurora e il crepuscolo, come anche Neftis. Shu è l'alba, Tefnut i raggi
dell'aurora: si dice che Shu e Tefnut sono gli occhi di Horo.
Gli Egizi notarono che il sole si trovava in punti diversi dell'orizzonte nel corso dell'anno, la posizione delle stelle variava in
rapporto all'Equatore e ai due poli: perciò si parlava dei loro
viaggi e di avventure degli dèi corrispondenti.
I templi erano orientati in modo da ricevere la luce del sole o
dell'astro cui erano dedicati. Non quella dei pianeti, errabondi
nel cielo, bensì quella delle stelle di cui molte avevano un punto
invariabile dove sorgevano o calavano per la durata di secoli.
II tempio di Iside delle piramidi (come anche il tempio di Gerusalemme) guardava a oriente: la luce del sole all'equinozio entrava attraverso la porta e attraversava il colonnato posandosi in-
fine sul recesso più segreto del santuario, sull'altare dei sacrifici. Il
sole colpiva nella ricorrenza annuale i gioielli del sacerdote sacrificante, suscitandovi un raggio riflesso.
La basilica di San Pietro fu ancora esattamente orientata in
modo che all'equinozio di primavera, all'alba si spalancassero le
porte dell'atrio ed il sole andasse a colpire l'aitar maggiore.
Il tempio egizio meglio conservato è quello ad Amen-Ra a Karnak, la cui area era doppia di quella di San Pietro oggi; aveva due navate, l'una volta al sole calante del solstizio estivo, l'altra al sole nascente del solstizio invernale. Nella tenebra del santuario soltanto
all'attimo esatto dell'anno «entrava il dio», tutto illuminando.
Al tempo dell'edificazione dei templi le costellazioni circumpolari, cioè che non sorgevano né tramontavano, erano l'Orsa
Maggiore, il Drago e l'Orsa Minore, che gli Egizi chiamavano
Coscia, Ippopotamo e Sciacallo. Poiché dio della notte era Set, li
si diceva «Coscia, moglie, sciacallo di Set». Il dio Horo designava
qualunque figura celeste nascente e perciò il mito di Horo che uccide l'ippopotamo (o il coccodrillo, che ne è l'equivalente, nelle
regioni più settentrionali) indica semplicemente il sole nascente
che cancella le stelle circumpolari. Ma questo vale per il tempo in
cui, a causa della precessione degli equinozi, era circumpolare il
Drago. Infatti dal 2000 a.C. in poi, Horo è raffigurato nell'atto di
trafiggere la coscia di Set: la precessione ha fatto diventare circumpolare l'Orsa Maggiore.
Accanto alle circumpolari ci sono le stelle che sorgono e calano
sull'orizzonte e perciò ci sono templi orientati in modo da raccogliere d'infilata attraverso i colonnati il fulgore d'una stella. Dice
Lockyer: «Dimostrammo che nei templi dedicati al culto del sole
e alla determinazione della lunghezza dell'anno, c'erano buone
ragioni perché si attenuasse la luce con diaframmi e volte di pietra, perché si voleva determinare il punto segnato dai raggi nei
due o tre di vicini al solstizio invernale e estivo per stabilire il momento esatto del solstizio. Ma se il tempio non era destinato ad
osservare il sole, perché tali diaframmi? Perché tenere cosi al buio
l'astronomo o il sacerdote?». Un passo di Erodoto fornisce a
Lockyer la spiegazione: nel tempio c'erano un pilastro d'oro e uno
di smeraldo cosi grandi da splendere nottetempo: una stella era
bastevole ad accenderne la luce. E quanto maggiore fosse il buio
tanto più fulgeva la stella. Salvo che una stella poteva visitare cosi
un tempio per due o tre secoli al massimo. Perciò bisognava ogni
tre secoli riorientare un tempio stellare, mentre uno solare poteva
rimanere intatto per millenni. Di qui si spiegano le cerimonie di
fondazione. Anzitutto si «tendeva la corda», cioè si fissava l'asse
del tempio, poi il re si recava sul posto assistito dalla dèa Sesheta,
«la signora della pietra del fondamento», al momento del sorgere
o calar del sole o della stella.
Il 20 giugno, il solstizio d'estate, il giorno più lungo dell'anno,
era il capo d'anno egizio perché segnava la piena del Nilo e si celebrava con un sacrificio al sole nascente. Per determinare i tempi
del rito occorreva basarsi sull'apparizione d'una stella che precedesse l'aurora e nel 3000 a.C. quella era Sirio, personificata da
Iside. Il tempio di Denderah era edificato per coglierne l'apparizione.
Da luglio a ottobre durava l'inondazione, da novembre a febbraio la semina, da marzo a giugno il raccolto; ciascuna stagione
era suddivisa in quattro mesi. I segni zodiacali (tanto in Egitto
come a Babilonia) erano perciò solo sei, simboleggiati da un toro,
una tartaruga (il nostro Cancro), una spiga (la nostra Vergine),
uno scorpione, un uomo caprino o pesce caprino (il nostro Capricorno) e un uomo-pesce (i nostri Pesci) forse fin dal 4000
avanti Cristo.
Bernardo Trevisano, «Il Giornale d'Italia», 28-29 luglio 1966.
Dal Toro ai Pesci attraverso lo zodiaco
Toro
Le feste del Toro, anche nelle forme più profane, tendono all'estasi. Viceversa nella liturgia cattolica sotto il Toro ci si prepara all'Ascensione e infine la si festeggia: Cristo risorto, sul monte Oliveto si trasfigura nuovamente come già sul Tabor, ma questa seconda volta i discepoli lo vedono salire e confondersi con il cielo.
Si stabilì la consuetudine di ascendere il monte Oliveto quaranta
giorni dopo Pasqua in processione solenne.
In Italia vige all'Ascensione la consuetudine dello «sposalizio col
mare» a Venezia (Europa rapita dal Toro?), e la festa del grillo a Firenze, nata forse dal bisogno di liberare i coltivi dal dannoso insetto.
Ai due apostoli San Filippo e San Giacomo ed ai loro dialoghi con
il Cristo, era dedicato il calendimaggio, ma la Chiesa ne restava
aliena come dai carnevali, dai relitti delle onoranze a Flora ed all'Albero di maggio così simile ai futuri «alberi della libertà» dei rivoluzionari francesi. Così le forze anticristiane si ricollegarono, attraverso
1 simboli e le festività prescelte, al mondo precristiano. L'aspetto «lavorativo» e non licenzioso della festa venne comunque inglobato
nella liturgia cattolica nel 1955 con l'istituzione della festa SanciiJoseph Opificis, il cui capitolo esorta alla carità; vi si canta il Salmo 1 (col
2 e il 3) sull'uomo che non segue i consigli degli empi e non siede
nelle adunanze dei protervi ma trova voluttà nella legge del Signore;
si esalta chi lavora al fine di poter custodire il Cristo. La liturgia della
festa è un capolavoro di citazioni sapientemente avvicinate.
Quanto all'aspetto floreale delle maggiolate, esso si conservò
attraverso la dedicazione del mese di maggio alla Vergine. Tuttavia si può, meditando sul simbolo del Toro nell'antichità, scoprire
qualche sottile nesso con l'idea dell'Ascensione.
Secondo Mircea Eliade il toro simboleggiò essenzialmente il cielo
fecondante e fin dal 2400 a.C. toro e fùlmine appaiono collegati alle
divinità celesti: il muggito è uguagliato al tuono. Esso è anche uguagliato al rombo del mare, sicché il toro è altresì sacro a Nettuno.
Il toro delle tombe regali di Ur in Caldea ha una cervice dorata
(solare, ignea) e una mandibola di lapislazzuli (acquea), dunque
simboleggia, secondo Cirlot, l'incontro del cielo e della terra, del
fuoco e dell'acqua. Del resto Sofocle parla della natura taurina di
Dioniso, dio dell'acqua infuocata, del vino. Dunque sotto questo
segno probabilmente fin dai primordi si meditava sulla comunicazione possibile fra terra e cielo, simboleggiata dal tuono-muggito del toro celeste. Sant'Agostino, interpretando le parole di
Mosé sulla stirpe di Giuseppe, simile ad un toro, dice che vi è profetato Cristo, «la cui bellezza è quella di un toro: a causa delle
corna della croce viene rappresentato figuratamente il Signore
(pulchritudo eius tauri est, propter cornua, de Domino intelligitur
fìguratum, Patrologia latina, XXXIV, col. 776)».
Cosi anche Sant'Ireneo nel Trattato contro le eresie afferma che
il toro rappresenta Cristo come vittima sacrificale e sacerdote.
Cancro
Dal 22 giugno al 22 luglio domina il segno del Cancro o del Granchio. Esso sta a nove mesi dall'Ariete che è simbolo della nascita,
perciò è tempo di concezione. Per gli Orfici era dunque il momento dell'incarnazione dell'anima, cioè della sua umiliazione,
del suo cadere ebbra nella materia e si fece eco di questa idea Cicerone nel Sogno di Scipione chiamando il Cancro la porta attraverso
la quale gli uomini scendono sulla terra. Si è alla svolta dell'anno,
ora il sole retrocede dal suo apice, diventa retrogrado, come il granchio, e si presta a simboleggiare appunto l'anima che s'incarna.
Nel novero delle dodici fatiche di Ercole, al Cancro si fa corrispondere l'idra di Lerna nata da Tifone ed Echidna, uccisa dall'eroe con l'aiuto di Iolao. È un segno pericoloso, nel quale il sole
può diventare di un'intensità feroce, si è al solstizio d'estate, celebrabile con miti come quello dell'idra ucciso col fuoco, o della
sconfitta del nefasto fratello di Osiride, Tifone.
Nel calendario ateniese di questo tempo si facevano sacrifici di
buoi ed ecatombi, si celebravano feste in onore della Vergine
Atena, nelle quali delle vergini dovevano depositare in un antro un
pacco, forse contenente un serpente, o si portavano in processione
ombrelli sacri. In tutte le civiltà antiche emergevano dalla meditazione di questo periodo dell'anno alcuni elementi: il rapporto con
qualcosa di bestiale (idra, serpente, granchio), con una esasperazione dell'elemento igneo, con un concepimento che è una discesa
nella materia. In Palestina si celebrava la festa di Elia nel Cancro,
sul monte Carmelo dove il profeta aveva prodotto, come narra il
Libro dei Re, fuoco e acqua, e negli usi dei popoli occidentali figura
quello di far attraversare un fuoco alle mandrie e di condurle a bagnarsi nelle correnti. Eligio di Noyon (588-659) avvertirà: «Non
credano i cristiani alle pire sedendovi accanto a cantare, perché
questa è opera diabolica, né si permettano alla festa di San Giovanni e al solstizio di ballare e cantare idolatricamente».
Le costumanze non si conformarono alla predicazione di cristiana austerità e alle feste del solstizio, del San Giovanni d'estate,
quando le forze elementari paiono sfrenarsi come disciolte dalla
calura, si continuò a bagnarsi nei ruscelli, a saltare attraverso i
fuochi, a bruciar fascine, a lanciar palle o ruote solari facendole
vorticare per i declivi. Si accendevano i fuochi sacri con legna di
quercia, si coglieva il vischio, emblema del fuoco, il «ramo d'oro»
che permette di calare negl'inferi, di scendere nella materia. Sono
i giorni in cui mordono le tarantole e in cui s'intrecciavano danze
durante le quali i volteggi dei ballerini parevano imitare i ragni
che si buttano a testa in giù dipanando le loro tele: le danze delle
spade che guariscono dal morso delle tarantole e dei ragni (in
tutta l'Europa, dall'Italia alla Scozia erano diffuse).
Sono residui romani popolari le credenze secondo le quali si sarebbe in un tempo di streghe, di forze telluriche scatenate. Il Cristianesimo aveva procurato di assorbire e filtrare questo vario retaggio celebrando il 24 giugno la nascita di San Giovanni Battista
qual è narrata nel Vangelo di Luca, facendo precedere la festa da
un digiuno e da una vigilia. Il Battista è il nuovo Elia, e nell'ufficio liturgico si sottolinea che egli fu, come forse Geremia, benedetto fin nel grembo (e non è il Cancro festa del concepimento?):
«prima che ti plasmassi nel grembo, io già ti conoscevo e prima
che tu uscisssi dal seno materno, già ti avevo prescelto» (come Dio
proclama nel Libro di Geremia)-, il cristiano deve sì meditare sul
concepimento, sul contatto fra lo spirito e la materia, ma per risalire all'idea della Provvidenza e della predestinazione. La esultanza per la nascita del Battista è la forma austera che il Cristianesimo impresse alle frenesie popolari.
La festa di San Pietro e Paolo cade altresì nel Cancro. La crocifissione a testa in giù di San Pietro ripete, rovesciata (come si rovesciava
il corso del Sole nel Cancro) la crocifissione del Salvatore a Pasqua;
l'umiltà di San Pietro è come una risposta all'idea pagana della nascita come degradazione: tanto più facile gli era salire in cielo con la
mente quanto più la sua figura veniva così umiliata nel mondo, notava Prudenzio. La festa fu, sin dai primi secoli, segnata da una
grande allegria popolare, simile a quella per la nascita del Battista.
Cade altresì nel Cancro la festa della Visitazione, che riconduce
alla contemplazione delle origini della vita, al primo periodo
dopo il concepimento, facendo meditare sull'incontro fra la Vergine e Santa Elisabetta, entrambe incinte, consapevoli di un destino già segnato per i figlioli recati in grembo.
Le letture delle Messe di questo periodo vertono sul mistero
della nascita alla verità che per il cristiano è morire al mondo, secondo l'Epistola ai Romani, il che è consono al tema stagionale
quale si presentava ai pagani più saggi per i quali l'essere introdotti
nella vita era una degradazione, una morte per l'anima; il cristiano
muore a questa morte e perciò vive spiritualmente. Il cristiano accoglie l'invito alla gioia che è insito nella calda stagione del Cancro, ma senza licenza: la sua è una gioia per fede nella Provvidenza.
Vergine
Dal 23 agosto al 22 settembre dura il segno della Vergine, cioè
della terra che ha ormai prodotto la spiga. Si raffigura come una
fanciulla che nella destra stringe una palma e nella sinistra una
spiga. Nella costellazione figura la stella Spiga.
Sempre nel mondo mediterraneo si è configurato così nella
fantasia questo momento del ciclo annuale: la Vergine fu Persefone in Grecia e a Roma, Astarte in Oriente, Belit in Assiria. In
Cina invece venne vista come il Serpente o la Coda di Quaglia.
Presso gli Egizi in questo segno il giovane Oro viene concepito
dalla vergine madre Iside raffigurata talvolta come avvoltoio, o
coccodrillo, o colomba. Oro salva dai pericoli della piena estate, è
simile al loto o al papiro che cresce sulla superficie delle acque,
Iside è venerata come colei che lo porta in grembo; spesso figura
con al seno il figlioletto, che è anche il suo sposo.
Suoi simboli sono la mela, il melograno, il papavero, il fico, la
pigna oltre alla spiga. Nel calendario romano il 23 agosto si celebrava la dèa delle messi Ops e si sacrificava su un colle per scongiurare gli incendi. Il 24 si apriva il mundus, la fossa simboleggiante il
mondo intero, al centro dell'Urbe. Dice Varrone: «Quando il mundus è aperto è come fosse schiusa la porta degli dèi tristi e inferi».
Probabilmente vi veniva riposta la spiga del nuovo raccolto
come in una tomba da cui doveva risuscitare. Questo spiega il
mito di Proserpina (la vergine Spiga) rapita alla madre da Plutone, dio della ricchezza e dell'inferno (del mundus, che era un
primitivo granaio), destinata a riemergere a primavera, Varrone
chiama Proserpina «fecondità dei semi».
Nel calendario liturgico la celebrazione delle messi comincia
fin dalla XI domenica dopo la Pentecoste, quando nell'Antifona
si cita dal Libro dei Proverbi: «Onora Dio secondo il tuo avere e offriGli le primizie della tua messe. In premio i tuoi granai andranno ricolmi e il torchio stillerà vino copioso». Quella della XII
domenica dopo la Pentecoste ripiglia il tema e lo approfondisce:
come le messi crescono per grazia divina, così i pensieri santi in
noi, e nella colletta mostra ancora un'altra estensione analogica
che si può fare meditando sullo spettacolo di questo momento
dell'anno. Nutrire tutti gli uomini con scarsa semente è un miracolo non minore della moltiplicazione evangelica dei pani; è lo
stesso motivo di sacro stupore che veniva instillato nelle anime
degli antichi adoratori di Proserpina ai misteri eleusini, ma allargato alla meditazione d'un ben altro frutto della spiga: l'Eucaristia e, nella domenica successiva (terza dopo San Lorenzo), estesa
ancora ad un'altra associazione mistica giacché le messi della terra
sono ora nella mente di tutti, ma occorre trasporre il visibile nell'invisibile. Orbene: quali sono le messi della semente spirituale,
della buona parola nell'uomo? Le tre virtù teologali: fede, speranza e carità. Come sono spesso vilmente tradite nel loro significato oggidì le ultime due virtù! Si parla di speranza di beni terrestri e politici, di carità come semplice solidarismo sociale o addirittura, e qui comincia la perversione satanica dei significati, di un
atteggiamento imbelle verso l'errore (Sant'Agostino scrisse: «C'è
una misericordia che punisce e una crudeltà che perdona»). Teologale vuol dire «che ha Dio come autore e come oggetto», la speranza è fiducia di raggiungere Dio, la carità è desiderio di raggiungerlo, è amore della Sua volontà (amore che porta naturalmente ad aiutare gli altri ad acquistare lo stesso bene).
Queste dunque le messi che dobbiamo raccogliere in noi con la
cura con cui stiviamo quelle visibili nelle arche.
L'associazione della Vergine (e quindi dell'anima verginale,
non corrotta dal contatto con il mondo) e della spiga (cioè della
fioritura interiore) è confermata dalla festa della Natività di Maria
Vergine, natività miracolosa perché da madre sterile: Santa Anna.
Dopo questa celebrazione dell'8, il 12 settembre si festeggia il
nome di Maria (che significa «Signora» in siriano, o «amata da
Dio»). Presso la basilica Ulpia al Foro Traiano c'è a Roma una
chiesa dedicata al Santo Nome di Maria.
Ma la Verginità è anche celebrata il 29 agosto con la festa di San
Giovanni Battista. A Roma, non lungi dal Velabro, in questa ricorrenza si celebra una sublime festa presso la Confraternita dei
fiorentini, intitolata al Santo: al crepuscolo si fa la circumambulazione del chiostro cantando inni gregoriani e si accendono candele in commemorazione dei condannati a morte assistiti dalla
Confraternita in antico, fra essi gli eretici (di questa come di altre
costumanze si legge la descrizione nel bel volume che ogni
amante di Roma dovrebbe conoscere: Le confraternite romane di
Martini e Maroni, edito dalla Fondazione Besso).
Il 30 agosto la chiesa stazionale per la festa di San Felice ed
Adaucto fu fissata sulla via Ostiense nel cimitero di Commodilla,
essa è importante per la meditazione di dopo la Comunione, soltanto il tepore, il sole della riconoscenza fa fiorire in noi la messe
dei doni divini: ecco un nuovo modo di far fruttare spiritualmente lo spettacolo naturale proprio del tempo dell'anno.
Scorpione
[...] Si rianima l'anno, dopo l'equilibrio quasi immobile del
tempo della bilancia, nel periodo dal 23 ottobre al 21 novembre,
sotto il segno dello Scorpione, l'animale preposto a simboleggiare
questo tratto dell'anno già dalla fantasia babilonese, da cui lo ricevette l'intero mondo antico. La velenosità lo rendeva emblema
di perfidia e bellicosità, eppure si riteneva che costituisse anche,
schiacciato o incenerito, il miglior rimedio contro le ferite che
aveva inferte e si metteva in rapporto con l'attività agricola che ferisce la terra ma altresì la feconda. Il suo mese è uno di morte per
la vegetazione, eppure è anche di semina. In quanto benigno talvolta lo scorpione è sostituito dall'aquila.
Lo scorpione è omologo, come dimostrò Deonna, al dio Mercurio, che presiede ai mutamenti e conduce i morti come psicopompo cioè guida delle anime. Il mito greco narra che Orione il
cacciatore, nato da una pelle di toro, inseguì le Pleiadi e la dèa Artemide, ma Apollo lo fece mordere da uno scorpione. La favola
esprime l'opposizione dei due segni, del Toro primaverile e dello
Scorpione autunnale.
I Cinesi esprimono le stesse costanti attraverso altre figure: il
loro simbolo autunnale è la tigre e la stagione è di guerra oltre che
di fertilità; per loro Orione è Tsan e Sin è lo scorpione, e sono due
fratelli nemici.
Fra i miti di tutti i popoli si osservano concordanze: la rossa
stella Antares della costellazione dello Scorpione da molte parti è
associata a Marte. Presso i Persiani il contrasto sarà fra il toro e lo
scorpione che lo morde all'atto del sacrificio mitraico.
II 1° novembre è una festa pastorale; si riconducono le greggi
negli stazzi e si accendono falò: il momento è pericoloso.
La liturgia cristiana opera la consueta conversione e trasfigurazione di tutti questi dati naturali.
La morte non è una esclusione dal consorzio, ma una trasformazione del rapporto che lega i fedeli, perciò sotto questo segno
autunnale che dovrebbe essere funesto si celebra invece la delicata
festa d'Ognissanti, consacrata altresì alla comunione dei Santi, al
nesso invisibile che lega i vivi ai purganti ed ai beati. La festa nacque allorché il Pantheon venne consegnato al Pontefice romano
Gregorio III (731 -741) il quale consacrò quel luogo di tutti gli dèi
a Cristo, alla Vergine, agli Apostoli, ai Martiri e Confessori ed a
«tutti i giusti perfetti morti in tutto il globo»; ma la data originaria fu il 13 maggio, soltanto Gregorio IV la fissò al 1° novembre,
che precede la commemorazione dei defunti.
Nella funzione del 1° novembre si legge la visione apocalittica
della Chiesa trionfante, di cui faranno parte coloro che avranno
condiviso con Cristo i patimenti.
I primi cristiani usavano conviti funebri sulle tombe, nel Medioevo s'introdusse l'usanza di rammentare una volta al mese il di
del Giudizio, ma fu Sant'Odilone di Cluny a stabilire la commemorazione annuale dei defunti. La redazione dell'Ufficio è un capolavoro che include il Dies Irae ed una preghiera a San Michele
psicopompo, come Mercurio-scorpione, di cui il cardinale Schuster scrisse che «l'ufficio di psicopompo attribuito a San Michele
ha riscontro in moltissimi monumenti della primitiva letteratura
cristiana: Praepositus paradyso, princeps Angelorum, ed esercita
l'incarico di ponderare sulla statera il merito delle anime, prima
d'introdurle nel regno celeste».
San Michele ferisce e atterra con la sua spada il male; è la funzione cristiana della forza mortifera, dell'impeto e dell'accorgimento guerrieri scorpionici, i quali vanno diretti contro il demonio. La sua presenza è sensibile in ogni uomo che, minacciato da
una qualche forza malvagia, invece di soccombere e scoraggiarsi
esclama: «Chi è simile a Dio?» e si rinfranca con questo paragone
dinanzi al quale tutte le forze del mondo diventano trascurabili.
Infatti in ebraico Michele è appunto quella esclamazione: Mi
(chi?) ka (come) £/(Dio).
Capricorno
Nel segno del Capricorno si entra nel solstizio d'inverno il 22 dicembre, e se ne esce il 20 gennaio.
Il seme è sepolto nella terra nevicata, il gelo stringe le acque: il
simbolo che tanti popoli scelgono per questo paesaggio è un caprone con coda di pesce, fin dagli zodiaci babilonesi. In sanscrito
il nome del segno è Makàrà: leviatano, coccodrillo, anfibio, mentre il segno azteco è Cipadi, un mostro marino simile al narvalo. I
Greci lo mettono in rapporto con la capra Amaltea nutrice di
Giove nella grotta dove il giovane dio si ripara dalla furia del padre
Saturno. Infatti, allorché la natura è ritirata e spoglia, torna a dominare il dio spodestato, il padre Saturno o Crono. A Babilonia
all'inizio dell'anno si celebrava l'uccisione d'un mostro, si allontanava il capro espiatorio.
Questo momento dell'anno agrario suggerisce un'analogia con
la notte, col tempo in cui il sole percorre le acque infere e notturne.
Certe immagini sono indissolubilmente legate al Capricorno:
il rarefarsi della forza solare, che è come morta cioè in viaggio, il
suo ritiro che prelude ad un ritorno più splendido, e infatti proprio al colmo della desolazione, il 25 dicembre, riprende a salire
la linfa nei càlami delle piante; nel pieno della morte passeggera si
prepara la vita, si ritorna allo stato primordiale indifferenziato in
seno alla madre che prepara al riemergere nella vita attiva e indipendente.
Di riflesso si ricavano tradizionalmente dalla situazione certi
insegnamenti morali: bisogna pigliare contatto con ciò che è sepolto in noi, morto in apparenza, e le feste del Capricorno procurano appunto di far compiere questa operazione.
Che cosa è il mondo sepolto dal gelo? Una palude limacciosa,
un corso d'acqua torbida e per attraversarlo indenni giova spogliarsi di cose superflue via via accumulate, rinnovarsi.
Le feste tradizionali sono perciò feste del dono dell'infanzia
(nascita del nuovo anno) e della decrepitezza (ultimi istanti del
vecchio).
AI dono i pagani ricollegavano la licenza saturnale dei costumi
e orge di cibo e bevande specie nel culto lenèo di Dioniso-Durases, nato dalla vergine terra; il Concilio diTours nel 567 represse
queste manifestazioni, che pure persistettero nel Capodanno. È
anche tempo d'indovinelli (da quelli dei saturnali romani ai
merry «¿¿¿/«inglesi), cerimonie proprie di tempi perigliosi e ambigui. Gli indovinelli sono prove che mostrano se si è o meno di
mente pronta e sciolta da preoccupazioni, capaci di cogliere un
linguaggio ornato e enigmatico.
Nelle feste babilonesi di Capricorno già compare una navicella, l'uso si riproduce in Egitto, e nel folklore europeo e marocchino riappare (in un canto popolare alsaziano si parla della «nave
di Natale»). Navicelle su ruote vennero allestite nel Medioevo
dalle gilde dei tessitori, esse sono dedicate a San Nicola patrono
dei marinai e tessitori: è la nave con cui il sole attraversa gli spazi
notturni e quella con cui l'uomo affronta le acque infernali.
La catena delle associazioni mitiche e archetipiche del Capricorno si può cosi ricomporre: dicembre è il momento del freddo
più intenso e dell'oscurità massima. Occorre allora attraversare
un mare buio su una navicella guidata da un nocchiero, diventare
cioè marinai, accettare di guardare in volto le figure che sono sepolte in noi nel profondo e che potrebbero dominarci a nostra insaputa: il vecchio re sepolto o Saturno (il Saturno le cui funzioni
vengono poi ereditate dalla figura di San Nicola, il Santa Klaus inglese e Babbo Natale), cioè le figure che ci dominano dall'infanzia suscitando in noi desideri confusi e incerti; bisogna dunque
mostrarsi capaci di sacrificare, essere sciolti e disinvolti lasciando
affiorare in noi ciò che è nuovo e antico insieme.
L'acqua del Capricorno richiama gli animali corrispettivi:
rane, cicogne palustri. Le canne di palude sono i vegetali che rappresentano questa cerchia di associazioni. Saturno è legato all'idea dei rifiuti in quanto è un rifiuto dei tempi, vecchio re esiliato,
sotterraneo, nume ritirato che può però essere fecondante, concimante. Con lui, il Vecchio, ritorna la Vecchia: Perchta, Ecate, Befana, anche lei decrepita ma recante un corno d'abbondanza.
Il tempo del Capricorno è quello in cui bisogna accordare il ca-
lendario lunare con il solare e perciò gli antichi vi inserivano i
giorni intercalari. Fra la fine dell'anno antico e l'inizio del nuovo,
in questi giorni incerti si deve vivere il contrasto mai pienamente
risolto fra la vita lunare - cui si ispirano la caccia, la navigazione —
che è propria dei tempi matriarcali, e la vita solare (agraria).
Durante tali giorni incerti si fanno doni e si rovesciano i costumi consueti, i saturnali romani festeggiavano Saturno e Giano
(o Giana o Diana) dal 17 dicembre al 9 gennaio, ed ebbero un
corrispettivo babilonese nell'abolizione dei ranghi sociali e nella
consuetudine delle strenne. Fan festa allora gli schiavi, pigliando
il posto dei padroni, si accendono fuochi simbolici.
Le feste della tenebra invernale debbono essere comunque di
spoliazione festosa, onde ci si rende simili agli alberi nudi, si dà
tutto per riavere tutto, si opera la rinuncia onde essere in seguito capaci di fruire, così soltanto ciò che si riceverà sarà dono a sua volta.
Dai Melanesiani agli Indiani d'America (il potlatch cade nei
giorni di Capricorno), dagli antichi Cinesi ai germanici, fino al
mondo classico la concordanza, la somiglianza di queste festività
è perfetta, sia nelle modalità come nei significati morali.
Con il Cristianesimo tutto questo complesso di usanze si corona d'un significato ulteriore e maggiore. Il 25 dicembre risalgono le linfe nelle piante, con il corteggio di associazioni che questo comporta, ma con il Cristianesimo tutto ciò diventa una figurazione della nascita della Salvezza incarnata. Il giorno sacro non
celebra soltanto la lenta risurrezione della luce visibile dopo il
giorno più breve (Santa Lucia), ma l'avvento d'una diversa luce,
della chiarezza interiore. Il Salvatore è come un albero fruttifero
(è la vite vera, dice il Vangelo di Giovanni), vige la consuetudine
di levare un albero e ornarlo. Già i Babilonesi e i germanici adorano l'albero del solstizio ornandolo di simboli della crescita e fertilità: campanelli, doni, mele, noci, pani, palle, stelle; orzo, incenso e focacce usavano i Romani alle feste di Giano in gennaio.
Tanto più è palese questo significato in uno zodiaco orientato,
come certuni dell'antichità, in modo che l'anno cominci coi
Pesci, perché in tal caso il Capricorno è posto a Oriente, lo Sposo
s'annuncia col primo risalire delle linfe. L'inverno è stagione atta
a contemplare lo spettacolo per eccellenza di desolazione, la
strage degli innocenti che accompagna la prima infanzia di Cristo: gli innocenti mostrano come non si debba reagire al male col
male, col risentimento ma, viceversa, con la speranza che il sacrificio serva a un alto fine. Quale che sia la morte, occorre affrontarla con volto attento alla nascita della vita o totalmente rassegnato, perché altro modo non c'è di patire con animo sereno, soffrendo senza turbamento. La Epifania è il giorno in cui si impara
a non conformarsi ai principii del mondo ma alla volontà di Dio:
i paramenti liturgici saranno bianchi prima della festa poi verdi:
prima innocenza e in seguito speranza di vita [...].
Gli oggetti simbolici sono la conchiglia (giace nel mare, è buia
e spiralata, era la moneta dei tempi matriarcali), lo specchio (che
inverte i rapporti e già presso gli Egizi era un simbolo del tempo
del Capricorno); il cane (che accompagnava Artemide o Ecate e
scorta nelle calate in inferno).
Concentrazione, denudamento, confronto con le forze infere:
tali i sentimenti legati al momento, e insieme ad essi, la gioia del
donare, onde ci si disfa del superfluo. Di Capricorno si accendono i ceppi nuovi, perché deve ardere un nuovo fuoco.
La Madre e il Fanciullo nella grotta-stalla sono il simbolo che
solleva dallo spettacolo della terra squallida, nei cieli densi di
nubi, nell'animo chiuso e nel corpo tremante che cerca il calore
del chiuso.
Pesci
Dal 19 febbraio al 20 marzo dura la dominazione in cielo del
segno dei Pesci. Il pesce nelle mitologie del Vicino Oriente antico
simboleggia salvezza e medicina, ed il segno segue all'Acquario,
come a indicare che dalle acque emerge la salvezza. Infatti il segno
porta piogge abbondanti e i semi cominciano a sentire l'effetto
dell'umidità, ma la primavera è ancora di là da venire: si celebra
infatti il Carnevale, la cui allegria ha qualcosa di isterico, a contrasto con la vera gioia del Calendimaggio.
Nelle stultorum feriae o feste dei pazzi dei Romani, che si svolgevano un po' prima dell'inizio dei Pesci, ci si mascherava, si agitavano bubbole, s'indossavano vestiti a toppe variopinte (centuncult) mettendo in burla le occupazioni serie. Nell'VIII secolo si
denominano spurcalia, giorni di sporcizia e grasso, questi del Carnevale (e in inglese ne resta traccia nella espressione shrove-tide,
giorni grassi).
Le società di stolti e quelle di giovinotti, che si distinguono appena nel folklore europeo, hanno per compito di celebrare queste
festività.
Gli stolti dell'antica Roma cacciavano urla di animali, e praticavano giochi con l'orso. Nel folklore europeo ne resta traccia, poiché
sotto i Pesci viene inscenata una caccia all'orso, che spesso diventa
una caccia all'orco o uomo selvatico o buffone. Nel Tiralo le feste
dell'orso o uomo dei boschi sono assai ben conservate, e si concludono con la sua uccisione, dopo che si è sposato con la WìldeFrau
o donna selvaggia, la Berta italiana (donde il verbo berteggiare).
Del resto l'orso era sacro ad Artemide (e nel Tiralo la Vergine è
protettrice degli orsi), sicché forse si trattò in origine di riti di cacciatori, fraintesi e degenerati presso contadini e cittadini.
Alcuni tratti si riscontrano in tutti i carnevali: si usano maschere, spesso animalesche, si imitano i gridi bestiali, ci si traveste
da persone d'altro sesso, si fanno caricature di stranieri, si commettono atti licenziosi. Già a Babilonia sono stabilite tali costumanze, e presso i Romani sono presenti i personaggi carnevaleschi fondamentali: il vecchio balordo o Pappus, la vecchia balorda, il nanerottolo dossenus cioè il gobbo, maccus (donde ammaccare e maccheroni).
La Chiesa sempre si oppose al Carnevale, a questo ritorno delle
celebrazioni pagane di spiriti d'immondizia e di trasformazione e
di licenza (nel Penitentiale Vigilianum dell'VIII secolo sono condannati «coloro che nel ballo portano vestito di femmina e si fingono mostri e orchi»); era una celebrazione di Diana (l'Artemide
cui sono sacri gli orsi), come i sabba diabolici o «cacce di Diana».
Ritornava la buffa divinità romana Anna Perenna, la vecchia ridicola che sostituì Minerva fra le braccia di Marte.
La Chiesa procurò di contrapporre a queste celebrazioni il simbolo della cenere, cioè dell'estinzione d'ogni fuoco impuro, la lettura dei passi evangelici intorno al digiuno (che dev'essere praticato con letizia e non al modo dei farisei), ed intorno alla tentazione di Cristo nel deserto. La liturgia è una lezione sulla letizia
cristiana, così diversa dai bagordi pagani che perdurano nel Carnevale, vi si legge in San Paolo ove dice «quasi tristes, semperautem
gaudentes>y. il cristiano deve saper congiungere la tristezza per il
peccato con una gioia serenissima, stato troppo complesso perché
venga afferrato dalla turba carnevalesca.
Non a caso nella III domenica di Quadragesima si legge l'epistola paolina dove si raccomanda di evitare la turpitudine, il vaniloquio, la scurrilità, sostituendole piuttosto con la resa di grazie.
È questo uno dei punti dove il divario tra i riti cristiani e pagani
sopravviventi è irrimediabile, e per le coscienze più rozze anche in
tempi del tutto cristiani il segno dei Pesci non è stato mai vissuto
secondo lo spirito liturgico, ma soltanto secondo quello pagano.
L'unico nesso fra le due religioni è materiale: la Quaresima coincide con il sacrificio del re per burla o dell'orso o orco o della vecchia o orca (nel folklore italiano si parla di «segare la vecchia»)
degli antichi, che era anch'esso luttuoso. Ma per i pagani, almeno
per i degenerati fra loro, si trattava di affliggersi dopo aver festeggiato in modo scurrile; un puro contraccolpo psichico.
Gli articoli sul Toro, il Cancro, la Vergine, lo Scorpione, il Capricorno
e i Pesci, afirmadell'eteronimo Bernardo Trevisano, uscirono su «Il
Giornale d'Italia» nel corso del 1966 nelle seguenti date: 22-23 aprile,
22 giugno, 15-16 settembre, 27-28 settembre, 19-20 gennaio e 18-19
febbraio.
Melville e l'abbandono dello zodiaco
Sappi,
Qualsiasi cosa avvenga;
Si confermerà ancora
La caduta d'Adamo. Un seguito
Ci sarà, che ora si vede in germe.
Miriadi in ruoli di pigmei,
Abbassati all'uguaglianza;
Nel compiacimento delle arti materiali
Può esserci una civica barbarie;
L'uomo fatto ignobile, brutale
Dalla scienza popolare, ateo
Perché approssimativo [...]
H. Melville, Clarel-Bethlehem
Diversissime, salvo all'aspetto, la poetica dei romantici e la poetica dell'associazione mitica di Melville. La prima fu propriamente edonistica, degustava il sogno come evasione dal reale,
come isola tutelata, intérieur dentro all' intérieur borghese, fine a
se stessa; l'associazione mitica di Melville è un modo di conoscenza.
È una rèverie romantica il passo della Berenice di Poe dove il
protagonista si perde nella contemplazione stuporosa: «Meditare
per lunghe ore con attenzione concentrata intorno a qualche puerile artificio del margine o della composizione tipografica d'un
libro; restare interamente assorto, la maggior parte del giorno, su
un'ombra bizzarra obliquamente proiettata su damaschi polverosi, su un pavimento tarlato; perdermi per un'intera notte a fissare la fiamma palpitante di una lampada o le braci rosseggiami
del camino; ripetere con monotonia qualche banale parola, ripeterla tanto e tanto che il suono finisce col non avere significato;
perdere ogni sentimento di moto e di esistenza in un vuoto assoluto, ostinatamente protratto».
Si ponga a confronto la meditazione di Melville sopra un esemplare di teratologia del gabinetto di curiosità del dottor Cutycle in
White Jacket.
Era la testa d'una donna matura, dall'aria singolarmente dolce e
docile, ma piena d'un dolore divorante, inappagabile. Si sarebbe
detto il volto di qualche badessa volontariamente separata, per un
delitto inconfessabile, dalla società umana, che facesse una vita
torturata di penitenza senza speranza, tanto la testa era meravigliosamente triste e pietosa, da far piangere. Ma al primo sguardo
non erano tali emozioni ad affiorare. L'occhio e l'anima atterriti
erano inchiodati, affascinati, agghiacciati dalla vista di un orrido
corno, rugoso come quello d'un ariete che dalla fronte gettava
ombra sul viso. Poi, continuando a guardare, la fascinazione agghiacciata da tale orrore s'attenuava a poco a poco, il cuore si fendeva per la tristezza nel contemplare quei tratti invecchiati, d'un
pallore livido e cenerognolo. Il corno pareva il segno d'una maledizione abbattutasi su qualche peccato misterioso, concepito e
commesso prima che lo spirito fosse entrato nella carne. Il peccato
pareva imposto e non volontariamente cercato, prodotto di necessità impietose della predestinazione; piegava il peccatore sotto
il peso d'una disgrazia senza peccato.
Melville coglie allo stato nascente i sentimenti che scaturiscono
dalla contemplazione e lasciandoli apparire nella loro nudità ne
decifra il significato simbolico: la disgrazia senza peccato che si
lega però nella sua essenza oscura all'idea di peccato. A Poe basta
che la contemplazione lo distragga, essa ha i caratteri del vizio.
Poefìssalo sguardo per assopirsi deliziato, Melville per conoscere.
A Poe erano consentanei e diletti Tennyson, Longfellow, Béranger, egli amò il cantilenato e l'orecchiabile; Melville amò la prosodia irta e il recitativo. A Poe sarà consentanea la paura, a Melville il tremore. La poesia dev'essere un sogno airy andfairy-like
per Poe; per Melville il sogno rivela forme fluttuanti che prima bisogna osservare passivamente per poi gettare l'arpione su quella
che simboleggia la realtà, come è detto in Mardr.
Sogni! Sogni! Sogni dorati; interminabili e dorati, come le fiorite
praterie che si estendono dal rio Sacramento nelle cui acque fu tessuta la doccia di Danae, praterie come circolari eternità foglie di
giunchiglia spezzate; e i miei sogni sono simili ai mufloni, che pascolano all'orizzonte, e per tutto il mondo; e tra loro irrompo con
la mia lancia, per trafiggerne uno prima che tutti si perdano in
fuga.
I sogni si stendono come Ande e Alpi e oceani, per Sicilie assolate
e Antartici diacci, «ma sotto di me, all'Equatore, la terra palpita e
pulsa come un cuore di guerriero; finché non so più se sia io
stesso. E la mia anima sprofonda negli abissi e saetta verso i cieli
[...] Come una fregata sono pieno di mille anime [...] SI molte
anime sono dentro di me. Nelle mie bonacce tropicali quando la
mia nave giace trasognata sulla riva dell'eternità, parlano ad una
ad una poi tutte insieme».
Cosi il ritrarsi nel sogno è un ritrovare il mondo dentro di sé; e
ci si cala in sé per «creare il creativo» come Melville scriverà, sempre in un altro punto di Mardi (dove sotto il nome di Lombardo
s'intende Shakespeare):
Quando il gran Lombardo si dispose alla sua opera, non sapeva
che cosa ne sarebbe venuto. Non si costruiva secondo piani; continuava a scrivere e cosi facendo arrivò sempre più in fondo a se
stesso, come un risoluto viaggiatore che si addentra per foreste
ingannevoli, infine compensato delle sue fatiche. «A suo tempo»
scrisse nella sua biografia: «uscii in spaziosa, serena, aprica regione di profumi dolci, uccelli cinguettanti, piante selvagge, risate canagliesche, voci profetiche. Eccomi infine arrivato» gridai, «Ho creato il creativo» [...] e aveva accanto a sé il suo lembo
di vello.
II vellum Gedeonu, l'elisir di vita, cioè la creatività, la felicità: si attingono dopo un viaggio rituale, dopo il difficilis transitus.
Quali le condizioni? L'abbandono anzitutto; ma l'abbandono
non basta, se ci si ferma a questo punto si è nella sterile fantasticheria, nell'accumulo di frantumi, nella concentrazione maniaca
e compiaciuta di Poe. Si deve lasciar campo alle associazioni di
immagini e di idee, ma a patto di riconoscere in esse il simbolo vi-
tale (bisogna precipitarsi nella mandria con la lancia in pugno e
trafiggere uno dei mufloni prima che la visione scompaia). Lo
strumento per farlo sarà l'analogia che congiunge ordini di fatti
diversi, apparenze sensibili e verità ideali. A questo punto non si è
più se stessi, persone singole, ma un coro di voci: la molteplicità
dell'universo riaffiora dentro di noi. Questo non è più un gusto
del fantastico, dell'aereo, del sognante, sibbene una ricerca delle
analogie che conduce alla radice della creatività. Guai però a compiere l'operazione con animo impuro, cioè volendone trarre una
consolazione. È questa impurità che Melville rimprovera al trascendentalismo emersoniano, che pure voleva scovare in ogni
tratto del reale un'analogia che consentisse di trascenderlo. Perciò
si irrita a affermazioni consolatorie come questa del saggio di
Emerson, The Poet: «Usiamo i difetti e le deformazioni per un
sacro fine, cosi esprimendo la nozione che i mali del mondo sono
tali soltanto per 1'"occhio maligno", e replica (nelle note marginalia)-. "Che cosa intende quest'uomo? Se il signor Emerson viaggiando in Egitto vedesse affiorare su di sé i segni della peste - lo
considererebbe una vista maligna o no? E se maligna, sarebbe il
suo occhio malvagio perché la vede maligna, o piuttosto, sarebbe
maligno il suo sentimento che usa l'occhio?"».
La volontà di trovare consolazione e di ricevere edificazione, è
contraria alla premessa dell'abbandono. La conoscenza per miti
non si ottiene facendo intervenire la volontà di trasfigurare. Le
analogie peraltro non sono arbitrarie, poiché una tradizione mitologica già le porge al contemplatore. Cosi avviene per ogni contemplazione, che certe immagini religiose mitiche trasmesse dalla
tradizione riaffiorino involontariamente. Ad un uomo «marino»,
cioè sciolto dalla tradizione della sua terra questo equivarrà a lasciar giocare tutte le tradizioni mitiche d'ogni tempo e popolo.
Già i trascendentalisti usarono dei miti indù e il Gòrres fra i romantici tedeschi mirava a creare una sorta di pantheon che comprendesse tutti i miti della terra. Eclettica sovrapposizione? No,
purché si tenga fermo il principio dell'abbandono: i miti riaffioreranno inevitabilmente, mai si dovranno giustapporre per intellettuale volontà di conciliazione [...].
***
«Non permettere che alcun fatto resti tale» è il preceno segreto di
Melville e se in Carlyle e nella poetica dei metafisici o nelle consuetudini dei predicatori puritani che sollecitavano (con Jonathan Edwards) a scorgere negli accadimenti images ofshadows
of divine things (ancorché la logica puritana ritenesse di credere
alla natura meramente ornamentale dei simboli), si hanno dei paralleli, tuttavia il bisogno di trasformare in una continua estasi generatrice di visioni e di associazioni simboliche le realtà visibili,
scaturisce autoctono dall'animo naturalmente religioso di Melville. Religioso in senso proprio s'intende chi ha subito la morte e
ha avuto il dono della rinascita, chi è risuscitato da visioni e patimenti infernali: l'oltraggio smisurato della vita a bordo d'una
nave è una scaturigine di pensieri simbolici, poiché non l'orgoglio, non la volontà di vivere, non la capacità di naturale oblio bastano a fornire la forza necessaria per patire una tale crocifissione.
Valgano le parole d'un monaco della Tebaide, l'abate Evagrio
nella sua operetta Su vani pensieri maligni raccolta nella Philokalia-.
«Attraverso lunghe osservazioni abbiamo scoperto che la differenza tra i pensieri che sono degli angeli e quelli degli uomini e
quelli ancora che vengono dai dèmoni sono come segue: quelli
degli angeli procurano di scoprire la natura delle cose e il loro significato spirituale, ad esempio, a qual fine l'oro fu creato e perché sta sparso come sabbia nelle valli della terra e 11 scoperto con
grande fatica e sforzo? Come mai quando è scoperto viene lavato
nell'acqua, messo nel fuoco e poi giunge nelle mani degli artisti
che ne foggiano per la casa di Dio un candelabro, un incensiere,
vasi dai quali per grazia di Dio non beve più il re di Babilonia, ma
nei quali un Cleofa reca un cuore bruciante per tali misteri (Luca
XXTV, 32). Il pensiero dei dèmoni questo non conosce né comprende, ma svergognatamente suggerisce soltanto l'acquisto dell'oro materiale predicendo il piacere e la gloria che se ne trarranno. Quanto al pensiero umano esso non procura di possedere
né è curioso di sapere che cosa simboleggi l'oro ma introduce
nella mente una nuda immagine dell'oro, senza passione o cupi-
digia. Se un uomo esercita la mente in conformità con questo
esempio, scoprirà che lo stesso ragionamento vale per altri oggetti».
II
Ethdlassa tès ghenéseos sjmbolon.
Il primo capitolo di Moby Dick comincia con una dichiarazione non umana, ma angelica. Cali me Ishmael: chiamami
Ismaele, non già mi chiamo Ismaele. Non ha importanza il nome
del protagonista-narratore, ma ciò che egli simboleggia. Ismaele è
l'uomo che si sa dotato di una superiorità non riconosciuta dal
mondo: il primogenito di Abramo è un bastardo cacciato nel deserto, fra altri reietti; là impara a sopravvivere a questa morte, in
perfetta solitudine, indurito contro le avversità.
L'Ismaele di Melville decide di imbarcarsi, ha poco denaro e
nulla che lo trattenga a terra. È in uno stato di irritazione e inquietudine; la noia è un sintomo di squilibrio e di pietrificazione
delle passioni, un corteggiamento della morte, talché l'accidia e
l'ira sono unite nell'animo di Ismaele come nella stessa palude Stigia gli accidiosi sono arruffati e gli iracondi dritti in piedi con
sembiante offeso. Nell'accidia il sole par fermo, le fonti vive dell'animo sono seccate. Bisogna affondare nell'acqua per rialzarsene. Drìving off spleen, regulating circulation è il proposito di
Ismaele. I pretesti per la partenza, povertà e mancanza di amici,
sono occasioni e non cause, per chi non si voglia puro meccanismo. Che cosa è soggettivamente il destino oggettivo della povertà? Un fermo tedio che chiede la morte.
Tedio espresso da «una piega amara della bocca» e da «un novembre nell'anima», umido e piovigginoso. La pioggia è simbolo
dantesco di peccato, di contrappasso per il peccato, cioè per l'intoppo, la mancanza di fede. Imbarcarsi: my substitute for pistol
and ball, un suicidio dissimulato, una morte rituale [...].
L'acqua attira: se si percorre un viottolo in campagna menerà di
certo ad una polla o a un ruscello, un uomo è tratto come da un
magnete verso le acque, poiché l'acqua e la meditazione sono sposate per sempre. E un pittore che cosa rappresenterà in un paesaggio arcadico? Un ruscello che incatena gli occhi del pastore. E
perché il mare era sacro ai Persiani, perché Nettuno era fratello di
Giove, perché Narciso, non potendo appagarsi della vista blanda
e tormentosa di se stesso nell'acqua, ci si gettò? Nelle acque dei
mari noi cerchiamo quell'immagine.
Ismaele s'imbarcherà come marinaio e non come passeggero.
Non perché ami la fatica, anzi tiene in abominio tutti i «lavori rispettabili». Non ne farebbe alcuno: al più potrebbe fare il cuoco di
bordo. Melville non lascia allo stato naturale, immediato l'immagine del cuoco, ma la media e interpreta. Non piace cucinare la
selvaggina, ma l'atto si può osare grazie al rispetto e alla riverenza
che lo mediano: gli Egizi, attraverso le loro meditazioni sulla selvaggina cucinata, giunsero a costruire quegli enormi forni che
sono le piramidi. Luoghi di morte e rinascita, simili a montagne.
Così Ismaele accetta il decreto del fato che lo manda su una baleniera, illudendosi di voler cercare magari la balena. Decreto insensato? Egli è assegnato ad una parte tragica: all'esercizio di stoicismo necessario per sopportare la schiavitù, gli ordini degli ufficiali, l'indegnità di ricevere pagamento per la sua fatica. Quale il
disegno del destino? [...].
All'inizio di un mutamento dell'anima, osserva Jung, appaiono
sogni e segni di animali: serpe, uccello, cavallo, lupo, leone, drago.
In un secondo momento a queste immagini degli istinti che si debbono affrontare succede una serie diversa: cella, incavo, profondità
di acque, mare. A questi seguiranno fuoco, armi, strumenti, a significare che si sta operando la trasformazione. Il momento cruciale evocherà nel sogno, e nella realtà significante, i simboli dell'ermafrodito, del transito periglioso, della sospensione, dell'aleggiare o nuotare, dell'albero che connette cielo e terra. La rinascita
ed il nuovo equilibrio meridiano saranno indicati da circoli, quadrati, fiori, ruote, soli o, nelle forme negative, da reti e carceri.
Siamo subito, ad apertura del Moby Dick, nella cerchia dei simboli del secondo momento [...].
L'acqua che cinge l'universo, l'Oceano, è un circolo, simbolo
dell'eternità che è fruizione immediata di cose infinite, stato divino (Borges ricorda che è la lettera prima dell'alfabeto ebraico,
Yalef, radice, fonte d'ogni cosa, cioè esistenza per la quale vale il
principio che regola i numeri transfiniti: il tutto non è maggiore
di ciascuna delle parti) [...].
L'acqua che può zampillarci dentro è un'immagine di libertà,
di felicità. Ma può anche essere simbolo di angoscia poiché ogni
simbolo è bifronte. L'uomo che si è chiuso nella sua volontà tenendo a bada come bestie pericolose i suoi istinti, sentirà l'urgere
delle acque interiori come una minaccia [...].
Ili
Il secondo capitolo del Moby Dick trasporta dal «novembre nell'anima» al dicembre che segna la partenza da terra, dal mese dei moni
al mese della rinascita. Qui non domina l'immagine dell'acqua ma
quella del vento che è tanto la «prova dell'aria» dopo la «prova dell'acqua» quanto un'immagine di critica sociale, come sarà nella poesia di Bertolt Brecht: «Di queste città resterà solo chi le attraversa ora,
il vento! La casa colui che banchetta fa beato: ché egli la vuota».
La città di mare dove giunge Ismaele è ventosa e nera come sarà
la Londra descritta in Israel Potter, città di Dite, pullulìo di fiammelle agitate nell'oscurità. Spira un vento gelido nella città dove
Lazzaro trema di freddo e vorrebbe le fiamme dell'inferno piuttosto di sentirsi inazzurrare le mani al vento gelido [...].
Ismaele cerca ospitalità alla Locanda dello Sfiatatoio e all'entrata ravvisa un quadro indecifrabile, dipinto forse da qualche
pittore del tempo della persecuzione delle streghe che si fosse proposto di delineare il caos. Massa nera schiumosa, lievito e melma:
forse the hreaking up ofthe iceboundstream of Time.
Ancor qui un oggetto, il quadro astratto. Bisogna interpretarlo
abbandonandosi alle associazioni: caos primigenio, poltiglia,
massa nerastra. Non basta, si deve «fare un involontario giuramento in sé di scoprirne il significato». Seguono altre associa-
zioni: il mare sconvolto dall'uragano, la lotta dei quattro elementi. Ed ecco l'illuminazione: il fiume del tempo congelato che
si rompe. Immagine di affrancamento: «Una volta che questo si
scopre, il resto è chiaro»; è il padre-leviatano stesso che cozza contro una nave. Liberazione è distruzione, si rischia di morire al momento della rivelazione. Infatti chi, leggendo le parole, poniamo,
di Pierre de Caussade, non s'allarma? Affidarsi allo spirito che
«spira dove vuole e non sai dove vada né di dove venga?».
Senza leggi, senza certezze? E se il Dio tradisce, se ci si trova nel
male? Se il padre in noi non è conciliato con noi?
L'acqua di vita si scioglie dalla presa del ghiaccio e appaiono le
immagini di strumenti, s'è visto, segno di passaggio ad una fase
ulteriore; la locanda dello sfiatatoio ha una collezione di arpioni,
di mazze e lance.
Per dormire nella taverna Ismaele dovrà acconciarsi ad un
compagno di letto, dopo il vento glaciale troverà ristoro e tepore
ma a una condizione che gli ripugna, poiché detesta non poter
dormire nella sua pelle.
Ismaele dovrà dormire con il selvaggio Quiqueg, che adora un
idoletto grottesco in forma di feto. Dovrà subirne l'abbraccio
quasi maritale.
Ricorda che da bambino veniva confinato a letto per punizione
(solitudine imposta dalla madre) e che una volta dovette aspettare
parecchio per risorgere e gli parve che una mano si posasse sulla
sua sopra la coperta, infondendogli terrore. Cosi il braccio di
Quiqueg lo cingerà: la mano sovrannaturale dell'infanzia, il braccio innaturale della prova iniziatica si fondono.
Dopo gli strumenti appare l'ermafrodito, segno della terza
fase. Ismaele e Quiqueg formano una coppia, innaturale; sono
elementi diversi: il nero e il bianco, il selvaggio e il civile, l'inconscio ed il conscio. Quanto sia palese l'accenno all'innaturalità
della situazione è superfluo dire (Ismaele ricorda le sculacciate
dell'infanzia, Quiqueg reca un arpione) [...].
Per Ismaele il passaggio alla vita vivente, alla liberazione è facilitato dalla sua capacità di affrontare il suo inconscio, pur fra i mille
terrori che questo comporta. Egli deve conciliarsi con ciò che si
nasconde in lui, con la sua infanzia; con la mano spettrale che
s'immaginò di sentire posata sulla sua un giorno dell'infanzia, a
profondità terrificanti della sua memoria.
Egli dovrà conciliarsi con ciò che lo sgomenta, lo atterrisce, lo
disgusta e che pertanto mostra di essere parte di lui da lui ricacciata e osteggiata, dovrà, dinanzi ad essa, evitare di darsi sentimento di sorta.
[...] Vincere la paura non significa solo affrontare l'ignoto, abbandonare la città, ma anche smantellare le difese interiori, le corazze che si sono indossate a difesa del mondo, sciogliersi dalla paralisi e dai gesti di allarme. Allora crollano le paure del nuovo e
dello strano e dello straniero, si ravvisa proprio in ciò che ha ripugnato ciò che attrae. Si è liberi di «accordarsi ai magneti», si è acquistata la virtù dell'abbandono; le acque del tempo sono state
sciolte, il gelo è stato vinto dal fuoco [...].
La prima tappa dell'iniziazione di Ismaele è compiuta, egli si è
sciolto dalla noia, dalla paura, dal risentimento e dal rispetto sociale, ha vinto le anchilosi e le coazioni, ha inserito nel suo cielo
mitico anche i miti di Quiqueg (l'idolo, gli usi delle isole del Sud)
IV
A preparare Ismaele e il lettore a questo disgelo del fiume del
tempo c'era stato un intermezzo: la predica di padre Mapple nella
cappella dei balenieri, il sermone sul Libro di Giona. Dapprima il
pastore aveva fornito una spiegazione devozionale comune:
Giona non aveva, per ubbidire a Dio, disubbidito a se stesso. Poi
aveva dischiuso il significato riposto del mito: rifiutarsi di predicare a Ninive e cercar l'imbarco per Tarsis significa non aver capito la virtù dell'abbandono e del rifiuto d'ogni consolazione:
«Guai a colui che tenta di versar olio sulle acque quando Dio le
fermenta in burrasca! Guai a colui che tenta di piacere invece di
atterrire! Guai a colui che in questo mondo non corteggia il diso-
nord». Nel poema Clarel il canto di Sodoma riproporrà questa
idea del male: Sodoma è inghiottita nella terra oggi mefitica perché in essa vissero peccatori, ma la loro colpa «non fu tutta carnale» [...].
Mansuetudine e tremore nel cuore ci vuole per affrontare il rischio di vivere secondo l'ispirazione, cioè disponendosi a rispettare i segni di Dio che il destino offra, a essere abbeverati dalle
acque di vita. Questo l'insegnamento che Ismaele riceve a terra,
sicché quando s'imbarca per la crociera gli sarà agevole comprendere (capitolo XXIII) che «nel porto c'è sicurezza, comodità, focolare, cena, coperte calde, amici, tutto quanto è caro al nostro
stato mortale. Ma in quel vento di burrasca, il porto, la terra, sono
il pericolo più crudele per la nave [...] che precipita per amor della
salvezza perdutamente nel pericolo: il suo unico amico è il suo nemico più accanito [...] verità intollerabile [...] che ogni pensare
serio e profondo è soltanto l'intrepido sforzo dell'anima per mantenere la libera indipendenza del suo mare mentre i venti selvaggi
della terra e del cielo cospirano a gettarla sulla costa servile e traditrice. Ma siccome nell'assenza della terra soltanto sta la suprema
verità senza rive, infinita come Dio, così meglio è perire in quell'abisso ululante che essere vergognosamente sbattuto sottovento,
anche se in ciò fosse la salvezza».
I contenuti nuovi che affiorano dall'inconscio sono rischiosi,
sono vivi perché ambigui. Ma proprio perché ci si difende da essi,
hanno un carattere tremendo e pauroso. Proprio perché non ci si
è purificati dalla paura e dalla sua compagna astuzia, dal panico
che detta il gesto di offesa e di difesa nonché dall'obbedienza alle
norme della comunità proprio perciò il contatto con le acque di
vita è fonte di orrore e sgomento.
Segue alle due rivelazioni, la verbale e discorsiva di padre Mapple e la reale e tangibile di Quiqueg, un interludio giocoso, che
potrebbe apparire insensato. I due compagni dioscuri stanno in
una locanda dove si mangia solo pesce, dove tutto è fishy: che significa, proprio del pesce, scivoloso, viscido; dove si mangiano
telline, clams, che rendono tutto clammy, appiccicoso, umidiccio.
Tali bisticci insistiti significano che la convivenza con il nobile
selvaggio, le esperienze che toccano in virtù dell'abbandono alla
propria natura sono tali da far rabbrividire, raccapricciare la sensibilità neurotica. In antico nei riti misterici ampia parte avevano
i serpenti sacri, che si dovevano attorcere attorno al neofita: lubrichi animali, pelli viscide e umidicce che si sopportano soltanto
quando interiormente ci si sia sciolti dai ribrezzi difensivi, dal panico pauroso. Quando non serpenti, sangue e strida.
La scuola della spontaneità, dell'imprevedibilità, della naturalezza, può produrre un uomo capace di pensare untraditionally
and independently, «ricevendo tutte le impressioni dolci e selvagge, fresche dal seno virginale, volonteroso e confidente della
natura», imparando un linguaggio «ardito, nervoso e alto» [...].
V
La nave Pequod sulla quale s'imbarcano i due amici è simbolo
della società. La società è rappresentata dalla nave quando se ne
vuole indicare il carattere instabile dissestato, sennò sono la città
o il giardino a costituirne l'immagine. Ora il Pequod è un'azienda
azionaria; coloro che tengono il potere sono pochi (nel caso: Bildad e Peleg), e la loro mente utilitaria ama rivestire di ipocrite ragioni lo spietato sfruttamento. Sono mandatari d'una folla di piccoli risparmiatori e a quelli rispondono della loro amministrazione efferata, fredda, frutto dell'avarizia spinta all'impersonalità.
Ma chi dirige l'azienda non risponde al meccanismo dell'avarizia, l'imprenditore e tecnico rappresenta qualcosa di diverso dal
capitalista. Colui che comanda il Pequod, la società aziendale e
utilitaria, è Ahab.
Egli salpa il giorno di Natale, quando le linfe cominciano a risalire i calami delle piante; viene paragonato a Perseo, l'eroe solare
per eccellenza, e naviga verso i mari caldi, deciso a circumnavigare
il globo, come il sole. È il sole, o l'eroe solare della nuova società.
Che cosa lo rode e spinge innanzi? Non il guadagno, non l'avventura per se stessa e nemmeno un impulso mitico. È la ricerca della
balena bianca. Ma che significa? È, la balena, la materia che la baleniera trasforma in merce, ma Ahab ha trasformato la produzione in un fine a sé [...].
Ahab è la produzione fine a se stessa, fatta dio. Egli «fatica inconsciamente» di continuo, anche quando pare riposarsi a fumare la pipa. Non ha bisogno delle istituzioni consuete del rispetto, della fedeltà, delle maniere consacrate (dei residui feudali,
familiari non ha infatti strettamente bisogno la società borghese),
ma «non trascurava le forme e le usanze essenziali [...]» e «dietro a
queste forme si mascherava, adoprandole per altri e più privati
fini che non quelli cui esse dovevano in legittimo servire». Ahab
inganna con una parvenza di rispetto verso le forme consacrate di
vita, come lo Stato borghese. Ahab stringe in suo potere la società
soprattutto grazie ai discorsi esaltati e alla distribuzione di liquore. L'artificio del rispetto gerarchico ereditato da altre forme
sociali è indispensabile («per questo i veri princìpi dell'impero di
Dio sono trattenuti dal prender parte ai comizi elettorali, lasciando i più alti onori agli uomini che si rendono famosi più per
la loro infinita inferiorità a quel pugno di uomini scelti dal Divino Inerte, che non per la loro indubbia superiorità al morto livello della massa»).
Ahab, ridotto ad un ronzio di meccanismi vitali al servigio
della sua ossessione è però anche profondamente ferito. La produzione fine a se stessa è simboleggiata dal suo inguine offeso che
non gli impedisce di procreare, dalla ferita per fuoco che lo solca
in viso.
Eroi claudicanti sono nella mitologia i maestri del fuoco,
Odino, Edipo. In genere nella mitologia classica sono gli eroi appartenenti al draconteum genus, che perseguono una saggezza solare ma sono legati ancora alla terra paludosa (e quindi incapaci di
camminare scioltamente). Ahab è legato al fuoco, ma non al
fuoco come oggetto di contemplazione pura sibbene al fuoco che
brucia, al fuoco che incendia. Il fuoco che non dà luce ma arde e
consuma è non già Febo ma Fetonte, ed è legato a un'idea del sacrificio cruento e barbarico più che all'idea dell'illuminazione
umana e solare [...].
Ahab usa dello stesso intruglio magico dei dittatori: rispetto
verso un minimo di consuetudini avite, invito al disprezzo e all'esaltazione fredda mediante discorsi isterici. Il dilemma fra l'odio e la pietà e l'ossequio che infierisce nel cuore di Starbuck è lo
stesso che ha dilaniato il cuore dei buoni borghesi europei nelle
dittature. L'obbedienza da giocatore o da meccanico di Stubb e
Flask è la stessa che ha fatto marciare gli eserciti totalitari. Il rapporto dei capitani d'industria Peleg e Bildad con Ahab (che pare
condurre una crociera per loro conto ma in realtà agisce al di
fuori del loro calcolo economico) si riproporrà fra gl'industriali e
i dittatori.
La ciurma cerca tuttavia la festa, che tolga all'obbrobrio quotidiano del lavoro alternato da scoppi di isteria durante le adunate
in coperta. Ma come possono conoscere l'abbandono festivo le
masse? Melville compone la scena stupenda della notte di baldoria sul castello di prua [...].
Un marinaio francese esorta il mozzo negro idiota, Pip, a suonare il suo tamburello affinché tutti possano ballare. È l'inizio del
divertimento dell'èra industriale, macabra finzione di allegria.
You havegot to bavefuri whetheryou like it or not. L'idiota rifiuta,
ma il marinaio francese imperversa, e a furia di esortazioni la
ciurma si mette a ballare. Invano risuonano echi di nostalgia per
le vere feste, che vogliono un palchetto solido, la terra ferma sotto
i piedi. Bisogna darsi vena, si strappino i sonagli, si faccia frastuono, ci si stordisca nella finzione della festa! [...].
È il principio dell'industria del divertimento per voyeur; il pagano risponde evocando le danze religiosamente ordinate delle
sue donne ignude: Holy nakedness ofour dancinggirls, irrevocabilmente perduta innocenza e solennità, rituale celebrazione smarrita da chi è ridotto alla scurrilità disperata.
La tempesta riporta all'opera i marinai, per affrontarla l'unico
fuoco disponibile è l'alcol distribuito da Ahab.
Il battesimo del fuoco che segue al battesimo dell'acqua è il
grog, ignis ex aquis alla misura della ciurma.
La tecnica di comando di Ahab è, come si è detto, quella del
dittatore dell'èra totalitaria [...].
Starbuck osa domandare quale profino si trarrà dalla crociera
contro Moby Dick, dalla produzione esasperata e Ahab dice: «tu
hai bisogno di una parola un po' più profonda». Per la massa è sufficiente l'eccitazione magnetica, il giusto dosaggio di fùria artificiosa, di droghe tollerate (il grog) e di rispetto verso gli usi generali [...].
VI
Ismaele è stato cancellato, la sua persona è sparita, basta il suo
sguardo attento a ciò che avviene attorno a lui, capace di non
frapporre alcun vapore importuno fra sé e la realtà sociale nella
quale è calato, il microcosmo-Pequod. Ismaele cede il suo posto
alle cose stesse: il segreto per arricchire vertiginosamente. Gli
compare quindi tutto il reale in un guscio di noce: la nave (non la
città o il giardino), la società che si esprime massimamente nella
società per azioni cioè nella combinazione dell'avarizia e della
frode, onde in nome di una moltitudine di miseri risparmiatori
un gruppo di despoti esperti del calcolo minuzioso e sopraffatore
regge la comunità ridotta ad azienda. Ma chi incarna lo spirito
dell'azienda-società è Ahab, colui che magnetizza la massa degli
sradicati, che rimesta nel crogiolo di tradizioni smozzicate e di felicità infrante [...].
Il groviglio delle responsabilità inestricabili della nuova società
industriale è creato, è un meccanismo simile alle macchine di cui
si serve: «la mia ruota dentata s'adatta a tutte le loro varie ruote...
io mi precipito infallibilmente!», Ahab è stato falciato da Moby
Dick: la natura in lui è ferita, alienata e per placare il dolore della
mutilazione, per far cessare il rovello «inconscio» quando non palese, egli agisce; (capitolo XLI): «il suo intelletto naturale, che era
stato un agente vivente, divenne uno strumento vivente» [...].
Il rapporto fra il potere economico e il delirio ideologico è così
chiarito: «È abbastanza probabile che lungi dal perdere fiducia a
motivo dei sintomi così foschi nella sua attitudine ad un altro
viaggio di caccia, la gente calcolatrice di quell'isola prudente fosse
invece incline all'idea che proprio per quelle ragioni lui era anche
meglio indicato e assettato per un'impresa cosi piena di furore e
ferocia».
La natura in antico veniva riverita, oggi viene aggredita senza ritegni, ogni traccia di divinità, cioè di inconoscibilità è in essa sparita. Come l'uomo si atteggia a domatore di circo con i suoi istinti
e li tiene a bada con la frusta della volontà così si atteggia a domatore della natura la quale pertanto diviene incrocio di ruote, gioco
di elementi da sfruttare e nulla più. Quale il colore della balena,
della natura? Il bianco. Quali le associazioni del color bianco, del
candore? Melville le elenca con minuzia, le incarnazioni ora tremende ora benigne del «mutismo e dell'universalità», della sconfinata estensione, del «mistico cosmetico, il gran principio della
luce».
Il capitolo sul candore è insieme un incantesimo e una litania:
una compiuta operazione di conoscenza per simboli.
La conoscenza per figuras s'avvicina assai di più delle definizioni logiche a spiegare un universo appassionato, un cosmo vivente, e «una rivelatrice pantomima d'azione» superiore ad «un
domestico capitolo di parole».
Quale il metodo seguito da Ahab per dominare la natura? Egli
deve sottrarle la sua qualità essenziale, l'imprevedibilità. Perciò
costruisce una complessa carta delle migrazioni dei capodogli,
come una rete statistica e induttiva che dovrebbe delimitare, rendere prevedibile la natura mediante «ragionevoli congetture,
quasi certezze». L'arma dello scienziato e tecnico moderno è il
concetto di probabilità e di media statistica.
Ma per dominare la natura, osservava Hegel, l'uomo deve dare
in pasto se stesso. Così Ahab sente nel sonno aprirsi abissi d'angoscia. La loro causa? La razionalità stessa che si converte nel suo
contrario, nel terrore senza fondo. «Il principio o spirito eterno
vivente in lui» veniva nella veglia «impiegato dalla ragione discriminante come suo veicolo o agente esterno», nel sonno pigliava la
sua rivincita diventando un avvoltoio che è la creatura stessa che
egli ha creato [...].
Ahab ha rinunciato a intravedere di là dell'orrore meccanico il
fulgore, o almeno il barlume dell'orfica pace, della Tahiti o regione delle cose che risplendono, perfette nel mondo esterno e
«più perfette» nel fondo dell'anima. Ha convertito tutto l'universo in forza, rinunciando al lume naturale, e la forza è pura immaginazione, poiché esclude il momento contemplativo, che sta
fuori della forza.
Il processo lavorativo diviso per specialità è lo sfruttamento
dell'oggetto naturale spogliato di tutti i suoi attributi simbolici,
privato della sua aura, non più contemplato ma solo modificato;
una balena sfruttata a modo è un esempio capitale. Non a caso
molti capitoli del Moby Dick sono dedicati a tale descrizione, ma
mossa da riverenza, poiché: «Oh Natura e tu anima umana!
Come le vostre analogie si distendono oltre quanto è dicibile!
Non il minimo atomo si muove o vive nella materia, che non
abbia il suo sottile riscontro nello spirito!».
Il lavoro per Melville è liturgia, decifrazione di simboli nelle
operazioni materiali. La testa fragrante di spermaceti non è analoga al regno delle idee platoniche, affogarvi non è rischioso
quanto calarsi nella contemplazione? La parte più preziosa della
balena, è lo spermaceti profumato, l'essenza libera dell'universo,
l'acqua di vita, che mette in stato di benigna estasi o grazia.
Ma tali operazioni paiono inessenziali a Ahab, nulla lo impegna fuorché l'operazione massima, l'uccisione. Egli è simile al re
Ahab del Libro dei Re, che a dispetto dei prodigi di Elia sul monte
Carmelo (Elia vi fa scaturire acqua e accendervi fuoco), è legato al
culto di Baal.
Quale il dramma segreto di Ahab? Lo dice egli stesso in un monologo {Tramonto), che nessuno della ciurma gli contrasti il
passo, che tutti s'adattino come ruote d'un meccanismo: il
dramma del dittatore. Ma Ahab è insieme il dittatore e l'uomo
per eccellenza moderno, scisso dalla natura e di ciò che ha coscienza, salvo che, come Baudelaire, esalta la sua jattura come
segno di elezione: «Oh! C'era un tempo che come l'aurora nobilmente m'incitava, così il tramonto mi portava sollievo. Ora non
più. Questa bella luce non rischiara più me: ogni bellezza mi è angoscia dacché non posso più goderla. Dotato della percezione superiore mi manca la bassa potenza di godere: sono dannato cosi
nel modo più sottile e perverso» [...].
Per Ahab invece la natura è soltanto l'ostacolo contrapposto all'io, una maschera di cartone da trafiggere. La natura egli la sente
soltanto nell'urto, nell'opposizione della sua forza alla forza della
natura (che non è propriamente una forza, poiché non ha una coscienza che per contrasto la faccia apparire forza). Starbuck vive a
metà fra il mondo della comunione, del rispetto e della riverenza
per la natura ed il nuovo mondo meccanico di Ahab, è diviso fra
odio e obbedienza verso il suo capo. Ma proprio per la sua qualità
mezzana gli è consentita la pietà, lo smarrimento partecipe della
sventura che Ahab vive interamente, porta alle ultime conseguenze [...].
VII
Si avvicina la stagione dell'Equatore, Ahab sta misurando la latitudine mentre il sole imperversa: «la nudità immutata dei raggi è
simile agli splendori insopportabili del trono di Dio» dice una
frase che par tratta dallo Zohar. Ahab sta con «il suo strumento da
astrologo all'occhio», mentre il Parsi dell'equipaggio fissa il sole
«soggiogato, con una terrestre apatia» [...].
Ahab è un adoratore del fuoco che non vuole più dirigersi secondo il corso zodiacale del sole determinato dal quadrante o
gnomone. Egli adora il fuoco infernale e non il celeste.
Gli eroi solari delle mitologie rappresentano il superamento
della natura palustre, matriarcale, che appare «fangosa» all'uomo
civile. Apollo, Ercole, Mitra sono compiuti eroi solari mentre
Dioniso è una conciliazione dell'acqua col fuoco, della vita animale e naturale ed estatica con la conoscenza. Il passaggio dal matriarcato alla solarità olimpica è rappresentato da eroi claudicanti
come Edipo. Il contatto col fuoco è ambivalente, può essere contatto con una furia suicida o con una purezza contemplativa, e i
personaggi zoppi, segnati dal fuoco rappresentano il carattere sinistro del contatto [...].
Ciò che danna Ahab è la sua adorazione puramente demoniaca
del fuoco, il suo ripudio del sole, la sua rinuncia a guidare il suo
corso sulla posizione del sole nello zodiaco [...].
Le dodici categorie-simboli dello zodiaco sono abbandonate
da Ahab, e si avvera la maledizione che Shakespeare presagiva per
l'uomo che avesse abbandonato l'asse che non vacilla, il firmamento, nella famosa allocuzione di Ulisse nel Troilus and Cressida;
il potere, universale lupo, divorerà tutto e poi divorerà se stesso,
poiché nulla riconoscerà che abbia valore eterno, nemmeno le orbite degli astri e le favole che sono connesse ai dodici segni e celebrate negli anni liturgici, nell'opera agraria. Su quell'ordine non
dirigerà il suo corso.
VIII
In Moby Dick è raffigurato l'uomo nuovo, che non è come Ahab,
demoniaco, l'uomo che il mezzo ha trasformato in fine: il maestro
d'ascia che rifa la gamba di legno ad Ahab, uomo d'una stolidezza
senz'anima, preparato in tutto, indifferente a tutto, per il quale i
denti sono pezzetti d'avorio, le teste bozzelli di gabbia, gl'individui argani, lui stesso una ruota che emette un ronzio quando
parla, il suo stesso corpo una garitta.
In Mardi era descritta, apparenza sensibile che è simbolo della
stortura onde si divide mezzo da fine, la fabbrica inglese ottocentesca. I pellegrini che cercano la felicità in terra (cioè Yillah la
donna angelicata), giungono a Do minora, l'Inghilterra:
Muovendo i nostri passi verso la valletta, ruggente per le rocce,
scorgemmo un torrente che scendeva dai monti. Ma prima che
quelle acque giungessero al mare, pagavano un tributo di vassalle.
Piegate per condotti e fossi, spingevano grosse ruote, dando vita a
diecimila zanne e dita, la cui presa non c'era forza che reggesse, e il
cui tocco era tuttavia morbido come vellutata zampa di gattino.
Con brutale potenza trasportavano ingenti pesi, simili a proboscidi che abbattono ippopotami eppure sentono i battiti d'una
tarma. Da ogni versante d'attorno, spingendo fuori a ogni giro
meravigliosi parti, incessanti come i cicli che ruotano in cielo.
Alto mormorava il telaio, volteggiava come folgore il volano, ruggiva rossa la tetra foggia, risuonava incudine e mazza, ma non si
vedeva un mortale.
«Olà, mago! Esci dall'antro!»
Ma sordi furono i fusi, come i muti che sordamente servono il sultano.
«Poiché siamo nati, vogliamo vivere!» leggemmo su una bandiera
purpurea che scherniva le nubi purpuree, all'avanguardia d'una
torma dai berretti rossi, che corse dinanzi a noi allora usciti dalla
valletta. Ne seguivano altre; nere o macchiate di sangue: «Mardi
appartiene all'uomo».
«Abbasso i proprietari di terre.»
«Adesso è la volta nostra.»
«Viva i diritti! Morte ai torti!»
«Pane, pane!»
«Approfittate della marea prima che si ritiri!»
Sono pagine scritte nel 1848. La torma è guidata da tre maschere,
che la menano verso i palazzi, ma badano a disperderla fra fossi e
selve, sicché possa essere assalita e rotta dalle guardie del re.
Lo strumento giganteggia; si evoca il suo creatore ma invece
compare la turba degli uomini impazziti per i suoi effetti. Chi è il
mago? La risposta vien data da Melville nella novella The BeliTower, dove si narra del grande artefice leonardesco Bannadonna
che crea un congegno perfetto destinato a rovinargli addosso. È
una novella che ha elementi figurativi quali solo il surrealismo riproporrà nei suoi paesaggi di frantumi accampati nei deserti (e
non a caso doveva essere Max Ernst a illustrare Mardi). Che cosa
è il peccato di Bannadonna? Lo stesso del dottor Rappaccini di
Hawthorne, l'aver ridotto la scienza a empietà sperimentale.
Come creò Bannadonna il suo congegno meccanico, il suo
Golem?
Badando a «risolvere la natura, a insinuarsi furtivo in lei, a intrigare di là da lei, a procurare che qualcun altro la riducesse in
mano sua?». No. «Questo non era stato il suo fine; bensì senza
chiedere favori ad altri elementi o esseri, da solo rivaleggiare con
lei, superarla, dominarla. Si piegava per conquistare. Per lui il
senso comune era teurgia; il macchinario miracolo; Prometeo il
nome eroico del macchinista e l'uomo il vero Dio.» Il mago è lo
scienziato moderno, che non badò a solve natureo stealinto hersecondo la «sottile idea dei visionari metafisici per cui fra le forze
meccaniche più sottili e la più grezza vitalità animale si può scoprire un germe di somiglianza», e nemmeno a intrigue beyondher
ovvero a operare come gli alchimisti secondo le affinità fra il
mondo interiore dell'uomo e quello esteriore, e tanto meno a procure someone to bindheràót a sollecitare l'intervento di Dio come
i sanguine theosophists. Il vero mago è il filosofo del senso comune
borghese, John Locke. Per lui l'uomo è una tabula rasa, che riceverà con mortuaria purezza, con passività di mummia l'impronta
delle sensazioni. Quale il modello d'una tale rappresentazione
dell'uomo? Melville lo indica nel Tartarus ofMaids-. la carta che
esce da una cartiera in una desolata valletta inglese è la poltiglia rimescolata da ragazze intisichite, ed esce bianca, pronta a qualsiasi
uso, dalla loro sofferenza, come sperma per matrici [...].
La macchina non è più il simbolo rotante dell'eterna pace ma
una ruota che dirama ad altre ruote il suo movimento, è ruota e
linea infinita insieme: simbolo di morte vivente. Questo videro
Blake e Melville.
La natura diventa il mezzo dell'affermazione dell'uomo, l'uomo
si riduce a mezzo dei fini oscuri della natura.
Come liberarsi?
La questione era anche biografica, in Melville. Cioè era la sua
stessa vita in questione: che senso aveva aver subito, dopo i rovesci
di fortuna dovuti alle crisi della prima industrializzazione dell'America, la più turpe miseria, l'essersi dovuto imbarcare su navi orride infestate dalle ciurme di sradicati brutali, l'avere poi scorto la
fulgida bellezza delle isole del Sud, oasi di grazia e di gioia nel
mondo dominato dallo spirito commerciale (oasi che Engels nell'Origine della famiglia additerà come mèta e ritorno dell'umanità
dopo la fase comunista), per poi tornare ancora una volta all'obbrobrio della vita sulle baleniere, l'aver dovuto affrontare ancora la
solitudine e miseria in patria? Erano prove che l'avevano maturato?
Ma allora quali insegnamenti erano chiusi in quei simboli? I trascendentalisti potevano insegnare a distogliersi dalla turpe realtà
nuova immergendosi nella panica natura, ravvisando simboli dell'armonia universale in ogni particolare, anche nei più triviali (nel
fumo del sigaro il ritmo di espansione e ritrazione, di emanazione e
ritorno al centro), Melville rifiuta con sdegno la facilità di questa ricetta. Come si può cancellare il dolore con la contemplazione?
Afferrare i simboli necessari era sua missione, ma non consolarsi o consolare. Doveva comprendere, non cercare ristoro. Che
cosa significa una nave che veleggia verso le balene? Che cosa significa l'industria dello sfruttamento della balena in mano agli
imprenditori quaccheri del Nantucket? Che cosa significa essere
uccisi sul lavoro? Che cosa spinge gli uomini a quell'impresa?
Non gli bastava la conoscenza discorsiva, le formule filosofiche
e dileggiò i filosofi in Mardi. Né gli bastava la soluzione politica
dei mali, il credo democratico, dileggiato parimenti. Che senso
aveva il tempo se non esisteva un punto archimedico fuori di esso?
E quale poteva essere un tal punto se non l'eternità?
Quindi tutto ciò che in terra esiste deve essere figurazione dell'eternità e del tentativo di attingerla. Tutto ha un senso solo se
posto in rapporto con l'illuminazione.
***
Quale l'orizzonte in cui si muove l'uomo?
L'orizzonte che cinge il mare: «ondulato come il vasto serpente
dalle mille pieghe che avvolge il globo» è cioè il serpente che si
morde la coda, l'uroboros, la compiutezza: Dio che è circonferenza il cui centro è in ogni luogo. La sfera è simile alla coscienza
nel cui ambito si muove l'uomo, e Melville in Mardi si dichiara
«intento all'essenza delle cose, il mistero che sta oltre, agli accenni
di pianto che troppo riso ridesta, a ciò che sta sotto l'apparenza,
alla perla preziosa che sta dentro la ruvida ostrica [...]. C'è un
mondo di meraviglie entro la sfera della coscienza spontanea [...]
un mistero nell'ovvio e tuttavia un'ovvietà nel mistero».
«In un ritiro impenetrabile dorme l'universo, rotondo, cinto
dallo zodiaco, cerchiato dall'orizzonte, avvolto dal mare, fasciato
di scogliere, inchiavardato da monti, annidato fra pergole, recinto da regalità, serrato nelle proprie braccia, stretto fra sé [...],
polpa fra scorza e scorza, scintilla più segreta del rubino, seme fra
nidi di succo nell'arancia dalla scorza dorata, regale rosso nocciolo della femminea pesca; inspirata sfera delle sfere.»
Melville rinuncia al pensiero discorsivo del suo tempo e alla
narrazione realistica (o meglio, direbbe Borges, nominalistica) e
si abbandona all'associazione sui simboli.
La prima contemplazione dello zodiaco è in Marcii-.
Come il sole per divino influsso ruota per l'eclittica, infilando
Cancro, Leone, Pesci e Acquario, cosi per mistico impulso sono
mosso a questo progresso veloce fra gli atolli, cintura di bianche
scogliere attorno a Mardi. Lettore, ascolta! Ho viaggiato senza
carta; con il compasso e con lo scandaglio non avremmo trovato
queste isole di Marcii. Chi si butta con coraggio getta tutte le gomene; e allontanandosi dalla brezza comune, che vale per tutu,
gonfia le vele con il suo fiato.
La ricerca della verità come scoperta vuole che si stia soli dinanzi
al mondo, l'illuminazione non è collettiva, per sua natura. Bisogna abbandonare ogni concetto noto, bisogna ignorare ogni conoscenza morta per trovare ciò che vive e dà vita. Bisogna che si
muoia per rinascere, che si sia divinità solari. Cioè che si viva
come il sole attraverso lo zodiaco. Questa è la radice della saggezza
secondo YEpinomis di Platone.
Ahab configge all'albero (capitolo XCIX) un doblone equadoriano, dell'Equatore o cinta della terra, con uno zodiaco che cinge
tre monti.
Ciascun membro della ciurma interpreterà come potrà. Il sole
è come il vetro del mago che rispecchia il contemplante ed il suo
periplo nell'anno attraverso i segni significa che l'uomo non deve
vivere in pace ma nella sofferenza, poiché è nato nelle doglie.
Stubb, che è l'uomo ridotto a giocatore, che accetta la vita come
partita, leggerà nello zodiaco la vicenda dell'uomo generato nella
libidine dell'ariete, spinto avanti dalla cornata del toro, straziato
fra i gemelli virtù e vizio, ma assalito alle spalle mentre si dibatte
fra i due dal granchio o Cancro, che trascina indietro a dove il
leone assesta una zampata e dà un morso; la vergine ristora con il
primo amore, ma con la bilancia la felicità ch'ella ha largito si mostra mancante, e allora lo Scorpione ferisce e l'arciere saetta e l'acquario inonda finché si trova pace mortale fra i pesci.
Ma non è certo questo, giocoso e macabro, lo zodiaco che irraggia dai tatuaggi del puro selvaggio Quiqueg. Ma Quiqueg non
saprebbe mai ormai più interpretare i segni che porta tatuati sul
corpo.
Nessuno sulla nave, cioè nella società, sa che cosa sia il destino
dell'uomo: lo zodiaco è diventato privo di senso.
La perdita dello zodiaco è la perdita che grava sull'uomo per la
colpa di Bannadonna: di Newton e di Locke.
La bestemmia di Stubb che dileggia il destino dell'uomo segnato nei cieli con bravata di giocatore è assai più tremenda della
bestemmia di Ahab che battezza il suo arpione in nomine diaboli.
«Paragone», n. 128, agosto 1960.
Appunti sul futuro
L'inoltrarsi comporta certi rischi: molte certezze
storiche ci sembreranno una fila di cartoni da
teatro, e svaniranno per lasciarci a tutta prima in
un gran buio [...]. D'altronde questo sgomento
bisognerà presto o tardi affrontarlo comunque,
perché l'idea progressista della storia è già stata
confutata. La cattedrale inghiottita d'un'età
dell'oro, scientifica e religiosa, è riemersa agli occhi
degli studiosi...
Introduzione a Marius Schneider,
Il significato della musica
Ogni mistica delle ère future, da ogni parte della
terra, nel Tao-te Chingtiovz. tutti i suoi principi e le
sue certezze. Ma anche la saggezza mondana trova
in queste pagine deliziose le sue verità segrete.
Dai Taccuini
Nota introduttiva
Nel dicembre del 1992 si svolse a Orvieto un convegno internazionale su un tema che, al di là degli aspetti tecnici noti agli allora
pionieri in materia, scatenò nei primi anni Novanta infuocati dibattiti sulle implicazioni di un avvento ritenuto socialmente pericoloso dai più, neutro secondo taluni e seducente oltre ogni dire
485
per pochissimi tra i quali Zolla, attorniato quella volta da sociologi come Alberto Abruzzese, ingegneri informatici come Vittorio Fagone, fdosofi come Mario Perniola, artisti tedeschi e italiani
e molti altri (gli Atti sono raccolti in Realtà virtuale: nuovi linguaggi dell'arte, a cura di Ribes Veiga, Elart, Orvieto 1992).
I sei testi radunati in Appunti sulfuturo mettono in piena luce
riflessioni, congetture e previsioni di Zolla, sull'effetto globale
che potrà scaturire dagli usi e gli abusi della realtà virtuale nel secolo XXI. «La concezione meccanicistica» andava ripetendo «sarà
cancellata. Si dovrà accedere a un'intelligenza formale a partire
dal principio d'informazione. Il senso dell'io si verrà stemperando. Ma in gioco non ci sarà soltanto l'indurito io occidentale,
bensì anche il concetto di "realtà". L'idea riverita di "concretezza"
non sarà più la suprema istanza.»
Il reale illusorio: una diversa recita
Attorno al 2030 sarà sovranamente dominante l'intelligenza robotica, cosi rapida rispetto all'umana che si avvia a esserne guidata. L'uomo apparirà svelato in tutta la tardità e goffaggine che
gli sono proprie.
Ogni enunciato verbale è destinato a essere sviluppato in tutti
i sensi possibili; si stanno preparando in Giappone programmi
computeristici logici e rettoria che potranno esplorare l'intero
arco delle deduzioni a partire da qualsiasi affermazione e sapranno anche rivestire i discorsi con tutti i colori previsti da Ermogene di Tarso.
L'uomo sarà così allontanato dalle attività dove il suo impero
sembrava incrollabile; la parola sarà manipolata, il culto del verbo
computerizzato: liquidato.
Potrebbe costituire uno stupendo vantaggio, se sussistessero
menti in grado di concentrarsi sullo scopo massimo, decise a raggiungere la condizione dell'uomo liberato, quale fu tante volte definito e descritto nella letteratura vedantica. Se tutte le possibilità finora aperte saranno dimesse, altro non dovrebbe rimanere all'uomo
che incamminarsi sulla via che finora barlumava sul filo dell'orizzonte e sembrava quasi irraggiungibile. L'intera forza della sua
mente a questo punto dovrebbe volgersi all'idea del liberato in vita,
nel quale il sonno è presente nel pieno della veglia, perché hanno cessato di affiorargli dentro multicolori, insidiosi, confusi i desideri e
per questo verso egli dorme, tuttavia è un testimone degli eventi e
per questo verso è pienamente desto. Non indugia sul passato, non
si tormenta dell'avvenire, non permane nel presente: sfiora le apparenze della realtà come incessanti illusioni, momenti di un infinito
inganno. Così neutrale e lieto egli vive, come i tanti perfetti maestri
vedantini anche recenti, da Ramana Maharshi a Nisargadatta
Mahàràj, alle cui opere incantevoli e semplicissime periodicamente
torniamo per assaporare questa massima possibilità dell'uomo.
Ci si domanda: sarà dato di approfittare della dominazione totalitaria dell'intelligenza robotica per dedicarsi esclusivamente a
questo scopo supremo?
A chi stia aggrappato ai valori umani consueti nell'Occidente,
l'avvento dell'intelligenza robotica dovrebbe dare brividi di raccapriccio. Sparirà ogni spazio dove l'ingegno umano possa sopravvivere e celebrarsi: non durerà la diagnosi intuitiva del medico, né la dialettica dell'avvocato, né la cura del narratore e nemmeno la capacità argomentativa del filosofo, la robotica avocherà
a sé ogni professione.
Ma Hans Moravec va ben al di là di queste discussioni, approda
alla realtà che si inaugurerà nel 2030 e immagina per allora il chirurgo che aprirà il cranio a chicchessia per simulare su un programma di computer via via le funzioni proprie delle varie sezioni
cerebrali [...]. Alla fine tutte le funzioni dell'intera area cerebrale
saranno trascritte.
Il corpo allora morirà e Moravec immagina di dire all'uomo in
procinto di farsi così trasferire la mente in un programma: «La tua
prospettiva sarà trasferita a un corpo nuovo, dello stile, del colore,
del materiale che ti sarai scelti».
L'uomo dovrebbe poter diventare dunque abbastanza prossimo all'immortalità, la sua mente figurerà in un programma di
dove potrà attingere, volendo, a fonti sensibili eventualmente diverse da quelle che ci sono familiari.
Roger Penrose ha reagito sostenendo che non sappiamo ancora
nulla delle modalità di coesistenza di una fisica newtoniana einsteiniana di contro a una fisica quantica nel funzionamento del
cervello; pare infatti che l'occhio sia in grado di registrare anche
un solo fotone, che operi dunque entro la fisica quantica.
Finché il combinarsi delle due fisiche distinte nel cervello non
sarà formulato e spiegato, non sarà dato di simulare su un computer la mente umana.
Non credo che l'obiezione debba arrestare le previsioni di Moravec, ma si potrebbe anche limitarsi all'altra novità che egli esamina a fondo e che chiama «occhiali magici»: sono elementi che
forniscono a chi li indossi un programma televisivo che si sostituisce alla normale percezione. Programmi a questo fine già si assiepano all'Ufficio brevetti di Washington. Già si usano gli occhiali magici per allenare i piloti alla guerra aerea e li si vede uscire
dalla cabina in cui hanno affrontato le avventure simulate, pallidi
come cenci.
Un'Università americana offre occhiali magici a chi voglia comprare case disegnate alla sua Facoltà di architettura; esse si visitano
(ovvero: se ne visitano le prospezioni computerizzate) e nel farlo è
anche dato di suggerire le proprie modifiche al progetto aprendo
finestre e usci, spostando infissi.
Queste simulazioni totali del reale alleneranno a capire l'illusorietà dell'esperienza stessa. Potranno offrire tutto ciò che si possa
mai desiderare, vicende soavi e pacificanti oppure sconvolgenti e
tremende oppure le due alternate. E torna l'interrogativo: da questa varietà infinita di simulazioni, non dovrebbe scattare alla fine
la nascita d'un uomo liberato? La fonte degli stimoli si dovrebbe
placare, tanta sarà la libertà di scelta, la facilità d'ogni appagamento e si dovrebbe arrivare al momento della riflessione e meditazione che capovolga il gioco.
Credo sarà possibile inoltrarsi in tutti i possibili viaggi, reali e
immaginari, godere di tutti i diletti e al loro culmine queste esperienze dovranno rovesciarsi in una liberazione totale.
O mi illudo pensando che questo sia un destino aperto a tutti?
Forse i più saranno ricacciati indietro a piaceri sempre più stanchi, tortuosi, disperati e incattiviti e soltanto pochi otterranno la
liberazione?
Il reale illusorio, «Technology Review», n. 24, agosto 1990.
La macchina profetica di Primo Levi
Lenta lenta si va scaglionando la bibliografia della realtà virtuale,
con pochissime opere per ora e spesso con un'ostentazione di puerilità da lasciare allibiti. Eppure un primo contributo, quasi impeccabile, uscì addirittura nel 1966, prima di ogni esperimento a
me noto, nel racconto intitolato Trattamento di quiescenza, compreso nelle Storie naturali ài Primo Levi.
Non stupirà coloro che avevano già misurato le straordinarie
facoltà di Levi. Nel 1985, egli arrivò a descrivere tre eventi di laboratorio non riproducibili in maniera meccanica, ma possibili,
vale a dire: tre prove della realtà alchemica. Levi aveva segnalato
d'aver veduto due volte su migliaia di casi essiccarsi una palla di
resina semifusa a 65 gradi centigradi, aveva osservato un filo di
rame smaltato dentro al forno che non cedeva lo smalto a schegge,
bensì in forma di elica dal passo regolare; una volta aveva versato
in un mulino i componenti d'uno smalto tra sferette d'acciaio,
che divennero dei pentagono-dodecaedri (questi straordinari rilievi si trovano nell'articolo Riprodurre i miracoli, comparso sulla
«Stampa» il 15 settembre del 1985).
Il raccontino descrive una macchina costituita da un casco che
trasmette sensazioni visive, auditive, tattili, olfattive, gustative e
dolorose e «inoltre le sensazioni per così dire interne, che ognuno
di noi allo stato di veglia riceve dalla propria memoria». Rispetto
ai caschi attuali che trasmettono sensazioni, questo immaginato
da Levi trasmette a livello nervoso. Non è un'allucinazione né un
sogno perché, finché dura il nastro della programmazione, «non
è distinguibile dalla realtà». Levi si rendeva conto che questa macchina sarebbe stata l'ultimo passo dopo gli spettacoli e le comunicazioni di massa: somma soddisfazione dell'età anziana, a cui sarebbe aperta una ricchezza di esperimenti sconfinata, ma anche
ausilio didattico per lo studio della geografia e delle scienze naturali. Si sarebbero compilati programmi con esperienze di aviatori,
esploratori, subacquei, seduttori e seduttrici.
Il protagonista del raccontino fa provare ad un amico una partita di calcio, «con l'onda di allegrezza nel sangue, e poco dopo il
sapore amaro della scarica di adrenalina» e soprattutto gli fa riprovare la sensazione di lievità e prontezza della gioventù. Quindi
mostra una serie di viaggetti ed esperimenti di grossi eventi naturali, registrad a partire dall'insieme di sensazioni e pensieri d'un
artista.
Tutto avviene con un'immediatezza sorprendente: si è concentrati in un punto come proiettili, con un corpo agile e docile e si
dispone di una programmazione che sconcerta: violenza, guerra,
sport, autorità, ricchezza sono alcuni dei temi proposti; si potrà
subire o scatenare un pestaggio, si potrà essere provocati in modo
crudele e perseguitati a sangue oppure si potrà interpretare la parte
attiva e crudele, andando fino in fondo all'odio e alla collera.
C'è anche l'esperienza erotica, sulla quale è superfluo intrattenersi: basta menzionare la possibilità di provare le esperienze del
sesso opposto al proprio. «Credo che nessun teologo ci troverebbe
nulla da ridire: chi commette peccato non è mica lei» dice il protagonista all'amico. A questo punto ci si è spinti su un limite temibile. Quando l'amico si ritrova a essere sconvolto da un seduttore e getta uno sguardo nello specchio per vedersi nella forma
d'una donna incantevole, in un attimo di disperazione tenta di
strapparsi il casco.
Esisterà la serie delle programmazioni chiamata «effetto Epicureo», fondate sul fatto che la cessazione di uno stato di sofferenza o di bisogno concede il massimo di piacere: sono centoni di
fame o di sete placata, di dolori interrotti. Inoltre si estende la serqua delle gioie, che fanno affiorare il dubbio: non saranno forse
diserzioni, solipsismi, vizi solitari? Ma si avranno di queste remore a settanta o ottant'anni?
Il protagonista «illustrò poi brevemente i nastri [...] a fascia blu
(salvataggi, sacrifici, esperienze registrate su pittori, musici e
poeti nel pieno del loro sforzo creativo) e i nastri a fascia gialla, che
riproducono esperienze mistiche e religiose di varie confessioni».
Infine segue la serie nera: esperienze costruite ex novo, onda su
onda, come si combina la musica sintetica: vite di neonati, psicopatici, idioti, animali. Una di queste l'amico vuole provare: vola
nella notte sulle Alpi udendo gli scrosci di torrenti, le sferzate del
ventaccio, la pressione delle correnti addosso al corpo e alle ali.
Sente soltanto ciò che gli si agita dentro di norma allorché si rammenta senza parole di dover fare qualcosa in certa direzione, entro
un paesaggio stampato chiaramente nella fantasia. Scorge una
lepre e raccoglie le ali, precipita, finché a ridosso dell'animaletto
ristende le ali e si blocca, traendo fuori gli artigli. Segue l'eccidio.
Ma perché non provare una sequenza all'incontrano? Alla conclusione del raccontino Levi annota che nella realtà virtuale non
ci potrà essere assuefazione, perché, se si agirà sulla memoria si
potrà accendere una memoria d'accatto.
Fra un programma e l'altro il protagonista rilegge l'Ecclesiaste,
unico libro che trovi ancora degno di meditazione: parla dell'iterazione infinita dell'esperienza, non v'è nulla di nuovo sotto il
sole, soltanto l'eterno ritorno. Alla fine si sente confluire nella
persona di Salomone sazio di sapienza e di giorni accanto alla sua
regina nera. Ma Salomone era com'era per una lunghissima vita
piena di opere e di colpe, mentre il protagonista è già il frutto di
incalcolabili registrazioni e si avvia perciò verso la morte già sperimentata tante volte sui nastri. Levi aveva colto tutto ciò che gli
era concesso. Ciascuno potrà arrancare verso il punto cui egli si
portò nel 1966. Potrà forse immaginare l'andare oltre? Credo che,
avendo percorso i sentieri innumerevoli dell'esplorazione sciamanica, qualche estensione sia lecita. Forse forse avendo acquisito la
libertà di concezione che si dischiude a partire dallo stato di liberazione teorizzato da Indù e Buddhisti, qualche orizzonte diverso
si profila. Ma Levi era pervenuto ai limiti dell'Occidentale.
Un miracolo di Primo Levi profeta della realtà virtuale, «Corriere della
Sera», 1 giugno 1993.
La presenza virtuale disincarnerà la mente
Atsushi Aiba, direttore della rivista «Shiso» e direttore all'editrice
Iwanami, mi domandò il motivo per cui mi trovavo in Giappone
e gli risposi che volevo sapere dove ci si spingesse nella ricerca sulla
realtà virtuale. Fui sconcertato dal lampeggiare dei suoi occhi, da
uno scatto gioioso della mano: mi confessò che toccavo la sua passione maggiore; prevedeva che l'editoria si dovesse inoltrare al di
là della produzione di libri.
Aiba aveva appena pubblicato un sistema multimediale sui
monasteri del Ladakh e i loro mandala, ma si stava prodigando
ora nella preparazione della prima realtà virtuale per l'Iwanami.
Me ne parlò con precisione esultante: avrebbe fatto vivere l'esperienza di un sommo mistico buddhista, Kùkai, di quando sostava
in una caverna giapponese, incerto se recarsi in Cina. Sognò che
gli si manifestava il pianeta Marte. Lentamente questo gli si accostò, fino a scivolargli nella bocca. Una visione breve, forse, sarebbe stata pronta fra tre anni.
Avevo appunto pensato e anche scritto che il buddhismo
avrebbe potuto accogliere la realtà virtuale e quale ambiente più
di quello giapponese poteva essere propizio? Qui le stanze delle
case tradizionali, anche le più riservate e care, sono sempre e soltanto una momentanea illusione; si fa scivolare una parete di
carta e tutto cambia da cima a fondo. Un'apertura sotto il livello
dell'occhio dà sul verde del minuscolo giardino, ma sembra di
scorgere un'immagine di selva: la vita è un contesto di parvenze.
Ci si congedò con un lieto «Fra due o tre anni!».
Mi recai al laboratorio d'un giovane professore del Dipartimento di informatica all'Università di Tokyo, Michitaka Hirose,
dove mi fu presentata la schiera di ragazzi che manovravano un
parco di computer. Il più raccomandato dal professore era quello
che aveva inventato la creta virtuale, mi fu mostrata. Un accavallìo di montagnole dove si poteva intervenire con una specie di
mouse per modellare. Mi si mostrò anche l'elmo che s'indossa per
entrare in una realtà virtuale e per continuare altresì a vedere la
realtà ordinaria o per sovrapporre la prima alla seconda: un chi-
rurgo potrà farsi squadernare sul corpo del paziente le figure rivelate dalle risonanze magnetiche, un ingegnere potrà scorgere le
tubature sepolte sotto un edificio.
Ma il progetto che più alletta Michitaka è la realtà virtuale in
cui si fa viaggiare la luce a una velocità ridotta, sperimentando
così tutti gli effetti einsteiniani: lo spazio si deforma e gli oggetti
in movimento si rastremano; l'educazione alla fisica diventa diretta, visibile e tangibile. Mi assicura che la realtà virtuale accrescerà l'intelligenza negli anni Novanta.
I piccoli problemi si moltiplicano e risolvono di fùria, già al
simposio di Tsukuba del novembre 1992 si era notato che nel trasferimento di realtà lontane alla presenza dell'osservatore, lo spazio percorso produce alterazioni, i movimenti della testa si comunicano con ritardi che finiscono col frastornare e nauseare: s'è scoperto che basta accogliere il messaggio entro una capsula che generi una realtà virtuale.
Mi porta in tutt'altra direzione l'incontro con Hayura Ito ai laboratori Fujita; per lui l'impegno è di produrre esserini immaginari dotati d'intelligenza e sentire. Li chiama charlottes, non dice
perché. Hanno un loro ritmo di vita, alternano razionalità e
istinto nel comportamento, sono in grado di comunicare con noi
e forse di aiutarci.
Per comunicare con loro, si può parlare, ma anche fare cenni.
«Eccogliele», mi dice Hayura e vedo dei corpicini tondi che a
prenderli in mano paiono pesare fino a venti chili, programmati
a seguire l'ideale giapponese: sono intelligenti, spiritosi e fortemente socievoli, capaci d'intonarsi al ritmo dell'osservatore e di
mettersi a cantare se gli si agita dinanzi il braccio come direttori
d'orchestra.
La società dei telefoni lavora a creare ambienti virtuali dove più
persone si ritrovano a manipolare oggetti a tre dimensioni, senza
più usare gli occhiali. Per ora si mira a collegare docenti e allievi,
si fanno fare spese a un mercato virtuale, si aiutano i paralitici a
muoversi e districarsi, ma nulla vieta di andare oltre: penso a
quando si sarà forniti di una molteplicità di braccia come divinità
indù o giapponesi.
La persona più affascinante tra tutti i giovani (nessuno mi pare
al di sopra dei trent'anni), nei quali mi sono imbattuto errando
fra grandi aziende, università e centri di ricerca autonomi, fu certamente un venezuelano, volto latinamente modellato, gesti gentili, l'occhio quieto e pronto. Si chiama Tijerino, lavora al centro
di ricerche ATR accanto a Kyoto. La sua carriera di studi fu esemplare.
Cominciò a frequentare università americane, in Arizona
prima e quindi in California, dove si laureò. Capì che il futuro
forse non si stava più preparando là dove si trovava e studiò per un
anno, per dodici ore al dì, il giapponese. Si trasferì quindi a
Osaka, dove ebbe il suo titolo di studio. Fu subito assunto qui all'ATR, gli si mise fra le mani tutto ciò che desiderava.
Con lui posso gettare lo sguardo ai margini più remoti: il suo
progetto finale è di combinare un gioco di specchi che circondi lo
spettatore delle immagini sgranate dal computer, mentre un sistema di campi magnetici gli fa provare le sensazioni tattili e un sistema stereofonico gli fa udire i suoni della scena virtuale. Nel futuro ci si sarà spogliati degli strumenti che oggi ci aduggiano, si
entrerà nella stanza della realtà virtuale e la si vivrà esattamente
come l'ordinaria.
Tijerino conclude: «La telepresenza disincarnerà la mente».
Nell'impero dei segni, «Corriere della Sera», 3 novembre 1993.
Esperienze di mondi plurali
Con la realtà virtuale si schiude davanti a noi un nuovo mondo
che recupera quella dimensione di spiritualità che l'Occidente
aveva tentato di comprimere mediante operazioni materialistiche
e meccanicistiche, nonostante le invocazioni spesso disperate e
ammonitrici dei suoi mistici medievali e moderni.
Quale influsso avrà la realtà virtuale sulla condizione dell'uomo?
Io credo che gran parte della giornata entro il 2030 sarà assorbita dall'uso di questa tecnologia. Essa dominerà sia l'informazione che l'intrattenimento, e i viaggi saranno compiuti per realtà
virtuale e l'intrattenimento assumerà per noi aspetti ancora inconcepibili; immagino, inoltre, che avrà pieno sfogo il desiderio
di lotta e di sopraffazione che ora già colma i prodotti nei negozi
di videoprogrammi.
Nella realtà virtuale, credo, si arriverà alla radice masochistica
e sadica dell'istinto per cui si potrà sfogare in pieno il desiderio e
anche la passione di tortura per la sofferenza.
Ciò che mi preme di più è cogliere l'effetto globale; l'uomo sarà
modificato in virtù dello spostamento costante da una realtà ordinaria a una pluralità di realtà virtuali cosicché il primato, l'assolutezza della realtà concreta crollerà. Anche se molti temono appunto questo aspetto, io invece ritengo che questa trasmutazione
umana sia accettabile con il risultato che il senso dell'Io si stempererà avvicinandoci, noi abitanti dell'Occidente, all'idea dell'Io
che prevale in Oriente.
Guardiamo, ad esempio, i giapponesi: essi ricevono per tanta
parte un'educazione buddhista la cui prima mira è di estirpare il
senso dell'Io perché l'Io buddhista è un'illusione, essendo formato
da una serie di cause fortuite e risultando composto da elementi
variabili e mutevoli. Di questa labilità dell'Io, occorre avvedersi,
accrescerne la consapevolezza, sentirsi aggregati in un mutamento
costante senza un fondamento, una radice, esenti quindi da una
personalità. La lingua giapponese stessa favorisce questo tipo di
apprendimento. Naka Masao, nel suo libro Ich-Darstellung im
Deutschen undjapanischen (Stuttgart, Urachhaus, 1988), si chiede
perché un giapponese non parli mai di sé come Io e risponde affermando che egli, sentendo il dettato divino nel suo cuore ed essendo Dio non il centro del mondo ma semplicemente articolandosi in una pluralità di dèi, è pura molteplicità, «portatore dell'azione solare». L'Io giapponese si può paragonare al nostro «si» impersonale, che si usa per concentrare l'attenzione su un'azione e su
uno stato, lasciando sullo sfondo il soggetto; infatti in giapponese
spesso la frase «io vado a casa» si dice semplicemente «andare a
casa».
In una mente cosi conformata cadono quindi ovvie le parole
dell'educazione buddhista dell'Io da eliminare, da ignorare, parole che irrompono invece come una rivelazione violenta, come
un oltraggio, nella mente di un occidentale, la cui lingua l'ha condotto a comprimere le fuggevoli sensazioni interiori in un'essenza
incrollabile che egli addirittura proietta nell'eternità, se ancora
crede nella religione avita.
Alla saggezza di Hume che negava la sussistenza dell'Io, nella
storia filosofica d'Europa si sovrappose la complicata costruzione
kantiana che ristabilì il dominio dell'Io, addirittura dell'Io trascendentale.
Credo perciò che nella realtà virtuale possa entrare con estrema
facilità un giapponese, mentre un occidentale attraverserà un periodo di tragico adattamento dal momento che non potrà più illudersi di essere lo stesso nell'esperienza virtuale e in quella reale.
Accanto all'indurito, artificioso Io occidentale, cadrà anche il
concetto di realtà come siamo soliti considerarla, annessa all'idea
di concretezza; infatti la realtà assumerà una pluralità di volti,
moltiplicandosi senza tregua e cancellandosi come «suprema
istanza della vita».
Ora, se guardiamo indietro nella storia, ci accorgiamo che tutta
l'arte illusionistica moderna, a partire dall'arte medievale e più
precisamente dalla configurazione bizantina dell'icona, è un tentativo di pervenire al completo inganno, ad una realtà virtuale,
accessoria di quella visibile e udibile quotidianamente. D'altra
parte, le caverne scolpite e colorate erano destinate a racchiudere
un'allucinazione; l'idolo, un abbaglio, una vertiginosa simulazione, contro la quale si misero in guardia gli ebrei e gli arabi.
Entrando nel gran salone delle figurine del Museo di Bali e raggiungendo quelle immaginette ancora intrise di tinte vivaci ed incantevoli, ci coglie un'esultanza comparabile a quella che poteva
cogliere l'antico spettatore di fronte alle statue multicolori della
Grecia classica, ben altra da quel gelo trasognato tipico del Neoclassicismo. D'altra parte quando la Chiesa d'Oriente fissò l'icona canonica, mirò a deviare da un'allucinazione volgare per indurre l'astante ad una visione conoscitiva e teologica. La Chiesa di
Roma tradì il dettato conciliare e avviò la riforma illusionistica o,
come dicevano i Greci, «carnale», dando il via a un processo che
doveva concludersi alla fine dell'Ottocento, con la mone dell'illusione.
Ma a quali punti si spingesse, al culmine della Controriforma,
la volontà di suggestionare, si può comprendere osservando celti
monumenti, ceni monti sacri dell'Italia settentrionale, come il
santuario di Crea, nel Monferrato, dove incombono sulla testa
del fedele trecento statue sospese alla volta, con gli angeli e i santi
in festa attorno agli sforzi vertiginosi di Gesù, della Vergine, del
Padre e della Colomba svettante.
Potrebbe la Chiesa riprendere quest'arte simulatrice? In realtà,
non appena ci guardiamo alle spalle, l'ultimo tentativo di simulazione fu compiuto con il filmetto di Pasolini {Il vangelo secondo
Matteo) esibito ai padri conciliari, con la sua biografìa del Cristo
a metà tra Chiesa e Urss.
Non credo che la vita di Gesù sia riproducibile in realtà virtuale, né che sia tollerabile al di fuori dell'alone oratorio; non credendo che trasmetta il messaggio salvifico, non credo neppure
che la realtà virtuale possa essere usata oggi dalla Chiesa cattolica.
Non ritengo inoltre che le religioni aniconiche possano impedire
lo sviluppo della realtà virtuale, dal momento che questa non è
idolatria ma esperienza.
Con l'irruzione della realtà virtuale la modalità tradizionale di
fare spettacolo è destinata a scomparire: il teatro, che si è sforzato
in epoca recente di coinvolgere nella rappresentazione gli spetta-
tori, troverà nella realtà virtuale l'appagamento totale e, quindi,
morirà. D'altronde anche il cinema, che già Huxley immaginava
si dovesse spingere sino all'illusione più totale, con sussulti e folate di odori, si estinguerà di fronte alla forza immaginifica della
realtà virtuale; e cosi parimenti la televisione.
Non credo che ci sia un futuro virtuale per le religioni esistenti;
mi pare, invece, molto probabile che delle esperienze mistiche
sciamaniche possa essere fornita una riproduzione efficace. Si
pensi, per esempio, a ciò che si potrebbe realizzare in realtà virtuale con la consulenza di sciamani praticanti, grazie alla quantità
di materiale filmico custodito al Centro Culturale di Seul in
Corea del Sud. La sciamana coreana ha mantenuto intatta una
tradizione che risale alla preistoria: le sue allucinazioni sono talmente rigorose, benché ella le possa variare a piacimento, che potrebbero essere riproducibili alla perfezione in un programma di
realtà virtuale [...].
Si potrebbe pensare che le ricerche sulla cosiddetta intelligenza
artificiale abbiano qualche connessione con la realtà virtuale e
che, tutto sommato, la scienza non riuscirà mai a rendere disponibili tutti gli aspetti della realtà; non vedo, tuttavia, un rapporto
organico tra intelligenza artificiale e realtà virtuale, nel senso di
dipendenza della seconda dalla prima. Il solo rapporto esistente
tra i due fattori è che entrambi introducono un nuovo modo di
pensare in senso formalistico; eppoi, ammesso che la scienza
possa modellizzare solo parte della realtà, questo non intaccherebbe le possibilità di applicazione della realtà virtuale e l'espansione, forse illimitata, della stessa.
Alcuni critici della realtà virtuale sostengono che essa creerà in
futuro una società atomizzata, costituita da individui sradicati dal
loro contesto sociale, e che ciò potrebbe inaridire le nostre sensazioni, le nostre passioni, con il risultato di produrre un mondo
popolato da robot, da morti viventi. Personalmente concordo sul
fatto che diminuiranno radicalmente i rapporti sociali, ma in ciò
non vedo controindicazioni. La realtà virtuale prospetta sicuramente un estraniamento dell'uomo dalla società solamente per il
fatto che tale esperienza è essenzialmente individuale; le relazioni
umane si potranno conservare solo nel momento in cui si comunicheranno le esperienze virtuali agli altri. Inoltre, non è vero che
la realtà virtuale è diversa da quella quotidiana, in quanto anch'essa è percepibile attraverso i sensi, è «concreta», e quindi non
può inaridire le nostre sensazioni perché ha la stessa valenza dell'altra, anzi ne è un arricchimento. Altro quindi che mondo di
zombie! Ci aspetta un mondo di creativi.
Un'altra preoccupazione potrebbe concernere le modificazioni
che necessariamente avverranno nella cultura, nell'arte, nella letteratura, in tutte quelle scienze umanistiche che finora hanno prosperato. Anche in questo caso, non credo che ciò sia necessariamente negativo. Le discipline umanistiche svolgeranno un ruolo
molto minore, alcune di esse forse spariranno, come spariranno
gli spettacoli, il teatro, il cinema, il turismo, addirittura, perché
sarà la realtà virtuale a farci sognare, immaginare, viaggiare.
Dal punto di vista antropologico alcuni critici rilevano che il
mondo occidentale può produrre una realtà virtuale, per cosi
dire, solamente di matrice occidentale, in quanto questa tecnica è
espressione delle nostre categorie culturali, e quindi, in gran
parte, irriproducibili in un'altra cultura, come d'altronde sono irriproducibili in modo perfetto le esperienze sciamaniche orientali
o addirittura quelle animali. Il relativismo culturale, comunque
lo si voglia intendere, pone degli ostacoli diffìcilmente superabili
ad una visione del mondo integrata sulla quale si basa in definitiva la realtà virtuale.
Non mi pare, tuttavia, che questa obiezione di natura filosofica, antropologica e linguistica, intacchi il concetto stesso di
realtà virtuale, ossia la costruzione di nuovi tipi di realtà come arricchimento delle nostre capacità percettive. D'altronde è assai
discutibile negare, come fa il relativismo, la possibilità di avere
esperienze simili, o addirittura identiche, in culture diverse, e, in
secondo luogo, il problema della organizzazione culturale di un
dato percettivo è lo stesso sia che si parli di realtà quotidiana che
di realtà virtuale.
In definitiva, mi sembra che queste obiezioni di carattere filosofico non siano pertinenti al tema trattato; in un certo senso la
questione della realtà virtuale non merita di essere esaminata da
un punto di vista filosofico, perché non è niente altro che un ampliamento della nostra capacità di fare esperienze concrete. Virtuale e reale indicano e significano, perciò, la stessa cosa.
La realtà virtuale, in Natura, cultura, mente, a cura di S. Adami, M. Mar-
cucci e S. Ricci, Franco Angeli, Roma 1996, pp. 57-64.
Stati Uniti d'America: 2030
È andata a finire che una certa parte della vita e certe giornate fra
le più intense e trasognate sono trascorse in America.
Quelle folate di realtà intensa e densissima che mi hanno modellato le ricevetti nei villaggi indi o spagnoli del Nuovo Messico,
inebriato dall'odore del deserto, meravigliato per l'ordine metafisico che intuivo nei villaggi secolari; nello scatenamento di fantasia lungo certi viali assolati della California; sulla riva del Pacifico,
in parchi stillanti dello stato di Washington; nei villaggi Amish,
identici a quelli bernesi del secolo XVII in Pennsylvania.
Ma una valutazione fredda e perentoria delle circostanze la
ebbi allo State Department di Washington, negli uffici delle tante
Università calate nella verzura.
E certe prospettive di borghi infami a perdita d'occhio, l'ubriaco vomitante sotto l'insegna del prestito su pegni, il bellimbusto che lancia la sua intesa tra il fetore di cucine turpi, diedero
un'informazione minuziosa sulle basi della civiltà americana.
Fu Ostrogorsky a spiegare come sulla malavita si regga l'edificio, come ogni banda assoldi il suo mast-head: l'idealista blaterante che copre il sopruso sistematico. Un orrore, eppure non saprei invocare un reggimento preferibile. Un'ossessione della legge
che quasi strozza, eppure non so suggerire altro ad un occidentale.
Questa costruzione in cui culmina l'Occidente, è forse in declino. La sua potenza militare verrà via via a servire sempre meno.
Il primato finanziario è già svanito.
L'industria ha tentato di fermare l'evolversi della tecnica, ha
procurato di arrestare l'automazione, ma così facendo ha sigillato
la vittoria giapponese.
Alla depressione attuale l'America non può che sperare di reagire alla maniera dell'amministrazione Roosevelt. L'immenso
paese dovrà scendere a un rango minore, trovando un'intesa difficile (forse impossibile) con i popoli finora oppressi.
Nel 2030 sarà stabilita negli Stati Uniti, ma forse retta da mani
giapponesi, la realtà virtuale. Quell'apertura su una molteplicità
di realtà equivalenti e in contrasto fra loro, che fu il sogno degli ul-
timi anni Sessanta, quella liberazione che fu tentata e mancata
con l'LSD, si offrirà in maniera sana e impeccabile. L'umanità
americana sarà forse la prima a essere tramutata interamente, diventerà l'avanguardia librata al di sopra della realtà comune.
Fin qui l'occhio si può spingere, ma la storia: l'imprevedibilità,
il rischio di follia e di tirannide cingono stretto stretto l'uomo, nel
futuro come nel passato.
Che cosa ho ricavato dal restare a ridosso della realtà americana
durante una vita?
Ho scampato il pericolo di farmi mai guidare dalle vecchie
idee, dai rimasugli di passato che allignano in Europa.
Le follie del Novecento, comunismo e fascismo, in America
non attecchirono mai; in un certo senso l'occhio rivolto all'America può indagare il fondo metafisico costante, senza mai subire
deviazioni.
Quelli che inventano la realtà,
1992.
«Il Gazzettino», Venezia, 11 settembre
Per una mistica futura
Un pensiero di Naropa è rimasto finora recluso entro il buddhismo. Sarà cruciale comprenderlo quando la distinzione tra realtà
reale e realtà virtuale sarà meno drastica e intimante di oggi:
«L'immagine sacra non è un essere e nemmeno un non essere perché si ha la visione di una cosa che è tuttavia vuota di realtà. Nonostante l'assenza d'un ente reale, qualcosa tuttavia appare, come
màyà\ come sogno o magia. Benché non vi sia una sostanza reale,
ben si vede tuttavia che questo qualcosa nasce, e come la gemma
dei desideri, ha il potere di adempiere alle aspettative di infinite
creature».
Su questo fondamento si potranno ripresentare sentimenti e
eventi tradizionali della vita mistica. Non si ergeranno attorno ad
essi mura invidiose, non voleranno sarcasmi, non si scateneranno
esecrazioni morali. La loro via resterà sgombra.
La mistica del futuro potrà d'altra parte rifarsi a forme sopravviventi ai margini del mondo attuale come il taoismo t'ai chi, Io
yoga, il buddhismo vajra, lo dzog-chen, il ch'an e lo zen, le infinite
versioni dello sciamanesimo emergenti del mondo.
Eclissi e riemersione della mistica, «AM: Rivista della Società Italiana di
Antropologia Medica», 3-4, ottobre 1997.
Epifanie
Nella nostra civiltà c'è un triplice spiraglio del
divino: nella scienza che deve essere pura per poter
essere utile in seguito, nella bellezza cui si sia
ancora per avventura sensibili e nella disgrazia più
profonda che non si sopponi per aderire a una
forza, ma per essere crocifissi.
Che cos'è la tradizione
Nota introduttiva
Ci sono parole, anche d'uso corrente, vestite di luce. «Epifania»
che significa in greco «apparizione» è una di queste. La si associa
alla venuta dei Magi a Betlemme per adorare il Divino Bambino,
e la festa che le corrisponde, il 6 gennaio, è tra le più solenni del
calendario cristiano. Ma non è necessario appoggiarsi al credo cristiano per cogliere le risonanze del tema epifanico che annuncia
l'esistenza di ponti sottili tra ciò che ha vita e cade e ciò che dà vita
e sale— come scrisse una volta Zolla a proposito di un antico testo
cabbalistico.
Quando le parole e le frasi di uno scrittore gettano ponti di
questo tipo, cessano di essere parole e frasi e diventano portenti
visibili: epifanie. Come figure in un caleidoscopio, le prose accolte in quest'ultima sezione aggrumano temi cangianti e disparati - dalla Pentecoste alle combinazioni impresse nel nome di
505
Laura, la donna angelicata dal Petrarca; dal golem, il «doppio» arcano dell'uomo nell'immaginario ebraico, all'androgino rivisitato nel mito greco e indiano, a Pinocchio, il burattino emblema
di metamorfosi; dalle luminescenze peciose nei dipinti di Strindberg al duende evocato dal più dionisiaco dei poeti spagnoli,
Garcia Lorca; dal culto bengalese di sahaja, personificazione della
vampa erotica al di là del desiderio, all'idea di una conoscenza
senza dualità, alla pittura vista come l'arte che vince la morte e infine al mare tremendo e mite nel quale EZ, sulle orme di Hofmannsthal, immaginò la foce della vita.
Un ardore fattosi lode: a proposito di un romito inglese
Nacque Richard Rolle poco prima o pochissimo dopo il 1300 a
Thornton Dale nello Yorkshire, da gente misera, ma si mostrò
cosi pronto d'ingegno che il prete suo maestro di scuola gli pagò
gli studi a Oxford. Tornò dai suoi a diciannove anni, e già aveva
deciso di staccarsi dal mondo. Era una vocazione che non lo conduceva in un Ordine, ma lo spingeva verso i boschi e la solitudine,
alla vita eremitica che andava ormai scomparendo in Inghilterra.
Dovette scappar di casa perché i suoi lo credettero pazzo. Andò
vagabondando ed un giorno, a Dalton, entrato in chiesa, fu riconosciuto dai figli d'un suo compagno di studi di Oxford, lo squire
del luogo. Fu invitato a predicare e commentò le parole di San
Paolo sui gemiti inenarrabili coi quali lo Spirito prega nell'uomo.
Lo fece con tale forza da guadagnarsi i parrocchiani ed il loro
capo. Ebbe in casa di costui una cella e potè, così protetto come in
un bozzolo, cominciare la lenta opera di purificazione e di metamorfosi, che durò quattro anni e tre mesi e raggiunse l'apice. Egli
scoprì l'efficacia del nome di Gesù come giaculatoria e della posizione seduta, della quale sempre torna a parlare (questa d'una stazione abbandonata eppure eretta, perpendicolare al suolo, come
di un re sul trono, è l'unica prescrizione della setta za-zen, che significa appunto «sedere zen»: le spalle sono del tutto rilasciate, il
peso del corpo cade su un punto vicino all'ombelico, si è senza
turbamento e vigili, concentrati, senza sforzo). Fu assalito dai dèmoni, e una volta, narra la Vita del suo ufficio, lo visitò la forma
d'una donna da lui dianzi vagheggiata, e lo avvicinò, ed egli non
poteva muoversi, ed ella lo stava avvolgendo, quando egli riconobbe in lei il demonio e subito gettò i suoi pensieri nel dolore
tremendo della morte del Cristo, invocò il sangue sparso sulla
croce, e di colpo si sciolse dalla paralisi e fu salvo. La purificazione
lo condusse finalmente alla «apertura della porta», come egli la
chiama, quindi alle tre fasi successive, calor, canor, dulcor com'egli le chiamò: un calore perfino fisico, un ardore contemplativo
che ridondava nel corpo stesso, poi uno sciogliersi in canto e infine una dolcezza soave. Più tardi questi momenti divennero in
lui tre abiti costanti, alternamente prevalendo l'uno o l'altro. La
successione delle tre fasi è come una smaterializzazione, onde si
passa dal puro calore o fuoco che è l'essenza di ogni cosa, al puro
suono e di 11 all'ineffabile, amorosa origine. Cosi nella cella d'una
casa dello Yorkshire, grazie alla semplice ascesi mentale [...], egli
ripercorre la via immemoriale, a ritroso, verso l'Inizio, la Creazione, che è pur indicata in ogni teoria del sacrificio, attraversa i
tre stadi della pura luce, del puro suono, dell'ineffabile pienezza.1
Il senso d'un calore anche fisico e l'audizione d'un canto di cori
vicini e invisibili sono accadimenti frequenti negli annali della
vita mistica, ma come per quasi ogni verità di quest'ordine si rischia d'essere fraintesi a divulgarli. I mistici inglesi successivi,
l'autore di The Cloud ofUnknowing e Hilton, insegneranno a sospettare dell'ardore sensibile.
Ciò che distingue Rolle fra i mistici d'Occidente è la sua teoria
dei suoni interiori salvifici, i quali rendono intollerabile ogni musica esteriore e audibile. Nel Melum egli dice che «calpestando il
male egli procura di essere fatto perfetto dal canto».2 Fu censurato
per questa dedizione alla musica catartica interiore ed egli si lamentava nel suo contorto latino. «Non credunt quod capior ad Carmen canorum, autscriberem constanter in modo mirabile de cantu
cantatesi, eppure come dice la bella versione inglese delle sue proteste, « the Magnificent Majesty mode me miraculous in mind through music»: la mirabile Maestà lo rese di mente miracolosa attraverso la musica.
Ma altre censure cominciano a tormentarlo [...]; si tenta di indurlo in chiacchiere sperando di sorprenderlo in eresia. Lo si accusa probabilmente di disubbidienza, o almeno di sottrarsi alle
condizioni in cui vige l'obbedienza. Egli difende con asprezza i diritti della vita eremitica del rapporto «dal solo al Solo», come di1. Sulle cosmogonie si veda M. Schneider, Le basi storiche della simbologia musicale
in «Conoscenza religiosa», 3 settembre 1969.
2. La mistica comparata avrebbe in Rolle un caso d'elezione: egli scoprì via via, in
termini indiani, la via del mantra«Gesù!», Xasanao posizione giusta, il calore o tapas
ed infine lo sabdayoga, «unione del suono» o anahid «suono assoluto». Per i paralleli con altri mistici occidentali, vedi l'ultimo capitolo in E. Zolla, Lepotenze dell'anima, Bompiani, Milano 1968.
ceva Plotino, e osserva che ormai si vuol vivere in comunità perché non si gode più della conversazione angelica. E osa incalzare:
non si è santi perché si ubbidisce ai superiori, ma perché si procura d'ubbidire a Dio solo.
La diffidenza verso Rolle durò a lungo se il romito suo discepolo Thomas Basset attorno al 1400 lo difende ancora dall'accusa
di voler rendere il fedele giudice di se stesso.
Eppure non c'è nulla in comune fra Rolle e i Lollardi, egli non
pronuncia eresie, la sua rivendicazione della solitudine eremitica,
dei gradi di calor, canor, dulcor, non è una proclamazione del libero esame. Cosi le sue traduzioni dei Salmi non sono esortazioni
a improvvisare un'esegesi, ma moduli che egli offre per giungere
come lui all'estasi. Il loro inglese è delizioso, soltanto i sommi traduttori di Giacomo I eguaglieranno quella melodicità. Rolle fu
lontano dalle eresie quanto la beata Angela da Foligno, che gli è
molto affine per il disdegno delle insidie settarie e la singolarità
delle esperienze.
Introduzione a Richard Rolle, Canto d'amore, a cura di E. Zolla e M.
Castino, Esperienze, Fossano 1970.*
* La pagina interna bianca del libriccino reca una dedica autografa in latino a Vittoria (Cristina Campo).
Non c'è cima senza fondo
La leggenda insegna che Elsa, la vergine calunniata, e l'intero Brabante furono salvati da Lohengrin. L'eroe volle che restasse ignoto
il suo nome e con saggio candore i Brabantini si dissero che da lui
proveniva loro la serenità e questo bastava. Elsa invece non resistette, domandò all'eroe il nome e l'origine, ed egli dovette abbandonare lei e il Brabante.
Così fu di questo libro felicemente anonimo, che anonimo
sparse molte soavità nei cuori e per tanti tramutò il pianto dell'afflizione nel dono delle lacrime. Nel Medioevo si stava agli effetti
d'un'opera, senza interrogazioni curiose, filologiche, avvocatesche,
e all'anonimato si rimediava, semmai, con un nome d'autore illustre qualsiasi. Non còsi la Cristianità umanistica; dinanzi a questo
libro non si diede pace, confrontò testimonianze, scrutò le patine di
pergamene e la qualità di sbiaditi inchiostri per estorcerne un
nome, una residenza, una data. Ma via via, quanto più venne affinandosi e arruffandosi l'indagine, di tanto s'affievolì l'influsso, immenso, dell'opera. L'autore aveva pur voluto rimanere oscuro.
Come il gaudente soltanto dietro lo schermo d'una bautta
corre all'avventura con agio perfetto, è prudente che chi voglia
confidare verità mistiche si occulti, non denudi il volto, non sveli
il sigillo dei suoi limiti umani.
Il libro pure ingiunge di non cercare chi l'abbia composto.
All'ordine si disubbidì, si tentò di ricostruire la psicologia di
chi forse era riuscito a non averne più una, prima d'accingersi a
insegnare agli altri come si fa a liberarsi dell'io; si volle accertare
l'ambiente, le tendenze sociali che influirono su chi se ne era
strappato; ci s'impuntò ad appurare l'epoca precisa in cui era vissuto chi aveva trasceso il suo tempo per confondersi con uno
qualsiasi e con ognuno dei momenti esemplari dell'eone cristiano. Tant'è, le attribuzioni spaziano fra il primo millennio e il
secolo XV. L'ultimo ragguaglio sull'indagine interminabile è di
Albert Ampe (L'Imitation deJésus-Christ et son auteur, Edizioni di
Storia e Letteratura, Roma 1973), il quale di suo propone come
data di composizione il 1370 circa.
L'attribuzione più remota aggiudica l'opera a San Basilio (cosi
un manoscritto del 1482).
In Francia, in Italia, in Boemia si osò indiziare come autore San
Bernardo, finché si notò che nel testo è citato il posteriore San
Francesco.
Un traduttore francese nel 1538 insinua che l'autore fosse Ludolfo di Sassonia.
Molti si ostinarono a ficcare il libro fra le opere di Jean Gerson
(m. 1426), [...] quel Gerson cancelliere della Sorbona, dov'era
succeduto al suo maestro Pierre d'Ailly (lo stesso d'Ailly che nel
De concordantia astronomiae prevedeva per il 1789 [...] la rivoluzione francese: «il y aura grands, nombreux et étonnants changements dans le monde, prìncipalement dans la Loi et la Religion»).
Cene dottrine particolari sul discernimento degli spiriti, sull'arte
di distinguere le ispirazioni diaboliche, naturali e soprannaturali,
sono comuni all'Imitazione e al Gerson (come anche al d'Ailly).
Ma come scambiare il melodico stile, opulento nell'aggettivazione, ornatamente addottrinato, del Gerson con quel nudo ricalco del Libro dei Proverbi che è l'Imitazione^
Un'altra attribuzione emerse quando il Caietano a Genova si
trovò fra le mani un testo ascritto a Gersen, abate di Santo Stefano
a Vercelli tra il 1220 e il 1245. Ancor oggi s'insiste a prò di questo
oscuro benedettino.
Ma l'attribuzione più convincente è pur sempre stata quella a
Tommaso da Kempis.
Tommaso nacque a Kempen presso Dusseldorf nel 1379 o
1380. Entrò nel 1398 nella comunità di pii copisti raccolta da
Florent Radewijns a Deventer. Erano costoro ispirati a Gerard
Groot, l'amico di Ruysbroeck (c'è chi ha voluto attribuire a Groot
il brogliaccio su cui si sarebbe poi rifinita XImitazione). Nel 1399
Tommaso si offriva oblato al convento dei canonici regolari di
Zwolle, dove avrebbe preso gli ordini nel 1413 o 1414. Fu proprio dell'ambiente della nuova devozione fiamminga, cui Tommaso appartenne, il disinteresse per le squisitezze dottrinarie, a
prò del metodo mistico pratico, inculcato con periodi brevi di
due membri (raccolti da ogni fonte: i cosiddetti apiario)-, rit-
mando queste asciutte frasi, o sprofondandosi in una di esse, ci si
affrancava dal delirio raziocinante, avvocatesco, delle vecchie dispute.
L'anno in cui Tommaso si aggregò alla comunità, moriva
Gerhard Zerbolt di Zutphen, maestro di esercizi spirituali, che lasciava la sua Riforma interiore o le potenze dell'anima e le sue
Ascensioni spirituali-, era uno d'una pleiade, di cui i più prossimi a
Tommaso sono Henri Mande e Gerlac Petersz o Pettersen, del
tutto staccato, quest'ultimo, dal linguaggio scolastico, librato in
patetici colloqui con Dio.
Nel 1741 Tommaso concluse la sua vita, che era trascorsa tutta
daustrata, preservata da ogni contaminazione di avvenimenti
esterni.
Oltre a molte ascetiche, egli lasciò alcune opere squisitamente
mistiche: il Soliloquio, ì'Hortulus rosarum, la Vallis liliorum, la
Cantica, il De elevatione mentis e vite di santi, fra cui quella di Liduvina di Schiedam, amata da Gòrres e da Huysmans, quando
essi, evasi dal loro secolo, cercarono riparo nei giardini spirituali
del Medioevo.
Nel 1441 sta di fatto che Tommaso autografò una copia dell'/mitazione soggiungendo: finitus et completus. Ma la prima attribuzione a lui nel suo ambiente data dal 1428. C'è chi non ne è del
tutto persuaso.
Il mondo in cui questo libro era lettura di tutti ormai è scomparso. Ripenetrarvi fra non molto sarà altrettanto arduo come ripristinare con la forza d'una retta fantasia, per esempio, una scena
di uomini dal berretto a punta che in cima ad un colle etrusco
scrutino, con estatica attenzione, in un fegato violaceo, liscio e
palpitante, il cosmo e il destino. Vanno infatti impallidendo, dileguando via via che la morte falcia le ultime vive memorie, le
scene che bisognerebbe rievocare intorno alle pagine di questo libretto. Scene un tempo quotidiane - come il canto virile che si
alza a vespro verso le buie materne volte d'una cattedrale o il delicato fruscio di sai fra l'uno e l'altro rintocco della campana - giova
riconvocare nell'orecchio; il mite sapore di cibi certosini giova
immaginare ancora sul palato; e rivedere con l'occhio monache
dal volto celato in perpetuo dal cappuccio nero, esalanti da dietro
una grata la loro compassione per i viventi nel mondo per citare
brandelli a caso di quel che era un vivido arazzo, inghiottito dalla
corruzione e dalla morte ormai al pari dei delicati riti isiaci o delle
messe nestoriane delle steppe asiatiche, dei riti manichei, tutti
ormai riassorbiti nel cielo delle forme formanti donde erano calati in forme formate e visibili, forse destinati in nuovi eoni a riassumere forme caduche o forse viceversa a rimanere, ormai, nell'eterica, intangibile perfezione dell'infinita possibilità.
Sulla Roma cristiana oggi si rimormorano i versi di Baldesar
Castiglione dedicati alla pagana:
Superbi colli, e voi sacre ruine
Ch '1 nome sol di Roma ancor tenete,
Ahi che tante reliquie miserande avete
Di tant'anime eccelse e pellegrine!
Eppure chi saprà far sua \Imitazione, potrà cantare con Isaia,
LVIII:
Ricostruiamo le rovine antiche
e Tu farai risorgere le fondamenta dei secoli trascorsi,
Ti chiameranno «Restauratore delle rovine»,
«Colui che rende riabitate le strade».
Che cosa può cogliere delle pagine di questo libro un lettore
d'oggi?
Esse andavano soprattutto lette in celle o passeggiando per
chiostri, perciò vi si inculca impunemente l'obbedienza, la conformità a comunanze impegnate nella pura contemplazione. Chi
nel mondo le leggeva, si trasportava per un momento in quei
nudi silenzi.
Certo poco ne esala oggidì, rispetto alle amorose rispondenze
che vi scopriva il lettore antico, cui ancora era accessibile il refrigerio di sacri silenzi. A lui certo non dava fastidio quel rammen-
tare i tormenti infernali in tono di minaccioso monito e rimbrotto (resta da vedere chi sia puerile: colui che rifiuta queste minacce o chi se ne serve e sa che accoglierle è profitto).
Sicuramente tuttavia il lettore d'oggi, se sarà attento, scoprirà
qui tesori che gli sono ben necessari. Può impararvi una conoscenza religiosa che gli illuminerà dall'alto l'anima, quell'anima o
psiche la quale oggi i più sottili poeti esplorano come cieche talpe,
palpandone le viscide pareti, misurandone a carponi i camminamenti, nemmeno immaginandosi che esiste un mondo superiore
all'anima, un cielo da cui la si può scorgere come da una specola:
lo spirito.
A passare dall'anima allo spirito insegna questo libro, non alla
maniera complessa e argomentante di certe altre opere di Tommaso da Kempis, bensì mercé un miracolo: uno stile di assoluta
accessibilità. E dire che il trapasso dall'anima allo spirito è un concetto fra tutti difficilissimo. Quasi nessun moderno è capace di
coglierlo. Come non afferrarlo però nell'esposizione di queste pagine (III, 33), là dove esse invitano a notare quel fermo e puro occhio dell'intenzione (intenzione di purità e chiarezza interiore),
quell'occhio che contempla, grazie all'intenzione incrollabile, la
propria psiche oscillante e mutevole? Altrove questo libro tenta di
destare la stessa conoscenza dello spirito, distinto dall'anima, proponendo quello che potrebbe essere un perfetto koan: «Dove sei
tu quando non sei presente a te stesso?».
Forse avverrà che il lettore d'oggi impari la soavità dell'ordine e
della precisione nell'uso di parole che la pratica religiosa dell'ultima fase cristiana ha coperto di melma sentimentale. Eccone ripristinato il significato luminoso: per «purezza» nell'Imitazione
s'intende «ciò che fa sì che non si cerchi consolazione dalle creature»; per «carità» e «amore» s'intende un sentire che vuole restare
libero da ogni affetto mondano «per non essere impedito nel vedere l'interiorità correndo verso Dio»: un levarsi sopra se stessi per
colmo di stupore e meraviglia e gratitudine.
La magia nera delle parole della tribù qui è esorcizzata; le contaminazioni di sacro e profano qui sono bandite. E quali profitti non
raccoglieranno coloro che metteranno in serbo certe massime,
come: «se cercherai in qualche cosa te stesso diventerai arido»;
«abbi i beni temporali per uso, gli eterni nel desiderio»; «chi si gloria fuor di Dio, del Principio delle cose, non potrà riposarsi in allegria, né allargare il cuore, ma sarà impacciato e angustiato».
Il libro è ascetico prima che mistico, eppure addita sobriamente alle gioie spirituali, a quel pleroma&i cui le voluttà terrestri
e le delizie note al mondo profano sono offuscati frantumi. Per
avvicinare a tali gioie, suggerisce in uno scorcio operazioni vertiginose: se tu vedessi tutte le cose dinanzi, sarebbe vana visione. I
segreti magici taoisti del non agire eccoli in un guscio di noce,
esposti da questo libro che un tempo andava per le mani di tutti,
là dove suggerisce: «mettiti sempre in fondo e ti sarà data la cima,
perché non c'è cima senza fondo».
Oh candido Nietzsche, convinto, come un illuminista qualsiasi, che questa esoterica dottrina fosse una morale di schiavi!
In una vignetta dell'Amphitheatrum sapientiae aeternae, il secentesco libro di figure alchemiche di Khunrat, si vede il Ricercatore che insegue un coniglio bianco che s'è infilato in una buca del
terreno da cui si passa ai regni arcani e mistici. Per schiere di morti
questo libro fu - e forse sarà per nuovi lettori ancora - un tal coniglio bianco, fecondo, fulmineo mediatore.
Introduzione a YImitazione di Cristo, Rizzoli, Milano 1958.
La Pentecoste e il mondo moderno
Èpossibile rivivere la Pentecoste nel mondo moderno?
Sì, ad un patto difficile a tenere: a patto di cominciare con l'irridere tutto ciò su cui il mondo moderno si fonda, su tutte le idee
che il mondo moderno ama. Se siete da tanto, cominciamo a rievocare ciò che accadde nell'anno 33 in Gerusalemme. Ma come
pensare di riviverlo? Con un'analisi storica? Non andremmo
molto lontano usando soltanto gli strumenti dello storico. Ancora: è questo un avvenimento che la storia giudica o un evento
che giudica la storia? È compreso dalla storia o comprende in sé la
storia? È storia o fonte di storia?
Affacciamoci su questa città [Assisi], ma con quale animo?
Quello di chi raccoglie notizie per un'autorità civile che vuol essere
ragguagliata? Il vostro rapporto suonerebbe come quelle poche
frasi dello storico latino: «gli Ebrei hanno tumultuato spinti da un
tal Cristo o Cresto».
Se vi muove la vera curiosità, o la vanagloria del dotto, vedrete
semplicemente delle folle in pellegrinaggio, un certo agitarsi attorno a dei predicatori improvvisati. I santi trassero il miele di
una letizia ineffabile da questa Gerusalemme di Pentecoste, una
gioia che vorrebbero dall'aldilà trasmetterci, per poco che li volessimo ascoltare. Noi diremo dunque: voglio andarci, perché
desidero comporre nella fantasia il quadro di ciò che avvenne, sapendo che i santi della Cristianità da quel quadro trassero ciò che
li rese sapienti, forti, incrollabili, ispirati. Se quel quadro ci apparirà nitido, avremo in dono un senso di gloria, qualcosa di più
della letizia.
Nel tempio di Gerusalemme: riti e simboli
Siamo in maggio: in tutto il mondo si celebrano i raccolti; nel
tempio di Gerusalemme si celebra un rito, si offrono due pani,
fatti con il frumento nuovo a Colui che ha donato il sole, la terra
e la vita a quei pani. Cinquanta giorni prima, a Pasqua, sono stati
offerti invece pani azzimi, senza fermento, e pani d'orzo, non di
frumento; ora invece si offre, si consacra una pasta fermentata.
Un grande simbolo si cela nel lievito: simile a un seme, racchiude
qualcosa della potenza creativa, rappresenta meglio fra tutti gli
emblemi del mondo, dunque il Creatore, ma è anche un simbolo
duplice e pericoloso. Ci può essere una fermentazione che non è
quella della creatività, venendo da colui che odia la creatività.
Cinquanta giorni prima, per rispettare questa simbologia dei fermenti, si era evitato di usare il lievito nel pane, consumandolo azzimo, cotto sotto le ceneri, quasi a simbolo di penitenza. Quel fermento che cinquanta giorni prima era aborrito, ora è religiosamente usato; fermento e fervore vengono dalla stessa radice;
fuoco, spuma e fermento sono simboli equivalenti. Si medita
dunque oggi in Gerusalemme sul lievito visibile e quello che invisibilmente pervade la città.
Osserviamo: si sacrificano due agnelli, il sacerdote agita sopra
e sotto di essi due pani che scuote avanti e indietro, in su e in giù.
Quell'andare avanti e indietro dei pani rappresenta la benedizione dei quattro punti cardinali, simboleggia lo spazio intero e
l'ordine dello spazio, quindi la bellezza del mondo. Quel sollevarli e abbassarli significa Colui cui appartengono cielo e terra,
cioè l'origine e l'originato, l'angelico e il visibile, il segreto e il manifesto. Quel sacerdote agita quei pani per fermare i venti e le rugiade nuove, cioè per simboleggiare la difesa che la lode di Dio
offre per riparare il delicato frutto dello spirito che in noi ora dovrebbe granire, come è granito il frumento. Quasi non c'è fine alle
spiegazioni simboliche... cinquanta giorni prima era stata celebrata la Pasqua che significa «passaggio» e se da un lato si celebrava il passaggio dall'Egitto al deserto del Sinai, si intendeva altresì celebrare il passaggio dalla vita carnale alla spirituale, dalla
prigionia del mondo alla libertà della solitudine. Ad ogni Pentecoste tutti celebravano il grano e il lievito, la rivelazione e le leggi
che permettevano di santificarsi, il cibo materiale e il sovrasostanziale. Se avessimo interrogato un mistico [...] ci avrebbe spiegato
che l'uomo è simile ad una candela: il corpo è il cero, lo stoppino
l'anima e la fiamma lo spirito.
In attesa della Pentecoste
I discepoli e la Vergine da pochi giorni erano stati abbandonati
dal Maestro che si era lasciato sacrificare come un agnello, dopo
aver insegnato una celebrazione particolare della Pasqua, del passaggio. Sarebbe stato altrettanto sconvolgente il mutamento
della Pentecoste? I discepoli si erano dunque ritirati a pregare,
colmi d'incertezza e assillati da interrogazioni; dal Maestro avevano avuto spiegazioni ma restavano a cospetto di enigmi insondabili. Tutta la storia della loro fede avita era confermata e capovolta. L'intensità di gioia e di sgomento di quei giorni dobbiamo
farla nostra, in certa misura, se vogliamo intendere quel che avvenne dopo. Essi recitavano la preghiera insegnata dal Maestro,
ma quel regno dovevano invocare e nel contempo non pensarci
[...]. Infine giunge l'ora terza di stamattina. Ed ecco quel fragore
del Sinai fu di colpo riudito e cominciò a soffiare un vento veemente. Dio — dice la Scrittura - apparve sul Sinai come fornace,
qui invece appaiono lingue di fuoco, o apparizioni simili a lingue
di fuoco, e calano sui discepoli. In questo quadro leggiamo la
teoria della Grazia. Se il sole è la fornace cosmica, emblema del
Padre, la luce e il calore sono la sua sostanza. Ma la partecipazione a questa sostanza ci è comunicata come qualcosa che è destinata individualmente a noi: il nostro destino è sempre singolare; lo Spirito si effonde sull'uomo singolo, anche se propiziato
da preghiera comune. Coloro che sono accorsi al boato osservano sgomenti quegli uomini che, travolti da un'ebbrezza divina, esultano. Alcuni s'accostano con devozione, altri dicono:
«costoro hanno bevuto vin dolce, cioè nella Palestina di allora,
vino pepato».
Quanti di noi stanno dall'una e quanti dall'altra parte?
Quanti di noi direbbero: «hanno bevuto vin dolce!»? Quanti di
noi vorrebbero, viceversa, mettersi in ginocchio ed ascoltare? Ci
vuole molta umiltà ed audacia per non esclamare: «sono ubriachi» invece che: «hanno conosciuto di schianto verità tali, hanno
capito di colpo tali cose che non stanno più nel loro corpo, bruciano, radicalmente diversi dai poveri esseri umani travolti dalle
loro comuni esultanze. Che io lo impari da loro!». Pochi sanno
dire cosi.
Nella calca di Gerusalemme così dissero tremila persone!
In quell'ora si svelò il Mistero della Trinità
In quell'ora terza, dice la liturgia greca, si svelò il mistero della Trinità, solo allora si compì la rivelazione completa: «Noi tutti» proclama maestosamente, alla nona ora «sui quali la grazia deificante
ha soffiato dall'alto, divenuti folgoranti, splendenti, tutti trasformati da un mutamento inaudito e magnifico, contemplando la
sapienza uguale di forza e indivisa, glorifichiamo l'essenza del triplice irraggiare».
«Porziuncola», Assisi, nuova serie 502, n. 7, agosto-settembre 1972, pp.
220 s. Testo della conferenza per la serie «Appuntamenti dello spirito»,
Sala Francescana di Cultura, Assisi, maggio 1972.
L'azione profana di oggi fu sacrale nei primordi
Ogni cosa si spiega ritraendola alle sue origini, e all'inizio di ogni
opera umana scopriamo un rito, sicché l'esclamazione di Faust si
salva purché completata: «All'inizio fu l'azione rituale».
E quale azione oggi profana non fu infatti sacrale nei primordi?
L'agricoltura stessa si dice nascesse dalla costumanza di posare primizie votive sui tumuli e di farvi immolazioni che ingrassavano il
terriccio; le piante cosi disseminate e nutrite dalle onoranze funebri spuntavano quasi come una risposta dei morti. L'opera agraria
che ne sorse fu tutta sacerdotale e le tradizioni contadine ne recano qualche esile traccia. Il primo allevamento del bestiame non
fu economico ma zoolatrico; la sensitività talvolta vaticinante dell'anima belluina destava meraviglia e le capacità che hanno le bestie di accettare senza retour sur soi mème iì primo destino e la loro
pratica dell'orazione (poiché ancora Tertulliano nel De Oratìone
affermava che le bestie pregano) inducevano a tributar loro un
culto.
Ma perfino le astuzie della caccia, la quale nei primitivi suscita
pene e pentimenti placati soltanto in virtù di cerimoniali espiazioni, furono originariamente riti che imitavano l'andatura e il
timbro degli animali con un'emulazione religiosamente amorosa
o almeno simpatica che ne penetrava il segreto, ne coglieva il
ritmo (il nome segreto), offrendo un irresistibile specchio alla
loro anima. Nei riti dionisiaci che tuttora si perpetuano nelle
campagne della Tracia era consuetudine tempo addietro richiamare dai monti con certi canti il capro che l'anno prima era stato
messo in libertà e che accorreva come risucchiato nel vortice delle
musiche e dei balli, quasi offrendosi in olocausto. Tuttora in Spagna usa indurre le colombe a calarsi in volo scagliando con la
fionda una pietra da cui pendono certe carte le quali vibrano con
un suono consentaneo alle colombe; rito originariamente d'omaggio, certamente all'origine dell'arte dei frombolieri iberici lodati da Cesare.
Tuttora si incanta il serpente con il tamburo in Marocco, ed in
India con il flauto, né dovrebbe essere impossibile scoprire negli
Abruzzi qualche superstite serparo esperto nelle seduzioni del fischio rituale. La storia dell'amore dell'uomo per le bestie è delle
più tristi, poiché è quella d'una mimesi culturale che si corrompe
fino a diventare adescamento di cacciatore. Si narra spesso che i
santi impetrino nuovamente il totemico, rituale rapporto con le
belve, e d'altronde la santità è appunto la restaurazione delle origini; un tempo ci si dilettava di dipingere Elia col suo corvo, San
Girolamo col leone, San Francesco dinanzi agli uccelli o al lupo,
Sant'Antonio che parla ai pesci.
Soltanto la singolare gravitazione verso la rapacità dei moderni
fa adoprare qualunque ritrovato per fini utilitari: ai Cinesi non
venne fatto di usare la polvere pirica se non per i fuochi d'artificio
delle loro celebrazioni né d'impiegare la bussola se non per i riti di
geomanzia; i mulini in Giappone furono adibiti dapprima soltanto a far girare le macine da preghiera.
E quale lavoro non imitò una cosmogonia? La tessitura, la fusione dei metalli furono imprese sacrali, in cui ogni gesto rinviava
a processi paralleli e scambievoli di purificazione interiore, i loro
canti di lavoro erano nel contempo inni liturgici e le loro macchine erano sacre suppellettili.
Come non esistette in antico un lavoro non contemplativo cosi
nemmeno era concepito un gioco fine a se stesso. Presso alcune
tribù dell'Equador il gioco dei dadi tuttora è un'evocazione dei
morti, e il gioco del pallone fu presso gli antichi messicani un
culto in cui le squadre dei celebranti dovevano scoprire dalla sorte
se stavano impersonando l'una o l'altra persona del Serpente piumato, ed era ancora una cerimonia ecclesiastica nel Medioevo europeo, nella cattedrale di Auxerre.
E ciò che oggi è macelleria fu immolazione ieratica, ciò che è
matrimonio fu ierogamia, ciò che è gara fu riesumazione religiosa
della lotta perenne tra gli opposti, ciò che è guerra o azione in giudizio fu tenzone cerimoniale e ordalia, la ginnastica e gli esercizi
acrobatici. Nello stato primordiale per l'uomo conta la quiete interiore non deturpata da passioni personali o collettive, da immagini arbitrarie o da futilità, poiché per esperienza egli sa che ripulendo l'anima fino a renderla specchiante, si acquista preveg-
genza, giustizia (quale arte di assegnare a ogni cosa il suo luogo
naturale), indifferenza regale. Impetrare la quiete è il sommo
bene, di fronte al quale ogni diverso proposito diventa trascurabile; quando si imponga inevitabilmente il bisogno d'occuparsi
di altra cosa l'uomo tradizionale la inquadrerà in modo da non esserne sopraffatto, e cosi la guerra diventerà esercizio ascetico, la
caccia sarà esercitata con riverenza verso le vite che tocchi sopprimere, il raccolto stesso impegnerà ad atti di omaggio verso le forze
vegetali. Il miglior mezzo per tenersi in uno stato di equilibrio
perfetto è la contemplazione del tutto sicut in principio etnuncet
semper e la sua ricapitolazione perpetua, perciò ogni manufatto
umano nello stato primordiale deve presentarsi alla contemplazione e ripetere simbolicamente il modello del cosmo quale struttura di piani digradanti dall'essere al divenire.
Di queste verità ci si è accorti abbastanza di recente, grazie all'opera di Bachofen nel secolo scorso e all'audace Frobenius, ma
anche per merito di certi inglesi: Tylor nel 1871 credette di contribuire alla dogmatica e apologetica dell'evoluzionismo con Primitive Culture, ma veniva soprattutto notando quante cose d'apparenza trascurabile della vita quotidiana fossero fossili dall'augusto passato, come la raganella o la trottola, antichi strumenti
sacri. Nel 1912 poi, Murray intrattiene sulla nascita liturgica
della tragedia e Cornford sulla consimile scaturigine dei gioci
olimpici e nel 1923 Goitein riconosce la forma integra di ciò che
oggi sono gl'istituti giuridici nelle ordalie e infine nel 1927 Scott
Buchanan (in Poetry and Mathematics) osa discernere dietro ogni
giudizio sintetico, e dunque dietro ogni pensiero scientifico, la
procedura sacrale dell'agone, con i suoi momenti: lo sparagmóso
lacerazione, Yanagnórisis o riconoscimento, e l'epifania infine
della nuova idea.
L'azione profana di oggifu sacrale nei primordi, «Corriere della Sera», 15
settembre 1966.
La sapienza primordiale
Capita, a chi studi la letteratura mistica, di intravedere una storia del tutto opposta a quella evoluzionistica, dei manuali, delle
concioni e, di conseguenza, dell'opinione comune: invece di
movimenti lineari o di spirali (reculs pour mieux sauter) che si
snodano verso un futuro sempre più confortevole, il divenire si
configura come un caleidoscopio dove un numero noiosamente
uguale di vizi contrasta, sotto vesti via via diverse, la successione
di stupendamente uguali vocazioni, all'estasi o semplicemente
all'impassibilità.
Queste pigliano forme, si valgono di simboli analoghi fra loro
nel tempo e nello spazio senza che nessi storici, trasmissioni documentabili giustifichino tale loro perennità: identico nel volgere
dei millenni il santo, identico il suo avversario, la storia si vanifica
in un'eterna lotta dello stesso eroe con un Proteo multiforme
quanto immutevole. A voler delineare comunque una storia, essa
appare allora semmai come un moto calante da un Eden dove la
comunità intera aspira all'estasi e al rito e vive con empito i suoi
simboli, come una vicenda digradante di corruzione in traviamento fino ai moderni mondi industriali. Emblema della storia
sarà dunque non già il Titano che scali l'Olimpo spezzando a una
a una le proprie catene e via via strappando a Giove le armi, bensì
piuttosto il granchio freneticamente retrogrado.
Questa visione della storia universale presso i conformisti passa
per un'allucinazione, una febbre che coglierebbe l'incauto il quale
osi esplorare una regione infida, contro la quale la cultura ufficiale, giudiziosa, non manca di porre in guardia: il mondo dei mistici per la cultura moderna è infatti un quartiere culturale malfamato, la parola stessa «mistico» passa per un termine spregiativo,
perfino più di «torre d'avorio» (locuzione nella quale soltanto un
uomo di un rigore e una indipendenza straordinari oggi saprebbe
riconoscere un altissimo fine e una lode quale soltanto la Madre
di Dio merita in pieno).
Eppure tutti gli antichi, da Confucio a Platone, nutrirono la
certezza d'un Eden primordiale che oggi sembra, ai più, malfa-
mata. Sembra, forse per poco tempo ancora, poiché da molti e diversi punti di partenza si torna ad approdarvi e si riconosce la follia della vessatoria fede evoluzionistica, rifiuto positivistico da lasciarsi ai Teilhard de Chardin. Nella storia delle religioni il saccheggiato e poco citato Wilhelm Schmidt mostrò come tutti i dati
si chiarissero se si postulava una Rivelazione primordiale. Nella
storia della musica Curt Sachs avviò quegli studi di etnomusicologia che Marius Schneider ha condotto al punto in cui riaffiora il
postulato di una sapienza primordiale perfetta. Nella etnologia è
avvenuto che tutti coloro i quali abbiano indagato a fondo un
qualche popolo fossile, abbiano visto riemergere sotto i loro occhi
il cosmo ordinato e perfetto delle origini (è di questi giorni il volume di G. C. Griaule Etimologie et langage, sulla teologia vissuta
del Verbo presso i Dogon). Nella paleontologia Koenig mostra
come questa riscoperta si imponga, una volta che ci si sia affiancati dai pregiudizi positivistici e si cessi di misurare la eccellenza
intellettuale dell'uomo sulla qualità tecnica dei suoi manufatti.
In questo momento è proprio dal luogo dove sembrava volersi
arroccare lo spirito dell'evoluzionismo che giungono i più
confortanti messaggi: la storia della scienza diventa la via d'accesso più diretta alla sapienza, alla metafìsica primordiale grazie
alla «cosmologia arcaica» che Giorgio de Santillana sta lentamente edificando con l'aiuto di alcuni collaboratori che si è saputo scegliere nel Massachusetts Insti tute of Technology (un sinologo, un astronomo eccetera). Il mese scorso egli ha esposto, in
una conversazione all'Istituto Accademico di Roma, questa sua
esperienza, con graziosa semplicità: «Io sono storico della scienza
- svolgo quindi un'attività considerata rispettabile - ma mi sono
abbandonato alla fuga nelle antiche età, all'indietro, e da storico
del pensiero greco che fui per qualche tempo — si sta sempre bene
in Grecia - mi sono ritirato piano piano verso i millenni avanti
Cristo. Le mie ricerche sul pensiero scientifico mi spinsero più in
là della Grecia, e mi trovai in ambienti molto meno familiari e naturali - la Grecia è un pochino casa mia — ma mi ci spinsi perché
cercavo quale fosse l'origine di questa nuova cosa nel mondo, che
è il pensiero scientifico. E quando mi guardai attorno là dove ces-
sano i documenti scientifici strettamente detti, mi trovai in regioni dove si parlava senza alcun costrutto dal punto di vista
scientifico. Si chiamava allora, questa roba, materiale mitico e religioso. La parola "religioso" concede spesso ai dotti di non aver
da cercarne il senso, e al traduttore di mettere insieme parole in libertà, purché abbiano un certo senso poetico, aulico. Ma mi colpirono anche nei cosiddetti Primitivi certi discorsi che dimostravano un costrutto effettivo che, seppure incomprensibile, si riallacciava certamente anche alla mitologia greca. E fidando nell'idea che questa gente non erano dei sempliciotti o dei visionari come qualche volta i traduttori li facevano apparire e appoggiandomi alle grandi ricerche dell'etnologia culturale - in questo soprattutto i tedeschi mi hanno aiutato, perché gli americani sono
rimasti un pochino troppo fissi all'antropologia - andai avanti, e
ci vollero anni di schedatura e di ricerche critiche, ma via via era
come se vedessi emergere un continente sommerso - come la
cathédrale engloutie di Debussy, di cui ancora si sentono le campane sotto l'acqua. Era un continente nel tempo, non già nello
spazio, era il mondo che conosciamo, ma attraverso millenni
scomparsi - diciamo almeno fino al 7000 avanti Cristo».
De Santillana cita Cocteau: «puisque ces mystères nous dépassent,
tâchons de nous enfaire l'organisateur», e ricorda come in questa nostra generazione una pleiade di studiosi si sono messi all'opera:
«nomi come Hartner, van den Waerden, von Dechend, Needham,
Werner, Marius Schneider, forse provenienti da tutto l'orizzonte
della cultura». Infatti Marius Schneider sta completando, anche
lui, una monumentale Cosmogonia. Una naturale convergenza
di studi va determinando quella che l'ultimo grande metafisico
europeo, René Guénon, chiamava la Tradizione e la sua «scienza
sacra».
Nel volume da poco uscito presso Sansoni, Le origini del pensiero scientifico, de Santillana parla della «grande costruzione arcaica» [...] su cui già si era posata la polvere quando i Greci entrarono in scena. Tuttavia qualcosa di essa sopravviveva nei riti tradizionali, nei miti e nelle fiabe che nessuno più capiva. Presa alla
lettera, essa fu il lievito dei culti sanguinari con cui si propiziava la
fertilità, basati sulla fede in un'oscura forza universale di natura
ambivalente, fonte al contempo del bene e del male, datrice di
vita e di morte. I suoi motivi originali riscoperti riecheggiarono,
conservati quasi integralmente, nel pensiero assai più tardo dei
Pitagorici e di Platone».
La teoria del sacrificio qui adombrata, l'unica all'altezza degli
studi migliori viene a dar ragione al polemista settecentesco antivichiano, il Finetti, con postuma giustizia.
In un colloquio dell'Unesco nel dicembre scorso de Santillana
forniva altri accenni dell'astronomia arcaica, base del primordiale
pensiero metafisico, per il quale il fine supremo di ogni indagine
doveva essere la conciliazione dell'uomo e del fato, poiché tale era
il semplicissimo fine che le scienze hanno smarrito del tutto nell'evo moderno.
L'uomo dei primordi pensava non già secondo concetti rigidi
ma secondo «schemi come la eclittica con le sue costellazioni, le
stazioni degli astri, le zone celesti, certi miti-chiave, questa strana
uranogeografia dove si connettono cielo e terra sotto la dominazione dei signori planetari dall'inesorabile corso. Ma è anche un
legame fra l'armonia e gli astri, l'armonia e le unità di misura, i
principii supremi di esattezza che si denominarono maat in
Egitto e ria ovvero rito in India. "Fra la musica degli zufoli rituali
e il calendario, affermò un principe cinese, la combinazione è cosi
precisa che non ci passerebbe un capello." E così l'alchimia fu
combinata con l'astrologia, e poi la astromedicina, le piante, i metalli, gli alfabeti, i giochi sapienti come gli scacchi, i quadrati magici come quello che sussiste nella Malinconia di Dùrer, il microcosmo combinato col macrocosmo.
«Il tutto non già disposto come un sistema logico, ma come
una fuga musicale, come deve essere un vero organismo chiuso
[...]. Ce ne resta il numero e il ritmo, l'incidenza del momento
unico, del tempo giusto, il kairós dicevano i Greci, che decide fra
essere e non essere: poiché ci fu un tempo in cui il giusto era innanzitutto l'esattezza, e il peccato era l'imprecisione.»
«Corriere della Sera», 5 agosto 1966.
Il duende ignoto ai filosofi
I quadri dell'Occidente che attraevano come sortilegi gli Indù
furono le scene di baccanali. Ricolmano ancor oggi i musei
dell'India. Era come se i signori di quella terra intatta percepissero l'emozione nascosta, la giga taciuta dell'occidentale.
Non è mai stata una religione apertamente praticata il dionisismo. Nell'antichità fu condannato dai senati, esplose periodicamente, fu nascosto; forse ebbe la sua giornata trionfale con
Nerone. Il cristianesimo tentò di rubargli date (il 25 dicembre), miti (Cristo-vite), sapori (la coppa del sangue eucaristico) per seppellirlo in eterno. Ma la storia europea lo vede
riaffiorare: il suo fremito lo s'indovina a ogni scarto dell'Ordine cristiano. E guai, quando ricompare: getta nella transe,
spinge all'assassinio. Tuttavia, non si estirpa. La poesia ne è fatalmente pervasa.
Nella Spagna ancora vastamente preservata dall'industria splendette il più scatenato seguace di Dioniso, l'addensarsi di sussulti,
vertigini, deliri e dionisiache conoscenze che fu Lorca. Con la successione fluviale delle sue metafore travolse e ammutolì chi lo udì
e lo lesse, esse gli zampillavano gloriose, auliche, erudite, gitane e
aristocratiche; scaturivano da esperienze ancora trepide: convegni
esaltati, danze tradizionali, incontri con piante, canti popolari carichi di tutte le civiltà che alimentarono la Spagna, da Bisanzio all'Arabia, ricordi di libri squisiti.
La memoria di Lorca era effervescente; lasciandoci contagiare
dalle sue espansioni, dalle sue scoperte incessanti, esultiamo, diventiamo lucidi ed ebbri: la nostra mente si distoglie dalla realtà
quotidiana, si insedia nella meraviglia. Lorca illimpidisce e stordisce. Offre un bicchiere di vino pregiato. Credo che ci sia un
corrispettivo di Lorca abbastanza sicuro: la recitazione dei canti
vedici dopo l'ingestione del soma. A poco dalla morte di Lorca,
nel 1939, l'identica tremenda esaltazione si ripresentò in un giovane italiano intriso di letture russe, Tommaso Landolfì, che
scriveva il suo capolavoro, una perfetta riemersione dionisiaca,
La pietra lunare.
Reputo il saggio sul duende fra i massimi del secolo. È di
fatto un trattato solenne intorno a un vocabolo dei più ricchi
della lingua spagnola. In Andalusia designa un incanto inesprimibile e colmo di mistero, nella parlata quotidiana denota una
fonte di inquietudine interiore, ma in antico anche un particolare broccato, oltre al folletto. Tutte queste accezioni confluiscono nella creatura effigiata da Lorca, il quale tuttavia nulla
s'inventa ad arbitrio: la trae dal limo que todos conocemos, que
todos ignoramos.
Questo trattato parte dall'interrogazione: «Chi è l'ispiratore
angelico che insieme ci solleva e ci fa patire?». La posero alcuni nel
nostro secolo, come Rilke e modestamente Benjamin e con la
massima profondità Brjusov. Essa presuppone una superba letteratura, che nella prima metà del secolo non era nota a molti,
quella russa sullo sciamanesimo.
Chi appunti lo sguardo dentro di sé scorge nebbie e ombre; il
poeta in quella confusione ravvisa invece membra e volti squadrati da un'intensissima luce, paesaggi interni: vicende che
echeggiano miti, fiabe immemoriali, sicché soltanto un poeta
può descrivere con quella folla anche il duende ignoto ai filosofi
(benché il custode di Socrate appartenesse alla stirpe). Il poeta
vede verginalmente e raffigura con fedeltà. Esclude dalla visuale
l'angelo, e la musa, configge lo sguardo nel profilo elusivo del
duende, che s'installa en las últimas abitaciones de la sangre. Si
scarta la fragranza di violette della poesia settecentesca (Lorca
pensava forse a Pope? Alla sua proliferazione di spiriti?). Si toglie
di mezzo la cerchia di Dio, sia la brutale eremitica sia la rarefatta
mistica. Ciò che avvince Lorca, su cui egli si fissa è la mano di
Goya che tr
Scaricare