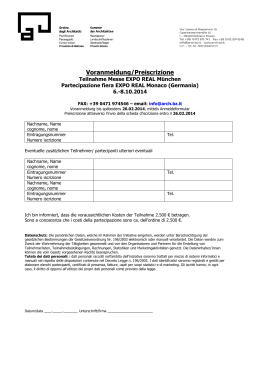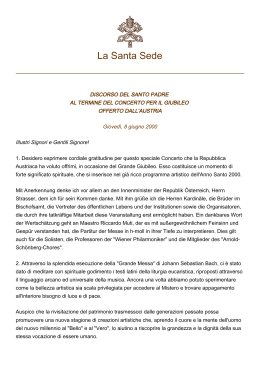Jacques e i suoi quaderni 34-35 _____________________________________ Pubblicazione semestrale. Registrato presso il Tribunale di Pisa il 3 settembre 1893, n. 16. Redazione: Marianne Hepp ............................................................................................................. Numero 34-35, 2000 © 2000, Jacques e i suoi quaderni, Pisa Seconda edizione, luglio2002 4 Jacques e i suoi quaderni _____________________________________________________________ Enrico De Angelis L’Ottocento letterario tedesco 2000 34-35 5 6 Indice Sul metodo .......................................................................................................... 11 Premesse........................................................................................................... 13 a. Il narratore...................................................................................................................... 13 b. Che cosa è destinato a restare fuori............................................................................ 15 c. La caducità...................................................................................................................... 16 d. “Germanistica”..............................................................................................................18 Discussioni....................................................................................................... 21 a. Sulla teoria della ricezione ............................................................................................ 21 b. Sul postmoderno ........................................................................................................... 24 c. Il narratore...................................................................................................................... 26 I Il tempo del Nebeneinander........................................29 I, 1. .................................................................................................................... 31 I, 2. .................................................................................................................... 41 Excursus: Persona e idea........................................................................................................ 47 Excursus: Sociologia e Dichtung .............................................................................................50 Excursus: Sulla periclitante costruzione del senso ....................................................................69 I, 3. .................................................................................................................... 72 Excursus: Sulla resistenza delle forme.....................................................................................82 II Le tradizioni............................................................... 111 II, 1.................................................................................................................. 113 II, 1, 1. Nascita della germanistica.................................................................................113 II, 1, 2. La Dorfgeschichte .............................................................................................118 II, 1, 3. Il romanzo storico .............................................................................................120 II, 1, 4. Le letterature dialettali.......................................................................................122 II, 1, 5. La satira ...............................................................................................................124 II, 2. Editoria e pubblico.............................................................................. 127 II, 3. I teatri. Teoria e prassi ........................................................................ 131 II, 4. Riflessioni sul dilettantismo ............................................................... 134 II, 4, 1. La borghesia. ......................................................................................................135 II, 4, 2. Contro il romanticismo.....................................................................................137 II, 4, 3. L’alternativa. .......................................................................................................137 7 II, 5. La tradizione lirica............................................................................... 152 II, 5, 1................................................................................................................................152 II, 5, 2................................................................................................................................159 II, 6. Il mito americano ................................................................................ 170 II, 7. Il Faust dopo Goethe .......................................................................... 171 Excursus: Tradizioni...........................................................................................................181 III Il popolare ................................................................ 185 III, 1. Il popolare I e dintorni .................................................................... 187 III, 1, 1. Il Volkstück.......................................................................................................187 III, 1, 2. ............................................................................................................................199 Excursus: Sulla saldezza della forma-rifugio.........................................................................211 Excursus: Attualità, località................................................................................................215 III, 2. Popolare II e congedo....................................................................... 217 III, 2, 1. .............................................................................................................................217 III, 2, 2. .............................................................................................................................231 Excursus: il Bildungsroman .................................................................................................240 IV Troppo a tempo - fuori del tempo ....................... 249 IV, 1. ............................................................................................................... 252 Excursus: Biedermeier, ovvero: Come si costruisce una definizione. .........................................263 V Mondanità, province. ............................................... 269 V, 1.................................................................................................................. 271 Excursus: Il racconto a cornice..............................................................................................287 V, 2.................................................................................................................. 288 VI Come resiste il Romanticismo............................... 325 VI, 1. La triade............................................................................................... 327 VI, 2. Due riflessioni sul romanticismo lontano ...................................... 335 Excursus: Dall’A alla Z.....................................................................................................343 Excursus: Dalla Z alla A...................................................................................................345 8 VII Realismo.................................................................. 347 VII, 1. Il lavoro ............................................................................................. 353 Excursus: L’antisemitismo nella letteratura tedesca ...............................................................357 VII, 2. Le grandi trasformazioni ................................................................. 370 VII, 3. L’ascesa sociale ................................................................................. 372 VII, 4. Il controllo sociale............................................................................ 378 VII, 5. La sessualità....................................................................................... 380 VII, 6. Le donne............................................................................................ 387 VII, 7. La famiglia ......................................................................................... 391 VII, 7, 1. La domestica....................................................................................................392 VII, 7, 2. Progetti matrimoniali .....................................................................................394 VII, 7, 3. Conflitti ...........................................................................................................396 VII, 7, 4. Relazioni extraconiugali .................................................................................396 Excursus: Sulla mancata comunicazione fra autore e lettore...................................................397 VII, 8. Fantasmi ............................................................................................ 400 Postilla ............................................................................................................ 403 VIII.................................................................................. 405 VIII, 1. Un imbarazzo.................................................................................. 407 Excursus: “Progresso” in letteratura. ....................................................................................412 VIII, 2. A futura memoria. La scrittura “privata” .................................... 412 IX Moderno I ................................................................ 417 IX, 1. Preliminari........................................................................................... 419 IX, 2. I circoli, le riviste................................................................................ 422 IX, 3. Le teorie .............................................................................................. 424 IX, 4. Il nuovo (la metropoli, la tecnica) e il vecchio (la forma) ............ 430 IX, 5. Il teatro................................................................................................ 433 IX, 6. Le associazioni ................................................................................... 436 9 IX, 7. La Freie Bühne. Gerhart Hauptmann. ........................................... 439 IX, 7, 1. Papa Hamlet........................................................................................................441 IX, 7, 2. Vor Sonnenaufgang (Prima dell’alba).................................................................442 IX, 7, 3. Holz (e Schlaf) ..................................................................................................448 IX, 7, 4. Scissioni e filiazioni ..........................................................................................450 IX, 7, 5. Die Weber (I tessitori) .......................................................................................452 IX, 7, 6. Verso il teatro intimo.......................................................................................455 IX, 7, 7. Ulteriore produzione di Hauptmann.............................................................456 IX, 8. Il Phantasus di Arno Holz.................................................................. 457 IX, 9. Moderno I: Conclusioni.................................................................... 467 X Moderno II ................................................................ 469 X, 1. Egemonia e vivacità culturale ............................................................ 471 X, 2. Conoscenza del simbolismo francese............................................... 474 X, 3. Definizione........................................................................................... 476 X, 4.................................................................................................................. 480 X, 4, 1. ...............................................................................................................................481 X, 4, 2. ...............................................................................................................................527 X, 4, 3. Decadenti............................................................................................................540 X, 5. Moderno II. Conclusione................................................................... 554 Excursus: Soggetto, prima e poi ............................................................................................555 Col senno di poi................................................................................................. 557 a. Finale come apologo ...................................................................................................559 b. Che cosa non è moderno nell’epoca della modernità?...........................................560 c. La coerenza. Premesse in forma di bilancio ............................................................563 d. La coerenza. Rappresentazione e sostituzione........................................................565 e. Il canone .......................................................................................................................567 f. Un problema generale .................................................................................................571 Da solo mi presento e son l’epilogo...................................................................... 572 Riferimenti bibliografici ............................................................................... 574 10 Sul metodo 11 12 Premesse a. Il narratore 1. In questo libro si narrano cento anni di storia della letteratura tedesca; le date che delimitano il periodo sono il 1813 all’inizio e il 1914 alla fine. Esse sono date che nel ricordo generale significano guerre - guerre di liberazione dal dominio napoleonico, scoppio della prima guerra mondiale - e proprio come tali vengono qui utilizzate. Dunque gli estremi dell’epoca qui considerata non sono costituiti in primo luogo da avvenimenti letterari ma da eventi di altro genere, che per abitudini di vita consideriamo più importanti, più evidenti, prioritari. Si può applicare alla letteratura, sia pure in forma attenuata, quel che Aristotele scriveva per la nascita della filosofia: quando gli uomini ebbero sistemato le loro incombenze più urgenti e soddisfatto i loro bisogni fondamentali, allora ebbero l’otium, e nell’otium può fiorire la filosofia. La letteratura, è vero, non si colloca entro la filosofia e tuttavia ha a che fare col mondo della riflessione. Il suo mezzo è l’espressione verbale che, per quanto la si voglia considerare come ancora legata all’elementare, tuttavia per chi la osserva e la racconta deve esserne almeno parzialmente uscita; per esempio non si narra il semplice grido ma il suo contrapporsi al silenzio, dunque si narra un rapporto e non l’elementare. La storia della letteratura, infine, è opera di riflessione, all’interno della quale non vorremo dimenticare quegli eventi primari che comunque si impongono: la vita e la morte, la guerra e la pace. Dunque la storia della letteratura è opera di uno storico – che chiameremo narratore – la cui storia specifica rientra in una storia più generale; per conseguenza egli sa che anche la sua narrazione è parte di una storia più generale, già perché è parte di lui stesso. 2. Ma i movimenti interni alla specifica storia della letteratura sono più autonomi; si possono osservare, riferire e commentare le decisioni che gli scrittori stessi prendono sia dichiarando di riferirsi alla realtà non letteraria, sia confrontandosi con altri scrittori. Sono decisioni omogenee e queste, insieme con i loro risultati, costituiscono l’oggetto specifico della nostra storia. Da più di una prospettiva c’è da aspettarsi l’obiezione che questa sarà magari una storia, non però una storia di ciò che è essenzialmente letteratura ma solo di ciò che le è esterno. C’è da ribattere che difficilmente pare potersi affrontare un’interpretazione (o, altrimenti detto, cogliere quel che è essenzialmente letteratura) senza che la storia sopra sommariamente definita abbia fatto il suo lavoro e abbia collocato il formarsi del testo e del contesto, i quali vengono a loro volta influenzati dalle decisioni degli autori. Pertanto storia e critica si condizionano a vicenda. 13 3. Chi viene decidendo e deciderà man mano tutto questo (già per esempio attraverso la selezione di quanto va narrato) è un narratore. Con le sue sufficienze e insufficienze, con i suoi giudizi e pregiudizi, porrà svolte, cesure, climax e quant’altro. Si confronterà con altri narratori, di questa o di altre storie, con teorici, con le aspettative del pubblico e via via; ma la responsabilità è sua. Il che vuol dire che il risultato della storia sarà una sua costruzione. A sua volta il narratore cercherà di far passare le sue decisioni come oggettive, inoppugnabili, inevitabili, dichiarando di aver messo la sua soggettività al servizio della più palmare necessità. Qualche argomento a sua difesa sarà perfino ovvio. Dirà per esempio che un libro scritto - poniamo - nel 1830 differisce da uno scritto cinquant’anni prima o dopo sia a causa della lingua sia a causa dei temi e di chissà quanti altri segnali; dunque assegnargli un posto non è questione di costruzione, di decisione soggettiva e insomma di arbitrio, ma di date. Si possono immaginare altri argomenti simili a questo, perfino condivisibili. Ma la personalità del narratore ha tale e tanto spazio per manifestarsi, che vogliamo tenere ben fermo alla sua responsabilità. 4. Io, il narratore, risparmierò al lettore ogni attualizzazione forzata. Quando attualizzazioni del genere avvengono, esse mi hanno l’aria di voler mascherare che il narratore non è interessato alla sua materia e vuol parlare d’altro. Non è il mio caso. Altra cosa, invece, è identificare e segnalare le tendenze di lungo periodo, che durano ancora oggi, senza dimenticare evoluzioni e cambiamenti. A ciò l’epoca qui trattata si presta bene. Infatti le forme del nostro moderno vivere ed esprimersi cominciano da prima, dal Settecento, man mano intensificandosi, specializzandosi e imponendosi; quindi ci sarà modo di assistere a volte al nascere, a volte allo svilupparsi di forme che sono anche le nostre. 5. Un’altra cosa risparmierò al lettore: una particolare forma di privilegiare l’una rispetto all’altra corrente. Ho le mie preferenze, i miei valori e le mie idiosincrasie; mostrerò tutto ciò. Ma quel che non farò sarà quel che si può riassumere nella frase: ah, se si fosse sviluppato e affermato questo invece di quello! Si potrebbe credere che un atteggiamento del genere non sconvenga al teorico, intento a cercare qua e là le sue pietre da costruzione. Io però non credo nemmeno a questo: i materiali da costruzione cambiano col tempo, cioè con l’interpretazione; quindi quel che alla fine avrebbe in mano sarebbe più prodotto di costruzione che semplice materiale; il massimo risultato sperabile sarebbe una provvida illusione. Ma questo è il meno. Io non preporrò Stifter a Heine, né Heine a Stifter, perché per conoscere devo integrarli, non scegliere fra i due. Quella costruzione che è la storia letteraria va contemplata tutta intera - e dunque allontanata tutta intera - perché essa è costruzione tutta intera e non solo in parte. Io ne sono parte attiva come narratore nell’oggi. Il mio prediligere e deci14 dere si pone nell’oggi, non nello ieri. E l’oggi va dichiarato come oggi, non va confuso con altro. b. Che cosa è destinato a restare fuori 1. Chi consulti un manuale ben elaborato troverà che il periodo 1813-1914 viene suddiviso in una dozzina di ripartizioni, e magari anche di più. A volte l’apparenza è puramente cronologica: se si dice Vormärz si intende ciò che viene prima del marzo 1848, cioè prima dei moti rivoluzionari; se si dice Jahrhundertwende ci si riferisce agli anni di svolta dal XIX al XX secolo. A volte, invece, quelle suddivisioni non vogliono essere così comprensive, ma indicare un settore, una corrente, una scuola all’interno di una certa epoca: è il caso di Junges Deutschland. A volte si riferiscono a contenuti e stili che si ritiene di poter individuare con precisione: neoromanticismo, neoclassicismo, simbolismo, impressionismo. Oppure intendono indicare un’atmosfera che non ha mai dato luogo a una scuola o a un gruppo che pure dovrebbe essere identificabile in una omogeneità di stili e di contenuti, magari anche per preminenza produttiva di una zona geografica sull’altra: è il caso del Biedermeier. Avviene che anche quando le ripartizioni sono ristrette o per numero di interessati o per durata o per influsso, esse tendano tuttavia a straripare, coinvolgendo nella loro orbita chi altrimenti non si saprebbe troppo bene come collocare. Tuttavia nessuna ripartizione riesce a coprire lo spazio cronologico assegnatole comprendendovi tutti coloro che vi hanno operato. Ciò è vero anche per Vormärz e Jahrhundertwende. Tali denominazioni infatti non sogliono essere adoperate come segnalazioni di date ma ambiscono a essere contrassegno stilistico e tematico. Per cui dire che un’opera è stata scritta nel 1840, rientrando così nel Vormärz, dovrebbe voler dire che essa ha caratteristiche affini alle altre opere scritte nello stesso periodo, ma non - per esempio - a quelle scritte durante la Jahrhundertwende. La seconda affermazione può essere tranquillamente accettata, la prima lo può essere solo se lasciata nel vago. Quando si vuol essere più precisi, si assiste a un complesso lavorio su quelle denominazioni, volto sia a estenderle sia a restringerle. Il fatto è che, a volerle intendere per quel che vogliono essere, cioè constatazioni stilistico-tematiche, le somme di tutte le denominazioni non coprono interamente il secolo da considerare. La loro presenza, anzi la loro intramontabilità, è un segno importante: non si può fare a meno di avere dei concetti intorno ai quali raggruppare dei fatti, anzi senza concetti non li raggruppiamo affatto; ma d’altra parte non c’è un concetto unitario e omniassorbente intorno al quale raggrupparli. L’insufficienza della somma di tante definizioni e suddivisioni dice però di più. Dice che la sommatoria è selezionante e che dunque crea delle zone opache al concetto. La re15 sponsabilità non può essere d’altri che del narratore e non la vogliamo alleggerire nemmeno un po’. Solo che non si tratta d’un incidente di percorso: col suo stesso definire egli seleziona e dunque, mentre porta certe cose al concetto, altre le allontana, le rende opache e propriamente mette se stesso nella condizione di non capirle. 2. Se le denominazioni e i concetti esistenti non soddisfano, il problema di un loro superamento non è insolubile: li si scompongono, ricompongono, ridefiniscono. Praticamente, si passa il tempo proprio a far questo. Alla fine potremo avere concetti precisi e utili; essi ci aiuteranno a vedere un’essenza che, se li avremo costruiti con una certa duttilità, sarà variegata e mobile entro i confini assegnati. In tal modo gli autori di un qualche sottoperiodo non saranno l’uno interscambiabile con l’altro e anzi ciascuno sarà anche movimentato nella propria storia personale. Ma ai suoi bordi quel concetto sarà chiuso in modo ben netto: ai suoi bordi ci sarà la “catastrofe” in altro. Le “catastrofi” non sono collegate fra loro in modo rettilineo. Non avremo una storia che per una qualche necessità naturale vada dallo stadio A alla catastrofe A1, la quale darà luogo inevitabilmente allo stadio B e a nessun altro, cui seguirà la catastrofe B1 ecc. Non dimentichiamo che la storia è una costruzione e - per di più - lacunosa e parzialmente opaca. Una pretesa quale quella di una storia assoluta maschererebbe tutto ciò. Resti invece chiara la responsabilità del narratore. Da una catastrofe all’altra si passa per sua decisione e le zone opache sono da addebitare a lui. La stessa costruzione della catastrofe è opera sua. Dunque si tratta di mantenere vivo un ricordo: la concettualizzazione non è esaustiva. È vero che senza concetti non raggruppiamo fatti, non li capiamo e quasi non li vediamo. Ma quel ricordo è sempre pronto a mettere in crisi la concettualizzazione avvenuta, a tornare al primario, all’antecedente al concetto, permettendo così nuovi concetti e nuove prospettive. Ci troviamo intanto con una storia interna al singolo concetto, cioè a una piccola storia; con un ricordo e una ricorrente presenza delle zone opache da noi stessi create. Quel che chiamiamo storia è la riserva di quel che non capiamo fra l’una e l’altra delle piccole storie. c. La caducità 1. Almeno dall’età romantica a oggi siamo abituati ad aspettarci dalle opere letterarie delle cose non semplicemente diverse ma in più rispetto alla filosofia. Quest’ultima infatti, esprimendosi nel concetto, chiede una risposta o un proseguimento per mezzo di concetti, cioè chiede ancora una filosofia. Il complesso delle opere letterarie (per indicare la cui caratteristica di realizzazione poetica c’è una bella, antiquata parola tedesca: Dichtung) può avere sì la risposta in un’altra 16 opera, ma si apre all’interpretazione. Tale risposta, parimenti giustificata, non è più omogenea, non soltanto perché traduce in termini concettuali un’espressione che non è eminentemente concettuale - e già questo è un notevole problema - ma perché la traduzione non è mai né unica né univoca. Insomma ci aspettiamo che la Dichtung dica di più e di diverso rispetto a quel che non appaia dire. Questo presupposto è però una condizione storica; e il modo di soddisfarlo è anch’esso storicamente condizionato. Col che risiamo alla responsabilità del narratore e alla condizionatezza e caducità delle sue decisioni. Ne deriva una prima conseguenza: l’essere il narratore all’interno di una tale tradizione detta un primo criterio di selezione. È selezionabile quel che è interpretabile, cioè quel che costitutivamente garantisce il persistere di zone opache al concetto. A causa della non unica traduzione concettuale della Dichtung, molti mondi nascono dall’interpretazione. Si potrebbe pensare, per puro amore di logica, che la loro infinita totalità esaurirebbe l’oggetto, ma forse è più logico pensare di no. In ogni caso, noi non possiamo eseguire una tale somma totale poiché ci troviamo di volta in volta dentro uno dei mondi risultanti. Anzi non possiamo affatto rinunciare alla momentanea assolutezza di ciascuno di loro, fino a vedere che essa si disloca, liberando qualcosa che solo ora ci appare essenziale mentre prima non potevamo vederlo affatto. Ciò vuol dire che le zone opache sono caduche: con quel dislocarsi della totalità, esse vengono illuminate. Ma non scompaiono: si dislocano anch’esse, senza che mai un processo di costruzione possa farne a meno. 2. La seconda conseguenza e il secondo criterio di selezione si conciliano molto male con i primi. Ho avuto modo di dire che, entro i confini assegnatele, la piccola storia si muove con più autonomia perché, per esempio, si può dar conto delle decisioni di scrittori che si confrontano con scrittori. Generalizzando si può dire che la considerazione sociologica costituisce un secondo criterio di scelta. Qui i problemi di interpretabilità e di zone opache suscitano assai meno preoccupazioni. I prodotti letterari cooptati da questo secondo criterio possono essere il resoconto giornalistico, la memorialistica e simili, che per loro natura non devono avere bisogno di interpretazione ma di collocazione in un contesto. Tutt’altra cosa rispetto a quanto appena discusso. Dunque questo metodo sta minando se stesso. Di un articolo di giornale si può dire (se del caso): il tale mente; ah, se invece di questo si leggesse quello! Applicarlo al passato è un po’ ingenuo, e qui comunque non lo si farà. Però la prospettiva è cambiata. 3. Viene il dubbio che anche quanto detto prima sia arbitrario o almeno non necessario. Confermano in questo scetticismo i commenti che di fatto hanno oscurato dei testi invece di chiarirli e li hanno resi illeggibili invece che più ac17 cessibili. Certi testi di Goethe sono stati trattati peggio della Bibbia, volendosene spremere i quattro significati: letterale, allegorico, simbolico e teologico. Quasi si avrebbe voglia di tornare a una lettura ingenua, preferendo capirne troppo poco che troppo. Da questo scetticismo salva l’esperienza. Autori come Stifter scomparirebbero alla vista se li si leggesse ingenuamente, cadendo nella trappola di quella superficie fatta di buoni sentimenti e anzi addirittura di prediche. Ciò rimette in primo piano la personalità del narratore, ma ormai siamo ben convinti di quanto precaria sia la costruzione finale, e tanto più precaria quanto più si fa teoricamente ambiziosa. È una costruzione che mentre vive denuncia già le cause del proprio deperire. 4. Contraddizioni da tutte le parti. Con esse dovremo convivere, costruendo un sistema che nasca sapendo di risolversi in contraddizioni e cercando intanto di tenerle più lontane possibile attraverso l’illuminazione di quanti più fatti possibili. d. “Germanistica” Questo libro è scritto da un non tedesco per non tedeschi. A prima vista tale informazione sembra del tutto inutile; non si vede infatti dove possa essere il problema in generale, meno che mai nell’epoca della comparatistica, per non dire della globalizzazione. Ma l’informazione suona diversamente e rivela il suo problema se viene riscritta utilizzando la terminologia tedesca, perché allora bisognerà dire che questo libro è scritto da un non germanista per non germanisti; infatti germanista indicò all’origine lo studioso delle origini della germanità, da rinvenire nella storia della lingua, del diritto germanico, della storia, in particolare delle usanze primeve, tutte studiate per poter ricostruire l’essenza e l’unità germaniche, avendo come intento di compensare l’assenza di uno stato unitario oppure (cambiati i tempi) di costruirlo e quindi di rafforzare la sua specificità. Ben presto giuristi e storici, come pure gli etnologi, seguirono proprie vie e il germanista venne inteso per sottrazione di quelle discipline. Restò però al germanista un convincimento: che le prime verità si rivelino attraverso la manifestazione poetica popolare e che pertanto il germanista, quale studioso della lingua e della letteratura, abbia il compito di identificare l’eterna essenza germanica, con i fini politici già detti. Il lettore non creda che quanto detto si riferisca a una preistoria chissà quanto lontana: la germanistica nasce nel lasso di tempo trattato in questo libro e le sue idee fondamentali, maggioritarie ancora negli anni Sessanta del XX secolo, sono ancora e sempre rinvenibili in germanisti non secondari. È dunque evidente che il presente libro non può porsi gli stessi fini della 18 germanistica; ma è altrettanto evidente che scrivere una storia della letteratura tedesca pone problemi specifici, al di là di quelli posti da una storia della letteratura in genere. Va dunque dichiarato perché venga scritta. Alcune risposte sono possibili, e parti di esse sono forse ovvie. Proviamo a passarle rapidamente in rassegna. È dunque possibile che sia lo storico sia il lettore desiderino nella presente storia un’analogia alla posizione germanistica: mutuarne cioè l’intento di perseguire l’unità della nazione, contemporaneamente ritenendo il linguaggio poetico capace di rivelare le prime verità; in tal caso un intento neorisorgimentale si fonderebbe con un’eredità romantica, magari nella rielaborazione di Heidegger. Se questo è l’intento, la germanistica offrirebbe un modello, sperimentato e variato nel tempo (e quindi diciamo piuttosto una gamma di modelli). Non offrirebbe però l’aggiornamento presumibilmente auspicato, cioè la differenziazione delle culture regionali: il modello Jakob Grimm ha infatti talmente prevalso da non far prendere in considerazione (in modo significativo) questa dimensione; e sì che lo spazio linguistico tedesco avrebbe in proposito da offrire tutto il materiale. Altro possibile intento potrebbe essere ereditare dall’esperienza della germanistica un altro schema: ricostruire il passato al fine di identificare le prospettive per il futuro; tale esercizio è stato ampiamente svolto nel secolo scorso, con accenti politici di volta in volta spostati. Se tale intento può essere ancora considerato attuale, allora nel senso di uno studio dei limiti posti all’azione dal gravare del determinismo dell’eredità culturale e dei momenti di frattura come possibilità di allargare quei limiti. Terzo importante modello: la presenza costante di una dimensione etica. Essa ha cambiato fisionomia nel tempo: etica della Bildung nel senso schilleriano, etica liberale con i germanisti romantici, ma anche etica dello Ständestaat con altri della stessa generazione (spesso addirittura fusa e confusa), etica nazionalista e peggio con generazioni successive. C’è da scegliere e da modificare, anche da rovesciare, mantenendo tuttavia l’aggancio tra rivelazione attraverso la Dichtung e coscienza morale. Tutte queste risposte possono essere giuste (mutatis mutandis) ma sono parziali e comunque, dal punto di vista di chi scrive, non primarie. Con le risposte che ora seguiranno ci muoveremo ancora tra le risposte parziali; però il confronto non avviene più con la germanistica ma con una più ampia prospettiva sulla cultura tedesca. La nostra civiltà ha le sue riconoscibili radici nel romanticismo; ciò non è stato seriamente contestato da nessuno. Ha senso risalire alle proprie radici, e il romanticismo è stato una creazione tedesca, perciò (si può concludere) ha senso interessarsi alla storia della letteratura tedesca. A ciò si possono obiettare due cose: 1) che il romanticismo europeo è stato piuttosto un’invenzione di M.me de Staël che dei tedeschi; 2) che, anche a non tener conto dell’obiezione precedente, il discorso dovrebbe spostarsi e annettere senso piuttosto a una storia 19 della letteratura europea che insegua i suoi centri propulsori attraverso spazio e tempo piuttosto che concentrarsi su una sola letteratura vista dall’esterno. La seconda obiezione può essere ripresa così: che una storia del genere sarebbe auspicabile (il che non è una replica completa); alla prima invece c’è da rispondere: a) che M.me de Staël ha indubbiamente inventato molto, ma senza la materia prima tedesca le sarebbe stato difficile inventare; b) che il romanticismo tedesco non è la stessa cosa del romanticismo francese, italiano ecc., ma che indubbiamente il primo, superato il filtro della Staël, è stato assorbito lentamente dalle altre letterature e quindi ha avuto effetti variati e prolungati nel tempo. Il presente volume non ha a che fare, se non marginalmente, col romanticismo tedesco; ma quel che gli è seguito e che viene qui trattato si è in buona parte affermato attraverso prese di posizione nei suoi confronti. Alla luce del precedente discorso, ciò fa apparire il suo interesse come una specie di interesse di seconda istanza; non è propriamente così: i due poli Heine e Stifter pongono problemi tuttora non aggirabili. Nel discorso riguardante la riflessione sulle origini si pongono anche i seguenti problemi riguardanti la cultura italiana e il suo rapporto con quella tedesca: la nostra dipendenza dallo storicismo e dalla filologia tedesca. Al di là del problema delle origini si pone quello dell’attuale realtà culturale: le letterature moderne (e le culture moderne in genere, almeno per quanto concerne quelle occidentali, delle quali si può parlare con qualche competenza in più e qualche imbarazzo in meno) sono tornate, se non proprio all’internazionalismo medievale, certo a una gran circolazione; quindi scrivere di letteratura tedesca può essere giustificato dall’attuale gran circolazione, per cui anche una letteratura straniera è “nostra”, anche al di là degli influssi storicamente avutisi. Che poi qui venga scritta una storia della letteratura tedesca (e per di più solo in parte) invece di una storia delle letterature occidentali dipende da fattori importanti quali la competenza, l’attuale organizzazione del sapere e via dicendo. Le considerazioni appena fatte sono facilmente completabili a opera del lettore e possono eventualmente essergli sufficienti. Ritengo però di dovergli dire la ragione che muove me. In realtà essa è stata anticipata nel precedente § 3 e qui non resta che precisarla. La germanistica è pur sempre un derivato della critica romantica; entrambe hanno visto nella Dichtung una forma di conoscenza. E ciò era tanto più possibile in quanto i Dichter (veramente non solo romantici; diciamo piuttosto dell’età classico-romantica, per quanto in misura diversa) hanno scritto sulla base di quello stesso presupposto. Dunque la ragione che mi muove è una ragione conoscitiva: scrivo la presente storia perché mi sento autorizzato a vedere nella letteratura tedesca (sottolineo: tedesca) una forma di riflessione. In verità ciò si attenua nel corso dell’Ottocento; le correnti più europeizzanti, il realismo e il naturalismo, sono quelle che offrono meno soddisfazione a una conoscenza parallela a quella filosofica (oppure che sia una forma di quella filosofica), anche se forse ne offrono più a una conoscenza sociologica. 20 Ma la specificità tende a ripristinarsi verso la fine del secolo, o almeno a riaffermarsi in determinati settori. La critica romantica, e per certi aspetti perfino la germanistica nella sua storia, sono state solidali con quel tipo di riflessione. Dunque accetto senz’altro l’eredità dell’epoca classico-romantica (del resto sarebbe illusorio non farlo) ma, di certo, senza dimenticare quel che c’è stato nel frattempo; e dunque non si tratta di ripetere o di mimare quel momento. Pertanto si impone di precisare che cosa intenda per “forma di riflessione”; a tal fine però rimando alle analisi e alle strutturazioni concrete. Discussioni a. Sulla teoria della ricezione La data di nascita di tale teoria viene posta al 1967, quando Hans Robert Jauß tenne la sua prolusione all’università di Costanza. Ecco dunque qualche breve cenno alle sue idee, prima di vedere quali ampliamenti hanno sperimentato. Una frase che Hans Robert Jauß ama ripetere, indicandovi lo spunto iniziale della sua riflessione, è la seguente: nessuno scrittore scrive le sue opere per i critici di mestiere e per le lezioni dei professori universitari ma per il pubblico dei lettori. Il critico deve perciò tener presente che egli stesso è un lettore e che il suo lavoro, per quanto specializzato diventi e per quanto complessi ne siano i gradi, procede però da un primo livello, quello della percezione estetica; è esso a permettergli di andare avanti, cioè di diventare un critico da lettore che era. Il pubblico ha un suo ruolo creativo, partecipa creativamente al processo artistico; infatti esso sviluppa e trasforma il proprio modo di rispondere all’opera, facendo così cambiare i presupposti di ogni nuova produzione, che si troverà di fronte un pubblico sempre mutato, le cui aspettative saranno fondamentali per la sorte dell’opera letteraria. Pertanto lo stesso significato e la stessa forma dell’opera sono un potenziale che si sviluppa nel corso di un processo storico. Hans Robert Jauß ha sempre e insistentemente sostenuto che la sua attività teorica è la teoria di una prassi; che cioè guarda al concreto, all’attività effettiva della lettura. Occorre forse completare la sua insistenza con un’altra osservazione: la sua attività, teorica e pratica, risponde a un’esigenza etica, quella di sottolineare il posto della letteratura nella vita. Jauß ha anche esaminato il piacere che risulta al lettore dall’identificarsi con l’eroe, anche nella letteratura più triviale e di evasione. Sulla scorta di Freud Jauß riflette sul piacere estetico come liberazione di scariche più profonde e ritorno felice del rimosso e dimenticato. Il piano della ricezione ingenua dei testi finzionali non viene disdegnato né dimenticato. Al 21 critico poi toccano altre responsabilità; la sua opera evidenzia dei gradi e si sviluppa su livelli molteplici, con l’obbligo di andare oltre quello della prima lettura; sempre però seguendo anche un’esigenza etica oltre che scientifica. Queste sono le idee-base di colui che viene considerato l’iniziatore della teoria della ricezione. Vari altri teorici hanno contribuito a un allargamento del campo di riflessione, cui si sono aggiunte delle prassi critiche anche nate precedentemente e indipendentemente. Oggi fa parte della teoria della ricezione anche la ricerca sui meccanismi del mercato librario, l’analisi delle reazioni dei lettori, la ricerca degli influssi letterari, delle reazioni varie (per esempio sotto forma di recensione) e via di questo passo. Data la natura della presente pubblicazione, non è possibile dare a tutti questi punti di vista lo spazio che meriterebbero; mi limito a farli affiorare qua e là, compiendo una scelta a seconda dell’importanza che ritengo si debba loro attribuire. Tuttavia anche al di là di questi limiti esterni, e pur con tutti i riconoscimenti del caso, la presente storia non intende collocarsi fra quelle riconducibili alla teoria della ricezione. In questa ritengo ci sia troppo poco posto per il nuovo; pur insistendo essa molto sulla funzione creativa del lettore nel suo attribuire un senso al testo, quando si vanno a vedere i risultati pratici appare che lettori sono fondamentalmente gli altri, che il critico interviene a fare un bilancio oggettivo, non problematizzando la propria soggettività. La modifica di alcune di tali conseguenze pratiche aiuterà a precisare questo concetto. La nostra lettura di un testo, sostengono i teorici della ricezione, è preformata dalle letture che sono avvenute prima di noi; l’attesa con cui ci avviciniamo a un testo avviene su un terreno, tutto sommato, stabile. È vero che al suo primo apparire va misurata la distanza estetica fra l’opera d’arte e l’orizzonte d’attesa dei suoi lettori, quindi va visto se l’opera allarga quegli orizzonti o in quale altro modo vi si rapporti. Ed è vero anche che una lettura è potenzialmente comunicativa, cioè vorrebbe poter conquistare lettori allo stesso testo, se approvato, oppure distoglierne se disapprovato; per farlo, deve munirsi di argomenti. Tutto ciò suona distante e non dice ancora molto sull’atteggiamento di noi moderni nei confronti di testi antichi; sembrerebbe piuttosto che siamo costretti solo a piccolissime varianti entro una storia sostanzialmente continua e che la nostra creatività vada educatamente ridotta ai minimi termini. Voglio ora mostrare come questi presupposti possano essere applicati e modificati in un caso estremo e quindi come, un passo dopo l’altro, si sia costretti ad accentuare le distanze. Il caso estremo è quello del Woyzeck. Qui il lettore non ha semplicemente dato un senso al testo ma l’ha addirittura costituito. Si è parlato, nel caso del primo editore, addirittura di falsificazione; ma le verità che sono seguite non erano meno false, e ciò non tanto a causa di singoli errori, bensì perché era comune il presupposto: si credeva che il dramma fosse l’ultimo di Büchner, rimasto incompleto solo per la morte repentina dell’autore (e quindi, a dirla cinica22 mente, per puro caso), e che quindi occorresse pensarlo come proiettato verso una completezza. Si dirà allora che l’equivoco era stato originato da circostanze esterne o che l’orizzonte d’attesa dei lettori-editori non era pronto a ricevere la constatazione del dato di fatto, cioè che quel dramma era il primo tentativo drammatico di Büchner, da lui abbandonato? Difficile decidere. Una volta però accettata questa constatazione, si ha di certo una sostituzione di paradigma; cambia il senso dello sviluppo di Büchner (anche se molte analisi parziali fatte secondo il paradigma precedente restano valide: basterà citare quelle sull’evoluzione del protagonista da un blocco di stesura all’altro). Altri imbarazzi invece vengono risolti; per esempio il seguente: nel passaggio dal terzo al quarto blocco di stesura Büchner ha sacrificato una bellissima scena, esistente nel terzo, in cui il dottore e il capitano rivelano a Woyzeck che la sua donna Marie lo tradisce; così nel quarto blocco lo spettatore, che invece sa del tradimento, vedrà Woyzeck a contrasto con Marie senza che gli venga mostrato il raccordo attraverso il quale anche Woyzeck viene ad avere la stessa informazione dello spettatore. La drammaturgia dunque è cambiata (si punta più su contrasti immediati che sulle informazioni), cosa che provoca problemi su altri piani. E che questi altri problemi non siano stati risolti va di pari passo con l’abbandono dell’opera. Nel caso di questa singola realizzazione la funzione creativa del lettoreeditore è evidente, anche a tanto tempo dal rinvenimento dei manoscritti e dalla loro edizione. Ma una storia non ha a che fare con una singola opera. Una storia ha a che fare con il complesso dei possibili cambi di paradigmi (oppure con la voluta riaffermazione dei vecchi). A questo si è voluto pensare con le considerazioni metodologiche poste all’inizio. Il rivelarsi progressivo e un po’ fantasmatico del senso a patto di cambi di paradigma ha preso il posto di un ancoraggio un po’ troppo immobile alla tradizione; la concettualizzazione di campi di indagine quali cose ben delimitate ai bordi ma mosse al loro interno, senza che una si “rovesci” nell’altra, ha accentuato la funzione soggettiva dello storico chiamato ad assumersi la responsabilità delle sue definizioni; il riferimento al costanteincostante apparire dell’opera così come al contesto del suo formarsi vuole assicurare che tutto questo esercizio abbia validità intersoggettiva, che cioè appartenga a una tendenza storica in cui un discorso si fa solo se ha un fundamentum in re, se cioè rinvia a un’opera, perfino se quest’opera è più o meno inventata, come è stato per lungo tempo il Woyzeck. Siamo obbligati a illuderci di poter cogliere un’opera nella sua verità assoluta, perché un lettore c’è se c’è un’opera. Ma dovremmo essere al punto di non illuderci sulle nostre illusioni. 23 b. Sul postmoderno In precedenza (Premesse, b.) è stato detto che da più punti di vista c’è da aspettarsi l’obiezione che una storia quale quella qui proposta non possa essere considerata storia di quel che la letteratura essenzialmente è. Una tale obiezione potrebbe venire, per esempio, da un’area che, con termini solo in parte coincidenti, si chiama decostruzionista, post-strutturalista, post-moderna. Nella posizione di uno dei critici più in vista di quest’area, Paul de Man, l’obiezione segue a una premessa, secondo la quale «la letteratura è sempre stata essenzialmente moderna». Ma la modernità è contraddizione, di cui la letteratura è costitutivamente vittima. «La modernità esiste nella forma di un desiderio di cancellare tutto quanto è avvenuto prima, nella speranza di raggiungere alla fine un punto che potrebbe essere chiamato un vero presente, un punto d’origine che indica un nuovo orientamento. […] La modernità si affida al potere dell’istante presente come origine, ma scopre che, nel dividersi dal passato, si è nello stesso istante divisi dal presente.» Questa simultaneità di momenti (della «fuga dalla propria specificità», del «ritorno che riconduce la letteratura a ciò che essa è» e infine «quello critico in cui la fuga si rovescia nel ritorno o viceversa») è eterna: de Man dichiara senz’altro di insistere «su categorie e dimensioni letterarie che esistono indipendentemente dalle contingenze storiche». Un presupposto del genere non pare fatto per incoraggiare l’esperienza storica; ma de Man non elude il problema. Dapprima inserisce la storia nell’esperienza contraddittoria della modernità nel suo contemporaneo dividersi dal passato e dal presente; quindi la lega alla ripetizione della letteratura quale perennità della modernità (dunque è la modernità «il principio che conferisce alla letteratura durata ed esistenza storica»). Infine pone il problema nel seguente modo: È possibile concepire una storia letteraria che non dimezzi la letteratura col porci ingannevolmente dentro e fuori di essa, e sia in grado di mantenere da un capo all’altro l’aporia letteraria, render conto nello stesso tempo della verità e della falsità della conoscenza che la letteratura trasmette su di sé, distinguere rigorosamente tra il linguaggio metaforico e linguaggio storico, e spiegare la modernità letteraria come anche la sua storicità? Paul de Man non risponde esplicitamente no, ma dalle sue posizioni è difficile ricavare altro che un no. Ecco, comunque, la sua risposta: Per diventare dei buoni storici della letteratura, dobbiamo ricordarci che ciò che di solito chiamiamo storia letteraria ha poco o nulla a che fare con la letteratura e che ciò che chiamiamo interpretazione letteraria – a patto solo che sia una buona interpretazione – è in effetti storia letteraria. 24 Pare di poter concludere che mentre la teoria della ricezione s’ingegna di mettere ostacoli alla storia per troppo scarso amore del nuovo, quest’ultima posizione, esplicitamente antitetica, voglia arrivare allo stesso risultato per eccessivo amore del moderno. Ma per rendere giustizia alle posizioni di de Man occorre inserirle nel contesto cui appartengono, nel crollo dei grandi sistemi che ritenevano di poter interrogare esaurientemente l’ambiente della vicenda umana per dare risposte altrettanto esaurienti, pretendendo di evidenziare nessi certissimi e necessari tra le fasi storiche, fino a ritenersi in diritto di additare mete oggettivamente iscritte nel corso della storia, quindi prevedibili e proponibili insieme con le vie e i mezzi necessari. È stata la fine del concetto di progresso così come inteso nell’Ottocento, quale successione di tappe necessariamente conseguenti e ascendenti e, come si è detto con altra terminologia, la fine delle grandi narrazioni. Questo ripensamento ha percorso vie molteplici e ha investito tutti i campi: delle espressioni artistiche, della riflessione su di esse, dell’etica, della politica e via dicendo. Il luogo delle grandi narrazioni è stato preso da quelle che potremmo chiamare narrazioni locali, che si precludono le grandi sintesi e che si moltiplicano tendenzialmente all’infinito; di queste ci sono molte varianti, ma non è il luogo e l’ora di recensirle. Quel che sembra essere più in ombra, troppo in ombra, è che le piccole storie o (con altra terminologia) le soluzioni parziali sono intercomunicanti e dunque capaci di organizzarsi in sistema tale che (pur restando esso un sistema aperto) il capovolgersi di una soluzione parziale avrà effetti – non dominabili e quindi non riassimilabili in un sistema chiuso – sull’assestamento globale. La via di accesso alla gestione di un sistema del genere sembra essere quell’atto etico che, risvegliando possibilità rimaste non realizzate e concentrandole nel loro microcosmo momentaneo (così da avere un massimo di densità senza squadernamento di sistema rigido), consideri paradossalmente la verità come risultato univoco di un rapporto non univoco ma poliforme con la vita, il quale a sua volta ospiti libertà di intendere (non limitato all’intendere scientifico) e sintetizzi (almeno per tendenza) la gamma delle capacità umane. La validità di questo atteggiamento si misurerà sulla sua capacità di comunicare senso alla realtà determinata man mano che l’atteggiamento stesso si costituisce. Che è una proposta non mia ma formulata e articolata da Robert Musil negli ultimi anni del suo scrivere e riflettere (1938-1942) e rimasta sepolta fra le sue carte. Sulla presente narrazione tutto questo ha primariamente due conseguenze: il richiamo alla responsabilità del narratore e delle sue scelte; la permanente messa in discussione delle procedure adottate. Per il resto, che cosa si intenda qui per storia e problemi connessi è già stato detto. Per lasciarsi compiutamente alle spalle quanto non viene accettato dalle posizioni postmoderne, qui esemplificate attraverso de Man, va fatto un ulteriore passo, rispondendo alla domanda: come si costituisce una tradizione e a opera di chi? Nel corso dell’Ottocento vennero date varie risposte; per i romantici e poi per i germanisti la risposta era scontata: 25 la tradizione si costituisce attraverso il popolo, che vi esprime la propria essenza. Su questa base si ritenne che il modo più adeguato di proseguire una risposta nei tempi moderni con i mezzi moderni fosse proporsi di continuare la tradizione, e a tale fine la letteratura portò alla ribalta strumenti quali il romanzo storico e la Dorfgeschichte (più limitatamente il Kunstmärchen e, con problematica tutta a parte, il Volksstück). Furono risposte sbagliate e tentativi falliti (con un discorso a parte e di gran lunga meno perentorio per il Volksstück). Una tradizione non è citazione ma canone. Neanche il profluvio di citazioni nel postmoderno smentisce ciò: la citazione è infatti riconoscibile perché attinge a una tradizione, per quanto ironizzata, defunzionalizzata e via dicendo. Nel postmoderno si ha citazione di una struttura (già funzionante secondo il principio di causa-effetto oppure come portatrice di sviluppo), evidenziandone le articolazioni per mostrare che non sono più funzionali e arrestano lo sviluppo (non causano e non sviluppano ma mimano la causazione e lo sviluppo, abbondando nella recensione delle forme); è dunque indispensabile un rapporto col materiale da citare, cioè con la tradizione, ma non con la sua funzionalità. Però tutto questo non ha sostanzialmente spostato il canone; anzi si può dire che tutto il turbinio di metodi avutosi nella critica letteraria a partire dagli anni Sessanta non ha avuto sul canone se non effetti marginali. Neanche il presente libro opera spostamenti del genere; stabilisce bensì altri equilibri, cambia non poche analisi e ridefinisce i raggruppamenti; però non scompare da quest’orizzonte nessun autore significativo e non ne emerge prepotentemente nessuno che non avesse già il suo posto negli anni Sessanta. Il problema del canone è un doppio problema: un problema di valutazione e un problema di memoria culturale. Mentre per considerazioni più specifiche rimando ad altro momento di questo libro, qui preme sottolineare che entrambi i problemi detti tornano a mettere in primo piano la responsabilità del narratore. È la sua costante messa in discussione a costituire il riferimento più tenace delle presenti pagine. c. Il narratore Qui ad portas poche parole sul narratore in genere, mentre alla fine se ne diranno ad personam: il narratore che qui interviene è uno che fa pratica di concetti, sia come strumenti per interpretare, sia come risultati dell’interpretazione; quindi gli andrà concessa la qualifica di intellettuale. Oggi l’intellettuale non lo si concepisce che come specializzato; ma anche la specializzazione non interessa nessuno se in essa non si esprime un’idea. Questa tesi (che è di Max Weber) può forse essere aggiornata così: l’intellettuale è colui che semplifica la massa delle informazioni al fine di costruire un concetto capace di intervenire (conoscitivamente) sulla realtà. Nella “semplificazione” è già contenuta la carica di 26 invecchiamento e di errore. Nel trarre poi tutte le conseguenze dal suo operare, l’intellettuale fa lo stesso che prevedere; la sua riflessione è dunque prevedere l’azione di intervento e le sue conseguenze. Ma in tal modo egli sospende (almeno temporaneamente, e si spera non più che temporaneamente) la complessità, per solidarizzare con il risultato della sua semplificazione, cioè con l’identità conseguita. Ciò rischia di mettere in pericolo tutto quanto si è visto finora: l’invecchiamento sarebbe irrigidimento, fino a negazione delle aperture e della messa in discussione di sé. È un freno non sufficiente (anche se utile) limitarsi a prevedere solo le conseguenze sul sistema quale momentaneo ritaglio di cui si fa parte e non oltre, assicurandosi per altra via uno sguardo sugli altri sistemi sussistenti ed esterni. Infatti in ogni caso il risultato dell’intervento riproporrà la complessità, non la semplificazione, cui invece non si può far altro che tener fermo se si vogliono enunciare previsioni e riflessioni; la salvaguardia di annunciare che comunque si avrà come risultato una complessità aiuta poco poiché dal punto prospettico iniziale tale complessità è prevedibile solo come moltiplicazione di cose sempre uguali, cioè non si ha né previsione né riflessione. Non pare esserci altra soluzione se non di essere ciechi e dichiararlo. La giustificazione di questo complesso (riflettere nella cecità) – e forse, più ancora che la sua giustificazione, la sua sopportabilità – è ricercabile nel momento etico. E avendo a che fare con la letteratura tedesca, sviluppatasi almeno a partire da Schiller sotto il binomio etica ed estetica, le suggestioni in proposito non mancano. Quanto risulterà, metterà in luce l’apporto del concetto costruito ma anche ciò che è estraneo al concetto e quanto non è costruito (ma eventualmente perfino determinato); non restringerà la gamma degli interessi, ma li criticherà anche tutti uno per uno, gerarchizzandoli ma in una gerarchia periclitante; cercherà nei momenti più validi (cioè posti più in alto in una tale gerarchia) delle risposte come frammenti di un sapere sulla vita, ma sempre tenendo presente la componente giocosa della letteratura e quindi la revocabilità di quelle risposte. Come la precedente descrizione dell’intellettuale ha utilizzato, dopo Max Weber, spunti vari (e riappropriati fino al travisamento) di Niklas Luhmann, così neanche quest’ultima proposta è mia; ancora una volta, essa è di Robert Musil. 27 28 I Il tempo del Nebeneinander 29 30 I, 1. La teorizzazione arriva tardi, nel 1850, quando sono state scritte e pubblicate le opere importanti che essa avrebbe dovuto spiegare. Oltre che tardi, arriva sghemba perché si presenta come relativa al solo romanzo invece che come pertinente a tutte le forme letterarie, comprese quelle di nuova affermazione, se non di nuovo conio. Tarda, sghemba e - bisogna aggiungere - spaesata: vuol essere un programma per il futuro e non si rende conto che il meglio del genere è alle spalle. Infine: non è nemmeno una teoria vera e propria ma una serie di frasi di buona volontà. È la cosiddetta teoria del Nebeneinander (dell’accostamento) e a formularla fu Karl Gutzkow (1811-1878). Il romanzo del passato, argomenta questi, poteva narrare dei fatti in successione. Il romanzo moderno non può più: la vita è diventata troppo complicata e il romanzo esce dai propri confini libreschi, coinvolgendo quelle figure extraromanzesche che ne accrescono e determinano il significato. Dunque fatti e personaggi vanno accostati e non narrati in successione. Potremmo forse traslare così il discorso di Gutzkow: il filo del racconto non può più farci da guida, perciò tanto più importante è la trama del tessuto. Gutzkow fu un intellettuale onesto, coraggioso ed esemplare nel suo genere. Attivissimo in tutti i generi letterari, durante gli anni Trenta fu particolarmente benemerito come pubblicista, collaboratore, animatore, fondatore di riviste. Espresse e difese gli ideali della democrazia e del liberalismo, finendo anche in galera per un suo romanzo (vedremo presto). Non si vendette mai, sebbene fosse spessissimo a caccia di soldi: nel 1842 rifiutò una proposta del governo francese, finanziariamente allettante, per pubblicare sulla stampa tedesca articoli amichevoli. L’anno seguente rifiutò un’offerta prussiana: la Prussia avrebbe soppresso il divieto di vendere le sue pubblicazioni se egli si fosse impegnato per iscritto (come avevano già fatto Laube e Mundt) a non pubblicare niente contro stato e chiesa. Nel 1844 convinse Freiligrath a restituire al re di Prussia una consistente pensione annua. Col successo, Gutzkow non fece certo vita da povero, ma ebbe disponibilità finanziaria in maniera irregolare e usando il denaro soprattutto come compensazione psicologica. Inoltre ci volle un bel po’ prima che i soldi fluissero. A suo modo fu esemplare: fu il primo scrittore notevole a voler vivere esclusivamente della sua opera letteraria. Per tutti gli altri di cui avremo modo di parlare non fu così. Alcuni erano benestanti in proprio (Börne) o grazie alla dote della moglie (Laube); altri avevano delle professioni che erano la loro fonte vera di sostentamento (Immermann era giudice militare); altri infine vivevano grazie a sussidi e pensioni (Heine). Quando qualcuno voleva vivere di quel che scrive- 31 va, doveva ovviamente vendere in maniera proporzionata. Ciò vuol dire che o vendeva uno scritto (un romanzo, poniamo) in altissimo numero di copie, oppure moltissimi scritti in adeguato numero di copie. Il primo caso succedeva poche volte, il secondo era più frequente. Ed era già cominciato in epoca classico-romantica; si ricorda di questa lo scrittore August Lafontaine (1758-1831), autore di centocinquanta romanzi, del quale sopravvive memoria perché Chamisso assicura che lo spunto per il suo Peter Schlemihl gli venne da uno di quei romanzi (nessuno, né io né altri, ha avuto il coraggio di leggerli tutti e centocinquanta per identificare di quale esattamente si tratti). E si ricorda Christian Vulpius (1762-1827), cognato di Goethe: sessantun romanzi (di solito in più volumi) e trentaquattro testi teatrali, imitato a sua volta da altri prolifici autori. Ma nel corso del XIX secolo il fenomeno si estende a livelli impressionanti. Theodor Mundt (1808-1861) scrisse molto; di lui si contano ottantatre titoli: una bazzecola rispetto a quanto pubblicò sua moglie, la signora Klara, sotto lo pseudonimo di Louise Mühlbach (1814-1873): duecentonovanta volumi di romanzi di avventure, lasciando ampiamente alle spalle gli oltre centoquaranta volumi di avventure marine di Heinrich Smidt (1798-1867) o la produzione abbondante, ma impallidente al confronto, di un John Retcliffe, pseudonimo di Hermann Goedsche (1816-1878), o di un Gregor Samarow (pseudonimo di Oscar Meding, 1829-1903). Karl May (1842-1912) è un caso un po’ a parte: entro il 1950 pare fossero state vendute cinquanta milioni di copie di suoi romanzi, caso quasi unico di successo di cassetta che dura oltre la morte; di lui si riparlerà in occasione delle autobiografie. A Gutzkow tutto sommato andò anche bene; a Wienbarg e a Mundt molto meno. Non erano tempi facili; a più di uno la troppa prigione spezzò la fibra morale (fu il caso di Laube), altri ammutolirono o quasi (Wienbarg). Lo stesso Gutzkow risentì nel carattere del corso che aveva preso la sua vita; inclinò a depressioni, nel 1865 tentò il suicidio; restò vivo, ma sul piano psichico non si riprese mai completamente. Si era dato alla letteratura per il desiderio di avere un influsso (così si esprimeva) non sullo stato, da cui non si aspettava nulla, ma sul popolo. E nemmeno sul popolo direttamente ma sui suoi fiancheggiatori. Qui in realtà si toccava il paradosso: Gutzkow si rendeva conto di non scrivere in maniera popolare e di non poter attingere un vasto pubblico in via diretta; dunque sperava in moltiplicatori. D’altra parte con le sue riviste si atteggiava egli stesso a moltiplicatore. Però la più riuscita delle sue riviste politico-culturali, il “Telegraph”, non arrivò nemmeno a cinquecento abbonati; finanziariamente era una perdita e in generale gli editori lavoravano a lungo in perdita con lui. Gutzkow affermò comunque ripetutamente di non poter stare senza un organo di stampa; fin dentro gli anni Quaranta egli fu effettivamente una delle figure-guida nella pubblicistica e ne vennero azioni conseguenti e - com’è il caso di ripetere - coraggiose. Poi Gutzkow si diede più al teatro e lì il quadro cambiò. La teoria del Nebeneinander venne esposta dall’autore nella prefazione del 32 suo primo romanzo di grande successo, Die Ritter vom Geiste (I cavalieri dello spirito, 1850 sgg.), un’opera sterminata, in ben 9 volumi, secondo una moda dell’epoca; un romanzo fuori tempo, che opponeva Gutzkow ai realisti (come vedremo al momento opportuno), ma che riuscì a far parlare di sé. Gutzkow muoveva ben sessanta personaggi, appartenenti a tutte le classi sociali e alle possibili stratificazioni che si incontravano nella realtà, nell’intento di dare uno spaccato il più possibile completo della società tedesca. La teoria doveva giustificare l’accostarsi degli intrecci, i mezzi letterari usati per tenerli insieme. Gutzkow era talmente letterato da conoscere tutte le vie, quasi ci sarebbe da dire tutti i trucchi. E li usò con tale maestria da strappare l’ammirazione ancora di Arno Schmidt, il grande prosatore tedesco del secondo dopoguerra. (Il lettore però non si lasci incantare: quel romanzo è illeggibile.) Eppure la teoria veniva impoverita da questa enunciazione occasionale e strumentale. Die Ritter vom Geiste non erano affatto il primo romanzo del Nebeneinander: i romanzi di Immermann hanno tutto il diritto di essere considerati nella stessa prospettiva. Ma restiamo pure a Gutzkow, per il momento. Se solo si intende la definizione senza pedanteria (e bisognerà pur farlo), il romanzo che nel 1835 lo rese famoso e lo portò in prigione, Wally, die Zweiflerin (Wally, la dubitante), va anch’esso considerato come rientrante nella logica del Nebeneinander sia per i temi sia per le forme. Poiché però l’evento ebbe grande importanza, non soltanto per Gutzkow, occorrerà un po’ di contesto prima di parlare specificamente del romanzo. Nel 1831 Gutzkow, che conduceva un’incerta vita a Berlino, venne chiamato a Stoccarda dal pubblicista Wolfgang Menzel (1798-1873) per lavorare con lui a una rivista. Cominciò così la carriera giornalistica di Gutzkow. Menzel non era privo di meriti e dovremo reincontrarlo. Il suo ex-pupillo ebbe poi a raccontare di aver adottato il punto di vista del maestro, i cui pilastri erano: stato e nazionalità in politica, romanticismo e Jean Paul nella cultura. Questo gli trasmetteva l’ex Burschenschaftler Menzel, tanto seguace di Jahn da essere stato insegnante di educazione fisica. Menzel era una mala lingua e pretendeva da sé e dai suoi collaboratori una carica polemica cui Gutzkow non si sentiva portato. Questo irrequieto giovane scriveva anche per altri organi di stampa, sia per ambizione, sia per bisogno, sia per riversare sullo scritto le sue idee liberali. In tal modo venne in contatto con Heinrich Laube (1806-84), il quale gli mostrò altri orizzonti culturali, aprendolo a un apprezzamento di Heine quale prima Gutzkow non aveva. Questi inoltre studiò la letteratura contemporanea, sia tedesca sia francese (George Sand, da cui Wally verrà fortemente influenzata, Balzac, SaintSimon, Hugo, de Vigny), allargò il giro delle sue frequentazioni a Wienbarg e a Mundt che sostenevano ben altri principî estetici che non Menzel. Nel novembre 1834 si arrivò così alla rottura con quest’ultimo; Gutzkow cambiò rivista e, per tal via, anche editore. Progettò poi con Wienbarg una “Deutsche Revue”, che non arrivò a uscire per gli avvenimenti connessi con Wally. 33 Scritto in tre settimane, il romanzo venne messo in circolazione il 12 agosto 1835. Non più soltanto ribelle ma anche concorrente, Gutzkow venne attaccato da Menzel, che in due articoli, dell’11 e 14 settembre, gli mosse le accuse di oscenità, immoralità e blasfemia, allargando la condanna a tutta un’area culturale chiamata Junges Deutschland, che pretendeva rinnovare i costumi e la mentalità tedesca semplicemente prestando orecchio alle nuove indecenze francesi. Menzel si vendicò con successo. Innanzitutto le ottocento copie stampate del romanzo andarono a ruba, anzi se ne fece mercato nero; resoconti di spie assicurano che ne furono lettori anche gli artigiani. Presto seguirono proibizioni in vari stati tedeschi. Il 30 novembre Gutzkow viene arrestato, il 13 gennaio 1836 viene condannato a un mese di prigione. Viene liberato il successivo 10 febbraio. Precedentemente, il 10 dicembre 1835, il Bundestag concludeva un dibattito aperto da un’iniziativa del rappresentante austriaco su istruzione di Metternich, proibendo di diffondere gli scritti prodotti dagli autori dello Junges Deutschland; come tali venivano nominati: Börne, Gutzkow, Heine, Laube, Mundt e Wienbarg. Non era mai esistita né mai esisterà un’associazione, una “scuola” o addirittura (come voleva Metternich) una cospirazione di quel nome; essa esistette per volontà del Bundestag. La denominazione però esisteva già. A inventarla era stato Ludolf Wienbarg (1802-1872); essa compariva nel titolo dei suoi influenti Ästhetische Feldzüge. Dem jungen Deutschland (Campagne estetiche. Alla giovane Germania, 1834). Ispirato dall’ideologia delle Burschenschaften, corretta da uno studio di Schleiermacher e Goethe e dall’influsso di Heine - cosa che lo aveva tenuto al riparo da una possibile, diffusa esaltazione per Arndt, Jahn e Fichte – Wienbarg aveva ripreso l’ispirazione democratica di Menzel (correggendola nel punto essenziale dell’atteggiamento nei confronti di Goethe, come vedremo) e si era pronunciato per un’arte che fosse pienezza di vita etica. Menzel reagì solo dopo aver attaccato Gutzkow; Wienbarg aveva ricostruito la storia della cultura tedesca facendola culminare in Lutero e in Goethe, sostenendo che varie forme del cristianesimo erano morte e che nella lotta che andava contro esse sostenuta seguendo quei due maestri si sarebbe sviluppata una nuova estetica, una trasformazione delle cose e quindi una nuova arte e una nuova vita. Menzel replicò che questo era ateismo e che Wienbarg voleva servirsi dell’intelletto come mezzo per instaurare il trionfo della sensualità come fine; aggiungeva che Wally permetteva di capire davvero gli Ästhetische Feldzüge. Non fu Wienbarg ma Ferdinand Gustav Kühne (1806-88) ad elencare quello che considerava il quintetto di Junges Deutschland: Wienbarg, Mundt, Gutzkow, Laube e lui stesso. Il Bundestag decise diversamente. Non era una scuola, dunque; i raggruppamenti che se ne facevano erano fluttuanti. Così sono rimaste le cose; non al gruppo, che non c’è mai stato, ma all’area si sogliono assegnare coloro che si pronunciarono a favore di qualche 34 suo rappresentante più considerato. Finché tutto si stempera nella generale aurea del Vormärz. Gruppo, area o altro che fossero, quei tali erano non poco litigiosi: Kühne recensì Wally dicendo che faceva venire la nausea, Mundt dicendo che Gutzkow soffriva di diarrea da raddrizzamondo. In seguito Gutzkow si mise a litigare con Heine e infine a Gutzkow dette ampiamente dell’imbecille Immermann, un autore che per la verità nessuno ha messo in rapporto con lo Junges Deutschland, cui però Heine, Gutzkow stesso e altri guardavano con rispetto. Gutzkow non era un imbecille; ma dovette riconoscere egli stesso che come scrittore gli mancava forza plastica e la capacità di disporre un intreccio portandolo a un culmine. Non era un Dichter, non lo è mai stato. Né queste erano le doti che riconosceva a se stesso, ma un anelito politico, culturale, morale. Quest’autore è testimone, praticamente irrinunciabile, di un’epoca in cui le complicazioni non mancavano. Metternich - il colto Metternich, l’ammiratore di Heine, colui che si faceva comporre ed eseguire al pianoforte il Buch der Lieder, ogni sera per anni - aveva intessuto una rete spionistica semplicemente formidabile: non c’era autore democratico che non venisse spiato; e i doppiogiochisti abbondavano. Gutzkow era fra gli spiati; questo non impedì certo a Metternich di riceverlo e perfino di farlo trattare con cortesia in occasione di un viaggio nel Lombardo-Veneto; ma è vero che si era già nel 1843 e Gutzkow veniva considerato già più moderato rispetto a quando scriveva Wally. Le spie di Metternich erano talmente efficaci che lo storico odierno può attingere alle loro relazioni, sicuro di avere ottimo materiale informativo; sono sicuramente tra le fonti migliori. Di quell’epoca, e soprattutto degli anni Trenta, Gutzkow ha sempre dato un ritratto movimentato; e con lui concorda la memorialistica degli altri autori, che seguiteremo a chiamare di area. Da una parte non c’era nessuna guida che si imponesse ma solo qualche residuo. Il residuo più importante era l’ideologia delle Burschenschaften, che però appariva già fossilizzato: si era fermato al sanscrito (così scrive Gutzkow, forse alludendo agli studi dell’ultimo Friedrich Schlegel). Chi allora ancora operava o aveva cominciato a operare non veniva sentito come sufficientemente autorevole dalla generazione dei ventenni: non certo Fouqué, che pure a detta sia di Immermann (per personale esperienza) sia di Heine aveva finalmente reso popolare il romanticismo, fin allora rimasto un fatto di élite; non Wilhelm Hauff, non i poeti svevi, nemmeno i grandi autori ancora in vita (e non erano pochi). Meglio andava a Immermann e a Grabbe; le opere di quest’ultimo cominciarono ad apparire a stampa a partire dal 1827, però nessuno le rappresentava. Comunque nessuno dei due riuscì a imporsi come guida. Con Heine e Börne (1786-1837) le cose erano complicate. Attiravano l’attenzione, avevano successo, davano da pensare. Ma erano ebrei. Sollevavano i grandi problemi dell’epoca, li sollevavano per i tedeschi da tedeschi, e tuttavia nessuno riusciva a dimenticare che si trattava di ebrei. La serietà di Heine nes35 suno voleva percepirla e se ne dava la colpa ai suoi troppi scherzi. Insomma non li si poteva ignorare, però l’antisemitismo aveva provveduto a una barriera che resisteva. Il popolo dei pensatori e dei poeti riteneva di poter ancora e sempre dibattere intorno a Goethe-Schiller, Hegel-Schleiermacher e che lì, non fra gli ebrei Heine e Börne, si decidessero le cose vere. Con la rivoluzione parigina del luglio 1830 le cose cambiarono. Si prestò di nuovo attenzione alla politica francese e alla cultura francese. Ciò era facilitato, sul piano psicologico, dal successo che la cultura tedesca aveva avuto in Francia (attraverso il romanticismo e non solo). Si lessero e tradussero gli autori già nominati in precedenza e altri che incontreremo (Gutzkow fu tra i promotori di una traduzione delle opere di Hugo cui parteciparono anche Büchner e Freiligrath); Börne e Heine li si cominciò, se non ad amare, almeno a capire. Da quel momento, ha ribadito più volte Gutzkow, fu tutto un fervore. E nel vuoto fino a quel momento esistente (o almeno sentito come tale, il che è lo stesso) venne a costituirsi l’area degli autori poi detti dello Junges Deutschland. Non fu comunque un idillio. La litigiosità, scoppiata prestissimo e che diventò estrema quando la repressione forzò a pentimenti e abbandoni, non era dovuta solo a personalismi ma anche alla constatazione di quanto vaghi e disparati fossero i vari fini. Un fine comune non c’era. Gutzkow vi rifletté in prigione, constatando che tutti andavano in ordine sparso e che erano troppo diversi fra di loro. A dare un chiaro segno che tutto quel fervore poteva essere vissuto come tragedia intervenne un fatto clamoroso. Il 29 dicembre 1834 si suicidava Charlotte Stieglitz (1806-1834), moglie del poeta Heinrich Stieglitz (1801-1849). Costui soffriva di depressioni, scoramenti e abbandoni. A dirla in parole semplici, non combinava niente. La moglie decise allora di suicidarsi nella speranza che un profondo dolore desse al marito la sveglia e lo rendesse capace di quelle creazioni che fin allora non gli erano riuscite. Il vedovo seguitò a non combinare niente ma l’atto della moglie destò immensa sensazione. Mundt, che di Charlotte era stato amico, le dedicò nel 1835 un volume di cui parleremo in altro luogo. Nello stesso anno Gutzkow la prendeva a modello della sua Wally per mostrare (scrisse) come l’interesse per le idee possa essere vissuto fino a diventare una tragedia personale. Il romanzo presenta al suo inizio la situazione di vuoto già descritta: nessuna guida (vengono presi in giro Tieck, ancora vivo; Hoffmann, morto nel 1822 ma ancora letto; i poeti svevi, definiti noiosi senza tanti complimenti), deludente stato di una vita impossibilitata a operare. I giovani sono «cimiteri di pensieri morti», scettici, leggeri, freddi, destinati a essere infelici e a dare infelicità. Tentano di cambiare il panorama gli scrittori che ora chiamiamo dello Junges Deutschland, i quali vengono pur essi citati, peraltro con giudizi differenziati: senza troppo calore Wienbarg, Laube e Mundt, diversamente Heine e Börne. Anche a Menzel vengono fatti riconoscimenti; questi però non abboccò, e a suo modo 36 aveva ragione: Gutzkow voleva infatti assimilarlo all’estetica di Wienbarg. Solo nella nostra epoca, scrive infatti, la letteratura ha cominciato a raccogliere le proprie forze in autonomia; essa non sarà più né classica, né romantica, né «fantastica» (il riferimento è a Hoffmann) ma per la prima volta sarà autonoma: da lei tutti i settori della vita prenderanno ispirazione, non viceversa. La vita stessa, con esplicito riferimento a morale e tradizioni, deve subordinarsi alla poesia; niente c’è infatti di più alto. Questo è il quadro generalissimo. I contenuti più specifici sono: democrazia, ma non spinta fino a fare «scoperte fra le capanne» (è evidente il riferimento allo Hessischer Landbote - Il messaggero dell’Assia - di Georg Büchner, un autore nei confronti del quale Gutzkow ha ogni benemerenza); egotismo, cioè morale intesa come dispiegamento di sé. Come si vede, non c’è un discorso sulle forme dello stato. Gutzkow scrisse che né lui né altri vi pensavano. Pensavano invece alla generale formazione dell’uomo. Il conflitto nasce dalla natura e dal posto che deve avere la religione. Forme di pensiero sociale e socialista (Lamennais e Saint-Simon) vengono prese in considerazione entro questa prospettiva e ad essa ricondotte. L’impossibilità di conciliare ragione e religione in generale, ragione e cristianesimo in particolare e di far resistere quest’ultimo ai risultati delle ricerche sulla storia e sul mito vengono ampiamente discusse nell’opera, prendendo in considerazione gli sviluppi della moderna filosofia tedesca (Kant, Hegel, Schelling), ma seguendo soprattutto il lì non nominato David Strauß. Infine si dichiara che l’epoca moderna concilierebbe più che volentieri la libertà dei popoli con la fede, ma il cristianesimo si oppone dovunque all’emancipazione dei popoli. Un’appendice reca le cose più fini. Essa s’intitola “Verità e realtà” e difende il principio della possibilità contro quello della realtà. Non può accadere solo quel che accade; il mondo della possibilità, dei sogni, serve agli uomini liberi per costruirvi il loro proprio mondo. L’invisibile mondo delle possibilità viene aperto dalla religione a titolo di consolazione, dalla poesia per spiegare la realtà. Sulla religione, la poesia ha il vantaggio della probabilità. Nella poesia lottano verità e realtà. Gli stolti si decidono per la realtà, i liberi per la verità invisibile, le persone colte per la probabilità. Chi è libero sa che quel che non accade è sempre vero, persino se non può accadere. E questa è proprio l’epoca in cui comincia a svilupparsi una poesia della verità ideale e dell’irrealtà effettuale. Prima dell’appendice la protagonista si è però suicidata. Nel corso del romanzo aveva avuto modo di esprimersi contro l’istituzione del matrimonio e a favore dell’emancipazione della donna e dell’amore. Inoltre aveva percorso intrecci gratuiti e incredibili, che risparmio al lettore (anche per evitarne l’ilarità). Ma anche i difetti fanno di Wally un romanzo del Nebeneinander. La gratuità delle vicende, l’uso di varie forme letterarie (romanzo inframmezzato da novelle e da pure scene di conversazione, diario e infine trattato, con in appendice addirittura un manifesto) indicano una mancanza di interdipendenza: c’è solo 37 giustapposizione. Il conflitto del romanzo lo dice e le sue forme lo esprimono: non semplicemente non c’è subordinazione, ma manca addirittura un centro. Quel che va detto con chiarezza (se non è già più che chiaro) è che Wally (né Gutzkow altrove) non gestisce tutto ciò ma lo subisce. Più che dare una teoria del Nebeneinander, Gutzkow ne è stato un testimone e una vittima. Attivissimo e anzi inesauribile, Gutzkow seguitò a scrivere di tutto, su tutto e in tutti i modi: recensioni, saggi, racconti, romanzi, commedie e tragedie. Toccò temi importanti: la censura, la tolleranza religiosa, la democrazia e via dicendo. Sempre con nobili intenzioni e pessimi risultati (si suole considerare con più benevolenza una o due commedie). Oggi si legge con interesse la sua memorialistica. Un suo saggio su Goethe fu importante e dovremo riparlarne. Così come dovremo riparlare di Gutzkow in altri contesti, poiché visse a lungo e sempre attivo. I romanzi di Immermann sono stati non più che ricordati, per non interrompere il discorso su Gutzkow. Essi meritano di essere trattati un po’ più per esteso, sia per l’abilità tecnica dell’autore, sia per l’interesse dei temi. Karl Lebrecht Immermann (1796-1840) fu uno straordinario letterato, di grande cultura e di notevoli meriti organizzativi quale fondatore e direttore del teatro di Düsseldorf; fu estimatore e protettore di Grabbe, di cui però non mise in scena nulla. Conosceva il mestiere del romanziere in modo perfetto e nei due romanzi che scrisse profuse tutte le sue conoscenze in materia. Il primo dei due (1836) azzecca soprattutto il titolo, Die Epigonen (Gli epigoni), ma la spiegazione che ne dà è deboluccia. Immermann celebra l’ultimo quarto del XVIII secolo, quello in cui ritiene sia nata la letteratura moderna, e lo difende dai sui detrattori, i romantici; i classici però (prosegue Immermann) hanno lasciato agli epigoni tanti di quei tesori intellettuali da far nascere tanti chiacchieroni approssimativi, tanti giornalisti; perciò occorre tornare alla passata semplicità: mettere vera intenzione in ogni cosa, dire solo quello che realmente si pensa, essere vero in ogni fibra. Occorre dire che i suoi convincimenti Immermann li ha espressi assai meglio nelle sue memorie. Tuttavia nel romanzo ci sono cose divertenti e interessanti; per esempio il modo in cui tra i personaggi vengono distribuite le letture: una ragazza picchiatella legge Hoffmann (che per misura terapeutica viene dato alle fiamme: l’eroe di Immermann ha ricordi troppo vivi della festa alla Wartburg); la moglie d’un ricco industriale, finta virtuosa, legge Novalis (il cui Heinrich von Ofterdingen piace però anche al nostro eroe); una languida duchessa, persa in sogni del passato, legge Goethe e Schiller e traduce Scott. C’è poi qua e là qualche divertente satira (tra gli altri ne fanno le spese le Burschenschaften e il povero August Wilhelm Schlegel, che ormai tutti prendevano in giro), ma soprattutto c’è il modo in cui l’autore Immermann entra nel romanzo come personaggio, distruggendone la finzione, così come gli altri personaggi si esprimono sul romanzo stesso in cui compaiono. Per il resto occorre accontentarsi delle 38 buone intenzioni, con le quali viene condotta la critica all’età contemporanea. Notevole è che vi si parli di industria. Il romanzo si appoggia esteriormente ai Wilhelm Meisters Lehrjahre (Gli anni di apprendistato di Wilhelm Meister) e ciò rende ancora esitante la percezione e messa in scena del Nebeneinander, eppure stiamo andando chiaramente in quella direzione. Attraverso una fabula che non riesce mai a decollare (e che a tratti è proprio penosa; per esempio quando Immermann ricorre a effettacci quali cadaveri di uomini amati conservati a portata di mano come scheletri o corpi in bagni chimici), riuscendo al massimo a produrre qua e là qualche pagina d’un certo interesse, il protagonista viene in contatto con le più diverse cerchie e con tutte le classi sociali. Il romanzo vuole infatti dare uno spaccato della società dal 1823 al 1829 (con una “coda” del 1835); e sul piano documentario ha il suo interesse. La nobiltà della Restaurazione sogna di ripristinare pari pari il feudalesimo; viene messa in ridicolo, tuttavia non le vengono negate tutte le simpatie. I nuovi possidenti vorrebbero tanto imitarne i costumi. La nascente borghesia industriale e liberale le fa invece una guerra totale, politica ed economica. I politici sono per l’assolutismo, tuttavia stanno lavorando al nuovo, sia pure in modo confuso; personalmente se ne dice tutto il male possibile. Ci sono però persone ancora più confuse: sono i «demagoghi»; non sono loro i veri nemici del vecchio, sono gli industriali. Né lo sono i romanticizzanti «filelleni», pronti a trasformarsi in filistei alla prima occasione. L’antisemitismo è dovunque, dal basso popolo in su. Gli ipocriti superconvertiti e superconvertitori abbondano; è però un segno dei tempi che l’irrequietezza venga espressa in tutti i modi, anche cambiando religione. Poi ci sono i dibattiti pedagogici e i dibattiti sull’arte. Le pagine più interessanti sono quelle dedicate al funzionamento di un grosso gruppo industriale, al paesaggio industriale, agli operai: ai loro ambienti senza gusto, ai loro modi rozzi, alla litigiosità che li fa spesso ricorrere al coltello, alle loro reazioni religiose, che spingono i cattolici alla bigotteria e i protestanti al pietismo. Ma nel mio riassunto ho reso il romanzo ben più coerente di quanto non sia. A parte il conflitto fra nobiltà e borghesia industriale, non c’è nessun legame che tenga insieme le zone di volta in volta illuminate: esse sono proprio nebeneinander. Immermann sembra perfino darne una giustificazione indiretta quando descrive quel che secondo lui è un generale stadio di stallo: Nelle nostre storie fa la sua parte la lotta fra i vecchi e i nuovi tempi; essa non è ancora composta. La nobiltà aveva terribilmente scosso le sue stesse radici, i suoi vizi portavano lo sconvolgimento e la desolazione nelle case borghesi. Il terzo stato, armato con l’arma che è sua, il denaro, si vendica con una guerra di sterminio freddamente condotta. Ma nemmeno esso raggiunge la sua meta. Nascono così cose che nessuno prevede e nessuno domina. Forse non è proprio una dichiarazione di poetica, ma le somiglia. Dichiarazioni dichiaratamente di poetica ci sono, e sono interessanti, anche se il romanzo non riesce a 39 concretizzarle; ecco le due più importanti, confermate e meglio argomentate da Immermann nelle sue memorie: C’è qualcosa di più importante della forma, cioè il contenuto. Le fonti del vero e del buono sono oltre le parole e i precetti. Mai gli individui hanno avuto un’importanza pari a quella che hanno ai nostri giorni. A casa sua, tra moglie e figli, al petto dell’amata, al tavolo dei suoi affari, nella stanza da studente, ciascuno è diventato una natura storica, le cui vicende devono interessarci e affascinarci se siamo capaci di calarci in esse. E dunque da lì deve prendere le mosse la letteratura moderna. L’individualità che Immermann così tratteggia è manifestamente quella borghese, di cui dà effettivamente un ritratto convincente nella parabola ascendente e poi discendente d’un grande complesso industriale. Di contro suona incredibilmente ingenuo il finale del romanzo, in cui il protagonista programma di mandare in malora le fabbriche e far tornare gli operai a fare i contadini; sembra quasi voler confermare le preoccupazioni del grande industriale sull’incapacità degli eredi ad amministrare quel che ricevono. Un più vasto repertorio delle sue abilità sfoggiò Immermann nel suo secondo romanzo: Münchhausen. Eine Geschichte in Arabesken (Münchhausen. Una storia in arabeschi, 1838-39), sul quale dovremo tornare più in là; per ora basterà una breve presentazione. I mezzi che l’autore usa in quest’opera si inseriscono in una tradizione già lunga, che risale a Sterne e in Germania era stata tenuta viva da Jean Paul; conta però anche che mezzi simili fossero stati usati sulla scena anche da Tieck, come Immermann da drammaturgo ben sapeva; significativo che la quarta e ultima parte del romanzo si apra proprio con una lettera a Tieck. Ma il romanzo in realtà si compone di due romanzi, assai poco legati l’uno all’altro, cioè messi letteralmente nebeneinander; uno è il romanzo dell’eroe eponimo, l’altro è un idillio campestre; questo ebbe tanto successo da essere edito più volte a parte col titolo Der Oberhof 1. Il Münchhausen vero e proprio consiLa traduzione del titolo crea qualche problema. La vicenda ha il suo epicentro in una fattoria, quindi il titolo potrebbe plausibilmente tradursi con la La fattoria o, con traduzione letterale, La fattoria superiore; tale traduzione sarebbe anzi a suo modo inattaccabile. Ma il proprietario della fattoria non viene chiamato Bauer (agricoltore), bensì Schulze (una carica amministrativo-giuridica ecc. alla quale non esiste una precisa corrispondenza nella nostra lingua) e quel che avviene è legato a una particolare amministrazione della giustizia; quindi una traduzione altrettanto legittima potrebbe essere Il tribunale. Una parola che si riferisca a entrambe le realtà non esiste in italiano; al massimo potrebbe venire in soccorso il toscano, ma solo con approssimazione, attraverso la traduzione La corte nel doppio significato di corte di giustizia e di agglomerato rurale intorno a un cortile centrale, il quale peraltro non è la fattoria di un solo proprietario terriero (contrariamente all’accezione tedesca) ma il luogo nel quale si concentrano le abitazioni 1 40 ste in una serie di parodie di scrittori contemporanei: dal carteggio GoetheSchiller (1830), a Gutzkow (Wally e altro), a Mundt, a David Friedrich Strauß, a George Sand, a Bettina von Arnim, Platen, Rückert, Freiligrath, Görres, Kerner; ma soprattutto viene parodiato Hermann von Pückler-Muskau (allora molto popolare), tanto che Münchhausen finisce con l’esserne per più aspetti quasi una controfigura. Le parodie non arrivano a rendersi autonome rispetto ai testi di riferimento, non sviluppano un mondo, un linguaggio, una prospettiva per cui si vada oltre un generico intendere, da parte del lettore, che Immermann sta criticando vari eccessi della sua epoca. Il romanzo si lascerebbe anche leggere piacevolmente se quegli scrittori fossero ancora vivi per noi; ma stando le cose diversamente, non c’è da meravigliarsi se già a partire dal 1860 gli venne preferita la metà col titolo Der Oberhof, che veniva considerata iniziatrice di un genere per molto tempo in voga, quello della Dorfgeschichte. Nelle intenzioni di Immermann, però, essa doveva rimettere a posto quel mondo capovolto che era l’altra metà; Münchhausen faceva castelli in aria e in generale nella sua vicenda i tentativi di cambiamento erano tutti sbagliati, anzi lui stesso è un puro personaggio nichilista: l’altra metà recuperava il realismo e in sostanza la tradizione, entro la quale però venivano portati a buon fine quei ragionevoli cambiamenti che la arricchivano e rendevano progressista senza svilirla e senza svuotarla. Come si vede, c’era abbondanza di buone intenzioni; il Nebeneinander poteva però consentire al lettore di preferire il nichilismo, tanto più che Immermann ci si era manifestamente divertito molto di più. I, 2. Abbiamo visto e vedremo ancora con quale insistenza ci si lamentava che a partire dalla fine delle guerre di liberazione non esistessero più maestri che venissero sentiti come tali. È un sentimento importante, di cui è d’obbligo tener conto. Ma nelle dichiarazioni, anche se ripetute, oltre alla parte di detto c’è una parte di non detto. E per capire entrambe le parti occorre allargare lo sguardo. Negli anni Venti erano ancora vivi personaggi importanti, che venivano psicologicamente legati a fasi passate, da essi però ancora coltivate e proseguite. È vero che Hoffmann moriva già nel 1822 e Jean Paul nel 1825; ma Tieck (17731853) era vivo, vegeto e bene in vista, anzi cominciava una nuova fase della sua produzione; Eichendorff aveva avuto un grande inizio ma doveva ancora dare il di varie famiglie contadine, solitamente legate da vincoli interfamiliari; e inoltre proprio non so quanto questa seconda accezione circoli fuori della Toscana. 41 meglio di sé; Brentano era ancora attivo nella sua parte migliore; sua sorella Bettina aspettava ancora di restare vedova per debuttare. I Wanderjahre non erano ancora usciti nella loro versione definitiva, buona parte della lirica dell’ultimo Goethe attendeva ancora di essere scritta; per non parlare di Faust II, che nella versione integrale apparirà solo postumo. È anche vero che molti romantici non sono più tali: Tieck è un caso del genere e presto, seppure in tutt’altro modo, ciò sarà vero anche per Brentano. Ciò che i romantici hanno iniziato e stanno continuando avviene in campi ultraspecializzati: per esempio nelle più svariate filologie, sotto la grande guida di Jakob Grimm; ma le nuove generazioni le sentono asfittiche. Creuzer sta studiando i miti, ma le reazioni sono analoghe. Görres è troppo di parte perché possa fare il maestro. C’è posto per la riflessione retrospettiva, cui si dedicano i fratelli Schlegel; ma ciò è per definizione non propulsivo, e anzi permette quella confutazione ultra accorciata che è lo sberleffo. È un momento con tanti pieni e con tanti vuoti. Ma a far dire che predominano i vuoti è l’assenza di prospettive culturali e politiche. Quest’ultimo aspetto si capisce da sé: la Germania divisa in trentanove stati non offre un centro di significativa aggregazione e riferimento; per non dire delle condizioni psicologiche in cui la Restaurazione costringe a vivere. E le prospettive culturali non possono accontentarsi della ripetizione del già stato, il profilarsi di grandi risultati filologici non è poi così allettante. Più volte le nuove generazioni si chiedono chi sono; «Epigoni», risponde Immermann, che nel suo romanzo non salva nessuno. Ma si tentano risposte più precise. E allora assume grande importanza il dibattito su Goethe. Il fatto è che di Görres, di Tieck, degli Schlegel e via dicendo pare ci si possa sbarazzare alzando le spalle. Brentano, Eichendorff e altri neanche vengono presi in considerazione, oppure sì, addirittura con benevolenza, ma lasciando intendere che, per quanto bravi, è bene se ne stiano zitti e riveriti. Con Goethe ciò non appare possibile; e allora si prende posizione, ripetutamente e appassionatamente. A giudicare dalle diverse veemenze messe nella difesa e negli attacchi, pare che, tranne la cerchia intorno a Varnhagen von Ense (e sua moglie Rahel, finché visse) non siano poi moltissimi a tenere a Goethe. Ma lo scontro su di lui, per quanto becero in certi momenti, fu occasione di chiarimenti di fondo. Il dibattito su Goethe cominciò in vita di Goethe. Esso ebbe una prima fase acuta intorno al 1821, in occasione della prima edizione dei Wanderjahre, quando ci fu abbondanza di persone disposte ad accusare Goethe di immoralità e a preporgli Schiller. Corifeo fu il parroco Johann Friedrich Wilhelm Pustkuchen (1793-1834), che pubblicò una propria, apocrifa continuazione dei Lehrjahre. Fra coloro che intervennero ci fu Immermann che nell’occasione (commentò in seguito Heine) si guadagnò gli speroni; la sua stroncatura di Pustkuchen fu in effetti una cosa notevole. Anni dopo il dibattito si rinfocolò. A dargli il via fu la Deutsche Literatur (Let42 teratura tedesca, 1828) di Wolfgang Menzel (1798-1873), il quale, ampliando una dichiarazione dell’ultimo Friedrich Schlegel, sconfessato ormai da Goethe, rimproverò a quest’ultimo la mancanza di un centro, preferendogli l’idealismo di Schiller e pretendendo quasi di scrivere una storia della letteratura facendo a meno di Goethe. A quell’epoca sembravano pensarla così in molti: Börne, che accusava Goethe di essere un lacché, Grabbe, Freiligrath. Christian Dietrich Grabbe (1801-1836), che già aveva avuto qualche cenno antigoethiano, tornò sull’argomento nel 1830, con una biliosa recensione del carteggio Goethe-Schiller appena edito. La recensione non ha valore critico ma testimoniale: testimonia la mancanza di una guida, di un punto di riferimento, di una prospettiva (cose che Grabbe dice in modo esplicito); è un ulteriore esempio di chi, nel confronto Goethe-Schiller, si schiera per la «verità», la «naturalezza» e l’«obiettività» del secondo (nel tratteggiare il quale Grabbe disegna in realtà un autoritratto); dimostra la nessuna comprensione per l’ultimo Goethe (la cui produzione accettabile viene fatta terminare con le Wahlverwandtschaften – Le affinità elettive - del 1809) e la scarsa per il Goethe precedente; infine - e questa è la cosa più interessante - sembra aspettarsi un rinnovamento generale dalla rivoluzione del luglio 1830. Wienbarg introdusse poi la correzione cui si è accennato; essa poggiava sulla distinzione fra l’uomo e ministro Goethe da una parte e il creatore dall’altra. Ai rimproveri mossi al primo, Wienbarg faceva credito. A Goethe si rimproverava infatti di essersi astratto dalla realtà del tempo; specificamente, di non aver protestato contro i Karlsbader Beschlüsse, di non aver speso una parola per la reintroduzione in Prussia di una libertà di stampa quale c’era stata all’epoca di Federico II. Ma abbiamo anche visto come riteneva di dover considerare il poeta Goethe. In una «sfera separata dal mondo», in un «magico mondo ideale» vivevano, secondo Wienbarg, i due che fino a tempi recenti potevano essere visti come modelli: Goethe e Jean Paul. Non è più così con i nuovi scrittori: essi hanno abbandonato quelle altezze e «costituiscono una parte del pubblico». La nuova arte è afferrata dallo spirito del tempo, non è semplicemente al servizio delle Muse ma della patria, il suo destino è far sì che la realtà non si riduca a ciò che si oppone all’ideale. La nuova prosa non ha il maestoso periodare di Goethe poiché rivela sempre la propria origine dalla vita; in compenso è più ardita. Il prosatore che Wienbarg opponeva a Goethe era Heine, da lui lodato anche perché aveva abbandonato (almeno per allora) la lirica a vantaggio della prosa. Nel 1836 Gutzkow intervenne sull’argomento con il suo saggio meglio riuscito: Über Goethe im Wendepunkt zweier Jahrhunderte (Su Goethe alla svolta fra due secoli). Gutzkow vi ribadisce che dal 1815 in poi è mancata una guida spirituale autorevole. Poco tenero in generale con i romantici, sostiene che chi di loro ancora viveva e operava (nomina Tieck, Hoffmann, Jean Paul) non offriva spunti di rinnovamento. Notevole la sua insistenza sull’inefficacia di Jean Paul, che invece sia Börne sia Menzel volevano elevare a modello. Occorreva dunque rico43 minciare lì dove si era smesso, cioè dalla critica, il cui oggetto eminente doveva essere Goethe, pietra di confine su cui il vecchio era finito e il nuovo doveva cominciare. Il vecchio era il Settecento, epoca in cui era stretta l’alleanza tra la nobiltà e la letteratura, che viveva di mecenatismo. Era anche l’epoca in cui era l’individuo a farsi eco dell’organo della cultura; del resto c’era disprezzo per le masse. Tuttavia la stessa epoca, col suo classicismo, ha avuto anche il merito di consolidare e rafforzare la lingua tedesca, che grazie a tale esperienza è ora in grado di resistere all’imperversare dei tanti dilettanti e amanti della natura. Ma dall’aristocrazia non ci si poteva aspettare il rinnovamento che i nuovi tempi esigevano. Furono dunque i ceti inferiori a farsene carico, anche in letteratura. Si passò attraverso la Rivoluzione e si arrivò all’epoca moderna, che è approdata all’estremo opposto, all’esaltazione della letteratura di tendenza, a patto che essa sacrifichi conseguentemente l’individualità. Goethe è alla cerniera di tutto ciò. Con abilità, Gutzkow utilizza anche quelle che erano universalmente considerate debolezze di Goethe per trarne frutto. Alla base del suo ragionamento c’è la distinzione fra talento e genio. Il genio può abbracciare tutto in una volta, eppure la sua irrequietezza lo spinge da una cosa all’altra; è dunque capace di una pluralità di cose, ma non di tutte. Il genio è fatto di contenuti, esso è invenzione/rinvenimento e deve trovare un mezzo di difesa per non disperdersi: Goethe lo trovò nel suo limitarsi e perfino nella sua limitatezza «filistea». Il talento è invece capace di tutto ciò che può essere imitato; è obbligato a mostrarsi nelle sue realizzazioni e ha dalla sua la possibilità di durare. I rimproveri fatti a Goethe sono stati rivolti al suo talento; non hanno tenuto conto del suo genio. (Gutzkow allude evidentemente a Menzel, che a Goethe negava ogni genio, riconoscendogli solo del talento.) Goethe stemperò la lingua della classicità: la riproduzione si trasformò in astrazione, sacrificando la corposità (qui Gutzkow rimprovera a Goethe i troppi superlativi e le troppe costruzioni con participio). Goethe non è il poeta del sublime ma del bello. Il sublime è semplice, è senso della massa e del suo centro; esso ci schiaccia. Il bello invece è composto di tante parti, è vita, è comunicazione, esortazione, innalzamento del lettore, che viene reso partecipe della creazione artistica. Goethe non era un dialettico ma un empirico; le sue conclusioni sono sempre raggiunte integrandovi le sue energie personali. Il suo empirismo era egoista, con l’egoismo della salute: si occupava di tutto, ma accettava solo quel che era preformato in lui. Il suo cammino è stato percorso lontano dal pubblico, col quale non aveva rapporto: non fece scuola, non fu né volle essere popolare, fu sempre nuovo e scomodo. Gli obiettivi del nuovo secolo, il quale nelle sue istituzioni e nelle sue espressioni storiche è più poetico del precedente, possono essere raggiunti con l’aiuto di Goethe, cui pure sono appartenuti. Essi sono: liberare il pensiero dal dogmatismo e dal sistema (Gutzkow dichiara esplicitamente di non essere interessato all’alternativa Schelling-Hegel); rivalutare l’errore come possibilità di un pensie44 ro che miri all’individualità della verità e alla bellezza della forma; unificare ciò nella formula: «bella è solo la verità individualizzata». La letteratura di tendenza ha i suoi diritti, però al suo pensiero, volendo esso essere il pensiero della generalità, mancherà sempre o la verità o la bellezza. Infine: la letteratura medî dei convincimenti modesti, cioè non proponga obblighi. La nazione vuol rispecchiarsi nella letteratura, questa pertanto ne esprime la situazione politica, religiosa, morale. La letteratura universale è garanzia di quella nazionale. Il sodalizio Goethe-Schiller viene così spiegato da Gutzkow: il primo rappresentò l’individuo e la natura, il secondo l’universale umano e la storia. Schiller era mosso dall’interessante (cioè cercava particolari che illustrassero l’universale) e da un istinto non già pieno di contenuti; Goethe legava l’interesse alla cosa e lo manifestava micrologicamente, procedendo da piccoli punti accidentali. Il lettore avrà facilmente constatato quale progresso segni questo saggio, sia rispetto a Menzel, di cui capovolge i termini arrivando così a una costruzione ben più ricca e interessante, sia anche rispetto a Wienbarg, di cui pure riprende alcune idee portanti, quali quella della letteratura nazionale, ma arricchendo anche queste con apporti di varia natura. Eppure - fatta salva ogni possibile differenza: di livello, di prospettiva e anche di buon gusto - a tutti questi saggi è comune un aspetto essenziale: sono saggi programmatici. Gli autori vi danno indicazioni per cose da fare, per atteggiamenti da assumere; danno la linea giusta per arrivare a conseguire certi obiettivi, di solito attraverso sforzi comuni. Con i programmi la situazione è sempre un po’ buffa: sono rivolti al futuro ma non sono previsioni del futuro; e quindi quando il futuro è passato non c’è neanche spazio per un’azione notarile, che chieda conto delle percentuali di realizzazione, tanto e comunque i programmi non si realizzano mai (e questa è la fortuna del futuro). I programmi non fanno nemmeno un bilancio del presente, poiché quel che vogliono ottenere non è ancora nel presente, al massimo c’è in germe, oscuramente e confusamente. Ma quando i programmi illuminano quel che c’è e non c’è, non è detto che per ciò stesso il “questo” si metta a brillare tanto da esistere a lungo. Esiste sì nel saggio programmatico e nel momento, difficile però dire se anche altrove e in altri momenti. D’altra parte il programma svolge una parte essenziale nel processo di chiarificazione di chi vi partecipa (da autore o da lettore), quindi non lo si può liquidare così facilmente; e tuttavia, non liquidato, da una considerazione del genere esce confinato in uno spazio stretto. Ciò vale per quanto è successo nel passato, del quale non si può cambiare niente, e può valere nel presente, soprattutto quando un qualche programma mobilita a impedire che si realizzi. È opportuno ricordare la nobile presa di posizione da parte di Immermann, diversa da molte altre per tono, tempi e contenuto. Immermann, che era intervenuto tempestivamente a proposito dei Wanderjahre, si annunciò molto tardi a 45 proposito del secondo dibattito; anzi non vi entrò nemmeno perché quella che tracciò alla fine della sua vita fu una panoramica culturale retrospettiva, preziosa per certi aspetti (ne riparleremo a suo luogo) e molto distaccata per altri. In Die Jugend vor fünfundzwanzig Jahren (I giovani di venticinque anni fa, 1840) Immermann data l’inizio della letteratura tedesca vera e propria, quella «cui si può predire un influsso nazionale di lunga durata». Quando stato, chiesa e ogni idea guida appare dissolta, ecco imporsi la soggettività, ecco che l’individualità vuole entrare come tale nella vita. Goethe ne è il maggiore rappresentante: nelle cose egli non vuole altro che se stesso. Dunque la letteratura tedesca non è nata nel medioevo, non ha alcuna radice romantica, essa è moderna grazie alla sua classica soggettività. I lettori vi reagirono altrettanto soggettivamente; convinti che la poesia sia un agire in versi, reagirono con partecipazione ai contenuti, non accettando di vedere la letteratura come gioco. Tale privilegiamento di contenuti è per Immermann «una necessità tedesca»: dichiarazione che nella sostanza conosciamo già dagli Epigonen. Nel caso del dibattito su Goethe fu possibile tre anni prima del saggio di Gutzkow una presa di posizione di cui non si può assolutamente dire che fosse programmatica ma che aveva tutte le prerogative della vitalità. Fu quella di Heinrich Heine (1797-1856) all’interno del suo saggio Die Romantische Schule (La scuola romantica, 1833). Rapidamente Heine riassume gli argomenti di quella che chiama una coalizione dell’estrema destra con l’estrema sinistra, unite contro Goethe. Da una parte c’erano i bigotti che rimproveravano a Goethe l’assenza di fini morali, la non nobiltà del suoi personaggi e insomma volevano sottometterlo alla croce, mentre Goethe aveva protestato che croce, tabacco, cimici e aglio gli facevano male. Costoro a Goethe preferivano Schiller. Dall’altra c’erano i liberali, gli «uomini del movimento», ai quali dispiaceva che Goethe fosse troppo cresciuto per lasciarsi trattare come un albero della libertà, sulla cui testa mettere un berretto frigio. Ai primi, i difensori di Goethe replicavano che nell’arte non ci sono fini, neanche fini morali; perciò non la si può giudicare secondo il rapporto fine-mezzi. Anzi l’arte deve restare indipendente dalla morale, che varia nei tempi e fra le civiltà; l’arte sarebbe dunque un secondo mondo, indipendente e superiore alla religione, alla morale e alla storia. Heine si dice non del tutto convinto dall’argomento, che induce a sentirsi non semplicemente superiori alla storia ma addirittura indifferenti. Schiller è invece da lodare perché accettò la storia e si occupò di quei problemi che la Rivoluzione francese dimostrò interessare tutta l’umanità. Goethe fu invece più per i sentimenti individuali, per l’arte, per la natura. Le opere di Schiller invitano all’azione; non così quelle di Goethe. Il panteismo venne inteso da quest’ultimo come eguale presenza di Dio in tutte le cose, dunque eguaglianza di tutte le cose; e ciò genera indifferentismo. La correzione operata dal saintsimonismo, secondo cui quella presenza non è uguale ma graduata e la manifestazione di Dio è nella storia, induce a rivolgersi attivamente al mondo. Goethe ebbe pertanto 46 un influsso negativo sullo sviluppo politico del popolo tedesco. Ciò detto, Heine sentenzia lapidario: «niente è più stolto di sminuire Goethe a vantaggio di Schiller». La differenza artistica fra i due gli appare abissale; Goethe ha reso semplicemente perfetto tutto ciò che ha rappresentato. Come si vede, Heine giudica la controversia con distacco, tanto più accentuato dal definire se stesso come uno che era stato antigoethiano per pura invidia. Ha l’aria di dire: tempi passati. Il che non era esatto: il libro di Wienbarg e il saggio di Gutzkow erano ancora da venire; e il lettore avrà facilmente notato che le posizioni di Heine non vi rimasero senza influsso. Eppure quei saggi successivi gli rimasero indietro. Heine non lamentava l’assenza di modelli, perché non ne stava cercando. Non si proponeva di raggiungere mete con o senza Goethe perché stava effettivamente lavorando con un suo metodo e suoi presupposti. Dunque non inglobava Goethe nel proprio mondo ma neanche aveva bisogno di espungerlo. Non voleva essere ecumenico, ma nemmeno operare quella selezione che dell’escluso faccia un nemico. Non un programma, non una dichiarazione di tendenza, non un bilancio storico, non una semplice presa di distanza. Quella che scrive Heine è una testimonianza del mondo del Nebeneinander. Suppongo che il lettore sia meravigliato di tale conclusione, che ancora rievoca la formula coniata da Gutzkow per un suo illeggibile romanzo, e a quell’epoca, per di più, ancora da inventare. Avevo però avvertito che la formula non è da intendere in senso troppo ristretto. Ma certamente è anche venuto il momento di allargare l’intendimento e in genere di allargare l’orizzonte. Excursus: Persona e idea Ciò vuol dire anche subito differenziare Heine dagli altri. Heine non è una vittima della mancanza di centro e della giustapposizione: egli vi convive, la osserva, la doma, la gestisce. L’idea del Nebeneinander non potrebbe essere allargata come avverrà tra poco se non vi fosse Heine. Anzi essa non si allargherebbe nemmeno a tutta l’area dello Junges Deutschland, nemmeno a tutto Gutzkow, restandosene confinata alla prefazione in cui è nata, se non vi fosse Heine. Quel che a tale proposito si può dire per Heine spiega anche tutti gli altri, però va oltre loro, prendendo spunto da chi ha avuto ben diversi risultati; e quindi quella spiegazione va un po’ larga a chi non è Heine: cioè non spiega fino in fondo; con Heine infatti passiamo dalla sociologia alla Dichtung. L’idea c’è perché c’è un suo supporto, che funge da catalizzatore. E quindi è vera eppure non lo è; dice di tutti (Heine compreso) più di quel che sono: in Heine si legge anche un po’ degli altri Jungdeutsche, in questi un po’ di Heine. Nasce dalla sociologia, cioè dalla ricostruzione di un ambiente, ma non resta alla sociologia. Non per questo la dimentica: essa ha l’intento di spiegare, quindi ha un aspetto strumentale in cui restano visibili le origini. Ma scaturisce da un’esperienza di lettura, quindi da un’interazione fra narratore e cosa letta; dunque è un precipitato di vita, con le sue parti di soggettività e oggettività. 47 Se ne può fare a meno? Certo: se si vuole restare alla sociologia. E altrettanto certamente il suo legame con l’oggetto è sempre in pericolo. Ci si ricordi del frammento romantico: esso era tale perché l’autore legava ogni momento alla totalità, la quale poteva concentrarsi e rivelarsi ovunque, ma con predilezione in ciò che già formalmente era non concluso né chiuso, aprendosi con ciò verso l’infinito. Immaginiamo ora lo stesso frammento privo di ogni riferimento alla totalità, alla sostanza e simili: ne risulta una serie di parti indipendenti, liberamente combinabili. E l’autore è colui che ne dispone a suo piacimento, spostandole, accostandole, ripetendole come vuole. Non è più la totalità quella che deve sprizzarne, ma la singola cosa espressa e la soggettività di chi la esprime e dispone. Di conseguenza uno scritto riportabile alla logica del Nebeneinander, e dunque composto di tante parti autonome, mai totalizzanti e capaci di mantenere sempre in rilievo l’autore che ne dispone, non ha strettamente bisogno di essere letto in successione; le sue parti sono interscambiabili e trasportabili da uno scritto all’altro. Ci si può chiedere se ciò non sia condizionato, in tutto o in parte, dal processo di stesura commerciale: dal giornalismo, che della trasponibilità e ripetitibilità non può fare a meno sia per richiamare al lettore quel che è necessario richiamare, sia per riaffermare delle linee generali che il tener dietro alla quotidianità rischierebbe di confondere, con la conseguente difficoltà di comprendere la quotidianità stessa; dall’abitudine a pubblicare a puntate, cosa che specializza una tecnica di separazione funzionale, toto coelo diversa dalla frammentazione romantica. Comunque sia: all’opera viene meno ogni parvenza di necessità metafisica, di assolutezza, di sacralità (il che contribuisce a spiegare il tono tanto diverso tenuto da Heine nel parlare di Goethe e Schiller); in compenso risulta calata nelle necessità del giorno. Il che può contribuire alla sua efficacia, ma anche renderla accidentale, episodica, svagante. E se le va male, diventa chiacchiericcio fra autore e lettori, strapazzando l’ideale di trasformarsi in vita, che era già un ideale romantico, ma che gli Jungdeutsche avevano riaffermato per conto loro. Ne risultano libri potenzialmente interminabili anche quando sono brevissimi; e dispersivi anche quando hanno da esporre una sola tesi: perché la combinabilità delle parti sta sempre lì a ricordare che niente di interno e di necessario impone di arrestarsi. Il giudizio sta allora attento a che la cosa còlta abbia senso e che quell’unità di arte e vita significhi che per parlare sensatamente di un problema esso deve essere il nostro. Forse tutto ciò è riassumibile nel termine “attualità”; attualità di allora e attualità dell’allora per noi di oggi. Ma la caratteristica essenziale dell’attualità è quella di passare. Heine sarebbe allora un passato continuo? Può darsi che in ciò sia del vero e che così si spieghi almeno in parte l’irritazione incessante che Heine è stato per i suoi critici, senza che neanche le 48 stroncature più autorevoli l’abbiano mai fatto sparire dall’orizzonte. Ma è ancora una conclusione insufficiente: l’attualità si riferisce al rapporto fra cosa espressa e tempo dell’espressione, mentre è ancora da considerare la soggettività di chi esprime e quindi mettere in rapporto soggettività, accostamento e permutazioni (cioè il Nebeneinander che risulta) e circostanze in cui tutto avviene (quella che abbiamo chiamato attualità). C’è qualcosa da aggiungere sulle circostanze legate al mercato, cui più volte si è alluso. Heine non visse esclusivamente dei proventi dei suoi scritti: gli occorsero un cospicuo vitalizio di un suo zio, integrato da una pensione che il governo francese gli passò segretamente dal 1836 al 1848, il tutto integrato da qualche speculazione in borsa, fatta con l’aiuto del barone Rothschild (o meglio fatta da quest’ultimo, che associava Heine ai suoi guadagni). Come stessero le cose per altri contemporanei, s’è detto. Ma anche se i loro proventi di scrittori non erano esclusivi, l’impressione che davano, che risultava e che presumibilmente anche oggi siamo disposti ad accettare, era che quei proventi fossero gli unici a contare e che fare gli scrittori di professione fosse cosa da prendere alla lettera. È che hanno scritto moltissimo e hanno riciclato i loro scritti in tutti i modi: pubblicandoli e ripubblicandoli su riviste dipendentemente dall’onorario (per Heine la cosa era facilitata dal suo pubblicare sia in francese sia in tedesco) e trasportandone delle parti da un’opera all’altra. Inoltre scrivevano di tutto, provandosi in tutti i generi letterari. Ma quel che hanno sviluppato come strumento preferito è stato l’articolo di giornale o il saggio per rivista. La saggistica non ha più i caratteri della saggistica di Schiller né dei romantici; tranne le dovute eccezioni, non è propositivo-teorizzante, meno che mai vuole risistemare il mondo. Piuttosto si esercita su figure e testi specifici, li analizza con metodi che sentiamo più affini all’odierna critica letteraria. D’altra parte dai risultati critici non di rado si vogliono ricavare proposte; ma è anche vero che di solito le proposte vogliono soprattutto collocare correttamente il giudicato nel presente. Insomma è la cosiddetta critica militante, che non sta zitta mai, che può andare avanti all’infinito, che rischia di ripetersi all’infinito se pretende di trovare in tutto la stessa cosa o rimproverare la mancanza della stessa cosa. Quella saggistica è invecchiata, ma nel senso che una volta è stata giovane. Ed è pronta a ridiventarlo, almeno nelle sue espressioni più riuscite, per esempio nel saggio di Heine Die Romantische Schule, non appena venga la voglia di contestarne le tesi, cioè di lasciarsi coinvolgere nella discussione, magari per non mettere gli inizi della modernità in Francia (come fa lui) ma proprio in Germania. Né Heine né i suoi contemporanei hanno inventato forme nuove; si direbbe piuttosto che essi stessi siano stati inventati dal prepotente svilupparsi delle forme: dal prepotente diffondersi della stampa periodica e dalla pubblicazione a puntate, come più volte detto; dalla predilezione per il resoconto di viaggio (portato proprio da Heine al livello maggiore), che è fatto di una serie di puntate, le quali garantiscono la possibilità di mettere insieme le cose più disparate, 49 già che del viaggio si spera che sia movimentato ma anche sicuro e che tutto ciò che vi accade sia al suo posto. Il mezzo di comunicazione condiziona le forme. Forse la forma non è ancora essa stessa il messaggio, però ci siamo vicini. La saggistica che ne risulta ha leggi sue, e chi l’ha capito meglio di ogni altro è stato proprio Heine: una tesi sintetizzata in un’unica frase, e tutto il resto del saggio come contorno. Non è cosa da poco, poiché il contorno è la vita quotidiana, quella cui partecipano tutti di tutti e più o meno allo stesso modo. La differenza la fa la soggettività. Il che dimostra che questa soggettività è figlia del mercato, o che comunque vi si adatta bene. Possiamo allora tirare le fila di quanto già visto e sostenere che essa gestisce l’episodico, il casuale, il mutevole; propone ciò che attende risposta (quindi la soggettività si presenta come la battuta di un dialogo), quel che aggancia il lettore anche se questi è di parere opposto o addirittura un avversario di principio; ha come suo ambiente il luogo della compravendita e perfino l’accompagnamento di chiacchiere (viene anche il dubbio che non si debba scrivere “perfino” ma “strutturalmente”); essa si trova a suo agio tra quel che appare ed è essa stessa quel che appare. Così l’Io non è più quello fichtiano o romantico in generale, che era già stato sbeffeggiato da altri (soprattutto da Jean Paul, che nella sua Clavis fichteana del 1810 e nel suo impopolare capolavoro Der Komet – La cometa - del 1820-22 impostò una relazione fra carattere e filosofia in Fichte, poi variata da molti, da Heine come da Immermann); è invece quello storico, quello particolare e partigiano; quello esposto non alla metafisica o altre sublimi verità, ma esposto al momento, alle cose che accadono hic et nunc, alla cronaca. A mettere in mostra tale soggettività appare adattarsi meglio di ogni altra una forma che non semplicemente non sia fissamente legata a un genere letterario ma che per di più e soprattutto mostri di essere palesemente, provocatoriamente gestita. L’atto del gestire si evidenzia al meglio nei passaggi di confine: dal sentimentale all’ironico, per esempio, ma comunque e tendenzialmente - chissà se non addirittura fondamentalmente - saltando di palo in frasca. Eravamo partiti da un Nebeneinander che schiacciava l’autore, siamo ora arrivati a un Nebeneinander entro cui trionfa la soggettività. Il punto di partenza era la sociologia, il punto di arrivo non lo è più. Excursus: Sociologia e Dichtung 1. Sugli aspetti economici e sociologi della produzione del Vormärz siamo bene informati; intere scuole di studiosi si sono rese benemerite per le loro ricerche quantitative. La loro utilità è fuori discussione ed esse sono state qui tenute molto presenti, anche se il lettore non è stato bombardato di cifre. È vero che ricerche di quel genere non sono state compiute su tutti gli autori di cui si è avuto e si avrà modo di parlare e che l’incompletezza delle informazioni rischia di portare a conclusioni non fondate. È anche vero (e questo è più preoccupante) che in qualche 50 caso si assiste a estrapolazioni non sostenute dai dati e dovute piuttosto all’ideologia. Ma questi incidenti sono evitabili e rimediabili. Voglio piuttosto dichiarare in che modo ho qui fatto uso di quelle ricerche: non ho mai dimenticato che, come critico e narratore, sono prima di tutto un lettore; in questa veste conduco un discorso sia con l’autore sia con gli altri lettori; coinvolto nella discussione, posso anche fare proposte rivolte al testo, all’autore, agli altri lettori. Se tutto ciò venisse invece espunto dalla ricerca, taglieremmo fuori quella fetta di pubblico che è la più importante di tutte: noi stessi che leggiamo. Le ricerche dette sono preziose in più casi: per esempio ci possono rivelare in che modo il pubblico è entrato nell’opera e l’ha condizionata. (Ecco il caso più semplice: un romanzo pubblicato a puntate richiede si sviluppi una certa tecnica dell’interruzione, altrimenti i lettori non andranno a comprare il prossimo numero.) Ma a questo punto il ricercatore riprende la sua funzione di lettore e decide se mantenere la sua stessa lettura al livello anteriore oppure proporre un nuovo livello; senza perdere per strada né il testo né il suo autore. 2. L’immagine che noi abbiamo dell’Ottocento è ben diversa da quella che l’Ottocento ebbe di se stesso. Autori che allora ebbero un successo a volte strepitoso, oggi non c’è forza che possa recuperarli; ciò vale per Gutzkow, Freytag, Heyse, Uhland, Geibel, Liliencron, Raupach. Autori allora ignorati sono per noi i veri classici: Büchner, Mörike, Droste-Hülshoff, il primo Keller. Altri sono ancora presenti ma drasticamente ridimensionati: Hauptmann. Di altri ancora ammiriamo di più quel che i contemporanei ignorarono: Grillparzer. Altri sono stati capiti solo dopo averli sottratti a un limitato, equivoco successo: Stifter. Se volessimo affidarci ai soli risultati di un calcolo quantitativo, le differenze fra quell’Ottocento e il nostro risulterebbero irrimediabili: in tutti i generi letterari le preferenze erano talmente lontane dalle nostre che le coincidenze finiscono per essere ogni volta una sorpresa. Anche le forme di mediazione erano ben diverse: le riviste, per esempio, nelle quali usciva (a puntate o no) un po’ di tutto, avevano un successo e una funzione per noi non più possibili. 3. Una diffusa prevenzione dice che la letteratura tedesca sia povera di grandi figure. È possibile che chi voglia impiegare il suo tempo nel far tali conteggi comparativi possa confermare o smentire un’opinione del genere. Tuttavia essa ha una sua verità indipendentemente da ogni verifica: forse il lettore converrà che, se avremo voglia di leggere della narrativa senza affannarci troppo il cervello ma andando lo stesso su una qualità sicura, prenderemo in mano piuttosto Balzac che Stifter; quest’ultimo usa trucchi che nel primo non sono nemmeno concepibili e quando alla fine l’abbiamo capito non siamo nemmeno sicuri di averlo capito. Stifter è un caso estremo, d’accordo; ma anche con autori che hanno avuto subito successo perché hanno trovato un linguaggio comunicativo, per esempio Heine, il rapporto attuale è denso di tormenti che non pongono né i contemporanei autori francesi né quelli inglesi. Insomma esiste un grosso problema di comunicazione, che già si poteva intuire da quanto detto in precedenza. Se ci mettessimo a scrivere una storia della letteratura tedesca dell’Ottocento secondo le categorie della diffusione e del successo, la maggior parte degli autori qui trattati non ci sarebbe affatto o sarebbe relegata a una nota a piè di pagina. Dunque abbiamo a che fare con personalità poco comunicanti a livello immediato e sfug51 genti anche a un livello mediato. Ma proprio qui è il punto e il fascino: in questo mondo non si entra se non coinvolgendolo in un dibattito culturale fortemente concettualizzato, che prende i suoi strumenti dall’estetica, dalla sociologia e dalla filosofia. Una storia della letteratura tedesca che non sfidi la soggettività del suo narratore a dimostrare le sue pretese d’oggettività mi pare abbia scarse possibilità di essere una storia. 4. Il presente manuale, pur se contiene non poche novità sia nelle valutazioni specifiche sia nei raggruppamenti, ha un suo conformismo fin troppo facilmente contestabile: vi si trovano gli stessi nomi trattati in qualunque altro manuale, e vi si trovano sostanzialmente con la stessa evidenza: Heine viene ritenuto più importante di Anastasius Grün, Fontane più di Spielhagen. Non è che me ne penta. Tuttavia questa storia potrebbe essere trattata in maniera diversa. Per esempio si potrebbe considerare l’episodio di Kaspar Hauser, cui vennero dedicati in abbondanza testi di vario genere, ricavarne insegnamenti storici, giuridici, sociologici (sull’immaginario collettivo, sul fantastico, su quanto restava del mito del buon selvaggio e così via) e poi misurare su questi parametri tutti gli scrittori che si prestano, anche se su Kaspar Hauser non hanno scritto niente. Come questo, si sarebbe potuto prendere un altro tema e condurre un’operazione analoga. Oppure - tutt’al contrario - si sarebbero potute fare delle storie congetturali, per esempio misurando gli autori (e sarebbe stato da decidere quali: se quelli qui prescelti oppure quelli più affermatisi alla loro epoca o altri scelti secondo altri criteri ancora) sulle estetiche predominanti nel loro tempo. Tutto questo non è stato fatto e ci si è mossi prendendo come punto di partenza il quadro canonico accettato nella nostra epoca (peraltro dinamizzandolo) e anche il modo di procedere per individualità, per raggruppamenti e subordinatamente per generi letterari. La destinazione dell’opera richiedeva un procedimento di questo tipo, che ha anch’esso i suoi vantaggi; ma vale la pena di suggerire almeno qualche esperimento mentale del tipo detto, e quindi sottolineare ulteriormente la precarietà di questa storia. Non voglio nascondere al lettore le difficoltà che io stesso ho con Heine. Già mi concilio poco in generale col Nebeneinander, pur se da lui così straordinariamente gestito. Ma mi prende vera e propria irrequietezza di fronte all’aspetto che esso assume nella saggistica. I due più importanti saggi di Heine vengono considerati essere Die Romantische Schule (1833) e Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland (Sulla storia della religione e della filosofia in Germania, 1834). Dal primo riesco a ricavare qualcosa, perfino qualcosa d’importante; mi mancano invece tutti i presupposti culturali e psicologici per apprezzare il secondo. Il primo è fatto di tanti pezzi messi “nebeneinander”; alcuni di questi, ricondotti a un contesto più generale, si rivelano elementi di un grande dialogo in cui è proprio Heine a dire le cose più incisive e durature, come abbiano visto a proposito della discussione su Goethe; altri hanno caratteristiche diverse ma altrettanto importanti, che vedremo più in là. Il secondo è più unitario, ma forse Heine non era adatto al saggio di grande respiro. Egli si rivol52 ge al pubblico dei giornali e delle riviste e di questo tipo di saggistica (l’ho detto e lo ribadisco) afferra perfettamente la legge: una tesi sintetizzata in un’unica frase più volte ripetuta (in questo caso: protestantesimo e filosofia moderna, fra loro strettamente collegati, sono i due formidabili apporti tedeschi alle rivoluzioni passate e venture) e tutto il resto del saggio come contorno, in cui si parla di questioni personali, di cronaca e cose simili, con ogni tanto un gruppo di righe dall’informazione più sostenuta: una dozzina di righe per riassumere Kant, due gruppi di tre righe l’uno per riassumere Fichte. Nel 1854 Heine, che ripropone al pubblico i due saggi, vorrebbe farli precedere da sue Confessioni di cui parleremo più in là; in esse dichiara di aver scritto anche una trattazione della filosofia di Hegel, mancante nella prima edizione, ma di averla gettata nel fuoco a causa del suo mutato punto di vista in questioni religiose (che non era un capovolgimento ma una diversa accentazione, cui però Heine teneva molto). È possibile. Forse è solo la mia mancanza di fantasia che mi rende inconcepibile uno Hegel trattato al modo del saggio di Heine e mi fa sospettare che lo scrittarello sia stato piuttosto bruciato per consapevolezza di scrittore; mi rafforza nel sospetto il constatare che quando Heine parla di Hegel in epoca antecedente ai suoi ripensamenti religiosi riesce penoso. Ma forse è un mio pregiudizio; riuscito a proporre un riassunto della Wissenschaftslehre (Dottrina della scienza) di Fichte in tre righe (dico tre), forse avrebbe anche proposto una Phänomenologie des Geistes (Fenomenologia dello spirito) in dieci righe, destinando tutto il resto a contorno, quel contorno fatto di amabili conversari in cui tutti si ritrovano. Tutti litigano per gravi motivi ideali, però o frequentano lo stesso ristorante oppure i ristoranti separati per clientela ideologica hanno stesso menu e stessi prezzi. E il salmone alla mugnaia non si fa con la Fenomenologia. Questi sono i miei pregiudizi, che il lettore doveva conoscere. Aggiungo che a essi non rinuncio, ma che so di aver torto. Heine si rivolgeva a un pubblico che manifestamente conosceva, presso il quale ebbe successo e al quale comunicò comunque cose nuove. Io tuttavia riservo la mia ammirazione agli articoli politici, che considero incomparabilmente meglio riusciti. (Sono in inquietante compagnia: anche Metternich li ammirava.) La politica viene fuori da tutte le parti, a ogni occasione, anche quando la sede di pubblicazione e il titolo del contributo meno lo farebbero aspettare: una corrispondenza sui pittori francesi esposti a Parigi nel 1831 dice cose interessanti sui pittori ma di gran lunga di più su Luigi Filippo. E altrettanto prepotentemente esplodono le considerazioni sulla letteratura, che del resto Heine lega alla politica. A volte dà delle informazioni, ma si vede presto a che cosa ciò gli serva: a parlare di sé, a teorizzare, a sintetizzare. Se focalizziamo l’attenzione su questi punti e subordiniamo loro il resto, allora cambiano anche i risultati e arriviamo a una serie di prese di posizione e dunque di idee che Heine lancia nel dibattito culturale, quale che sia la sede e l’argomento apparente, perfino nei saggi che per altre ragioni meno lasciano soddisfatti. Ma a questo punto dobbiamo approfondire il discorso sulla 53 soggettività. In occasione del dibattito su Goethe si fece un gran parlare di soggettività e oggettività. Nell’occasione (1828) Heine assunse una posizione che poi ripeté più volte. L’idea dell’arte, sostenne, è al centro dell’epoca goethiana (quella che noi oggi chiamiamo classico-romantica) e al centro dell’opera di Goethe stesso. Ma il periodo dell’arte è finito; il mondo obiettivo, da esso creato, non è più consono ai tempi; si sta affermando la più sfrenata soggettività. Da una parte, dunque, l’arte e il mondo antico (Heine allude a una rivista edita da Goethe, “Kunst und Altertum”), dall’altra la natura e la gioventù (ma in altro momento dirà: dall’altra parte c’è la democrazia). Dalla nuova arte ci si aspetta che non si separi dalla politica del giorno, che non lavori con preoccupazioni private. Nel futuro ci sarà anche una nuova arte con una sua nuova tecnica e con un suo sistema simbolico; nel frattempo, via libera alla soggettività, all’individualità, alla personalità, libere da convenzioni sia terrene sia divine, a sfogare la loro gioia di vivere in tutti i suoni e i colori. «Oggi la poesia non è più oggettiva, epica e ingenua, ma soggettiva, lirica e riflessiva.» L’arco del discorso qui riassunto va dal 1828 al 1835 (l’ultima citazione è ricavata proprio da Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland) ed è valido per tutto Heine. Non tutti la pensavano come lui, per esempio il suo amico Immermann la pensava in modo opposto; ma Heine è senza tentennamenti in materia. Resta ora da chiedersi che cosa è soggettività. Heine ce ne dice qualcosa: essa è libertà, vitalità, riflessione. Ma si tratta di vederla nell’atto pratico. Diremo dunque che soggettività è ciò che si rivela nell’atto di gestire il Nebeneinander; dunque per averne le caratteristiche occorrerebbe recensire tutti i modi della gestione. C’è però un modo più rapido per arrivare non a una statistica ma a un’ipotesi verificabile: è procedere dai materiali gestiti. Ricorderemo che questi non sono più i frammenti del romanticismo ma parti autonome. Il loro punto di fuga sono la politica e la teoria e critica della letteratura; quali che siano le occasioni e i materiali, è lì che prima o poi la riflessione arriverà. La politica è per sua natura destinata a realizzarsi nel molteplice; e la letteratura, che vi è collegata, pure. La gestione di questi materiali (cioè i punti di passaggio, le connessioni o disgiunzioni, le aperture sui punti di fuga) non avviene con la sovranità che ci rivelerebbe un io romantico, sostanziale e assoluto; piuttosto il gestire passa, insieme con i suoi materiali, da una cosa all’altra; ma non è succube, poiché è sempre pronto a staccarsene, a mostrare che il senso in essi visto c’è ma forse non c’è, e così a buttarli in balia della perdita di senso, cioè nel ridicolo. I materiali non li dà la natura oppure Dio oppure delle libere associazioni di idee, anche se la fabula (e Heine stesso in alcune sue dichiarazioni) vorrebbe farcelo credere. C’è pur sempre un autore che li trova, li seleziona, li dispone. La sua abilità consiste nel mostrarsi e nello scomparire subito dopo, lasciando intendere che non ha voluto definire e illustrare né una totalità né - meno che mai - la propria sostanzialità, ma solo e proprio i periclitanti rapporti che ha posto. Questa soggettività si mostra fun54 zione del collegamento; esiste perché c’è un collegamento, cioè perché ci sono altre cose; ma queste sono scambiabili e, se hanno un significato specifico, non è detto che lo abbiano proprio. In mezzo a quelle cose la soggettività si trova per caso; e sembra trovare per caso anche se stessa. Tutto ciò non è romanticismo, d’accordo, e tuttavia lo richiama continuamente per assenza. Come stiano le cose in materia lo dice Heine stesso nel celebre attacco dei Geständnisse (Confessioni): A suo tempo un francese di spirito mi definì un “romantique défroqué” [un romantico spretato]. La definizione è pertinente. Nonostante le campagne di sterminio da me condotte contro il romanticismo sono sempre rimasto un romantico. Sono l’ultimo poeta del romanticismo: con me si è chiusa la vecchia scuola lirica tedesca e al tempo stesso io ho aperto la nuova scuola, la moderna lirica tedesca. Nella storia del romanticismo tedesco merito di essere ricordato con evidenza. La «campagna» principale venne condotta da Heine nel saggio Die Romantische Schule (1833). I romantici vi vengono accusati di essere reazionari, oscurantisti, retrogradi; di essersi opposti al meglio della Germania, a quell’idea di umanità e fratellanza universale che era stata coltivata da Lessing, Herder, Schiller, Goethe, Jean Paul; di aver semplicemente voluto ripristinare il medioevo. Ma ci sono due riconoscimenti; uno va alla fondazione e all’apertura delle nuove scienze filologiche; l’altro, ben più importante, è legato alla vita, a quel che Heine chiama eleganza: dagli Schlegel in poi, sostiene, non si scrive più un tedesco che puzzi di tabacco e di sego. Prima di loro il nome di poeta tedesco evocava uno straccione, un pitocco, un ubriacone; ma ora nel suo panorama è entrata l’eleganza e la civiltà: si può scrivere in maniera elegante di argomenti scientifici. Se poi si riflette che proprio con i romantici si ha l’insistenza su una identificazione tra scrittura e vita che Hegel loda nello Junges Deutschland e in definitiva in se stesso, ne risulta che anche per lui i romantici erano ambivalenti: rivolti al passato, eppure iniziatori dell’era moderna. E ora l’intellettuale rinnovato deve affrontare il suo tempo. Sta nascendo la psicologia sociale e non pochi autori (Laube e Mundt, per esempio) si dedicano a scrivere volumi interi su personaggi dell’epoca etichettandoli come «caratteri». Heine liquida questa prospettiva senza mezzi termini, consapevole com’è del modo sovrano in cui procede nel disporre i suoi materiali; insomma consapevole di quanto è forte e irrinunciabile la sua soggettività. Il poeta che affronta l’era moderna non lo fa per una questione di carattere; carattere è conformismo: Possiede carattere chiunque viva in determinate cerchie di una determinata concezione di vita, si identifichi per dir così con essa e non si trovi mai in contrad- 55 dizione con i suoi pensieri e sentimenti. Ma il poeta deve far valere la sua soggettività, la sua capacità inventiva, le sue scoperte, si gridi pure all’arbitrio, all’incoerenza, alla mancanza di carattere. Il carattere va bene per quella grande massa di autori la cui penna, nello scrivere, è guidata unicamente dall’ispirazione del momento e che obbediscono alle parole, più che comandarle. Con gli artisti quel principio è inammissibile, poiché essi sono maestri della parola, la piegano a qualsiasi scopo, la modellano a piacere, scrivono oggettivamente e il loro carattere non si rivela nel loro stile. (Ludwig Börne, 1840) Abbiamo qui la prova che quando Heine sostiene che la nuova letteratura è quella della soggettività liberata, anzi sfrenata, intendeva proprio sul serio. Il ritratto dell’artista (che intanto ha fatto un bel passo avanti rispetto a quello classico-romantico e a quello degli Jungdeutsche, anche se questi vengono riconosciuti come suoi ascendenti) si completa nel concreto, cioè a contatto di quella realtà che deve affrontare e che ora descriveremo con gli occhi di Heine; nella concretezza gli sarà filo conduttore quella soggettività che siamo venuti conoscendo e la cui perdita condannerebbe l’artista ad avere un rapporto solo illusorio o velleitario con la realtà (mentre filo conduttore di quanto viene ora esposto è il già citato saggio contro Ludwig Börne). La quale realtà è quella di una democrazia che non riesce ad affermarsi. Le condizioni politiche della Germania sono quelle che sono; ma anche sul resto del mondo non c’è da farsi illusioni; poiché in altra parte di questo libro si parlerà del mito americano, che attraversa la letteratura tedesca dell’Ottocento, sarà qui il caso di dire che Heine non vi ha mai aderito, anzi ha definito l’America una «enorme prigione della libertà, in cui il più ripugnante di tutti i tiranni, la plebaglia, esercita il suo rozzo dominio». La rivoluzione di luglio ha suscitato grandi speranze, ma Heine si fa molto critico con Luigi Filippo. Tuttavia ha occhi per vedere quale progresso sia l’affermarsi del capitale finanziario; Rothschild, che glielo impersona, «è un distruttore violento del patriziato privilegiato e il fondatore della nuova democrazia»: con il suo sistema di titoli di stato pone le condizioni prime del progresso sociale, distruggendo il predominio del latifondo, permettendo che si possa vivere di una «ricchezza mobile» e dunque centralizzando nelle capitali intelligenze e autorità sociali. Ma ovviamente personaggi del genere hanno tutto da perdere se avviene un rivolgimento generale, e i portatori di quest’ultimo dovrebbero essere ben altre classi. Heine sa bene che in Germania sono gli artigiani ad assumere posizioni rivoluzionarie; sa però anche che sui rivoluzionari impegnatisi in quei moti che in Germania stessa sono seguiti al luglio francese i nazionalisti hanno esercitato un’influenza ben più radicata nel popolo di quanta non ne esercitassero e tuttora non esercitino i li56 berali, coloro che parlano di fratellanza universale. Già: gli artigiani, le classi umili, il popolo. Saranno loro i portatori della rivoluzione, non c’è dubbio. Ma il popolo puzza. Il popolo non è né bello, né buono, né intelligente (completerà nei Geständnisse). È vero che la sua bruttezza si chiama sporcizia, la sua cattiveria si chiama fame, la sua stupidità si chiama ignoranza e che dunque occorrerebbe dargli case sane, nutrirlo e istruirlo. Ma il poeta si rende ben conto che il progresso è tragedia. Vincerà il comunismo, e in teoria lui sarebbe disposto a sacrificare tutti i vantaggi dell’arte per il bene del popolo; ma in concreto non gli fa nessun piacere immaginare che i fogli delle sue poesie serviranno a fare cartocci per il tabacco da naso delle vecchiette del futuro. Finché ci limitiamo a conoscere le rivoluzioni attraverso i libri, tutto sembra molto bello, come in quei paesaggi che, artisticamente incisi su bianca carta velina, hanno un aspetto tanto lindo e invitante, mentre poi, osservati in natura, forse guadagnano quanto a grandiosità, ma offrono nei particolari uno spettacolo assai sordido e sporco; i mucchi di letame, incisi su rame, non mandano cattivo odore, e il pantano è facile a guadarsi con gli occhi! Ciò fa apparire per quello che è realmente, e cioè avvenimento tragico, il compito generale posto dal poeta nella sua interpretazione generale della storia dell’umanità: la riconquista del sensualismo e, in prospettiva, il superamento del dissidio fra quelli che chiama nazareni ed elleni, ebreo-cristiani e pagani, spiritualisti e sensualisti. Raggiungere nuovamente l’armonia fra i due poli è forse il compito della civiltà europea; il superamento dell’unilaterale predilezione per lo spiritualismo, l’ascetismo e simile ridonerà la salute. È stato il cristianesimo a far trionfare la stortura (che gli ebrei gli hanno trasmesso come una specie di vendetta postuma) e a promettere che i torti si raddrizzeranno solo in cielo. Ma attraverso le benedizioni di libere istituzioni politiche e industriali vorrei stabilita già in questa terra quella felicità che secondo l’opinione dei pii dovrebbe aver luogo solo col giudizio universale, in cielo. (Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland – Per una storia della religione e della filosofia in Germania) Soggettività, distacco, ma discorso chiaro sui compiti e sulle tendenze storiche di fondo. Oggi è troppo facile dire che certe profezie di Heine non si sono avverate (per esempio quella sulla sicura, terrificante rivoluzione progressista della Germania; una Germania terrificante è venuta e per fortuna è anche passata, ma era di tutt’altro genere); oppure obiettargli che, nonostante tutti i crimini del socialismo reale, esso non ha fatto con le sue poesie cartocci rivoluzionarcomunisti per tabacco da naso, anzi delle sue opere ha fatto un vero culto e una straordinaria diffusione; in compenso oggi ci sono le trasmissioni di varietà e le telenovelas, ben più micidiali. Soggettività come responsabilità autocritica, libera 57 e creativa, e «scrittura obiettiva», cioè coinvolgimento in problemi veri, sono indicazioni importanti, che in lui hanno dato luogo a una forma unica di arte. E gli faremo giustizia esaminando i modi di questa. Si tratta di verificarvi il tipo di soggettività che già conosciamo. I libri che fondarono durevolmente la fama di Heine furono due: la raccolta di poesie Buch der Lieder (Libro di canti, 1827) e i Reisebilder (Immagini di viaggio, 1826-31). Nelle poesie Heine profonde una tale abbondanza di invenzioni metriche e ritmiche, una tale maestria nel dominio di tutte le forme quali di rado si riscontrano nella storia della lirica. Sonetti, ballate, inni, quartine; cicli in senso stretto o accostamenti paraciclici; varietà nei registri di linguaggio: l’inventiva di Heine non ha freni. E altrettanto varia è la tecnica per portare alla luce quella soggettività gestoriale del Nebeneinander che dà qui dei frutti eccezionali. Alcune poesie, prese da sole, potrebbero stare benissimo in Eichendorff: non si vede che cosa ne turbi il romanticismo (e fu proprio tale la lettura che ne fece Schubert quando ne scelse per il suo ultimo ciclo di Lieder); a relativizzarle pensa il contesto. Ma poi: troviamo descrizioni che potrebbero scivolare con estrema facilità nel patetico o anche semplicemente nel romantico, e invece un tono obiettivo le frena; è il caso di “Abenddämmerung”, in cui è da notare anche il ritmo straordinario, quasi di un racconto in prosa. Anzi è da notare che i contemporanei furono colpiti subito dal modo heiniano di spingere la prosa verso la poesia mediante solo pochi interventi; cosa che subito però gli è stata ritorta contro quale preteso limite: un atteggiamento durato fino al nostro secolo, a Karl Kraus e Adorno. E poi troviamo narrazioni lirico-prospettiche come “Im Hafen”, un racconto (e quindi quasi un poemetto epico) monologato, fatto da un marinaio ubriaco, che dalla sua prospettiva non può dirci la verità su quel che sta avvenendo e che noi ricostruiamo da qualche suo cenno (l’oste l’acciuffa e lo caccia dalla taverna). Oppure troviamo poesie come la seguente: Mein Herz, mein Herz ist traurig, Doch lustig leuchtet der Mai; Ich stehe, gelehnt an der Linde, Hoch auf der alten Bastei. Da drunten fließt der blaue Stadtgraben in stiller Ruh; Ein Knabe fährt im Kahne, Und angelt und pfeift dazu. Jenseits erheben sich freundlich, In winziger, bunter Gestalt, Lusthäuser, und Gärten, und Menschen, 58 Und Ochsen, und Wiesen, und Wald. Die Mägde bleichen Wäsche, Und springen im Gras herum: Das Mühlrad stäubt Diamanten, Ich höre sein fernes Gesumm. Am alten grauen Turme Ein Schilderhäuschen steht; Ein rotgeröckter Bursche Dort auf und nieder geht. Er spielt mit seiner Flinte, Die funkelt im Sonnenrot, Er präsentiert und schultert Ich wollt, er schösse mich tot. Risplende festevole il maggio, / ma triste, ma triste è il mio cuore. / Io sto sugli antichi bastioni, / poggiato ad un tiglio in fiore. // Scorre laggiù l’azzurro / canale calmo e lento: / un ragazzotto in barca / tiene l’amo e fischia al vento. // Spiccan di fronte in vari / ridenti minuscoli aspetti / e ville e prati ed orti / ed uomini e buoi e boschetti. // Ragazze stendono i panni / sciamando sul verde pendio. / Lungi un mulino macina: / ascolto il suo ronzio. // Sta una garetta di guardia / al vecchio forte lassù: / un milite in rossa uniforme / passeggia su e giù. // Gioca col suo moschetto, / così, senza un perché: / presentat’arm, spall’arm ... / Vorrei che sparasse su me! L’ultimo verso arriva inaspettato; lo stupore suggerisce l’ironia, che è parente del riso. Ma se si pensa alla serietà della cosa, non c’è proprio niente da ridere. Il non romantico gestisce il romanticismo, facendo intendere quanto poco affidamento c’è da fare sia sull’uno sia sull’altro. Heine interiorizza il gioco delle dislocazioni, dei piani sfalsati. Non c’è da cercare il senso riposto, ma il non farsi del senso, o almeno la sua non afferrabilità. Questo è un punto importante. La poesia di Heine si allargherà a vari soggetti: al démi-monde, all’attualità, specificamente alla politica; alluderà oppure ricorrerà ad allegorie. Ma resterà nemico di quel Tiefsinn che rimproverava agli illeggibili filosofi. Heine non spiattella le cose nude e crude; ciò sarebbe del resto contrario alla sua consapevole teoria della soggettività. Ma le allusioni e le allegorie non richiedono chissà quale esegesi; non richiedono un lettore esoterico ma un lettore che abbia occhi e che sia consapevole del fatto che un autore costruisce anche quando appare limitarsi ad accostare, a dissociare, ad alterare toni, linguaggi, prospettive e mezzi retorici in genere. In precedenza è stato accennato al rimprovero di prosasticità rivolto alla lirica di Heine; si è andati in realtà ben oltre: la sua lingua è parsa degna di gazzet59 tieri e commercianti, la disponibilità ad ampliare il mondo dell’espressione è parsa cedimento alla parola corrente. E lasciamo stare le ripulse collocabili nella gamma che va dal nazionalismo all’antisemitismo. Dunque mi pare giusto rendere omaggio proprio a questo Heine, allo Heine “prosastico, gazzettiere, commerciante”. A tale proposito, ecco una prima citazione, che nell’ultimo verso della quartina scade (si fa per dire) nel linguaggio corrente: Die Welt ist dumm, die Welt ist blind, Wird täglich abgeschmackter! Sie spricht von dir, mein schönes Kind, Du hast keinen guten Charakter. Il mondo è cieco e stupido, / ogni giorno si fa più banale. / Di te, bella bimba, si chiacchiera / che non hai una seria morale. E poi eccone una seconda, nella quale le terminazioni alla francese passano dall’arcaismo settecentesco al linguaggio da borsa: Die Erde war so lange geizig, Da kam der Mai, und sie ward spendabel, Und alles lacht, und jauchzt, und freut sich, Ich aber bin nicht zu lachen kapabel. Die Blumen sprießen, die Glöcklein schallen, Die Vögel sprechen wie in der Fabel; Mir aber will das Gespräch nicht gefallen, Ich finde alles miserabel. Das Menschenvolk mich ennuyieret, Sogar der Freund, der sonst passabel; Das kömmt, weil man Madame titulieret Mein süßes Liebchen, so süß und aimabel. La terra è stata a lungo avara; / ma venne il maggio e divenne magnanima. / E tutte le cose sorridono a gara, / ma non può ridere la mia anima. // Campane suonano, sboccian viole, / gli uccelli parlano ed hanno un’anima. / Ma non mi piaccion le loro parole, / trovo ogni cosa che mi disanima. // La razza umana mi annoia e accora, / anche l’amico che spesso m’anima… / Questo perché or si chiama «signora» / l’amor mio dolce, la mia dolce anima! È possibile che chi condivide le accuse riportate sopra se ne senta corroborato; o almeno che si senta confortato in un’accusa subordinata, secondo la quale Heine avrebbe ecceduto nello scherzo, anche a scapito dei suoi temi seri. Posizioni del genere, così come il loro contrario, mettono in discussione il nostro 60 rapporto con il romanticismo. Nello stesso lasso di tempo, avendo cominciato prima ma essendo andato avanti a oltranza, un autore di nove anni più anziano di Heine e destinato a morire dopo Heine, Joseph von Eichendorff (1788-1857) componeva più di una poesia sul tema della donna che va sposa a un altro. Eichendorff restò romantico fino all’ultimo e un confronto fra i due può esserci di qualche aiuto. Per ragioni di brevità scelgo, di Eichendorff, Begegnung (Incontro), che è del 1810; ma andrebbero altrettanto bene Der letzte Gruß (L’ultimo saluto) o Die Hochzeitsänger (I cantori nuziali), rispettivamente del 1830 e del 1837 circa, tanto costante è questo tema, così come il modo di trattarlo, in Eichendorff come del resto in Heine (la cui poesia precedentemente citata è del 1822-23): Begegnung Ich wandert in der Frühlingszeit, Fern auf den Bergen gingen Mit Geigenspiel und Singen Viel lust’ge Hochzeitsleut’, Das war ein Jauchzen und Klingen! Es blühte rings in Tal und Höhn, Ich konnt vor Lust nicht weitergehn. Am Dorfe dann auf grüner Au’ Begannen sie den Reigen, Und durch den Schall der Geigen Lacht’ laut die junge Frau, Ihr Stimmlein klang so eigen, Ich wußte nicht, wie mir geschehn – Da wandt sie sich in wildem Drehn. Es war mein Lieb! ’s ist lange her, Sie blickt’ so ohne Scheue, Verloren ist die Treue, Sie kannte mich nicht mehr – Da jauchzt’ und geigt’s aufs neue, Ich aber wandt mich fort ins Feld, Nun wandr’ ich bis ans End’ der Welt! Incontro Passeggiavo ed era primavera, / lontano sui monti andava, / con canti e con violini, / un allegro corteo nuziale: / che giubilo, che melodie! / Sulle vette e nella valle tutto era in fiore, / per la gioia non potei passare oltre. // Al villaggio, poi, sul prato verdeggiante / cominciarono le danze, / e attraverso il suono dei violini / rideva forte la giovane donna. / La sua vocina così strana suonava, / ch’io non capivo che m’accadeva, 61 /quand’ella si voltò, girandosi di scatto. // Era il mio amore! Di molto tempo fa. / Lei guardava, senza alcun rossore, / la fedeltà è perduta, / più non mi conosceva - / Nuovo tripudio ricominciò e suono di violini, / ma io m’allontanai per i campi, / e ormai m’aggirerò sino al giorno del Giudizio. I testi parlano da soli, il confronto porta da sé alle conseguenze: quella di Heine e quella di Eichendorff sono state due espressioni altrettanto legittime e contemporaneamente possibili. Eichendorff prende sul serio le movenze del canto popolare; Heine può riprenderle scherzandoci, perché sa che la loro serietà è fuori discussione. Eichendorff è un grande poeta nel momento in cui fare i romantici veniva sentito come epigonismo; Heine sente arrivare l’epigonismo ma non ha altra realtà al di fuori del riferimento al romanticismo. Eichendorff è sicurissimo della sua lingua, espressione diretta di tutto il dicibile; per Heine la lingua consiste di citazioni e, se non vuole essere supponente, deve in primo luogo citare e mettere in discussione se stessa. Per Eichendorff il dolore umano è talmente autentico e il cuore dell’uomo è talmente al centro di tutto, che ha senso parlarne senza perifrasi; per Heine l’unico modo di parlarne è truccarlo e nasconderlo, tanto è in bilico lo statuto dei sentimenti. Da una parte, dunque, un romantico senza esitazioni, dall’altra chi sta assistendo alla fine di un’epoca, ma di un’epoca che non ha rivali e di cui è necessario cogliere quel che ancora si può, mostrando peraltro quanto è discutibile ed effimero tale bottino. Così che oggi quasi non appare possibile leggere l’uno senza l’altro, vedendo dentro Heine il ricordo del contemporaneo Eichendorff: questi come poeta esente da dubbi, quello come poeta che ha solo dubbi, esprimibili però solo attraverso la rovesciata serietà dell’altro, attraverso cioè il mondo che la sostanzialità dell’uomo l’ha presa con la massima serietà, tanto da arrivare a rovesciarla nel suo contrario, nel nichilismo, già al suo interno. Ma questo discorso lo fermiamo qui. Il lettore avrà notato che tutti gli esempi sono stati tratti dal Buch der Lieder (1827); il dernier cris dei germanisti vuole invece che si preferisca il Romanzero (1851), nel quale – così si ritiene – Heine sarebbe meno Heine. Il che significa che questo poeta seguita a costituire un problema. Comunque intendo assicurare il lettore: Heine è rimasto Heine fino in fondo. Ha cambiato qualche idea e in generale ha avuto uno sviluppo, come è ovvio per uno che poeteggi per una quarantina d’anni; ma non certo uno sviluppo tale che autorizzi a contrapporre l’ultimo Heine al primo. Giusto seguire quello sviluppo se si tratta di capire meglio quel poeta; ingiusto strumentalizzarlo nel modo detto. Perciò qui non seguiremo il progressivo allargarsi della tematica sociale, la ripresa delle lamentazioni ebraiche, l’affacciarsi insistente del tema della morte (costretto per tanti anni a letto, Heine ha avuto tutto il tempo di meditarlo); invece renderemo omaggio alla sua costanza scegliendo dal Romanzero la seguente citazione: 62 Alte Rose Eine Rosenknospe war Sie, für die mein Herze glühte; Doch sie wuchs, und wunderbar Schoß sie auf in voller Blüte. Ward die schönste Ros im Land, Und ich wollt die Rose brechen, Doch sie wußte mich pikant Mit den Dornen fortzustechen. Jetzt, wo sie verwelkt, zerfetzt Und verklatscht von Wind und Regen – Liebster Heinrich bin ich jetzt, Liebend kommt sie mir entgegen. Heinrich hinten, Heinrich vorn, Klingt es jetzt mit süßen Tönen; Sticht mich jetzt etwa ein Dorn, Ist es an dem Kinn der Schönen. Allzu hart die Borsten sind, Die des Kinnes Wärzchen zieren – Geh ins Kloster, liebes Kind, Oder lasse dich rasieren. Rosa vecchia Era lei, quand’io 1’amai,/ un bocciuol di fresca rosa. / Crebbe poi e agli aurei rai / pompeggiò meravigliosa.// Fior più bello d’ogni fior, / io tentai di corlo alfine. / Ma pungente seppe allor / discacciarmi con le spine. // Or ch’è vecchia ed avvizzì, / floscio fior di dubbia fama, / ora sono il cher Henri, / carezzosa a sé mi chiama. // «Caro Enrico, bien-aimé» / mi sussurra ogni momento. / Or se pungemi alcunché, / sono i peli del suo mento. // Pungon troppo, in verità, le verruche setolute. / Va in convento, Ofelia, va! / Oppur ràditi la cute. Una poesia di questo genere non piaceva per niente a Karl Kraus, il quale anzi ne deplorava la permanenza nel Romanzero come di un residuo di altri tempi. Ma a Kraus in realtà non andava affatto a genio lo Heine del Buch der Lieder; e allora, senza infingimento alcuno, è proprio quello che va riproposto con forza, depurandolo da fraintendimenti sentimentali e assecondandone la virulenza invece di lasciarsene imbarazzare. Del resto lo Heine del Romanzero, quello col quale i suoi avversari mostrano di volersi conciliare, rivendicava l’unità della sua 63 vita e della sua battaglia con la seguente, famosa poesia: Enfant perdu Verlorner Posten in dem Freiheitskriege, Hielt ich seit dreißig Jahren treulich aus. Ich kämpfte ohne Hoffnung, daß ich siege, Ich wußte, nie komm ich gesund nach Haus. Ich wachte Tag und Nacht. - Ich konnt nicht schlafen, Wie in dem Lagerzelt der Freunde Schar — (Auch hielt das laute Schnarchen dieser Braven Mich wach, wenn ich ein bißchen schlummrig war). In jenen Nächten hat Langweil ergriffen Mich oft, auch Furcht - (nur Narren fürchten nichts) — Sie zu verscheuchen, hab ich dann gepfiffen Die frechen Reime eines Spottgedichts. Ja, wachsam stand ich, das Gewehr im Arme, Und nahte irgendein verdächtger Gauch, So schoß ich gut und jagt ihm eine warme, Brühwarrne Kugel in den schnöden Bauch. Mitunter freilich mocht es sich ereignen, Daß solch ein schlechter Gauch gleichfalls sehr gut Zu schießen wußte - ach, ich kanns nicht leugnen – Die Wunden klaffen - es verströmt mein Blut. Ein Posten ist vakant! - Die Wunden klaffen – Der eine fällt, die andern rücken nach – Doch fall ich unbesiegt, und meine Waffen Sind nicht gcbrochen — Nur mein Herze brach. Enfant perdu Sentinella perduta nella guerra / di libertà, trent’anni combattei, / senza speranze di vittoria in terra, / né di tornare vivo ai lari miei. // Fui sempre all’erta e in veglia, notte e giorno, / mentre dormian gli amici qua e là. / (Del resto, il russamento tutt’intorno / teneami desto pure malgré moi). // Di noia e di paura, sì, soffersi. / (Solo i babbei non temono alcunché). / Per discacciarle, fischiettavo versi / frizzanti d’ironia fra me e me. // Sì, sempre all’erta, col fucile in spalla, / quando un allocco s’appressava ostil, / sparavo bene e una bollente palla / cacciavo dritta nel suo ventre vil. // Talvolta, certo, quell’ostile allocco / sparava con eguale abilità / contro il mio corpo... Ah sì! negarlo è sciocco. / La piaga è aperta. Il sangue n’esce già. // La piaga è aperta. Il luogo mio è vacan- 64 te. / Altri verranno al posto di chi muor. / Ma muoio invitto. E no, non sono infrante / l’armi ch’io lascio. Infranto è solo il cuor. Heine è diventato ben presto noto alla cultura italiana, in un primo momento attraverso la mediazione di traduzioni francesi; su ciò esistono ricerche specialistiche, che non ripeteremo. Qui basterà citare un paio di esempi, cercando di arrivare quanto più vicini ai nostri giorni. Ecco dal Buch der Lieder una poesia e poi il suo rifacimento a opera di Giacomo Noventa (1898-1960): Herz, mein Herz, sei nicht beklommen, Und ertrage dein Geschick, Neuer Frühling gibt zurück, Was der Winter dir genommen. Und wie viel ist dir geblieben! Und wie schön ist noch die Welt! Und, mein Herz, was dir gefällt, Alles, alles darfst du lieben! No’ angossarte, putèl, spera, E razona el dolor; No’ ghe xé ’na primavera Sola pa ’l nostro cuor. Torna a l’età maùra L’avrìl… un altro avrìl: No’ ’ver paura, Ancùo… (da Versi e poesie, Mondadori, Milano 19752) Secondo esempio: una poesia di Heine dai Neue Gedichte (Nuove poesie, 1844) Mit schwarzen Segeln segelt mein Schiff Wohl über das wilde Meer; Du weißt, wie sehr ich traurig bin, Und kränkst mich doch so schwer. Dein Herz ist treulos wie der Wind Und flattert hin und her; Mit schwarzen Segeln segelt mein Schiff Wohl über das wilde Meer. nella traduzione di Giosuè Carducci: 65 Passa la nave mia con vele nere, Con vele nere pe ’l selvaggio mare. Ho in petto una ferita di dolore, Tu ti diverti a farla sanguinare. È, come il vento, perfido il tuo core, E sempre qua e là presto a voltare. Passa la nave mia con vele nere, Con vele nere pe ’l selvaggio mare. E in un ripensamento ancora di Giacomo Noventa Gò vestìo, sì, de luto la me barca, E me fido del mar; Tì ti-sa ben che mi gò perso tuto, Par volerte amar. El to cuor m’à tradìo, come fa ’l vento A ùn che sa dove andar; Mi gò vestìo de luto la me barca, E me fido del mar. I prodotti italiani si allontanano talmente dall’originale (cosa che nel caso di Noventa è oggetto di dichiarazione esplicita) da richiedere di essere giudicati con criteri atti a creazioni, non a traduzioni o simili; allora si apprezzerà la sonorità-felicità della resa carducciana, contrastante con il tema rinunciatario che viene narrato, e le forti tensioni ritmiche e fonetiche nella riflessione intimistica di Noventa. Heine è un’altra cosa. Insomma si tratta di tre poeti che nei casi specifici hanno lavorato sugli stessi materiali, i quali in Heine avevano ricevuto la prima illuminazione; e questo è un segno (non so quanto piccolo o quanto grande, ma comunque a esso ci fermeremo) della serietà con cui la poesia italiana si è misurata con Heine. Heine mette in mostra l’arte che riflette su se stessa. Eccone qualche esempio dai Reisebilder (Ideen. Das Buch Le Grand): Damals hatten nämlich die Franzosen alle Grenzen verrückt, alle Tage wurden die Länder neu illuminiert, die sonst blau gewesen, wurden jetzt plötzlich grün, manche wurden sogar blutrot, die bestimmten Lehrbuchseelen wurden so sehr vertauscht und vermischt, daß kein Teufel sie mehr erkennen konnte, die Landesprodukte änderten dich ebenfalls, Zichorien und Runkelrüben wuchsen jetzt, wo sonst nur Hasen und hinterherlaufende Landjunker zu sehen waren, auch die Charaktere der Völker änderten sich, die Deutschen wurden gelenkig, die Franzosen machten keine Komplimente mehr, die Engländer warfen das Geld nicht mehr zum Fenster hinaus, und die Venezianer waren nicht schlau genug, unter den Fürsten gab es viel Avancement, die alten Könige bekamen neue Uniformen, neue Königtümer wurden gebacken und hatten Absatz wie frische 66 Semmel, manche Potentaten hingegen wurden von Haus und Hof gejagt, und mußten auf andre Art ihr Brot zu verdienen suchen, und einige legten sich daher früh auf ein Handwerk und machten z. B. Siegellack oder - Madame, diese Periode hat endlich ein Ende, der Atem wollte mir ausgehen - kurz und gut, in solchen Zeiten kann man es in der Geographie nicht weit bringen. I francesi avevano allora spostato tutte le frontiere, ogni giorno sulle carte geografiche i paesi cambiavano colore: quelli che erano sempre stati blu diventavano improvvisamente verdi, alcuni addirittura rosso sangue, le statistiche dei testi scolastici, ben precise sino a quel momento, si ritrovarono così cambiate e rimescolate che neppure il demonio avrebbe potuto riconoscerle, anche i prodotti del suolo cambiarono d’origine: cicoria e barbabietole crescevano ora nei luoghi ove sino allora non si erano viste che le lepri e i nobilotti di campagna lanciati alla loro caccia, mutarono persino i caratteri dei popoli, i tedeschi divennero flessibili, i francesi cessarono d’essere complimentosi, gli inglesi smisero di gettare i denari dalla finestra, i veneziani non furono più abbastanza scaltri, ci furono molti avanzamenti fra i regnanti, qualche vecchio re ebbe un’uniforme nuova; furono sfornati nuovi regni che si vendevano come i panini caldi, altri potenti, viceversa, furono banditi dai loro possedimenti e dovettero cercare di guadagnarsi il pane in altro modo, alcuni entrarono nell’artigianato e fabbricarono ad esempio malacca o - Signora, finalmente questo paragrafo sta per finire, mi manca il fiato - in poche parole in tempi simili non è possibile far grandi progressi in geografia. Oppure sfoghi sul fattorino che aspetta impaziente i nuovi fogli da portare in tipografia - cioè cenni alle condizioni reali della produzione letteraria - oppure affermazioni sulla libertà sia del lettore sia dello scrittore, che suonano come dichiarazioni su una maniera di scrivere che dispone liberamente dei materiali e che vuole essere letta di conseguenza: Madame, Sie wünschen, daß ich erzähle, wie die kleine Veronika ausgesehen hat. Aber ich will nicht. Sie, Madame, können nicht gezwungen werden, weiter zu lesen, als Sie wollen, und ich habe wiederum das Recht, daß ich nur dasjenige zu schreiben brauche, was ich will. Ich will aber jetzt erzählen, wie die schöne Hand aussah, die ich im vorigen Kapitel geküßt habe. [...] Und als sie sagte: Das tut der Tod - Doch ich will heute diese Geschichte nicht erzählen, sie würde sich zu sehr in die Länge ziehen, ich müßte auch vorher von der lahmen Elster sprechen, die auf dem Schloßplatz herumhinkte und dreihundert Jahr alt war, und ich könnte ordentlich melancholisch werden - Ich bekomme plötzlich Lust, eine andere Geschichte zu erzählen, und die ist lustig, und paßt auch an diesen Ort, denn es ist die eigentliche Geschichte, die in diesem Buche vorgetragen werden sollte. Signora, Lei desidera che io Le descriva la piccola Veronica, ma io non voglio. Lei, Signora, non è obbligata a leggere un rigo in più di quanto non voglia, ed io da parte mia ho il diritto di scrivere solo quel che voglio: ora Le descriverò la 67 bella mano che ho baciata nel capitolo precedente. ... E quando disse: «Così fa la morte...» - ma oggi non voglio raccontarLe questa storia: andremmo troppo per le lunghe, e prima dovrei parlare della gazza zoppa che saltellava nella piazza del Castello e che aveva trecento anni, e mi immelanconirei per davvero. Mi viene voglia di raccontare un’altra storia, una storia allegra che qui viene a proposito, - perché è la storia che mi ero proposto di narrare in questo libro. Ed ecco un altro aspetto combinatorio importante, quella che un secolo dopo sarebbe stata chiamata enumerazione caotica, cui Heine procede secondo criteri coglibili con evidenza: ich erinnere mich dessen noch sehr gut, es standen daneben viel freudige Spielsachen von Perlemutter und Gold, eiserne Herzen an güldenen Kettlein, Porzellantassen mit zärtlichen Devisen, Schnupftabaksdosen mit hübschen Bildern, z. B. die göttliche Geschichte von der Susanna, der Schwanengesang der Leda, der Raub der Sabinerinnen, die Lukrezia, das dicke Tugendmensch mit dem entblößten Busen, in den sie sich den Dolch nachträglich hineinstößt, die selige Bethmann, la belle ferronière, lauter lockende Gesichter - aber ich kaufte doch die Pistolen, ohne viel zu dingen, und dann kauft ich Kugeln, dann Pulver, und dann ging ich in den Keller des Signor Unbescheiden, und ließ mir Austern und ein Glas Rheinwein vorstellen Apfeltörtchen waren nämlich damals meine Passion - jetzt ist es Liebe, Wahrheit, Freiheit und Krebssuppe Wenn wir die Geschichte durchgehen, Madame, so haben alle große Männer einmal in ihrem Leben davon laufen müssen - Loth, Tarquinius, Moses, Jupiter, Frau von Staël, Nebukadnezar, Benjowsky, Mahomet, die ganze preußische Armee, Gregor VII, Rabbi Jizchaz Abarbanel, Rousseau - ich könnte noch sehr viele Namen anführen, z. B. die, welche an der Börse auf dem schwarzen Brette verzeichnet sind. Ricordo ancora perfettamente; erano esposte accanto a molti gai gingilli d’oro e di madreperla, cuori di ferro appesi a catenelle d’oro, tazze di porcellana con tenere iscrizioni, tabacchiere ornate da graziose figure: ad esempio, la divina storia di Susanna, il canto del cigno di Leda, il ratto delle Sabine, Lucrezia, la grassona virtuosa con il seno scoperto in cui (a posteriori) sta per immergere il pugnale, la defunta Bethmann, la belle ferronière, tutte figure seducenti. Ma nondimeno comprai le pistole, senza troppo mercanteggiare, e poi le pallottole e poi la polvere. E poi mi recai alla taverna del signor Unbescheiden dove mi feci servire delle ostriche e un bicchiere di vino del Reno. Le frittelle di mele erano allora la mia passione (oggi le mie passioni sono l’amore, la verità, la libertà e la zuppa di gamberi) Percorrendo la storia, Signora, non c’è grand’uomo che, almeno una volta nella vita, non abbia dovuto darsi alla fuga - Lot, Tarquinio, Mosè, Giove, Madame 68 de Staël, Nabucodonosor, Benjowsky, Maometto, tutto l’esercito prussiano, Gregorio VII, il rabbino Isacco Abarbanel, Rousseau - e potrei citarne molti altri - ad esempio tutti coloro che figurano sulla lavagna nera della Borsa. Col che siamo ben lungi dall’aver esaurito i mezzi retorici di Heine, che ne inventa di nuovi a ogni pagina. Recensirli sarebbe noioso e rovinerebbe la gioia della lettura; basterà ricordarne - non certo per completare ma per testimoniare il piacere della lettura - il colloquio con la madre in Deutschland. Ein Wintermärchen (Germania. Racconto invernale, 1844), in cui le domande vengono sistematicamente eluse, oppure quel luogo dei Geständnisse in cui l’autore decide di andare a Parigi perché lì si possono mangiare ostriche mentre nel carcere di Spandau la cucina è cattiva, poi d’inverno neanche riscaldano le catene che uno porta ai piedi. Excursus: Sulla periclitante costruzione del senso 1. Heine costringe a modificare qualcosa delle premesse metodologiche generali. Gli autori selezionati vi erano stati distinti grosso modo in due categorie e ora dobbiamo accorgerci che Heine non appartiene a nessuna delle due. A Heine non si arriva attraverso la somma infinita delle interpretazioni con le quali il senso man mano si disloca, poiché Heine non confeziona nessun senso specifico ma apre verso il senso in generale, staccandosi di volta in volta dal risultato. Non mette in crisi questo o quel senso ma l’univocità del senso in generale. Heine mostra come il processo artistico comincia a costituirsi da ciò che non è arte: dall’articolo di giornale, dalla produzione di mercato, da ciò che si presenta come certo e univoco; e procede verso l’arte estrema, cioè verso il distacco nei confronti del senso in generale. Ma questo percorso viene riflettuto e la riflessione sa anche individuare leggi, tendenze, compiti; tutto ciò resta nell’opera perché il cammino che qui viene descritto e contemporaneamente percorso è un cammino completo. A tale completezza è essenziale la contraddizione di fondo, quella che impedisce alla totalità di fare anche solo capolino. Si può sognare che la contraddizione verrà risolta (così come verrà armonizzata quella fra spiritualismo e sensualismo), ma i sogni sono sogni. Nel frattempo la soggettività deve render conto di se stessa e dei suoi oggetti. E lo fa scatenandosi come soggettività che accetta di essere chiamata ogni volta al redde rationem, senza riconoscere né autorità né principî che le possano chieder conto di alcunché. Quest’arte sta sempre per diventare non-arte, così come il suo senso sta sempre per diventare assenza di senso. 2. Heine ha messo in crisi ben altro. Wolfgang Preisendanz gli ha dedicato un importante saggio, che si vorrebbe poter discutere per intero poiché contiene cose definitive sul Witz di Heine, cose molto importanti sulla soggettività (cose che non mi convincono, come quella sulla necessità di una lettura esoterica), ma soprattutto delle tesi generali di estetica, ripensate sotto l’impulso di Heine. Mi concentrerò su quella centrale. In Heine, sostiene Preisendanz, il momento ideologico diventa funzione ermeneutica dell’immaginazione poetica; questa a sua volta 69 diventa funzione euristica del contenuto ideologico di esperienza. Due sono le conseguenze: cade la pretesa dell’estetica di quella che Heine stesso chiamava l’età artistica, e cioè dell’estetica della totalità, secondo cui la poesia è tale perché rappresenta quel che si lascia dire esclusivamente come poesia; e c’è una conseguenza più generale: l’estetica stessa pare doversi relativizzare storicamente, con tutti i problemi che ne conseguono. Se pensiamo fino in fondo la prima conseguenza ne ricaviamo che secondo Preisendanz tutto il contenuto della poesia di Heine è rivelato univocamente e che la forma in cui esso è espresso non gli aggiunge nulla; infatti esso potrebbe essere non espresso in poesia e il lettore «esoterico» postulato da Preisendanz pare avere proprio questo compito: condurre l’esegesi finché tutto è spiegato e, per così dire, tradotto in prosa. La diversa posizione qui sostenuta è già stata illustrata; c’è qui da aggiungere che nelle sue analisi Preisendanz esamina i criteri di costruzione seguiti da Heine e da questo punto di vista non c’è che da condividere i risultati cui arriva; ma tali criteri non sono la stessa cosa dell’atteggiamento di Heine di fronte al senso. Costruzione e problema del senso (e della soggettività) non sono la stessa cosa. Indubbiamente, invece, Heine mette in crisi i precedenti concetti di estetica, vivi fin dentro la nostra epoca; in questo senso è un cosiddetto «fenomeno di confine». Heine elimina quei confini nel senso già detto, cioè nel senso che nella sua opera resta visibile tutto: dalla zona non poetica in cui tutto è cominciato fino a quella poetica che è stata raggiunta. Tutto vi resta inglobato e visibile; a maggior ragione resta tale la mano che ha tracciato il cammino, arrivando a quell’espressione che dica più di quel che dice (e magari tacendo additi altro) e che non può stare senza la complicità di noi lettori, mobili attributi di un ipersenso non garantito se non dalla nostra attribuzione, minacciante sì di coinvolgere della nostra vita più di quel che non vorremmo, ma reso infine innocuo proprio dalla sua forma e dal gioco di convenzioni che la concerne. Heine polemizzò molto; pretese, come già visto, che non si ponesse un’equazione tra scrittura e carattere (dimenticando di aver fatto a Fichte uno scherzo del genere) e che invece lo si considerasse un poeta, al modo in cui lui intendeva il poeta. Ma proprio per questo la situazione era paradossale e le polemiche non potevano che aumentare; come di fatto fecero, fino ai nostri giorni. Polemizzò violentemente con lui Arnold Ruge, prima che diventassero amici. In un articolo del 1838, in cui l’impianto hegeliano si sente tutto, Ruge gli riconobbe di aver dato voce all’emancipazione dalla vecchia fede nell’autorità e di avere così fondato un genere nuovo; ma gli rimproverò di essersi fermato al primo momento della ricerca della libertà, al soggettivismo fichtiano, e di aver espresso il lato sereno, umoristico, witzig della cultura delle Burschenschaften; anzi di averlo tanto estremizzato da non aver mai fatto parte di queste ultime. Là l’impegno di Heine è puramente negativo, formale, senza contenuti e senza principî; egli è la dimostrazione di quel che fa l’amore per la libertà quando è bloccato da un ostacolo. Heine è puramente distruttivo; la sua espressione è confinata al Witz, perché questo è la stessa «personalità libera, consapevole di 70 sé, dominante; insomma è il godimento dell’arbitrio geniale.» Ruge fondava così uno degli stereotipi della critica heiniana: l’esclusiva riconduzione al Witz. Heine ignorò l’attacco; Ruge viveva a Halle, lui a Parigi, avevano ambienti di riferimento parzialmente diversi. Ma non poté ignorare l’attacco di Börne, che per un certo tempo aveva frequentato. Nei Briefe aus Paris. 1830-31 (Lettere da Parigi. 1830-31, 1832-34), reagendo a una corrispondenza giornalistica di Heine raccolta in volume col titolo Französische Zustände (Sulla situazione francese, 1833), Börne ingiunse sostanzialmente a Heine di limitarsi a fare il poeta, visto che della verità gli interessava solo la bellezza e non accettava le durezze della politica. Purtroppo mescolò anche insinuazioni personali che avrebbe potuto risparmiarsi. Abbiamo già visto che cosa Heine intendeva per poeta; in effetti la sua definizione fu data proprio come risposta postuma a Börne, con un libro che a sua volta scatenò la reazione di Gutzkow (con conseguente rottura) e di altri. Lo scontro, se lo si vuol ridurre a una formula (cosa che peraltro Heine non fece), lo si può riassumere così: Börne era per un movimento repubblicano subito, Heine gli opponeva che non c’erano da fare fughe in avanti e che un intellettuale avrebbe dovuto capire i rapporti di classe meglio di quanto non facesse Börne. Börne era un giornalista straordinario. Questi Briefe aus Paris vennero bensì pubblicati soltanto in volume ma conservano tutto l’impianto della corrispondenza giornalistica, mostrandone anche un’interessante evoluzione. La prime lettere sono una vera festa del Nebeneinander; prendo come esempio la n.16, datata 8.12.1830: si comincia commentando la morte del figlio di Goethe, August; si prosegue con il criticare alcuni articoli del “Constitutionnel”; segue un pettegolezzo; poi un aneddoto che somiglia molto a un pettegolezzo su altro tema; c’è quindi la descrizione di un concerto: è stata eseguita la Symphonie phantastique di Berlioz, un «giovane compositore» che è in potenza un nuovo Beethoven, «però matto da legare»; segue un altro spettacolo. Tutto questo in poco più di quattro pagine e con una verve, uno spirito, un sarcasmo e una serietà, un alternarsi di umori e passioni di cui il mio riassunto dà una pallidissima idea. A poco a poco le cose cambiano, i temi diminuiscono finché si arriva alla lettera monografica; e allora le abilità di Börne vengono impegnate a variare quel tema, a illustrarlo dai vari lati, a renderlo vivido al lettore. Börne è stato davvero un grande giornalista. 71 I, 3. Dobbiamo ora riprendere con altro accento un tema già affiorato: che cosa avviene delle forme in quest’epoca. Ciò di cui ora ci interessiamo è il radicale rinnovamento delle forme teatrali a opera di Grabbe e di Büchner, precisando subito che esso dimostrò efficacia solo agli inizi del Novecento, quando le opere dei due vennero scoperte (o riscoperte) e portate sulla scena: fu solo allora che chi poi fu chiamato espressionista trovò in quelle opere i modelli che gli aprirono nuovi orizzonti. Nel repertorio dei teatri però riuscì ad affermarsi stabilmente solo Büchner; Grabbe ebbe e ha tuttora una sorte più travagliata, di cui parleremo a tempo opportuno. Forse il processo di rinnovamento si lascia seguire meglio in Christian Dietrich Grabbe (1801-1836); non soltanto per motivi cronologici ma anche e soprattutto perché esso ha lasciato nelle sue opere delle evidenti ferite. Sugli stimoli esterni non c’è eccessiva chiarezza. Sappiamo che Tieck aveva potentemente agito in direzione di uno svincolamento dalle norme classiche e che le sue opere venivano rappresentate spesso e con successo; sappiamo anche che, quando fu a Düsseldorf (1834-36), Grabbe poté assistere a molte messe in scena curate da Immermann, anzi ne fu recensore. I contatti con Tieck, poi, erano precedenti; nel 1822 gli mandò da leggere la sua prima tragedia, nel 1823 passò addirittura alcuni mesi presso di lui a Dresda. Tieck fu a sua volta editore delle opere di Kleist (1821) e soprattutto di Lenz (1828); Lenz va particolarmente ricordato perché tracce macroscopiche dell’esperienza lasciata dalla conoscenza delle sue opere si trovano sia in Grabbe sia in Büchner. Questo per quanto riguarda gli influssi esterni, a proposito dei quali non si va molto oltre questi indizi. Grabbe però ci ha lasciato dichiarazioni sparse e saggi teorici, che aiutano ad andare oltre. Innanzitutto ha tenuto a precisare che le sue opere rispondono a un progetto dal quale dipendono tutti i particolari, compresi quelli che chiama «eccessi», compreso il variare della metrica; Grabbe infatti non si limita al metro classico, cioè al Blankvers, ma usa anche coppie di versi rimati, versi brevi e brevissimi e andamenti strofici o parastrofici. Inoltre in occasione delle sue ultime tragedie affermerà qualcosa che vale retrospettivamente anche per le altre: ritiene insostenibile far ruotare tutto intorno a un eroe tanto innalzato da farlo apparire un feticcio. Affermazione che prima di verificarla nella prassi si può chiarire già accostandola a considerazioni contenute in un saggio precedente (Über die Shakespearo-Manie, Sulla mania shakespeariana, 1827), che va letto come altre cose di Grabbe, cioè come cifrate dichiarazioni su se stesso. Al Giulio Cesare di Shakespeare Grabbe rimproverava due cose: col venir meno del protagonista, punto di riferimento generale, non esiste nessun carattere capace di prenderne il posto; inoltre Shakespeare, qui e altrove, ha grosse difficoltà nel rappresentare il popolo. Traduzione in chiaro: nessuna tra72 gedia può essere polarizzata su un protagonista che domini la storia o su un fatto rigeneratore, poiché non esiste né l’uno né l’altro (i fatti, dirà in Don Juan und Faust - Don Giovanni e Faust -, 1829, non sono molto più che fiabe inventate per ammaestrare; essi passano in secondo piano rispetto alla storia generale; ma questo è un bel guaio, perché dalla storia nessuno ha mai imparato niente); il popolo è il grande oggetto sempre cercato e sempre sfuggente: ci si sforza di costituirlo, ma Grabbe mostra i fallimenti che si incontrano per questa via. Dunque non esiste un centro, né sotto forma di eroe né sotto forma di avvenimento o di sistema di valori; tale mancanza può discendere da una generale filosofia della storia e del posto dell’uomo in essa (così espressa nel già citato Don Juan) oppure può essere primariamente riferita al determinato periodo storico di cui una tragedia si occupa: è il caso di Marius und Sulla (Mario e Silla, 1823), che esplicitamente la denuncia. Questi motivi interiori (che presto verificheremo e arricchiremo nell’analisi delle tragedie), uniti all’insistente richiesta di Grabbe di esaminare le sue opere secondo il loro progetto centrale, ci aiutano a capire come egli abbia utilizzato le esperienze di Tieck e di Lenz per arrivare a risultati originali. Esteriormente Grabbe ha conservato a lungo la divisione in cinque atti; credo che però nemmeno la più duttile fatica riuscirebbe a trovarvi, al di fuori di una qualche genericità, una corrispondenza con le prescrizioni e le suddivisioni classiche, che ai singoli atti assegnavano rispettivamente l’esposizione, lo sviluppo, il climax, la retardatio e la catastrofe. Infine, dietro suggerimento di Immermann, Grabbe abbandonerà nelle ultime due tragedie la suddivisione in atti a favore di una loro presentazione anche formale come successione di scene. A proposito delle quali lo stesso Immermann (di cui è stato già ricordato come abbia protetto Grabbe; qui occorre aggiungere che su di lui ha scritto un notevole saggio) notava che esse sono dei tableaux, man mano più laconici. Non era per Grabbe, infatti, tratteggiare il nascere e crescere di un personaggio o di una vicenda; non era per lui porre limiti a un’azione: quel che gli ci voleva era il risultato finale e il tableau gli serviva per fermarlo in qualche modo; il tableau, ovvero il blocco compatto e concluso, da una parte impedirebbe all’azione di straripare, sia pure alla bell’e meglio, ma dall’altra (come mi sembra di dover interpretare) la priverebbe del tipo di dinamismo cui si è abituati dalle tragedie classiche basate sul viluppo di colpa, innocenza, ignoranza e fato. Forse il giudizio non è totalmente giusto (anche perché con tableaux Immermann non intende le singole scene ma il risultato complessivo), però indubbiamente c’è molto di vero. Che Grabbe non rispetti le tre unità, che si prenda grandi licenze metriche, che alterni prosa e versi e che infine passi totalmente alla prosa, tutto questo non è certo oggetto di meraviglia; ma lo è il modo in cui lo fa. Ci sono delle tragedie in cui praticamente a ogni scena si cambia luogo e prospettiva; ci sono masse e personaggi che arrivano sempre di nuovo; ci sono protagonisti che non arrivano mai a dominare, cioè mai a essere veri protagonisti: per arrivare a far sì che si assestino occor73 re uno sforzo finale di riflessione, un qualche commento a opera di non importa chi (loro stessi oppure un personaggio secondario oppure un nemico, o magari anche una didascalia), e non per mancanza dell’ultimo tocco di forza plastica, come diceva Immermann, ma per sfiducia di Grabbe nella consistenza e centralità del personaggio in generale. Altra cosa notevole è che gli antagonisti non vengono quasi mai a un confronto diretto. Sia i singoli sia i gruppi contendenti stanno ognuno per conto proprio, letteralmente nebeneinander. Però all’interno degli antagonismi maggiori viene ospitata una serie di antagonismi minori: qui si verifica più di una volta l’incontro-scontro, anche con una certa ampiezza nelle motivazioni; tali episodici incontri però non hanno mai lo scopo di attenuare la distanza fra gli antagonisti maggiori, che restano nel loro isolamento; Grabbe pare proprio deciso a mettere in evidenza l’assenza del centro, che resta uno dei punti più fermi della sua poetica. Ciò che Grabbe immette massicciamente a distruggere la forma tradizionale e a crearne una nuova è una dimensione antitetica al dramma; come notava già Immermann, si tratta della lirica nella prima tragedia e dell’epica a partire da Marius und Sulla (1823). Quando Grabbe verrà riscoperto, sarà il suo teatro epico ad attirare maggiormente l’attenzione; è significativo che nel 1922 Bertolt Brecht, il teorico e realizzatore del teatro epico nel nostro secolo, abbia progettato una rielaborazione dello Hannibal (Annibale, 1835), peraltro non condotta a termine. Il dinamismo classico è sostituito in Grabbe da mezzi decisi di volta in volta, ma comunque dal variare di situazioni opposte: può essere l’alternare scene di massa con scene ristrette a due personaggi e senza alcun rapporto con le scene vicine; può essere il passare da una massa a quella opposta; può essere altro ancora. Mai però il dinamismo è dato dall’evolversi di un personaggio o dall’iniziativa dell’antagonista o dal compenetrarsi di azione, colpa ed espiazione. Il centro è saltato, c’è solo posto per il Nebeneinander sia nel progetto generale sia nei particolari che da esso discendono. È però arrivato il momento di dire che il concetto di Nebeneinander non è più sufficiente. Da esso abbiamo preso le mosse e ciò è stato utile; ma per spiegare Grabbe e soprattutto Büchner occorre introdurne un altro: quello del nichilismo, che nelle sue articolazioni specifiche verrà spiegato man mano. La negazione del centro ha dunque una doppia valenza: nichilista per quanto riguarda il sistema dei valori, portata al Nebeneinander come conseguente dispersione dei materiali. Il generale progetto drammaturgico è strettamente legato alla filosofia di Grabbe, che dunque converrà illustrare insieme con quello; la raggrupperemo intorno ai seguenti punti: concezione della storia; concezione del popolo e del rapporto che con esso ha l’«eroe»; posto delle passioni, e in genere delle motivazioni personali; ruolo assegnato alla natura; funzione dell’artista. 1. A un Annibale provvisoriamente sfuggito ai romani un re da operetta (parodia di Luigi I di Baviera) dichiara di averne studiato i piani di battaglia e come 74 risultato gli comunica che essi mancano di sistema; allo sbalordito interlocutore, il quale ribatte (scusandosi) di aver disposto le truppe secondo le circostanze e le necessità, il re ribatte che questa non è una scusa valida e che il sistema va rispettato sempre. Gli sfugge il piccolo particolare che Annibale ha vinto sempre e che le guerre non si vincono soltanto con le battaglie ma con la politica. Il sistema è cosa da tavolino; con esso non si fa la storia. Ma è impossibile dire che cosa faccia la storia. Un progetto superiore non sembra esistere. Non ve n’è assolutamente traccia nella prima tragedia di Grabbe, Herzog Theodor von Gothland (Il conte Theodor von Gothland, 1822): a reggere il mondo pare sia il destino cieco, ma poi anche ciò viene smentito perché alla prova dei fatti risulta che quel destino è stato voluto dalle passioni umane e allora è forse più giusto dire che a reggere il mondo è la malvagità estrema; comunque non un piano divino; di Dio, «per il suo onore», è preferibile pensare che non esiste. E questo è un motivo costante nell’opera di Grabbe: dal Marius und Sulla (1823) a Hannibal (1835) gli dèi vengono sì invocati, ma per constatare subito dopo che essi si disinteressano delle sorti umane. I protagonisti stessi (seguiteremo a chiamarli così) o non hanno un’idea completa e adeguata di quel che vogliono oppure non l’hanno affatto. Ciò è addirittura ovvio per Gothland, che dice esplicitamente di cercare invano una meta; però questa prima tragedia, che per ammissione dello stesso Grabbe soffre di sovrabbondanza, non è la sua più tipica; conta più che quel tipo di cecità, parziale o totale, si incontri nelle successive. E così è di fatto, a partire da Marius und Sulla. Mario è ancora stupefatto della sua carriera e sopraffatto da due cose: dal ricordo, che in Grabbe assume sempre una valenza negativa, e dal desiderio di vendetta. Silla ha un progetto e ne riparleremo; ma la realizzazione coincide con le sue dimissioni e il ritiro a vita privata, perché tra progetto e suo portatore umano non c’è coincidenza. Come esplicitamente nota Grabbe, la mancanza di un centro nella vita romana ha reso necessario il dispotismo; a realizzarlo è Silla per sue qualità superiori a quelle di Mario, però è stato più il progetto a farsi carico di lui che non viceversa. In questa tragedia c’è forse una qualche riconoscibilità di una tendenza nella storia; ma ciò non impedisce a Grabbe di dire che il motore della storia è la crudeltà, dunque non un qualche disegno provvidenziale. E quel che diremo in seguito a proposito del popolo toglie ulteriore credito all’idea di un progetto storico. Annibale ha sì un progetto, quello di distruggere Roma; ma il suo vero avversario è in patria, e quello dovrebbe saper combattere; quando fa un errore politico clamoroso, uno dei suoi avversari si accorge e commenta che Annibale è solo uno spadaccino, mancante della lungimiranza politica necessaria a imporsi e a vincere. Né dalla tragedia risulta mai che il suo progetto sia anche giusto, fatta salva l’ammirazione per il valore umano e militare del personaggio. Diversamente stanno le cose con Arminio, che nella Hermannsschlacht (La battaglia di Arminio, 1835-36) riesce a portare a termine il progetto immediato (cacciare i romani) ma non quello più ampio (unificare il popolo) meno che mai 75 quello di lunga tendenza (sostituire la potenza germanica a quella romana); nei suoi fallimenti non è diverso da altri «eroi» di Grabbe, ma la differenza è che egli vede i progetti di lunga scadenza e gli altri no. Tali progetti vengono corretti e integrati da una profezia del morente Augusto: i tempi nuovi saranno dati dalla fusione di germanesimo e cristianesimo. Sembra che quando l’amor di patria lo muove Grabbe ritrovi all’improvviso il senso della storia. Nella Hermannsschlacht ciò risulta in maniera temperata sia dai fallimenti di Arminio (anche a lungo termine, poiché la profezia di Augusto è una correzione troppo importante) sia dalla sorte di Varo (ne parleremo oltre); ma nei due drammi storici sugli Hohenstaufen, Kaiser Friedrich Barbarossa; Kaiser Heinrich der Sechste (L’imperatore Federico Barbarossa; L’imperatore Enrico VI, 1829-30), sembra sentir parlare Hegel in persona: tutte le forze storiche hanno un senso e una missione di lunga durata, che al momento giusto si realizza; quel che non si realizza là per là, semplicemente non è ancora maturo. Federico Barbarossa, il papato e i comuni hanno tutti il loro senso e il loro successo. L’imperatore ha due scopi, entrambi cosmici: uno è frenare lo strapotere della Chiesa e dunque assicurare la libertà dello spirito; l’altro è unificare e dominare la Germania e così dominare il mondo pur senza conquistarlo (perché le conquiste sono accattonaggio). Entrambi gli scopi vengono raggiunti e questo è il compimento della sua missione terrena: ora potrà anche andare a fare una bella morte nella Crociata. Ma anche il papa ha ragione: l’imperatore è andato troppo oltre il suo tempo, diventandogli così estraneo; in quel tempo, in cui forze opposte si fronteggiano con immediatezza, ci vuole la forza mediatrice del papato per tenere a freno i cavalieri e i vassalli affinché l’imperatore non li annienti. Se non ci fossero i contrappesi dei vassalli e della Chiesa, proprio Federico risulterebbe il peggior tiranno. E infine i comuni: Milano combatte per la libertà e per i secoli futuri; e le repubbliche hanno il fiato più lungo dell’impero. Così tutto va a posto. Anche se l’imperatore commette l’errore di combattere e perdere a Legnano, la storia rimette a posto le cose: quella sconfitta era giusta, così come sono giuste le successive vittorie militari e diplomatiche. Questi due drammi sono ben diversi dalla restante produzione di Grabbe e non rientrano nell’immagine che è legata alla sua riscoperta; essi possono spiegare alcune peculiarità della Hermannsschlacht ma non è attraverso di loro che è passato il rinnovamento del teatro, pur avendo i loro motivi di interesse nello sforzo di scrivere delle tragedie di storia patria che fondessero due esperienze diverse: Shakespeare con Schiller, il movimento di personaggi e di masse con il programma ideologico. Ma, ripeto, non è questo il Grabbe che ci interessa e quindi non ce ne occuperemo oltre. Forse è però opportuno aggiungere quanto segue: Grabbe trova qui una ragionevolezza nella storia e un eroe che se ne faccia portatore (dunque un eroe vero), però solo a patto di una grande compressione dei tempi: la lotta contro il papato e per la libertà di coscienza sarà vinta nella realtà da Lutero; l’unificazione e centralità della Germania sarà un ideale 76 delle guerre di liberazione; la libertà di tutti i cittadini (o, come si diceva allora, la repubblica), di cui si fanno portatori i milanesi, sarà anch’essa uno di quegli ideali. Come dice il papa, quelle sono battaglie per secoli futuri; al momento la ragione della storia percorre altre vie. E tuttavia ciò non impedisce che nella finzione scenica, paradossalmente e al di là di queste dichiarazioni, l’imperatore abbia pieno successo. (Dei due drammi è più interessante il primo; il secondo, anche se presenta qualche possente scena, è piuttosto ripetitivo; ed è anche un po’ strano che, se Federico Barbarossa aveva avuto pieno successo, il figlio si ritrovi con gli stessi problemi e altri ancora.) 2. Il popolo è il grande presente-assente. Non dico nel Gothland, in cui c’è in tutto un cenno alla necessità che svedesi e finlandesi vivano in pace e per il resto ci sono soltanto eserciti e niente popoli; ma il Gothland è una serie di motivi interessanti, non ancora il luogo in cui Grabbe abbia sviluppato tutto il suo pensiero e le sue tecniche. Prepotentemente il popolo compare da Marius und Sulla in poi, e con caratteri abbastanza costanti: il popolo ha ragione, ma senza una guida è zero. In Roma esso non ha propriamente una patria perché è solo oggetto di sfruttamento da parte del Senato; da Mario invece ci si aspetta che metta in onore il merito invece del privilegio della nascita e che insomma capovolga i rapporti sociali. Le guide attuali, però, e cioè i tribuni della plebe, sono dei demagoghi, dei politicanti cinici e corrotti, non migliori degli altri. Mario però non mostra la statura politica che ci vorrebbe; dunque, più trasportato che guida, si muove quasi in sogno, vecchio ex-contadino che, come dice Silla, sa stare solo fra i pari suoi e solo finché l’assiste la forza elementare della gioventù, ormai passata. Anche il popolo tedesco della Hermannsschlacht ha tutte le ragioni del mondo. Loro e i romani non si capiscono proprio; le leggi che i romani vogliono applicare senza tenere alcun conto delle tradizioni locali si rivelano di un formalismo tale da coincidere con l’ingiustizia reale. Ed è un formalismo dietro il quale non è difficile nutrire interessi concreti, corruzione compresa. Ma l’attaccamento alle tradizioni, quali che esse siano, comprese le più arretrate, non costituisce ancora un popolo vero e proprio; meno che mai lo costituisce la cecità oltre la necessità del momento, meno che mai l’ostinarsi nei particolarismi, il rifiutare di darsi uno scopo generale e i mezzi relativi. Al di là del momento l’«eroe» non ha rapporto con il popolo reale, che non c’è, ma solo con l’idea che se n’è fatta. Il suo antagonista Varo ha altri problemi, ma non certo soluzioni più felici. Gli è chiara l’insensatezza di quel che sta facendo e di quanto non trovi alcuna comprensione né presso i contemporanei né presso i posteri. L’eroismo individuale si scontra col formalismo delle leggi, che lo perseguitano anche mentre tutti e lui stesso stanno morendo; e i posteri non capiranno né il suo eroismo né i suoi dubbi di fronte a quelle lotte che non lo convincono. Così gli unici con i quali riesce a parlare sono i pochi pessimisti che la pensano come lui. 77 Ma peggio di tutti va col popolo come figura in Hannibal. La notizia della vittoria di Canne viene accolta con freddezza da un mercato intento ai suoi traffici, che quelle vittorie non incrementano e che anzi quella guerra sta ostacolando; perciò hanno buon gioco i politicanti che negano sostegni all’esercito in Italia. Altra cosa è quando tocca lottare per l’estremo, cioè per la propria libertà: allora tutti si trasformano in eroi, e il popolo cartaginese non è secondo a nessuno. Solo che le guerre di liberazione possono anche finire con brutte sorprese; ne sa qualcosa il popolo di Capua (e il popolo tedesco) che, andato via l’occupante, ha visto rispuntare i tirannelli locali come e peggio di prima. Oltre la cerchia familiare e quella dei suoi fedelissimi (o al massimo oltre all’esercito insieme col quale ha sempre combattuto) l’eroe non ha nessuno cui comunicarsi. Manca, in linea di massima, perfino l’incontro con l’antagonista. Mario e Silla non s’incontrano mai; l’uno conta sì per l’altro, ma conta come nome, cioè come simbolo intorno al quale altri possono riconoscersi, ma come figura in carne e ossa l’«eroe» quasi scompare. Esistono però gli antagonismi minori, ed entro questi i confronti e gli incontri possono avvenire anche con frequenza, come si vede in Hannibal: i triarchi cartaginesi sono in continua lotta frontale e poi ci sarà l’incontro-scontro con i legati romani; non però un loro confronto diretto con Annibale, che pure per un certo tempo li sostituisce al potere, esercitando quel reggimento liberale che nella Germania dell’epoca veniva sperato da più parti; ma dura quei pochi momenti che mancano alla sconfitta di Zama e la triarchia riprende il sopravvento. Il dramma in cui Grabbe ha raggiunto i risultati più alti nel trattare il rapporto tra «eroe» e popolo è Napoleon oder Die hundert Tage (Napoleone ovvero I Cento Giorni, 1829-30; Grabbe ci tenne a precisare di averlo terminato prima della rivoluzione di luglio). In una straordinaria scena iniziale (di cui piacerebbe sapere se Büchner l’abbia letta prima di scrivere il suo Dantons Tod; purtroppo è impossibile rispondere) ci passa davanti quasi tutta la popolazione di Parigi: soldati congedati, emigranti tornati, venditori ambulanti e via dicendo. È la Parigi dell’iniziale Restaurazione, con i cambiamenti non revocabili lasciati dalla Rivoluzione e da Napoleone, con i ritorni possibili e impossibili tentati dai Borboni, con le speranze e le frustrazioni di tutti. Ogni tanto si fa il nome di Napoleone, ogni tanto viene ricordato il passato; ma sulla scena c’è Parigi, dove c’è chi ha fame, chi si arricchisce o si è arricchito, chi ha speranze o problemi; e nessun «eroe». Poi ci viene mostrato un altro insieme: Luigi XVIII e la sua corte. Lì eroi non ci sono perché proprio non ce ne possono essere; questa massa di persone, con la sua miopia, le sue vanità, persa nei suoi sogni e incapace di tener testa al nuovo, per esempio ai fabbricanti con le loro macchine a vapore (come si lamenta un nobile), sparirà anche presto e definitivamente dalla scena. Per il momento incombe su di loro il nome di Napoleone, senza che neanche riescano ad apprezzare bene il pericolo, che trattano alla stregue di un pettegolezzo di corte. Solo alla fine del terzo atto Napoleone entra a Parigi. Ma intanto le scene di 78 strada si sono popolate anche di chi mancava: dei voltagabbana così come dei residui giacobini, che vorrebbero tanto riprovarci; effettivamente riescono ancora a riportare in auge la lanterna di place de Grèves impiccandovene uno, ma poi devono cedere alla popolarità di Napoleone, un imperatore che avrebbero fatto volentieri penzolare. Il Napoleone di nuovo installato non è all’altezza di quanto da lui si sperava; l’attesa delle masse era ben più potente. Napoleone non ha imparato molto da quel che gli è successo; politicamente si arrabatta e poi via in quel che gli riesce meglio: la guerra. Sarà sul campo di battaglia di Ligny e di Waterloo che lo vedremo a lungo: quanto più matura la sua sconfitta, tanto più sta da imperatore sulla scena e tanto meno popolo ha intorno: solo generali e soldati. L’esercito che combatte con Blücher è invece popolo. Grabbe presenta i volontari delle varie regioni, amabilmente mettendone in luce i difetti più che i meriti. E nello stesso tempo chiarendo quali ben diverse aspettative hanno i due popoli. Immermann ha sostenuto che Grabbe ha reso poetiche perfino le manovre militari; non si può che dargli ragione. Alla fine gli ingannati saranno i popoli. Napoleone non ha dato la libertà ai francesi; la dichiarazione che aggiunge alla Carta dei Borboni non dà la libertà di stampa; l’unico liberalismo riconosciuto è l’obbedirgli. Ma la sua sconfitta non libera i popoli dalla tirannia; viene scacciato un grande tiranno, ma per far posto a tanti piccoli tiranni; non ci sarà la pace perpetua ma la ninna nanna degli animi; e non l’età dell’oro ma quella delle menzogne e delle quisquilie. È da Napoleone stesso che Grabbe fa profetizzare tutto ciò; dopo di lui ci sarà un gran vuoto, ma lo spirito del mondo è lì, pronto a riesplodere e a dar libero corso alle ondate della rivoluzione (ecco perché Grabbe ci teneva a dire che aveva completato l’opera prima del luglio 1830: non voleva apparire un opportunista, ma invece uno che aveva previsto gli eventi). Più modestamente Blücher assicura ai vincitori di Waterloo: se il futuro sarà degno di voi, bene; altrimenti consolatevi pensando che ne avreste meritato uno migliore. Mai Grabbe ha raggiunto pari risultati nel mettere in scena grandi masse e nell’esprimere il ventaglio di esistenze di interi popoli. Il dramma ha il suo centro qui; e secondariamente nel rapporto popolo-«eroe». Altri temi non vengono sostanzialmente toccati; Napoleone prova a parlare di destino, ma è solo per mascherare gli errori che gli sono costati le sconfitte del 1813-14. Ma il popolo non parla di destino né di tradimenti; il nome di Napoleone serve ai parigini per criticare quel che c’è al momento; un re imbelle, un governo incapace, la miseria. E i prussiani sono occupati anche loro da altre cose: fondersi in una patria vera, anche se non sanno spiegare bene che cosa significhi “libertà”. Gli eroi sono lontani, i problemi di tutto il popolo sono vicini e concreti, ma diversi fra loro. Gli uni si aiutano col nome di un eroe, gli altri col nome di un concetto. 3. Silla, colto, feroce, spiritoso, e tanto più feroce quanto più spiritoso, ha pas79 sioni come tutti; solo che, a differenza di tutti, sa domarle. La passione che più trova campo d’azione in Grabbe è la vendetta; e la tragedia straripante di passioni è la prima, il Gothland. Essa non è legata a eventi o luoghi particolari ma, come scriveva Immermann, è la tragedia dell’uomo in generale. È piena di eccessi fino a diventar monotona (e non si è nemmeno conservata la versione più efferata che, letta da Heine e da lui passata a Rahel Varnhagen, turbò talmente quest’ultima da precludere a Grabbe l’accesso al suo salotto). Una notizia falsa e calunniosa spinge Theodor von Gothland al fratricidio e poi a eccessi sempre maggiori. Il calunniatore lo costringe a guardare in faccia la verità: se ha creduto alla calunnia, sebbene sia stato messo in guardia in più modi, è perché ha voluto crederle, è perché cercava un pretesto alla sua catena di orrori. Quindi non è tanto la passione della vendetta a muovere Gothland, quanto piuttosto la sua crescente crudeltà. Quando infine si vendica del calunniatore deve ammettere che le morti che su di lui vuol vendicare gli sono in realtà indifferenti ma che deve fingersene sdegnato per poter agire. Dopodiché tutto gli diventa indifferente davvero: regno, cielo, inferno, vita e morte. Del resto ha già avuto modo di accorgersi quanto poco conti la grandezza: è stato sul punto di morire, eppure tutto nel mondo seguitava nel suo corso, indifferente alla sua sorte. Ma Gothland è appunto un estremo; nelle altre tragedie ci sono passioni più a portata di mano: sete di vendetta (Mario, in parte Arminio, ma al servizio dell’amore della libertà), bramosia di potere (la triarchia in Hannibal), vanità (il re Prusia anch’esso in Hannibal). Nell’«eroe» però esse non sono mai i motivi scatenanti dell’azione; a loro si sovrappongono sempre motivi più generali: la necessità di un disegno razionale in Silla, l’amor di patria in Arminio. 4. Alla natura sono dedicati splendidi squarci lirici nel Gothland, improvvise scene di pace in Hannibal, mentre nella Hermannsschlacht l’amore per la natura è una forma dell’amor di patria. Una brevissima tragedia, Nannette und Maria (1823), è forse quella in cui la natura ha più spazio. Il titolo lo danno due donne che sono rivali in amore, però senza saperlo: Maria ha infatti sempre nascosto il suo amore per Leonardo, e la ragione che ne vien data è l’orgoglio. Ma la vicenda dimostra che Nannette è terrorizzata dal sesso e dalla necessità di crescere abbandonando la casa del padre; Maria è terrorizzata da qualcosa di ancora precedente, dall’amore mostrato e corrisposto. Nasce da qui la tragedia, che secondo dichiarazioni dell’autore dovrebbe riconciliare chi aveva trovato repellente il Gothland; ma per altri aspetti la vicinanza è ancora grande e i momenti incredibili non sono affatto scomparsi. Quel che non si dimentica è il modo in cui i versi passano incessantemente dalla descrizione del paesaggio a quella dei corpi e viceversa; si tratta di una fusione così vivida, così (è il caso di dirlo) passionale, che la tragedia potrebbe scaturire più plausibilmente da tale intensità che dagli equivoci costruiti non senza goffaggine da Grabbe. 80 5. All’assedio e distruzione di Numanzia Grabbe fa assistere anche il commediografo Terenzio; costui nota come si sono trasformati gli Scipioni: da delicati intellettuali a guerrieri tutti dediti alla morte; ora lo trattano con sufficienza: il destino di Numanzia secondo loro va bene per una commedia, le proteste di Terenzio a proposito delle atrocità commesse sono stupidaggini oppure buone al massimo per una farsa. L’impotenza del Dichter di fronte agli avvenimenti appare con evidenza. (Tutt’altro avviene nei drammi storici su Federico Barbarossa ed Enrico VI: lì il Dichter è pari all’imperatore, essendo entrambi dei creatori: «a entrambi obbedisce il mondo: quel che l’imperatore crea nella realtà, il poeta lo crea nel suo mondo fantastico».) È qui opportuno dire che non la figura del poeta ma la realtà letteraria del suo tempo è stata al centro di una commedia di Grabbe: Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung (Scherzo, satira, ironia e significato più profondo, 1822); una commedia fortunata, che è riuscita a restare sulle scene. Indubbiamente la satira di autori secondari di quell’epoca non ci interessa più (piccante è semmai che Grabbe condanni anche due opere di Goethe: il Westöstlicher Divan e i Wanderjahre). Ma ci sono pagine bellissime che si accostano senza difficoltà a Leonce und Lena di Büchner, sia per la forza del linguaggio sia per affinità semantica; c’è poi uno smontaggio finale dell’illusione teatrale, in proseguimento e sviluppo della tradizione di Tieck; e c’è un’apertura verso l’epica, con l’inserimento di una vicenda esterna a quella principale, narrata da uno dei personaggi. Un secondo tentativo di satira del genere, El Cid, è invece fallito (ricordiamo che tra i personaggi satireggiati c’è anche il povero Platen, un poeta cui accenneremo in altro luogo, tra le altre cose sfortunato polemista che se le tirava proprio addosso). Nello Scherz si ritrovano, in forma appunto scherzosa, vari dei motivi fin qui visti, dal nichilismo alla critica al sistema. Ma ancora più notevole è che la commedia, ammettendo i livelli “bassi”, consente di estendere la critica a tutte le classi sociali: nobiltà, piccola borghesia, artigiani e contadini. La critica della vita borghese è anche l’unica cosa che attragga l’interesse in quello che è un vero passo falso di Grabbe, la fiaba drammatica Aschenbrödel (Cenerentola, 1835): il padre di Cenerentola è un poveraccio stretto fra una moglie bisbetica e spendacciona, figlie vanesie e fannullone e creditori. Dai vari cenni il lettore avrà notato che Grabbe è attento all’attualità anche quando il tema ne è apparentemente lontano. Per esempio in Silla sono da vedere riferimenti a Napoleone e all’affermarsi del suo dominio nel vuoto europeo; e poi, oltre al dramma dedicato esplicitamente ai Cento Giorni, Grabbe ne cominciò uno dal titolo Kosciuszko di cui c’è da rimpiangere che non sia andato oltre le prime due, bellissime scene. Ma né l’attualità allora né le attualizzazioni successive riuscirono a imporre Grabbe sulle scene. In vita venne recitato solo Don Juan und Faust; e c’erano perfino le premesse di un successo perché le musiche di scena furono scritte da un compositore quanto mai affermato, Albert 81 Lortzing. Tuttavia, come già detto, bisognò aspettare la fine del secolo perché si cominciasse lentamente a riscoprirlo. Poi gli toccò di essere incamerato dai nazisti come uno di loro; questo procurò finalmente la messa in scena della Hermannsschlacht (prodotta ben undici volte), ma in compenso il disinteresse del dopoguerra. A parte le alternanze politiche, non è facile prendere posizione su Grabbe, tanto magmatico è il suo mondo. Alla lettura molte cose convincono e anzi entusiasmano; per altre non è così. Ma resta sempre il dubbio di come andrebbero le cose sulla scena. In tempi recenti ci sono state due produzioni del Gothland, reinterpretato come tragedia dell’ineluttabile orrore dell’èra moderna; ma - a parte che in tal caso i films dell’orrore rendono meglio l’idea – l’indubbia qualità delle messe in scena non pare aver segnato la rinascita di Grabbe. Excursus: Sulla resistenza delle forme Davanti a opere come quelle di Grabbe, piene di cambiamenti di scena, di scene di massa, di violente contrazioni temporali e lunghi salti spaziali, potremmo credere, noi abituati al cinema, che forse quest’arte potrebbe rendere loro giustizia meglio del teatro per il quale sono state pensate. Infatti il cinema è riuscito a integrare delle forme di epica la cui integrazione forse al teatro non è riuscita affatto oppure che lascia perplessi, come in questo caso. C’è però da chiedersi se così si renderebbe giustizia a Grabbe e se ai suoi drammi non sia essenziale la presenza dei corpi, la ristrettezza degli spazi, l’obbligatorietà delle prospettive, cioè ciò che è essenziale al teatro. La peculiarità di Grabbe, insomma, consisterebbe nello sforzare all’estremo quel che il teatro può dare, nel fare un teatro che a ogni momento pare sia lì lì per non essere più affatto teatro ma stia per diventare altra cosa; eppure non lo diventa, eppure torna a essere teatro. L’esempio estremo è Marius und Sulla: Grabbe l’ha pubblicato come frammento, dichiarando che aspettava il giudizio del pubblico per decidere se valeva la pena di completarlo oppure no. Per conto mio non riesco a credergli. Il fatto è che i primi due atti e gran parte del terzo sono compiuti; ma già nel terzo le parti compiute sono collegate da narrazione e riflessione, delle quali consistono per intero gli atti quarto e quinto. Qui il teatro è sul punto di non esserci più: gli ultimi due atti sono divisi appunto in atti e in scene - e Grabbe assicura che un eventuale completamento non li avrebbe fatti straripare e insomma sarebbe stato autenticamente teatrale - però manifestamente lo stato degli appunti sembra rivelare la tentazione di farli esplodere. Questo frammento, anch’esso a suo modo, non ha più niente di romantico. Tuttavia la forma non esplode. Posso immaginare che essa metta a dura prova una realizzazione scenica che voglia esserle adeguata. Grabbe sforza la forma fino al suo punto-limite. La mistura di nichilismo e di Nebeneinander ha prodotto l’esplorazione del limite. La liminarità di Grabbe è crisi permanente, ancora recuperata dalla resistenza della forma. È limite, ma non un limite generico: è limite dal teatro verso altro, eminentemente verso l’epica. Ma è pur sempre teatro, che non s’annulla come tale. La resistenza della forma aggiunge pertanto un significato al discorso di Grabbe. 82 Per tutto il periodo che ci occuperà in questo volume le forme hanno resistito più che bene. Anzi dopo Grabbe esse non verranno sforzate in forma simile per molto tempo; occorrerà aspettare Arno Holz e successivamente il simbolismo, il primo con esperimenti che anche esteriormente si richiameranno a Tieck, il secondo con l’invenzione del dramma lirico; ma non raggiungeranno l’estremismo di Grabbe. Noi posteri, abituati ad altre cose, siamo forse in grado di rispondere meglio a certe domande poste all’epoca di Grabbe. Infatti abbiamo assistito a movimenti estremi quali la Body Art e il Living Theater, che hanno ripreso in ben altro modo la problematica di una coincidenza dell’arte con la vita. Dunque possiamo riproporci diversamente i problemi di Grabbe , per esempio così: se le forme dell’arte vengono sforzate fino al punto cui le hanno portate esperienze quali quelle citate, si allargano i confini dell’arte oppure se ne esce? Quale è il punto di non ritorno? Ai tempi di Grabbe si insisteva su una continuità di arte e vita; si è visto in che termini e con quali attese. Non si voleva certo dire soltanto che l’arte è una delle manifestazioni della vita, perché sarebbe banale. Non era precisato in modo da non lasciare equivoci se l’arte dovesse esprimere tutta la vita, ma ci si andava abbastanza vicini. In quella specie di psicodramma che è il saggio su Shakespeare, in cui mostra di scagliarsi contro questo autore o i suoi maniaci e invece si tormenta su problemi tutti suoi, Grabbe dà una strana risposta: l’arte è compensazione globale. Infatti quando le conquiste napoleoniche tolsero ai tedeschi la libertà, scrive, la cercarono nell’arte e vollero in questa recuperare i territori che avevano perduto nella realtà. (E poi va avanti dibattendo, oltre su quanto già riferito, sulla difficoltà di trovare un linguaggio misurato - sembra una critica al suo Gothland - su come individuare il centro della vicenda e l’equilibrio degli spunti drammatici, su quali libertà ci si può permettere nella versificazione, su come arrivare a un finale soddisfacente senza che, scomparsi i personaggi più interessanti, nella scena restino solo i più noiosi; su come evitare gli estremismi e le esagerazioni. Ma quel che più sembra angosciarlo sono gli immensi salti di spazio e di tempo; si chiede addirittura se farli in quel modo smisurato non significhi «giocare con le forme teatrali» e cadere nel manierismo. Tutti problemi suoi, come si vede.) Se si mettono insieme le dichiarazioni di Terenzio in Hannibal e di Heinrich von Ofterdingen in Kaiser Friedrich Barbarossa si ha una precisazione delle dichiarazioni precedenti: nel suo mondo magico il poeta crea e nella realtà critica, quale rappresentante della moralità e della sensatezza delle azioni. Nella pratica artistica il modo in cui Grabbe pensò di assolvere questi compiti fu il mettere a rischio le forme, spingendole fino all’estremo che esse potessero sopportare. Ma non le soppresse. 83 Karl Georg Büchner nacque il 17 ottobre 1813 a Goddelau, vicino Darmstadt, allora capitale del Granducato d’Assia. Il padre Ernst era medico per antica tradizione familiare, la madre Caroline Reuß discendeva da una famiglia di funzionari che per secoli aveva risieduto in Alsazia; a Strasburgo si trovavano ancora parenti della madre, il che avrà la sua importanza nella vita di Georg. Questi era il primogenito; gli seguirono sette tra fratelli e sorelle, che furono tutte persone di successo nei settori della vita nei quali si impegnarono; oggi ricordiamo ancora il fratello Ludwig per la sua opera Kraft und Materie (Forza e materia, 1855), e in questa sede ricordiamo che ebbe anche i suoi meriti come editore delle opere postume di Georg. Per costui la famiglia restò sempre un fondamentale punto di riferimento affettivo e culturale. Nel 1816 i Büchner si trasferiscono nella capitale Darmstadt, a seguito dei progressi nella carriera del padre. La città contava allora circa 20000 abitanti. Non era moltissimo; Francoforte, città libera ai confini del Granducato, aveva 50000 abitanti. Ma soprattutto Darmstadt non era affatto una città vivace; viveva della burocrazia granducale, tanto che veniva chiamata Pensionopoli. Il regime era semiassolutista; nel 1820 era stata bensì promulgata una costituzione, ma essa non concedeva quasi nulla, a questa che era una delle 39 unità politiche in cui era stata smembrata la Germania dopo il Congresso di Vienna. Nel Granducato la miseria era grande, gran parte della popolazione attiva (si parla del 40-45%) doveva arrangiarsi per sopravvivere e far sopravvivere la famiglia. Chi possedeva un campo veniva stremato dalle tasse; la carestia del 1817-19 si fece perciò sentire molto. La rivoluzione del luglio 1830 in Francia si trascinò dietro una serie di sollevazioni in Europa. Nell’Assia esse cominciarono il 24 settembre, quando vennero incendiati gli uffici del dazio in Hanau, nei giorni seguenti quelli fra Hanau e Francoforte e poi via via in vari villaggi, finché il 30 le truppe governative repressero tutto in un bagno di sangue. I vincoli feudali ancora esistenti, le tasse, i dazi interni erano state le cause ultime delle sommosse. A quell’epoca Büchner ha quasi 17 anni; un anno ancora e terminerà la scuola. Da sei anni la famiglia ha acquistato e abita una grande casa, con un grande giardino. Büchner riceve il primo insegnamento elementare dalla madre, fino al 1822. In quest’anno passa a una scuola pubblica e poi dal 1825 al 1831 frequenta il ginnasio. La madre gli rende familiare la letteratura tedesca classicoromantica e le tradizioni popolari di canti e fiabe. Il padre aveva preso parte da giovane per cinque anni alle campagne napoleoniche, arruolato come sanitario; durante una parata ricevette un complimento da Napoleone, cosa che lo inorgoglì per tutta la vita. Dopo il congedo continuò i suoi studi a Parigi (li aveva cominciati in Olanda), quindi tornò in Assia, dove fece una brillante carriera. I figli ne conobbero le idee plasmate dall’illuminismo, ne conobbero lo spirito di tolleranza religiosa e la moderazione in politica. Era annoverato tra coloro che erano genericamente “all’opposizione”. In seguito però le attività politiche dei 84 figli, di carattere cospirativo come allora era inevitabile, e dunque pericolose, lo fecero non poco arrabbiare. Tra i libri che possedeva c’erano anche le annate della rivista “Zeitschrift für Staatsarzneikunde” sulla quale egli stesso pubblicò due saggi e dalla quale in seguito Georg trasse le informazioni di base per il Woyzeck. E c’era una compilazione in 36 volumi degli avvenimenti della storia contemporanea dal 1789 al 1830 (Johann Konrad Friedrich, Unsere Zeit – Il nostro tempo -, Stuttgart 1826-30), molti volumi della quale concernevano ovviamente la Rivoluzione francese. Era il libro preferito del padre, che spesso alla sera ne faceva pubblica lettura alla famiglia. Diventerà la fonte principale per Dantons Tod (La morte di Danton) del figlio Georg. Il quale frequenta scuole eccellenti, soprattutto per quanto concerne il settore umanistico. Non che fosse un idillio. Basterà ricordare quanto segue. L’insegnante di tedesco Karl Christian Baur non era per nulla amato da Büchner. Il sentimento deve essere stato reciproco; fatto sta che nel 1835 il vecchio insegnante reagì al capolavoro dell’ex allievo, Dantons Tod, pubblicando una poesia in cui accusava il dramma di non seguire regole, di essere nichilista, ateo, sensuale, sanculotto e via dicendo. Non si può nemmeno negare che avesse capito; ma aveva capito da maestrino. Dall’epoca scolastica sono conservati alcuni scritti dell’allievo Georg. A quest’epoca risale anche il frammento di un racconto dedicato al padre, una poesia per il compleanno della madre e una poesia dedicata per Natale a entrambi i genitori. Tutte e tre le composizioni risalgono al 1828; l’autore aveva 15 anni. Il 29 settembre 1830 Büchner tiene a scuola un Discorso in difesa di Catone l’Uticense. È solo un’esercitazione scolastica, è vero. Ma c’è stata la rivoluzione di luglio in Francia e sono in corso le sommosse in Assia; e Büchner parla della necessità di «intervenire nel corso della storia», di «lottare con il destino», non di rassegnarsi a esso; il suo Catone è uno che combatte per la libertà. Nell’ottobre 1831 Büchner termina la scuola. Per desiderio del padre si iscrive alla facoltà di medicina di Strasburgo (città di provenienza della madre), dove si reca però solo nel novembre, dedicando il tempo di mezzo a studi preparatori, per i quali aveva in casa tutti i mezzi necessari. A Strasburgo Georg frequenta la corporazione di studenti “Eugenia”, introdottovi dai fratelli Stoeber, destinati a diventare degli amici sempre più importanti. Nell’“Eugenia” si conducono anche discussioni politiche, documentate da un protocollo delle sedute. Büchner attacca la «corruttela dei giovani tedeschi» e la «innaturalezza delle condizioni sociali, soprattutto per quanto riguarda ricchezza e povertà», mostrandosi «un acceso, radicale repubblicano». Ma Büchner pare piuttosto isolato nelle sue posizioni. Comunque il suo radicalismo è agli atti. Non era però l’“Eugenia” il luogo in cui esso poteva svilupparsi. Quando Büchner tornerà in patria porterà con sé idee del primo socialismo, che non poteva certo aver appreso nella corporazione studentesca. Sulle sue fonti in materia non sappiamo niente di preciso; sono però possibili delle ipotesi. A Stra85 sburgo esiste una sezione di un movimento sparso per tutta la Francia: “Société des droits de l’homme”, alla cui testa sono studenti della stessa facoltà frequentata da Büchner: medicina. Segretario, anzi, ne è un parente dei già ricordati Stoeber. Questa, comunque, è un’ipotesi (e forse più che un’ipotesi, come si vedrà più in là) di come Büchner possa essere venuto a conoscenza sia delle idee vicine a quelle di Babeuf e di Louis Auguste Blanqui, sia di come si organizza una società segreta. Certo è che non è favorevole all’«aristocrazia del denaro», al potere in Francia dopo la rivoluzione di luglio. Altrettanto certo è che è informato sulle teorie di un’altra tendenza socialista, quella che risale a Saint-Simon: un saintsimonista popolare e un po’ buffo venne conosciuto da Büchner alla fine di maggio 1833, come raccontò lui stesso in una gustosa lettera ai genitori; è da sottolineare che Büchner dichiara di aver riconosciuto nel suo interlocutore un saintsimonista perché ha portato il discorso sulle donne in Germania: l’emancipazione della donna e il libero amore erano due dei principî del saintsimonismo. E a Strasburgo venne stampata e molto diffusa l’arringa che in un processo Blanqui aveva tenuto a propria difesa, in cui presenta la società come un meccanismo per lo sfruttamento del proletariato, di un meccanismo cui rapinare i proletari è indispensabile se vuole sopravvivere, e conclude con la necessità della rivoluzione contro l’«aristocrazia del denaro». È praticamente impossibile che Büchner non l’abbia letta. Intanto in Assia (come in altre parti della Germania) non sono ancora finiti gli effetti della rivoluzione di luglio. Il 27 maggio 1832 si arriva alla “festa di Hambach”: presso le rovine del castello di tale nome, nelle vicinanze di Neustadt, circa 30000 persone manifestano contro il feudalesimo ancora vigente negli stati tedeschi e contro la Restaurazione. Gli studenti di Gießen (una città che per Büchner diventerà presto importante) vi hanno mandato dei delegati; lo stesso hanno fatto gli artigiani. È da sottolineare che fra studenti e artigiani era avvenuto un avvicinamento già da vari mesi, occasionato da comuni dimostrazioni per la libertà della Polonia (che nel 1830-32 si era ribellata alla Russia, senza successo). Alcuni dei delegati parteciperanno in seguito alle attività cospirative di Büchner. A Butzbach, circa 16 km a sud di Gießen, è politicamente attivo il liberale Friedrich Ludwig Weidig (1791-1837), che presto rincontreremo. Alle varie attività e sommosse, che avvengono un po’ in tutta la Germania, c’è una risposta da parte dell’organismo centrale che è stato instaurato in seguito al Congresso di Vienna: il Bundestag, con sede a Francoforte, presieduto dall’Austria e costituito da delegati delle varie unità tedesche. Tra la fine di giugno e l’inizio di luglio esso promulga una serie di misure contro la stampa, le organizzazioni e le riunioni politiche. I circoli politici non disarmano e progettano un attacco alla caserma di polizia di Francoforte. Poiché diffidano dei borghesi e puntano sui contadini, si decide di aspettare la fine dei raccolti. Alcuni studenti di Gießen intraprendono a tal fine un’azione di propaganda fra i contadini. Qua e là nell’Assia si fa strada l’idea di passare a un’organizzazione cospira86 tiva, per esempio sul modello dei Carbonari. Il 3 aprile 1833 alle 21.30 ha infine luogo l’attacco progettato; esso viene respinto e represso in un’ora. Tra gli attaccanti ci sono nove morti, ventiquattro feriti gravi e gran quantità di arresti. La popolazione di Francoforte non si era unita agli attaccanti. Alcuni dei partecipanti erano stati compagni di scuola di Büchner e diventeranno suoi compagni politici. La sconfitta non arresta il formarsi di circoli cospirativi. Il 7 agosto 1833 Büchner lascia Strasburgo per completare gli studi in patria e secondo le leggi dell’Assia. A Strasburgo ha studiato, ha avuto la sua scuola politica («ne riportò idee molto rivoluzionarie», come dichiarerà in seguito uno studente di Gießen imprigionato); ed è nato l’amore: il diciottenne Büchner si è innamorato nella primavera del 1832 della figlia di un pastore protestante presso il quale egli alloggia: è la ventenne Wilhelmine Jaeglé. Büchner rivelerà il fidanzamento ai genitori solo per la Pasqua del 1834. I due non fecero in tempo a sposarsi e la sopravvissuta Wilhelmine non si sposò mai. Nel 1851 aprì a Strasburgo una scuola elementare per ragazze. Le testimonianze su di lei da giovane sono piene di lodi, non così invece quelle su di lei da donna anziana, descritta come ostinata e bigotta. Morì nel 1880. Il 31 ottobre 1833 Büchner si iscrive alla facoltà di medicina dell’università di Gießen. La cittadina fa 7000 abitanti, gli studenti sono 500. All’inizio Büchner vive isolato e manifestamente non si trova bene nel nuovo ambiente. Intanto studia. Segue anche corsi di filosofia (che sarà sempre una sua passione); per quanto risulta dai documenti, segue quelli tenuti nel semestre estivo dal prof. Joseph Hillebrand, un docente che aveva grande successo fra gli studenti; molto probabilmente però ha seguito anche quelli tenuti dal prof. Johann Bernhard Wilbrand, anatomista e filosofo. Tra i professori di Gießen va poi ricordata una celebrità: Justus Liebig. Di tutti costoro torneremo a parlare in occasione del Woyzeck. È testimoniato che a Büchner la vita goliardica non piaceva e che gli altri studenti lo trovavano antipatico, tanto più in quanto avevano subito capito in lui il rivoluzionario. Verso la fine di novembre Büchner si ammala e torna a Darmstadt per cinque settimane. Il 9 dicembre 1833 scrive di essersi gettato con tutto il vigore possibile nello studio della filosofia (Spinoza, forse?). Nel gennaio 1834 torna a Gießen. Da qui verso la fine del mese scrive alla fidanzata una lettera rivelatrice del groviglio e della passione dei pensieri che in lui si agitano: Già da qualche giorno prendo ogni momento la penna in mano, ma finora non sono riuscito a scrivere una sola parola. Ho studiato la storia della Rivoluzione. Mi sono sentito come annientato sotto il mostruoso fatalismo della storia. Trovo nella natura umana una spaventosa uniformità, nella condizione umana un’ineluttabile violenza, concessa a tutti e a nessuno. Il singolo, solo schiuma sulle onde; la grandezza, un puro caso; la sovranità del genio, una commedia di 87 burattini, una lotta ridicola contro una legge ferrea: riconoscerla è il massimo, dominarla impossibile. Non penso proprio più a inchinarmi dinanzi ai cavalli da parata e ai fannulloni della storia. Ho abituato il mio occhio al sangue. Però non sono una lama da ghigliottina. Il “bisogna” è una delle parole dannate con le quali è stato battezzato l’uomo. Il detto: «Bisogna che ci siano degli scandali, ma guai a colui che dà scandalo», è raccapricciante. Cos’è che in noi mente, uccide, ruba? Ma non voglio seguitare a pensarci. Invece seguita a pensarci e questi concetti trovano una loro realizzazione artistica nel Woyzeck sia nel Dantons Tod. Verso la metà di febbraio scrive in una lettera ai genitori delle parole che sembrano quasi un ritratto di Woyzeck fra due suoi persecutori (il capitano e il dottore): C’è una gran quantità di gente che, possedendo ridicole cose esteriori, cui si dà il nome di istruzione [= il capitano], oppure robaccia senza vita, chiamata scienza [= il dottore], sacrificano al loro sprezzante egoismo la gran massa dei loro fratelli [= Woyzeck]. Mai ricordato nella corrispondenza, mai menzionato da alcuna testimonianza, dalle carte che Büchner lasciò alla morte affiorò inatteso un dramma senza titolo (oggi lo conosciamo sotto un titolo editoriale, Woyzeck, dal nome del protagonista). A chi lo trovò esso apparve «quasi compiuto». Quasi compiuto e trovato solo dopo morte: bastò associare queste due constatazioni per convincersi che Büchner fosse stato impedito dalla morte a completarlo; se ne dedusse anche che bisognasse sforzarsi di vederlo proiettato verso il completamento, tanto più che il primo abbozzo aveva perfino un finale. Questo è stato forse l’equivoco più fecondo di tutta la storia della filologia: il primo editore del Woyzeck, lo scrittore slesiano Karl Emil Franzos (1848-1904), lo pubblicò (prima su rivista nel 1878, poi in volume nel 1879) contaminando i vari manoscritti e dando così ai frammenti un capo e una coda. In questa versione il testo andò in scena a Monaco l’8 novembre 1913, destando un’impressione enorme. Già nell’edizione a stampa e a maggior ragione con l’esecuzione teatrale Woyzeck fu fondamentale per scrittori e musicisti: Hauptmann, Rilke, Hofmannsthal, Heym, Brecht ne furono fortemente impressionati; Wedekind dichiarò che senza il Woyzeck non ci sarebbe stato nemmeno il suo Frühlingserwachen (Risveglio di primavera, 1891). A tutt’oggi l’edizione curata da Franzos ha una sua vita poiché attraverso qualche mediazione arrivò fino ad Alban Berg che ne ricavò il libretto della sua opera Wozzeck, composta fra il 1915 e il 1922, eseguita per la prima volta nel 1925. Insomma un fortunato, felice equivoco iniziale. Quando poi è durato, quell’equivoco è stato uno dei più esiziali della storia della filologia. Il Woyzeck è infatti il primo tentativo drammatico di Büchner, da lui cominciato a Gießen l’8 dicembre 1833, continuato a Darmstadt fino al 20 luglio 88 1834, e quindi lasciato cadere per ragioni che non sappiamo. Cosa particolarmente notevole: esso venne scritto contemporaneamente allo Hessischer Landbote (Il messaggero dell’Assia), lo scritto politico di cui parleremo tra poco, e accompagna l’attività cospirativa di Büchner. Sarà dunque opportuno fermarci su questa prima di affrontare il Woyzeck. Tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio Büchner fa la conoscenza del già ricordato Weidig, rettore della scuola latina di Butzbach e instancabile animatore di circoli di opposizione. Weidig era favorevole a uno stato nazionale che superasse i particolarismi feudali; pare che propendesse per la repubblica ma non chiudeva la porta ai fautori della monarchia costituzionale; cercava insomma una vasta base di consensi. Era stato uno dei promotori decisivi dei fatti di Francoforte. E in generale con pubblicazioni, prediche, attività pubbliche e attività cospirative era una forte presenza. I consensi che seppe conquistarsi furono tanti che al suo arresto, quando ci si arrivò (fine aprile 1835), si procedette di notte e dopo aver fasciato con dei panni gli zoccoli dei cavalli perché la popolazione del villaggio in cui era stato mandato per punizione a fare il parroco non si accorgesse di nulla e non lo difendesse. Molto moderato agli inizi, la lotta lo rese man mano più radicale. Büchner non riteneva matura una rivoluzione (e aveva dato un severo giudizio dei fatti di Francoforte). Certamente essa non doveva essere intrapresa da un pugno di liberali bensì dalla «grande massa del popolo»; occorreva perciò conquistarla attraverso un’adeguata propaganda. La grande massa era costituita, secondo Büchner, dalla popolazione agraria, che sopportava in sostanza tutte le spese; questa poteva essere interessata a una rivoluzione, che non doveva certo stabilire un’«aristocrazia del denaro, come in Francia» era accaduto con la rivoluzione di luglio. Insomma Büchner metteva all’ordine del giorno il contenuto sociale dello Stato. All’inizio del marzo 1834 vengono rilasciati i suoi ex-compagni di scuola dei tempi di Darmstadt, arrestati per i fatti di Francoforte e ora di ritorno a Gießen come studenti. Con loro Büchner ritrova il contatto. Già tra il 6 e l’8 marzo intraprende i passi per fondare con loro una sezione della “Società per i diritti dell’uomo”. Qualcuno ricevette l’impressione che Büchner fosse appartenuto all’analoga sezione di Strasburgo; ma anche in caso contrario, certo egli ne copiò l’organizzazione. Con Weidig si mette d’accordo per scrivere un opuscolo di propaganda, che è pronto già alla fine di marzo. Dopodiché Büchner torna a Strasburgo per le vacanze di Pasqua. Ve lo richiama l’amore (per lettera comunica da Strasburgo ai genitori di essersi fidanzato; il padre s’infuria), ma a Strasburgo può anche constatare l’accresciuto diffondersi delle idee comuniste risalenti al pensiero di Babeuf e, più direttamente, di Filippo Buonarroti. Intorno alla metà di aprile, Büchner torna a Darmstadt, dove fonda una seconda sezione della “Società per i diritti dell’uomo”, che arrivò a contare undici membri (all’inizio: tre studenti e tre artigiani). Così come l’impostò Büchner, era 89 un’associazione comunista, senza esitazioni. Alla fine di aprile Büchner torna a Gießen, dove dà gli ultimi ritocchi sia all’opuscolo di propaganda già abbozzato, sia alla locale sezione della “Società”, con nove membri: sette studenti, due artigiani. (La sezione di Gießen visse solo otto settimane perché i membri si divisero, aderendo gli uni a un’associazione studentesca, gli altri a un’unione artigiana. Büchner restò solo con due compagni.) Un amico trascrive l’opuscolo di Büchner perché l’originale era illeggibile (ahimè, la cosa vale anche per i manoscritti del Woyzeck!) e lo porta a Butzbach da Weidig. Questi osserva che «le invettive contro i ricchi» sono troppo violente e che i virulenti attacchi all’opposizione moderata alienerebbero i «rivoluzionari costituzionalisti»; perciò occorrono dei cambiamenti. Weidig operò pertanto questi cambiamenti, aggiunse una premessa, una conclusione e la maggior parte delle citazioni bibliche che oggi si leggono in quell’opuscolo. Gli diede anche un titolo: Der hessische Landbote. Il manoscritto di Büchner non si è conservato, per cui la collazione è impossibile. Sappiamo però che Büchner si arrabbiò molto per le soppressioni e le modifiche apportate da Weidig e non voleva più riconoscere l’opuscolo come suo. Oggi si propende a credere che la prima parte sia più o meno sua e la seconda invece sia soprattutto di Weidig. Comunque per i tempi l’opuscolo risultò più che incendiario; anche i liberali lo respinsero e videro che esso mirava a quella che nel loro linguaggio chiamarono «totale anarchia». Weidig soppresse la parte in cui Büchner attaccava l’aristocrazia del denaro. Büchner aveva usato frasi evangeliche per difendere i diritti sacri dell’umanità, Weidig invece utilizzò la Bibbia sia per assimilare all’eresia l’egoismo degli abbienti sia per assicurare l’esito religioso degli sforzi comuni (si tengano a mente queste cose per quando dovremo parlare delle citazioni bibliche nel Woyzeck), stabilendo una triade di tradizione romantica nell’interpretazione della storia (prima la libertà degli antichi Germani, poi il peccaminoso allontanarsi da essa, quindi rinascita del popolo nel futuro paradiso repubblicano). Ma occorre ribadire che il testo complessivo risultò indigeribile per il sistema statale dell’epoca; quel che Büchner aveva scritto contro il sistema fiscale (definito senz’altro un furto), legale (sfruttamento legalizzato) e sociale (classe alta come parassita delle classi inferiori) restò. Restò tanto che un congiurato ebbe l’impressione di un testo basato su un qualche scritto francese, perché era troppo rivoluzionario per la cultura tedesca. L’instancabile Weidig viaggiò da metà maggio alla metà di giugno per tutta l’Assia a preparare una riunione di oppositori per il 3 luglio nelle rovine del castello di Badenburg (tra Gießen e Marburgo), sempre mirando a una vasta coalizione. I delegati che vi parteciparono, approvarono l’opuscolo nella versione da lui rivista; Büchner (che era fra i partecipanti) rimase in minoranza, però non si tirò indietro. Tra il 5 il 9 luglio lui stesso, insieme con un altro congiurato, portò a Offenbach il manoscritto da stampare clandestinamente. Verso la fine di luglio ne erano pronte tra le 1200 e le 1500 copie. Subito cominciò la diffu90 sione, ma già il 1° agosto venne arrestato uno studente che ne portava con sé 139 copie: c’era stata la spiata di un traditore, che in Büchner sospettò anche l’autore dell’opuscolo. Pertanto il 4 agosto venne perquisita la sua stanza, sequestrate alcune lettere e sigillato l’armadio. Büchner non è presente alla perquisizione; è in giro ad avvertire i congiurati di quel che sta succedendo. Al ritorno trova una convocazione. Si presenta dal giudice e, con freddezza e cortesia (così scrive lui stesso), gli chiede: «Ho saputo che durante la mia assenza ha onorato la mia camera di una Sua visita; vengo a chiederle il motivo di tale benevolenza.» Dopodiché chiede e ottiene che siano tolti i sigilli e gli vengano restituite le lettere. Non contento, si rivolge al comitato disciplinare dell’Università, protestando contro la perquisizione. Comunque non viene arrestato, sia che a suo carico non ci sia ancora niente di preciso, sia (come pare) che lo si voglia lasciar provvisoriamente libero per motivi tattici. La diffusione del Landbote riprese. In novembre se ne fece anche una seconda edizione di 400 copie, ancora più addomestica della precedente. La diffusione toccò nel complesso più di venti località. Lo scopo che Büchner si poneva era, come già detto, di conquistare le masse e intanto sondare la loro disponibilità a una propaganda rivoluzionaria. All’inizio di settembre torna a Darmstadt «per desiderio del padre», e vi resta per tutto il semestre invernale. Intanto la polizia stava indagando sulla “Società” e a poco a poco stava scoprendo quasi tutto. Questo dunque è il contesto nel quale viene scritto il Woyzeck. La vicenda si basa su vari fatti di cronaca, ma soprattutto su quello di Johann Christian Woyzeck, che nel 1821 aveva ucciso a Lipsia la donna con cui aveva una relazione e che era stato lì giustiziato nel 1824. Il caso aveva fatto scalpore. Alla base c’era una storia di miseria, di disperazione e di degradazione estrema. Ciò che aveva suscitato clamore intorno al caso non era stata però la dimensione sociale ma la questione giuridica; si era cioè discusso ampiamente se l’omicida poteva essere considerato capace di intendere e di volere, e quindi imputabile, oppure no. Il concetto discendeva dal codice napoleonico e per la giustizia sassone costituiva un problema tutto sommato nuovo e interessante. La perizia medico-legale che portò all’esecuzione venne pubblicata su una rivista alla quale collaborava anche il padre di Büchner. Il figlio a sua volta scrive nel suo dramma delle frasi ricalcate su alcune espressioni della perizia (rispetto alla quale sono citazioni appena appena variate) e in generale mostra di conoscere la perizia assai bene; dunque il caso emerge da quella che Büchner poteva considerare la rivista del padre. I cambiamenti che egli apporta alla vicenda sono anch’essi interessanti: la vicenda viene trasportata da Lipsia in una cittadina che non riceve un nome ma nella quale non si fa molto sforzo a riconoscere Gießen; e vi vengono satireggiati professori di quella università già ricordati: Justus Liebig (proprio lui, quello dei dadi da brodo) e uno che oggi è completamente 91 dimenticato, Johann Bernhard Wildbrand: costui costringeva a lezione il proprio figlio a sventolare le orecchie, per portarlo a esempio di certe sue astruse teorie. Si noti: padre e figlio; questo episodio viene ricordato in un abbozzo di scena non particolarmente riuscito e non inserito nel complesso delle scene del dramma, quasi che il rapido sfogo sia stato sufficiente a scaricare la tensione personale. Il dramma è scritto in una lingua che ogni lettore di Gießen o di Darmstadt può tradurre con estrema facilità nel proprio dialetto: questo almeno viene asserito da chi quel dialetto lo parla. Il Woyzeck è di un radicalismo e di una violenza quali raramente si conoscono nella letteratura. Del dramma Büchner scrisse un primo abbozzo completo, nel quale la sua attenzione si appunta maggiormente sui fatti (sulla gelosia, sull’omicidio) e molto meno sulle ossessioni e allucinazioni del protagonista. Negli sviluppi successivi (due, entrambi interrotti) proprio queste vengono sviluppate e messe in risalto, mentre fanno la loro comparsa i persecutori di Woyzeck, un medico e un capitano; Woyzeck assume i contorni di personaggio perseguitato, deriso, allucinato, che parla poco ma quelle poche volte è tagliente. Il dramma è costituito da una serie di scene nel collegare le quali Büchner ha saltato (sempre di più, man mano che la materia si sviluppava) i possibili collegamenti esteriori. Presumibilmente il dramma era pensato come atto unico; in ogni caso manca una divisione in atti. Il testo ha cospicue ascendenze letterarie. Sono stati fatti molti nomi: Lenz, Goethe, Jean Paul, Grabbe e altri ancora. In alcuni casi sono state riconosciute dipendenze puntuali: per esempio Marie che in un pezzetto di specchio si contempla gli orecchini donatile dal Tambur maggiore ricorda la Margarethe del Faust nella scena dei gioielli (anzi nel primo abbozzo Marie si chiamava addirittura Margreth). Ma tutto ciò non deve far dimenticare la grande originalità di Büchner; nel caso specifico, sarebbe fuorviante assimilare questi due personaggi femminili. Degli altri accostamenti ricordati è opportuno dire che esisteva una tradizione da cui Büchner (consapevolmente o no) poteva attingere sia per sviluppare la sua tendenza a porre come protagonista quel Woyzeck dalle disperate condizioni sociali, economiche e culturali - e allora è forse Lenz l’autore da mettere in risalto (pur di aggiungere che tale sviluppo arriva a estremi mai prima conosciuti) - sia per essere spinto a quelle arditezze formali che faranno la fortuna del Woyzeck come spinta al superamento del naturalismo. Di particolare interesse è la massiccia presenza di citazioni bibliche, attraverso le quali la vicenda di Woyzeck e Marie viene di volta in volta anticipata e commentata. Büchner era scettico in materia di religione e il suo Woyzeck non vive certo secondo precetti di chiesa. Eppure in bocca a Marie viene messa una citazione dalla I epistola di Pietro, che nel suo contesto suona così: «anche Cristo ha patito per voi, lasciandovi un esempio, onde seguiate le sue orme; egli, che non commise peccato e nella cui bocca non fu trovata alcuna frode» (II, 2122; ho sottolineato le parole citate nel Woyzeck). Non è garantito che in tal modo 92 Woyzeck venga paragonato a Cristo (come è stato supposto); il contesto del dramma suggerisce piuttosto di intendere: non ingannare nessuno, così come Cristo non lo ha mai fatto. Ma il riferimento a Cristo e alla sua passione si ha anche in una scena in cui Woyzeck fa una specie di testamento, così che il sospetto della sua assimilabilità a Cristo si fa insistente: a un Cristo di passione, accompagnato da tante allusioni all’Apocalisse. Il Cristo che perdona l’adultera, il Cristo che lascia venire a sé i pargoli viene invocato, ma il destino di Woyzeck e Marie, vittime di un’ingiustizia infinita, segue il suo corso. Un confronto con le opere successive aiuterà sia a capire meglio sia a mostrare i cambiamenti che avverranno in Büchner. Le opere che si mettono ora a confronto sono il dramma storico Dantons Tod (inizio del 1835) e la commedia Leonce und Lena (1836). L’argomento del dramma è suggerito dal titolo: racconta gli ultimi giorni di vita di Danton e del suo gruppo, fino alla ghigliottina. Della commedia è quasi impossibile dare un qualunque riassunto senza svilirla: un principe e una principessa, che non vorrebbero sposarsi, invece si sposano; ma il lettore abbia pazienza fino al momento in cui tratteremo di quelle opere teatrali per saperne di più. Nel frattempo ne toccheremo solo alcuni temi. Nel Dantons Tod c’è una controversia sui principî della morale. Danton stesso nega che compito della politica sia stabilire la virtù e punire il vizio; anzi nega il concetto stesso sia di virtù sia di vizio e quindi nega la riconoscibilità di un principio sulla base del quale regolare il mondo. Robespierre gli oppone la coscienza, che ci rivelerebbe sia l’essere sia la virtù nella loro purezza. Replica Danton: la coscienza ci rinvia soltanto la nostra immagine; noi dunque ci facciamo belli come scimmie e ci poniamo davanti a uno specchio costruito da noi stessi; non esiste un luogo in cui l’assoluto si riveli. Ne consegue che ciascuno ha il diritto di comportarsi secondo la propria natura; chi la segue e la realizza è un epicureo: infatti quanto più la sua natura è nobile, tanto più belle saranno le sue azioni, ma anche tanto maggiore il suo piacere. L’importante è che non danneggi gli altri. La morale viene dunque intesa non come obbedienza a principî ma come sviluppo delle forze proprie dell’uomo; non come ottemperanza a precetti ma come creatività. Compito della morale - e della politica - è assicurare lo spazio entro il quale le forze libere possano svilupparsi. Entro questa prospettiva i dantonisti si richiamano alla natura; la loro tesi è sintetizzata in queste frasi: Ciascuno deve potersi far valere e imporre la propria natura. (I,1) Che volete voi con la vostra morale? Non so se ci sia un bene o un male in sé e non ho bisogno per questo di cambiare il mio modo di agire. Io agisco secondo la mia natura, quel che le è adeguato è bene per me e lo faccio, quel che le va contro è per me male e non lo faccio, anzi mi difendo se mi attraversa il cammino. (III,1) 93 Anche Woyzeck parlava della natura; ma quanto è diverso: Sì, signor capitano, la virtù! Non è che ci capisca tanto. Vede, noi poveracci non abbiamo virtù; ti viene solo la natura. Ma se fossi un signore, con un cappello, un orologio, un bel cappotto e sapessi parlare bene, allora mi piacerebbe avere la virtù. Dev’essere una bella cosa la virtù, signor capitano. Ma io sono un poveraccio. La natura libera e creatrice, di cui parleranno i dantonisti, per Woyzeck non è nemmeno pensabile; lui non può permettersi il lusso di quelle argomentazioni. E il concetto di libertà può suonargli come una presa in giro quando è a colloquio non con il capitano, che non sa mettere due parole in fila e al quale è rivolta la battuta precedente, bensì con il dottore. Questi conduce su Woyzeck degli esperimenti: lo sottopone a un’alimentazione di soli piselli per vedere (come interpreta uno studioso) fino a che punto di sottonutrizione e di avvelenamento può essere sottoposto un uomo. Come criterio di misurazione il dottore usa l’analisi delle urine; dunque per contratto si è assicurato l’urina di Woyzeck e si indigna quando vede il suo soggetto fare la pipì contro un muro invece che nella provetta. Woyzeck gli risponde che ce lo ha spinto la natura, ma a questa risposta il dottore si indigna ancora di più: Non ho forse dimostrato che il musculus constrictor vesicae è sottoposto alla volontà? La natura...! Woyzeck, l’uomo è libero, nell’uomo l’individualità trascende a libertà. Parlare di libertà a un uomo che per vivere è costretto a fare l’animale da laboratorio non è molto credibile. La generalizzazione che Büchner farà esporre dai seguaci di Danton non risponde alla seguente domanda: quale natura e quale libertà restano a uno come Woyzeck? I discorsi dei dantonisti emergono quando la rivoluzione è comunque fallita e quando su di essa pesano tanti crimini, sia quelli di Danton (le stragi di settembre) sia quelli di Robespierre. Inoltre Dantons Tod si pone il problema di come giustificare l’azione e il suo rapporto con le conseguenze imprevedibili o almeno impreviste: si vorrebbe la felicità umana e il risultato è un sistema fatto di cadaveri. Quelle teorie sulla morale sono una correzione teorica, ma quando si sta al pratico che cosa se ne fa un uomo nelle condizioni di Woyzeck? Sia nel Dantons Tod sia in Leonce und Lena Büchner mette in bocca ad alcuni personaggi una specie di sogno nichilista: i sistemi filosofici inumani vanno abbandonati e al loro posto va patrocinata la libera realizzazione delle capacità umane, senza vincolarle preventivamente a concezioni rigide. Danton stesso esclama: «Il mondo è il caos. Il nulla è il dio mondano che va fatto nascere.» (IV,5). Questo è un abbozzo di programma. Nella commedia seguente se ne 94 può fingere una qualche realizzazione, come è appunto lecito a una commedia, nei modi e negli spazi che le sono propri. Leonce parla dunque anche lui di caos e di creazione, non più come programma ma come cose già in atto: «Con che respiro fresco e che splendore di bellezza la creazione si libera dal caos e mi corre incontro!» (II,4). Per la verità tutto, alla fine, viene smascherato come teatro, pura messa in scena, e quindi si suggerisce che la realizzazione in realtà non c’è stata; però a tratti il bel sogno è parso possibile. Alla fine della commedia viene invocata una «religione comoda». Woyzeck aveva risposto nel modo seguente al capitano che l’aveva rimproverato di aver fatto un figlio «senza la benedizione della chiesa»: Signor capitano, il buon Dio non starà a guardare se per quel passerotto abbiamo detto una preghiera prima di farlo. Il Signore ha detto: «Lasciate che i pargoli vengano a me.» Questa forse sarebbe una «religione comoda». La differenza è che chi la invoca alla fine della commedia è già diventato presidente del consiglio o giù di lì e la inserisce nel suo programma di governo; tutto quel che aveva ottenuto Woyzeck, che ministro non diventa davvero, era stata invece la scandalizzata reazione del capitano: Che razza di risposta è questa? Mi confondete tutto, con questa risposta. Nel Dantons Tod si parla di una filosofia inumana, che però sembra anche superabile attraverso il «Dio nulla»; in Leonce und Lena la stessa filosofia viene messa alla berlina in una straordinaria scena in cui la espone il re Peter mentre si veste, confrontando i fondamenti del sistema con i capi del suo abbigliamento. In Woyzeck era stato il capitano a esporre la sua filosofia. Eccone i tratti essenziali: Mi prende una gran paura per il mondo, quando penso all’eternità. Eterno: questo è eterno. Questo è eterno, è chiaro, no? Adesso però non è più eterno e questo è un attimo, sicuro, un attimo. Morale è quando uno è morale, capito? La virtù, la virtù! Se no come farei ad ammazzare il tempo? Insomma, il capitano non è un gran pensatore; è solo un piccolo tiranno. Ma per Woyzeck è sufficiente. Il sistema filosofico si è ridotto a quelle due stupidaggini; e se fossimo in una commedia ci sarebbe da ridere. Qui però ride solo il capitano, a spese di Woyzeck. Il capitano non è Robespierre, il suo sistema filosofico non decide i destini di un grande paese; non è nemmeno re Peter, quindi non decide nemmeno i destini di un microscopico regno da operetta. Però il sistema di dominio è diffuso capillarmente, si riproduce in ogni cellula della so95 cietà, i tiranni e le vittime si moltiplicano a ogni rapporto sociale. Le grandi soluzioni appaiono lontane. Peggio ancora stanno le cose con la scienza. Si sa che uno dei miti della Rivoluzione francese era stata l’interpretazione scientifica della realtà, sia nel campo delle scienze naturali sia negli altri. E nel Dantons Tod Büchner mette in bocca a Saint-Just uno straordinario discorso in cui, fra le altre cose, emerge anche questo mito, sotto forma di paragoni con i fenomeni naturali (un tema diffuso ampiamente nella cultura - tedesca e non solo tedesca - tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento: basterà ricordare che anche Goethe nel Faust II spiega la rivoluzione attraverso paragoni con le scienze naturali). Nel Woyzeck la scienza era impersonata dal dottore: «C’è una rivoluzione nella scienza, io la faccio saltare in aria!» E tutte e due, scienza e filosofia, si mostrano come sistemi di dominio. Si potrebbe andare avanti nel confronto tra le opere drammatiche di Büchner. E per esempio mostrare che la visione provvidenzialistica del mondo, esposta con serietà da un personaggio nel Dantons Tod (III,7) e lì strapazzata dallo stesso Danton, si presenta già nel Woyzeck come parodia fattane da un ubriacone che filosofeggia con la bottiglia (un suggerimento che sarà esplicito in Leonce und Lena, mentre nel Woyzeck l’autore trova in questa eco della voltairriana parodia della fisico-teologia la provvisoria conclusione di un suo proprio ragionamento sul determinismo spinoziano): perché c’è l’uomo? In verità in verità vi dico, come avrebbero fatto a vivere il contadino, lo scopettaio, il calzolaio, il medico, se Dio non avesse fatto l’uomo? Come avrebbe fatto a vivere il santo se Dio non avesse dato all’uomo la vergogna? o il soldato, se Dio non avesse fornito all’uomo il bisogno di ammazzarsi? A settembre Büchner torna a Darmstadt, dove per desiderio del padre resta durante il semestre invernale. Nella sua città riorganizza la “Società per i diritti dell’uomo” e riprende lo studio della Rivoluzione francese. Lavora anche in un laboratorio del padre, tenendo inoltre lezioni di anatomia per giovani che si preparano allo studio della medicina. A metà gennaio 1835 comincia a scrivere il dramma Dantons Tod, che termina il 21 febbraio, dopo cinque settimane. Terminato il dramma, Büchner pensa di ricavarne qualche soldo. Spedisce quindi il manoscritto all’editore Sauerländer di Francoforte. Una lettera però andò anche a Karl Gutzkow. Questi dirigeva all’epoca la sezione letteraria della rivista “Phoenix”, pubblicata dallo stesso editore. A Büchner dovevano esserne note le idee repubblicane. Il drammaturgo, che non conosceva personalmente il critico, lo pregava di appoggiarlo presso l’editore, «se la coscienza di critico glielo permetteva». Gutzkow lo fece, e con successo. Pregò però Büchner di voler acconsentire ad attenuare le parti più scabrose per evitare le ire della censura e così convincere definitivamente l’editore; a questo scopo era disposto a venire a 96 Darmstadt. Noi però sappiamo in quali circostanze era stato scritto il dramma; e quindi non ci meraviglieremo di quella che pare sia stata la risposta dell’autore: facesse un po’ lui. Il 7 marzo arriva un’altra lettera di Gutzkow con il compenso dell’editore (cento fiorini); Büchner non riceve né l’una né l’altro: è scappato la notte prima. Il dramma verrà pubblicato, prima in una selezione sulla “Phoenix” dal 26 marzo al 7 aprile, poi in volume nel luglio (la tiratura è di 400 copie), con cambiamenti (cioè addolcimenti) che a Büchner non piaceranno per niente ma che non basteranno nemmeno un po’ a tacitare recensori, diciamo così, pudichi. A ogni buon conto il manoscritto si è conservato e si è potuto ripristinare tutto. È un dramma in quattro atti, dal linguaggio fortemente metaforico; poiché, come già nel Woyzeck, i collegamenti esterno fra le scene sono ridotti al minimo, ad assicurarli c’è proprio il tessuto linguistico: una battuta ripresa o variata, un’opposizione, un parallelismo. Per tutto il dramma si dibatte sul valore e la responsabilità dell’intervento umano nella storia. In un colloquio fra i due antagonisti Danton e Robespierre il primo nega che un sistema statale possa proporsi di punire il vizio; anzi nega sia il concetto di vizio sia quello di virtù. Robespierre gli oppone la coscienza, dalla quale si dovrebbero attingere l’essere e la virtù nella loro purezza. Replica Danton che la coscienza ci rinvia soltanto la nostra immagine; noi ci facciamo belli come scimmie per porci davanti a uno specchio costruito da noi stessi. Ne consegue che ciascuno ha il diritto di comportarsi secondo la propria natura. Chi la segue e la realizza è un epicureo; quanto più la sua natura è nobile, tanto più belle saranno le sue azioni, tanto maggiore il suo piacere. L’importante è che non danneggi gli altri. La morale viene dunque intesa non come obbedienza a principî ma come sviluppo delle forze proprie dell’uomo; si è compiuto, col nichilismo büchneriano, il passaggio da una concezione della morale come ottemperanza a una morale come creatività. Compito della morale - e, si aggiunge nel dramma, della politica - è assicurare lo spazio entro il quale le forze libere possano svilupparsi. Robespierre ha i suoi dubbi, così come Danton (il Danton delle stragi di settembre) ha le sue colpe. Ma ai dubbi Robespierre non cede; egli porta fino in fondo il tentativo compiuto dai pensieri per farsi carne, pur avendo dubbi sulla propria stessa sincerità e infine sull’utilità delle sue azioni rispetto alla salvezza, al dominio della virtù, addirittura alla redenzione cui pure mirano. Robespierre è un sistematico; ma di sistemi costruiti con teschi umani. Ma questi discorsi, per quanto importanti nel loro contenuto, non danno ancora un’idea del dramma, che si segnala per l’arditezza del linguaggio, per il vigore delle situazioni drammatiche e per la rapidità dei passaggi da una scena all’altra; ecco dunque una citazione, che dà un’idea almeno del linguaggio: ROBESPIERRE. La rivoluzione sociale non è ancora finita, chi fa una rivoluzione a metà si scava da sé la propria fossa. La buona società non è ancora 97 morta, la sana forza popolare si deve mettere al posto di questa classe rovinata in ogni senso. Il vizio dev’essere punito, la virtù deve dominare per mezzo del terrore. DANTON. Io non capisco la parola punizione. Tu, con la tua virtù, Robespierre! tu non hai preso danaro, tu non hai fatto debiti, non hai dormito con una donna, hai sempre portato un vestito decente, non ti sei mai ubriacato. Robespierre, sei di una rettitudine rivoltante. Io mi vergognerei di correr per trent’anni fra cielo e terra sempre con la stessa fisionomia morale, solo per il gusto di trovare gli altri peggiori di me. Ma non c’è dunque niente in te che qualche volta, sottovoce, segretamente, ti abbia detto: «Tu menti, menti!»? [...] ROBESPIERRE. Neghi dunque la virtù? DANTON. E il vizio. Ci sono soltanto epicurei a questo mondo, chi rozzo e chi fine, e Cristo fu il più fine; e questa è l’unica differenza che io riesco a trovare fra gli uomini. Ognuno agisce secondo la propria natura, vale a dire «fa quel che gli piace». Vero, Incorruttibile, che è crudele ferirti così nel tuo tallone d’Achille? ROBESPIERRE. Danton, in certi momenti il vizio è alto tradimento. Nel secondo atto c’è una grande scena metaforica di teatro nel teatro. Essa si svolge in una strada e il teatro che ci viene mostrato è quello delle classi sociali; Danton vi fa da spettatore, un po’ affascinato e un po’ respinto dalla finzione teatrale. Aprono la scena alcuni sanculotti presto interrotti da un cantastorie; segue un mendicante, quindi due signori ben vestiti (e il loro vestito assurge a simbolo nella conversazione col mendicante), quindi ancora prostitute e soldati. Compare quindi lo spettatore Danton, che sembra preso d’amore per la vita. Ma perché il lettore non pensi a qualche atteggiamento sentimentale, eccogli subito detto come si esprime Danton: DANTON. Non è divertente tutto ciò? Sento qualcosa nell’atmosfera; è come se il sole covasse lussuria. Non verrebbe voglia di saltar lì in mezzo, strapparsi i calzoni e accoppiarsi per di dietro come cani in strada? [...] DANTON (a Camille). Non aspettarti da me niente di serio. Io non capisco perché la gente non si ferma per la strada e non si ride in faccia. Credo che le loro risa dovrebbero sprizzare dalle finestre e dalle tombe e il cielo 98 crepare e la terra torcersi dal ridere. In un secondo commento Danton mette in risalto la finzione dello spettacolo; dunque si è innamorato di una finzione, ma per quanto si sappia che lo spettacolo è menzognero, l’amore per la vita è più forte. Tra un commento e l’altro di Danton compare un terzetto, presumibilmente di aristocratici; essi fanno discorsi molto vicini a quelli dei sanculotti dell’inizio. Questi rapporti sociali così intricati e artificiali e per di più tutti basati sulla menzogna possono essere fatti saltare in aria con facilità. Così, riferendosi all’ultima commedia che si dà a teatro, un signore si esprime su questa «torre di Babele». A starci in mezzo però si viene colti dalle vertigini. Il rapporto col mondo è in pericolo. Gli uomini potrebbero ridersi in faccia invece di prendere sul serio le proprie parti. Quello che sembra così certo e naturale cela abissi: Già, la terra è una crosta sottile, io penso sempre di poter cadere dentro un buco di questi. La metafora del teatro collega altre scene: Camille Desmoulins ne farà uso e, come previsto da Danton, in questo spettacolo, che trasportato dal teatro alla strada mostra tutta la sua povertà, tutti loro morranno sul serio. La svolta della vicenda sarà segnata da un discorso di Saint-Just. Contrariamente ai discorsi di Robespierre e ai vari episodi del dramma, il discorso di Saint-Just non ha corrispondenza nelle fonti; Büchner vi ha concentrato una serie di concetti rivoluzionari, propri non soltanto dei giacobini ma anche dei girondini; l’idea della rivoluzione come accelerazione della storia la si trova, per esempio, nei girondini Condorcet e Mercier. Saint-Just, come già accennato, fonda il suo discorso sul rapporto tra natura fisica e natura morale e sugli effetti che le idee esercitano nel fisico. La natura fisica (argomenta) segue imperturbabile e irresistibile le proprie leggi; quando queste comportano dei cambiamenti nell’assetto esteriore, l’uomo paga con migliaia di morti. La natura morale obbedisce a leggi analoghe a quelle della natura fisica; il loro effetto comporta cambiamenti e i cambiamenti costano morti. La rivoluzione è solo l’accelerazione di tali effetti morali. Dunque Saint-Just non ha né i dubbi di Danton né quelli di Robespierre. Esistono leggi certe dell’azione, scientifiche come quelle della natura. Esiste un soggetto certo: Lo spirito universale si serve, nella sfera spirituale, delle nostre braccia, così come in quella fisica usa vulcani e inondazioni. Non c’è più posto né per i nottambuli di Robespierre né per il nulla di Danton. Per Robespierre la traduzione del pensiero in atto era pur sempre un problema; il rapporto tra azione e fini correva pur sempre il rischio del rinnegamento e della menzogna. Per Danton era il concetto stesso di legge a risultare inso99 stenibile. Per Saint-Just invece c’è la certezza della scienza, quella che HéraultSéchelles chiamava «la meccanica dell’orologiaio ginevrino». Per Hérault stesso la natura era un’altra cosa: era la forza interna del singolo. Per lui e per Camille essa non va interpretata ma va fatta agire nella sua spontaneità, col solo limite di non danneggiare gli altri; la forma statale deve essere il risultato di questo agire, incontrollabile, imprevedibile e libero, non una camicia di forza o un vestito al quale far adattare il corpo. Per Saint-Just invece la natura è definita, interpretata e prevista sulla base di leggi; dunque la si può accelerare, il che vuol dire dirigerla alla meta. Dunque esiste una conoscibilità certa e scientifica di tutta la natura, dunque esiste una sostanza nella morale e nella storia, che il rivoluzionario si limita a interpretare e a tradurre in azione. Siamo evidentemente agli antipodi. È ora il caso di vedere più da vicino il nichilismo di Danton e del suo gruppo, nel suo valore di proposta libertaria, vitale e ottimistica. I suoi punti principali sono i seguenti: 1. Contro il concetto di morale deduttiva e pertanto imperativa; le viene contrapposta una morale creativa secondo la citazione precedente. 2. Contro la razionalità della storia intesa come costante progresso in cui anche gli errori hanno funzione positiva e la morte non avviene invano poiché semina qualcosa che in seguito certamente maturerà. Danton liquida nel modo seguente tale concezione dialettica: DANTON. Una prospettiva edificante! Da un mucchio di letame all’altro! Proprio la divina teoria delle classi, vero? Dalla prima alla seconda, dalla seconda alla terza e così via? Ne ho abbastanza di questi banchi di scuola, mi hanno fatto venire i calli sul sedere, come alle scimmie. (III/7; 61, 1-5) 3. Contro la stessa razionalità intesa come identità di ragione e potere popolare. Al contrario quella che si chiama la sana ragione è fatta di idee fisse (cioè di pazzia) generalizzate. 4. Contro il concetto di Dio e di sistema. Il primo si regge solo sul concetto di perfezione e quindi di assenza di imperfezione. Ma ecco l’obiezione: Si può negare il male ma non il dolore; solo l’intelletto può dimostrare Dio, il sentimento invece protesta indignato. Fa attenzione, Anassagora, perché mai soffro? Questa è la rocca dell’ateismo. (III/1; 48, 34-37) 100 Applicato alla storia, questo pensiero ribadisce la negazione della tesi che tutto in qualche modo possa rientrare in una concezione armonica del divenire umano, in cui anche il dolore abbia una sua funzione positiva. Pensare una cosa del genere è immaginarsi una divinità che gode delle urla e gli uomini come strumenti di un divertimento crudele. Dunque la storia umana non può essere l’effondersi di una sostanza, non può essere la storia di Dio. 5. Conseguenza di ciò è l’abbandono del concetto di sistema: esso si costruisce con teschi umani. 6. Di contro ciò, la proposta positiva del nulla. Dapprima, per la verità, la difficoltà di trovarlo dopo tanta abitudine a Dio, al piano armonico del mondo, alla convinzione che niente può distruggersi: DANTON. [La pace è] Nel nulla. Immergiti in qualcosa che sia più tranquillo del nulla, e se dio è la pace più alta, allora dio non è forse il nulla? Ma io sono ateo. Quel maledetto principio per cui qualcosa non può annullarsi! E io sono pur qualcosa, questa è la disgrazia! La creazione s’è tanto estesa che niente più è vuoto, tutto è pieno e brulicante. Il nulla s’è ucciso, la creazione è la sua ferita, noi le sue gocce di sangue, e il mondo la tomba dov’esso marcisce. Tutto ciò suona un po’ pazzo, eppure qualcosa di vero c’è. (III/7; 61, 13-17) Il nulla resta dunque una speranza: DANTON. Il mondo è il caos. Il nulla il dio che deve nascere. (IV/5; 72, 11-12) L’ultimo atto esalta due figure femminili: Julie, moglie di Danton, e Lucile, moglie di Desmoulins. Entrambe seguono i loro sposi nella morte, la prima avvelenandosi nello stesso momento in cui Danton viene ghigliottinato, la seconda creando le premesse per essere a sua volta ghigliottinata; così infatti si chiude il dramma: 101 PIAZZA DELLA RIVOLUZIONE Due boia indaffarati intorno alla ghigliottina . PRIMO BOIA è in piedi sulla ghigliottina e canta. E quando vado a ca’ brilla la luna così chia’... SECONDO BOIA. Ehi, Hai finito? SECONDO BOIA. Sì, subito! (Canta) nella finestra del mio pa’ Perché stai sempre con le putta’? Ecco fatto! La giacca! (Vanno cantando) E quando vado a ca’ brilla la luna così chia’... LUCILE (entra e si siede sugli scalini della ghigliottina). Mi siedo nel tuo grembo, silenzioso angelo della morte. (Canta) C’è un mietitore, si chiama morte, Iddio l’ha fatto potente e forte. Cara culla, che hai portato nel sonno il mio Camille, tu l’hai soffocato sotto le tue rose. E tu campana funebre che con la tua dolce voce l’hai condotto alla tomba. (Canta) Sono migliaia, sono infiniti che ormai sotto la falce son caduti. Arriva una pattuglia UN CITTADINO. Ehi, chi è là? LUCILE (riflettendo e come se prendesse improvvisamente una decisione). Viva il re! CITTADINO. In nome della repubblica! (Viene circondata dalle guardie e condotta via). Questo luogo è stato commentato da uno dei più grandi poeti del Novecento, Paul Celan, al quale cedo la parola: Eppure, quando si discorre dell’Arte, c’è sempre anche qualcuno che si trova presente e... non presta veramente ascolto. Più esattamente: qualcuno che ode e tende l’orecchio e guarda... e poi non sa di che si è parlato; che, comunque sente il parlante, lo «vede parlare», ne ha percepito linguaggio, figura e, allo stesso tempo - chi potrebbe dubitarne, qui, nell’ambito di quest’opera? - allo stesso 102 tempo anche: respiro, il che significa direzione e destino. Si tratta – i presenti lo sanno da lungo tempo poiché essa, tanto spesso citata e non a caso, si presenta loro a ogni nuovo anno - si tratta di Lucile. Il «qualcosa» intervenuto mentre dura la conversazione s’impone brutalmente, giunge con noi fino alla Piazza della Rivoluzione, «le carrette si fanno avanti e si arrestano». Il loro carico è lì, al completo, Danton, Camille, gli altri. Essi, tutti, anche qui trovano frasi, artistiche frasi, che ben arrivano a segno; si parla, e qui Büchner ogni tanto può limitarsi a citare, si parla di accedere-uniti-alla-morte, Fabre perfino vuole poter morire «doppiamente», ognuno è al massimo dell’esaltazione, soltanto un paio di voci, «alcune» - innominate - «voci», trovano che tutto questo sia «già stato visto e provochi la noia». E qui, dove tutto volge alla fine, nei lunghi momenti in cui Camille - no, non lui, non lui stesso, bensì un uomo sulla carretta - in cui Camille teatralmente – quasi si vorrebbe dire in versi giambici – muore di una morte che noi – ma solo due scene più avanti in virtù d’una frase a lui tanto estranea – e a lui tanto prossima possiamo sentire come la morte propriamente sua, quando attorno a Camille pathos e sentenziosità confermano il trionfo della «marionetta» e del «filo», ecco apparire Lucile, la medesima – cieca all’Arte – Lucile, per la quale la lingua possiede qualcosa di personificabile e percettibile coi sensi, eccola di nuovo, con il suo improvviso «Viva il re!» Dopo tutte le parole pronunciate su quella tribuna (che è il patibolo) – quale parola! È l’antiparola, è la parola che strappa il «filo», la parola che non s’inchina più dinanzi alle «cariatidi e ai destrieri da parata della storia», è un atto della libertà. È un passo. Certo, la si può intendere - e questo non sarà un caso, se si guarda a ciò che io ora, che io oggi ardisco di dire a questo proposito -, la si può intendere dapprima come un’adesione all’ancien régime. Qui invece - consentite a uno che si è nutrito anche degli scritti di Pëtr Kropotkin e Gustav Landauer di porlo espressamente in evidenza - qui non vi è nessun atto d’omaggio alla monarchia, a un passato che si vuol conservare. Qui l’omaggio è reso a quella maestà che testimonia della presenza dell’umano, alla maestà dell’assurdo. Tutto ciò, Signore e Signori, non ha un nome stabilito una volta per tutte, ma io credo che sia... la Poesia. Büchner è in fuga: gli è arrivato un mandato di comparizione, è sicuro che seguirà l’arresto. Un rivoluzionario ha cambiato bandiera e provoca l’arresto di cinquanta persone, tra cui Weidig, che morrà in carcere in circostanze per niente chiare; la morte venne fatta passare per suicidio, ma si pensò che fosse invece morto a seguito delle torture inflittegli. Il 12 marzo Büchner è a Strasburgo. E vi si mantenne molto calmo. Gutzkow gli procura del lavoro come traduttore; in otto settimane Büchner traduce due drammi di Victor Hugo, Lucrezia Borgia e Maria Tudor, pubblicati nell’ottobre ancora dall’editore Sauerländer; il 18 dicembre gli arriva la stessa 103 somma che intanto aveva effettivamente ricevuto per il Danton, cioè altri cento fiorini. Non gli bastano certo per vivere; a mantenerlo agli studi è ancor sempre il padre, per infuriato che sia (tornerà a scrivere personalmente a Georg solo dopo che questi avrà avuto il dottorato dall’Università di Zurigo). Sempre pensando a una pubblicazione patrocinata da Gutzkow, Büchner intraprende un altro lavoro. Esso è occasionato dall’amico teologo August Stoeber, già frequentato durante il precedente soggiorno a Strasburgo, il quale mette a disposizione di Büchner copia di una relazione stesa dal parroco svizzero Johann Friedrich Oberlin, presso il quale il drammaturgo Jakob Michael Reinhold Lenz (1751-92) aveva soggiornato per circa tre settimane a partire dal 20 gennaio 1778, lì mandato da amici che ne speravano un miglioramento delle sue compromesse condizioni psichiche. August Stoeber aveva pubblicato nel 1831 alcune lettere e una poesia inedita di Lenz; il padre di August, Ehrenfried, ne aveva pubblicato nello stesso anno una voluminosa biografia di seicento pagine. Tra l’aprile e il novembre 1835 Büchner scrive un frammento di novella, pubblicato postumo ed editorialmente intitolato Lenz. Era previsto che fosse una lunga novella, da pubblicare a puntate sulla progettata “Deutsche Revue” di Gutzkow; questa però venne soppressa e Gutzkow stesso, come sappiamo, venne arrestato, il 30 novembre, accusato di aver «attentato alla religione» col suo romanzo Wally, die Zweiflerin. Büchner non lo dimenticherà e all’inizio del gennaio 1836 gli scriverà una lettera che raggiungerà Gutzkow nella prigione di Mannheim. A sua volta Gutzkow pubblicherà nel 1839 il frammento di novella come omaggio alla memoria dell’amico. Alcuni spunti della novella hanno affinità con motivi presenti fin dal Woyzeck: per esempio le allucinazioni del protagonista, il modo in cui questi interpreta tutta la natura come segno (e vorrebbe saper leggere le figure dei funghi); ulteriori temi da considerare sono da una parte il programma poetico qui esposto, dall’altra l’esortazione a studiare la vita dei più umili, compresi i fremiti e i movimenti appena percettibili nell’espressione del volto, l’esortare ad avere occhi e orecchi per i sentimenti anche degli uomini più prosaici del mondo. Nel complesso la novella viene fatta rientrare nella tradizione tedesca delle novelle sull’artista, cominciata con Hoffmann; talmente forte è però la personalità di Büchner che tale inquadramento dice poco. Büchner si pronuncia contro l’idealismo nell’arte, cioè contro il tentativo di adottarla per farle trasfigurare la realtà. Ma lasciamo ancora la parola a Celan: L’Arte - «ah, l’Arte»: essa possiede, oltre alla sua capacità metamorfica, anche il dono dell’ubiquità: la si ritrova anche nel Lenz, anche qui – mi permetto di sottolinearlo -, come nella Morte di Danton, in forma di episodio. «Lenz a tavola ritrovò il suo buon umore: si parlò di letteratura, egli era così nel suo campo...!» «... La percezione che tutto quanto è creato ha vita, sta al di sopra di quei due criteri [bello e brutto] ed è l’unico nelle cose dell’Arte...» 104 [...] questo passaggio, più di ogni altro, ha una rilevanza storico-letteraria, bisogna saperlo leggere contestualmente alla già citata conversazione nella Morte di Danton, qui si manifesta la concezione estetica di Büchner, movendo da qui si giunge, al di là del frammento büchneriano del Lenz, a Reinhold Lenz, l’autore delle Annotazioni sul teatro, e oltre a lui, ossia oltre il Lenz storico, ancora più indietro fino al – letterariamente – tanto gravido «Elargissez l’Art» del Mercier, questo passaggio apre delle prospettive, qui è anticipato il Naturalismo, è anticipato Gerhart Hauptmann, qui vanno anche cercate e trovare le radici sociali e politiche dell’opera di Büchner. [...] Lenz, ovvero Büchner, riserva, «ah, l’Arte», parole alquanto sprezzanti all’«Idealismo» e ai suoi «burattini». Egli contrappone a essi - e qui seguono le righe indimenticabili sulla «vita dell’essere più umile», sui «palpiti», sulle «allusioni», sulla «quasi impercettibile, finissima mimica» - a essi egli contrappone ciò che è naturale e creaturale. E questa concezione dell’Arte egli ora l’illustra servendosi di un’esperienza vissuta: «Mentre ieri risalivo la valle, vidi due fanciulle sedute su una pietra: l’una stava annodandosi i capelli, l’altra l’aiutava; e i capelli d’oro le scendevano giù; quel serio, pallido viso, pur così giovane; quell’abito nero; e quell’altra che l’accudiva con tanta premura. I quadri di più raccolta bellezza prodotti dalla scuola tedesca antica danno appena un’idea di tutto questo. Qualche volta si vorrebbe essere un volto di Medusa, per poter mutare in sasso un simile gruppo, e far accorrere la gente». [...] Notino, prego Signore e Signori: «Si vorrebbe essere un volto di Medusa» per ... afferrare come naturale, tramite l’Arte, ciò che naturale è. Beninteso, si vorrebbe non significa qui: io vorrei. È come un porsi fuori dell’umano, un trasferirsi, uscendo da se stessi, in un dominio che converge sull’umano ed è arcano - il medesimo in cui sembrano essere di casa la figura scimmiesca, gli automi e con questo... ah, anche l’Arte. Così non parla il Lenz storico, così parla il Lenz di Büchner, qui abbiamo sentito la voce di Büchner: l’Arte per lui serba anche qui qualcosa di arcano. [...] ritorno al Lenz di Büchner, all’episodio del colloquio dunque, che viene condotto «a tavola» e durante il quale Lenz «era di buon umore». Lenz ha parlato a lungo, «ora sorridente, ora serio». E adesso, poiché il colloquio è finito, si dice di lui, ossia del disputante sulle cose dell’Arte, ma allo stesso tempo dell’artista Lenz: «Egli aveva dimenticato se stesso totalmente» Leggendo questo, penso a Lucile, leggo: Egli, egli stesso. Chi porta Arte negli occhi e nella mente, costui – e sono sempre al racconto su Lenz -, costui è dimentico di sé. Arte crea lontananza dall’io. Arte esige qui, in una direzione ben determinata, una determinata distanza, un determinato cammino. [...] forse la Poesia, come l’Arte, raggiunge assieme a un io dimentico di sé quell’alcunché di arcano e straniato, e si rende - ma dove? ma in che luogo? ma con che cosa e in quanto che cosa? – si rende nuovamente libera? In questo caso l’Arte non sarebbe che il cammino che la Poesia è tenuta a percorrere – niente di meno e niente di più. [...] Stiamo forse ora trovando il luogo in cui risiedeva l’arcano, il luogo dove la 105 persona è in grado di affrancarsi come un io.. straniato? Stiamo trovando un tale luogo, un tale passo? «... solo gli risultava talvolta sgradito il fatto di non poter camminare sulla testa.» Eccolo, questo è Lenz. Questo è, così credo io, lui e il suo passo, lui e il suo «Viva il Re» «... solo gli risultava talvolta sgradito il fatto di non poter camminare sulla testa.» Chi cammina sulla testa, Signore e Signori, - costui ha il cielo come abisso sotto di sé. [...] Lenz - ossia Büchner - ha qui compiuto un ulteriore passo avanti rispetto a Lucile. Il suo «Viva il Re» non è più parola, è un pauroso ammutolire, qualcosa che toglie a lui - e anche a noi - il respiro e la capacità di parlare. Poesia: ciò può significare una svolta del respiro. Chi può saperlo? La Poesia percorre forse il cammino - anche il cammino dell’Arte – proprio in vista di una simile svolta? Forse - poiché l’estraneità, ovvero l’abisso e il volto di Medusa, l’abisso e gli automi, tutto sembra allinearsi nella stessa direzione, - forse le riesce di distinguere tra estraneità ed estraneità, forse proprio qui il volto di Medusa si atrofizza, forse fanno cilecca gli automi, proprio qui - per questo incomparabile breve istante? Forse qui con l’Io – con questo io affrancatosi qui e in tale modo – forse qui si libera ancora qualcos’altro? Forse è a partire da questo punto che il poema è se stesso... e ora può percorrere, in questo modo anartistico ed emancipato dall’Arte, le proprie altre strade, dunque anche le strade dell’Arte - percorrerle e più e più volte ancora? Forse. A Strasburgo Büchner non esercita attività politica. Gli emigranti tedeschi non gli piacciono, li accusa di essere una “babilonia”; il riformismo da intellettuali non è il suo. Certo, non dimentica gli amici politici, con i quali resta in contatto epistolare. Ma di fatto ha abbandonato la politica. Il taglio è così radicale che qualche compagno lo ritiene un’abiura. Studia. È ancor sempre studente di medicina e cerca dei proventi stabili. Viene a sapere di possibilità accademiche a Zurigo e si mette al lavoro per utilizzarle. Nel dicembre 1835 comincia a lavorare a una dissertazione sul sistema nervoso dei barbi (una specie di carpa), che termina nel marzo 1836. In aprile la espone in tre sedute alla “Société du Muséum d’histoire naturelle”, con ottimo esito e la società decide di stamparla nella serie delle proprie pubblicazioni, sostenendone anche i costi. Büchner la rielabora (fino al 31 maggio); la stampa, in francese, avverrà nella primavera del 1837 in trecento copie. Il 3 settembre 1836 l’università di Zurigo (evidentemente sulla base di una copia del manoscritto) gli concede il dottorato, cosa che serve anche a rabbonire il padre. Il trasferimento a Zurigo però richiede tempo; un tempo che Büchner utilizza per preparare il suo corso e approfondire i suoi studi di filosofia, e precisamente sui sistemi filosofici tedeschi dopo Cartesio e Spinoza. Pensava infatti di offrire lezioni anche in questo settore, cosa che poi non avverrà. Il fatto è che Büchner non ha più voglia di fare il medico. I lavori intrapresi per la dissertazione gli hanno fatto 106 schifo (letteralmente così si esprime in lettere a due diversi destinatari) e non vedeva l’ora di toglierseli dai piedi. Lui vuol fare il filosofo. Gutzkow glielo sconsiglia: allo studio della medicina, osserva, Büchner deve molto anche come scrittore, perché è da lì che gli viene la sua “autopsia”; e poi, se si butta sulla filosofia con la stessa irruenza che sulla letteratura, come la prenderanno i filosofi tedeschi? Ma il primo argomento che Gutzkow fa valere è: il padre non sarebbe per niente contento di questo cambio di mestiere. Il padre infatti fa prima scrivere dalla madre e poi scrive personalmente a Georg che tenga delle lezioni di anatomia comparata. E questo farà Georg a Zurigo: un corso di anatomia comparata di pesci e anfibî. Nel frattempo egli ha già scritto una prima versione in due atti della commedia Leonce und Lena, volendo concorrere a un premio messo in palio dall’editore Cotta di Tubinga per una commedia in uno o due atti. Il termine di consegna è il 1° luglio; Büchner scrive la commedia in al massimo un mese (dunque nel giugno 1836), la spedisce, ma essa arriva due giorni dopo il termine e gli viene rispedita senza che il pacco sia stato aperto. Con calma, Büchner la rielabora in tre atti, completandola dopo l’arrivo a Zurigo. Leonce und Lena, quella che con Der zerbrochene Krug di Kleist è la più bella commedia tedesca, venne pubblicata in parte ancora da Gutzkow nel 1838 a puntate su una rivista, e integralmente nel 1850 da Ludwig Büchner. Sulla scena arrivò soltanto il 31 maggio 1895 a Monaco. Leonce und Lena è la commedia di chi ha scritto Dantons Tod e non ne ha certo abbandonato la filosofia, però per rendere quella concezione del mondo adatta a una commedia deve provvisoriamente sospendere la drammaticità dei conflitti e ciò si fa avvicinando i contrari. Perciò la commedia è l’opposto di Dantons Tod, mentre invece gli opposti sono al suo interno meno opposti. Aumentano i contrasti tra i motivi, essi però non sono mortali. Quasi ogni scena della commedia si basa su un litigio che si ricompone subito. Occorre poi notare che - ad abundantiam - le scena della commedia vengono costruite su un principio oppositivo interno (già presente in Dantons Tod ma qui ulteriormente accentuato): divise in due o più parti, di cui l’una si oppone all’altra. Infine nella sua ricchezza lessicale, sintattica e retorica il linguaggio si fa ancora più ardito, vorrei quasi dire più violento, che nel dramma. Ma si risolve su se stesso; le battute sono di autocritica prima che di critica. Il principe Leonce, erede al trono del regno di Pipì, dovrebbe sposare la principessa Lena, del regno di Popò; questa è la volontà del re Peter, padre di Leonce. Ma né Leonce né Lena vogliono queste nozze, perciò fuggono entrambi, incontrandosi subito alla prima tappa della loro fuga, senza però conoscersi. Si innamorano e tornano nel regno di Pipì travestiti da automi; il re Peter, non potendo venir meno alla sua parola di re, che per quel giorno aveva ordinato nozze e felicità, li sposa in effigie; dopodiché i due automi si tolgono le maschere, vengono riconosciuti, Leonce sale al trono e fa un programma di governo 107 mentre re Peter si ritira a pensare con i suoi saggi. Re Peter è infatti un re-filosofo, che espone un suo sistema pseudospinoziano nel seguente modo: PETER (mentre viene vestito). L’uomo deve pensare, e io devo pensare per i miei sudditi; perché loro non pensano, non pensano. La sostanza è la cosa in sé, che sono poi io. (Corre mezzo nudo per la stanza) Afferrato il concetto? La cosa in sé è in sé, capite no? Adesso vengono i miei attributi, le mie modificazioni, le affezioni e gli accidenti: ma dov’è la mia camicia? e i pantaloni? Alt! santo cielo! ho il libero arbitrio tutto aperto davanti! Dov’è la morale? dove sono i polsini? Ho le categorie in un disordine spaventoso, e ci sono due bottoni allacciati in più; la tabacchiera è andata a finire nella tasca a destra ... insomma tutto il mio sistema è rovinato. To’, e cosa significa questo nodo al fazzoletto? Ehi tu, cosa significa questo nodo? Di che cosa volevo ricordarmi? Come si vede, la condanna del sistema è una costante di Büchner: essa avviene nel Woyzeck (nel primo abbozzo del quale c’è anche un’allusione a Spinoza), nel Dantons Tod e infine in Leonce und Lena. Così come ci sono altre costanti (per esempio la metafora del vestirsi) che legano un’opera all’altra. Fra le novità della commedia attira l’attenzione la presenza di stupendi squarci lirici. Eccone uno: LENA (parla fra sé). La capinera ha cinguettato in sogno. La notte dorme più profondamente, le sue guance si fanno più pallide, il suo respiro più calmo. La luna è come un bimbo che dorme, nel sonno i riccioli d’oro gli sono caduti sul caro volto ... Oh, ma il suo sonno è la morte. Come riposa l’angelo morto sul suo buio cuscino, e le stelle gli ardono intorno come candele! Povero bimbo! È triste, morto e così solo. I due, come già detto, si sposano. La commedia propone di accettare lo stato di fatto, ricreandolo. Nel frattempo si insiste sull’insensatezza di una vita che non crea ma ripete; un uomo che vive così (si dice) è un burattino preso sul serio. Sulla ripetitività, sulla meccanicità e sulla finzione che le prende sul serio si basa la morale. Alla fine si propone un programma di vita e di governo basato sull’inutile: la speranza di felicità è seria ma l’esito è finzione, teatro, nel quale la rappresentazione si può replicare a piacere, purché non si dimentichino le parti: LEONCE. Guarda, Lena, abbiamo le tasche piene di bambole e giocattoli. Cosa vogliamo farne? Vogliamo far loro i baffi e appendergli le sciabole? Oppure mettiamo loro la marsina e facciamo che si occupino di politica infusoria e di diplomazia e noi ci mettiamo lì vicino col microscopio? Oppure vuoi un organetto sul quale corrano in girotondo degli estetici topolini bianchi? Costruiamo un teatro? (Lena si appoggia a lui e scuote il capo) So ben io quel che vuoi: facciamo distruggere tutti gli orologi, proibire 108 tutti i calendari e contiamo le ore e le lune soltanto sull’orologio dei fiori, soltanto secondo le fioriture e i frutti. E poi circondiamo il nostro piccolo regno di specchi ustori, che non ci sia più inverno e noi ci si possa distillare l’estate a Ischia e a Capri e rimanere tutto l’anno fra rose e viole, fra aranci e lauri. VALERIO. E io divento primo ministro e farò emanare un decreto per cui chi si fa crescere calli alle mani venga fustigato, chi si ammazza dal lavoro sia perseguito come criminale e chiunque si vanti di guadagnare il proprio pane col sudore della fronte sia dichiarato pazzo pericoloso per la società umana; e noi, infine, ci mettiamo all’ombra e preghiamo Dio che ci conceda maccheroni, meloni e fichi, e ugole musicali, corpi classici e una comoda religione! Il 17 ottobre 1836 Büchner si trasferisce a Zurigo. Il 5 novembre vi tiene la sua lezione di prova e viene assunto tra i liberi docenti dell’università. Comincia il suo corso di “Dimostrazioni zootomiche”, che tiene nella stanza in cui abita; ha cinque studenti, ma di solito se ne presenta uno solo. A metà dicembre 1836 lo scrittore Ernst Adolf Willkomm (1810-1886) vuole invitarlo da Lipsia a partecipare a una collana di testi drammatici da lui diretta. Non si sa se l’invito sia stato realmente fatto né se Büchner abbia mai spedito qualcosa. Il 2 febbraio Georg Büchner si ammala di tifo. Accorre la fidanzata, ma le condizioni del malato sono già disperate. Büchner riesce ancora a riconoscerla; fa sforzi per dirle qualcosa, si ha l’impressione che voglia parlare di qualcosa che gli sta a cuore, ma non riesce a dire niente. Il 12 febbraio 1837 muore. Tra le sue carte vengono trovati i frammenti del Woyzeck; la fidanzata ritiene che vi si debba trovare un dramma su Pietro Aretino, ma non se ne rinviene traccia nemmeno a una seconda ricerca; alcuni dubitano che sia mai esistito. Venne invece rinvenuto “una specie di diario”, in cui sia Wilhelmine Jaeglé sia un’amica dell’autore lessero delle splendide cose. Ma questa “specie di diario” è andata persa. 109 110 II Le tradizioni 111 112 II, 1. II, 1, 1. Nascita della germanistica Dal 24 al 26 settembre 1846 si riunirono nella sala imperiale del Römer di Francoforte 200 fra studiosi e amministratori (una settantina erano docenti universitari), dando così luogo al primo congresso dei germanisti. Su proposta di Ludwig Uhland (1787-1862) venne subito acclamato presidente Jakob Grimm (1785-1863), il quale pronunciò un importante discorso di accettazione. In esso sostenne la tesi di fondo secondo cui «un popolo è la sintesi di coloro che parlano la stessa lingua» e sulla base di questa lingua avrebbe dovuto un giorno essere unificato; sembra dispiacergli che il predominio del tedesco non sia più tale né in Francia né in Inghilterra, ma il resto appare bastargli. Soprattutto loda che il «dialetto altotedesco» si sia immutabilmente imposto su tutti gli altri, così che col loro sacrificio la nobile lingua scritta risultante acquisti forza e vigore. L’assemblea vedeva riuniti filosofi, storici e giuristi. Grimm, autore di una grammatica storica della lingua tedesca, editore di documenti giuridici e di raccolte di miti e saghe, a buon diritto presidente, si fece carico di dimostrare la connessione fra le tre discipline; passò pertanto, con un «facile passaggio», alla storia, mostrando che le era indispensabile la conoscenza della lingua antica per accedere ai documenti. Ma le cose più interessanti le disse relativamente al contrasto fra diritto germanico e diritto romano, inserendosi così in una complessa disputa, che non è qui il luogo di ripercorrere. Grimm occupa (come si direbbe in linguaggio politico moderno) il centro: non è pensabile eliminare il diritto romano dal moderno pensiero giuridico tedesco; però attraverso un’indagine storica se ne possono rintracciare i lasciti, che a poco a poco si costituiscono in un intero, inducendo al pensiero che varie splendide, antiche istituzioni, andate perse e adatte al nostro modo tedesco di essere, possono venir rievocate e applicate almeno in parte, sia per colmare lacune lasciate dal diritto romano, sia per sostituirlo là dove questo non appare più rispondere alle esigenze odierne. In tal modo si può mirare a una nuova legislazione e a «bandire parti considerevoli del diritto straniero». La stessa posizione centrista Grimm la occupava a proposito del purismo: niente pulizie estreme, niente coniazioni inconsulte e inutili, ma conoscere a fondo la lingua nelle sue possibilità, così da non «usare parole straniere quando ce ne sono di tedesche altrettanto buone e anzi migliori». Per finire Grimm esortava a tener fuori «la politica vera e propria». In questo non fu ascoltato: i 113 convenuti svilupparono invece le loro idee liberal-nazionali pronunciandosi contro la censura, a favore dell’introduzione di tribunali popolari per spezzare il monopolio nobiliare sulla giustizia, contro la pretesa della corona danese allo Schleswig-Holstein; rivolsero un appello agli emigrati tedeschi in America affinché seguitassero a coltivare la lingua patria, ascoltarono conferenze su onomastica e toponomastica. Il congresso seguente ebbe luogo nel 1847 a Lubecca, in cui si ripeté lo stesso scenario, tra liberale, nazionale e nazionalistico; si fecero però sentire anche coloro che per esempio sul riferimento al diritto romano avevano idee più realistiche, altri che non erano inclini a colonizzare l’est (come visto, già Grimm si era rassegnato a non colonizzare l’ovest, risultando per altro un po’ ambiguo a proposito dell’Olanda) e altri ancora che esortarono gli emigrati in America ad assimilarsi quanto prima. Gli appelli finali risultarono nazional-liberali. Un terzo congresso non ci fu mai: nel marzo 1848 scoppiò la rivoluzione e molti dei germanisti si candidarono al Parlamento di Francoforte: Jakob Grimm, Ludwig Uhland, Georg Gottfried Gervinus (di cui ci occuperemo più in là), Ernst Moritz Arndt, Friedrich Theodor Vischer, Friedrich Ludwig Jahn (proprio lui, quello delle Burschenschaften e dell’educazione fisica) vi entrarono e vi lavorarono; non per nulla lo si chiamò Professorenparlament: di professori ce n’erano ben 106, oltre a 223 giuristi. Il parlamento regge meno di un anno, dal maggio 1848 al marzo 1849, quando viene sciolto; Gervinus si era dimesso prima. Per quel che riguarda la germanistica: non si arrivò più a un congresso delle tre scienze, germanistica significò in seguito chi si occupa della lingua e della letteratura tedesche ma – lo vedremo presto – secondo una determinata ideologia, che risente pur sempre qualcosa dell’impostazione originaria. Sul piano organizzativo, i germanisti intesi nel senso più limitato appena detto entrarono in un’associazione di varie filologie già fondata a Göttingen nel 1837, all’interno della quale si costituì nel 1861 una sezione di germanistica; a un’associazione autonoma si arrivò solo nel 1912. Per il resto ci fu una serie alternata di repressioni, ricatti, compromessi e premi, in cui particolarmente abile si dimostrò la Prussia. I fratelli Grimm pubblicarono il primo volume del loro dizionario tedesco nel 1854, introducendolo con sentiti ringraziamenti alla protezione loro concessa dal re di Prussia. Ad altri invece le cose andarono meno bene: alcuni persero il posto, altri finirono in prigione. Dall’altra parte la Prussia proseguì una politica culturale che l’aveva portata nel 1810 a istituire all’università di Berlino un insegnamento di letteratura tedesca moderna, nel 1831 a mettere in programma un esame di storia della lingua tedesca per tutti i candidati all’insegnamento medio superiore, estendendo e rinforzando questa disposizione negli anni Sessanta; intanto il numero dei docenti universitari erano venuto man mano crescendo, fino a diventare considerevole e diffuso. In compenso la germanistica diventava nazionalista e filoprussiana, mentre al tempo stesso intraprendeva una specie di musealizzazione dei suoi valori: il classicismo weima114 riano diventava un valore assoluto, la filologia goethiana diventava una specie di branca autonoma e obbligata, l’analisi immanente aveva il compito di prescindere dalla storia, la filologia aveva come suo unico fine l’oggettività (e qui occorre dire che in essa si ebbero i risultati più durevoli e interessanti). Ci furono indubbiamente eccezioni, che sarà doveroso ricordare, ma questo fu il panorama globale. Si è parlato del 1846 come data del primo congresso; ma già nel sentire dei contemporanei la germanistica si stava formando da vent’anni e oltre; oggi si tende a vederne i primi vagiti tra il 1806 e il 1812 (c’è chi risale fino al Settecento, il che però pare difficile se si vuol mantenere quanto più si può del significato del termine secondo Grimm). Una data fondamentale è il 1835, quando il già ricordato Georg Gottfried Gervinus (1805-1871) pubblicò la Geschichte der poetischen Nationalliteratur der Deutschen (Storia della letteratura poetica nazionale dei Tedeschi) considerata la prima vera storia della letteratura tedesca; nell’introduzione dichiarava di aver dovuto inseguire il suo oggetto a cominciare dall’epoca in cui esso aveva lasciato a malapena tracce, per poi sopportare il vergognoso gioco dei monaci, la sregolatezza dei cavalieri, le catene degli artigiani, gli assoggettamenti a opera dello straniero, finché, sostenuta dai lumi universalmente diffusi, si liberò, diventò padrona di sé, «rivalendosi poi con vendicative conquiste dell’ultimo assoggettamento sopportato». È infatti pur vero che nel risalire alla fonte della vera poesia tutte le nazioni europee accompagnano e spesso superano i tedeschi, alla fine però restano tutte indietro, una dopo l’altra. Posta questa premessa, ecco lo scopo: far capire alla nazione il suo valore attuale, rinvigorire la ripiegata fiducia in sé e accanto all’orgoglio per i tempi antichi infonderle gioia per il momento presente e il più sicuro coraggio per il futuro. Dunque la sua storia sceglie il materiale accordandolo ai bisogni del presente e tali bisogni (giudica Gervinus) vengono soddisfatti al meglio dalla storia della letteratura. Gervinus era vigoroso nel sostenere che la sua era proprio una storia, non una branca dell’estetica. In concreto, egli vedeva il culmine dello spirito tedesco raggiunto dall’età classica (da Lessing a Goethe e Schiller), sintesi di cultura dotta e cultura popolare; a esso segue – ed è il momento in cui Gervinus scrive – un’epoca in cui non c’è più bisogno di letteratura ma di azione, i cui contorni contribuì a tracciare nei congressi dei germanisti e nel parlamento di Francoforte. Si noti bene: per Gervinus la storia della letteratura è vera storia perché il suo oggetto, la letteratura, è arrivato alla conclusione: un’implicazione, questa, che squalificava quella critica che oggi chiamiamo militante e che in seguito egli avrebbe usato contro i positivisti, i quali non concepivano la storia 115 come storia di un’idea. La sua concezione era il controcanto nazionale alla tesi heiniana della fine della “Kunstperiode”; d’accordo nel non fuggire nella pura estetica, ma l’idea che fonda l’azione non può essere che l’idea nazionale. Con le modifiche del caso, i principî di questa storiografia risalgono a Hegel (con un importante apporto di Schleiermacher: nell’introduzione alla sua storia scrive che essa non è fatta per Chi oggi non è capace di capire lo spirito di epoche e nazioni straniere come delle sue proprie, […per] chi non coglie la storia dell’umanità per correr dietro a quelle di singoli popoli e singole epoche […e invece] vuol misurare il mondo col piccolo metro della sua limitatezza personale o nazionale). Ma quell’insistere sull’idea di nazione e di popolo rinvia difilato al romanticismo e quindi a una base comune coi fratelli Grimm. Era convincimento comune che lo spirito di un popolo si esprime nella sua lingua e dunque, per raggiungere l’essenza dello spirito tedesco, occorre studiarne la lingua nelle manifestazioni più pure; si riteneva che tali fossero le più antiche e le più popolari. Il popolare si riteneva di trovarlo conservato al meglio presso i contadini e nella loro lingua e cultura integra e schietta, garante della ricercata autenticità e purezza dello spirito tedesco. Nella prefazione al secondo volume dei Kinder- und Hausmärchen (Fiabe del focolare, 1815) Wilhelm Grimm (1786-1859) riteneva di poter asserire che l’addurre come fonte una contadina di un paesino nelle vicinanze di Kassel garantisse da solo che si trattava di fiabe «autenticamente assiane». Era anche sicuro che tutte quelle fiabe fossero «tedesche pure e assolutamente non prese in prestito» e infine che in esse fosse «contenuto nient’altro che mito tedesco primigenio». Arrivato così alle fonti della naturalezza, pensava che essa potesse crescere e svilupparsi, cioè nient’altro che realizzarsi; in questo senso interpretava le evidenti tracce storiche moderne, presenti nelle fiabe. Le ricerche moderne hanno mostrato quanto internazionali siano le provenienze di quelle fiabe, quanto cittadine le versioni raccolte, quanto influenzate da raccolte moderne e quanto di storie e istituzioni moderne (scambiate per primeve) ci fosse dentro. I Grimm, e non solo loro, restarono vittime dell’entusiasmo per il loro principî, anche se i loro meriti (non da illustrare qui) restano fuori discussione. Fatale fra tutte restò l’idea di una lingua primeva come rivelatrice immediata della verità grazie all’identificazione di suono e significato. D’altra parte fu questa, se non a promuovere l’unificazione delle scienze, però a farle marciare lungamente insieme in quanto esprimentesi nella stessa lingua. Per quanto importante fosse la germanistica, per lungo tempo nel corso della prima metà del secolo essa non fu la presenza critica più visibile. Ci fu grosso modo un decennio fra gli anni venti e trenta durante il quale la più in vista fu la critica dello Junges Deutschland e di ciò che lo preparò. Questi critici seppero 116 subito adeguarsi alle condizioni del mercato: la produzione libraria era cresciuta molto, nessuno era in grado di rincorrere tutta la bibliografia, le riviste la segnalavano e la recensivano, dunque svolgevano un servizio importante. Gli Jungdeutsche scrissero per riviste: quando ne pubblicarono di proprie, raggiunsero solo un basso numero di abbonati (da 400 a 600), ma il numero diventa più rilevante se si mettono insieme tutte le riviste e le raccolte di saggi e recensioni che gli stessi autori pubblicavano in volume; inoltre scrivevano spesso per giornali e riviste non redatte o dirette da loro stessi, e queste avevano di solito tirature considerevoli. L’attività critica di questi autori aveva un taglio corrispondente al mezzo: dovevano essere brillanti e nei migliori (Gutzkow e Wienbarg, per tacere di Börne, Heine e dello stesso Menzel, i cui meriti vennero poi offuscati dal suo comportamento infame) fu realmente così; ma anche gli altri furono solitamente efficaci. Il loro modo di fare critica è forse chiarito da un termine che essi stessi usarono volentieri: caratterizzazione (Charakteristik); ciò voleva dire che non trascuravano alcun aspetto che potesse illustrare la personalità di un autore; insomma, erano giornalisti veri. Il loro interesse andava soprattutto al contenuto, e specificamente al contenuto ideologico. Furono inoltre particolarmente attenti all’attualità. Queste due ragioni li portarono ad attaccare fortemente i romantici e a memorabili campagne contro il sopravvissuto più in vista del romanticismo: l’influentissimo Ludwig Tieck. Come recensori di riviste, questi critici dovevano occuparsi un po’ di tutto, ma questa necessità fu la benvenuta per allargare il concetto di critica; non solo recensirono opere letterarie, ma anche opere di storia, filosofia, economia e soprattutto di politica. E, cosa forse ancora più importante: non trascurarono la letteratura di massa. Anche se i più in vista, gli Jungdeutsche non erano i soli; accanto a loro c’erano i critici professatamente hegeliani e verso la fine degli anni trenta furono proprio i neo o posthegeliani a porsi meglio in vista: personaggi come Robert Prutz, Karl Rosenkranz, Arnold Ruge, David Friedrich Strauß, Friedrich Theodor Vischer attrassero su di sé l’attenzione in misura maggiore e meritatamente. Di costoro Prutz (1816-1872), a lungo dimenticato, è stato a buon diritto rivalutato negli ultimi decenni; il suo spirito liberale, la sua coerenza nei decenni, la sua attenzione alla letteratura di intrattenimento, alla letteratura femminile, alla letteratura di viaggi, ai fenomeni della ricezione danno ai suoi scritti interesse e vitalità. Ancora un breve cenno a un uomo straordinario: Karl August Varnhagen von Ense (1785-1858), uno dei più grandi stilisti che la letteratura tedesca abbia conosciuto. Sul piano dei valori letterari, la sua importanza è oggi affidata eminentemente all’autobiografia. Ma scrisse anche degli straordinari ritratti di gente da lui conosciuta (e si può proprio dire che conoscesse tutti); memorabile quello su Clemens Brentano, al quale fra l’altro ebbe anche occasione di mollare un paio di schiaffi. A lungo fu una specie di eminenza grigia della letteratura: abile difensore dello Junges Deutschland, partecipe recensore di Heine come di Kel117 ler (fu uno dei pochi a rendersi subito conto che Der grüne Heinrich – prima versione – era un capolavoro) ma soprattutto ammiratore, propagatore e difensore di Goethe, Varnhagen è stato un personaggio notevolissimo, per qualche strana ragione perseguitato dalla fama di essere stato il marito della grande e tanto diversa Rahel Levin, che effettivamente durante la sua vita (morì nel 1833) l’aveva messo in ombra. Ma tant’è: diversi, diversissimi, per tanti aspetti addirittura opposti, entrambi sono stati grandi personalità. L’attività di Joseph von Eichendorff (1788-1857) come critico si svolge nell’ultima parte della sua vita (le cose più interessanti compaiono a partire dal 1847); occorre dire chiaramente che il critico non è all’altezza del lirico e del narratore. Interessante è la sua attenzione a tutto: a Stifter, Heine, Gotthelf, Auerbach, Lenau eccetera, così come alla Trivialliteratur; i suoi giudizi appaiono ben ponderati e articolati, al di là della loro condivisibilità. Ma tutto ciò ha interesse erudito, sociologico e di politica culturale: Eichendorff cercava soprattutto la valutazione in nome del cattolicesimo. Maggiore interesse ha il volume Über die ethische und religiöse Bedeutung der neueren romantischen Poesie in Deutschland (Sul significato etico e religioso della recente poesia romantica in Germania, 1847), dove tenta un bilancio dell’esperienza romantica, schierandosi contro Heine e a favore di Stifter; ma questo è anche tutto quel che se ne può dire. II, 1, 2. La Dorfgeschichte La germanistica, che abbiamo seguito nel suo costituirsi, cercava nel passato (e meglio ancora nei pretesi primordî) i valori basilari e perenni dello spirito tedesco, al fine di trarne le giustificazioni e le direttrici per l’azione presente. Per quanto diversamente interpretato (e con conseguenze estreme in Gervinus), questo condiviso presupposto era di chiaro conio romantico. Di quei valori basilari si volevano inoltre seguire le tracce fin nel presente al fine di rinvigorirle e ripristinarle lì dove possibile (esempio: l’atteggiamento di Jakob Grimm di fronte al diritto germanico); si voleva cioè ripercorrere e proseguire una tradizione. Era un presupposto fuori discussione che a costituire la tradizione fosse il popolo, che in essa esprime la propria essenza. Di fatto rispondeva alla domanda “come si costituisca una tradizione e a opera di chi” eminentemente chi si proponeva di continuarla; dunque a quella domanda se ne allacciava implicitamente un’altra: come continuare la tradizione. Il fenomeno della Dorfgeschichte va considerato come una delle forme di risposta. Per i contemporanei l’iniziatore della Dorfgeschichte fu Berthold Auerbach (1812-1882); altri nominano, insieme con lui e (anche) con preferenza rispetto a lui, Karl Immermann per quella parte del Münchhausen che sotto il titolo Der Oberhof ebbe una fortuna editoriale autonoma. Ma per chi scrisse Dorfgeschichten 118 il modello fu senz’altro Auerbach. Per i contemporanei gli autori eminenti di tale genere furono costui e Jeremias Gotthelf; oggi quest’ultimo si è guadagnato altra considerazione e un posto a sé. Il che vuol dire che nelle storie delle tradizioni finiamo col mettere sempre e, se non soltanto almeno principalmente, i minori. Conseguentemente, chi ignorasse la Dorfgeschichte ignorerebbe un poderoso fenomeno sociologico e ideologico, che in realtà non ci si può permettere di ignorare; ma perderebbe ben poco sul piano della qualità. In questa sede, espunti dalla storia del genere Gotthelf, Stifter, Keller, Droste-Hülshoff, ci concentreremo su Immermann e Auerbach. Der Oberhof va inserito nella logica complessiva del Münchhausen, la quale è traducibile così: l’epoca presente (ricordiamo che il romanzo venne pubblicato nel 1837-38) è caratterizzata dallo svuotamento di valori, diventati poco più che superstizione; dalla mancanza di un criterio di condotta, per cui ogni stramberia diventa perfino plausibile. Per tutto ciò, lo strumento di rappresentazione e di critica è la satira (col che Immermann si inseriva su uno dei filoni più fecondi della prima metà del secolo). Ma di fronte a ciò esiste un mondo per la verità con molti e gravi difetti, anzi superato se non addirittura morto, però da prendere sul serio e sulla cui base si può costruire un futuro; è il mondo contadino nell’autonomia della sue istituzioni. Queste hanno creato «una potenza indipendente», per nulla ribelle, poiché anzi, formando dei cittadini autonomi, liberi, virili e pieni di fermezza, hanno fatto tanti regnanti ognuno nella propria casa e coi propri pari: un re che può contare su sudditi del genere è, lui sì, «una grande potenza e un signore senza pari». Che un mondo del genere si basi sul patriarcato (coi suoi giudizi inappellabili e con la regolamentazione minuziosa della vita privata) e sulla ferocia del conformismo, Immermann sembra non averlo notato oppure approvarlo. Ne loda l’autarchia economica, ma poi ne deplora l’inimicizia nei confronti dello stato. Loda «i primordi della comunità germanica», di cui lo stato moderno ha raccolto solo i «frantumi», ma il rapporto fra tutto ciò e la proclamata fedeltà al re, cioè come questi residui di tradizioni rafforzino lo stato, non viene messo chiaramente in luce. Qualcosa va in direzione di una lode dello Ständestaat, poiché mentre l’attenzione è puntata sulle morenti istituzioni contadine, del «popolo immortale» sembra far parte anche il «ceto medio», almeno quello «onesto, consapevole, attivo e laborioso». Quest’ultimo, peraltro, pare acquistare la giusta coscienza di sé solo a contatto con le campagne, che peraltro si chiudono all’etica urbana. Una cosa poi pare ben chiara: dentro questa prospettiva è criminoso pensare di violare i confini tra i ceti. Insomma qui c’è un groviglio che il concetto di popolo riesce solo a nascondere, non a dipanare. E tuttavia la narrazione è piena di lodi al popolo, in prospettiva del quale pare si debba volere anche un rinnovamento della letteratura. Berthold Auerbach (1812-1882) divenne celebre per le sue Schwarzwälder Dorfgeschichten (Storie dei villaggi della Foresta nera), che comincia a pubblicare nel 1842. Di esse l’aspetto più importante è l’intenzione. Auerbach sostiene che la 119 letteratura tedesca non può proporsi la caratterizzazione di tipi nazionali, come invece possono gli scrittori inglesi e francesi, perché la Germania non è un paese centralizzato. In compenso la realtà tedesca mostra lo sviluppo delle culture locali, e queste devono essere oggetto privilegiato sia della politica sia della letteratura: «la consapevolezza dell’unità deve penetrarle e deve prodursi anche qui una vita articolata.» Conseguenza ultima è che «la moderna letteratura popolare può consapevolmente riprendere e proseguire quel che una volta la saga faceva in tutta ingenuità». Di fatto le Dorfgeschichten di Auerbach sviluppano il contrasto città-campagna: nella prima è tutto il male, nell’altra tutto il bene. Alcune delle sue storie divennero molto popolari e hanno anche qualche effettivo merito; una di esse, Die Frau Professorin (La signora professoressa, 1846) ebbe un grande successo, cui l’aiutò la riduzione drammatica che Charlotte BirchPfeiffer (1805-1868) ne fece nel 1847 col titolo Dorf und Stadt (Paese e città). II, 1, 3. Il romanzo storico fu un’altra forma di risposta alle domande prima riportate. L’affinità con la risposta della Dorfgeschichte venne notata dallo steso Auerbach nella prefazione già riassunta. È singolare rilevare che durante quella che fu la più abbondante fioritura di romanzi storici (tra il 1850 e il 1870, come risulterà fra poco) i teorici più in vista del realismo formularono nei confronti di tale genere le stesse esigenze che Auerbach aveva formulato per la Dorfgeschichte. A causa della frammentazione della storia tedesca (scrive Julian Schmidt nel 1852), chi vuole scrivere un romanzo storico deve mettere a fondamento la storia di una provincia, con i suoi vantaggi di concretezza ma anche con i suoi svantaggi di chiusura e limitatezza. In ogni caso il momento dell’unità deve passare attraverso «le storie provinciali, [le quali] possono costituire l’oggetto di un romanzo storico solo se ambientate in un’epoca in cui si collega loro un interesse storico generale.» Adeguate sono le vicende, locali bensì, ma capaci di «ricordare alla nazione di essere una totalità». Come si vede, dalla Dorfgeschichte e dal romanzo storico ci si attendevano le stesse cose. Ci fu prima una grande fioritura immediatamente successiva alla diffusione dei romanzi di Walter Scott, inventore, diffusore e primo modello di questo genere letterario; essa durò dal 1834, quando Ludwig Rellstab (1799-1860) pubblicò il primo romanzo storico tedesco, fin verso la metà degli anni quaranta. I temi di questa fase sono attinti in larga parte dalla storia più recente: il titolo del romanzo di Rellstab, limitato a una data, 1812, ovviamente riferita alla campagna di Napoleone in Russia, dà bene un’idea di questi temi. Ma dopo una breve interruzione la moda riprese: i romanzi storici tedeschi prodotti tra il 1858 e il 1861 furono la metà del complesso della produzione di romanzi tedeschi in generale, che però erano in minoranza rispetto ai romanzi stranieri venduti in 120 Germania; ma nel 1860-62 i romanzi storici furono il 30% di tutti i romanzi – tedeschi o stranieri che fossero – comparsi sul mercato. Per la seconda metà del secolo nel suo complesso sono stati contati 816 titoli di romanzi storici. Se si considera tutto il secolo e inoltre che molti romanzi erano in più volumi, si arriva complessivamente alle varie migliaia di volumi. I temi man mano cambiarono: fino al 1875 i soggetti storici erano tratti ancora prevalentemente dalle vicende napoleoniche e dalla storia del Settecento, poi crebbe molto la scelta di temi più lontani o addirittura antichi. Evidentemente prima si cercò di tener vivi alla memoria quel complesso di eventi che avevano dato impulso al desiderio di unificazione nazionale e successivamente, una volta raggiunta questa, di assicurarsi una continuità storica nel corso delle epoche, a giustificazione e consolidamento di quanto era avvenuto. Di tutto ciò oggi non rimane quasi più nulla, tranne forse, a livello quanto mai minore, Willibald Alexis (pseudonimo di Wilhelm Häring, 1798-1871) con un solo titolo, Die Hosen des Herrn von Bredow (Le brache del signor von Bredow, 1846), e resta perché si tratta di un romanzo storico-umoristico, dunque nemmeno esso tipico. L’immensa massa restante viene oggi annoverata nella Trivialliteratur: dunque le due risposte allora più popolari, la Dorfgeschichte e il romanzo storico, sono oggi scomparse dal nostro orizzonte e la germanistica stessa ha dovuto non essere più la stessa per sopravvivere. Quella risposta che fu il romanzo storico fu differenziata: di volta in volta fu richiamo al passato per poter rinnovare il presente, oppure rifugio nel passato per sfuggire alla modernità tecnica e scientifica, oppure ricerca di sicurezza nella continuità storica e altro ancora, a seconda dei tempi e degli autori. Comune fu comunque il presupposto di un’unità culturale nazionale, contrapposta o da contrapporre alle tendenze particolaristiche. E tuttavia compaiono anche grandi nomi fra gli autori di romanzi storici: Stifter con Witiko, Raabe con qualche titolo del suo ultimo periodo (per es. Das Odfeld, Il campo di Odino), Conrad Ferdinand Meyer con tutta la sua opera narrativa. Qui siamo effettivamente su un altro piano. Però delle opere da considerare di Raabe e di Meyer c’è da contestare che siano veri romanzi storici, come vedremo parlando di tali autori; resta dunque Witiko, che Ernst Bertram definì nel 1921 «l’unico vero» romanzo storico tedesco. Esso non ebbe neanche il minimo successo in vita dell’autore ed è rimasto sempre sostanzialmente nell’ombra; per l’economia della presente trattazione sarà più comodo affrontarlo entro l’opera complessiva di Adalbert Stifter. 121 II, 1, 4. Le letterature dialettali Questo titolo ha il compito di segnalare una lacuna: la mancanza di un capitolo dedicato alle letterature dialettali. E le righe che seguono servono a spiegare questo paradosso. Nelle correnti storie della letteratura a me note si procede nel seguente modo: quando si arriva all’epoca Biedermeier si dedica attenzione anche a Ernst Elias Niebergall (1815-1843) e al suo capolavoro, la commedia Datterich (1841), scritta nel dialetto di Darmstadt; arrivati al periodo del realismo, si dedica attenzione a Klaus Groth (1819-1899) e alla sua raccolta di poesie Quickborn (1852), a Fritz Reuter (1810-1874) e alle sue opere in versi e in prosa; entrambi costoro scrissero in Plattdeutsch (ma precisare ulteriormente la loro lingua comporterebbe complesse discussioni, che qui non affronteremo). Dedicare attenzione è più che giusto: Datterich (il titolo significa: uno che beve tanto da tremare) è un capolavoro, almeno una delle sezioni di Quickborn (= Fonte di vita), quella dedicata alle poesie di animali, reca cose di grande valore, i romanzi di Reuter (personalmente trovo splendide cose anche nella sua prima raccolta di poesie – Läuschen und Rimels, Raccontini e filastrocche, 1853 – che gode di minor favore presso la critica) meritano i loro giudizi positivi. Resta però inevasa la domanda fondamentale: quale posto spetti alle letterature dialettali e quale sia il loro rapporto con la più generale letteratura in lingua tedesca. Per illustrare meglio la lacuna e la mancata risposta lascio la parola al ricordato Klaus Groth, l’unico dei tre citati che abbia avuto ambizioni teoriche e che a tal fine abbia affrontato degli studi (appoggiati da accademici, come si vedrà, e giunti a riconoscimenti accademici: dal 1886 fu professore presso l’università di Kiel). In saggi usciti tra il 1865 e il 1866 (Erhaltung der Volkssprache, Conservazione del linguaggio del popolo), in cui sosteneva idee da lui peraltro propugnate in numerose occasioni e su un lungo arco di tempo, Groth accusava Jakob Grimm di considerare i dialetti come prodotti decaduti da un comune ceppo unitario e per conseguenza rozzi. Forse Groth citava a memoria (sebbene tra virgolette) e quel che dice non si ritrova così in Grimm; importante è però che Groth non si sentisse per nulla protetto e garantito dal “padre della germanistica”. Del resto nella dedica a Gervinus, posta in testa alla Geschichte der deutschen Sprache (Storia della lingua tedesca, 1848), Grimm scriveva che «i membri interni di un popolo devono aggrupparsi o dividersi in base ai loro dialetti» e che perciò non devono esserci (come c’erano allora) quattro Turingie e due Assie; ma aggiungeva subito che «ogni ceppo, il cui onore ci è mostrato dalla storia, deve gioiosamente sacrificarsi alla più grande Germania.» Di certo un Groth non si sentì incoraggiato da un atteggiamento del genere. Si può obiettare che a quel tempo Grimm aveva dalla sua validi motivi, o che comunque allora le cose andavano così; si può aggiungere che Grimm stesso era un ammiratore del vigore linguistico di un Gotthelf e, fa di più, che Groth ebbe dei protettori chiaramente discendenti da una cultura alla Grimm: Max Miller (1823-1900), linguista e orientalista, e so122 prattutto Karl Müllenhoff (1818-1884), germanista fra i più in vista e per un certo tempo il più in vista in assoluto, che si impegnò per Groth come forse nessun altro. Il dialetto restava comunque una realtà culturale di secondo piano e l’atteggiamento della prima metà del secolo (l’unità nazionale innanzitutto) non cambiò sostanzialmente, anzi venne rafforzato dopo l’unificazione della Germania (quando dal consolidamento dell’unità si passò a una politica di espansione). Oggi l’atteggiamento potrebbe essere diverso: crescere attraverso le differenze; ma lavori storici che obbediscano a questo principio non ci sono ancora, quel che si può leggere sull’argomento è ancora troppo arretrato (al di là delle tante notizie raccolte), a volte preoccupantemente arretrato, come se fosse impossibile scrollarsi di dosso i pregiudizi ereditati dall’età guglielmina e successive. Una storia della letteratura tedesca secondo geografia e localizzazione, comprendente sia la Hochsprache sia i dialetti, è ancora di là da venire. E quella che poteva essere una terza risposta è mancata e manca alla percezione. Né ci vengono aiuti dai critici dell’Ottocento. Jacob Grimm, Robert Prutz (1816-1872) e Julian Schmidt (1818-1886, un critico che rincontreremo come uno fra i maggiori teorici del realismo) preferirono Reuter a Groth. Si può essere d’accordo; ma ciò significa anche necessità di riflettere su una dichiarazione di Reuter a Schmidt, contenuta in una lettera del 20.3.1861; Reuter vi accettava una «limitazione della letteratura plattdeutsch a temi della vita piccoloborghese»; era sua convinzione che una letteratura del genere doveva cedere senz’altro il passo alla letteratura in Hochsprache. In fondo questa era la condizione alla quale i germanisti erano disposti ad accettarla; a essa andavano tutti i riconoscimenti (compresi quelli accademici a Groth), ma entro questi limiti. Nemmeno Groth ci dà grandi appigli per cambiare punto di vista: gli strumenti teorici che aveva a disposizione erano anch’essi di derivazione romantica; anzi egli non faceva che restringere il punto di vista di Grimm: se lo spirito del popolo si manifesta nella lingua, allora quello della sua regione si esprime nel Plattdeutsch, che va unificato, normato attraverso regole grammaticali, ortografiche e quant’altre, e affermato come lingua scritta accanto allo Hochdeutsch. Era un programma culturale inaccettabile allora e di nessun aiuto oggi. Questo capitolo resta pertanto non scritto poiché in realtà non si tratta di un capitolo ma di un cambiamento di prospettiva, per il quale né io né, a quanto pare, altri siamo pronti. 123 II, 1, 5. La satira Torniamo per un momento a Immermann e alla logica complessiva del suo Münchhausen: per una parte esso si apre ai valori positivi che crede di identificare nella Dorfgeschichte, per un’altra esso costruisce una satira contro una serie di pseudovalori. Tuttavia occorre precisare che i due mondi sono fra loro collegati: Münchhausen è il cialtrone inseguito dal conte Oswald von Waldburg, avendo il primo fatto discorsi imprudenti sulla cugina del secondo; ma si scoprirà che Münchhausen, oltre che un cialtrone, è anche padre della trovatella Lisbeth, la figura di donna positiva che agisce nello Oberhof e di cui Oswald si innamora. Ciò risparmia a Münchhausen la meritata punizione a opera dell’inseguitore, ma in compenso l’autore lo farà dissolvere nel nulla alla fine del romanzo. A tenere il campo restano le figure positive, che risultano tali nel contatto fra il meglio del mondo nobiliare e il meglio del mondo contadino. I valori di quest’ultimo – l’abbiamo già visto – sono affidati alla Dorfgeschichte. Del mondo nobiliare fa le lodi lo stesso barone Münchhausen, che pure è vissuto facendosene beffe e che ha usurpato il titolo di nobile, non essendo affatto barone ma (a quanto pare di capire) una via di mezzo fra il callifugo e qualcosa di peggio. «La nobiltà è una magia» perfino quando il titolo è inventato. Immermann mette in bocca a Münchhausen una dichiarata citazione da Heine, secondo il quale Mirabeau non avrebbe mai avuto il coraggio di far tremare il trono di Francia se non fosse stato un conte lui stesso. In altre parole, il rinnovamento deve cominciare a opera di una parte della stessa classe dirigente; nel caso specifico, della nobiltà. Finché però si resta alla dimensione negativa del mondo nobiliare, esso è tutto oggetto della satira, e cioè di accuse, condotte con mezzi comici, il cui fine è la dissoluzione dell’oggetto in vista di una nuova costruzione, sia nella letteratura sia nella realtà. La figura stessa di Münchhausen è più complessa; oggetto lui stesso di satira, è però autore di riflessioni sulla satira. Nell’epoca presente, dice Münchhausen, l’eroismo è finito: Napoleone l’ha consumato tutto; capi politici veri non se ne vedono; lo speculatore (in filosofia e in borsa), l’originale, l’infelice sono mestieri e atteggiamenti superati. «Che cosa resta? Mentire, far fuochi d’artificio, produrre frottole. […] Ho speculato sulle follie: è il gioco d’azzardo più alto e nobile che ci sia.» Se un Münchhausen muore, con lui «muore tutta una stirpe divina di trovate, fantasie, incomparabili salti del ghiribizzo e dell’inventiva.» Tutte cose insostituibili. Münchhausen mette a nudo come tutta la vita si costruisca su menzogne, che però ricevono altri nomi: onore, fedeltà, amor di patria e via e via, mentre i veri motivi delle azioni restano inespressi. Agli occhi di questo Münchhausen la vita si riassume in «una febbre del nulla, dunque un nulla malato!» Dunque l’eroe eponimo è oggetto di satira, ma anche veicolo di satira e un satirico lui stesso. L’autore lo fa infine scomparire insieme col mondo criticato: crollato il castello in cui ci sono state mostrate le sue avventure, la sua missione sulla terra è finita e l’autore ne sceneggia la misteriosa, 124 definitiva scomparsa. Il mezzo che Immermann più usa nella sua satira è la parodia. Come già accennato altrove, più parodiato nel romanzo è Hermann von Pückler-Muskau (1785-1871), una divertentissima figura la cui produzione letteraria cadde tutta fra due rivoluzioni: cominciò nel 1830, terminò nel 1848. La sua opera più celebre fu la prima: Briefe eines Verstorbenen. Ein fragmentarisches Tagebuch aus Deutschland, Holland, England, Wales, Irland und Frankreich, geschrieben in den Jahren 1826 bis 1829 (Lettere di un defunto. Diario a frammenti, scritto dal 1826 al 1829 in Germania, Olanda, Inghilterra, Galles, Irlanda e Francia). Pubblicate anonime nel 1830, queste lettere erano state rese pubblicabili attraverso una scelta e una attività redazionale operate da Karl August von Varnhagen e da sua moglie Rahel Levin, attratti verosimilmente dalla critica sociale che vi leggevano. Il principe Pückler-Muskau era infatti di sentimenti liberali e la sua descrizione sardonica di tante usanze nobiliari era convincente. Ebbe occasione di dimostrare che faceva sul serio quando si offrì di tenere prigioniero lo jungdeutscher Heinrich Laube quando nel 1835 dovette scontare una pena detentiva per reati di stampa: mai prigionia fu più piacevole. I Briefe furono un immenso successo, aiutato anche da un’entusiastica recensione di Goethe. Laube e Heine ne curarono la traduzione francese; ebbe successo anche quella, così come pure una traduzione inglese. Börne recensì invece quelle Lettere con molta serenità; da sottolineare che ne stroncò quanto in esse pretendeva essere satira, sia perché insipida sia perché basata su concezioni esse stesse troppo vecchie. Il libro di quest’autore che forse più va ricordato sono le Andeutungen über Landschaftsgärtnerei verbunden mit der Beschreibung ihrer praktischen Anwendung in Muskau (Cenni di giardinaggio paesistico e descrizione della sua applicazione pratica a Muskau, 1834): sono la giustificazione teorica e la descrizione dell’immenso parco all’inglese (oltre 500 ettari) che Pückler-Muskau stava realizzando nei suoi possedimenti, che non portò mai a termine (ma ne fece un bel pezzo), che vendette perché lo completassero altri, mentre col ricavato della vendita ne sistemò un altro più piccolo (pur sempre oltre 200 ettari). Come personaggio ispirò molte opere; tra queste va segnalata almeno la più grande, il racconto Die Narrenburg (Il castello dei pazzi) di Adalbert Stifter. Gran parte della storia della letteratura tedesca potrebbe venir riscritta come storia della satira; un inizio in questo senso è anche stato fatto. Per quel che riguarda il nostro periodo, va notato che la produzione satirica si lascia dividere abbastanza bene fra le due metà del secolo: sostanzialmente più ambiziosa nella prima metà, ma più inventiva di forme nuove nella seconda metà, quando deve tener conto della diffusione di massa. Nella presente sede gli autori satirici non vengono trattati a parte e la presente rubrica serve eminentemente a richiamare l’attenzione del lettore sull’importanza di questo settore produttivo. È questo però il luogo per segnalare a parte due autori, riscoperti in tempi recenti, la cui produzione si segnala per la particolare buona riuscita del suo lato 125 satirico. Il primo di loro è Georg Weerth (1822-1856), che scrisse dal 1842 al 1849, cioè ammutolì col fallimento della rivoluzione. Viene particolarmente lodato un suo breve romanzo, Leben und Taten des berühmten Ritters Schnapphahnski (Vita e gesta del celebre cavaliere Schapphahnski, 1848-1849), scritto a imitazione di Heine e pubblicato a puntate sul giornale diretto da Karl Marx, “Neue Rheinische Zeitung”, prima di essere raccolto in volume. Si tratta del primo romanzo tedesco a puntate, una forma di pubblicazione importata dalla Francia; il risultato per Weerth consistette in un buon successo e in tre mesi di prigione (da lui scontati nel 1850) perché il modello reale di Schapphahnski era troppo riconoscibile. Il romanzo è effettivamente gradevole, ma forse Weerth ha scritto di meglio: corrispondenze per il giornale di Marx – e, prima che questo venisse fondato, per la “Kölnische Zeitung” – durante il periodo rivoluzionario. Alcuni dei suoi articoli, corrispondenze e “schizzi” rispondevano a un piano preciso. Spiccano, per il loro contenuto satirico, le Humoristische Skizzen aus dem deutschen Handelsleben (Schizzi umoristici tratti dalla vita commerciale tedesca); pubblicate nel 1848 sui due giornali nominati, esse sono un derivato da un progetto di romanzo abbandonato, cui Weerth lavorò essenzialmente nel 1846-47 e che sarebbe dovuto essere un romanzo sui rapporti di classe in Renania, con descrizioni di fabbriche e del lavoro industriale. Sarebbe stato il primo romanzo del genere; ma non riuscì, Weerth lo abbandonò e in suo luogo pubblicò le riuscitissime satire citate. Su ciò torneremo in altro luogo. Più notevole ancora è la sua produzione lirica (anche satirica), di cui si parlerà più in là. L’altro autore da segnalare è Adolf Glaßbrenner (1810-1876), la cui opera maggiore è Berlin wie es ist und – trinkt (il gioco di parole del titolo non è traducibile; così come è scritto, esso significa: Berlino com’è e come beve; scrivendo però ißt, che si pronuncia in modo di poco diverso, il titolo significa: Berlino come mangia e come beve), pubblicata in una lunga serie di fascicoli fra il 1832 e il 1837 e poi di nuovo fra il 1842 e il 1850, prima come seguace di Börne, poi con attenzione più specifica e realistica alle categorie sociali che si sarebbero fatte carico della rivoluzione. Fallita questa, Glaßbrenner, che non rinnovò i suoi ideali, si fece molto più bonario. Seguì con ciò, anzi piuttosto subì, l’evolversi del gusto del pubblico, lui che il contatto come giornalista non lo perse mai. Durante la seconda metà del secolo si arrivò alla fondazione di riviste fondamentalmente umoristiche, ma a volta anche satiriche, a grande tiratura. Ma a questo punto è necessario allargare lo sguardo al complesso editoria e pubblico. Prima di abbandonare Glaßbrenner è opportuno ricordare che nel 1839 il rifiuto della censura gli impedì di fondare una rivista settimanale insieme con l’onnipresente, duttile Varnhagen von Ense; doveva portare il titolo “Der Preuße. Freimüthige Blätter für Leben und Kunst” (Il prussiano. Fogli franchi per l’arte e la vita). 126 II, 2. Editoria e pubblico Nel 1828 Wolfgang Menzel (1798-1873) poteva scrivere nella sua Deutsche Literatur (Letteratura tedesca) che secondo una stima moderata si stampano ogni anno in Germania dieci milioni di volumi. Dal momento che il catalogo della fiera del libro pubblica ogni semestre mille nomi di scrittori tedeschi, si può supporre che attualmente vivono in Germania circa 50000 persone che hanno scritto uno o più libri. Quanto ai contenuti, Menzel ne parlava così, con riuscito umorismo: Qualunque cosa succeda, la conseguenza più importante è che ci si scrive sopra; anzi molte cose sembrano succedere solo perché se ne scriva. Però in Germania la maggior parte delle cose viene solo scritta e mai fatta. Nello stesso anno ricompariva in volume un saggio di Wilhelm Hauff (18021827), uscito due anni prima proprio sul “Morgenblatt” diretto da Menzel (Die Bücher und die Lesewelt, I libri e il mondo dei lettori); è una visione farsescoallucinante di una fabbrica di traduzioni: Nel cortile dietro l’edificio c’è la macina che produce la carta infinita; questa arriva, già asciutta, come una colata di lava, al pianterreno dell’edificio principale, dove un meccanismo la taglia in fogli che poi spinge sotto le presse della tipografia. Sono in tutto quindici presse, ciascuna delle quali fa 20000 copie al giorno. Accanto ci sono l’essiccatoio e la rilegatoria. Si calcola che la pasta per carta, ancora liquida alle cinque del mattino, è divenuta un elegante libretto già il mattino seguente alle undici, dunque in 30 ore. Al primo piano c’è l’impresa traduzioni. Ci sono due sale in ognuna delle quali lavorano in 15; a ciascuno viene consegnato ogni mattino alle 800 mezzo quinterno di Walter Scott, che deve aver tradotto entro le 1500. Questa è la cosiddetta traduzione grezza. In questo modo vengono tradotti 15 quinterni ogni mattina. Alle 1500 ricevono un buon pasto; alle 1600 viene riconsegnato a ciascuno mezzo quinterno di traduzione già stampata, da rileggere e correggere. E via di questo passo. Menzel si permette qualche approssimazione, Hauff un’atmosfera surreale, ma quel che scriveva Hauff (modesto narratore e acuto giornalista) era tutto vero alla lettera, quel che scriveva Menzel era esagerato ma non poi troppo. La produzione libraria stava rapidamente crescendo, aiutata sia da innovazioni tecniche che permettevano di stampare molto più rapidamente che prima del 1820 e di abbattere i costi, sia dall’allargarsi dei potenziali acqui- 127 renti, attratti da molteplici fattori, tra i quali ovviamente i costi (minimi per certe collane) e il tipo di diffusione (a dispense collocate da piazzisti, per determinate opere) avevano fondamentale importanza. Ecco alcune cifre. Nel 1821 vengono prodotti 4505 titoli, che crescono fino a un massimo di 14039 nel 1843; c’è poi un progressivo regresso fino a 8540 titoli nel 1856 e una risalita, per molti anni assai lenta; solo nel 1879 si raggiunge e supera il primato del 1843 con 14179 titoli. La produzione letteraria (romanzi, lirica, drammi, arte e musica) ha il primo posto percentuale all’inizio del secolo (29,4% nel 1801-05) ma retrocede progressivamente e abbastanza rapidamente; negli anni Cinquanta dominano i libri di preghiera e di teologia, la letteratura è solo al quarto posto con l’8-10%; negli anni 70-80 la percentuale crescerà fino intorno al 12%, ma la letteratura resterà sempre al quarto posto. La diffusione è capillare: le librerie salgono da 729 nel 1832 a 887 nel 1843 a 3375 nel 1880; a queste vanno aggiunte le ditte di soli piazzisti (856 in tutto). Le tirature erano assai varie; le collane economiche tiravano gli esemplari a centinaia di migliaia, queste però davano o solo traduzioni (perché non si pagavano i diritti d’autore) o classici tedeschi non protetti dal diritto d’autore (che per Goethe, Schiller ecc. venne a scadenza nel 1867). Particolare successo ebbero le enciclopedie: Brockhaus pubblicò la sua in una prima edizione in 6 volumi e in sole 2000 copie nel 1809, ma all’11a edizione in 15 volumi del 1864-68 si era a oltre 300000 copie. Di norma però le tirature erano basse: da 600 a 800 copie per un romanzo, da 250 a 500 per un volume di poesie, intorno alle 500 per un dramma. I bestsellers, per esempio Barfüßele di Auerbach, potevano arrivare molto più in là (in questo caso 17000 copie vendute in un anno), ma erano appunto eccezioni. Il mercato era costituito in primo luogo dalle “biblioteche circolanti”: si pagava una modesta tassa d’iscrizione per avere libri in prestito; in vista di questo mercato, i libri venivano preferibilmente stampati in più volumi, in modo che, dandone in prestito uno alla volta, questo restasse presso l’imprestatario meno tempo di quanto vi sarebbe restato un libro stampato in un solo volume. Tre quarti della produzione andava a tali biblioteche; in Effi Briest (1894-95) la protagonista non compra libri ma invia la domestica a prenderne in prestito uno dalla biblioteca circolante; quelli che si compravano (e le case editrici lungimiranti cercavano di stabilirsi anche in questo settore per poter pubblicare letteratura senza fallire) erano libri di preghiere oppure manuali tecnici per le varie professioni oppure libri di scuola, a parte quelli che circolavano a opera dei piazzisti (centinaia di migliaia di copie) o che venivano venduti a dispense e a parte le collane ultraeconomiche, il cui prezzo per volume era inferiore all’abbonamento alla biblioteca. C’erano alcune eccezioni; per esempio una collana di romanzi che oggi chiameremmo di largo consumo (la collana si chiamava “Album” e uscì dal 1845 al 1876) stampava 3000 copie per titolo, di cui ben 7-800 copie venivano vendute a privati (il resto alle biblioteche); altre imprese però non furono altret128 tanto fortunate. Il numero esatto delle biblioteche circolanti non è noto; ufficialmente ne esistevano 617 nel 1865 e 1056 nel 1880; in realtà pare fossero molte di più e che già nel 1855 ce ne fossero 2000; la maggior parte, evidentemente, non erano ufficiali e di quelle ufficiali molte, soprattutto in provincia, dovevano possedere ben pochi volumi (intorno ai 2000), soprattutto letteratura di consumo, anche invecchiata; quelle grandi e ufficiali arrivavano invece anche a 50000, le più grandi a 500000. Di che cosa potesse essere una biblioteca circolante di provincia può darci un’idea l’autobiografia di Karl May, Mein Leben und Streben (La mia vita e i miei sforzi, 1910), di cui avremo occasione di riparlare. Siamo in una cittadina della Sassonia intorno alla metà dell’Ottocento; ragazzo, May deve lavorare servendo un campo di bocce annesso a una birreria. Il birrario gestisce anche una biblioteca circolante, che Rendeva in maniera straordinaria, essendo l’unica delle due cittadine [Hohenstein e Ernstthal]. Acquisti nuovi non se ne facevano. L’unico cambiamento era che le copertine diventavano sempre più sporche e i fogli sempre più unti e logori. Ma i lettori erano sempre lì a divorarne il contenuto [… Eccone] alcuni titoli: Rinaldo Rinaldini, capo dei briganti di Vulpius, il cognato di Goethe. Sallo Sallini, il nobile capo dei briganti. Himlo Himlini, il benefattore capo dei briganti. La caverna dei briganti sul Monviso. Bellini, l’ammirevole bandito. La bella sposa del brigante, ovvero La vittima del giudice ingiusto. La torre della fame, ovvero La crudeltà delle leggi. Bruno von Löweneck, l’ammazzapreti. Hans von Hunsrück ovvero Il nobile brigante che difende i poveri. Emilia, la monaca murata viva. Botho von Tollenfels, salvatore degli innocenti. La sposa sul patibolo. Il re assassino. I peccati dell’arcivescovo, eccetera eccetera. C’erano però altri veicoli per la diffusione letteraria: le riviste. Nel 1863 venne fondata la “Deutsche Roman-Zeitung” (Rivista tedesca di romanzi), che pubblicava romanzi sotto forma di periodico; erano anch’essi romanzi pensati per il largo consumo e la rivista arrivò a tirare più di 15000 copie. Tra le riviste c’è però da distinguere. Da una parte c’erano quelle (si sarebbe detto in seguito) impegnate sul piano letterario o della politica culturale; dall’altra riviste che volevano soddisfare i gusti del pubblico e puntare al largo successo commerciale; altre, infine, cercarono di combinare i due tipi. Il numero globale delle riviste non è certissimo perché le statistiche non concordano: secondo alcuni si va dalle 371 nel 1826 alle 688 nel 1848 su su fino alle 1971 del 1875; altri invece contano dalle 579 nel 1841 alle 1102 già nel 1850. Chiaro, comunque, è il crescere della loro diffusione. Tra le riviste impegnate vanno contate il “Telegraph für Deutschland” (Telegrafo per la Germania) diretto da Karl Gutzkow e gli “Hallische Jahrbücher” (Annali hallensi) diretti da Arnold Ruge: avevano dai 500 ai 600 abbonati. In generale le riviste vendevano assai poco; la stragrande maggioranza era sotto i mille abbonati, il 20% arrivava da 1000 a 2500 e solo il 4% superava i 5000. Nel 1833, a imitazione dell’inglese “Penny 129 Magazine of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge”, venne fondato il “Pfenning Magazin der Gesellschaft zur Verbreitung Gemeinmütziger Kenntnisse” (Rivista da un centesimo, a opera della società per la diffusione di conoscenze di utilità generale; con titolo leggermente mutato durò fino al 1855), un settimanale di otto pagine in quarto che usciva ogni sabato e il cui abbonamento era estremamente basso: cominciò con 35000 copie e salì presto a 100000; era una rivista di intrattenimento, attraente per le molte illustrazioni, apolitica, destinata alle classi borghesi in ascesa. Ce ne furono varie imitazioni, finché negli anni Cinquanta arrivò a formarsi e a imporsi la “rivista per famiglie”, prima fra tutte e modello per tutte “Die Gartenlaube” (Il pergolato), fondata nel 1853 con 5000 copie e arrivata al massimo nel 1875 con 382000. Seguì una serie di imitazioni, che però non arrivarono a quel successo. Vanno elencati a parte i giornali umoristici, primi fra tutti il berlinese “Kladderadatsch” [=Patatrac] (50000 copie) e il monacense “Fliegende Blätter” (Fogli volanti; vi collaborò Wilhelm Busch). Gutzkow, sempre sulla breccia, cercò una sintesi fra la rivista letteraria e quella per famiglie con “Unterhaltungen am häuslichen Herd” (Conversazioni al caminetto, 1853-64), arrivando a pubblicare 6000 copie, mentre i puramente letterari “Grenzboten” (Messaggeri di confine; suoi avversari) erano intorno alle 1000 copie. Tutte queste riviste pubblicavano anche racconti o romanzi a puntate. Alla “Gartenlaube” collaborò pur sempre Stifter. Comunque e in generale anche queste riviste erano veicoli per la diffusione di creazioni letterarie; di solito anzi i romanzi uscivano prima su rivista e poi in volume: le riviste fornivano un lancio pubblicitario e anche degli onorari non disprezzabili, tanto più che vendevano più di quanto non avrebbe poi venduto il romanzo in volume. Buona parte dei romanzi analizzati in questo volume seguì questo itinerario. Vanno segnalati ancora due avvenimenti importanti: il 30 aprile 1825 venne fondata l’associazione dei librai tedeschi, cui a metà degli anni Quaranta aveva aderito circa la metà di tutti i librai; essi promossero delle iniziative di informazione comune, altre contro le edizioni pirata e condussero con i governi trattative che portarono a una legislazione prima contro le edizioni dette (1835) e poi, negli anni Quaranta, a una regolamentazione del diritto d’autore. Molto minor successo ebbe il tentativo di organizzare gli scrittori, che pure venne tentato fra il 1840 e il 1845. 130 II, 3. I teatri. Teoria e prassi Il teatro romantico tardò ad affermarsi. Il ritardo riguardò sia i testi teatrali sia le tecniche della messa in scena. La commedia Ponce de Leon di Clemens Brentano venne messa in scena al Burgtheater di Vienna nel 1814 in un rifacimento dal titolo Valeria oder Vaterlist (Valeria ovvero L’astuzia paterna) e cadde dopo un sola recita. Achim von Arnim e Joseph von Eichendorff non arrivarono affatto sulle scene; Kleist si tentò più volte di portarcelo ma senza grandi esiti: Kättchen von Heilbronn, data a Vienna ancora in vita dell’autore (1810), fu recitata con cambiamenti notevoli; lo stesso avvenne per l’edizione che già l’anno seguente ne mise in scena Hoffmann a Bamberg (pare con notevoli effetti per quanto riguarda la scena dell’incendio). Kättchen comunque ebbe una certa fortuna perché seguirono delle messe in scena a Monaco (1816), a Breslavia (1817) e di nuovo a Vienna (1821). E a Vienna venne messo in scena nel 1821 anche il Prinz von Homburg (Il principe di Homburg), profondamente cambiato e con altro titolo (Die Schlacht bei Fehrbellin, La battaglia di Fehrbellin); così passò a Francoforte e Amburgo, per approdare infine a Dresda, dove Tieck aveva altri intendimenti. Del resto i primi romantici non sentivano Kleist come uno di loro. Tuttavia il romanticismo aveva il suo effetto: aumentarono nei repertorî le féeries popolari e drammi a effetto con fantasmi e simili. Furono soprattutto questi a diffondere l’immagine più consueta del romanticismo teatrale, che certo non aveva molto in comune con quello dei romantici maggiori. Altro discorso conviene per Zacharias Werner (1768-1823); costui viene considerato l’unico autore romantico che abbia avuto successo sulle scene, ma sul suo romanticismo lascia qualche perplessità proprio la sua carriera. La sua tragedia di maggior successo e condizionatrice di tanti sviluppi, Der vierundzwanzigste Februar (Il 24 febbraio), fondò il cosiddetto Schicksalsdrama. Presupponeva bensì Die Braut von Messina (La sposa di Messina) di Schiller; ed era stata preceduta da un tentativo romantico di andare nella stessa direzione (con il Beneck di Tieck, 1797); ma nasceva attraverso un accordo con Goethe, che l’aveva commissionata per lo Hoftheater di Weimar da lui diretto, dove ebbe la prima esecuzione pubblica il 24 febbraio 1810 (c’era stata un’esecuzione privata a Coppet alla presenza di M.me de Staël; uno degli attori era stato August Wilhelm Schlegel). Fu dunque da Weimar che questa tragedia cominciò i suoi grandi successi, fu Goethe a lanciarla. Data l’osmosi che a quell’epoca ancora c’era tra Goethe e i romantici, il successo weimariano non parlerebbe contro il romanticismo di Werner se non ci fossero altri elementi da considerare, in primo luogo la tecnica di recitazione: nel teatro di Weimar gli attori si disponevano tutti sulla stessa fila e parlavano rivolti al pubblico; e poi un altro elemento: fuori Weimar fu Iffland che portò al successo Werner in altre sue opere (non nel 24. Februar, che disapprovò) e Iffland era tutt’altro che un attore romantico. Werner dunque si affermava attraverso vie 131 non romantiche; il teatro romantico stentava a venir fuori nella sua concezione complessiva. Fu Ludwig Tieck (1773-1853) che mise le basi affinché ciò fosse possibile; ma ciò avvenne tardi, quando il romanticismo come produzione di testi era limitato ai pochissimi tardoromantici (e ai tanti pseudoromantici). Nel 1819 Tieck si stabilì a Dresda, dove cominciò subito a dare pubbliche, celebri e frequentate letture, soprattutto da Shakespeare: erano delle dimostrazioni concrete di come egli intendeva il teatro. Prestissimo venne scelto come consulente dello Hoftheater, di cui influenzò il repertorio; per suo consiglio venne messo in scena Shakespeare e, cosa fondamentale, il Prinz von Homburg di Kleist. Nel 1825 Tieck diventò drammaturgo: doveva dare il suo parere su lavori nuovi, proporre come assegnare le parti, eseguire gli adattamenti scenici del caso e in generale preparare i testi per la scena, leggere i nuovi lavori agli attori. Era un importante passo avanti ma non era ancora la regìa. Fino al 1832 Tieck influenzò il cartellone secondo idee romantiche: ebbero posto Goethe (Tasso, Faust), Shakespeare (Enrico IV, Otello, Giulio Cesare), Lope de Vega, Grillparzer (Ein treuer Diener seines Herrn, Un fedele servitore del suo signore) e ancora Kleist (Der zerbrochene Krug, La brocca rotta), ma anche la commedia viennese con Bauernfeld (1802-1890); dopo il 1832 sembra cercare più l’effetto e la cassetta: ecco allora Ernst Raupach (1784-1852) e Charlotte Birch-Pfeiffer; d’altra parte ecco ancora Grillparzer (Der Traum ein Leben - Il sogno, una vita -, Medea) e, cosa molto notevole, il primo dramma jungdeutsch, Richard Savage di Gutzkow. Fondamentali poi le edizioni che Tieck fece di Lenz e di Kleist. Nel 1841 Tieck lascia Dresda per Berlino, chiamato al Königliches Theater e qui finalmente fu regista; fondamentali le regie dell’Antigone di Sofocle con musiche di Mendelssohn, del Gestiefelter Kater (Il gatto con gli stivali) di Tieck stesso (senza troppo successo) e soprattutto del Sogno di una notte di mezz’estate, ancora con musiche di Mendelssohn (14 ottobre 1843). Tieck fece costruire una scena su tre piani: dal piano più basso una doppia scalinata, le cui rampe salivano intorno a una grotta centrale, portavano a un primo ripiano; al disopra di una fila d’alberi c’era poi un ulteriore ripiano. Comprese le comparse, si muovevano sulla scena un centinaio di persone. Ebbe in tempi brevi quaranta repliche ma restò in repertorio fino al 1885, con complessive cento sessantanove repliche; era il vero trionfo della concezione romantica del teatro, fu qui che cominciò in pratica ciò che era già stato teorizzato da A.W. Schlegel e cui in seguito Wagner diede il nome di Gesamtkunstwerk. Tieck curò particolarmente i ritmi della recitazione, volle una scena mai troppo alta e raddoppiò il proscenio, su cui faceva svolgere molte delle scene fondamentali. Tutto ciò era già contro Goethe; la recitazione di profilo invece che esclusivamente frontale coronava il distacco. Mentre Tieck era ancora a Dresda, operava a Düsseldorf, come direttore artistico e regista, Karl Immermann, vicinissimo alle concezioni di Tieck; diresse il teatro di quella città dal 1832 al 1837. Immermann concepiva una scena che si 132 avvicinasse il più possibile allo spettatore; sottolineava l’importanza primaria del regista; sottolineava i limiti della decorazione. Impostava il suo lavoro nel seguente modo: dava lettura dell’opera da rappresentare; seguivano prove di lettura da parte dei singoli attori, quindi una lettura generale comune; avevano poi luogo le “prove in camera”, cioè atti o scene provati senza decorazione, in modo che l’attore tendesse al massimo la propria fantasia; seguivano infine le prove sulla scena. Particolarmente importanti risultavano le seguenti messe in scena: Kleist, Der Prinz von Homburg (1833); Shakespeare, Amleto (183 ); ma soprattutto Tieck, Ritter Blaubart. Ein Ammenmärchen (Il cavalier Barbablù. Fiaba per bambini; 3 maggio 1835), una sceneggiatura che fece epoca. Immermann costruì la sua regia secondo i principî del crescendo e diminuendo; curò molto i costumi e pose molta attenzione a che il grottesco venisse recitato adeguatamente. Particolarmente riuscita fu l’ultima scena, nella quale Immermann usò tutto il teatro come altana, così che gli spettatori erano parte stessa dell’azione. Di Immermann si lodano poi, in generale, gli effetti di luce e nel Blaubart, in particolare, gli effetti di chiaroscuro. Memorabile anche la messa in scena del Faust (8 novembre 1834). Da ricordare, infine, che Immermann mise in scena anche Nestroy, Raimund e Bauernfeld. Ma solo dopo aver lasciato la direzione del teatro di Düsseldorf riuscì a Immermann nel 1840 la sua miglior resa. Si trattò di una recita privata di Shakespeare, As you like it. Con l’aiuto di amici pittori, Immermann costruì una scena assai larga e poco profonda, così che la vicenda scenica avesse un po’ l’andamento di un bassorilievo; la decorazione fu costruita così da essere allusiva invece di schiacciare l’azione e, al contrario, di lasciare spazio alla fantasia degli spettatori. Per stabilire uno stretto contatto fra testo, scena e pubblico, Immermann fece svolgere gran parte delle scene più importanti sul proscenio, allungato fino alle prime file degli spettatori. Solo dopo il successo di Immermann Tieck seguì a Berlino vie analoghe. La tradizione di Immermann venne ripresa a Monaco nell’ultimo decennio dell’Ottocento e nel primo del Novecento. E se si mette nel novero anche il nascere e l’affermarsi dell’opera romantica (Undine di Hoffmann, 1816, ma soprattutto Der Freischütz - Il franco cacciatore di Carl Maria von Weber, 28 giugno 1821), la cronologia del teatro romantico nei suoi successi va costruita così: dapprima l’opera, quindi Immermann, infine Tieck. 133 II, 4. Riflessioni sul dilettantismo La teorizzazione del dilettante comincia in Germania nell’ultimo decennio del Settecento. Quella di Goethe e Schiller non è la prima, verrà per di più conosciuta piuttosto tardi (scritta nel marzo-maggio 1799 a Jena, verrà pubblicata solo nel 1832 tra le opere di Goethe); ma è quella dall’impostazione più ampia e, una volta conosciuta, eserciterà grande influenza. Sarà bene cominciare da qui, recuperando poi quanto ha preceduto. Scritti in comune da Goethe e Schiller nel marzo-maggio 1799 a Jena, questi abbozzi dovevano costituire la base per un articolo da pubblicare sui “Propilei”, la rivista d’arte destinata a educare un pubblico affinché a sua volta esso fosse fondamento e humus per una grande produzione artistica. L’articolo non fu mai scritto per esteso e anche la rivista ebbe breve vita, spiazzata dalla concorrenza del gusto romantico, contro il quale negli abbozzi ci sono nette prese di posizione. Di dilettantismo si parlava in Germania già da un po’ (della cosa, se non del termine); nella sua orbita si muoveva il romanzo autobiografico di Karl Philipp Moritz Anton Reiser (1785-90); dilettante era stato lo stesso Werther di Goethe (Die Leiden des jungen Werthers - I dolori del giovane Werther - sono del 1774) e anche il suo Wilhelm Meister (i Wilhelm Meisters Lehrjahre - Gli anni d’apprendimento di Wilhelm Meister - furono pubblicati nel 1795-96). Ma si trattava di personaggi negativi (il primo) oppure che rinsavivano (il secondo). Anche i romantici parlavano di dilettanti, ma in tutt’altro modo: il Berglinger di Wackenroder (Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders - Effusioni di un monaco amante dell’arte -, 1796) non rinsaviva e finiva male, ma del suo finir male l’autore era compartecipe e non ne aveva scritto la biografia a scopi terapeutici, come Goethe aveva fatto per Werther: la dilacerazione era cosa che i romantici proclamavano e, se del caso, vivevano. Avevano appunto un altro modo di avvicinare la realtà. Gli abbozzi di Goethe e Schiller sono rimasti tali, ma la loro sistematicità è stringente. Un breve riassunto lo renderà evidente. Il dilettantismo è necessario per tre motivi: 1. è una conseguenza necessaria del diffondersi delle arti e dunque di un’educazione adeguata alla partecipazione ad esse; 2. è una conseguenza necessaria della stessa natura comunicativa delle arti; gli artisti ne hanno bisogno poiché le arti vogliono provocare godimento, questo richiede partecipazione e quest’ultima provoca inevitabilmente produttività; il godimento non è dunque possibile senza produttività; 3. in tale produttività si realizzano gli impulsi umani: l’impulso a esprimersi, l’impulso a imitare, l’impulso a plasmare. 134 È dunque un triplice ordine di necessità: 1. storica, 2. sociale, 3. istintuale. Dalla necessità si ricava anche l’utilità del dilettantismo: 1. esso forma dei conoscitori; 2. potenzia le capacità umane anche in funzione della vita pratica; 3. sviluppa corpo e mente nella libertà e nella formazione di concetti. Ma se passiamo a osservare in che modo artista e dilettante si differenziano ci renderemo facilmente conto dei danni del dilettantismo. L’arte risponde a leggi, richiede delle abilità e mira alla verità dell’oggetto. Invece il dilettante non vuol sapere di leggi, non si sottopone allo sviluppo rigoroso di abilità e si allontana dalla verità dell’oggetto poiché si lascia attrarre da ciò che gli è vicinissimo. Pertanto eccone i lati negativi: 1. l’educazione colta diventa giustificazione del vivere borghese, della coltivazione di valori medi e mediocri; dell’esaltazione del possesso di oggetti d’arte; 2. l’estremo soggettivismo lavora in senso opposto alla spinta alla socievolezza, porta cioè all’isolamento, alla fiacchezza di carattere, all’incertezza e insicurezza; 3. tutto ciò a sua volta si ritorce a danno della libertà, che ne risulta limitata. Dei singoli dilettantismi viene dato un giudizio differenziato, a seconda che si rivolgano ad arti in cui il soggettivismo abbia una parte maggiore oppure minore. Ma nel complesso il dilettantismo viene visto come più dannoso che utile, sia al soggetto sia soprattutto alle arti. Nel suo effettivo articolarsi, il testo va oltre lo sviluppo di quest’impianto. È interessante sottolineare almeno altri tre elementi: il giudizio sulla borghesia (cioè sulla premessa sociale del dilettantismo), la polemica coi romantici, la proposta alternativa. II, 4, 1. La borghesia. L’educazione colta (l’abbiamo appena detto) diventa giustificazione del vivere borghese. E la borghesia viene ritratta in due suoi caratteri essenziali: la brama di possesso e la spinta al livellamento. Goethe dedicò al collezionista un lungo saggio romanzato (Der Sammler und die Seinigen, Il collezionista e i suoi), 135 concepito anch’esso insieme con Schiller e poi effettivamente pubblicato sui “Propilei” (1799), la sfortunata rivista cui era destinato il nostro articolo; in quel saggio il collezionista viene inserito nella storia di una famiglia che si sviluppa socialmente e culturalmente, quindi il ritratto risulta più complesso e variegato. Nel testo sul dilettantismo esso è in compenso più incisivo e per questo più “cattivo”. Il collezionista viene definito utilissimo; ma non si dimentica che si tratta pur sempre di un tiranno che vuole imporre il proprio parere, che in definitiva vuole mettere in mostra se stesso, vuole asservirsi l’artista; il sostegno finanziario raggiunge questo scopo. Ricordiamo che all’epoca dell’articolo era bruscamente finita (o stava finendo) la forma nobiliar-feudale di sostegnoasservimento: scompariva l’orchestra di corte, per esempio, con musicisti e musicanti ingaggiati nel personale di servizio; il mecenatismo dei principi prendeva altre forme: Goethe stesso non era il poeta di una corte ma un funzionario pubblico di uno stato, che come compito non aveva quello di scrivere poesie ma di svolgere lavoro amministrativo. Il trapasso delle forme conosceva momenti intermedi e non poca vischiosità, tuttavia non si ritiene in genere fuorviante sostenere che il «sostegno economico» era affidato ormai al mercato. Goethe e Schiller non dicono «mercato» ma dicono «modo di vivere borghese»; non pare che ci sia molta differenza. Il collezionista vi figura come acquirente, con le ingiustizie e i condizionamenti a lui imposti dalla cultura, ma che soprattutto vuole imporre alla produzione artistica, conformandola ai propri gusti. È la smania di possesso a formare il mercato, è la carriera della borghesia verso la ricchezza e la cultura a condizionarlo. Tiranna ma per via indiretta, colta ma limitata ed egoistica, smaniosa di possesso, capace di imporre su larga scala il brutto e certamente il mediocre: tale appare la borghesia nel ritratto che ne dà l’articolo. E non è finita con ciò. L’arte porta alla comunicazione tra gli uomini, alla socievolezza: è l’interpretazione dell’apollineo secondo la cultura classica, destinata a lunga e complessa carriera. Nella borghesia di cui già sappiamo, la socievolezza si esplica solo in ciò che è vuoto oppure irrilevante oppure solamente appariscente: fatto per brillare, per rispondere a una moda, per soddisfare la vanità. È un decadere della dimensione comunicativa dell’arte. La borghesia è l’esteriorizzazione di tutte le specie di possesso; questo è il prezzo pagato per la sicurezza del godimento e la diffusione delle arti. Il culmine delle critiche è forse raggiunto nell’illuminare una conseguenza delle scelte cui porta la ristrettezza di orizzonti: la borghesia dà sì la scalata alla cultura, ma innanzitutto mette in primo piano se stessa e le capacità conoscitive che le sono proprie. Dunque apprezza ciò che le è vicino, senza capacità di sollevarsi a una mèta che richieda un complesso lavoro culturale; esattamente come fa il dilettante. Dunque la borghesia è nazionalista, e lo è in primo luogo sul piano culturale: si colleziona il già noto e vicino, ci si risparmia la fatica del concetto. La fase più importante (e famigerata) del nazionalismo doveva ancora venire, ma nell’articolo se ne registra il nascere. 136 II, 4, 2. Contro il romanticismo. Le dichiarazioni sul Witz e sulle nevrosi mirano ai romantici. Goethe avrebbe finito, vari anni dopo, addirittura considerando il romanticismo una malattia opposta alla sanità del classicismo. La nevrosi era per i romantici (o almeno per alcuni di loro, come il già ricordato Wackenroder) conseguenza necessaria del contrasto fra l’entusiasmo dell’artista e la miseria di questa terra. Per Goethe e Schiller questo è dilettantismo e niente di più: è mancare di sostanza, oppure di regole, oppure della conciliazione fra l’una e le altre. Il Witz, poi, viene trattato ancora peggio: a Goethe e Schiller pare sinonimo di soggettivismo, anzi di follia. Eppure per i romantici il Witz era essenziale, era il veicolo della sintesi momentanea, era il momento di comparsa dell’infinito nel finito, era il motore di tutti i capovolgimenti romantici. Ed era legato all’arbitrio, cioè alla soggettività. Ma questa appariva l’unico veicolo per accedere all’obiettività. Il Witz era tutto, e invece per i dioscuri non è che dilettantismo. Forse non si maligna poi troppo se si ritiene che sotto sotto i romantici vengano tacciati globalmente di dilettantismo! II, 4, 3. L’alternativa. Goethe e Schiller oppongono una teoria dell’oggettività e dell’ideale. Mostrano grande fiducia nella possibilità di attingere la verità dell’oggetto, di far parlare la verità oggettiva invece delle reazioni soggettive e sentimentali. In breve, propongono l’estetica classica. Non è certo una posizione ingenua; basti vedere come rivendicano il diritto dell’artista alla ricerca, e cioè all’incertezza; come sottolineino il dubbio sul merito dell’esistenza, attribuito dal dilettante (e nel caso specifico dal borghese che gli sputa dietro) a ciò che semplicemente c’è. Eppure alla fine di questi appunti, frammentari e geniali, resta da decidersi: se sentirsi più affini ai dioscuri e alla loro sicurezza nel ristabilire equilibri e di vivere in maniera equilibrata il contrasto con la realtà moderna; oppure ai romantici, che accettavano di bere l’amaro calice fino alla feccia. Gli inizi erano stati diversi. Niente lasciava prevedere la sistematicità degli appunti del 1799 e meno ancora che essi dovessero parare la svolta radicale fatta dall’idea del dilettante nella cultura romantica. Eppure agli inizi ritroviamo lo stesso Goethe: è suo infatti il primo grande esempio di eroe dilettante nella letteratura tedesca, il già menzionato Werther del 1774. Pur con tutta la partecipazione che gli viene dimostrata, Werther ci interessa qui come personaggio negativo: in quanto tale, egli esemplifica l’associazione di straordinaria sensibilità e perdita della realtà. Per Werther, che si perde nella contemplazione della natura 137 oppure della donna amata, tutto il resto non esiste. Ai suoi occhi ciò significa che l’io (il nostro sentimento in modo eminente) si fonde in un tutt’uno con l’oggetto amato e contemplato; ma a Werther stesso non sfugge che l’identificazione non è totale né totalmente comunicabile ad altri. Al contrario, quanto più intenso il sentimento, altrettanto imperiosa e dolorosa è la constatazione che l’identificazione non si lascia comunicare in forma tale che essa diventi patrimonio di tutti gli uomini. Dunque quell’identificazione conduce all’isolamento. Ora il doppio veicolo che da una parte la facilitava e dall’altra le dava una qualche espressione era costituito dalla pittura (più precisamente dal disegno) e dalla letteratura: Werther tenta più volte di disegnare i paesaggi che vede; e inoltre le sue esperienze e il suo evolversi sono accompagnati da letture (che si evolvono anch’esse, passando da Omero a Ossian). Il complesso di sensibilità, isolamento ed esperienze d’arte - così come esso è dato nel romanzo - ci consente di interpretare Werther come figura del dilettante, segnato da una scissione tra grande sensibilità da una parte e scarsissima capacità di agire dall’altra. Il sentire e il fare percorrono vie diverse; il soggettivo viene scambiato con l’oggettivo, in modo che la confusione fra queste due dimensioni provochi un perenne autoinganno. L’atto e l’attimo della contemplazione, carichi di tutta la sensibilità dell’osservatore, ipotizzano sintesi universali, senza che però ci sia alcuna forma di attività e meno che mai di interazione. Di fatto l’osservatore sta proiettando se stesso nell’osservato, aiutandosi con il riferimento a modelli letterari, che sintetizzano (o condizionano) lo stesso sentire. A dare il tocco definitivo a tutto ciò c’è l’assenza di qualunque indicazione per raggiungere effettivamente l’identificazione che parrebbe stare a cuore a Werther. L’identificazione è presentata come un valore assoluto, ma al di là di ogni procedimento reale per raggiungerla, e per di più inesprimibile e conseguibile solo nella solitudine, in opposizione a ogni consorzio umano. Si parla dunque di inesprimibilità oppure ottusità altrui, senza riflettere sulla politica. Nel 1790, nella quarta e ultima parte scritta del suo romanzo eponimo, un ammiratore del Werther, Anton Reiser, si mette in cammino col suo bravo Omero in tasca (lui stesso non sa se quest’idea gliel’ha data il romanzo di Goethe) e tante fantasie nella testa. Vuol fare l’attore e non è da disconoscere la costanza, la tenacia - ma diciamo pure tranquillamente: l’eroismo - con cui persegue tal fine. Ma ciò che gli dà forza non è il giudizio critico, non è lo sguardo aperto sulla realtà: è invece l’immaginazione, che gli trasforma tutto. Un tale è un semplice oste di villaggio? Non importa, la sua fantasia lo rende sublime. E quel convento di francescani, non dovrebbe essere sublime? Sì, forse, ma un fraticello cammina troppo in fretta, il suo passo non ha dignità poetica, perciò tutta l’immagine si immiserisce e viene liquidata come di cattivo gusto. Anton Reiser potrebbe anche rinunciare a fare l’attore per fare invece il contadino, il soldato o lo spaccapietre; ma ciò va bene solo se queste professioni diventano parti per attore. Nella fantasia l’eroe recita a se stesso la parte del soldato, ma nella realtà 138 ce la mette tutta per salvarsi dall’arruolatore. È pronto a recitare tutte le parti, ma solo perché lui stesso non ha esistenza; non vuole rappresentare niente all’esterno, ma recitare a se stesso, nel proprio interno, le parti che non può svolgere nella vita. Scambia così per mestiere e per impulso all’arte quella che è solo immaginazione e interiorità. Perfino i suoi scoraggiamenti momentanei, anzi la sua disperazione (per i quali ci sarebbe una ragione obiettiva) diventano recitazione, cioè autocompassione. Da qui passa all’odio di sé e al desiderio della morte; col che trova pace e si addormenta. (Circa un secolo dopo, Nietzsche avrebbe riassunto così: il pensiero del suicidio ci ha aiutato a superare tante notti insonni.) Di giorno fa addirittura dei progressi su questa via: si inventa la parte del perseguitato politico e del duellante, la recita agli altri e finisce col crederci lui stesso. Qualche anno dopo una via analoga seguirà un alto dilettante ancora, destinato a stabilire un modello di immensa portata: sarà il goethiano Wilhelm Meister, anche lui aspirante attore. Ma siccome vuole recitare solo se stesso, gli verrà sconsigliato di insistere; col che gli viene assicurato il lieto fine. Il romanzo di Karl Philipp Moritz è rimasto incompiuto, il destino finale di Anton Reiser non è stato esplicitato. Chiaro però è che il dilettantismo va evitato e che del dilettante va dato un giudizio negativo. Il condannabile atteggiamento del protagonista può anche essere stato causato da comportamenti altrui, però in definitiva il dilettante è lui e su lui si rovescia il giudizio negativo. Non è la cosa più facile dirgli di smetterla, di ravvedersi, di non farlo più; però è proprio questo che si desidera da lui. Insomma Anton Reiser, ottimo, colto, coraggioso giovane, ha torto e niente più; chiunque sia stato il primo colpevole (e nel suo caso sono chiaramente l’ambiente bigotto in cui è cresciuto e specificamente i genitori), è lui a scontarla. E siccome, ripeto, non è facile tirar fuori dai guai uno che vi è tanto immerso, Goethe farà partire il suo Wilhelm Meister in maniera meno disastrosa e soprattutto gli metterà alle costole un complicato apparato di salvezza; anzi farà di più: farà scrivere da altri, man mano che essa si svolge, quella vita che l’eroe crede di decidere a proprio piacimento. Così, trasformato in eroe doppiamente letterario (del romanzo di Goethe e del romanzo del romanzo), il protagonista sarà pronto per fare non certamente l’attore ma il commerciante e il padre di famiglia. Col che si è detta solo una piccola parte delle complicazioni di questo romanzo. Comunque: addio al dilettante, ben venga il borghese senza più grilli per il capo. Nel frattempo però del tema del dilettante si impadroniscono i romantici, che gli imprimono una drastica svolta. Goethe e Moritz hanno bisogno di spiegare, al lettore o direttamente al protagonista, che quest’ultimo è un dilettante e niente di più, perciò si stia in guardia! Il Berglinger di Wackenroder non ha bisogno di quest’insegnamento: sa bene di essere un dilettante, ma è proprio questo ciò che lui vuole essere! Tra vita e arte c’è contrasto? Dunque ha torto la vita, la cosiddetta realtà. Ma, certo, chi ne muore è il musicista Berglinger. Questi 139 proprio non riesce a conciliarsi con le circostanze esterne. Per suo padre la musica e l’arte in genere sono cose sospette, al servizio delle passioni e delle concupiscenze scatenate. Per i parenti la musica probabilmente va bene per accompagnare il servizio religioso, ma la mangiata che segue ha l’aria di essere più importante. Ma il peggio deve venire insieme col successo: Berglinger diventa maestro di cappella per accorgersi che la sua arte dipende dai favori della corte; esegue le proprie opere per accorgersi che il suo animo viene gettato ai piedi di gente ingioiellata e pomposamente vestita, che non sa cosa farne e comunque di solito non se ne accorge. Berglinger voleva elevarsi al disopra del mondo e invece vive in un’atmosfera soffocante. Vorrebbe dissolversi tutto nella natura e nel divino, ma pare che la cosa proprio non riesca. E il più è ancora da dire: Berglinger non vuol sapere di regole. Queste sono cosa dell’intelletto matematico, non di quel sentimento che egli vuole esprimere tutto d’un getto, come un’unica pennellata su una tela. È la stessa dimensione tecnica dell’arte che viene così rifiutata. L’armonia deve essere pura natura, la melodia puro divino. E così, tra una società che non capisce e regole che legano l’animo, l’artista contempla alla fin fine solo se stesso. Risultato: il mondo va a rotoli e lui non se ne accorge; la lotta tra il divino entusiasmo e la vile terra scinde il suo spirito dal suo corpo. Berglinger scrive un oratorio sulla passione di Cristo, che risulta un capolavoro perché il padre gli è morto e le sorelle gli sono finite male, dunque vi riversa tutta la sofferenza del suo animo e poi muore. Come epitaffio gli viene dedicata una condanna della sua fantasia, il rimprovero di non aver saputo scindere arte da vita e la constatazione che era più atto ad apprezzare l’arte che a produrne. Insomma viene definito un dilettante secondo le teorie di Goethe, Schiller e Moritz. Ma c’è un’alternativa? Sono un’alternativa reale quei Raffaello, Guido Reni e Albrecht Dürer contrapposti a Joseph Berglinger? Nel 1798 Tieck li riproporrà pari pari nello Sternbald; ma siccome tutto lo Sternbald si svolge all’epoca di Dürer, alla domanda non si è ancora risposto. Dunque: è possibile all’artista contemporaneo essere qualcosa di diverso da Berglinger? È possibile superare la fase di un dilettantismo che è autoannientamento? È possibile superare le condizioni sociali che hanno portato a ciò? Queste domande, a prima vista romanzesche, acquistano in drammaticità e in urgenza se inquadrate nel dibattito estetico-politico dell’epoca, nel quale spiccano i Briefe Über die ästhetische Erziehung des Menschen (Lettere sull’educazione estetica dell’uomo) di Friedrich Schiller (pubblicate nel 1795) e Über das Studium der Griechischen Poesie (Sullo studio della poesia greca; pubblicato nel 1797) di Friedrich Schlegel. Scritti quasi contemporaneamente, per le circostanze della pubblicazione il secondo fece da replica al primo. Entrambi constatavano la discrepanza tra l’idea unitaria dell’arte da una parte, la frammentazione della nazione e l’insufficienza dello stato (anzi: degli stati tedeschi) dall’altra; ma nella descrizione dello stato di fatto e nelle prospettive finali Schlegel era certamente 140 più drammatico di Schiller. Il discorso sul dilettante va dunque collocato su questo e sull’interpretazione che si dava della realtà politica, sociale e culturale nel suo complesso. Né i classicisti né i romantici erano ciechi; e i romantici cercavano una soluzione non meno dei classicisti, facevano però conti diversi sul prezzo da pagare. In questo dramma Friedrich Schlegel introduce una figura positiva di dilettante: è la pittrice Lucinde (1799). Non è una gran pittrice e nemmeno vuole esserlo. È dichiaratamente una dilettante. Anche i quadri di Julius, l’uomo che nelle sue braccia trova la felicità e un senso alla propria vita, non sembrano riuscire dei capolavori. Ma il senso finale di questi sforzi congiunti vuol essere altro: vuol essere la vita libera e indipendente, in opposizione alla realtà del mondo comune, alla vita così come vorrebbe esserci imposta. Solo in questo senso, come nuova creazione, la vita stessa diventa un’opera d’arte. Goethe e Schiller avevano visto le donne come veicoli essenziali del dilettantismo. Schlegel non lo nega davvero, ma nel dilettantismo vede la vita stessa che, incurante delle regole, vuole riaffermare la propria indipendenza, la propria naturalezza, la chiarezza - se è necessario anche l’ostentazione - delle attribuzioni sessuali. L’opposizione a una vita artefatta permette lo sguardo totale. Lucinde riafferma la passività femminile, la quale vuol dire valorizzazione di ogni attimo (che il dinamismo maschile vorrebbe svalutare a vantaggio della corsa da un momento all’altro), e l’interezza del sentire (che l’analisi maschile vorrebbe dissolvere in cento contrasti). Posizione forte, decisa, decisamente alternativa a quella classicista. Ma non ha successo. Nel 1804 Jean Paul, un autore per più aspetti vicino ai romantici, anzi in certe posizioni coincidente con Friedrich Schlegel, se la prende con i nichilisti adoperando un vocabolario che si può applicare tutt’intero ai dilettanti: perduti in fantasticherie, sprezzanti di ogni legge e della realtà, tutti dediti all’arbitrio della smania di sé e della considerazione unicamente di se stessi; incapaci di studiare la natura ma pronti a scambiare le proprie sensazioni con l’oggettività. E come loro capostipite cita Novalis. Prosegue, e proseguirà a lungo, l’identificazione del romanticismo col dilettantismo. Nel 1832 vengono pubblicati per la prima volta gli appunti di Goethe e Schiller sul dilettantismo. Che ci si riferisca a questi o ad altro, certo è che punti di vista a questi assimilabili si ritroveranno un po’ dovunque: negli autori dello Junges Deutschland Karl Gutzkow, Karl Immermann e Heinrich Laube, nell’autore Biedermeier Franz Grillparzer (1791-1872), nel realista Otto Ludwig (1813-1865). Però accanto a tali prese di posizione (su quelle di Ludwig torneremo), che sono interessanti ma non certo sconvolgenti, si vanno precisando punti di vista ben più meditati, decisamente originali, anzi che scompongono e ricompongono tutto il quadro, ma che alla loro epoca ebbero effetto nullo. Dobbiamo tornare ancora una volta a Goethe (sempre lui!). Nel 1809 aveva pubblicato Die Wahlverwandtschaften (Le affinità elettive). Il protagonista maschile 141 era ancora una volta un dilettante, il nobile Eduard. Werther si era sparato, Wilhelm Meister era stato salvato perché s’erano mossi cielo e terra. Cielo e terra, sotto forma di forze mitiche, si muovono anche stavolta; Eduard non si spara, però gli va male lo stesso. Questo romanzo è ben più radicale, e certamente molto più vasto e ambizioso nel suo impianto di fondo, anche se all’apparenza le sue vicende sono più anguste e tutte personali. Limitiamoci però al tema del dilettantismo di Eduard, rinunciando a un’interpretazione globale del romanzo. Eminentemente due sono le attività in cui Eduard ci appare come dilettante: come giardiniere e come esecutore al flauto. Gli arnesi che usa per il giardinaggio sono arnesi raffinati, adatti a un nobile come è lui, da riporre in un astuccio dopo l’uso. Il lavoro è solo piacere, di fatica non c’è traccia; l’unica funzione del lavoro dilettantescamente inteso è trasformare la realtà in valore estetico, degno di contemplazione. Quel che viene realmente attivato non è l’interazione con la realtà ma l’immaginazione. Ma l’altra attività ci interessa ancora di più. Eduard è un flautista dilettante, che non è mai riuscito a imparar bene la tecnica. Per di peggio i suoi tempi musicali sbagliati non dipendono neanche dall’incapacità di leggere lo spartito ma dal voler mettere in mostra se stesso, nelle sue difficoltà come nelle sue capacità. Il suo arbitrio e il suo soggettivismo sono quelli del dilettante. È ancora necessario recuperare qui uno scritto di Goethe, cui si è già accennato. Si tratta di una novella epistolare sull’arte, Der Sammler und die Seinigen, concepita insieme con Schiller e pubblicata nel 1799. Anche questo scritto appartiene alle considerazioni sul dilettantismo in una delle sue manifestazioni che Goethe e Schiller consideravano tra le più importanti (come risulta anche dagli schemi sul dilettantismo in generale): quella del collezionista. Queste due caratteristiche - collezionista e mediocre sonatore di flauto vengono riunite da Adalbert Stifter (1805-1868) nel protagonista del suo racconto Turmalin (Tormalina, 1852-53). Un altro personaggio, un attore-seduttore, rappresenta una ulteriore caratteristica del dilettante: egli è ciò che recita; non si esercita nei suoi ruoli, non vi riflette ma vi si immedesima; non interpreta ma è realmente quel che mostra. Tutte espressioni che, viste sulla linea MoritzGoethe-Schiller, ci fanno riconoscere il dilettante, al di là del gran successo che l’attore di Stifter raccoglie sulla scena. Del resto anche il protagonista è qualcuno che mette in scena la propria vita: basta leggere la descrizione della sua abitazione, coronata da una frase che, sempre letta secondo la linea citata, ci rivela ancora una volta il dilettante: limita al minimo i suoi rapporti col mondo esterno. Per certi aspetti il racconto è denuncia del comportamento di un padre che rovina la figlia; è denuncia del soggettivismo, del dilettantismo, del culto della mera apparenza. Del resto la colpa di aver rovinato la salute fisica e mentale della figlia gli viene addossata esplicitamente. E quanto al suo dilettantismo e all’amore per l’apparenza basti rinviare al suo collezionismo guidato dalla sola 142 categoria «uomini importanti», che nemmeno conosce bene, tanto che spesso deve andarsi a informare su chi siano gli uomini di cui ha raccolto i ritratti pur senza saperne nulla. Fin qui saremmo a una ripetizione - geniale e personalizzata quanto si vuole - dei dilettanti goethiani. Ma nel racconto c’è ben altro, come vedremo in altro luogo; qui basteranno gli accenni pertinenti al tema. La seconda parte del racconto è affidata a una narratrice che, parlando di sé, vuol darci un quadro di vita solida e serena, in tutto e per tutto opposto a quello del pensionato; in realtà essa rappresenta l’inconcutibile limitatezza, certezza e intolleranza del buon senso borghese. Tutte le attività di artista dilettante svolte dal pensionato (musicista, pittore, poeta, parascultore) sembrano avere un che di prevedibile e in questo senso di più che comprensibile; e tuttavia alla sensibilità e alla cultura della narratrice mostrano l’imitazione dei classici, mancando però il fondamento, l’origine e lo sviluppo di quanto espresso, e mostrando invece un carattere esibitorio ed eccitante. La narratrice non riesce a vedere oltre e le conseguenze della sua cieca sicumera saranno disastrose. Andare oltre dovrebbe essere compito del lettore, che però finora si è dimostrato inferiore al compito, tanto efficace è il criptaggio cui è ricorso Stifter. La morale della vicenda è che il dilettante non è più il borghese, come volevano Goethe e Schiller nei loro schemi; attraverso lo scardinamento dell’esistenza borghese, egli è arrivato fino alla sostanza della poesia. Ma si è anche consegnato inerme nelle mani dei borghesi che ne hanno fatto - se si può un dilettante serio, rovinandone definitivamente sia la vita sia l’accesso alla poesia. L’altra grande variante di metà secolo sul tema del dilettantismo la dà Gottfried Keller (1819-1890), immediatamente dopo (la prima versione del Grüner Heinrich viene pubblicata nel 1854-55). Sullo sfondo c’è certamente ancora Goethe: il protagonista ne legge le opere e si sente conquistato dalle sue teorie dell’arte, che però per sua debolezza non riesce a tradurre in pratica. C’è nello sfondo il Wilhelm Meister (come lui, Heinrich fa confusione tra necessità e caso). Ma c’è ben altro, c’è ben di più. Veicolo di questo «di più» è un denso discorso sull’arte astratta (insisto sulle date: siamo a metà secolo; il capitolo che ci interessa venne scritto al più tardi nel 1853). Nel discorso viene coinvolto in primo luogo il concetto di inconscio: si parla di anima assopita, di oblio di sé, di arte onirica, di cose fatte senza saperlo né volerlo, tanto che Heinrich non vuole essere colto «in flagrante». Non conosco esempi precedenti nei quali la relazione tra arte e inconscio sia stata posta in questo modo. I romantici, è vero, avevano detto sull’inconscio cose straordinarie, sia a livello teorico (basti pensare ai lavori di Gottfried Heinrich Schubert) sia entro la pratica artistica (Hoffmann aveva insisto sulla “vista doppia” dell’artista). Ma Keller fa un deciso passo avanti: l’inconscio opera attraverso un gran talento e la sua ragnatela, anzi il suo labirinto, depositato in un’opera d’arte, è della più grande coerenza. L’inconscio non 143 esisterebbe senza il conscio; quest’ultimo tenta di guidare il primo in modo da uscire da quanto l’inconscio mostra attraverso la sua ragnatela e cioè, in ultima analisi, dal conflitto con se stesso. E poi c’è la connessione con l’arte astratta, altra strepitosa novità. Keller la vede come espressione di un conflitto interiore ed esorta a risolverlo in qualche modo; certamente oggi non siamo disposti ad accettare in tutto e per tutto il suo discorso. Ma prima della soluzione terapeutica Keller sviluppa più o meno tutte le utopie che all’arte astratta si sono legate nel tempo; le sue sono pagine profetiche. L’arte è ciò che non è (das Wesenlose). Per realizzarsi deve liberarsi da tutto ciò che è oggettuale. Solo nel nulla essa realizza specificamente sia la sua libertà sia la sua logica. Nel nulla essa crea una replica del mondo, fatta di passioni e cose oscure, per poi superarla riaffermando il puro nulla. In ciò l’artista è l’antiDio: Dio crea il mondo dal nulla; ma la creazione è il male, è un ascesso del nulla, è un decadere di Dio. La divinità dell’arte consiste nel superare l’intrico della materialità per tornare nel nulla. E il veicolo di questo è l’astrazione. Il suo scopo ultimo è arrivare al puro essere, lontano da ogni materialità e libero da ogni tendenza (cioè da ogni fine legato alla realtà). Dunque l’astrazione assoluta è, oltre che puro essere, totale libertà. In ciò possono unificarsi tutte le arti e risvegliare l’artista che è in tutti. L’arte sarà perciò l’arte di ciascuno, effimera e unica. Vanno abolite le tecniche definite terrene e l’unica tecnica (che neanche deve più sopportare questo nome) sarà la pura astrazione dell’arte geometricomatematica. Per il suo tempo questi discorsi erano profetici: sarebbero stati effettivamente fatti almeno agli anni Trenta del nostro secolo, compresa l’utopia dell’arte di tutti. Keller vi è stato abilitato da due presupposti: dalla grande corrente del nichilismo tedesco (che meriterebbe studi approfonditi: comincia tra i filosofi come dibattito sull’idea di creazione dal nulla e va avanti nella letteratura percorrendo tutte le direzioni possibili, compresa quella politica: basterà ricordare nomi di autori tanto diversi quali Büchner e Grillparzer); e dal concetto di dilettante. Heinrich è dilettante in tutto, in pittura come in generale nel sapere (gustose le pagine in cui si mette a frequentare l’università di Monaco). Ed è a questo dilettante che viene concesso lo sfondamento in direzione dell’arte astratta. Però solo a metà. Il fatto è che il dilettante merita un’ambigua lode: è lui che si affanna dietro al nuovo, è pertanto lui che prepara i grandi maestri, che con molta semplicità ne realizzeranno le aspettative, ed è poi lui che li supera, cioè che cerca altre novità. Ma vive affannato: «è il grande mediatore, moderatore e fornitore dell’economia mondiale», però vive male, orgoglioso e malinconico nel suo sforacchiato mantello di cavaliere, destinato ai «mezzi slanci». Il discorso di Keller sul dilettantismo è il più ardito e più complesso fra tutti. Gli autori che stiamo esaminando hanno tutti dato contributi notevolissimi alla 144 definizione del concetto, illustrandone di volta in volta lati diversi. Ma Keller pare essere andato più lontano di tutti. Poi la realtà storica si incaricherà di realizzare e trasformare le sue idee: l’arte astratta come Kunstgewerbe riceve da lui una nota negativa, mentre invece il Bauhaus farà sul serio; l’arte come felicità istintiva e immediata, concessa a tutti, sarà un’utopia di grande successo; l’arte come effimero universale sarà alla lunga l’arte di massa. Forse la dimensione che Keller non considera, e che invece era presente a Goethe e a Schiller, è quella socio-economica che permette il fiorire e il deformato realizzarsi di quelle idee. Il quadro del dilettantismo non è stato esaurito da nessuno e, ripeto, i contributi vanno tenuti tutti presenti. Nel frattempo si è affacciato sulla scena (è proprio il caso di dirlo) il dilettante par excellence, Richard Wagner (1813-1883). Nel 1843 viene eseguito il Fliegender Holländer (L’olandese volante), nel 1845 il Tannhäuser, nel 1850 il Lohengrin. E in questo stesso anno è stato pubblicato il suo saggio Das Kunstwerk der Zukunft (L’opera d’arte dell’avvenire), cui nel 1852 seguirà il grande libro Oper und Drama (Opera e dramma). Ha anche avuto tempo di guastarsi con tanta gente (per esempio con Heinrich Laube, dapprima amico e fautore, ma dissenziente fin dal Fliegender Holländer). Sarà un importante scrittore realista, Otto Ludwig, ad applicare a Wagner - e cioè, nelle sue intenzioni, contro Wagner - il concetto di dilettante. Al concetto di Gesamtkunstwerk obietta di essere dilettantesco perché mescola tra loro i generi artistici. Wagner è versatile come è appunto il dilettante e delle sue manchevolezze vuol far virtù. Wagner è dilettante come musicista, è dilettante come poeta e drammaturgo; la sua arte è ciarlataneria, pura retorica, pura declamazione. Tutti concetti che ricorreranno nell’ultimo Nietzsche. La differenza c’è: Ludwig tiene fermo a un’estetica che tenga ben distinti i generi artistici e in particolare letterari (Ludwig è stato un interessante teorico dell’arte teatrale); Nietzsche non sarà certo così professorale. E poi Ludwig sfondava una porta aperta: Wagner non solo era dilettante, non solo sapeva di esserlo, ma addirittura metteva in scena il proprio dilettantismo. Purché ci si intenda sulle parole. Forse basterà richiamare due chiare prese di posizione. Per Wagner l’arte tedesca - compresa quella di Goethe e di Schiller, da lui espressamente menzionati - è segnata dal dilettantismo. La parola è qui sinonimo di sperimentazione continua e si oppone alla salda forma dell’arte romanza. Secondo Wagner l’arte tedesca deve ancora conseguire un saldo principio stilistico senza però che questo cada nell’apriorismo, e dunque nella dimensione non libera, delle leggi artistiche dei popoli romanzi. La seconda affermazione è riferita da Wagner a se stesso: come musicista - asseriva - lui non aveva molto da dire; ma aveva tutto da dire quanto all’unificazione di musica e poesia. Per la seconda tesi vale l’esegesi di Thomas Mann; la prima viene illustrata dai Meistersinger von Nürnberg (I maestri cantori di Norimberga; prima esecuzione 1868). Se Walther von Stolzing non fosse in un’opera comica sarebbe un mo145 numento equestre. E certo ha tutto un suo modo di stare nell’opera. Eva è civetta e allusiva, Sachs le tiene testa e all’occorrenza - con Beckmesser - sa anche essere maligno. Walther non ha niente di tutto questo. Lui è sempre appassionato e l’ironia gli è sconosciuta. Quando canta le sue canzoni l’orchestra ce lo presenta come un romantico prestandogli dei timbri che sembrano richiamarsi alla tradizione del Franco cacciatore. Ma indubbiamente anche lui ha la sua omogeneità con l’opera. È squattrinato: è venuto a Norimberga per vendere un terreno (e un critico lungimirante ha scritto: povero suocero, quant’altri ancora gliene farà vendere!). È arrogante: a David che gli espone le regole replica che quella è roba per calzolai e lui non vuole mica mettersi a fare lo scarparo; con grande sforzo poi accetta di sedere sulla sedia per cantori (ohibò, lui lì? il suo posto è solo su un destriero). È un po’ teppista: a ogni occasione la mano gli corre alla spada. È un discreto ignorante: David può constatarlo. Insomma è un po’ Siegfried e un po’ Parsifal. Però è innocuo o comunque domabile: Siegfried ammazzava a destra e a sinistra. Eva invece gli fa rinfoderare la spada ogni volta: Parsifal conquistava alla fine un suo pericoloso sapere. Walther invece ha bisogno di Sachs fino in fondo. Stretto fra Sachs e Eva, Walther non potrà più nuocere. (E stia attento a Eva: con quella donna gli spunteranno presto tanti bei San Giovanni sulla fronte: Sachs l’ha indirettamente avvertito ma Walther non sembra aver afferrato). Ebbene, è a costui che Wagner affida compiti rivoluzionari. Walther è l’estremista che, da buon estremista, fallisce nel suo compito iniziale, in maniera da assicurare la vittoria finale di Sachs e, in subordine, di Pogner: cioè del rinnovamento delle istituzioni e del trionfo della borghesia. Nei Meistersinger si realizza il programma dello scritto Über Staat und Religion (Su stato e religione, 1864), certo con maggior chiarezza e anche con esiti che vanno oltre quanto inteso da Wagner nello scritto programmatico. Walther dalla rivoluzione all’integrazione ma con la proiezione verso un’altra società: è un po’ la storia di Wagner stesso, dal 1848 di Dresda ai Meistersinger stessi e già con un occhio al Parsifal. Cominciamo da Walther il rivoluzionario. Un giovane vuole essere ammesso in una comunità ben definita nella sua economia, nelle istituzioni, nell’assetto politico e nella cultura. Nel caso specifico il punto di passaggio eminente è quello culturale. Su questo piano la comunità è chiusa, guarda con sospetto al nuovo. Già al semplice annuncio di richiesta di ammissione i maestri ricorrono a un fugato, una forma che col procedere dell’opera si mostrerà sempre più litigiosa, per dimostrare la loro perplessità. Walther, per conto suo, ha ascoltato con molta impazienza e senza impararne niente l’apprendista David, che come un invasato gli ha snocciolato un’incomprensibile terminologia (un po’ come se oggi uno dovesse imparare a memoria tutto il vocabolario dei semiotici). David non pensa neanche un po’ a ribellarsi; non per nulla finirà nelle braccia di Maddalena, che potrebbe essere sua nonna. Walther invece, come si conviene ai generali e ai rivoluzionari, è un 146 terribile semplificateur e di tutta quella roba non vuole sapere. Accetta dapprima i luoghi delle istituzioni, ma vuole imporre il suo gioco. È un autodidatta, dunque è uno che si è formato avendo come maestro non più che un simbolo: Walther von der Vogelweide era morto da un pezzo, come nota Beckmesser, dunque non aveva potuto domare l’allievo, insegnargli la disciplina, le regole come imposizione. Pertanto il giovane rivoluzionario ha avuto con le istituzioni al massimo un rapporto umbratile. Il nuovo lo presenta spontaneamente, non per polemica. In questo senso egli è rimasto vicino alla natura, dunque vicino al popolo come lo intende Sachs (che poi tutto ciò avvenga in seno alla musica meno naturale e anzi più artificiosa che Wagner abbia scritto è un problema di cui dovremo ricordarci più in là). Dentro la comunità che deve giustificarlo ed eventualmente accoglierlo ci sono posizioni differenziate. C’è la maggioranza dei maestri che è per la conservazione e basta. C’è Pogner, il padre di Eva, che è per moderate riforme. La sua posizione è espressa con chiarezza nell’allocuzione iniziale: la borghesia, con le sue ricchezze e il suo amore per la pace, è il suo mondo; ma quel che vorrebbe in più è un maggiore dinamismo culturale e a tal fine gli sembra adeguata una moderata modifica in un meccanismo istituzionale: che cioè un certo livello di decisione venga reso meno definitivo, affiancandogli un’altra istanza che ne circoscriva il campo di validità. (Nella fabula: i maestri premieranno un vincitore e solo questi potrà chiedere Eva in moglie. Eva però potrà rifiutarlo. - Ma poi allora che farà? Resterà zitella? Pogner non l’ha pensata bene fino in fondo.) Questa posizione viene fatta rapidamente saltare dall’urgere sia di Walther sia di Sachs: Pogner ne resterà prigioniero e Walther lo dirà esplicitamente a Eva; ma, appunto grazie all’azione combinata dei due, Pogner potrà uscire dal vicolo cieco in cui l’ha cacciato questa riforma a metà. Hans Sachs infatti propone di fare un passo avanti: sospendere completamente quell’istanza decisionale e rivolgersi invece al popolo in modo che le decisioni di questo abbiano in futuro ripercussioni sulla ristretta istanza dei maestri; Sachs propone un rinnovamento di quest’ultima attraverso un ricorso al popolo. (Dopo che la proposta di Sachs ha scatenato un putiferio, lì per lì passa quella di Pogner; ma l’esito finale sarà più complesso.) Walther non sembra aver capito molto delle possibilità offerte da questa situazione. Fallito nel tentativo di farsi accettare, vuole semplicemente romperla con le istituzioni (quindi mette mano alla spada e cerca di rapire Eva). Fallisce anche questo tentativo (è Sachs a impedirgli ratto e fuga). Walther però gli resta abbastanza fedele perché, mentre si presenta di nuovo davanti all’istituzione (va a cantare per il premio), lo fa però come sfida e rifiuta di entrare a farne parte (non accetta il collare di maestro). E qui fallisce definitivamente: convinto da Sachs, accetta infine di entrare in un’istituzione che per intervento suo e del popolo sarà rigenerata. Chi vince alla fine non è nessuno individualmente ma è il trio Sachs-Walther-popolo, peraltro gestito da Sachs. Singolarmente presi, nes147 suno dei tre componenti la spunterebbe. Quella di Walther è certo una rivoluzione molto elementare. Qualche contenuto più raffinato che se ne può ricavare lo dobbiamo piuttosto alla maieutica di Hans Sachs, che però lo finalizza ad altri scopi. Così Wagner ha volto le spalle alla rivoluzione, si sta assestando nell’integrazione e si apre la strada (ahimè!) verso la rigenerazione. Nel primo atto, quando cerca di far accettare la propria proposta relativa al premio da conferire, Sachs parla del popolo come dell’unica istanza che abbia accesso alla natura. La natura che si vede alla fine del secondo, quando il popolo scende in piazza a picchiarsi di santa ragione, è piuttosto burrascosa. Non per questo Sachs perde la testa né il senso della priorità: prima di tutto impedisce che l’attentato alle istituzioni vada in porto, senza che peraltro le forze innovatrici vadano perdute (acciuffa Walther impedendogli la fuga e per così dire sequestrandolo, mentre rispedisce Eva a casa), e poi mantiene in piedi quel tanto che serve ancora delle vecchie (libera Beckmesser da David). Dunque Sachs sa padroneggiare certe situazioni. E nel terzo atto spiega come stanno le cose. Le istituzioni (spiega a Walther) non si spaccano ma si conquistano; queste poi non hanno tutti i torti a resistere: chi si fa avanti con cose nuove deve dimostrare di avere il fiato per portarle avanti e per dar vita a nuove istituzioni, non a una fiammata caotica. Per di più le istituzioni con cui si ha a che fare nel caso concreto saranno anche stantie ma il contesto è sano, e comunque le si può rinverdire e riportare alle giuste fonti. Naturalmente bisogna sapere come stanno le cose. Cioè che da una parte la follia regge il mondo, dall’altra che la vita ha senso solo come pace e amore universale e che a mettere insieme queste due cose interviene il retto intendimento della politica. È quanto Sachs espone nel monologo sulla follia del mondo (il quale a sua volta va visto sullo sfondo del ricordato saggio Über Staat und Religion). Le cose (argomenta Sachs) avvengono solo nel generale inganno sui loro fini: è la stessa costituzione del mondo a volere così. Ognuno persegue dei fini distruttori e autodistruttori illudendosi di trovarvi gioia e felicità: solo l’inganno costitutivo del mondo permette di illudersi, in maniera che in ultima analisi vengano inconsapevolmente perseguiti quei fini che invece ne permettono il proseguimento. (Che cosa stia scritto nell’in-folio che Sachs tiene sulle ginocchia mentre monologa non si sa: che siano le opere di Schopenhauer?) C’è però un fine consapevole agli uomini, che per quanto può li eleva al di sopra di questo cieco, insensato egoismo: è il patriottismo, l’amore per la propria patria elevato al di sopra di quello egoistico e anzi antitetico a quest’ultimo. E qui Sachs si lancia nelle lodi di Norimberga, operosa (come già aveva ricordato Pogner), costumata e amante della pace. La durevolezza del patriottismo, cioè di questo sia pur modesto superamento dell’egoismo, è assicurata dallo Stato e dai suoi valori simbolici (nello scritto teorico scrive: dal re). Questo complesso di eticità (patriottismo nello scritto, «fedeli costumi» nel monologo) e istituzioni ad alto valo148 re simbolico assicura stabilità allo Stato. Ciò che va oltre supera la comprensione dell’onesto cittadino. E il patriottismo è insufficiente perché per sua natura conduce alle guerre esterne (dalle quali Sachs ha cominciato) e non di rado anche a disordini interni. Anche la saggia e pacifica Norimberga non ne è andata esente: la follia è sempre pronta a riesplodere. E sarà sempre così (qui il monologo di Sachs non trova più supporto nello scritto ricordato) se la natura verrà perennemente compressa: l’illusione dell’amore, l’intuizione di forze nuove e non riconosciute, un amore contrastato ed ecco l’esplosione della follia. Niente di irreparabile, d’accordo (in orchestra i motivi di Norimberga e della festa di san Giovanni riescono ad assorbire lo gnomo e la lucciola facendo loro ampie concessioni sul piano ritmico); si può trovare una soluzione. Ma per far questo occorre intendere bene la politica: occorre guidare saggiamente quella stessa follia che è una componente ineliminabile della realtà (è quel che dovrebbe fare il re).Ciò è peraltro garantito, oltre che dallo Stato e anzi congiuntamente con l’eticità di questo, dall’arte. Ma questa parte del suo pensiero Sachs la esporrà più in là. Il suo monologo va inteso come sentimentale nel senso schilleriano del termine: riflessione su un’ispirazione di cui si presume che abbia riferimento diretto alla natura e al popolo, allo scopo di adattarla a forme complesse. Nel monologo Sachs si propone infine di guidare la follia così che la funzione del popolo in quell’«opera» possa cambiare e guidare a buon esito il progetto di riferimento alle radici naturali dell’arte e dello Stato. Il popolo che compare nel terzo atto è probabilmente ancora natura - Sachs almeno non lo smentisce - ma è ormai natura incanalata: non è più notte ma giorno e l’irrazionale sembra ormai bandito. Le corporazioni non sono più in camicia da notte ma con bandiere e costumi e non sono più intente a picchiarsi ma a celebrarsi. È all’interno di questo popolo che si troverà la conciliazione generale e che le istituzioni potranno rigenerarsi integrando il nuovo e diverso. Tutto ciò presuppone però delle regole, non l’esplosione incontrollata. Regole non statiche e non oppressive, ma tuttavia regole. Sachs si fa compito di spiegarlo a Walther. Quando questi nel primo atto aveva protestato contro le regole che gli venivano elencate, dichiarandole roba da calzolai, David, che aveva introdotto la metafora, non se n’era lasciato impressionare e aveva seguitato a elaborarla. David ha i suoi limiti e concepisce tutto come artigianato. Ma non ha tutti i torti. Il suo maestro Sachs apporta un nuovo punto di vista quando esorta i maestri, sconcertati dal nuovo canto e quasi indignati, a ricavare le regole dall’opera compiuta invece che giudicare questa sulla base di regole a essa esterne. Così Sachs ha introdotto i concetti sia di relativismo delle regole sia di loro immanenza nel prodotto riuscito; il che comporta un avvio istintuale del giudizio analitico. Su tutto ciò torna nel monologo del sambuco al secondo atto, quando constata che quel canto è senza errori eppure non rispondente ad alcuna regola; per di più capace di mettere insieme vecchio e nuovo. Inimitabile, insomma. Fi149 nalmente, parlando con Walther nel terzo atto, arriva all’equilibrio. Le regole (così come il monarca nello Stato) assicurando la continuità, cioè che ci sia culto dell’arte anche in tempi grami (quando sono passate la primavera, la gioventù e il primo amore; più tardi dirà: anche quando sarà caduto lo Stato e la continuità istituzionale). Ma le regole non sono imposizioni e il risultato più fecondo si ha dall’incontro tra chi ha già un patrimonio di regole e chi le riscopre per conto suo. Dunque il presupposto fondamentale è darsi delle regole e poi seguirle; e nel far ciò occorre far capire che sono regole, non capricci. Pertanto esse devono essere stabili. Sachs ricorre costantemente alla metafora del matrimonio; anche se la situazione la suggerisce, l’immagine vuol essere qualcosa di più che non un’allusione alla fabula: si riferisce all’affidabilità istituzionale e alla produttività delle regole. Se però le regole devono essere stabili, affidabili e produttive, non per questo saranno irrigidite; così le nuove regole di Walther somiglieranno molto a quelle dei maestri, però non saranno identiche. La canzone che le fonda e allo stesso tempo vi si ispira sarà più complicata di quelle cui sono abituati i maestri e ovviamente non risponderà del tutto alle loro regole. Ma sarà accettata; e sarà anche meno complicata del canto dell’emancipazione. Prima però che il nuovo corso di Walther si imponga occorre far vedere che quanto egli propone è effettivamente più fecondo del vecchio: da qui la necessità della sconfitta di Beckmesser. La vecchia istituzione deve rinnovarsi perché il nuovo è capace di integrarsi nel vecchio senza perdersi e al contrario rivificandolo. In questo modo si acquisisce una produttività maggiore entro l’unica cosa che garantisce stabilità: le istituzioni con alto valore simbolico. Il nuovo entra pacificamente nelle forme dell’antico, tra la conciliazione generale. Nietzsche rielaborerà idee di Wagner stesso quando parlerà del dilettantismo del musicista nella quarta delle Unzeitgemäße Betrachtungen (Considerazioni inattuali, 1876), “Richard Wagner in Bayreuth” (cap. II). Il discorso di Nietzsche è incentrato sulla dimensione psicologica, educativa, tecnica; il che potrebbe far pensare a un impoverimento del discorso wagneriano se invece, a leggere con più attenzione, la dizione appassionata non suggerisse che Nietzsche sta parlando piuttosto di se stesso e che pertanto quelle righe vanno intese più come autobiografia che come saggio critico: Wagner appare usato come veicolo per l’autocomprensione, cosa che all’ombroso maestro difficilmente sarà sfuggita. Ma quando Thomas Mann (1875-1955) riprende le idee di Nietzsche, anche di queste a loro volta si fa ben altro. E sì che il saggio di Mann è incomprensibile senza vedervi alle spalle l’esperienza nietzscheana. Nietzsche, il primo come l’ultimo, viene ripreso (il primo Nietzsche viene addirittura citato alla lettera) ma ripensato e - è il caso di dirlo - inverato. Wagner un dilettante? Sissignori, e che altro se no? Ma il dilettantismo appare come l’idea germinale di un mondo che passa da uno stravolgimento all’altro, come precipitato di forze eccedenti il mondo reale, come generazione di un mondo tendenzioso, illuso di un equilibrio (per esempio quello tra le forme artistiche) che invece è tirannica subordi150 nazione a un’idea centrale onnipervadente. E il suo misurarsi col mondo ha sempre un risultato eccessivo, non realistico. Facciamo un’operina leggera! Risultato: Die Meistersinger. Facciamo una coserella cantabile! Risultato: Tristan und Isolde. Tutto uno scatenamento di forze eccessive, scaraventate sul mondo con esiti imprevisti. Davvero Mann stava scrivendo solo di Wagner? Il suo saggio è un contributo fondamentale alla comprensione di Wagner, non c’è dubbio; la sua analisi sul modo in cui in Wagner la poesia dipende dalla musica è decisiva. Ma di certo i suoi contemporanei lo lessero in altro modo, e con ragione; ritennero che Mann vi avesse parlato anche del nazismo, e precisamente contro il nazismo. Fu proprio per questo saggio che si palesò la rottura, fu per esso che Mann venne attaccato e fu per questo che non tornò più nella Germania hitleriana. Anche nel suo caso le conseguenze erano state incontrollabili. Al nazismo per la verità aveva solo vagamente accennato (per esempio verso le ultime righe); ma indubbiamente aveva parlato più che di Wagner: aveva parlato di tutta una dimensione della cultura tedesca. Con lo scritto di Mann termina la riflessione sul dilettantismo. In precedenza (già nel 1910) Rudolf Kassner (1873-1959) aveva tentato di sintetizzarla vedendovi lo specchio di quella che una volta si chiamava l’anima tedesca. Le osservazioni che vi si trovano sono attente e indubbiamente mettono a punto molti particolari importanti; appaiono però anche molto legate alla cultura del volgere di secolo e in definitiva rendono conto del modo in cui il dilettante si collocava in essa. Kassner illustra la psicologia dell’artista dilettante con osservazioni alla cui validità non c’è nulla da aggiungere o togliere; ma per conto mio non riesco a evitare un’ingiustizia: quella di confrontarlo col successivo, epocale saggio manniano e di trovarlo conseguentemente un po’ spiazzato. Dunque la riflessione sul tema ha accompagnato la cultura tedesca per circa un secolo e mezzo. L’esposizione continua allo sperimentalismo, la carica di soggettivismo e individualismo, il dubbioso rapporto con una tradizione non agevole da definire perché considerata di recente formazione (le citazioni non risalgono mai oltre Goethe), l’irruenza di nuove dimensioni sociali e l’ambiguità della collocazione del soggetto producente nel loro interno sembrano essere stati gli elementi che più hanno ispirato e condizionato tale riflessione. 151 II, 5. La tradizione lirica II, 5, 1. Durante l’Ottocento la produzione lirica diventò un fatto di massa. Si può dire che tutti scrivevano liriche e - quel che più conta - quasi tutti ne pubblicarono. Questo fenomeno non fu soltanto tedesco, ma nello spazio linguistico tedesco ebbe cause specifiche, andamento specifico, caratteristiche specifiche nella forma e nel contenuto. Il grande impulso venne dalle guerre antinapoleoniche. Alcuni poeti patriottici diventarono famosi: Theodor Körner (1791-1813), Ernst Moritz Arndt (1769-1860) e, in misura minore, Max Schenkendorf (1783-1817). Ma costoro furono solo i più rappresentativi e i più popolari di una vasta produzione di lirica patriottica. I loro modelli furono Schiller, Bürger, Schubart, il romanticismo in genere e il Volkslied. Molte di queste poesie vennero scritte su arie già note oppure vennero messe in musica da compositori rinomati (Carl Maria von Weber tra gli altri) e tutto, sia il tipo di musica sia il tipo di composizione verbale, era pensato in vista della diffusione. E alcune diventarono popolarissime, sopravvivendo ben oltre l’occasione per la quale erano state composte. Tutto ciò però riguardava fondamentalmente la Germania del Nord e più in particolare il regno di Prussia; nelle zone renane, in Baviera e in Austria le cose stavano diversamente, e ciò in dipendenza dai diversi rapporti intercorrenti fra quelle zone e l’egemonia napoleonica. Quando Napoleone fu sconfitto e il Congresso di Vienna portò a esiti ben diversi da quelli che i patrioti avevano sperato, il carattere della lirica cambiò. Fino a quel momento era stata lirica patriottica, che chiedeva l’indipendenza dallo straniero e contrapponeva globalmente la Germania a ciò che non era tedesco (in particolare alla Francia), esaltando altrettanto globalmente la Germania, senza specificare meglio; in questo senso era una lirica che solo in germe conteneva elementi politici. In seguito fu costretta a diventare politica, cioè a porsi dei fini più specifici, e porli in primo piano rispetto ad altri ed eventualmente a difenderli e a contrapporli ad altri. Schenkendorf, Clemens Brentano e lo stesso Goethe scrissero delle poesie contro i principi tedeschi che al Congresso di Vienna dimostrarono di non sentirsi legati a promesse. Friedrich Gottlob Wetzel (1779-1819), Friedrich Förster, Friedrich August Staegemann scrissero specifiche poesie contro il Congresso di Vienna. Friedrich Rückert (1788-1866), un poeta oltremodo prolifico (scrisse circa 10000 poesie), cominciò a farsi notare con della poesia politica e particolarmente con 45 Geharnischte Sonette (Sonetti corazzati, 1814); Rückert se la prese sia con la Rivoluzione francese, causa di tutti i mali, sia con la Santa Alleanza, nemica dell’unità e libertà dei tedeschi. Oggi però lo ricordiamo per altri meriti: 152 per la sua alta statura di orientalista, che fra l’altro lo condusse sia a rendere accessibili varie culture orientali (araba, persiana e non solo) attraverso traduzioni, sia a introdurre nella poesia tedesca nuovi metri, da quelle ispirati. Fu il primo a introdurre il Ghasel: composizione con versi a quattro arsi, che riprende a ogni verso pari la rima della prima coppia di versi, lasciando non rimati i dispari (aa ba ca ecc.); ogni coppia di versi costituisce un’unità di senso. E padroneggiò anche altri metri orientali. Oggi la sua fama è legata ai testi di cui si sono impadroniti i musicisti: Schubert, Schumann, Brahms, Liszt, Loewe, Mahler, Richard Strauss hanno composto su di loro alcuni fra i loro Lieder più belli e famosi. Ma Rückert meriterebbe un oculato recupero, che operi una drastica scelta nella sua produzione, ripresentandone al lettore anche un aspetto diverso da quello tutto sommato omogeneo dalla liederistica sopra ricordata (in cui soltanto Mahler, col suo ciclo Kindertotenlieder (Canti per i bimbi morti) ha operato una scelta diversa dagli altri). A mo’ di saggio, ecco una sua ballata. Der Krämer von Ispahan In Ispahan ein Zoll, ein neuer, Ist auferlegt der Krämerschaft; Ein Krämer aber meint, die Steuer Geh über seines Beutels Kraft. Er zählte, rechnet’ und verglich es, Dann macht’ er rasch sich auf den Weg Dahin, wo eben öffentliches Gehör erteilt der Beglerbeg. Er drängt sich durch die dichten Gassen: «Herr, ich entrichte nicht den Zoll.» «So muß du diese Stadt verlassen», Erwidert jener ruhevoll. «Herr, hier kann ich den Zoll nicht geben, Und wohin soll ich in der Welt?» «Nach Schiras oder Kaschan eben, Wo es am besten dir gefällt.» «In Schiras ist dein jüngrer Bruder» Der Krämer wagt das kühne Wort «In Kaschan ist dein Neff’ am Ruder; Was kann ich hoffen da und dort?» «So magst du dich nach Hofe wenden Und klagen, Unrecht tu man dir.» «Am Hofe hat die Macht in Händen 153 Dein ältrer Bruder, der Wesir.» «So geh zur Höll und laß dein Äffen!» Der Krämer spricht: «Dort ist vielleicht Dein Vater selig anzutreffen; Wie schwer ist’s, daß man euch entweicht!» «So geh mit Gott, ich will’s bedenken, Daß auf mein ganz Geschlecht nicht fällt Der Vorwurf, dich am Recht zu kränken In dieser und in jener Welt.» Il merciaio di Ispahan A Ispahan hanno imposto / ai merciai un dazio nuovo. / Uno però dice che questa tassa / supera le sue forze. // Contò, calcolò, paragonò / e poi si mise rapido in cammino / verso il luogo in cui il daziere / teneva udienze pubbliche. // Si fa strada per le vie pigiate: / «Signore, io il dazio non lo pago.» / «Allora lascia la città» / fa quello, calmo. // «Signore, qui non posso pagare / e dove devo andare mai?» / «A Sciraz o a Kashan, / dove ti pare.» // «A Sciraz c’è il tuo fratello minore» / si fa coraggio il merciaio / «a Kashan comanda tuo nipote, / che posso sperare da quelle parti?» // «Allora va a corte a denunciare / il torto che ti si fa.» / «A corte ha tutto in mano / tuo fratello maggiore, che è visir.» // «Allora va all’inferno e finiscila!» / Dice il merciaio: «Lì magari / incontro tuo padre buonanima; / quant’è difficile sfuggirvi!» // «Allora va’ con Dio, voglio pensarci su, / che sulla mia stirpe non ricada / l’accusa di farti torto / in questo e quell’altro mondo.» Il Ghasel fece particolare impressione a August von Platen (1796-1835), tormentata, quasi tragica figura. Cominciò con invettive antinapoleoniche per passare poi a tutt’altro atteggiamento: a capire la Rivoluzione francese, ad aprire gli occhi sul dispotismo. Ma oggi non lo ricordiamo più per la sua poesia politica. Platen fu una figura tragica perché sbagliò regolarmente nel valutare sia se stesso sia gli altri. Impiegò buona parte del suo tempo a scrivere testi teatrali che gli riuscirono regolarmente male e temeva di non essere portato per la lirica, che invece è quasi la sola cosa di lui a interessarci. Si imbarcò in un’infelice polemica con Immermann e con Heine, che gliela fecero scontare; soprattutto Heine fu violento con lui, ma non fu certo una nobile gara. Per l’occasione, Platen fece sfoggio di antisemitismo, Heine ne strapazzò l’omosessualità. Immermann invece ne sbeffeggiò l’ossessione metrica. Effettivamente nell’abbondante produzione lirica di Platen occorre tagliare con energia per far affiorare quel che ne resta di valido; i tentativi che da un po’ di tempo vengono intrapresi in questo senso cominciano a dare i loro frutti; e quella che ne emerge come la più valida è la lirica amorosa di Platen. Eccone un esempio: 154 Daß ich dich liebe, hast du nie vermutet, Nie konnten’s Menschen um uns her beachten: Mein ganzes Sein ist nur ein stilles Trachten, Und leise pocht das Herz mir, weil es blutet. Ob’s ruhig in mir, oder ob es flutet, Teilnehmend wolltest du das nie betrachten, Und daß die Deinen mich für wenig achten, Das hat mich oft geschmerzt, doch oft ermutet. Denn meine Seele strebte warm nach oben, Und was mir freundlich, feindlich trat entgegen, Ein Traum erschien mir’s, der mich rings umwoben Und also will ich auch der Liebe pflegen, Mit einer Sinnesart, die nicht zu loben, Doch, die zu schelten, mich bedünkt verwegen. Mai hai saputo che ti amo, / mai se n’è accorto chi era intorno: / tutto il mio essere è un tacito tentare / e il cuore mi batte piano perché sanguina. // Mai un tuo sguardo partecipe, / fosse in me calma o tempesta, / e spesso mi ha addolorato la scarsa / stima per me dei tuoi, ma spesso incoraggiato. // La mia anima puntava con calore in alto / e quel che incontravo, nemico o amico, / mi pareva un sogno che m’imprigionava. // E così voglio amare / con sensi da non lodare / ma che sarebbe temerario biasimare. Un secondo, grande impulso alla produzione lirica venne dalle Burschenschaften, le associazioni studentesche che a loro volta erano un prodotto delle guerre antinapoleoniche. L’università di Jena ebbe funzione di guida; coerentemente con la storia della città e della sua università, il patriottismo che ne ispirò la lirica si ispirava al concetto romantico di popolo, che peraltro andava a trovare i suoi miti non più nel medioevo ma più indietro, in quello che poteva apparire germanicità pura, per esempio in Arminio e nella battaglia di Teutoburgo. La vita studentesca comportava un’ampia fase di socialità e di conseguenza lo sviluppo di canti adatti. A Jena venne fondato nel 1816 il coro delle Burschenschaften, su imitazione del quale ne sorsero altri nelle altre università, dotandosi ciascuno di una sua raccolta di canti. Anche il movimento ginnico di Jahn contribuì alla diffusione del canto e di suoi testi. Gießen, Heidelberg, Halle, Tübingen, Breslavia, Bonn, Lipsia furono le università che ben presto seguirono Jena; tra gli editori di quelle raccolte di canti figurano poeti di nome come Gustav Schwab (1792-1850) (Tübingen), Karl von Holtei (1798-1880) (Breslavia), August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798-1874) (Bonn). La poesia delle Burschenschaften conservava carattere nazionale. La cosa è notevole poiché 155 dopo il 1815, a seguito della frantumazione della Germania, i poeti che volevano occuparsi delle questioni correnti erano costretti a occuparsi di ciò che accadeva all’interno dei loro stati o staterelli; d’altra parte ciò faceva acquistare in concretezza e rendeva più propriamente politici i loro prodotti. Nel Württemberg Ludwig Uhland (1787-1862), Justinus Kerner (1786-1862) e Friedrich Rückert vengono coinvolti anche in un certame poetico a proposito della costituzione. I testi delle Burschenschaften mantenevano tutti un tono sostenuto, solenne, addirittura sublime; parlavano di libertà, patria, dio, onore, fedeltà, germanesimo antico. I loro modelli erano Schiller e Körner. Particolarmente importanti i testi che vennero prodotti a Lipsia; fra gli autori si distinse Karl Follen (1794-1855), di cui è particolarmente importante “Brause, du Freiheitssang” (Risuona possente, canto di libertà!, 1816) e il Großes Lied (Grande canzone, 1818). L’attivismo degli studenti di Gießen era assai notevole; nel 1819 un Fragund Antwortbüchlein über Allerlei was im deutschen Vaterlande besonders Not tut (Libriccino di domande e risposte su tutto ciò che è particolarmente urgente nella patria tedesca) di Wilhelm Schulz metteva a contrasto la fame dei contadini con il lusso dei principi. Ricordiamo che a Gießen maturò quindici anni dopo l’azione politica di Büchner. Ma intanto andò da Gießen a Mannheim nel 1819 lo studente Karl Ludwig Sand, portando nello zaino le poesie di Körner e il vangelo di Giovanni, per uccidere August Kotzebue. Sand venne decapitato e sulla sua sorte vennero composte poesie in quantità, quasi tutte di solidarietà. Nell’agosto 1819 la conferenza dei ministri del Deutscher Bund si riunì a Karlsbad e adottò una serie di decisioni (Karlsbader Beschlüsse), ratificate dal Bundestag il 20.9.1819, tutte intese alla cosiddetta Demagogenverfolgung. In pratica, veniva sancita la fine di ogni libertà di espressione; vennero proibite le Burschenschaften e ogni università dovette ospitare dei plenipotenziari preposti a controllare studenti e professori. Le conseguenze sulla vita culturale sono facili da immaginare; ma non per questo si smise di far letteratura. Wolfgang Menzel pubblicò nel 1823 i suoi Streckverse (Polimetri) alla maniera di Jean Paul, che gli attirarono attenzione e consensi (e alcuni sono veramente ben riusciti). Sia lui sia Wilhelm Hauff (1802-1827) provenivano dalle Burschenschaften; se ne sente chiaramente l’ideologia nella produzione poetica, cui nel giovane Menzel si aggiunge l’ironia. Hauff poi si fece un nome per la sua narrativa: con un suo romanzo storico e con racconti storici (Jud Süß – L’ebreo Süß -, 1827, ebbe particolare importanza: ispirò a Victor Hugo il suo Le roi s’amuse, 1837, che a sua volta fu alla base del Rigoletto, 1851, di Verdi; e nel 1925 indusse Lion Feuchtwanger a riprendere la materia in un romanzo), e con fiabe che pubblicò inserendole in una cornice a mo’ del Decamerone (v. oltre l’Excursus sul racconto a cornice). Nel 1821 ci furono vari moti rivoluzionari in Italia, in Spagna e in Grecia; questi ultimi colpirono grandemente l’immaginazione europea; ne nacque il movimento dei filelleni, che diede luogo a collette di denaro, alla partenza di 400 volontari (200 dei quali tedeschi) e a tante produzione letteraria. All’inizio i 156 governi europei sotto l’influsso di Metternich negarono ogni solidarietà ai greci (congresso di Verona 1822); poi le cose cambiarono e nel 1827 le potenze europee affondarono nella battaglia di Navarino la flotta turca; tra il 1829 e il 1830 venne riconosciuta l’indipendenza della Grecia dalla Turchia. Il movimento filellenico fu particolarmente attivo nella Germania sudoccidentale; tra coloro che lo guidavano ci furono Uhland e Schwab. Poesie filelleniche scrisse Ludwig Rellstab (1799-1860), anche lui noto soprattutto per un romanzo storico, ma oggi conservato alla nostra memoria perché Schubert compose su suoi testi i primi sette Lieder dell’ultima raccolta, Schwanengesang (Canto del cigno, 1828). Poesie filelleniche scrissero Chamisso, Kerner, Hoffmann von Fallersleben, Heinrich Stieglitz, ma soprattutto Wilhelm Müller (1794-1827), anche lui oggi noto soltanto perché Schubert pubblicò addirittura due cicli di Lieder su suoi testi: Die schöne Müllerin (La bella mugnaia, 1823) e Die Winterreise (Viaggio d’inverno, 1827). Sul piano formale, la copiosissima lirica filellenica non portò niente di nuovo: Schiller era sempre il modello massimo, Körner era anche lui molto seguito, ma interessante notare è che in Svevia si fa sentire anche l’imitazione di Hölderlin. Con l’occasione, comunque, parve appropriato ispirarsi anche a Omero e Anacreonte. La poesia di Wilhelm Müller e di Rellstab vanno viste nell’epigonismo romantico; lo stesso vale per quella di Adelbert von Chamisso (1781-1838). Già autore del suo unico capolavoro Peter Schlemihls wundersame Geschichte (La straordinaria storia di Peter Schlemihl, 1814), Chamisso fu in seguito l’autorità poetica della Germania del Nord, così come Uhland lo era per il Sud. Oggi resta delle sua poesia soltanto quel che fu messo in musica da Schumann nel 1840 (il ciclo Frauenliebe und –leben, Amore e vita di donna) e da altri compositori. Ma scrisse anche importante lirica politica e sociale e introdusse in Germania (attraverso imitazione e traduzione) la poesia di Pierre Jean de Béranger. Poco invece si muoveva in Baviera e in Austria. In Baviera poetava lo stesso re Luigi I in modi neoclassici, consolando i suoi sudditi con argomenti cristiani. In Austria invece Metternich, ottimo conoscitore di poesia, non aveva fra le tante colpe anche quella di scrivere in proprio. In compenso Anastasius Grün (pseudonimo di Anton Alexander Graf Auersperg, 1806-1876), divenuto famoso con la raccolta di poesie fortemente influenzate da Uhland Spaziergänge eines Wiener Poeten (Passeggiata di un poeta viennese, 1831), poteva ospitarvi la seguente satira di Metternich, divenuta giustamente famosa: Salonszene Abend ist’s; die Girandolen flammen im geschmückten Saal, Im Kristall der hohen Spiegel quillt vertausendfacht ihr Strahl, In dem Glanzmeer rings bewegen, schwebend fast und feierlich, Altehrwürdge Matronen, junge schöne Damen sich. Und dazwischen ziehn gemessen, schmuck im Glanze des Ornats, Hier des Krieges rauhe Söhne, Friedensdiener dort des Staats; 157 Aber einen seh ich wandeln, jeder Blick folgt siner Bahn, Doch nur wenig der Erkornen sind’s, die’s wagen, ihm zu nahn. Er ist’s, der das rüst’ge Prachtschiff Austria am Steuer lenkt, Er, der im Kongreß der Fürsten für sie handelt, für sie denkt; Doch seht jetzt ihn! wie bescheiden, wie so artig, wie so fein! Wie manierlich gegen alle, höflich gegen groß und klein! Seines Kleides Sterne funkeln karg und lässig fast im Licht, Aber freundlich mildes Lächeln schwebt ihm stets ums Angesicht, Wenn von einem schönen Busen Rosenblätter jetzt er pflückt, Oder wenn, wie welke Blumen, Königreiche er zerstückt. Gleich bezaubernd klingt’s, wenn zierlich goldne Locken jetzt er preist, Oder wenn er Königskronen von gesalbten Häuptern reißt; Ja fast dünkt’s mich Himmelswonne, die den sel’gen Mann beglückt, Den sein Wort auf Elbas Felsen, den’s in Munkats’ Kerker schickt! Könnt Europa jetzt ihn sehen, so verbindlich, so galant, Wie der Kirche frommer Priester, wie der Mann im Kriegsgewand, Wie des Staats besternter Diener ganz von seiner Hand beglückt, Und die Damen, alt und junge, erst bezaubert und entzückt! Mann des Staates, Mann des Rates! Da du just bei Laune bist, Da du gegen alle gnädig überaus zu dieser Frist; Sieh, vor deiner Türe draußen harrt ein dürftiger Klient, Der durch Winke deiner Gnade hochbeglückt zu werden brennt. Brauchts dich nicht vor ihm zu fürchten; er ist artig und gescheit, Trägt auch keinen Dolch verborgen unter seinem schlichten Kleid; Östreichs Volk ist’s, ehrlich, offen, wohlerzogen auch und fein, Sieh, es fleht ganz artig: Dürft ich wohl so frei sein, frei zu sein? Salotto È sera; le girandole fiammeggiano nella sala adorna, / nel cristallo degli alti specchi s’illumina il loro raggio, / nel mare di splendore tutt’intorno si muovono, quasi sospese e solenni, / venerande matrone, belle signore giovani. // E in mezzo passano misurati, eleganti e spendenti in pompa magna, / qui i ruvidi figli della guerra, lì i servitori dello stato in pace; / uno vedo però incedere, tutti gli sguardi ne seguono il cammino, / ma pochi son gli eletti che osano avvicinarlo. // È lui che guida il forte galeone Austria, / lui che nel congresso dei principi per lei agisce, per lei pensa; / ma guardatelo adesso! Che modestia, che grazia, che finezza!/ Come gentile con tutti, gentile con grandi e piccoli // Le stelle del suo abito brillano parsimoniose e quasi trascurate alla luce, / ma mite sorriso amichevole gli aleggia sempre in volto, / quando ora coglie petali di rosa 158 da un bel seno / o fa a pezzi regni come fiori vizzi. // È con uguale suono affascinante che ora loda vezzose ciocche bionde / oppure strappa corone da capi di re unti; / anzi mi pare quasi delizia celestiale quella che fa felice colui / che la sua parola spedisce sugli scogli dell’Elba o nel carcere di Munkats. 2 // Potesse vederlo ora l’Europa, così gentile, così galante, / come lo vedono il pio prete, l’uomo in divisa, / lo stellato servitore dello stato reso felice dalla sua mano / e le signore, vecchie e giovani, più di tutti affascinate e deliziate! // Uomo di stato, uomo di consiglio! Visto che sei dell’umore giusto / e oggi generoso con tutti; / guarda, fuori davanti alla porta aspetta un poveraccio / che arde d’essere reso felice da un cenno della tua grazia. // Non averne paura; è costumato e per bene, / non nasconde pugnali sotto il suo vestito semplice; / è il popolo austriaco, aperto, educato e fine, / che ti supplica educatamente: posso prendermi la libertà di essere libero? Nella sua seconda raccolta, Schutt (Detriti, 1835) aggiunse ai temi della prima le lodi alla libera America, influenzando Lenau. Un altro austriaco, Joseph Christian von Zedlitz, condusse un interessante esperimento formale, utilizzando la canzone come base per composizioni di ampio respiro. Fu intorno al 1830 che punti di incontro dei letterati viennesi diventarono i caffè; polizia e censura non consentivano altre sedi; diventarono famosi, in questo senso, il Silbernes Kaffehaus e il caffè Schringer. La tradizione durò a lungo. II, 5, 2. La rivolta polacca del 1830-31 suscitò un’ondata di poesie per la Polonia, cui contribuirono poeti di prestigio come Lenau, Platen e Chamisso, ma anche poeti oggi dimenticati come Harro Harring (1798-1870), Johann Philipp Becker (1809-1886) e via dicendo. Lo stesso avvenne in occasione dello Hambacher Fest (1832), lo stesso in occasione di avvenimenti politici di cui parleremo più in là. In generale è da osservare che accanto alla poesia politica, pur così abbondante, veniva coltivata in maniera ancora più abbondante una poesia, per così dire, privata; vi si parlava d’amore (con annesse gioie e dolori), dell’alba e del tramonto, delle stagioni e simili; insomma vi si variava - e forse neanche vi si variava quanto vi si ripeteva - tutto un repertorio di convenzioni. Fu un’epoca in cui tutti scrivevano e pubblicavano versi e c’era un pubblico che voleva sentirsi dire sempre le stesse cose. Si fa presto a sorriderne: il fatto è che alcune poesie di autori oggi dimenticati imperarono a lungo nelle antologie scolastiche, condizionando il modo medio di intendere la poesia fin dentro il XX secolo. Ci All’isola d’Elba venne notoriamente ridotto per qualche tempo Napoleone; nel carcere di Munkat (l’ungherese Munkács, oggi Mukacevo in Ucraina) venne imprigionato Alexander Ypsilanti dal 1821 al 1823. 2 159 furono dei successi oggi impensabili; cominciarono negli anni Quaranta, ma fu negli anni Cinquanta che comparvero le raccolte più fortunate: Joseph Viktor von Scheffel (1826-1886) pubblicò nel 1854 il Trompeter von Säckingen (Il trombettiere di Säckingen) che nel 1892 arrivò alla 200a edizione; nel 1846-47 pubblicò il nucleo di una raccolta che nel 1868 intitolò Gaudeamus, arrivata nel 1868 alla 59a edizione. Grosso successo ebbero poeti come Joseph Christian von Zedlitz, Oskar von Redwitz (1823-1891), Otto Roquette (1824-1896), Friedrich Wilhelm Weber (1813-1894) e altri; ma certo 65 o anche 70 edizioni non tenevano il passo col Trompeter von Säckingen. Friedrich von Bodenstedt (1819-1892) però vi si avvicinò coi suoi Lieder des Mirza Schaffy (Le canzoni di Mirza Schaffy, 1851), che entro la fine del secolo arrivarono a 150 edizioni. Quelle di Scheffel sono poesie amabili e carine; e questo è quanto. Sia lui sia Bodenstedt fecero parte del circolo dei poeti monacensi (Scheffel, a causa di motivi esterni, solo per poco tempo), che volevano conciliare realismo e idealismo, certo a tutto vantaggio del secondo. Figura-guida del gruppo monacense era Emanuel Geibel (1815-1884), che è quasi impossibile ricordare per la lirica che scrisse in proprio, di un epigonismo tardo-romantico e dall’ampio successo (i suoi Gedichte del 1840 erano nel 1884 alla centesima edizione), ma senz’altro per la sua attività di traduttore di poesie dallo spagnolo, dal francese, dal greco e dal latino; lo stesso vale per altri poeti monacensi, quali Adolf von Schack (1815-1894), Wilhelm Herz, Paul Heyse (1830-1914) e Friedrich von Bodenstedt. Né questa attività rimase limitata ai monacensi: poeti di tutt’altro orientamento quali Ferdinand Freiligrath (1810-1876) e Georg Herwegh (1817-1875) tradussero anche loro molto; per tacere di Rückert. In generale l’attività di traduzione da poeti antichi e moderni, occidentali e orientali, venne sviluppata per tutto il secolo. Ci sono dunque da tener presenti queste due cose quando si parla della lirica del Novecento: che essa cercò costantemente di annettersi esperienze esterne e che moltissimi fra coloro che ebbero successo ricalcando le convenzioni oggi sono totalmente scomparsi dal nostro orizzonte. Negli anni Trenta continuò una produzione di poesia politica, che in Wilhelm Weitling (1808-1871) e altri diventò poesia comunista. Nel 1840 però la cosiddetta crisi del Reno (alcuni giornalisti francesi rivendicarono il Reno come confine con la Germania) diede occasione alla produzione di poesie nazionaliste. Una delle più note divenne Der deutsche Rhein (Il Reno tedesco) di Nikolaus Becker (1809-1845). Tale tipo di poesia distoglieva però gli occhi dalle condizioni interne della Germania; a Becker risposero poeti democratici come Robert Prutz (1816-1872) e Georg Herwegh, e altri ancora, sostenendo che il Reno già allora non era libero perché non era libera la Germania al suo interno. (Risposte vennero anche dalla Francia con Alphonse Lamartine e Alfred de Musset.) Ma con questo l’ondata di poesie nazionaliste non cessò davvero: è di questo periodo anche una poesia famigerata, Die Wacht am Rhein (La guardia al Reno) di Max Schneckenburger (1819-1849). E in generale prende voce come minimo una 160 stanchezza nei confronti della poesia impegnata sui problemi politici interni. È il singolare caso di Heinrich Hoffmann von Fallersleben, il quale scrisse una poesia di replica a Becker, ospitandolo in una raccolta cui dà il titolo Unpolitische Lieder (Canzoni non politiche, 1840-41) e destinata a ottimo successo (12000 copie vendute in un solo anno). Il titolo andava inteso ironicamente, cioè l’autore intendeva scriveva poesie politiche, usando in ciò una strategia interessante: ricalcava infatti la lirica destinata a essere cantata da associazioni corali, rifunzionalizzandola e ironizzandola; le melodie venivano da lui indicate con riferimento a un diffuso manuale dell’epoca. Il tono era ironico, certamente, e a quell’epoca certe cose non si tolleravano; ma a noi oggi (e ai più critici già allora) quell’ironia appare tanto bonaria e tanto poco riflessa da lasciarsi dire che con lui la poesia politica non è battagliera ma semplicemente spiritosa. Il lettore può farsene un’idea dall’esempio seguente: Wie ist doch die Zeitung interessant! Wie ist doch die Zeitung interessant Für unser liebes Vaterland! Was haben wir heute nicht alles vernommen! Die Fürstin ist gestern niedergekommen, Und morgen wird der Herzog kommen, Hier ist der König heimgekommen, Dort ist der Kaiser durchgekommen, Bald werden sie alle zusammenkommen Wie interessant! Wie interessant! Gott segne das liebe Vaterland! Wie ist doch die Zeitung interessant Für unser liebes Vaterland! Was ist uns nicht alles berichtet worden! Ein Portepéefähnrich ist Leutnant geworden, Ein Oberhofprediger erhielt einen Orden, Die Lakaien erhielten silberne Borden, Die höchsten Herrschaften gehen nach Norden Und zeitig ist es Frühling geworden Wie interessant! Wie interessant! Gott segne das liebe Vaterland! Com’è interessante il giornale! Com’è interessante il giornale / per la nostra cara patria! / Che cosa abbiamo appreso oggi! / La principessa ieri ha partorito, / e domani verrà il duca, / qui rientrato è il re, / passato è di là l’imperatore, / e ben presto tutt’insiem si troveranno - / Interessante! come tutto è interessante! / Dio benedica la cara patria! // Quanto è interessante il giornale / per 161 la nostra cara patria! / Che cosa abbiamo appreso oggi! / Un cadetto è diventato tenente, / un predicatore di corte ha avuto un’onoreficenza, / i lacché invece delle bordure d’argento, / le Loro Signorie se ne vanno a nord / e la primavera è arrivata a tempo - / Interessante! Come tutto è interessante! / Dio benedica la cara patria! A ogni buon conto Hoffmann è tuttora recitato, anzi cantato: fu lui a comporre nel 1841 il Lied aller Deutschen (Canto di tutti i tedeschi), quello che comincia col verso «Deutschland, Deutschland über Alles», adattandolo alla musica che Joseph Haydn aveva composto per l’inno dell’imperatore d’Austria; a partire dalla seconda strofe quel Lied è ancora l’inno nazionale tedesco. E un altro suo apporto assicura la presenza tuttora viva di questo autore: ancora vengono cantate le sue canzoncine per bambini, come Alle Vögel sind schon da, Winter ade, Gänse-Kantate (Tutti gli uccelli sono già arrivati, Addio inverno, Cantata delle oche) e altre ancora. Nel 1841 Franz Dingelstedt (1814-1881) pubblicò anonimi i Lieder eines kosmopolitischen Nachtwächters (Canti di un guardiano notturno cosmopolita); affini alla poesia di Hoffmann, apparvero però più eleganti ai contemporanei, e certo sono molto riusciti nell’ironia. Nel 1843 Dingelstedt veniva nominato bibliotecario e lettore presso la corte di Stoccarda; ben presto cominciava una brillante carriera come direttore artistico di importanti teatri (Monaco, Weimar); sarebbe arrivato fino a dirigere il Burgtheater di Vienna (dal 1871). Heine gli dedicò due feroci poesie (An den Nachtwächter e Der Ex-Nachtwächter). Ma le poesie del Nachtwächter hanno comunque una loro validità. Ecco la poesia che apre la raccolta: Weib, gib mir Deckel, Spieß und Mantel, Der Dienst geht los, ich muß hinaus. Noch einen Schluck... Adies Mariandel! Ich hüt’ die Stadt, hüt’ du das Haus! Nun schrei’ ich wieder wie besessen, Was sie nicht zu verstehen wagen Und was sie alle Tag vergessen: Uht! Hört, Ihr Herrn, und laßt Euch sagen! Schnarcht ruhig fort in Euren Nestern Und habt auf mein Gekreisch nicht acht! Die Welt ist akkurat wie gestern, Die Nacht so schwarz wie alle Nacht. Auch welche Zeit, will Niemand wissen, ’s gibt keine Zeit in unsren Tagen, Duckt Euch nur in die warmen Kissen Die Glocke die hat nichts geschlagen! 162 Laß keiner sich im Schlaf berücken Vom (vulgo Zeitgeist) Antichrist, Und sollte wen ein Älplein drücken, Dankt Gott, daß es nichts Ärgres ist. Das Murren, Meistern, Zerrn und Zanken, Das Träumen tut es freilich nicht, Drum schluckt sie runter, die Gedanken, Bewahrt das Feuer und das Licht! Auch wackelt nicht im bösen Willen An Eurem Bett und räkelt nicht, Die Zipfelmütze zieht im Stillen Zufrieden übers Angesicht. Der Hund im Stall, der Mann beim Weibe, Die Magd beim Knecht, wie Recht und Pflicht, So ruht und rührt Euch nicht beileibe, Auf daß der Stadt kein Schad’ geschicht! Und wann die Nacht, wie alle Nächte, Vollendet hat den trägen Lauf, Dann steigt, doch stets zuerst das rechte Bein aus den Federn, sittsam auf! Labt Euch an dem Zichorientranke Und tretet Eure Mühlen gern, Freut Euch des Lebens voller Danke Und lobt, nächst Gott, den Landesherrn! Moglie, dammi cappello, spiedo e mantello, / comincia il servizio, devo uscire. / Ancora un sorso… Addio Mariuccia! / Io veglio sulla città, tu sulla casa! / Ora torno a gridare come un ossesso / quel che non osano capire / e che dimenticano tutti i giorni: / Udite, signori, udite!// Seguitate tranquilli a russare nei vostri nidi /e non badate ai miei strilli! / Il mondo è precisamente come ieri, / la notte è nera come tutte. / Che ore sono nessun vuol saperlo, / non ci sono ore ai giorni nostri, / accucciatevi pure tra i cuscini caldi, / la campana non ha suonato. // Nessuno nel sonno si lasci turbare / dall’anticristo (detto anche spirito del tempo), / e se per caso t’opprime un incubetto, / ringrazia Dio che non è peggio. / Brontolare, biasimare, litigare, accapigliarsi, / sognare, certo non serve a niente, / perciò inghiottite i pensieri, / conservate il fuoco e la luce! // Non vi dimenate nel letto volendo / il male, non fate gli scomposti, / se state quieti la berretta da notte / se ne sta soddisfatta sulla testa. / Il cane nella stalla, il marito con la moglie, / la serva col servo, come è giusto e doveroso, / riposatevi, insomma, e perbacco non vi muovete, / che alla città non càpiti del male! // E quando la notte, come tutte, avrà finito il pigro corso, / alzatevi costumatamente, sempre però / uscendo prima la gamba destra! / Ristoratevi con surrogato caldo / e 163 ripetete la solfa quotidiana, / siate felici e grati della vita / e lodate, dopo di Dio, il sovrano! Il «guardiano notturno» varia nei versi finali di ogni strofe l’autentico canto dell’autentico guardiano. L’influsso di Heine è palese (ma andrebbe ricordato anche quello di Anastasius Grün per quel che riguarda l’impostazione globale del ciclo), è però importante aggiungere che gli “Zeitgedichte” (in Neue Gedichte) di Heine sono posteriori e proprio stimolati dal successo d Dingelstedt. Hoffmann ebbe un prosecutore in Adolf Glaßbrenner (1810-1876), satirico efficace sia in poesia sia in prosa; vale la pena citarne qualcosa: Das Märchen vom Reichtum und der Not Es waren einmal Bruder und Schwester: Der Reichtum und die Not; Er schwelgte in tausend Genüssen, Sie hatte kaum trocken Brot. Die Schwester diente beim Bruder Viel hundert Jahre lang; Ihn rührt’ es nicht, wenn sie weinte, Noch wenn sie ihr Leiden besang. Er fluchte und trat sie mit Füßen, Er schlug ihr ins sanfte Gesicht; Sie fiel auf die Erde und flehte: «Hilfst du, o Gott, mir nicht?» Wie wird das Lied wohl enden? Das ist ein traurig Lied! Ich will’s nicht weiter hören Wenn nichts für die Schwester geschieht! Das ist das Ende vom Liede, Vom Reichtum und der Not: An einem schönen Morgen Schlug sie ihren Bruder tot! La fiaba dello sfarzo e della miseria C’erano una volta un fratello e una sorella: / lo sfarzo e la miseria; / lui se la godeva in mille spassi, / a lei mancava anche il pane secco. // La sorella servì il fratello / per quattrocento anni; / lui non si curava se lei piangeva / né quando cantava il suo dolore. // Bestemmiava e la prendeva a calci, / le picchiava il dolce volto; / lei cadeva a terra e implorava: «Dio, non mi aiuti?» // Come finirà questa canzone? / È una canzone triste! / Non voglio seguitare ad ascoltarla / se non si fa qualcosa per la 164 sorella. // Questa è la fine della canzone / dello sfarzo e della miseria: / un bel mattino / lei accoppò il fratello! Nel 1842 sorse una disputa tra Ferdinand Freiligrath (1810-1876) e Georg Herwegh (1817-1875). Freiligrath aveva cominciato come tardoromantico vicino ai poeti svevi, quindi si era dato alle poesie esotiche, sulla moda lanciata da Victor Hugo (di cui fu anche traduttore). Nel 1841 pubblicò una poesia, Aus Spanien (Dalla Spagna), nella quale introduceva una strofe programmatica, nella quale diceva che il poeta è superiore a ogni partito, col che intendeva dire: a prender parte per questo contro quello; portava l’esempio di Omero che è greco ma è pieno di simpatia per i troiani, e del poeta moderno che può entusiasmarsi per Napoleone ma anche condannare la fucilazione del duca d’Enghien perpetrata su suo ordine. Herwegh replicò che tutto nella storia avviene perché si prende partito. Intervennero anche altri (per esempio Geibel contro Herwegh) e ne nacque un importante dibattito. Freiligrath stesso subì un’evoluzione che lo portò fino al marxismo (nel 1844 rifiutò di accettare oltre una pensione che il re di Prussia gli aveva assegnato su intervento di Alexander von Humboldt dal 1842; abbiamo già visto la parte che nel rifiuto ebbe Gutzkow); la raccolta di poesie che segna questo periodo si intitola Ça ira (1846), dal noto canto rivoluzionario francese. In seguito Freiligrath litigherà con Marx e si staccherà dal marxismo; nel 1871 si farà prendere dall’entusiasmo per la vittoria della Prussia sulla Francia l’unificazione bismarckiana della Germania, però non accetterà più riconoscimenti ufficiali, volendo restare fedele alla sua posizione liberale, che nel 1848 aveva mostrato da posizioni assai in vista e che gli era costata la galera. In tutte le fasi della sua evoluzione Freiligrath fu un maestro del verso, in particolare del verso lungo; le sue poesie sono narrazioni: questo era il loro carattere migliore (a volte sciupato da un eccesso di retorica). Tutt’altro tipo fu Herwegh, nella cui produzione aumentarono progressivamente il radicalismo, la parodia, il sarcasmo. Contrariamente a Freiligrath, non aderì mai al comunismo e al marxismo, ma i suoi sentimenti libertari e democratici sono fuori discussione. Nella sua vita ci furono sbagli e debolezze; una di questa però fu rivelatrice: il 19 novembre 1842 Herwegh venne ricevuto in udienza dal re Federico Guglielmo IV di Prussia, il cosiddetto “re romantico”, la cui ascesa al trono (7 giugno 1840) aveva suscitato speranze di libertà e di rinnovamento. Risultato: di una sua progettata rivista veniva proibita preventivamente l’importazione dalla Svizzera; Herwegh protesta in una lettera al re e il giorno dopo viene espulso dalla Prussia; dall’udienza era passato poco più di un mese e così aveva fine un equivoco durato anche troppo. Herwegh dovette la sua notorietà ai Gedichte eines Lebendigen (Poesie di un vivente, 1841). Un notevole talento poetico mostrò Georg Weerth (1822-1856); stilisticamente le sue ballate lavorano ancora con i mezzi della tradizione (anafore, epa165 nalessi, particelle connettive), che però entrano in contrasto con i nuovi, quasi feroci contenuti mediati dalla prospettiva sociale di Weerth. Ecco subito un esempio: Hungerlied Verehrter Herr und König, Weißt du die schlimme Geschicht? Am Montag aßen wir wenig, Und am Dienstag aßen wir nicht. Und am Mittwoch mußten wir darben, Und am Donnerstag litten wir Not; Und ach, am Freitag starben Wir fast den Hungertod! Drum laß am Samstag backen Das Brot, fein säuberlich Sonst werden wir sonntags packen Und fressen, o König, dich! La canzone della fame Augusto signore e sovrano, / hai saputo la cattiva nuova? / Di lunedì abbiam mangiato poco, / e al martedì non abbiam mangiato affatto. // E il mercoledì abbiam mancato del necessario / e giovedì abbiamo sofferto privazioni; / e ah, il venerdì quasi / siam morti di fame! // Perciò sabato fai cuocere / il pane per bene e con riguardo - / sennò domenica prendiamo te / e divoriamo te, o re! La satira è rivolta contro i ricchi ma anche contro i rivoluzionari da strapazzo: Die deutschen Verbannten in Brüssel Und in den Kaffeehäusern von Brüssel, Da sassen sie und weinten Und hingen die Paletots an die Wände Und tranken Mokka mit Zucker und Kognak Und seufzten und jammerten sehr - wenn Dein sie gedachten, germanische Heimat! [...] Sinnend schaut ich sie oft; und entsetzt dann Hört ich, wie laut sie zu klagen Erhoben: «O weh uns! Nimmer Essen wir jetzt mehr deinen 166 Pumpernickel, Westfalen! und Posen, deine Kapusta! Nicht mehr rauschen die Fichten uns deiner Seligen Steppen, o Uckermark! Nicht mehr Fühlen den Biss wir deiner Kasernen-Wanzen, o Preussen! [...] Nicht mehr tönet der Männer der Bernsteinküst liberales Gejammer Erfreulich ins Ohr uns! [...] Müssen Burgunder trinken und Leifg’en Champagner und Austern Essen, Ostender, Fasanen und tête de Veau en tortue und was sonst noch Bietet die Fremde an kaum wohl Geniessbaren Sachen! [...] Müssen allein jetzt wandern den dorn’gen Lebensweg, nicht länger bewacht von Väterlichen Gendarmen, die gern uns Stets daheim geschützt vor der Pest Modernen Ideen und Hochverrätrischer Tollheit!» (1847) Gli esiliati di Bruxelles E nei caffè di Bruxelles, / sedevano e piangevano / appendevano i cappotti alle pareti / e bevevano moca con zucchero e cognac / e sospiravano e molto si lamentavano - quando / a te pensavano, patria germanica! // Stavo spesso a guardarli pensieroso; e inorridito allor / li sentivo lamentarsi ad alta voce: / «Oh, poveri noi! Mai più / mangeremo il tuo / pan di segala, o Westfalia! / né i tuoi cavoli, o Posnania! // Non più stormiran per noi gli abeti delle tue / steppe felici, o Uckermark! né più / il morso sentiremo delle tue / cimici da caserma, o Prussia! [...] // Non risuonerà più lieto / nei nostri orecchi il lamento liberale / degli uomini della Bernsteinküste! - [...] // Costretti siam qui a bere borgogna e / noioso champagne / a mangiare ostriche, specialità di Ostenda, / fagiani e tête de veau en tortue / e ciò che di appena commestibile altrimenti / può offrire la terra straniera! // Percorrere or dobbiamo da soli lo spinoso cammino della vita, non più a lungo sorvegliati / dai patri 167 gendarmi, che di buon grado / sempre ci han protetti dalla peste / delle moderne idee e / dalla follia dell’alto tradimento!» E contro i reazionari: Heute morgen fuhr ich nach Düsseldorf In sehr honetter Begleitung: Ein Regierungsrat - er schimpfte sehr Auf die Neue Rheinische Zeitung. - Die Redakteure dieses Blatts -, so sprach er, - sind sämtlich Teufel [...] Für alles irdische Missgeschick Sehn sie die einzige Heilung In der rosenrötlichen Republik Und vollkommener Güterteilung. [...] Auch nach Weibergemeinschaft steht ihr Sinn. Abschaffen wolln sie die Ehe: Dass alles in Zukunft ad libitum Miteinander nach Bette gehe: [...] Auflösen wollen sie alles schier; Oh, Lästrer sind sie und Spötter; Kein Mensch soll in Zukunft besitzen mehr Privateingentümliche Götter -. [...] Ich bin entzückt, mein werter Herr, Von Ihrer honetten Begleitung Ich selber bin ein Redakteur Von der Neuen Rheinischen Zeitung. Oh, fahren Sie fort, so unsern Ruhm Zu tragen durch alle Lande Sie sind als Mensch und Regierungsrat Von unbeschränktem Verstande. Oh, fahr er fort, mein guter Mann - 168 Ich will ihm ein Denkmal setzen In unserm heitern Feuilleton Sie wissen die Ehre zu schätzen. Ja, wahrlich, nicht jeder Gimpel bekommt Einen Tritt von unsern Füssen Ich habe, mein lieber Regierungsrat, Die Ehre, Sie höflich zu grüssen. (1848) Stamane sono andato a Düsseldorf / in molto rispettabil compagnia: / un consigliere di seconda classe - inveiva molto / contro la Neue Rheinische Zeitung. // «I redattori di quel giornale», / così diceva, «son tutti diavoli; // Per ogni terrena sfortuna / propongono una sola soluzione / la repubblica rosa-rossiccia / e dei beni completa spartizione. // Mirano anche alla comunione delle donne. / Abolire vogliono il matrimonio: / sicché chiunque in futuro a piacere / con chi gli pare si possa accoppiare: // Disgregar voglion proprio tutto; / oh, blasfemi son essi e schernitori; / nessun dovrà in futur più possedere / divinità di proprietà privata.» // Sono estasiato, mio egregio signore, / della sua rispettabil compagnia - / Anch’io sono un redattore / della Neue Rheinische Zeitung. // Oh, continui pur per ogni dove / a diffonder così la nostra fama - / Lei è un uomo e un consigliere / d’illimitato intelletto. // Oh, continui pure, il mio buon uomo - / Erigere gli voglio un monumento / nel nostro allegro Feuilleton - / apprezzare ne saprà l’onore. // Sì, perché non ogni allocco riceve / una pedata dai nostri stivali - / Ora ho l’onore, mio caro consigliere, / di salutarla in tutta cortesia. Credo non ci sia bisogno di commento, tale è l’immediatezza con cui queste poesie parlano. 169 II, 6. Il mito americano La battaglia decisiva per l’indipendenza americana venne combattuta a Yorktown nell’ottobre 1781; essa lasciò sul campo gran numero di morti, sia da parte americana sia da parte inglese. Ma quasi tutti quei morti erano tedeschi. La spiegazione si ha se si pensa che l’emigrazione tedesca in America era già notevole (e sarebbe cresciuta moltissimo in seguito); e una seconda spiegazione può fornirla una scena di Kabale und Liebe (Intrigo e amore), la “tragedia borghese” di Schiller completata nel 1783, l’anno stesso in cui si concludeva la pace che metteva fine alla guerra d’indipendenza: a Lady Milford un domestico rivela che le perle regalatale dal principe tedesco di cui è la favorita sono state pagate con la vendita di cittadini tedeschi, arruolati a forza e ceduti agli inglesi per la guerra americana. In tutta la Germania ne vennero venduti 30000; ritornarono in 17000; ricavato globale: circa 12 milioni di talleri. C’erano dunque buoni motivi per occuparsi dell’America anche in letteratura. Fu l’America dell’emigrazione quella che attrasse l’attenzione. Alla fine di Ahnung und Gegenwart (Presagio e presente, 1815) di Eichendorff alcuni personaggi emigrano in America perché vogliono ricominciare daccapo, dopo una vita fin allora dispersiva. L’emigrazione in America è anche l’esito di una grave crisi tessile descritta nei Wanderjahre (Anni di apprendistato, 1829). Ben presto non ci sarà scrittore che non faccia almeno un rapido cenno all’America; perfino un personaggio della Guerra dei Trent’anni nello Hochwald (La fustaia, 1842) di Stifter ha modo di farvi un salto. Keller vi ambienta la parte finale e beffarda di una sua novella (Die Berlocken – I ciondoli -, dal Sinngedicht - Epigramma), Raabe varie parti di suoi romanzi (per esempio Die Leute aus dem Walde – La gente del bosco -; Die Akten des Vogelsangs – Gli atti del quartiere Vogelsang); l’opera di Fontane pullula addirittura di riferimenti all’America; e si potrebbe continuare per un pezzo. Qualche scrittore tenta di far personalmente la prova dell’emigrazione: ciò tocca a Lenau, che vi si reca nel 1832-33 a cercare di far soldi e se ne torna con le pive nel sacco, seppure con qualche poesie interessante. Platen pensò anche lui a emigrare ma poi, dedicata all’America del futuro e della libertà un’elegia, preferì girare l’Italia per l’ultima parte della sua vita. I motivi del mito americano si condensano presto: l’America è la terra delle possibilità infinite; l’America è il luogo in cui si può già vedere il futuro. Entrambi i motivi possono far da sostegno ad argomentazioni positive oppure ad argomentazioni negative; entrambi conoscono comunque un grande successo. Il mito americano maturerà i suoi frutti artistici migliori nella prima metà del Novecento, con il primo romanzo di Kafka, Der Verschollene (Lo sperduto, che il primo editore con non immotivato equivoco intitolò Amerika), e con alcune poesie di Brecht. Fu però l’Ottocento la grande epoca della sua cultura. Su esso si specializzano scrittori non di primo piano ma degni di un loro interesse. Alcuni 170 divennero popolari come scrittori di romanzi di avventure: Charles Sealsfield (pseudonimo di Karl Postl; 1793-1864), per molti anni residente in America, è tuttora presente ai lettori con il suo ciclo di racconti Das Kajütenbuch oder Nationale Charakteristiken (Il libro della cabina ovvero Caratteristiche nazionali, 1841), fra cui particolarmente notevole il racconto Die Prärie am Jacinto (La prateria del Giacinto), forse il migliore esempio di descrizione di quegli spazi sconfinati. Di Friedrich Gerstäcker (1816-1872) era ancora diffuso fino a non moltissimi anni fa come libro per ragazzi Die Flußpiraten des Mississippi (I pirati del Mississippi, 1843). Ma chi soprattutto ricordato è il prolifico Karl May, in cui ciclo di Winnetou (1893 sgg.) e altri ancora sono ambientati appunto in America. Come appartenenti al filone politico-culturale vanno ricordati almeno due romanzi: Die Europamüden. Modernes Lebensbild (Stanchi dell’Europa. Un quadro della vita moderna, 1838) di Ernst Willkomm (1810-1886, l’abbiamo già incontrato per un suo non maturato rapporto con Büchner e di lui ci occuperemo ancora), che contrappone l’ideale della repubblica americana alle realtà europee (il suo romanzo si svolge però tutto in Europa) e il suo opposto, Der Amerikamüde (Uno che si è stancato dell’America, 1855) di Ferdinand Kürnberger (18211879), che prendendo spunto dall’esperienza di Lenau descrive l’America come paese avido, conformista, violento e intollerante. Il tema America veniva toccato anche in altro modo, per esempio nei non pochi romanzi dedicati all’emigrazione; un fenomeno notevolissimo, se si pensa che dal 1844 al 1861 emigrarono in America 1476000 tedeschi. I nomi e i titoli qui fatti sono quasi nulla rispetto alla pertinente, vastissima produzione letteraria. L’America funzionò anche come osservatorio di sviluppi reali contrapposto a utopie, o meglio a fisime e peggio; ce ne ricorderemo quando, parlando di Soll und Haben (Dare e avere, 1855) di Gustav Freytag (1816-1895), menzioneremo anche il seguito che, a confutazione, ne scrisse Reinhold Solger. II, 7. Il Faust dopo Goethe Nel 1824 Heine stava passeggiando per lo Harz e stava per diventare un grande scrittore. Solo che nessuno ne sapeva ancora niente. Anzi a vedere le cose dall’esterno si potevano avere nei suoi confronti non poche perplessità. Aveva 27 anni, aveva già fatto fallimento come commerciante e non aveva nemmeno concluso gli studi; è vero che due anni prima aveva pubblicato le sue prime poesie, raccogliendo una benevola recensione da Karl Varnhagen von Ense, che aveva conosciuto frequentando il salotto della moglie Rahel; e un’altra di Immermann. Ma era ben poco. Pertanto quando nel corso di quella passeggiata 171 questo strano tipo arriva, un passo dopo l’altro, fino a Weimar e va a trovare Goethe (con la cui lirica non avrebbe avuto poi molto in comune) la conversazione partì male e finì peggio. Goethe non seppe far di meglio che chiedergli che cosa stesse scrivendo. «Sto scrivendo un Faust» rispose Heine. Goethe si arrabbiò e lo mise alla porta. La lezione non servì a nulla: Heine scrisse lo stesso il suo Faust. Nel 1847 inviò infatti a Londra, come gli era stato richiesto, uno schema per balletto, che pubblicò poi nel 1851 col titolo Der Doktor Faust, ein Tanzpoem, nebst kuriosen Berichten über Teufel, Hexen und Dichtkunst (Il dottor Faust, un poema a ballo con notizie curiose su diavoli, streghe e poesia). Il testo non è bello. Anzi - bisogna dirlo subito - le tantissime opere faustiane scritte dopo il (primo) Faust di Goethe, quasi quattrocento, sono un’ecatombe di cose mal riuscite. Quella di Heine rientra nel novero. Di interessante c’è che nel balletto il diavolo è una donna: non si chiama Mefistofele ma Mefistofela, e fin da quando compare è disposta a sedurre Faust a qualunque costo. Faust si lascia sedurre; prende gusto alla cosa e quindi si lascia sedurre da altre belle fanciulle, finché conosce la figlia di un sindaco e - che sia voglia di darsi alla politica o semplicemente «dedicarsi alla felicità borghese» - vuole trascinarla immediatamente in chiesa per sposarla. A questo punto però riappare Mefistofele che gli fa scontare tutte le scappatelle portandoselo all’inferno. Heine non era il primo a trasformare in donna il diavolo di Faust. Ma questo insistito esercizio ci consente di mettere subito in luce un importante aspetto del mito faustiano, e cioè la sua plasmabilità. In Heine è il diavolo, col suo cambiamento di sesso, a risultare plasmabile; ma è più spesso Faust stesso a trasformarsi: in determinati rifacimenti prende i tratti di don Giovanni, in altri (segnatamente a partire dal 1840) assume anche i tratti dell’ebreo errante. Questo pendolo, così vastamente oscillante fra don Giovanni e l’ebreo errante, ci propone ed evidenzia uno degli aspetti più drammatici del mito faustiano. Don Giovanni è un personaggio che coglie infinite volte l’attimo fuggente senza stancarsi mai. L’ebreo errante ha anche lui un rapporto con l’attimo, ma un rapporto opposto: non è teso a cogliere l’attimo che ripropone di continuo ma è in fuga perenne da un attimo sempre uguale. L’unicità dell’attimo ripetitivo e da cogliere nel caso del don Giovanni, non ripetibile ma neanche revocabile, unico, non sviluppabile e da cui sempre fuggire nel caso dell’ebreo errante, ci dice che in entrambi i casi abbiamo pur sempre a che fare con attimi e non con tempi di sviluppo. Che cosa si è frantumato con questa doppia concezione? Si è frantumato quel tempo continuo, che era alla base del Faust goethiano. Tutto ciò che tale tempo comporta in Goethe stesso è riassunto con una parola intraducibile dello stesso Faust: Streben. Nel significato del termine entrano tante cose. Se si tiene presente sia il primo sia il secondo Faust si nota con facilità che il protagonista allarga progressivamente i propri orizzonti: va così dal godimento un po’ banale della taverna di Auerbach a quello ben più interessante e 172 raffinato con Margherita, allargando poi il suo intervento nella sfera mondana fino a un sogno di dominio universale e di rivolgimento dei destini dell’umanità nella visione, per quanto illusoria, di una attività di lavoro rivolta alla natura e messa al servizio dell’uomo. Arrivare a una meta del genere (illusoriamente raggiunta, ripeto) passando attraverso le rovine (concrete) che Faust provoca significa allargare progressivamente il rapporto con la sostanza dell’uomo e dell’essere in generale, che costituiscono l’oggetto vero del desiderio da parte di Faust. Il Faust goethiano può avere tante esperienze perché egli è a sua volta sostanziale: da una parte è una sostanza in rapporto vero con qualunque altra cosa, dall’altra è una sostanza unica, non divisibile nei diversi frammenti dell’esperienza, ma al contrario loro centro unificatore. Dopo Goethe, questi concetti cadono uno dopo l’altro. Cade innanzitutto il concetto di sostanza e di conseguenza quello della unificabile pluralità di esperienze. Quello che fanno i Faust post-goethiani è concentrarsi su un’unica esperienza, che viene incessantemente ripetuta. Il tempo dello Streben goethiano era un tempo realizzatore di qualcosa al di là delle distruzioni, era un tempo salvifico al di là delle colpe. Ma successivamente si accampa e domina un tempo discontinuo, non realizzatore e non sostanziale: accumulo di attimi invece che dispiegatore della sostanza. In concomitanza si assiste all’eliminazione di due cose: del diavolo e della salvazione. Il diavolo resta per la verità sempre sulla scena (assumendo nomi diversi); ma non ha più statura di antagonista. L’antagonismo è uscito dal diavolo ed è rientrato in Faust stesso. Nell’opera di Goethe di antagonismi ce n’erano ben due: quello di Mefistofele col Signore (dal quale procede la scommessa) e quello di Mefistofele con Faust; fra costoro c’è in corso una lotta e Faust sarà del diavolo se dirà sì all’attimo. Con i diavoli successivi le cose cambiano: il diavolo non ha più il compito di far inciampare Faust nell’attimo di cui desiderare che si arresti perché bello; il diavolo diventa semplicemente il mezzo magico a servizio della cattiva coscienza del protagonista. Cade poi anche il concetto di salvazione. È stato più volte detto che la salvezza del Faust goethiano è difficilmente scusabile sul piano drammaturgico. Si può aggiungere che quella salvezza è scusabile sul piano logico per due motivi: il primo è il progressivo allargarsi dell’esperienza di Faust, che infine lo porta a vedere il positivo; ora il positivo non è il terreno del diavolo ma di Dio: lo dice perfino Mefistofele quando si presenta a Faust asserendo di essere lo spirito che opera sempre cercando il male ma dando risultato sempre al bene. E il bene, ripeto, non è terreno del diavolo: nell’agone del mondo vince Dio. Il secondo motivo non viene detto esplicitamente. Ci si ricorderà che nel Mercante di Venezia la salvezza del personaggio in pericolo avviene con mezzi non troppo diversi: c’è una sfida, una scommessa che ha come pegno una parte carnale dello scommettitore. Ma tale parte viene negata al vincitore Shylock con 173 una serie di sofismi. Nel Faust di Goethe i sofismi non vengono enunciati ma semplicemente eseguiti; e quando gli angeli si vantano del trucco con cui hanno ingannato il vincitore Mefistofele fanno qualcosa di analogo e somigliano a un avvocato che si vanta dei sofismi utilizzati. È cioè la ragione umana che ha sempre il diritto di affermare se stessa, comunque vadano le cose. La ragione umana è il positivo realizzato, cioè è quel che Mefistofele stesso aveva dichiarato di essere: una forza al servizio del risultato (positivo, anche se solo nell’utopia) nella storia dell’umanità: quel positivo che Faust aveva creduto di ravvisare nell’umanità operosa che riplasma la natura a proprio vantaggio. Come è noto, quando Faust dice che a certe condizioni potrebbe gridare all’attimo di fermarsi, egli è cieco e scambia per tutt’altro il lavoro dei Lemuri che gli stanno scavando la fossa; dunque Faust trova il positivo esclusivamente nell’utopia. L’utopia è il nuovo Dio e il segno dell’utopia è Dio: il culmine, l’idea suprema in cui si riassumono le varie forze è infatti l’idea divina. E la salvazione, cioè la realizzazione di questa utopia, è anch’essa nient’altri che Dio. Possiamo immaginare che tutto questo crolli quando crolla il tempo continuo. Quando Grabbe nel 1829 e Lenau dal 1833 in poi riprendono in mano il mito di Faust, si trovano ad affrontare qualcosa per cui valgono criteri completamente diversi rispetto a quelli di Goethe. Il loro antagonismo nei confronti di quest’ultimo è esplicito, dichiarato e voluto. E il senso di tale antagonismo può essere riassunto dal termine “nichilismo”, sotto il quale si possono sussumere gran parte dei nuovi sforzi. Può essere piccante notare che gli elementi nichilisti evidenti nell’elaborazione del mito faustiano vengono sviluppati in gran parte nel cattolicissimo territorio degli Asburgo. Non sono sicuro di quale ne sia la ragione; un fatto si lascia però notare, e cioè come l’arco tra peccato e grazia divina venga teso al massimo, (e dietro questo atteggiamento si fa notare l’influsso di Calderón). Conseguenza di ciò è che la salvezza si allontana e tanto più evidente resta il peccato, cioè la non-essenza pura. Tutto questo ha inizio col Don Juan und Faust di Christian Dietrich Grabbe. In bocca a Faust viene messa una frase che può servire da emblema per tutta la storia del nichilismo; eccola: C’era una volta Dio, che finì a pezzi; noi ne siamo i frammenti: lingua e tristezza, amore e dolore e religione sono solo sogni di lui. (IV,3) Ecco ancora un «Dio è morto» detto dopo Jean Paul (e ben prima di Nietzsche). Nella plasmabilità della figura di Faust quel che si trasforma a poco a poco è il rapporto tra soggetto conoscente ed essenza da conoscere. Poiché non c’è più Dio, non c’è più da conoscere un’essenza: importante è conoscere il particolare corposo. Di ciò e dunque dell’alternativa a Faust, s’incarica in Grabbe don Gio174 vanni. Costui, cercando affannosamente l’aria dopo che è stato costretto a mascherare una propria voglia con parole ipocrite, esclama: Oh parole, parole! Solo là dove ti soffocano i baci la vita è beata. (I,1) E questa, fa intendere il contesto, è la sola realtà, da opporre alla malinconica magia. La realtà è per don Giovanni l’amore; ma si intende che potrebbe essere qualunque realtà fisica. In altra parte della tragedia, trovandosi in casa infestata da spiriti, che vi hanno lasciato il loro cattivo odore, don Giovanni comanda infatti a Leporello di cucinare un arrosto perché al mondo non c’è niente di più reale dell’odore: in un attimo ci trasporta magicamente nel regno della realtà. (IV,4) La realtà è dunque quel che ha a che fare col corpo. Ci sono due inviti a convertirsi che don Giovanni rifiuta. Al governatore morente replica: quel che oggi ho fatto era più che naturale; e il naturale, caro il mio vecchietto, è anche il giusto. (III,1) E «quel che sono resto!» dirà infine alla statua del governatore. Io sono don Giovanni e dunque divento nulla se divento un altro! (IV,4) Faust aveva corso questo rischio accettando di essere ringiovanito. È però a Faust che viene riservata una più profonda conoscenza del nichilismo. A costui che insiste perché gli vengano rivelati i principî ultimi dell’universo, il diavolo replica: non li capiresti nemmeno se te li spiegassi per bene perché si trovano al di là del linguaggio. Voi riuscite a pensare solo quel che vi riesce di racchiudere in parole. (II,1) La lingua, insiste il diavolo, è più grande dell’uomo e «ciò che non ha parole non ha né senso né chiarezza.» I cultori della semiotica non si rallegrino troppo di questo loro precursore; l’ultima parola spetta infatti a Faust, che conclude: «Dunque tutta l’umanità non sarebbe che un cumulo di chiacchiere.» Alla negazione dell’essenza (alla «morte di Dio») tiene così dietro la negazione di un io capace di afferrare la sostanza (la ragione umana coi suoi strumenti logici, si riduce a un «cumulo di chiacchiere»). 175 Grabbe ce ne dà la giustificazione storica lanciando Faust in un lungo monologo in cui sostiene «non sarei Faust se non fossi tedesco» (I,2) e spiega poi la condizione storico-culturale della Germania. Ma non dà indicazioni positive. Il nichilismo viene visto come risultato di una crisi e non viene detto come superarlo. Don Giovanni non è una vera alternativa, tanto che il diavolo può alla fine portarli entrambi all’inferno argomentando così: lo so che puntate alla stessa meta anche se cavalcate due cavalli. (IV,4) Gli spunti in positivo che possono venire da don Giovanni vengono intesi come non più che episodici, quasi una specie di sollievo momentaneo entro la rassegnazione. Questo è il limite che mi pare si debba riconoscere a tale nichilismo. Analogo limite si trova nel Faust di Nikolaus Lenau (1802-1850), che peraltro presenta un impianto teorico. Ancora prima dei limiti sarà bene vedere proprio questo impianto in quel che offre di affascinante. Lenau affronta e smonta successivamente le tre grandi idee in cui secondo Kant si riassume il sapere (o pseudosapere) metafisico: l’idea dell’anima, l’idea del mondo e l’idea di Dio. Il programma decostruttivo è esplicitamente annunciato da Mefistofele: Da Cristo si è separato; non mi resta ormai che separarlo dalla natura. [...] Una volta ottenuta la rottura tra di loro e impedito così il contatto con ogni forza che vuole la pace, finirà col trovarsi solo col suo Io. (Faust, scena “Der Teufel”, Il diavolo) E Lenau comincia dallo smontare l’idea di Dio. Prima di fare il patto col diavolo, Faust riflette: Non sarà che il mondo ha avuto origine dal fatto che Dio ha perso se stesso? Forse il divino si è staccato da Dio per poi tornare pellegrinando verso Dio? Forse che l’essenza divina si è risvegliata, e risalendo gli oscuri abissi del presentimento originario, dove giacciono sopiti i germi di Dio si è elevata alla potenza dello spirito? Di modo che la natura, con il suo odio e con il suo amore, ha fatto germogliare Dio come fosse un fiore? (“Die Verschreibung”, Il patto) L’idea che il divino sia sceso nel mondo per risalire a Dio previo attraversamento di tutto il mondo è evidentemente il modello cristiano: Dio si incarna in Cristo il quale con la propria morte redime tutta l’umanità. Ma a nessuno può sfuggire che lo stesso modello è stato a base delle teorie rivoluzionarie almeno da Rousseau in poi. A lungo conservatosi, questo modello ipotizza innanzitutto un’epoca felice (per Rousseau si tratta dell’epoca che precede la proprietà privata; per Marx sarà l’epoca in cui l’uomo si appropria dei 176 prodotti del proprio lavoro; per Nietzsche l’epoca della bestia bionda, quando gli ariani invadono l’Europa dominandola secondo i propri principî). A tale epoca felice segue una caduta, qualcosa come un peccato originale (tale per Rousseau è l’avvento della proprietà privata, per Nietzsche la lunga caduta è quella in cui gli ebrei prima e i cristiani poi si sono rivoltati alla bestia bionda; per Marx si tratta dell’espropriazione del prodotto del lavoro). Infine seguirà la redenzione (la volontà generale, il superuomo, il comunismo; come già il regno di Dio), la quale annullerà radicalmente la storia finora avutasi. Sintetizzando in termini teologici: c’è uno stato iniziale di grazia da cui si decade e che poi si recupera attraverso quella che S. Agostino chiamò la “felix culpa”: quella che indusse Dio a incarnarsi e a scendere fra gli uomini. Il mondo di grazia che sarà restaurato alla fine non è la ripetizione del Paradiso terrestre, da cui siamo stati cacciati una volta per tutte, ma una cosa talmente superiore che non se ne può neanche parlare con cognizione di causa. Per Nietzsche occorrerà addirittura presupporre un rifacimento biologico dell’uomo. Lenau è del tutto al di fuori di questo schema che critica esplicitamente. Afferma infatti l’impossibilità di tale ipotesi (chiamiamola così) agostiniana: è impossibile il ritorno del divino a se stesso attraverso il passaggio per il mondo, poiché «la vita è dissipazione». Non esiste pertanto un nucleo originario che si espanda in maniera omogenea, cioè in modo tale che se ne possano tenere le fila attraverso il mondo. Le fila non esistono, perché la vita è più ricca di quanto vorrebbe una concezione del genere; dunque non esiste nemmeno un punto nodale in cui quelle fila si raccolgano per capovolgere quanto è avvenuto fin lì e - secondo l’escatologia cristiano-rivoluzionaria - porti a salvazione tutta la sostanza umana. È sempre Faust a proporre le tesi ora riassunte (nella scena citata, continuando): Sì, bisogna chiedersi in tutta serietà se il mondo, con il suo corso, si debba definire una caduta o un’ascesa. E se si trattasse invece di un effondersi, un fuoriuscire, un traboccare della plenitudine divina, che non ritorna più alla sua fonte? Se tutta la vita non fosse che dissipazione dell’infinita ricchezza di Dio, di cui mai più egli avverte la perdita [...]? Per tale via Lenau arriva a negare la sostanzialità del concetto di natura e susseguentemente che la storia abbia un fine. Egli si rifà alla concezione romantica secondo la quale il Dio ebraico aveva la grande pecca di creare dal nulla, facendo così della natura una pura strumentalità a servizio dell’uomo; era pertanto Dio stesso a introdurre il male nel mondo, concedendo all’uomo una potestà violenta sulla natura. Per quanto lo riguarda direttamente, Lenau sostiene che chi ha posto un cuneo a dividere l’uomo dalla natura è stato Cristo, dichiarando quest’ultima peccaminosa. Dunque l’uomo non può più avere un rapporto diretto con la natura: o essa è peccato (e dunque da evitare) oppure è lo specchio di Dio se redenta (e dunque il rapporto avviene con la mediazione di Dio). In 177 questo modo non si riesce a costruire un senso all’interno del mondo stesso ma si deve continuamente cercarlo altrove. È Mefistofele a riassumere la situazione: Gli ebrei vi hanno rovinato il mondo! Lo spirito benefico dell’India e della Grecia è scivolato via su di voi senza che ne abbiate tratto alcun profitto; ora, per la vostra stupidità, viviamo in un mondo di noia. Sono stati gli ebrei, quei maniaci del Messia, a cacciare il vostro carro in un pantano senza uscita. Hanno preso quel loro Messia e l’hanno incastrato, a mo’ di cuneo, nel punto in cui l’uomo e la natura si toccavano; ora sono separati: lei di qua, lui di là, da quando certi sciocchi pastori si sono messi a cantare per le campagne. In quella notte, che fu la peggiore di tutte le notti, apparve il bambinello tanto atteso; gli ebrei cominciarono a tremare e a dubitare della loro follia, ma, per lo spavento, si dissero che quello non era il vero Messia. Lo spaventi però è rimasto sul viso di quei traditori ed è rimasto, come un marchio indelebile, anche su quello dei loro discendenti; in quell’ora la natura, attraversando in un colpo solo tutto il futuro, incise con uno scalpello appuntito il segno della maledizione sulle generazioni seguenti: «Gli ebrei hanno rotto il patto che li legava a me!» (“Das Waldgespräch”, Il colloquio nel bosco) Quest’ossessione antisemita ha dell’incredibile. Essa usa un argomento della polemica cristiana contro gli ebrei: il popolo eletto non sarebbe più tale per non aver riconosciuto il Messia; ma in realtà Lenau ce l’ha col concetto stesso di Messia, cioè con l’incarnazione di Cristo e la redenzione connessa, dunque col concetto essenziale del cristianesimo. Per cui l’esplosione di razzismo con tanto di supporto fisiognomico sarebbe ridicola, nella sua illogicità, se non fosse tragica. L’incredibile discorso prosegue con una profetica lode di Spinoza (colui che «porterà il nome della corona di spine») e con una dichiarazione di immanentismo: Un giorno, per espiare quell’antica maledizione, nascerà un grande ebreo, ma sarà troppo tardi! Scrittore ricco di dottrina, autore di opere indimenticabili, egli inchioderà Gesù al palo della morte con le punte di diamante del suo spirito e porterà il nome della corona di spine. Ma ormai in voi si sono spente le forze di un tempo, sono appassiti i grandi sentimenti che sgorgavano dal cuore, sono svaniti i canti eroici, i miti pieni d’incanto, è scomparso l’amore possente che genera gli dei. La natura è stata tradita e la sua fiducia voi l’avete calpestata e perduta per sempre; per quanto ora cerchiate di scrutarne il volto, essa non vi aprirà più il suo cuore scontroso; chi non la elegge a suo bene supremo, chi cerca un Dio nell’Aldilà, la perde per sempre. Negato il concetto di Dio (e, più precisamente, che Dio dia senso alla storia, che la storia umana sia storia del divino) e negato il concetto di natura (cioè che esista una organizzabilità immediata, sensata e oggettiva del nostro rapporto fisico col mondo circostante, retto da leggi) resta da negare il concetto di io, inteso principalmente come facoltà si produrre idee. Mefistofele definisce tali idee 178 cavalli [su cui] balzare di colpo in groppa e fare una cavalcata attraverso il mondo, finché il cavallo mi disarciona e fugge via impaurito, per tornare dal suo padrone e ai suoi pascoli tranquilli. (“Der Sturm”, La tempesta) Che cosa resta di tutto l’universo? La noia, riempita di costruzioni arbitrarie: Come quel guardiano che nella foresta faceva ruotare attorno al suo capo quel tizzone ardente [per scacciare una civetta indesiderata], così il guardiano eterno fa ruotare come un turbine attorno al suo capo impassibile l’incendio dei pianeti dell’universo, per scacciare dalla sua notte quella civetta che altrimenti gli si avvicina gracchiando: la noia. (ibidem) È su questa tesi della ripetitività inessenziale del mondo che poi Lenau svilupperà, in un’opera a parte, la sua concezione del don Giovanni (Don Juan, 1844). Arrivato intanto a concludere su un Faust nichilista, Lenau gli dà almeno l’orgoglio del nichilismo conquistato: Faust non aspetta che sia il diavolo a portarlo all’inferno ma si suicida. Da questa fase nichilista dell’elaborazione del mito faustiano non emerge una proposta positiva credibile. Di Grabbe si è già detto: il suo don Giovanni non è un’alternativa. Nel Faust di Lenau compare a un certo punto il marinaio Görg a mostrare un rapporto immediato con la natura; Faust però ne dimostra l’insufficienza teorica. Sia in Grabbe sia in Lenau quelle proposte parziali hanno valore etico e non teoretico e non scongiurano la tragedia. Gnoseologia, etica e metafisica venivano talmente separate da non ritrovare un punto di fusione; l’opera decostruttiva era tanto primaria da non lasciare posto ad altro. Ma, per quanto parziali, quelle proposte ponevano un problema di estremo interesse: come può il nichilismo agire nel mondo? Esso era particolarmente acuto dopo che sia Grabbe sia Lenau avevano escluso la catarsi del superuomo, Grabbe addirittura citando il termine “Übermensch”, di notoria ascendenza goethiana (III,3; cfr. Lenau). Il tema dell’agire di Faust nel mondo non era certo nuovo; e non mi riferisco a quella metafora della storia del mondo che è il secondo Faust di Goethe, ma ai tentativi di far agire Faust nella storia concreta: per dirla in breve, all’acquisizione di una dimensione politica per Faust. Nel suo Doktor Faust pubblicato nel 1797 (dunque sette anni dopo che Goethe aveva pubblicato il suo Faust. Ein Fragment, al quale il testo in questione non mostra di riferirsi) Friedrich Julius Heinrich von Soden (1754-1831) aveva fatto agire Faust nella guerra contadina del 1525, dotandolo di amor di patria e suggerendo attraverso di lui una soluzione moderata degli impulsi rivoluzionari, dirottandoli a favore dello Standestaat, dello stato corporativo. Nel 1861 Faust viene fatto agire nella 179 stessa ambientazione ma con tutt’altri intenti - e cioè da un punto di vista democratico e repubblicano - dal critico e scrittore Friedrich Theodor Vischer (1807-1887), in un progetto di secondo Faust, alternativo a quello realizzato da Goethe. L’agire nel mondo è un problema valido anche per il nichilismo. Grabbe, che nel suo Don Juan und Faust affronta ripetutamente il tema della storia e dell’agire in essa, formula così il proprio pensiero: Distruggere e delle rovine fare un cumulo, questo l’uomo sa farlo; e sa farlo con cesti e secchi con cui aggiunge una pietra all’altra o una goccia all’altra, chiamandole arte e scienza! Dio crea dal nulla, noi da rovine! (I,2) Una tesi cui il don Giovanni di Lenau tenterà di opporsi. C’è ancora un buffo tentativo di cui vale la pena parlare. Heine ha fatto di Mefistofele una donna; una scrittrice a suo tempo assai in voga e di cui ci occuperemo ancora altrove, la contessa Ida Hahn-Hahn (1895-1880), da Heine ampiamente sbeffeggiata, femminilizza Faust nel suo romanzo Gräfin Faustine (La contessa Faustina, 1841). Costei vorrebbe tanto imitare lo Streben di Faust, solo che Faust II non le è piaciuto; quindi decide che le occorre riscriverlo, o meglio riviverlo; insomma Gräfin Faustine sarebbe un Faust II riveduto e corretto. Infatti il Faust goethiano (così lo riassume lei) va prima dietro al piacere dei sensi finché non se ne sazia, quindi cerca il godimento nell’ambizione, nello splendore mondano e nella vanità mondana. Non ci riesce molto e in compenso tutto quest’agitarsi spirituale lo spegne. Proprio qui è l’errore; se l’amore non lo soddisfa, dovrebbe provare con l’ambizione (ma non se ne era già parlato?), con gli splendori del mondo (anche questo non sembra nuovo) e con l’arte. In ogni caso non si può far spegnere un Faust ma al massimo spezzarlo; una volta rotto, può anche tornarsene o da Gretchen o da Filemone e Bauci, ma solo per morire. Questo si può fare in un’epoca in cui si scrive troppo (sostiene la contessa, che pure pubblicò opere per complessivi 66 volumi). Di conseguenza Faustine ha molti amori, tutti finiti male per gli uomini, che si ammazzano o scompaiono in malo modo; dipinge capolavori, scrive capolavori; quindi, stufa di tutto, si ritira tra le suore di stretta clausura (invece di ripercorrere il finale di Faust II) e lì muore presto perché alla clausura non resiste. Sarebbe tutta una storia da ridere se non ci fossero osservazioni non sciocche sulla natura dell’amore: L’amore è consacrarsi a un oggetto; ma l’oggetto deve proprio restare sempre lo stesso? Non ci sono in noi progressi e rivolgimenti che a loro volta ne richiedono altri? A vent’anni possiamo essere tanto maturi da prevedere il nostro sviluppo e le conseguenti esigenze fino ai trenta e disporci subito in tal senso? 180 Non si dovrebbe prendere a regola l’eccezione né dire che amore è solo il tenersi allo stesso oggetto. L’amore: non vedi che oggi ci innalza fino al cielo e domani ci precipita nell’inferno? A momenti di estasi […] ne seguono altri […] in cui dissentiamo su piccolezze; e siccome sono piccolezze ognuno pensa che l’altro potrebbe pur cedere. La mia anima si è inebriata con la tua in tali estasi d’amore ed entusiasmo che tutto quel che può occorrerle in questa regione può essere solo ripetizione e forse… scialba per di più. Excursus: Tradizioni Questa sezione è stata intitolata “Le tradizioni”; quel che vi è stato trattato si è svolto nella prima metà del secolo. Abbiamo cominciato non con l’esistenza ma con la presa di coscienza della tradizione, anzi di più. Una tradizione indica, fra le altre cose, una costanza nel tempo; nella presa di coscienza con cui abbiamo cominciato si trattava, oltre la costanza, della ricerca di un’essenza fondante, riconoscibile soprattutto nei primordi e da riproporre nella sua schiettezza; la tradizione che solo attraverso la sapiente mediazione di Grimm veniva sottratta all’immobilità. Il compito che quella presa di coscienza si poneva era di disvelare l’essenza in modo da costruire su di essa il futuro; si trattava, cioè, di scoprire ciò che è alla base di una tradizione per poter continuare la tradizione. In tal modo la tradizione consapevole era tanto disvelamento quanto costruzione. Il ripensamento dell’idea di nazione e la nascita del nazionalismo furono alla base del successo avuto da quella tendenza. Depurato da quanto c’era di equivoco e c’è di non accettabile dietro un presupposto quale il nazionalismo, occorre pur dire che, non essendosi da allora abbandonate considerazioni di lungo periodo e dell’omogeneità da esse comportata (pur con le tantissime trasformazioni da esse subite), quelle concezioni nascevano insieme con l’era moderna; in altre parole, dobbiamo farci tuttora i conti. Abbiamo constatato che prendere coscienza di una tradizione significa ipso facto farne nascere un’altra. L’abbiamo studiato in due fenomeni letterari: nella nascita della Dorfgeschichte e nell’immenso successo del romanzo storico. Abbiamo accennato agli equivoci cui quei generi erano legati; qui è il caso di sottolineare che l’aspetto volitivo fu ben sottolineato nelle teorizzazioni relative, anche polemiche: a quei generi veniva assegnato un compito, quello di lavorare all’unità della nazione finché questa non fu raggiunta, e di rafforzarla e potenziarla in seguito, fino al rovesciamento in strumenti di espansione. Dunque non si trattava di prendere atto dell’essenza popolare e nazionale ma di guidarla, limitando (si veda l’atteggiamento nei confronti delle letterature dialettali) quelle spinte che parevano non andare nel senso voluto. Non si trattava di imparare dal popolo che cosa fosse l’essenza ma di insegnargli verso dove e in che modo guidarla. E siccome a leggere quella letteratura era il “popolo” borghese e urbano, anche se si parlava di villaggi contadini, si trattava di dire a quei lettori quale era la loro missione, assicurandoli al tempo stesso che il resto del “popolo” (quello di cui si scriveva) li avrebbe seguiti purché la politica egemone mostrasse di ispirarsi alla sua essenza. Dunque disvelamento 181 dell’essenza, presa di coscienza della tradizione, fondazione di nuove tradizioni (che però si presentavano come la tradizione sic et simpliciter, quella basilare ed essenziale), erano tutte operazioni di egemonia. La satira si fa carico della pars destruens. Di per sé, satira e tradizione possono andare perfettamente d’accordo, tant’è vero che esiste una tradizione della satira. Ma mentre la tradizione si veste di sacralità, la satira è dissacrante e quindi facile a rinvenire e recepire spazi nuovi. L’esito non è obbligatorio; prova ne sia la satira di Immermann, che alla fine converge con la pretesa sacralità delle tradizioni contadine, proponendo bensì la fine sia del mondo satireggiato sia di tradizioni desuete, ma anche la costruzione di una monarchia ben ordinata sulla base dei valori traditi da queste ultime. Questo è un esito che rientra nelle operazioni di egemonia di cui si diceva sopra; a suo modo, è un esito nuovo, tuttavia controllato da quella gestione egemonica della tradizione di cui finora s’è detto. L’apertura verso spazi nuovi può voler dire di più, fino all’oblio della tradizione, oltrepassandola per risalire al contesto che ha reso possibili i discorsi su di essa: fino alla modernità. Allora la pars costruens, esplicita o implicita che sia, non avrà più di mira valori costanti fino alla atemporalità ma la modernità stessa; con Weerth e Glaßbrenner abbiamo accennato a questa zona. Ma ci si può chiedere se qui non si rischia una nuova forma di cecità, con una satira che tardi a prendere di petto una tradizione nei suoi aspetti irriflessi, costrittivi e frenanti anche tutti coloro che partecipano della modernità; perciò la pars costruens rischia di restare costruzione astratta o al più di accompagnare, nel suo ruolo di opposizione, l’imporsi di un’egemonia che maneggi il concetto di tradizione, e accompagnarla spronando tale egemonia a raffinarsi, operando continuamente sulla tradizione in modo da adeguarla ai tempi nuovi. Heine, che nella polemica con Börne si richiamava alla peculiarità e ai limiti dell’intellettuale, ci aiuta a vedere più lontano del pur simpatico Glaßbrenner (che per coincidenza fu dalla parte di Börne contro Heine). Intanto stiamo vedendo come si stia restringendo un mondo che il concetto di tradizione voleva comprensivo di tutto un popolo: è diventato opera di egemonia di una classe e più precisamente degli intellettuali di quella classe e più precisamente ancora di un filone di quegli intellettuali. Di questo passo si può arrivare a una tradizione che, per quanto vasta, è comparativamente per pochi eletti: l’abbiamo visto col mito di Faust, già oggetto di un Volksbuch ma infine decaduto a motivo letterario per letteratura dotta; col mito americano, che invece ha un’altra storia: motivo letterario, ma prevalentemente per letteratura di massa e in presenza della realtà sociale dell’emigrazione; l’abbiamo non più che accennato per la filologia goethiana, che diventerà una specie di patentino di riconoscimento per germanisti. Così il complesso dei letterati, dei critici e degli storici costruisce le proprie tradizioni, che gli servono a identificarsi, a riconoscersi, a regolare i rapporti interni ed esterni. Posta la loro identificazione, occorre vedere come i letterati e i loro critici si incontrano; non fra loro (l’incontro fra letterati e germanisti non sembra costituire un problema per nessuno; le cose vanno al meglio quando i letterati di cui i germanisti parlano sono già morti) ma con il pubblico. In quest’ottica abbiamo accennato alle due istituzioni più importanti: l’editoria e il teatro (per i germanisti avremmo dovuto trattare delle scuole e delle università, mentre invece vi abbiamo accennato molto in fretta). Sulla costituzione del pubblico ci danno indizi le statistiche dei lettori e degli spettatori, ma sulla sua qualità forse il più ce lo dice un’indagine sul dilettantismo. Una produzione di 182 libri e riviste così vasta, una vita teatrale così vivace presuppongono un pubblico recettivo fino all’imitazione; è appunto questo il terreno del dilettantismo, che ha conosciuto anche personaggi notevoli: Pückler-Muskau è presumibilmente il più noto fra loro, consapevole di essere un dilettante e anzi teorizzatore di questa sua qualità. Ma certo non tutti i dilettanti possono permettersi 900 ettari da trasformare in parco. Avevamo cominciato con un ambiziosissimo concetto di tradizione e siamo approdati al costituirsi, perpetuarsi e comunicarsi di gruppi. Per di più in questa sede sono stati trattati fondamentalmente i minori (anche con qualche ingiustizia: forse Weerth non è un “minore”). La cosa è stata fatta a ragion veduta: si può parlare di tradizione quando c’è diffusione, quando non si appunta lo sguardo primariamente sulle personalità emergenti ma su chi la tradizione la riceve come cosa più o meno indiscussa, eventualmente la subisce o la soffre, e in questo modo contribuisce a proseguirla come cosa naturale, dotata di una sua autorità. Le personalità di spicco non si intendono senza il loro contesto, ma questo vale anche per le tradizioni stesse. Esse non vivono di per sé ma per le circostanze che le fanno vivere. Il modo in cui si riflette sulle tradizioni non è spiegato dalle tradizioni stesse, ma dal momento in cui la riflessione si opera e nel quale confluisce la tradizione stessa insieme a ciò che tradizione non è; vi confluisce la ripetizione, ma anche ciò che si verifica per la prima volta. Quindi la tradizione è data insieme col suo contrario. Perciò sarei stato costretto a dividere in due parti la storia delle tradizioni: perché occorreva darne di volta in volta il contesto. (E alla fine – per complicare il discorso – si vedrà perché la seconda parte manca.) Tutto questo l’abbiamo constatato. Ma occorre aggiungere che il condizionamento storico è stato a sua volta constatato attraverso un condizionamento storico. Infatti la riflessione sulle tradizioni e sulla loro forza coesiva nasce nell’epoca dell’individualismo e del dinamismo. Le tradizioni appaiono essere una sua giustificazione paradossale (in altri momenti si sarebbe detto: dialettica): ci muoviamo, e ognuno per sé, ma sulla base di ciò che è costante e coesivo, che è cioè l’opposto del movimento e dell’individualismo. Le tradizioni servono così a tante cose: sono giustificazione ideologica ma anche mistificazione; sono immaginario compensativo di una realtà che va in tutt’altro modo, ma anche invocazione di un freno e di un ubi consistam. E sono magari anche riconoscimento di ciò che non si lascia gestire ma, al contrario, ci condiziona. Le tradizioni delle quali qui ci siamo occupati sono state messe su carta: sono diventate dei testi critici e letterari. Abbiamo visto un determinato loro rapporto con la realtà extraletteraria: a quei testi venivano assegnati dei compiti. La traduzione in termini effettivi era riservata alla politica, che però teneva molto conto di quel fiancheggiamento ideologico: sul campo di battaglia di Königgrätz (1866) Bismarck ottenne dal re di Prussia la revoca di una sospensione inflitta alla “Gartenlaube”; e d’altra parte venne detto che il vero vincitore di quella battaglia, in cui la Prussia schiacciò l’Austria, era stato il maestro di scuola prussiano. Quella realtà in cui la politica traduceva la letteratura e la germanistica (o che queste ultime si incaricavano di giustificare) ha poi avuto ben altri nomi che Königgrätz; fino ad approdare a Hitler, al quale la germanistica si consegnò mani e piedi, facendo finta di nulla dopo la guerra e dunque guardandosi bene dal fare l’autocritica. 183 Probabilmente tutto ciò condiziona lo sguardo di uno storico della letteratura tedesca. Può darsi che studiosi di altre letterature se la cavino diversamente. A me confesso che riesce difficile leggere Auschwitz come un testo scritto mascherato, oppure leggere un testo scritto come se si trattasse immediatamente o quasi di Auschwitz; la prima soluzione la pretende de Man («le basi della conoscenza storica non sono fatti empirici ma testi scritti, anche se questi testi si mascherano da guerre o da rivoluzioni»), la seconda ritengo sia una non giustificata estrapolazione della vulgata zdanoviana. La letteratura tedesca fa forse soffrire più di ogni altra, ma forse tanto più stimola a chiarirsi; e per esempio a distinguere le sue responsabilità da quelle della politica, perché diverse sono le loro categorie, dunque devono essere diverse le loro “letture”, ben distinte nei metodi. Quando si incontrano, ci sarà da mettersi di volta in volta dal lato della letteratura e dal lato della politica, proprio come insegnava Heine. E intanto c’è da dire addio alla germanistica (preciso: alla “germanistica”). 184 III Il popolare 185 186 III, 1. Il popolare I e dintorni III, 1, 1. Il Volkstück L’autore di cui stiamo per parlare rientra nella storia del teatro popolare e ci permette innanzitutto di capire che cosa è cultura popolare; però ha una sua chiara fisionomia. Ha una sua fisionomia, però non la si apprezza e non la capisce al di fuori della cultura in cui rientra. Ferdinand Raimund (1790-1836) è al centro di questo movimento pendolare. Questo non è il luogo per ricostruire la tradizione d’appartenenza. Occorrerebbe risalire al Medioevo; non lo faremo, ma è bene sapere che occorrerebbe farlo. E occorrerebbe soffermarsi sulla grossa svolta che il teatro barocco ha significato anche per il teatro popolare, perché i suoi effetti durarono fin dentro l’Ottocento. Meno che mai andrebbe dimenticato il succedersi delle figure comiche dominanti: lo Hanswurst, inventato nel 1705 da Joseph Anton Stranitzky (e che Gottsched fece simbolicamente bruciare a Lipsia nel 1737 dall’attrice Neuberin durante un prologo in teatro); il Kasperl, presentato per la prima volta da Johann Joseph Laroche nel 1781; e poi le figure rimaste meno a lungo, ma proposte sempre di nuovo, fino ai primi decenni dell’Ottocento, e che ebbero importanza nell’evoluzione del teatro popolare. Ma se volessimo restare a questi elementi avremmo molta difficoltà nel definire il teatro popolare. Essi sono indispensabili, anzi vanno allargati, eppure non sono sufficienti. Cominciamo con l’allargarli. Ai tempi di Raimund esistevano a Vienna tre grossi teatri frequentati da artigiani, piccoli impiegati, commercianti e operai. I prezzi erano bassi, i teatri stracolmi. Essi erano: il Theater an der Leopoldstadt, aperto nel 1781; il Theater an der Wien, aperto nel 1786; il Theater in der Josephstadt, aperto nel 1788. Il Theater an der Wien era stato costruito da Emanuel Schikaneder (il librettista del Flauto magico) ed era dotato di tali macchinari scenici quali non aveva nessun altro teatro di Vienna, compreso il Burgtheater, cioè il teatro per la nobiltà e i borghesi più facoltosi. Prima di allora, peraltro, i teatri popolari erano ospitati in edifici molto meno vistosi, spesso in baracche di legno; le avvenute costruzioni solide indicano che il teatro popolare era economicamente produttivo. Il suo pubblico affezionato era popolare; ma neanche i frequentatori del Burgtheater disdegnavano di farvi una capatina. Il pubblico andava attirato numeroso; occorrevano quindi molte novità: i tre teatri insieme mettevano in scena un minimo di trenta lavori per stagione. C’erano quindi autori ultraprolifici: ci fu chi scrisse trecento commedie (Alois Gleich, 1772-1841) o almeno duecento (Karl Meisl, 1775-1853). È facile immaginare che per scrivere tanto si saccheggiava tutto il saccheggiabile: commedie altrui (non solo austriache ma anche inglesi e francesi, che fungevano in ogni caso da 187 modelli), romanzi e insomma tutto quel che capitava. Fiorivano le contaminazioni e le parodie; questa anzi era una delle espressioni privilegiate del comico. Importante, comunque, è che tutto venisse scritto: fin dal 1752 la censura aveva proibito l’improvvisazione sulla scena; pertanto i testi dovevano essere presentati scritti all’approvazione, che veniva data con l’espresso divieto di allontanarsene. Ciò diede l’avvio a una maggiore riflessione sui testi da recitare: l’attore non poteva più sperare di cavarsela e magari di salvare la serata ricorrendo ai lazzi, perché questi l’avrebbero portato in prigione. Quei teatri mettevano in scena un po’ di tutto: melodrammi, farse, balletti, drammi cavallereschi, insomma tutto quel che attirava il pubblico. Die Ahnfrau (L’àvola) di Grillparzer ebbe la sua prima (1817) nel Theater an der Wien e da qui passò al Burgtheater; König Ottokars Glück und Ende (Fortuna e fine di re Ottocaro) dello stesso Grillparzer, invece, fece la via inversa: dal Burgtheater (1823) al Theater an der Wien. Difficilmente però queste tragedie possono rientrare nel nostro concetto di teatro popolare. Dunque le notizie fin qui date, per quanto irrinunciabili, non bastano a definirlo. Ci aiuta un po’ di più il sapere che, anche se il repertorio era parzialmente interscambiabile, non così gli attori: non si conosce alcun caso di attori che, diventati famosi nel teatro popolare, siano poi passati al Burgtheater. Raimund, affermatosi prima come attore e poi come autore, si crucciò tutta la vita per la mancata ascesa, anche con conseguenze sui suoi testi scritti. Dunque il teatro frequentato da un pubblico popolare metteva in scena di tutto. Ma gli autori che sono giunti a noi sono autori di testi comici; al loro interno, per la verità, tali testi non sono esclusivamente comici: e qui entriamo nella zona di analisi che procede bensì dalla tradizione di cui sopra, ma che ci illustra dall’interno, dalla fisionomia dell’autore Raimund, un primo concetto di popolare. «Zauberposse», «Zauberspiel» e «Zaubermärchen» sono le parole che compaiono nei sottotitoli dei lavori di Raimund a designarne l’appartenenza di genere. Ciò rientra nella tradizione che, con antecedenti che qui non verranno trattati, si sviluppa a Vienna a partire grosso modo dal 1780 (cosa che spiega perché Il flauto magico di Mozart cominciò la sua carriera da un teatro popolare): la vicenda teatrale - chiamiamola così - terrena veniva inserita entro un mondo di fiaba, interveniva a legarne e a scioglierne i nodi. A sua volta la fiaba faceva affidamento sui macchinari scenici e si faceva propriamente carico della spettacolarità dell’insieme. A riprova, ecco una didascalia da Raimund: Il contadino milionario Atto primo Scena prima Gran sala delle fate, brillantemente illuminata da lampade magiche di vari colori che - montate su candelabri - ornano la scena. Nello sfondo, l’apertura di una gran porta ad arco, coperta da un cortinaggio simile ad uno scialle con fregi d’oro. Nel centro della scena due furie, un tri- 188 tone, e il piccolo Borasc suonano un quartetto di due violini, viola e violoncello. Le voci del quartetto si alternano con gli a solo. Gli strumenti sono d’oro, il leggio immaginario. In circolo stanno seduti Zenobio, Antimonia, Selima, Zulma, Lira, il mattino, la notte, la sera e diversi personaggi allegorici, maghi e fate ai quali, di quando in quando, quattro genietti alati in livree da domestici offrono dolciumi su vassoi d’argento. La scena è accompagnata da coro. Occorre dunque dire con chiarezza che il teatro popolare non era un teatro “povero”, ma un teatro che puntava molto sulla spettacolarità dei grandi mezzi scenici, ossia sulla tecnica più avanzata dell’epoca. Inoltre faceva uso della musica sia come accompagnamento orchestrale sia - e soprattutto - sotto forma di canzoni, altra richiesta irrinunciabile di quel teatro. Ma già qui, dalla musica, cominciava la richiesta di semplicità: canzoni orecchiabili e trasportabili fuori della farsa, in modo che potessero diventare popolari in modo autonomo. Ma soprattutto la richiesta di semplicità veniva rivolta alla vicenda: caratteri fissi, traversie e soluzioni prevedibili. A riassumere le farse di Raimund secondo questi parametri le si può far sembrare facilmente insopportabili. Ci sono infatti la virtù e il vizio, ben distinti e distribuiti, neanche fossero tagliati a fette; e alla fine la virtù viene sempre premiata, il vizio viene sempre punito, la sconsideratezza diventa ragionevolezza, così come analoghi vizi minori vengono guariti. Poi non bisogna diventare ricchi perché fa male alla virtù e anche alla salute: ti viene la gotta e peggio, mentre invece la povertà rende forti, belli, sani e felici. Certo oggi nessuno vorrebbe andare a teatro per sentirsi fare una predica del genere; anche la cultura popolare (ammesso che esista ancora e non la si debba chiamare semplicemente cultura di massa) ha altri modelli. Quei parametri vanno capiti entro la loro tradizione e più specificamente nella loro discendenza dal moraleggiante dramma barocco. Ora la tradizione è tanto importante nella sua vitalità quanto è importante l’arrangiamento che si trova con essa. Proviamo a riassumere i presupposti determinati dalla tradizione nel suo evolversi fino a Raimund; ma già accostare tradizione ed evoluzione significa molto: significa che si poteva cambiare, ma che i cambiamenti dovevano essere accettati dallo stesso pubblico che era abituato ad altre cose. I presupposti che Raimund si trovava a dover soddisfare da una parte, e che lui contribuì a far evolvere dall’altra, erano: uso di grandi apparecchiature sceniche, della musica e di una cornice fiabesca, come già detto; snodi accettati e accettabili e di conseguenza caratteri ben riconoscibili, tendenti a essere fissi. Essi non sono più il Kasperl o quelli seguiti; tuttavia al loro presentarsi devono già darsi come definitivi: l’affamato, l’indebitato, l’ipocrita e via dicendo devono essere chiaramente e definitivamente tali. La vicenda deve avere gli esiti moraleggianti che si è detto. Ma ecco gli arrangiamenti: gli elementi di fissità nei caratteri e nella vicenda servono come coordinate di riconoscimento; sono ciò che facilita l’accesso al complesso dello spettacolo. Entro quelle coordinate c’è lo sviluppo del particolare, c’è l’attenzione portata sulle situazioni quotidiane, proprio quelle del pubblico al quale ci si rivolge. Ecco allora che vengono sviluppati i temi della povertà (in cui non ci si poteva ri189 conoscere alla lettera, ma che era la cifra della vita frugale o modesta), della ricchezza (di cui è difficile proibire il sogno), o i temi elementari della gioventù e della vecchiaia, dell’innamoramento e della via verso il matrimonio, che solleva non pochi problemi economici, oltre che affettivi; e poi i problemi della convivenza, le difficoltà che suscitano le disparità di carattere, l’andamento dell’economia domestica, le preoccupazioni per i figli; il desiderio di uscire da tutto ciò, o sbattendo la porta di casa o mettendosi almeno per un po’ nei panni di un altro. E anche la constatazione che i sogni restano sogni e che il loro effetto consistente è il suggerimento di prendere le cose per un altro verso, magari tornando a teatro per divertirsi un po’. Tutto questo va bene finché il compromesso con la tradizione regge e finché i mezzi scenici fanno quel che devono fare, cioè grosso spettacolo per la gioia degli occhi. Non va più bene quando il contorno straripa e pretende di diventare il centro della vicenda. Raimund è caduto in quest’equivoco, scrivendo due Zauberspiele che già ai suoi tempi non arrivarono al successo: Moisasurs Zauberfluch (Lo scongiuro di Moisasur) e Die unheilbringende Krone (L’infausta corona magica); soprattutto in quest’ultima Raimund aveva preso la fiaba tanto sul serio da volerla trasformare in tragedia. Non era il suo campo; e il suo ammiratore Grillparzer fu il primo a notarlo. Il capolavoro di Raimund viene considerato Der Verschwender (Il prodigo, 1834), l’ultima farsa da lui scritta. Qui il mondo di fiaba si riduce al minimo, quanto basta per assicurare il finale edificante, e irrompe invece la vita: c’è un corrotto che prende tangenti e rovina l’economia (solo del suo padrone; ma si provi a pensarla in grande); ci sono i deboli che nemmeno da ubriachi riescono a farsi coraggio contro i prepotenti; c’è chi è in posizione tale da calunniare e rovinare impunemente il prossimo; ci sono fidanzati che litigano da fidanzati, ma poi in modo cattivo da coniugi, quando ci sono in ballo i soldi e la supremazia; ci sono le resistenze delle classi inferiori ai modelli di vita delle classi superiori (ciò vale finché non decidono di copiarli; nel caso specifico, c’è una critica alla caccia descritta come grande fatica: oggi si direbbe una critica alle fatiche dello sport da parte di uno che fatica per la vita; solo che non si può dire, perché lo sport ha conquistato le masse, almeno come tifoseria); ci sono le fughe d’amore che non riescono; ci sono le speculazioni che portano al fallimento. Va sottolineato che l’elemento fiabesco più insistito, l’apparizione di un mendicante visibile solo a un personaggio e invisibile a tutti gli altri, è di un inquietante che tiene viva la tensione, anche se dal punto di vista dei presupposti tradizionali serve al finale edificante. Del resto, si sa, una commedia deve finire bene. Da quanto visto dovrebbe risultare problematico trasportare Raimund al di fuori della sua tradizione e specificamente da Vienna. Ci provò, in verità, lui stesso con tournées di recite in Germania (Monaco, Berlino, Amburgo), dove ebbe un lento successo. E ciò ci porta a considerare che la figura dell’interprete è essenziale al suo successo; Raimund del resto era un “divo” (anche negli in190 gaggi) che stabiliva immediatamente il contatto con il pubblico e con il quale il pubblico poteva identificarsi. Con ciò sono stati elencati quasi tutti i caratteri popolari dei lavori di Raimund; resta da aggiungere il colorito locale nella lingua e la frequenza del ricorso alle battute grosse (non grasse: queste, anzi, Raimund le eliminò completamente). Eccone un esempio: Ho seccato il dottore per tanto tempo finché mi ha dato quel rimedio che mi farà furbo. Ogni settimana ne piglio una boccetta che costa quaranta ducati e mi mette la testa a soqquadro. Dice di continuare a prenderne soltanto per un paio d’anni e quando ci avrò speso sui duemila ducati vedrò luce tutto in una volta e soltanto allora vedrò chiaramente quanto ero sciocco prima. (Il contadino milionario) Un po’ alla Totò, insomma. Nel Verschwender battute del genere vengono meno, tuttavia proprio qui pare di riconoscere una polemica contro battute più leggere, quelle che non fanno ridere ma solo sorridere, insomma battute da Burgtheater; è un ipocrita tangentista a dire che lui non ride ma sorride: Tu navighi verso l’Inghilterra, [ti auguro] buon vento! Io resto qui e voglio guidar in porto la mia navicella. Però è proprio vero che il sole sorge e poi tramonta! Chi è ora da invidiare? Lui, l’orgoglioso, il celebre mecenate, che con l’animo avvilito deve affidare gli avanzi della sua felicità al mare infido, oppure io, il cameriere mite, modesto, il quale umilmente può mettere al sicuro il bene acquistato in segreto? E a chi devo questa vittoria? (Si batte la fronte). A te, saggezza, la più multiforme delle idee! La natura mi ha dato soltanto una robusta vescica biliare, che non è scoppiata ad onta di tutte le pazzie che da cinque anni mi è toccato vedere in questa casa, ma la saggezza mi ha insegnato a sorridere. È una gran cosa, il sorriso! Quanti uomini si sono creati, sorridendo, la loro fortuna, e un imbecille può sembrare per un minuto un uomo ragionevole se sa sorridere con garbo. Perciò voglio sorridere finché avrò vita e quando sarà la fine poi voglio scoppiare in una risata sonora - cui seguirà il silenzio della tomba. Raimund scrisse solo otto lavori, i più importanti dei quali vengono considerati i tre seguenti: il già citato Verschwender (1834) e inoltre Das Mädchen aus der Feenwelt oder Der Bauer als Millionär (La fanciulla del mondo delle fate ovvero Il contadino milionario, 1826), Der Alpenkönig und der Menschenfeind (Il re delle api e il misantropo, 1828). Nel secondo c’è l’incontro con la gioventù e la vecchiaia cui si è già alluso, mentre del terzo occorre ricordare due possenti momenti: un misantropo vuol restare solo e a questo scopo ha deciso di installarsi in una casupola abitata da povera gente, che lui scaccia offrendo una somma di denaro, alta per quelle persone che non ne hanno mai visto una simile. La violenza di quel gesto, il panico che esso diffonde nei destinatari e le lacerazioni che in essi provoca, sono cose che rendono indimenticabile la scena. L’altro grande mo191 mento è quando il personaggio del misantropo si raddoppia: per guarirlo dalla misantropia, uno del mondo di fiaba assume le sue sembianze mentre il misantropo ne prende altre e quindi assiste alle azioni di se stesso restando se stesso ma parendo agli altri un altro. Chi ama le indagini psicanalitiche ha qui vasto campo. Mentre i successi di Raimund duravano e gli incassi crescevano, era già cominciata l’ascesa e la concorrenza di Johann Nestroy (1801-1862); l’ipocondriaco Raimund se n’ebbe a male. Labile di carattere e ombroso, al morso di un cane si convinse di essere idrofobo e si sparò una pallottola in bocca; morì dopo un’agonia di cinque giorni. In Nestroy troviamo ancora gli elementi già riscontrati in Raimund, ma troviamo anche un’altra personalità e quindi delle differenze. La più vistosa è che Nestroy riduce da subito ai minimi termini l’apporto della féerie e ben presto l’elimina del tutto. La seconda è che i riferimenti alla realtà contemporanea si fanno man mano più precisi. La terza è che negli anni Quaranta cambia anche il pubblico; non che l’aristocrazia sostituisca il popolo, ma di certo agli spettacoli di Nestroy non assiste più solo il popolo più minuto; del resto aumenta anche il costo dei biglietti. Per il resto, riguardo alla tradizione, niente di cambiato, almeno a un primo sguardo; i mezzi restano quelli che avevano cominciato ad affermarsi con la commedia classica e che si erano poi conservati soprattutto nel teatro popolare: equivoci, travestimenti, scambi di persona, agnizioni, giochi di parole e via dicendo. Anzi Nestroy ne fa un uso ben maggiore che non Raimund. Ma basta guardar meglio per capire quale grande cambiamento è avvenuto: quei mezzi non sono più delle coordinate messe lì al fine principale di consentire allo spettatore un riconoscimento e quindi dargli sicurezza, ma vengono usati come mezzi certi e affidabili per aggredire il nuovo, e cioè situazioni riconoscibili e storiche portate sulla scena. A loro volta tali situazioni sono sì addomesticate perché si sa in anticipo che in una farsa il cattivo non può essere pericoloso più che tanto e le zone di pericolo verranno delimitate e vinte, però Nestroy tende molto l’arco fra la presentazione dell’inquietante e il suo superamento. In lui insomma si vede con chiarezza che la commedia è una tragedia rovesciata; fa ridere perché è sulla scena, ma nella realtà non farebbe ridere affatto. I buoni della commedia non sono affatto buoni ma cattivi fino alla crudeltà. E a interessare non è la bontà ma la cattiveria, o almeno l’emarginazione; se poi queste due sono combinate, allora non si può avere di meglio. Nestroy ne fece la prova da subito, dalla commedia che lo lanciò definitivamente sia come autore sia come attore: Der böse Geist Lumpazivagabundus oder Das liederliche Kleeblatt (Lumpazivagabundus spirito malvagio ovvero Un terzetto scapestrato, 1830). Tre spiantati fanno una grossa vincita al lotto, dopodiché uno sposa il suo amato bene, diventa socio del suocero e seguita a far soldi, gli altri due restano quel che sono, rispettivamente un ubriacone e un dongiovanni, si fanno gabbare per 192 bene e tornano a fare gli spiantati; ma sono loro due i personaggi interessanti, non il terzo. Nestroy interpretava l’ubriacone e in questa parte ebbe i suoi più grandi successi, e sì che ne interpretò di farse e di parti! Dove la simbiosi di cattiveria ed emarginazione raggiunge il culmine è in Der Talisman (Il talismano, 1840), una commedia che è tutto un ribollire di trovate ma che avrebbe bisogno di poco per passare in tragedia. È la storia di un’emarginazione, poi di una carriera rapida e senza scrupoli una volta trovato il «talismano» per accedervi, quindi di un crollo quando il «talismano» viene scoperto e sottratto e quindi di una nuova ascesa, anch’essa senza scrupoli, una volta cambiato «talismano». Le ascese vengono favorite da appoggi non disinteressati; d’altra parte chi si muove verso l’alto non ha esitazioni a lasciarsi alle spalle chi l’ha appoggiato prima. Così del resto commenta lo stesso protagonista: La mia posizione in questa casa è come la tavola del naufrago: devo buttare giù gli altri oppure affogare io. È la commedia, cioè le trovate sceniche e il linguaggio, a rendere accettabile tutto questo e a far ridere. Ma è un riso crudele, perché così è la vita. L’emarginazione è data da un pregiudizio sociale, che però ritiene di avere una base nella natura: nel caso specifico il protagonista ha i capelli rossi e il pregiudizio lo respinge ai margini; il talismano è una parrucca, nera finché si tratta di salire i primi gradini dell’ascesa sociale, bionda quando si tratta del salto finale. (Questa base fisica può non esser presa sul serio da chi non sa quanto contino certi presupposti nelle varie culture popolari; ma in tal caso si pensi al colore della pelle invece che dei capelli, e si avrà l’esempio che si cerca.) Privato del primo talismano, il protagonista viene considerato non più uno che ha fatto una brillante carriera in base ai suoi meriti ma un arrampicatore sociale che non ha badato a mezzi e non si è fatto scrupoli. Il protagonista commenta il proprio crollo in termini economici: L’orgoglioso edificio delle mie speranze è bruciato senza assicurazione, le azioni della mia fortuna sono crollate del 100% e il mio attivo corre alla più rotonda delle somme: a zero. A questo punto interviene però un secondo e più potente talismano: i soldi (al modo di una commedia: per un’improvvisa eredità ed entrata in possesso di negozio). In un finale maligno, il protagonista non si fa scrupoli nemmeno stavolta; mediatrice di tanta fortuna era stata infatti una nobile signora che sperava così in un buon matrimonio per la sua cameriera personale; ma c’è lì in agguato una pastorella schietta e pura, che spunta fuori al momento da lei atteso e intasca il marito; del resto fin dall’inizio della commedia si è premurata di far sapere che quando vuole una cosa l’ottiene sempre. Ma si tratta appunto di una commedia; la simpatia dello spettatore va al protagonista (naturalmente era Nestroy 193 a interpretarlo), che il destino e gli uomini sono sempre pronti ad angariare e che dunque deve essere più pronto del destino. Altrove però non c’è dubbio: a interessare sono i dichiaratamente “cattivi”. In Der Zerrissene (Il dilacerato, 1844) c’è una situazione straordinaria intorno a una Madame Schleyer. Un focoso e ingenuo fabbro, che si è spiantato per lei e al quale lei è scomparsa, crede che gli sia stata rapita; in realtà, lei è scappata con un altro. (Nestroy rielabora qui un episodio della sua vita: la moglie l’aveva abbandonato, mollandogli anche il figlio, per seguire un conte ungherese; ma la cosa non finì bene per lei, che in seguito dovette implorare un aiuto economico dall’abbandonato marito.) La signora ricompare come vedova che tenta di tenersi a galla con dei mezzucci; capita in casa del signor Lips, un tale che, avendo abbondanza di soldi, può permettersi di avere anche lo spleen e, per sfuggirgli, decide di sposare la prima donna che vedrà, cioè appunto la signora Schleyer. Nella scena in cui i due si incontrano e nelle schermaglie fra il ricco dilacerato e la signora, che si presenta come virtuosa ma ingannata e sfortunata, Nestroy ha profuso una girandola di battute come non ce ne sono nel resto della commedia. Ed è ancora per Madame Schleyer che il fabbro e il ricco si battono, credono di uccidersi a vicenda e infine si riconosceranno innocenti e vivi in un’efficace scena di incontro tra finti spettri. L’altra scena di cattiveria, minore ma apprezzabile, è quella dello scroccone che si giustifica ricordando i doveri dell’amicizia (dell’altro) e facendone le lodi. Insomma, sono i cattivi che contano. È quel che oggi troviamo ancora interessante in Zu ebener Erde und erster Stock oder Die Launen des Glücks (Pianterreno e primo piano ovvero I capricci della fortuna, 1835), in cui spicca per vitalità la figura del disonesto cameriere Jakob (non per nulla Nestroy s’era riservata questa parte). Ma indubbiamente dal punto di vista storico sono qui importanti altri elementi e i contemporanei vi videro altre cose. Nestroy vi sfruttò appieno le possibilità tecniche del Theater an der Wien: la scena era divisa in due metà, una inferiore e una superiore (come dice il titolo) e molti erano i cambiamenti a vista, grazie alle scene girevoli. In tal modo, attraverso due azioni sostanzialmente indipendenti, potevano essere messi a contrasto due ambienti sociali: quello del ricco speculatore al primo piano con quello del povero rigattiere al pianterreno. E non si tratta di un contrasto al di là dei tempi: nella vita del riccone (e anche del cameriere che l’imbroglia) hanno la parte decisiva, prima benefica e poi malefica, i commerci, le banche e le assicurazioni, cioè la realtà che si veniva imponendo a livello europeo; e il rigattiere ha i suoi problemi con l’affitto di casa e con la famiglia numerosa, composta di più nuclei che si affollano nel poco spazio. Fu da quella commedia che si cominciò ad attendere da Nestroy la svolta decisiva nel teatro austriaco: una commedia aristofanesca, come si disse, con saldo riferimento alla realtà contemporanea e con integrazione dei mezzi ereditati dalla tradizione. Nestroy partecipò alla rivoluzione del 1848, si arruolò nella guardia repubblicana e montò la guardia con tanto di sciabolone (i viennesi corsero a vederlo 194 come se fosse uno dei suoi tanti travestimenti). E alla rivoluzione dedicò una commedia (Freiheit in Krähwinkel, Libertà a Roccacannuccia, 1848) che dal punto di vista drammaturgico è un trionfo del travestimento; il personaggio interpretato da Nestroy, il repubblicano Ultra, vi si travestiva da: gesuita, ambasciatore russo, commissario europeo per la libertà e l’uguaglianza, proletario e infine da Metternich; un gruppo di ragazze veniva travestito da studenti, perché si sa che senza studenti le rivoluzioni moderne non si possono fare. (Per rendere plausibili i travestimenti, si dice che sono a disposizione i costumi teatrali sequestrati a un capocomico in difficoltà. Così si insinua in questa commedia anche un embrionale elemento di teatro nel teatro.) E poi ci sono i soliti scambi di persona, equivoci, eredità e via dicendo. La satira delle condizioni contemporanee viene condotta con tutti questi mezzi: i quali con poche battute fanno emergere la prepotenza e la disonestà dei potenti, l’ottusità dei burocrati, le paure dei piccoli impiegati, la bigotteria di gente varia e via dicendo. Nestroy non s’illude neanche che la rivoluzione sia un toccasana; prevede anzi che, spezzate le catene, i cittadini mostreranno tutta la loro grettezza, si spaventeranno delle tante novità e rimpiangeranno i tempi andati; e da uno spione fa dire: basta lasciarli sfogare e poi, quando gli sarà passata, si lasceranno pizzicare uno per uno. E fu profetico: la commedia andò in scena il 1.7.1840 e fino al 31 luglio venne recitata quasi ogni giorno; poi la stagione finì, Nestroy partì in tournée e la recitò anche in Germania; il 4 ottobre ci fu a Vienna la 36a e ultima replica; il 31.10.1848 le truppe governative rioccuparono Vienna. E oltre ai mali più gravi che questo significò, quali arresti in massa ed esecuzioni, venne anche reintrodotta la censura. Ma con la censura, che pure gli aveva suggerito parole di fuoco nella sua commedia rivoluzionaria, Nestroy sapeva cavarsela bene. Lo dimostrò subito in quella straordinaria parodia di una tragedia di Friedrich Hebbel che fu il suo atto unico Judith und Holofernes (Giuditta e Oloferne, 1849). Quando si parla male di re, magnati, preti e false vergini si dice la verità e la censura lascia fare perché pare poco interessata a ebrei e babilonesi. Ma ecco che cosa ha fatto passare la censura: ARALDO. Nabucodonosor vuole che d’ora in poi non vengano adorati altri dèi all’infuori di lui. OLOFERNE (tra sé). Dove si vede che arie cominciano a darsi i re quando hanno degli Oloferni che gli conquistano il mondo. ARALDO. Nabucodonosor vuole che si sacrifichi a lui ogni aurora. OLOFERNE. Solo all’aurora? (A parte) Diventa ragionevole, costui: ma noi, come suoi sudditi, siamo sue vittime a ogni ora del giorno. [...] 195 OLOFERNE. Chi sono questi Ebrei? AMBASCIATORE. Gli Ebrei sono uno strano popolo. OLOFERNE. Gli darò una bella lezione. Chi è il loro re? AMBASCIATORE. Il loro Dio è anche il loro re. OLOFERNE. In altri paesi il re è anche Dio, alla fine è tutt’uno. E questo per quanto riguarda le speculazioni in tempi di guerra: JOAB. Dimmi, paparino, a che punto stanno le metalliche babilonesi e le lionesi mesopotamiche? JOJAKIM. Joab, figlio mio, chi pensa in questo momento alla Borsa? Le azioni delle ferrovie del Nord Assiria salgono di ora in ora, il nostro corso vitale è quotato alla pari con la morte, Oloferne verrà qui come sensale e ci penserà lui alla chiusura. JOAB. Dicono che avremo un gran rincaro dei prezzi e la carestia; allora la miglior cosa è investire in titoli di Stato. Gli si dovrebbe fare un processo, a quell’Oloferne: lui che è solo generale, come cavolo ti tratta i re? È subordinazione, questa? I misteri della censura sono insondabili; forse avranno creduto che fossero espressioni di antisemitismo. Una commedia che sembra il condensato di tutto Nestroy è Einen Jux will er sich machen (Vuol prendersi uno spasso, 1842). Per la verità qui non c’è il “cattivo” (tranne in una parte piccolissima e irrilevante) ma ci sono tutte le citazioni desiderabili della “cattiveria”, a cominciare dal programma che abbozza un commesso, alla vigilia di diventare socio del suo padrone: WEINBERL. Chi della vita del mondo sa solo poche cose che ha appreso in qualche vecchio libraccio spaiato, chi il levar del sole lo vede solo dal finestrino del solaio, chi il rosso del tramonto lo conosce solo dai racconti dei clienti, prova dentro di sé un vuoto che tutte le botti d’olio del Sud, tutti i barili d’aringhe del Nord non bastano a riempire, un gusto insipido che tutte le noci moscate dell’India non riescono a insaporire. [...] Il servitore è schiavo del negozio. La seconda schiavitù è più nobile, ma non ci godi più che nella prima. Avessi, nella mia vita, un solo punto elettrizzante, potessi dire, anche solo di poche giornate: Che tipaccio sono stato, quella volta là! Ma niente, non sono mai stato un tipaccio. Come sarebbe bello se un giorno, ormai vecchio commerciante in compagnia 196 di altri vecchi commercianti, seduto davanti a un buon vinello giovane, quando chiacchierando tra amici si rompe il ghiaccio del magazzino dei ricordi, si spalanca il portone dei bei tempi e la vecchia merce si stipa nella bottega della fantasia, quando insomma si svuota il sacco delle antiche storie, io potessi dire: «Oh, anch’io, una volta, sono stato un tipaccio, un dritto, una birba!». Devo ... devo, a qualunque costo, procurarmi questa coscienza di dannato tipaccio! E allora via con: sostituzione di persona, mancato rispetto dell’orario di lavoro, falsa promessa di matrimonio, conti non pagati e via dicendo. Tutto, ovviamente, sulla base di equivoci, travestimenti, scambi e complicazioni varie, triplicate dall’intrecciarsi di tre diverse avventure. Poi tutto finisce bene, com’è pure ovvio, e c’è anche tanto di eredità; «ma quanti zii e zie devono morire ogni anno, solo perché tutto finisca bene!» La cosa straordinaria di questa commedia è che oggetto di divertimento diventano gli stessi mezzi teatrali di cui l’autore si serve; tutto è tradizionale, non c’è alcun mezzo nuovo: ma nessuno di essi è preso sul serio, nessuno deve portare a un qualche fine nobile, tutto è ugualmente motivo e veicolo del divertimento. Non c’è quasi lavoro di Nestroy che non sia nato come rielaborazione di lavori altrui; questo è ovvio per le parodie (ce ne sono anche da Wagner: Tannhäuser e Lohengrin), ma è vero anche per il resto. Le ragioni sociologiche più generali sono già state dette, e Nestroy scrisse pur sempre 83 lavori teatrali. Ma forse c’è una ragione in più: l’avere fondamento in un altro testo (parodiato, stravolto o saccheggiato che fosse) era anch’esso un modo di riferirsi alla realtà, stavolta alla realtà di una tradizione, di uno sviluppo o di un’attualità della vita teatrale. La lingua di Nestroy è un viennese avvicinato allo Hochdeutsch; con tale lingua, scrisse Karl Kraus, Nestroy elevò barricate di parole contro la banalità. E tuttavia è necessario richiamare l’attenzione sul carattere ambiguo di quel che chiamiamo “popolare”. Le due parti in cui Nestroy ebbe maggior successo furono quella del calzolaio ubriacone Knieriem in Lumpazivagabundus, che recitò 259 volte (anche in età avanzata il pubblico viennese glielo richiedeva) e quella del commesso Weinberl in Jux, che recitò 161 volte. La prima è quella di un artigiano spiantato che rifiuta l’ascesa sociale; nel secondo caso l’ascesa avviene già all’inizio con la promozione da commesso a socio, ma il commesso la mette poi a rischio per tutta la commedia, durante la quale il suo comportamento è l’opposto di quel che ci si aspetta da un socio. Si può pensare che questi rifiuti di ascesa sociale (pur diversi e pur con il lieto fine) siano un segno di forte identificazione e che si rifiuti quell’ascesa perché l’appartenenza al proprio gruppo è primaria. Ma di fatto a quell’ascesa non viene contrapposto nulla di altrettanto positivo. A meno di non voler considerare valori elementari come la gioia del vino o l’amore per le donne, che però Lumpazivagabundus mostra anche veicoli attraverso i quali si può essere imbrogliati; oppure l’amore per la sregolatezza, che però in Jux viene severamente punita quando sulla scena compare un ladro 197 (per così dire) vero. A riprova: Der Talisman, in cui l’ascesa sociale ha una parte essenziale, finisce con le lodi dell’amore semplice e puro in seno alla natura, e questo sarebbe il controvalore (che peraltro l’ambiguità del finale rende incredibile). Insomma: non bisogna chiudere gli occhi sulla forte componente conservatrice della cultura popolare. E neanche su un’altra componente: la radicale ambiguità. Qui non basta richiamare l’attenzione sull’ambiguità dei contenuti, quali segnalati dal finale del Talisman, in cui il ritorno alla natura si fa con tanti soldoni e con pastorella pronta ad acciuffare il buon partito. L’ambiguità è più vasta, ma paradossalmente alla fine essa ci assicura che non possiamo rinunciare a parlare di cultura popolare, a patto di non mitizzarla. L’ambiguità riguarda la fluidità dei confini. Si è già avuta l’occasione di nominare Franz Grillparzer; la sua Ahnfrau ebbe la sua prima nel Theater an der Wien, cioè in un Vorstadttheater, sede privilegiata per i Volksstücke, ovvero per il teatro popolare; e qui approdò dal Burgtheater König Ottokars Glück und Ende; e ci approdò talmente bene che nel Talisman Nestroy poté riassumerne una determinata situazione semplicemente citando quel titolo: E questa è la fortuna e la fine del re Ottocaro! Non era un caso: questa tragedia mostra affinità col Volksstück. Ciò vale anche per Der Traum ein Leben (Il sogno – una vita, 1817-31), che ricorre addirittura a un inquadramento nel sogno, affine a quello nelle féeries usato da Raimund e per un certo tempo anche da Nestroy; la sua definizione di genere, datagli dallo stesso Grillparzer, è del resto «fiaba drammatica». C’è però da aggiungere che, come già il titolo suggerisce, questa «fiaba drammatica» risente di un’esperienza nata anche dalla lettura di Calderón. Più in generale, i lavori teatrali di Grillparzer hanno uno dei loro punti di riferimento nel teatro barocco spagnolo. Come si ricorderà, il teatro barocco è uno degli antenati del teatro popolare viennese. Dunque c’erano punti di contatto non velleitari; né c’è da meravigliarsene se si riflette che proprio nell’epoca barocca furono precisati i rapporti fra cultura alta e cultura popolare in modi che almeno per i paesi cattolici (e forse non solo per quelli) sono arrivati fino all’epoca moderna, portandosene dietro la fecondità così come le ambiguità. Ma, con tutti i contatti che si vogliono, nessuno pensa di assegnare Grillparzer alla cultura popolare. Per definire quest’ultima e delimitarla occorre dunque combinare più criteri: sociologici, cioè quale è il pubblico realmente raggiunto; psicologici, cioè per quale pubblico si intende scrivere; strutturali, cioè in quale storia di forme e di tipizzazioni ci si muove; tematici, in cui confluiscono tutti i precedenti: certi temi, con certi linguaggi e certe forme raggiungono un determinato pubblico e non un altro; se vogliono raggiungerne un altro, vanno filtrati in altre forme e altro linguaggio. Nella fluidità che risulta da quanto detto deriva la necessità di parlare di culture diverse e l’imprecisione in cui si cade quando lo si fa. 198 III, 1, 2. La carriera teatrale pubblica di Franz Grillparzer (1791-1872) va dal 1817 al 1838, cioè dalla prima della Ahnfrau al fiasco di Weh dem, der lügt (Guai a chi mente). Ciò che scrisse in seguito per il teatro venne pubblicato quasi tutto postumo. E in generale c’è da dire che dopo il suo ritiro scrisse molto ma pubblicò pochissimo e raramente cose importanti (tra le quali, peraltro, il racconto Der arme Spielmann, 1847). Ma poiché quel che veniva scrivendo per il cassetto era di importanza almeno pari a ciò che aveva pubblicato, e forse superiore, ci sarà da riflettere sulle ragioni del ritiro. Si ponga mente alle date: nel 1817 erano ancora vivi e attivi quasi tutti i protagonisti dell’età classico-romantica. Goethe avrebbe pubblicato il Divan solo nel 1819. Era ancora vivo e attivo Kotzebue, che insieme con Iffland (morto nel 1814) era stato uno dei modelli del giovane Grillparzer. C’è poi quello che da tutti, Grillparzer compreso, viene sentito come un interregno, «l’incapace periodo tieckiano-menzeliano», come scrive nel 1836, un periodo che nella coscienza di tutti è durato fin troppo a lungo e che probabilmente veniva considerato già occupante l’epoca in cui cade la Ahnfrau. E di fatto a quell’epoca non c’era in giro molto di nuovo. Quando nel 1838 Grillparzer si ritira, è ancora il periodo dello Junges Deutschland, un’area che Grillparzer non ama affatto, ma che gli pare una buona «cura da cavallo» contro la pochezza contemporanea. Nel frattempo egli era stato in contatto con chi c’era e contava. Nel 1826 aveva visitato Tieck, Goethe, Rahel Levin, Hegel, Chamisso; nel 1836 Börne e Heine. La sua attività pubblica coincise cronologicamente con quella di Raimund e grosso modo con quella del primo Nestroy, che è il più interessante. Ma nel complesso mantiene le distanze. Il sistema di Hegel non è per lui, Börne e Heine gli piacciono umanamente (almeno il primo) ma per nulla il loro ambiente politico. Goethe è da lui ipervenerato, ma quando viene invitato a un colloquio privato non accetta, per paura di essere costretto a portare alla luce le divergenze esistenti fra loro; vedremo infatti che Goethe fu per lui sì un modello, ma più un modello cui opporsi che uno da imitare. Insomma, a torto o a ragione, anche Grillparzer si sentiva agire nel deserto. Sarà bene ricordarsene quando parleremo del suo rapporto con la tradizione. Forse c’erano anche elementi privati. La vita di un funzionario medio-basso nella Vienna di Metternich doveva essere occasione di non poche frustrazioni. Metternich stesso poteva permettersi di citare a tavola cento versi a memoria e con ammirazione dal proibito Childe Harold di Byron, e precisamente i versi che all’epoca venivano avvertiti come i più sovversivi; ma la censura era pronta a fare tutte le difficoltà a Grillparzer, spettatore alla stessa tavola di quell’esibizione. E poi c’erano le nevrosi amorose. 199 La stessa carriera teatrale di Grillparzer fu piena di alti e bassi. Grande successo della Ahnfrau (1817) e ancor più di Sappho (1818); modestissimo successo della trilogia Das goldene Vließ (Il vello d’oro, 1821), di cui solo la terza parte si affermò un po’, ma non più che un po’ (in compenso piacque a Hegel); di nuovo grande successo con König Ottokars Glück und Ende (1825) ma anche notevoli seccature con la censura; stranissima la sorte di Ein treuer Diener seines Herrn (Un fedele servitore del suo signore, 1828): grande successo iniziale, l’imperatore vuol comprare il testo a condizione che esso non venga più recitato né stampato, la cosa non va in porto e dopo ben poche repliche il testo viene dismesso fino al 1851; fiasco di Des Meeres und der Liebe Wellen (Le onde del mare e dell’amore, 1831); trionfo di Der Traum ein Leben (1834); infine fiasco di Weh dem, der lügt (1838) e ritiro dalle scene (e quasi da ogni uscita pubblica come letterato) di Grillparzer. È possibile, più che possibile che le sue nevrosi l’abbiano aiutato in questa decisione. Tuttavia l’esame dei testi e dell’evoluzione dell’autore suggerisce l’esistenza di motivi oggettivi, che vedremo. Nel 1851 Heinrich Laube, l’ex Jungdeutscher approdato alla direzione del Burgtheater, provvede a un rilancio di Ein treuer Diener e di Des Meeres und der Liebe Wellen, che grazie a lui arriva al successo. Laube però ci dice anche che i tentativi di portare fuori Vienna l’ultima tragedia nominata e la «fiaba drammatica» Der Traum ein Leben sono falliti. Aggiunge poi che l’insuccesso sia di Des Meeres und der Liebe Wellen sia di Weh dem, der lügt erano stati dovuti alla loro epicità, dunque al loro scarso carattere drammatico; nel primo caso aveva potuto rimediare cercando una adeguata protagonista femminile, nel secondo caso non aveva nemmeno tentato perché Weh dem non può affatto essere considerato un Lustspiel. Laube, cui tutti hanno riconosciuto grandi meriti come uomo di teatro, dà qui delle indicazioni preziose. Aggiungiamo che neanche le tragedie postume ebbero poi questo grande successo. E che, tranne Sappho, non pare che alcuna opera teatrale di Grillparzer sia riuscita ad affermarsi fuori dell’Austria (forse con l’eccezione della Ahnfrau, in cui però il vero Grillparzer non c’è ancora, o al massimo c’è in embrione); ma Sappho, che piacque a Goethe, venne vista nel 1819 a Francoforte da Börne, che ne scrisse una partecipe recensione. Diamo un’occhiata alle forme: tutti i lavori teatrali precedentemente elencati (e poi di nuovo tutti quelli postumi) sono Trauerspiele, con eccezione degli ultimi due: il Traum è una «fiaba drammatica», Weh dem è un Lustspiel. Dunque quando Grillparzer si ritirò era in atto un cambiamento. Per rendercene conto e per fare una storia della produzione di questo autore dobbiamo tornare a fare un discorso sulle forme. Dal punto di vista delle forme Grillparzer è il più classico fra i classici; perfino più classico di Goethe poiché Grillparzer non ha mai avuto un suo Sturm und Drang. Ebbe a modello appunto la Iphigenie auf Tauris di Goethe; lo dice esplicitamente a proposito di Sappho. Ma ecco che già le cose si complicano. Sicuramente le forme classiche vengono conservate intatte (le poche licenze che si 200 prende, per esempio nella versificazione del Goldenes Vließ, sono funzionali a uno scopo - nel caso specifico: caratterizzare le diverse culture dei personaggi e non intaccano il rispetto della forma classica), ma l’Iphigenie non è certo il solo modello. Classicità significa in Grillparzer essere dentro una somma di tradizioni, tutte rispettate, citate, riconoscibili. Ciò è vero perfino per Die Ahnfrau, un formidabile drammone con corna, uxoricidio, parricidio, incesto (o quasi), figlio scambiato, masnadieri, rovine, tombe scoperchiate e fantasma, e tutto questo perché si scateni la forza del destino; infatti Grillparzer si inserisce tempestivamente nell’ondata dei drammi del destino, iniziata appena due anni prima da Zacharias Werner con l’atto unico Der vierundzwanzigste Februar (Il ventiquattro febbraio, 1815), scrivendo però una tragedia in cinque atti classicamente divisi: romanticismo recepito in una forma classica. Ma quando la tecnica di Grillparzer si affina e i suoi intenti si precisano, il suo rapporto con le tradizioni si fa più ricco, certo, consapevole. Volksstück, teatro medievale, teatro barocco (di ascendenza spagnola), classicità (sia secondo Goethe sia secondo Schiller), sono forme fuse, a volte nello stesso lavoro. Ecco per esempio Ottokar: la materia è trattata nel teatro popolare da cui Grillparzer la riprende; inoltre egli pensa a un teatro nazionale secondo modelli schilleriani; nel secondo e nel quarto atto usa la tecnica medievale dell’allineamento (una serie di figure compare in successione, ciascuna si presenta e poi si congeda), appena appena velata da un minimo di contorno; infine c’è il richiamo al barocco desengaño quando Ottokar capisce i suoi errori e le sue colpe e accetta la morte più come espiazione che come orgogliosa conseguenza. In altre opere il riferimento al barocco è ancora più evidente; nel gran teatro del mondo Dio assegna all’uomo una parte, di cui alla fine chiede conto; in Ein Diener come in Weh dem non si impegna direttamente Dio ma la massima autorità disponibile (il re, un vescovo), che assegna un compito politico-morale (un dignitario deve sostituire il re mantenendo la pace; un cuoco deve liberare un ostaggio senza mentire e senza far comunque niente di male), di cui alla fine chiederà conto, discutendo però al tempo stesso se il compito assegnato era giusto e fattibile (e questo dubitare segna una notevole differenza rispetto al modello barocco). Dunque il classicismo di Grillparzer va inteso come sintesi di tradizioni, il cui ancoraggio è la forma classica. Sono inoltre tradizioni indubbiamente valide per tutta Europa, ma la cui somma e vitalità si trovava nella realtà sia passata sia presente della cultura austriaca; cosa che diventa intuibile se alle tradizioni dette si aggiunge quella specificamente viennese dello Zaubermärchen (usata nel Traum, anche se il canovaccio era stato desunto da un antipode, cioè da Voltaire), ma che a sua volta si integra con la consapevolezza che Grillparzer aveva di essere un autore specificamente austriaco; ne prende atto, perfino con una certa sorpresa, nel 1837. Non che la sua caratterizzazione dello specifico austriaco sia un granché (lo trova nella modestia, nel buon senso e nella schiettezza del sentire), ma importante è che lo accetti. E nel concreto delle realizzazioni esso ci viene incontro nel modo detto. 201 Quanto ai suoi intenti dichiarati, ecco una piccola summa dei suoi pensieri sul dramma, messi insieme dal 1820 al 1840. Il dramma deve procedere secondo una rigorosa causalità; la sua azione deve mostrare chiaramente le cause e in quale modo gli eventi rispondano a un’intenzione, sia questa del protagonista, dell’antagonista o anche di circostanze che assumono la funzione di un’intenzione (nel qual caso si può parlare di destino). Le cause agiscono sulla libertà umana, attivando anche degli impulsi inconsapevoli; nel caso che a muovere all’azione siano circostanze esterne, non sotto il nostro controllo ma tuttavia oggetto della nostra riflessione, abbiamo il destino. I singoli fatti vanno connessi secondo il principio di causalità; è questo il carattere primario del dramma. Tuttavia la storia ci dice che tra un elemento e l’altro della catena della cause si verificano delle incongruenze; servendosi dell’intuizione, la tragedia può cercare di farle vedere, ma certamente qui si corre un rischio. (Grillparzer aggiunge che per parte sua lo corre volentieri perché è stufo di allineare i tanti passaggi psicologici che altrimenti ci vorrebbero.) Scopo della tragedia è la catarsi; essa si ha riconoscendo la nullità della vita terrena e l’esistenza di un ordine cosmico, che all’interno di un gruppo (una stirpe o altro) riequilibra le mancanze individuali. È evidente il classicismo di tali dichiarazioni di poetica, sia pure con la coloritura barocca attinente la catarsi. Le tragedie di Grillparzer ruotano intorno a valori, virtù (o anche a vizi, cioè a dei controvalori), calati in personaggi che hanno valenza cosmica, non episodica; il singolo personaggio e le sue azioni devono far vedere quella proiezione cosmica. Inoltre giova ripetere che il classicismo di Grillparzer è un concentrato di tradizioni. Insomma la sua è la via opposta a quella di Grabbe: le forme non tendono a dissolversi ma a inglobare; contro tutto ciò che è straripante, esse assicurano un ancoraggio fuori discussione. Ma già qui c’è da chiedersi se non si stia insinuando qualche elemento di crisi e se la solidità della forma non nasconda qualcosa; se quel tutto che il classicismo di Grillparzer ingloba non sia troppo e se in quella forma classica non ci sia un animus molto meno classico. La catastrofe, in cui secondo Grillparzer la necessità deve vincere sulla libertà (e non viceversa, altrimenti non si scriverebbero più Trauerspiele), dovrebbe anche ricomporre i contrasti nel modo detto, rinviando a un ordine superiore. Ma se c’è "troppo" da ricomporre, la catastrofe diventa sempre più difficile, il finale si fa sempre più problematico. E poiché i finali più problematici di tutti sono quelli delle opere postume, abbiamo un primo indizio per capire l’evoluzione (e il ritiro) di Grillparzer. Occorre ora integrare le precedenti dichiarazioni di poetica con una dichiarazione della Selbstbiographie (Autobiografia, 1853), in cui Grillparzer spiega quello che a Goethe avrebbe dovuto dire ma non disse nel 1826: mentre l’ideale goethiano privilegiava la compostezza e la misura, Grillparzer si sentiva più portato alla forte fantasia e a calde sensazioni; la predilezione per le esplosioni selvagge alla Ahnfrau non si era spenta in lui. Anzi aggiungeremo che la forza devastante delle passioni è al centro di varie sue tragedie successive. 202 Ebbene, è proprio l’irrefrenabilità delle passioni a rendere problematici certi finali e a spingere Grillparzer verso soluzioni formali e tematiche delle quali presumibilmente non è troppo sicuro, non troppo convinto, non troppo soddisfatto. Ricordiamoci che i due ultimi lavori teatrali pubblici non sono più Trauerspiele ma forme che permettono soluzioni positive: un dramatisches Märchen, un Lustspiel. Se l’interpretazione che comincia così a delinearsi è esatta, allora il classicismo di Grillparzer, così compatto, così carico e a sua volta così ancorato nella tradizione austriaca, assume il carattere di luogo di rifugio. Grabbe fa esplodere (o quasi) le forme perché ci sono troppe spinte eccentriche; poiché c’è un eccessivo ribollire e un accumulo di spinte, Grillparzer vuol riportarle tutte alla sicurezza della forma. Entrambi i tentativi falliscono a loro modo: la forma resiste a Grabbe, il tentativo di conciliazione catartica si rifiuta agli sforzi di Grillparzer. E ciò comincia da subito, dalla acclamatissima Sappho. La poetessa torna da Olimpia con la corona della vincitrice e con un frastornato bel giovine, Faone, che era andato a Olimpia per far correre i suoi cavalli e si ritrova a Lesbo, promesso sposo di Saffo. Faone non capisce bene quel che gli è successo; lui ammirava la poetessa Saffo, nei suoi sogni lei e la poesia si fondevano; ma adesso non capisce proprio a che punto si trovi. È che Saffo vorrebbe due corone, come dice lei stessa: quella della poesia e quella della vita: che la vita dia l’arte e che l’arte dia la vita. Faone dovrebbe assicurarle la vita, lei a Faone l’arte. Ma la cosa non funziona. Già le persone vicine a Saffo rimangono sbalordite quando lei presenta quel giovinetto nulladicente come nuovo padrone di Lesbo. E poi lo stesso Faone, passando da uno stordimento all’altro, prima si invaghisce e poi si innamora di una schiava di Saffo; costei crede di portare un argomento di rilievo dicendo che la fanciulla, Melitta, non è molto intelligente. Il fatto è che Faone non si è innamorato di Saffo ma vede l’amore attraverso la poesia di Saffo. Il suo amore vale qualcosa perché è quello di Saffo; la sua amata è amabile perché in lei c’è lo spirito di Saffo. Ma Saffo stessa deve restare in alto, fra le divinità; l’oggetto dell’amore è altra cosa: brutalmente Faone le spiega che lui può innamorarsi solo di una donna pari a lui, non di una divinità. Una dea non scende impunemente fra i comuni mortali. Saffo dice di aver capito: a lei sono leciti solo piccoli sorsi alla coppa della vita, non di più; quindi, per non cadere nel ridicolo e non venir meno alla sua parte (divinità da venerare, non donna da amare), si uccide. Giustamente Börne, che pure ammirava molto questa tragedia, si mostrò perplesso. Saffo comincia con l’annunciare l’ambizioso programma di una fusione tra arte e vita; ma prima di tornare nella parte che è sua, prima di rinunciare alla vita per assurgere definitivamente tra le divinità, Saffo ha vissuto uno straordinario dramma borghese. Le scenate di gelosia fra lei e la schiava Melitta, i furibondi litigi fra lei e Faone, il tipo di amore che sorge tra Faone e Melitta, sono tutti avvenimenti, stupendamente mostrati, propri del dramma borghese: fatti e parole vengono stravolti per ritorcerli contro la perso203 na prima amata e ora divenuta odiosa. Nessuno degli avvilimenti e delle bassezze possibili viene risparmiato a nessuno. Sospetti, insinuazioni, residue speranze, calunnie, odî, sotterfugi: non manca nulla. Questo avvilimento, si direbbe in un dramma borghese, se l’è voluto Saffo stessa col suo doppio errore iniziale: credere che l’unità di vita e arte sarebbe potuta avvenire al suo modo e scegliere l’auriga Faone come il mediatore ideale. Ciò cui in seguito assistiamo è però la maturazione erotica di Faone, che va incontro all’unica cosa cui può andare incontro, cioè a quella Melitta, così poco dotata intellettualmente, che lui sente pari a se stesso e che sta maturando a sua volta. Tutti avevano visto Faone poco adatto al ruolo assegnatogli da Saffo, solo costei era rimasta cieca. Dei discorsi iniziali e finali di Saffo non capisce niente. L’inizio e la fine sono un monologo di Saffo: lei pone la tesi di una fusione tra arte e vita, lei smentisce la possibilità di questa fusione. Al centro però niente e nessuno le fa eco. Quando alla fine si uccide, lei mette fine a un dramma borghese, entro il quale la sua problematica non è mai entrata, e che finisce con l’essere un exemplum, mentre non doveva essere tale ma costituire l’ostacolo reale per la tesi iniziale. Insomma: si vedono le conseguenze di un errore (la scelta di Faone), ma molto meno l’irrealtà della tesi più generale (impossibilità di fondere arte e vita). Dunque già in Sappho comincia a esserci troppo. Certamente l’impostazione del rapporto arte-vita non avrebbe potuto essere gradita agli autori della Junges Deutschland. I quali a quell’epoca non c’erano ancora (Gutzkow aveva a quell’epoca sette anni; Laube, cui in seguito Grillparzer avrebbe dovuto tanto, aveva dodici anni; Mundt ne aveva dieci); però c’era Börne, che nella sua recensione non toccò affatto il problema. E c’era Goethe con la sua Iphigenie, che Grillparzer aveva preso a modello; scrisse anzi di dovere probabilmente proprio a ciò le lodi di Goethe per Sappho. Ma si vede la lontananza fra i due: Goethe cerca una qualche forma di equilibrio fra due culture e una vaga conciliazione alla fine si profila anche. Impossibile dire la stessa cosa per Sappho. E meno ancora è possibile dirlo per il Vließ, la cui realtà è comunque più complessa. Il vello è l’oggetto del desiderio, di cui fin dall’inizio ci si impadronisce peccaminosamente. A torto esso è stato asportato dal tempio di Apollo a Delfi e da lì sono iniziate sciagure sempre maggiori: dal furto all’assassinio dell’ospite-ladro approdato nella Colchide, alle stragi legate all’impresa degli Argonauti, alla prevaricazione di Pelia su Giasone, alla morte del primo e all’espulsione del secondo, al tradimento di Giasone, alle stragi di Medea. Alla fine però Medea stessa riconduce il vello a Delfi, sottoponendosi al giudizio dei sacerdoti di Apollo. Il dio è dunque l’istanza superiore, le colpe di Giasone (e di tutti gli altri) sono fuori discussione, la nullità della vita umana è dimostrata proprio su di lui: Medea gli rimprovera alla fine di avere tenuto da conto la vita più di quel che non fosse necessario e di non aver capito che quel che inseguiva, felicità e vittoria, sono ombra e sogno. Fra i due, alla fine è Giasone il più dispe204 rato; di lui resta incerto se saprà sopportare ed espiare come Medea. Dunque tutti gli intenti espressi da Grillparzer nella sua poetica appaiono qui realizzati. E in mezzo c’è l’esplosione delle passioni: l’avidità, l’anelito alla gloria, l’amore, la gelosia, la vendetta e via dicendo. Ebbene nell’ultima parte della trilogia, Medea, esse danno luogo a una tragedia borghese, più violenta, più ricca e più complessa che in Sappho. La prima parte della trilogia, Der Gastfreund (L’ospite), è non più che funzionale; la seconda, Die Argonauten (Gli Argonauti), ha dei momenti interessanti (il corteggiamento tra chiassoso e sconsiderato di Giasone, l’innamoramento di Medea con tutti i suoi pentimenti e tentativi di ritirata, i pregiudizi degli altri Argonauti a proposito della barbara maga). Ma è la terza, Medea, che richiama tutto il nostro interesse e la nostra partecipazione. Medea è per Giasone da un pezzo una palla al piede. Finché si era nella Colchide andava bene, ma qui in Grecia, a Corinto per di più, è solo una barbara e una strega. Medea faccia pure tutto quel che vuole per ellenizzarsi, Giasone ha deciso in anticipo che non ci riuscirà. Se solo potesse liberarsene! Medea intanto ci prova; rinuncia alla magia; cambia abbigliamento, vorrebbe perfino imparare a cantare e a suonare canzoncine greche. La nutrice le ricorda che se rinuncia al passato non avrà futuro ma solo attimi di presente irrelato, e comunque non legherà a sé il marito, che si è già stancato. Medea insiste: vuole chiarezza con se stessa e fusione (oggi diremmo: integrazione, assimilazione) col mondo che la circonda. Ma ha fatto i conti senza Giasone, che a piccoli passi si allontana da lei fino a rinnegarla. Nel descrivere questa marcia di allontanamento Grillparzer è straordinario: dapprima Giasone esorta Medea, con non poca rudezza, a comportarsi da persona civile invece che come faceva tra i barbari; poi addossa al destino la responsabilità di quanto è successo, negando la volontarietà delle proprie azioni e dunque anche del passato corteggiamento (non l’abbiamo fatto né io né tu, le dice; semplicemente è successo); quindi si ricorda con ritardi sempre maggiori, sempre più fuori tempo, di essere responsabile anche per lei, che si è affidata alla sua protezione (così la racconta lui); quindi spiega al re di Corinto, Creonte, che ha sposato Medea in una specie di obnubilamento: nella Colchide lei era l’unica persona quasi umana, lui era giovane e sventato, con tutte quelle avventure era diventato un mezzo barbaro, insomma c’era cascato. L’autocompassione, l’ipocrisia, l’egoismo, la vigliaccheria, le menzogne di Giasone vengono fuori man mano. Quella barbara strega gli fa ribrezzo, ora; però non molto prima le ha fatto capire che le sue arti magiche sarebbero state molto ben applicate per ammazzargli lo zio Pelia; ora lo nega perché, come si suol dire, mancano le prove; ma Medea l’aveva capito più che bene. E ha capito anche che tipo sia Giasone; rivolta a Creusa dice: Tu non lo conosci, ma io sì, e a fondo! C’è solo lui, esiste solo lui, nel vasto mondo, e tutto il resto, gli altri, sono soltanto strumenti delle sue gesta. Pieno di sé, badando non all’utile ma solo alla propria immagine, lui gioca con la sua felicità e con quella degli altri. Se s’incapriccia della fama, è pronto ad abbattere 205 chiunque, se vuole una donna se la prende e anche se così spezza il cuore di qualcuna, cosa gli importa? Quello che lui fa è bene, perché è bene ciò che lui vuole. Ah, tu non lo conosci, ma io sì, e a fondo! E se penso a tutto ciò che è accaduto, potrei vederlo morire e mettermi a ridere, sì, a ridere! La povera Creusa, che sente fare questo discorso e poi ne ode di analoghi da Giasone, esclama: E io credevo che i coniugi si amassero! Creusa, che contribuisce alla tragedia finale e ne sarà la prima vittima, è l’unica a essere rimasta quella che era: non si è mai mossa da Corinto, i suoi pregiudizi sembrano innocui e facilmente superabili. Questa natura adolescenziale sembra non far niente di personale; porta via a Medea il marito, ma senza voler male a Medea: è che lei e Giasone erano stati insieme fin da piccoli, Creusa non ha né dubbi né scatti, non ha problemi, non si pone domande; non ha bisogno di capire niente, tutto va bene così com’è. La dilacerata è solo Medea: «Vieni, uomo odiato, vieni, sposo mio» (1110), dice a Giasone; tenta ancora di riconquistarlo, ma Giasone ha trovato il comodo rifugio dell’autocompassione e non c’è niente da fare. Allora Medea torna a essere Medea: recupera i suoi oggetti magici, torna maga, torna a essere quella selvaggia che tutti scacciano e si vendica ammazzando sia Creusa sia i propri figli. Poi si congeda da Giasone, lei, la più forte, con parole di pace, ripetendogli più volte il «Lebwohl» con cui il barbaro Troante si congedava dall’Ifigenia goethiana. Medea spiega a Giasone il senso di quel che è successo e le sue colpe; e poi va a Delfi, a riportare il vello al suo posto e a farsi giudicare. Ci sono molte cose, come si vede: un processo di dissoluzione di una coppia quale neanche Strindberg avrebbe mostrato; un processo di integrazione mancata; una figura di perenne, maccheronica adolescente. E l’azione catartica al disopra di tutto. Forse la fusione è qui meglio riuscita che non in Sappho, anche se ci si può chiedere se catarsi tragica e dramma borghese vadano poi tanto d’accordo. Inoltre l’unità della vicenda simbolico-catartica si ricostruisce solo integrando la trilogia, mentre in realtà è la terza parte a interessare e quasi per nulla le prime due. Ma Medea è la parte in cui esplodono le più violente, le più borghesi passioni moderne nelle loro espressioni più moderne, a cominciare da quelle ignobili. E sono le sole a tenere il campo; l’unico momento di riequilibrio lo dà la stessa passionale Medea, che ormai odia Giasone e la propria sorte, ma che sarebbe ancora disposta a correggere tutto, se Giasone accettasse di sopportarla insieme con lei o almeno non le venissero distolti i figli. La civiltà moderna invece è tutta contro Medea, che vuole non solo respingere ma punire, interpretando la giustizia come più le fa comodo. Questa mancanza di contrappesi costituisce uno dei motivi di fascino della tragedia. Nelle due tragedie seguenti, nelle quali i contrappesi ci sono e sono ben chiari, alla fine anzi addirittura vincitori, aumentano le difficoltà e le perplessità. Ottokar è la tragedia della hybris. Protagonista è Ottocaro, re di Boemia dal 1253 al 1278; ma in controluce occorre vedervi la vicenda di Napoleone. Le troppe vittorie gli hanno dato alla testa e Ottocaro pensa di essere ormai lui a 206 stabilire ciò che è bene e ciò che è male. Per motivi dinastici, ripudia una moglie anziana e saggia, che finora ha saputo frenarlo quando occorreva, ne usurpa i beni (che sono contee e regni) e sposa una donna giovane, carina e vivace, con nuova dote di beni. Crede inoltre di essere lì lì per avere la corona imperiale, e anzi si fa pregare per poter porre condizioni. Invece da quel momento gli va tutto male. Le sue ingiustizie e usurpazioni gli costano la corona, buona parte dei suoi vassalli e simili passano all’imperatore Rodolfo d’Asburgo, nella sua stessa corte lo insidiano i nemici interni, uno dei quali addirittura gli soffia via la nuova moglie. Ottocaro persiste nella sua hybris e nella sua cecità, finché muore in battaglia. Prima però ha il tempo di farsi la morale: Non ho abitato bene nel tuo mondo, grande Iddio! Come tempesta ho attraversato i tuoi campi. Ma solo tu puoi imperversare, poiché solo tu, grande Iddio, puoi guarire. E anche se non ho voluto il peggio, chi ero da pretendere criminosamente di gareggiare col signore dell’universo, cercando attraverso il male una via verso il bene? Alla hybris di Ottocaro si contrappone la moderazione, la giustizia e la legalità dell’imperatore Rodolfo d’Asburgo; di conseguenza, a partire da quando questi compare, e cioè dal terzo atto, la tragedia perde il suo ritmo; ma nei primi due atti, finché si consuma la hybris del re di Boemia e già si vede quali tracolli privati e pubblici gli si preparano, la tragedia è forse la più avvincente fra tutte. Diversamente vengono posti gli equilibri nel Diener; qui l’istanza suprema, il re, compare solo all’inizio e alla fine, a porre il compito e a giudicare. Tutta la tragedia è invece attraversata dalla tensione tra la fedeltà di Bancbanus, chiamato a reggere il regno in assenza del re, e la sfrenatezza del conte Otto, fratello della regina. Proprio per essere fratello della regina Otto crede, un po’ come Ottocaro, di potersi permettere tutto. Insidia Erny, la giovane sposa di Bancbanus, che si sente anche attratta dal giovane, ma non certo dalla sua arroganza. Del resto Otto stesso si presenta così: Mi credete innamorato? Forse! Chissà! O forse no. Non sono così facile a eccitare. Conosco gli uomini, studio le persone, tanto più che la voglia di sapere si rivolge alle donne. […] Se non sono buono, non voglio nemmeno sembrarlo. Ma voi fate le pie colombe e lo siete solo in una cosa, nell’essere sempre ardenti. In un’altalena di sentimenti, Erny (una delle figure più riuscite in tutta la produzione di Grillparzer) sta per fare un passo falso, da cui la salva un franco colloquio col comprensivo marito; e allora alla prima occasione dichiara al troppo impetuoso, irriguardoso, superbo Otto di disprezzarlo. Ciò scatena in Otto una follia furiosa; per sfuggire, Erny si suiciderà e ciò provocherà nel regno dei tumulti cui solo Bancbanus cerca di tenere testa: 207 Ribelli! Io con voi? Io sono l’uomo della pace, il custode della quiete. Il mio re mi ha messo qui a mantenere la pace. E al ritorno del re lo pregherà di spingere la sua istanza di giudice al livello supremo, di giudicare cioè come Dio stesso, la volontà invece del capriccioso esito; ciò apre la via al perdono, così come il senso di giustizia di Bancbanus, cioè la sua decisione di aspettare il re come giudice e intanto mantenere la pace per quanto può, riesce a usare a fin di bene perfino Otto, facendogli mettere in salvo l’erede al trono. Sia Otto sia Ottocaro hanno perso il contatto con la realtà; questi lo recupera riconoscendo la nullità dei suoi sforzi e dunque il supremo ordine divino, Otto dapprima raddoppia la sua hybris con una follia omicida poi con una follia terrorizzata, e lo recupera solo indirettamente, quale strumento del bene. L’istanza positiva (l’imperatore in Ottokar, il re nel Diener) intervengono quando il mondo è tutto sconquassato; il danno peggiore è avvenuto proprio nella seconda tragedia, dove il re ha lasciato un suo rappresentante: il mondo è tanto sottosopra che solo il ritorno dell’istanza suprema, di uno che giudica «come Dio», può riportarlo all’ordine. Non sono inutili soltanto gli sforzi di Otto e di Ottocaro, ma anche quelli di Bancbanus. A ogni modo l’ordine, divino o quasi, viene ripristinato; e ciò significa, nel caso concreto, che le passioni sono state sconfitte, sottomesse, riutilizzate. Ed ecco la svolta improvvisa: in un rifacimento della leggenda di Ero e Leandro, Des Meeres und der Liebe Wellen, le passioni vengono sì sconfitte, ma da un ordine cattivo, dal prete conservatore di un dio bugiardo e di una fede basata sull’abolizione della scelta e sull’elogio della costrizione (con l’implicita critica morale e politica che si può immaginare). Quel che Ero cerca non è un nuovo ordine divino, anzi al prete che vi si richiama oppone l’invito a non volersi far forte di quel che non si sa, essendo gli dèi troppo lontani perché possiamo ricavare da loro i nostri diritti; e dunque dovere sia tutto ciò che un cuore sereno, d’accordo con sé e con il mondo, pone di fronte al diritto altrui. La svolta è importante, ma la tragedia non offre quasi nulla, tranne l’incontro fra Ero e Leandro nel secondo atto e una deliziosa scena d’amore alla fine del terzo. Laube deve essere stato un mago se riuscì a rivitalizzare questa tragedia, sia pure solo per Vienna. Grillparzer accettò il fiasco perché si rendeva conto dei difetti d’impianto. Comunque la svolta è importante; si vede che Grillparzer sta cercando qualcosa di nuovo, sia pure ancora confusamente. Non esistono indizi esterni che ci illuminino. Nel 1823 (dunque ben prima delle Wellen) Grillparzer aveva scritto, su richiesta del musicista, un libretto d’opera per Beethoven, che però nel 1827 morì senza averla musicata; il titolo era Melusina e rielaborava motivi di questa favola, un po’ all’opposto di quel che poi avverrà nelle Wellen; qui Ero non si cura della consacrazione che di lei è avvenuta come sacerdotessa casta, poiché scopre l’amore e quindi ridefinisce diritti e doveri come abbiamo visto, lì invece viene 208 punito un uomo che solo a metà vorrebbe stare al servizio amoroso di potenze superiori. La forma della fiaba drammatica viene ripresa nel Traum, con la spettacolarità propria a questo genere del Volksstück. La ricerca del nuovo si salda con la ripresa di una tradizione. Il riassunto della fabula potrà alle prime sorprendere il lettore; eccolo: il giovane Rustan è desideroso di avventure e le vive in sogno. Sono avventure legate a una colpa: una menzogna lo aiuta a far carriera ma per coprire la menzogna è costretto al delitto, che lo porta ad altri delitti, mentre intanto arriva al potere supremo. I suoi inganni e le sue colpe vengono però alla luce, Rustan perde il potere, viene inseguito e non perde la vita solo perché si sveglia, guarito dalla voglia di avventure. Non ci sarebbe niente di veramente nuovo (ancora un discorso sulla vanità del mondo e delle sue pompe) se non fosse per la forma; ma appunto questa assicura che i crimini siano quelli di una fiaba, cioè tanto spaventosi quanto innocui, e per di più in un grande spettacolo con enormi serpenti e apparizioni fatate. Stavolta la riconciliazione con l’ordine è data da un sorriso invece che da una forma di giudizio universale, come era stato fino al Diener incluso. Certo, la morale della favola ricalca l’aspetto più conservatore del teatro popolare o, visto da altra angolatura, la dimensione rinunciataria della cultura Biedermeier. Ci sarebbe, per la verità, un’altra possibilità di lettura, ma temo che essa rientri fra quelle attualizzanti di cui più in là dirò tutto il male possibile. Eccola: Il sogno di Rustan è il sogno di uno che in realtà non vuole avventure perché non è all’altezza di averne; quelle sognate, infatti, si basano tutte sulla falsità e sul tradimento. Rustan si rivela per quello che è: un vigliacco. Si immagini uno che voglia fare chissà quale sconquasso e poi si limiti a prendere una sbronza; o che pensi a chissà quali avventure cosmiche che poi si risolvono in un safari tutto compreso, restando opportunamente razzista perché con questi negri non si sa mai. Del resto Rustan al risveglio congeda lo schiavo negro la cui sola vista gli ricorda la voglia di avventure. Insomma: Rustan rinuncia ben volentieri a una vita attiva per un posto sicuro e una moglie con discreta dote, le uniche cose delle quali sia all’altezza. Questa potrebbe essere una possibilità di lettura, con la riserva di cui sopra; pur con tutti i benefici del dubbio, essa non è da scartare; anzi vedremo più in là quanto possa tornare utile. Comunque sia: è fuor di dubbio che Grillparzer sta cercando vie nuove, e precisamente quelle di una conciliazione non tragica. Il che viene confermato dall’ultimo lavoro pubblico, addirittura un Lustspiel: Weh dem, der lügt. L’intento di questa commedia, mostrare una sorridente possibilità di conciliazione dell’ordine umano, senza ricorrere a un sovvertimento generale tale che solo un dio possa riequilibrarlo, è fallito sia sul piano ideologico sia sul piano drammaturgico. Un vescovo accetta che il suo cuoco Leon tenti di liberare un ostaggio in mano a nemici (e che è nipote del vescovo stesso) a condizione che non dica mai bugie né faccia niente di moralmente condannabile. Leon accetta la condizione; però, come gli obietta Edrita, la ragazza che vorrà 209 fuggire con lui, non si mente solo con le parole ma anche con i fatti; e Leon è un bugiardo per i suoi fatti: con il suo modo di fare egli inganna i suoi nemici. Oppure lascia che sia Edrita stessa a farsi carico dell’inganno per disarmare uno degli inseguitori. Oppure ricorre a sofismi per non rapire Edrita, che comunque fugge con lui di sua volontà. Ne risulta, insomma, una specie di gesuitismo di cui Leon si rende ben conto e che non lo rende per niente contento. Sul piano drammaturgico, poi, la commedia si priva di quasi tutti gli strumenti tradizionali della commedia: niente giochi di parole, equivoci, travestimenti, scambi di persona ecc. ecc. perché offenderebbero tutti la verità. Restano pochissimi mezzi; il primo è il litigio diretto. E indubbiamente Grillparzer sa ricavarne profitto; i risultati maggiori si hanno nella prima scena del secondo atto, nel litigio che oppone Leon al re barbaro cui si è fatto vendere come schiavo (è una scena scintillante); e poi nell’ultimo atto, quando Leon litiga direttamente con Dio, pretendendone il miracolo che, per quel che gli pare, gli è stato promesso (e qui piacerebbe sapere a chi stava pensando Grillparzer; il motivo del litigio con Dio è medievale e ha un antecedente grandioso nel Parzival di Wolfram von Eschenbach). Un’altra via che l’autore percorre è quella di far nascere l’equivoco dall’eccesso di verità; quando Leon tenta di rubare la chiave che apre e chiude la porta della reggia-fortezza in cui è prigioniero e in ciò viene sorpreso dal re barbaro, una sostituzione della chiave in questione non viene creduta proprio perché Leon la fa notare. Non si può mettere in dubbio l’abilità di Grillparzer nel fare buon uso dei mezzi che gli restano; ma indubbiamente sono pochi. Privo dei suoi mezzi tradizionali, il linguaggio non sintetizza nulla ed è costretto a distendersi in lunga narrazione; quel che non fa il linguaggio, debbono farlo i personaggi: un linguaggio epico e non sintetizzante impedisce a Leon di impossessarsi della chiave che gli serve per fuggire, dunque deve intervenire Edrita come Deus ex machina. Oppure è Dio stesso a intervenire al momento opportuno con un miracolo (o almeno così pare a un primo momento), per mantenere quella che Leon credeva la promessa data attraverso un fulmine. Alla fine il vescovo che chiede il rendiconto della missione si aspetta che Leon abbia mentito; Leon deve ammettere che non è andato tutto schiettamente. Il vescovo aveva sostenuto all’inizio che solo la verità rende buoni e che verità è l’esistenza stessa. La teoria, per quanto solennemente sostenuta, si dimostra insufficiente. Il nipote liberato è un sempliciotto e il vescovo deve ammettere che non è riuscito come avrebbe dovuto; dopodiché, sempliciotto com’è e respinto dalla ragazza da cui si credeva amato, s’apre per lui la strada del convento e lo studio dell’unica verità assoluta, quella divina; il che suona comico, ma forse di un comico involontario. E poi ci sono i sentimenti, che come al solito non vogliono far quadrare i conti, col loro linguaggio tortuoso. E il vescovo deve constatare: Chi mi spiegherà questo mondo dai mille riflessi confusi? Dicono tutti la verità, ne sono fieri, e lei inganna se stessa e lui, lui inganna me e lei; quello mente perché gli hanno mentito e tutti dicono la verità, tutti. Tutti. 210 La mala pianta non si sradica, mi pare. È già tanta fortuna se sopra ci nasce un po’ di grano. […] Conosco una terra che è il trono di ogni verità, dove perfino la menzogna è solo un vestito variopinto che nel crearlo lui chiamò caducità e di cui avvolse la stirpe dei peccatori affinché gli occhi non accecassero alla luce. Questo è il tentativo di compromesso cui arriva Grillparzer. Il pubblico non l’accettò e, verrebbe voglia di aggiungere, Grillparzer neppure. Fatto sta che dopo il fiasco di questa commedia egli si ritira; aveva sopportato il nessun esito delle prime due parti del Vließ (cosa anche finanziariamente dolorosa), lo scarso successo dello Ottokar, le pochissime repliche del Diener, il fiasco delle Wellen. Si può dire che fu la goccia che fece traboccare il vaso? Possibile ma poco credibile, poiché in precedenza c’era stato il trionfo del Traum. La questione non è decidibile. Resta che all’analisi l’ultimo Grillparzer pubblico mostra la ricerca di vie nuove e che dopo la proposta di compromesso del Lustspiel si ritira. Nelle opere postume cercherà altre vie, senza né compromessi né giudizio divino. Excursus: Sulla saldezza della forma-rifugio. In Raimund e Nestroy abbiamo visto la forma fungere da veicolo di riconoscimento. Essa poteva svolgere le funzioni più conservatrici oppure accogliere la vita multicolore, fino a dare all’emarginato un posto di tutto rilievo. Poteva primariamente assicurare l’identità del suo pubblico, ma anche fare ampio spazio alla critica della realtà. Una tale forma non ha bisogno di cercare il compromesso perché è essa stessa un compromesso; anzi è di più, è ambiguità. È l’una e l’altra cosa delle alternative che le si pongono, perché le contiene entrambe e le mantiene sempre l’una accanto all’altra: l’interpretazione (sulla carta o sulla scena) avrà solo da pigiare più su un pedale o più sull’altro. Quindi tale forma è saldissima, resistentissima; può però capitarle di involgarirsi fino a incanaglirsi se questa è la sorte del suo pubblico: se questo viene emarginato tutt’intero e disacculturato. In Grillparzer la forma è altrettanto salda, ma quasi come prodotto altrui; le tantissime spinte del mondo moderno vengono ricondotte a tradizioni. Esse però ribollono con non minore violenza. Il compromesso compromette la forma, o sottraendole strumenti importanti, o facendola apparire tutt’intera come una citazione. Alla citazione è legato l’arbitrio (già semplicemente per la scelta che essa testimonia) e l’estraniamento (di essa dal suo contesto, dalla realtà nostra che a essa viene ricondotta). La citazione del barocco non può ripristinare il mondo del barocco, che era legato allo spettacolo dell’assoluto, a uno sdoppiamento di cultura. Quest’ultimo sopravviveva a Vienna, dove anzi si era composto in un’osmosi (e Grillparzer è un autore per Vienna, come insisteva Laube), ma lo spettacolo dell’assoluto era entrato in crisi. Ormai non si credeva più che, essendo nullità il mondo umano, l’assolutismo fosse giusto per tenerla faticosamente insieme e mimare umbratilmente il mondo divino. Il mondo scoppia a 211 ogni momento e le sue spinte vogliono farsi valere. In un primo momento il rifugio è stata la forma; in un secondo momento, quando la forma stessa rischia di entrare in crisi, è il ritiro a fare da rifugio. La forma è salva, le passioni sono sempre più ribollenti. Dopo il suo ritiro Grillparzer completò ancora tre Trauerspiele: Libussa, Ein Bruderzwist in Habsburg (Dissidio tra fratelli in casa Asburgo, completata nel 1848), Die Jüdin von Toledo (L’ebrea di Toledo, nel 1851, poi rielaborata) e lavorò a un quarto, che però restò frammento, Esther. Libussa prende spunto da leggende intorno alla fondazione di Praga per costruire un’allegoria della storia dell’umanità: essa comincia con una specie di peccato originale, passa al matriarcato, quindi alla codificazione del diritto, al patriarcato, alla vita urbana, alle istituzioni. Non è una visione idillica: il diritto va di pari passo con l’ingiustizia e la prevaricazione, il patriarcato e le sue istituzioni vanno di pari passo con uno stato che si insinua ovunque e non di rado risponde a interessi particolari, le istituzioni generano rivoluzioni e le parole di libertà e uguaglianza copriranno le passioni più basse. Tuttavia questa è la storia e questo è il progresso dell’umanità: l’unificazione di un popolo, «cieco quando agisce e ignavo quando pensa», è un passo necessario perché un giorno, invece di ripristinare l’impossibile paradiso perduto, l’utile, la scienza e il sentimento si precisino nei loro contorni reciproci e si installino nei cuori degli uomini: sarà questo il ritorno degli dèi sulla terra. Questo Trauerspiel è una confessione delle idee di Grillparzer, legata a una esile fabula dal ritmo troppo lento. Altra cosa è la Jüdin. Ancora una volta erompe il tema sul posto delle passioni nella vita del singolo e nella storia. In astratto se ne può affermare l’utilità e sostenere che una formazione completa deve passare anche attraverso le passioni. Così, appunto in astratto, afferma all’inizio il re stesso, che pure non ha finora mai conosciuto passioni, paragonando la saggezza a un albero che ha i rami ben in vista ma che attinge il suo nutrimento da radici che attingono dal torbidume, lontane dalla luce. E alla fine ribadirà sostanzialmente questa tesi, sia pure con qualche correzione suggerita dalla vicenda. Ma in concreto è successa una tragedia da cui nessuno esce innocente. La regina mostra la sua gelida virtù, più adatta a spingere altri nell’errore che a trattenerlo; il re si mostra un dilettante nelle passioni come nella politica; i grandi del regno mettono a repentaglio proprio l’autorità del regno col loro sentirsi garanti e veicoli della ragion di stato; Rahel, l’ebrea che pure si è innamorata sinceramente del re e che con la vita paga per tutti, è riuscita a dare alla sua passione la veste più frivola e più sospetta; suo padre vi ha visto solo una fonte di guadagno; sua sorella non ha avuto l’energia di frenarla. Il re, del tutto inesperto nell’amore, è lusingato dalla passione suscitata in Rahel e chiede buffamente a un dignitario d’istruirlo un po’. S’illude, il re, di poter fermare il gioco quando vuole; in realtà seguirà sempre passivamente le circostanze. Trascurerà colpe212 volmente gli affari del regno per seguire la sua passione; che non è amore, come Rahel ben si accorge. L’interpretazione che il re riesce a dare considera tutta la vicenda come non più che una malattia di crescenza, riducendo tutto al privato, all’episodico, all’egoistico, incurante dei lutti e degli sconquassi. E così la grande passione è ridotta a puro strumento di crescita, anzi a instrumentum regni. Magari Rahel merita un epitaffio migliore, però solo dopo che è stata ammazzata; allora si può anche riprendere il discorso barocco sulla nullità del mondo terreno, però intanto è morta lei. Ma non bisogna nemmeno disconoscere che contro la nullità dell’umano non viene posta l’assolutezza del divino bensì la schiettezza della natura: Rahel era, secondo il re, la verità stessa, anche se deformata, poiché tutto quel che faceva procedeva dalla sua natura, schietto, inatteso e senza precedenti. E anche il re paga: abdica a favore del figlio, di cui si considera solo il comandante in campo. Le passioni, dimostrando la loro forza, hanno anche dimostrato che la storia umana, nella quale hanno un così gran posto, non si lascia poi guidare così docilmente; né vi riescono meglio la virtù, la volontà, la ragion di stato e quant’altro viene di volta in volta invocato: viene relativizzato tutto. Lo scopo finale, al cui servizio si mette il re dopo aver abdicato, e cioè l’ordine del regno affidato più a un complesso di fattori che a singole mani, suona più come ipotesi che come certezza. Il padre di Rahel pronuncia una profezia che pare bensì riferirsi allo stadio più avanzato raggiunto allora dall’Europa, cioè al trionfo dell’interscambio finanziario, ma che sembra piuttosto essere la tesi della Jüdin; forse non la tesi principale, o almeno non con la forza di presentarsi come tale, e tuttavia l’unica che può tenere insieme le tante verità parziali che siamo venuti percorrendo: I soldi, amico mio, sono alla base di tutto. Se il nemico vi minaccia, vi comprate delle armi e il soldato serve per il soldo. Tu mangi e bevi soldi perché quel che mangi è comprato e comprare significa soldi e basta. Un giorno, amico mio, tutti saranno una cambiale con scadenza a breve. Così questo Trauerspiel, dalla vicenda lineare, riesce a toccare tanti temi. Sapientissimo nel trattamento scenico, in cui i gesti e gli oggetti assumono funzioni decisive ed esattamente prescritte, vigoroso nel linguaggio, è una testimonianza tra le più felici delle nuove ricerche di Grillparzer. Il più complesso e il più ambizioso dei Trauerspiele di Grillparzer è però il Bruderzwist. Ambientato allo scoppio della Guerra dei Trent’anni, esso è un interrogarsi sul rapporto fra verità e ordine profondo delle cose da una parte, giustificazione e agire umani dall’altra. C’è un’azione principale, già complessa di per sé, e una serie di vicende secondarie. Straordinaria è la sapienza scenica che 213 tiene insieme tutto questo: la bellezza del linguaggio, la densità dei gesti, la funzionalità degli oggetti scenici, il ritmo mai ferito. La tesi di fondo emerge con chiarezza e, ad abundantiam, viene anche illustrata (almeno in una sua parte) in due drammatici colloqui fra l’imperatore e il suo consigliere Julius nel terzo e nel quarto atto, cui si aggiungerà una tardiva resipiscenza dell’imperatore. L’ordine, sostiene a lungo l’imperatore, non è di questo mondo; l’ordine vero è eterno, è divino, e l’uomo può solo turbarlo con le sue azioni; il massimo che si può ottenere è un egualitarismo che è livellamento. Julius replica che la visione dell’imperatore può andare anche bene su un piano cosmico ma noi viviamo nel tempo, non nell’eternità; e il tempo richiede diritti precisi e concreti: persino il ribaldo vuol soltanto per sé star fuori del diritto, e vuole tutti gli altri legati dalla legge perché non gli si rubi ciò che ruba. Pensan lo stesso gli altri e ogni furfante è solo contro tutti; ma i più vincono e con loro trionfa anche il diritto. Se no, non ci sarebbe il mondo, e tutti, da un pezzo, i vincoli del ben comune avrebbe lacerati l’egoismo. [...] D’ordine ha gran bisogno questo mondo e gli basta vedere il suo contrario in cruda nudità per ritornare, rabbrividendo, sulla retta via. (2123-23, 2160-63) Ma non vincerà questa tesi; vincerà quella degli avversari, per i quali il diritto è forma e niente di più. Sono loro i rappresentanti del mondo moderno, loro a imporre la loro visione della storia, secondo la quale il mondo è retto da un saldo progetto e ogni passo ci porta più vicini alla meta. Chi partecipa però a un tale progetto non si nasconde che, mentre il tempo percorre i suoi «labirinti», quelle che si saziano sono le varie bramosie e avidità; e sono in chiaro che, mentre il formalismo vuol regolare tutto e pretende di riuscirci, le azioni umane sono sostanzialmente incontrollabili e tuttavia chi le compie ne è responsabile: THURN. È l’intenzione un cavaliere cauto sul focoso destriero che è l’azione. Egli lo sprona acché operi in fretta. Quando tocca la meta, lo rattiene, e crede che ciò basti. Ma la bestia, 214 trascinata dal nobile suo sangue, dal lancio della corsa e dalla forza, rompe ancora per prati e campi e grano finché il morso sconfigge la sua foga. E allora si ritorna. (2211-22) La violenza delle passioni, l’imperscrutabilità dei sentimenti e tuttavia la responsabilità per le azioni vengono trattate anche nella vicenda di don Cesare, figlio naturale dell’imperatore, cieco davanti ai sentimenti di Lucrezia, un’altra delle straordinarie figure femminili di Grillparzer, vissuta dal lettore più attraverso il riflesso di don Cesare che non direttamente. A tragedia finita, tutti hanno perso: il vecchio pensiero è stato sconfitto, col nuovo cominciano lutti dei quali non si vede l’esito. Grillparzer lavorò anche a un frammento, Esther, che disgraziatamente è rimasto frammento; quel che ne abbiamo e quel che sappiamo delle intenzioni ce ne fa avere un grande concetto; pur frammento, ha avuto una notevole fortuna sulle scene, addirittura in vita di Grillparzer, che permise la recita del primo atto per motivi di beneficenza. Esso è una ricerca di ulteriore novità, ma se ne ha veramente troppo poco per fare un discorso impegnativo. Excursus: Attualità, località. La critica ha fatto numerosi tentativi per attualizzare Grillparzer, spingendolo verso la psicanalisi, Ibsen e via dicendo. Per quanto giustificati possano essere tali tentativi, c’è anche da chiedersi se essi non nascondano un disagio davanti a un autore sentito al tempo stesso così lontano e così affascinante che per sostenerne l’urto e impedirne il distacco occorra ricondurlo a qualcosa di più familiare e quindi ad altro. Il punto più scottante è che Grillparzer fu lui stesso un attualizzatore, col suo citare tutto il possibile passato; voler attualizzare un attualizzatore sembra piuttosto uno scherzo. Chiediamoci piuttosto il perché di quel suo citare. Forse c’è utile un confronto con chi in epoca vicinissima a noi ha fatto in altra arte un’operazione analoga: Paul Hindemith. In quello che a torto o a ragione appare un disfacimento generale (delle forma a Hindemith, della sostanza etica a Grillparzer), viene posto l’atto decisionale (e fortemente soggettivo, ma certamente non giustificato soggettivisticamente) di attenersi alla storicità (il che è un ossimoro) ma svuotandola dei suoi contenuti e riempiendola di nuovi e contrari (il che la paralizza). In Grillparzer s’è visto come ciò avviene: le forme classiche non ospitano più eroi classici; nessuno di loro, infatti, comanda alle circostanze ma è un prodotto delle circostanze (valga per tutti l’esempio del re nella Jüdin); oppure c’è l’ideologia barocca mentre invece il dramma è borghese. Dunque l’autore decide di ereditare una salda forma, tramandata dalla storia, secolarizzandola se occorre (v. le forme medievali in Ottokar, v. anche il rifacimento del mito di Adamo ed Eva in Libussa: nel primo caso una secolarizzazione di forme, nel secondo una di contenuti), contestandone, se del caso, i contenuti o comunque sostituendoli (v. il dram215 ma borghese di Sappho), ma senza mai ferire la forma come forma (il tipo di divisione in atti, il rapporto fra azione principale e azione secondaria e via dicendo). Anzi, come abbiamo visto, Grillparzer non cita semplicemente una forma ma tutte le forme storiche legate a un determinato luogo, cioè a Vienna. Sono forme storiche, localizzate e citate; mentre le prime due caratteristiche ne indicano l’oggettività, l’ultima le mette in relazione con la decisione soggettiva. Questo procedimento attualizzante può lasciare sconcertati. Facilmente esso suggerisce una soluzione estrema: può invitare a perpetuarlo oppure ad allontanarlo recisamente da noi. A Grillparzer sembra comunque assicurata la categoria del disagio, senza che ciò sia disconoscimento delle sue qualità. Grillparzer fu anche produttore copioso di lirica, di cui diede egli stesso la migliore valutazione: gli serviva come mezzo per capirsi. E scrisse due racconti, fra le cose più alte della novellistica ottocentesca: Das Kloster bei Sendomir (Il convento di Sendomir, 1827) e Der arme Spielmann (Il suonatore povero, 1847). Il primo ci interessa per due ragioni: Grillparzer ci mostra come si può scrivere un grande racconto con i mezzi della Trivialliteratur (è infatti una storia di amori, misteri, tradimenti, vendette, ammazzamenti, incendi, rimorsi ed espiazioni); e inoltre contiene uno dei suoi straordinari ritratti di donna, una Elga accostabile alla Erny del Diener e alla futura Lucrezia del Bruderzwist, coi suoi sentimenti imperscrutabili, la sua gioia di vivere, la sua capacità di affetti e il suo cinismo. L’altro racconto è una metafora dell’arte, del suo ambiguo posto nel mondo, della sua sostanziale incomunicabilità. Entrambi sono racconti a cornice; peraltro dalla tecnica molto diversa: nel primo è lo stesso autore di un omicidio per gelosia a narrare la vicenda, ma la sua identità verrà scoperta solo alla fine; nel secondo c’è già nella cornice un io narrante che reca tratti ricavati dalla biografia dello stesso Grillparzer. Il suonatore di cui si parla nel racconto interno mostra di essere un inetto nella vita e facile zimbello di tutti. Dal suo violino, con cui si guadagna la vita mendicando, ricava una serie di suoni senza nesso, senza ritmo e senza melodia; per di più suona in luoghi e in ore che sono sempre periferici rispetto a quelli in cui potrebbe fare qualche soldo in più. Nel labirinto sonoro che produce si capisce solo che ama le consonanze e che fugge le dissonanze. Il suo esercizio più alto, quello che dedica a Dio, anzi quello che secondo lui è un cantare Dio stesso, consiste di suoni puri: una nota sola dal piano al forte per poi spegnersi e ricominciare; segue un intervallo e poi un altro, sempre con la stessa logica: trovare la più grande gioia nei suoni in sé. Questa meditazione sulla pura arte è incomunicabile al pubblico e semmai solo un altro artista può ripeterla per sé. È godimento dell’arte pura, antecedente e indifferente ai contenuti nei quali può depositarsi. È anche un’arte perennemente destinata a essere sconfitta dalla vita. 216 III, 2. Popolare II e congedo III, 2, 1. L’antropologia non è un valore; questa è la prima metà di un motto sotto il quale potrebbe essere compresa la produzione letteraria di Jeremias Gotthelf (che in realtà si chiamava Albert Bitzius - 1797-1854 -; vedremo presto come nacque lo pseudonimo); quella prima metà viene correttamente intesa se mantenuta strettamente legata alla seconda, e cioè: ma guai a chi la ignora. Ciò ci permette un nuovo accesso al concetto di popolare, già trattato con l’occasione di altri autori. Gotthelf esordì nel 1837, a quarant’anni, con un romanzo dal titolo Der Bauernspiegel oder Lebensgeschichte des Jeremias Gotthelf von ihm selbst geschrieben (Lo specchio del villano ovvero Biografia di Jeremias Gotthelf scritta da lui stesso). Il romanzo ebbe successo e lo scrittore adottò da quel momento lo pseudonimo lì introdotto; il prenome rinvia al profeta Geremia e alle sue lamentazioni, il cognome “Diomiaiuti” indica in che direzione va cercata la speranza. Questa finta autobiografia contiene il programma futuro dello scrittore e quindi prenderla a filo conduttore facilita la presentazione. Già l’analisi del titolo ci mette in possesso di numerose informazioni. Questo libro vuole essere uno specchio; il perché e il percome viene spiegato nel libro stesso. Lo «specchio» ha un intento pedagogico, su questo non viene lasciato alcun dubbio; ecco infatti il consiglio che a un certo punto viene dato al narratore-protagonista: quando i bambini sono a scuola e la sera è ancora lontana, allora sedetevi e scrivete la vostra vita! Poiché essa, così come voi la raccontate, mette in luce una quantità di pregiudizi, illustra alla gente tanti peccati che non erano mai stati considerati tali, dato che nessuno dà mai ascolto al pastore. La vostra vita di certo aprirà gli occhi a più d’una persona, che dirà: “Già, anche a me è andata proprio così, ma dovrà cambiare”. E ciò lo dirà molta più gente di quanto voi pensiate, perché gli uomini e la loro vita sono tra di loro molto più simili di quanto si potrebbe credere alla prima impressione, ciò che vi è capitato è successo in centinaia di posti. Per cui succederà che in centinaia di posti la gente penserà che voi stiate ritraendo loro e parlando di loro; poi si ricorderanno di Jeremias Gotthelf. All’interno del libro stesso viene identificato il pubblico, costituito da quel tipo di svizzeri che compaiono nel romanzo: questo libro [...,] lo sto scrivendo proprio affinché la gente possa leggerlo, visto 217 che deve fungere da specchio per molti. La mia intenzione è di scrivere ciò che mi accade qui da noi, nella nostra patria, in modo che chi legge possa imparare qualcosa. La prefazione alla prima edizione diceva però qualcosa di più e di diverso: «Il mio specchio vi mostra il lato in ombra della vostra vita, non quello alla luce del sole; mostra dunque ciò che abitualmente non si vede, non si vuole vedere». Si tenga presente che il concetto di specchio era una metafora corrente in epoca barocca, corrente sia in area cattolica sia in area protestante. Abbiamo qui un primo riferimento al barocco, e altri seguiranno. Gotthelf voleva essere uno scrittore popolare, con una sua missione morale e pedagogica; ebbene anche il calvinista Gotthelf, parroco di mestiere, trovava in modelli barocchi il primo impulso al suo cammino. Più specificamente, il suo voleva essere uno specchio per i contadini; nel suo romanzo essi compaiono in quantità, tuttavia non dominano da soli la scena; ci sono anche artigiani, cittadini e burocrati, però indubbiamente i contadini sono la parte privilegiata. Ciò poteva avere una giustificazione sociologica, ma di certo questo non era il solo motivo: c’era una ragione culturale. I contadini vengono rappresentati come la base più solida e più costante della società, dunque quella alla quale bisogna rivolgersi. Tra loro e gli artigiani c’è ben poca comunicazione, tanto forte è il pregiudizio degli uni nei confronti degli altri: Non pensavo affatto ad imparare un mestiere; credo che se mi fosse stato proposto avrei pensato che volessero compromettere il mio onore. Ero abituato a considerare gli artigiani una classe minore, vedevo come un qualsiasi servo di contadini guardava l’artigiano dall’alto in basso, si credeva migliore e gli dava ordini. Non avevo mai visto un figlio di contadini imparare un mestiere, neanche se dovevano vivere in sette in una fattoria arida, piuttosto si faceva sfruttare come vassallo da contadini insaziabili. Vedevo che ogni artigiano, appena aveva un po’ di soldi, si comprava della terra, aspirava a diventare contadino e attaccava ad un chiodo il suo mestiere. Vedevo una quantità di artigiani falliti, calzolai che non potevano neanche comprare sei corone di pelle, sarti al ricovero o alla comunità, maniscalchi in cattive compagnie, fabbri in masse di ladri, falegnami senza lavoro, muratori nell’inoperosità, carrai che erano il terrore di tutti i contadini che avevano un bel territorio o un manzo già bello grasso, fornai senza farina ma col naso rosso, tessitori con lo sguardo affamato e il respiro corto; questo vedevo, ed è per questo che mi sarei vergognato ad iniziare un mestiere; il fatto che la colpa di tutto ciò non si trovasse nel mestiere bensì da tutt’altra parte andava al di sopra della mia comprensione. Dei burocrati diremo oltre. Il mondo contadino non è certo un idillio, come si intuisce già dalle parole appena riportate. Diciamo pure che Gotthelf ne rappresenta tutti i lati e che quelli negativi prendono quasi tutto lo spazio per sé. Ma erano i contadini a contare e a loro bisognava rivolgersi. Il romanzo ha for218 ma di autobiografia; nel romanzo barocco c’è il celebre precedente del Simplicissimus di Grimmelshausen, dal finale così dichiaratamente religioso; in epoca successiva l’autobiografia (autentica, stavolta, non più fittizia) fu l’unica forma di scrittura profana ammessa dal pietismo. Dato l’intento religioso e civile proprio di Gotthelf, questi sembrano i predecessori più pertinenti; dunque il modello barocco è richiamato ancora una volta, peraltro presumibilmente rafforzato da esperienze di altra provenienza. I contadini non erano solo la classe numericamente e culturalmente più rilevante; nella prefazione alla seconda edizione (1839), Gotthelf sottolinea che i contadini, ricchi e poveri, buoni e cattivi, costituiscono tutti insieme un ceto unico, mentre i ceti signorili sono troppo differenziati fra di loro; è per questo che nel suo libro sono i contadini a costituire la sostanza, mentre degli altri ceti compaiono solo singole figure e solo su questo sfondo. Il perché di queste comparse era stato spiegato fin dalla prefazione alla prima edizione: esse gettano riflessi scuri su quello specchio già scuro. Vedremo che queste ombre assumeranno carattere concreto e documentato. Quel che Gotthelf non dice esplicitamente ma lascia tuttavia intuire è che i contadini erano anche i destinatari necessari di una missione, poiché in loro si mescolava cristianesimo e superstizione; e dunque il primo andava depurato dalla seconda. Su tale mescolanza Gotthelf non lascia dubbi: In vero nella nostra famiglia era come in cento altre, si credeva a molto, ma c’erano due cose che non si facevano: non si indagava seriamente da dove provenisse ciò in cui si credeva, se avesse le sue fondamenta nella Bibbia o se nascesse così, senza sapere da dove, come le tarme nella lana. Anche l’idea di predicare il vangelo ai contadini per distoglierli dai residui di paganesimo risaliva all’età barocca; ricordiamo però che in Gotthelf non è meno forte l’idea di una missione civile. Qui però il nostro romanzo conclude con una certa ambiguità: il protagonista-biografo muore (poiché in un’autobiografia la morte non si racconta, è un indizio a suggerircela) quando sta per assumere la carica di segretario comunale, dunque quando sta per diventare (lo dice lui stesso) la persona più importante del villaggio, passando nelle fila di quella burocrazia di cui si è parlato malissimo in tutto il romanzo ma cui pure ha tentato di accedere, avendo disimparato il mestiere del contadino, avendo un gruzzolo e avendo capito da che parte va il mondo. È un finale complesso, su cui sarà necessario tornare; intanto qui notiamo che per una parte (dunque non in tutto) esso ha affinità con quello del Simplicissimus: anche lì uno scomparire dal mondo (per volontario ritiro, non per morte) nel quadro di una considerazione globale del mondo stesso (che c’è anche in Gotthelf, ma che è fatta di una serie di proposte, non di un rifiuto). Il linguaggio usato, qui come nelle opere successive, fa ampio posto al dialetto bernese. In alcune opere non si va oltre l’uso di singoli vocaboli, ma altrove 219 si tratta di pagine e pagine; e non sempre è solo per riportare fedelmente un qualche discorso, cioè per caratterizzare realisticamente un personaggio. Su questa scelta avranno certamente agito spinte diverse; tra l’altro, la scelta del destinatario. Gotthelf voleva essere letto dal popolo, nella lingua da questo parlata. D’altra parte il tipo di linguaggio usato identificava il lettore e lo delimitava. Quanto ci fosse di realistico e quanto di utopistico è un altro discorso; Gotthelf stesso parla ampiamente (in questo come in altri romanzi) di interi strati della popolazione che sanno a malapena compitare e ai quali comunque occorrerebbe far leggere in primo luogo la Bibbia. Ma questo è il dilemma costante degli scrittori che si vogliono popolari: vogliono farsi leggere da coloro che non possono leggerli, per dir loro cose diverse da quelle che hanno sempre accettato e di cui non sono affatto sicuri che le accetteranno. D’altra parte Gotthelf ha avuto un grande successo ma i suoi lettori effettivi li ha trovati nella borghesia bernese, che fra l’altro aveva i soldi per permettersi quei costosi volumi; nessun personaggio di Gotthelf legge un romanzo di Gotthelf. Le qualità del suo linguaggio hanno comunque contribuito a farne un classico; alla costituzione di quel linguaggio non possono essere considerati estranei degli intenti missionari, ma nemmeno va dimenticato che il barocco fu un’epoca di grande sperimentazione linguistica e che Gotthelf può averne ricevuto un sia pur lontano impulso. Infine: il Bauernspiegel presenta una grande galleria di tipi umani, che in epoca barocca si sarebbe chiamata il grande spettacolo del mondo; e che, forse non con tanta evidenza in questo romanzo ma con estrema evidenza altrove (per esempio nel più noto dei racconti di Gotthelf, Die schwarze Spinne - Il ragno nero -, 1842), sono direttamente a contrasto le potenze estreme: Dio e il diavolo, giustizia e ingiustizia, amore del prossimo e perversione morale. Però - e questo è un punto di decisiva divergenza rispetto a quei lontani modelli - non c’è traccia di allegoria. Gotthelf è uno scrittore realista, e da questo punto di vista non stringe compromessi. L’eredità barocca gli ha dato indubbiamente dei modelli di riferimento, ma Gotthelf è uomo del suo tempo, che tratta problemi del suo tempo; non ha in mente un ordine eterno ma il cambiare della realtà economica e politica: il suo eroe partecipa alla rivoluzione parigina del luglio 1830, però dalla parte sbagliata, da quella di Carlo X di cui è al servizio come mercenario svizzero; alla fine del romanzo compare una macchina per tessere, poiché si sta diffondendo la filatura a domicilio; la burocrazia sta assumendo un’importanza mai vista prima; cambiano le tecniche di costruzione e perfino le coltivazioni e Gotthelf non inventa un qualche idillio per opporsi al progresso: Tutto il paesaggio mi sembrava trasformato. Dappertutto spuntavano case nuove tra alberi ben piantati, non più pieni di muschio di vischio. Vetrate grandi, finestre pulite dimostravano uomini più puliti, tetti blu d’ardesia erano testimoni di uomini previdenti e intelligenti. [...] ora tutto brillava in un bagliore rossastro e ondeggiava nel vento come un campo di grano. 220 Anzi l’idillio Gotthelf non se lo propone proprio mai. La prima metà del romanzo ci porta attraverso una serie di esperienze che tutte insieme somigliano piuttosto a un inferno. C’è un rispetto scrupoloso delle usanze in ogni manifestazione della vita: il battesimo, il matrimonio, l’abbigliamento, l’uso delle varie parti in cui è divisa la casa contadina, il posto che ognuno vi ha per abitarvi e lavorarvi, il corteggiamento, la frequentazione dell’osteria e della chiesa, l’ospitalità, i cibi, insomma tutto quel che può trovar posto in una ricerca antropologica è rintracciabile negli scritti di Gotthelf; gli studi comparativi che sono stati condotti hanno dimostrato la competenza dello scrittore. Ma in questo mondo, in cui nessuna usanza è corrotta o decaduta e incompresa, dominano sovrani la truffa e l’imbroglio. Il padre truffa i figli, la nuora truffa i suoceri, i fratelli si truffano fra di loro. Per non parlare degli estranei. Le istituzioni benefiche a vantaggio dei poveri sono un mezzo di oppressione quanto al loro funzionamento concreto, uno strumento ben accetto all’ipocrisia e, per non smentire la costanza di questa virtù, una truffa quanto al rendiconto finale. Tutto questo non è né accidentale né opposto al sistema antropologico descritto, il cui fine non è di assicurare e promuovere l’amore reciproco ma regolare i rapporti infraumani, basati sulla ricchezza e sul potere. Valga come esempio una storia di eredità narrata all’inizio del romanzo. Due genitori vendono la fattoria al figlio minore Sami; la vendita avviene in segreto «poiché volevano usare a vantaggio di Sami gli altri fratelli come garzoni senza pagarli». Che la fattoria andasse al figlio minore era nell’uso; ma in questo caso essa è stata venduta per la metà del suo valore, e questo appare agli altri fratelli una truffa sull’eredità futura. Ed ecco la spiegazione: Il nonno era davvero un uomo così cattivo da truffare in modo così vergognoso i suoi altri sette figli? O no, egli era soltanto come cento altri contadini! In vita sua non aveva pensato e mirato ad altro che a mettere insieme un grosso gruzzolo; i suoi figli li vedeva come formiche, che dovevano abbarbicarsi sempre più a questo grande gruzzolo. Che questo gruzzolo così messo insieme restasse unito anche dopo la sua morte, era il suo pensiero più caro; non pensava affatto che così facendo gli altri suoi sette figli sarebbero diventati mendicanti, o forse pensava che sarebbe stata la cosa migliore se nessuno degli altri si fosse sposato e fossero tutti rimasti i servi non pagati del loro fratello. L’uomo è portato a questa mancanza di cuore senza limiti e a questa durezza innaturale, quando nella vita e nella morte idolatra il denaro e i beni materiali. Tuttavia il nonno sembra aver visto giusto poiché alla lunga i fratelli di Sami (eccetto il padre del narratore) non si sposano, restano suoi servi e lui eredita tutto; e questo era appunto nell’uso, un uso adatto a conservare una determinata struttura economica e di potere. Sistema antropologico intatto e ribollire di odî si compenetrano in questo 221 romanzo come non sempre in Gotthelf. Altrove egli ha preferito presentarli separatamente, per esempio nella già ricordata Spinne: all’inizio, come cornice, c’è un battesimo, descritto con una precisione tale che un antropologo non saprebbe far meglio e che nel lettore ingenuo può suscitare l’impressione di un idillio; nel racconto interno c’è poi lo scatenarsi dell’empietà. Quanto poi sistema antropologico e sistema economico siano compenetrati, Gotthelf lo mostra esemplarmente in un altro dei suoi racconti più noti: Elsi, die seltsame Magd (Elsi, la strana domestica, 1843): Elsi, strana perché non accetta forme lecite e anzi ambite di corteggiamento, tutte fatte seguendo scrupolosamente le usanze, suscita sospetti; la spiegazione del suo rifiuto si ha nella vergogna che lei prova per essere figlia di un fallito: il passaggio di ceto provoca infatti una ricollocazione nel sistema antropologico. Questo è anche il destino che tocca al protagonista del Bauernspiegel. Come sul sistema economico, così Gotthelf porta la sua indagine sul sistema di potere. Poiché il romanzo ha forma autobiografica, alla forma più astratta di potere si arriva a romanzo inoltrato. A metà di esso il narratore-protagonista in un rendiconto tragicomico dà la colpa dei suoi guai prima al contadino che l’ha truffato sul salario, quindi alla comunità che l’ha truffato in altro modo, infine al governo che tollera tutto ciò. Situazione a parte, Gotthelf sta molto attento alla struttura di potere; non ignora davvero che tutta la ritualità da lui descritta ha senso perché in definitiva soddisfa degli interessi e gli interessi a loro volta fanno riconoscere una gerarchia. La gerarchia familiare è la prima a essere indagata: il padre comanda perché è contemporaneamente padrone di un podere; nelle situazioni in cui non lo è, la sua zona di comando è più o meno inesistente. Il comando si estende a tutti coloro che lavorano alle sua dipendenze, dai figli in là; non semplicemente a ognuno è assegnato un lavoro, ma a ognuno è concesso l’accesso a specifiche parti della casa e connessi (una cosa, quest’ultima, che forse si vede meglio in Wie Uli der Knecht glücklich wird - Come il servo Uli diventa felice -, 1841, meglio noto col titolo della sua seconda versione Uli der Knecht, 1846). Nelle opere successive al Bauernspiegel questa funzione di comando riceve anche attributi morali che nella prima opera, in cui si vede tutto in negativo, essa non aveva ancora; così nella Spinne: I contadini rimasero soli nella vecchia casa, a viverci come a loro pareva, e quando Cristiano manifestò il proposito di tenerli un poco sotto il suo controllo, le donne non glielo permisero e lo rimproverarono aspramente, la madre per superbia, e la moglie per gelosia. Là dentro non v’era perciò nessun ordine, e ben presto non vi fu nemmeno più timor di Dio; già si sa che dove non c’è un capo, tutto va a rotoli. Se non c’è un capo che tanga le redini in casa e fuori, ben presto avviene che quello che fa le birbonate più grosse si ritenga il padrone, e chi le dice più grosse si ritenga il migliore. Ma su tale funzione c’è da segnalare un racconto terribile, Der Sonntag des 222 Großvaters (La domenica del nonno). A prima lettura pare un racconto agiografico: un vegliardo muore circondato dal suo parentado, dopo aver provveduto al bene di tutti anche al di là della propria vita. Se lo si legge attentamente, le cose appaiono ben diverse: per tutta la vita ha schiacciato con la propria autorità il figlio, rendendolo insicuro e infine inetto, privato di ogni margine di autonomia. È stato anche lui a trovargli una moglie che perpetuasse questo stato di soggezione; ora, in punto di morte, stringe con la nuora un patto affinché quello stato continui e, non fidandosi del tutto, raddoppia quella tutela con un’altra ancora, coinvolgendo nel patto un altro parente. Solo adesso, soddisfatto, questo patriarca kafkiano può morire in pace. Dal sistema antropologico-economico-sociologico del Bauernspiegel non c’è possibilità di uscita né in esso c’è possibilità di miglioramento; sempre, invece, di peggioramento. Lì esso viene vissuto in primo luogo come sistema di oppressione. In seguito Gotthelf manterrà un’implicita promessa, contenuta già nella prefazione alla prima edizione: avrebbe cioè descritto anche il lato esposto al sole; allora sarà possibile la scalata di Uli der Knecht, perché a guidarlo ci sarà un padrone buono, giusto e generoso. Di persone del genere, nel Bauernspiegel non se ne vedono; quando se ne affaccia timidamente uno, allora ci pensano i servi a imbrogliarlo e a renderlo innocuo, così che non possa far del bene a nessuno. Questo mondo è dunque immobile e se si muove è solo in peggio. Una maturazione tale da prenderlo sul serio, rispettarlo e tuttavia tentare di cambiarlo è possibile solo imparando a vederlo anche dal difuori dopo averlo conosciuto dall’interno; e cioè, in un primo momento, fuggendone. Ci sarà l’impatto con la città, che sulle prime semplicemente frastorna il protagonista; poi, arruolatosi come mercenario, ci sarà l’esperienza di Parigi e della rivoluzione del 1830. Tornando a casa potrà portare una maturità completa, con nel suo piccolo un sapere teorico, un sapere morale e un sapere economico: Non ero più quel ragazzo ignorante e rozzo che non sapeva neanche come si chiamasse il paese in cui abitava, che non sapeva né scrivere né pronunciare il proprio nome, né quanto facesse sette per sette. Ero consapevole di essere superiore alla maggior parte di quelli che stavano nel mio comune, e di sapere più di tutti i maestri di scuola che mi avevano insegnato. [...] ero diventato un uomo sicuro e consapevole di sé [... e avevo] la convinzione che si doveva studiare anche se ancora non si sapeva per che cosa, ma anche una seconda, cioè che bisognava risparmiare anche senza sapere per che cosa, per chi. A questo punto il romanzo è entrato nella sua seconda parte, quella politica. La prima cosa che viene messa a fuoco è lo strapotere della burocrazia: Più tardi ebbi modo di osservare tutto ciò ancora meglio, vidi impiegati comunali, per esempio segretari, impressionare interi comuni col loro fare sfrontato e 223 altezzoso, far ammutolire chiunque. [...] vidi che di fronte a questa sfrontatezza esibita tutti tremavano, nessuno poteva aprir bocca per dire quali fossero i diritti e quali i doveri, a cosa servisse la legge. Dopo la nostra nuova costituzione, non mi sarei mai aspettato che i funzionari del governo trattassero la gente a loro capriccio, sarebbe ben triste se anche le leggi le applicassero in questo modo, cioè secondo i capricci, i favori e la comodità. [...] La personalità dei governanti contribuisce almeno per i due terzi alla felicità o all’infelicità di un paese, la costituzione invece per un terzo. Ma questo è nulla: saldata ai pregiudizi e alla ferrea struttura antropologica prima descritta, la nuova dimensione politico-burocratica è più esiziale di quel che erano i feudatari, cui in una scena grottesca vengono paragonati gli «scribacchini»; e in generale «ciò che avviene in campagna è ancora più terribile di ciò che avviene nelle città e anzi in campagna bisogna ingoiare molto di più.» Il protagonista si candida successivamente a un posto di maestro di scuola, di ispettore stradale e infine di poliziotto e sempre viene respinto; questo vogliono i pregiudizi, ma questo vuole anche la tutela degli interessi con i quali egli si scontra. La società sta cambiando, i ceti si stanno differenziando: Con terrore vedo sempre più nel popolo crearsi una spaccatura. Dalla popolazione si distinguono funzionari, uomini d’affari etc., cioè la parte più sveglia del popolo, e questi cominciano a lasciare la locanda, a ritrovarsi insieme nei clubs, nei circoli di lettura o come si chiamano tutte queste cose, e si separano dalla massa; nell’osteria ci restano i più ignoranti, dove nessuno può offrire agli altri qualcosa di buono. Non si dà importanza a questa cosa e si giudica assolutamente naturale, il fatto che certe persone istruite non sopportino più tutte le noie di un’osteria e preferiscano godersi il meglio tra di loro. Ma ci si sbaglia; così come all’osteria, fanno anche nella vita, nell’abbigliamento etc., gradatamente in tutte le cose si separano dal popolo, addirittura tolgono i bambini d’in mezzo al popolo e li conducono per strade speciali. In questo modo si forma una nuova classe e chi vorrà darmi torto, se chiamo questa classe una aristocrazia. Attraverso il suo isolamento questa classe perde tanto più la fiducia del popolo, quanto più vicino gli era stata prima. Il popolo però, privo della sua compagnia, non viene più da quest’ultima elevato e nobilitato, bensì viene respinto e sottomesso, si inselvatichisce e diventa la vittima di ogni fanatico che voglia agitarlo per un qualsiasi scopo malvagio. Quello che resta popolo, diventa estraneo al resto del mondo, si rinchiude sempre più nei propri pregiudizi e diventa più o meno inaccessibile. Ma se se ne vuole ottenere qualcosa occorre tener conto della sua cultura così come essa è. La maggior parte di coloro che vogliono rendere felici i popoli naufragano proprio nel fatto che o non conoscono i pregiudizi del popolo oppure non vi pre- 224 stano attenzione e li osteggiano senza un minimo di riguardo, vi si siedono sopra sconsideratamente. Ciò a poco a poco irrita il popolo, che vorrà tenersi sempre più stretto ciò che gli si vuole prendere Il protagonista stesso commette errori del genere, quando cerca di convincere contadini particolarmente conservatori che non è contro la religione imparare un po’ di geometria, di storia e di scienze naturali. Questo popolo residuale è non meno intollerante e superstizioso di quello di prima; anzi, dati i tempi mutati, odia la democrazia, che è estranea alla sua cultura, e ha una vera e propria idolatria per il principio di autorità. Il protagonista cerca di dire che in una società moderna c’è bisogno di molti saperi e che questi non mettono necessariamente in pericolo la religione; del resto (cerca di ricordare a tutti) nei tempi passati era molto peggio. A questo punto l’autore mette in bocca a uno degli astanti, «uno che di solito non parlava molto», una straordinaria risposta, che vale la pena leggere per intero: Quando alla fine, ormai senza respiro, presi un sorso dal mio bicchiere, un giovane, che in genere non parlava molto, iniziò lentamente a rispondermi come segue: che non stava a noi chiederci se gli antichi avessero avuto una religione o se fossero stati invece dissoluti, “loro non facevano parte di noi, non si facevano passare per nostri modelli. Loro erano i nostri signori ed era nel loro interesse restare i nostri signori il più a lungo possibile. Questo interesse può anche essere stato la loro unica vera religione, tuttavia ci insegnava a mantenere la convinzione che l’autorità di Dio fosse assoluta, ci insegnava a educarci come cristiani tolleranti, se non per amore della religione, almeno per amore dell’ubbidienza. Ora però sono tutti uguali, il presidente del consiglio cantonale non vale più dello spazzacamino quindi ognuno può mettersi con un altro, ognuno può pensare: ‘ciò che a lui è permesso, a me non è certo vietato’; quanto più uno si trova in alto, tanto più può servire da esempio, e se il suo esempio è cattivo riuscirà a corrompere ancora più gente. Oggi non abbiamo più signori, la patria è diventata un patrimonio comune del quale ad alcuni è semplicemente affidata l’amministrazione. Nei miei affari però, non affiderò i miei averi a persone senza religione, dissolute e in balia dei loro desideri; non mi danno alcuna sicurezza, per quanto possano parlare bene; guarderanno sempre prima a loro stessi e neanche diventare dei ladri è per loro un problema di coscienza, se appena appena gli fa comodo. E allora devo affidare la patria a gente simile, persone che non potrebbero mai diventare censori in un paese rispettato dove ancora non si abbia l’abitudine di affidare la pecora al lupo? Non mi interessa ciò che hanno fatto gli antichi, ma mi interessa ciò che fanno questi qua, mi interessa sapere se hanno o no una religione; perché se non ne hanno, prenderanno anche la mia e la seppelliranno.” Nonostante le sue molte sconfitte, il protagonista non desiste. Il romanzo si chiude nel modo ambiguo che si è detto, peraltro con la chiara consapevolezza 225 che per poter agire bisogna far parte della nuova struttura del potere. Al quale vengono assegnati dei compiti precisi, all’interno della concezione calvinista dei rapporti fra stato, chiesa e società, ma che contengono rilievi importanti anche al difuori di quella concezione; si tratta infatti di una diagnosi di come sorge lo stato totalitario con il consenso delle masse; se si pensa all’anno in cui queste parole furono scritte se ne apprezzerà il valore profetico, oltre all’esattezza di fondo: In ogni comunità c’è chi veglia sul mantenimento dell’ordine e su un continuo e costante riformarsi che non renda mai necessaria la rivoluzione; perché la rivoluzione nasce solo laddove si dimentica la riforma. Nel nostro paese è l’autorità civile e laica, appartenente anch’essa alla chiesa, a dover svolgere questo compito e a dover vegliare sul bene della chiesa, così come veglia sul bene dello stato. Se però l’autorità non fa tutto questo e permette che chiunque faccia ciò che vuole contro la chiesa vigente, beninteso non contro lo stato, oppure mantiene nell’ordine e nella disciplina solo coloro che sono a favore della chiesa, mentre lascia mano libera, a seconda del capriccio, a quelli che, pubblicamente o in segreto, sono contro la chiesa, in questo caso accadono tre cose: 1. L’autorità assume la parvenza di staccarsi dalla chiesa (non si sta parlando di fede) o perlomeno di desiderare il suo scioglimento. 2. Il popolo, non vedendo nell’una parte né forza né volontà, inizia ad avere rispetto per coloro che con volontà di ferro e forza bruta divulgano e proteggono ciò che ritengono giusto e si autogovernano a modo loro, a modo loro mantengono ordine e disciplina al loro interno. Dal rispetto all’approvazione il passo è breve. 3. Coloro che restano fedeli alla chiesa, i quali ogni giorno devono sentirsi imprecare contro impunemente, non trovando la protezione necessaria, sono spinti alla brutta idea di farsi giustizia da soli, di prendere nuovamente possesso dei diritti e dei doveri non più controllati dall’autorità e di mantenere l’ordine e la disciplina a proprio modo. [...] Sta davvero male uno stato in cui tutti gli interessi devono essere tutelati da una legge, ma ancora peggiore è quello stato in cui colui che ha sentito solo da lontano l’odore del potere crede di riunire in se stesso tutta l’intelligenza possibile e, pubblicamente o tra i denti, diffida e disconosce tutta l’onestà prima a ogni altro ceto tranne il suo, poi a ogni appartenente al suo stesso ceto tranne se stesso. Ho fatto ampio uso di citazioni per richiamare l’attenzione su questo trascurato, bel romanzo. Nei romanzi successivi Gotthelf sviluppò quanto qui aveva programmato, cercando di metter in luce quei lati positivi che in primo momento aveva deliberatamente e dichiaratamente messo da parte. Tali romanzi hanno trovato maggiori consensi. In realtà i risultati sono diseguali; a me non riesce, per esempio, di entusiasmarmi per una lunga, noiosa, presuntuosa predica quale è Der Geltstag (La bancarotta, 1845). Ma non c’è da meravigliarsi che in una così vasta opera ci siano cose non riuscite: Gotthelf scrisse quattordici romanzi e 226 una cinquantina di racconti, alcuni dei quali lunghi quasi quanto un romanzo, senza contare i numerosi volumi di giornalista e di predicatore. All’interno di quest’opera ci sono dunque cose non riuscite ma anche capolavori. Su alcuni di questi va richiamata l’attenzione. Uli der Knecht si è conquistata una notevole popolarità; lo si può definire un manuale di come si arriva al comando, al benessere e perfino alla felicità nel più schietto spirito calvinista. A lungo viene sviluppata l’iniziazione al comando: Uli, il protagonista, è all’inizio un servo che deve interiorizzare le norme della morale, la spinta all’istruzione, la coscienziosità e la perizia nel lavoro; quindi l’uso del denaro, rifuggendo dalle tentazioni di speculazioni mirabolanti, che si rivelano imbrogli, e cominciando a far uso della nuova realtà, cioè delle banche; deve anche imparare a commerciare per conto del padrone, che però lo associa al guadagno. Questi primi passi riescono bene perché c’è un padrone che sa guidarlo, anche impedendogli passi falsi nella scelta della moglie. Quindi Uli, per una fortunata circostanza e sempre con la generosità del padrone, cambia posto di lavoro e diventa massaio. Qui ha i suoi problemi sia con i nuovi dipendenti, sia col nuovo padrone, che non sa comandare; qui Uli mostra quel che ha imparato: essere primo nel lavoro, sia per competenza sia per applicazione; avere una visione chiara dell’insieme, così da poter pianificare a tempo e realisticamente; costanza nell’esecuzione. Tutte queste qualità mancano al nuovo padrone, che per di più non sa nemmeno valutare giustamente i compensi dovuti a prestazioni straordinarie; e d’altra parte è geloso di Uli, tanto da essergli quasi d’ostacolo, così che Uli sarà costretto a porre la questione dell’unità del comando. Intanto Uli è arrivato a trent’anni e non si è ancora sposato; viene pertanto sviluppato il secondo tema del romanzo, attinente alle strategie matrimoniali. Gotthelf ne sviluppa tutta la ritualità, a cominciare dalle vanterie con le quali si cerca di far colpo sull’altro e nelle quali in più di un caso si mescola la bugia. Il primo elemento da considerare è la ricchezza, il secondo è la laboriosità e un fisico che la garantisca. Quando Uli arriva alla sua scelta, il lettore sa che c’è amore nel senso romantico-moderno del termine; ma le qualità che vengono fatte valere (non essendoci la ricchezza) sono: la donna in questione è instancabile, allegra, risparmiatrice, capace di cucinare e di prendersi cura dei malati. Uli dunque si sposa - condizione indispensabile per poter dirigere una fattoria sulla base della divisione del lavoro - e prende in affitto la fattoria del nuovo padrone, togliendo quest’ultimo da un grave imbarazzo e garantendo a se stesso un’ascesa sociale. Ma ancora una volta ciò è permesso dal sostegno morale e materiale del vecchio padrone, che ammorbidisce anche le resistenze del nuovo. Forse questo riassunto dice poco; in effetti è la grandiosa forza plastica di Gotthelf a rendere straordinarie le lotte per il comando (sia contro i servi infingardi sia contro il padrone inetto), le contrattazioni sul prezzo di una mucca, le donne che cercano di accalappiare un marito o gli uomini che cercano di accalappiare una dote. Geld und Geist oder Die Versöhnung (Soldi e spirito ovvero La conciliazione, 227 1843-44) si divide in tre parti; la prima, cui propriamente si riferisce il titolo, è forse quanto di più bello abbia scritto Gotthelf. Vi si descrive una famiglia di contadini (genitori, due figli e una figlia) con i suoi lati positivi e negativi, che hanno trovato un loro equilibrio. I difetti descritti non sono cosa da poco per la morale calvinista e contadina: lui è pigro, lei è eccessiva nel donare; dei figli, il maggiore sembra un po’ apatico, la figlia scarsamente amante del lavoro, il minore un po’ troppo taciturno. Ma tutti questi difetti sono compensati da virtù, così che in casa c’è pace, armonia e prosperità. Gotthelf ha preparato il lettore al verificarsi di un evento drammatico; esso potrebbe venire da qualunque parte, poiché sono stati elencati i difetti di tutti. Il colpo arriva perché il capofamiglia cade in un imbroglio (a opera di quegli «scribacchini» che Gotthelf odia tanto); vi cade per quel suo misto di pigrizia e bonomia, cui però si aggiunge stavolta la mancanza di coraggio che non gli fa ammettere di non intendersi di determinate operazioni. La perdita è grave ma non irreparabile. Però ne nasce una mancanza di fiducia fra i coniugi che li porta ad allontanarsi l’uno dall’altro. Ciò si ripercuote su tutti i rapporti familiari ed extrafamiliari; i genitori, tutti intenti alla loro lotta, si curano meno dei figli, questi non riescono a metter pace fra loro anzi ne accrescono la diffidenza e infine i rapporti tra i figli stessi ne risultano turbati. E sotto ciò c’è la consapevolezza che non è tanto la perdita di denaro a essere importante quanto la perdita della pace e dell’armonia interne, che a sua volta genera cambiamenti nei rapporti esterni. Sarà la moglie a trovare il coraggio e la costanza necessari per mettere fine a questo stato di cose e a trovare la via per la riconciliazione generale, che rinsalderà ulteriormente la famiglia; l’esperienza servirà in particolare al più giovane, di cui da questo momento il romanzo segue le vicende (e anzi qui sarebbe dovuto terminare il racconto, che Gotthelf proseguì e sviluppò a romanzo dietro pressione dei lettori). Occorre dire che alla donna la forza è venuta da una predica; questo schema si ripeterà anche nelle due parti seguenti. La seconda è dedicata alla storia d’amore fra Resli (il figlio minore) e Anne Mareili, figlia di un ricco contadino. È una storia che si sviluppa subito in maniera drammatica: Anne Mareili trova Resli privo di conoscenza in seguito a una rissa e lo porta in casa, con grave disappunto del padre, che lo lascia andare (ma praticamente lo manda via) prima ancora che sia in grado di affrontare il ritorno. Seguono le schermaglie fra le due madri, un incontro clandestino fra i due ragazzi, infine la richiesta di Resli al padre della ragazza. La terza parte è dominata dalla figura di questo padre, dalla sua aridità e dalla sua tirannia: la figlia è per lui una pedina per impadronirsi dei beni altrui. Resli resiste, ciò suscita l’incomprensione di Anne Mareili e, a quel che pare, la rottura fra i due, che si ricongiungeranno solo al capezzale della morente madre di Resli, in un finale che Gotthelf lascia dichiaratamente impreciso. In una nota, poi, scherza addirittura su questa vaghezza e sui lettori che vogliono una conclusione con tutti i particolari. Anche se l’esemplificazione non è stata abbondante, si sarà intuito quel che è 228 successo dopo il Bauernspiegel: avendo acquisito una volta per tutte il quadro d’insieme, Gotthelf ha scelto di volta in volta dei temi più limitati e mirati, sviluppandoli secondo le premesse dell’etica calvinista e dando loro solitamente un esito positivo. Ma si ricorderà che nel primo romanzo il narratore moriva quando stava per diventare segretario comunale, quando cioè l’intento pedagogico stava per saldarsi al potere politico-burocratico. Nei romanzi e nei racconti successivi questa saldatura non è più avvenuta; evidentemente Gotthelf non ci aveva mai creduto. È stato un grande narratore, sia nel tratteggiare grandi quadri sia nel costruire strutture minori. A titolo di esempio citerò un capitolo (il tredicesimo) da Jakobs des Handwerksgesellen Wanderungen durch die Schweiz (Viaggi dell’artigiano Jakob attraverso la Svizzera, 1846-47). Jakob (un artigiano, stavolta, non un agricoltore) arriva a Fribourg in cerca di lavoro. La descrizione della città, oggettiva nella primissime righe, rivela subito un osservatore partecipe, che non è indifferente al carattere misto di quel che descrive, alla divisione in città alta e città bassa, francese e tedesca, cattolica e protestante, gesuitica e libera. Jakob si mette in cerca di lavoro, ma senza fortuna; la sua ricerca è vista quasi più con gli occhi dei fortunati che un lavoro ce l’hanno e nel disoccupato vedono la sorte che potrebbe aspettarli. Sconfitto, Jakob torna nella locanda e nella notte ha un incubo: gli pare che i gesuiti lo torturino a lungo. Al risveglio deve accorgersi che non i gesuiti ma il suo compagno di stanza l’ha derubato ed è scappato. Ne segue un confuso litigio con l’oste; finalmente Jakob capisce che l’oste non è un gesuita, in compenso si convince che chi l’ha derubato sia un comunista, spia dei gesuiti. L’oste lo rimette un po’ in sesto e Jakob prosegue per Verey, dove però ugualmente non trova lavoro ma artigiani che gli parlano dell’immanente rivoluzione comunista. Tutto convinto ed esaltato, Jakob prosegue per Losanna. Questo è un capitolo scelto da un romanzo che nella sua programmaticità presenta non pochi aspetti aridi, cosa che purtroppo vale in generale dell’ultima fase di Gotthelf, dal 1845 in poi. Ma il grande narratore non viene mai meno, anche se a volte si rivela solo a tratti. All’inizio abbiamo detto che la formula in cui si può riassumere l’opera di Gotthelf è: l’antropologia non è un valore ma guai a ignorarla. A questo punto però è necessario fare un bilancio, che costringerà ad aggiungere qualcosa. Si è ben visto che Gotthelf non idealizza il popolo (neanche quando cambia soggetto e dai contadini passa agli artigiani). Non credo che ciò rischi di sfuggire essendoci, diciamo così, degli eroi positivi; troppo evidenti sono infatti quelle che Gotthelf stesso chiamava le ombre dell’insieme. C’è addirittura un intero, fluviale romanzo, Wie Anne Bäbi Jowäger haushaltet und wie es ihm mit dem Doktern geht (L’economia domestica di Anne Bäbi Jowäger e come se la cava a medicare, 1843-44), dedicato ad esaminare usi popolari esiziali e in cui una coppia di coniugi, validamente sostenuta da tutto il contorno popolare, giustifica i disastri 229 che combina semplicemente richiamandosi alle usanze. Dunque nessuna idealizzazione. D’altra parte fin dal Bauernspiegel Gotthelf aveva sostenuto che occorre conoscere il popolo per poterlo avvicinare senza combinare disastri. C’è ora da chiedersi che cosa intendesse con un tale avvicinamento. Sembra che Gotthelf si aspetti tutto dalla morale e dal possesso, niente invece dalla politica; quel finale interrotto del Bauernspiegel, mai più ripreso e sviluppato, sembra avere valore simbolico. La morale che Gotthelf intende è la morale calvinista; essa vuole essere insegnata, e così il discorso s’allarga alla pedagogia. In alcune opere il discorso sembra essere troppo ristretto; per esempio in Uli der Knecht non si fanno molti tentativi per insegnare qualcosa oltre la lettura della Bibbia; altrove però (per esempio nella prima parte di Geld und Geist) gli effetti di un’istruzione troppo superficiale si fanno sentire; e in Anne Bäbi la conseguenza di un’ignoranza pari a un’istruzione che non va oltre l’elementare e l’antiquato sono fatali. Sembra dunque che la soluzione dei problemi debba venire innanzitutto dalla religione, intesa sia come morale sia come educazione; quindi da un programma pedagogico più latamente inteso; e infine da un’attività lavorativa che porti al possesso, e per possesso si intende fondamentalmente quello di una fattoria. La politica è la grande assente, dirò con un paradosso solo apparente, soprattutto dai suoi romanzi più intenzionalmente politici; i politicanti vi appaiono infatti solo come ladri, truffatori, profittatori, oppure come mestatori. Sembra che tra antropologia e politica non vi sia né possa esservi comunicazione né dall’una una via d’accesso verso l’altra e che, ripeto, non si vada oltre la somma di antropologia, morale e possesso (con gli allargamenti sopra visti). Ma parlare di somma è forse inadeguato; forse si dovrebbe piuttosto dire che l’antropologia va sottratta alla politica prima di sommarla alle altre grandezze. Pare infatti che nel mondo di Gotthelf la proprietà non richieda leggi e istituzioni ma solo usanze; basterà la morale per guidarle al meglio. La cosa stupisce un po’ perché i romanzi di Gotthelf non ignorano le banche né il commercio (questo, peraltro, ne esce moralmente sempre molto male); non ignorano le città con la loro vita complessa (anche le città ricevono la loro condanna e Gotthelf protesta molto contro la loro pretesa superiorità; tuttavia il narratore del Bauernspiegel matura in città e segnatamente a Parigi, in quella che Walter Benjamin chiamerà la capitale del XIX secolo). Meno che mai ignorano i problemi legati al rifacimento, davvero non sempre pacifico, della costituzione svizzera; è vero che secondo il Bauernspiegel la costituzione risolve i problemi dei cittadini solo per un terzo mentre è la personalità dei governanti a fare gli altri due terzi; ma si tratta pur sempre di tre terzi di politica. Gotthelf non vuole la rivoluzione e ritiene che quel che può impedirla sono le riforme continue; difficile però pensare che esse avvengano senza la politica. Eppure la politica manca; essa manca addirittura in Zeitgeist und Bernergeist (Spirito del tempo e spirito bernese, 1852-52), in cui gran parte di quel che viene detto (e che rincara di molto le lamentele sopra riportate) è probabilmente giusto e denuncia rigorosamente arrivismo, sprechi, eccesso di burocra230 tizzazione e via dicendo; a tutto ciò però oppone ancora una risposta quale quella già detta, mostrata in un caso specifico di interiorizzazione individuale, quanto più possibile lontana dalla politica. Dunque non si tratta di un romanzo politico ma di un romanzo in cui si rifiuta la politica. Perciò alla formula iniziale c’è da aggiungere il suo contrario: nonostante tutto, l’antropologia copre l’assenza di politica. La descrizione del popolo finisce per dar luogo al mito sui legami che dovrebbero promuovere l’ascesa economico-morale; e questo mito si rivolge contro la politica. Abbiamo cominciato con un grande realista, ci ritroviamo con un mito restaurativo. È un finale che sembra verificarsi regolarmente quando si comincia a parlare di popolo, e sarebbe interessante trovarne la ragione. Nel caso specifico pare proprio da escludere un riferimento al romanticismo come pure a esperienze tedesche legate alle guerre di liberazione. Ci sarebbe da chiedersi se non vada fatta qualche ricerca in direzione dell’impostazione ereditata dall’età barocca e quali mutamenti essa abbia subito strada facendo. O se non ci siano cause molto più vicine e immediate. Il fascino di Gotthelf sembra destinato a crescere col tempo. III, 2, 2. Nella casa di fronte c’era un atrio oscuro e aperto, pieno zeppo di cianfrusaglie vecchie e nuove. Le pareti erano coperte di vecchi drappi di seta, di tessuti lavorati e di arazzi di ogni specie. Armi e attrezzi arrugginiti, dipinti a olio anneriti e laceri rivestivano i pilastri dell’ingresso, spingendosi fuori sulla facciata da ambo i lati; su una moltitudine di tavole e suppellettili antiquate torreggiavano pile di vasellame in vetro e porcellana, inframmezzate da ogni sorta di figure di legno e di terracotta. Nei locali più interni erano accatastate montagne di letti e di masserizie, e sui loro altipiani e sporgenze, a volte su pericolose creste isolate, sorgeva ancora dappertutto un orologio barocco, un crocifisso o un angelo di cera e altre cose simili. Nel retro più profondo poi, in una tetra penombra, sedeva sempre una donna attempata, grassa, vestita all’antica, mentre un ometto ancora più anziano, segaligno, trafficava qua e là nell’atrio con l’aiuto di alcuni dipendenti e sbrigava una folla di gente che andava e veniva di continuo. Ma l’anima del negozio era la donna, e da lei partivano tutti gli ordini e le disposizioni, sebbene non si muovesse mai dal suo posto e ancor meno la si fosse vista per strada. Aveva sempre le braccia scoperte e portava camicie bianchissime con le maniche pieghettate ad arte, come non se ne vedeva più da nessuna parte e come forse si portavano cent’anni addietro. Era la donna più originale del mondo, giunta in città trent’anni prima, povera in canna e ignorante, per procacciarsi il pane. Dopo essersela cavata miseramente per lunghi anni col guadagno giornaliero e duro lavoro, era riuscita a mettere su una piccola bottega da rigattiere e col tempo, assistita dalla fortuna e dall’abilità negli affari aveva raggiunto una 231 comoda agiatezza, che governava nel modo più singolare. Leggeva solo, ma con difficoltà, le cose stampate in gotico, ma non sapeva né scrivere né fare i conti con i numeri arabi, che non riuscì mai a imparare; tutta la sua arte del calcolo consisteva in un uno, un cinque, un dieci e un cento romani. Quelle quattro cifre, rimaste in uso nel popolo da un millennio, le aveva imparate nella sua prima giovinezza, in una remota e dimenticata parte del paese, e le maneggiava con un’abilità straordinaria. Non teneva alcun registro e non possedeva nulla di scritto, ma era in grado di dominare in ogni momento tutto il volume dei suoi affari, che speso ammontava a parecchie migliaia ripartite in tante piccole somme, coprendo velocissimamente il piano della tavola con imponenti colonne di quelle quattro cifre, tracciate con uno dei pezzetti di gesso che portava sempre in tasca. Messe giù a memoria in tal modo tutte le somme, raggiungeva il suo scopo semplicemente cancellando col dito bagnato una fila dopo l’altra con la stessa velocità con cui le aveva compilate, e contando segnava da parte i risultati. Sorgevano così nuovi gruppi più piccoli di numeri, di cui nessuno, tranne lei, conosceva l’importanza e il valore, poiché erano sempre le stesse quattro semplici cifre, che per gli altri avevano l’aspetto di una scrittura magica di pagani antichi. La donna così descritta è la signora Margret, che per Heinrich Lee, narratore e protagonista in questa parte del romanzo Der grüne Heinrich (Il verde Heinrich, 1854-55), rappresenta un po’ quel che sono le nonne che raccontano le favole; la differenza è che la signora Margret non racconta favole ma è lei stessa la fonte di un mondo favoloso, sviluppando la fantasia del narratore bambino e predisponendola alle forti impressioni. Nella signora Margret e nel mondo che la circonda viene alla luce lo strato più antico della cultura popolare; una cultura ben diversa da come la vedeva Gotthelf (di cui Keller fu critico non tenero), già per il motivo che Keller non aveva intenti pedagogici e che il suo fine non era dimostrare la scalata alla proprietà fondiaria fatta in nome di Dio e con solidi agganci nella rissosa comunità. Per cui anche quando il materiale demologico è lo stesso nei due autori, il risultato non è mai lo stesso. A Margret e a suo marito alcune cose vengono da un passato talmente remoto da parere eterno, di altre cose però sono stati testimoni oculari. Lui crede fermamente nelle streghe e a beneficio del piccolo Heinrich intesse su questo motivo delle storie buffe a proposito delle quali non è chiaro quanta parte ne creda lui stesso; ma nella sua primissima giovinezza (quindi intorno alla metà del Settecento) si erano svolti gli ultimi processi alle streghe e i suoi racconti ricalcano da vicino i verbali di quei processi e tutte quelle credenze, giuntegli dalla tradizione orale. Anche la signora Margret sa raccontare delle arti magiche ancora praticate in campagna ai tempi della sua giovinezza; e di vari episodi di spettri e di magia lei stessa vuole essere stata protagonista. Molte cose, durante quella giovinezza, parevano testimoniare di un passato bensì lontano ma non immemorabile: i contadini satolli che si comportano con crudeltà nel mezzo di una carestia degli anni Settanta appaiono come discendenti dei tiranni feudali i cui castelli sono ancora sparsi 232 tutt’intorno. Entro questa cultura, così storicizzata da Keller, s’inserisce lo sviluppo personale e apparentemente atemporale (ma in realtà tutto comprensibile nelle sue ragioni sociologiche ed economiche) fattone in particolare dalla signora Margret, per la quale tutto ciò che esiste, anche la materia più inanimata, è piena di significato e di vita. Sebbene illetterata, ha raccolto una gran quantità di libri: C’erano diverse bibbie, antiche cosmografie con innumerevoli xilografie, descrizioni di viaggi infarciti di favole e, soprattutto, mitologie nordiche, indiane e greche del secolo passato con grandi stampe ripiegate, che erano in gran parte sgualcite e lacere; queste opere di stile ingenuo le chiamava senz’altro i libri dei pagani o anche degli idoli. Possedeva inoltre una ricca collezione di quegli scritti popolari che davano notizia di un quinto evangelista, degli anni giovanili di Gesù, di sue avventure ancora sconosciute nel deserto, del ritrovamento del suo cadavere ben conservato, insieme a documenti dell’apparizione e delle confessioni di un libero pensatore che soffriva nell’inferno; alcune cronache, erbari e profezie completavano la raccolta. Le convinzioni religiose sono al centro di tutto e a loro viene tutto ricondotto; ma prima di questa riconduzione si esplora il mondo degli spiriti, dei presagi, dei sogni, si parla di viaggi attraverso i corpi celesti, si parla di vulcani e di profondità marine di cui si è inteso dire. Tutto appare in sintonia con la fede religiosa, Margret e suo marito credono parimenti a Dio quale creatore sagace di tutte le cose meravigliose e a quel loro mondo, senza sentirsi minimamente in contraddizione. Questo mondo attira intorno alla signora Margret un piccolo pubblico, con i suoi stessi bisogni spirituali e nel quale non viene ammesso alcun influsso pietista, mentre al pietismo viene invece contrapposta una corposa fede nei sensi: Erano dei poveri, donne e uomini, che, in parte attirati dal profumo della tavola ben fornita, in parte dalla vivace conversazione su cose di più alto livello, cercavano e trovavano lì ristoro alla fatiche della giornata. Ad eccezione di alcuni rari parassiti ipocriti, avevano tutti un sincero bisogno di riscaldarsi lo spirito con discorsi e insegnamenti su cose per loro insolite, e specialmente di cercare, nel campo della religione e del meraviglioso, un nutrimento più saporito di quello offerto dalle condizioni culturali del tempo. Insoddisfazione dell’anima, sete inappagata di verità e di sapere, vicende di vita provocate dal tentativo di appagare nel mondo sensibile tali impulsi irrequieti, portavano quella gente lì da lei, oltre che in seno a certe strane sette, sulla cui vita e operato la signora Margret si faceva informare con diligenza, essendo tropo profana e comoda per arrivare al punto di prendervi parte. Rimproverava invece con parole pungenti i bacchettoni e si faceva sarcastica e amara quando notava troppa spazzatura mistica. Aveva bisogno del misterioso e del meraviglioso, ma nel mondo dei sensi, nella vita e nel destino, nei mutevoli fenomeni esterni; di miracoli dell’anima, di disposizioni privilegiate, di eletti e cose simili non voleva sentir parlare e dava vio- 233 lenti rabbuffi ai suoi ospiti, quando volevano tirar fuori fatti del genere. La signora Margret è una merciaia e la sua fede non lo dimentica: oltre che creatore di cose meravigliose, Dio è da apprezzare perché aiuta chi comincia dal nulla facendosi man mano una solida posizione economica. Di conseguenza la signora Margret, generosa sempre, lo era particolarmente nei confronti di chi mostrava di avere dalla sua la fortuna, mentre mostrava un’ostinata antipatia nei confronti di chi restava inconsapevolmente povero. Nel suo testamento lascerà tutto a uno di quei promettenti scalatori sociali, l’ultimo della serie, il quale venderà tutte le cose da lui considerate di valore, senza capire quale tesoro di cultura dilapidi. Del resto già a un certo punto della sua vita la signora Margret aveva dovuto dividere tutto col marito, il quale aveva contribuito all’ascesa economica semplicemente col suo allegro bighellonare e che resterà a vivere a carico della moglie, sopravvivendole di tre anni e morendo proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto cambiare l’ultima moneta d’oro rimastagli. Questo episodio occupa non più di una ventina di pagine in un libro che ne ha quasi novecento. Esso si presta bene a esemplificare alcune caratteristiche del romanzo e quindi è stato scelto e lungamente illustrato non soltanto perché è indimenticabile e perché mostra ancora una variante del modo di rapportarsi alla cultura popolare, ma appunto per il suo valore esemplare. Der grüne Heinrich (ricordo che stiamo qui parlando della sua prima versione) comincia con una breve parte introduttiva che pone le premesse dell’insieme e cui si riallaccerà strettamente la parte conclusiva; segue quindi la lunghissima retrospettiva della storia della giovinezza scritta dallo stesso protagonista e pertanto narrata in prima persona; essa occupa ben più della metà del romanzo; e quando arriva a coincidere con quanto visto nella parte introduttiva, allora il romanzo prosegue in terza persona fino alla fine. Già da qui si vede un certo squilibrio nella disposizione temporale; esso costituisce uno dei fascini maggiori della prima versione e invece a Keller stesso dispiacque fin da subito e fu uno dei motivi che lo indusse a un tardo rifacimento, come vedremo più in là. In realtà quello squilibrio è giustificato dal tormentoso sviluppo del protagonista e a sua volta genera una delle soluzioni più geniali nel trattare il tempo. L’episodio della signora Margret, che arriva fino all’età adulta del protagonista (unico conoscente di tempi antichi che accompagnerà alla tomba anche il marito) e che nelle sue premesse risale tanto indietro nel tempo, viene trattato tutto in blocco. Secondo la pura cronologia esso dovrebbe essere in atto parallelamente a molti altri, ma nella strategia narrativa non è così: tutto quel che riguarda la signora Margret è trattato nello stesso blocco e solo un paio di cenni fatti più in là indicheranno la contemporaneità cronologica cui si è accennato. La stessa strategia vale per numerosi altri episodi: la loro trattazione non è lineare ma tematica e la loro collocazione dipende dal momento in cui hanno avuto importanza eminente. Di conseguenza la loro funzione dipende dal tipo di riflessione indotta nel protagonista- 234 narratore. Ecco quale è la riflessione indotta dall’episodio Margret: Devo infatti ricondurre alla prima giovinezza la mia inclinazione e una certa abilità nel collegare agli eventi della vita destini inventati e storie intricate, abbozzando in tal modo romanzi allegri e tristi, il cui punto focale ero io o chi mi stava vicino e che mi tenevano occupato per molti giorni, finché si dissolvevano in nuove azioni, conformi all’umore e alle circostanze esterne. Si trattava, in quel primo periodo, di immagini brevi e mutevoli, che si formavano inconsciamente e velocemente mi scorrevano davanti, come i ricordi in libertà e le trame dei sogni di un dormiente. Mi si intrecciavano con la vita reale tanto strettamente da non riuscire quasi a distinguere le due cose. Come si vede, tale riflessione introduce un altro blocco narrativo, che ha tutt’altro tema e nel quale la signora Margret non viene più ricordata; il nuovo blocco occasiona poi un altro blocco e così via. La scomposizione del tempo e la ricomposizione per temi è uno dei modi in cui il romanzo trova i suoi criteri organizzativi e uno dei modi in cui la confusione nell’animo di Heinrich Lee trova una qualche via per riassettarsi. Non è l’unico e lo vedremo presto; qui occorre ancora richiamare l’attenzione su un tratto essenziale del modo di narrare. Si sarà notato che qua e là il narrare cede il posto a un andamento saggistico: Keller discute le date, le fonti e le ragioni della cultura della signora Margret e di suo marito; finché parla della biblioteca e di come viene costituita, obbedisce a un topos letterario: ma quando dice perché il pubblico si radunava in quelle discussioni o quando dà altre informazioni cronologiche, dietro il narratore lampeggia il saggista. Si badi bene: il saggista, non il moralista; l’attività caritatevole che privilegia i ricchi in spe lascia riconoscere la morale calvinista ed è facile immaginare che cosa ne avrebbe fatto un Gotthelf; proprio qui, invece, Keller è schiettamente narratore. E quando lascia via libera agli spunti saggistici, non lo fa per giudicare ma, come si addice a un saggio, per spiegare precisamente e per spiegare dal punto di vista dell’osservatore che, essendo stato coinvolto, vuol però oggettivizzare e razionalizzare quel che ha osservato. Heinrich Lee non è un personaggio corale né sta per altri che per se stesso; interiorizza cose che però persistono nella loro autonomia. Il carattere di blocco, autonomo cronologicamente e oggettivamente, trae forse la giustificazione da qui. Lo sviluppo di Heinrich Lee è tumultuoso, drammatico, anzi non arriva mai a buon fine. Il modo di narrare mima quest’andamento. Un ubi consistam esso lo trova, oltre che nei blocchi tematici, nei raddoppi o in iterazioni anche più frequenti. Ecco alcuni esempi: un imbarazzo nel pregare ad alta voce viene raddoppiato dalla storia orribile, successa un secolo prima, di una ragazza che ha le stesse difficoltà; a seguito di alcuni fallimenti nei rapporti col mondo circostante, Heinrich si chiude in sé e inventa dei suoi mondi fantastici, distrutti da lui stesso uno dopo l’altro, fino al più complesso e laborioso, ispirato da una delle strampalate cosmogonie della signora Margret; analogamente, a seguito di altri e 235 più gravi fallimenti svilupperà un’introspezione mista ad autocompassione, che lo porta a sviluppare uno strano tipo di pittura; ciò avrà conseguenze importanti e di vario genere, ma intanto teniamo presente che quella pittura non è per sua natura così lontana dai mondi fantastici creati (e distrutti) anni prima per motivi analoghi. Ma il raddoppio più straordinario è, già nella storia della giovinezza, il raddoppio delle donne amate, che corrispondono a due lati della personalità di Heinrich. Si chiamano Anna e Judith; la seconda è la donna matura, sensuale e comprensiva, la prima rappresenta l’amore ancora pieno di stupore: pur pensando sempre alla giovane Anna, mi trattenevo volentieri con la bella Judith, perché nell’incoscienza di quel periodo scambiavo una donna per l’altra e non credevo minimamente di commettere un’infedeltà se, al cospetto di quella figura femminile sbocciata in tutto il suo rigoglio, pensavo al tenero bocciolo lontano più gradevolmente che altrove, perfino più che alla sua stessa presenza. Anche nei singoli episodi questa vicenda ha le sue iterazioni: un biglietto d’amore scritto da Heinrich per Anna si perde fortunosamente dentro un alveare e sarà scoperto e letto da altre persone, un altro verrà da lui affidato alla corrente di un fiume, che lo porterà fino al petto di Judith. Ma l’iterazione in più grande stile si avrà in occasione di una grande festa popolare. Sarà il caso di ribadire che Keller conosce e descrive le usanze popolari, in molte parti del suo romanzo, con competenza in nulla inferiore a quella di Gotthelf; è lo spirito a essere opposto. Il narratore si mostra osservatore ingenuo a causa dell’età (in quel momento ha sedici anni); per esempio lo scandalizza che un oste difenda ostinatamente il proprio tornaconto, mascherandolo da interesse generale, proprio in occasione di una festa come quella, in cui si celebra la nascita della Svizzera indipendente e in cui l’oste stesso è vestito da Guglielmo Tell; è chiaro che è il narratore, non l’autore a scandalizzarsi ingenuamente, accusando l’oste di non corrispondere all’idea che si è fatto del popolo. A questo punto però un altro personaggio fa al narratore un discorso nel più schietto spirito liberale: chi non sa conquistare e difendere apertamente il proprio interesse, non sarà mai nemmeno in grado di procurare spontaneamente un guadagno al suo prossimo! [...] Uno che rinuncia perennemente, che in ogni cosa si mantiene mansuetamente indietro, sarà magari un brav’uomo, innocente, ma nessuno gli sarà grato o dirà di lui: costui mi ha procurato un vantaggio! [...] Dove non si è capaci di impegnarsi apertamente per il proprio utile e per i propri beni, certo non vorrei stabilirmici, perché non c’è da guadagnare altro che la magra brodaglia dell’ipocrisia, della salvezza per grazia e della corruzione romantica. E via di questo passo: sulla democrazia rappresentativa, su quello stranissimo corpo che è la burocrazia, lontana da ogni vita economica effettiva e propensa a corrompersi, e tuttavia indispensabile. 236 Entro questo grande affresco, in cui la vita popolare è ritratta per intero, dalle antiche usanze alla moderna vita economica e politica, si sviluppa, nella stessa serata, la doppia storia d’amore con Anna e con Judith: con Anna c’è il primo bacio, incerto, impacciato, stordente; e poi c’è la notte d’amore con Judith. Il narratore può dire di sé cose contrastanti: «Mi faceva piacere che la mia vita aprisse davanti a me un aspetto dopo l’altro»; ma anche: «Sentivo il mio essere diviso in due parti: davanti ad Anna avrei voluto nascondermi presso Judith e davanti a Judith presso Anna.» La spiegazione verrà più tardi: mentre io amavo in Anna la parte migliore e più spirituale di me stesso, Judith a sua volta cercava nella mia giovinezza qualcosa di meglio di quanto il mondo le avesse offerto fino ad allora; eppure si accorgeva di allettare solo la parte sensuale di me. Heinrich ha diciotto anni; Anna muore; lui, in un accesso di selvaggio romanticismo, decide di lasciare la saggia Judith, che lo esorta invano a restare libero, a non legarsi a nulla, non ai suoi folli propositi e in definitiva nemmeno a lei. Judith non ottiene nulla, nemmeno quell’amore non vincolante che aveva chiesto; la vedremo per l’ultima volta mentre emigra per l’America, mentre Heinrich fa i suoi preparativi per lasciare la Svizzera e andare a Monaco (città, peraltro, mai nominata nel romanzo) a completare i suoi studi di pittore. Il suo comportamento nei riguardi delle due donne gli verrà rimproverato da un amico pittore, anche lui coinvolto in complicate storie d’amore: Ciò che hai sperimentato ancora mezzo bambino era il semplice risveglio della tua consapevolezza, che in modo del tutto normale si scisse in due parti e aderì accidentalmente ai primi oggetti che ti si fecero incontro. La metà sensuale alla donna matura e forte, quella più sensibile, spirituale, alla giovane fanciulla eterea, che hai tradito con la donna matura. A dispetto di te stesso non l’avresti mai fatto, se ci fosse stato in te un vero, intero amore! Proprio a seguito di questo colloquio i due si scontreranno in un duello, nel quale l’avversario di Heinrich avrà la peggio; morrà a distanza di tempo, in conseguenza della ferita riportata. E a questo punto il romanzo ha uno di quei momenti nei quali Keller mostra a quali straordinari sviluppi stesse facendo da battistrada. Immalinconito a seguito del duello, Heinrich si è messo a dipingere una strana cosa: Fra i grandi dipinti spiccava particolarmente un telaio lungo perlomeno otto piedi e alto altrettanti, con della carta grigia fissata su e in piena luce su un poderoso cavalletto. Nella parte bassa del telaio c’era un primo piano cominciato a carboncino, e alcuni tronchi di pino, abbozzati con due tratti leggeri, salivano in alto. Uno di essi era già marcato a penna, poi il lavoro sembrava essersi fermato. Su tutto il rimanente spazio vuoto sembrava pendere un’immensa ragnatela gri- 237 gia, che però si dimostrava a un’analisi più attenta il lavoro più strano del mondo. A uno scarabocchio che Heinrich aveva fatto sopra pensiero in un angolo, come per provare la penna, si era aggiunto a poco a poco un immenso tessuto di tratti, che egli andava estendendo ogni giorno e quasi ogni ora perduto nelle sue fantasticherie, tanto che ora ricopriva la maggior parte del campo. Ma ad osservare ancor più attentamente il garbuglio, vi si scopriva la più mirabile coerenza, la più lodevole diligenza, perché in una teoria ininterrotta di tratteggi e di tortuosità, che si assommavano forse a migliaia di braccia, formava un labirinto il cui percorso si poteva seguire dal principio alla fine. Di quando in quando si mostrava una maniera nuova, per così dire una nuova epoca del lavoro; apparivano modelli e motivi nuovi, spesso molto delicati e graziosi. Se la somma d’attenzione, d’ingegnosità, di perseveranza che era stata necessaria per quest’insensato mosaico, unita a tutto il talento di Heinrich, fosse stata applicata per una vera opera, egli avrebbe certo dovuto compiere un capolavoro. Solo qua e là apparivano dei ristagni minori o maggiori, quasi dei nodi nelle tortuose vie della sua anima distratta e crucciata, e la maniera accurata e intelligente con la quale la punta della penna aveva cercato di trarsi d’impaccio dimostrava chiaramente come la coscienza di Heinrich, benché sognante, cercasse di venir fuori da quel guazzabuglio. Ma di tutto ciò abbiamo già parlato con riguardo alla riflessione sul dilettantismo. Heinrich capisce che l’ideale per il quale era vissuto dal quattordicesimo anno in poi, la scelta di vita rivolta alla pittura, non era stato che un caso, «un’associazione di idee dettata da circostanze casuali». Ma «Ragazzi di ventidue, ventitré anni non sanno ancora che ogni vita crea il proprio uomo e non hanno ancora alcun motivo di consolazione per gli anni che credono perduti.» Segue rapida e durevole la decadenza. Heinrich ritarderà in tutti i modi il rientro in patria, che avverrà al termine di sette anni e in coincidenza coi funerali della madre, morta di stenti. Heinrich, consumato dai rimorsi e ormai estraneo, morirà anche lui dopo poco tempo (appunti preparatori prevedevano addirittura un suo suicidio). Il finale è perfettamente calibrato sull’inizio, del quale costituisce, a seconda dei momenti, una realizzazione dei presagi negativi, una revoca delle promesse, un’interpretazione funerea di simboli dapprima presentatisi come positivi. Il romanzo non ebbe alcun successo di pubblico; quando nel 1879-80 venne pubblicata la seconda versione, Keller comprò tutte le copie restanti della prima; di questa erano state stampate 1000 copie, rimaste per buona parte invendute. Ma lui stesso era mezzo pentito della prima versione già al momento in cui la pubblicava; in una prefazione all’ultimo volume ne deprecava la mancanza di forma e in particolare l’eccessiva lunghezza dell’autobiografia giovanile. A molti anni di distanza ne affrontò la rielaborazione, sollecitando e ottenendo molti consigli da Theodor Storm. Il finale venne radicalmente cambiato, tutto il romanzo venne narrato in prima persona, alcune parti vennero spostate; insom238 ma: nella struttura generale tutto divenne molto più normale o, come c’è chi preferisce dire, tutto venne armonizzato. Anche episodi importanti ne risentono: il duello non ha più luogo, la vicenda della “ragnatela dipinta” prende ben altro corso. Per arrivare a un lieto fine, la decadenza di Heinrich non ha più la misura della prima versione; un idillio che ritardava il ritorno e che con la sua retardatio e illusoria felicità aveva la funzione di sottolineare ancora di più il fallimento, viene allargato e preso sul serio, anche se poi svanisce e si risolve in modo incredibile; Heinrich arriva in tempo per chiudere gli occhi alla madre morente, vendendo la cui casa guadagna anche un bel gruzzoletto; sente poi nascere in sé la vocazione politica e si mette a fare lo statale; Judith, opportunamente ringiovanita rispetto alla prima versione, torna per lui dall’America, sempre innamorata e con la novità di essere ben provvista di denaro; e vivono insieme per vent’anni felici e contenti (tanto più che non si sposano ma ognuno vive per conto suo) finché lei muore e lui resta in vita per poter scrivere Der grüne Heinrich (seconda versione). Insomma: Keller resta uno dei più grandi narratori europei e per certi aspetti addirittura profetico: il suo modo di trattare il tempo precede di un decennio e mezzo il Flaubert dell’Éducation sentimental (1869) e i surrealisti ci metteranno un’ottantina d’anni per raggiungere la sua critica d’arte, senza neanche sapere che Keller l’aveva superata nello stesso romanzo in cui l’aveva formulata. Però quandocumque dormitat bonus Homerus e così del Grüner Heinrich prima versione Keller ha fatto il Grüner Heinrich seconda versione. La colpa della decisione è ovviamente sua; ma c’entra per qualcosa anche un rigurgito di ideale goethiano. 239 Excursus: il Bildungsroman I Wilhelm Meisters Lehrjahre hanno sulla coscienza molte cose; la più grave fra tutte è quella di aver indotto i germanisti a parlare di Bildungsroman. Quando si vanno a vedere le cose in concreto, si vede che agli esempi solitamente addotti per dimostrare l’esistenza di questa categoria mancano le caratteristiche essenziali del prototipo goethiano, le quali sono: una teoria fondamentale e applicata sull’intreccio fra caso e destino; un destino guidato da un’organizzazione mondana ma chiaramente superiore; un romanzo inteso come autoscrittura (il manoscritto che Wilhelm Meister legge sulla torre è il romanzo che il lettore è venuto man mano leggendo); un protagonista incapace di attirare l’attenzione su di sé, tanto scarsi sono i suoi talenti, e a proposito del quale si parlerebbe solo di accidentalità se non ci fosse la società della torre a occuparsi di lui. Tra gli esempi comunemente riconosciuti di Bildungsroman c’è appunto il Grüner Heinrich. Heinrich Lee è un personaggio che come pittore è altrettanto poco dotato quanto Wilhelm Meister lo è come attore; c’è un grande episodio in cui lui stesso lo capisce: è quando mostra un suo quadro a un pittore vero per averne un giudizio e costui, per illustrare la propria critica, traccia sullo stesso motivo uno schizzo in base al quale dipinge poi un proprio quadro; confrontando i due, esposti l’uno di fronte all’altro, Heinrich capisce la differenza fra l’artista vero e il dilettante. Ma il suo dramma concentra su di lui l’attenzione, diversamente da quanto succede con Wilhelm. E inoltre a Heinrich mancano tutte le altre caratteristiche di Wilhelm; è certamente un fallito, e in molte situazioni non più che spettatore o addirittura oggetto di moti che non capisce; ma proprio questo è il tema, proprio questa mancanza di rapporto col mondo. Insomma del modello goethiano resta pochissimo, non più che lo schema di come si comincia col voler diventare una certa cosa e si finisce in tutt’altro modo. A me pare troppo poco e troppo generico. Ma la categoria Bildungsroman si è imposta e quindi è bene tenerla presente. Concetto e prima definizione risalgono in verità al 1870 e ne fu autore Wilhelm Dilthey; poi ne furono tentati vari aggiornamenti. Ecco la definizione che ora si trova in una delle opere di consultazione più in uso: «romanzo al cui centro si trova l’influsso che i beni culturali oggettivi, le esperienze psichiche e l’ambiente personale esercitano sulla maturazione interiore, con conseguente dispiegamento e sviluppo armonico delle attitudini spirituali (carattere, volontà), in vista di una personalità globale, responsabile e umanitaria». Altre definizioni discordano dalla presente per altre accentuazioni, tutte però sono d’accordo in due cose: nel sostenere che il Bildungsroman è una specialità tutta tedesca (qualcuno aggiunge: quella che meglio rende l’animo tedesco) e che i veri e propri Bildungsromane sono assai pochi. Per il periodo cronologico preso in esame nel presente volume sarebbero da considerare i seguenti (oltre a Der grüne Heinrich): Mörike, Maler Nolten; Stifter, Der Nachsommer; Freytag, Soll und Haben; Raabe, Der Hungerpastor. C’è chi ne aggiunge ancora uno o due; ma nel complesso, come si vede, se ne sogliono ricordare proprio pochi. E, per di più, sono Bildungsromane soltanto se i Lehrjahre, sul modello dei quali è nato il concetto, vengono ridotti a quella poca cosa che si diceva, magari completandola così: si parte con grandi ambizioni e ci si ritrova a sistemarsi nella vita borghese. Della cultura tedesca mi sono fatto un’idea più lusinghiera; non 240 riesco a vedere in questa concezione il massimo che essa abbia dato. Lo studente però non tenga conto del mio parere e impari bene le definizioni date; così si sistemerà anche lui. Visto che siamo nella zona delle cattiverie, aggiungiamone un’altra. All’inizio degli anni Cinquanta Keller iniziò un poemetto (che completò e pubblicò molto più tardi): Der Apotheker von Chamounix oder Der kleine Romanzero (Il farmacista di Chamounix ovvero Il piccolo Romanzero); come dice il secondo titolo, Keller prendeva di mira Heine, di cui intendeva parodiare il Romanzero e soprattutto la sua postfazione. Ma con l’occasione dimenticò tre cose: 1. che una parodia deve essere più divertente dell’originale; che una parodia deve far riconoscere l’originale senza ombra di dubbio, ma non deve farlo rimpiangere neanche come genere, oltre che come creazione specifica; che una parodia deve essere godibile anche se non si conosce l’originale, cioè deve avere una sua autonomia. Ma di questi incidenti non faremo poi caso più che tanto. Più o meno parallelamente alla parodia fallita, Keller lavorò a una che non fallì nessuno dei suoi bersagli e risultò una delle sue cose più spiritose, malignamente, anzi (è quasi il caso di dirlo) diabolicamente divertenti: sono le Sieben Legenden (Sette leggende, 1872). Vi si trova una Santa Eugenia, protettrice delle studentesse che non vogliono studiare (sarebbe come dire che un santo è protettore di calzolai che fanno scarpe sfondate); è tutt’intenta a studiare filosofia con due baldi giovani e rifiuta un pretendente che non solo non vuol fare il filosofo ma nemmeno apprezza la voglia della sua amata di avere gli uomini a mazzi di tre per volta (naturalmente la vincerà lei, dopo alcune boccaccesche vicende); San Vitale è specialista nel convertire prostitute, finché ci prende un po’ troppo gusto e si lascia convertire lui; Santa Dorothea sembra una che in vita, professando religione, ami le pratiche sado-maso, ma in cielo se la spasserebbe niente male col suo Teofilo, se non le capitasse la disavventura di andare a finire nella casetta della Santissima Trinità e di addormentarvisi. Quanto alla Madonna, una volta si mette a far la lotta col diavolo stringendolo più che può, un’altra regge il bordone a una monaca che si è stufata del convento e scappa per cercarsi un marito e far figli, dopodiché, stufatasi di marito e figli, ritorna in convento come se niente fosse. La lettura di queste leggende (nate effettivamente come parodia di uno zuccheroso libro devoto) è vivamente da sconsigliare a chi non abbia il gusto della malignità, mentre le lettrici più adeguate sono presumibilmente le fanciulle che siano state a scuola dalle Orsoline e simili, perché saranno le meglio preparate a capire le allusioni e le intenzioni blasfeme dell’autore. Ai germanisti che vogliono restar seri si può invece dire che Keller intendeva combattere un cristianesimo inteso come nemico della gioia dei sensi; ciò appare con particolare eviden241 za nell’ultima leggenda, quando i santi e i beati in paradiso scoppiano in un pianto dirotto rimpiangendo le gioie della terra e deve intervenire la Santissima Trinità in persona a farli star zitti con un bel tuono minaccioso e a cacciar le Muse, che avevano suscitato quel rimpianto. In un lungo lasso di tempo (1856-1874) Keller scrisse e pubblicò i dieci racconti di quella che è la sua raccolta più nota e importante, Die Leute von Seldwyla (Gli abitanti di Seldwyla). Seldwyla è il nome di una cittadina inventata, tra le cui mura Keller raccoglie quel che ritiene più importante della sua Svizzera. Prima ancora di descriverla è il caso di richiamare l’attenzione su un fatto importante: Keller non riteneva di far parte della letteratura svizzera, per la semplice ragione che non ammetteva l’esistenza di una letteratura svizzera. L’esistenza di una nazione svizzera (fondata sulla peculiarità dell’esperienza federale) e di un patriottismo svizzero (legato alla necessità di difendere quell’esperienza e il suo territorio) erano per lui valori al disopra di ogni discussione; ma di una letteratura svizzera non era assolutamente il caso di parlare perché avrebbe significato isolamento culturale. Ecco che cosa fa dire in proposito dal verde Enrico: Ci sono [...] molti dei miei connazionali che credono in un’arte e in una letteratura svizzera, persino in una scienza svizzera. Ma il rosseggiare delle Alpi e la poesia delle rose alpine sono presto esaurite, quelle poche battaglie belle vengono presto cantate, e così nelle feste pubbliche, con nostra vergogna, dobbiamo prendere tutti i brindisi, i motti e le iscrizioni del Tell schilleriano, che fornisce sempre il materiale più adatto alla circostanza. Per quanto riguarda la scienza, poi, essa ha senz’altro bisogno anche di più del grande mercato mondiale e in primo luogo dei popoli maggiori affini per lingua e spirito, se non vuole perdere la battaglia. Lo Svizzero francese è fedele a Corneille, Racíne e Molière, a Voltaíre o Guizot, a seconda del suo partito; il Ticinese crede solo nella musica e nella cultura italiane; lo Svizzero tedesco li deride entrambi e attinge la propria formazione dai pozzi profondi del popolo tedesco. Tutti però si sforzano di riportare ogni cosa, impegnandola unicamente a maggior gloria della loro terra, e molti addirittura esagerano in questo loro proposito, finendo con l’onorare usanze antiquate in modo impensabile e ridicolo, contrario alle loro stesse fonti. [...] noi non possiamo certo isolarci! Per una buona esistenza patriottica ci vogliono in ogni tempo lo stesso numero di membri che ci sono ora, né più che meno. Per le questioni culturali è diverso; in questo caso è necessario il maggior numero possibile di buone idee, ed è fuor di dubbio che in quaranta milioni di teste ne nascano di più che in due milioni soltanto! I caratteri di Seldwyla vengono dati da due prefazioni, da un racconto programmatico (Frau Regula Amrain und ihr Jüngster, La signora Regula Amrain e il suo figlio minore) e da alcune annotazioni specifiche sparse in altri racconti. L’impostazione generale è che la città conta più della campagna, l’imprenditore più dell’agricoltore. L’idillio non c’è in nessun dove; al massimo esso si lascia collocare in alcuni momenti della vita, e precisamente negli amori infantili, di 242 cui Keller è grandioso osservatore. I suoi svizzeri (o, se si preferisce, gli abitanti della sua Seldwyla) sono litigiosissimi, sia fra di loro sia con le città o i cantoni vicini; politicamente, poi, sono assai “mobili”, almeno in un primo tempo. Successivamente diventano menefreghisti, pensando solo ad arricchirsi attraverso speculazioni; ma questo sarà il tema specifico del secondo e ultimo romanzo di Keller, Martin Salander. Anche i cittadini di Seldwyla ricevono da Keller il compito di arricchirsi; ma col lavoro assiduo e onesto; pare che non ci riescano troppo, che la loro propensione al lavoro lasci a desiderare e la loro applicazione abbia del dilettantesco. Come si vede, Keller è molto critico; però riconosce ai suoi cittadini almeno la mancanza di due vizi: non sono fanatici (come dimostrano nel contrasto con la vicina città di Ruechenstein in Dietegen) e non sono ipocriti (Die drei gerechten Kammacher, I tre giusti pettinai), perciò riescono a convivere e a sopravvivere. Per il resto, sono un concentrato di tutti i vizi, tanto che Keller non resiste a dettare saggi ammonimenti, a predicare la virtù, a fare il Nestore morale (Frau Regula, La signora Regula): occorre essere tolleranti e non andarsi a immischiare, specie con la forza, nelle faccende politiche di cantoni altrui; occorre essere morigerati e costumati, liberali e non qualunquisti; i lavori vanno affidati a persone competenti, e chi non ne capisce ne stia fuori. I dieci racconti (non tutti dello stesso valore) svariano dall’umoristico al tragico e presentano una grande varietà di personaggi e situazioni. Tra queste vanno ricordati quegli amori infantili cui già si è accennato, con la loro gamma di manifestazioni, che vanno dalla tenerezza, alla crudeltà (c’è in Romeo und Julia auf dem Dorfe (Romeo e Giulietta del villaggio) un’indimenticabile scena in cui viene sventrata una bambola), alla tirannia (che in Dietegen viene esercitata dalla piccola Küngolt ai danni dell’eroe eponimo). Keller s’è scatenato in una serie di ritratti muliebri negativi: l’intrigante Violande in Dietegen, mentre due figure mostrano calcolo e aridità di cuore in Spiegel das Kätzchen (La gattina Specchio, è un racconto a cornice, in cui è avida e arida la donna del racconto interno, che però è falso, mentre è una calcolatrice e una tiranna domestica la strega-beghina del racconto esterno). Misteriosa ma occhiuta è la donna di Der Schmied seines Glückes (L’artefice del suo destino), che senza dire una parola ma solo - si può dire mangiando e dormendo seduce un avventuriero che voleva accaparrarsi un’eredità, contrabbanda come figlio del marito quello che invece ha avuto dall’altro e così si assicura la permanenza in casa e la ricchezza, mentre l’avventuriero viene cacciato ignominiosamente. Ma gli uomini non se la cavano meglio delle donne. La (per quei tempi) non più giovanissima signorina Züs Bünzlin (Kammacher) ha un suo parallelo in Viggi Störteler (Die mißbrauchten Liebesbriefe, Lettere d’amore mal usate): questi è un commerciante al quale non mancherebbe niente se non si ostinasse a fare lo scrittore da strapazzo; lei è una dalla cultura approssimativa, ma vanesia e calcolatrice, cui Keller mette in bocca discorsi tanto insensati quanto presuntuosi, paralleli alle lettere sconclusionate, ma con pretese letterarie, che Viggi scrive alla moglie con l’intento di provocar243 ne risposte analoghe, così da poter pubblicare tutto il carteggio sotto lo pseudonimo di Kurtalwino. Entrambi vengono puniti. La moglie di Viggi, Gritli, incapace di scrivere quelle porcherie, intesse col povero maestrino Wilhelm una fittizia corrispondenza, che poi ricicla al marito. Scoperta per caso la faccenda, questi reagisce furiosamente e si arriva al divorzio; la punizione maggiore pare tuttavia essere non lo scorno ma il venir Viggi accalappiato da un’anima gemella, un’attricetta di provincia. L’ingenuo Wilhelm però è rimasto scottato e l’autore gli fa passare un lungo tempo in solitudine ed espiazione (forse per aver scritto nello stesso stile di Viggi) prima di unirlo a Gritli. Anche Züs Bünzlin viene punita in qualche modo. Dei tre uomini che gareggiano contemporaneamente per la sua mano e per un negozio, lei vuole assolutamente escludere uno dalla gara, perché è il meno dotato finanziariamente. Costui però è dotato su altri piani e mentre lei crede di poterlo trattenere dalla gara facendogli un po’ di moine, ne fa qualcuna di troppo e, moina dietro moina, si lascia sedurre. Gli altri due concorrenti hanno intanto sbagliato gara (in questo molto ben aiutati da tutta la popolazione di Seldwyla), così al terzo resta il negozio e quella moglie. Così scopriamo che il vero punito è lui. Ci sono però anche donne che arrivano a salvare delle situazioni: tale è Nettchen (Kleider machen Leute, L’abito fa il monaco): una serie di equivoci ha indotto a credere che il povero sartorello Wenzel Strapinski sia un conte polacco. Ciò gli procura vari vantaggi e una fidanzata, la quale, quando verrà scoperta la vera identità di Wenzel, gli rimarrà fedele sulla base del seguente ragionamento: Che cosa sono la felicità e la vita? Da che cosa dipendono? Che cosa siamo noi, se diventiamo felici o infelici per una ridicola bugia da carnevale? Che colpe abbiamo commesso da guadagnarci disonore e disperazione a causa di un’inclinazione lieta e fiduciosa? Chi ci invia banali miraggi che ci distruggono la vita mentre loro stessi svaniscono come deboli bolle di sapone? I racconti fin qui ricordati hanno fondamentalmente carattere umoristico (questo è meno vero per Dietegen, che tocca un po’ tutti i sentimenti) e sono ottimamente riusciti (non voglio tacere la mia preferenza, che va allo Schmied). Fuori da questo quadro è il racconto Romeo und Julia, una tragedia dell’avidità, che travolge prima i litigiosi protagonisti e poi i loro figli; è una delle vette più alte raggiunte dall’arte di Keller. Qui però il tema economico è introduzione e condizione per una tragedia d’amore, sfociante nel doppio suicidio degli amanti. Più spazio gli tocca in Das verlorene Lachen (Il ridere perduto), un racconto sovraccarico (Keller stesso riconobbe che avrebbe dovuto piuttosto ricavarne un romanzo), in cui si parla anche di religione, filosofia, politica e altre cose ancora. Non mancano belle pagine; soprattutto notevole che dalle crisi commerciali internazionali, così come dalle truffe in commercio e dalle speculazioni senza scrupolo, Keller abbia saputo ricavare grandi scene. Ma c’è veramente troppo; l’orizzonte di Keller si allargava mentre la mano si veniva stancando. 244 Il racconto venne scritto nel 1872-73. Una dozzina d’anni dopo il tema dell’economia si imporrà in un romanzo, il già ricordato Martin Salander (1886). Non è la migliore opera di Keller: dopo un buon inizio, c’è una lunghissima fase di stanca, per prendere finalmente un colpo d’ala nella terza e ultima parte. Keller non è più lo stesso ma anche il mondo intorno a lui è cambiato; i modesti speculatori di Seldwyla sono diventati ben altro. Del resto, il romanzo è bensì ambientato in Svizzera ma riguarda dichiaratamente una realtà ben più vasta (cosa che Keller indica - forse un po’ goffamente, non essendo ormai sempre padrone dei migliori mezzi espressivi - ripetendo più volte che tutto il mondo è paese). Nella vicina Germania questa è l’epoca dei Gründerjahre, e lì si vede al meglio (cioè anche al peggio) che cosa sia quel capitalismo d’assalto, praticato un po’ dovunque (Italia compresa). Esso va di pari passo col cinismo: due gemelli decidono di entrare in politica e, per avere maggiori probabilità, di iscriversi ognuno a uno dei due partiti maggiori; poiché ciascuno è indifferente a quale, se li giocano a dadi. I piani pedagogici che Martin Salander concepisce per opporsi allo sfascio morale sono ingenui quanto utopici e la moglie lo prende adeguatamente in giro. A un certo punto tutto crolla: nel giro di poche pagine, che sono l’acme del romanzo, l’immenso imbroglio, in cui si mescolano pubblico e privato, viene alla luce, svelando anche la sua raffinatezza, la laboriosità e l’immensa ragnatela di complicità. Ed esso, nonostante le pagine moderatamente concilianti e ottimistiche del finale, appare inarrestabile poiché i protagonisti di questa tangentopoli cosmica non mostrano né pentimento né vergogna; uno di loro pensa addirittura di uscirsene in pubblico con un libro dal titolo “Sulla violazione dei doveri nella vita pubblica e sociale; cause e rimedi considerati dal punto di vista di un’autocoscienza. Saggio di pedagogia sociale”. Ricompare per l’occasione anche un cosiddetto amico di gioventù che per due volte ha spogliato il protagonista di tutti i suoi averi e che ci proverebbe ancora col figlio. Gli va male, però consente a due spettatori di augurare al padre un’altra bella musata, magari non rovinosa come la prima, perché si renda conto di quanto sono inconcludenti i suoi piani da salvatore del mondo. Keller andrebbe sottratto alla germanistica per restituirlo alla lettura. La germanistica è stata capace di preferire Der grüne Heinrich nella seconda versione, che riesce a sciupare (ma in germanistico si dice: equilibrare) la prima. Si deve inoltre agli sforzi congiunti dei germanisti se si sono trovati insospettabili pregi nella seconda raccolta di Keller, le Zürcher Novellen (Novelle zurighesi, 1876-78), nelle quali con stile sussiegoso vengono esposti in forma narrativa importanti eventi della storia passata e vengono date grandi quantità di informazioni etnologiche, tante che avrebbero fatto invidia a Gotthelf, ma di ambientazione urbana invece che campagnola. Seguì una terza e ultima raccolta, Das Sinngedicht (L’epigramma, 1881), a lungo celebrata per il rapporto tra cornice e racconti; poi, passato fra i germanisti questo esercizio, si è cominciato a guardare più da vicino i singoli racconti che sono di discreto intrattenimento; due anzi (Don Cor245 rea, Die Berlocken - Don Correa, I ciondoli -) contengono nobili pagine in cui si parla chiaro sul colonialismo e sul mito del buon selvaggio. Ma la fama di Keller non è certo affidata al Sinngedicht, alle cui novelle manca concentrazione e capacità di conduzione verso l’acme, che si rivela sempre piuttosto debole. Sorprende poi che Keller non evidenzi certi temi che sembrano più suoi; per esempio in Regine il tema della sensualità che si sveglia in una giovane donna (spaventando il marito) non arriva a costituire il centro, soffocato com’è da altri, che in realtà ne dipendono. La ragione per cui Keller non può essere considerato parte di una letteratura svizzera è perché non ne ammette l’esistenza. Ma i suoi riferimenti sono concreti e attengono a quella realtà che conosce meglio, cioè appunto alla Svizzera. Nei Kammacher viene commentata la seguente frase: la patria è dove si sta bene. Ha diritto a dirla, scrive l’autore, chi è costretto a emigrare: la patria vera e propria in un certo senso lo caccia e l’emigrante è impegnato a costruirsi un ambiente umano e materiale lì dove emigra e dove cercherà di trovarsi bene; ma in altri casi quella frase indica solo mancanza di riferimenti affettivi e morali. Nel racconto in questione frase e commento servono a caratterizzare personaggi che intendono piazzarsi a Seldwyla proprio per quelle mancanze. Questo è uno dei momenti (dato per negazione) dei condizionamenti sociali, psicologici e storici in base ai quali i personaggi in generale vivono oppure subiscono le loro azioni e conseguenze. In Romeo und Julia gli innamorati vivono la loro tragedia percorrendo passo passo il processo di un regolare fidanzamento e nozze borghesi; il percorso avviene, per così dire, per citazione: i due (ma soprattutto la ragazza) cercano di figurarsi una normalità di situazione mentre hanno già deciso di andare incontro alla morte; hanno però bisogno di un’immagine concreta di felicità e all’immaginazione si offre solo ciò che appartiene all’ambito di esperienza dei due. Nelle situazioni umoristiche le cose non vanno in maniera sostanzialmente diversa. Lo Johannes Kabis (in italiano: Giovanni Cavolobianco) dello Schmied che crede di sedurre la bella mangiante e semidormiente mentre in realtà ne viene sedotto e incastrato, agisce in quel modo perché così si fa; solo che gli eventi lo sorpassano. Un po’ come succede alla Gritli e al Wilhelm dei Liebesbriefe: lei crede di usare bene l’astuzia femminile e di poterlo fare impunemente; ma gli avvenimenti le scappano di mano in due modi: perché viene scoperta e perché s’innamora sul serio. Il condizionamento sociale emerge in tutti i personaggi del ciclo di Seldwyla e non solo in quelli. Ciò convive con la presa di posizione diretta dell’autore nei loro confronti ma anche con descrizioni dal valore simbolico; quindi nei Kammacher Keller da una parte può sostenere che sul petto di Züs Bünzlin si sarebbe potuto scrivere, tanto era piatto, dall’altra descrivere il percorso di una cimice sulla parete come premonizione della sorte dei garzoni. L’umorismo a sua volta può convivere con tutt’altro: in Kleider machen Leute con l’autocritica delle romanticherie da parte di un personaggio, nei Liebesbriefe con scene di indignazione au246 tentica, nei Kammacher con scene di incubo e desolazione. Non c’è una letteratura svizzera, ma è comunque dalla concretezza della sua Svizzera che Keller attinge. 247 248 IV Troppo a tempo - fuori del tempo 249 250 Nel 1877 erano in circolazione 200000 copie delle poesie di Ludwig Uhland e altrettante del Buch der Lieder di Heine. Oggi nessuno legge più Uhland; e sì che era il più significativo dei poeti della scuola sveva. La quale si è trovata in una situazione estremamente singolare. Centro della scuola sveva veniva considerato Justinus Kerner; casa sua accolse molti fra i personaggi più importanti dell’epoca, quali Tieck, Rückert, Freiligrath e altri. Gli altri appartenenti alla scuola erano Gustav Schwab, Ludwig Uhland e un quarto, oggi ancora più dimenticato, Karl Mayer. Erano tutti molto colti, molto dentro l’attività culturale dell’epoca, in contatto con Goethe, E.T.A. Hoffmann e tanti altri, intenti a collaborazioni con Fouqué e Chamisso, in contatti strettissimi con Mörike (che può essere considerato membro aggiuntivo della loro scuola), con Lenau e altri ancora; Kerner, Schwab e Uhland ebbero grandi meriti nel rilancio della poesia di Hölderlin (il poeta, alloggiato per tanti anni nella sua famosa torre a Tübingen, ricevette numerose loro visite). Si presentano ufficialmente come scuola sveva nel 1812. Kerner era medico e spiritista, Schwab era un filosofo classico che ebbe grande parte nella diffusione di rinarrazioni di mitologia classica, Uhland fu giurista, filologo, etnologo e uomo politico. Insomma una costellazione umanamente e culturalmente interessante. Li si potrebbe assimilare, perfino senza forzature cronologiche, ai romantici Schubert (lo studioso dei lati oscuri delle scienze naturali), a Creuzer (lo studioso della mitologia), a Eichendorff (giurista, oltre che poeta). Tutto questo per dire che non erano isolati e non erano nati fuori tempo. Eppure Heine ebbe modo di chiamarli dei morti viventi. Heine esagerava, forse? Di certo anche Goethe fu assai freddo nei confronti di Uhland. Il quale ebbe grande importanza nella formazione di quella grande poetessa che fu Annette von Droste-Hülshoff (1797-1848); e intorno ai tre poté gravitare non incompreso un altro poeta autentico quale Mörike. Infine: tutti e tre hanno scritto poesie per niente brutte, alcune anzi pregevoli. Eppure quel giudizio di Heine non era campato in aria: i tre non apportavano niente di nuovo, ripetevano soltanto, e per di più quando non era più il tempo di ripetere. Ma tutto ciò è paradossale! Il romanticismo non era morto: Eichendorff e Bettina von Arnim erano lì, vivi e vegeti, a dimostrare il contrario; per non dire di Creuzer e di Jakob Grimm. Ce la caveremo dicendo che gli svevi erano meno dotati? Non basterebbe: se erano meno dotati, non erano certo degli incapaci. Non si può nemmeno dire che contro gli svevi abbiano congiurato delle circostanze avverse: in vita conoscevano tutti ed erano ben piazzati anche nel settore dell’editoria; e poi, come già detto, secondo una ricerca condotta nel 1877 Uhland e Heine godevano in misura pari del favore del pubblico. C’è dunque da chiedersi che cosa è successo dopo, ma anche che cosa è successo fin da subito: che cosa cioè abbia fatto apparire quei poeti come spiazzati fin da subito. Aggiungiamo, per completezza, che qualche loro poesia ha attirato l’attenzione dei più noti compositori di Lieder; ma sappiamo tutti che in questi casi è in primo luogo il musicista a interessare, mentre gli autori delle poesie li si riapprende 251 spesso di volta in volta dai programmi di sala e che dunque questa via assicura una sopravvivenza molto problematica. Gli svevi proseguivano la tradizione romantica. Ma di ciò non pare si sentisse molto il bisogno: al presentarsi come scuola, ci si sarebbe aspettato che portassero una parola nuova, il che non avvenne. Era una parola seria e solida, ma già nota. Il grande successo che ebbero, finché lo ebbero, era dunque un successo di seconda battuta, quale potevano averlo dei romantici molto meno impegnativi dei romantici di Jena, di Berlino o di Heidelberg. Il romanticismo, poi, era sconfinato nella Trivialliteratur, finendo con l’essere tutt’altra cosa, ma soprattutto essendo orecchiabile. Forse Uhland dovette il suo lungo, grande successo anche a questo accostamento; e chissà che questo stesso equivoco non spieghi almeno in parte il successo di Heine col suo Buch der Lieder. Ma certamente gli equivoci finiscono verso la fine del secolo con l’avvento del simbolismo; allora la pietra di paragone diventò un’altra, lo spartiacque venne ritracciato. Uhland non sopravvisse; Heine, dopo alterne vicende, durate decenni, venne infine riletto al di fuori del romanticismo. La scomparsa di Uhland è stata pacifica, la sopravvivenza di Heine è stata oggetto di aspri contrasti. IV, 1. Eduard Mörike (1804-1875), vicinissimo ai poeti svevi però mai identificato con loro, diede risultati importanti nella poesia dal 1822 al 1863, dunque per oltre quarant’anni. Lo spettro delle sue esperienze liriche è molto ampio; l’originalità con la quale sviluppò i temi di più tradizioni e la sicurezza con la quale affrontò e risolse problemi formali, a volte fondando a sua volta nuove tradizioni, dovrebbe emergere dall’analisi di alcune sue poesie, che ora seguirà. Ecco, come prima, la seguente: Auf eine Lampe Noch unverrückt, o schöne Lampe, schmückest du, An leichten Ketten zierlich aufgehangen hier, Die Decke des nun fast vergeßnen Lustgemachs. Auf deiner weißen Marmorschale, deren Rand Der Efeukranz von goldengrünem Erz umflicht, Schlingt fröhlich eine Kinderschar den Ringelreihn. Wie reizend alles! lachend, und ein sanfter Geist Des Ernstes doch ergossen um die ganze Form Ein Kunstgebild der echten Art. Wer achtet sein? Was aber schön ist, selig scheint es in ihm selbst. 252 A una lampada Non ancora rimossa, o bella lampada, tu adorni, / a catenelle qui graziosamente appesa, / la volta dell’elegante sala / quasi oramai dimenticata. / Sopra l’incavo del tuo marmo bianco, / che intreccia ai bordi il serto / d’edera verde e dorato nel metallo, / lieti puttini a schiera cingono la ronda. / Che fascino per tutto! ridente e un mite spirito / però di serietà profluso in questa forma. - / Un manufatto schietto d’arte. Chi lo cura? / Ma quel ch’è bello, beato appare in sé. Scritta e pubblicata nel 1846, questa poesia viene considerata l’archetipo di una forma lirica detta Dinggedicht, illustrata nel seguente modo in un lessico di frequente consultazione: nel presentare l’oggetto e soltanto l’oggetto, la forma linguistica deve già dare un’interpretazione di quella cosa-essenza; il senso nascosto e parlante della cosa deve irrompere da solo nella forma linguistica. Insomma: niente commenti, niente stati d’animo, ma nemmeno descrizione puramente esteriore; una cosa viene presentata perché ha un senso e un’essenza, e questi devono apparire senza mediazioni. La citata poesia di Mörike sta ancora agli inizi della storia del Dinggedicht (anzi è essa a iniziarla) e vi si vede ancora un residuo di reazione secondo sentimenti personali; ma è non più che un residuo. La lampada non è ancora stata rimossa: il che lascia intuire che presto lo sarà. Ma, ancora al suo posto, dovrebbe ricordare la funzione che aveva: quella di far luce; di questa invece non si parla: non si parla della lampada se non per ricordarne la bellezza; è appesa al soffitto come da funzione, ma non illumina nulla; decora, invece. Non importa tanto che sia appesa al soffitto quanto che lo sia «gradevolmente». È dunque una seconda funzione la sola a essere ricordata, quella decorativa. La lampada si trova (ancora) in un Lustgemach, cioè in una stanza sontuosamente arredata per un piacevole intrattenimento. Ma nemmeno il piacevole intrattenimento c’è più perché anche il Lustgemach è quasi dimenticato; sembra però che resti qualcosa del suo arredamento: almeno la lampada, sebbene ancora per poco. Dunque anche in questo caso di due caratteristiche - assetto (arredamento sontuoso) e destinazione (piacevole intrattenimento) - ne resta una sola: la lampada non fa più luce, l’intrattenimento non c’è, resta l’aspetto decorativo. Il Lustgemach è «quasi» dimenticato del tutto; ci si ricorda che lì un tempo ci si intratteneva? O ci si ricorda del bell’arredamento, almeno quel tanto che basta per ricordarsi di portare via tra poco la lampada? Questa distinzione non viene fatta: con l’oblio le distinzioni tendono a svanire. Comunque - così si evince dal contesto - quasi nessuno capita più qui o, se ci capita, lo fa sbadatamente (Wer achtet sein?). Ecco però che in quest’oblio e in questa vaghezza qualcosa sembra reclamare attenzione e precisione: la bella lampada. Essa ha forma, colori, materiali diversi, particolari figurativi che tendono addirittura a 253 raccontare una storia. Su marmo, metallo, edera e puttini veniamo informati attraverso uno sguardo preciso e circostanziato. Ma quanto veniamo in realtà a sapere? E quanto preciso è il nostro sapere? Si allude a Dioniso con l’edera e c’è qualche cenno amoroso attraverso i puttini? Oppure quel verde-oro mette insieme arte e natura senza raccontarci troppa mitologia e senza troppe allusioni? Dioniso e puttini alludono al passato uso del Lustgemach oppure non ci dicono niente in proposito? Lo sguardo preciso è lo sguardo che arriva dopo l’oblio o almeno quando - quasi dimenticato il Lustgemach - lo sguardo stesso può essere tanto preciso quanto esterno. Esso non può dirci più di quanto vede: una dimensione resta sempre e comunque tagliata fuori. Questa sembra essere la condizione affinché la forma compaia nel suo fascino e nella sua quieta e dolce serietà. La fine dell’intrattenimento, la fine della funzione, l’oblio permettono di ricordare - e indirettamente - una sola presenza umana: quella dell’artefice del manufatto d’arte. Ma neppure lui compare: compare solo il suo prodotto. E non compare di fronte a un gruppo di persone intente a intrattenersi, per le quali non sarebbe comparso affatto se non a sua volta come decorativa fonte luminosa. La lampada è solo bella, ora che non serve più e che è agli ultimi istanti della sua posizione funzionale, peraltro non attivata, di fonte luminosa. «Ma ciò che è bello splende beato in sé.»; in Faust II, 7403, qualcosa di simile dice Chirone a proposito di Elena: «Die Schöne bleibt sich selber selig» (nella traduzione di Franco Fortini: «Sta beata di sé la bellezza»). Bellezza, felicità e irraggiamento sembrano venire anch’essi sulle soglie di un ricordo: il ricordo di una citazione. Perché ci sia ricordo deve esserci stato un oblio. È a Elena che si allude, al simbolo della bellezza che riassume un mondo: un mondo a sua volta della bellezza e delle sue crudeltà. Il ricordo è un ricordo di civiltà ma anche un ricordo erotico. Anch’esso però ha perso una dimensione, come tutto ciò che precede: ha perso la donna. Restano la bellezza, la felicità e lo splendore, ma solo in sé. È però questa perdita che ci permette di vedere nella lampada la dimensione di opera d’arte. Quell’«in sé» risponde a due cose: alla perdita di una funzione vitale, di un essere per altro e per gli altri, e allo svelarsi (ma fondamentalmente a sé) della cosa come cosa d’arte. La cosa «in sé» c’è quando è dimidiata ma al tempo stesso ci sia una traccia evidente del suo passato vitalistico. Senza forza vitale non c’è cosa, ma nemmeno ce n’è in presenza della forza vitale. La cosa «in sé» non è un ricordo, non è ricostruzione di una storia; ma ha bisogno di un supporto materiale (marmo, metallo) che suggerisca la possibilità di ricostruire quella storia (ci interpreti l’edera e i puttini) e tuttavia non ci consenta di costruirla realmente poiché lo sguardo resta esterno; tutto ciò è possibile solo se l’oblio non è calato totalmente su quella storia e su quella funzione, almeno non tanto da non renderci sicuri che la forza vitale è stata lì. La cosa «in sé» è una cosa-soglia. L’osservatore della cosa-soglia non se ne appropria, anzi la stacca da sé poiché essa splende solo in se stessa. Il suo sguardo è preciso ma non completo, 254 però reso possibile solo dall’intuizione di una passata completezza. La sua comunicazione è circostanziata, però quello della completezza è solo un suggerimento vago, non colmo di contenuto. Il veicolo che al tempo stesso unisce e divide cosa «in sé» e osservatore è quello della forma. Grazie a questa l’osservatore riconosce la cosa come cosa «in sé», però solo nell’ambiente in cui in passato non era riconosciuta come tale, da cui sta per essere allontanata e in cui nessun altro la vede, né per quella che è né - dunque - in assoluto. Ciò che è sulla bella lampada è «ridente»; difficilmente ci si potrebbe aspettare tristezza da cosa destinata a un Lustgemach; ma sembra che sia «ridente» perché «affascinante», cioè in virtù della forma. La funzione viene sempre di nuovo allusa e sempre di nuovo espunta. La cosa si fa visibile quando quasi non c’è più nessuno a vederla, quasi non fa più nessuna delle sue funzioni (e comunque non la principale), quasi non la si capisce più. Allora è tutta materia e tutta forma e permette di costruire il sistema illusoriamente completo del suo essere «in sé», ma dichiarando con ciò, tramite l’osservatore, che essa non è lì per l’osservatore. Questa cosa, ai bordi del vitale e all’ultimo sprazzo della sua vita appena cominciata, è un prodotto dell’arte. Difficilmente potrà esserci più di una volta. Dell’anno precedente, 1845, è la seguente poesia: Auf einer Wanderung In ein freundliches Städtchen tret ich ein, In den Straßen liegt roter Abendschein. Aus einem offnen Fenster eben, Über den reichsten Blumenflor Hinweg, hört man Goldglockentöne schweben, Und eine Stimme scheint ein Nachtigallenchor, Daß die Bluten beben, Daß die Lüfte leben, Daß in höherem Rot die Rosen leuchten vor. Lang hielt ich staunend, lustbeklommen. Wie ich hinaus vors Tor gekommen, Ich weiß es wahrlich selber nicht. Ach hier, wie liegt die Welt so licht! Der Himmel wogt in purpurnem Gewühle, Rückwärts die Stadt in goldnem Rauch; Wie rauscht der Erlenbach, wie rauscht im Grund die Mühle! Ich bin wie trunken, irregeführt O Muse, du hast mein Herz berührt Mit einem Liebeshauch! 255 In viaggio M’aggiro per le vie / d’una piccola amabile città / che nel rosso tramonto tutta splende. / Una finestra schiudesi, / traboccante di fiori; ne discende / un tintinnare d’oro, / ed una voce che somiglia un coro / di notturni usignuoli; i fiori tremano, / s’avviva l’aria, le vermiglie rose / più luminose brillano. // A lungo resto attonito, / di meraviglia oppresso e di piacere. / Com’io sia fuori della porta uscito / non lo so neppur io. Così lucente / è il mondo in questa parte! Il cielo ondeggia / in purpureo tumulto; alle mie spalle / si avvolge la città d’aurei vapori. / Come soave mormora il ruscello / sotto gli ontano, come romoreggia / il mulino laggiù! / Son com’ebbro e smarrito. O Musa, tu / hai toccato il mio cuore / con un soffio d’amore. Una doppia dislocazione si accompagna a una cancellazione. Ciò che potrebbe essere preciso diventa vago, ciò che dovrebbe essere impalpabile tende a materializzarsi. Chi canta resta invisibile; è un uomo, una donna? All’inizio non sembra nemmeno un essere umano, sono tocchi di campana; forse questa è una metafora, ma la struttura della frase non lo dice con chiarezza. Possiamo immaginare che canta una donna se pensiamo al quadro sociale dell’epoca e se decidiamo di interpretare quei tocchi di campana senz’altro come metafora: la voce argentina è o di donna o di bimbo. Niente però ce lo assicura dall’interno della poesia. Questa voce così ben nascosta ha un effetto fisico: fa vibrare i fiori, vivere l’aria, addirittura ravviva il colore delle rose. Il rosso di sera, al contrario, dovrebbe essere impalpabile; e invece viene descritto come cosa quasi materiale: come oggetto fra gli oggetti, esso giace sulla strada, che il viatore calpesta. Il contatto fisico col tramonto è spinto quanto più in là si può. Materiale e non materiale tendono a scambiarsi di posto. Questo spostamento generale ha influsso sul tempo: il viatore resta fermo a lungo. Eppure non resta affatto fermo se di punto in bianco lo ritroviamo fuori della cittadina. Il mondo si è riassestato per il meglio, fuori è tutto bello e luminoso mentre la città lasciata brilla in un vapore dorato. E alla fine l’invocazione alla musa. Dunque l’attimo è stato ricostruito nella poesia. La ricostruzione coglie l’attimo, lo allunga nel tempo (il viatore sosta a lungo) ma lo conserva come attimo, cioè lo scioglie dalla catena temporale e lo allontana: non è più presente se non nella ricostruzione. Abbiamo qui la chiave degli spostamenti precedenti; l’attimo è stato ricostruito, è divenuto un tempo che non è tempo: così l’immateriale può diventare materiale e ciò che potrebbe essere identificabile con parametri certi è stato respinto nel vago. Tutto diventa la realtà della realizzazione poetica. Sua condizione è la non rigidità degli elementi. L’attimo stesso è tale nella sua estrema debolezza di essere. Ciò viene confermato da una poesia che Mörike volle mettere in testa alla sua raccolta, un po’ come manifesto: An einem Wintermorgen, vor Sonnenaufgang (In un mattino d’inverno prima dell’alba). L’attimo lì rappresentato è sospeso tra il 256 ricordo e la speranza; anzi il ricordo neanche riesce realmente a formarsi, restando incerto e vago; altrettanto incerta è la realtà esterna. L’attimo non ha altro contenuto che se stesso e la sua essenza consiste nel rompere la successione temporale. Sembra che questa caratteristica dell’attimo sia identica alla gioia. Tale prospettiva non ridefinisce il tempo; essa lo scompone, lo predilige nella sua discontinuità e lo svuota di ogni contenuto che non sia il tempo stesso; questo svuotamento è gioia. Celebre, forse fra tutte le liriche di Mörike, è il ciclo di Peregrina (1824-28, con una complicata storia di varianti). Esso si divide in cinque parti, molto diverse tra loro per forma metrica e linguaggio: la storia è dunque messa in movimento già dal variare di queste grandezze. Ne cito alcuni versi della seconda parte e il sonetto conclusivo: II Aufgeschmückt ist der Freudensaal. Lichterhell, bunt, in laulicher Sommernacht Stehet das offene Gartengezelte. Säulengleich steigen, gepaart, Grün-umranket, eherne Schlangen, Zwölf, mit verschlungenen Hälsen, Tragend und stützend das Leicht gegitterte Dach. Aber die Braut noch wartet verborgen In dem Kämmerlein ihres Hauses. Endlich bewegt sich der Zug der Hochzeit, Facklen tragend, Feierlich stumm. Und in der Mitte, Mich an der rechten Hand, Schwarz gekleidet, geht einfach die Braut; Schön gefaltet ein Scharlachtuch Liegt um den zierlichen Kopf geschlagen. Lächelnd geht sie dahin; das Mahl schon duftet. V Die Liebe, sagt man, steht am Pfahl gebunden, Geht endlich arm, zerrüttet, unbeschuht; Dies edle Haupt hat nicht mehr, wo es ruht, Mit Tränen netzet sie der Füße Wunden. 257 Ach, Peregrinen hab ich so gefunden! Schön war ihr Wahnsinn, ihrer Wange Glut, Noch scherzend in der Frühlingssturme Wut, Und wilde Kränze in das Haar gewunden. Wars möglich, solche Schönheit zu verlassen? - So kehrt nur reizender das alte Glück! O komm, in diese Arme dich zu fassen! Doch weh! was soll mir dieser Blick? Sie küßt mich zwischen Lieben noch und Hassen, Sie kehrt sich ab, und kehrt mir nie zurück. II // Decorata è la gioiosa sala. / Rilucente, gaietto, nella tiepida notte dell’estate / sta l’aperto padiglione. / Come colonne salgono a coppie / avviticchiate serpi di metallo, / dodici con colli attorcigliati, / reggono e sospendono leggera / la testura del tetto. // Ma nascosta la sposa aspetta ancora / nella cameretta in casa sua. / Ecco si muove alla fine il corteo delle nozze / portando torce / in solenne silenzio. / E nel mezzo / alla mia destra / nerovestita va semplice la sposa; / in belle pieghe un velo scarlatto / è drappeggiato sulla graziosa testa. / Incede sorridente; già la tavola profuma. V // L’amore, lo si dice, sta alla gogna, / e infine se ne va povero e scalzo; / il nobil capo non ha dove posare, / di lacrime si bagna i pie’ feriti. // Ah, è così che ho trovato Peregrina! / Bella la sua follia, le guance in fiamme, / scherzando al turbinio di primavera, / selvatiche corone fra i capelli. // Come potei lasciare quella bella? / - Più seducente torna quella gioia! / O vieni, ch’io ti stringa tra le braccia! // Ahimè, ahimè, che cosa è questo sguardo? / Mi bacia tra l’amore ancora e l’odio / e poi si volta e più non torna a me. I primi versi citati hanno per base l’idillio 15 di Teocrito in cui si narra delle nozze di Afrodite e Adone. La prima quartina del sonetto finale ha invece a base un luogo del Simposio di Platone (203 c-d). La differenza di tono fra i due gruppi di versi salta agli occhi, parallelamente alla loro diversa assegnazione di campo: da una parte il mito, dall’altra la filosofia; da una parte l’irrazionale, dall’altra la ragione. La filosofia interviene a dire la verità su qualcosa che il mito aveva un po’ rivelato e un po’ mascherato; essa chiarisce, nella fattispecie, che l’amore è umiliazione, non sacralità. L’uomo non può vivere nel mito e nell’irrazionale, ma la religione pretende di dissolvere quell’esperienza vitale che è l’amore; questo però non si lascia dissolvere. La filosofia può combattere la dimensione orgiastica e mitologica dell’amore, questo però non è annullabile. Il compromesso è dato dalla vita come ricostruzione e ricordo. E quest’ultimo si atteggia nelle forme classiche, ritenute generalmente dignitose e composte (qui il 258 sonetto contro i versi sciolti), però piene di un contenuto che risente della passata esperienza. Il ricordo è assicurato contro la ripetizione dell’avvenimento. La ricostruzione della storia segue le seguenti tappe: una situazione ancora composta (prima poesia in ottave) ma già inquieta (si parla di annegarsi nel «calice dei peccati»); una discesa nel mito (II; forma innica); la rottura con il primo porsi del desiderio di un rinnovamento amoroso, che verrà soddisfatto solo dal ricordo (III; la struttura formale replica la precedente); evocazione e visione (IV; quartina seguita da ottava); razionalizzazione (V, sonetto). Come conclusione la storia è sostituita dal ricordo; e questo a sua volta non ricostruisce la sequenza temporale ma l’attimo, non la realtà ma il suo depotenziamento. La ricostruzione è però costruzione artistica; il depotenziamento opera un recupero in un’altra dimensione. Già da alcuni cenni precedenti si è visto l’importante rapporto che Mörike ha intrattenuto con la cultura classica greco-latina. Del resto fu anche traduttore di Teocrito, Anacreonte e altri classici. La seguente poesia (1863) mostra come Mörike riuscì a unire spunti classici con motivi destinati ad avere nel futuro un successo strepitoso: Erinna an Sappho Erinna, eine hochgepriesene junge Dichterin des griechischen Altertums, um 600 v.Chr., Freundin und Schülerin Sapphos zu Mitylene auf Lesbos. Sie starb als Mädchen mit neunzehn Jahren. Ihr berühmtestes Werk war ein episches Gedicht "Die Spindel", von dem man jedoch nichts Näheres weiß. Überhaupt haben sich von ihren Poesien nur einige Bruchstücke von wenigen Zeilen und drei Epigramme erhalten. Es wurden ihr zwei Statuen errichtet, und die "Anthologie" hat mehrere Epigramme zu ihrem Ruhme von verschiedenen Verfassern. “Vielfach sind zum Hades die Pfade”, heißt ein Altes Liedchen – “und einen gehst du selber, Zweifle nicht!” Wer, süßeste Sappho, zweifelt? Sagt es nicht jeglicher Tag? Doch den Lebenden haftet nur leicht im Busen Solch ein Wort, und dem Meer anwohnend ein Fischer von Kind auf Hört im stumpferen Ohr der Wogen Geräusch nicht mehr. - Wundersam aber erschrak mit heute das Herz. Vernimm! Sonniger Morgenglanz im Garten, Ergossen um der Bäume Wipfel, Lockte die Langschläferin (denn so schaltest du jüngst Erinna!) Früh vom schwüligen Lager hinweg. Stille war mein Gemüt; in den Adern aber Unstet klopfte das Blut bei der Wangen Blässe. 259 Als ich am Putztisch jetzo die Flechten löste, Dann mit nardeduftendem Kamm vor der Stirn den HaarSchleier teilte - seltsam betraf mich im Spiegel Blick in Blick. Augen, sagt ich, ihr Augen, was wollt ihr? Du, mein Geist, heute noch sicher behaust da drinne, Lebendigen Sinnen traulich vermählt, Wie mit fremdendem Ernst, lächelnd halb, ein Dämon, Nickst du mich an, Tod weissagend! - Ha, da mit eins durchzuckt’ es mich Wie Wetterschein! wie wenn schwarzgefiedert ein tödlicher Pfeil Streifte die Schläfe hart vorbei, Daß ich, die Hände gedeckt aufs Antlitz, lange Staunend blieb, in die nachtschaurige Kluft schwindelnd hinab. Und das eigene Todesgeschick erwog ich; Trockenen Augs noch erst, Bis da ich dein, o Sappho, dachte Und der Freundinnen all Und anmutiger Musenkunst, Gleich da quollen die Tränen mir. Und dort blinkte vom Tisch das schöne Kopfnetz, dein Geschenk, Köstliches Byssosgeweb, von goldnen Bienlein schwärmend. Dieses, wenn wir demnächts das blumige Fest Feiern der herrlichen Tochter Demeters, Möcht ich ihr weihn, für meinen Teil und deinen; Daß sie hold uns bleibe (denn viel vermag sie), Daß du zu früh dir nicht die braune Locke mögest Für Erinna vom lieben Haupte trennen. Erinna a Saffo Erinna, celebrata giovane poetessa dell’antichità greca (ca. 600 a.C.), amica e allieva di Saffo di Mitilene sull’isola di Lesbo morì fanciulla a 19 anni. La sua opera più famosa era un poemetto epico, Il fuso, di cui però non si sa niente di preciso. Delle sue poesie si sono conservati in tutto alcuni frammenti di pochi versi e tre epigrammi. Le furono erette due statue e l’Antologia reca vari epigrammi in suo onore, composti da autori diversi. // “Tante sono le vie che vanno all’Ade”, dice / una vecchia canzone “e su una di queste ci vai tu, / non dubitare!”. E chi dubita, mia dolce Saffo? / / Ma solo leggermente resta ai viventi in petto / tale parola; e un pescatore che abita sul mare fin da bimbo / non ode più il rumore delle onde nell’ottuso orecchio. / Ma in modo strano si spaventò oggi il mio cuore. Ascolta! // Nel giardino splendore di sole mattutino, / versato sulle cime degli alberi, / presto sloggiò la dormigliona (così di recente rimproverasti / Erinna!) dall’afoso giaciglio. / Quieto era il mio animo; ma nelle vene / a fiotti pulsava il sangue, pallide le guance.// Quando alla toeletta mi sciolsi le trecce / poi con pettine profumato di nardo separai davanti alla fronte / il velo dei capelli, sguardo nello sguardo stranamente nello specchio mi colpì. / Occhi, diss’io, voi occhi, che volete?/ Tu, spirito mio, oggi abitante ancora sicuro 260 là dentro, / fidamente sposato a sensi viventi, / quasi con serietà estraniante, un po’ ridendo, un demone, / mi fai cenno vaticinando morte! / - Ah, all’improvviso mi percorse / come un fulmine! come se una morta freccia dalle piume nere / sfiorasse vicinissima le tempie, / così che io, coperto con le mani il volto, a lungo / rimasi a vorticare sull’orrido notturno abisso. // E soppesai il mio destino di morte; / dapprima a occhi asciutti; / finché pensai a te, o Saffo, / e alle amiche tutte / e alla graziosa arte delle Muse, / e allora sgorgano le lacrime. // E dal tavolo brillava la belle rete per capelli, tuo regalo, / prezioso tessuto di bisso, sciamato d’api d’oro. / Questo, quando prossimamente festeggeremo / la fiorita festa della magnifica figlia di Demetra, / vorrei dedicare a lei, per conto mio e tuo; / che ci resti propizia (ché lei può molto), / che tu non troppo presto debba tagliare dall’amato capo / la bruna chioma per Erinna. Un motivo millenario, l’alba come simbolo della vita che sorge o cui ci si ridesta, viene qui capovolto: l’alba è desolazione, rivelazione della caducità della vita, minaccia sicura di morte. Qualche anno prima in Le crépuscule du matin da Les fleurs du mal (18571) di Baudelaire l’alba era apparsa con connotazioni negative che si ritroveranno circa trentacinque anni dopo in Vor Tag (Innanzi giorno) di Hofmannsthal e dopo ulteriori venti anni nella Recherche di Proust. Ma la sua prima, grandiosa apparizione, come punto di incontro di più tradizioni, l’aveva fatta in Mörike. Da quanto si è visto finora, è nel concetto di liminarità che si sintetizza al meglio l’attività di Mörike: la cosa gli diventa cosa-soglia, il tempo si scompone condensandosi nell’attimo in cui tutto si capovolge. Di questa problematica tenta di dare una fondazione più ampia l’unico romanzo di Mörike, Maler Nolten (Il pittore Nolten, 1832), in cui compare anche il ciclo di Peregrina in una sua variante. Sul piano formale, il romanzo prosegue la tradizione romantica, col suo combinare tutti i generi possibili; vi vengono iscritte poesie, novelle, lettere, un diario, un’azione scenica; non mancano fantasmi o simili (c’è un morto che spegne una candela) né intrighi vari. Non tutto è alla stessa altezza ma indubbiamente molti aspetti del romanzo sono notevolissimi, anche sul piano tecnico; tra questi va particolarmente sottolineato l’uso del flash-back. Sul piano culturale va poi detto come in questo romanzo, che gli storici della letteratura definiscono senz’altro un Bildungsroman, Mörike abbia fatto dei riusciti sforzi per evitare somiglianze coi Lehrjahre (semmai ce ne sono con le Wahlverwandtschaften, in particolare nel finale, che per l’occasione viene anche tirato troppo per le lunghe). È un romanzo sull’arte e sull’amore. Vi si sostiene che l’arte vera è rapporto col demonico e che sull’amore vero difficilmente si può dire qualcosa, data la fondamentale ambiguità dei sentimenti. Il pittore Nolten ama Agnes, o almeno così crede; e ci dice anche le ragioni per le quali la ama (o meglio: l’avrebbe amata; infatti all’inizio del romanzo se ne è staccato e spera che la cosa finisca anche da parte di lei). Eccole: in lei aveva visto purezza del sentimento e illimi261 tata dedizione, unite a una modestia di fanciulla. Questa prime impressioni dovrebbero restare, secondo lui, eterne. Quando (per una serie di equivoci e di intrighi, come si scoprirà) sarà costretto a sospettare in lei un’ombra della falsità tipica delle donne, allora, anche se considera l’ipotesi che Agnes possa essere scusata, deve però constatare che il significato complessivo di quella donna è andato per lui perduto. Il suo amico, l’attore Larskens, gli rimprovera di andare a caccia di ideali quando invece si sta parlando d’amore; e per amore lui intende qualcosa che distragga da una fantasia preoccupantemente sfrenata (vedremo che questa sfrenatezza è legata al demonico) per trasportarci nella sfera del «chiaro sole quotidiano». Non che la predica venga da un buon pulpito; è proprio lui, grande amatore di donne, a voler tener vivo l’amore fra Nolten e Agnes, della quale quasi si innamora per interposta persona; nel suo ruolo di mediatore vuole infatti conquistare quella salute spirituale e quell’intima innocenza che in sé non trova. Agnes è così per entrambi una creatura irreale, un prodotto di fantasia. Nolten racconta di quando lui stesso era ragazzo, si sprofondava in fantasie e inventava racconti che poi ripeteva a dei bambini, fra cui Agnes. Lui stesso ammette di abbandonarsi ancora, da adulto, a questi infantilismi; ma a quanto pare si aspetta che Agnes resti direttamente un’eterna bambina. Per un certo tempo Nolten ama un’altra donna, Constanze, da cui è riamato; in lei si trovano cultura (non l’infantilismo di Agnes) e, a quanto pare, equilibrio; Constanze dovrebbe dunque essere capace di mediare fra l’artista e la società. Ma al momento opportuno i suoi sentimenti si dimostreranno intricati come non sospettava nessuno, meno che mai lei stessa, che dunque ne resterà spaventata più che ogni altro. C’è una terza donna, Elisabeth, simbolo del demonico nell’amore e nell’arte; con lei Nolten crede di cavarsela promettendole un semplice amore spirituale. Ma l’arte è arte (e l’amore è amore) perché rivela gli abissi più riposti del nostro mondo interiore e porta alla luce quanto c’è di più sotterraneo. Davanti a ciò, sia Agnes sia Constanze sono puri nomi. Nolten però inganna se stesso quando immagina l’arte come una zona autosufficiente, capace di sostituire tutto il mondo, anzi di aver, rispetto a esso, un valore compensativo e di essere capace di purificare la realtà, facendo godere di quell’ideale che quest’ultima fornisce solo in maniera insufficiente. Larskens gli obietta che un’artista non deve temere la passione né per i dolori che essa comporta né per gli eccessi delle sue gioie; ma a sua volta commette l’altro errore, quando gli propone di riposarsi dall’arte nell’amore solare di Agnes. La quale Agnes sarà magari anche infantile (e anzi alla fine diventa addirittura matta), ma certamente non è scema. Capisce bene quant’è strano il rapporto fra lei e Nolten; e nell’amore per lui si mescolano repulsione e dispetto; insomma l’amore è complicato anche in Agnes, che a ogni buon conto rimanda il matrimonio fin al punto che questo non avviene più. Ci sono, nel romanzo, un paio di donne che sembrano rispondere alle concezioni idilliche di Nolten: si chiamano Margot e Nanette; ma vi corrispondono proprio perché non coinvolte in niente di amo262 roso: la seconda infatti è la sua sorella più giovane, l’altra è un’ospite che per il momento cerca soltanto la compagnia delle coetanee. Con i suoi pregiudizi sulla chiarezza, sull’infantilismo e sulla domabilità del demonico, Nolten causa in Agnes una crisi che la porta alla morte. Anche se ciò causa a sua volta la morte di lui, forse è proprio quel che egli voleva; almeno si dice che Agnes gli appare nella sua più perfetta bellezza e suscita al massimo la sua ammirazione proprio quando lei appare trasfigurata da una sua sensazione di morte. Quest’esperienza sarà poi al centro della più celebre novella di Mörike, Mozart auf der Reise nach Prag (Mozart in viaggio per Praga, 1855): l’arte si muove al confine tra vita e morte. Excursus: Biedermeier, ovvero: Come si costruisce una definizione. Da un po’ di tempo siamo entrati nell’area culturale che è stata denominata Biedermeier. Tale denominazione è ben più arbitraria che quella di Junges Deutschland; in quest’ultimo caso esistevano almeno frequenti contatti personali, quando non addirittura amicizie; esistevano influssi e dipendenze, seppure non omogenei. Nel caso del Biedermeier, invece, vengono messi insieme personaggi come Gotthelf, Annette von Droste-Hülshoff e Stifter, i quali nemmeno sapevano l’uno dell’altro. Tuttavia la denominazione ha avuto un successo non immeritato poiché possiede una sua plausibilità e una sua utilità; tutto sta a vedere quel che con essa si intende. La definizione è nata, per così dire, a tavolino; nessuno degli autori che ora consideriamo Biedermeier si definì tale né pensò mai di appartenere a un così vasto gruppo. I punti di riferimento che ciascuno aveva non erano necessariamente validi per gli altri; non sono esistiti gruppi Biedermeier, né programmi, né riviste comuni. Il termine (che significa grosso modo Il Signor Chebravuomo) comparve in funzione parodistica nelle storielle e vignette di Ludwig Eichrodt (pseudonimo di Rudolf Rodt, 1827-1892) a partire dal 1850. All’inizio del XX secolo il termine fu ripreso per denominare prima lo stile degli interni di quell’epoca, poi le arti figurative e infine la letteratura (peraltro dopo molte resistenze); più di recente sembra lo si voglia estendere a indicare alcuni aspetti della musica dell’epoca. Ciò che pare voglia legare campi così diversi è la preferenza per le piccole dimensioni nelle forme e per gli stretti confini tracciati al campo di osservazione e all’ambientazione al fine di salvaguardare l’armonia. A riprova di ciò si ricorda che le forme più diffuse della lirica erano quelle brevi e che la pubblicazione avveniva di preferenza in almanacchi e riviste per famiglie; inoltre che fioriva la poesia d’occasione, moltissima della quale nasceva per gli album che in tanti tenevano a disposizione per gli ospiti. Si fa inoltre notare che domina un’atmosfera di rinuncia, di contenimento delle passioni e dunque - a causa della fatica che ciò costa - di malinconia che in molti casi arriva alla nevrosi; l’umorismo, quando c’è, nasce dall’amore per quel che di solito è trascurato, non appariscente, minore. Ciò viene completato da un atteggiamento conservatore, inteso a sottolineare che tutto ciò che appare è transitorio. In questa atmosfera (mortuaria, si direbbe) si spiega il diffondersi del collezionismo come recupero del piccolo transeunte (e maniacale allineamen263 to di ciò che si ripete con piccole variazioni). Il Biedermeier aveva indubbiamente i suoi ideali, che derivava dall’epoca classico-romantica; ma se ne metteva in luce il contrasto con la realtà e non si voleva negare il dualismo della vita. Fin qui la communis opinio, che contiene molti accenni preziosi a un certo stile di vita e anche indicazioni da utilizzare e sviluppare. Ma poiché si tratta di una definizione data a posteriori, tutto sta a vedere quali autori vengono selezionati e come li si interpreta. Facciamo alcuni esempi concreti. Di Raimund e Nestroy (autori compresi nel Biedermeier) si possono facilmente mettere in rilievo gli elementi conservatori e le esortazioni ad accontentarsi e a rinunciare; ma innanzitutto essi hanno le ambiguità di cui abbiamo parlato e poi gli elementi conservatori della cultura intesa come popolare sono di gran lunga più durevoli; troppo poco, dunque, per designare un’epoca storica. Altro esempio, che non manca mai per indicare quasi la quintessenza del Biedermeier: Der Traum ein Leben di Grillparzer. Se lo si interpreta come un’esortazione a rassegnarsi, a non cercare la felicità nel gran mondo, nel potere e via dicendo, perché due cuori e una capanna rendono buoni e felici, allora abbiamo certamente soddisfatto importanti presupposti della definizione del Biedermeier. Però abbiamo visto quanto ambiguamente stiano le cose con quella fiaba drammatica e che ne è possibile tutt’un’altra interpretazione, cioè questa: speriamo che il filisteo Rustan non realizzi mai i suoi sogni, perché dalla sua inadeguatezza al grande ruolo può nascere solo un criminale in grande stile; il sogno ci rivela il fondo torbido dell’ometto per bene. E allora dall’ometto Biedermeier, convivialmente sorridente sotto i baffi, che non dà nell’occhio se non per qualche discorso un po’ esaltato da innocuo avventore di birreria, che volentieri si perdona, all’occorrenza salta fuori uno Hitler. Che un’interpretazione del genere ci metta di fronte a una consapevolezza del Biedermeier ce lo confermano tante cose, prima fra tutte l’esperienza di Stifter: un autore letto già ai suoi tempi come noioso pittore idillico perché mette in opera un enorme apparato di protezione e di mascheramenti al fine di far svolgere tanto più indisturbato le sue tragedie; e quando si dà all’utopia (come nella Mappe meines Urgroßvaters), tira fuori un’utopia che è di rara ferocia nella sua furia armonizzatrice. Gli autori del Biedermeier mettono in guardia dalla violenza delle passioni e dall’incontrollabilità dell’inconscio, senz’altro: ma ciò è perché rispetto ai romantici, da cui pure procedono, hanno fatto notevoli passi avanti nella conoscenza di questi settori. Insomma: la definizione di Biedermeier sopra riportata può servire a inquadrare un Wilhelm Hauff o altri minori, leggere i quali è sempre bene ma non indispensabile; rende servizi più limitati man mano che gli autori crescono di statura; e in alcuni casi è fuorviante. Tuttavia questa discussione si sta svolgendo proprio con quella definizione, cioè con un patrimonio storico che sarebbe insulso buttar via, sia per le cose giuste che contiene sia perché per contrasto si arriva più speditamente a un’altra concezione. Per il momento possiamo fare una proposta metodologica: accettare di ricostruire il Biedermeier a tavolino, così come finora è stato fatto, anche conservando nel suo quadro gli autori che vi vengono considerati appartenenti; far però discendere la concezione generale del Biedermeier dalle interpretazioni degli autori (non viceversa), rapportati al complesso dei parametri cui essi rispondono. Concretamente si è visto come: nel caso di Raimund, Nestroy e Grillparzer il riferimento è stato alla storia della cultura viennese in vari suoi aspetti e livelli, per altri i riferimenti sono stati e saranno diversi. Dai 264 risultati si può ricavare il profilo di quel Biedermeier che oggi leggiamo ancora, e nella prospettiva che ci interessa. Dovremo dunque passare in rassegna i motivi risultanti; considereremo rilevante un tema quando arriva alla sua espressione migliore, per noi ancora viva; la recensione delle espressioni compiute sarà il profilo del Biedermeier. A partire da queste si potrà cercare di comprendere i conati non completamente riusciti, invece che viceversa. In tutto questo c’è ovviamente in gioco la sensibilità di noi moderni e la possibilità di vedere nel Biedermeier quel che altre epoche non hanno potuto vedere. Ne viene fuori una fortissima carica teorica, un dibattere questioni del nichilismo, un ridefinire il concetto di causa così come il rapporto tra fisica e metafisica, il ripensare daccapo ai concetti di tempo, di spazio, di io e via dicendo. Questo nuovo profilo sarà interessante se ci rivelerà cose nuove, contemporaneamente mettendo se stesso in discussione. Intanto però mette in discussione il profilo finora affermatosi. Innanzitutto facendo vedere quanto poco alla lettera vada presa la preferenza per le forme piccole. Grillparzer scrive le sue brave tragedie in cinque atti e, come se fosse poco, con il Goldnes Vließ arriva addirittura al ciclo di tragedie. È vero che la novella è ben più fortemente rappresentata che non il romanzo (eppure Gotthelf scrisse pur sempre quattordici romanzi); ma non è per niente raro che le novelle vadano verso le 150 pagine, e per una forma piccola è proprio tanto. Più giusto invece è dire che le forme vengono ripensate. Il racconto conosce uno sviluppo delle sue strutture e assesta in via definitiva la struttura a cornice. Sulle forme liriche si sperimenta in molte direzioni: dal tardo romanticismo si eredita la predilezione per la ballata, ma su questa spinta la forma poetica si fa sempre più lunga: ci sono narrazioni in versi (per es. nella Droste-Hülshoff e in Mörike) fino a veri e propri poemi epici (Lenau) e l’inventiva arriva fino alla stesura di poemi drammatici (Lenau). Ci sono cicli lirici vari, da brevi ad amplissimi (Mörike, DrosteHülshoff). Non è tanto il piccolo a saltare agli occhi quanto la voglia di sperimentare con tutte le forme e non solo con esse; abbiamo visto in Mörike e vedremo con la Droste-Hülshoff che la lirica Biedermeier conosce una gamma di esperienze fra le più ardite. I cicli di racconti sembrano invece aver interessato meno: Stifter ne tentò uno ma poi abbandonò l’idea. È vero che l’ambientazione preferisce spazi ristretti o controllati; tali almeno sono quelli nei quali si svolgono le scene decisive. Per contrasto ci sono descrizioni naturali che associano il realismo dei particolari al controllo dei più grandi spazi (basterà citare Brigitta di Stifter, Am Turm della Droste-Hülshoff). Lo spazio controllato finge un’armonia che non c’è, rientrando a far parte di quell’opera di mascheramento cui si accennava. E poi non sempre finge armonia: nello spazio controllato della Narrenburg di Stifter c’è posto per tutti gli eccessi. Quest’ambiguità (e quest’equivoco critico) va vista insieme con il rapporto che il Biedermeier ha intrattenuto con l’eredità, in primo luogo con quella romantica. Questa aveva lasciato delle riflessioni sul nichilismo già arrivate a un punto molto avanzato (basti rammentare qui Jean Paul); una parte della cultura Biedermeier ne trasse profitto. Resta però quasi un rimpianto per una perduta filosofia di valori, di conseguenza tristezza per la sua scomparsa. Aver negato un elemento assoluto di coesione del mondo fa apparire intollerabile l’universo perché i suoi elementi isolati sembrano incontrollabili e reciprocamente indifferenti; anzi, non più coesi, rischiano di apparire senza senso e senza valore, parvenza e sogni dalla libertà solo illusoria e momentanea. È un processo, questo, che si può seguir bene nel Faust di Lenau. Ma anche chi 265 non generalizza allo stesso modo ha le sue esperienze inquietanti, quali si depositano bene in Stifter come in Mörike e come in altri. Abbiamo visto come si parli dell’amore in Maler Nolten; qui è opportuno ripetere una cosa già nota al vecchio profilo del Biedermeier: questa cultura accetta gli ideali romantici ma non si fa illusioni sulla possibilità di affermarli nella realtà. I romantici hanno messo le basi per la concezione moderna dell’amore, questo è incontestabile; fra le altre cose ne hanno messo in luce le capacità creative, che oggi ci appaiono ovvie già perché l’amore è procreatore. Ma nella sua tensione verso la creatività il romantico tende a eliminare gli aspetti meno controllabili dell’amore, fino a quelli scandalosi (i quali compaiono pure, ma senza lasciare traccia nella concezione più diffusa dell’amore romantico); al massimo essi vengono sostituiti dalle inquietudini o anche dalle tragedie delle situazioni specifiche, non pertinenti all’essenza dell’amore. L’amore romantico resta fondamentalmente un’energia creatrice che cerca il suo oggetto per rifuggirne sempre via. In questo schema sono insite contraddizioni: l’amore crea l’oggetto pur restando soggettività? O cerca il già creato da altri e sussistente di per sé? Fugge da un oggetto in fondo mai trovato? Ma le contraddizioni sono ben note ai romantici e da loro anzi volute; i primi romantici non le temevano perché erano convinti di poterle trascendere, rivivificare e riproporre ad altro livello: gli ultimi romantici le accentuavano nella consapevolezza che tra esse si muove la vita, dominabili o (come per lo più) non dominabili che esse siano. Ci sono conseguenze che i romantici non traggono ma che vengono tratte dalla cultura Biedermeier. Ci si può infatti chiedere se tutto questo soggettivismo non sia semplicemente un condensato di inganni, eventualmente di autoinganni. Per vedere solo l’immagine che ha costruito e proietta, il soggetto non vede la realtà, che invece va per conto suo. Le ragioni per cui non la vede possono essere le più svariate, ma in ogni caso sono concrete e ne andrebbe reso conto in maniera concreta, indagandole sul piano sociologico, culturale, psicologico o che altro; ma il romantico non si propone nemmeno un’indagine del genere. Non se la propongono nemmeno gli autori Biedermeier, d’accordo, però sanno come stanno le cose: basti vedere che fine fa il Nolten di Mörike con le sue insufficienti concezioni dell’amore. Certo, non viene data un’alternativa. L’inganno può essere pilotato o aiutato o addirittura provocato dall’esterno: chi sa di essere oggetto dell’immagine amorosa sfrutta l’immagine per il proprio tornaconto. La genericità dell’inganno di cui parlano i romantici diventa squallore e scacco di tutta una vita quando l’inganno viene visto nel suo particolare. Ma la cosa non è così banale: l’inganno può combinarsi con l’autoillusione, come accade ancora a Nolten. Oppure l’inganno può essere più abissale: tutta la vita apparente copre, con le sue forme levigate, un ribollire di passioni in mezzo al quale gli amanti si cercano e si fuggono e insomma si combattono, ingannando se stessi, l’oggetto amato e tutto il mondo intorno: Stifter tematizzò tutto ciò nello Hochwald. D’altra parte questo soggettivismo non può essere mero narcisismo? Allora non si ha produttività di niente ma solo sterilità. Non si possono fare gli errori più grandi in nome della fedeltà agli ideali e alla pretesa di vederli realizzati intorno a sé, interpretando la procreazione come forma di produttività più o meno ottimistica anzi idillica? Fu ancora Stifter a interrogarsi su ciò nel Waldgänger. E via contestando e revisionando. L’amore come processo infinito (crudele o no, turpe o no) può essere un’esperienza personale, ma cade l’ottimismo che ne 266 faceva una chiave per percorrere tutto il mondo nelle sue dimensioni sia etiche sia gnoseologiche. Era un ottimismo da sistema, che credeva di poter comprendere tutto il mondo e dichiarava inesistente quel che non comprendeva; nelle sue manifestazioni migliori il Biedermeier né si dà a questa illusione né la sostituisce con altra. C’è insomma un intenso lavorio sulle tradizioni. Ancora un esempio. In un suo straordinario, lungo racconto, Der Sammler und die Seinigen, Goethe aveva trattato del collezionismo attraverso alcune generazioni; e una serie di appunti, stesi insieme con Schiller, aveva trattato del dilettantismo. Ebbene, Stifter scompone e ricompone queste associazioni in due racconti: Turmalin, in cui si parla di un collezionista e dilettante, e Kalkstein, in cui attraverso quattro generazioni si assiste all’ascesa e decadenza di una famiglia; vedremo nei particolari quali sono le novità da lui apportate. C’è, indubbiamente, pochissima politica diretta; non che sia assente del tutto: in Maler Nolten c’è un solo riferimento alla realtà politica contemporanea dai Karlsbader Beschlüsse in poi, ma è un riferimento che non lascia niente a desiderare quanto a precisione e a rilevanza narrativa (combinandosi con la vendetta di Constanze). È anche vero che Stifter e Grillparzer si spaventarono del Quarantotto; Grillparzer diede una tormentata giustificazione della democrazia solo nel Bruderzwist, Stifter presentò la sua raccolta Bunte Steine come un antidoto alla rivoluzione. D’altra parte l’ultima cosa che si può dire di loro è che ignorassero la realtà del loro tempo. Erano dei disillusi, che scavando nelle nevrosi, nelle inibizioni, nell’inconscio facevano dei progressi decisivi nella conoscenza delle cose e degli uomini. Intanto le cose si sono venute ramificando, ed è giusto che sia così; poiché dare un profilo preciso del Biedermeier significa scrivere la storia di un’epoca, vedendo solo in seguito quel che si lascia unificare; un “seguito” che per comodità è stato messo qui, quando non può esserci il sospetto che si tratti di una definizione a priori né c’è bisogno di aspettare fino all’ultimo per avere un momento di confronto. 267 268 V Mondanità, province. 269 270 V, 1. Un comune riferimento a Uhland ci permette di accostare due poeti peraltro ben diversi: Nikolaus Lenau (pseudonimo di Nikolaus Niembsch von Strehlenau) e Annette von Droste-Hülshoff. Ognuno dei due ebbe a dire che aveva dovuto dare nell’occhio agli svevi per essere apprezzato dai propri connazionali (Lenau dagli austriaci - anche se come luogo di nascita veniva dall’Ungheria -, la Droste-Hülshoff dai conterranei della Westfalia). I punti di contatto sono già quasi finiti se si aggiunge che entrambi erano nobili e appartenenti a famiglie cattoliche, e che entrambi mostrarono un rapporto (per la verità assai diverso) con la cultura americana. Ma è tanto più interessante vedere a che diversità di esiti porti l’accennato riferimento a Uhland; di questi si intende in primo luogo il tipo di ballata: molto sviluppata in ampiezza, basata su materia storica o leggendaria con forte riferimento locale, e in cui l’osservazione precisa della natura ha una parte essenziale. Lenau arrivò subito al successo: la prima edizione dei suoi Gedichte (1832) ne richiese subito una seconda (1834). Fu anche un gran successo mondano, che Lenau curò con efficacia. Vestiva all’ungherese (lui che della lingua possedeva sì e no qualche parola), suonava il violino e la chitarra, era grande amatore di donne (finché non prese la sifilide, cui seguirono la paralisi, la pazzia e la morte; ma già prima di questa vicenda era stato menato per bene per il naso). Subito dopo la prima edizione delle poesie, Lenau pensò di andare in America, terra della libertà, del futuro e dei soldi. Cantando la natura incontaminata, comprò nell’Ohio 400 acri di terra da disboscare e coltivare; vestito coi suoi eleganti vestiti ungheresi e in guanti da passeggio, prese effettivamente in mano l’ascia lasciandola cadere dopo pochi colpi, sia che avesse scoperto quanto fosse faticoso, sia che gli sciupasse i guanti. Si mise a fare viaggi in slitta, andò a vedere il Niagara, ammirò gli indiani, disse che gli americani sono avidi e zotici e tornò in Europa, stabilendosi ben presto a Vienna, dove rinnovò i suoi successi di byroniano bello, malinconico, tenebroso, pieno di grazia, di senso della natura e di Weltschmerz, e dove trovò prestissimo chi lo prese al laccio. Costei si chiamava Sophie von Loewenthal, sposata con figli, colta, discretamente isterica e, dicono i biografi, esente da bisogni sessuali per sue ragioni patologiche. Si lasciava baciare e accarezzare ma niente di più; in compenso era gelosa e ogni volta che Lenau faceva il tentativo di volare via, lei lo riacciuffava; capì vagamente quel che gli aveva fatto solo quando Lenau impazzì. Lenau è diventato popolare per le sue poesie: per il grande senso della natura, per l’introduzione di paesaggi ungheresi e americani. Alcune sue poesie hanno resistito nelle antologie, gruppi di versi sono tuttora da ammirare. E tuttavia 271 non pare essere qui il Lenau che oggi può interessarci di più; lo troviamo invece nelle composizioni lunghe, di cui in altro contesto abbiamo analizzato il Faust (1836). Già sono notevoli le forme utilizzate. Faust è un poema drammatico (ma c’è chi l’ha inteso come vero e proprio dramma e l’ha messo in scena); ciò permette, con l’uso di didascalie e con l’attribuzione di battute a vari personaggi, di saltare quei raccordi esterni che sarebbero necessari all’epica e di variare il verso a seconda dei personaggi e delle situazioni. Seguì Savonarola (1837), un ciclo di 25 romanze in quartine dalle tetrapodie giambiche a rima alternata (abab); questa forma prosegue una tradizione che aveva già dato eccellenti risultati nel romanticismo (si pensi alle Romanzen vom Rosenkranz – Romanze del rosario - di Clemens Brentano) e va vista soprattutto in questa luce. Occorre aggiungere che trattava il tema della purezza religiosa quale poteva essere gradito agli svevi; Savonarola non è l’opera più propria di Lenau: essa nacque sotto l’influsso che per un certo periodo ebbe su di lui il teologo danese Hans Lassen Martensen e si trattò fondamentalmente di una parentesi (che però riuscì a dispiacere a David Friedrich Strauß, il quale si sentì personalmente attaccato, e agli hegeliani). Sul piano artistico ci sono da segnalare solo pochi episodi (per es. quello di Tubal, in cui l’antisemitismo del Faust viene revocato) e l’emergere di quella tendenza allo smisurato che si affermerà nel ciclo successivo, Die Albigenser (Gli Albigesi, 1842). Sono 32 canti («freie Dichtungen», li definisce Lenau) dalla metrica e dal ritmo variati. Lenau non risparmia scene cruente, che del resto la repressione dell’eresia catara per mezzo di una “crociata” voluta da papa Innocenzo III nei primi del Duecento offriva a sazietà. Accanto a ciò, grandi scene di introspezione psicologica e affreschi di storia della cultura. I canti offrono ritratti di personaggi e di situazioni. C’è il modo in cui i persecutori dei catari diventano quel che diventano: l’ex trovatore Fulco sfoga nella persecuzione l’esito funereo di un amore comunque infelice e umiliante, sperando di riunirsi in cielo alla donna amata e quindi odiando quegli eretici che gli tolgono la consolante idea della resurrezione dei morti. Lo stesso Innocenzo III è pieno di dubbi sia prima sia dopo lo sterminio degli Albigesi. Lenau cerca di immedesimarsi negli animi dei crociati come in quelli degli eretici e illustra gli eccessi e le ragioni degli uni e degli altri. Ma è fuor di dubbio che lui sta dalla parte della libertà di pensiero, del diritto al dubbio e pertanto (pur se solo in questo senso) degli albigesi. Della loro lotta vede anche il valore politico: chi comincia a interrogarsi su Dio (scrive), prima o poi si interrogherà anche sui suoi prìncipi, non sarà più un suddito cieco ma vorrà veder chiaro sul diritto di chi comanda. E quindi cominciano le grandi scene cruente: Simon de Montfort, conquistata la rocca di Brom, fa accecare cento cavalieri, li lega a una corda e li manda così al conte Foix come rosario vivente. Gli accecati imprecano a chi ritengono causa della loro sorte, Simon oppure Innocenzo, finché uno dà la colpa a Cristo direttamente, di cui Innocenzo bacia le ferite come un leone mansueto che lecca il suo padrone; ma la lingua ha sentito il sapore del sangue e si risveglia il leone selvaggio, che prima 272 dilania il suo padrone credendo ancora di baciarlo, quindi si scatena per tutto il mondo. È la fede a comportare rovine; e alla fine di tante dispute teologiche ci sono i cadaveri a far da cibo ai corvi. Come atteggiarsi di fronte a tutto ciò (si chiede il poeta)? Perdonare cristianamente? Odiare? La questione viene dibattuta nel canto iniziale e poi in quello finale; il primo è teso fra le due alternative, l’ultimo colloca la vicenda degli albigesi nella lunga lotta dell’umanità per la libertà dello spirito; ecco il celebre finale: Das Licht vom Himmel läßt sich nicht versprengen, Noch läßt der Sonnenaufgang sich verhängen Mit Purpurmänteln oder dunklen Kutten; Den Albigensern folgen die Hussiten Und zahlen blutig heim, was jene litten; Nach Huß und Ziska kommen Luther, Hutten, Die dreißig Jahre, die Cevennenstreiter, Die Stürmer der Bastille, und so weiter. La luce del cielo non si lascia disperdere, / l’aurora non si lascia nascondere / con mantelli di porpora o tonache nere; / agli Albigesi seguono gli Ussiti, / che ripagano col sangue quanto quelli hanno sofferto; / dopo Huß e Ziska vengono Lutero, Hutten, / i trent’anni, i ribelli delle Cevennes, / i conquistatori della Bastiglia e via e via. Negli Albigenser Lenau riconquista il suo panteismo e si mostra ben consapevole della forma scelta: frammentare l’accadimento complessivo in singole vedute prospettiche. Le reazioni dei vecchi amici non furono positive: Justinus Kerner dovette essere calmato personalmente da Lenau, Berthold Auerbach se la prese in particolare col canto finale. Al pubblico piacque ben più che non il Savonarola; le ammiratrici protestanti trovarono opportuno servirsene come libro di devozioni. L’ultimo grande lavoro di Lenau fu Don Juan, da lui definito «Ein dramatisches Gedicht»; vi lavorò fino a quando non glielo impedì la pazzia, scoppiata negli ultimi mesi del 1844 (Lenau tentava invano di sottrarsi a Sophie attraverso un progetto matrimoniale, sulle prime improbabile, cui però era incredibilmente riuscito a dare perfino un fondamento economico; ma Sophie non mollava la presa nemmeno un po’). C’è chi dubita che questa composizione (pubblicata da Anastasius Grün nel 1851) sia da considerarsi propriamente un dramma; certamente vi è molto più vicina del Faust, ma altrettanto certamente non sembra la più adatta per la scena. Anche il Don Juan è a suo modo un dramma (o un poema drammatico, se si preferisce) dello smisurato. Il protagonista rifiuta sdegnosamente l’idea che la gioia possa consistere nello stare nei limiti, nell’accontentarsi e anzi insiste sulla novità del piacere; se non è nuovo, non può essere piacere: «non voglio costruire templi per mezzo di rovine», dice un verso, singolarmente assonante a uno del Don Juan und Faust di Grabbe. Il don 273 Giovanni di Lenau si lascerà uccidere da un mediocre vendicatore solo quando non sarà più capace di trovare piacere nella novità. Questo poema è discretamente sconcertante; accanto a scene efficaci ha dei momenti di involontaria comicità: don Giovanni è ricco sfondato (si meraviglia lui stesso di quanto lo sia), brillante, coraggioso e pieno di donne, il Weltschmerz ci sta come i cavoli a merenda. Ma, a parte questi incidenti, questo Don Juan è notevole: Lenau introduce con prepotenza la problematica dell’attimo in cui tutta la vita si condensa e che perpetuamente ha bisogno di ricominciare senza ripetersi; questo suo personaggio fa pensare al Don Giovanni e a simile problematica di Kierkegaard più che ad altri. Contemporaneamente va avanti quel processo di dissoluzione della catena temporale che occupava le forze concettuali di altri autori del tempo. A Lenau sono state di svantaggio le stesse ragioni che ne favorirono il primo successo. Le sue composizioni lunghe meritano una rilettura, la sua lirica meriterebbe una scelta drastica, tale da favorire l’individuazione di poche poesie canoniche, che più direttamente possano coinvolgere il lettore di oggi. Detto con una formula: a Lenau non è toccata l’operazione benemerita che Hofmannsthal ha svolto nei confronti della produzione poetica di Conrad Ferdinand Meyer, da lui ridotta a una dozzina di liriche; forse per Lenau non si tratterebbe tanto di liriche intere quanto di gruppi di versi, ma sarebbe un’impresa da tentare, se non si vuole solo lasciarlo in qualche antologia di scuola austriaca. Non sarà l’impresa più facile del mondo né è detto in assoluto che essa debba riuscire. Le ricerche più recenti hanno messo in luce il carattere problematico della lirica di Lenau, pur nei suoi momenti migliori: l’io lirico ritiene ancora d’essere soggetto del mondo, cui la natura è servizievole scenario per l’effusione, pronta a cambiare insieme con i suoi umori, oppure a rivelare l’io a se stesso, o anche fargli da contrasto e a rivelargli l’effettivo isolamento, sempre però ritenendolo il depositario della sostanza universale (e nelle poesie meno riuscite, più byroniane e a suo tempo più alla moda, ciò diventa descrizione del Weltschmerz). Di conseguenza Lenau appare come un poeta che, fuori tempo, cerca ancora l’armonia universale e a tal fine è costretto a guardare al passato. Se non si dovesse andare oltre questi risultati, sarà difficile che Lenau torni presto a parlarci, sarà difficile anche frammentarlo in modo che si apra ad altro che al Weltschmerz e si limiterà a essere ancora a lungo un tormento scolastico. Giudichi il lettore quale sorte toccherà alla seguente poesia, pur sempre una delle sue meglio riuscite: Herbstentschluß Trübe Wolken, Herbstesluft, Einsam wandl’ ich meine Straßen, Welkes Laub, kein Vogel ruft Ach, wie stille! wie verlassen! 274 Todeskühl der Winter naht; Wo sind, Wälder, eure Wonnen? Fluren, eurer vollen Saat Goldne Wellen sind verronnen! Es ist worden kühl und spät, Nebel auf der Wiese weidet, Durch die öden Haine weht Heimweh; - alles flieht und scheidet. Herz, vernimmst du diesen Klang Von den felsentstürzten Bächen? Zeit gewesen wär’ es lang’, Daß wir ernsthaft uns besprächen! Herz, du hast dir selber oft Weh getan, und hast es andern, Weil du hast geliebt, gehofft; Nun ist’s aus, wir müssen wandern! Auf die Reise will ich fest Ein dich schließen und verwahren, Draußen mag ein linder West Oder Sturm vorüberfahren; Daß wir unsern letzen Gang Schweigsam wandeln und alleine, Daß auf unsern Grabeshang Niemand als der Regen weine! Decisione autunnale Nuvole cupi, aria d’autunno / mentre cammino per le mie strade, / foglie appassite, non un canto d’uccello - / e che silenzio e che solitudine! // Con il gelo della morte s’avvicina l’inverno; / dove sono, o boschi, le vostre delizie? / O campi, delle vostre messi copiose / le onde dorate sono svanite! // Si è fatto tardi e fa freddo, / la nebbia si è distesa sul prato, / piange nel vento fra gli alberi spogli / la nostalgia; - tutto fugge e dice addio. // Cuore mio, avverti questa voce / dei ruscelli tra le rocce? / Da lungo tempo ormai / avremmo dovuto parlarci seriamente! // O cuore mio, hai fatto spesso del male / a te stesso e ne hai fatto anche agli altri, / per aver amato, per aver sperato; / ora è finita e dobbiamo andare! // In viaggio ben stretto voglio tenerti / dentro di me al riparo, / da ponente soffi pure il vento, / infuri pure la tempesta; // da soli faremo così / in silenzio l’ultimo cammino / e così sulla nostra tomba domani / potrà piangere soltanto la pioggia. 275 I punti di contatto fra Lenau e Annette von Droste-Hülshoff sono stati precedentemente enumerati quasi al completo. Qualcosa però va aggiunto: anche Annette era una natura passionale, e la sua vita fu costellata di amori infelici. Ma si tenga presente il doppio limite: della condizione della donna in quell’epoca e dell’educazione nobiliare. Annette li accettò entrambi; la forza del suo erotismo e la tensione della sua mente si scaricarono in atteggiamenti contraddittori, che, stando alle testimonianze pervenuteci da più parti (ambiente familiare o esterno che fosse), la rendevano oltremodo antipatica. Seguì le vicende culturali del suo tempo attraverso mediatori, che le procuravano libri e riviste. E subì gli influssi che subivano tutti; fondamentale quello di Uhland, ma nell’opera di Annette si trovano anche motivi risalenti a una più generale tradizione romantica (per es. Fouqué e Arnim), all’interesse per la cultura popolare propria dei Grimm; c’è anche un’occasionale presenza di Byron, motivi vari appartenenti anche a quanto si era popolarizzato del romanticismo mescolandosi con tante altre cose nella Trivialliteratur; un’episodica ma forte presenza dell’americano Washington Irving (Bracebridge Hall, 1822) per un’opera progettata in grande ma eseguita solo in piccola parte (Bei uns zu Lande auf dem Lande - Da noi, nella nostra terra in campagna -; Annette vi lavorò fondamentalmente nel 1841 ma quanto ne scrisse uscì postumo, nel 1862). Ma al di là di queste e di altre letture è importante notare due cose: sul piano sociologico, Annette era ben contenta di non essere dipendente dal mercato librario; il suo orgoglio di aristocratica le permetteva di accontentarsi della rendita toccatale in seguito alla morte del padre, con metà della quale compensava l’ospitalità garantitale dalla sorella. Sul piano della storia della sua opera la quantità delle letture non impedisce di seguire lo sviluppo di forme e temi suoi peculiari. Annette dedicò molta, costante attenzione alle forme lunghe: ballate e poemetti di notevole ampiezza, cicli di poesie; altrettanto notevole l’attenzione al variare delle forme metriche. Raggiunse risultati notevoli dovunque, eppure non è nelle forme lunghe che diede il meglio di sé ma in singole, copiose liriche. L’amore, la memoria, l’incerta apertura al mondo, la riflessione sulla morte (fino a un sadismo che è parente stretto dell’amore) trovano una sistemazione di netta originalità in questa poetessa che è grande maestra nell’allusione, nell’esplorazione degli spazi, dei colori, della consistenza delle cose, così come nell’evocazione di atmosfere e di situazioni. Ma ecco subito un esempio, tratto dalla grande stagione creatrice (1841-42): Am Turme Ich steh auf hohem Balkone am Turm, Umstrichen vom schreienden Stare, Und laß gleich einer Mänade den Sturm Mir wühlen im flatternden Haare; O wilder Geselle, o toller Fant, Ich möchte dich kräftig umschlingen, 276 Und, Sehne an Sehne, zwei Schritte vom Rand Auf Tod und Leben dann ringen! Und drunten seh ich am Strand, so frisch Wie spielende Doggen, die Wellen Sich tummeln rings mit Geklaff und Gezisch Und glänzende Flocken schnellen. O, springen möcht ich hinein alsbald, Recht in die tobende Meute, Und jagen durch den korallenen Wald Das Walroß, die lustige Beute! Und drüben seh ich ein Wimpel wehn So keck wie eine Standarte, Seh auf und nieder den Kiel sich drehn Von meiner luftigen Warte; O, sitzen möcht ich im kämpfenden Schiff, Das Steuerruder ergreifen Und zischend über das brandende Riff Wie eine Seemöwe streifen. Wär ich ein Jäger auf freier Flur, Ein Stück nur von einem Soldaten, Wär ich ein Mann doch mindestens nur, So würde der Himmel mir raten; Nun muß ich sitzen so fein und klar, Gleich einem artigen Kinde, Und darf nur heimlich lösen mein Haar Und lassen es flattern im Winde! Alla torre Sul balcone, alla torre, lassù in alto, / avvolta dal gridare degli storni, / come una menade lascio che il vento / mi frughi nella chioma palpitante. / Oh, compagno mio fiero, ragazzo scatenato, / vorrei prenderti stretto, / e fibra contro fibra, a due passi dal vuoto, / ci batteremmo a morte. // E al di sotto, a riva, vedo le onde, / vivaci al gioco come dei mastini, / che corrono, che abbaiano, che soffiano, / e lanciano fiocchi di spuma. / O, buttarmici subito vorrei, / nel fitto della muta furibonda, / inseguire per boschi di corallo / il tricheco, la preda più gioiosa. // E là in fondo ravviso una bandiera / sventolare insolente come in guerra, / la chiglia che s’alza e s’abbassa / distinguo, dall’aerea vedetta. / Oh, vorrei stare su quella barca in lotta, / afferrare la barra del timone, / trasvolare gli scogli ribollenti / via via come un gabbiano. // Se fosse un cacciatore alla campagna / o un soldato, magari solo un pezzo, / anche soltanto un uomo fossi, almeno, / il cielo mi darebbe il suo consiglio; / ma così, tutta candida e garbata, / messa a sedere come un bimbo bravo, / posso 277 solo, in segreto, sciogliere i miei capelli / e farli sventolare alla tempesta. La sapienza compositiva è evidente: in ciascuna delle prime tre ottave la prima metà descrive una situazione mentre nella seconda metà si esalta il desiderio, finché nelle ultime strofe, quando sembra che tutto ceda alla rassegnazione, abbiamo la spiegazione dei versi iniziali: un corpo che vibra d’amore, sia pure con estrema riservatezza e discrezione. Forse l’erotismo della poetessa si è manifestato meglio qui, in questo continuo crescere del desiderio, che dal balcone, alla spiaggia, al lago passa al vento, alla caccia, alla tempesta di mare per radicarsi infine nel corpo, che non in pur gran belle poesie d’amore dirette al da lei amatissimo Levin Schücking (O frage nicht, Kein Wort - Non chiedere, Non una parola), di diciassette anni più giovane (tanto legato al mercato librario da dover produrre complessivamente duecento volumi di genere vario) e suo grande ispiratore. Fu un amore che diede luogo anche a poesie serene fino allo scherzo e alla battuta, lasciando tuttavia il posto a una riflessione che il tempo può incaricarsi di volgere in un senso o nell’altro: Die Schenke am See (Str. 6.) Sieh drunten auf dem See im Abendrot Die Taucherente hin und wieder schlüpfend; Nun sinkt sie nieder wie des Netztes Lot, Nun wieder aufwärts mit den Wellen hüpfend; Seltsames Spiel, recht wie ein Lebenslauf! Wir beide schaun gespannten Blickes nieder; Du flüsterst lächelnd: immer kömmt sie auf! Und ich, ich denke: immer sinkt sie wieder! L’osteria in riva al lago (str. VI) Vedi, sul lago, nel tramonto rosso, / gli smerghi, che si tuffano e riaffiorano; / van sotto come il piombo delle reti, / e poi tornano a galla, balzando con le onde: / che gioco singolare, eguale all’esistenza! / Tutti e due l’osserviamo appassionati. / Tu sorridi e sussurri: risalgono sempre! / Ma io rifletto: vanno ancora a fondo! È comunque la forza dell’amore che spinge a un generale inno alla vita, riscattando anni di solitudine e di chiusura (Spätes Erwachen - Tardo risveglio -, 1844). Ma già mentre componeva le sue grandi poesie d’amore Annette ne scriveva altre nelle quali il tema dell’amore fa tutt’uno con quello della caducità e della morte; in questa fusione merita d’essere sottolineata la concretezza delle cose in cui la caducità si verifica: sono oggetti di quelli che si usano conservare a memoria di persone care (ritratti, ciocche di capelli) e che assumono un’aria funerea; d’altra parte tutta questa concretezza è visionaria, suggerita da un’immagine - un albero pari a un’immensa lucciola - che nemmeno la consa278 pevolezza riesce a razionalizzare («sapevo che era una luce accesa in camera mia»). Ma questo senso della caducità e quest’incertezza nell’identificazione è al tempo stesso amore per le cose, rivestite di un’aura che viene loro da due qualità contraddittorie: essere precisamente quelle ed essere immaginate come tutt’altre, con una dedizione che va alla loro sostanza tanto reale quanto onirica (Im Moose - Nel muschio; v. anche Das alte Schloß - L’antico castello). Il senso della morte è costante nella Droste-Hülshoff; a volte riesce anche a essere sarcastico (Silvesterabend – Capodanno -, 1843-44); e in generale non manca una vena assai pungente a questa poetessa, che qualche ritratto ci fa vedere con un sorriso tagliente, occhi penetranti e tratti invece impenetrabili. Di che cosa fossero capaci il suo amore insieme con la sua dedizione alle cose (fatta nel modo accennato poco sopra) ce lo dice questa poesia, che è forse un caso estremo: Brennende Liebe Und willst du wissen, warum So sinnend ich manche Zeit, Mitunter so töricht und dumm, So unverzeihlich zerstreut, Willst wissen auch ohne Gnade, Was denn so Liebes enthält Die heimlich verschlossene Lade, An die ich mich öfters gestellt? Zwei Augen hab ich gesehn, Wie der Strahl im Gewässer sich bricht, Und wo zwei Augen nur stehn, Da denke ich an ihr Licht. Ja, als du neulich entwandtest Die Blume vom blühenden Rain Und “Oculus Christi” sie nanntest, Da fielen die Augen mir ein. Auch gibst einer Stimme Ton, Tief, zitternd, wie Hornes Hall, Die tuts mir völlig zum Hohn, Sie folget mir überall. Als jüngst im flimmernden Saale Mich quälte der Geigen Gegell, Da hört ich mit einem Male Die Stimme im Violoncell. Auch weiß ich eine Gestalt, So leicht und kräftig zugleich, 279 Die schreitet vor mir im Wald Und gleitet über den Teich; Ja, als ich eben in Sinnen Sah über des Mondes Aug Einen Wolkenstreifen zerrinnen, Das war ihre Form, wie ein Rauch. Und höre, höre zuletzt, Dort liegt, da drinnen im Schrein, Ein Tuch mit Blute genetzt, Das legte ich heimlich hinein. Er ritzte sich nur an der Schneide, Als Beeren vom Strauch er mir hieb, Nun hab ich sie alle beide, Sein Blut und meine brennende Lieb. Amore ardente E dunque vuoi sapere / perché talvolta ho un’aria trasognata, / persino matta o sciocca, / distratta che non merita perdono? / Vuoi sapere, implacabile, / cosa di tanto caro / racchiude, ben serrato, quel cassetto / cui sto spesso vicina? // Due occhi ho veduto / come nell’acqua il raggio si riflette, / e solo che s’accendano due occhi, / allora io ripenso a quella luce. / Così, è passato poco, / quando, cogliendo dalla siepe un fiore, / oculus Christi hai detto, / ecco che di quegli occhi mi sovvenne. // E c’è un tono di voce, / fondo e tremante come echeggia il corno, / che di me si fa gioco / e m’accompagna sempre dappertutto. / Tra i lumi del salone, di recente, / lo stridio dei violini m’affliggeva, / ed ecco che, improvvisa, / sentii nel violoncello quella voce. // E poi, una figura / conosco, tanto forte e insieme lieve, / che per il bosco mi precede sempre / e vola sullo stagno. / Pensosa, l’altro giorno, contemplavo / sull’occhio della luna / una striscia di nubi dileguare, / ed ecco quella forma, come un fumo. // E senti, senti ancora: / laggiù, dentro lo stipo, un fazzoletto, / inzuppato di sangue, / che ho messo via in segreto. / Delle more cogliendomi dal rovo, / lui s’è ferito al filo del coltello; / adesso li possiedo tutti e due, / il sangue suo ed il mio amore ardente. Due occhi come un ramo spezzato, una persecutrice voce beffarda, onnipresente come un fantasma, poi un fantasma tutt’intero, quindi un fazzoletto insanguinato; tutto questo in una poesia d’amore. Non pare ci sia bisogno di molti commenti per spiegare fino a quale violenta intensità potesse depositare tale amore nelle poesie di Annette. La vena di decadenza e di morte sembra a volte stare da sola, ma si vede ben presto che è tutta sottesa dal ricordo di un amore; una libellula decapitata, un mozzicone di corda come capelli imputriditi, un tramonto riflesso da una pozzanghera come un occhio torbido, fiori malaticci e via dicendo, tutto questo gira intorno a un guardiacaccia morto, che 280 nell’immaginazione vaga ancora per i boschi, chiamando col fischietto il cane abbaiante e saltellante, mentre esso in realtà è stato ucciso sulla tomba del padrone (Das öde Haus - La casa abbandonata -, 1843-44). Un mazzo di fiori rimanda ad anime vaganti, al ricordo di una morta; una sala incantata è fatta di fiori che pendono come anime rinsecchite, ma dalle pareti scendono fate e sospiri d’amore mentre muschi e alghe avvolgono l’io lirico «come vene ripiene di sangue» (Meine Sträuße - I miei mazzi di fiori -; v. anche Blumentod - Morte di fiori -, 1820; Die tote Lerche - L’allodola morta -, 19844; e anche Im Grase - Nell’erba , 1844-45). Ci sono poi le poesie del ricordo, che allargano e restringono gli spazi secondo il bisogno (Die Taxuswand; Die Bank - La siepe di tasso, La panchina , 1842-43), fino a trasformare una cosa in quella desiderata: Die Bank (Str. 6.-7.) So sitz ich Stunden wie gebannt, Im Gestern halb und halb im Heute, Mein gutes Fernrohr in der Hand, Und laß es streifen durch die Weite. Am Damme steht ein wilder Strauch, O, schmählich hat mich der betrogen! Rührt ihn der Wind, so mein ich auch, Was Liebes komme hergezogen! Mit jedem Schritt weiß er zu gehn, Sich anzuformen alle Züge; So mag er denn am Hange stehn, Ein wert Phantom, geliebte Lüge; Ich aber hoffe für und für, Sofern ich mich des Lebens freue, Zu rösten an der Sonne hier, Geduld’ger Märtyrer der Treue. La panchina (str. VI-VII) Così, siedo per ore, affascinata, / divisa tra il passato ed il presente, / e lascio che il mio bravo cannocchiale / esplori la distanza. / Ecco, sopra la chiusa, quel cespuglio, / che terribile inganno ! / Se si scuote nel vento, / mi sembra venga avanti chi mi è caro! // Sa camminare al ritmo d’ogni passo / ed assumere tutti i connotati: / dunque, che resti accanto a quella siepe, / fantasma egregio, amabile menzogna. / Io continuo a sperare, tuttavia, / fintanto che di vivere son lieta, / di stare ad arrostirmi a questo sole, / paziente martire della fedeltà. Oppure ancora ripetono quella dedizione alle cose che già conosciamo, caricandole di una loro storia (Die Nadel im Baume; Nach fünfzehn Jahren - L’ago nell’albero, Quindici anni dopo -, 1842-43). 281 Annette von Droste-Hülshoff era la prima a sapere di quali tensioni era costituita; e sulla base di queste diede di sé un grande ritratto (Das Spiegelbild, L’immagine allo specchio), anche rielaborando il motivo romantico del sosia (Doppeltgänger - Il sosia -, 1844). Ecco disegnato l’aspetto scostante: Das Spiegelbild (Str. 4.) Und was den Mund umspielt so lind, So weich und hülflos wie ein Kind, Das möcht in treue Hut ich bergen; Und wieder, wenn er höhnend spielt, Wie von gespanntem Bogen zielt, Wenn leis es durch die Züge wühlt, Dann möcht ich fliehen wie vor Schergen. L’immagine nello specchio (str. IV) Ciò che intorno alla bocca si disegna, / la morbida dolcezza d’una infanzia indifesa, / vorrei custodirlo fedele; / ma quando accenna a scherno, / quando prende la mira come un arco, / quando s’altera appena l’espressione, / vorrei fuggire come dagli sbirri. Ma ecco, proprio alla fine, quel nucleo di tenerezza di cui non si può neanche dire che venga rivelato, sebbene tardi, ma piuttosto che viene ancora nascosto: (Str. 6.) Und dennoch fühl ich, wie verwandt, Zu deinen Schauern mich gebannt, Und Liebe muß der Furcht sich einen. Ja, trätest aus Kristalles Rund, Phantom, du lebend auf den Grund, Nur leise zittern würd ich, und Mich dünkt - ich würde um dich weinen! (Str. VI) / E tuttavia, come ti fossi affine, / un incanto m’avvince ai tuoi terrori, / e amore allo spavento deve unirsi. / Sì, se venisse fuori dallo specchio, / fantasma, e calpestassi questo suolo, / avrei soltanto un brivido, e mi pare, / - che piangerei per te! Non sarà fuor di luogo rilevare che la parte più intima occupa di preferenza gli ultimi versi delle poesie di Annette; così è in Am Turme, Brennende Liebe, Die Schenke am See (L’osteria in riva al lago; l’ammiccante saluto finale dell’oste alla coppia che se ne va è: «Geruh’ge Nacht – stehn’s nit zu zeitig auf!»), Das öde Haus (la scena affettuosa tra cane e padrone è proprio alla fine) e via dicendo: la zona più carica di affetti si protegge in tutti i modi, ponendo distanza sia attra282 verso modi scostanti sia altrimenti, con un pudore tanto più decisamente difeso quanto più intensa è la forza erotica. Ci sono poi descrizioni della natura, in parte vista, in parte immaginata, in parte vissuta: Die Mergelgrube (La marniera); Mondesaufgang (Sorgere della luna, 1844), Durchwachte Nacht (Notte insonne, 1844-45). Le ultime due le si vorrebbe citare per intero, tale è la loro bellezza; in Durchwachte Nacht è proprio la completezza del processo a contare, con quelle ore notturne che vengono scandite l’una dopo l’altra, dalle 10 di sera alle 4 e oltre del mattino. Ma anche se la lunghezza non lo permette, vanno tuttavia documentate alcune cose: la qualità delle immagini in Mondesaufgang: (Str. 1.) An des Balkones Gitter lehnte ich Und wartete, du mildes Licht, auf dich! Hoch über mir, gleich trübem Eiskristalle, Zerschmolzen schwamm des Firmamentes Halle; Der See verschimmerte mit leisem Dehnen, Zerfloßne Perlen oder Wolkentränen? Es rieselte, es dämmerte um mich, Ich wartete, du mildes Licht, auf dich! L’apparizione della luna (str. I) Appoggiata all’inferriata del balcone / ero in attesa, o luce soave, di te! / Alta sopra di me come un opaco cristallo di ghiaccio / libera fluttuava la cupola del firmamento; / il lago risplendeva nel suo distendersi lento / perle disperse o lacrime di nubi? / Un lieve mormorio, l’oscurità intorno a me, / io ero in attesa, o luce soave, di te! Per tornare ad assistere a immagini di tale abbondanza e varietà bisognerà aspettare il simbolismo. Così come sarà proprio del simbolismo sviluppare i motivi di Durchwachte Nacht, per esempio il seguente: (Str. 2.) Noch ist nicht alles Leben eingenickt, Der Schlafgemächer letzte Türen knarren; Vorsichtig in der Rinne Bauch gedrückt, Schlüpft noch der Iltis an des Giebels Sparren, Die schlummertrunkne Färse murrend nickt, Und fern im Stalle dröhnt des Rosses Scharren, Sein müdes Schnauben, bis, vom Mohn getränkt, Sich schlaff die regungslose Flanke senkt. Notte insonne (str. II) Ma non tutte le vite son già spente, / stridono, in casa, le ultime porte, / cauta s’arrampica, dentro la gronda, / per le travi del tetto, la mustela; / 283 la giovenca assonnata dà col capo, / lamentosa; lontano, nella stalla, / raspa, sbuffa il cavallo, sinché, vinto, / il fianco fiacco gli s’affloscia giù. Accanto alla produzione che si è cercato illustrare, Annette von DrosteHülshoff ne sviluppa un’altra fatta di ballate, di poemetti e di poesie religiose. Devo confessare al lettore che a me manca la sensibilità adatta a tale produzione; per non sottrargli l’informazione relativa riferirò pertanto quel che ne pensano gli estimatori. Fra i poemetti viene annessa particolare importanza a Des Arztes Vermächtnis (Il testamento del medico, 1834), in cui vengono dibattute le capacità della conoscenza umana e il libero arbitrio; il protagonista, tormentato da un avvenimento di cui non sa se sia avvenuto in sogno o nella realtà, dubita della verità del mondo in generale; né riesce a trovare la forza di liberarsi in un modo qualunque da questa situazione, che termina quasi nella follia. Molti estimatori ha anche il ciclo Das geistliche Jahr (L’anno liturgico, scritto in due riprese: 1820 e 1839), in cui le poesie che accompagnano l’anno liturgico diventano man mano una lotta della poetessa con se stessa, che cerca la propria fede e intanto manifesta tutti i suoi dubbi. Sul piano formale la raccolta è una grande prestazione: le 72 poesie che la compongono sono tutte variate per metrica, per ritmo, per sistema di rime. Annette von Droste-Hülshoff ha scritto anche un capolavoro in prosa, il racconto Die Judenbuche (Il faggio degli ebrei, 1842), che le acquisì molti consensi alla pubblicazione, venne poi rapidamente dimenticato, ma dalla ristampa avvenutane nel 1876 su suggerimento di Storm (e a cura di Paul Heyse e Hermann Kunz) si assestò permanentemente fra i racconti più letti dell’Ottocento. Anche qui Annette è grande maestra nell’arte del non dire. Ciò pone un qualche problema nel riassumere il racconto: quello di non cedere alla tentazione di spiegare più di quanto lì venga spiegato. La storia si svolge nel Settecento, anzi ci sono delle date precise: Friedrich Mergel, il protagonista, nasce nel 1738; un avvenimento cruciale (su cui ci intratterremo più in là) avviene nel luglio 1756, quando Friedrich ha diciotto anni; un altro, decisivo, nell’ottobre 1760 e tutto finisce nel settembre 1789. Tanta precisione da una parte quanta vaghezza dall’altra. All’inizio vengono date anche delle motivazioni sociologiche di quel che si sta per narrare: tutto avviene in una società chiusa e appartata, senza né industrie né commercio, con leggi troppo semplici e insufficienti, così che sulle idee di giusto e ingiusto si era creata una qualche confusione. Furti di legname e bracconaggio erano all’ordine del giorno e il villaggio nel quale Friedrich nasce e cresce ne era particolarmente esperto. Suo padre, un violento ubriacone, muore assiderato quando Friedrich ha nove anni; la madre resta a dargli insegnamenti secondo i quali gli ebrei sono tutti delinquenti e il furto di legname e il bracconaggio sono cose lecite. Tre anni dopo un fratello della madre, Simon, si offre di prendersi cura del ragazzo; in realtà lo corrompe. Friedrich diventa uno strano personaggio: dà pochi soldi a casa, ne spende quanti può per fare l’elegante, lavora vigorosamente per guadagnare e per poi passare il tempo in un’occupazione che 284 non è più per un diciassettenne: custodire le mucche al pascolo, straccione e sognante. Nel frattempo una imprendibile banda di ladri di legname prende talmente a imperversare, con tanta impudenza e tanti danni che le guardie forestali devono darsi da fare più del solito, peraltro senza venire a capo di nulla. Faccio ora posto a una lunga citazione, per mostrare come la scrittrice riesca ad alludere senza dire. Siamo in un giorno del luglio 1756, alle tre del mattino; Friedrich è al pascolo, sdraiato sull’erba, con gli occhi quasi chiusi dalla stanchezza e tuttavia a guardare l’imboccatura della valle: Dalla boscaglia giungeva di quando in quando un rumore sordo, seguito da uno schianto; durava pochi secondi, ripercuotendosi in una lunga eco contro le pareti di roccia; poi di lì a poco, da cinque a otto minuti, ricominciava di nuovo. Friedrich non ci faceva caso; solo qualche volta, quando il fragore era eccessivamente forte e prolungato, alzava il capo e girava lentamente lo sguardo sui vari sentieri che sboccavano nel fondovalle. Il chiarore dell’alba si andava già intensificando; gli uccellini cominciavano a cinguettare, e la rugiada montava sensibilmente dal fondo. Friedrich, appoggiato al suo tronco, s’era lasciato scivolare sul dorso e, con le braccia intrecciate sotto la nuca, seguiva immobile il graduale affacciarsi dell’aurora. D’improvviso balzò a sedere, gli passò un lampo sul volto, e per qualche secondo rimase con l’orecchio teso e il busto in avanti come un segugio cui giunga sentore di selvaggina. Si cacciò fulmineo due dita in bocca ed emise un fischio acutissimo, prolungato. - Fido! Bestia maledetta… - e un sasso andò a colpire sul fianco lo sprovveduto animale che sonnecchiava senza la minima preoccupazione, ma, svegliato di soprassalto, dapprima roteò su se stesso azzannando a vuoto, poi saltellando su tre zampe e guaiolando s’avviò proprio nella direzione da cui gli era piovuto il malanno. Nel medesimo istante i rami d’un vicino cespuglio si scostarono senza quasi frusciare e ne venne fuori un uomo vestito d’una cacciatora verdognola, con uno scudetto sul braccio sinistro e schioppo in pugno col grilletto armato. Lanciò una rapida occhiata verso la gola boscosa, fissò a lungo e con particolare intensità il giovane, poi fece un passo avanti e accennò in direzione del cespuglio. Ne sbucarono fuori ad uno ad uno sette otto individui, tutti nella stessa montura, coltello da caccia alla cintola e schioppo in pugno pronto a sparare. Il capo dei forestali interroga Friedrich, che però dà delle risposte vaghe; manda allora avanti gli altri per restare solo con Friedrich, al quale rivolge parole ingiuriose; Friedrich riesce a mantenersi calmo, a fargli notare che lui non ha mai rubato legname, a esortarlo a passare sopra quanto di spiacevole entrambi hanno detto. Un brontolio imbarazzato fu la sola risposta del forestale, che come la maggior parte dei caratteri ruvidi era facile a pentirsi. Voltò brusco le spalle e s’incamminò verso la macchia di cespugli. 285 - Non di lì, sior Brandis! – gridò Friedrich. – Se volete raggiungere i vostri, è di lassù accanto al faggio che sono andati. - Al faggio? – ripeté incredulo il forestale. – Mai più! Hanno preso di là, per il Mastergrund. - E io vi ripeto: accanto al faggio! Ma se è proprio lì, a quel ramo storto, che s’è impigliata la cinghia dello schioppo di Heinrich, cul Stangun! O io sono cieco? -. Il forestale si lasciò convincere e s’avviò nella direzione indicatagli. Friedrich per tutto quel tempo non aveva cambiato posizione; semisdraiato, il braccio intorno a un ramo risecchito, guardava immobile come l’altro scivolava lungo il sentiero invaso dalla vegetazione, col passo lungo e cauto di quelli del suo mestiere; silenzioso come la volpe che s’arrampica sul pollaio. Dietro di lui ricadevano qui un ramo, lì un altro, e i contorni della sua figura si facevano sempre più vaghi. Ancora un luccichio tra le fronde: un bottone metallico della sua cacciatora, ed era scomparso. Il volto di Friedrich durante quel graduale eclissarsi aveva perduto la sua impassibilità glaciale; alla fine i suoi tratti sembravano inquieti e agitati. Si pentiva forse di non aver raccomandato al Brandis di tenere per sé le informazioni fornitegli? … Fece alcuni passi in quella direzione, e s’arrestò. - Troppo tardi! – disse fra sé, e allungò la mano verso il suo cappello. Un lieve picchiettio tra i cespugli, a una ventina di passi: ancora il Brandis, che affilava la pietra focaia. Friedrich stette in ascolto, poi tagliò corto: - No! – e frettolosamente raccolte le sue robe, spinse le mucche attraverso la gola. Friedrich torna a casa ammalato e resta agitatissimo per tutto il giorno. Più tardi verremo a sapere che il forestale è stato ucciso nella notte. Attraverso indizi vari il lettore si convince che a ucciderlo è stato lo zio di Friedrich; viene a sapere che Friedrich ha indicato al forestale una direzione sbagliata, ma non certo con l’intenzione di mandarlo a morte. La banda incriminata scompare; in altra circostanza si verrà a sapere che Friedrich possiede anche un qualche scritto di persona sospettata di rapporti con la banda. Ma oltre questo non si ha alcuna certezza; il lettore può sospettare quel che vuole, l’autrice non gli dice niente di più. Passano gli anni, Friedrich ricade sotto l’influsso di Simon; voglioso di brillare e suscettibile, è sempre dovunque ci sia da divertirsi e sempre in lite con tutti. Si scopre presto che fa debiti. Nell’ottobre 1760 c’è una festa in occasione di un matrimonio (un triste matrimonio, detto per inciso: una giovane donna va in sposa a un vecchio brontolone di cui deve rimettere a posto un’economia domestica sbandata e amarlo per di più). Friedrich vi compare e vuol fare la sua bella figura ostentando un orologio d’argento; presto però compare il creditore, l’ebreo Aaron, a reclamare dieci talleri, dovutigli già dalla Pasqua, proprio per quell’orologio. L’orgoglioso Friedrich, annientato e pallido come un cencio, abbandona la festa. Tre giorni dopo viene trovato il cadavere di Aaron, ucciso da un corpo contundente, sotto un faggio dello stesso bosco in cui l’ubriaco padre 286 di Friedrich era caduto e morto assiderato. Si cerca Friedrich a casa sua; non c’è, ma il suo letto è ancora caldo. Si ricostruisce che Aaron era stato ucciso la sera stessa del litigio con Friedrich. La comunità israelitica compra il faggio al fine di non farlo abbattere e vi fa incidere una scritta in ebraico, che verrà tradotta solo alla fine del racconto. Sei mesi dopo un altro ebreo confessa, in tutt’altra circostanza, di essere stato lui a uccidere Aaron a fine di rapina; ma s’impicca prima che la confessione venga convalidata. Ci si chiede perché allora Friedrich sia scappato e si pensa che sia per qualcosa connesso con i furti di legname. Ventotto anni più tardi lo stesso Friedrich, che torna sotto mentite spoglie dalla prigionia turca e senza che tutti i particolari del suo ritorno siano chiariti, all’apprendere del suo scagionamento commenterà: «tanti patimenti per nulla»; e come ragione della fuga darà la questione del legname e la parte che vi aveva avuta lo zio Simon, anche qui senza effondersi in particolari. Circa un anno dopo si impicca al faggio dell’ebreo, su cui la scritta incisa recava: «Al tuo avvicinarti a questo luogo andrà a te come tu avrai fatto a me». Questa scritta fa intendere che a uccidere Aaron è stato effettivamente Friedrich (così come era sulla base della fonte utilizzata dalla scrittrice); si badi però che il testo non lo dice e che esso anzi dà dei segnali contrari. Ed è questo l’aspetto da privilegiare, è qui la grande arte della Droste-Hülshoff. Die Judenbuche non è un giallo, non c’è da indovinare l’assassino; c’è invece il contrasto fra ciò che si sa o si crede di sapere con certezza, le conseguenze cui crede di pervenire il raziocinio umano e la non controllabilità di quel che avviene sia in base a quel che non sappiamo sia a quel che crediamo di poter conseguire sulla base delle nostre ipotesi. Come si vede, un processo d’occultamento è alla base della lirica così come della prosa di questa scrittrice. Excursus: Il racconto a cornice E un processo quando non di occultamento (il che peraltro è vero per Stifter) almeno di allontanamento è la chiave del racconto a cornice e ciò che aiuta a spiegarne il successo, che fu grande e motivato soprattutto nell’epoca della quale ci stiamo occupando. Il racconto a cornice è in realtà un doppio racconto, fatto di uno esteriore (Rahmenerzählung) che al proprio interno reca un altro racconto (Binnenerzählung). Alle origini di questa forma c’è il ciclo di racconti: una qualche azione generale introduce e separa tra loro singoli racconti; il lettore italiano può comodamente e fondatamente pensare al Decamerone come a uno dei modelli di tale ciclicità. Un modello simile venne proposto per la prima volta in Germania da Goethe (Unterhaltungen deutscher Ausgewanderter - Conversazioni di fuoriusciti tedeschi -, 1795) e venne ripreso dai romantici (Achim von Arnim, Der Wintergarten - Il giardino d’inverno -, 1809; Ludwig Tieck, Phantasus - Fantasio -, 1812-16; E.T.A Hoffmann, Die Serapionsbrüder - I fratelli di S. Serapione -, 1819-21) e da chi già viene classificato nel Biedermeier (Wilhelm Hauff, Märchen – Fiabe -, 1825-28). Per importanti che siano questi 287 precedenti, occorre pur dire che col singolo racconto a cornice avviene un gran salto: la cornice infatti non gli è più esterna, ma ne fa parte integrale; e il problema del rapporto fra cornice e narrazione interna diventa cruciale. I vari autori lo risolveranno ognuno a suo modo e tuttavia qualche costante si può stabilire: di solito c’è un personaggio che figura sia nella cornice sia nel racconto interno, costituendo il tramite fra i due; ha in entrambi una funzione subordinata, ma soprattutto l’ha nel racconto interno. È infatti in quest’ultimo che hanno luogo gli avvenimenti più inquietanti e la strategia narrativa consiste proprio nell’allontanarli e nell’addomesticarli. Questo è il punto più importante e più costante, mentre per il resto sono possibili molte variazioni, la più frequente delle quali è che il narratore esterno introduce un narratore interno senza comparire nel narrato di quest’ultimo; a volte il narratore interno prende voce attraverso un manoscritto rivelato per l’occasione; oppure il racconto interno contiene a sua volta un racconto ancora più interno; e via dicendo. Quella che colpisce di più è comunque la strategia di allontanamento, suggerendo al lettore il problema di come valutare la Binnenerzählung all’interno della vita meno inquietante (almeno all’apparenza) che si svolge nella cornice. Il grande maestro del racconto a cornice, colui presso il quale tale forma ha più senso che in chiunque altro, è stato Adalbert Stifter. V, 2. Nella notte fra il 25 e il 26 gennaio 1868 Adalbert Stifter, già infermo da tempo, si vibra una rasoiata alla gola. La moglie, che l’aveva lasciato solo, lo trova rantolante e fuori conoscenza in mezzo a un lago di sangue. La morte avverrà due giorni dopo, senza che l’agonizzante abbia ripreso conoscenza. Sul certificato di morte, il medico ne attribuisce la causa a «febbre etica»; si tenta in tutti i modi di nascondere il suicidio, dirottando l’attenzione verso la cirrosi epatica, l’atrofia, il catarro e tutto il resto di cui Stifter da anni soffriva. E così al momento della morte si replicava una costellazione schizofrenica quale l’aveva accompagnato in vita. A Oberplan (nella Boemia allora austriaca) da un modestissimo commerciante di lino che morrà dodici anni dopo, nasce l’autore il 23 ottobre 1805. Così dicono i documenti; non però le dichiarazioni autobiografiche, che promuovono la data a 1806, così da rimuovere i due soli mesi che erano intercorsi tra le nozze dei genitori e quella nascita. Otto anni Stifter li passa nell’abbazia benedettina di Kremsmünster, allievo modello nella cui opera non si avvertirà traccia confessionale. A 21 anni s’iscrive alla facoltà di Legge di Vienna, frequentando però non le lezioni di diritto ma quelle di matematica e scienze naturali, studiacchiando poi per conto suo un po’ di filosofia, storia e fisica. Soprattutto dipinge, legge Goethe e Hartmann, si entusiasma per Jean Paul. 288 Si innamora di Fanny Greipel; è vero che né la famiglia di lei (ricchi commercianti) né lei stessa sembrano tanto convinte. Comunque Stifter rifiuta di farsi una posizione (il che l’avrebbe potentemente aiutato nel suo corteggiamento) “dimenticando” di sostenere una prova orale per avere un posto all’università di Praga, dopo che aveva superato la prova scritta. E mentre invia a Fanny lettere e versi, conosce una modista di nome Amalia Mohaupt; con Fanny era l’amore angelico, con Amalia finalmente c’è il sesso (ci sarà - pare anche una figlia prima del matrimonio, morta dopo poche settimane; e poi gli Stifter non avranno più figli). Amalia, gelida, dura e ignorante, si scatenerà nel consumismo appena potrà, asseconderà il marito nella pedanteria ... e lo aiuterà a precipitarsi nei debiti. Fanny dunque è scomparsa dalla scena e Stifter sposa Amalia; i due adottano una serie di “figlie”, parenti di lei o presunte parenti di lui. In realtà vengono trattate da serve e ne muoiono tre, una dopo l’altra; la prima di loro, suicida dopo una vita di oppressione. L’aveva in qualche modo preceduta una sorella di Amalia, che inizialmente viveva coi due coniugi e che i due avevano fatto morire da sola all’ospizio, senza poi neanche presentarsi al funerale. I rapporti tra marito e moglie non sono meno schizofrenici: Stifter sopporta la moglie come un gran peso, ma non può farne a meno. Si lamenta quando lei è lontana (e lei gli risponde, in lettere che sono tutte una sgrammaticatura, di mandarle i soldi per il viaggio invece di far tanto il poeta); e poi scappa di notte (letteralmente) quando lei si avvicina troppo. E i rapporti con la madre? A credergli, la ama sopra ogni cosa, ma nei lunghi anni in cui abitano vicini non va mai a trovarla; e in Granit (Granito) ne fa un ritratto gelido. Nel racconto Das Heidedorf (Il villaggio nella landa) erige un monumento alla propria nonna; ma il ricordo che ne dà nel frammento autobiografico, sotto forma di complimento, offre il ritratto di una sadica. Si potrebbe continuare così per un pezzo: recita la parte del borghese ben pasciuto (mangia fino a diventare così grasso da occupare, a braccetto della moglie, tutta la scala che un entusiasta, ignaro lettore sale a quattro a quattro per un appuntamento col prediletto descrittore di vaghe silfidi) ma è querulo appena può. Non è mai riuscito a concludere gli studi ma recita la parte del gran didatta. È reazionario e nazionalista, ma progetta di scrivere un romanzo sull’ammirato Robespierre. Vive vent’anni a Vienna, ma di nessuna città c’è traccia nelle sue opere di livello. E per di più la cosa non gli serve nemmeno un po’ a sprovincializzarsi. Ma questo provinciale logorroico e montato, questo nevrotico modello, ha creato fra i maggiori capolavori nella letteratura europea del suo tempo e non solo del suo. Egli - come altri autori di quella fase che nella letteratura tedesca va sotto il nome di Biedermeier - basa la sua forza sul concetto di scissione: un mondo ordinato, tutto ben assestato, immobilizzato, gerarchizzato, insomma idillico, nasconde abissi; anzi non semplicemente li nasconde: l’abisso è piutto289 sto la sua vera struttura. Accanto a ciò, l’aspetto illuminista sopravvive e si rinvigorisce. Per cui in definitiva la schizofrenia si rivela come un troppo lento (o addirittura impossibile) tradurre nella prassi quel che in teoria appare più che digerito. La sfasatura fra i due piani è la vera malattia mortale di Stifter. Il quale pubblicò numerosi racconti, la più parte dei quali da lui riuniti in due raccolte (Studien – Studi -, 1844-50, e Bunte Steine - Pietre variopinte -, 1853), due romanzi (Der Nachsommer - Tarda estate -, 1857, Witiko, 1865-67) e qualche saggio di tipo giornalistico. In vita dell’autore ebbe successo solo la prima raccolta (che arrivò a quattro edizioni); il primo romanzo gli attirò lo sberleffo di Friedrich Hebbel, il quale sostenne che chi fosse stato capace di leggerlo fino in fondo avrebbe meritato la corona del regno di Polonia; il secondo romanzo gli sbarrò addirittura l’accesso a qualche rivista che pur gli aveva commissionato alcuni dei suoi ultimi racconti. Di Hebbel avremo modo di riparlare; da un suo epigramma già rivolto contro i racconti delle Studien venne provocata l’importante prefazione a Bunte Steine. Il metodo secondo il quale viene scritto il presente volume ha cominciato a svilupparsi sulle esperienze fatte analizzando Kleist e Stifter; quest’ultimo cade nell’arco cronologico qui previsto e si ha quindi l’occasione per essere più espliciti in questioni metodologiche. Occorre peraltro una conciliazione con i problemi di spazio; pertanto verranno esaminati ampiamente alcuni pochi racconti e sacrificati gli altri e i romanzi (a parte pochi cenni). Dalle Studien scelgo due racconti: Der Hagestolz (Lo scapolo), ma innanzitutto Abdias, un racconto che, già pubblicato a parte, portò a Stifter il suo primo successo. Vi si narra la storia dell’ebreo Abdias. Costui, che vive in Algeria, intraprende per obbedienza al padre la carriera di mercante mentre la sua natura lo porterebbe piuttosto alla meditazione; sposa la bella Deborah ma il matrimonio è infelice. La sua casa viene saccheggiata, Deborah muore per un misto di spavento e di fatiche del parto; partorisce infatti una figlia, Ditha, che nasce cieca. Abdias abbandona l’Africa per l’Europa (e più precisamente per la Boemia), al fine di mettere in salvo la figlia e tornare a vendicarsi di chi è la causa delle sue sventure; ma l’attaccamento alla figlia lo fa indugiare in Europa. Gli effetti di un fulmine ridanno la vista a Ditha; ma non molto tempo dopo un altro fulmine la ucciderà. Il padre ne resterà sconvolto fino a una forma di innocua follia. Questo è il bruto riassunto. Segue ora l’analisi. Per esplorare Abdias dobbiamo attraversare tre livelli di significato: al primo c’è il problema del rapporto causa-effetto, al secondo c’è quello della poesia, al terzo ci sarà quello dello spazio e dell’organizzazione del mondo sulla base della non-loquenza. I primi due sono relativamente semplici da analizzare: le analisi già fatte da altri in materia ci saranno d’aiuto e varie sentenze di Stifter completeranno l’opera. Il terzo porrà problemi nuovi. Le prime due pagine del racconto (specie di introduzione tematica subito ritrattata), enunciano il tema della causalità. Parlare di fato quale «ultima irrazio290 nalità dell’essere» oppure cristianamente di destino («una cosa mandata da una potenza superiore») non è un parlare corretto, poiché essi vanno sostituiti con una «serena catena di fiori, [...] la catena delle cause e degli effetti». Questa catena ha qualcosa di singolare: da una parte essa appare quanto di più oggettivo si possa pensare, distesa com’è attraverso tutto il mondo («si stende attraverso l’infinito»), in maniera dunque che niente le possa sfuggire. Dall’altra però l’uomo non ne sembra prigioniero: il suo cuore ne viene illuminato, il che è evidentemente meno forte che inserirlo in un lungo rapporto causale; ma soprattutto la ragione, che è pur un elemento della catena, è quella che può fungere da centro prospettico e riannodare la catena stessa fino al suo compimento, cioè fino a Dio. La ricostruzione avviene dunque attraverso una prospettiva soggettiva: senza epicentro nella ragione umana, niente catena. Se ora la catena è ricostruita completamente e correttamente, non c’è caso ma conseguenze (quel che noi chiamiamo l’inatteso sono soltanto le lacune della ricostruzione); e non c’è disgrazia ma colpa (quel che chiamiamo sventura è in realtà un uso scorretto della causalità). Delegato a operare la ricostruzione con completezza è il progresso della conoscenza umana, il quale farà vedere come perfino il dolore è, in ultima analisi, anch’esso un fiore di quella catena. E bisogna dire che a questa dimostrazione sembra mirare l’illuminismo provvidenzialistico di Stifter: il temporale che in Abdias dà la vista a Ditha provoca altrove devastazione, quello che le dà la morte è per altri luoghi una benedizione, così come il temporale finale dello Hagestolz provoca da una parte effetti benefici, dall’altra malefici: l’armonia del tutto è fatta di contrari che uno sguardo superiore sa conciliare. Ma questa modesta sapienza viene interrotta già nella prefazione, che mette fine alle ipotesi per limitarsi a raccontare una storia che non risolve il problema ma induce a porselo. Lo dice lo stesso Stifter (che nelle sue opere ci dà molto di più di quanto non riesca a far affiorare nella sua riflessione). Per prima cosa cerchiamo di renderci conto delle sue intenzioni. In Abdias egli effettivamente costruisce una sequenza completa di cause ed effetti: ciò che succede al protagonista è sempre riconducibile a una causa, umana o naturale; e, quando la causa è umana, le colpe e i meriti di Abdias sono attribuibili con certezza. Da Abdias potremmo addirittura ricavare una specie di questionario a domanda e risposta; invito il lettore a seguirmi in questo esperimento perché, anche se è un po’ buffo, mostra con estrema evidenza quanto sia stretta quella catena di cause ed effetti cui Stifter si riferiva: DOMANDA: Perché Abdias, che pure è un sognatore, che anzi sembra avere la stoffa del profeta, si dedica al commercio? RISPOSTA: Perché obbedisce a suo padre Aaron e alla sua filosofia («poiché l’uomo non ha null’altro al mondo se non ciò che egli si acqui- 291 sta») e perché questa è la tradizione, che anch’egli accetta («ma allora il figlio rassegnato e paziente prendeva il bastone del padre») da bravo figlio obbediente. DOMANDA: Perché Abdias è odiato? RISPOSTA: Perché «Fortuna e ricchezza si accumulavano sempre di più.» DOMANDA: Perché sua moglie Deborah lo disprezza e lo fugge? RISPOSTA: Perché Abdias è rimasto sfigurato dal vaiolo e Deborah «aveva ricevuto solo occhi carnali, per vedere la bellezza del corpo, e non gli spirituali, quelli del cuore.» DOMANDA: E allora perché Abdias l’aveva sposata? RISPOSTA: Perché «quando l’aveva scorta a Balbek anche lui non aveva visto che la sua grande bellezza, e quando fu lontano non portò con sé che il ricordo di quella bellezza.» DOMANDA: Perché Abdias si dà sempre più al commercio e sta sempre più lontano da casa? RISPOSTA: «perché in terre lontane aveva ciò che a casa gli era negato: stima, considerazione, autorità.» DOMANDA: In che modo Abdias tradisce la sua città? RISPOSTA: Facendo ostentazione di ricchezza, per esempio andando in giro «nelle loro frivole vesti». DOMANDA: Perché Melek-Ben-Amar saccheggia la città? RISPOSTA: Perché, quando si era presentato a Abdias come inviato del Bei a trattare un prestito, questi lo aveva trattato dall’alto in basso («assai a lungo l’aveva fatto aspettare e assai insistentemente l’aveva fatto pregare prima di accondiscendere»). E si potrebbe continuare così fino alla fine. Ma penso che basti accennare brevemente ad alcuni punti importanti: Abdias vuole vendicarsi di Melek e piantargli un coltello nel cuore perché questo è l’uso del suo popolo. Va perciò in Europa perché vuole mettere la figlia al riparo da Melek. La nascita di Ditha l’ha allontanato dal commercio perché Abdias vuole dedicarsi tutto alla sua missione 292 di padre e di vendicatore. La scoperta della cecità di Ditha lo fa però tornare al commercio al fine di assicurare alla figlia quella ricchezza in cui, come già suo padre, vede l’unica sicurezza. Quando però Ditha riacquista la vista, cambia anche la vita di Abdias, che abbandona il commercio per darsi all’agricoltura. E infine quando Ditha muore, Abdias - colpito in quell’affetto che è stato la causa immediata più importante dei tanti cambiamenti successivamente intervenuti nella sua vita - non regge al colpo e impazzisce. A parte queste cause, chiare e certe, ci sono relazioni causali più sfumate, meno certe nei meccanismi, ma non meno univoche. Tali sono innanzitutto quelle riconducibili a cause naturali. Le condizioni in cui Ditha è partorita possono essere state causa della sua cecità (il narratore non ce lo dice esplicitamente ma ce lo lascia supporre). La motivazione del processo a seguito del quale Ditha riacquista la vista è molto cauta e data sottolineando la nostra ignoranza delle cause naturali; però non è meno certa, anche se il narratore sottolinea come ne siano sconosciuti i meccanismi (a livello filologico si sono potute ricostruire le conoscenze di magnetismo ed elettricità che Stifter aveva e che ha utilizzato per l’occasione). La ragione della morte di Ditha è ugualmente univoca: l’elettricità, di cui lei come suo padre sono carichi in maniera eccezionale, costituisce già un pericolo in occasione dell’esposizione a un temporale; per di più Abdias accumula una quantità di covoni per riparare sé e la figlia da una pioggia che non cadrà: tutto questo attira il fulmine e Ditha muore. Ecco dunque che c’è una causa naturale (attrazione elettrica) e una causa umana (l’accumulo di covoni), dunque una responsabilità non molto dissimile da quella per cui Abdias aveva ucciso un suo fedele cane, fraintendendone il comportamento e credendolo rabbioso. Ci sono poi rapporti causali più complessi. La persecuzione cui Abdias è sottoposto da Melek causa molti danni, fra cui la morte della moglie Deborah. E tuttavia essa fa in tempo a riportargli l’amore di Deborah e dare a costei la felicità, anche se l’uno e l’altra durano pochissimo. Anzi dopo il momento distruttivo che vorrebbe fargli gettare la figlia sulle sciabole dei soldati predatori, Abdias scorge in quegli affetti «il principio di quella salvezza, che non era mai venuta e che non aveva mai saputo dove cercare». Altrettanto complessa - magari anche di più - è la ragione per cui Abdias va in Europa. Sappiamo già che vi vuole mettere al riparo Ditha per quando andrà a vendicarsi di Melek. Ma l’attrazione per l’Europa è di molto precedente: Abdias è in realtà attratto da un altro modo di vivere e da un altro sapere. Perciò nella decisione di passare in Europa giocano più motivi: quello della sicurezza è cosciente e viene enunciato, quello della autoaffermazione è remoto e il lettore deve ricostruirlo. Insomma le tesi di Stifter sono ricostruibili con chiarezza e il racconto potrebbe essere rinarrato da questo punto di vista: le cause dei comportamenti di Abdias possono essere ricostruite sia sul piano sociologico (addirittura per quel che riguarda i moventi più lontani, fino al carattere: Abdias è taciturno perché 293 vissuto nel deserto, nasconde i suoi pensieri perché perseguitato da secoli, si dà al commercio perché è obbediente), sia sul piano più immediato e individuale quando si devono spiegare cose puntuali. Quindi si possono dare le cause delle decisioni, delle capacità e delle incapacità, delle colpe e dei meriti. Alla fine si ottiene un equilibrio complessivo in quella fiorita catena di cause ed effetti; basterà ricordare gli esempi dei due temporali che portano sia vita sia distruzione, così come il saccheggio di Melek aveva portato odio per Abdias ma anche l’amore di Deborah per lui. Non solo tutto si equilibra, ma alla fine trionfa addirittura il bene: Abdias ha reso fertile quella valle desolata, e seppure non ne abbiano goduto molto né lui né Ditha, la terra però è passata a suoi amici. Come se non bastasse, Stifter sembra voler suggerire che noi stessi possiamo trovare un equilibrio personale all’interno di quella catena che è la vita. Non lo dice, per la verità, in maniera diretta; tuttavia la nettezza con cui sono individuate le cause dei comportamenti di Abdias sembra andare in questa direzione. E non c’è da negare che una tale sapienza non è da disprezzare, anzi che è utile e che lo si voglia ammettere o no - costitutiva della nostra vita. Se però si dovesse limitare Stifter a questo catechismo, sarebbe mortalmente noioso e disperatamente insufficiente. Occorre dunque cercare gli altri strati di significato per vedere se c’è di più. Il secondo strato di significato è quello simbolico; come ci si può aspettare, vi si accede dal precedente. Occorre infatti chiedersi: quale è la causa per cui Abdias comincia a deviare dalla retta via per andare incontro al suo destino? La risposta è: l’obbedienza (con tutta la dialettica caricata su questa risposta). In soldoni: Abdias ha represso in sé la sua tendenza fondamentale, diciamo pure la sua vocazione, che perfino il padre aveva intuito: quella di darsi alle gioie non materiali, alle gioie che appartengono al cuore; di diventare un profeta e una guida per il suo popolo. Il ragazzo - «tenero fiore» - è portato a pensieri del genere. E anche nel deserto Abdias potrebbe diventare quel che Maometto diventò per il suo popolo: la tendenza alla riflessione è analoga nei due, e all’apparenza anche la loro vita è simile. Di tale riflessione ci sarà una reminiscenza quando, schivato da Deborah, Abdias penserà a un nuovo tipo di sapere, quello europeo. Ma è un pensiero per il quale Abdias non cerca conseguenze reali: Ma erano solo pensieri fuggevoli; così un fiocco di neve scende davanti al viso di chi valica l’Atlante, ed egli non riesce ad afferrarlo. E finalmente, proprio come Maometto, Abdias riesce a dimostrare le sue doti di condottiero in battaglia; solo che ne rifiuta le smodatezze, detesta come i vinti di poco fa si trasformino in belve. «Abdias, che aveva guidato l’attacco, era impotente a frenarlo». E poi ormai è troppo tardi per certi pensieri, possono al massimo aversi delle fantasticherie. Il mancato profeta sembra realizzarsi nella figlia Ditha, in cui si suol vedere il simbolo della poesia. Riassumo velocemente 294 i risultati cui è giunta la critica: Abdias e Ditha sono ebrei sia perché nell’Oriente («orientali» sono per Stifter gli ebrei) Stifter vede la fonte della poesia (secondo una affermata tradizione), sia perché, essendo perseguitati e costretti a nascondersi, essi dimostrano entro quali stretti limiti la poesia possa influire sul mondo. I tanti riferimenti all’Oriente fatti durante il soggiorno dei due in Europa dovrebbero evidenziare il trapiantarsi della poesia da Oriente a Occidente (l’Algeria, da cui prende le mosse la novella, non è più a oriente della Boemia, ma sul piano simbolico la cosa non ha influenza). Questi pensieri possono essere sviluppati e di fatto lo sono stati, raggruppando intorno a loro gran parte del materiale di Abdias. Giustamente si è insistito sul carattere ambivalente della poesia: Ditha sboccia alla vita ma di fatto si ravviva solo quando la natura presenta aspetti distruttivi, come durante i temporali. Ma tutta questa parte riceve la sua luce dal terzo strato. Per arrivarci ipotizzo (stavolta devo limitarmi a un’ipotesi) ancora un legame causale. Ditha è nata cieca e non cammina; tra queste due cose c’è un evidente legame: Ditha non vuol camminare perché le manca la vista per orientarsi nello spazio. Ditha è nata cieca e non parla: suppongo che Stifter abbia visto un legame causale anche tra questi due elementi (il secondo dei quali sarebbe altrimenti ingiustificato nel racconto, contro tutti i principî stifteriani. Perché e percome ce l’abbia visto però non sono in grado di dire). Su questo non parlare, l’autore insiste a lungo. Ditha emette suoni fuori del comune, di cui tutti ignorano il significato: Anche la sua lingua non parlava ancora, ma quando era molto contenta emetteva strani balbettii, che non somigliavano ad alcuna lingua umana e non si sapeva che cosa significassero. [...] Pronunziava le sue ignote parole. E c’è poi quel passo straordinario in cui Abdias, riconosciuta la cecità della figlia, di cui non si era accorto fino a quel momento, accetta di ricevere da lei un’educazione linguistica, di imparare cioè quella lingua ignota, per cui Ditha inventa sempre nuove parole, e in cui i due si capiscono: Le insegnava le parole di cui lei ignorava il significato - lei ripeteva le parole e ne inventava altre attinte alla sua condizione interna, che egli non capiva e che imparava a sua volta. Così parlavano insieme per ore e ore e ciascuno di essi sapeva ciò che l’altro intendeva. Stifter sostiene qui una tesi da lui ribadita anche in altri racconti: la poesia risiede al di là del linguaggio. Il discorso si appunta poi sulla natura liminare della poesia. Questa ha le radici nella non lingua, tuttavia è nella lingua che deve avvenire la sua manifestazione. Ciò è possibile grazie alla mediazione che la poesia è in grado di sviluppare. Il lungo processo nel quale Ditha, improvvisamente vedente, si appropria del mondo esterno, culmina nell’illustrare la peculiarità della sua appropriazione: la vita diurna e la vita onirica sono per lei tutt’uno; e 295 quelle immagini che del mondo si era fatta da cieca - incomprensibili per tutti si mescolavano ora a quelle esterne. C’è da chiedersi se, oltre a quelle immagini, non ci sia anche da dire “la sua lingua”. La conseguenza di questa sintesi è: ne nacque un modo di pensare e di parlare che a chi non la conosceva appariva altrettanto sconcertante che se avessero davanti a sé un fiore parlante. Così viveva in un mondo fatto di vista e di cecità. Si potrebbe banalizzare tutto mettendo in evidenza una semplice e schietta verità: in tal modo Stifter vuol fondare il diritto dello scrittore alle sue figure retoriche, delle quali in particolare esemplifica la sinestesia. Ma il problema è più vasto; Stifter alla fine non assegna a Ditha nessuna lingua particolare ma un miscuglio di ben tre: arabo, una seconda innominata lingua orientale e la lingua del posto (il tedesco): Così la fanciulla conosceva in realtà una mescolanza di tutte quelle e in tale lingua si esprimeva e aveva un modo di pensare adeguato a essa. Non si sarebbe potuto parlare più chiaro sulla natura liminar-mediatrice della poesia. Ora è questa poesia, non-loquente, mediatrice, distruttrice e impotente, a ricostruire il mondo. Ma arrivati a questo punto non possiamo più procedere semplicemente allineando dichiarazioni di Stifter. Dobbiamo fare un salto. La ricostruzione del mondo avviene infatti attraverso la forma della narrazione e qui ci incontriamo con i concetti di progetto, tempo e spazio. Lo studio dei rapporti causali può infatti giustificare quanto finora detto e quanto ancora ci sarebbe da dire in proposito ma non giustifica - almeno non allo stesso modo l’avvicendarsi dei modi della narrazione. Intanto guardiamo il cammino percorso: dalla fisica (la catena delle cause e degli effetti) siamo passati alla metafisica (la non-loquenza della poesia) da cui stiamo ora ritornando alla fisica (alla rifondazione del mondo esterno), che per tal via assumerà un altro aspetto. Possiamo ora dividere Abdias in quattro parti; la divisione dipende dal modo della narrazione. Nella prima parte noi seguiamo i pensieri di Abdias, che appunto ci vengono rivelati, e controlliamo i suoi movimenti sintetizzando il tempo e lo spazio. Per esempio leggiamo: Quando furono passati alcuni anni dalla morte di Aronne e di Esther [= i genitori di Abdias], le cose principiarono man mano a mutare nella casa presso le palme. Fortuna e ricchezza si accumularono sempre di più. Abdias era solerte nel suo lavoro e lo estese maggiormente, e faceva del bene agli animali, agli schiavi e ai vicini. Ma in cambio quelli l’odiavano. Sulla donna che s’era scelta secondo il suo cuore riversava i beni di questa terra e, sebbene fosse sterile, da tutti i paesi le portava a casa le cose più diverse. Ma poiché un giorno a Odessa 296 si ammalò e contrasse la brutta malattia del vaiolo, Deborah lo ebbe in orrore, quando fu tornato, e si distolse per sempre da lui. Qui noi lettori abbiamo il controllo della situazione: conosciamo cause ed effetti, azioni e reazioni; niente ci resta nascosto né abbiamo bisogno di soccorsi esterni per ricostruire la situazione: essa ci viene posta oggettivamente davanti agli occhi. O quando leggiamo di come Abdias a poco a poco arriva all’episodio (la gratuita umiliazione inflitta a un emissario del Bei) che gli farà scaricare sul capo la vendetta, ci viene fornito il materiale in tutta la sua ampiezza: l’allontanarsi da casa perché Deborah lo sfugge, il godere del potere e della ricchezza come compensazione, fino all’accecamento. Spazio, tempo, cause, intenzioni, effetti e via dicendo, tutto ci viene fornito in maniera direttamente controllabile. Di punto in bianco questo modo di narrare cessa, in coincidenza con la vendetta di Melek. A partire da quel momento e per un lungo tratto noi non sapremo più nulla dei pensieri e delle decisioni di Abdias. Anzi noi non avremo più nessun controllo generale, non ci verrà fornita nessuna sintesi. Le azioni si succedono frammentate e noi sappiamo solo quel che accade in quel momento e lo sappiamo dall’esterno. Per ricostruire le intenzioni di Abdias dobbiamo aspettare o il compiersi dell’azione o, meglio ancora, una qualche rivelazione del narratore, che però ci viene fornita solo nella terza fase. Questa comincia al momento in cui Abdias sbarca in Europa e si caratterizza per essere un compromesso fra le prime due: non veniamo di regola subito in possesso di tutti i dati che ci permettono di capire un’azione, e tuttavia il narratore fa qua e là delle eccezioni, rivelandoci qualche pensiero nascosto oppure facendo dei propri commenti i quali, sebbene fatti per così dire dall’esterno (dal punto di vista dell’ignaro lettore), servono proprio a mettere il lettore sull’avviso. Ciò dura fino al momento in cui Abdias uccide il cane. L’ultima fase riprende il modo della prima. Il variare di queste fasi non è giustificato da dichiarazioni dell’autore. Dunque occorre far parlare il testo. E noi vediamo che esse sono caratterizzate da quattro diverse fasi di progettualità. Nella prima noi siamo confrontati con vasti sogni di Abdias, che però non diventano mai progetti. Del sogno di andare in Europa leggiamo esplicitamente che era un brandello di pensiero, inafferrabile e senza conseguenze. Quando Abdias andrà effettivamente in Europa, non sarà per conoscere quel che conoscono i saggi di lassù (come era nel sogno), tanto è vero che nessuna traccia se ne avrà nell’educazione di Ditha, ma per un groviglio di altri motivi. Si tratta però di sogni molto vasti, così come vagante è la vita materiale di Abdias. Dunque sono sogni che fondano grandi spazi e il modo di narrare vi si adegua. Nella seconda fase Abdias sembra aver scoperto la salvezza nei nuovi sentimenti d’affetto che gli nascono per Deborah e soprattutto - morta la moglie per Ditha. È il momento in cui Abdias fa passi contraddittori: da una parte 297 rompe con la vita condotta fino a quel momento (quando gli viene organizzata una carovana perché possa rimettersi in sesto, egli non se ne cura minimamente), dall’altra però costruisce tutto un progetto basato su un elemento della cultura da lui ereditata, cioè la vendetta. D’altra parte questo progetto è talmente legato a un altro essere umano, cioè alla necessità di mettere in salvo Ditha, da venirne ritardato e condizionato, fino al non confessato abbandono. Tutta questa fase (e parzialmente anche la terza) viene trattata da Stifter in maniera antitetica alla progettualità: il suo modo di narrare non sintetizza lo spazio e il tempo ma li dissipa. Nel progetto noi ci poniamo come cause di effetti che vogliamo si rivelino nel futuro. A seconda della vastità del progetto, esso richiede una serie di rapporti causali e di effetti intermedi. Il tempo non è solo una unità di misura ma un modo di configurarsi di tutto l’insieme. Finché Abdias non cambia il suo progetto di vendetta per dedicarsi a guidare Ditha nel mondo delle cose viste, egli non fa che costruire una prigione. Non soltanto egli ripete in Europa la vita del deserto ma addirittura si sceglie una valle sterile e desolata come il deserto. Come se non bastasse, la casa che egli costruisce vuole essere una fortezza, ma di fatto si presenta come una prigione, al centro della quale è Ditha; a chiarire le cose - se ce ne fosse bisogno - Stifter le mette in camera un uccellino in gabbia (sarà il fulmine a liberare l’uccellino dalla gabbia e Ditha dalla cecità) e avverte il lettore che quel modo di costruire non era proprio necessario in Europa. Per quel che possono servire confronti esterni, ricordo che nello Hagestolz (Lo scapolo), novella di due anni posteriore, c’è una costruzione di cui si parla all’inizio come di una fortezza ma di cui più volte in seguito si dirà a chiare note che è una prigione. Allora questo progetto, che non fonda lo spazio e il tempo ma li subisce, è un progetto distorto. Tutto cambia nella sua ultima fase: Abdias accetta il linguaggio di Ditha, anzi l’impara da lei. E questa lingua-non lingua, questa immersione nel non-loquente da cui si riemerge con una proposta di mediazione fra linguaggio e non linguaggio, è essa che fonda il mondo in modo proprio: uno spazio e un tempo progettuali e concreti. Abdias rende fertile la valle desolata. È dall’immersione nella metafisica che la fisica ha avuto un senso; la causalità del progetto può allora effettivamente fondare il tempo e lo spazio. La base di tutto ciò è l’amore correttamente inteso. Der Hagestolz lo tematizza con tutta la chiarezza desiderabile. Victor che sta per recarsi nella sua prigione (cioè il nipote che sta per recarsi sull’isola abitata dallo zio scapolo) comincia col perdere il senso del tempo e dello spazio. Per giorni non parla con nessuno e ha a che fare solo con lo sconfinato abbandono dell’aria; la montagna su cui sale sembra non finire mai, la discesa appare senza un termine; le distanze perdono contorni reali, il lago sembra essere al tempo stesso a portata di mano e irraggiungibile, i punti cardinali stessi sono poco chiari. Victor si avvia verso una specie di regno della morte, desolato, abbandonato, senza segni umani, in cui le 298 prime parole che gli vengono rivolte sono l’ordine di affogare il suo cane. Poi entrerà nella prigione: tutta circondata da un muro invalicabile, la casa dello zio ha anche cancelli che chiudono i corridoi, porte sempre chiuse e addirittura porte a trabocchetto, finestre sbarrate o a bocca di lupo. All’inizio lo zio scapolo, prigioniero nella sua stessa prigione, uno zio che ci viene presentato la prima volta come preso da tremito alla paura della morte, sembra il grande sconfitto. Quando Victor pensa di lui come di uno «che ha amato se stesso per innumerevoli anni», sembra dettato il giudizio finale: lo zio sembra dover essere l’immagine della morte perché è quella dell’egoismo, del disamore, della paura del prossimo. Il seguito della novella si incarica di smentire l’ingenuo giudizio di Victor. Lo zio gli spiegherà: ciascuno è al mondo per se stesso; l’altruismo può avvenire sulla base di un amore per se stessi, corretto e forte. L’amore di sé è realizzato se tutte le forze si dispiegano nel mondo. Se diamo spazio alle nostre forze, se la nostra realizzazione fonda uno spazio concreto e non unilaterale, allora siamo al meglio anche per gli altri, allora possiamo essere altruisti fino a sacrificare la nostra vita. Ognuno esiste per se stesso, ma esiste soltanto se tutte le forze che gli sono toccate vengono applicate al lavoro e all’attività - perché questo è vita e godimento - e se perciò esaurisce questa vita fino all’ultima goccia. E non appena è tanto forte da conquistare questo spazio a tutte le sue forze, grandi e piccole purché tutte, allora esiste anche per gli altri nella maniera migliore, e può esistere sempre e non può essere altrimenti se non che agiamo su coloro che ci sono intorno; poiché compassione, partecipazione e disponibilità sono anche forze che esigono di agire. Ti dico anzi che la dedizione di sé per altri, fino alla morte, se mi è concesso dire, non è altro che il più forte sbocciare del fiore della propria vita. Ma chi nella sua miseria tende solo una forza vitale per soddisfare nient’altro che una singola richiesta, fosse anche quella della fame, esiste per sé in una maniera unilaterale e miserevolmente sghemba e rovina quelli che gli sono intorno. Questa progettualità riceve la sua base più forte dalla fisicità. Perciò lo zio consiglia a Victor di sposarsi e avere figli. Ma, prima ancora, di viaggiare, di non restare nella unilateralità delle forze - cioè nella debolezza e nel rattrappimento consigliatagli da chi gli è vicino: il sapere e il naturale buon senso vanno allargati per un bel tratto di mondo, se non vogliono trasformarsi in debolezza. Questa gli rivela lo zio - era stata la debolezza che aveva reso infelice la vita di persone amate: suo fratello (il padre di Victor) e la donna da entrambi amata. Tutto questo, chiarisce lo zio, va fatto rispettando la natura. E solo adesso si chiarisce un’immagine. Quando Victor era sbarcato nell’isola dello zio, aveva notato degli alberi da frutto avvizziti, che contribuivano all’immagine funerea dell’insieme. Lo zio gli spiega l’errore dei monaci che li avevano piantati: la natura del terreno è tale che quelle piante non possono sopravvivere; lo possono invece le piante forti, le querce e i faggi, che si adattano alla roccia. Così deve essere l’amore di 299 Victor: adatto alla roccia, non dipendente e morbido. In questo modo Victor sarebbe potuto diventare realmente un figlio («Saresti finalmente divenuto un figlio»). Ecco che cos’è l’amore tra padri e figli, ecco che cos’è la fisicità del progetto vitale: un cuore da bimbo, ma un intelletto e uno spirito forti. Il consiglio - pure dello zio - di darsi all’agricoltura invece di fare l’impiegato, riassume tutto ciò in un simbolo. Der Hagestolz insegna dunque a non forzare il progetto (lo zio non costringe a vivere gli alberi che non ce la fanno) ma a dargli una fondazione sull’amore biologico. E l’amore deve essere forte, adeguato alla vita; altrimenti si finisce traditori di se stessi, come il padre di Victor. Inoltre deve essere un amore esperto del mondo, non limitato alle quattro pareti; questo è il vero altruismo, in queste condizioni si possono amare gli altri fino alla dedizione di sé, perché di fatto la base dell’amore vero e altruistico è l’egoismo, il volere la felicità. Apparentemente lo zio ha fallito: non ha figli, Victor non diventa suo figlio; perciò lo zio vive in prigione, nell’isola della morte, dove lo spazio e il tempo non si raccapezzano più. Ma di fatto è lui che ha salvato quanto si poteva delle situazioni altrui. È lui che ama ed è il più forte. Se Victor non intristisce da impiegato, lo deve a lui. Questo è l’egoismo-altruismo. Per motivi di spazio non è qui possibile soffermarsi molto su altri racconti delle Studien ma occorrerà limitarsi a pochi cenni. Segnalerò pertanto Die Narrenburg (Il castello dei pazzi), che è la storia di un avvicendamento al potere e l’esposizione di una filosofia di intervento sulla storia; gli strumenti per tale intervento sono due: il pudore e la fedeltà. Pudore significa retto uso del tempo, così da produrre ciò che è utile e durevole, pensandolo e progettandolo bene, realizzandolo senza impazienza. La fedeltà procede da un corretto rapporto con la natura e dall’assenza di egoismo. Più in generale: pudore è agire sulla storia assecondando i ritmi della natura; fedeltà è sapersi sempre in una comunità. Purtroppo così non diciamo nulla né degli altri temi (per esempio dell’avvicendamento di borghesia e nobiltà) né della straordinaria struttura di questo racconto a cornice. Originariamente legato al precedente, il racconto Die Mappe meines Urgroßvaters (Le carte del mio bisnonno) tematizza il sentimento della medietà, dell’amore universale nella certezza e costanza della nostra individualità. Ogni essere è l’anello di una catena infinita, in cui si trova solo. La vita è tenuta insieme da una catena di amore e dolore. Questo insieme costituisce la «insignificante» vita quotidiana, il cui propellente è l’amore. La cosiddetta «grande storia» ne è un pallido riflesso, perché in essa invece l’elemento propulsivo appare costituito dai contrasti. Effettivamente nella storia sembra vigere la discontinuità: le memorie - scritte e orali - svaniscono, i nostri stessi ricordi si dissolvono quando a illuminarli interviene la cruda luce del presente; i dati obiettivi non so300 no tali, perché perdono il loro carattere infinito. E questo è maggiormente vero per il distacco rispetto alle generazioni future: anche i fuochi fatui invecchiano e scompaiono per le nuove generazioni. Ma tutto questo va rigenerato: la tradizione non va semplicemente ripresa ma sempre di nuovo fondata. Quando seguiamo, da adulti, gli impulsi dell’infanzia (e qui è interessante che Stifter distingua tra impulsi di fondazione e impulsi di distruzione; è dei primi che si raccomanda il seguito, non certo dei secondi), allora scopriamo che non esiste caso e che invece tutto si concatena. Ed ecco che il passato ricompare e quel che sembrava inabissato riaffiora (il terzo narratore scopre finalmente le carte del padre dentro quelle del bisnonno). Tutto sarà comune e normale: il processo temporale segnerà la tragedia quotidiana di ogni vita. Occorre amarla, amando noi stessi in maniera creativa. Detto in parole molto semplici: nelle Studien questo racconto a cornice (che allinea ben tre narratori) espone l’utopia di Stifter, con uno sforzo di armonizzazione tanto violento da essere a volte preoccupante. Per l’autore esso era così importante che nell’ultima fase della sua vita volle rielaborare la Mappe per ricavarne un romanzo; ma l’opera rimase interrotta. Un altro straordinario racconto è Der Hochwald (La fustaia), grandiosa analisi del rapporto fra tempo mitico e tempo storico, condotta analizzandone la base biologica, cioè un amore talmente passionale da essere devastante. Il suo aspetto straordinario è nella tecnica narrativa: nel rendere il non detto più importante del detto, nell’introdurre azioni e pause che portano scompiglio nell’ordine razionale delle cose. Il tema (e in parte anche l’ambientazione) venne ripreso da Stifter nel suo ultimo romanzo, Witiko, in cui però il rapporto è capovolto: qui è il tempo storico a culminare in tempo mitico, previo peraltro uno smussamento di contrasti. Secondo quanto già accennato, nel 1849, Friedrich Hebbel attaccò Stifter accusandolo di cantare maggiolini e ranuncoli perché non conosceva gli uomini e il mondo; in generale Stifter poteva essere un eccellente cantore del piccolo perché la natura l’aveva reso incapace di vedere il grande. Era un chiaro segnale dell’equivoco che su Stifter cominciava e che sarebbe durato fino a non molti decenni fa; ci torneremo. Stifter replicò a Hebbel nella prefazione a Bunte Steine, cominciando dal definire che cosa intendeva per piccolo e per grande e poi passando a considerazioni più generali. Seguiremo ora analiticamente tale prefazione, che è attualmente riconosciuta come uno dei più importanti testi di poetica dell’Ottocento. Secondo dichiarate intenzioni, nella prefazione a Bunte Steine Stifter vuole semplicemente esporre le proprie opinioni su determinati concetti, niente di più. Ci si può dunque aspettare che la prefazione non sia impiantata come un trattato filosofico ma che invece si limiti a informare su opinioni dandone una giustificazione presumibilmente succinta e non elaborata in tutte le sue premesse e 301 implicazioni. Ciò (così sembra potersi ulteriormente argomentare in limine) suggerisce al lettore un certo atteggiamento interpretativo; viene infatti indotto a tenere in limiti le proprie aspettative. D’altra parte, poiché le opinioni espresse verteranno su concetti e su valori, il lettore è anche autorizzato a tenere un atteggiamento diverso da quello che presumibilmente avrà nei confronti dei racconti del volume e che Stifter pare suggerirgli quando gli augura un’ora piacevole sulla base di una omogeneità del sentire, esortandolo a considerare i racconti come contributo alla costruzione dell’eterno mediante l’apporto di un granello di bene. Al lettore dei racconti Stifter propone dunque un atteggiamento comunitario, etico-estetico. Sia come sia (e su questa proposta di Stifter comunque torneremo), né al lettore sfugge né Stifter ignora che la prefazione stessa richiede altro atteggiamento di lettura. Fatto salvo quel che si diceva poco fa, l’atteggiamento che ci si può aspettare non sarà molto diverso da quello che richiede un saggio filosofico. È vero che di non tutte le opinioni verrà data la fondazione, oppure non verrà data a sufficienza e che la trattazione sarà quanto mai succinta; tuttavia le poche pagine della prefazione riassumono un sistema di pensiero, pur tacendone parti essenziali. La prefazione ha dunque diritto a dei riguardi perché non si può pretendere che dica quel che non vuol dire ma ha diritto anche a essere considerata come pertinente al genere filosofico. Sotto questo secondo aspetto si applica a essa il metodo che si applica all’analisi di un sistema di pensiero: esame del rapporto fra premesse e conseguenze in quanto sviluppate all’interno del sistema e previsione delle conseguenze non sviluppate ma indotte o inducibili; esame del sistema nella sua globalità come risposta a sollecitazioni esterne. Nel caso specifico occorre considerare che il sistema in questione è esposto come prefazione a un volume di racconti che (con molti distinguo da vedere a suo luogo) si danno come solidali col sistema stesso; Stifter del resto lo avverte nelle ultime righe della prefazione in modo non equivocabile seppure un po’ tortuoso. Ma tra filosofia e opera narrativa c’è un tale salto di genere e di atteggiamento che esaminare quel nesso di solidarietà ci pone davanti a problemi ulteriori. D’altra parte tale esame sarà decisivo per rendere conto di una caratteristica assai importante del sistema di Stifter: quello di essere esposto in una prefazione. Considerare il modo della presentazione del sistema è infatti essenziale alla sua analisi. Le sue lacune di cui si diceva (incompletezza della fondazione e delle implicazioni) possono infatti apparire giustificabili in una premessa: ma a quel complesso che è costituito da premessa e da ciò che a essa segue sembra lecito porre delle domande in più. Con la difficoltà - giova ripeterlo - che ciò che segue appartiene a un genere diverso; e quindi occorrerà decidere il metodo per passare da un genere all’altro considerandoli nella loro autonomia, e tornare poi a confrontarli fra loro. Per quante risapute obiezioni si possano muovere a una pretesa omogeneità di rapporto tra premesse e conseguenze - soprattutto lì dove le une e le altre appartengano a campi così diversi come appunto nel nostro caso - da una parte 302 quella pretesa va pur sempre verificata; e dall’altra, nel caso concreto, la prefazione rielabora e (nei suoi limiti) sistematizza idee messe per iscritto da Stifter a partire dal 1846, dunque da una data antecedente alla stesura di tutti i racconti di Bunte Steine, così che quella prefazione testimonia almeno della cultura dell’autore, attiva al momento della stesura; per cui si pone il problema di constatare quale rapporto ci sia fra tale cultura e i racconti messi sotto la sua egida. A ciò va aggiunto che tutti i racconti, già pubblicati su riviste (tranne uno), furono rielaborati, in parte anche profondamente, per essere ripubblicati insieme; e che nella revisione vennero curate le linee per una realizzazione stilistica dei presupposti teorici. Ciò pone il problema del rapporto tra prefazione e racconti come quello tra premesse e loro sviluppi. Cosa cui però non ci incoraggia nessuna esperienza estetica. Vediamo ora come la prefazione ci aiuti a vedere se le idee espresse indichino qualcosa sul condizionamento culturale dell’autore, indotto a osservare certe cose invece che altre e in un modo invece che nell’altro, oppure se indichino qualcosa di più. A tal fine la prefazione va rimessa in forma, mostrandone con chiarezza la natura sistematica o almeno parasistematica. La riordineremo così in tre sezioni: 1. la prima concerne le leggi del mondo fisico. 1.1 Il mondo fisico è governato da leggi. Queste sono tali in quanto si verificano sempre e dovunque e sono perciò «l’intero e universale», oggetto vero della «strategia spirituale dello studioso». 1. 1. 1 Le leggi sono ciò che «conserva il mondo». Esempio dell’azione di tali leggi: «l’alitare dell’aria, il frusciare dell’acqua, il crescere del frumento, l’incresparsi del mare, l’inverdirsi della terra, lo splendere del cielo, il brillare delle stelle». 1.2 I fenomeni violenti ed eccezionali che si verificano nella natura sono particolari, «fenomeni singoli», «effetti di leggi molto superiori», «risultati di cause unilaterali». Essi passano presto e i loro effetti non sono durevoli; solo l’«inesperto e disattento» dedica loro tutta la sua attenzione. Esempi: «il temporale che irrompe pomposo, il fulmine che fende le case, la tempesta che agita i marosi, la montagna che erutta fuoco, il terremoto che sovverte le terre». Le leggi agiscono «miti e incessanti, [...] cambiando, formando e producendo vita». Ciò che non risponde a tali requisiti è solo un evento trascurabile, al massimo un piccolissimo segno della forza della legge e niente di più. 1.3 La deduzione di quanto sopra è affidata all’esperienza storica: oggi la nostra «mente» e il nostro «sguardo» sono cresciuti, così che siamo maturi 303 per «l’intero e universale»: per la «legge» e per il suo «miracolo», tralasciando «le cose stupefacenti». 2. La seconda sezione concerne le leggi morali. 2. 1 Anche le leggi morali, come quelle fisiche, «conservano», e precisamente sono ciò che «conserva l’umanità». Esse - così pare di potersi evincere dal discorso di Stifter - non regolano il rapporto uomo-natura (o almeno ciò non viene detto); regolano invece il divenire del singolo e il rapporto uomo-comunità (dei rapporti fra singoli non si fa ugualmente parola). Si dividono in due classi: 2. 1. 1 «Ci sono forze che mirano al perdurare del singolo», «assicurano la persistenza del singolo e per tal via quella di tutti». L’universalità della legge è inoltre confermata dal senso morale di chi agisce a loro modo, poiché allora «ci sentiamo come umanità intera». L’universalità assume dunque la forma concreta dell’umanità nel suo complesso. 2. 1.2 Ci sono poi leggi che «agiscono per la conservazione dell’umanità intera», cioè si riferiscono direttamente al generale e non possono venire limitate dalle singolarità anzi all’opposto le limitano. Queste leggi (2. 1. 1 e 2. 1.2) sono «l’unica cosa universale, l’unica che conserva e non ha mai fine». E sono l’oggetto vero di «chi indaga sull’umanità». Esempi di 2.1.1: «Tutta una vita piena di giustizia, semplicità, superamento di se stessi, ragionevolezza, adoperamento nel proprio ambito, ammirazione del bello, connessa con un morire sereno e tranquillo». Esempi di 2.1.2: «La legge di queste forze è la legge della giustizia, la legge dell’eticità, la legge che vuole che ciascuno sussista rispettato, onorato, indisturbato accanto all’altro, che egli possa percorrere la sua superiore via umana, si conquisti l’amore e l’ammirazione dei suoi simili, che egli venga custodito come gioiello, al modo in cui ogni uomo è un gioiello per tutti gli altri uomini. Questa legge è dovunque uomini abitino accanto a uomini ed essa si mostra quando uomini agiscono nei confronti di uomini. Essa è nell’amore reciproco dei coniugi, nell’amore dei genitori per i figli, dei figli per i genitori, nell’amore reciproco di fratelli e sorelle, degli amici, nella dolce inclinazione dei sessi, nella laboriosità da cui veniamo mantenuti, nell’attività con cui si agisce sia nel proprio ambito, sia in lontananza, per l’umanità, e infine nell’ordine e nella forma in cui intere società e stati avvolgono e portano a compimento la loro esistenza.» 2.2 304 Quando qualcuno «distrugge le condizioni dell’esistenza di un altro» (dunque quando vengono violate le leggi di cui in 2.1.1) «ripristiniamo lo stato [di convivenza e] ci sentiamo come umanità intera». Quando osserviamo grandi movimenti umani che alla lunga cambiano la «forma» di un’epoca ed eventualmente non vi rinveniamo «la legge della giustizia e dell’eticità» (dunque quando vengono violate le leggi di cui in 2.1.2) ne distogliamo lo sguardo quali studiosi dell’umanità e li consideriamo pochezze; se invece vi rinveniamo «la legge del giusto e dell’eticità», «allora ci sentiamo innalzati all’altezza dell’umanità in generale, ci sentiamo umanamente universalizzati, sentiamo il sublime». Esempi negativi rispetto a 2.1.1: «possenti moti dell’animo, terribili esplosioni d’ira, brama di vendetta, spirito infiammato che tende al fare, che travolge, trasforma, distrugge e nell’eccitazione spesso getta via la propria vita: [...] prodotti di forze singole e unilaterali, come le tempeste, le montagne che eruttano fuoco, i terremoti». Esempi negativi rispetto a 2.1.2 non vengono dati. 2.3 È compito dello studioso dell’umanità cercare «la mite legge da cui il genere umano è guidato. [...] la legge etica [che] agisce silenziosa e vivificante l’anima attraverso gli infiniti rapporti degli uomini», ricordando bene che nelle imprese compiute «le meraviglie dell’attimo [...] sono solo piccoli segni di questa forza universale», o, peggio ancora, unilaterali, «cosa piccola, indegna dell’uomo». 2.3.1 Conquistare lo «sguardo d’insieme su cose superiori» è stato anche qui un fatto storico: finalmente «furono stabiliti tra gli uomini suddivisioni e rapporti, il diritto dell’intero congiunto a quello della parte, e magnanimità verso il nemico e repressione delle proprie sensazioni e passioni a vantaggio della giustizia ritenute alte e magnifiche». Si può sperare di più per il futuro poiché, se non realizzato, almeno «un vincolo che unisse tutti i popoli fu pensato cosa desiderabile, un vincolo che scambi tutti i doni di un popolo con quelli di un altro, promuova la scienza, ne manifesti i tesori a tutti gli uomini e nell’arte e nella religione guidi a ciò che è semplicemente alto e celeste.» 2.3.2 C’è qui però un’aggiunta. Mentre non si parlava di un decadere delle scienze naturali, pare che le cose stiano altrimenti con le scienze morali. Si crea infatti anche la realtà di popoli in decadenza i quali perdono la misura del giudizio e del comportamento morale, fino al culmine in cui «il singolo disprezza l’intero». 3. La terza sezione concerne le leggi dell’estetica. I poeti prediligono come loro temi quelli in cui si manifestano le forze mora- 305 li per affidare le loro opere a un sentire affine, presupposto in lettori sia vicini sia lontani. Se il singolo o tutto un popolo patiscono per «il giusto e l’eticità» noi li concepiamo non come vinti ma come trionfatori, e ci solleviamo verso il «puro etere della legge etica» perché avvertiamo il sentimento dell’intero. Questo è il sentimento del tragico. Quando invece sentiamo che nella storia l’umanità va incontro a «una grande meta eterna», allora abbiamo il sentimento dell’epico. Entrambi (epica e tragedia) sono sottospecie del sublime. Questo si insedia nell’animo «dovunque [...] nel tempo o nello spazio attraverso forze smisurate si opera congiuntamente verso un intero pieno nella forma e consentaneo alla ragione»; specificamente esso viene esaminato come risultante dalla contemplazione dell’umanità mossa dalla legge del «giusto» e dell’«eticità». L’impianto kantiano-schilleriano dell’insieme è indisconoscibile e alcuni studiosi l’hanno dimostrato analiticamente. Elementi singoli del discorso stifteriano, come già detto, sono testimoniati per iscritto fin dal 1846, cioè da sei anni prima della data in calce alla prefazione. Questa stessa ha avuto un’occasione contingente; c’è però verso la fine una frase singolare su cui occorre richiamare l’attenzione: le esperienze degli scorsi anni. Stifter si riferisce alla rivoluzione del 1848. Stavolta all’inizio della prefazione egli scrive che la poesia si basa sulle esperienze del genere umano e che lui stesso ne ha fatte alcune rielaborandole in tentativi poetici. Però abbassa di livello le sue pretese, dichiarando che i racconti qui presentati non sono poesia, pur presumendo quella comunità del sentire su cui costruisce anche il poeta, che presuppone una «omogeneità di sentire» nel lettore. Ma noi sappiamo da altra fonte, e cioè da una lettera dello stesso Stifter, che Bunte Steine sono proprio una risposta alla rivoluzione del 1848; dunque la dichiarazione sulle esperienze va presa sul serio: sia i racconti sia la prefazione, dunque tutte le Bunte Steine nel loro complesso, sono una risposta a un fatto esterno. Scrive infatti Stifter, giustificando la scelta di un pubblico infantile o come scriverà poi nel sottotitolo della raccolta - di «giovani cuori»: «I bambini non fanno la rivoluzione e le madri nemmeno» (da una lettera datata 6 marzo 1849). Abbiamo così le sollecitazioni culturali (Kant e Schiller) e le sollecitazioni storiche (la rivoluzione) cui il sistema di Stifter vuol dare una risposta. Il sistema di risposta si costruisce attraverso un insistito parallelismo tra leggi naturali e leggi morali. È però piuttosto agevole constatare l’imprecisione di tale parallelismo. La seconda sezione straripa infatti rispetto alla prima. Zoppicano gli esempi di 2.2: la brama di vendetta non può essere «esattamente come un’eruzione vulcanica» poiché di quella si può dire che è male, di questa invece no. L’obiezione non è troppo esterna. Abdias nelle Studien era costruito sul concetto di una natura che rispetto all’uomo è indifferente, non maligna; e Bergkristall (Cristallo di rocca) non rinnega quella tesi, anche se la sviluppa in altro mo- 306 do. Inoltre la classificazione di 2.1.1 e 2.1.2 non corrisponde a 1.1.1 poiché il fare dell’uomo sull’uomo (invece che dell’uomo sulla natura) porta a conseguenze più complesse. E infine il parallelismo è clamorosamente smentito dall’aggiunta di 2.3.2. Possiamo dire che qui c’è una contraddizione. Essa non dipende dalla mancata fondazione del parallelismo (su cui non c’è molto da dire poiché sapevamo in anticipo che la prefazione non ci avrebbe detto tutto) ma dal dinamismo del sistema. La prospettiva storica, quella dello sviluppo delle forze conoscitive e operative dell’uomo, prende man mano il sopravvento e finisce con l’usare la fisica a mo’ di esempio parziale e subordinato. Il sistema dimostra la sua vitalità aprendosi oltre le proprie premesse. È in questo senso, nel senso della sua vitalità, delle sue aperture, delle sue «contraddizioni», che il sistema della prefazione può pretendere la solidarietà dell’intera raccolta e costituire con essa un sistema unico, posto pur sempre che si riesca a passare congruentemente da un genere all’altro. La conseguenza non può essere data dal replicarsi della prefazione nei racconti, altrimenti non saremmo più nel sistema vivo. La replica c’è e va notata, ma da sola dice troppo poco: non dice perché c’è stato bisogno di racconti, perché mai non è bastata la prefazione da sola. In Kalkstein (Pietra calcarea) si trovano replicate varie tesi: la tempesta è «piccola» mentre la vita composta e la morte serena del parroco sono «grandi». Ma oltre a ciò Kalkstein dice ben altro ed è questo altro a fare la vita del sistema. Eppure anche se dicesse solo quello, ciò sarebbe comunque altro, poiché apparterrebbe al mondo delle immagini invece che a quello dei concetti. Per decidere sul rapporto prefazione-racconti, occorre pur sempre pronunciarsi su questioni di principio. Nessuna tecnica vuole insegnare ad analizzare un testo in maniera non precisa; e ciò significa pur sempre ridurlo a concetti esatti, al più con l’avvertenza che è possibile anche un’altra interpretazione, dunque ricavarne altri concetti. L’alterità radicale non è questione dell’interpretazione testuale ma è un postulato esterno a essa; solo la riflessione globale può farsene carico, e non più che ricordandola nella sua genericità; quando infatti la si dovesse mostrare essa cesserebbe di essere alterità ma sarebbe risultato interpretativo, sarebbe concetto univoco. Il livello più basso di questa univocità è dato dalla verifica del programma nei racconti, cioè dalla replica della prima nei secondi. Per Kalkstein si è già accennato, per Bergkristall la riconciliazione tra famiglie e l’integrazione nel villaggio, entrambe avvenute a causa del sacrificio (mancato ma rischiato) di due bambini, sembra dare un assaggio di quella conciliazione universale tra popoli di cui si parla nella prefazione. Volendo si può trovare altro materiale di verifica. Ma non è l’impresa più interessante, anche se è dovuta. Un secondo livello di univocità è trovare nei racconti quei concetti che non sono già nella prefazione, accentuando così le «contraddizioni», cioè la vitalità e il dinamismo, del sistema. Ciò richiede qualche sforzo in più, che però risulta premiato. 307 Da Granit apprendiamo dapprima che cosa voglia dire coartare l’altrui dignità umana (secondo uno dei peccati previsti nella prefazione); il comportamento gelido - per non dir peggio - della madre si allarga fino al simbolo epocale della peste: la peste è quando «i figli non amano più i genitori e i genitori non amano più i figli». Noi lettori, stando alla prefazione, dovremmo avvertire il sublime perché con le reazioni ripristiniamo lo stato di giustizia. Sin qui c’è (o ci sarebbe) la conferma della prefazione. Ma rispetto a quella ci sono due cose in più: la prima è la famiglia dei venditori di morca, che al di là della peste ha conservato lo stato di persone giocose e libere. La «peste» dei rapporti umani egoistici da una parte, il gioco e la libertà del romantico Wanderer dall’altra. E soprattutto c’è il modo della riconciliazione: questa avviene attraverso un battesimo generale della contrada, che nel dialogo tra nonno e nipote viene chiamata rinominando tutti i suoi componenti. La conciliazione è nel nome che dà e riconosce individuatezza. Già in Bunte Steine - per tacere del successivo romanzo Nachsommer (L’estate di San Martino, 1857) - questa funzione del nome (che vedremo ancora) è fondamentale; e subito nel primo racconto c’è una specie di orgia denominativa. L’appropriarsi della natura attraverso i nomi apre la via alla riconciliazione fra gli uomini. Che la libertà giocosa e la denominazione abbiano un rapporto non viene detto esplicitamente. Però esse hanno una funzione analoga: si pongono infatti rispettivamente prima della «peste» tra madre e figlio e dopo la «peste»; ciò che veniva prima, però, è a sua volta conseguenza di una peste superata. Dunque ci viene suggerito, anche se non detto esplicitamente, che forse anche la denominazione è da considerare come libertà giocosa, che porta all’associazione tra gli uomini. Tutte connessioni che sono un di più rispetto alla prefazione. In Kalkstein la vita del parroco virtuoso (quasi santo) sembra confermare punto per punto la prefazione. Ma abbiamo subito il riempimento di una sua lacuna; lì infatti si diceva che acquisire il giusto concetto di grande e piccolo era questione di progresso storico ma non si diceva nulla sulla natura dei processi storici pertinenti. La storia del parroco insegna che per arrivare allo «sguardo sulle cose» occorre passare tra sofferenze inumane, risultare sconfitti e vivere una sola metà della propria vita. Stavolta la conciliazione con la vita non avviene più attraverso un processo denominativo; al contrario, né il parroco né l’agrimensore suo interlocutore ricevono mai un nome. In Kalkstein la denominazione procede secondo una logica multipla; ricevono un nome solo le donne, delle quali una (Luise) rappresenta la continuità nella storia di una famiglia, un’altra (Sabine) è simbolo dell’eternità, una terza (Johanna) è la possibilità di un destino personale. Chi, come il parroco, rappresenta le radici della vita, cioè la chiarezza del destino generale, non ha un nome. Quanto ai luoghi naturali, un nome proprio (al femminile, chissà se è una coincidenza) l’ha il ruscello che straripa (secondo 1.2 della prefazione) e poi bisogna arrivare fino al centro amministrativo di Karsberg per trovarne un altro, con un interessante processo di 308 potenziamento rispetto a Kar (conca) e Steinkar (Conca Petrosa), che sono i luoghi nei quali si svolge la vicenda. Che cosa c’è dunque di nuovo rispetto alla prefazione? Il togliere ogni aura di trionfalismo alle sue tesi, mettendo in risalto la sofferenza che fa loro da veicolo; il mostrare come quelle tesi - così sofferte si sviluppano attraverso una manipolazione dello spazio (indeterminatezza spaziale della zona finché non si arriva al nome Karsberg) e del tempo (le donne lo simboleggiano), cioè attraverso un sacrificio dell’individuatezza, che sola porta a cogliere la verità esistente nell’abisso di dolore, passioni e imprevedibilità che è l’uomo. Esiste inoltre (confermando la fine del trionfalismo) la cessazione di garanzia dell’esito: il racconto a cornice è fatto in modo che primo narratore, secondo narratore e lettore arrivino quasi a identificarsi abolendo così lo schermo rassicurante della cornice e rischiando di cadere nelle sofferenze e nella sconfitta del parroco. Modesto contraltare a ciò è la denominazione Karsberg. Il racconto, uno dei più riusciti in assoluto, meriterebbe un’analisi più specifica; mi accontenterò di dire che esso reca nel racconto più interno (parzialmente ispirato a Der arme Spielmann di Grillparzer) la storia dell’ascesa e decadenza di una famiglia di imprenditori, quasi un Buddenbrooks ante litteram. La prefazione presentava le leggi morali come parallele a quelle naturali; ma di questo parallelismo non si vede traccia nei racconti. Per di più sia Kalkstein sia Bergkristall presentano una natura di per sé indifferente alla sorte dell’uomo. Quest’ultimo vi compare solo come osservatore della natura, dunque assumendo un punto di vista estetico. Quanto all’etica, si fa vedere come sia necessaria la solidarietà per vincere quello che la natura ha di pericoloso. Messe così le cose, che senso ha ancora quel dualismo? E che senso ha dire che l’estetica si basa sull’etica? È pur vero che Bergkristall (come già accennato) ha una morale chiaramente consona con la prefazione. Anche l’attività denominatoria le è consona. Dei due bambini sappiamo subito i nomi; così pure della madre, grazie all’omonimia con la figlia. Ma il padre resta a lungo innominato e solo la madre gli darà alla fine il suo nome, quando se lo sarà meritato attraverso la ricerca dei figli su per la montagna. Tutto occupato nella cocciuta lotta a distanza col suocero, Sebastian si era fino a quel momento occupato poco dei figli e non aveva mostrato di amarli come avrebbe dovuto. La duplicazione della coppia padremadre nei due figli (di Konrad si dice che è serio come il padre e Sanna viene esplicitamente associata alla madre) permette che tutto vada a buon fine. La denominazione avviene dunque al termine di un processo di conciliazione generale: l’individuatezza è una conquista sociale al modo in cui lo è Karsberg in Kalkstein. Tutto questo però è ripetizione oppure completamento della prefazione. Quel che c’è di nuovo sono la scissione e la ripetizione. Di quest’ultima si ha un segno nel celebre «Sì, Konrad» che la bambina ripete ben diciassette volte. Ma ripetizioni ci sono anche nella tessitura del racconto; e mentre le prime indicano la fiducia e la compattezza fra due esseri, primo esempio di quella più ampia fra le due famiglie e i due villaggi che si instaureranno alla fine, le altre indicano il 309 persistere della minaccia: «era ghiaccio - solo ghiaccio»; «volevano ridiscendere dall’altra parte. Ma non c’era un’altra parte»; «[...] scendere dal muro di ghiaccio [...] ma non scesero»; «ma non videro valli [...] solo ai bambini non saliva alcun suono»; «ma non giunsero ad alcun limite, non guardarono in basso»; «ma anche quel giorno c’era ghiaccio, solo ghiaccio. [...] Ma là trovarono di nuovo il ghiaccio»; «La neve riprese a salire [...] si arrampicarono dunque di nuovo»; «neve e soltanto neve. [...] Non si vedeva altro che neve, la bianca e luminosa neve»; «sempre attraversando la neve, sempre la neve». E via dicendo, infittendosi man mano. Conviene considerare a parte altre ripetizioni. Sono quelle dei segni fraintesi: i bambini mostrano ripetutamente la loro gioia di fronte a quei fenomeni che costituiscono minaccia di morte e che loro non intendono al verso giusto: il sole mostra un’immagine «fosca e rossastra», è «rosso sangue» e ciò vuol dire che minaccia tempesta. Ci sono segni di «pioggia imminente»; ma siccome il colore dell’acqua nel ruscello mostra che «sulle vette più alte doveva regnare già il freddo», forse non sarà semplice pioggia. Ebbene a questi e a vari altri segni i bambini reagiscono regolarmente con manifestazioni di gioia. Ma questa ripetizione introduce una scissione: il rapporto con la realtà non si basa sulla saggezza che viene dall’esperienza. È vero che Konrad ammette a un certo punto: «ho pensato subito che avremmo avuto neve»; ma l’atteggiamento fondamentale è quello della beata incoscienza. Consideriamo ora che il già ricordato «Sì, Konrad» viene pronunciato per confermare le scelte del fratello, che però risultano regolarmente sbagliate; dunque anche questo tipo di ripetizione - indice di fiducia e solidarietà - non assicura la presa corretta sulla natura. Stavolta il valore etico della denominazione è forte, ma il suo valore conoscitivo è nullo. Dei bambini si dice che vanno avanti con tenacia e forza esattamente come gli animali, «poiché non sanno cosa li attende e quando le loro riserve si esauriranno». Anche se il paragone con gli animali non ricorre più, sull’ignoranza dei bambini si insiste ancora; è grazie a tale incoscienza che essi compiono addirittura l’impresa temeraria di attraversare il ghiacciaio e il crepaccio. Dunque i bambini hanno una natura animalesca. Ebbene anche il villaggio di Gschaid sembra una copia della natura; a questo proposito viene ripetuta quasi identica una frase della prefazione: «gli abitanti della valle chiamano i piccoli mutamenti grandi, li osservano con attenzione e calcolano in base a quelli il progredire dell’anno». Se si confronta ciò con l’esempio delle misurazioni magnetiche illustrato nella prefazione si potrebbe concludere che ci siamo: ecco assicurato il parallelismo fra etica e natura. E invece non è così. Il mondo chiuso («un mondo proprio») e pressoché immutabile («sono molto costanti e tutto resta com’è») è quello che li separa dal mondo, che impedisce gli scambi con l’esterno, che non accetta i momenti del gioco perché non finalizzato all’utile, non controllabile, imprevedibile (da qui la condanna della vita condotta dal calzolaio in gioventù, e che infine porta all’isolamento della moglie e dei figli di Sebastian). Gli abitanti di Millsdorf han310 no invece più contatti con l’esterno; anzi tra costoro il suocero del calzolaio, «cosa inaudita nella valle, [lavorava] con macchine»: a Millsdorf è addirittura arrivato il progresso tecnologico. Ma questo non sembra aver influito positivamente sui sentimenti di solidarietà umana: il suocero sfida il genero a fare la stessa scalata sociale e i due uomini non si vedono fino al momento della sfiorata tragedia. I segni di tempesta fraintesi dai bambini erano stati visti anche dagli adulti: all’inizio si cita un’opinione della «gente di campagna», ma la nonna, che pure era parsa preoccupata dai segni visti da lei, solo alla fine grida: «Mai più, mai più [...] in tutta la loro vita i bambini dovranno scavalcare il valico in inverno». La natura non è un idillio; all’inizio le montagne sembrano antropomorfizzabili: il ghiacciaio quasi invia un saluto ai valligiani; ma quando lo si va a vedere da vicino tutto si rivela «selvaggio», «confuso» e «sporco». Così come succede ai colori, sui quali da lontano ci si sbaglia e che da vicino non aiutano meglio. Che resta, dopo tutto ciò, del parallelismo tra leggi naturali e leggi etiche? Non se ne vede più traccia; tutto viene spostato a favore del primato dell’etica sociale, degli sforzi comuni per superare i pericoli della natura; solo grazie a ciò si può arrivare all’individuatezza e Sebastian ricevere il suo nome. La scissione di cui si diceva è scissione tra uomo e natura, da ricomporre mediante l’etica sociale, visto che quanto di naturale è rimasto nell’uomo è o ingannevole (nelle valutazioni dei bambini) o addirittura perverso (nel comportamento degli adulti). Turmalin (Tormalina) invece sembra nascere con la dichiarata intenzione di confermare la prefazione: all’inizio si dice infatti che si vogliono mostrare gli effetti deleteri della perdita dell’«intima [mite] legge». Di conseguenza il racconto è stato interpretato come denuncia del comportamento di un padre che rovina la figlia e come denuncia del soggettivismo, del dilettantismo, del culto della mera apparenza. Non c’è dubbio che tale interpretazione sia fondata; al pensionato viene fatta esplicitamente colpa di aver rovinato la salute fisica e mentale della figlia (che resta sempre senza nome) e quanto al suo dilettantismo e all’amore per l’«apparenza» basti rinviare al suo collezionismo guidato dalla sola categoria «uomini importanti», che nemmeno conosce bene, tanto che spesso deve andarsi a informare su chi siano gli uomini di cui ha raccolto i ritratti. Eppure questa interpretazione lascia perplessi su più di un punto; proviamo a vedere se nel racconto, oltre alla conferma della prefazione arricchita dalla polemica contro il soggettivismo e a un forte richiamo all’etica, sola base di un’estetica giusta, non ci sia anche tutt’altro. La seconda parte del racconto è affidata a una narratrice che a prima vista sembra la versione cittadina di chi si trova alle radici della vita. In lei si duplicano alcuni tratti apparsi nella vita del pensionato, ma con opposta funzione. Per esempio appare in entrambi i casi un’«anziana serva»; però quella del pensionato sembra poco più che una mummia mentre la narratrice ci dice, della propria, una serie di particolari che nella storia non hanno alcuna funzione ma che 311 servono a dare un minimo di spessore e di vita anche a quel secondarissimo personaggio. Così la narratrice ci parla della curiosità da cui è spinta a osservare la strana coppia che vede dalla finestra, ci dice qualcosa sui motivi contingenti che l’hanno spinta alla finestra. Ci dà insomma un quadro di vita solida e serena, contro quella imbalsamata del pensionato della prima parte. Ma perché introdurre una seconda narratrice mentre per la prima parte è bastato un primo narratore? E perché tra le due parti e i due narratori si apre nella vita del pensionato una lacuna che non si riesce a colmare? Se proviamo a sviluppare l’ipotesi che la narratrice (come l’agrimensore di Kalkstein) non sia in grado di capire le cose fino in fondo ci si chiariranno molte stranezze. Le chiacchiere della seconda narratrice non hanno solo la funzione sopra detta; la narratrice sembra parlare perché considera importante tutto ciò che la riguarda e misura gli altri su se stessa. Se lei non capisce nulla dell’arte poetica della figlia ciò vuol dire in primo luogo che è lei a non capirle; ciò che risulta obiettivamente non è che quelle arti siano assurde ma che non le si comunicano. La musica del pensionato è diversa da «tutto ciò che abitualmente viene chiamato musica»; non carezza l’orecchio ma lo provoca perché dopo aver «indotto l’orecchio a seguirla, giungeva sempre qualcosa di diverso da ciò che uno si aspettava». La narratrice ne è irritata perché assicura che lei «aveva il diritto di aspettarsi». E invece no, occorre sempre ricominciare da capo, fino a una «confusione» quasi «folle». Al di là di questo, però, in quella musica c’è qualcosa; «irritava», d’accordo, però alla fine «si era quasi commossi». Il marito della narratrice, che pur concorda nel vedere un’«anima» in quella musica, sposta tutta la cosa sul piano tecnico, cioè sullo sbagliato impiego del fiato. Ha ragione? È possibile; certo che il narratore della prima parte, quello stesso che media la narrazione della donna, non ce ne aveva detto nulla. Anzi dalla descrizione della prima parte sembra di poter ricavare l’impressione che la musica del pensionato sarà stata magari futile e dilettantesca, però di certo non incomprensibile. Di più: tutte le sue attività di artista dilettante (musicista, pittore, poeta, parascultore) sembrano avere un che di prevedibile e in questo senso di più che comprensibile. Ma certo non commuoveva nessuno. Nella seconda parte la figlia parlerà «la più pura lingua letteraria» però non si capirà niente lo stesso, tanto che quanto dice sembra «stupido, se non fosse stato, in parte, molto intelligente». Quando la ragazza parla alla taccola le dà «nomi bizzarri e incomprensibili» e in generale quei colloqui erano «per noi incomprensibili». Ebbene, questi colloqui, come le poesie che la ragazza scrive, «contenevano frasi simili» a quelle dei classici che vengono recitati alla ragazza dalla pedagogizzante narratrice; e addirittura la musica del padre sembra «nello stesso spirito». Tuttavia gli scritti della ragazza non sono poetici perché, analogamente alla musica del padre, manca loro «fondamento», origine e sviluppo di quanto espresso. Per di più le citazioni insegnatele la ragazza le ripete come si trattasse di un’«esibizione» e considerandole comunque come «eccitanti». Tutto da condannare, dunque? Se si tenta un con312 fronto con Ditha, la figlia di Abdias, nasce qualche dubbio; anche lei ha un difetto fisico: è cieca e senza orientamento nello spazio. Da qui ella sviluppa una lingua incomprensibile a tutti. Suo padre, il similmente isolato Abdias, arriva infine a comprenderla e a svilupparla con lei; finché da quella lingua così privata se ne forma una quasi comunicabile, in base a un compromesso fra più lingue. Si aggiunga che Abdias ha le sue colpe per la condizione della figlia e infine che i due hanno rotto con l’ambiente di provenienza e girovagato a lungo prima di trovare un insediamento definitivo. Saltano agli occhi le somiglianze con la storia del pensionato e di sua figlia. Nella storia di costoro c’è per di più una parte mai chiarita, anzi rimasta nella «leggenda»: «Una volta circolò la leggenda che il pensionato fosse nelle foreste boeme, che abitasse là in una spelonca, vi tenesse nascosta la bambina, uscisse per procurarsi di che vivere e vi tornasse la sera.» L’unica spelonca che a noi lettori è mostrata è l’abitazione malsana di periferia; resta però il fatto che un’epoca della vita del pensionato presenta lacune e che queste sono colmate dalla leggenda. Da ultimo: la fonte esterna di Stifter, il racconto Der arme Spielmann di Grillparzer, presenta un analogo musicista, inetto alla vita, produttore di una musica che non si comunica. Ditha è notoriamente simbolo della poesia. Difficile non vedere nel pensionato e sua figlia, oltre al rapporto distorto di cui si è detto, anche due esemplificazioni di un’arte non comunicabile perché troppo essenzializzante. Essa ha origine da una sfera non attingibile alla ragione (perciò avvolta nella leggenda) e con cui invece mettono in comunicazione l’isolamento, la sofferenza, la vita dimenticata. Ricordiamo che il pensionato aveva (nella prima parte) due violini e due flauti. Egli porta via un solo flauto (semplificando dunque sui mezzi della sua produzione musicale) e per di più appunto il flauto, «che maneggiava per proprio diletto e allo scopo di migliorare in quest’arte»: proprio lo strumento che sapeva usare di meno e che suonava solo per sé, dunque non per gli ospiti. Di conseguenza fin dalla scelta dello strumento il pensionato sceglie la semplificazione radicale e la non comunicazione. L’arte non si concilia mai a pieno con la vita: costretta a fare una vita per così dire normale, la ragazza sembra venir privata di tutte le sue facoltà spirituali, cosa che per la narratrice è il successo di «trasformare [...] quell’ammaestramento [...] quasi inquietante in pensieri semplici, coerenti e logici e di dare inizio in lei a una comprensione delle cose del mondo»; l’estorta rassegnazione della ragazza si chiama per la benefattrice «abituarsi al normale andamento delle cose». Alla fine la ragazza vive di una carità mascherata: la gente, commossa del suo destino, le compra i prodotti del suo lavoro femminile. È una carità ottenuta diversamente che dal padre accattone; e pur sempre carità. Questo è il rischio cui pongono capo gli sforzi della narratrice. Una persona di buon senso, non c’è che dire: è lei a ridimensionare la notizia della morte del pensionato (che non si è suicidato ma è morto per un incidente), è lei a ricondurre a taccola l’avventuroso corvo visto dal figlio. E in313 fine lei subentra al primo narratore quando questo stesso pareva voler lasciarsi prendere la mano dalla leggenda: quando parlava di una spelonca nella selva boema, mentre in realtà c’è solo una stamberga di periferia. Dunque perfino il primo narratore (quello che nella terminologia corrente si dovrebbe chiamare voce autoriale) non ha uno statuto superiore a quello della seconda narratrice: lui cede ai sogni, lei no. Lei è integrata perfettamente nel proprio mondo, col solido buon senso; non riusciremmo a immaginare che potrebbe mai toccarle la sorte del pensionato. La «serva anziana» di costui era poco più che una mummia, mentre delle cameriere della narratrice veniamo a sapere tutto. E che dire degli atteggiamenti della narratrice rispetto alla musica? La narratrice non possiede le cognizioni tecniche necessarie per criticare le violazioni delle regole che devono presiedere alla strutturazione tonale della frase, tuttavia esercita con sicurezza la sua critica perché difende i propri diritti di ascoltatrice. Non possiamo definirla una dilettante come il pensionato della prima parte perché in lei niente è così mobile come nel pensionato; costui le provava tutte, il che lasciava presagire una certa instabilità, poi puntualmente verificatasi nel variare del suo atteggiamento rispetto a Dall dopo il tradimento e la scomparsa della moglie. La narratrice non è una dilettante perché è inconcutibile e inamovibile nel suo buon senso; è inconcepibile, dal suo punto di vista, che si possa vivere al di fuori. Al contrario, lei è capace di integrarvi tutto. E così la ragazza ne diventa la vittima. A far da involontario intermediario fra la narratrice e il pensionato è introdotto un nuovo personaggio, il professor Andorf. Anche costui è un dilettante, ma di una specie particolare: è un esteta; anzi è un esteta decadente (è uno dei momenti profetici di Stifter). Quel che gode di più è lo spettacolo del progressivo imputridire altrui, o almeno delle cose. Ha scelto una casa fatiscente per il piacere di assisterne alla lenta morte. La narratrice racconta ciò in tono laudatorio. Lei, per quanto riguarda le sue reazioni, è più moderata; ma quando visita la casa del professore si sofferma ad ammirare quello spettacolo di decadenza che a costui dà gioia, e nella sua reazione non si coglie alcuna nota di biasimo. Certo, l’appartamento del professore è tutt’altra cosa: vetri puliti, bianche tende alle finestre. Ma lo spettacolo della morte altrui (o almeno della morte delle cose) non pare proprio dispiacerle. Il pensionato e sua figlia vivono - al contrario del professore e della narratrice - nella morte vera. Il padre le fa scrivere componimenti su solo due temi: sulla futura morte di lui, sull’avvenuto suicidio della madre disperata. Solo così noi veniamo a sapere di questo suicidio e non avremo mai la certezza che esso sia avvenuto e non sia una trovata retorica. Se è avvenuto, allora la ragazza sa più di quello cui porteranno le ricerche del marito della narratrice, che non verrà mai a saper nulla della sorte della madre; ma, appunto, restiamo nell’incertezza: che la ragazza sappia di più resta solo un’ipotesi. Indubbiamente l’educazione artistica della ragazza risente di tutto il dilettan314 tismo del padre. Di costui pare aver ereditato - almeno mima - le reazioni epidermiche; recita brani dei classici, ma come un’attrice. E poi conosce solo dei brani, non sa di contesti; né ha alcun rapporto in generale conoscitivo con le opere. Non può averle lette ma solo aver imparato quei brani: a casa sua non c’erano i libri da cui recitava. A ogni buon conto la narratrice le toglie questa fisima: non legga più classici ma solo libri «facili». L’attività denominatoria non riesce in questo racconto a compiere il miracolo che fa in altri: non istituisce una comunità, i nomi che la ragazza dà alla taccola restano «incomprensibili». Per agire socialmente la poesia deve uscire dalla sua incomunicabile essenzialità e scendere a patti, diventare comprensibile, prestarsi allo sviluppo che la narratrice può comprendere. Forse è vero, forse Stifter condanna sul serio una poesia che non si pieghi; ma la poesia per sua natura non si piega e il compromesso è giudicato dal suo stesso nome. Per la realizzazione di un programma ci vuole bensì l’«immedesimazione» e occorrono «amici omogenei nel sentire», come dice la prefazione; ma la poesia stessa sgorga da altre fonti, più o meno inspiegabili. Anche per questo verso siamo ben oltre la prefazione. Solo dopo aver partecipato agli sforzi comuni per strappare i propri figli all’orrido, invece di seguitare nella battaglia solitaria e disumana contro il suocero, Sebastian riceve il proprio nome. E l’orrido era il sempreuguale dello spazio. Il sempreuguale quale ripetibilità infinita è un segno del mito, quindi la denominazione è un superamento del mito. Ma la Sabine di Kalkstein è il sempreuguale del tempo e come tale riceve un nome: è la rivendicazione della costanza della natura e del mito all’interno del progetto umano. Se poi supponiamo che l’attività denominatoria sia funzione eminente della poesia, allora essa (in Turmalin) si contrappone agli sforzi integrativi, cioè riduttivi ma - a quel che pare - eticamente preziosi della comunità. Invece in Granit l’attività denominatoria assicura il contatto con la natura e quindi la pace fra gli uomini nel rispetto della libertà giocosa. Forse possiamo tentare di unificare tutto ciò ipotizzando che attraverso gli sforzi comuni - dunque attraverso l’etica sociale - la poesia si dimostra ed è domesticabile. Ma di per sé isola. Dunque il mito dà luogo alla storia passando però attraverso l’abisso del cuore umano; la metafisica sorregge la scienza delle cose ma passando attraverso la non loquenza o l’incomunicabilità. Abbiamo così ricavato un sistema più complesso che all’inizio. Eccolo in breve. A. Le leggi della natura sono tali perché costanti, universali, globali e intese a conservare il mondo. B. Anche le leggi etiche rispondono agli stessi requisiti. 315 C. La comprensione delle leggi fisiche e la comprensione e l’applicazione sempre più complessa delle leggi etiche sono conseguenze dello sviluppo storico. D. Nella storia dell’etica è concepibile un tracollo. E. L’etica offre la base all’estetica. F. Nell’interscambio tra uomini e natura la denominazione occupa un grande posto: essa consente l’appropriazione della natura e il riconoscimento dell’individuatezza. G. La natura non è fatta in vista dell’uomo. H. La conquista della verità e della poesia avviene a prezzo di grandi prove, che compromettono per sempre chi le supera, fino a sacrificarne l’individuatezza e a respingerlo dalla comunità umana. I. La naturalezza non può essere un modello di vita. L. L’attività denominatoria è funzione di quella poetica, che di per sé sola non fonda alcuna comunità, anzi isola chi la pratica a fondo. La natura contraddittoria del sistema così ottenuto non ci imbarazza; sappiamo infatti che essa è dovuta al dinamismo. Dobbiamo però chiarire in linea di principio come sia stato possibile ottenere un sistema omogeneo (cioè tutto di concetti) quando invece avevamo a disposizione due grandezze disomogenee, e cioè da una parte già un sistema di concetti (nella prefazione) e dall’altra una raccolta di racconti. Dunque avevamo per base due diversi sistemi di organizzazione e due diverse basi materiali: da una parte concetti, dall’altra sia dei concetti (più o meno relativizzati a seconda del da chi e del come venivano espressi) sia delle immagini organizzate. Perciò c’è da render conto anche di un’altra cosa: pur avendo detto all’inizio che le immagini dicono altro dal concetto anche quando paiono esserne una conferma, questo postulato sembra essere andato perduto nell’univocità della soluzione sistematica. Prima di render conto del primo punto (in che modo è stato ottenuto il sistema finale) anticipo che la soluzione ottenuta viene messa in discussione dalla sua stessa base: dalle immagini. Queste sono il motore per arrivare a sempre nuovi concetti, anche a quelli che io come interprete non sono stato in grado di vedere poiché, mentre le immagini sono qualcosa che li sostiene e li provoca, sono anche ciò che non vi si lascia ridurre. Il mio discorso, a considerarlo nella sua autonomia, è stato un’organizzazione di concetti, solidale in ciò ai concetti espressi da Stifter come tali. Ma per esprimere quell’organizzazione (nei due aspetti di concetti “raccontati” e “immagini”) io ho dovuto riorganizzarmi e un po’ scomporre, un po’ mimare l’organizzazione che vedevo in Stifter. Riorganizzarsi vuol dire non coincidere perfettamente con la prima organizzazione; la 316 non coincidenza può essere più grave nel caso delle immagini e meno nell’altro, però è pur sempre non coincidenza. Dunque finiamo con l’avere due sistemi diversi: quello del critico e quello dell’autore. Nella non coincidenza c’è la possibilità dell’“errore”. Ma la stessa non coincidenza permette di riaggiustare continuamente il discorso critico, cioè di riparare all’“errore”, ovviamente mediante un riaggiustamento del sistema critico, che per una tal via - non coincidendo in modo nuovo - darà luogo ad altri “errori”. Per analogia però indurremo che anche nel doppio sistema di partenza (prefazione + immagini) c’era una qualche non coincidenza; anzi che questa era entro le immagini stesse, per quel tanto che esse sono rapportabili a concetti: potremo così spiare nel non-detto del testo, senza che tale non-detto ci si riveli mai fino in fondo, ma sfidandoci ogni volta a tentare di dirlo. Abbiamo ricostruito un sistema di pensiero e a ciò sono stati utili vari procedimenti. È stato importante ricostruire (sia pure solo con rapidi cenni) uno sfondo storico e una motivazione da esso dettata. Stifter voleva scrivere un’opera alternativa ai moti rivoluzionari, un’opera per i bambini e le madri, che non fanno la rivoluzione, e atta a favorire, attraverso un processo pedagogico, lo sviluppo dell’etica, già favorito all’agire di una «dolce legge». Questo intento permette di capire una sutura che Stifter introduce nel suo sistema di immagini e cioè in particolare l’introduzione di una seconda narratrice in Turmalin: costei consente di allontanare il più possibile sia dall’autore sia dal lettore la rivelazione della natura dionisiaca dell’arte, quella che sembra compromettere le tesi esplicitate con riferimento agli esempi della tragedia e dell’epica e che vogliono convogliare l’arte verso un esito etico-sociale. In questo modo una tesi sull’arte e una forma narrativa vengono fatte interagire fino a rivelare quello che doveva esserci nascosto e che nella vicenda interpretativa di Turmalin è rimasto effettivamente nascosto. Per capir questo, dunque, ho bisogno di più confronti esterni: con le intenzioni storiche, con le intenzioni estetiche, con le versioni dello stesso racconto (tra la prima e la seconda, più problematica versione, la narratrice interviene per spezzare l’unità del racconto, cioè per allontanare, nascondere e quasi sopprimere - ma a distanza dal primo narratore, quindi prendendosene la responsabilità - quanto di conturbante c’è da dire). All’interno della stessa versione confronto luoghi del testo esaminandone sia la similarità sia la diversità di posizione e quindi di funzione. Tutto ciò si lascia fare con metodi “scientifici”, cioè verificabili e “falsificabili”. Tutto ciò dà luogo a un sistema di concetti con cui ho indubbiamente forzato quello di Stifter. È sì omogeneo a questo poiché ne mima il rapporto posto fra etica ed estetica; ma non vi coincide poiché sussiste grazie alla frattura che ha stabilito nel secondo. E inoltre come interprete mi trovo al di fuori del suo sistema di metafore; se volessi mimare quest’ultimo non sarei un interprete ma costruirei qualcosa di interpretabile a sua volta e allo stesso modo. Qui non è questione di sfasatura di tempi storici ma di campi d’azione; la creatività dei concetti crea solo un sistema di concetti. 317 Non molto dissimile è stato il procedimento per tradurre in concetti l’attività denominatoria. È stato decisivo collocare i luoghi di questa attività nei vari racconti: nulla avremmo potuto ricavare dal nome Sebastian in Bergkristall se l’avessimo trovato già all’inizio. Nel confrontare però gli esiti di queste analisi nei racconti non siamo arrivati a un risultato univoco: le conclusioni valide per Granit e Bergkristall non lo sono state per esempio per Turmalin, in cui sulla denominazione fa aggio il filtro della seconda narratrice ben sicura di poter distinguere tutto ciò che è “incomprensibile” (ma che a sua volta non riceve un nome); né sono valide per Kalkstein o Katzensilber (Biotite bianca), in cui le cose stanno ancora diversamente. Abbiamo attribuito un valore concettuale alle stesse forme, sia nel loro esserci sia nel loro non esserci: così la periclitante cornice di Kalkstein ci ha portati a un discorso sulla parziale identificazione di lettore e narratori, rimettendo in discussione una tesi di Stifter e così portandoci a un altro concetto, non esplicitato dall’autore. Qui non siamo più alle intenzioni di Stifter quali sono ricostruibili dal suo sistema concettuale (quello della prefazione e delle lettere); anzi in esso non sembrano inscrivibili, o solo con difficoltà. Questi concetti vogliono essere una traduzione delle leggi poetiche, cioè di immagini e loro organizzazione, in un’organizzazione di concetti, che trova in quelle la propria base. Siamo a un circolo vizioso: il sistema concettuale dell’interprete si basa su un sistema che risponde a leggi proprie, la cui riducibilità a quei concetti viene dimostrata solo da questi mentre il sistema base si rifiuta di dimostrarla. Un sistema pretende così di tutelare ciò cui pretende di dovere la propria materia, che però gli è estranea. A sua difesa può rilanciare solo oltre se stesso sostenendo di essere un’accumulazione di pensiero detto e organizzato, che consente l’accesso a quel che è il non-detto e fonte e materia dell’organizzato; ma questo rilancio porta solo a un altro sistema, che a sua volta sosterrà di far scorgere un altro nondetto e così via. Il sistema qui ottenuto risente della prospettiva etico-estetica teorizzata da Stifter. Dunque è comunque avvenuta una mimesi. E perciò è molto discutibile che questo complesso di ragionamenti sia senz’altro trasponibile a un autore fuori da quella prospettiva. È concepibile che in tal caso sia necessaria tutt’altra mimesi. La ricostruzione del sistema concettuale intenzionale dell’autore resta un prius e il rapporto (cioè eventualmente la distanza) fra quello e il nostro detta il metodo di indagine. Dopo qualche istante, Natalie, Clotilde e io venimmo chiamati in sala, e Matilde disse: il signore e la signora Drendorf hanno chiesto la tua mano per loro figlio Heinrich, Natalie. Queste parole, molto semplici, si leggono a pagina 692 di un romanzo (Der Nachsommer - L’estate di San Martino -, 1857) che conta poco più di settecento 318 pagine; quindi grosso modo alla fine del romanzo. Non hanno bisogno di particolare commento: c’è una richiesta di matrimonio e la madre sta comunicando alla figlia che due signori hanno chiesto la mano di costei per conto del proprio figlio. La cosa un po’ buffa è che soltanto a pagina 692 si viene a sapere che il pretendente si chiama Heinrich Drendorf; per 691 pagine e mezza il nome di Heinrich Drendorf non era mai stato fatto, sebbene questo signore comparisse fin dalla prima riga del romanzo, di cui è sia protagonista sia narratore. Finalmente pronunciato, in quel nome si riassume la globalità di un processo capace di spaziare attraverso la forma del mondo. Quanto è avvenuto per 692 pagine è stato il formarsi di una persona (per cui questo romanzo è stato posto sotto la categoria Bildungsroman), che ha attraversato quella che per Stifter è l’enciclopedia delle cose da fare: la conoscenza della natura, la pratica dell’arte, la conoscenza delle forme sociali, della storia, attraverso l’itinerario lungo il quale per Stifter si esplicano le forme umane. Il nome è diventato finalmente pronunciabile, e cioè si possono fondare forme di convivenza, quali il matrimonio, che a loro volta si reimmettono nel processo: l’io non è il legislatore e creatore del mondo, ma è il riassunto di ciò che ha capito e fatto per dare impulso a nuove relazioni di capire e fare. Allo stesso tempo, il nome pronunciato dimostra la traducibilità linguistica del processo. Queste tesi si lasciano ricondurre a un nucleo più ristretto: quel che importa è la sostituzione della razionalità del processo con la vitalità del progetto, cioè la sostituzione di una interpretazione del mondo che pretenda di essere tutta riportata a termini razionali con quella che Stifter chiama la reverenza nei confronti delle cose, posta su una base vitalistica e orientata verso la coltivazione del particolare. Nel 1857 esce dunque un romanzo che non ripete i dubbi e le esperienze abissali del passato ma anzi si pone come un romanzo positivo. Ciò è stato molto contestato all’interno della storiografia e della critica stifteriana. Occorre però dire che se si vede in Stifter non semplicemente il tentativo di restaurare quello che c’era prima della rivoluzione, ma il tentativo di proporre soluzioni a due fallimenti, al fallimento rivoluzionario e alla negatività della critica alla rivoluzione, se cioè si vede in Stifter il positivo che viene dall’esperienza stessa del negativo, allora occorre dire che il suo tentativo si oppone alla smania di trovare sia un punto finale della storia sia un momento in cui ricominciare tutto da capo. Ma occorre aggiungere subito, (anche se propongo di vedere Stifter in questo modo, cioè non come un restauratore, ma come uno che trae la conseguenza da certi fallimenti, e non da disperato, ma come uno che vuole costruire) che egli paga dei prezzi molto alti. La devozione nei confronti delle cose diventa descrizione maniacale di qualunque atteggiamento. Il porgere una scodella di minestra, cosa che si può dire con tre parole, in Stifter prende mezza pagina, perché descrive la piega che fa la manica di un vestito, l’ombra che getta questa piega sulla manica e tutto insieme poi sul tavolo, il colore del polsino che si vede at319 traverso la manica, la posizione della figura sul tavolo, il mestolo che viene impugnato, la scodella che viene avvicinata, la minestra che viene versata, la scodella che viene posata, la zuppiera che viene posata, e tutto questo con frasi inscatolate l’una nell’altra, per cui la descrizione di ogni cosa minima diventa un avvenimento epocale. Il prezzo dunque è stato pagato da Stifter in termini di assenza di dinamismo, dicono alcuni. In realtà il prezzo è ancora maggiore: esso è stato pagato in termini di repressione di ogni movimento, pur puntando Stifter alla proposizione di un progetto su base vitale, cioè biologica. È questo il senso del matrimonio finale. E quanto a quel nome sospirato tanto a lungo, se ne può dare ancora una spiegazione, la quale tenga conto di questa reverenza per le cose. Il suggerimento che viene fatto è che si può arrivare a un nome proprio, quindi a dispiegare ampiamente il proprio soggettivismo, se si è prima passati attraverso un processo di oggettivazione, se ci si è identificati stabilmente con una cosa. Solo in un secondo momento, si suggerisce, ci si può storicizzare esaltando la propria soggettività. Come spiega però la biografia di questo signore, tale esaltazione è contemporaneamente delimitazione: ha rinunciato alla donna amata, ha abbandonato il servizio di stato a vantaggio delle cose, e quindi da una parte si è delimitato, dall’altra si è doppiamente oggettivato, prima in ciò che possiede e poi nelle singole cose che produce. C’è, come si vede, uno scambio tra oggettività e soggettività, che però passa necessariamente attraverso una drastica, dolorosa, rinunciataria delimitazione. E a questo punto si danno i nomi; in questo romanzo, Stifter ripete pari pari l’esperienza già fatta nei racconti precedenti. Denominare significa fondamentalmente due cose. La prima è: mettere ordine nel mondo, testimoniare una raggiunta consapevolezza, una raggiunta formazione, un rapporto positivo con le istituzioni; cioè significa testimoniare interrelazioni sociali giuste. La seconda è quella che non viene più ripetuta: denominare significa creare un’essenza, cioè dar luogo alle forme poetiche. Nel ripensamento che Stifter sta facendo di questa sua stessa esperienza dopo il fallimento della rivoluzione, restano da una parte le interrelazioni e dall’altra l’oggettivazione, l’identificarsi con singole cose. Quello che è stato accantonato era l’elemento inquietante, e cioè che il denominare mettesse in contatto con una zona mai controllabile. C’è però ancora qualcosa da notare a proposito della reverenza per le cose: essa è tutt’altro che bigotta ma mira al sodo: alla razionalizzazione del lavoro, al profitto. Data l’importanza, è bene dilungarsi un po’ e con l’occasione evitare uno dei tanti equivoci su Stifter. Un altro personaggio importante, innominato anche lui per qualche centinaio di pagine, rivela a un certo punto il proprio nome e in quell’occasione racconta la propria storia: racconta la propria irrequietezza e dice come, per ragioni biografiche, a un certo punto fosse entrato nel servizio statale. In esso non era riuscito a conciliare una parte della sua educazione, l’amore per le forme belle, con quello che invece si richiede a uno che sia in quella professione, cioè lo sguardo generale sulle cose (per cui si fa un deter320 minato lavoro, anche se esso nel particolare non dice niente di interessante a chi lo fa, ma serve alle relazioni generali). Queste relazioni generali non sono forme belle, sono relazioni vuote. Chi ama le forme non può amare questo tipo di relazioni: «le forze che si muovevano in lui pretendevano forme, e si muovevano soltanto intorno a delle forme». Perciò abbandona il servizio di stato, per dedicarsi a «venerare le cose, non a guardare l’utilità di chi venera le cose, ma soltanto a obbedire a quello che le cose pretendono». Tuttavia all’interno di questa stessa dichiarazione si parla di una qualche utilità che dalle cose si può tuttavia ricavare. Le cose in questione sono, romanticamente, le rose; il nostro narratore è diventato un coltivatore di rose. Ed ecco le conseguenze di tal riflessioni e di tale maturazione: si accorge che nella casa da lui frequentata il valore del tempo era considerato grandemente e che veniva utilizzato con molto scrupolo. «Allora» continua il narratore «anche se finora non potevo rimproverarmi di essere uno che sciupa il tempo, tuttavia cominciai a procedere con più ordine che in precedenza verso uno scopo unico, durante un tempo determinato, in maniera da poter finalmente raggiungere un effetto adeguato allo sforzo che impiegavo, e mi proponevo risultati esattamente delimitati». Come si vede, qui siamo alla misurabilità: sia del rapporto causa-effetto sia del tempo. Contemporaneamente siamo all’interno di una nuova costellazione, cioè di aspettative diverse. «I miei subordinati trovarono un punto di riferimento concreto nel nuovo ordine, e crebbe la loro fiducia in me [sembra un discorso morale? ma ecco la sorpresa:] così che il lavoro risultò meglio commisurato e funzionale allo scopo». La costellazione introduce dei valori misurabili. Si converrà che è quanto mai fuori luogo parlare di Stifter come autore idillico e in fuga dal suo tempo. Eppure è questa l’interpretazione che gli è toccata più di frequente. Nei tempi moderni è stato un po’ lo scrittore nazionale dei tedeschi che dopo la seconda guerra mondiale sono stati espulsi dai Sudeti. Colui che nel Witiko aveva cantato la convivenza dei vari popoli in Boemia poteva effettivamente dire una parola di pace e di riconciliazione, e fin qui niente di male. Ma l’idillio e il nazionalismo della Dorfgeschichte, che si sono voluti vedere in lui, questi erano proprio fuori posto. Ogni tanto emergeva qualche voce discordante; Arno Schmidt, che abbiamo già incontrato nel suo strano entusiasmo per Gutzkow, definì Stifter un «sanfter Unmensch», un dolce mostro. E sarebbe stato perfino giusto, se ciò non fosse andato di pari passo con un suo tentativo di svalutarlo. Stifter è invece uno dei riferimenti classici di Peter Handke, che qualcuno definisce uno dei grandi maestri della miniatura; una lunga citazione dallo Hagestolz nella sua commedia Die Unvernünftigen sterben aus (Esseri irragionevoli in via d’estinzione, 1973) viene da lui così commentata: Allora, nell’Ottocento, anche se non si avevano proprio più per niente sentimenti cosmici, almeno ce n’era un ricordo e una nostalgia. Per questo li si poteva imitare e recitare agli altri, come per esempio in questa storia. E poiché li si 321 imitava con tanta serietà e pazienza e coscienziosità come un restauratore, quale Stifter del resto era, i sentimenti si provavano anche realmente, forse. Ma a quell’epoca si stava parlando di Stifter già diversamente che nel passato: era occorso uno scossone venuto dalla scuola di Adorno e che letteralmente oggi appare insostenibile, ma che tuttavia aveva cominciato a mettere Stifter in rapporto con i problemi dei nostri tempi. Witiko (comparso in tre volumi dal 1865 al 1867), secondo e ultimo romanzo di Stifter, ebbe un’accoglienza talmente cattiva che all’autore riuscì poi difficile, nel poco tempo che gli restò da vivere, piazzare ancora dei racconti presso riviste. E neanche in seguito ha avuto molti estimatori. Tuttavia (come già ricordato) nel 1921 Ernst Bertram lo dichiarò l’unico vero romanzo storico tedesco; e aggiungiamo che i primi due volumi vanno annoverati tra le maggiori cose della letteratura tedesca. Si tratta per più ragioni di un vero romanzo storico, paradossalmente con tutte le falsificazioni del romanzo storico. La vicenda è ambientata nella Boemia del XII secolo e riguarda le lotte per la successione a quel trono. Witiko vi è coinvolto, appoggiando il pretendente che ritiene sia tale secondo giustizia; il tema vero è dunque la legittimazione del potere, il rapporto governante-governati, il consenso che è legittimo dare a chi ha il potere e che questi può legittimamente attendere, i modi della conciliazione tra fazioni. Dunque si trattava di tempi politici e giuridici, che interessavano sia la moderna natura dello stato e del convivere civile, sia l’origine della convivenza specifica fra tedeschi e boemi. Tutto questo doveva avere una trattazione epica, per la quale Stifter trovò un stile scarno e ripetitivo, che nei suoi momenti migliori arriva a grandi effetti; esso va di pari passo con altri due momenti, in tensione fra di loro: una oggettivizzazione e una relativizzazione spinte all’estremo. Eccone due esempi. La dieta di Wisehrad deve decidere sulla successione al morente duca Sobeslaw; per incarico di quest’ultimo, Witiko vi partecipa per osservare e possibilmente sventare le manovre dei nobili. Dopo che Witiko si è presentato all’assemblea e ha detto tutta la verità sulla sua presenza, l’attenzione si sposta da lui e verte sugli interventi dei nobili. Noi lo perdiamo completamente di vista: il quadro si frammenta nei tanti interventi. Che cosa faccia o pensi nel frattempo Witiko non lo sappiamo. Solo più tardi, e solo dal commento di un altro personaggio, verremo a sapere che il suo contegno è stato valoroso, standhaft. Così il quadro, già frammentario, si ricompone: la relativizzazione e l’oggettivazione crescono ma invece di divaricarsi, si completano a vicenda. Durante la battaglia di Holaubkau Witiko dà «ai suoi cavalieri l’ordine di una manovra per avvolgere i nemici; ne risultò una falla, i nemici vi entrarono e fuggirono verso Praga». Sulla prime il lettore è portato a credere che si tratti di un semplice sbaglio di Witiko; perfino l’amico e combattente Odolen lo crede! Poi invece si chiarisce – e per bocca dello stesso Witiko – che non era un errore ma 322 una consapevole disubbidienza. Ancora una volta, il quadro si ricompone come prima. Nel colloquio iniziale con Bertha, la ragazza che poi sarà sua moglie, questa chiede a Witiko: «cerchi una felicità diversa da quella che si ha a casa?» E Witiko: «Sì […], vado verso un grande destino, quale si addice al giusto.» Ciò – si noti bene – richiede di affrontare la ricerca nello spazio e richiede l’attività del fare; infatti non sarebbe una cosa giusta se si sapesse già dove si trova la felicità e bastasse recarsi a raccoglierla. Prima mi farò da solo la mia sorte. Che cosa significhi questo per la concezione dello spazio lo si vede – e credo sia l’esempio più notevole – quando Witiko, non essendosi posto al servizio di Wladislaw, il pretendente eletto a torto nella dieta ricordata, si ritira a Plan. Da lì egli fa una serie di visite; ognuna è trattata per conto proprio, come se si ripetesse una frantumazione che noi conosciamo magari non tanto da quella dello spazio in Der Hochwald quanto da quella dei gesti in Abdias. Alla fine però si ricostruisce sia l’insieme dello spazio sia il senso: Witiko ha descritto un cerchio intorno a Plan, allo scopo di visitare tutti i suoi vicini e stabilire buone relazioni. Egli dunque ha esplorato lo spazio secondo un disegno, per di più allargando il raggio: infatti a quelle visite di più giorni e settimane era preceduta l’esplorazione quotidiana dello spazio più immediato. Ora se si dice che nel Witiko non c’è movimento lo si può dire fondatamente in un senso: che cioè non c’è subordinazione di un settore dello spazio all’altro ma tutti hanno gli stessi diritti. E a ciò rende giustizia lo stile epico, con le sue famose (o famigerate) iterazioni, che apparentemente segnano il passo e di fatto assestano gli avvenimenti. Dietro tutto ciò c’è una filosofia. Nei suoi giri tra i vicini, Witiko porta poche certezze, un’indecisione – che poi non si distingue troppo dalla tolleranza – e per il resto ha da imparare e da stare ad aspettare che i tempi maturino. È comunque certa una cosa: non si lascerà trascinare «dall’impeto degli impulsi», come invece capita ad altri. E poiché questo modo di fare gli è estraneo può affermare: «Molti uomini non posso capirli e riconoscerli nel loro agire». Ma questa ignoranza è piuttosto l’opposizione di un tipo di vita all’altro. Anche il decorrere del tempo appare meno terribile perché il passato e il futuro vengono riempiti di un contenuto che assicura la continuità: il passato è reso pieno dai ricordi dei genitori, il futuro dal pensiero dei discendenti, il presente dal bene che si può fare per chi ci è intorno: «Tutti cercano il loro futuro», disse Boleslawa, «e credono che arriveranno a qualcosa di molto buono.» «Se non lo facessero», replicò Lubomir, «la vita si fermerebbe. È ancora una fortuna se da parti estranee non vengono cose che smarriscono l’uomo e lo fanno 323 tralignare.» «E poi si può ancora cercare di ottenere il bene per chi ci vive intorno», disse Boleslawa. «Quando io, che non cerco più un nuovo futuro, mi trovo fuori, dalla gente che ci abita intorno», disse Lubomir, «e loro mi fanno domande o espongono desideri oppure io parlo con loro, allora quel che succede a me è proprio ciò che io voglio per loro.» «Quel che l’uomo fa è anche la sua compagnia», disse Boleslawa, «non è così, venerabile padre?» «Quel che un uomo umilmente compie», disse l’uomo all’estremità inferiore della tavola, «è la discendenza che gli rimane, per quanto incompiuta essa sia.» «Se però la felicità di questa terra non viene turbata», disse Lubomir, «e nella capanne, nelle case e nei campi innocenti non arriva la disgrazia.» Allora è possibile leggere in Witiko «Tutti i segni si compiono» perché il tempo e lo spazio sono sotto controllo, mentre in Der Hochwald si poteva leggere «Tutti i segni di Ronald ingannavano». Si può obiettare che non sempre questa impostazione convince. D’accordo, Witiko non è uno sciocco, e quando viene offeso sa difendersi, anche con la spada se è necessario. E tuttavia i contrasti sembrano tutti addolciti, così che può nascere qualche dubbio sulla liceità dell’operazione; e viene da chiedersi se le tensioni delle precedenti opere di Stifter non erano più convincenti del successivo assestamento: quando si concilia troppo, il potere diventa anch’esso troppo; e non può essere solo un caso che il romanzo finisca con immagini di desolazione: con Federico Barbarossa che rade al suolo Milano, mentre il volenteroso Witiko gli dà una mano. 324 VI Come resiste il Romanticismo 325 326 Si è più volte avuta occasione di riferirsi al romanticismo, tanto per segnalarne la fine quanto per ricordarne la persistenza. Ora è giunto il momento di condensare tali richiami intorno a due serie di fenomeni discretamente omogenei fra loro. La prima è quella della triade femminile che nel 1834-35 calamitò su di sé l’attenzione del mondo intellettuale; la seconda è quella – curiosa, imbarazzante, paradossale – di chi conservò l’eredità romantica come stratificazione di significati nella stessa opera. VI, 1. La triade Mettendo insieme le tre donne di cui si parlerà, si fa un omaggio allo Junges Deutschland. Rahel Levin ha bensì una storia ben più lunga e complessa di questa temperie culturale, cosa che (mutatis mutandis) si può dire anche di Bettina von Arnim; e l’adesione di Charlotte Stieglitz allo Junges Deutschland è creazione del suo editore, mentre il marito si è mostrato in proposito assai perplesso. Tuttavia fu allo Junges Deutschland che esse apparvero come una triade: tra loro omogenee e fonti di ispirazione omogenea. A noi oggi le cose appaiono ben diversamente, e lo vedremo; ma è giusto prendere lo spunto da quell’atto di ricezione, che è un importante atto storico e creativo: esso non si limitò infatti a recepire, ma creò dal nulla la figura di Charlotte Stieglitz. La triade è una triade perché, sulla scorta soprattutto di Rahel, lo Junges Deutschland inventò la terza figura. Il 7 marzo 1833 muore a Berlino Rahel Levin, sposata Varnhagen von Ense (nata a Berlino stessa nel 1771). Nello stesso anno il marito ne pubblica, in edizione fuori commercio, una scelta di lettere, diari, dichiarazioni orali annotate da qualcuno, sotto il titolo Rahel: ein Buch des Andenkens für ihre Freunde (Rahel: un libro per memoria dei suoi amici); nel seguente anno 1834 questa scelta viene ampliata, portata da uno a tre volumi e, con lo stesso titolo, messa regolarmente in circolazione. Ebbe grande successo, tanto che presto seguirono altri volumi di scritti scelti. Ma fu soprattutto l’opera citata a fare storia. Vari testi lì contenuti, per la verità, erano già stati pubblicati in vita dell’autrice, però sotto anonimato. E i celebri salotti della Levin si erano tenuti a Berlino dal 1796 al 1806 e poi di nuovo dal 1819. Ma attraverso la pubblicazione di quel libro, ella parlava ormai a un altro pubblico, a un’altra generazione e diventava addirittura uno dei numi tutelari dello Junges Deutschland; Gutzkow (e non fu certo il solo) parlò del «trifoglio» formato da Rahel, da Bettina von Arnim (nata Brentano) e da Charlotte Stieglitz. Erano persone ben diverse tra loro, ma vennero comunque viste come una triade. 327 Il pensiero di Rahel è sicuramente importante, ma più importante ancora appare il modo in cui esso si forma e si comunica. Il pensare è la vita stessa: un libro, una conversazione, un’emozione, uno spettacolo, un viaggio, una malattia, una visita (anche fastidiosa), insomma qualunque cosa occorra a un essere umano, in qualunque momento della giornata, sono avvenimenti per una sintesi di riflessione e sentimento, di esperienza intima e comunicazione, di assimilazione e restituzione: Che cos’è l’uomo se non una domanda? Egli è qui per domandare, solo per domandare, per porre domande sinceramente ardite e per aspettare umilmente la risposta. Porre domande non ardite e darsi risposte lusinghevoli è la ragione profonda di ogni errore: e se si è sinceri eppure si sbaglia, è per eccesso di delicatezza e difetto di chiarezza. (A Adam von Müller, 15.XII.1820; III, 30) Rahel tiene in gran conto il sentimento, ma non è una sentimentale; tiene in gran conto il raziocinio e, per quanto si possa scendere nel profondo della coscienza, Rahel ritiene che vi si troverà ancor sempre giudizio, il quale a sua volta appartiene alla nostra organizzazione tanto quanto il nostro corpo (3.I.1820; III, 3). Possiamo essere d’accordo oppure no con questa e altre idee di Rahel; possiamo condividere oppure no i suoi giudizi su fatti e persone della cultura dell’epoca; quale che sia la nostra reazione, ci troveremo di fronte a una forma del far cultura che in lei raggiunge un vertice: cultura è ogni atto di vita. E Rahel è uno specchio e una miniera: lei conobbe davvero tutti, gli impulsi, gli stimoli, le idee che irraggiavano da lei arrivarono a chiunque all’epoca scrivesse e pensasse. La sua sintesi di illuminismo, classicismo e romanticismo, il suo essere di casa e nel razionalismo come nella mistica, nel liberalismo come nel socialismo fecero di lei un punto di riferimento; e il libro che per primo ne consegnò la parola alle generazioni successive e fondamentalmente allo Junges Deutschland divenne un modello, imitato con importanti conseguenze. Tra le recensioni che lo salutarono, scegliamo quella di Theodor Mundt (pubblicata nel 1835) all’edizione in tre volumi. Mundt vede in Rahel colei che non posa mai e non nasconde niente ma, al contrario, «porta alla luce quel che c’è di più segreto e pericoloso nell’intimo della natura», aiutando a interrogare «il dolore metafisico primario di tutto l’universo». Pertanto Rahel suscita impressioni tanto più sconvolgenti in quanto esse vengono consegnate a un’epoca di epigoni: si ricordi che la sensazione di epigonismo, emblematicamente riassunta nel titolo del romanzo di Immermann, era quanto mai diffusa; Mundt parla della sua epoca come di una in cui la forza della tradizione schiaccia l’originalità, di un’epoca di transizione fatta di paura del presente e del futuro; e ne parla anche (manifestamente echeggiando Heine) come di una che si è appena congedata dall’era artistica. Rahel appare come una che sa rivivere in maniera produttiva e 328 interiorizzata le idee dell’epoca, le quali nel caso di Rahel vanno dall’illuminismo a Saint-Simon. Mundt discute a lungo le idee di Rahel in materia di religione, discutendone ampiamente poiché secondo Mundt la forma attuale della religione non è superata e nell’idea originaria del cristianesimo occorre cercare il punto di partenza per ogni ulteriore sviluppo. In piena consonanza con le idee jungdeutsch, Mundt, ammesso il superamento dell’epoca artistica e constatato che «l’epoca industriale promessa dai nostri profeti sociali [=Saint-Simon] è ancora una chimera», sottolinea che, «dovessimo fallire nella produzione di opere d’arte scritte su carta, siamo però già intenzionati a non fermarci lì e a far valere nella vita, nello stato e in tutta la nostra formazione umana quel che deve diventare opera d’arte». Per la verità Mundt non è per nulla sicuro dell’esito, poiché parla della sua come di un’epoca frammentata e vede l’epigonismo in un eccesso di consapevolezza, che paralizza l’azione e conduce a una «viltà piena di pensiero». Come si vede, più che una recensione quella di Mundt è una presa di posizione: quella di Rahel è una voce importante e un’influenza ineludibile. Proprio Mundt doveva saperlo meglio di tutti poiché nello stesso 1835 pubblicò un libro ricalcato per filo e per segno su quello di Rahel. Tuttavia esso non portava il suo nome; sul frontespizio si leggeva semplicemente: Charlotte Stieglitz, ein Denkmal (Charlotte Stieglitz, un monumento); la prefazione, datata 5 agosto 1835, era firmata da un “curatore” non nominato. Il libro pubblicava una scelta di lettere, diari e dichiarazioni orali di Charlotte Stieglitz, nata nel 1806 e morta suicida pochi mesi prima (dicembre 1834). Il caso fece enorme impressione: ne parlarono quasi tutte le riviste europee; ma – questo possiamo dire oggi – fu più un caso voluto da Mundt che non risiedente nelle cose stesse. Rispetto al libro di Rahel, infatti, questo si differenzia per i continui commenti, le interpretazioni, le vere e proprie proposizioni di tesi che Mundt interpola, mentre Varnhagen si era limitato a un’introduzione costituita da ricordi personali. Mundt dichiara subito che il concetto di «cosa pubblica» (Öffentlichkeit) è cambiato e che, per dirla in termini moderni, il privato è pubblico: occorre aprire le camere e il libro mostrerà in un caso singolo l’espressione di una situazione generale. Charlotte Willhöfft aveva sposato il mediocre poeta Heinrich Stieglitz (18011849). Ne era risultata un’unione destinata a finire tragicamente: lei nervosa fino all’esaltazione, lui incline a manie depressive; lei colta ma non produttiva in proprio, lui tanto ambizioso quanto indolente e, per dirla tutta, assai poco dotato. Mundt li conosceva e frequentava entrambi; di lei era ammirato e forse innamorato; le aveva anche dedicato un libro (Kritische Wälder. Blätter zur Beurteilung der Literatur, Kunst und Wissenschaft unserer Zeit – Selve critiche. Fogli per giudicare la letteratura, l’arte e la scienza del nostro tempo -, Leipzig 1833). Insomma da più segni si deduce che Mundt voleva fare di Charlotte Stieglitz una seconda Rahel: una giovane Rahel per la nuova generazione. Del resto il libro di Rahel viene ampiamente citato. 329 Il suicidio di Charlotte ha cause molteplici, ma una anche molto vicina, e fu questa a far sensazione. Vedendo la non produttività del marito, combinata con le sue crisi depressive, e le molte cose che non andavano nel loro matrimonio, Charlotte ne dedusse che per farlo uscire da quell’esclusivo rimuginare su se stesso e in definitiva dalla sua autocompassione sarebbe occorso «un grande e autentico dolore», il quale l’avrebbe innalzato al di sopra di se stesso e addirittura reso felice. Tale dolore liberatorio e ispiratore lei pensava di causargli col proprio suicidio. L’esperimento fallì: il marito, anche da vedovo, rimase quello di prima. Nel libro si parla di tutti gli argomenti allora attuali; un po’ ne parla Charlotte nei suoi documenti, molto Mundt nei suoi commenti: emancipazione della donna, saintsimonismo, religione, unificazione della Germania. C’è comunque una tesi di fondo, e questa ci limiteremo a seguire: Mundt presenta Charlotte come la realizzazione dell’amore romantico. La prima formulazione di questa tesi si ha quando viene narrato il loro disastroso viaggio di nozze; a quest’amore romantico manca l’uomo che ne sia all’altezza: [il corteggiamento dell’uomo deve infine] manifestarsi in infinita dedizione e alienazione dell’io. Non è l’io ad amare, ma l’io e il tu; e l’amore supremo, posizione e negazione al tempo stesso e allo stesso tempo opposizione e legame, sacrificio e godimento, rassegnazione e concessione: tutto il dualismo della vita si mostra e risolve. In seguito, sorridendo ma col viso porpora, Charlotte parlò in un momento di confidenza di questo strano inizio della luna di miele, da lei definita una paralisi del cuore di fronte alla realtà. Ed ecco la fusione d’amore e morte (Mundt commenta qui una poesiola di Charlotte): È solo l’idea ad amare; e la lite amorosa si spegne nel pensiero, la cui forza è stringere nell’unità ogni scissione. Eterna vicinanza è il pensiero che si è separato dall’immagine dell’apparenza, riassorbendo però in sé l’immagine stessa. [… Ma Charlotte] è amica della morte e volentieri morrebbe per conseguire eterna vicinanza all’oggetto amato, da cui nella realtà finita si separa. E così via, descrivendo il matrimonio dei due (o almeno i suoi momenti positivi) secondo i canoni romantici e soprattutto descrivendo i meriti femminili in modi che richiamano molto da vicino analoghi passi della Lucinde di Friedrich Schlegel. Finché s’incontra un elogio della castità che col romanticismo non c’entra niente e invece la dice lunga su quel matrimonio. L’impressione generale è che Mundt tenda non a superare il romanticismo, ma a farlo valere come un’eredità fra le altre, designando l’ambito in cui è autonomi e sufficiente, mentre la realtà nel frattempo si è ampliata e altri settori semplicemente si aggiungono. Quest’impressione è confermata da un appunto 330 di Charlotte, nel quale costei contrappone il soggettivismo di Rahel e Schleiermacher all’oggettualità dell’artista il quale, secondo lei, ha tanti vantaggi rispetto a loro: era l’idea jungdeutsch del superamento dell’era artistica nell’unione di oggettività e formazione interiore. Il marito descrisse attenuandola l’adesione di Charlotte allo Junges Deutschland (Heinrich Stieglitz, Erinnerungen an Charlotte – Ricordo di Charlotte -, hrsg. von Louis Curtze, 1863, p. 52), ma non sembra aver ragione. Piuttosto c’è da dire che a non reggere è il paragone RahelCharlotte; con tutto il rispetto per le sofferenze della seconda, il confronto non è neanche vagamente proponibile. Nello stesso 1835, che sembra un vero annus mirabilis, esce il primo volume di Bettina von Arnim nata Brentano (1785-1859): Goethes Briefwechsel mit einem Kinde (Carteggio di Goethe con una bimba), che la rende famosa d’un colpo. Qui non siamo più al caso Stieglitz-Mundt, non siamo più all’assegnare al romanticismo un posto limitato accanto a esperienze aggiuntesi, forse ritenute più urgenti e importanti (cui Mundt fece spazio nel suo brillante Madonna, anch’esso pubblicato nel 1835, un libro che fa da pendant alla Stieglitz e che meriterebbe di essere trattato ampiamente). Con Bettina la prospettiva è diversa: almeno i suoi primi tre libri mostrano in che modo il romanticismo possa ambire a riassumere in sé un punto di vista generale, una prospettiva dalla quale legittimamente giudicare la contemporaneità. Bettina non è una sopravvissuta, ma al contrario una romantica con pieno diritto e piena autorità. La forma di questo primo libro non potrebbe essere più romantica: lettere, poesie, diari, note musicali, racconti, tutto vi è utilizzato. I risultati sono forse diseguali (e stupendi in singoli momenti) ma la tesi è chiara: l’arte è tutta la vita, ed essa è oggetto d’amore; questo si rivolge a tutto il mondo dell’arte, quindi anche al suo produttore; e l’amore fa vedere tutto in altra luce, cioè produce un altro mondo, di cui è pressocché impossibile dire se ne sia più autore chi dà di sé l’opera d’arte ammirata (Goethe) oppure chi la ammira (Bettina). L’opera ebbe una grande eco; fra i recensori si segnalano un entusiasta Jacob Grimm, dei partecipi Joseph Görres e Willibald Alexis, un arguto Ludwig Börne, un sentenzioso Gervinus e ancora una volta Mundt, secondo il quale Bettina ha tirato fuori «i misteri più profondi, estremi e intimi della natura femminile». Nel 1840 uscì il secondo libro di Bettina: Die Günderode, dedicata a far rivivere la figura di un’altra suicida per amore, la poetessa Karoline von Günderode (1780-1806). Il libro colma una lacuna ed effettua una correzione nel grande trattato dell’amore scritto dai romantici. Friedrich Schlegel aveva sostenuto che l’amicizia è possibile solo fra uomo e uomo, non fra donne, non fra uomini e donne; l’amicizia, infatti, deve essere spirituale e avere limiti precisi, mentre le donne amano totalmente quel che amano. Die Günderode invece offre il ritratto della più straordinaria amicizia femminile del romanticismo. L’amicizia fra Bettina e Karoline (all’epoca cui si riferiscono le lettere esse avevano rispettivamen331 te dai 19 ai 21 e dai 24 ai 26) ebbe un po’ della passione, soprattutto da parte di Bettina; tanto che uno dei temi trattato dalle amiche – e non in astratto ma su se stesse – è quello della gelosia. Sembrava dunque che Schlegel avesse visto giusto. E assumendo come proprio il principio della passività Bettina sembra confermare un altro punto importante nella concezione schlegeliana della donna. Bettina infatti motteggia con arguzia e pertinenza, su questo e su quello, lasciando chiaramente intendere che questo motteggiare non è un principio di ribellione; piuttosto il mondo è quasi un pretesto perché Bettina vi veda come in un caleidoscopio, magari un po’ ridicolo ma colorato e mobile come si conviene; di esso inoltre è capace di analizzare i singoli vetri. Karoline una volta le rimprovera questo atteggiamento e una volta invece glielo ascrive a merito. Infatti da una parte le rimprovera di spegnere la propria energia, dandole della vigliacca: Il tuo sguardo pauroso non osa interpretare lo spirito che alberga in te. Trascuri ostinatamente la tua stessa natura, smorzi la tua forza rigogliosa congiurando malvagiamente contro la tua capacità di capire, che poi di nuovo ti sopraffà […] Pensando a te mi sembra sempre che sul tuo capo assonnato le nuvole scarichino la loro carica elettrica nell’aria pesante, il lampo penetra tra le tue ciglia abbassate, illumina i tuoi sogni segreti, li attraversa con entusiastica passione, cui tu dai voce senza sapere cosa dici, e poi torni a dormire. […] Perché sei vile: le tue ispirazioni ti esortano a pensare, ma è questo che non vuoi, essere svegliata; tu vuoi dormire. Karoline ha una parte di ragione: Bettina sa istintivamente – vorrei dire femminilmente – in anticipo di voler restare nell’ambiente e nelle situazioni che pure schernisce. Ma Karoline trova per questa passività la parola giusta: energia, facendo del termine un uso ben diverso da quello che ne aveva fatto Schlegel: Tu hai l’energia e il coraggio necessari a sostenere il tuo amore per la verità e ha al tempo stesso un’indole così serena che a malapena si accorge delle ingiustizie che vengono perpetrate ai suoi danni. Per te è cosa da nulla tollerare ciò che agli altri risulta insopportabile, eppure non sei compassionevole, ciò che ti spinge a venire in aiuto del prossimo è l’energia. Dovendo riassumere i dati del tuo carattere, potrei predirti, se tu fossi un ragazzo, che sei destinata a diventare un eroe; siccome però sei una donna, interpreto le tue varie attitudini in vista di uno stadio di vita futura, le accetto come basi per la costituzione di un carattere energico, che verrà forse alla luce in un’epoca di vivace attività. Bettina incarna la passività anche nella sua opposizione all’utile, verificando così un altro principio posto da Schlegel. Solo che spinge quest’opposizione molto in là, fin dove forse non sarebbe piaciuto a Schlegel. Bettina infatti non vuole prestarsi a fare niente di utile, neanche nel campo dello spirito. Suo fratello Clemens la rimprovera: 332 disperdi le tue forze spirituali con le quali potresti raggiungere una libertà splendida. Ah! Non sei capace di dedicarti a una cosa sola con tutti i tuoi cinque sensi e capirla interamente? […] tutta la grazie del tuo spirito [è] gettata al vento. Bettina stessa conferma: il mio spirito non vuol prendersi cura di me e vaga laggiù, lontano, dove un’ape vola in cerca di semplici fiori da cui centellinare il nettare, con la differenza che lo spirito il miele non lo sa fare, anzi mangia tutto da solo. Ma subito dopo trova da consolarsi: E giacché l’ape fa il miele per istinto, mentre il mio spirito questo istinto non lo ha, non dovrà nemmeno svernare in luoghi dove non gli necessiti una scorta alimentare: esso appartiene alla terra dell’eterna primavera. E perché mai dovrebbe fare qualcosa di utile? Ma un libro è grosso, ha tante pagine vuote e per riempirle non posso certo inventare tutto di sana pianta, mi sembra che ciò incatenerebbe più che mai la mia libertà. […] un pensiero ondeggia al vento allegro, mentre sul foglio non può cullarsi come sopra i fiori, non può posarsi su una rosa per poi passare all’altra, rimane lì come infilzato. Sarà! Intanto la Günderode è 315 pagine; e l’opera complessiva di Bettina è di svariate migliaia. Bettina comunque vuole essere inutile. La sua vita è negli attimi e quegli attimi lei li trasforma in osservazione e gioia, non in azione o in riflessione astratta. La stessa lode profetica di Karoline, sopra riportata, finisce con l’avere un che di ambiguo: protesta contro la subordinazione femminile, ma anche scarsa comprensione per questa gioia che si dissipa e si disperde per la buona ragione che si realizza in ogni attimo, non attraverso una progressione nel tempo. E in generale la Karoline di questo libro, che pure porta il suo nome, non risulta la personalità più interessante. Un po’ saputella, trova che le critiche sociali dell’amica manchino di sostanza e di realismo; le ammannisce massime di vita in cui della sua stessa vita non si rintraccia un bel nulla. Anzi dice chiaro e tondo che la vitalità di Bettina le dà noia, addirittura la «scuote dalle fondamenta». L’amicizia di Bettina per lei non sembra però aver risentito di questo; e poiché le due personalità appaiono complementarsi e poiché infine Karoline non è seconda nel descrivere ritratti e situazioni il lettore è disposto – credo – a tollerare certe incomprensioni. Ma esse c’erano. Si toccano con mani nella reazione che Karoline ebbe nei confronti di Clemens Brentano, al quale muove delle critiche bensì più decise, 333 ma comunque basate sulla stessa matrice delle sue più dolci critiche a Bettina: Sì – gli scrive – io capisco l’attimo in cui mi ha scritto; ma non sono mai riuscita a più che a capire un po’ i suoi attimi. Della loro connessione e del loro tono di base non so proprio niente. Gli dice di non riconoscere neanche le proprie parole quando le riferisce lui; e quanto alle sue proprie, dice di non averle mai capite ma ciò nonostante le fanno venire da ridere. E via di questo passo, finché lo ammonisce a non essere cupo e isolato ma a vivere sempre giovane, sognante e fresco. Strana situazione, strane parole. Vengono da una persona infelice, di cui si vede male come potesse profferirle con autorità. La vitalità e il tumulto romantico sembrano addirsi poco a Karoline. Già con Bettina ha più una parte reattiva. È Bettina a parlare di sé e a porre problemi. Karoline fa spesso la parte di chi crede di risolverli. Con Brentano non le riuscì (qualche accenno a tentarla infatti c’è) e allora restò solo – se non proprio lo spavento (ma forse era proprio questo) – almeno il disagio. Karoline è stata maestra nel cacciarsi in situazioni senza uscita. Figlia povera di una nobile famiglia decaduta, costretta a vivere di beneficenza in una specie di convento, Karoline ebbe infine bisogno dello sbalestrato Friedrich Creuzer, frastornato dalla propria ascesa sociale e soprattutto dal modo in cui era avvenuta; a lui poteva sentirsi superiore e dargli del vigliacco con più motivazioni che a Bettina. E poi soffrire di tutto, caricando le sofferenze su questa situazione, fino a togliersi la vita. Karoline non si apre mai con Bettina, la quale non saprà della storia con Creuzer se non dopo la morte dell’amica. Ecco una cosa che Schlegel non aveva previsto: un’amicizia femminile in cui le cose più intime restano non dette. È vero che neanche Bettina dice niente di molto intimo, ma ciò ha in lei tutto un altro fondamento: Bettina osserva e accetta. In una persona petulante ciò equivarrebbe a un eterno, inconcludente chiacchiericcio; ma Bettina era Bettina e tutto questo il lei diventa gioia del particolare. Lei non parla dell’intimo perché l’ha tutto capovolto ed estroflesso. Qui è la sua gioia, qui è la sua intimità. Bettina parla e parla. Simile in ciò al fratello, Bettina aveva realizzato una vita romantica: essere in un ambiente significava essere tra sé. La comunità è solo la comunità degli eletti. Clemens ne dà uno «scombinato» esempio nel Godwi, in cui tutti parlano a tutti e di tutto, compreso dell’autore del libro preso in giro dai personaggi, e infine nelle poesie finali, che attraverso parodie e imitazioni chiamano in campo tanti amici e conoscenti. Essere tra sé è il modo – limitato ma concreto, concreto ma limitato – di realizzare la comunità. Con l’acciottolio da chiacchiericcio che questa limitata comunità di amici eletti e liberi comporta come sottofondo. Nel 1844 viene pubblicato un ulteriore libro di Bettina: Clemens Brentanos Frühlingskranz aus Jugendbriefen ihm geflochten, wie er selbst schriftlich verlangte (Corona primaverile di Clemens Brentano, intrecciata con le sue lettere giovanili, secon334 do le sue prescrizioni scritte). Clemens era morto nel 1842 e negli ultimi anni si era segnalato per la bigotteria e per l’abiura del giovanile romanticismo. È proprio questo che invece sua sorella Bettina vuol far rivivere, con tutta la sua radicalità. Il tentativo era più che attuale; questa pubblicazione era stata infatti preceduta da Dies Buch gehört dem König (Questo libro è del re, 1843), vertente sui problemi politici più importanti del momento: la libertà d’espressione, la povertà; nello stesso periodo Bettina progetta Das Armenbuch (Il libro dei poveri), che non verrà portato a termine, ma per il quale Bettina raccoglie ampio materiale, sia sulla povertà nelle città sia sulle condizioni dei minatori slesiani, con la cui rivolta la sua attività di pubblicista venne messa in connessione. Il colloquio col re di Prussia venne proseguito in Gespräche mit Dämonen (Dialoghi coi demoni, 1852). Non si trattava certo di piaggerie, ma di rivendicazioni. Bettina non si nascondeva: anche quando pubblicava sotto anonimato, tutti sapevano che lei era l’autrice. E così quando sotto pseudonimo pubblicò nel 1849 un appello An die aufgelöste Preussische National-Versammlung (Alla disciolta assemblea nazional prussiana). Non per nulla Joseph von Eichendorff, romantico a tempo pieno ma dell’ala conservatrice, era imbarazzato da questa Bettina che seguitava imperterrita a professare, ad attualizzare, a praticare le idee del primo radicalismo romantico, mentre gli ancora viventi padri fondatori avevano preso tutt’altre vie. VI, 2. Due riflessioni sul romanticismo lontano In altre parti di questo libro è stata rilevata l’importanza di concettualizzare i testi trattati ed è stato rilevato come questo atteggiamento sia un’eredità romantica. Finora abbiamo anche effettivamente proceduto in tal modo; la novità di quanto sta per seguire è che abbiamo l’occasione di due verifiche imbarazzanti. I due autori che qui ci interessano sono Friedrich Hebbel (1813-1863) e Richard Wagner (1813-1883). Tra i due non corse buon sangue; Wagner stroncò i Nibelunghi di Hebbel con argomenti ai quali c’è poco da opporre; eppure questi due autori, diversi in tutto, vanno qui accomunati per questo loro conservare un’eredità essenziale del romanticismo: in una Dichtung deve esserci una stratificazione di significati, che procedono da quanto è più evidente ai sensi fino alla concettualizzazione più astratta. Ciò è consapevole in Wagner; da una parte egli definì «romantische Oper» le seguenti sue creazioni: Der fliegende Holländer (L’olandese volante, 1841), Tannhäuser oder Der Sängerkrieg auf der Wartburg (Tannhäuser ovvero Il cimento dei cantanti sulla Wartburg, 1843-44) e Lohengrin (1846-48); dall’altra teorizzò in scritti appositi lo stratificarsi di significati. Qui però comincia già l’imbarazzo: per quella stratificazione è necessaria la musica nel suo rapporto con un testo verbale; inoltre tale teorizzazione avvenne quan335 do Wagner aveva cessato di definire «romantiche» le sue opere. Questo secondo aspetto, per la verità, è meno imbarazzante del primo: “romantico” Wagner non lo era stato nel senso pieno di un Weber o di uno Schumann o di uno Schubert ma nel senso che aveva ereditato e proseguito quel che del romanticismo gli pareva essenziale. (Tuttavia un conoscitore che va preso molto sul serio, Thomas Mann, scrisse che il concetto di romanticismo è pur sempre quello che meglio riesce a unificare l’essenza di Wagner.) L’altro aspetto può essere aggirato nel seguente modo: le sue teorie sono retrospettivamente applicabili, almeno per la gran parte, al Tannhäuser (un po’ meno alle altre due opere). E soprattutto vale il seguente argomento: i libretti di Wagner (egli stesso ne era l’autore) non danno solo un primo significato, per esempio non si racconta soltanto la vicenda dei Nibelunghi, ma sempre anche un secondo e più importante, per esempio si narra la storia dell’umanità nel suo sciogliersi dallo stato di natura, nel passare al mondo dell’economia capitalistica e infine nel crollo del mondo sia mitico sia della storia inumana per avviarsi a una soluzione eventualmente aperta all’avvento dell’umanità vera. Di ben diversa natura è l’imbarazzo nei confronti di Friedrich Hebbel. Questi volle tanto fortemente l’esistenza di un secondo e più importante significato al di là di quello letterale da spiegarcelo lui stesso di volta in volta. L’imbarazzo nasce in primo luogo dal fatto che Hebbel oggi sopravvive per l’unico lavoro drammatico, Maria Magdalene, in cui, con sua sorpresa, ciò non gli riuscì (e che lo fa collocare fra gli autori del realismo); in secondo luogo dalla penosa circostanza che fallisce (fino al ridicolo) lì dove crede di conseguire i meriti maggiori. Oggi non gliene disconosciamo davvero, ma li vediamo da tutt’altra parte, lì dove lui non li vedeva: nell’aver ricondotto alle dimensioni del dramma borghese, alla sua psicologia e ai confini dei suoi orizzonti, quel che ancora si aggirava come ingombrante materiale mitico e tragico. Non è un merito da poco (e va in tutt’altra direzione rispetto a Wagner), anzi diciamo pure che si tratta di una svolta epocale. Ma Hebbel, che pure ne fu autore, pare non abbia proprio avuto occhi per vederlo. La dilacerazione che c’è nelle opere di cui ora parleremo rischia di renderle puro oggetto di interesse storico; quando tale interesse risulta giustificato, la conseguenza è una sentenza fatale perché l’opera viene condannata a un’artificiale vita accademica, a essere oggetto di indagini che vanno benissimo solo perché non fanno male a nessuno e perché sono gli altri a farle. Ma se facciamo lo sforzo di capire Hebbel oltre Hebbel arriviamo a capire un filone culturale che è importante per la nostra cultura odierna. Bisognerà anche avere il coraggio di lasciarsi alle spalle un paesaggio di rovine invece di dare un colpo al cerchio e uno alla botte. Cominciamo con la sua prima tragedia, Judith (Giuditta, 1841). Dobbiamo essere contenti della sua esistenza perché permise a Nestroy la sua geniale parodia; questo è il suo merito maggiore. La vicenda si ispira a un libro che non è riconosciuto fra quelli canonici del Vecchio Testamento, ma che ha avuto grande fortuna fra pittori e letterati. Giuditta è una ve336 dova ebrea abitante a Betulia; quando la città è assediata dalle truppe del re babilonese Nabucodonosor comandate da Oloferne, lei si reca nella tenda di quest’ultimo, lo seduce e quando è addormentato gli taglia la testa, salvando così la sua città. Hebbel sostiene che tutto ciò è volgare e che la sua Giuditta deve essere una vedova vergine; infatti durante la prima notte di nozze ha reso impotente il marito con una sola occhiata. La stessa cosa non le succederà con Oloferne, «primo e ultimo uomo della terra», che se la porta a letto senza tanti complimenti. Giuditta lo uccide per ragioni tutte sue personali, che cerca di esporre a più riprese in un colloquio con la vecchia ancella. A costei dice di essersi voluta vendicare del disprezzo e anzi addirittura della violenza fattale da Oloferne, alla cui testa mozza chiede se ora finalmente la rispetta. L’ancella non ne è granché convinta e ribatte che se non fosse venuta nel fulgore della sua bellezza a sedurre Oloferne adesso non avrebbe di che vendicarsi. In realtà è Oloferne, «l’unico uomo del mondo», a sedurre Giuditta, la quale prega Dio di proteggerla dall’adorare quell’uomo che deve detestare, perché lui è proprio un uomo e deve ucciderlo se non vuol cadergli avanti in ginocchio. Insomma questa Giuditta o rende impotenti o ammazza dopo l’atto. È che non sopporta di essere donna; detesta le donne che tanto più godono quanto più vengono umiliate. Ecco la sua filosofia per esteso: Per una fanciulla non v’è istante più grande che quando cessa d’esserlo, e ogni bollore del sangue, che prima combatteva, ogni sospiro, che soffocava, accresce il valore del sacrificio che ha da compiere in quell’istante. Ella dà tutto quel che ha: è un desiderio troppo superbo, s’ella vuole ispirare con tutto quello che ha estasi e beatitudine? [Immagina] te stessa nella più profonda umiliazione, il momento in cui sei spremuta corpo e anima per supplire al vino abusato e aiutare a compiere un’ubriacatura volgare con una ancor più volgare; quando la brama dormente ruba tanto fuoco dalle tue proprie labbra quanto le occorre per uccidere ciò che hai di più sacro; quando i tuoi sensi stessi, come schiavi ubriachi che non conoscono più il loro padrone, si levano contro di te; quando cominci a credere tutta la tua vita di prima, il tuo pensare e il tuo sentire, un gioco semplice e superbo di sogni, e la tua vergogna il tuo vero essere! Non per questo Giuditta è senza desideri; al contrario, essa entra in scena raccontando un sogno che non è difficile interpretare come sogno erotico; e dichiara esplicitamente che ruolo della donna è far figli, cosa per la quale (aggiunge tanto per chiarire) è indispensabile un uomo. Alla fine chiede di essere ammazzata se per caso è rimasta incinta di Oloferne. Nel frattempo è tutta contenta di essere rimasta vergine; nelle sue annotazioni di diario, Hebbel sviluppa in proposito la seguente teoria: un’anima vergine può sacrificare tutto tranne se stessa, perché colla sua purezza cade il fondamento della sua forza, ella non può avere gli interessi della sua in- 337 nocenza, una volta che l’ha perduta. Perciò io ho fatto di Giuditta un che di mezzo fra la donna e la vergine, e così ho motivato la sua azione. Tutto questo appare molto tirato per i capelli e Nestroy ebbe buon gioco nella sua parodia; il compito più facile l’ebbe con Oloferne, perché gli bastò trasportare di peso le sue battute, che erano quasi la parodia di se stesse; ma anche per Giuditta non ebbe molte difficoltà. Retrospettivamente, poi, la tragedia dovrebbe far da sostegno alla seguente definizione generale: Il dramma rappresenta il processo di vita in sé [...] nel senso che ci pone davanti agli occhi l’individuo sciolto dal nesso originario e contrapposto all’intero, di cui resta pur sempre una parte, nonostante la sua incomprensibile libertà. (Ein Wort über das Drama – Due parole sul dramma, 1843) In parole semplici: Giuditta taglia la testa a Oloferne perché gli uomini non ci riescono; però in questo modo si oppone sia alla sua natura di donna sia al processo naturale generale. In questa Judith difficilmente si troverà qualcosa da salvare, né il linguaggio, né l’azione nelle sue motivazioni e nella sua ideologia. C’è invece una novità: le passioni, violente, oscure e spaventevoli, vengono quasi chiamate per nome, il tabù della sessualità viene quasi violato, la psicologia della contrapposizione fra i sessi viene indagata: da una parte la donna nella sua dipendenza dall’uomo, che di conseguenza tanto più odia quanto più ne viene attratta, dall’altra l’uomo che approfitta del suo ruolo di personaggio indispensabile e all’apparenza inattaccabile. Non è chi non veda che questa psicologia è storicamente e socialmente condizionata. Sul piano artistico la Judith è fallita e irrecuperabile, la giustificazione teorica che ne dà Hebbel, con quella sua esaltazione della vergine e quel discorso parahegeliano sul rapporto fra universale e particolare, è altrettanto condizionata e quindi più oggetto di studio che strumento di spiegazione; il merito invece comincia a farsi strada altrove, nell’illuminare aspetti essenziali della psicologia borghese. Entro tale ambiente l’individualità si profila, quindi si sviluppa l’attrazione personale, mentre la dipendenza economica e sociale si conserva, e quindi si sviluppano gli atteggiamenti di difesa. Poiché resta prigioniero della sua magniloquenza, Hebbel non arriva a essere uno Ibsen o uno Strindberg; però nei momenti in cui è lucido, vede profondo. Il ridicolo è però sempre in agguato. Eccolo all’opera in Gyges und sein Ring (Gige e il suo anello, 1853-54), una tragedia ricavata dall’episodio di Gige e Candaule narrato da Erodoto, contaminato da Hebbel con la leggenda dell’anello che rende invisibili, tramandata da Platone. Il re di Lidia Candaule è convinto che sua moglie Rodope sia la donna più bella del mondo e decide di convincerne l’amico Gige mostrandogliela nuda; risultato: Gige se ne innamora, Rodope si offende e ordina a Gige di ucciderle prima il marito, poi di sposarla ed ereditare il regno. Tutto ciò avviene, ma siccome è molto offesa, Rodope si 338 uccide immediatamente dopo le nozze. Siccome Candaule è un re riformatore cui le riforme non riescono tanto bene, meno che mai quella sulla moglie, la morale della vicenda sembra essere quella di non esagerare con le riforme (ovvero: se porti tua moglie a un’ammucchiata non puoi pretendere che non vada con un altro). Anche qui, la giustificazione di Hebbel è duplice: da una parte essa è rivolta all’antico e condanna il turbamento dell’armonia del mondo provocato dall’oltraggio ai costumi e alle tradizioni, dall’altra è rivolta al moderno, alla psicologia di Candaule come vanitoso, dedito alla vanteria e quindi disposto a trattare anche la moglie come oggetto di cui vantarsi. Hebbel tiene molto al suo significato “metafisico” (in Ein Wort über das Drama lo chiama proprio così) ma non meno a quello borghese. Abbiamo parlato di due tragedie, entrambe in cinque atti, la prima in prosa, la seconda in pentapodie giambiche. In entrambe sono stretti i legami con la tradizione: la prima conserva addirittura l’ancella nel ruolo di confidente, entrambe restano vicine alle unità di tempo e di spazio, anche se non le conservano proprio alla lettera. Hebbel ha prestato tanta attenzione alla psicologia moderna che viene da desiderare di avere a disposizione un altro Hebbel per psicologizzare il primo il quale, uscito dalla miseria nera e dalla nessuna considerazione, fece tutto quel che poté di nobile e di ignobile per non ritornarvi; inoltre, avendo conosciuto anche per esperienza diretta una grande gamma di comportamenti, non era cieco nei confronti della realtà ma era contrario a sommovimenti che potessero ripercuotersi negativamente per lui. Durante il marzo 1848 Hebbel si trovava a Vienna dove lui, cittadino dello Holstein, si era stabilito fin dalla fine del 1845. All’inizio simpatizzò per la rivoluzione, ma alla lunga fece il seguente ragionamento: c’era da scegliere fra da una parte il caos che lì per lì avrebbe sacrificato tutta la civiltà in attesa di un nuovo mondo e dall’altra la permanenza delle forze antiche, anche col pericolo che si sarebbe tornati ad abusarne. Poiché sacrificare la cultura gli parve eccessivo, Hebbel si attenne al secondo partito; ecco di conseguenza il rimprovero a Candaule che vuol far troppe riforme, compresa quella della moglie. Tra il 1855 e il 1860 Hebbel scrisse una trilogia, Die Nibelungen (I Nibelunghi), ricavata dal medievale Nibelungenlied. L’esercizio di drammatizzare il poema l’aveva cominciato Fouqué con Der Held des Nordens (L’eroe del nord, 1808-10) e con gran successo l’aveva proseguito l’autore di successo Ernst Raupach (Der Nibelungenhort - Il tesoro dei Nibelunghi -, 1834) e poi altri ancora. Hebbel si attiene all’originale con fedeltà ampia ma non assoluta. Il suo tentativo è quello di mostrare il cammino dell’umanità dal mito all’età eroica, al cristianesimo. È un cammino drammatico, attraverso il quale però si costruiscono mondi sempre nuovi, e sempre attraverso le colpe dei singoli, i quali di conseguenza giustamente periscono. Questo dunque il doppio livello: da una parte drammatizzare la vicenda dei Nibelunghi, dall’altra illustrare una filosofia della storia. Non ci soffermeremo troppo su questi aspetti (il secondo è stato molto dibattuto fra i 339 critici ed effettivamente offre ampio campo a disquisizioni interpretative); il punto più interessante è infatti un altro ancora: i Nibelunghi diventano un dramma borghese, e ciò attraverso quella non assoluta fedeltà all’originale cui si è accennato. Anche qui, il ridicolo è in agguato e il contrasto fra la materia epica e il nuovo ambiente psicologico in cui viene collocata è lì ad aprirgli le porte. Quando si dice a Sigfrido che non basta aver conquistato la mano di Brunilde per Gunther ma che ora deve aprire a quest’ultimo ben altre porte altrimenti la valchiria resta indomita, la risposta di costui è che veramente quella è anche la sua prima notte di nozze con la propria moglie, e «che cosa dire a Crimilde?» Lo rincuorano a non avere paura della moglie: la mamma deve ancora spiegarle tutto e ci metterà chissà quanto tempo, tutto il tempo che gli serve per sistemare Crimilde. Accanto a questo buffo eroe che ha paura della moglie, c’è l’eroe distratto. Nel poema medievale, Sigfrido regalava alla moglie il cinto e l’anello tolti in lotta a Brunilde; stupenda psicologia, ma per altri ambienti. Nella trilogia di Hebbel, Sigfrido smarrisce certi oggetti pericolosi; la moglie li crede un regalo per sé e solo un po’ per volta capisce che le cose stanno altrimenti; insomma, il marito voleva tener nascosta la scappatella, ma figuriamoci se la moglie non se ne accorge! Sia Brunilde sia Crimilde sono vendicative; e Hebbel segue con finezza le diverse motivazioni psicologiche di entrambe; l’odio di Brunilde per Sigfrido ha le sue radici nell’amore, quello di Crimilde per Brunilde nella lotta per il prestigio, in cui tutti i mezzi sono buoni. Brunilde ha perso una battaglia storica e attraverso la sua sconfitta resta sancita (per sempre, dice lei) la sottomissione della donna all’uomo; ma allora attraverso il marito vuole veder abbassati tutti i rivali, a partire dal troppo importante Sigfrido, e ancor più le loro mogli. Forse ancor meglio riuscito è lo scavo psicologico in Crimilde: resasi conto di averla fatta grossa nel suo litigio con Brunilde, nel suo timore accumula errori su errori, sempre tormentata dall’insicurezza, senza mai sapere in chi avere effettivamente fiducia e in chi no, rendendosi infine conto che Sigfrido non si intende di donne, altrimenti non avrebbe confidato quel po’ po’ di segreto concernente le nozze di Brunilde a una donna, «tremante creatura che si tradisce per paura». Questi sono singoli punti, anche se importanti. Ma oltre tutto ciò ci sono i toni di certi discorsi, l’allungarsi o il contrarsi di certe situazioni a fare di questi Nibelunghi un dramma borghese. Abbiamo insomma una situazione paradossale: un significato letterale viene raddoppiato da un significato “metafisico” consapevolmente organizzato, ma quello che oggi ci parla di più è un terzo significato, borghese e presumibilmente non consapevole fino in fondo. Che fine ha fatto l’eredità romantica? L’imbarazzo in cui ci mette Hebbel non è piccolo; e forse un qualche imbarazzo del genere ha contribuito a farlo classificare tra i realisti (cause più consistenti le vedremo altrove). Wagner criticò senza mezzi termini l’assenza di drammaticità nei Nibelunghi di Hebbel. Non che il suo Ring des Nibelungen (Anello del Nibelungo) non pre340 senti problemi, anche di ordine drammaturgico; ma questi sono davvero il meno (e poiché sono funzionali alla tecnica compositiva basata sul Leitmotiv, quei problemi diventano meriti da un punto di vista musicale). Quel che è più rilevante è che Wagner scrisse i libretti della sua tetralogia in un arco di tempo (dal 1848 al 1852) durante il quale le sue concezioni subirono un’evoluzione; e le varie fasi che ha attraversato hanno tutte lasciato le loro tracce nel testo finale. Che esso debba mediare più significati, è pacifico; quali, lo è molto meno. Basterà dire che Wagner musicò sì un solo finale, ma ne pubblicò ben tre, sorvolando sul fatto che sono assai diversi l’uno dall’altro. Forzando un po’ le cose e trascurando troppi particolari, della tetralogia (suddivisa in un prologo, Das Rheingold - L’oro del Reno -, e tre giornate, Die Walküre, Sigfried, Götterdämmerung - La Valchiria, Sigfried, Il crepuscolo degli dèi) si può comunque dire che essa è un’interpretazione della vicenda umana. Esiste un mondo governato da patti e leggi; essi hanno valore formale, non necessariamente legato a un valore sostanziale, e servono ad arginare il caos. Ciò è troppo poco; pertanto in un mondo siffatto può irrompere la passione per il potere legato alla sopraffazione economica, mentre i due sono legati alla messa al bando dell’amore fra gli uomini. In concreto, tale dominio si configura come dominio del capitalista che schiavizza i proletari dopo aver sottratto alla pura natura i suoi metalli più preziosi. Dunque il formalismo delle leggi convive con l’attacco alla natura e con l’inumanità del lavoro. Per metter fine a tale maledizione, che cumula sfruttamento, morte e distruzione, occorre l’uomo libero, al difuori da ogni legge; ma costui non può fare a meno di usare la violenza contro la violenza. L’uomo ideale non pare pertanto concepibile dall’interno del presente: anch’egli è coinvolto nella colpa e, per essere al di fuori di ogni legge, deve essere pura istintualità e immediatezza; così almeno l’ha disegnato Wagner. Il vecchio mondo deve perire, tutto deve tornare alla natura; ma che cosa c’è dopo? Il finale musicato da Wagner non lo dice; pare che lo dica la sua musica, perché nel gioco dei Leitmotive emerge quello interpretabile così: solo l’amore libera. Questa tesi coincide con uno dei finali pubblicati ma non musicati. Il terzo finale invece esorta a volere la propria morte attraverso la sofferenza dell’amore: così chi è colpevole scompare, lasciando via libera alla futura generazione umana, destinata a vivere nella realizzazione dell’amore. Tutto ciò viene detto da Wagner attraverso una rielaborazione del mito, basata più sull’Edda che sul Nibelungenlied, con aggiunta di elementi tratti dalla fiaba dei Grimm su colui che andò per il mondo a imparare la paura, e ispirandosi, nella varie fasi, alle filosofie di Bakunin, di Feuerbach e infine di Schopenhauer, senza attenersi alla lettera a nessuno di loro. Elementi romantici particolari sono altrettanto facili da trovare quanto quelli generali; l’idea di un eroe al di fuori delle leggi è romantica così come quella di una salvezza attraverso il ritorno al primordiale. E se vogliamo allargare lo sguardo oltre il Ring, ecco il culto della notte in Tristan und Isolde (Tristano e Isot341 ta, 1857), romantico per eccellenza. Ma tutto questo romanticismo non può far classificare Wagner (come pure Hebbel) tra i romantici fuori stagione. Si tratta invece di un’eredità romantica consapevolmente accettata, sviluppata e fusa con altri motivi, di disparata provenienza (a quelle dette c’è da aggiungere sia per Hebbel sia per Wagner la nuova concezione dei rapporti fra i sessi propria della cultura jungdeutsch e una riflessione su Hegel, questa soprattutto per Hebbel). Tutto ciò complica i problemi della classificazione, ammesso che siano importanti; per Hebbel sono stati risolti cacciandolo a forza dentro gli schemi del realismo, per Wagner non ci si è nemmeno provato. In altro luogo torneremo su Wagner e precisamente sul suo Parsifal. Qui è da aggiungere ancora qualcosa su Hebbel e sulla sua tenace ricerca, che lo portò a interessantissimi risultati anche nella lirica. Non si farà fatica a capire come la seguente sua poesia sia stata lodata da Hofmannsthal: Sie sehn sich nicht wieder Von dunkelnden Wogen Hinuntergezogen, Zwei schimmernde Schwäne, sie schiffen daher, Die Winde, sie schwellen Allmählich die Wellen, Die Nebel, sie senken sich finster und schwer. Die Schwäne, sie meiden Einander und leiden, Nun tun sie es nicht mehr, sie können die Glut Nicht länger verschließen, Sie wollen genießen, Verhüllt von den Nebeln, gewiegt von der Flut. Sie schmeicheln, sie kosen, Sie trozten dem Tosen Der Wellen, die zweie in eines verschränkt, Wie die sich auch bäumen, Sie glühen und träumen In Liebe und Wonne zum Sterben versenkt. Nach innigem Gatten Ein süßen Ermatten, Da trennt sie die Woge, bevor sie’s gedacht. Laßt ruhn das Gefieder! Ihr seht euch nicht wieder, Der Tag ist vorüber, es dämmert die Nacht. 342 Non si rivedono Tratti in basso / da scure onde / due cigni scintillanti si allontanano, / i venti gonfiano / a poco a poco le onde, / le nebbie calano cupe e grevi. // I cigni si evitano l’un l’altro e soffrono, / ora non lo fanno più, non possono / più a lungo richiudere l’ardore, / vogliono godere, / avvolti dalle nebbie, cullati dall’onda. // Si accarezzano e vezzeggiano, / resistono al mugghiare / delle onde, uniti in una sola cosa, / e per quanto le onde crescano, / loro ardono e sognano / sprofondati in amore e delizia da morire. // Dopo intimo accoppiamento / un dolce languore / e l’onda li separa di sorpresa. / Lasciate riposare le piume. / Non vi rivedrete più, / il giorno è passato, incombe la notte. Non tutto lo Hebbel lirico è a quest’altezza, anzi per il resto non lo è mai; ci sono numerose poesie ben riuscite, che hanno per oggetto sia la comunicazione umana sia descrizioni naturali, e tuttavia la sua Gedankenlyrik rimane sempre al di qua della grande poesia. Ciononostante vanno riconosciuti a Hebbel almeno due meriti: di aver intensificato un patrimonio di immagini andando su una via che solo il simbolismo avrebbe percorso lucidamente; e di aver tenuto viva la tradizione della forma rigorosa mostrando che essa era capace di rinnovarsi nei contenuti. Excursus: Dall’A alla Z. La letteratura tedesca finisce nel 1956. Questo è l’anno in cui muoiono (a un mese di distanza) sia Brecht sia Benn; Thomas Mann li aveva preceduti di un anno. Quel che segue è letteratura scritta in tedesco, e per brevità verrà pur sempre chiamata letteratura tedesca; ma la letteratura veramente tedesca è finita nel 1956. Stabilita la data di morte, resta da stabilirne quella di nascita. La risposta istintiva sarebbe: 1794, l’annus mirabilis di Jena. Ma questa è una storia scritta da un non germanista per non germanisti, cioè una storia che si racconta fra coloro i quali, volentes nolentes, sono stati sotto il segno di M.me de Stäel e del modo in cui lei ha inventato il romanticismo europeo; perciò dobbiamo retrodatare quella nascita al 1774, l’anno del Werther. Tale costrizione ci fa perfino comodo, permettendoci di includere opere attente alla problematica politica e sociale, con cui quelle (propriamente) romantiche entrano in tensione. Così il punto di vista esterno costituisce un privilegio, consentendo di constatare una morte sfuggita ai tedeschi e una nascita che conta più per noi che per loro. Una nascita e una morte, un avvio e una conclusione. Quel che vi si trova in mezzo è ciò che ha motivato il presente studio: la sintesi di pensiero e immagine, la letteratura come conoscenza privilegiata, spesso e volentieri più avanzata della filosofia, della sociologia e di altre forme di conoscenza. Tale profilo riceve la sua impronta dal romanticismo. Ora nessun esercizio retorico-dialettico può fare di Benn e Brecht dei romantici, almeno non nel senso tedesco (quanto al senso di M.me de Stäel, mi astengo dal discuterlo); e tuttavia essi hanno affidato 343 alla poesia una funzione conoscitiva quale a nessun’altra forma accessibile all’uomo. Nel caso di Benn, per di più, c’è anche da rilevare che il nichilismo, per lui così importante, fu una scoperta romantica; e l’attenzione a motivi del nichilismo è verificabile in gran parte della produzione lirica di Brecht, in tutte le sue fasi. L’enigma dell’esistenza umana viene scandagliato in versi tanto da Brecht quanto da Benn; le conclusioni concettuali e pratiche cui essi vogliono giungere (qui come nel caso del nichilismo) sono diverse, lo scandaglio invece è affidato allo stesso strumento (la poesia) e la pretesa di successo nell’operazione conoscitiva è immensa in entrambi. I quali sono gli ultimi rappresentanti di tutto ciò. Ben lontani dal romanticismo, certo; e ciò a differenza di quel Thomas Mann, per il quale la vicinanza è tanto evidente che ci possiamo permettere di tacerne. Inspiegabili senza il clima berlinese degli anni Venti. Ma inspiegabili senza anche quell’impulso lontano. Indubbiamente ci sono stati validi continuatori, si siano chiamati (o si chiamino tuttora) Paul Celan, Thomas Bernhard, Hans Magnus Enzensberger e forse altri, il cui valore è fuori discussione. Magari si vorrebbero più valori e più alti, ma questo è secondario. Il fatto è che si tratta di tentativi isolati, da considerare sulla base di uno sfondo culturale che appare come piovuto da un altro pianeta. E poi si tratta di continuatori. Il ripensamento che la cultura tedesca ha fatto di se stessa l’ha indotta a cercare nel buio, oppure l’ha condotta a un voluto riaggancio alla tradizione, che sa un po’ troppo di spericolata citazione. Non è stato un sommovimento tipo Weimar, che ha fatto ripensare tutto per essere ancora di più presso di sé. 1774-1956; 182 anni. Ci sono stati grandi risultati letterari prima e qualcuno anche dopo. Ma la letteratura tedesca vera e propria è stata contenuta in quel lasso di tempo, in meno di due secoli. Nemmeno è detto che la sua fine sia un male. Anche ammesso che di scandagliatori dell’animo nei suoi aspetti più riposti come Stifter o di sezionatori della realtà apparente come Heine (e via proseguendo) non ne avremo più, è pur possibile che col romanticismo tramontino le sue ambiguità, in primo luogo il romanticismo politico. Quando poi però ci si chiede che cosa mettere al suo posto, essendo tramontate anche le ideologie che volevano soppiantarlo, magari si proporrà Musil, che è tutt'intero in quella letteratura, e non solo cronologicamente. Però Musil è stato scoperto (e aspetta di essere scoperto, se mai ce lo faranno leggere per intero) dopo che quella letteratura è finita. Così è anche possibile che essa non sia finita ma solo latente. E che siamo finiti noi nel paradosso. 344 Excursus: Dalla Z alla A. Una lettura privata cui ho sottomesso il precedente excursus mi ha attirato critiche tali da indurmi a riscriverlo dalle fondamenta. Ecco il nuovo testo: Nel presente capitolo si è parlato del permanere di una presenza romantica ancora ben addentro l’Ottocento. Credo legittimo chiedersi fin a quando si possa rinvenire una forte presenza del genere, anche al di là dei limiti cronologici proposti. Indubbiamente la Heimatliteratur (che deve ancora occuparci) può rivendicare nel romanticismo determinate sue ascendenze; e così successivamente la Blut-und-Boden-Literatur. Asteniamoci da ogni considerazione di valore e di merito. Ricordiamoci che, da tutt’altro versante ideologico, Thomas Mann si richiamò costantemente e fortemente al romanticismo. Ma anche Gottfried Benn (con il quale percorriamo una via ancora diversa) può essere spiegato nella sua attenzione al nichilismo (a momenti trasmutatasi in vera ossessione) indubbiamente risalendo a Nietzsche, senza però dimenticare che furono i romantici i primi ad averne la percezione. Il suo antipode Brecht era poi assai meno antipode di quanto sembri. È vero che i loro percorsi di vita vanno contrapposti, ma altrettanto vanno messe in luce importanti radici comuni; per esempio anche Brecht sapeva bene che cos’è il nichilismo. Ma a parte questo, l’impegno sociale di Brecht si inserisce in una specifica, lunga tradizione tedesca, così come Benn è tutto dentro la tradizione. Ora Thomas Mann muore nel 1955, Benn e Brecht nel 1956 (a un mese di distanza l’uno dall’altro). Quel che è seguito ha avuto espressioni di valore e momenti di interesse che nessuno può mettere seriamente in dubbio. Viene però da chiedersi se il 1956 non vada considerato come un anno di forte cesura e non debba costituire un punto fermo in una periodizzazione della letteratura tedesca nel Novecento. Poiché ci siamo già spinti troppo fuori dei nostri confini cronologici, non svilupperemo questa proposta. Ma forse non è stato inutile esporla qui. Questo, dunque, è il nuovo testo, con tanto bello sfumatino messo su tutto. Forse, esposta in maniera così seria e contegnosa, la proposta otterrebbe qualche attimo di non ostile attenzione, salvo poi non farne niente. Ma, così formulata, essa non è veramente la mia proposta e perciò lascio quest’ultimo excursus solo a testimonianza del modo in cui il presente volume non è stato scritto. 345 346 VII Realismo 347 348 Nel luglio 1848 Gustav Freytag (1816-1895) e Julian Schmidt (1818-1886) assunsero la redazione della rivista “Die Grenzboten”, che si pubblicava a Lipsia, facendone l’organo di un programma realista. Alla rivista e al programma aderirono vari membri di un gruppo già esistente a Dresda dal 1846, la Montagsgesellschaft (ne avevano fatto parte man mano i musicisti Wagner e Schumann, l’architetto Gottfried Semper, gli scrittori Auerbach e Gutzkow, pittori e scultori); vi si aggiunse Otto Ludwig; Gutzkow fu invece tra gli avversari dei “Grenzboten”, polemizzandovi dalla sua rivista “Unterhaltungen am häuslichen Herde” (1852-62). Il programma del gruppo dei realisti operanti dalla Sassonia venne riassunto da Julian Schmidt nei seguenti termini: l’epoca del realismo (cioè quella sua contemporanea) è contrassegnata dall’imporsi delle scienze empiriche, dal decadere della cultura individualistica a vantaggio di concetti universali e vincolanti del bello, del grande e del buono; dalla sconfitta dell’idea astratta del cosmopolitismo e dall’affermarsi delle idee concrete di stato e di nazione; dal generalizzato intento di conservare tutto ciò e di volgere l’attenzione alla storia patria; dal superamento del frammentismo nell’arte. Queste idee non restarono confinate in Sassonia ma trovarono ascoltatori attenti anche altrove, per esempio in Prussia, dove Fontane (allora non ancora scrittore di romanzi in proprio) si ispirò a idee del genere nella sua attività di recensore. Inoltre esse coincidevano col processo di revisione della filosofia hegeliana, portate avanti soprattutto dagli storici, alcuni dei quali (Mommsen, Treitschke) collaborarono ai “Grenzboten”; tale revisione era in realtà un compromesso poiché conservava come validi gli stessi concetti “sostanziali” dello hegelismo, quali eticità e nazionalità, considerandoli come obiettivamente presenti nella storia a dimostrazione che nella storia è immanente la ragione. Resta anche la fede, tutta hegeliana, che la società sia organizzata organicamente in libere comunità etiche; questa fede era stata un pilastro del liberalismo del Vormärz ma seguita ad agire nel periodo successivo (per esempio nello storico Gustav Droysen (1808-1884), che è pur uno di coloro che parteciparono alla revisione di Hegel, come pure in Rudolf Haym (1821-1901), che diede un contributo decisivo al successo del realismo). Ciò permette di capire come mai i realisti tennero fermo all’idea di un’opera d’arte organica (organica quanto si credeva fosse la realtà stessa), e di spiegarsi l’affinità col realismo dimostrata dagli estetici di Tübingen, con in testa Friedrich Theodor Vischer (1807-1887), ampiamente debitore allo hegelismo e teorico del realismo nelle arti figurative già dal 1843. Un altro importante gruppo di realisti, forse l’unico sfuggito all’egemonia dei “Grenzboten”, è localizzabile a Monaco; il critico più importante fu Moritz Carrière (1817-1895), l’unico narratore a essere sfuggito a un oblio completo fu Paul Heyse (1830-1914). I circoli monacensi erano fortemente impregnati di pensiero religioso e fondavano il realismo in un concetto apriori di Dio. Più esattamente, al monoteismo e al panteismo (cioè a concezioni secondo le quali 349 Dio è trascendente e immanente, centro del mondo ma anche sua periferia) opponevano quel che chiamavano panenteismo (derivavano il termine da Franz Baader, 1765-1841): Dio è immanente nel mondo e il mondo è immanente in Dio; non tutto è Dio ma non c’è niente che non venga da lui. L’attività artistica è un’interpretazione del mondo che deve ricondurne la duplicità all’unità originaria; a tal fine la realtà ha bisogno di essere idealizzata e il mezzo principale è l’umorismo, che unisce il desiderio del sublime con il dolore per ciò che ne è decaduto. Con queste loro riflessioni i monacensi rimanevano più vicini al classicismo (e anche al romanticismo) che non i sassoni, ma non avevano bisogno di postulare una realtà organica, la cui organicità l’opera d’arte dovesse mimare. I “Grenzboten” svilupparono un’ampia polemica contro il romanticismo, da loro inteso come principio dualistico, nemico della vita e della realtà. D’altra parte essi ridefiniscono i concetti romantici di Gefühl e Gemüt, intendendoli come conseguiti attraverso la socializzazione e l’interiorizzazione dei concetti borghesi di ordine e di valore; col che essi sviluppano le idee tardoromantiche di Jakob Grimm. La creazione letteraria deve cogliere la realtà nei suoi aspetti positivi e superare le contraddizioni; i realisti dei “Grenzboten” vogliono un’arte sana, che raffiguri positivamente la vita quotidiana ai suoi livelli medi; questa è la ragione per cui il “malato” Hebbel non trovò grazia agli occhi dei “Grenzboten” e di quant’altri ne condividevano l’ideologia. Come si può ricavare da quanto detto finora, il realismo dei critici citati non fu tanto una teoria quanto un programma, riassumibile in pochissimi punti: richiesta di usare uno stile medio, scegliere personaggi medi, descrivere la realtà armonicamente e idealizzandola, al fine di superarne le contraddizioni; centrale è inoltre l’individuo e non una qualche anonima forza storica; e ci vuole l’individuo medio, che permetta di illustrare il principio d’ordine della vita borghese; il criterio di composizione deve tener conto di tutto ciò, preferendo un’architettura equilibrata: come modello viene considerato il romanzo Soll und Haben (Dare e avere, 1855) di Gustav Freytag, come antitesi il già ricordato Die Ritter vom Geiste (1850-52) di Gutzkow. La povertà teorica non era un incidente: dopo il ’48 le grandi idee erano entrate in discredito insieme con il fallimento della rivoluzione; si dichiarava di non volerne più sapere, mentre sembrava essere sufficiente un’attesa fiduciosa nei confronti dell’economia e un adattamento alla situazione politica di fatto, spingendosi al massimo fino a un moderato liberalismo. Le grandi idee che seguitavano a vivere (come si è visto sopra) erano diventate cose quotidiane, valori ovvi e poco riflessi. Si potrebbe scrivere una storia del realismo dal punto di vista dei suoi propugnatori; ciò sarebbe concepibile e fattibile ma poco interessante: ne verrebbero infatti condannati quegli autori che oggi ci interessano di più e che vengono bensì considerati realisti dai moderni storici e teorici della letteratura, non però dai contemporanei le cui idee siamo venuti riassumendo. Il fatto è che il termine 350 realismo sfuggì di mano ai suoi propugnatori e venne utilizzato anche lì dove costoro non avrebbero voluto. Oggi vengono considerati realisti autori come Auerbach e Keller; invece Julian Schmidt biasimava la tecnica simbolica (dunque non realistica) del Grüner Heinrich (prima versione) e trovava non sana l’arte di Auerbach, pur dovendo più tardi constatare che tutta la discussione condotta su Auerbach aveva fatto di lui un realista agli occhi del pubblico. Inoltre Auerbach stesso si considerava un realista e ciò fu evidentemente decisivo; dati poi i legami tra Auerbach e Keller, anche costui venne associato ai realisti. Qualcosa di analogo deve essere successo per Fontane: prese le parti di Freytag e in generale si ispirò come critico alle idee di questi e di Schmidt, per cui venne considerato un realista; dati i rapporti che si stabilirono tra Fontane stesso, Storm, Keller, Heyse e Raabe, il concetto si estese a poco a poco. Esso arrivò a inglobare anche Hebbel quando si ritenne di constatare che un dramma, ai suoi tempi molto apprezzato, scritto da uno dei maggiori teorici del realismo, cioè Der Erbförster (Il guardiaboschi, 1850) di Otto Ludwig, dipendeva dalla Maria Magdalene (1844) di Friedrich Hebbel, ipotesi contro cui Ludwig protestò sempre vivacemente. Per render conto di questo allargatissimo concetto di realismo non vanno più bene i desiderata dei propugnatori quali sono stati fin qui considerati. Quel che si può dire per unificare il realismo è assai poco e riguarda la tematica, l’ambientazione (fondamentalmente borghese, ma non sempre), l’univocità del significato (in questo senso niente più legami con le precedenti fasi letterarie), la grande importanza data alla composizione “armonica” (in questo senso Der grüne Heinrich nella sua prima versione è quanto di più lontano possa esserci dal realismo). Si può aggiungere la predilezione per la forme narrative (rispetto alla lirica e al dramma) e poco altro. Insomma quel che si dice realismo lo si può definire attraverso una recensione dei suoi temi e dei suoi modi piuttosto che con teorie. È anche quel che faremo. Prima però sarà il caso di insistere sull’importanza della composizione, cui si è già accennato. Lo faremo esemplificando attraverso Theodor Fontane (1819-1898), un autore cronologicamente eccentrico: la sua attività di romanziere comincia infatti nel 1878, mentre la fase principale della propugnazione realistica si era svolta dal 1848 al 1866 (con posizioni differenziate già dal 1861) e gli storici moderni fanno sostanzialmente concludere il realismo col 1870. Ma degli autori che tratteremo qui Fontane è personalità che spicca in modo netto su tutti e quindi è giusto prenderlo non a modello medio ma a esemplificazione dei raggiungimenti maggiori. Sarà sufficiente accennare, in questa sede, al rapporto tra inizio e fine del romanzo più popolare di Fontane, Effi Briest (1895): tutto ciò che è elencato all’inizio viene rielencato alla fine, quando si è verificato un cambiamento unico ed essenziale: al posto della meridiana dell’inizio c’è la tomba della protagonista, il cui tempo è finito. È un romanzo costruito con straordinaria simmetria: l’azione si dipana in tre parti di pari lunghezza, precedute da una parte introdut351 tiva e una conclusiva, lunghe ciascuna la metà di una parte principale; e all’interno del romanzo ci sono episodi che anticipano altri episodi o altrimenti li commentano per affinità oppure per opposizione. Altrettanto raffinata la composizione dell’ultimo romanzo di Fontane, Der Stechlin (Lo Stechlin, 189798; a seconda delle età che attraversa, il lettore preferirà fra tutti questo oppure il precedente), che va qui ricordato anche perché in esso l’arte della conversazione e lo scintillare dell’umorismo raggiungono i vertici. Si potrebbe continuare per un pezzo, passando in rassegna un romanzo dopo l’altro. Ma forse è il caso di richiamare l’attenzione piuttosto su un altro aspetto: gran parte dell’opera di Fontane può essere considerata come una serie di variazioni intorno a un tema, con a volta a volta coincidenze e diversità di conclusioni, così da dare un ampio spaccato sociale. Mathilde Möhring (1891) e Frau Jenny Treibel (La signora Jenny Treibel, 1893) sono unificabili per essere due esempi opposti di scalata sociale; Mathilde Möhring così come l’Adultera (1882) trovano un importante punto d’incontro nel modo in cui entrambe le protagoniste raggiungono la loro autonomia (diventando cioè insegnanti); nell’Adultera è un quadro a far da filo conduttore alla vicenda così come in Unwiederbringlich (Senza ritorno, 1892) è una poesia; in Unwiederbringlich così come in Cécile (1887) le protagoniste si uccidono, in Cécile come in Effi Briest sono dei duelli a costituire il punto di svolta in matrimoni infelici. E si potrebbe continuare. Forse dunque non è solo il singolo romanzo a essere costruito in maniera pensata fin nei più piccoli particolari ma tutto un gruppo di romanzi presenta rimandi reciproci tali da indurre a recepirli come una grande costruzione globale. Aggiungiamo, in questa sede preliminare all’analisi precisa dei temi, che alla resa dei conti vedremo come quel che con denominazione globale viene chiamato realismo si configura con grandi diversità concrete dall’uno all’altro autore e che chiamare realisti tanto Freytag quanto Fontane (che pure lodò tanto il precedente) non può nascondere la diversità delle prospettive (a parte l’abissale differenza nella qualità). C’è però una complicazione di cui occorre tener conto. Gran parte dei realisti produsse anche durante i Gründerjahre: così si chiamano gli anni 1871 e seguenti, quando nella Germania appena unificata circolò una grandissima liquidità (enormemente accresciuta dalle somme che pagò come riparazione la Francia sconfitta nella guerra franco-prussiana), e si scatenò una vera frenesia nel fondare (da qui il nome Gründerjahre) società per azioni: ben 1018 nuove società per azioni vennero fondate tra il 1870 e il 1873, fino al crollo della borsa di Vienna nell’ottobre del 1873, che si ripercosse in Germania, alle promulgazioni di dazi protettivi nel 1878 e alla riforma della legislazione attinente la società per azioni nel 1884. Lo sviluppo economico, tumultuoso e anzi con aspetti drammatici, che era già cominciato negli anni Cinquanta, si accentuò. La differenza fra il complesso degli stati tedeschi visti intorno al 1850 e la Germania unificata, considerata intorno al 1880, si può riassumere così: all’inizio c’era un panorama 352 fondamentalmente agricolo con zone di forte industrializzazione, alla fine c’è un paese fra i più industrializzati del mondo con zone agricole; il rapporto si era capovolto. Sul piano politico e sociale sia il tipo di sviluppo sia il modo dell’unificazione hanno delle conseguenze; anch’esse si possono riassumere in poche parole: c’è un compromesso fra le classi; la nobiltà latifondista e militare, che ha condotto l’unificazione, estende i suoi interessi all’industria (cioè fonda industrie o entra nei consigli di amministrazioni di banche e simili), la borghesia estende i suoi interessi all’agricoltura (compra possedimenti agricoli posseduti dalla nobiltà accettandone le implicazioni politiche e sociali, prima fra tutte il maggiorasco, che è ovviamente l’opposto dello spirito liberale) e all’esercito (i borghesi vengono ammessi tra gli ufficiali). I matrimoni misti e l’innalzamento di borghesi ai ranghi nobiliari fanno il resto. Sul piano culturale ci sono da segnalare delle novità: il diffondersi della filosofia di Schopenhauer (già “scoperta” intorno al 1850) e un pessimismo ampiamente volgarizzato, nelle più varie combinazioni; il successo del darwinismo, anch’esso piegato a volgarizzazioni; ma soprattutto il moltiplicarsi delle dichiarazioni, dei programmi, dei manifesti culturali, insomma di tendenze varie, che si influenzano anche a vicenda. Tuttavia non mi è apparso conveniente dedicare un capitolo extra alla letteratura dei Gründerjahre, quanto piuttosto segnalare di volta in volta le varianti che cadranno sotto la nostra osservazione. VII, 1. Il lavoro Il romanzo-modello del realismo, il già ricordato Soll und Haben di Gustav Freytag, reca come motto una frase di Julian Schmidt, secondo cui è compito del romanzo andare a cercare il popolo tedesco lì dove si mostra al meglio, e cioè nel lavoro. L’evoluzione economica e sociale della Germania rendeva comprensibile un programma del genere. Nel 1806 era stata abolita in Prussia la servitù della gleba; il risultato era stato molteplice: un numero esiguo di agricoltori era entrato in possesso delle terre su cui lavorava da sempre, dovendone però cedere la parte migliore ai possidenti in riscatto dei diritti feudali; gli altri contadini restavano nel possedimento principale come braccianti oppure emigravano nelle città, dove in seguito avrebbero cercato lavoro nelle nascenti industrie, oppure emigravano in America in numero sempre più grande. I terreni degli agricoltori tendevano a spezzettarsi per ragioni di eredità mentre i grandi possidenti potevano permettersi di lasciare incolte le terre che non rendevano e di razionalizzare il resto della produzione. Il risultato globale era: grande proprietà razionalizzata, agricoltori in gran parte intenti a rendere fertili terre fin allora incolte 353 (e quindi a insediarsi soprattutto all’est, nel pezzo di Polonia appartenente alla Prussia), formarsi di un proletariato urbano. Con ciò il feudalesimo non era superato; molti agricoltori non riuscirono a riscattarsi economicamente e i grandi possidenti rientrarono in possesso di gran parte delle fattorie più piccole; solo la rivoluzione del 1848 riuscirà a ottenere lo sgravio dei diritti feudali senza indennizzo. L’industrializzazione cominciò lentamente e tuttavia negli anni Quaranta l’artigianato subì durissimi colpi dall’importazione di prodotti industriali dall’estero. Il processo di ammodernamento era però cominciato ed era destinato al successo. Nel 1828 cominciano ad aversi dei limitati accordi doganali, coronati nel 1834 dall’unione doganale di tutta la Germania, premessa per un commercio e un’industrializzazione tendenti ad abbracciare tutto il territorio. Verso la fine degli anni Quaranta comincia un’ondata di fondazioni di istituti di credito e l’industrializzazione spicca il volo praticamente in tutti i settori: nella chimica, nell’ottica, nei prodotti ferrosi, nella costruzione di macchinari e via dicendo. Un mercato poco controllato e leggi carenti avranno per conseguenza crisi periodiche, tra cui particolarmente rilevante quella del 1857. Questo è lo sfondo. Ma non è questo che ritroviamo nella letteratura tedesca. Non è il lavoro, che ci viene fatto vedere; non si parla (tranne pochissime eccezioni) di professioni che cambiano e si rinnovano, di tecnologie, investimenti, finanziamenti, leggi, materie prime, prodotti derivati, organizzazione del lavoro, scioperi e via dicendo. Il lavoro non sembra fatto per conseguire profitto ma per realizzare la virtù; e quindi noi lettori siamo chiamati ad assistere a una lotta fra il vizio e la virtù con l’occasione di una qualche situazione di lavoro, ma del lavoro stesso non ci viene detto nulla o quasi nulla. Che le cose dovessero andare così era addirittura un proposito espresso nella prefazione a quello che viene di solito considerato il maggior dramma del realismo, anche se scritto da uno che i realisti dei “Grenzboten” non consideravano affatto dei loro e scritto per di più quando di realismo non si parlava ancora: Maria Magdalene (1844) di Friedrich Hebbel, definito dall’autore stesso un «bürgerliches Trauerspiel». Compito del dramma, scrive Hebbel, è di mostrare lo stato del mondo e dell’uomo nel suo rapporto con l’idea e, nel caso specifico, col centro etico da cui tutto dipende; il dramma può assolvere tale compito, e quindi essere possibile, quando nello stato detto avviene un cambiamento radicale. Lo stato attuale delle cose, prosegue Hebbel, è sì di cambiamento, non però nel senso che si vogliano istituzioni nuove e inaudite, ma solo un migliore fondamento per quelle già presenti, delle quali si vuole che si basino sull’eticità e che siano necessarie. Il dramma di oggi deve mostrare come gli elementi scatenati dalla storia recente e finora ancora dispersi producano la nuova forma di umanità. Per far questo occorre scendere nelle brutture, dal momento che un generale rivolgimento può apparire solo nelle fratture personali. Compito di una tragedia borghese è mostrare come individui incapaci di dialettica si contrappongano all’interno di una cerchia molto ristretta e chiusa, da cui non sono ca354 paci di uscire, mentre la loro vita risulta legata a prospettive unilaterali. La tragedia nasce da questa chiusura e da questi limiti. Il lettore non può avere dubbi: la tragedia di Hebbel riguarda problemi etici e culturali. Il protagonista maschile è un falegname (Meister Anton), ma tutto quel che veniamo a sapere del suo lavoro è che ci ha rimesso mille talleri per salvare il suo vecchio maestro, che a lui orfano, poverissimo e analfabeta ha insegnato il mestiere senza pretendere nulla in cambio. Veniamo a sapere molto del suo carattere, per esempio che è ostinato ma che sa anche essere spiritoso, molto della sua cultura, per esempio che è geloso della sua indipendenza e riservatezza, che hai suoi bravi pregiudizi di casta (offende mortalmente e gratuitamente l’usciere del tribunale), ma soprattutto che tiene talmente tanto al rispetto e alla considerazione altrui da non sopportare che i suoi figli gli rechino «vergogna». Il suo concetto di giustizia lo induce a comportamenti che causano la sciagura altrui e l’isolamento proprio; il suo concetto d’ordine è tirannia: a casa sua, dice il figlio Karl, oltre ai soliti dieci comandamenti ce ne sono altri dieci. Il cappello va attaccato al terzo chiodo, non al quarto! Alle nove e mezza si deve aver sonno! Prima di San martino non è permesso aver freddo e dopo San Martino non è permesso sudare! Tutto questo va di pari passo con: Amerai il Signore Dio tuo! [...] Oggi è giovedì, hanno mangiato minestra con carne di vitello. Se fosse inverno ci sarebbero stati cavoli, bianchi a carnevale, verdi di quaresima! È un ordine tanto immutabile come che giovedì viene solo dopo che è passato mercoledì e non può dire a venerdì “vacci tu per me perché mi fanno male i piedi”! Alla fine, quando la moglie sarà morta per un colpo, la figlia si sarà suicidata e il figlio, rilasciato dopo un arresto dovuto alla vendetta dell’usciere di tribunale, starà per imbarcarsi, mastro Anton dirà di non capire più il mondo. Tutto si svolge sul piano etico: agli argomenti del falegname Anton vengono perciò opposti controargomenti anch’essi etici. La tragedia non ci chiarisce perché la morale di mastro Anton sia divenuta inadeguata; il lettore e lo spettatore sanno della sua virtù troppo rigida e del vizio dei suoi nemici; le due forze insieme stritolano la sua famiglia; che quell’irrigidimento sia l’eventuale difesa di un artigiano che l’evoluzione confina al margine dello sviluppo o addirittura ne lo scaccia, è cosa che non possiamo ricavare dall’interno e può essere solo una supposizione esterna, basata sulla conoscenza del contesto. Nelle prese di posizione dei realisti per così dire professionali, qualcosa del genere verrà pertinentemente rimproverato a Hebbel, ma con l’intento di scacciare il conflitto sociale dalla scena. Otto Ludwig trattò in un dramma che andò in scena nel 1850, Der Erbförster (Il guardiaboschi), una realtà economica ancora più arretrata; si tratta di un guardiacaccia che, tutto preso da quella che chiama la giustizia del cuore e pieno di disprezzo per la giustizia della carta bollata, non sa nemmeno distinguere tan355 to bene fra il mio e il tuo e protesta così contro il suo licenziamento: L’aver impiegato tutto il mio nella foresta non conta? E le piante che ho piantate tutte io stesso? Eh? Le mie piante, che il vento adesso non deve, non deve proprio stroncarmi? Forte di queste sue ragioni, seguita a fare il guardiacaccia contro il volere del padrone, con i guai che ne conseguono. I quali vengono occasionati da un bracconiere, indottrinato da un altro bracconiere dal nome significativo: Frei (libero), presentato da Ludwig come un delinquente rivoluzionario ateo, socialista e istigatore al più vile omicidio. Vale la pena leggere la sintesi della sua dottrina secondo il pensiero di Ludwig: La faranno finita coi tribunali, ve lo dico io. Fra dieci anni a nessuno verrà più in mente di domandare che razza di roba era una guardia. Adesso c’è la libertà e le leggi han fatto la loro parte. Ognuno può fare quel che vuole, nessuna legge, nessun tribunale, vi dico, niente prigione, niente manette. Se il Signor Iddio avesse fatte le leggi apposta per i signori, le avrebbe mandate al mondo col lor stemma sulla pelle. Una bagattella per un uomo come il Signor Iddio. Lo sa la gente adesso, che quelli che stanno a patire nelle galere son gente da levarcisi il cappello davanti e che i signori sono dei ladri, per quanto onesti siano. E quelli che lavorano troppo sono ladri, perché per colpa loro la brava gente, a cui non garba lavorare, è povera. Questo potete leggerlo sui giornali, stampato. [...] Quello che una volta chiamavano fedeltà e onestà, eran storielle che ci davano a bere le nonne. E chi mantiene la sua parola è un mariuolo, e con un uomo di questo genere non mi fiderei ad andare più in là dell’uscio. Il popolo è onesto, perché è il popolo. Dovreste sentir parlare quei signori là; c’era anche un professore che deve saperle, le cose. I risvolti proletari della rivoluzione del 1848 dovevano aver messo a Ludwig proprio una gran paura. Il suo guardiaboschi tiene fermo al suo concetto di giustizia e deplora la morale dei contadini, i quali lasciano correre se non ci rimettono del loro. Il contadino cui viene fatto questo rimprovero ribatte che la sua morale non è affatto stupida: Se aveste seguito la nostra morale, avreste fatto il vostro dovere e non un filo di più e avreste impiegato il vostro per voi e per i vostri figli e non per la tenuta di un altro. [...] Non vi pagano per essere il padrone ma il servitore. Qualche anno dopo Ludwig torna ad affrontare il tema della virtù lavorativa in un breve romanzo, Zwischen Himmel und Erde (Fra cielo e terra, 1856); stavolta l’ambiente è quello degli artigiani e precisamente dei copritetti, ma il tema non ha niente a che fare con l’economia: ancora una volta, il tema è la virtù, per di più in una vicenda discretamente incredibile. Der Erbförster aveva almeno un ec356 cellente primo atto. Soll und Haben (1855) vuol dare la grande sintesi; del resto è anche molto lungo. Ma, anche qui, di lavoro ne vediamo piuttosto poco. Anton Wohlfahrt è scritturale presso una ditta che commercia in spezie. Lui è lo specchio di tutte le virtù mentre il suo ex compagno di scuola Veitel Itzig è la sentina di tutti i vizi e per di più è anche ebreo; l’antisemitismo di Freytag, costante nella sua opera, trova il più ampio spazio in questo romanzo: tutti gli ebrei che vi compaiono sono canaglie, viscidi, ladri, ricattatori e se è necessario anche assassini. L’odio di Freytag doveva nascere da un ben radicato complesso, misto di inferiorità e di impotenza; un segnale è dato dal fatto che le sole pagine artisticamente riuscite del romanzo riguardano proprio Itzig: la scena dell’omicidio (parte VI, cap. 4) regge il confronto con i migliori romanzi di avventura scritti in Francia nel corso dell’Ottocento. Excursus: L’antisemitismo nella letteratura tedesca Il lettore avrà notato che questo libro è scritto da una posizione molto simpatetica nei confronti della cultura tedesca. Non per questo è il caso di chiudere gli occhi sui lati negativi. Negli ultimi decenni pare venga considerato di cattivo gusto parlare dell’antisemitismo: non lo si fa per i romantici, non lo si fa per Wagner, meno che mai per Nietzsche da quando è stato promosso a campione di democrazia. Si preferisce dire che gli ebrei parteciparono come volontari alle guerre antinapoleoniche (1813-15) e morirono a centinaia; il che è vero, solo che per i sopravvissuti il risultato fu un regresso nella legislazione che all’epoca napoleonica li aveva affrancati ed equiparati agli altri; e l’antisemitismo restò vigoroso. Ciò detto, e ribadito che a chiudere sempre gli occhi si diventa ciechi, c’è da chiarire anche che non è il caso di impostare il discorso distinguendo gli antisemiti (quasi tutti) dai favorevoli all’emancipazione e buttando i primi alle ortiche. Per quanto imbarazzante sia, dall’antisemitismo teorico, cioè da una nascita inter faeces et urinam, è nato per depurazione il moderno pensiero ecologico, di certo attraverso molte mediazioni, ma comunque cominciando da una critica al concetto di natura creata, così come viene posto dall’Antico Testamento, dunque da una critica al Dio giudaico e a quanto di questo era passato nel cristianesimo. Più in là avremo occasione di parlare del Parsifal e del suo antisemitismo; con l’occasione vedremo che la perfida ebrea Kundry vuol sedurre il puro Parsifal attraverso l’evocazione della madre: Wagner ha formulato il concetto della Mutterbindung ed è stato il primo a farlo. Tra lui e Freud non mi risulta che ne abbiano parlato altri; così c’è da chiedersi se dietro la prima teorizzazione del complesso d’Edipo non ci sia proprio l’antisemita Wagner. Che dunque non si stia a fare il processo a ogni negativa manifestazione del passato è un conto; che si chiudano gli occhi è tutto un altro. 357 Le forze che il romanzo mette in campo sono le seguenti: la borghesia, la nobiltà, i polacchi, gli ebrei e i rivoluzionari. I polacchi vengono trattati male almeno quanto gli ebrei; peggio, poi, se sono polacchi rivoluzionari. C’è un passo nel quale importanti aspetti dell’ideologia di Freytag vengono sintetizzati; sarà bene riportarlo, nonostante la sua lunghezza. Lo scritturale Antonio sta viaggiando con il suo principale attraverso una zona polacca per recuperare delle merci; siamo nel bel mezzo di una sommossa (nomi e date non vengono fatti; forse Freytag accenna ai moti che ci furono a Cracovia nel 1846); tra i due si svolge il seguente colloquio: [il principale]accennò ai due calci [di pistola] che spuntavano fraternamente dalla borsa dello sportello della carrozza, e disse ad Antonio: «Non credo che riuscirete a riprendere le nostre merci con quegli arnesi. Sono cariche?» Antonio annuì, e con l’ultimo avanzo dei suoi sentimenti bellicosi, rispose: «Sono pistole a canna rigata». «Ah sì?», replicò il commerciante gravemente; ordinò al cocchiere di fermare, trasse le armi dalla custodia e le scaricò in aria. «È meglio che ci limitiamo alle armi che siamo abituati ad usare», osservò bonariamente, restituendo le pistole ad Antonio, «siamo uomini pacifici, e vogliamo solamente riavere le nostre merci. Se non ci riusciremo col persuadere gli altri del nostro buon diritto, ogni altro mezzo sarà inutile. Questa rivolta consumerà molte cartucce per niente, tutte spese che non fruttano nulla e che mandano in rovina il paese e il popolo. Non c’è razza che meno di quella slava abbia la capacità di farsi strada e di acquistarsi col suo denaro civiltà e cultura. Tutto quel che sono riusciti ad accumulare facendo i lazzaroni o valendosi della forza bruta, lo scialacquano in divertimenti in grande stile. Da noi solo alcune classi privilegiate si dedicano a quest’occupazione, e la nazione le può sostenere; ma là, in Polonia, i privilegiati pretendono di rappresentare il popolo. Come se i nobili e una masnada di servi della gleba bastassero a formare uno Stato! Non ne hanno più diritto di questi passeri sugli alberi! L’unico guaio è che nei loro infelici esperimenti ci va di mezzo anche il nostro denaro». «Non hanno borghesia», confermò Antonio con convinzione. «Il che significa che non hanno civiltà. È stupefacente come siano incapaci di creare questa classe che rappresenta la civiltà ed il progresso e che può elevare a Stato una torma di contadini dispersi». «Però nella città insorta c’è ad esempio Corrado Günther, e in Galizia ci sono le case dei tre Hildebrand». «Ottime persone, ma tutti immigrati, e il sentimento borghese non mette radici, e raramente passa nella generazione successiva. Quelle che là chiamano città, non sono che ombre delle nostre, e i loro abitanti non possiedono quasi quelle qualità che da noi fanno della borghesia lavoratrice la prima classe nello Stato». «La prima?». «Sì, caro Wohlfahrt: nei tempi antichissimi tutti erano liberi o presso a poco uguali; poi venne la semibarbarie dei liberi privilegiati e dei lavoratori asserviti, ma solo dall’epoca delle nostre città esistono al mondo degli Stati civili, e si è riconosciuto che soltanto il lavoro rende la vita dei popoli grande, sicura e duratura». 358 Qui non soltanto si hanno le lodi della borghesia e la condanna sia della nobiltà sia della plebe rivoluzionaria, ma anche un abbozzo di teoria coloniale: la razza superiore deve colonizzare quella inferiore, come del resto viene detto esplicitamente in altro luogo: Quale che sia l’affare che ha condotto me, il singolo, fin qui, adesso ci sono e ci resto come uno dei conquistatori che hanno preso possesso di questa terra in nome del libero lavoro e della civiltà umana, togliendola a una razza più debole. C’è un’antica lotta fra noi e gli slavi. E con orgoglio sentiamo che dalla nostra parte c’è la civiltà, la voglia di lavorare, il credito. [...] Qui, la mano sull’aratro, sarai un soldato tedesco che spinge più avanti la pietra di confine della nostra lingua e dei nostri costumi. [...] Era riuscito a far sì che una nuova vita verdeggiasse su una landa incolta; si era adoperato anche lui per fondare una nuova colonia pel suo popolo. (VI, 1) Per un po’ lo scritturale è sedotto da un incantesimo (come lo chiama lui; da un paio di begli occhi, come dice il suo principale) a mettersi al servizio di una famiglia nobile finita in cattive acque e con grandi proprietà in Polonia; guarisce poi da quest’incantesimo, dà a se stesso il merito di aver contribuito alla colonizzazione e torna in Germania, dove corona la sua carriera sposando la sorella del principale, di cui diventa socio. La nobiltà non trova grazia agli occhi di Freytag se non (par di capire) perché si impegni nella colonizzazione, anche manu militari. Ecco invece come viene da lui giustificato l’intreccio fra etica coloniale e profitto dal punto di vista della borghesia: da una parte Anton dice a un suo compagno: «Non eravamo venuti qui per il nostro utile ma per creare qualche cosa»; dall’altra, passati i tempi dei sacrifici, occorre guadagnarci, «perché l’uomo commette un’ingiustizia se impegna la parte migliore di se stesso, la sua forza, in un lavoro che non lo premia nella misura che la sua attività meriterebbe.» Insomma: non si lavora per il profitto ma per soddisfare la pretesa di eticità e vedersela ricompensata. Il romanzo ebbe grande successo di pubblico e suscitò un ampio dibattito. Sia Gutzkow sia Fontane rimproverarono all’autore le sbavature stilistiche e in primo luogo l’umorismo fuori posto e le lungaggini; entrambi gli rimproverarono l’antisemitismo. Tuttavia quella di Gutzkow è una stroncatura proveniente da un’opposizione di fronti mentre invece Fontane difende Freytag proprio da Gutzkow e fa al primo molte concessioni. Gutzkow era certamente nel campo avverso; tre anni prima (1852) Julian Schmidt gli aveva stroncato Die Ritter vom Geiste, sostenendo che la pretesa panoramica globale, che Gutzkow voleva dare dei problemi del tempo in tutti i campi del pensiero e della vita, contraddiceva il concetto di arte e sarebbe stata possibile solo declassando i fenomeni concreti a genericità senza volto e vanificando le idee in individualità non riuscite. Gu- 359 tzkow sostiene che in Soll und Haben non c’è un’idea e che il realismo dell’autore fa dissolvere tutto in faccende private. In particolare gli contesta il modo di trattare il 1848, quando il suo eroe fronteggia i rivoluzionari polacchi (nella parte V del romanzo). Gutzkow (e così Fontane) non è amico dei polacchi ma (così pare di capire) a Freytag rimprovera il razzismo nei loro confronti, poiché nel romanzo non si trova nessun personaggio (polacco, sembra di dover completare) che «nei confronti della storia polacca provi quel che in quei giorni provavano tutti per la storia tedesca, dal principe fin giù al contadino e all’operaio»; insomma pare sarebbe stato doveroso, agli occhi di Gutzkow, dare un grande affresco nazionale anche della storia polacca. In generale chi conservava attaccamento agli ideali dello Junges Deutschland fu molto severo con Freytag: sia Gutzkow sia Hermann Marggraff (1809-1864) gli contestarono di non mostrare proprio nulla di lavoro autentico; Marggraff rilevò che se Freytag era davvero convinto delle universali capacità di pace, di fratellanza e di solidarietà insite nel commercio (come pure dichiara qua e là nel romanzo) avrebbe dovuto dimostrarlo descrivendo le situazioni corrispondenti, invece di limitarsi a qualche enunciato episodico. Robert Prutz (1816-1872) gli rimproverò, senza tanti complimenti, di aver fallito nel mostrare come il commercio rivoluziona il mondo; gli contestò inoltre l’umorismo fuori luogo e il modo indegno in cui aveva trattato ebrei e polacchi. Prutz aveva qualche titolo in più per dire la sua, sia perché era un notevole critico, sia perché si era provato anche lui in un romanzo sociale, di cui diremo qualcosa più in là. Fontane invece fece grandi lodi al romanzo, pur sollevando non lievi obiezioni. Ne loda l’avvicinarsi ai modelli Dickens, Thackeray e Cooper; ne loda la costruzione organica. Trova che esso abbia fuso tre drammi; anzi due tragedie (quella del nobile in terra di Polonia e quella dell’ebreo Itzig) con un dramma (quello di Wohlfahrt). Le tragedie: il nobile vuol conservare a ogni costo, l’ebreo vuole ottenere a ogni costo, dunque sono entrambi colpevoli ed entrambi vengono puniti (già da questo modo di riassumere si intuisce la posizione che Fontane prenderà sull’antisemitismo di Freytag; e in generale occorrerà tornare più in là su questa recensione); nella vicenda scenica di Wohlfahrt ci accompagna sempre la sensazione che la sua fortuna e il suo buon naturale avranno la meglio. Fontane è poi più che d’accordo con Freytag nel suo prender partito per la Prussia contro la Polonia, non invece nei suoi attacchi alla nobiltà e agli ebrei. Gli ebrei, dice Fontane, ormai ci sono e sono importanti; o li sterminiamo oppure cerchiamo «quel graduale amalgama che è la tacita benedizione della tolleranza e della libertà»; Fontane ritiene che sia dovere dello scrittore favorire questa seconda via, mentre meno di un secolo dopo Hitler percorrerà la prima. Invece Fontane difende Soll und Haben da Gutzkow, attribuendo al romanzo senz’altro un’idea, la celebrazione della borghesia, e concordando con Freytag quando questi vede nel commercio una possibilità che è andata perduta a uno sguardo settoriale e specializzato: il commerciante può essere 360 una potenza spirituale che ha conservato per tradizione lo sguardo sull’universale e il proprio rapporto con esso. Il commerciante non può più fare politica, non può intervenire e decidere direttamente, però ha lo sguardo chiaro per una certa quantità di diritti e di doveri [...] il cui coscienzioso rispetto diventa suo compito e suo orgoglio. Di totale consenso, come c’era da aspettarsi, fu l’intervento del sodale di Freytag, Julian Schmidt; secondo questi Freytag aveva conseguentemente espresso il seguente principio, ponendolo a base della borghesia: col credito non si deve mai oltrepassare il capitale, cioè nelle azioni e nelle sensazioni non si devono ricercare finezza e grandezza prima di aver rafforzato la base dell’eticità. Questa potrebbe essere, per usare un termine di Gutzkow e di Fontane, l’idea del romanzo. Con l’occasione Schmidt stende il definitivo atto di morte dello Junges Deutschland, reo di aver mescolato analisi e sentimento; «questo miscuglio è stato fatale: non appena il sentimento si distoglie dagli interessi particolari annaspando verso idee universali, decade in vuota retorica.» A metter fine allo Junges Deutschland è stato il 1848, che con i suoi scossoni ha distrutto tante belle illusioni. Schmidt aveva la sua parte di ragione quando sosteneva che la rivoluzione aveva portato dal chiuso all’aperto la legge, la costituzione, la moralità, che non potevano esaurirsi in formule generiche ma dovevano esplicitarsi in idee specifiche; ne concludeva che «questo allargarsi e approfondirsi delle idee etiche nel particolare della vita reale è il necessario, unico fondamento di una vera poesia.» Aveva anche le sue ragioni Fontane quando diceva che il pensiero fondamentale di ogni opera letteraria che faccia epoca deve essere ed è sempre stato semplice. Ma con queste interessanti posizioni di principio finivano col proteggere non la semplicità ma le semplificazioni di Freytag. Perché aveva tutte le ragioni Gutzkow quando lo tacciava di dilettantismo economico (così come Schmidt tacciava di dilettantismo culturale gli Jungdeutsche). Forse chi ha detto in materia le cose più giuste è stato un romanziere che non ha lasciato molta traccia di sé, Robert Gisecke (1827-1890); costui scrisse in una recensione che attribuire ogni commercio disonesto agli ebrei (oppure localizzarlo in America, che è a lungo il terreno d’azione di uno dei personaggi più importanti) è troppo comodo: quel che è all’ordine del giorno sono i quotidiani morsi di coscienza che toccano a ogni commerciante onesto, ebreo o cristiano che sia, a causa della speculazione e della concorrenza sempre più incalzanti. Era come dire che Freytag non aveva capito niente del capitalismo o, per dire le cose fino in fondo, che aveva fatto opera di occultamento, di apologia e di propaganda, e non degli aspetti migliori. Marggraff aggiunse l’ultimo tocco dicendo che nel romanzo non c’era traccia di industria, cioè (aggiungeremo noi) di quel che stava cambiando la Germania. Insomma fu una discussione di grande interesse. Alcune risposte meritano di essere segnalate più a lungo. 361 Adolf Zeising (1810-1876) scrisse con Hausse und Baisse. Ein Roman aus der Gegenwart (Rialzo e ribasso. Romanzo contemporaneo, 1864, 3 voll.) una risposta a Soll und Haben dal punto di vista del realismo monacense. Sul piano artistico la replica resta incommensurabilmente indietro rispetto al prototipo ed ebbe una sola edizione; ma sul piano dell’informazione ha i suoi motivi d’interesse perché chiarisce (anche in maniera banale) le differenze tra i realismi di Monaco e di Berlino. Il titolo si spiega così: solo la pura parvenza soggiace al rialzo e al ribasso della mutevole sorte [mentre invece] l’essere è incessante movimento e cambiamento ma allo stesso tempo conservazione e dispiegamento sempre più perfetti di se stessi. Questa tesi è esplicitamente appoggiata a una lunga, involontariamente comica spiegazione di un passo letteralmente citato dall’Enciclopedia di Hegel. Detto terra terra, la monarchia costituzionale e liberale propugnata da Zeising deve avere un fondamento morale o, con la terminologia del romanzo, deve essere idealismo. Alla fine si trova un matrimonio (anche nel senso letterale) di idealismo e materialismo, che dà luogo a un’industria bella ed ecologica, ricca di riforme sociali e sostenitrice di un partito di centro. Tutto ciò in nome della dialettica: Idealismo e realismo dovrebbero sempre essere in lotta fra loro, ma la loro lotta dovrebbe essere una gara nel reciproco riconoscimento […] Proprio nel loro scontro si sviluppano le loro maggiori forze; queste sono come grandezze opposte, che in un perfetto pareggio crollerebbero a zero. Ciò porta a un recupero del principio “Soll und Haben” (dare e avere), prima in senso dialettico (l’impresa economica è movimento), poi in una specie di visione cosmica, dapprima solennemente annunciata come sintesi di rispetto del passato e propulsione verso il futuro e poi detta in termini più comprensibili, così: Godere quel che abbiamo e fare quel che dobbiamo! Tutto questo può far sorridere. Ma alcune cose meritano più seria attenzione. Per esempio: Zeising non è per un diritto elettorale censitario né comunque per una politica economica a solo vantaggio degli imprenditori; il liberalismo è da lui interpretato come base per un ampio consenso interclassista. Il nemico lo vede sia nello stato assoluto, sia in un movimento schizzato in modo un po’ sommario (non so quanto volutamente), nel quale è comunque riconoscibile un confluire di comunismo e di anarchia, un movimento che vede la lotta politica come «lotta degli oppressi contro i privilegiati», strumentalizzabile dai reazionari in senso antiliberale. 362 Per il resto ci sono importanti punti di contatto con Freytag. Anche in Zeising compare il polacco falso, bugiardo, intrigante, sleale, doppiogiochista e via dicendo. Ma siccome nel caso specifico si tratta di un nobile, il polacco fa da tramite per la critica alla nobiltà (attaccata anche in altro modo). Anche in questo romanzo (come già negli Epigonen di Immermann, in Weiße Sklaven di Willkomm, nel frammento di romanzo di Weerth e successivamente in Hammer und Amboß di Spielhagen e chissà in quanti altri) appare un parco già nobiliare, ora trasformato in zona industriale, con tanto di fonderia, con turbíne, vapore e via dicendo. Col che siamo oltre Freytag, che si arrestava alla zona del commercio. Della fabbrica e della sua razionalità si parla bene anche prima che l’eroe del romanzo fondi le sue fabbriche ecologiche per il bene dell’umanità e per la fine della miseria in una determinata zona di sottosviluppo. Il fallito romanzo di Zeising dà altre interessanti informazioni: per esempio sulle paure che i moti del 1848 ancora destavano; Zeising non sembra in ogni caso un entusiasta della rivoluzione: tutt’altro, le sue menzioni dell’anarchia sono sempre negative. Le sue osservazioni sull’industria letteraria (la chiama proprio così), sullo stato del romanzo tedesco e sulla sua scarsa diffusione di massa, battuto com’è dalla concorrenza inglese e francese, lo portano infine alla seguente professione di poetica: Il romanzo deve darci un’immagine della vita immediata, in forma quanto più possibile plastica. Però lo sforzo per dare una risposta ai problemi [della religione, della politica, del diritto, dell’etica, dell’arte e della scienza], la disputa e la lotta intorno a loro fanno anch’essi parte della vita. Infine: il virulento antisemitismo di Freytag è qui assente. Soll und Haben ebbe una continuazione, che in realtà fu una somma di satira e confutazione, a opera di Reinhold Solger (1817-1866, nipote del filosofo romantico Karl Wilhelm Ferdinand Solger, 1780-1819), costretto all’emigrazione in America dagli esiti della rivoluzione del 1848. Qui scrisse il suo romanzo, pubblicato dapprima nel 1862 in rivista e dieci anni dopo sotto forma di libro col titolo Anton in Amerika. Novelle aus dem deutsch-amerikanischen Leben (Anton in America. Novella di vita tedesco americana, due volumi, New York 1872). In realtà, contrariamente a quel che suggerisce il titolo, non è Anton Wohlfahrt ad andare in America ma suo figlio Antonio, dopo avvenuta rottura col padre. Il romanzo è preceduto da una velenosa introduzione, in cui si dà una valutazione di Soll und Haben, romanzo che ha fatto un bel po’ di soldi; il suo eroe Anton viene trattato senza tanti complimenti da opportunista leccapiedi. All’inizio del romanzo si insinua sul suo conto anche di peggio (del negriero o giù di lì). Scoppia la rivoluzione del 1848; Anton trova l’occasione per ridimostrarsi leccapiedi, suo figlio gli dà sulla voce, litiga col padre, diventa democratico, partecipa alla rivoluzione, riesce a scappare dopo che questa è stata sconfitta e dopo circa dieci anni di peripezie arriva a New York, che gli pare bensì un mondo di 363 matti, ma almeno non una fabbrica di filistei. Qui si vede che cos’è la speculazione vera e che cos’è la crisi di sovrapproduzione del 1857-58; Antonio vede queste cose tanto da vicino da rovinarsi per bene. Il romanzo ha propriamente per oggetto la difficoltà di adattamento e il sogno di una sintesi. Antonio è un filosofo, ma per i filosofi sembra esserci tanto poco spazio in America quanto in Germania. In occasione di un colloquio, con evidente riferimento polemico a Soll und Haben, Solger fa dichiarare al suo protagonista: «Temo che la moderna letteratura tedesca, la quale va a cercare il popolo lì dove lavora, troverebbe in me un soggetto indegno.» «Tanto peggio per la moderna letteratura tedesca […] Nella storia la forza motrice è lo spirito, esso però non agisce all’improvviso ma solo attraverso la formazione di cellule. Tali cellule siamo noi uomini d’affari, lo spirito siete voi dotti, filosofi, poeti, profeti. Il presente appartiene a noi, il futuro a voi. Se voi restate fedeli a voi stessi, non vi piacerà il presente e non incenserete le forze che reggono il presente. La vita, l’ideale, sebbene non sia fuori di questo mondo, è eternamente al di sopra del presente, eternamente al di là.» Questa accettata estraniazione va di pari passo con una difesa della superiorità della cultura tedesca; e tutto, a sua volta, si associa a un desiderio di fusione tra le due culture, tra la filosofia tedesca e la libertà americana. Prudentemente (e profeticamente) tale fusione viene rimandata a chissà quando, poiché Antonio nel frattempo pianifica «un viaggio etnologico nell’interno dell’Asia, per trovare il mio baricentro nella vita.» Affinità con Soll und Haben mostra anche un romanzo, Der Hungerpastor (Il pastore della fame, 1864), che per lungo tempo ha condizionato l’immagine del suo autore, Wilhelm Raabe (1831-1910), il quale in realtà ha scritto di molto meglio, eppure a questa sua opera teneva moltissimo. (Detto tra parentesi: gli antisemiti della cerchia wagneriana recensirono entusiasticamente sia Soll und Haben sia Der Hungerpastor.) Anche nello Hungerpastor (peraltro meglio riuscito che non Soll und Haben) ci sono due compagni di scuola, uno dei quali è ebreo. Questi mostra, man mano che il tempo passa, di essere arido e avido; poi si sviluppa a quasi parricida (il padre lo previene perché gli prende un colpo e muore quando capisce le mire del figlio), a letterato parigino (che forse agli occhi di Raabe era anche peggio), a spia internazionale (al soldo dei governi tedeschi, spia gli esuli a Parigi) e forse (non è molto chiaro) a organizzatore di bisca, pur trovando sempre il tempo di intrigare contro il suo ex amico. A completare il panorama c’è da dire che questo ebreo così esemplare appartiene alla sinistra hegeliana e si dichiara amico di Heine; col che su quel movimento e su questo autore viene gettata la stessa luce sinistra che tocca al loro patrocinatore ed entrambi vengono da Raabe espulsi dal consesso tedesco. Sull’azione vigliacca di promuovere a spia un heiniano-hegeliano non c’è bisogno di far commenti. 364 L’amico (e presto ex-amico) cristiano, invece, ha studiato teologia, fa il precettore ma perde il posto perché si mette dalla parte degli operai (almeno qui si intravede un’industria, sia pure per pochissime pagine), infine sposa un’orfana e va a fare il parroco di un’affamata parrocchia in un villaggio di pescatori. Questa è un’importante differenza rispetto a Freytag; per quest’ultimo era fuori dubbio che il posto della borghesia fosse in città (tranne quando partiva per «lande desolate» a conquistare colonie), Raabe invece conserva un elemento che la germanistica suole attribuire eminentemente all’ideologia Biedermeier, cioè il contentarsi nella piccola dimensione. Tale elemento rimane costante nell’opera di Raabe, che pure ha un’interessante decorso sia evolutivo sia involutivo. E intanto attraverso lo Hungerpastor abbiamo avuto modo di incontrare l’industria. Per la verità, tentativi di scrivere romanzi industriali c’erano già stati all’epoca dello Junges Deutschland. Importanti pagine, come già visto a suo luogo, aveva dedicato all’argomento Karl Immermann nel suo Epigonen. Ma a scrivere il primo intero romanzo industriale tedesco era stato Ernst Willkomm (1810-1886) con Eisen, Gold und Geist (Ferro, oro e spirito, 1843), di cui tra poco. Nel 1845 ne scrisse un secondo, Weiße Sklaven (Schiavi bianchi) prendendo spunto dalla rivolta dei tessitori slesiani (giugno 1844), un avvenimento che suscitò una gran quantità di poesie, drammi, racconti e romanzi (ci fu perfino una poesia di Freytag nello stesso 1844; non per nulla Julian Schmidt scrisse che con Soll und Haben Freytag aveva definitivamente superato il suo periodo jungdeutsch) con due sole vere riuscite: la poesia di Heine Die schlesischen Weber (I tessitori della Slesia, 1844) e il dramma di Gerhart Hauptmann Die Weber (I tessitori, 1892), ma anche con gli interessanti prodotti poetici di Freiligrath (Aus dem schlesischen Gebirge - Dalle montagne della Slesia -, 1844) e Georg Weerth (Lieder aus Lancashire - Canti dal Lancashire -, 1845). La tesi del precedente romanzo di Willkomm, Eisen, Gold und Geist, era stata di mettere fine all’industria, distruggendo le macchine e tornando alla manifattura. Questo romanzo, insieme col successivo romanzo industriale di Willkomm (e con altri, di cui non discorreremo), influenzò il romanzo industriale del già ricordato Robert Prutz, Das Engelchen (L’angioletto, 1851); questo viene subito dopo la rivoluzione del 1848 e (per questo oppure nonostante questo) brilla per assenza di politica e per sovrabbondanza di considerazioni morali. Le quali peraltro avevano accompagnato la nascita del romanzo industriale. A questo punto è opportuno soffermarsi su Weiße Sklaven. Il romanzo, la cui vicenda-cornice si svolge nel corso di un anno, comincia nell’epoca contemporanea (alla fine del settembre 1832), con una denuncia particolareggiata delle condizioni di vita in fabbrica. Si tratta di una fabbrica tessile che occupa un migliaio di operai, una buona percentuale dei quali è costituita da manodopera infantile e femminile; le undici ore di lavoro al giorno (che nei volumi successivi aumentano a dodici) si svolgono in condizioni disumane (ampiamente descritte) e le riduzioni di salario sono un fatto costante, ripetuto a ogni svolta della vita 365 economica. Le condizioni economiche generali, inoltre, sono tali che gli operai non possono opporre alcuna resistenza: essi sono semplicemente sottoposti ai datori di lavoro, sono i moderni schiavi. I padroni, però, non sono che la vecchia aristocrazia riciclata; sulle macerie del vecchio castello i discendenti di quei nobili hanno costruito la fabbrica; hanno poi finto di democratizzarsi, deponendo il “von” del loro cognome (che usano però in privato). Ma così tutto è rimasto come prima: prima c’erano i servi della gleba, ora quel mezzo d’oppressione è sostituito dalla pretesa delle leggi economiche, sempre nelle stesse mani, appoggiate dalle leggi civili, che hanno lo scopo precipuo di sostenere la volontà e l’arbitrio dei potenti. A questo punto il romanzo salta al prima, cioè a una quarantina d’anni prima, al 1790, insomma ai tempi della Rivoluzione francese. Vengono descritte le vicende della servitù della gleba, i soprusi della nobiltà e la vendetta che di loro viene fatta a opera di un gruppo di briganti incaricati di ristabilire la giustizia. Per il modo in cui è costruita, questa parte della vicenda (che comprende i primi due volumi) mostra cospicui debiti nei confronti dei romanzi d’avventure già in voga da qualche decennio; ma, al di là di quelli, mostra di voler riprendere alcuni temi dello Sturm und Drang, quali l’esaltazione dei briganti come vendicatori del diritto calpestato e della libertà conculcata, e quali l’accusa alla nobiltà di voler frustrare la borghesia nelle sue aspirazioni d’ascesa (il capo dei briganti è un ex-precettore di cui è stato ostacolato l’amore per una fanciulla nobile). Gli ideali che i personaggi richiamano sono quelli di Schiller (più volte citato, sia per i Räuber sia soprattutto per il Don Carlos) cui vengono tranquillamente associati Bürger e Novalis; esplicitamente respinto è l’illuminismo francese, definito frivolo e sedizioso. Gli ideali di libertà e di uguaglianza vengono celebrati, ma come doti precipuamente tedesche; e le sollevazioni, sia quella già avvenuta dei servi della gleba (che bruciano il castello nobile, su cui comunque i discendenti quarant’anni dopo avranno eretto una fabbrica di cui gli ex servi della gleba saranno i nuovi schiavi) sia quella progettata dai proletari, avvengono e devono avvenire per motivi morali e religiosi: occorre rivendicare la giustizia e la libertà, definita quest’ultima «vera figlia di Dio e degli uomini», finché verrà il giorno in cui regni il diritto: questo tempo sarà «quel che i teologi chiamano il regno millenario». Insomma il panorama appare piuttosto chiaro: un forte nazionalismo porta a mettere in secondo piano (per quanto si può) gli influssi della Rivoluzione francese (l’abolizione della servitù della gleba viene spiegata come conseguenza della sollevazione che porta alla distruzione del castello, come se Napoleone non c’entrasse niente). La dimensione moralreligiosa delle nuove prospettive politiche e sociali viene fortemente sottolineata (senza molte illusioni sull’esito, poiché si parla della necessità di «ancora alcune rivoluzioni, come quella francese») e presentata come tipicamente tedesca. Ad affiancare tutto ciò, un antisemitismo e un disprezzo dei polacchi che l’autore non si prende neanche la pena di 366 argomentare, tanto ovvi essi dovevano apparirgli; pare gli sia sufficiente esprimerli con tutta la brutalità possibile. Dopo la lunga digressione sul passato, l’autore ci riporta al presente (volumi 3-5), a una vicenda che si svolge nell’arco di un anno (1832-1833). Qui egli tenta di descrivere la grande città (Amburgo) e di misurarsi coi problemi del crimine e della prostituzione quali fenomeni sociali; il risultato non è convincente, ma almeno Willkomm ci ha provato e dimostra anche una buona conoscenza della letteratura contemporanea, in particolare di Eugène Sue. Più interessante ancora è la sua conoscenza di situazioni concrete: la sua descrizione della fabbrica tessile sa di verità, i suoi conti in tasca alle varie classi di lavoratori vengono fatti secondo cifre precise di cui in una nota a piè di pagina l’autore assicura l’esattezza; anche sulle abitudini alimentari l’informazione appare circostanziata. Insomma Willkomm dà tutta l’impressione di essersi documentato. Anche sul piano politico ci sono delle ipotesi interessanti. Willkomm sembra vedere una forte riscossa della nobiltà sotto nuove vesti, e l’uso della libertà come pura parola attraverso la quale conculcare tutti i diritti sostanziali. Invoca un intervento dello stato attraverso (pare di capire) una politica fiscale, di crediti e di sussidi che tolga i dipendenti dalla mercé dei datori di lavoro, essendo questi padroni non solo di quelle braccia ma anche delle abitazioni e del tempo (si fa per dire) libero degli operai, che sono tornati di fatto a essere loro sudditi. Dall’insieme delle analisi e delle proposte appare che Willkomm abbia riflettuto con serietà sui modi nei quali era stato parzialmente liquidato il latifondo (cosa di cui si parla in altra parte della presente storia). Willkomm fa le lodi delle macchine e del progresso, ma profetizza anche un futuro di impoverimento generale, mentre tutta la ricchezza si concentrerebbe nelle mani di qualche migliaio di capitalisti (temi, questi, che di lì a poco si ritroveranno in Marx). Come rimedio, Willkomm suggerisce, oltre all’intervento statale, una partecipazione degli operai agli utili della fabbrica, che verrebbero corrisposti come interessi sul capitale, il quale invece dovrebbe restare intatto per poter essere reinvestito. Un po’ a contrasto e anche un po’ a conferma dei risultati di Willkomm conviene occuparsi del frammento di romanzo senza titolo scritto (nel 1845-46, a quanto pare) da un autore più volte ricordato in precedenza, Georg Weerth. Poiché lo si è riscoperto e in buona parte pubblicato in epoca recente come letterato vicino a Heine e ancor più a Marx, Weerth può autorevolmente confermarci tutte le difficoltà in cui si dibatteva il romanzo industriale, tanto più in quanto egli fece sforzi cospicui, e più coerenti di quelli di ogni altro, per farnelo uscire. Weerth aveva soggiornato a lungo in Inghilterra (1836-40 e 1843-46), dove parte del frammento presumibilmente fu stesa; e il confronto tra Inghilterra e Germania si trova in più punti di tale frammento: Weerth sottolinea sia il ben 367 diverso peso politico e sociale delle due borghesie, sia la diversa psicologia delle due classi operaie, sia l’inesistenza di un’organizzazione tra gli operai tedeschi; anzi uno dei personaggi, tornato da un qualificato lavoro di fabbrica in Inghilterra, assieme alle sue conoscenze tecniche porta anche quel che ha imparato sull’organizzazione, e in particolare sugli scioperi, col proposito di introdurlo tra gli operai tedeschi. Nel romanzo (o meglio, nel frammento di romanzo) viene realisticamente descritta una fabbrica con le sue condizioni di lavoro e di sorveglianza (cosa, quest’ultima, nuova e importante), con la giornata lavorativa di tredici ore; vengono descritti i vari tipi di occupati, dalla manodopera infantile a quella femminile a quella stagionale. Si parla ampiamente della decurtazione dei salari così come delle innovazioni tecniche, viste nei loro effetti antioperai. Viene descritto (marginalmente, per la verità) un quartiere operaio. E, cosa che forse conta di più, si delinea l’opposizione tra il tipo di socialismo radicale e quello sentimentale, nutrito di Dickens e di Sue (citati) e delle letture di Owen, Fourier, Weitling, Saint-Simon (tutti citati da Weerth). Non c’è una condanna né dell’industria né delle macchine, ma anzi se ne sottolineano gli elementi potenzialmente liberatorî. Il fabbricante che compare, viene presentato nella sua ideologia “cristiana”, nella sua convinzione, tanto cinica quanto sincera, di essere un benefattore dell’umanità. Questi elementi erano già in Willkomm; come lui, anche Weerth parla degli operai come schiavi moderni e come la nuova versione dei servi della gleba. Weerth però sottolinea le ambizioni politiche della borghesia: un partito non c’è ancora, ma l’introduzione del protezionismo doganale e, in un’ottica più ampia, della costituzione, dovrebbero servire a costituirlo. Singolare è la valutazione della nobiltà. Da una parte Weerth asserisce che essa non può costituire un partito e che quindi ha smesso da tempo di avere importanza politica. Dall’altra, mentre una metà dei nobili vive come se niente fosse cambiato e quindi va incontro alla rovina, l’altra è però attivamente presente nell’apparato statale oppure in un’agricoltura ben organizzata o infine si è data all’industria. Ma questa riflessione generale è lasciata cadere per limitarsi a presentare un nobile, indubbiamente indebitato e impoverito, però dotato di nobiltà d’animo. Suo nemico è l’industriale, che mira a sottrarre al nobile anche il castello (dopo avergli già portato via tutto il resto) per farne una distilleria. Per capire meglio l’inumanità della borghesia (che comunque già intuisce d’istinto e vede per esperienza), questo nobile legge addirittura Friedrich Engels, dalla cui opera Die Lage der arbeitenden Klasse in England (La situazione della classe operaia in Inghilterra, 1845) Weerth cita ampiamente. A complicare le cose, c’è un idillio tra uno dei figli dell’industriale e la figlia del nobile da una parte, e un altro dei figli dell’industriale e un’operaia, sorella dell’agitante socialista, dall’altra. Peccato che il romanzo sia interrotto: la confusione era notevole e prometteva garbugli ulteriori. Anche Weerth, come tutti coloro che scrissero romanzi su problemi sociali, 368 pone a base di tutto un’esigenza morale: l’industriale è spregevole (niederträchtig) e un effetto dello sciopero sarà mostrarne a tutti la vergogna morale (Schande). Il romanzo non venne terminato; quale ne sia stata la ragione, il frammento ci appare un qualcosa con troppa carne al fuoco. Alcuni personaggi, opportunamente modificati, servirono per alcuni già ricordati quadretti, in buona parte pubblicati su due diversi giornali nel 1847-48 (Humoristische Skizzen aus dem deutschen Handelsleben, Schizzi umoristici dal mondo commerciale tedesco). Weerth vi satireggia una borghesia commerciale cinica e pronta a trar profitto da ogni situazione. Il risultato artistico è in alcuni schizzi assai migliore, ma indubbiamente manca quel tentativo di ampio respiro che Weerth aveva provato nel romanzo. Seguirono numerosi romanzi industriali. Parleremo più in là di quello che scrisse uno dei rappresentanti più in vista del realismo, Friedrich Spielhagen (1829-1911): Hammer und Amboß (Martello e incudine, 1869). I risultati di questa panoramica sul lavoro nella letteratura realista sono ben magri; sempre assente il livello artistico (a parte la Maria Magdalene di Hebbel e pur essa con tutte le riserve del caso; ma è poi davvero un dramma realista?), desolante il panorama sociologico e ideologico. Cosicché suonano quasi liberatorie le poche, graffianti righe che all’argomento dedica Fontane nel suo Stechlin (1897-98). Una comitiva fa una gita nei sobborghi di Berlino; fra le tante cose di cui si discorre c’è anche la questione «se il quarto stato [cioè il proletariato] si affermerà e si consoliderà (perché alla fin fine sta tutto qui il nocciolo del discorso)». In lontananza si vede un impianto industriale; dopo poche battute, quell’impianto dà luogo ad alcune considerazioni di costume, che a loro volta si basano su una «domanda troppo difficile», come dice uno dei personaggi: Adesso facciamo (purtroppo) tante cose che, secondo la vecchia mentalità, non dovrebbero essere fatte. Per esempio, non sta bene stare sulla piattaforma del tram a cavalli tra un fattorino e una donna con la gerla; e più disdicevole ancora è andare a far compere in un mercatino ambulante, trascurando il dubbio che fa capolino: «Come fanno questi prezzi a essere così bassi?» (cap. XIV) Sono passati quarantatré anni da quando Fontane recensiva Soll und Haben. La borghesia, già scacciata dalla politica - come Fontane aveva rilevato in quella recensione -, vi è stata ammessa attraverso un compromesso con la nobiltà militare e possidente (e tempestivamente, nel 1881, Julian Schmidt ha revocato la polemica di Freytag contro la nobiltà, da lui a suo tempo condivisa). Fontane non si fa illusioni su nessuno: né sui nobili né sulla borghesia. Ma vede le cose. Lui sta da una parte specifica, è per la conservazione, è per il nobile Stechlin; senza fare di ciò una bandiera politica (Stechlin si lascia trascinare a candidarsi alle elezioni e le perde perché così deve essere) e piuttosto per dichiarare chi è 369 lui stesso. Per il resto vede le cose e le accenna: i prezzi bassi dovuti ai salari minimi, l’industria che c’è ma che si fa quasi finta di non vedere, i problemi dei lavoratori per i quali non si danno soluzioni da saccenti. È l’arte ironica e allusiva del grande Fontane. VII, 2. Le grandi trasformazioni vengono registrate tardi. A farsene carico è soprattutto Raabe nella sua opera tarda: Pfisters Mühle (Il mulino di Pfister, 1884) tratta dell’inquinamento industriale, Im alten Eisen (Al ferro vecchio, 1887) delle condizioni di vita nei quartieri poveri e sovraffollati della Berlino improvvisamente cresciuta, Die Akten des Vogelsangs (Gli atti del quartiere Vogelsang, 1896) di come una città diventa metropoli. Gli specialisti di Raabe, intenti a fornire un’immagine di quest’autore che non ricalchi quella già avuta dai contemporanei, non più rispondente alla nostra cultura e alle nostre aspettative, hanno richiamato l’attenzione sulla sua produzione tarda; un’iniziativa editoriale che ha appoggiato quell’operazione ha selezionato proprio e soltanto all’interno dell’ultima fase. L’operazione è convincente, la qualità dell’ultimo Raabe è fuori discussione e così pure l’interesse della sua tematica e della sua tecnica. Fra i tre romanzi sopra citati, il più interessante è l’ultimo (Die Akten des Vogelsangs), nel quale Raabe mostra, fra le altre cose, a che punto è arrivata quella sua maestria nel trattare la dimensione tempo, già rivelata con la sua prima opera, Die Chronik der Sperlingsgasse (Cronaca del Vicolo del Passero, 1857), poi persasi nelle opere di mezzo ma infine riesplosa, raggiungendo i risultati migliori in Stopfkuchen (L’ingordo, 1891). Tuttavia proprio il confronto fra Stopfkuchen e Die Akten des Vogelsangs induce ad alcune perplessità. Quest’ultima opera, come già detto, narra di come una città diventi metropoli. Vogelsang è il nome di un quartiere periferico, nel quale il concetto di comunità può essere preso sul serio; non che manchino le rivalità, tuttavia si riesce a convivere e le rivalità stesse dimostrano partecipazione al destino altrui. L’avanzare del progresso ingoia il quartiere, che viene progressivamente demolito per far posto a fabbriche e casermoni; qualche pezzetto si ostina a sopravvivere un po’ più a lungo degli altri (è il caso di un tratto di siepe o di un’ostinata signora che non cede la sua casa) ma il destino del quartiere è di scomparire; i suoi abitanti vengono dispersi, le loro vite si separano. Magari qualcuno ha successo, qualcuno arriva alla ricchezza; ma la sostanza umana va perduta, dal quartiere deturpato si fugge come da un incubo. E la reazione di chi è più sensibile fra tutti è di rinunciare al possesso e andare nudo per il mondo, protesta vivente contro la cupidigia del possesso, che ha distrutto illusioni, felicità e vita. Questa, in sintesi, 370 la tematica del romanzo. Per raccontarlo, Raabe mescola i piani temporali, passando continuamente dal presente (dei superstiti accorsi alla morte del più sensibile) al passato (del quartiere ancor intatto); una tecnica già usata in Pfisters Mühle, sebbene lì in modo più moderato. Nel frattempo però la tecnica del mescolamento temporale aveva dato il meglio di sé in Stopfkuchen; qui i tempi erano numerosi: il presente (il momento in cui il relatore scrive del passato prossimo), il passato prossimo (la visita che il relatore ha appena fatto nel paese natale), il passato meno prossimo (l’infanzia), un passato più lontano (la guerra dei Sette anni), un passato remoto (la preistoria, i fossili di cui il narratore del racconto interno è collezionista). La compressione dei tempi è tale che in più di un’occasione solo dopo qualche riga il lettore è in grado di distinguere l’un tempo dall’altro, tanto illusionistico è il modo di procedere dell’autore. E analogamente avviene per lo spazio: il resoconto viene scritto su una nave e Raabe passa in continuazione dal viaggio per mare a ciò che è accaduto sulla terraferma, utilizzando con grande sapienza i suoi agganci per fondere gli spazi quanto più si può. Tutto ciò rispondeva a una logica: il narratore esterno non ha conosciuto la verità, pur avendo percorso l’ampio mondo, il narratore interno l’ha conosciuta pur non essendosi mosso da casa e pur essendo stato isolato dal resto della comunità; il mescolamento dei tempi rende tutto presente e in questa sintonia con un’eterna presenza si rivela la comprensione della più intima natura umana, che lo svagare attraverso spazio e tempo può piuttosto nascondere. Il lettore può in tutto ciò riconoscere degli echi da Jean Paul o da ciò che è stato inteso come ideologia Biedermeier. A ogni buon conto quella tecnica serviva a immobilizzare il tempo. Nelle Akten des Vogelsangs invece è lo scorrere del tempo, con i cambiamenti che in tale scorrere vengono registrati, a provocare le crisi. Una sostanziale trasposizione della tecnica del romanzo precedente a questo sarebbe stata più convincente se se ne fosse fatta vedere l’impossibilità; e invece è proprio quel che Raabe non vuol fare: il suo tener fermo alle soluzioni individuali e un po’ romantiche lo porta a volte a mettere in ombra i contrasti, non perché non parli con energia delle crisi e del procedere della metropoli, ma perché tale procedere non diventa esso stesso parte della tecnica romanzesca. La qualità del tardo Raabe resta tanto poco impregiudicata che anzi sarebbe il caso di riaprire su di essa la discussione. Altri cambiamenti vennero registrati da Gottfried Keller in Martin Salander e negli ultimi racconti di Die Leute von Seldwyla, e di ciò si è già parlato. L’avanzare della socialdemocrazia trova un’eco nello Stechlin di Fontane. 371 VII, 3. L’ascesa sociale Sono poche le opere d’arte del realismo che non trattino questo tema; mi limiterò a pochi esempi significativi, dai quali risulta ancora una volta che l’argomento viene impostato considerandone i riflessi morali e culturali e tralasciandone le premesse economico-sociali; in compenso gli esempi sono di alta qualità artistica. Nella Maria Magdalene due giovani tentano la scalata sociale e di entrambi l’autore dà un giudizio negativo, diversamente calibrato. Uno (indicato semplicemente come «segretario») si è dato alla giurisprudenza e, terrorizzato dalla quantità di gente che vi è fallita, per poter riuscire si dedica con tanto esclusivismo ai suoi studi da dimenticare tutto quel che non li riguarda; in tal modo dimentica la ragazza che lo ama (Klara, figlia di Meister Anton) che, vistasi abbandonata e spinta dalle circostanze e dall’ambiente, accetta di fidanzarsi con Leonhard. Anche questi è intento alla sua ascesa sociale: vuole un posto di cassiere presso il comune; e lo ottiene anche, ubriacando al momento giusto il più quotato avversario e facendo la corte alla nipote del sindaco. È vero che è fidanzato con Klara, ma alla nipote dichiara che non è una cosa seria; infatti da Klara si aspetta 1000 talleri di dote e, per paura che ricominci l’amore di costei col segretario, la mette incinta. I 1000 talleri però non ci sono; così Leonhard pianta Klara e seduce la nipote del sindaco, che è gobba ma con ottima dote. Ciò fatto, Leonhard può dire a se stesso: «come ci si sente bene quando si è fatto il proprio dovere!» I conti non gli tornano fino in fondo perché il segretario, che non se la sente di legarsi ancora a Klara considerando quella gravidanza come cosa da non passarci sopra, lo ammazza in duello (senza poter scongiurare la tragedia di Klara, che nel frattempo si suicida per prevenire il minacciato suicidio del padre). Poiché tutto si svolge programmaticamente entro una piccola cerchia che i personaggi non riescono a rompere, non ci viene detto perché i due giovanotti siano presi dall’ossessione della carriera; lo spettatore deve saperlo da altre fonti: sulla scena egli vede soltanto dei comportamenti che ricevono un giudizio morale negativo. Facciamo un salto di quasi quarant’anni e vediamo che cosa succede in uno dei più grandi racconti di Theodor Storm (1817-1888) Hans und Heinz Kirch (1882). Altri tempi e anche altro ambiente; siamo nello Holstein e la tragedia nasce dalle attese che il padre ripone nel figlio. La vicenda è ambientata in una piccola città di mare e l’epoca abbraccia la quarantina di anni precedenti, terminando al presente della stesura. Nella cittadina il cursus honorum è stabilito con chiarezza: Nel coro della chiesa, costruita da un duca della regione nel tredicesimo secolo, si trovava l’ampio banco della gente di mare, tutto risplendente, al vespro, per 372 gli imponenti candelieri di metallo appesi alle pareti, e riconoscibile dal modellino d’una nave che, tutta attrezzata per salpare, dondolava penzolando dal soffitto. A questo posto in chiesa aveva diritto ogni cittadino che avesse superato l’esame di nocchiere e che possedesse una nave propria; ma anche coloro che erano ormai passati alla professione di commerciante, i primi armatori della città, potevano assistere da lì al servizio divino, seduti in mezzo agli altri capitani, mentre le mogli sedevano giù nella navata; poiché anch’essi erano pur sempre e prima di tutto gente che aveva solcato i mari, e la piccola barca ondeggiante là sopra era anche il loro emblema. Hans Kirch mira più in alto; e se magistrato e senatore non potrà diventarlo lui, dovrà sicuramente diventarlo il figlio Heinz. In questi Hans ripone tutte le sue speranze, su questi riversa tutto il suo affetto; solo che Hans, nel suo desiderio di ascesa sociale, vede talmente nel figlio lo strumento attraverso cui arriverà lui stesso al successo, che l’affetto stesso prende forme di tale durezza da allontanare il figlio dal padre. Quando Heinz si prepara a partire per il viaggio al termine del quale dovrebbe diventare timoniere, il padre trova il coraggio di dirgli due parole personali solo nel buio dell’ingresso, fuggendo poi in cortile per nascondere le lacrime; e qualche ora dopo tratta il figlio con durezza perché ha violato un determinato ordine domestico, rincasando troppo tardi. Il perché del ritardo Hans lo saprà nel momento peggiore, quando cioè gli sarà stato appena negato quel passo avanti nel cursus honorum che lui stesso ha appena tentato: la sera in questione il figlio si è fidanzato con una ragazza la cui madre ha una condotta morale unanimemente disapprovata. Preso da doppia rabbia, il padre scrive al figlio, ancora imbarcato, una violenta lettera; a questa non c’è risposta, ma alla fine del viaggio Heinz non torna a casa a fare il suo esame di timoniere bensì si reimbarca. Il padre non ha ancora capito la portata della rottura e si illude anzi che il lungo silenzio e la lunga assenza significhino che il figlio vuol tornare solo ricco e coronato dal successo. Ma nel mezzo di queste illusioni arriva una lettera non affrancata: se Heinz non ha neanche i soldi per pagare un francobollo, pensa il padre, allora tutte le speranze sono frustrate. Hans rifiuta la lettera, che verrà rispedita al mittente; invano Wieb (la fidanzata del figlio) cerca di riaverla dal postino: sapremo più tardi che Heinz, ricevendola indietro mentre si trova in una situazione disperata, capisce di essere stato respinto dal padre. La sua vita va a rotoli; profondamente trasformato, approda ad Amburgo dopo un’assenza complessiva di diciassette anni. Il padre va a riprenderlo ma non riesce a superare il crollo delle illusioni; trova tutti i modi di convincersi che quel figlio non è suo figlio e lo caccia nuovamente di casa; tutta la parentela gli è solidale, anzi lo spinge al passo, compresa la sorella di Heinz. Il quale non ha lì più niente da fare: Wieb stessa è finita in una taverna di malaffare; e quindi lascia definitivamente la casa. Ma nonostante tutte le durezze e gli errori Storm sembra amare quest’epoca ormai al tramonto, quando il ritmo della vita cittadina era regolato da una cam373 pana civica, da poco scomparsa dalla piazza del mercato. Ora i rapporti sociali sembrano favorire meno la mobilità: si è formato un piccolo patriziato, ma «fino a dieci anni fa» tutti dovevano seguire la stessa via: da mozzo a capitano, poi a circa quarant’anni armatore e infine senatore. Sul presente Storm non si pronuncia, di certo non sembra suscitare il suo entusiasmo il fatto che le attese di Hans si realizzino non nel figlio ma nel genero. Con Mathilde Möhring (scritto nel 1891, pubblicato postumo) Fontane tratta una dimensione finora mancante: il desiderio di ascesa sociale da parte di una donna. Stavolta siamo in una grande città perché la vicenda si svolge per la maggior parte a Berlino. Al momento in cui la conosciamo, la protagonista eponima ha ventitré anni, non è bella e vive assai modestamente con la madre, avendo perso il padre. Per arrotondare le entrate, le due donne decidono di affittare una stanza; diventa affittuario un pigro studente di legge, prossimo all’esame conclusivo. Mathilde si rende ben presto conto che questo ragazzo, bravo ragazzo ma scarso di energia e volontà, combinerà poco se non adeguatamente sorretto. Lo assiste amorevolmente durante una malattia, tanto amorevolmente che lo studente se ne innamora; i due si fidanzano e lei lo guida con mano sicura verso l’esame, superato poi con successo. Mathilde è realista: sa quel che lo studente Hugo può raggiungere e che cosa no; d’altra parte Mathilde stessa non è né ipocrita né avida: sa calcolare e se ne rende conto, ma senza essere inumana. Superato l’esame, Mathilde studia per bene le possibilità di lavoro del suo fidanzato e lo induce ad accettare un posto in una cittadina, sicura che lui ne sarà all’altezza. Così è, infatti; i due si sposano, si trasferiscono nella cittadina e Mathilde dà a Hugo quella forza e quei consigli che gli servono. Va tutto bene e tutto seguiterebbe così, quando Hugo improvvisamente muore. A Mathilde si aprirebbe un’altra e ben più allettante possibilità, se solo fosse cinica e senza scrupoli: diventare la dama di compagnia d’un conte, puntando a diventarne la moglie. Ma ecco che il suo orgoglio di donna e di vedova glielo impedisce. Torna a Berlino e, superato anche lei il relativo esame, diventa maestra elementare, intraprende cioè una delle pochissime carriere concepibili per una donna del suo ceto. È sola e indipendente, anche se vive molto modestamente. Le ultime due sono storie di ascese tentate e poi interrotte in qualche punto. Anche alcuni romanzi precedentemente considerati possono essere visti alla luce dell’ascesa sociale; è il caso di Soll und Haben, di Hammer und Amboß e anche dello Hungerpastor, con esiti diversi. A tutte queste vicende è comune che esse si svolgano in ambiente borghese, come del resto è ovvio: era alla borghesia che si poneva il compito di emergere. Ciò va di pari passo con la considerazione che viene fatta della nobiltà da una parte, del proletariato dall’altra. Si è già avuto modo di accennare alle prese di posizione degli autori che stiamo considerando nei confronti della nobiltà. A lungo abbondano le prese di posizione negative. Il Moses Freudenstein dello Hungerpastor accede, alla fine del romanzo, ai primi gradi della nobiltà e ciò viene 374 annunciato con una frase densa di contraddizioni: disprezzato sia da coloro che ha servito sia da coloro contro cui ha agito (come spia), Freudenstein riceve il grado di consigliere segreto, col che è, «alla lettera, bürgerlich tot», è cioè morto per la borghesia e civilmente morto. Si capirà che equiparare innalzamento alla nobiltà al disprezzo e alla fine di una vita onorata è un’eloquente presa di posizione. In un paio di romanzi precedenti Raabe era stato altrettanto poco tenero. Nella Chronik der Sperlingsgasse (1857), suo primo romanzo e uno dei migliori, un conte Friedrich Seeburg seduce una povera fanciulla e poi scompare, abbandonandola con un figlio (Franz) nella disperazione, tanto che la fanciulla si annegherà. Sapremo in seguito che il conte, che ha fatto perdere le tracce, è andato in Italia dove si è sposato e ha avuto una figlia (Helene), mentre la moglie moriva di parto. Il conte ripassa le Alpi e, poiché il castello della famiglia Seeburg è stato venduto, si stabilisce a Vienna, dove vive assolutamente isolato, tormentato dai rimorsi. Alla sua morte un anziano signore (non più un nobile) si occupa della figlia orfana, la sposa, ha con lei un figlio (Gustav) e muore a sua volta. Helene e Gustav si trasferiscono andando ad abitare nei pressi di Franz, che a sua volta si è sposato e ha avuto una figlia, Elise. Gustav ed Elise si innamorano e si sposano. Dunque c’è alla fine una riconciliazione, ma solo perché la borghesia ha accolto nel suo grembo la nobiltà. In Die Leute aus dem Walde (Gente del bosco, 1862-63) invece c’è un nobile che tenta di fare il seduttore di fanciulle, c’è anzi in generale una nobiltà severamente giudicata, e la via verso la riconciliazione è drastica; un altro nobile che si aggira per il romanzo, infatti, è parzialmente positivo solo perché ha sostanzialmente accettato il modo di vivere della borghesia: quel tanto di spavalderia che gli resta non è più l’arroganza del nobile quanto spericolatezza di avventuriero. Una via simile a quella di Raabe segue Friedrich Spielhagen (1829-1911) nel suo Problematische Naturen (Nature problematiche, 1861; il titolo prende spunto da un detto di Goethe); anche qui c’è una nobiltà viziosa e seduttrice, adeguatamente sgridata da un figlio illegittimo, peraltro irrequieto e dilacerato, comunque amato dalle nobili, bravo nel duello contro un nobile, ma tutto alla caccia di un ideale che è solo nella sua mente e che gli rende difficile la vita. Nel romanzo di proseguimento (Durch Nacht zum Licht - Verso la luce, passando per la notte -, 1862) il protagonista scopre le proprie origini nobiliari e viene reintegrato nel rango e nella ricchezza; alla fine però cade sulle barricate berlinesi del 1848, combattendo al fianco della borghesia: in questa fase Spielhagen non vede un futuro per la nobiltà in quanto classe. Problematische Naturen rese Spielhagen celebre d’un colpo. Ed egli restò a lungo sulla cresta dell’onda, sia come romanziere sia come teorico della letteratura. Diede, fra le altre cose, un contributo al romanzo industriale; su esso ora ci soffermeremo. Hammer und Amboß (Martello e incudine, 1869) cita, col suo titolo, un noto verso di Goethe; tuttavia la struttura binaria fa pensare al titolo del romanzo di 375 Freytag Soll und Haben, del quale pare essere una conseguenza e al quale in fondo è una replica. Il titolo significa: il mondo è strutturato sul rapporto padronischiavi, cioè sul rapporto tra i signori del martello e coloro da cui ci si aspetta che facciano sempre da incudine, subendone i colpi; la proposta è che tale antagonismo venga soppresso e si arrivi a una conciliazione degli opposti. Ciò vogliono le leggi della natura e così deve comportarsi anche l’uomo, la cui esistenza è sottoposta anch’essa alle leggi naturali; se l’uomo ne diventa consapevole e si appropria di tale legge dell’equilibrio, della conciliazione, della solidarietà, allora si hanno libertà e giustizia, altrimenti si hanno schiavitù e tirannia. Tutto ciò viene asserito con grande insistenza sull’aspetto morale, sulla dignità e santità del lavoro. Viene pur detto che tutto ciò non tiene conto di una verità: che il lavoro è una merce sul mercato mondiale la quale, come ogni altra merce, sottosta alla legge della domanda e dell’offerta, [per cui tanto l’incudine quanto il martello] sono colpevoli e devono pagare parimenti le spese del processo. La replica è ancora di carattere morale: i migliori devono superare già ora in se stessi questo dualismo, convincendosi di essere in ogni momento parte attiva e parte passiva, donatori e ricettori, martello e incudine. La vicenda è collocata nel Vormärz, a costo di qualche anacronismo: si vede che Spielhagen non ha voluto toccare né i temi della rivoluzione né quelli dell’organizzazione politica e sindacale dei suoi tempi; e si vede anche come egli voglia riprendere e continuare i temi dello Junges Deutschland o comunque del Vormärz: non per nulla vari aspetti del suo romanzo fanno pensare a Weiße Sklaven (1845) di Willkomm: c’è perfino una banda di briganti (nella versione moderna dei contrabbandieri), c’è una critica rivolta alla nobiltà, che nel 1869 avrebbe dovuto essere aggiornata (e che già da alcuni anni veniva per lo più attenuata, per essere poi lasciata cadere dagli scrittori dopo l’unificazione tedesca del 1871). È una critica che non manca di ambiguità: ci sono tre fratelli nobili, uno dei quali è oggetto di sarcasmo dall’inizio alla fine, uno invece ha molti lati positivi (è il capo dei briganti per sete di giustizia e, anche se la sua alternativa è sbagliata e perdente, personalmente però viene sostanzialmente valutato in senso positivo e i suoi lati negativi sono presentati come colpi di potenze avverse: l’evoluzione della società, la Germania impotente e apparentemente senza speranza, gli amici infidi); il terzo fratello, infine, è il teorico della conciliazione degli opposti, è il vero maestro del protagonista. La borghesia, invece, ha un suo rappresentante inizialmente più che dinamico (e nella stessa misura privo di scrupoli), portato poi alla rovina dalla sua furia speculatrice. Evidentemente Spielhagen non pone speranze nella nobiltà, che tuttavia pare poter riacquistare un suo ruolo facendosi educatrice del mondo moderno, trasmettendogli l’unica cosa che ha da trasmettergli: il senso della dignità, dell’armonia, della giustizia sociale. Non pone molte speranze nemmeno nella borghesia, le cui conquiste tecniche vengono tutte accolte mentre ne viene condannata la spietatezza. Que376 sto, almeno, è quel che si riesce a ricavare da un romanzo fin troppo avventuroso e molto parcamente teorizzante (a parte che nella spiegazione del titolo). Nel complesso il romanzo è ben costruito e nella Unterhaltungsliteratur ha mantenuto discretamente a lungo un suo posto: lingua generalmente vivace, situazioni a volte colorite, varietà di personaggi, colpi di scena, storie di corruzioni, raggiri, speculazioni e via dicendo. Indubbiamente la fabbrica si vede poco, le abitazioni operaie vengono descritte una sola volta nel loro squallore, la città vera e propria compare fugacemente e solo come creazione fatata. Di politica, insomma, c’è poco. Molto si insiste sulla solidarietà (gli operai offrono a un certo punto una spontanea rinuncia a una parte del salario per salvare la fabbrica in difficoltà), il che comporta anche attenzione a quelle che oggi chiamiamo assicurazioni sociali; ma nessuna parola sulle istituzioni politiche e organizzative. Straripano invece le avventure e le considerazioni morali, poste alla base di tutto. C’è perfino la frase che, scritta sul cancello di Auschwitz, diventerà famigerata: «Arbeit macht frei» (qui nella versione: «Nur die Arbeit kann uns frei machen», II, p. 31). Come accennato, l’atteggiamento nei confronti della nobiltà segnala in quest’opera una certa sua complessità. Ma in un successivo romanzo (Sturmflut – Inondazione -, 1877) Spielhagen, sensibile ai nuovi tempi, celebrò la conciliazione fra le classi. Di Julian Schmidt e della sua revoca dell’atteggiamento antinobiliare contenuto in Soll und Haben del suo amico Freytag si è già detto; interessante notare che in questo romanzo si condannava, e aspramente, quel maggiorasco che nella fase del compromesso fra classi la borghesia fu ben lieta di ereditare insieme con le tenute che veniva acquisendo. Da notare la singolarità dell’atteggiamento di Fontane: non ha mai tematizzato la conciliazione fra le classi, della nobiltà ha rilevato fondamentalmente gli errori e i limiti, un matrimonio misto viene trattato nello Stechlin con sarcasmo feroce (tutto a spese della nobile). Eppure non c’è da dubitare che Fontane vedesse una forza positiva nella nobiltà, così come in generale nell’assicurare la continuità di certe tradizioni; è vero che a occuparsene sono infine una nobile e un pastore, ma (a parte che non formano coppia) la nobile, piena di grazia e di spirito, se ne sta tutto sommato isolata e incompresa, e comunque in quell’associazione non c’è aria di conciliazione generalizzata quanto la promessa di vegliare, da parte di chi non avrà figli, su chi invece ne avrà ma che sembra dotato di troppa poca forza spirituale per poter assolvere autonomamente una qualche missione. È dunque un’associazione fra singoli spiriti chiaroveggenti. Su un’altra combinazione (che getta una luce ulteriore su quella appena vista) ci fermeremo invece più in là. 377 VII, 4. Il controllo sociale Nel 1882 Fontane pubblica Schach von Wuthenow; l’eroe eponimo è un ufficiale prussiano e la sua vicenda si svolge a Berlino poco tempo prima di quella battaglia di Jena (14 ottobre 1806) che vedrà la sconfitta dell’esercito prussiano a opera di Napoleone. La vicenda del romanzo, che porta il protagonista al suicidio, acquista carattere simbolico. Nella sua vita, nei suoi ideali, nei suoi progetti, insomma in tutto Schach mette al primo posto il decoro e la reputazione. Non è un uomo né di straordinario valore intellettuale né di carattere superiore; in società regge bene la sua parte ma non è certo fatto per calamitare l’attenzione né per dare il tono. Chi, nell’ambiente che frequenta, è in grado di giudicarlo meglio, lo vede come un uomo spasmodicamente dipendente dall’opinione altrui. Quella forma e quel giudizio sono tutto per lui. È indubbiamente una persona per nulla spregevole e anzi con un corretto senso della giustizia. Insomma è un onesto uomo medio, dotato quanto basta per figurare a livello buono nella società che si raccoglie intorno ai gradi alti della gerarchia militare e occasionalmente intorno a un principe reale. All’inizio del romanzo lo vediamo intento a corteggiare la vedova Josephine von Carayon; bella e più anziana di lui (ha trentasette anni), la signora ha una figlia, Victoire, deturpata dal vaiolo. Coloro che Schach frequenta parlano di un prossimo matrimonio fra questi e la vedova. Accade presto che i tre (madre, figlia, Schach) e una quarta persona facciano una gita in comune, in occasione della quale Victoire spera che Schach si dichiari alla madre e che così il corteggiamento abbia una sanzione ufficiale e definitiva. Il lettore però si accorge presto che Schach fa sì la corte alla bella madre però si intende molto meglio con la brutta figlia; tuttavia si vergogna di farsi vedere in pubblico in compagnia di quest’ultima, che se ne accorge e ne resta ferita. In occasione della gita Schach non si dichiara. Qualche tempo dopo Schach si trova in una compagnia convocata dal principe, da Schach ammirato anche se ne condanna la condotta non consona alle sue idee morali e soprattutto (il che è ancor peggio) praticata senza rispettare le convenzioni. Il discorso viene a toccare anche la Carayon e sua figlia, che il principe aveva conosciuto quando era un’incantevole quindicenne; Schach lo mette al corrente della trasformazione causata dal vaiolo. Il principe porta allora il discorso sulle varie specie di bellezza, soffermandosi su quella che chiama beauté du diable e che si attaglierebbe appunto a Victoire: è qualcosa che si basa «su di un elemento interiore, e l’elemento interiore che decide nel nostro caso è l’energia, il fuoco, la passione». Queste parole risulteranno fatali per Schach. Qualche giorno dopo egli si trova in compagnia di Victoire, la quale gli dichiara che uso fa della propria bruttezza: lei si sente libera poiché si sente di fare ciò di cui le sue coetanee hanno paura. Schach, sinceramente ammirato, trova che gli sia caduta come una benda dagli occhi: «Povera legge della forma e del colore!» dichiara. «Ciò che vale è soltanto 378 quest’unico eterno principio: che l’anima si crea il corpo, lo illumina e lo trasfigura.» Schach dichiara a Victoire di esserne innamorato. Presto dovrà rimpiangere il suo passo perché Victoire rimane incinta e Schach ha orrore di sposarla. Fra Josephine e Schach si svolge allora il seguente colloquio: «[...] Victoire mi ha pregata di tacere di tutto, di non svelare nulla, neanche a lei, e di non pretendere nulla. Come espiazione per una mezza colpa (e calcolo per eccesso, quando parlo di una mezza colpa) vuole sopportare l’intero castigo, anche di fronte al mondo e, con quel tratto romantico che le è tipico, sulla sua infelicità vuole costruirsi una felicità. Si compiace di un sublime sentimento da vittima, di un dolce languire per l’uomo che ama e per la creatura che amerà. Ma per quanto io sia debole nel mio amore per Victoire, pure non lo sono abbastanza per prestarmi a questa commedia della generosità. Appartengo alla società, adempio le sue condizioni, mi sottometto alle sue leggi; sono stata educata a farlo e non ho voglia di sacrificare la mia posizione sociale per un capriccio di rinuncia della mia unica, amata figlia. In altri termini, non ho voglia di rinchiudermi in un convento o di fare lo stilita lontano dalle cose terrene, neanche per amore di Victoire. E dunque devo esigere che sia legittimato ciò che è avvenuto. Era questo che avevo da dirle, signor capitano.» Schach, che nel frattempo aveva avuto occasione di riprendere il controllo di sé, replicò che sapeva bene che ogni cosa nella vita ha le sue naturali conseguenze, e non intendeva sottrarsi a tali conseguenze. [...] Tutto ciò fu detto con grande garbo e cortesia, ma pure, al tempo stesso, con una notevole freddezza. La signora von Carayon lo avvertì in un modo che non le fece solo male, ma la ferì davvero; quella che aveva udito non era la lingua dell’amore, né quella della colpa, e quando Schach tacque elle replicò tagliente: «Le sono molto grata per le sue parole, signor von Schach, in maniera del tutto particolare anche per ciò che di esse si riferisce alla mia persona. Che il suo “sì” avrebbe potuto suonare più franco e spontaneo, nel suo cuore lei lo sente certamente. Ma che importa? Mi basta il “sì”. Di che cosa sono poi assetata, in fondo? Di una cerimonia in Duomo e di una festa di gala. [...] e poi, [...] le do carte blanche, sarà di nuovo libero, libero come gli uccelli nel cielo, di fare e non fare, di odiare e di amare, perché sarà semplicemente accaduto ciò che doveva accadere». Ma immediatamente comincia lo scherno; Schach ne ha tanta più paura in quanto egli stesso ha il terrore della vita che comunque si immagina di dover condurre accanto a Victoire, costretto a vivere in campagna, dedito all’agricoltura, alla ristrettezza dell’ambiente, tagliato fuori dalla frequentazione della corte. Dopo un tentativo di fuga reso vano da un intervento del re in persona, Schach sposa Victoire, suicidandosi immediatamente dopo le nozze. Un personaggio commenta: Schach è perito a causa del suo amore per l’apparenza, e per la stessa causa andremo a fondo tutti. Poco tempo dopo la Prussia subiva la disfatta di Jena. Questo è un esempio di conformismo sociale all’interno della nobiltà. Ma 379 nel mondo borghese le cose non vanno meglio; Wilhelm Raabe ha avuto sensibilità per questo problema, trattandone in romanzi nei quali chi non si conforma in tutto alla pubblica opinione viene spinto ai margini (Abu Telfan oder Die Heimkehr vom Mondgebirge - Abu Telfan ovvero Il ritorno dalla montagna lunare -, 1867) oppure chi è già in partenza non completamente integrato viene bollato alla prima occasione con tutti i sospetti di infamia. Insomma: in questi scrittori il tema del controllo sociale è un tema rilevante. VII, 5. La sessualità Anche per la letteratura realista le camere da letto debbono restare chiuse; gli amori avvengono fra un capitolo e l’altro, oppure negli spazi bianchi. Vi si allude, ma quando lo si fa si tratta in genere di amori peccaminosi o comunque condannati. In Problematische Naturen Spielhagen presenta un barone che mette in atto un complesso apparato per sedurre una fanciulla borghese bella e pura: trova un gaglioffo che le inventa un’eroica morte del padre alla Beresina (la fanciulla è francese) spacciandosi per testimone oculare e ingaggia un’attriciucola cui fa recitare la parte di una vecchia zia che deve dimostrarsi disposta all’unione; poi, dopo che l’ha sedotta e messa incinta, torna a poco a poco alla sua vita dissoluta e violenta, trattandola «come una cagna». In generale una delle accuse rivolte ai nobili è di essere libertini senza scrupoli. Ma basta essere personaggi negativi perché una delle caratteristiche messe in campo sia la lussuria cinica e smodata; è il caso di Moses Freudenstein nello Hungerpastor. Nello Stechlin (e qui siamo a ben altro livello) Melusine sposa un conte Grimaldi e parte in viaggio di nozze per l’Italia; il percorso viene fatto in treno e il treno attraversa troppe gallerie; all’uscita della più lunga, racconta Melusine, «seppi a che vita squallida andavo incontro»: il marito ha sbrigativamente anticipato in galleria la notte di nozze. Ma la sessualità sembra fatta per complicare le cose (o meglio: è una sessualità tortuosa). Torniamo allo Hungerpastor: Freudenstein è ebreo e una delle accuse preferite dagli antisemiti è che gli ebrei sono incapaci d’amore e capaci solo di lussuria. Ciò lascerà traccia anche in quel contorto capolavoro che è il Parsifal (1882) di Wagner: la seduttrice Kundry è un ebreo errante al femminile, maledetta perché, assistendo a suo tempo alla crocifissione di Cristo, ha riso. Agli ordini del rinnegato e castrato Klingsor, Kundry seduce i cavalieri del Graal e li riduce in schiavitù; solo con Parsifal non riesce perché il suo bacio fa sentire a quest’ultimo quale perdizione ci sia nella lussuria. Alla fine Kundry si converte, si lascia battezzare e immediatamente dopo muore, evitando di creare imbarazzi quale ebrea convertita; del resto per Wagner era dovere dell’ebreo morire come individuo e con questa argomentazione cercò di spingere al battesimo il diretto380 re d’orchestra (ebreo, appunto) che per primo diresse il Parsifal. Ma nell’humus stercorario di questo antisemitismo affondano le radici concezioni ben più interessanti e valide: mentre rappresenta la lussuria, Kundry è anche colei che sa cose profonde sull’amore e in letteratura e in musica uno dei primissimi esempi forse addirittura il primo in assoluto - di condizionamento amoroso del maschio attraverso il legame con l’immagine materna. Kundry impersona anche una storia della natura dalla concezione tutt’altro che futile; una natura che si presenta all’inizio cieca, irrigidita, non ancora pervenuta alla coscienza; quindi si desta a un primo grado di vita, rozza e animalesca: in questa fase essa ha una funzione positiva, però solo nei confronti di quanto non è ancora arrivato al concetto. A questo punto la natura può procedere verso il concetto oppure seguire la sorte di una volontà fuorviata, aumentando il sapere ma solo al servizio degli egoismi da soddisfare. La sconfitta dell’egoismo, il rifiuto di servire ancora la schopenhaueriana volontà porta alla liberazione della natura. Klingsor e Kundry sono insomma due estremi: castrato lui, lussuriosa volontà egoistica lei; si tratterebbe di ristabilire l’equilibrio, ma a questo punto Wagner si sposta sul piano della rigenerazione del cristianesimo, su cui non lo seguiamo perché ci porterebbe a tutt’altro argomento. Il culmine della sessualità contorta verrà raggiunto da Leopold von SacherMasoch (1836-1895; è dal suo nome che Richard von Krafft-Ebing in Psychopathia sexualis, 1886, derivò il termine di masochismo). Suo capolavoro è considerata la raccolta Galizische Geschichten (Storie della Galizia, 1877-81), nelle quali (per l’aspetto che ci riguarda) compaiono uomini innamorati di donne bellissime e crudelissime, alle quali confessano che da loro accetterebbero tutto, compreso tormenti e morte, assicurando che nell’attimo della morte seguiterebbero a professare il loro amore. Le donne non se lo fanno ripetere due volte ed eseguono, godendo come Pasque; di sessualità come solitamente l’intendiamo non si vede nulla di nulla: al massimo qualche bacio. Sacher-Masoch era rappresentativo di un’epoca. L’unica novella sopravvissuta di uno scrittore a suo tempo celebrato, L’Arrabbiata (1854) di Paul Heyse (1830-1914), si muove in analogo orizzonte. Una ragazza, Lauretta (la vicenda è ambientata fra Sorrento e Capri), non vuol amare nessuno perché da piccola assisteva alle strane scene fra padre e madre: il padre picchiava la madre fino a farla cadere a terra, per poi prenderla fra le braccia e soffocarla di baci. Così Lauretta si rifiuta ad Antonino e quando questi, durante un viaggio in barca, la prende fra le braccia, gli morde una mano a sangue, e tanto gliene fa uscire che la barca sembra navigare nel sangue. Nella notte, poi, lei lo visita nella sua capanna e quando Antonino, tutto compreso del proprio torto, vuol mandarla via, Lauretta lo invoca affinché la prenda a pugni e a calci e faccia di lei quel che vuole, purché non la mandi via. Ma non è solo su questo versante che la sessualità si dimostra problematica, è anche su quello opposto della castità. Hans Unwirrsch, l’opposto di Moses Freudenstein, è talmente casto e puro da essere disturbato da alcune stampe mitologiche in cui le figu381 re femminili non hanno un’adeguata copertura di veli; Parsifal, poi, non sa nemmeno com’è fatta una donna, e pare che seguiti a ignorarlo fino alla fine della sua vicenda. Ci sono anche complicazioni di altro genere: in Problematische Naturen la fa
Scarica