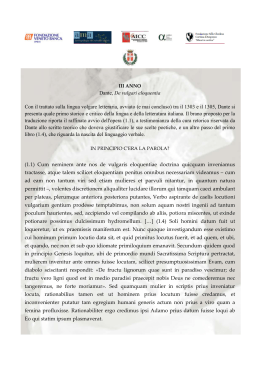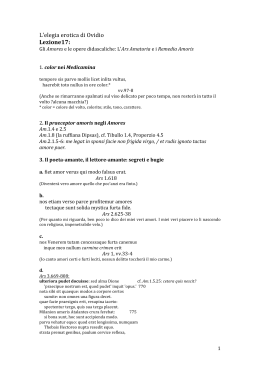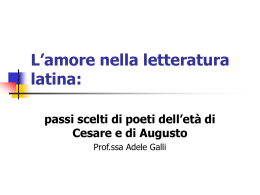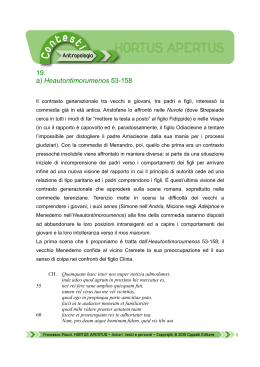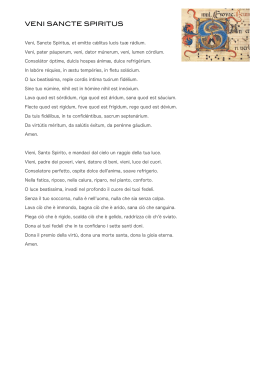Testi allegati al corso (file non completo aggiornato al 18 marzo 2010): 1) Erasmo da Rotterdam, Lettera dedicatoria dell’Elogio della follia da Erasmo da Rotterdam al suo Tommaso Moro Alcuni giorni fa, tornando dall'Italia in Inghilterra, per non sprecare in chiacchiere banali il tempo che dovevo passare a cavallo, preferii riflettere un poco sui nostri studi comuni e godere del ricordo degli amici tanto dotti e cari, che avevo lasciato qui. Fra i primi che mi sono tornati alla mente c'eri tu, Moro carissimo. Anche da lontano il tuo ricordo aveva il medesimo fascino che esercitava, nella consueta intimità, la tua presenza che è stata, te lo giuro, la cosa più bella della mia vita. Visto, dunque, che ritenevo di dover fare ad ogni costo qualcosa, e che il momento non sembrava adatto a una meditazione seria, mi venne in mente di tessere un elogio scherzoso della Follia. "Ma quale capriccio di Pallade - ti chiederai - ti ha ispirato un'idea del genere?" In primo luogo, il tuo nome di famiglia, tanto vicino al termine morìa, quanto tu sei lontano dalla follia. E ne sei lontano a parere di tutti. Immaginavo inoltre che la mia trovata scherzosa sarebbe piaciuta soprattutto a te, che di solito ti diletti in questo genere scherzi, non privi, mi sembra, di dottrina e di sale, perché nella vita di tutti i giorni fai in qualche modo la parte di Democrito. Sebbene, infatti, per singolare acume d'ingegno tu sia tanto lontano dal volgo, con la tua incredibile benevolenza e cordialità puoi trattare familiarmente con uomini d'ogni genere, traendone anche godimento. Quindi, non solo accoglierai di buon grado questo mio modesto esercizio retorico, per ricordo del tuo amico, ma anche lo prenderai sotto la tua protezione; dedicato a te, non mi appartiene più: è tuo. È probabile, infatti, che non mancheranno voci rissose di calunniatori ad accusare i miei scherzi, ora di una futilità sconveniente per un teologo, ora di un tono troppo pungente per la mansuetudine cristiana; e grideranno che prendo a modello la commedia antica e Luciano, mordendo tutto senza lasciare scampo. Vorrei però che quanti si sentono offesi dalla scherzosa levità del mio tema, si rendessero conto che non sono l'inventore del genere, e che già nel passato molti grandi autori hanno fatto lo stesso. Tanti secoli fa, Omero cantò per scherzo "la guerra dei topi con le rane", Virgilio la zanzara e la focaccia, Ovidio la noce. Policrate incorrendo nelle critiche di Ippocrate fece l'elogio di Busiride, Glaucone quello dell'ingiustizia, Favorino di Tersite, della febbre quartana, Sinesio della calvizie, Luciano della mosca e dell'arte del parassita. Sono scherzi l'apoteosi di Claudio scritta da Seneca, il dialogo fra Grillo e Ulisse di Plutarco, l'asino di Luciano e di Apuleio, e il testamento - di cui ignoro l'autore - del porcello Grunnio Corocotta menzionato anche da san Girolamo. Lasciamo perciò che certa gente, se crede, vada fantasticando che, per svago, a volte, ho giocato a scacchi, o, se preferisce, che sono andato a cavallo di un lungo bastone. Certo, è una bella ingiustizia concedere a ogni genere di vita i suoi svaghi, e non consentirne proprio nessuno ai letterari, soprattutto poi quando gli scherzi portano a cose serie, e gli argomenti giocosi sono trattati in modo che un lettore non del tutto privo di senno può trarne maggior profitto che non da tante austere e pompose trattazioni. Come quando con mucchi di parole si tessono le lodi della retorica o della filosofia, o si fa l'elogio di un principe, o si esorta a fare la guerra ai Turchi, mentre qualcuno predice il futuro, o va formulando questioncelle di lana caprina. In realtà, come niente è più frivolo che trattare in modo frivolo cose serie, così niente è più gradevole che trattare argomenti leggeri in modo da dare l'impressione di non avere affatto scherzato. Di me giudicheranno gli altri; eppure se la presunzione non mi accieca completamente, ho fatto sì l'elogio della Follia, ma non certo da folle. Quanto poi all'accusa di spirito mordace, rispondo che si è sempre concessa agli scrittori la libertà d'esercitare impunemente la satira sul comune comportamento degli uomini, purché non diventasse attacco rabbioso. Per questo mi meraviglia tanto di più la delicatezza delle orecchie d'oggi, che riescono a sopportare ormai solo titoli solenni. In taluni, anzi, trovi una religione così distorta che passano sopra alle più gravi offese a Cristo prima che alla minima battuta ironica sul conto di un pontefice o di un principe, soprattutto poi se entrano in gioco i loro privati interessi. D'altra parte, uno che critica il modo di vivere degli uomini così da evitare del tutto ogni accusa personale, si presenta come uno che morde, o non, piuttosto, come chi ammaestra ed educa? E, di grazia, non investo anche me stesso con tanti appellativi poco lusinghieri? Aggiungi che, chi non risparmia le sue critiche a nessun genere di uomini, dimostra di non avercela con nessun uomo, ma di detestare tutti i vizi. Se, dunque, ci sarà qualcuno che si lamenterà d'essere offeso, sarà segno di cattiva coscienza o per lo meno di paura. Satire di questo genere, e molto più libere e mordenti, troviamo in san Girolamo, che talvolta fece anche i nomi. Io non solo non ho mai fatto nomi, ma ho adottato un tono 1 così misurato che qualunque lettore avveduto si renderà conto che mi sono proposto la piacevolezza piuttosto che l'offesa. Né ho seguito l'esempio di Giovenale: non ho mai smosso l'oscuro fondo delle scelleratezze; ho cercato di colpire quanto è risibile piuttosto che le turpitudini. Se poi c'è ancora qualcuno che nemmeno così è contento, ricordi almeno questo: che è bello essere vituperati dalla Follia e che avendola introdotta a parlare, dovevo rimanere fedele al personaggio. Ma perché dire queste cose a te, avvocato così straordinario da difendere in modo egregio anche cause non egregie? Addio, eloquentissimo Moro, e difendi con zelo la tua Morìa. dalla campagna, 9 giugno 1508 ERASMVS ROT. THOMAE MORO SVO S. D. Superioribus diebus cum me ex Italia in Angliam recepissem, ne totum hoc tempus quo equo fuit insidendum amusois et illitteratis fabulis tereretur, malui mecum aliquoties uel de communibus studiis nostris aliquid agitare, uel amicorum, quos hic ut doctissimos ita et suauissimos reliqueram, recordatione frui. Inter hos tu, mi More, uel in primis occurrebas; cuius equidem absentis absens memoria non aliter frui solebam quam presentis presens consuetudine consueueram; qua dispeream si quid unquam in uita contigit mellitius. Ergo quoniam omnino aliquid agendum duxi, et id tempus ad seriam commentationem parum uidebatur accommodatum, uisum est Moriæ Encomium ludere. Que Pallas istuc tibi misit in mentem? inquies. Primum admonuit me Mori cognomen tibi gentile, quod tam ad Moriæ uocabulum accedit quam es ipse a re alienus; es autem uel omnium suffragiis alienissimus. Deinde suspicabar hunc ingenii nostri lusum tibi precipue probatum iri, propterea quod soleas huius generis iocis, hoc est nec indoctis, ni fallor, nec usquequaque insulsis, impendio delectari, et omnino in communi mortalium uita Democritum quendam agere. Quanquam tu quidem, ut pro singulari quadam ingenii tui perspicacitate longe lateque a uulgo dissentire soles, ita pro incredibili morum suauitate facilitateque cum omnibus omnium horarum hominem agere et potes et gaudes. Hanc igitur declamatiunculam non solum lubens accipies ceu mnemosunon tui sodalis, uerum etiam tuendam suscipies, utpote tibi dicatam iamque tuam non meam. Etenim non deerunt fortasse uitilitigatores, qui calum nientur partim leuiores esse nugas quam ut theologum deceant, partim mordaciores quam ut Christiane conueniant modestie; nosque clamitabunt ueterem comediam aut Lucianum quempiam referre atque omnia mordicus arripere. Verum quos argumenti leuitas et ludicrum offendit, cogitent uelim non meum hoc exemplum esse, sed idem iam olim a magnis auctoribus factitatum; cum ante tot secula Batrachomuomachian luserit Homerus, Maro Culicem et Moretum, Nucem Ouidius; cum Busyriden laudarit Polycrates et huius castigator Isocrates, iniustitiam Glauco, Thersiten et quartanam febrim Fauorinus, caluitiem Synesius, muscam et parasiticam Lucianus; cum Seneca Claudii luserit apotheôsin, Plutarchus Grylli cum Ulysse dialogum, Lucianus et Apuleius Asinum, et nescio quis Grunnii Coro cottæ porcelli testamentum, cuius et diuus meminit Hieronymus Proinde, si uidebitur, fingant isti me laterunculis in terim animi causa lusisse, aut si malint equitasse in arundine longa. Nam que tandem est iniquitas, cum omni uite insti tuto suos lusus concedamus, studiis nullum omnino lusum permittere, maxime si nuge seria ducant, atque ita tractentur ludicra ut ex his aliquanto plus frugis referat lector non omnino naris obese, quam ex quorundam tetricis ac splendidis argumentis? ueluti cum alius diu consarcinata oratione rhetoricen aut philosophiam laudat, alius principis alicuius laudes describit, alius ad bellum aduersus Turcas mouendum adhortatur, alius futura predicit. alius nouas de lana caprina comminiscitur questiunculas. Vt enim nihil nugacius quam seria nugatorie tractare, ita nihil festiuius quam ita tractare nugas ut nihil minus quam nugatus fuisse uidearis. De me quidem aliorum erit iudicium; tamet si, nisi plane me fallit philautia, Stulticiam laudauimus, sed non omnino stulte. Iam uero ut de mordacitatis cauillatione respondeam, semper hec ingeniis libertas permissa fuit, ut in communem hominum uitam salibus luderent impune, modo ne licentia exiret in rabiem. Quo magis admiror his temporibus aurium delicias que nihil iam fere nisi solennes titulos ferre possunt. Porro nonnullos adeo prepostere religiosos uideas, ut uel grauissima in Christum conuicia ferant citius quam pontificem aut principem leuissimo ioco aspergi, presertim si quid pros ta alphita id est ad questum, attinet. At enim qui uitas hominum ita taxat ut neminem omnino perstringat nominatim, queso utrum is mordere uidetur an docere potius ac monere? Alioqui quot obsecro nominibus ipse me taxo? Preterea qui nullum hominum genus pretermittit, is nulli homini, uiciis omnibus iratus uidetur. Ergo si quis extiterit qui sese lesum clamabit, is aut conscientiam prodet suam aut certe metum. Lusit hoc in genere multo liberius ac mordacius diuus Hieronymus, ne nominibus quidem ali quoties parcens. Nos preterquam quod a nominibus in to tum abstinemus, ita preterea stilum temperauimus ut cordatus lector facile sit intellecturus 2 nos uoluptatem magis quam morsum quesisse. Neque enim ad Iuuenalis exemplum occultam illam scelerum sentinam usquam mouimus, et ridenda magis quam foeda recensere studuimus. Tum si quis est quem nec ista placare possunt, is saltem illud meminerit, pulchrum esse a Stulticia uituperari; quam cum loquentem fecerimus, decoro persone seruiendum fuit. Sed quid ego hec tibi, patrono tam singulari ut causas etiam non optimas optime tamen tueri possis? Vale, disertissime More, et Moriam tuam gnauiter defende. Ex Rure Quinto Idus Iunias, [AN. MDVII]. 2) Dante Alighieri, Convivio, Trattato primo. 1. Sì come dice lo Filosofo nel principio de la Prima Filosofia, tutti li uomini naturalmente desiderano di sapere. La ragione di che puote essere ed è che ciascuna cosa, da providenza di propria natura impinta è inclinabile a la sua propria perfezione; onde, acciò che la scienza è ultima perfezione de la nostra anima, ne la quale sta la nostra ultima felicitade, tutti naturalmente al suo desiderio semo subietti. 2. Veramente da questa nobilissima perfezione molti sono privati per diverse cagioni, che dentro a l'uomo e di fuori da esso lui rimovono da l'abito di scienza. 3. Dentro da l'uomo possono essere due difetti e impedi[men]ti: l'uno da la parte del corpo, l'altro da la parte de l'anima. Da la parte del corpo è quando le parti sono indebitamente disposte, sì che nulla ricevere può, sì come sono sordi e muti e loro simili. Da la parte de l'anima è quando la malizia vince in essa, sì che si fa seguitatrice di viziose delettazioni, ne le quali riceve tanto inganno che per quelle ogni cosa tiene a vile. 4. Di fuori da l'uomo possono essere similemente due cagioni intese, l'una de le quali è induttrice di necessitade, l'altra di pigrizia. La prima è la cura familiare e civile, la quale convenevolmente a sè tiene de li uomini lo maggior numero, sì che in ozio di speculazione esser non possono. L'altra è lo difetto del luogo dove la persona è nata e nutrita, che tal ora sarà da ogni Studio non solamente privato, ma da gente studiosa lontano. 5. Le due di queste cagioni, cioè la prima da la parte [di dentro e la prima da la parte] di fuori, non sono da vituperare, ma da escusare e di perdono degne; le due altre, avvegna che l'una più, sono degne di biasimo e d'abominazione. 6. Manifestamente adunque può vedere chi bene considera, che pochi rimangono quelli che a l'abito da tutti desiderato possano pervenire, e innumerabili quasi sono li 'mpediti che di questo cibo sempre vivono affamati. 7. Oh beati quelli pochi che seggiono a quella mensa dove lo pane de li angeli si manuca! e miseri quelli che con le pecore hanno comune cibo! 8. Ma però che ciascuno uomo a ciascuno uomo naturalmente è amico, e ciascuno amico si duole del difetto di colui ch'elli ama, coloro che a così alta mensa sono cibati non sanza misericordia sono inver di quelli che in bestiale pastura veggiono erba e ghiande sen gire mangiando. 9. E acciò che misericordia è madre di beneficio, sempre liberalmente coloro che sanno porgono de la loro buona ricchezza a li veri poveri, e sono quasi fonte vivo, de la cui acqua si refrigera la naturale sete che di sopra è nominata. 10. E io adunque, che non seggio a la beata mensa, ma, fuggito de la pastura del vulgo, a' piedi di coloro che seggiono ricolgo di quello che da loro cade, e conosco la misera vita di quelli che dietro m'ho lasciati, per la dolcezza ch'io sento in quello che a poco a poco ricolgo, misericordievolmente mosso, non me dimenticando, per li miseri alcuna cosa ho riservata, la quale a li occhi loro, già è più tempo, ho dimostrata; e in ciò li ho fatti maggiormente vogliosi. 11. Per che ora volendo loro apparecchiare, intendo fare un generale convivio di ciò ch'i' ho loro mostrato, e di quello pane ch'è mestiere a così fatta vivanda, sanza lo quale da loro non potrebbe esser mangiata. 12. E questo [è quello] convivio, di quello pane degno, con tale vivanda qual io intendo indarno [non] essere ministrata. E però ad esso non s'assetti alcuno male de' suoi organi disposto, però che nè denti nè lingua ha nè palato; nè alcuno settatore di vizii, perchè lo stomaco suo è pieno d'omori venenosi contrarii, sì che mai vivanda non terrebbe. 13. Ma vegna qua qualunque è [per cura] familiare o civile ne la umana fame rimaso, e ad una mensa con li altri simili impediti s'assetti; e a li loro piedi si pongano tutti quelli che per pigrizia si sono stati, che non 3 sono degni di più alto sedere: e quelli e questi prendano la mia vivanda col pane, che la far[à] loro e gustare e patire. 14. La vivanda di questo convivio sarà di quattordici maniere ordinata, cioè quattordici canzoni sì d'amor come di vertù materiate, le quali sanza lo presente pane aveano d'alcuna oscuritade ombra, sì che a molti loro bellezza più che loro bontade era in grado. 15. Ma questo pane, cioè la presente disposizione, sarà la luce la quale ogni colore di loro sentenza farà parvente. 16. E se ne la presente opera, la quale è Convivio nominata e vo' che sia, più virilmente si trattasse che ne la Vita Nuova, non intendo però a quella in parte alcuna derogare, ma maggiormente giovare per questa quella; veggendo sì come ragionevolmente quella fervida e passionata, questa temperata e virile esser conviene. 17. Chè altro si conviene e dire e operare ad una etade che ad altra; perchè certi costumi sono idonei e laudabili ad una etade che sono sconci e biasimevoli ad altra, sì come di sotto, nel quarto trattato di questo libro, sarà propria ragione mostrata. E io in quella dinanzi, a l'entrata de la mia gioventute parlai, e in questa dipoi, quella già trapassata. 18. E con ciò sia cosa che la vera intenzione mia fosse altra che quella che di fuori mostrano le canzoni predette, per allegorica esposizione quelle intendo mostrare, appresso la litterale istoria ragionata; sì che l'una ragione e l'altra darà sapore a coloro che a questa cena sono convitati. 19. Li quali priego tutti che se lo convivio non fosse tanto splendido quanto conviene a la sua grida, che non al mio volere ma a la mia facultade imputino ogni difetto; però che la mia voglia di compita e cara liberalitate è qui seguace. 3) Giovanni Boccaccio, Lettera a Iacopo Pizzinga, 1371 Propositum igitur tuum et laborem egregium laudavi, et summe laudo, et laudabo, dum vixero; et in spem venio atque credulitatem, Deum Italico nomini misertum, dum video eum e gremio suae largitatis in Italorum pectora effundere animas ab antiquis non differentes, avidas scilicet, non rapina, vel sanguine, non fraude, vel violentia, non ambitione, vel decipulis sibi honores exquirere, sed laudabili exercitio, duce Poesi, nomen praetendere in aevum longiquum, conarique, ut possint viventes adhuc volitare per ora vivorum, et a corporea mole solutas posteritati mirabiles apparere. A quibus etsi non integrum deperditi luminis Italici restituatur columen, saltem a quantumcumque parva scintillula optantium spes erigitur in fulgidam posteritatem, et potissime, dum ab uno videmus in numerum deveniri. Fuit enim illi continue spiritus aliqualis, tremulus tamen et semivivus, potiusquam virtute aliqua validus, ut in Catone, Prospero, Pamphilio et Arrighetto Florentino presbytero, terminus quorum sunt opuscula parva, nec ullam antiquatis dulcedinem sapientia. Verum aevo nostro ampliores a Coelo venere viri, si satis adverto, quibus cum sint ingentes animi, totis viribus pressam relevare, et ab exilio in pristinas revocare sedes mens est: nec frustra. Videmus autem, nec te legisse pigebit, ante alios nota dignos, seu vidisse potuimus, celebrem Virum, et in Philosophiae laribus versatum Dantem Allegherii nostrum, omissum a multis retroactis saeculis fontem, laticesque mellifluos bibisse, nec ea tamen, qua veteres, via, sed per diverticula quaedam omnino insueta maioribus non absque labore anxio exquirentem, ac primum in astra levatum, montem superantem, eoque devenisse, quo coeperat, et semisopitas excivisse sorores, et in citharam traxisse Phoebum, et eas in maternum cogere cantum ausum. Non plebeium, aut rusticanum, ut nonnulli voluere, confecit, quin imo artificioso schemate sensu latiorem fecit, quam cortice. Tandem, quod equidem deflendum, incliti voluminis superato labore, immatura morte merito decori subtractus, inornatus abiit, hoc, praeter sacrum Poema, tradito, ut, post divulgatum diu pressum poesis nomen, possent, qui vellent, a poeta novo sumere quid poesis, et circa quod eius versaretur officium. Post hunc vero aeque Florentinus civis, vir inclitus Franciscus Petrarca, praeceptor meus, neglectis quorumdam principiis, ut iam dictum est, vix poeticum limen attingentibus, vetus iter arripere orsus est tanta pectoris fortitudine, tantoque mentis ardore, atque ingenii perspicacitate, ut nulla illum sistere impedimenta quiverint, vel iteneris terrere superbia, quin imo, amotis vepribus arbustisque, quibus mortalium negligentia obsitum comperit, restauratisque aggere firmo proluviis semesis rupibus, sibi, post eum et ascendere volentibus viam aperuit. Inde, Heliconio fonte limo iuncoque palustri purgato, et undis in pristinam claritatem revocatis, antroque Castalio silvestrium rumorum contextu iam clauso, reserato, ac ab sentibus Laureo mundato nemore, et Apolline in sede veteri restituto, Pieridisque iam rusticitate sordentibus, in antiquum redactis decus, in extremos usque vertices 4 Parnasi conscendit, et ex Daphnis frondibus serto composito, et suis temporibus addito, ab annis forsan mille vel amplius invisum ostendit Quiritibus, applaudente Senatu, et rugientes rubigine cardines veteris Capitolii in adversam partem ire coegit, et maxima Romanorum laetitia annales eorum insolito signavit triumpho. O spectabile decus! O facinus memorabile! (Giovanni Boccaccio, Lettera a Iacopo Pizzinga, 1371, in Giovanni Boccaccio, Tutte le opere, a cura di V. Branca, I, A. Mondadori, Milano 1992, pp. 664-668). (TRADUZIONE ITALIANA) Dunque ho lodato il tuo proposito e la tua egregia fatica, sommamente li lodo e li loderò finché vivrò; e m’induco a credere che Dio stia commiserando il nome italiano, mentre lo vedo dal grembo della sua generosità infondere nel petto degli Italiani anime non diverse da quelle degli antichi, avide beninteso, non di rapina, sangue, frode, violenza, ambizione, e che cercano di ottenere onori non con tranelli, ma con lodevole impegno, sotto la guida della Poesia tentano di prolungare il nome in lontane età e, per poter vivere ancora, di volare per le bocche degli uomini e, libere dalla corporeità, sembrare mirabili agli occhi della posterità. Anche se da loro non viene restituita integralmente la perduta gloria italiana, per lo meno da una sia pur piccola scintilla la speranza dei desiderosi si eleva a fulgida posterità, soprattutto vedendo da uno solo suscitarsene molti. In Italia, infatti, ci fu sempre un certo spirito, quantunque tremulo e semivivo, piuttosto che vigoroso per un qualche valore, come in Catone, Prospero, Panfilo e Arrighetto prete fiorentino, limite dei quali sono dei piccoli opuscoli senza sapore di un’antica dolcezza. In verità nel nostro secolo sono venuti dal Cielo uomini più illustri, a ben vedere, che, con la loro grandezza d’animo, hanno intenzione di risollevare l’oppressa con tutte le forze e ricondurla dall’esilio alle primitive sedi, e non invano. Vediamo inoltre, e non ti dispiacerà leggerlo, prima degli altri degni di nota, o abbiamo potuto vedere, che il celebre uomo, il nostro Dante Alighieri, versato anche nella filosofia, aver bevuto alla fonte abbandonata dei secoli passati latte mellifluo, ma non, tuttavia, esplorare le vie degli antichi, bensì, non senza penosa fatica, sentieri del tutto impraticati e levarsi per primo al Cielo, superare il monte e giunto al punto dove tendeva, ridestando le sempiassopite sorelle, sollecitò Febo a suonare la cetra e osò costringere quelle a cantare nella lingua materna. Non realizzò un’opera volgare o rustica, come alcuni hanno voluto, che anzi, con artificiose metafore la rese più grande nel senso che nelle parole. Tuttavia, cosa di cui bisogna certamente dolersi, superata la fatica dell’illustre opera, sottratto da una prematura morte alla meritata gloria, se ne andò senza onore, lasciando, oltre al sacro poema, il fatto che, dopo aver divulgato il nome della poesia a lungo oppresso, coloro che lo volevano, potessero apprendere dal nuovo poeta che cosa fosse la poesia e cosa il versificare. Dopo di lui sempre un cittadino fiorentino, l’illustre Francesco Petrarca, mio maestro, trascurati i principi di alcuni che, come si è detto, a malapena sono meritevoli del nome di poeti, cominciò a intraprendere l’antica strada con tanta forza d’animo, ardore intellettuale e perspicacia d’ingegno che nessun impedimento lo fece desistere, né lo spaventò l’asprezza della via, anzi, rimossi roveti e arbusti, con cui la negligenza umana l’aveva ricoperta, e restaurati con fermo argine le rupi corrose dalle piogge, aprì la strada a se stesso e a chi, dopo di lui, volesse salire. Quindi, purificati la fonte eliconia dal limo e dal giunco palustre, riportate le acque alla primitiva limpidezza, dischiuso l’antro Castalio, già serrato dalla trama dei rami silvestri, ripulito il bosco Laureo dai pruni e riportato Apollo all’antica sede e ricondotte le Pieridi ormai contaminate di squallida rusticità al primitivo decoro, salì fino alla vetta del Parnaso e, composta una corona d’alloro e postasela sul capo, la mostrò, sconosciuta da mille anni e forse più, ai Romani, con il plauso del Senato, e costrinse anche gli arrugginiti cardini dell’antico Campidoglio a riaprirsi, e con somma letizia dei Romani insignì i loro annali di un insolito trionfo. O mirabile decoro! O memorabile impresa! (Traduzione di Giovanna Fratini) 4) Coluccio Salutati, Lettera a Bartolomeo Oliari, agosto 1395 Hec ad dicendi formam. Nunc ad illa que scribis veniam; quorum duplex est ratio. Una quidem, qua nimis in meis laudibus exundas; altera quod postules ad eterne fame consecrationem me colligere de multarum epistolarum mearum pelago digniores, ut hac memoria eternaliter vivam et dictatoribus, quibus me imitandum proposuero, multum afferam adiumenti. Scribis igitur, ut ad primum veniam, te gaudere, quod quotiens de dictatoribus nostri temporis inter loquendum, ut solet, collatio fit, mox cunctis omnium consensu preferar; nec solum eruditos nostri 5 temporis, sed etiam inclytum illud eloquentie sidus, Cassiodorum, senatorium virum regumque Theodorici nepotumque suorum a secretis, cuius opera merito miramur et colimus, sive publicas dictet epistolas sive domesticos privatis litteris alloquatur, sive de anima subtilissime disputet sive de amicicia facundissime tractet, sive dulcissima translatione Tripartitam contexat hystoriam sive Psalmigraphi sensus altissimos perscrutetur; superasse dicar. In quibus quidem verbis tuis consuetam tibi requiro mentis perspicue claritatem. Nam, licet alios in me preferendo modernis error abducat, teque cecus amor, quo me prosequeris, sine dubitatione decipiat, unde est quod michi cedere tantum virum, quantum Cassiodorum fuisse cognoscimus, asseveras? Et quis antiquorum est, cuius dignus sim solvere calciamenta, cuique, quod ridiculum est, preferri debeam vel, quod moderatius est, equari? Tenet gradum suum insuperata vetustas et in campo remanet signis immobilibus atque fixis. Et quicquid sibi de subtilitate sophistica blandiatur modernitas, sapientia nos, crede michi, et eloquentia vincit; nec in aliquo videmus nostri temporis tantarum totque rerum esse noticiam, quot et quantarum fuisse decrevimus in antiquis. Floruit proculdubio seculum illud priscum omni studio litterarum et adeo in eloquentia valuit, quod non potuerit imitatrix quanvis et studiosa posteritas illam dicendi maiestatem et culmen eloquentie conservare. Mansit tamen in proximis successoribus similitudo quaedam et aliquale vestigium antiquitatis; sed, paulatim ab illa scribendi soliditate discedente posteritate, cum ipso temporis lapsu latenter primum decus illud effluxit, deinde manifestiore dissimilitudine ab eloquentie principe Cicerone discessum est. Fuerunt pauci tamen per tempora, qui adeo viderentur inter coevos emergere, quod ad illam attingere sublimitatem ab imperitioribus putarentur. Hec non michi credas velim, sed ipsos scriptores ante oculos tibi ponas. Et cum eius eloquentie summitas sine controversia sit in Cicerone et Ciceronis temporibus statuenda, quo seculo multi viri clarissimi floruerunt in facultate dicendi, considera parumper et ipsum eloquentie principem M. Tullium et illa dicendi lumina, que secum illo tunc temporis concurrerunt, et videbis longe magis hanc modernitatem ab illorum quolibet superari quam ipsos a Cicerone. Quem enim dabis, ut de oratorum eximio C. Iulio Cesare, L. Iulii filio, qui primus invasit imperium, et de eius successore Octaviano Augusto et aliis cesaribus, quibus proprium fuit in eloquentia cunctis vel, ut rectius loquar, multis antecellere, sileam [...]. Concurrerunt vel potius successerunt his temporibus Seneca Cordubensis, Valerius Maximus et hystoriae romane concinnator Titus Livius, tuus compatriota paduanus; de quibus quale sit faciendum iudicium, de primo M. Fabius Quintilianus, post C. Cesarem, Germanici filium, qui dicere consueverat ipsum arenam esse sine calce, libris Institutionum oratorie declaravit; de tuo vero concive Hyeronimus testis est, qui non dubitavit ipsum asserere lacteo eloquentie fonte manare; medius autem adeo gratus est, ut facile inter facundie principes numeretur, licet omnium consensu illa dicendi copia non redundet, nec ipse nec alii maiestatem attigerint Ciceronis. Nam quid de Cornelio Tacito referam, qui, licet eruditissimus foret, nedum proximos illos equare non potuit, sed a Livio, quem non sequendum solum hystorie serie, sed imitandum eloquentia sibi proposuit, longe discessit? Hoc idem licet de Tranquillo Suetonio, de Plinio Secundo, de Helio Spartiano, de Iulio Capitolino, de Helio Lampridio, de Iunio Vopisco, de Martiano Felici Capella, de Apuleio, de Macrobio et aliis pluribus affirmare; quorum scriptis percipitur quantum tractu temporis ornatus ille locutionis effloruit quantumque maiestas illa prisci sermonis, que cum Cicerone summum apicem tenuit, imminuta est. Et tamen usque in Theodosiorum et successorum proxima tempora, quibus Cassiodorus floruit, Ambrosius, Symmachus, Severinus, Hieronymus, Augustinus, Ennodius, Sidonius, Sulpitius Severus, et, qui prius viguit, eloquentissimus Firmianus, Orosius, Iulianus et his interiectus Ausonius et facundissimus Cyprianus et alii quamplures redivivam quodammodo facundiam reduxerunt; sive, quo verius loquar, continuatam in paucis unius ferme tractu seculi tenuerunt. Post quos tanta rei huius iactura facta est tantaque mutatio, ut Maronico versiculo liceat conqueri quod, Ex illo fluere ac retro sublapsa referri eloquentia visa sit; fracte vires, adversa dee mens. Inciderint enim licet Ivones, Bernardi, Hildeberti, Petri Blesenses, Petri Abaialardi, Riccardi de Pofhis, Iohannes Saberii et alii plures, qui sibi nimis de eloquentia blanditi sunt; non decet tamen ipsos priscis vel mediis illis dictatoribus comparare, a quibus tamen longe magis stilo quam temporibus discesserunt. Emerserunt parumper nostro seculo studia litterarum; et primus eloquentie cultor fuit conterraneus tuus Musattus Patavinus, fuit et Gerius Aretinus, maximus Plinii Secundi oratoris, qui alterius eiusdem nominis sororis nepos fuit, imitator; emerserunt et ista lumina florentina; ut summum vulgaris eloquentie decus et 6 nulli scientia vel ingenio comparandum qui nostris temporibus floruit, aut etiam cuipiam antiquorum, Dantem Alligherium, pratermittam; Petrarca scilicet et Bocaccius, quorum opera cuncta, ni fallor, posteritas celebrabit: qui tamen quantum ab illis priscis differant faculate dicendi nullum arbitror qui recte iudicare valeat ignorare. Et tu scribis iam michi cedere Cassiodorum, qui scio me, nedum non antiquorum cuipiam, sed ne modernis etiam preferendum? O quantum sentio, pater optime, quo sim in dictatorum numero recipiendus in me deficere; quot per dies singulos animadverto me reprehensibiliter ignorasse! Cumque, sicuti Cicero vult, professio bene dicendi hoc suscipere et polliceri videatur; ut omni de re, quecunque sit proposita, ornate copioseque dicatur, cum hoc, sicuti vides et sicuti ipse idem testatur Arpinas, nemo possit, ni fuerit omnium rerum magnarum atque artium scientiam consecutus; etenim, ut subdit, ex rerum cognitione florescat et redundet oportet oratio; que nisi sit ab oratore percepta et cognita, inanem quandam habet elocutionem et pene puerilem; cum, inquam, dictandi professio tot polliceatur, totque et tanta requirat, cur me non solum dictatoribus adnumeras, sed etiam anteponis? Quibus laudibus tuis excultissimi Symmaci verbis respondebo. Inquit enim ad quendam sibi de eloquentie commendationibus blandientem: pars epistole tue, que laudem michi assignavit, eloquii, sit licet nimis iocunda, minus tamen est vera. Et subiungendo prosequitur: non audeo dicere mentiris, sed desipis, cum hec de me predicas. Hec ille. Nam si ad solidum veritatis accedimus, illa prelatio, quam michi glorie ducis tibique delectationi semper esse testaris, omnis vana est et de falsa opinione concepta. Nec michi tamen, ut illi, iocunda est, sed, cum ruborem excitet, est suspecta. Scio nemini mortalium veram ex aliquo deberi laudem, quoniam, si qua bona fuerint, per nos ille spiritus operatur in nobis, qui bonorum omnium effector est. Sumus illius spiritus instrumenta: sibi debetur gloria, sibi laus. Nobis autem quod ab ipso, cum operatur in nobis et per nos, non deficimus, quod tamen et ipsum gratie sue donum est, commendatio deberi potest, qualis daretur cithare vel aliis musicis instrumentis, quibus optime dispositis et paratis, ingeniosus artifex perfectissime resonasset. Ergo ut cum eodem Symmacho super ista concludam: parce verbis lenocinantibus et fuco oblitis et ad gratiam comparatis. Et si me diligis, pater optime, recordare quod tuum est non blandiri, sed reprehendere, non occulere veritatem nec proferre mendacium, qui et clavium auctoritatem et predicande veritatis officium consecutus sis. Hec hactenus. (Coluccio Salutati, Lettera a Bartolomeo Oliari, cardinale padovano, 1 agosto 1395, in Coluccio Salutati, Epistolario, a cura di Francesco Novati, Roma 1896, vol. III, pp. 79-85). (TRADUZIONE ITALIANA) Questo per ciò che concerne la forma. Ora passiamo al contenuto della tua lettera, divisibile in due parti: una, in cui ti profondi in eccessive lodi nei miei confronti, l’altra, in cui chiedi, perché sia consacrato ad una eterna fama, che io raccolga, dalla massa delle mie epistole, le migliori, affiché io viva di fama eterna e dia un grande aiuto agli scrittori, a cui mi sia proposto come modello da imitare. Scrivi dunque, per venire alla prima parte, che ti rallegri del fatto che ogni volta che si parla dei maestri del nostro tempo e che si fa, come di consuetudine, un confronto, subito io venga preferito agli altri col consenso di tutti; e dicono che io abbia superato non solo gli eruditi del nostro tempo, ma anche quella fulgida stella dell’eloquenza che è Cassiodoro, uomo di stirpe senatoria e regale nonché segretario di Teodorico e dei suoi discendenti, la cui opera giustamente ammiriamo e veneriamo, sia che componga lettere pubbliche, sia che si rivolga con epistole private ai suoi familiari, sia che disputi sottilissimamente sull’anima, sia che tratti con grande facondia dell’amicizia, sia che unisca, con squisita abilità traduttoria l’Historia tripartita, sia che esamini a fondo gli altissimi significati di un salmista; in queste tue parole sento la mancanza della tua consueta notevole brillantezza mentale. Infatti, mentre nel preferirmi ai moderni è un errore a fuorviare gli altri, non è forse il cieco amore con cui mi descrivi a trarre in inganno te, onde l’affermazione che un uomo della grandezza di Cassiodoro sia inferiore a me? Chi c’è tra gli antichi, cui io sia degno di sciogliere le scarpe e a cui, quindi, cosa che è ridicola, io debba essere preferito o, più cautamente, essere uguagliato? L’insuperata antichità mantiene la sua posizione e rimane in campo con segni immobili e fissi, e qualunque cosa la modernità si racconti sulla sua sofistica acutezza, la sapienza e l’eloquenza degli antichi, credimi, ci sovrastano; né nella nostra epoca abbiamo notizia di tanti e tali ingegni, quanti abbiamo giudicato che ci sono stati nell’antichità. Senza dubbio il tempo antico brillò in ogni ambito di studi e fu così valente nel campo dell’eloquenza che la posterità, sebbene attenta imitatrice, non ha potuto mantenere quella grandezza oratoria; tuttavia negli 7 immediati successori rimase una qualche somiglianza, una qualche traccia dell’antichità; ma, a poco a poco, allontanandosi la posterità da quella solidità nello scrivere, assieme allo stesso scorrere del tempo quel decoro venne meno, dapprima invisibilmente, quindi con più manifesta dissomiglianza si allontanò dalla sublime eloquenza ciceroniana. Vi furono tuttavia nel corso dei tempi alcuni, pochi a dire il vero, che sembravano spiccare tra i contemporanei al punto che furono considerati da persone poco avvedute al livello della somma eloquenza ciceroniana. Vorrei che tu non credessi alle mie parole, ma ponessi davanti ai tuoi stessi occhi quegli scrittori. Ed essendo, senza controversia, il culmine dell’eloquenza in Cicerone e dovendolo collocare al tempo di Cicerone, in cui molti uomini illustrissimi brillarono per abilità oratoria, considera un po’ lo stesso maestro dell’eloquenza Marco Tullio e gli altri lumi che si incontrarono con lui in quell’epoca, e vedrai che questa modernità è superata da uno di quelli molto di più di quanto questi stessi non lo siano stati da Cicerone. Mi consentirai di tacere sull’esimio fra gli oratori, Caio Giulio Cesare, figlio di Lucio Giulio, che gettò le basi dell’impero, e sul suo successore Ottaviano Augusto nonché sugli altri cesari, che ebbero tutti la caratteristica, a dire il vero, di sovrastare molti in eloquenza [...]. Si incontrarono o, meglio, si succedettero in quell’epoca Seneca di Cordova, Valerio Massimo e il celebratore della storia romana Tito Livio, tuo concittadino padovano; per quanto riguarda il giudizio che si deve dare, sul primo M. Fabio Quintiliano, nella sua Institutio oratoria afferma che Caligola imperatore, figlio di Caio Germanico era solito dire che era sabbia senza calce; sul tuo concittadino c’è la testimonianza di Girolamo, che non dubitò che dichiarasse di derivare dalla fonte pura dell’eloquenza; il secondo, inoltre, fu così gradito da essere annoverato fra i padri dell’eloquenza, sebbene venga unanimemente considerato non ridondante di abilità oratoria e né lui né altri hanno raggiunto la maestà di Cicerone. E che potrei dire di Cornelio Tacito, il quale, sebbene fosse molto erudito, non poté eguagliare i suoi immediati predecessori, ma da Livio, di cui si propose non solo di continuare le Historiae, ma di imitarlo anche in eloquenza, si discostò molto? Lo stesso si può dire di Tranquillo Svetonio, Plinio Secondo, Elio Sparziano, Giulio Capitolino, Elio Lampridio, Giunio Vopisco, Marziano Felice Capella, Apuleio, Macrobio e molti altri, nei cui scritti si percepisce per quanto tempo questi ornamenti retorici fiorirono e quanto quella maestà antica, che con Cicerone raggiunse il culmine, si sia affievolita. E tuttavia fino all’epoca dei Teodosii e dei successori, Cassiodoro, Ambrosio, Simmaco, Severino, Girolamo, Agostino, Ennodio, Sidonio, Sulpicio Severo e, colui che per primo ebbe successo, l’eloquentissimo Firmiano, e ancora Orosio, Giuliano e, interposto fra questi Ausonio, il facondissimo Cipriano e molti altri in qualche modo tennero in vita l’eloquenza; o, per dirla meglio, la fecero durare ininterrottamente per quasi un secolo. Dopo di loro è avvenuto un così dannoso cambiamento che a Virgilio è lecito lamentarsi in un verso che l’eloquenza sembrò da allora incominciare a sciogliersi e a dileguarsi svanendolanguide le forze, avversa la mente della dea. Sebbene ci siano stati anche Ivone, Bernardo, Ildelberto, Pietro da Blois, Pietro Abelardo, Riccardo da Pofi, Giovanni Saberio e parecchi altri, che si sono dilettati molto nell’eloquenza, non è il caso, tuttavia, di paragonarli agli antichi o medi scrittori, da cui, comunque, si sono allontanati più per lo stile che per il tempo. Nella nostra epoca sono riemersi per un poco gli studi letterari; e il primo cultore dell’eloquenza fu il tuo conterraneo Mussato di Padova; ci fu anche Geri d’Arezzo, massimo imitatore dell’oratore Plinio Secondo, che fu nipote della sorella di Plinio il Vecchio; sono emersi anche questi lumi fiorentini; per non parlare di Dante Alighieri, sommo vanto dell’eloquenza volgare, non paragonabile per scienza ed ingegno a nessuno del nostro tempo, o anche a qualcuno degli antichi; e, s’intende, Petrarca e Boccaccio, di cui tutte le opere, se non sbaglio, saranno celebrate dalla posterità: tuttavia credo che nessuno che sappia giudicare rettamente ignori quanto questi siano lontani dagli antichi per abilità oratoria. E tu mi scrivi che Cassiodoro è inferiore a me, che non solo non sono preferibile a nessuno degli antichi, ma nemmeno ai moderni? O come sento mancare in me, ottimo padre, la consapevolezza della categoria di scrittori in cui debba venir incluso e per quanti giorni mi accorgo di averlo biasimevolmente ignorato! E dal momento che, come vuole Cicerone, l’arte del parlar bene sembra comportare che su ogni argomento, qualunque argomento venga proposto, si parli ornatamente e copiosamente, nessuno è in grado di fare ciò, come vedi e come attesta lo stesso Arpinate, a meno che non abbia conseguito una notevole preparazione in tutte le più importanti discipline ed arti; e difatti bisogna che dalla conoscenza delle cose derivi la buona riuscita di un’orazione; se l’oratore non ha questo solido bagaglio culturale, l’elocuzione sarà inconsistente e quasi puerile; ma se, dico io, l’oratoria richiede tante e tali caratteristiche, perché non solo mi consideri 8 tra gli oratori, ma addirittura mi anteponi agli altri? Risponderò alle tue lodi con le parole dell’onoratissimo Simmaco. Disse infatti a uno che lo ricopriva di elogi sulla sua eloquenza: "Parte della tua lettera, che mi ha assegnato la palma di oratore, quanto più è gradita, tanto meno è vera". E prosegue aggiungendo: "Non oso dire che menti, ma che sei pazzo a dire queste cose sul mio conto". Difatti, per accostarci di più alla verità, quella preferenza, che affermi essere per me motivo di gloria e per te di diletto, è del tutto ingannatrice nonché basata su una falsa opinione. Né a me, come a lui, è gradita, ma, poichè provoca un certo rossore, è sospetta. So infatti che a nessuno degli uomini è dovuta una vera lode, poiché se è stato fatto qualcosa di buono, è lo Spirito Santo, che opera in noi attraverso noi, il facitore di ogni bene.Noi siamo strumento di quello spirito: a lui si deve la gloria, a lui la lode. Noi, dal momento che non ci separiamo da lui, che opera in noi e per noi, cosa che è un dono della sua grazia, possiamo meritare una lode, come quella dovuta a una cetra o ad altri strumenti musicali ottimamente preparati e disposti, che un ingegnoso artista faccia risuonare perfettissimamente. Quindi, per concludere con lo stesso Simmaco: astieniti da parole adulatorie, piene di abbellimenti e pronunciate per compiacere. E se mi apprezzi, ottimo padre, tieni a mente che il compito non è blandire, ma riprendere, non è nascondere la verità né affermare il falso, poiché hai conseguito una certa autorevolezza e quindi il dovere di proclamare la verità. Traduzione di Giovanna Fratini 5) Pier Paolo Vergerio, De ingenuis moribus et liberalibus studiis, 1400-1402. Nam cum ad cetera quidem plurimum valent, tum vero maxime ad salvandam vetustatis memoriam necessaria sunt monumenta litterarum, quibus res hominum gestae, fortunae eventus insperati, naturae insolita opera, et super his omnibus rationes temporum continentur. Memoria etenim hominum, et quod transmittitur per manus, sensim elabitur, et vix unius hominis aevum exsuperat. Quod autem libris bene mandatum est, perpetuo manet, nisi pictura forsitan, aut excisio mermorum, aut fusio metallorum, potest etiam tale quiddam praestare. Verum ea nec signant tempora, nec facile varietatem indicant motionum, et exteriorem tantum habitum exprimunt, ac labefactari facile possunt. Quod autem litteris traditur, non modo haec quae dicta sunt efficit, sed et sermones quoque notat, et cogitatus hominum effingit, ac, si pluribus exemplariis vulgatum est, non facile potest interire, si modo et dignitas accedat orationi. Nam quae sine dignitate scribuntur, ea nec sortiuntur fidem, nec subsistere diu possunt. Quae igitur potest esse vita iucundior, aut certe commodior, quam legere semper, aut scribere, et novos quidem existentes res antiquas cognoscere, praesentes vero cum posteris loqui, atque ita omne tempus, quod et praeteritum est et futurum, nostrum facere? O praeclaram suppellectilem librorum, inquam (ut nos), et, o iucundam familiam, (ut recte Cicero appellat), utique et frugi et bene morigeram! Non enim obstrepit, non inclamat, non est rapax, non vorax, non contumax: iussi loquuntur, et item iussi tacent, semperque ad omne imperium praesto sunt, a quibus nihil umquam, nisi quod velis et quantum velis, audias. Eos igitur (quoniam nostra memoria non est omnium capax, ac paucorum quidem tenax, et vix ad singula sufficit) secundae memoriae loco habendos asservandosque censeo. Nam sunt litterae quidem ac libri certa rerum memoria, et scibilium omnium communis apotheca. Idque curare debemus, ut quos a prioribus accepimus, si nihil ipsi ex nobis gignere forte possumus, integros atque incorruptos posteritati transmittamus; eoque pacto, et iis qui post nos futuri sunt utiliter consulemus, et iis qui praeterierunt vel unam hanc suorum laborum mercedem repensabimus. (Pietro Paolo Vergerio, De ingenuis moribus et liberalibus studiis, in "Atti e memorie della R. Accademia di Padova", XXXIV, 1917-1918, pp. 119-120). (TRADUZIONE ITALIANA) Per tacere di moltissimi altri vantaggi, questi monumenti letterari a cui sono consegnate le gesta degli uomini che furono, i casi diversi e le inattese vicende della fortuna, le manifestazioni meravigliose della natura, e soprattutto le ragioni delle passate età, sono necessari per salvare la memoria dell’antico. 9 La memoria degli uomini, infatti, e quello che si trasmette di bocca in bocca, a poco a poco va in fumo, e a mala pena supera la durata della vita di un solo uomo. Mentre ciò che è stato registrato nei libri perpetuamente rimane, insieme a quel poco di più che per avventura viene tramandato a noi dall’arte della pittura e dai monumenti scolpiti nel marmo o fusi nel bronzo. Ma questi non riescono ad indicarci con precisione il tempo, né facilmente a dirci la varietà dei motivi e delle cause da cui le azioni dipendono, ma si possono limitare solo ad esprimere il nudo fatto, e possono facilmente rovinarsi. Invece la notizia di tutte queste cose si ottiene attraverso le lettere, le quali non solo registrano ciò che è stato detto, ma riproducono anche i discorsi degli uomini e raffigurano i loro pensieri; e se la narrazione di tutto ciò è stata divulgata in parecchi esemplari, la memoria non può facilmente morire, tanto più se il libro fu scritto in uno stile degno della materia; ché soltanto ciò che è scritto senza dignità non acquista fede né dura a lungo. Adunque qual mai genere di vita può esservi più utile e più giocondo di quello occupato continuamente nella lettura e nel comporre, ossia nel conoscere quanto fecero i nostri vecchi, e nel parlare coi posteri dei fatti nostri e, per così dire, far nostro il tempo che fu, come quello che sarà? Che bella suppellettile, i libri! Che dolce famiglia, come la chiama Cicerone, frugale e ben costumata: infatti non strepita, non urla, non è rapace, non divora, non disobbedisce; i libri a un nostro cenno parlano, ad un altro si chetano, sempre pronti ai nostri comandi; e tu li puoi stare a sentire quanto vuoi, e farli parlare di quello che vuoi. E siccome la nostra memoria tutto non può ritenere, anzi ritiene molto poco, penso che i libri debbano essere gelosamente custoditi da noi, quasi una seconda memoria, poiché essi, insieme alle lettere, sono il forziere comune, che racchiude tutto quanto noi possiamo sapere e ricordare. Perciò anche se non ci è concesso di aggiunger qualcosa di nostro, dobbiamo cercare, se non altro, di tramandare ai posteri, integralmente e ben conservati, quei libri che ricevemmo dai nostri antenati, appunto per fare un bene ai posteri, e per ricompensare, in questo unico modo almeno, le fatiche dei nostri padri. Traduzione di Giovanna Fratini 6) Poggio Bracciolini, Lettera a Guarino Veronese, 15 dicembre 1416. Poggius Florentinus Secretarius Apostolicus salutem dicit Guarino suo Veronensi. Licet inter quotidianas occupationes tuas, pro tua in omnes humanitate et benivolentia in me singulari iucundum semper tibi litterarum mearum adventum esse non ignorem, tamen ut in hisce perlegendis praecipuam quandam praestes attentionem, te maiorem in modum obsecro; non quidem ob eam causam, ut aliquid in me sit quod vel summe ociosus requirat; sed propter rei dignitatem de qua scripturus sum, quam certe scio, cum sis longe peritissimus, non parvam tibi ceterisque studiosis hominibus esse allaturam animi iucunditatem. Nam quid est, per Deum immortalem, quod aut tibi aut ceteris doctissimis viris possit esse iucundius, gratius, acceptius, quam cognitio earum rerum quarum commercio doctiores efficimur et, quod maius quiddam videtur, elegantiores. Nam cum generi humano rerum parens natura dederit intellectum atque rationem, tamquam egregios duces ad bene beateque vivendum, quibus nihil queat praestantius excogitari, tum haud scio an sit omnium praestantissimum quod ea nobis elargita est usum atque rationem dicendi, sine quibus neque ratio ipsa neque intellectus quicquam ferme valerent. Solus est enim sermo, quo nos utentes ad exprimendam animi virtutem ab reliquis animantibus segregamur. Permagna igitur habenda est gratia, tum reliquarum liberalium artium inventoribus, tum vel praecipue iis qui dicendi praecepta et normam quandam perfecte loquendi suo studio et diligentia nobis tradiderunt. Effecerunt enim ut qua in re homines ceteris animantibus maxime praestant, nos ipsos etiam homines antecelleremus. Huius autem sermonis exornandi atque excolendi cum multi praeclari, ut scis, fuerint latinae linguae auctores, tum vel praecipuus atque egregius M. Fabius Quintilianus, qui ita diserte, ita absolute summa cum diligentia exequitur ea quae pertinent ad instituendum vel perfectissimum oratorem, ut nihil ei vel ad summam doctrinam, vel singularem eloquentiam meo iudicio deesse videatur. Quo uno solo, etiam si Cicero romanae parens eloquentiae deesset, perfectam consequeremur scientiam recte dicendi. Is vero apud nos antea, Italos dico, ita laceratus erat, ita circumcisus, culpa, ut opinor, temporum, ut nulla forma, nullus habitus hominis in eo recognosceretur. Tute hominem vidisti hactenus lacerum crudeliter ora, 10 ora manusque ambas populataque tempora raptis auribus, et truncas inhonesto vulnere nares. Dolendum quippe erat, aegre ferendum nos tantam in hominis tam eloquentis foeda laceratione iacturam oratoriae facultatis fecisse; sed quo tunc plus erat doloris et molestiae, ex eius viri mutilatione, eo magis nunc est congratulandum, cum sit in pristinum habitum et dignitatem, in antiquam formam atque integram valetudinem nostra diligentia restitutus. Nam si Marcus Tullius magnum prae se fert gaudium pro Marco Marcello restituto ab exilio, et eo quidem tempore quo Romae plures erant Marcelli similes, domi forisque egregii ac praestantes viri, quid nunc agere docti homines debent, et praesertim studiosi eloquentiae, cum singulare et unicum lumen romani nominis, quo extincto nihil praeter Ciceronem supererat, et cum modo simili lacerum ac dispersum, non tantum ab exilio, sed ab ipso paene interitu revocaverimus? Nam mehercule nisi nos auxilium tulissemus, necesse erat illum propediem interiturum. Neque enim dubium est virum spendidum, mundum, elegantem, plenum moribus, plenum facetiis, foeditatem illius carceris, squalorem loci, custodum saevitiam diutius perpeti non potuisse. Moestus quidem ipse erat ac sordidatus, tamquam mortis rei solebant, "squalentem barbam gerens et concretos pulvere crines", ut ipso vultu atque habitu fateretur ad immeritam sententiam se vocari. Videbatur manus tendere, implorare Quiritum fidem, ut se ab iniquo iudicio tuerentur, postulare et indigne ferre quod, qui quondam sua ope, sua eloquentia, multorum salutem conservasset, nunc neque patronum quempiam inveniret, quem misereret fortunarum suarum, neque qui suae consuleret saluti aut ad iniustum rapi supplicium prohiberet. Sed quam temere persaepe eveniunt quae non audeas optare, ut inquit Terentius noster. Fortuna quaedam fuit cum sua tum maxime nostra, ut cum essemus Constantiae ociosi cupido incesseret videndi eius loci quo ille reclusus tenebatur. Est autem monasterium Sancti Galli prope urbem hanc milibus passum XX. Itaque nonnulli animi laxandi et simul perquirendorum librorum, quorum magnus numerus esse dicebatur, gratia eo perreximus. Ibi inter confertissimam librorum copiam, quos longum esset recensore, Quintilianum comperimus adhuc salvum et incolumen, plenum tamen situ et pulvere squalentem. Erant enim non in bibliotheca libri illi, ut eorum dignitas postulabat, sed in teterrimo quodam et obscuro carcere, fundo scilicet unius turris, quo ne capitalis quidem rei damnati retruderentur. Atqui ego pro certo existimo, si essent qui haec barbarorum ergastula, quibus hos detinent viros, rimarentur ac recognescerent amore maiorum, similem fortunam experturos in multis de quibus iam est conclamatum. Reperimus praeterea libros tres primos et dimidiam quarti C. Valerii Flacci Argonauticon, et expositiones tamquam thema quoddam super octo Ciceronis orationibus Q. Asconii Pediani, eloquentissimi viri, de quibus ipse meminit Quintilianus. Haec mea manu transcripsi, et quidem velociter, ut ea mitterem ad Leonardum Aretinum et Nicolaum Florentinum; qui cum a me huius thesauri adinventionem cognovissent, multis a me verbis Quintilianum per suas litteras quam primum ad eos mitti contenderunt. Habes, mi suavissime Guarine, quod ab homine tibi deditissimo ad praesens tribui potest. Vellem et potuisse librum transmittere, sed Leonardo nostro satisfaciundum fuit. Verum scis quo sit in loco ut, si eum voles habere, puto autem te quam primum velle, facile id consequi valeas. Vale et me, quando id mutuum fit, ama. Constantiae, XVIII Kalendas Ianuarias, Anno Christi 1417. (Poggio Bracciolini, Lettere, a cura di H. Hart, II, Olschki, Firenze 1984, pp. 153-156). (TRADUZIONE ITALIANA) Poggio Fiorentino segretario apostolico saluta il suo Guarino Veronese. So che, nonostante le tue numerose occupazioni quotidiane, per la tua singolare benevolenza verso tutti, l’arrivo delle mie lettere è per te sempre gradito; tuttavia ti raccomando vivamente di leggere questa con particolare attenzione, non perché abbia qualcosa che desti l’interesse anche degli oziosi, ma per l’importanza di ciò che sto per scriverti, che sono certissimo che provocherà una grandissima gioia a te che sei molto colto e agli uomini di studio. Infatti, o Dio immortale, che cosa c’è di più piacevole e gradito a te agli altri dottissimi uomini che la conoscenza di quelle cose grazie alla cui familiarità diventiamo più colti e, cosa ancor più importante, più raffinati? Infatti la natura, madre di ogni cosa, ha dato al genere umano intelletto e ragione, come ottime guide a vivere bene e beatamente, e tali che non possa pensarti niente di più egregio; ma non so se i beni più eccellenti tra tutti quelli a noi concessi, siano la capacità e l’ordine del parlare, senza cui la stessa ragione e l’intelletto non potrebbero valere quasi niente. Infatti è solo il discorso, di cui ci serviamo per esprimere la virtù dell’animo, che ci distingue dagli altri animali. 11 Grandissima, dunque, è la gratitudine che dobbiamo avere nei confronti degli inventori delle arti liberali, e soprattutto nei confronti di quelli che, con il loro studio e la loro cura, ci hanno consegnato i precetti del dire e una norma del parlare perfettamente. Infatti fecero sì che, proprio nell’ambito in cui gli uomini sono nettamente superiori agli altri animali, noi potessimo valicare gli stessi limiti umani. E sono stati molti gli autori latini che, come sai, si distinsero nell’arte di adornare e perfezionare il discorso, fra cui l’illustre ed insigne Marco Fabio Quintiliano, che ha esposto in modo talmente chiaro e compiuto, nonché con somma diligenza, le doti necessarie a formare il perfetto oratore, che non sembra, a mio parere, mancargli niente per raggiungere una somma dottrina o una singolare eloquenza. Ché se anche rimanesse solo lui, mancando Cicerone, padre dell’eloquenza romana, conseguiremmo una perfetta conoscenza dell’arte del discorso. Ma egli presso noi italiani era così lacerato e mutilato, credo per colpa dei tempi, che in lui non si riconosceva più alcun aspetto umano. Finora hai visto un uomo "con la bocca crudelmente lacerata, le narici sfregiate da ripugnanti ferite". Era assai vergognoso, e a stento sopportabile il fatto che, nella turpe mutilazione di un così eloquente uomo, l’arte oratoria avesse subito un così grave danno; ma quanto più ci si addolorava sapendolo mutilato, tanto più ora ci si deve rallegrare, dal momento che la nostra diligenza gli ha restituito l’antico abito e l’antica dignità, l’antica bellezza e la perfetta salute. E se Marco Tullio gioiva per i fatto che Marcello era tornato dall’esilio, e in un’epoca in cui a Roma c’erano parecchi Marcelli, egregi e valenti in pace e in guerra, che cosa devono fare i dotti, e in particolare gli studiosi di eloquenza adesso che abbiamo richiamato non dall’esilio, ma quasi dalla morte, tanto era lacero e disperso, questa singolare ed unica gloria del nome romano, estinto il quale non rimaneva che Cicerone? Se non gli avessimo portato aiuto, sarebbe sicuramente morto dopo poco. E non v’è dubbio che quell’uomo splendido, elegante, raffinato, pieno di virtù e di arguzia non avrebbe più resistere alla bruttezza di quel carcere, allo squallore del luogo, alla crudeltà dei custodi. Era mesto e malvestito come i condannati a morte, "con la barba incolta e i capelli pregni di polvere", sicché la stessa espressione del volto e l’abbigliamento sciatto rivelavano che era destinato ad una ingiusta condanna. Sembrava tenere le mani, implorare la fiducia dei Quiriti, affinché lo proteggessero da un’iniqua condanna, si lamentava di soffrire ingiustamente, proprio lui che un tempo col suo aiuto e la sua eloquenza aveva salvato molti, mentre ora non trovava nessun patrono che avesse pietà della sua sventura, si desse da fare per salvarlo e lo sottraesse a un ingiusto supplizio. Ma quanto inaspettatamente accadono spesso le cose che neppure oseresti sperare, come dice il nostro Terenzio. La fortuna fu dalla sua, ma anche dalla nostra: mentre ero in ozio a Costanza mi venne voglia di vedere il luogo in cui era tenuto recluso. Vicino a questa città c’è infatti un monastero di San Gallo, a circa venti miglia. E così andai lì per rilassarmi e al tempo stesso per vedere i libri, di cui si diceva che vi fosse un gran numero. E là, in una gran massa di codici, che sarebbe lungo elencare, ho trovato Quintiliano ancora sano e salvo, anche se pieno di muffa e di polvere. Quei libri infatti non erano in biblioteca, come la loro dignità richiedeva, ma quasi in uno svaventosissimo e oscuro carcere, dove non si caccerebbero nemmeno i condannati a morte. E io so per certo che chi andasse, per amore dei padri, ad esplorare gli ergastoli che racchiudono questi uomini, si renderebbe conto che una simile sorte è toccata a molti su cui ormai si dispera. Abbiamo trovato inoltre i primi tre libri e metà del quarto delle Argonautiche di Caio Valerio Flacco, e i commenti a otto orazioni di Cicerone opera di Quinto Asconio Pediano, uomo assai eloquente, menzionati dallo stesso Quintiliano. Ho copiato di mio pugno questi testi, e anche piuttosto velocemente, per inviarli a Leonardo Bruni e Niccolò Niccoli; i quali, dopo aver saputo del rinvenimento di questo tesoro, mi hanno chiesto con insistenza di inviare loro Quintiliano per lettera, prima possibile. Ricevi, dunque, carissimo Guarino, ciò che può esserti donato da un uomo ora a te tanto devoto. Vorrei anche poterti inviare il libro, ma bisognava accontentare il nostro Leonardo. Comunque sai dove si trova, e se lo vuoi avere, penso infatti che lo vorrai al più presto, lo potrai ottenere facilmente. Addio e amami, ché la cosa è ricambiata. Costanza, 15 dicembre 1416. Traduzione a cura di Giovanna Fratini 7) Leonardo Bruni, In nebulonem maledicum, 1424. 12 Itaque bellum indixit scurra nepharius cunctis praestantibus ingenio viris, nec viventibus modo sed etiam mortuis. Nam et Dantem optimum nobilissimumque poetam, vituperare assidue prope convicio non cessat, et de Petrarcha ita loquitur quasi de homine insulso et ignorantie pleno, Boccacium ita spernit ut tres quidem litteras scisse illum asseveret. Nec poetas modo et hoc genus litterarum, sed omnes pariter insectatur et ledit. Thomam certe aquinatem, quem virum, Deus immortalis, quanta scientia quantaque doctrina preditum, quem ego non verear cum Aristotele Theophrastoque coniungere, fatuus hic scurra ita spernit contemnitque ut litteris, ut ingenio, ut intelligentia caruisse illum palam omnibus audientibus predicare non desinat. Idem facit de ceteris defunctis, nisi quibus propter millesimum iam annum cedit. De viventibus autem pudet etiam nunc referre qua iste acerbitate Chrysoloram bizantinum abundanti doctrina hominem insectatus sit, quem omnes ob singularem scientiam moresque probatissimos colebamus; hic unus inventus est, qui omnifariam iniuriis contumeliisque lacesseret, quoad consilium cepit ex hac urbe demigrandi. (Leonardo Bruni, In nebulonem maledicum, in Leonardo Bruni, Opere letterarie e politiche, a cura di P. Viti, UTET, Torino 1996, pp. 343-344) (TRADUZIONE ITALIANA) E così questo nefando buffone ha dichiarato guerra a tutti gli uomini di brillante ingegno, sia vivi che morti. Infatti vitupera continuamente Dante, grandissimo ed eccellentissimo poeta, e quasi non la smette di biasimarlo, e di Petrarca parla come se fosse un uomo sciocco e pieno di ignoranza; disprezza Boccaccio al punto di sostenere che conosceva solo quattro sciocchezzuole. E non offende e danneggia solamente i poeti e questo tipo di cultura, ma tutti quanti allo stesso modo. Questo stupido buffone disprezza e tiene in così poco conto Tommaso d’Aquino (uomo, Dio immortale, dotato di tale sapienza e cultura che non avrei remore a metterlo accanto ad Aristotele e Teofrasto), da ripetere incessantemente a chiunque lo ascolti che era privo di ingegno e di qualsivoglia intelligenza. La medesima cosa fa nei confronti degli altri morti, fatta eccezione per quelli defunti da più di un millennio. Riguardo ai viventi, sarebbe vergognoso riferire con quale asprezza costui si scagliò contro il bizantino Crisolora, uomo di smisurata cultura che tutti per la singolare erudizione e i costumi integerrimi veneravamo; costui è stato il solo che lo abbia aggredito con insulti e oltraggi di ogni sorta, la qual cosa gli fece prendere la decisione di andarsene da questa città. Traduzione di Giovanna Fratini 8) Leonardo Bruni, Oratio in funere Johannis Strozzae, 1428. Nam quid ego de litteris studiisque nunc dicam in qua una re maxima quidem ac luculentissima principatus concessu omnium civitati nostre tribuitur? Nec ego nunc de vulgaribus istis mercenariisque, quamquam in illis quoque nostri excellunt, sed de politioribus illis divinioribusque studiis, quorum excellentia maior et gloria sempiterna immortalisque habetur, et loquor et sentio. Quis enim vel nostra vel superiori etate poetam aliquem nominare potest nisi florentinum? Quis hanc peritiam dicendi iam plane amissam in lucem atque in usum vitamque revocavit preter cives nostros? Quis latinas litteras prius abiectas atque prostratas et fere demortuas agnovit, erexit, restituit, ab interitu vendicavit nisi civitas nostra? Quare si Camillus recte conditor urbis romane dictus est, non quia condiderit eam ab initio, sed quod amissam occupatamque restituerit, cur non eadem ratione civitas hec nostra latine parens lingue merito nuncupetur, quam perditam dudum ac profligatam in suum nitorem dignitatemque restituit? Atque ut Triptolemo triticum exhibenti quicquid postea natum est attribuimus, ita civitati nostre quicquid litterarum politiorisque discipline ubique coaluit ferri debet acceptum. Iam vero grecarum litterarum cognitio, que septingentis amplius annis per Italiam obsoleverat, a civitate nostra revocata est atque reducta, ut et summos philosophos et admirabiles oratores ceterosque prestantissimos disciplina homines, non per enigmata interpretationum ineptarum, sed de facie ad faciem intueri valeremus. Denique studia ipsa humanitatis, prestantissima quidem atque optima, generis humani maxime propria, privatim et publice ad vitam necessaria, ornata litterarum eruditione ingenua, a civitate nostra profecta, per Italiam coaluerunt. 13 (Leonardo Bruni, Oratio in funere Johannis Strozzae, in Leonardo Bruni, Opere letterarie e politiche, a cura di P. Viti, UTET, Torino 1996, pp. 720-721). (TRADUZIONE ITALIANA) Che cosa dovrei dire ora delle lettere e degli studi, un campo davvero grandissimo e splendido, in cui, per consenso generale, alla nostra città è attribuito il primato? E non mi riferisco agli studi ordinari e prezzolati, per quanto anche in quelli i nostri eccellano, ma agli studi più nobili e più alti, la cui superiorità si considera maggiore, ed eterna e immortale la gloria. Chi, infatti, potrebbe citare un poeta, sia della nostra età che di quella precedente, che non sia fiorentino? Chi, al di fuori dei nostri concittadini, ha riportato alla luce, all’uso e alla vita questa scienza oratoria già completamente andata perduta? Chi, se non la nostra città, ha riconosciuto, ha innalzato, ha vendicato dalla morte le lettere latine prima trascurate e prostrate e quasi scomparse? Perciò, se a ragione Camillo è stato detto fondatore della città di Roma, non perché l’abbia fondata dalle origini ma perché l’ha risollevata dopo che era stata persa ed era stata occupata, perché, per la stessa ragione, questa nostra città non si chiama a buon diritto madre della lingua latina, avendola restituita nel suo splendore e nella sua dignità dopo che ormai si era perduta e dispersa? E come a Trittolemo, che ci ha dato il grano, attribuiamo tutto quello che è nato dopo, così alla nostra città deve essere fatto risalire, come ricevuto, quanto delle lettere e degli studi più elevati si è ovunque diffuso. E ancora: la conoscenza della letteratura greca, che da più di settecento anni era venuta meno in Italia, dalla nostra città è stata risollevata e ricondotta fra noi: e così i sommi filosofi e gli ammirevoli oratori e tutti gli altri uomini più insigni nel sapere, ora siamo in grado di guardarli non attraverso gli enigmi di inette traduzioni, ma faccia a faccia. Infine, gli stessi studi umanistici, certamente eccellenti ed ottimi, particolarmente specifici del genere umano, necessari alla vita sia pubblica sia privata, arricchiti da un’elevata conoscenza delle lettere, si sono diffusi per l’Italia dopo essere incominciati dalla nostra città. Traduzione di Giovanna Fratini 9) Matteo Palmieri, Vita civile, 1431-1438. Lo ‘ntaglio et l’architectura da noi indrieto per lunghissimo tempo maestre di scioche maraviglie, in ella età nostra si sono rilevate et tornate in luci et da più maestri pulitesi et facte perfecte. Delle lettere et liberali studii sare’ meglio tacere che dire poco. Queste principalissime conducitrice, et vere maestre d’ogni altra buona arte per più d’ottocento anni sono in modo state dimenticate nel mondo, che mai s’è trovato chi n’abbia avuto cognitione vera né saputo usare un loro minimo ornamento, in tanto che tutto quello si truova in carti o marmi per grammatica scripto fra questo tempo meritamente si possa chiamare grossagine rozza. Oggi veggiano per padre et ornamento delle lettere essere mandato nel mondo / el nostro Leonardo Aretino come splendido lume della eleganzia latina, per rendere agl’huomini la dolcezza della latina lingua. Il perché riconosca da Dio chi ha ingegno l’essere nato in questi tempi, i quali più fioriscono d’excellenti arti d’ingegno, che altri tempi sieno stati già sono mille anni passati, solo che e’ piacesse a chi tutto governa per gratia dare lunga et tranquillissima pace all’umile nostra Italia: che essendo, certo si vede che da queste prime rilevationi seguirebbono mirabili fructi, apti a correggere col tempo expressissimi errori di riputatissime doctrine. Le quali, pervertite da chi ha scripto di quelle ne’ tempi di sì lunga ignoranza, et poi studiate con loro obscuri et tenebrosi libri che per inestricabili vie non aprono, ma con insolvibili argutie obfuscano ogni scientia, sì che sanza alcuno largo fructo s’invechia in esse, fanno chell’abito fatto da chi n’è docto né possa né voglia consentire essere in esse migliore né più brieve via, et forse meritamente, non vogliendo perdere la riputatione et stima di quello che con fatica, credendo bene fare, hanno in tutta la vita imparato. Ma io bene credo essere non di lungi il tempo che dimonsterrà et philosophia et altre scientie potersi in su i principali auctori più brievemente et perfecte imparare, che non si fa in su le insolubili investigationi di quegli che, dicendo volere exporre, obfuscano gli ordinati et bene composti auctori degli elevati ingegni. Tosto si conoscerà il primo segno dell’animo bene composto essere stare fermo et seco medesimo, non 14 deviando da’ primi ingegni, considerare et rivolgere i termini fondamentali di qualunche scienzia o arte, et a quegli con ogni detto et facto conrispondere, sappiendo che ogni altra via è vaga et instabile et sanza fructo. Come per simele errore, non sono molti anni, si vedea molti grandissima parte della vita consumare in ell’arte et constructione di grammatica, dove i tristi maestri con tristi auctori insegnando et pervertendo in modo l’ordine che, insegnando grammatica, insieme philosofia et ogn’altra scientia confondevono, non altro fructo faceano che si faccia chi, leggendo il Danese, stimasse riuscire sommo maestro di dire in rima, ché agiovolemente, leggendo poi Dante o il Petrarca, conoscerebbe suo errore se lo intelletto infermo nollo cecasse. Oggi in brevissimo tempo si vede molti con tale eleganzia scrivere et dire in latino che in tutta la vita sì tollerabilemente non si dicea pe’ maestri de’ nostri padri. Confortovi dunque, Franco et te, Luigi, a seguire in egli studii come fate, acciò siate in fra i primi intendenti di vostra età, ché stimo, sella vita non v’abandona, vedrete l’un dì più chell’altro fiorire gl’ingegni de’ cittadini vostri, però che naturale è rinascere l’arti perdute quando vuole l’uso: come et in Grecia et a Roma anticamente si vide una età fiorire d’oratori, una di poeti, un’altra di legisti philosophi, historici o scultori, secondo erano più in uso, stimate et insegnate da i maestri di que’ tempi. La seconda cagione perché non si diviene excellente è rispecto al fine, il quale è perverso da noi, però che con ciò sia cosa che il fine d’ogni arte sia quella perfectamente intendere et dilectarsi nella sua vera cognitione per quiete dello intellecto che per sua natura disidera interamente sapere, nientedimeno grandissima parte degl’huomini aberrano, pognendo il loro fine in utile et honore non vero, ma oppinabile. Di quinci nasce che i secutori d’alcuna arte tanto ne imparano, quanto sono necessitati ad averne spaccio secondo il commune corso degli altri simili; poi fare meglio non si cura, et sempre segue in quelle prime grossezze, bastandogli che si creda ne sappia tanto gli basti a avere il corso. Questo errore non solo tiene adrieto l’arti servili et mecanice, ma ancora quelle che sono dette liberali, imperò che molti cercono doctrina di lettere tanto quanto possino exprimere certe parole grossamente per -es et -us, pur che dal vulgo ignorante sieno riputati grammatici. Altri dicono studiare loica et poi essere philosophi, che solo imparano a sapere garrire ne’ cerchi, dove spesso dalla ignoranza de’ circunstanti è giudicato che chi più garre più sappia. Così credo che sia de’ non perfecti doctori in medicina et legge, che più tosto ne imparano tanto quanto credono vendere, che e’ non cercono la vera doctrina per virtù et ornamento di loro et per universale salute di molti avendo ultimamente rispetto all’utile per solo premio della operata virtù come richiede il debito di ciascuno virtuoso. Molto è difficile affaticarsi nelle gran cose per solo utile d’altri secondo richiederebbe la vera virtù, et quegli chell’abbino facto sono stati in terra rarissimi uccelli et simili certo alla rara fenice, più rado veduti che ragionati. Meritamente per questo da e sapientissimi antichi sono stati celebrati di sommo honore et gloriosamente riveriti i nomi degl’inventori d’alcuni arti excellenti, che per tutto il tempo di loro vita si sono affaticati per l’universale salute et utilità commune dell’humana generatione. (Matteo Palmieri, Vita civile, edizione critica a cura di Gino Belloni, Sansoni, Firenze 1982, pp. 44-47) 10) Guarino Veronese, Lettera al figlio, 29 agosto 1452. Guarinus Veronensis suo dilecto filio Nicolao salutem. De proximo tuas una cum binis alteris gestatis in sinu litteras accepi, quibus miraris vel potius tacite mordes dictionem meam quibusdam ex epistulis meis quas olim paene puer lusi. Vocabula quoque nonnulla latini sermonis proprietatem minime redolentia et aliam loquendi atque eloquendi formulam prae se ferentia perpendis. Qua de re tuo de paterna scriptione iudicio gratulor; scriptis vero meis perinde ac ab inferis in lucem revolutis et ferme mihi ipsi incognitis nonnihil erubesco, quae post lethaeos haustus ad superos instar platonicae illius palinghenesías Mercurius alter revocasti. Hoc in loco virgilianum illud venit in mentem: "quae te tam laeta tulerunt saecula, qui tanti talem genuere parentes". Nam sicut infeliciter olim nobiscum actum erat, ut ad ineuntes usque annos nostros tantopere studia ipsa humanitatis obdormissent iacentis in tenebris, ut avitus ille romanae facundiae lepos suavissimusque scribendi flos emarcuisset et nescio quae "sartago loquendi venisset in linguas", unde 15 acerbata erat oratio: sic aetas haec "felix sorte sua", de qua longius provehar, ut docente me temporum varietatem addiscas. Ignorabatur "romani maximus auctor Tullius eloquii", "cuius ex lingua" penes maiores nostros "melle dulcior fluxerat oratio", a qua velut e speculo Italia dicendi formarat imaginem; solaque ciceronianae dictionis quondam aemulatio ac delectatio vehementem proficiendi causam induxerat. In eius autem locum longo post intervallo cum Prosperos, Evas Columbas et Chartulas irrumpentes quaquaversum imbuta absorbuisset Italia, quaedam germinabat dicendi et scribendi horrens et inculta barbaries. Uti beata quaedam tunc adorabatur ubertas, si quis ita dixisset: "Vobis regratior, quia de concernentibus capitaniatui meo tam honorificabiliter per unam vestram litteram vestra me advisavit sapientitudo". Inter has sermocinandi tenebras aliqua tamen ex naturae bonitate scintilla elucescebat, quae nullo duce caliginosum illum aerem avertere conaretur; nondum tamen, lippiscentibus oculis, illum avorum nostrorum splendorem ferre poterat; idque nobis obveniebat, quod e Germania proficiscentibus in Italiam percipiendae linguae latinae causa: qui si ad inculti et horridi oris populos divertant, imbibita locutionis sorde et spinosa verborum asperitate offendunt potius aurem quam alliciant; sin ad innatae facundiae et ingenitae dulcedinis linguas transmigrent, gustata mellitae dictionis suavitate cultus mox sermo suscipitur et vox ipsa cygnea. Mercurius interea, ut poetae aut astrologi dicerent, immo, ut verius christiana de fide loquar, Mercurii creator Dominus et moderator deus nostram miseratus imperitiam Manuelem Chrysoloram misit ad nos, virum omni doctrinarum copia abundantissimum, in quo nescias scientiane magis an virtus eniteret: utrum in eo perpendas, altero maius dices; et profecto nec laude crescere nec taciturnitate minui poterit. Quocunque ibat, suus ut dies festus celebrabatur adventus: gratus imperatoribus, acceptus pontificibus romanis, exoptatus populis veniebat. Diceres missum e caelo in terras hominem. Is delatus Florentiam quasi reflorescentis eruditionis auspicium et magnificentissimae civitatis delectatus hospitio, ibi sedem habuit multis conditam honoribus nec parvis fructibus laetissimam; ut, quae artium egregiarum munditiarumque ac expolitionis parens altera semper extitisset, ea ex urbe coeperit, sicuti Triptolemus alter, litterarum fruges per nostrorum ingenia dispertiri et nostrates ad colendum animare, unde germinantia late semina brevi fructus mirificos edidere. Sensim augescens humanitas veteres, ut serpens novus, exuvias deponens pristinum vigorem reparabat, qui in hanc perdurans aetatem romana portendere saecula videtur. Contigit igitur quod de suis civibus Tullius factum affirmat: "Post autem auditis oratoribus graecis cognitisque eorum litteris adhibitisque doctoribus incredibili quodam nostri homines dicendi studio flagraverunt". Huic itidem rei conducit scitum illud de Catone maiori testimonium: "Qui si eruditius videbitur disputare quam consuevit in suis ipse libris, attribuito litteris graecis quarum constat perstudiosum fuisse in senectute". Longa itaque desuetudine infuscatus ante latinus sermo et inquinata dictio Chrysolorinis fuerat pharmacis expurganda et admoto lumine illustranda. Ne feras gravate, Nicolae fili, si resurgentis disciplinae limatioris originem et paternam commonstro diligentiam simul et peregrinationem, quam ipse per aetatem ignorabas, <ut> et posteris prodas et ad studia calcar accipias. Seniori deinde Mediolani duci Iohanni Galeazo augustae sane dignitatis principi Manuel mirum desideratus in modum et grandioribus accitus praemiis fuit, quia suorum familiarium honestamento solus ille cumulus deesse videbatur et laudi, cum dux ipse incredibiliter gloriae avidus esset. Eo dehinc mortuo redeuntem in patriam Chrysoloram subsecutus sum, ut discendi ardoribus anhelantem instrueret erudiret informaret, modo id assequi potuissem. Hoc in tempore, ut initio dixi, cantare virgilianum potes illud: "Quae me tam laeta tulerunt saecula", in quibus politiora iam studia non solum nostrates sed etiam exteras nationes occupant. Ad paratam, ut dicitur, mensam accessisti, ubi reiecto putamine mundum ac delicatum nucleum esse potuisti. Post tot percursos oratores et poetas aliosque scriptores, qui ubique iam leguntur, emendatum purissimumque nactus es sermonem; quae quidem ab exordio res mihi nequaquam obtigit. Iam non hominum sed aetatis laus esse incipit, ut diserti dicantur homines latinaque sermocinatio; nec tam bene dicere commendatio est, quam male convitium; plusque latine nunc loqui decet, quam pridem barbare dedecebat. Eapropter, carissime fili, siquid improprie ineruditeque scriptum a me olim fuisse deprehendis, cogitare debebis id prioris saeculi vitium et depravatum fuisse morem. Proinde tu quasi balbutientem patris infantiam risu complectaris, quam derideas aut contemnas; nec vero lactentibus de labiis eruditionem exigas, quam adulta et grandior profiteri debe aetas. Nonne, "si parva licet componere magnis", vides alio Ennium alio modo cecinisse Virgilium? alio item Censorium alio genere orasse et scriptitasse Ciceronem? 16 non eo Fabium Pictorem modo quo T. Livium res gestas posteritati commendasse? Sic qui blaese balbeque mutire puer impune solitus erat, idem graviter et ornate dicere iam potest. Haec sunt quae tecum vertens mirari de meis iam scriptis desines et varietatem censorio non insectaberis iudicio. Vale. E Ferraria III kal. sept. MCCCCLII. (Guarino Veronese, Epistola ad filium Nicolaum, in Guarino Veronese, Epistolario, a cura di Remigio Sabbadini, II, R. Deputazione Veneta di Storia patria, Venezia 1916, pp. 581-584) (TRADUZIONE ITALIANA) Guarino Veronese saluta il suo amato figlio Nicola. Ho ricevuto di recente, con le altre due che porto sul cuore, una tua lettera dove ti stupisci, o piuttosto tacitamente critichi, lo stile di alcune mie epistole sulle quali mi esercitai quando ero ancora quasi un bambino. Soppesi alcune parole latine prive di qualsiasi proprietà e che mostrano un modo insolito di esprimersi e di parlare. Perciò mi congratulo con te del tuo giudizio sul modo di scrivere di tuo padre; ma arrossisco di quei miei scritti richiamati alla luce e che mi sembrano quasi sconosciuti. Tu, nuovo Mercurio, li hai riportati alla luce, oltre le onde di Lete, quasi per una resurrezione platonica. A questo punto mi viene in mente quel verso di Virgilio: "felici i secoli che ti generarono, tu che sei nato da genitori così illustri". Difatti come noi fummo così sfortunati che gli studi umanistici giacquero dormienti nelle tenebre, e il famoso gusto dell’eloquio latino e il soavissimo fiore dello scrivere aveva perduto ogni luce e non so quale "ruggine del discorso si era prodotta nelle lingue" rendendo aspro il linguaggio; così invece l’età presente è "felice per la sua sorte", ed io ne parlerò più a lungo perché tu conosca dal mio insegnamento la varietà dei tempi. Non si conosceva "Tullio, la massima autorità della lingua latina", dalla "cui lingua", al tempo dei nostri antenati, "il discorso era fluito più dolce del miele" e che l’Italia aveva considerato come specchio del proprio linguaggio; e allora la sola imitazione e ammirazione del linguaggio ciceroniano aveva introdotto una impetuosa causa di progresso. Quando poi, dopo un lungo intervallo, l’Italia si fu imbevuta di "Prosperi, Eve colombe e chartule" che irrompevano da ogni parte, germinò un’orrida e incolta barbarie del dire e dello scrivere. A quei tempi ci si deliziava di una felice eloquenza se qualcuno avesse detto: "Vobis regratior, quia de concernentibus capitaniatui meo tam honorificabiliter per unam vestram litteram vestra me advisavit sapientudo". Pure in quelle tenebre del discorso brillava qualche scintilla scaturita dalla buona natura, e senza alcuna guida tentava di fugare quell’aere caliginoso; ma tuttavia, con i suoi occhi miopi, non poteva certo reggere lo splendore degli avi nostri; ed accadeva anche a noi come a coloro che vengono dalla Germania per imparare il latino; che se si imbattono in popoli incolti e di cattiva pronunzia, parlano con una scorrettezza ormai acquisita e con un’asprezza di parole che offende l’orecchio e non lo accarezza; se, invece, passano tra genti naturalmente faconde e di accento dolce, la soavità di una dizione di miele che essi hanno gustato, ne rende subito eletto il parlare e dà loro una voce di cigno. Frattanto Mercurio, come direbbero i poeti e gli astrologi, o piuttosto, per dire con maggior verità secondo la fede cristiana, Dio creatore e guida di Mercurio, impietosito dalla nostra imperizia, ci mandò Manuele Crisolora, uomo ricchissimo di ogni dottrina, in cui non sai se risplendesse maggiormente la scienza o la virtù; se consideri in lui l’una si apparirà infatti maggiore dell’altra; e certamente né lode può innalzarlo né il silenzio diminuirlo. Dovunque andava, il suo arrivo era celebrato come un giorno di festa; giungeva gradito agli imperatori, accetto ai pontefici romani, richiesto dai popoli. Lo avresti detto un uomo mandato dal cielo. Egli giunto a Firenze, quasi auspicio dell’erudizione che vi rifioriva e lieto dell’ospitalità di quella città munificentissima, vi rimase tra molti onori e con frutti non scarsi; da quella città, che è stata sempre una seconda madre di egregia raffinatezza e di eleganza, cominciò, novello Trittolemo, a diffondere tra i nostri ingegni le messi delle lettere ed a stimolare i nostri concittadini alla cultura; onde poi, germinando largamente questi semi, maturarono presto mirabili frutti. L’umanità, crescendo sempre più, come un serpente nella nuova stagione, gettava via le vecchie spoglie riacquistando il primitivo vigore, che, perdurando nel nostro tempo, sembra continuare i secoli romani. Accade dunque ciò che Tullio affermava dei suoi concittadini: "Dopo aver ascoltato gli oratori greci e conosciute le loro lettere, compresi i loro dotti, i nostri furono presi da un’incredibile passione per lo studio del dire". E conclude ugualmente anche il famoso detto su Catone il vecchio: "Se nella discussione apparirà più dotto che nei suoi libri, lo si attribuisca alle lettere greche cui si sa per certo che dedicasse un 17 grandissimo studio nella vecchiaia". La lingua latina oscurata dal lungo disuso e la dizione corrotta esigeva dunque di essere purificata dai farmaci di Crisolora e di essere illuminata dalla luce perduta. Non ti spiaccia, Nicola mio, se ti illustro insieme le origini di una cultura più raffinata e le peregrinazioni e gli studi paterni, che tu stesso ignoravi a causa della tua età, perché tu le tramandi ai posteri e ne tragga stimolo ai tuoi studi. Dopo, desiderato in modo eccezionale e attratto da grandi premi, Emanuele andò presso il duca Giangaleazzo, signore di Milano, principe di quasi regale dignità; egli solo mancava infatti al decoro ed alla fama dei suoi familiari, mentre il duca stesso era incredibilmente avido di gloria. Dopo la morte del duca io seguii Crisolora che tornava in patria, perché, se mi fosse dato, anelante com’ero dall’ardore di studiare, potessi istruirmi, formarmi ed educarmi. Come ho detto all’inizio a questo punto puoi cantare il verso di Virgilio: "felici i tempi che mi generarono", nei quali studi più raffinati si diffondono non solo tra di noi, ma anche nelle altre nazioni. Tu ti sei seduto, come suol dirsi, ad una tavola imbandita. Ove respinte le scorie, hai potuto cibarti della polpa pura e delicata. Dopo aver ripercorso tanti oratori, poeti e scrittori di ogni genere, che ormai sono letti ovunque, hai potuto giovarti di una lingua corretta purissima; cosa che all’inizio non è certo toccata anche a me. Essere considerati facondi per il nostro modo di parlar latino non costituisce più una lode dei singoli ma del nostro tempo; né è più motivo di elogio il parlar bene, quanto ragione di rimprovero il parlar male; ed ora dobbiamo parlare un buon latino più di quanto prima non fosse vergognoso un linguaggio barbaro. Perciò, carissimo figlio, se trovi improprio e rozzo ciò che io scrivevo un tempo, dovrai pensare quanto fosse corrotto e depravato l’uso di quell’età. Considera sorridendo l’infanzia di tuo padre e il suo balbettio, piuttosto che deriderla e condannarla; e non chiedere alle labbra del lattante l’erudizione che è propria dell’età adulta e matura. Non vedi "se è lecito paragonare le piccole cose alle grandi", che Ennio ha cantato in modo ben diverso da quello da quello di Virgilio? Che Catone il Censore ha parlato e scritto con uno stile che non è quello di Cicerone? Che Fabio Pittore ha consegnato alla posterità un’opera storica ben diversa da quella di Tito Livio? Così il bambino che soleva senza sua colpa borbottare balbettando e storpiando, ora può parlare con gravità e decoro. Meditando su queste cose cesserai di meravigliarti dei miei scritti e non mi rimprovererai con un giudizio censorio. Addio. Ferrara, 29 agosto 1452 Traduzione a cura di Giovanna Fratini 11) Flavio Biondo, Roma instaurata, 1482. Nos sumus ex illis quos videmus praesentem romanae rei statum haud secus spernere et pro nihilo ducere ac si omnis eius memoria simul cum legionibus consulibus Senatu Capitolii Palatiique ornamentis penitus interisset. Viget certe viget adhuc et quamquam minori diffusa orbis terrarum spacio solidiori certe innixa fundamento urbis Romae gloria maiestatis. Habetque Roma aliquod in regna et gentes imperium, cui tutando augendoque non legionibus cohortibus turmis et manipulis, non equitatu peditatuque sic opus, nullo nunc delectu militum, qui aut sponte dent nomina, aut militare cogantur, eductae Roma et Italia copiae in hostem ducuntur <aut> imperii limites custodiuntur. Non sanguis ad praesentem servandam patriam effunditur, non mortalium caedes committuntur. Sed per dei nostri et domini nostri Jesu Christi imperatoris vere summi, vere aeterni religionis sedem arcem atque domicilium in Roma constitutum ductosque in illa ab annis mille e quadringentis martyrum triumphos, per dispersas in omnibus aeternae et gloriosissimae Romae templis aedibus sacellisque sanctorum reliquias, magna nunc orbis terrarum pars Romanum nomen dulci magis subiectione colit quam olim fuit solita contremiscere [...]. Propria quaedam habet urbs Romana adeo praeclara, excelsa, admiranda, ut nedum alibi in orbe inveniantur, sed nec etiam ea transferri liceat optari; in primis qui Romam ipsam rerum caput et dominam non viderit, temere quicquam alicubi admirabitur. Habet enim urbs ipsa apostolorum limina et terram sacro martyrum cruore purpuream. (Flavio Biondo, Roma instaurata, Venezia, Bonino de Bonini, 1482, c. e4 r-v) (TRADUZIONE ITALIANA) 18 Non siamo tra quelli che vediamo disprezzare la attuale situazione di Roma considerandola di nessun valore, come se ogni memoria di essa fosse andata interamente perduta insieme con le legioni, i consoli, il senato, gli ornamenti del Campidoglio e del Palatino. Vive, certamente ancora vive la gloria della maestà della città di Roma e, sebbene diffusa in un territorio di minore estensione, poggia su un più solido fondamento. Roma ha ancora un impero sui regni e sui popoli, per la cui tutela e crescita non c’è bisogno di legioni, coorti, squadroni e manipoli, di cavalleria e di fanteria, non c’è bisogno di nessuna leva di soldati, volontari o costretti a prestar servizio; non milizie da Roma e dall’Italia sono condotte contro il nemico o custodiscono i confini dell’impero. Non viene sparso sangue per la difesa di questa patria, non sono compiuti massacri. Ma essendo stata stabilita in Roma la sede, la rocca e il domicilio della religione per volere di Dio e di nostro Signore Gesù Cristo, vero Sommo ed Eterno Imperatore ed essendo stati qui celebrati i trionfi dei martiri per mille e quattrocento anni, attraverso le reliquie dei santi sparse in tutti le chiese, i santuari e le cappelle dell’eterna e gloriosissima Roma, ora gran parte del mondo venera il nome romano con una dolce sottomissione piuttosto che col terrore che un tempo esso era solito suscitare. A Roma appartengono cose talmente illustri, eccelse, ammirevoli, che non si possono trovare altrove né cercare di trasferire; in primo luogo chi non abbia visto Roma, sovrana del mondo, non potrà ammirare qualcosa che si trova altrove. La stessa città, infatti, possiede la sede degli apostoli e la terra rossa del sacro sangue dei martiri. Traduzione di Giovanna Fratini 12) Vespasiano da Bisticci, Le Vite, (1490 ca.). Considerando io più volte meco medesimo di quanto lume sieno mai istati gli scrittori appresso degli antichi et de’ moderni per avere illustrate l’opere de gli uomini singulari e molti uomini degni essere perita la fama loro per non c’essere chi abbi mandato a memoria de le lettere l’opere loro, e se al tempo di Scipione Africano non fussi istato Livio e Salustio, e altri degni iscrittori, periva la fama di sì degno uomo insieme collui, né sarebe memoria di Metello, né di Ligurgo, né de’ Catone, né de Paminunda tebano, né d’infiniti uomini hanno avuti i Greci e Latini, ma per essere istati degnissimi iscrittori apresso de le dette nationi hanno fatto l’opere loro degne e sono chiare e note ne’ presenti tempi, queste sono anni mille o più che le furono. Posonsi dolere gli uomini singulari quando ne’ tempi loro non sono iscrittori iscrivano l’opere loro. Dal principio ebe origine Firenze secondo è comune openione di messer Lionardo e d’altri iscrittori degni che vogliono ch’e’ Fiorentini avessino origine da cavalieri Silani, bene che questa opinione sia molto oscura e Plinio ancora pare che voglia ch’ella sia istata assai antica, iscrivendo ch’e Fiorentini si chiamavano Fluentini per esser la città posta in mezo de’ dua fiumi che è Arno e Mugnone et per essere in mezzo de’ decti fiumi la chiamarono Fluentia. Questo è grande testimonio della sua antichità, e agiugnesi a provare questo medesimo la forma del teatro si vede e il tempio di Marte ch’è Sancto Giovanni, che si vede esser cosa antichissima e certi aquedotti sono parte in pie’, e a tutte queste cose bisogna andare per congetture, per non c’essere suti iscritori l’abino mandato a memoria de le lettere. E per questo bisognò a messer Lionardo, avendo a scrivere la istoria fiorentina durare una grandissima fatica, none trovando notitia ignuna se none d’anni circa cento cinquanta, del resto bisognò soperire co l’autorità di queste cose nominate di sopra. Vedesi che dal prencipio della città di Firenze a Dante, non furono iscritori, che sono più d’anni mille, seguitò il Petrarcha et di poi il Bocaccio che scrisono, ma de l’origine della città none fanno mentione ignuna per none avere notitia. Furono dopo Dante i dua altri poeti meser Coluccio e in teologia maestro Luigi Marsilii, uomo singularissimo e il simile in altre facultà come in astrologia, musica, geometria, arisimetrica, e di questi ancora none ho fatta alcuna mentione particulare della vita loro ma universale da alcuno iscrittore. A la presente età ha fiorito in ogni facultà d’uomini singularissimi i quali se le vite loro fussino mandate a memoria de le lettere come gli antichi per esservi stati infiniti iscrittori come furono in questa età hanno fiorite tutte e sette l’arte liberali d’uomini eccellentissimi e non solo nella lingua latina, ma ne l’ebrea e ne la greca, dottissimi... iscrittori ed eloquentissimi none inferiori a passati. 19 Venendo dipoi a la pittura, scoltura, architetura, tutte queste arti sono istate in sommo grado come si vede per l’opere loro hanno fatte, et di queste se ne potrebe nominare infiniti. De quali è mancata la fama loro solo per none avere chi abbi iscritto di loro, e non è mancato per non eserci iscrittori, che ci sono istati eloquentissimi e dotissimi, ma non hanno voluto pigliare questa fatica conoscendo in prima non c’essere chi la gusti né chi la stimi, come merita una tanta fatica che si vede che nel tempo de la filice memoria di papa Nicola e de’ re Alfonso, perché erano premiati e avuti in sommo grado, quanto degni iscrittori furono e quante degne opere furono e tradotte e composte mediante i premi dati da sì degni prencipi, quanti furono i dua nominati, la fama de’ quali è rimasta eterna, e non solo i premi ma l’onorargli et tenergli in sommo grado. Era rimasto dopo questi dua prencipi uno degnissimo successore il quale fu il Duca d’Urbino, avendo imitati questi dua sì degni prencipi d’onorare e di premiare gli uomini literati e avergli in sommo grado, e fu loro protettore in ogni cosa, e a lui ogni uomo singulare aveva ricorso in ogni loro bisogno perché a fine e’ traducesino e componessino dette loro grandissimi premi di più opere, e tradussono e composono in modo che feciono per mezo delle letere la sua memoria eterna. Mancato il Duca d’Urbino, e non sendo più né in corte di Roma, né in corte de prencipe ignuno che presti loro favore, né chi gli stimi più, donde seguiti che le lettere sono perite, e ognuno s’è tirato indrieto, veduto essere loro mancato il premio come è detto. Sendo istato in questa età e avendo veduti tanti singulari uomini, de’ quali io ho avuto asai notitia, e a fine che la fama di sì degni uomini non perisca, bene che sia alieno de la mia profesione, ho fatto memoria di tutti gli uomini dotti ho conosciuti in questa età per via d’uno brieve comentario, per dua cagioni mi sono mosso, la prima a fine che la fama di sì singulari uomini non perisca, la seconda a fine che se ignuno si volessi afaticare a farle latine ch’egli abi inanzi il mezo col quale egli lo possi fare. E a ciò che tutti questi uomini singulari abino un degno capitano il quale e’ possino imitare, e perché lo spirituale debbe tenere il principato in ogni cosa meterò papa Nicola come capo e guida di tuti, e narrerò tutte le cose a notitia de la sua sanctità con più brevità sia possibile e de sì degno uomo per tante sua laudabili conditioni, che si fosse istato al tempo degli antichi, l’arebbono ilustrato co le lettere loro. Vedrassi nella vita di sì degno pontefice quanta forza abino avute le virtù, perché si conoscerà non esere venuto a questa degnità se none con questo mezo. (Vespasiano da Bisticci, Le Vite, a cura di Aulo Greco, Istituto Nazionale di studi sul Rinascimento, Firenze 1970, vol. I, pp. 29-34) 13) Niccolò Machiavelli: Lettera a Vettori, 10 dicembre 1513. Magnifico oratori florentino Francischo Vectori apud Summum Pontificem, patrono et benefactori suo. Romae Magnifico ambasciatore. Tarde non furon mai gratie divine. Dico questo, perché mi pareva haver perduta no, ma smarrita la gratia vostra, sendo stato voi assai tempo senza scrivermi et ero dubbio donde potessi nascere la cagione. Et di tutte quelle che mi venivono nella mente tenevo poco conto, salvo che di quella quando io dubitavo non vi havessi ritirato da scrivermi, perché vi fussi suto scritto che io non fussi buono massaio delle vostre lettere; et io sapevo che, da Filippo e Pagolo in fuora, altri per mio conto non l’haveva viste. Honne rihauto per l’ultima vostra de’ 23 del passato, dove io resto contentissimo vedere quanto ordinatamente e quietamente voi exercitate cotesto offizio pubblico, et io vi conforto a seguire così, perché chi lascia e’ sua commodi per li commodi d’altri, so perde i sua, et di quelli non li è saputo grado. Et poiché la fortuna vuol fare ogni cosa, ella si vuole lasciarla fare, stare quieto e non le dare briga, et aspettar tempo che la lasci fare qualche cosa agl’huomini; e allhora starà bene a voi durare più fatica, vegliare più le cose, et a me partirmi di villa et dire: eccomi. Non posso pertanto, volendovi render pari gratie, dirvi in questa mia lettera altro che qual sia la vita mia, et se voi giudichate che sia a barattarla con la vostra, io sarò contento mutarla. Io mi sto in villa; e poi che seguirno quelli miei ultimi casi, non sono stato, ad accozarli tutti, venti dì a Firenze. Ho insino a qui uccellato a’ tordi di mia mano. Levatomi innanzi dì, impaniavo, andavone oltre con un fascio di gabbie addosso, che parevo el Geta quando e’ tornava dal porto con i libri di Anphitrione; pigliavo el meno dua, el più sei tordi. Et così stetti tutto settembre; dipoi questo badalucco, ancora che dispettoso et strano, è mancato con mio dispiacere; et qual la vita mia vi dirò. Io mi lievo la mattina con el 20 sole et vommene in uno mio bosco che io fo tagliare, dove sto dua hora a rivedere l’opere del giorno passato, et a passar tempo con quegli tagliatori, che hanno sempre qualche sciagura alle mane o fra loro o co’ vicini. E circa questo bosco io vi harei a dire mille belle cose che mi sono intervenute, et con Frosino da Panzano et con altri che voleano di queste legne. E Frosino in spetie mandò per certe cataste senza dirmi nulla, et al pagamento mi voleva rattenere dieci lire, che dice haveva havere da me quattro anni sono, che mi vinse a cricca in casa Antonio Guicciardini. Io cominciai a fare el diavolo; volevo accusare il vetturale che vi era ito per esse, per ladro; tandem Giovanni Macchiavelli vi entrò di mezzo et ci pose d’accordo. Battista Guicciardini, Filippo Ginori, Tommaso del Bene e certi altri cittadini, quando quella tramontana soffiava, ognuno me ne prese una catasta. Io promessi a tutti; e manda’ne una a Tommaso, la quale tornò in Firenze per metà, perché a rizzarla vi era lui, la moglie, la fante, e’ figliuoli, che pareno el Gabburra quando el giovedì, con quelli suoi garzoni, bastona un bue. Di modo che, veduto in chi era guadagno, ho detto agl’ altri che io non ho più legne; e tutti ne hanno fatto capo grosso, et in specie Batista, che connumera questa tra l’altre sciagure di Prato. Partitomi del bosco, io me ne vo a una fonte, et di quivi in un mio uccellare. Ho un libro sotto, o Dante o Petrarca, o un di questi poeti minori, come Tibullo, Ovvidio et simili: leggo quelle loro amorose passioni, et quelli loro amori ricordomi de’ mia: godomi un pezzo in questo pensiero. Transferiscomi poi in sulla strada, nell’hosteria, parlo con quelli che passono, domando delle nuove de’ paesi loro, intendo varie cose, et noto varii gusti et diverse fantasie d’huomini. Vienne in questo mentre l’hora del desinare, dove con la mia brigata mi mangio di quelli cibi che questa povera villa e paululo patrimonio comporta. Mangiato che ho, ritorno nell’hosteria: quivi è l’hoste, per l’ordinario, un beccaio, un mugniaio, due fornaciai. Con questi io m’ingaglioffo per tutto dì, giocando a cricca, a triche-tach, et poi dove nascono mille contese et infiniti dispetti di parole iniuriose, et il più delle volte si combatte un quattrino, et siamo sentiti non di manco, gridare da San Casciano. Così rinvolto entra questi pidocchi traggo el cervello di muffa, et sfogo questa malignità di questa mia sorta, sendo contento mi calpesti per questa via, per vedere se la se ne vergognassi. Venuta la sera, mi ritorno in casa, ed entro nel mio scrittoio; et in su l’uscio mi spoglio quella veste cotidiana, piena di fango et di loto, et mi metto panni reali et curiali; et rivestito condecentemente entro nelle antique corti delli antiqui uomini, dove, da loro ricevuto amorevolmente, mi pasco di quel cibo che solum è mio et che io nacqui per lui; dove io non mi vergogno parlare con loro, et domandarli della ragione delle loro actioni; et quelli per loro humanità mi rispondono; et non sento per quattro ore di tempo alcuna noia, sdimenticho ogni affanno, non temo la povertà, non mi sbigottisce la morte: tucto mi transferisco in loro. E perché Dante dice che non fa scienza senza lo ritenere lo havere inteso, io ho notato quello di che per la loro conversatione ho fatto capitale, et composto uno opuscolo De principatibus, dove io mi profondo quanto io posso nelle cogitationi di questo subbietto, disputando che cosa è principato, di quale spetie sono, come e’ si acquistono, come e’ si mantengono, perché e’ si perdono. Et se vi piacque mai alcuno mio ghiribizo, questo non vi doverrebbe dispiacere; et a uno principe, et maxime a un principe nuovo, doverrebbe essere accetto; però io lo indirizzo alla magnificentia di Giuliano. Philippo Casavecchia l’ha visto; vi potrà ragguagliare in parte et della cosa in sé, et de’ ragionamenti ho hauto seco, anchor che tuttavolta io l’ingrasso et ripulisco. Voi vorresti, magnifico ambasciatore, che io lasciassi questa vita et venissi a godere con voi la vostra. Io lo farò in ogni modo; ma quello che mi tenta hora è certe mie faccende che fra sei settimane l’harò fatte. Quello che mi fa stare dubbio è, che son costì quelli Soderini e’ quali io sarei forzato, venendo costì, vicitarli et parlar loro. Dubiterei che alla tornata mia io non credessi scavalcare a casa, et scavalcassi nel Bargiello, perché, ancora che questo stato habbi grandissimi fondamenti et gran securtà, tamen egli è nuovo, et per questo sospettoso, né ci manca de’ saccenti, che, per parere come Pagolo Bertini, metterebbono altri a scotto, et lascierebbono el pensiero a me. Pregovi mi solviate questa paura, et poi verrò infra el tempo detto a trovarvi a ogni modo. Io ho ragionato con Filippo di questo mio opuscolo, se gli era ben darlo o non lo dare; et sendo ben darlo, se gli era bene che io lo portassi, o che io ve lo mandassi. El non lo dare mi faceva dubitare che da Giuliano e’ non fussi, non ch’altro, letto, et che questo Ardinghelli si facessi onore di questa ultima mia faticha. El darlo mi faceva la necessità che mi caccia, perché io mi logoro, et lungo tempo non posso star così, che io non diventi per povertà contennendo, appresso al desiderio harei che questi signori Medici mi 21 cominciassino adoperare, se dovessino cominciare a farmi voltolare un sasso; perché, se poi io non me li guadagnassi, io mi dorrei di me; et per questa cosa, quando la fussi letta, si vedrebbe che quindici anni che io sono stato a studio dell’arte dello stato, non gli ho né dormiti né giuocati; et doverrebbe ciascheduno haver caro servirsi d’uno che alle spese d’altri fussi pieno di exsperientia. Et della fede mia non si doverrebbe dubitare, perché, havendo sempre observato la fede, io non debbo imparare ora a romperla; et chi è stato fedele et buono quarantatré anni, che io ho, non debbe poter mutare natura; et della fede et bontà mia ne è testimonio la povertà mia. Desidererei adunque che voi ancora mi scrivessi quello che sopra questa materia vi paia et a voi mi raccomando. Sis felix. Die 10 decembris 1513. (Niccolò Machiavelli, Lettere, a cura di Franco Gaeta, Feltrinelli, Milano 1961, pp. 301-306) 14) Baldassarre Castiglione e Raffaello, Lettera a Leone X, 1519. Sono molti, Padre Santissimo, i quali misurando col loro picciolo giudicio le cose grandissime che delli Romani circa l’arme, e della Città di Roma circa al mirabile artificio, ai ricchi ornamenti e alla grandezza degli edifici si scrivono, quelle più presto stimano favolose che vere. Ma altrimenti a me suole avvenire, perché considerando delle reliquie che ancor si veggono delle ruine di Roma la divinità di quegli animi antichi, non istimo fuor di ragione il credere che molte cose a noi paiano impossibili che ad essi erano facilissime. Però, essendo io stato assai studioso di queste antiquità e avendo posto non picciola cura in cercarle minutamente e misurarle con diligenza, e, leggendo i buoni autori, confrontare l’opere con le scritture, penso di aver conseguito qualche notizia dell’architettura antica. Il che in un punto mi dà grandissimo piacere, per la cognizione di cosa tanto eccellente, e grandissimo dolore, vedendo quasi il cadavere di quella nobil patria, che è stata regina del mondo, così miseramente lacerato. Onde se ad ognuno è debita la pietà verso i parenti e la patria, tengomi obbligato di esporre tutte le picciol forze mie, acciocché più che si può resti vivo un poco della immagine, e quasi l’ombra di questa, che in vero è patria universale di tutti li cristiani, e per un tempo è stata tanto nobile e potente, che già cominciavano gli uomini a credere ch’essa sola sotto il cielo fosse sopra la fortuna e, contro il corso naturale, esente dalla morte, e per durare perpetuamente. Però parve che il tempo, come invidioso della gloria de’ mortali, non confidatosi pienamente delle sue forze sole, si accordasse con la fortuna e con li profani e scellerati Barbari, li quali alla edace lima e venenato morso di quello aggiunsero l’empio furore e ‘l ferro e il fuoco e tutti quelli modi che bastavano per ruinarla. Onde quelle famose opere che oggidì più che mai sarebbono floride e belle, furono dalla scellerata rabbia e crudele impeto de’ malvagi uomini, anzi fiere, arse e distrutte: sebbene non tanto che non vi restasse quasi la macchina del tutto, ma senza ornamenti, e, per dir così, l’ossa del corpo senza carne. Ma perché ci doleremo noi de’ Goti, Vandali e d’altri tali perfidi nemici, se quelli li quali come padri e tutori dovevano difender queste povere reliquie di Roma, essi medesimi hanno lungamente atteso a distruggerle? Quanti Pontefici, Padre Santissimo, li quali avevano il medesimo officio che ha Vostra Santità, ma non già il medesimo sapere, né il medesimo valore e grandezza d’animo, né quella clemenza che la fa simile a Dio: quanti, dico, Pontefici hanno atteso a ruinare templi antichi, statue, archi e altri edifici gloriosi! Quanti hanno comportato che solamente per pigliar terra pozzolana si sieno scavati dei fondamenti, onde in poco tempo poi gli edifici sono venuti a terra! Quanta calce si è fatta di statue e d’altri ornamenti antichi! che ardirei dire che tutta questa Roma nuova che ora si vede, quanto grande ch’ella si sia, quanto bella, quanto ornata di palagi, chiese e altri edifici che la scopriamo, tutta è fabricata di calce e marmi antichi. Né senza molta compassione posso io ricordarmi che poi ch’io sono in Roma, che ancor non è l’undecimo anno, sono state ruinate tante cose belle, come la Meta che era nella via Alessandrina, l’Arco mal avventurato, tante colonne e tempi, massimamente da messer Bartolommeo dalla Rovere. Non deve adunque, Padre Santissimo, essere tra gli ultimi pensieri di Vostra Santità lo aver cura che quel poco che resta di questa antica madre della gloria e della grandezza italiana, per testimonio del valore e della virtù di quegli animi divini, che pur talor con la loro memoria eccitano alla virtù gli spiriti che oggidì sono tra noi, non sia estirpato, e guasto dalli maligni e ignoranti; che pur troppo si sono infin qui fatte 22 ingiurie a quelle anime che col loro sangue partoriscono tanta gloria al mondo. Ma più presto cerchi Vostra Santità, lasciando vivo il paragone degli antichi, agguagliarli e superarli, come ben fa con grandi edifici, col nutrire e favorire le virtuti, risvegliare gl’ingegni, dar premio alle virtuose fatiche, spargendo il santissimo seme della pace tra li principi cristiani. Perché come dalla calamità della guerra nasce la distruzione e ruina di tutte le discipline ed arti, così dalla pace e concordia nasce la felicità a’ popoli, e il laudabile ozio per lo quale ad esse si può dar opera e farci arrivare al colmo dell’eccellenza, dove per lo divino consiglio di Vostra Santità sperano tutti che si abbia da pervenire al secolo nostro. E questo è lo essere veramente Pastore clementissimo, anzi Padre ottimo di tutto il mondo. Essendomi adunque comandato da Vostra Santità ch’io ponga in disegno Roma antica, quanto conoscere si può per quello che oggidì si vede, con gli edifici che di sé dimostrano tali reliquie, che per vero argomento si possono infallibilmente ridurre nel termine proprio come stavano, facendo quelli membri che sono in tutto ruinati, né si veggono punto corrispondenti a quelli che restano in piedi e si veggono, ho usato ogni diligenza a me possibile, accioché l’animo di Vostra Santità resti senza confusione ben satisfatto. E benché io abbia cavato da molti autori latini quello che intendo di dimostrare, però tra gli altri principalmente ho seguitato Publio Victore, il quale, per esser stato degli ultimi, può dar più presto particolar notizia delle ultime cose. E perché forse a Vostra Santità potrebbe parere che difficil fosse il conoscere gli edifici antichi dalli moderni, o li più antichi dalli meno, non pretermetterò ancor le vie antiche, per non lasciar dubbio alcuno nella sua mente. Anzi, dico che con poca fatica far si può, perché tre sorti di edifici in Roma si trovano: l’una delle quali sono tutti gli antichi ed antichissimi, li quali durarono fin al tempo che Roma fu ruinata e guasta da’ Gotti e altri barbari; l’altra, tanto che Roma fu dominata da’ Gotti, e ancor cento anni dappoi; l’altra, da quello fin alli tempi nostri. Gli edifici adunque moderni e de’ tempi nostri sono notissimi, sì per esser nuovi, come ancor per non avere la maniera così bella come quelli del tempo degl’imperatori, né così goffa come quelli del tempo de’ Gotti; di modo che, benché siano più distanti di spazio e di tempo, sono però più prossimi per la qualità, e posti quasi tra l’uno e l’altro. E quelli del tempo de’ Gotti, benché siano prossimi di tempo a quelli del tempo degl’imperatori, sono differentissimi di qualità, e come due estremi, lasciando nel mezzo li più moderni. Non è adunque difficile il conoscere quelli del tempo degl’imperatori, i quali sono li più eccellenti, e fatti con grandissima arte e bella maniera d’architettura; e questi soli intendo io di dimostrare: né bisogna che in cuore d’alcuno nasca dubbio che, degli edifici antichi, li meno antichi fossero meno belli, o meno intesi, perché tutti erano d’una ragione. E benché molte volte molti edifici dalli medesimi antichi fossero instaurati, come si legge che nel luogo dove era la casa aurea di Nerone, nel medesimo dappoi furono edificate le terme di Tito e sia la casa e l’anfiteatro, nientedimeno erano fatte con la medesima ragione degli altri edifici ancor più antichi che il tempo di Nerone, e coetanei della casa aurea. E benché le lettere, la scultura, la pittura e quasi tutte l’altre arti fossero lungamente ite in declinazione, e peggiorando fin al tempo degli ultimi imperatori, pure l’architettura si osservava e manteneva con buona ragione, ed edificavasi con la medesima che li primi. E questa fu tra l’altre arti l’ultima che si perdé. Il che si può conoscere da molte cose, e tra l’altre da l’arco di Costantino, il componimento del quale è bello e ben fatto in tutto quello che appartiene all’architettura, ma le sculture del medesimo arco sono sciocchissime, senza arte o bontate alcuna. Ma quelle che vi sono delle spoglie di Traiano e d’Antonino Pio, sono eccellentissime e di perfetta maniera. Il simile si vede nelle terme diocleziane, che le sculture sono goffissime e le reliquie di pittura che vi si veggono non hanno che fare con quelle del tempo di Traiano e Tito: pure, l’architettura è nobile e bene intesa. Ma poi che Roma da’ Barbari in tutto fu ruinata e arsa, parve che quello incendio e misera ruina ardesse e ruinasse, insieme con gli edifici, ancor l’arte dello edificare. Onde essendosi tanto mutata la fortuna de’ Romani, e succedendo in luogo delle infinite vittorie e trionfi la calamità e misera servitù, quasi che non convenisse a quelli che già erano soggiogati e fatti servi dalli barbari abitare di quel modo e con quella grandezza che facevano quando essi avevano soggiogati li barbari, subito con la fortuna si mutò il modo dell’edificare e dello abitare, e apparve un estremo tanto lontano dall’altro, quanto è la servitù dalla libertà, e si ridusse a maniera conforme alla sua miseria, senza arte, senza misura, senza grazia alcuna. E parve che gli uomini di quel tempo, insieme con la libertà, perdessero tutto l’ingegno e l’arte, perché divennero tanto goffi, che non seppero fare li mattoni cotti, nonché altra sorte d’ornamenti, e scrostavano li muri antichi 23 per torre le pietre cotte e pestavano li marmi e con essi muravano, dividendo con quella mistura le pareti di pietra cotta, come ora si vede a quella torre che chiamano della Milizia. E così per buono spazio seguirono con quella ingoranza che in tutte le cose di quei tempi si vede, e parve che non solamente in Italia venisse questa atroce e crudele procella di guerra e distruzione, ma si diffondesse ancora nella Grecia, dove già furono gl’inventori e perfetti maestri di tutte l’arti. Onde di là ancor nacque una maniera di pittura, scultura e architettura pessima e di nessun valore. Parve dappoi che i Tedeschi cominciassero a risvegliare un poco questa arte, ma negli ornamenti furono goffi e lontanissimi dalla bella maniera de’ Romani, li quali oltre la macchina di tutto l’edificio, avevano bellissime cornici, belli fregi, architravi, colonne ornatissime di capitelli e basi, e misurate con la proporzione dell’uomo e della donna. E li Tedeschi (la maniera de’ quali in molti luoghi ancor dura) per ornamento spesso ponevano solamente un qualche figurino rannicchiato e mal fatto per mensola, a sostenere un trave, e animali strani e figure e fogliami goffi e fuori d’ogni ragione naturale. Pur ebbe la loro architettura questa origine, che nacque dagli arbori non ancor tagliati, li quali, piegati li rami e rilegati insieme, fanno li loro terzi acuti. E benché questa origine non sia in tutto da sprezzare, pure è debole, perché molto più reggerebbono le capanne fatte di travi incatenate e poste a uso di colonne con li culmini e coprimenti (come descrive Vitruvio della origine dell’epoca dorica), che li terzi acuti, li quali fanno due centri. E però molto più sostiene, secondo la ragione mattematica, un mezzo tondo, il quale ogni sua linea tira ad un centro solo, perché, oltre la debolezza, un terzo acuto non ha quella grazia all’occhio nostro, al quale piace la perfezione del circolo, onde vedesi che la natura non cerca quasi altra forma. Ma non è necessario parlare dell’architettura romana per farne paragone con la barbara, perché la differenza è notissima, né ancor per descrivere l’ordine suo, essendone stato già tanto eccellentemente scritto per Vitruvio. Basti dunque sapere che gli edifici di Roma, insino al tempo degli ultimi imperatori, furono sempre edificati con buona ragione d’architettura, e però concordavano con li più antichi. Onde difficoltà alcuna non è discernerli da quelli che furono al tempo de’ Gotti e ancor molti anni dappoi, perché furono quasi due stremi ed opposti totalmente. Né ancor è malagevole il conoscerli dalli nostri moderni, per molte qualità, ma specialmente per la novità, che li fa notissimi. Avendo dunque abbastanza dichiarato quali edifici antichi di Roma sono quelli ch’io intendo di dimostrare a Vostra Santità, conforme alla sua intenzione, ed ancor come facil cosa sia il conoscere quelli dagli altri, resta ch’io dica il modo che ho tenuto in misurarli e disegnarli, acciocché Vostra Santità sappia s’io averò operato l’uno e l’altro senza errore, e perché conosca che nella descrizione che seguirà non mi sono governato a caso e per la pratica, ma con vera ragione. E per non aver io infin a mo’ veduto scritto, né inteso che sia appresso d’alcuno antico il modo di misurare con la bussola della calamita (il quale modo soglio usare io), stimo che sia invenzione de’ moderni. E però volendo anche in questo ubbidire al comandamento di Vostra Santità, dirò minutamente come si abbia da adoperare, prima che si passi ad altro. Farassi adunque un instromento tondo e piano, come un astrolabio, il diametro del quale sarà due palmi o più o meno, come piace a chi vuole adoperarlo, e la circonferenza di questo istromento si partirà in otto parti giusti, e a ciascuna di quelle parti si porrà il nome d’uno degli otto venti, dividendola in trentadue altre parti picciole, che si chiameranno gradi. Così dal primo grado di Tramontana, farà il primo d’Ostro. Medesimamente si tirerà pur dalla circonferenza un’altra linea, la quale passando per lo centro intersecherà la linea d’Ostro e Tramontana, e farà introno al centro quattro angoli retti, e in un lato della circonferenza segnerà il primo grado del Levante, nell’altro il primo di Ponente. Così tra queste linee che fanno li soprascritti quattro venti principali resterà lo spazio degli altri quattro collaterali, che sono Greco, Lebechio, Maestro e Scirocco. E questi si descriveranno con li medesimi gradi e modi che si è detto degli altri. Fatto questo, nel punto del centro dove s’intersecano le linee conficcheremo un umbilico di ferro, come un chiodetto, drittissimo e acuto, e sopra questo si metterà la calamita in bilancia, come si usa di fare negli oriuoli da sole che tuttodì veggiamo. Poi chiuderemo questo luogo della calamita con un vetro, ovvero con un sottile corno trasparente, ma che non tocchi, per non impedire il moto di quella né sia sforzato dal vento. Dappoi per mezzo dell’instromento, come diametro, si manderà un indice, il quale sarà sempre dimostrativo non solamente degli opposti venti, ma ancor de’ gradi, come l’armilla nell’astrolabio. E questo si chiamerà "traguardo", e sarà acconcio di modo che si potrà volgere intorno, stante fermo il resto dell’instromento. 24 Con questo adunque misureremo ogni sorte di edificio, di che forma sia, o tondo o quadro o con istrani angoli e svoglimenti quanto dir si possa. E il modo è tale: che nel luogo che si vuol misurare si ponga lo instromento ben piano, acciocché la calamita vada al suo dritto e s’accosti alla parte da misurarsi quanto comporta la circonferenza dell’instromento. E questo si vada volgendo tanto che la calamita sia giusta verso il vento degnato per Tramontana. Dappoi guardisi a quel vento e a quanti gradi è volta per diritta linea quella parete, la quale si misurerà con la canna o cubito o palmo, fin a quel termine che il traguardo porta per dritta linea, e questo numero si noti, cioè tanti cubiti e tanti gradi di Ostro e Scirocco o quale si sia. Dappoi che il traguardo non serve più per dritta linea, devesi allora svogliere, cominciando l’altra linea che si ha da misurare, dove termina la misurata, e così indirizzandola a quella, medesimamente notare i gradi del vento e il numero delle misure fin tanto che si circuisca tutto lo edificio. E questo stimo io che basti quanto al misurare, benché bisogna intendere le altezze e i tondi, li quali si misurano in altra maniera, come poi si mostrerà a luogo più accomodato. Avendo misurato di quel modo che si è detto, e notate tutte le misure e prospetti, cioè tante canne o palmi, a tanti gradi di tal vento, per disegnare bene il tutto è opportuno aver una carta della forma e misura propria della bussola della calamita, e partita appunto di quel medesimo modo, con li medesimi gradi delli venti, della quale ci serviremo come mostrerò. Piglierassi dunque la carta sopra la quale si ha a disegnar lo edificio, e primamente si tirerà sopra d’essa una linea, la quale serva quasi per maestra, al diritto di Tramontana. Poi vi si sovrappone la carta dove si ha disegnata la bussola e si drizza di modo che la linea di Tramontana nella bussola disegnata si convenga con quella che si è tirata nella carta dove si ha a disegnare lo edificio. Dappoi guardasi i numero delli piedi che si notarono misurando e li gradi di quel vento verso il quale è indirizzato il muro o via che si vuol disegnare. E così trovasi il medesimo grado di quel vento nella bussola disegnata, tenendola ferma con la linea di Tramontana sopra la linea descritta nella carta, e tirasi la linea di quel grado dritta, che passi per lo centro della bussola disegnata, e si descrive nella carta dove si vuole disegnare. Dappoi riguardasi quanti piedi si traguardò per dritto di quel grado, e tanti se ne segneranno con la misura delli nostri piccioli piedi su la linea di quel grado. E se, verbi gratia, si traguardò in un muro di piedi 30 a gradi 6 di Levante, si misurano piedi 30 e segnansi. E così di mano in mano, di modo che con la pratica si farà una facilità grandissima, e sarà questo quasi un disegno della pianta e un memoriale per disegnare tutto il restante. E perché secondo il mio giudizio molti s’ingannano circa il disegnare gli edifici, che in luogo di far quello che appartiene all’architetto, fanno quello che appartiene al pittore, dirò qual modo mi pare che s’abbia a tenere perché si possano intendere tutte le misure giustamente, e perché si sappiano trovare tutti li membri degli edifici senza errore. Il disegno adunque degli edifici si divide in tre parti, delle quali la prima è la pianta, o vogliamo dire disegno piano, la seconda è la parte di fuori con li suoi ornamenti, la terza è la parete di dentro pur con li suoi ornamenti. La pianta è quella che comparte tutto lo spazio piano del luogo da edificare, o vogliamo dire il disegno del fondamento di tutto lo edificio, quando già è radente al piano della terra. Il qual spazio, benché fosse in monte, bisogna ridurre in piano e far che la linea delle basi del monte sia parallela con la linea delle basi de’ piani dello edificio. E per questo devesi pigliare la linea dritta del piede del monte e non la circonferenza dell’altezza, di modo che sopra quella cadano piombati e perpendicolari tutti li muri. E chiamasi questo disegno "pianta", quasi che come lo spazio che occupa la pianta del piede, che è fondamento di tutto il corpo, così questa pianta sia fondamento di tutto lo edificio. Disegnata che si ha la pianta e compartitovi li suoi membri con le larghezze loro, o in tondo o in quadro o in qual’altra forma si sia, devesi tirare, misurando sempre il tutto con la picciola misura, una linea della larghezza delle basi di tutto lo edificio. E dal punto di mezzo di questa linea tirare un’altra linea dritta, la quale faccia dall’un canto e dall’altro due angoli retti: e questa sia la linea della intrata dello edificio. Dalle due estremità della linea della larghezza tireransi due linee parallele perpendiculari sopra la linea della base, e queste due linee sieno alte quanto ha da essere lo edificio. Dappoi, tra queste due estreme linee che fanno l’altezza, si pigli la misura delle colonne, pilastri, finestre e altri ornamenti disegnati nella metà della pianta di tutto lo edificio dinanzi, e da ciascun punto delle estremità delle colonne o pilastri e vani, ovvero ornamenti di finestre, si farà il tutto, sempre tirando linee parallele a quelle due estreme. Dappoi per lo traverso si ponga l’altezza delle basi, delle colonne, delli capitelli, degli architravi, delle finestre, fregi, cornici e cose tali: e questo tutto si faccia con linee parallele della linea del piano dello edificio. 25 Né si diminuisca nella estremità dell’edificio, ancorché fosse tondo, né ancor se fosse quadro, per fargli mostrar due faccie, come fanno alcuni, diminuendo quella che si allontana più dall’occhio, che è ragione di prospettiva e appartiene al pittore, non all’architetto, il quale dalla linea diminuita non può pigliare alcuna giusta misura: il che è necessario a questo artificio, che ricerca tutte le misure perfette in fatto, non quelle che appaiono e non sono. Però al disegno dell’architetto s’appartengono le misure tirate sempre con linee parallele per ogni verso. E se le misure fatte talora sopra pianta di forma tonda scortano, ovvero diminuiscono, ovvero fatte pur sopra il dritto in triangolo o altre forme, subito si ritrovano nel disegno della pianta, e quello che scorta nella pianta, come volte, archi e triangoli, è poi perfetto nelli suoi dritti disegni. E per questo è sempre bisogno aver pronte le misure giuste de’ palmi, piedi, dita, grani, fino alle sue parti minime. La terza parte di questo disegno è quella che abbiamo chiamata la parete di dentro con li suoi ornamenti. E questa è necessaria non meno che l’altre due, ed è fatta medesimamente dalla pianta con le linee parallele, come la prte di fuori, e dimostra la metà dell’edificio di dentro come se fosse diviso per mezzo: dimostra il cortile, la corrispondenza dell’altezza delle cornici di fuori con quelle di dentro, l’altezza delle finestre, delle porte, gli archi delle volte a botte o a crociera o che a altra foggia si sieno. E questa via abbiamo seguitata noi, come si vederà nel progresso di tutta questa nostra descrizione, alla quale essendo ormai tempo ch’io dia principio, porrò prima qui appresso il disegno d’un solo edificio in tutti i tre sopradetti modi, perché appaia ben chiaro quanto ho detto. Se poi nel rimanente io averò tanta ventura quanta mi viene in ubbidire e servire a Vostra Santità, primo e supremo Principe in terra della cristianità, siccome potrò dire d’esser fortunatissimo fra tutti li suoi più devoti servitori, così anderò predicando di riconoscere l’occasione di essa mia avventura dalla santa mano di Vostra Beatitudine, alla quale bacio umilissimamente li santissimi piedi. (Baldassarre Castiglione, Le lettere, a cura di Guido La Rocca, I, Mondadori, Milano 1978, pp. 531-542). 15) Erasmo da Rotterdam, Lettera a Leone X, 1 febbraio 1516. Leoni Decimo pontifici modis omnibus summo Erasmus Roterodamus theologorum infimus salutem dicit. Inter tot egregia decora, Leo decime, pontifex maxime, quibus undique clarus et suspiciendus ad Pontificiae dignitatis culmen adisti - hinc infinitis Mediceae domus ornamentis, non minus eruditorum hominum monumentis quam maiorum tuorum imaginibus et honoribus inclytae; hinc innumeris corporis animique dotibus, quas partim divini Numinis indulsit benignitas, partim eadem aspirante tua paravit industria. Non alia res te verius aut magnificentius illustravit quam quod ad istum honorem, quo maior inter homines homini non potest contigere, parem morum attuleris innocentiam: neque vero vitam modo ab omni dedecore longe lateque semotam, verum etiam famam nulla unquam sinistri rumoris labe aspersam. Id quod cum ubique difficillimum est, tum praecipue Rhomae: cuius urbis tanta est libertas, ne dicam petulantia, ut illic a conviciis parum tuta sit et integritas, ac ne ii quidem absint a crimine qui plurimum absunt a viciis. Quibus rebus factum est ut Leoni non paulo plus verae laudis pepererit, quod summum Pontificium promeruisset, quam quos accepisset. Iam in ipsa pulcherrimi simul et sanctissimi muneris functione cum tot praeclaris factis, tot eximiis virtutibus, susceptum honorem vicissim cohonestes, nihil tamen est quod te superis pariter et mortalibus commendet efficacius quam quod summo studio parique sapientia illud potissimum agis ac moliris, ut in dies in melius provehatur Christiana pietas, hactenus temporum maximeque bellorum vicio nonnihil labefacta collapsaque, ut est caeterarum item omnium rerum humanarum natura, ni manibus pedibusque obnitamur, paulatim in deterius relabi velutique degenerare. At res egregias aliquoties ut difficilius, ita et pulchrius est restituisse quam condidisse. Proinde quando tu nobis velut alterum exhibes Esdram, et sedatis, quod in te fuit, bellorum procellis, sarciendae religionis provinciam strenue capessis, par est nimirum ut omnes ubique gentium ac terrarum Christiani rem omnium pulcherrimam ac saluberrimam conantem pro sua quisque facultate adiuvent. Iam video passim excellentes ingenio viros, ceu magnos et opulentos reges, Solomoni nostro in templi structuram mittere marmora, ebur, aurum, gemmas. Nos tenues reguli seu potius homunculi qualescunque materias aut certe caprarum pelles, ne nihil conferremus, mittere studemus: vile quidem munusculum, quod ad nostram attinet operam, sed unde (nisi me fallit animus) Christi templo, si non multum 26 splendoris, certe non parum utilitatis sit accessurum; praesertim si eius calculo comprobetur, de cuius unius nutu ac renutu summa rerum humanarum pendet universa. Etenim cum illud haberem perspectissimum, praecipuam spem planeque, sacram, ut aiunt, ancoram restituendae sarciendaeque Christianae religionis in hoc esse sitam, si quotquot ubique terrarum Christianam philosophiam profitentur, in primis autoris sui decreta ex Evangelicis Apostolicisque literis imbibant, in quibus verbum illud coeleste, quondam e corde Patris ad nos perfectum, adhuc nobis vivit, adhuc spirat, adhuc agit et loquitur, sic ut mea quidem sententia nusquam alias efficacius aut praesentius: ad haec, cum viderem salutarem illam doctrinam longe purius ac vividius ex ipsis peti venis, ex ipsis hauriri fontibus, quam ex lacunis aut rivulis, Novum (ut vocant) Testamentum universum ad Graecae originis fidem recognovimus, idque non temere neque levi opera sed adhibitis in consilium compluribus utriusque linguae codicibus, nec iis sane quibuslibet, sed vetustissimis simul et emendatissimis. Et quoniam novimus in rebus sacris religiose quoque versandum esse, nec hac contenti diligentia per omnia veterum theologorum scripta circumvolantes, ex horum citationibus aut expositionibus subodorati sumus quid quisque legisset aut mutasset. Adiecimus Annotationes nostras, quae primum lectorem doceant quid qua ratione fuerit immutatum: deinde, si quid alioqui perplexum, ambiguum aut obscurum, id explicent atque enodent: postremo quae obsistant quo minus proclive sit in posterum depravare quod nos vix credendis vigiliis restituissemus. Quanquam, ut ingenue dicam, quicquid hoc est operis videri poterat humilius quam ut ei dicandum esset quo nihil maius habet hic orbis; nisi conveniret ut quicquid ad religionem instaurandam pertinet, haud alii consecretur quam summo religionis principi et eidem assertori. Neque metus est ne munus hoc nostrum qualecunque sis aspernaturus, qui non loco tantum referas illum qui donaria non preciis sed animis solitus sit aestimare, qui duo minutula pauperculae viduae splendidis et opimis divitum donariis praetulerit. Iam an non cotidie videmus inter auro gemmisque radiantia regum donaria pratensibus flosculis aut hortensibus herbulis concinnatas corollas suspendi divis, quas re tenuis, pietate dives offert plaebecula? Alioqui quicquid illud est seu magnum seu pusillum, seu ludicrum seu saerium, quod huius ingenioli fundus produxerit, id omne, ut nullus dedicem, suopte iure sibi potest vindicare summus ille apud suos virtutum ac literarum omnium Mecoenas et antistes, Gulielmus Vuaramus archiepiscopus Cantuariensis, totius Angliae non tituli tantum honore primas, ac tuae sanctitatis legatus, ut vocant, natus: cui meipsum quoque quantus quantus sum debeo, non modo universum studii mei proventum. Siquidem is (ut ne dicam interim cuiusmodi tum publicae tum privatim in me fuerit) id praestat suae Britanniae quod Leo praestat orbi terrarum: quodque medicea domus iam olim est Italiae vel hoc nomine terrarum omnium felicissimae, hoc is suis est Anglis, ceu salutare quoddam sidus, ab ipsis fatis in hoc datus ut eo praeside quicquid est bonarum rerum repullulet ac subolescat. Nam perinde quasi uno in homine plures sint heroes et unicum pectus non simplex inhabitet numen, ita miris modis archiepiscopum gerit ecclesiae, legatum sedi Rhomanae, consiliarium regiae, cancellarium iusticiae, Mecoenatem studiis; cuius opera potissimum factum est ut insula iam olim viris, armis opibusque pollens, nunc optimis item legibus, religione, moribus, ad extremum ingeniis omni literarum genere perpolitis adeo floreat ut cum quavis caeterarum regionum possit ex aequo contendere. Verum quo latius huius laboris nostri manaret utilitas, visum est tui nominis apud omnes sacrosancti ceu lenocinio quodam ad publicam orbis abuti commoditatem, praesertim cum huc vocet ipsa quoque rei ratio; quod pulchre congruebat ut illius auspiciis haec Christiana philosophia dirivaretur ad omneis mortales, qui Christianae religionis teneret arcem, ac per eum proficisceretur doctrina coelestis ad universos homines, per quem Christus nos voluit accipere quicquid homines e terris evehit in coelum. Quanquam adeo quid tandem vetat quo minus hic liber gemina commendatione fultus, hoc etiam felicius et auspicatius exeat in manus hominum, si duobus totius orbis summatibus viris communiter fuerit consecratus? quandoquidem aris templisque videmus hoc plus accedere maiestas ac venerationis, quod pluribus simul divis sint dedicata. Iam hoc quantumlibet novum videatur, modo publicae conducat utilitati. Et ea est Leonis modestia facilitasque, ut hac parte non minus sit maximus quam ea qua maximos omnes longo superat intervallo. Et ea est Archiepiscopi in omni decorum genere praestantia, ut Leonem omnibus numeris summum non alius magis deceat collega. Postremo si fas est apud tantum Principem nonnihil Thrasonis e comoedia referre, quantumvis in speciem humilis videatur hic meus labor, tamen confido futurum ut attentus lector aliquanto plus deprehendat in secessu quam prima statim fronte prae se ferat opus. 27 Sed ne celsitudinem tuam iugi sollicitudine terrarum orbi consulentem longiore sermone remorans in publica peccem commoda, quod reliquum est cum plebeio lectore transigam; sed prius illud apprecatus, ut cuius providentia Leo decimus contigit sublevandis rebus mortalium, idem eum nobis et quam maxime longaevum esse velit et felicissimum. Basileae anno restitutae salutis MDXVI calendis februariis. (Erasmo da Rotterdam, Lettera a Leone X, in Opus epistolarum Desiderii Erasmi Roterodami, a cura di P. S. Allen, II, Claredon Press, Oxford 1910, pp. 184-187) (TRADUZIONE ITALIANA) Molte sono, o Leone X, Pontefice Massimo, le esimie virtù tramite le quali, reso ovunque insigne e venerando, accedesti al culmine della dignità pontificia, da una parte per le infinite glorie della casa Medicea, celebre per i meriti dei suoi uomini eruditi non meno che per le gloriose figure e gli onori dei tuoi antenati, dall’altra per le innumerevoli doti fisiche e spirituali, che furono da un lato concesse dalla divina benevolenza, dall’altro dalla tua operosità favorita dal Cielo. Non c’è però prerogativa che ti caratterizza in modo più luminoso del fatto di aver apportato a questa carica onorifica, la più alta, tra gli uomini, che si possa ricoprire, una adeguata integrità di costumi, una vita assolutamente lontana da qualsiasi indegnità e una fama mai contaminata da alcuna maldicenza. La qual cosa è sempre piuttosto difficile a realizzarsi, e particolarmente a Roma, dove c’è una tale disinvoltura, per non dire petulanza, nello sparlare, che la stessa virtù non è affatto al sicuro dalle calunnie, così come neppure quelli che si astengono dal vizio sono immuni da critiche. Perciò Leone si è guadagnato gloria assai più vera, per aver meritato il Papato, piuttosto che per averlo ottenuto. Nell’esercizio di un Ministero bellissimo e santissimo come questo, onori, con le tue illustri azioni, le tue insigni virtù, l’eccelsa carica conseguita; non vi è niente, tuttavia, che ti raccomanda ai Celesti e ai mortali più efficacemente della grande energia e della pari saggezza con cui tendi al continuo incremento della fede cristiana, assai indebolita e scaduta a causa dei tempi e in special modo delle guerre, come è, d’altronde, nella natura di tutte le altre cose umane, che, se non ci opponiamo con tutti i mezzi a disposizione, tendono a deteriorarsi, e, per così dire, a degenerare. Ma, talvolta, come è più difficile, così è più meritorio restaurare un edificio che fondarlo. E poiché tu, per noi novello Esdra, avendo placato, per quanto sta in te, le bellicose procelle, cerchi strenuamente di risanare la religione, è certamente giusto che tutti i cristiani della terra, ciascuno in base alle proprie possibilità, ti aiutino a raggiungere un fine così nobile e salutare. Vedo già uomini d’eccellente ingegno, re grandi e opulenti, inviare al nostro Salomone marmi, avorio, oro, pietre preziose per la costruzione del tempio. Noi reucci di poco conto, o piuttosto omuncoli, ci prodighiamo a mandare, per contribuire, del materiale ordinario o addirittura della pergamena, misero dono, in realtà, quale si addice al nostro lavoro, ma che, se non m’inganno, arrecherà al tempio di Cristo, se non molto splendore, certamente non poca utilità, specialmente ove ottenga l’approvazione di Colui dal cui assenso o rifiuto dipende il governo di tutte le umane cose. Io credo che la megliore garanzia per il restauro e il risanamento della religione cristiana consista nel fatto di diffondere ovunque gli studi sacri, vera ancora divina, in modo tale che tutti possano attingere alle massime del suo Fondatore tramite gli scritti evangelici ed apostolici, in cui spira ancora, ancora si agita e parla, secondo me con più efficace immediatezza che altrove, quel Verbo celeste venuto a noi un giorno dal cuore del Padre; inoltre, mi sembra che questa salutare dottrina sia di gran lunga più pura e vivida se attinta dalle sue stesse sorgenti e studiate nelle sue stesse fonti, piuttosto che nei canali secondari o nelle acque stagnanti. Perciò abbiamo rivisto tutto il Nuovo Testamento sulla base degli originali greci, e non con sconsideratezza e leggerezza, ma ricorrendo alla consultazione di numerosi codici nelle due lingue, e non già i primi venuti, ma i più antichi e i più corretti. E poiché sappiamo che nelle cose sacre si deve procedere con adeguata reverenza, non contenti di tale diligenza, passando in rassegna tutti gli scritti degli antichi teologi, abbiamo dedotto dalle loro citazioni e dai loro commenti quale fosse la lezione che essi avevano seguito o mutato. Abbiamo aggiunto delle nostre annotazioni, che istruiscano il lettore sui criteri seguiti nella scelta delle varianti ed anche per spiegare eventuali difficoltà o chiarire passi ambigui ed oscuri, per evitare che in seguito possa corrompersi quel testo che abbiamo ricostituito con grandissima fatica. Per parlare sinceramente, questo lavoro può sembrare troppo modesto per essere dedicato a Colui cui nessuno al mondo è superiore; del resto è opportuno che tutto ciò che pertiene al rinnovamento della religione a 28 nessun altro sia consacrato se non al Sommo Capo e propugnatore di essa. Né vi è rischio che tu sprezzi questo nostro omaggio, quantunque modesto, poiché rappresenti Colui che è solito valutare le offerte non in base al valore materiale, ma secondo l’animo con cui vengono fatte, che preferì i due oboli della povera vedova agli splendidi e opulenti doni dei ricchi. Forse non vediamo ogni giorno appese ai sacri altari, fra doni regali risplendenti d’oro e di gemme, le ghirlande intrecciate di fiorellini campestri o di umili frutti dell’orto, offerte dal popolo, povero di mezzi, ma ricco di spirito religioso? Del resto qualunque cosa, grande o piccola, importante o meschina, il campicello di questo mio povero ingegno abbia prodotto, dichiaro che appartiene tutto e di buon diritto a quell’illustre Prelato, eminentissimo tra i suoi concittadini, Mecenate dei virtuosi e di tutti i letterati, cui debbo non solo ogni risultato utile dei miei studi, ma tutto, tutto me stesso, a Guglielmo arcivescovo di Canterbury, Primate d’Inghilterra, titolo davvero non solo onorifico, e Legato Nato, come si suol dire, della tua santità. Egli è, e non parlo di tutte le cortesie che, in pubblico e in privato, ha usato nei miei confronti, per la sua Britannia ciò che Leone è per il mondo intero: e come la casa Medicea, col suo illustre nome, ha reso già da tempo l’Italia la più fortunata di tutte le terre, così egli è per i suoi inglesi una sorta di benefico astro, concesso dagli stessi fati, affinché sotto la sua direzione cresca e si diffonda ogni forma di benessere. Infatti, come se in un solo uomo fossero racchiusi numerosi eroi e un unico petto sia abitato da molti numi, così egli svolge in modo mirabile il suo ruolo di arcivescovo della Chiesa, legato per la sede romana, consigliere per la reggia, cancelliere per la giustizia, Mecenate per gli studi; è massimamente per la sua opera che si è veificato che l’isola, già da tempo eminente per uomini, armi e ricchezze, fiorisce ora per leggi, religione, costumi, e infine per ingegni raffinati in ogni genere di studio, al punto tale da poter stare alla pari con qualsiasi altra nazione. Tuttavia, affinché l’utilità di questo nostro lavoro si diffonda più largamente, a vantaggio del mondo intero, ci sembrò opportuno servirci del tuo nome per tutti sacrosanto, tanto più che la natura della cosa sembrava richiederlo; ben si addice, del resto, che questa sapienza cristiana pervenga a tutti i mortali sotto gli auspici di colui che è alla guida della religione cristiana, e che la dottrina celeste vada incontro a tutti gli uomini tramite colui che ci rende accetti a Cristo, quand’egli chiama dalla terra al cielo. Che cosa vieta, d’altra parte, che questo libro, munito di una doppia commendatizia, venga dedicato in comune a due tra le più eccelse personalità dell’universo, e che per ciò stesso giunga nelle mani dei lettori sotto più fulgidi auspici? Vediamo talvolta come s’accrescano la dignità e il rispetto di templi e altari, poiché esse sono contemporaneamente dedicati a più santi. E per quanto ciò sembri insolito, quel che conta è che risulti di pubblica utilità. E tale è la semplicità e l’affabilità di Leone che, per queste doti come per molte altre, supera di gran lunga tutti i maggiori; e tale è la superiorità dell’arcivescovo in ogni genere di virtù, che nessun altro è più degno di stare a fianco di Leone, davvero sommo sotto ogni punto di vista. In ultimo, se rivolgendosi a un tale Principe è lecito esprimersi un po’ come Trasone nella nota commedia, per quanto possa sembrare umile questa mia fatica, tuttavia confido che l’attento lettore possa ricavare maggior profitto di quanto l’opera sembri promettere in apparenza. Ma trattenendo con più lungo discorso la tua eccelsa Maestà peccherei verso il pubblico bene, perciò tratterò del resto con il comune lettore; ma dopo aver pregato quel Dio, in virtù della cui provvidenza Leone X è stato inviato in aiuto alle vicende mortali, affinché voglia conservarcelo a lungo, concedendogli felicissima vita. Da Basilea, nell’anno di grazia 1516, il primo febbraio. Traduzione a cura di Giovanna Fratini 29
Scaricare