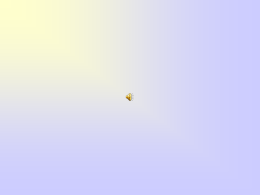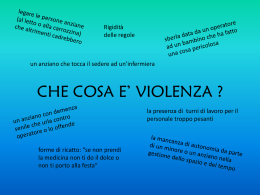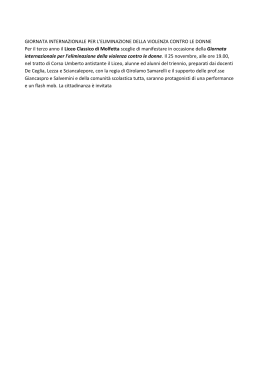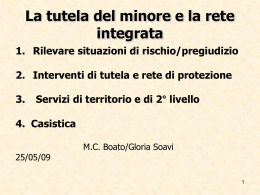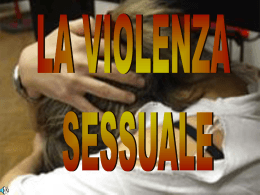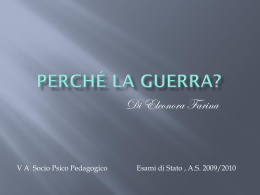Violenza degenere: il pregiudizio anti-omosessuale come tecnologia di genere di Elisa A.G. Arfini “La rinuncia accresce l'intolleranza” Freud, IL DISAGIO DELLA CIVILTÀ. Introduzione Nel 1998 Matthew Shepard, uno studente di 22 anni, viene ucciso a Laramie, Wyoming. I due uomini riconosciuti colpevoli dell'omicidio l'avevano brutalmente aggredito perché il ragazzo era gay. Si erano incontrati in un bar; Matthew, dopo essersi allontano in macchina con i due, verrà trovato il mattino dopo, legato a un recinto nella campagna circostante. Morirà dopo 6 di coma a seguito delle gravi lesioni riportate. La cronaca della vicenda gode di un'attenzione mediatica senza precedenti e prima ancora che il processo si concluda Matthew diventa il simbolo della violenza contro gli omosessuali. In sede di difesa processuale, gli assassini tentarono di spiegare la propria reazione violenta sulla base del fatto che Matthew gli avrebbe “rimorchiati” al bar e poi fatto proposte sessuali. Ciò avrebbe fatto perdere loro la piena facoltà di intendere e di volere, portandoli all'omicidio1. Questa strategia va sotto il nome di “panico gay” ed è una retorica che circola spesso nei casi di violenza motivata da omofobia, o meglio da pregiudizio anti-omosessuale. Concetti come omofobia o panico gay sottolineano la componente irrazionale e individuale di un meccanismo che in realtà si poggia su funzioni molto razionali e socialmente pervasive2. La violenza contro gli omosessuali non è figlia solo dello stigma, dell'imbarazzo, o del disgusto per il diverso, è invece funzionale al mantenimento dell'ordine dicotomico dei generi. Che la violenza sia uno dei dispositivi per la stabilizzazione dell'ordine di genere è stato dimostrato da molta letteratura, che però ha spesso limitato la 1 Sul caso Matthew Shepard è stata prodotta una docu-fiction, interpretata da attori ma basata su trascrizioni originali di interviste a soggetti coinvolti a vario titolo nel caso: The Laramie Project (2002) 2 Non abbiamo rinunciato a usare il termine omofobia in questo testo, perché è ormai di uso comune. Tuttavia è bene precisare che intendiamo questo meccanismo come fobia atipica, perché basata sul pregiudizio antiomosessuale piuttosto che su una paura irrazionale; una fobia che genera aggressività piuttosto che ansia. Per una rassegna di svariate posizioni all'interno di questo dibattito, si veda la ricca sezione “Omofobie” del volume Omosapiens (2006), con contributi di Lingiardi, V.; Falanga, S., Parisi, A., Di Chiacchio, C.; e Nardelli, N. concezione di violenza di genere come atto compiuto da uomini eterosessuali contro donne eterosessuali. Vogliamo invece suggerire che anche la violenza contro gli omosessuali può essere pensata come violenza di genere. Omofobia come discorsività Il pregiudizio anti-omosessuale non è altro che un funzione costitutiva delle società occidentali, che si fondano su una matrice eterosessuale, a sua volta precondizione per un'identificazione di genere corretta. La norma traccia un nesso irreversibile tra sessualità e identità di genere, per cui la deviazione di uno dei due aspetti retroagisce inevitabilmente sull'altro. Judith Butler (1997, trad. it 2005), nella sua indagine filosofica che rintraccia gli esisti psichici dell'esistenza sociale, ha mostrato efficacemente come sia proprio la proibizione dell'omosessualità a installare il nucleo della soggettività sessuata. Il frastagliato percorso che porta Butler a giungere a simili conclusioni, è animato dalla volontà di riformulare la comprensione della categoria concettuale di genere. Sarebbe fuori luogo ripercorrere qui tutte le tappe della complicata genealogia della teoria del gender. Basterà ricordare che il discorso di Butler si inserisce nel dibattito in un momento (i primi anni '90) in cui la posizione dominante è il cosiddetto paradigma sesso\genere. Secondo questa posizione, il sesso è il materiale biologico, naturale e immutabile su cui si installa il genere, ovvero la componente sociale dell'identità sessuata. Il genere rappresenterebbe quindi lo spazio di manovra dell'azione culturale, l'area all'interno della quale i conflitti per la cosiddetta “uguaglianza tra i generi” possono essere combattuti, il mondo in cui la volontà dell'individuo si può esplicitare e può operare cambiamenti. Questo paradigma tranquillizzò per un certo periodo di tempo il nervosismo causato dagli approcci deterministi, i quali - pur vedendo il genere come una categoria sociale - ne rintracciavano le cause in quell'origine naturale\biologica\ontologica rappresentata dal sesso. Il genere insomma, per quanto potesse essere sociale nella sua fenomenologia, rimaneva pur sempre l'esito di una causa biologica. Il paradigma sesso\genere, invece, sradicò questo rapporto causale e deterministico tra le due componenti dell'identità sessuale, sostenendo che i condizionamenti strutturali e culturali che formano il genere, discendono dal sesso biologico in maniera contingente e arbitraria, piuttosto che determinista e teleologica. Questa spiegazione andò incontro a un certo successo; in effetti si tratta di un paradigma rassicurante: non nega che – sotto strati di sedimentazioni culturali – esista una qualità, una variabile, un dato fondamentalmente che sia valido, immediato, vero. Non nega che la mascolinità e la femminilità esistano come dato pre-sociale, eppure non le definisce, le presuppone ma non le descrive: le immagina come caselle vuote. A ben vedere, tuttavia, questo paradigma solleva una serie di interrogativi che ne minano la solidità. Per esempio, se l'accesso al genere avviene attraverso una mediazione culturale, allora come si rende intellegibile il sesso? E' possibile accedere alla materialità biologica del sesso senza una griglia percettiva e cognitiva che non sia già sociale? Se esiste una qualche forma manifesta del sesso, la sua manifestazione non è già culturalmente mediata? E soprattutto, cosa conta come sesso, e cosa conta come genere? Di fronte a questa domanda, è facile immaginare come il paradigma sesso\genere cada nella trappola del dualismo natura\cultura, dualismo che condanna la spinta critica ad esaurirsi nell'interminabile (e sostanzialmente inutile) impresa di definire di volta in volta i confini tra ciò che è naturale e ciò che non lo è (talvolta con strumenti cosiddetti “culturali”, talvolta con strumenti cosiddetti “scientifici”). Un primo impulso a uscire dall'impasse venne dato da Gayle Rubin nel 1984 che, in “Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality”, propone una versione modificata del paradigma, sostenendo che “sex as we know it […] is itself a social product” se “what counts as sex is equally culturally determined and obtained” (1984, 230), intendendo dire con ciò che nel momento stesso in cui possiamo dire di conoscere qualcosa del sesso, già l'abbiamo trascinato nel mondo sociale. La posizione di Rubin dunque suggerisce che ciò che conta come sesso è definito culturalmente; che – benché esista una indubitabile materialità dei corpi, questa non è sinonimo di sesso. Parlare di sesso è invece già descrivere, e quindi ascrivere una qualità, una sfera di influenza, un destino, e un set di possibilità a un dato corporeo di per sé muto e inaccessibile. L'analisi di Rubin, per quanto convincente, ci lascia però con un problema: a cosa serve allora il sesso? Perché individuare in questa categoria concettuale il dato pre-sociale da cui discende, in maniera più o meno causale, il genere? Se il sesso è un dato culturale, come si giustifica questo attaccamento normativo alla sua naturalità? Sarà Butler a rispondere a questi interrogativi, a fornire cioè una giustificazione funzionale della dicotomia sesso\genere. E' l'eteronormatività a installare il sesso come precondizione naturale del genere. La matrice eterosessuale è un regime normativo che interviene nella formazione delle proiezioni identificatorie a seguito delle quali il soggetto emerge come tale. La dicotomia sesso\genere è un'ipostasi in cui il sesso viene naturalizzato, e questa naturalizzazione è successivamente resa invisibile dal potere discorsivo. Il sesso viene reso ontologicamente primario, diventa il dato pre-discorsivo e pre-sociale perché deve essere, come tutto ciò che è naturale, immutabile. Ma è in primo luogo la proibizione dell'omosessualità a installare la norma eterosessuale che conduce ad un'identificazione di genere corretta. Date queste premesse, pertanto, potremmo trovare tracce di omofobia ovunque esistano soggetti sessuati. E' certamente il pregiudizio anti-omosessuale la ragione della maggior parte delle difficoltà che le persone omosessuali, bisessuali, transgender, queer e intersessuate3 devono affrontare: la mancata o scarsa rappresentatività nella sfera pubblica, nelle istituzioni, nei gruppi di interesse, nei media; alto tasso di discriminazione e stigmatizzazione nel lavoro, nella famiglia, nella scuola ad ogni livello, nell'assistenza medica, nelle confessioni religiose, etc. Insomma, per dirla con Michael Warner (1993), "questo non è un pianeta queer". Tutt'altro. La violenza fisica e la violenza rappresentata\simbolica provocano ferite ugualmente gravi. In questo lavoro però verranno mantenute separate a livello analitico e si forniranno esempi e dati relativi alla violenza fisica. I crimini violenti di motivati da pregiudizio richiedono un approccio dedicato e una strategia di contrasto che va messa in atto in campi specifici: in primo luogo quello giuridico, ma anche nell'ambito dell'assistenza medico-legale, del supporto psicologico, dell'attivismo locale, delle campagne di educazione\prevenzione, della raccolta di dati statistici e del coordinamento delle operazioni istituzionali (tra forze dell'ordine, tribunali, ospedali, associazioni, etc.); riconoscere quindi una specificità ai crimini violenti è necessario per poter trovare strategie situate. Tuttavia, è di fondamentale importanza postulare una base comune ai diversi tipi di omofobia per due ragioni. In primo luogo la violenza fisica è presente non solo nel momento in cui si attua, ma esiste come paura nell'esistenza quotidiana dei soggetti che si possono considerare a rischio; esiste il crimine e la paura di subirlo, così che la violenza è presente sempre in forma implicita, fantasmatica, prefigurata. In secondo luogo le forme della violenza contro gli omosessuali sono interrelate a un livello ancora più profondo perché la violenza fisica è culturalmente legittimata. Ciò non equivale ad affermare in maniera semplicistica che la violenza rappresentata scateni per via imitativa la violenza reale, significa invece suggerire che la violenza circola nelle realtà e nelle rappresentazioni, scavalca i confini tra potenziale e attuale, e così facendo si sedimenta nei comportamenti tanto quanto negli schemi percettivi. Per gay, lesbiche e devianti di genere, la possibilità di subire violenza è una minaccia talmente costante che si configura a un livello pre-riflessivo. Quando allora una simile potenzialità si sedimenta a livello identitario, plasma i corpi e la percezione di quello che è loro lecito fare e abituale subire. Statistiche sui crimini motivati da pregiudizio anti-omosessuale Per offrire una rassegna sui crimini violenti contro gli omosessuali ci baseremo su una serie di dati statistici. Innanzitutto bisogna lamentare la mancanza di dati quantitativi relativi 3 Da cui la dicitura: GLBTQI (Gay, lesbian, bisexual, transgender, queer, intersexed). all'Italia4; pertanto ci riferiremo ai dati relativi agli Stati Uniti, dove, in seguito alla legislazione sugli hate crimes e all'attività di alcune associazioni, le statistiche presentano campioni più consistenti. L'atto legislativo più importante che gli Stati Uniti hanno implementato in materia di contrasto alla violenza omofobica è stato l'Hate Crime Statistics Act (HCSA), che dal 1990 regola per le legge la raccolta di dati sui "crimes that manifest evidence of prejudice based on race, religion, sexual orientation or ethnicity" (U.S. Code, 1990) 5 (Nel 1994 sono stati aggiunti alla lista i crimini commessi contro portatori di disabilità fisica o mentale). L'HCSA è stato un passo di fondamentale importanza perché ha segnato a livello legislativo il riconoscimento della specificità – ovvero della particolare gravità – dei crimini violenti perpetrati su base pregiudiziale. In seguito è stato approvato il Hate Crimes Prevention Act (HCPA), la cui ultima versione risale al 2005 (U.S. Code, 1990). Ciò ha dato avvio alla possibilità di assegnare aggravanti e quindi di comminare pene più severe. Naturalmente c'è chi si è inserito nel dibatto sostenendo che la definizione stessa di “hate crime” è illegittima e insostenibile perché qualunque crimine è motivato dall'odio. E' però questa una posizione poco solida che si giustifica sulla base di una specie di morale per cui ogni azione illegale è motivata dal “Male”. Anche se ciò fosse vero, rimane il fatto che i crimini contro la persona motivati dal pregiudizio sono socialmente gravi (perché perpetuano una cultura della discriminazione) e si configurano materialmente come particolarmente brutali, dal momento che la violenza è in sé il fine e la ragione ultima dell'atto. L'azione del legislatore americano ha dato inizio a una raccolta statistica su base nazionale; l'organismo incaricato di ricevere il flusso di dati è il Federal Bureau of Investigation (FBI)6. Avremo modo di vedere che la raccolta dati governativa non si è rivelata particolarmente efficace e affidabile; ciò nonostante, l'HCPA ha rappresentato un passo importante sia sul campo giuridico – perché ha consentito alle corti di isolare analiticamente questo tipo di crimini violenti e quindi di considerarli come aggravanti – sia a un livello culturale. In quest'ultimo senso, la definizione legislativa di hate crime è importante perché fa sì che sia il significato dell'azione, oltre che all'azione in sé, a determinare una specifica reazione da parte delle autorità. Che i crimini motivati dal pregiudizio abbiano trovato 4 Tuttavia l'ILGA (International Gay and Lesbian Association) ha pubblicato una serie di report suddivisi per paese, Italia inclusa, in cui si intende fornire una panoramica socio-legale sulla situazione degli omosessuali. Le voci di solito includono variabili quali: libertà di associazione, unioni di fatto, pensioni, occupazione, immigrazione, eredità, diritto d'asilo, accesso alle tecnologie riproduttive, servizio militare, etc. Cfr.: www.ilga.org 5 E' da notare che l'orientamento sessuale è l'unica variabile, assieme alla religione, che deriva pienamente da una libera scelta del soggetto giuridico. E' da notare anche il fatto che il legislatore americano si è premurato di rendere chiaro che la tutela dell'orientamento sessuale non coincide con una “approvazione” dell'omosessualità; leggiamo infatti alla sezione 2 comma b. che: "Nothing in this Act shall be construed, nor shall any funds appropriated to carry out the purpose of the Act be used, to promote or encourage homosexuality” (U.S. Code, 1990) 6 All'interno dell'unità Uniform Crime Reporting che è attiva dal 1930. una propria specificità all'interno del sistema legale, è anche il riconoscimento di un'urgenza sociale: una situazione dolorosa anche per molti, prima che diventi un 'problema pubblico' deve essere compresa come tale da determinati gruppi di individui (rappresentanti politici, organizzazioni sociali, gruppi d'interesse, etc.) e in determinati setting istituzionali (politici, legislativi, medici, pedagogici, etc.)7. Per questo è stato fondamentale l'apporto delle organizzazioni di base, che hanno fatto pressione affinché venisse accordata visibilità al problema. Ed è sempre alle organizzazioni di base, nello specifico caso della violenza omofobica, che si deve il proseguimento dell'opera di documentazione. Come abbiamo anticipato, la raccolta di dati a livello federale non è particolarmente significativa; innanzitutto perché la percentuale dei crimini che vengono denunciati è stimata essere meno della metà di quelli che vengono effettivamente commessi (Herek et al., 2002). Sporgere denuncia significa esporsi ulteriormente come omosessuale, proprio nel momento in cui è stata la propria posizione identitaria a scatenare la violenza. Inoltre, molti\e temono di non trovare il necessario supporto presso le forze dell'ordine, che – soprattutto negli Stati Uniti8 – non godono di buona fama in materia di tolleranza nei confronti degli omosessuali. Per evitare insomma una sovraesposizione, l'ulteriore umiliazione di una reazione più o meno velatamente pregiudiziale da parte delle forze dell'ordine, per via del senso di colpa e di imbarazzo che un simile tipo di violenza provocano, spesso non si sporge denuncia. Oltre a questo problema strutturale, la raccolta dati nazionale subisce una serie di intoppi burocratici: l'organismo centrale è mal interfacciato con le agenzie sul territorio, e localmente le forze dell'ordine hanno criteri poco uniformi nel definire cosa conti come hate crime. Uno strumento utile che tuttavia può ancora fornirci il report FBI è la comparazione con altri tipi di crimini. In termini percentuali le ultime statistiche disponibili (U.S. Department of Justice, 2006) producono questo quadro: Percentuale Tipo di pregiudizio 56.0 Razza 15.7 Religione 14.0 Orientamento sessuale 13.7 Etnia o provenienza regionale 0.6 Disabilità Fonte: Hate Crime Statistics 2005 -FBI 7 Queste considerazioni derivano dalla concettualizzazione dei meccanismi di 'collective action framing'. Si veda a questo proposito: Snow e Benford (2000) 8 In fondo l'atto fondativo e il mito eziologico della comunità gay americana, ovvero i disordini di Stonewall, fu una rivolta di drag queens contro poliziotti, che tentarono un raid nel popolare locale Stonewall del Greenwich Village a New York, il 28 giugno 1969 (D'Emilio, 1983). Non esistono dati affidabili che possano rivelarci la percentuale assoluta di omosessuali rispetto alla totalità della popolazione; tuttavia, è preoccupante notare che ben il 14% dei crimini motivati dal pregiudizio siano commessi su un gruppo sociale che come incidenza sul totale della popolazione probabilmente non supera di molto il famoso 10% del rapporto Kinsey. Difficoltà di gestione e sfiducia verso le forze dell'ordine e il sistema legale rendono il rapporto dell'FBI poco indicativo. A ciò pongono parziale rimedio le organizzazioni radicate nella comunità GLBTQI. La più importante sul territorio statunitense è la National Coalition of Anti-Violence Programs, che annualmente pubblica un rapporto in cui confluiscono i dati raccolti dalle organizzazioni locali che fanno capo alla coalizione (NCAVP, 2006). IL NCAVP fornisce inoltre una serie di strumenti educativi e di supporto alle vittime, e, ponendosi come organizzazione GLBTQI, vanta maggiori probabilità di ricevere segnalazioni. Infatti, per avere una stima di quanto i rapporti governativi siano in difetto rispetto alla reale situazione basti considerare questo dato: il report FBI copre l'82.8% della popolazione nazionale e – nel 2003 – riporta 1406 incidenti; per lo stesso anno il report NCAVP ne indica 2272 su un campione pari al 27.2%. 2003 Campione N° di incidenti NCAVP 27.2%. 2272 FBI 82.8% 1406 Fonte: NCAVP 2004 Uno sguardo generale al rapporto della National Coalition of Anti-Violence Programs per il 2005 rivela che c'è stato un calo generale dei crimini (valutato intorno al 13%). E' lecito ricollegare il dato al fatto che nel periodo precedente a quello preso in esame l'omosessualità è stata una questione di rilievo nazionale – e ha quindi goduto di un certo grado di iper-visibilità in seguito ad alcuni fatti specifici: la causa Lawrence v. Texas (Supreme Court of the United States, 2003) (a seguito della quale è stata abrogata la legge contro la sodomia), il tentativo di legalizzare i matrimoni omosessuali in Massachussets e a San Francisco (e la conseguente minaccia di un emendamento costituzionale per “prevenire” il fenomeno), la circolazione di una retorica a supporto della “famiglia naturale” nel corso delle elezioni del 2004. Relativamente alla tipologia di crimini commessi, ricaviamo direttamente dal rapporto la seguente figura: Fonte: NCAVP 2004 Come suggerisce la grafica, l'omicidio è solo la punta dell'iceberg; tuttavia rimane il fatto che più di altri acquista drammatica visibilità. Chi viene ucciso per via del proprio orientamento sessuale non può nascondere l'offesa subita, e la morte diventa non solo un fatto di cronaca, ma anche l'oggetto di un lutto collettivo da parte della comunità. Relativamente all'identità di genere delle vittime, osserviamo una prevalenza di uomini, come mostra il grafico: Fonte: NCAVP 2004 Possiamo interpretare questo fatto in ragione di una maggior visibilità degli uomini gay rispetto alle donne; innanzitutto, consideriamo il fatto che atteggiamenti intimi tra donne sono ritenuti socialmente più accettabili che tra uomini, e questo rende più facile l'identificazione della vittima. Inoltre, le abitudini sociali della cultura gay portano gli uomini più delle donne a raggrupparsi in spazi dichiaratamente omosessuali. Non si tratta solo di spazi ricreativi (bar, discoteche, saune, palestre, etc.), ma anche di cruising areas, zone in cui gli uomini si trovano in cerca di incontri sessuali; questi spazi diventano potenzialmente pericolosi soprattutto perché sono appartati (es.: parchi, parcheggi) e vengono frequentati nelle ore notturne. Il dato relativo alle statistiche sulla violenza contro persone trans rivela una netta prevalenza di vittime MtF (male-to-female: da maschio a femmina). Anche in questo caso possiamo interpretare il fenomeno in base alla differente visibilità dei due gruppi. In primo luogo, il passing (passare cioè come individuo appartenente al genere di preferenza) è generalmente più facile per gli uomini che per le donne; infatti, gli ormoni che rendono maschile un corpo che in origine era femminile (vale a dire il testosterone) agiscono in maniera molto radicale. Quando un uomo trans assume testosterone questo gli provoca la crescita della barba, la ridistribuzione della massa corporea, l'abbassamento della voce; di contro, gli ormoni femminili non hanno un effetto così pervasivo (es.: la barba non scompare, la voce non si alza), per cui il passing può risultare più difficile. In secondo luogo, alcune donne transgender lavorano nell'industria del sesso, mentre non c'è notizia di uomini trans che facciano lo stesso. Questo genere di attività può essere rischiosa, soprattutto per le prostitute, che lavorano in zone a bassa legalità e sono considerate facili prede perché ci sono scarse probabilità che sporgano denuncia o che venga loro accordata credibilità nel caso lo facessero. Così come nel caso della violenza contro le donne, la maggior parte delle violenze è di natura domestica, tra partners dello stesso sesso. A quanto pare, in questo caso la violenza non fa distinzioni tra sessualità. Non ci dilungheremo su questo aspetto perché riguarda una componente più relazionale e psicologica che legata al pregiudizio e al rapporto con la società eterosessuale. Ci limitiamo però a ricordare alcune specifiche difficoltà degli omosessuali che subiscono una relazione abusiva: la tutela legislativa così come la struttura delle terapie di supporto sono orientate all'eterosessualità. All'interno della coppia, poi, l'outing può essere usato come ricatto, mentre la gravità dei fatti può essere negata sostenendo che una relazione omosessuale non può essere abusiva o che, in ogni caso, non esistono forme di supporto specifiche9. Oltre all'opera di documentazione, il NCAVP e altre organizzazioni simili compiono azioni integrate per contrastare e fronteggiare la violenza. La raccolta di dati, per quanto al momento ancora parziale, rimane comunque un fronte di massima importanza perché è mirata a fornire statistiche che possano fornire una percezione forte e reale del problema. Tuttavia per fare in modo che un problema sociale venga percepito come tale, non basta offrire gli strumenti per identificarlo, bisogna anche fornire una visione d'insieme che oltre al problema ponga attenzione alle possibili soluzioni10. In questo modo, l'intervento pubblico (istituzionale, legislativo) è già orientato sulla base di quello che viene proposto dalle organizzazioni di base. Le strategie delle associazioni GLBTQI che si occupano di violenza sono simili a quelle impiegate dalle analoghe esperienze dei gruppi che lavorano nell'ambito della violenza contro le donne. A livello di prevenzione si promuove l'educazione e la sensibilizzazione, anche tra gli stessi soggetti omosessuali. Si organizzano corsi di auto-difesa, si distribuiscono fischietti e in generale si promuove l'attenzione e la vigilanza. Per esempio si suggerisce di “rischiare l'imbarazza”: il consiglio che viene dato è fidarsi del proprio istinto, non esitare a chiedere aiuto o cercare riparo, evitare insomma di “fare finta di niente” perché un simile comportamento è controproducente, meglio fronteggiare il presunto assalitore e sondare le sue intenzioni. Anche se questi consigli possono essere utili dal punto di vista pratico, portano con sé il rischio di alimentare uno stato di paura perenne, di porre l'accento più sul pericolo che non sulle sue soluzioni e di scoraggiare, in ultima analisi, una visibilità serena. E' meglio quindi suggerire che sono certe situazioni ad essere potenzialmente pericolose, non la propria identità omosessuale, e che il rischio si fronteggia con la tutela dei diritti, non con l'auto-limitazione11. Se poi il crimine 9 Per una discussione più ambia di queste tematiche si veda: (Island e Letellier, 1997) 10 Come notano come notano Snow e Benford: “problem definition is a process of image making, where the images have to do fundamentally with attributing cause, blame, and responsiblity” (Snow e Benford 1989, p. 282 cit. in Jenness e Broad, 1994) 11 Un ulteriore problema è dato dall'intersezione razza\orientamento sessuale. La comunità GLBTQ negli Stati viene commesso, le organizzazioni mettono in atto varie strategie: hotlines, supporto psicologico, assistenza medica, assistenza legale, aiuto nell'interazione con la polizia12. Omofobia come violenza di genere Come abbiamo visto, le strategie di contrasto e supporto delle associazioni GLBTQI hanno ereditato molta dell'esperienza delle iniziative contro la violenza sulle donne. Anche la riflessione teorica merita un intreccio. Trasforini (1999) offre un'analisi della violenza di genere come dispositivo tecnologico che plasma i corpi sessuati nelle loro caratteristiche e possibilità. A livello genealogico, due sono state le retoriche che hanno plasmato la consistenza dei corpi delle donne: “da un lato quella che definisce lo spazio moderno, in particolare la costruzione immaginaria di luoghi legittimi e pertinenti per genere; dall’altro quella della medicina che scruta e traccia i confini della consistenza e dei rischi dei corpi” (ibid., 195). Insieme, questi dispositivi hanno inscritto nei corpi delle donne una consistenza debole, rendendoli accessibili e violabili. Da un lato quindi, la definizione di sfera pubblica e sfera privata ha creato delle vere e proprie geografie della paura, che limitano ai corpi delle donne l'accesso al mondo esterno; un dispositivo paradossale, se è vero che la stragrande maggioranza delle violenze sulle donne è commessa nell'ambiente domestico. Anche le geografie della paura dei corpi omosessuali hanno un tratto paradossale: come abbiamo visto, le aree ad essere più a rischio sono proprio quelle che dovrebbero offrire un rifugio, uno spazio dedicato. Il desiderio di appartenenza diventa allora pericoloso; così come la libertà di espressione, il desiderio di visibilità. Infatti, la violenza motivata da pregiudizio omosessuale si basa su un dispositivo di fondo: l'attribuzione. Il corpo di una donna è distinguibile il più delle volte sul semplice dato visivo e percettivo, una percezione che non si può semplicemente scegliere di non fornire. E come si identifica un corpo omosessuale? Il corpo omosessuale può rendersi visibile a seguito di azioni consapevoli, attraverso dichiarazioni esplicite, comportamenti codificati nella sotto-cultura gay, esposizione del proprio rapporto con il partner, presenza e frequentazione di iniziative e spazi dedicati. L'omosessuale insomma, può scegliere di essere out. Oppure di passare come eterosessuale. Uniti è ancora prevalentemente bianca. La popolazione afroamericana, in particolare, vive di solito una cultura fatta di forti legami famigliari e di radici religiose che offrono un ambiente poco tollerante nei confronti dell'omosessualità. Tuttavia, se la comunità gay è soprattutto bianca, essa non può rappresentare un rifugio o un'alternativa. 12 Un particolare tipo di misura è stata sperimentata in alcune città americane, vale a dire i gruppi di vigilanza. Questi gruppi (generalmente di 4-6 persone) forniscono un servizio di “ronda” negli spazi gay delle città, per dissuadere eventuali assalitori e fornire testimonianza in caso di incidenti. Nel quartiere gay della città, il Castro, ha operato la San Francisco Street Patrol. Un'esperienza simile è stata effettuata a Seattle dalla Q-Patrol (dove “Q” sta per queer) e dalle New York Pink Panther Patrol, Massachussetts Pynk Panther, Houston QPatrol. Infatti, se essere out rappresenta un pericolo è lecito chiedersi: chi si può permettere la visibilità? Da parte del movimento c'è sempre stato un certo sforzo di incoraggiamento al coming out13, nella convinzione che le politiche del riconoscimento si basino sulla visibilità. La visibilità produce esempi positivi, catalizza adesioni politiche, ingrossa i ranghi degli attivisti, riduce l'omofobia interiorizzata, libera dalle costrizioni della segretezza. Tuttavia, molti14 hanno portato in luce i problemi insiti nella promozione di una visibilità a-critica. Il rischio è quello di non interrogarsi su quali siano le identità sessuali degne di essere rese visibili, perché, a ben vedere, non tutte lo sono. Le vetrine della visibilità sono definite in partenza dalla stessa logica che si cerca di sovvertire, e con esse viene definito quale tipo di conoscenza debba circolare attorno alle identità riconosciute. Il danno viene subito quando le uniche identità che riescono a superare l'esame del riconoscimento sono quelle già assimilate e rese inoffensive. I gay e le lesbiche che “sembrano normali”, per esempio, escludono dall'arena politica e dalla sfera pubblica tutti coloro che che sono considerati devianti, malati, pervertiti e pericolosi. Persone queer che vogliono affrancare la propria rappresentazione identitaria e il proprio desiderio dallo stigma di devianza, patologia, perversione. I movimenti identitari hanno dato un forte impulso alla circolazione di narrative personali (Zimmerman, 1984); ma quando l'enfasi è stata posta con troppa leggerezza sulla visibilità, si è alimentata la creazione di ulteriori modelli normativi, una limitazione dello spettro di identificazioni accolte nella comunità, e una tensione verso coloro i quali le sfuggivano. Per tornare all'intreccio tra violenza contro le donne e violenza contro gli omosessuali, Trasforini identifica il ruolo del discorso medico nella costruzione della consistenza dei corpi; con la sua visione della donna isterica il sapere medico ha contribuito a indebolire i corpi rendendo le donne “delle potenziali eterne malate” (Knibiehler cit. in Trasforini 1999, 205). Anche riguardo all'omosessualità il discorso medico ha prodotto molti saperi, e la retorica della malattia è stata pervasiva, indicando l'omosessuale via via come deviante, pervertito, pedofilo, effeminato, degenerato, invertito, etc. Non si può riassumere la secolare ingerenza della medicina sui corpi omosessuali. Dalla definizione di perversione di matrice ottocentesca, si è dovuto aspettare fino al 1973 per vedere l'omosessualità fuori dal DSM-II (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), il documento che definisce lo standard a livello internazionale per il trattamento delle malattie mentali (APA, 1973). Ma c'è un dato contemporaneo che ricollega medicina e visibilità e che può essere utile ricordare in questo contesto. Con il dilagare dell'epidemia di AIDS, i corpi gay hanno dovuto fronteggiare quello 13 Si veda per esempio la campagna ora in corso della Human Rights Campaign Foundation, che si chiama “Talk about it!” e è volta ad incoraggiare i coming out. 14 Oltre naturlamente a Foucault (1976) e alle sue discussioni dell'ipotesi repressiva e del beneficio del locutore, si veda nello specifico Roof, 1996. che sembrava essere un incubo che si tramutava in realtà. La patologizzazione dell'omosessualità ha acquisito uno spessore materiale, scientificamente testabile, ed endemico. L'AIDS è diventata la malattia gay e i danni che porta sono biologici e sociali. Pensiamo al fatto che una categoria particolare di assalitori nei casi di crimini contro gli omosessuali è quella rappresentata dai soggetti che agiscono sotto la spinta di una dichiarata ideologia anti-gay. Sono gli stessi, spesso esponenti dell'estrema destra o di raggruppamenti ultra-cristiani, che durante le loro manifestazioni inalberano cartelli su cui si può leggere “Ringraziamo Dio per l'AIDS” o “AIDS = la cura per l'omosessualità”. La fantomatica (e un po' invidiata dagli etero) promiscuità dei gay viene così punita dal castigo divino. La malattia non ha fatto altro che aumentare la percezione del corpo gay come malato, abbietto, ripugnante, e ora anche pericoloso. Gli assalitori possono agire non solo in base ai dettami delle proprie ideologie, contro i corpi abbietti in virtù della purezza morale, ma anche in virtù di un'opera di tutela, contro i corpi contagiosi. Tutto ciò ha portato a una sovraesposizione del corpo gay guidata da una logica del sospetto: a partire dall'inizio dell'epidemia, tra gay e non gay si è sviluppato un insolito expertise nel distinguere un capillare rotto da una lesione da sarcoma di Kaposi. Eppure, anche se la malattia ha acquisito una certa visibilità, la morte – il suo esito inevitabile – è rimasta troppo spesso fuori della scena, per le ragioni che vedremo in seguito. In conclusione possiamo dire che se l'isterizzazione ha reso accessibile il corpo delle donne, la patologizzazione, e in particolare l'AIDS, hanno reso il corpo gay abbietto e passabile di eliminazione. Trasforini conclude il suo lavoro affermando che violenza di genere è “l’autorizzazione sociale del genere maschile ad accedere senza negoziazione nel territorio della corporalità personale femminile” (Trasforini 1999, 208); cioè è certamente ammissibile, ma è pur vero che la violenza di genere non si riduce ad un unico movimento, quello dell'uomo eterosessuale contro la donna eterosessuale. Far combaciare la violenza di genere con "violenza di un uomo eterosessuale su una donna eterosessuale" è una riduzione impropria. Il rischio implicito nell'equivalenza violenza di genere=violenza di uomini etero su donne etero è quello di reificare ulteriormente una divisione binaria dei generi che si basa sulla subordinazione sessuale della donna. C'è in effetti chi si spinge in questa direzione, definendo la sottomissione sessuale come il dispositivo attraverso il quale i corpi diventano sessuati. Ho intenzione di mostrare invece che anche l'omofobia è un tipo di violenza di genere e che anch'essa deriva non semplicemente dalla stigmatizzazione sociale dell'omosessualità, ma dal ruolo che questa ricopre nell'economia eteronormativa che definisce i generi. Jenness e Broad in un articolo del 1994 lamentano il fatto che le organizzazioni che si occupano di violenza contro gli omosessuali hanno adottato le strategie dei movimenti femministi, ma non hanno ereditato un'adeguata riflessione di genere. Per esempio, la scarsa attenzione alla dimensione di genere è dimostrata dal fatto che nella comunità: “there is no discussion of how lesbians may be raped as a form of antigay and lesbian violence, and a form of violence against women.”(Jenness e Broad 1994, 414). Se questo è il punto dire che la comunità omosessuale non riflette sul genere equivale a dire che le lesbiche non sono pensate come donne perché non viene contemplata la possibilità che siano violentate in quanto donne. Questo tipo di posizione rivela un paradigma ispirato all'opera MacKinnon, che è poi quello che ha più di altri informato la politica femminista nel mainstream americano. Secondo MacKinnon: “gender emerges as the congealed form of the sexualization of inequality between man and women” (MacKinnon 1987, 6). Seguendo una simile logica si arriva alla paradossale conclusione che ciò che definisce la Donna è la possibilità di subire violenza, e che quindi la lesbica è in fondo pur sempre una donna solo in virtù del fatto che può ancora essere stuprata. E' ovvio quindi che, all'interno di questa logica, la comunità queer non abbia riflettuto sul genere. In questa economia, si può essere soggetti sessuati solo all'interno di una relazione eterosessuale abusiva. Sosteniamo invece che le tecnologie del genere, anche quelle che si basano sulla violenza, sono infinitamente più pervasive. Nella sua discussione della posizione di MacKinnon, Judith Butler (2005, 53) mette in luce un paradosso: se il genere è una forma congelata di subordinazione sessuale, e quindi emerge come prodotto di quella relazione sessuale, di che genere erano i soggetti che l'hanno iniziata? Come si fa a creare una relazione in cui l'uomo subordina la donna se prima di questo atto di subordinazione i soggetti non sono sessuati? Forse è meglio pensare che la subordinazione sessuale e la violenza contro le donne è solo un tipo di tecnologia del genere, attraverso la quale la norma si riproduce, ma che da sola non è in grado di installare una soggettività sessuata nell'individuo. La soggettività sessuata, l'assunzione del genere, è stata indagata con attenzione da Butler; come abbiamo anticipato in apertura, l'identità nel soggetto si forma a seguito del tabù dell'incesto e della proibizione dell'omosessualità. Nel tradizionale quadro edipico è il tabù dell'incesto a dare inizio alla formazione identitaria. Tuttavia Butler fa notare come questo tabù si debba basare originariamente su una proibizione ancora precedente: quella dell'omosessualità. Infatti: “la proibizione dell'incesto presuppone la proibizione dell'omosessualità, in quanto presume l'eterosessualizzazione del desiderio” (ibid., 129), ed è per questo che “il desiderio omosessuale getta nel panico il genere” (ibid., 131). Il panico gay A proposito di panico, come abbiamo anticipato in apertura, nelle cronache giuridiche della violenza contro gli omosessuali ricorre spesso il concetto di “panico gay” nelle difese degli imputati (gay panic defence). Molto spesso gli assalitori voglio giustificare i propri atti sulla base di un tentativo di auto-difesa: il gay (notoriamente promiscuo) è rappresentato come una sorta di predatore sessuale. Al fine di evitare di essere irretito dal desiderio gay, l'assalitore reagisce violentemente, in una sorta di stato alterato di consapevolezza. La violenza diventa una strategia per preservare la propria eterosessualità. Analogamente, la violenza è spesso vissuta da chi la commette come una riprova della propria eterosessualità: è questo il motivo per cui a volte la violenza è praticata, spesso da soggetti di giovane età, in gruppo, o sotto la pressione di un gruppo, davanti al quale si vuole dimostrare di essere “uomini veri”. Collegare queste considerazioni alle riflessioni di Butler sulla proibizione dell'omosessualità non significa tracciare un nesso causale per cui tutti gli uomini eterosessuali che agiscono violenza sono omosessuali repressi. Innanzitutto nel quadro di Butler non è corretto parlare di repressione; la repressione è un meccanismo messo in atto da un soggetto già formato. La rinuncia all'attaccamento omosessuale è piuttosto una forclusione, un atto che fonda il soggetto, e che quindi risulta irrecuperabile. Non si tratta tanto di sanzionare l'attaccamento omosessuale, quanto di prevenirlo. Ma sebbene non sia corretto individuare un nesso causale e diretto tra la proibizione dell'omosessualità come meccanismo fondante del soggetto e la violenza omofobica, è importante capire che la violenza contro gli omosessuali ha a che fare non solo con la sessualità, ma anche con il genere, sebbene sia l'orientamento sessuale la discriminante sulla base della quale si accanisce il pregiudizio. L'omofobia è dunque una violenza di genere, perché è alimentata dal tentativo di solidificare la matrice eterosessuale, matrice che a sua volta definisce la dicotomia di genere uomo\donna. Un capitolo a parte meriterebbero le cronache della transviolenza. Il caso che ha avuto più risonanza anche in Europa è quello di Brandon Teena, il ragazzo transgender violentato e ucciso in Nebraska nel 1993, la cui storia è ampiamente circolata a seguito di una trasposizione cinematografica di notevole successo15. Nessun film invece ha ancora raccontato la storia di Gwen Araujo, una ragazza transgender di diciasette anni, che nel 2002 è stata uccisa da 3 conoscenti. A quanto pare, la ragazza aveva avuto incontri sessuali con ognuno dei suoi assalitori; dopo che fu forzatamente costretta a mostrare i propri genitali, venne assalita dai tre ragazzi, colpita in vario in modo, trascinata in un garage e infine strangolata; in seguito i tre scaricarono il corpo in una zona disabitata. Così come nel caso di Brandon Teena, ciò che 15 Oltre al film, Boys don't Cry (1999), è disponibile un documentario con interviste ai soggetti coinvolti (inclusi i due assasini) che si intitola: The Brandon Teena Story (1998). avrebbe dovuto scatenare l'omicidio è la rabbia per essere stati ingannati dal soggetto, inganno che si tenta di far passare come un'attenuante. Il trans, in questo tipo di retorica, è un soggetto ingannatore, bugiardo, quindi sostanzialmente malevolo; gli imputati sono le vere vittime, vittime di un inganno, vittime che devono per di più subire l'onta di non essersi accorti del tranello. L'insinuazione secondo la quale gli imputati fossero già al corrente della condizione della vittima è pericolosa, in primo luogo perché smonta la strategia della difesa, e in secondo luogo perché postula che gli imputati potessero avere un desiderio deviante per il soggetto trans. E la devianza di questo desiderio è dovuta al fatto che si rivelerebbe essere un desiderio omosessuale. Quando uno degli assassini di Gwen scoprì che la ragazza aveva genitali maschili scoppiò a piangere gridando: “I'm not fucking gay! I can't be fucking gay”, e poi la uccise. Il caso ha fatto scalpore anche perché è avvenuto nella liberale California, a pochi kilometri dalla capitale queer degli stati uniti: San Francisco. Il conservatorismo - sia esso di matrice anarcoliberale o ultra-cristiana - di cui sono imbevute piccole località come Falls City, Nebraska (dove venne ucciso Brandon Teena) o Laramie, Wyoming (dove venne commesso l'omicidio di Mattew Shepard), rendeva più sostenibile la brutalità di certi crimini. Il processo sul caso Araujo - rallentato da difficoltà concettuali e formali - si è da poco concluso, e con condanne esemplari. La conseguenza forse più positiva di questa tragica vicenda è stata l'approvazione, nell'agosto 2006, dell'atto 1160, intitolato Gwen Araujo Justice for Victims Act, che decreta l'inammissibilità in ambito processuale di difese che si basino sulla “strategia del panico”. Il panico derivante dalla scoperta che la vittima possiede determinate caratteristiche, incluse quelle relative all'orientamento sessuale e all'identità di genere16, non è più un'attenuante. Anche se l'atto per ora è stato approvato nella sola California, è lecito sperare che una legislazione simile venga adottata anche dagli stati. La funzione del lutto La funzione che queste morti hanno assunto a livello dell'immaginario collettivo è naturalmente il diventare simbolo di una violenza collettivamente esperita, seppur in gradi minori. Ma sono anche, e forse soprattutto, il canale di sfogo di un lutto che ha bisogno di essere espresso pubblicamente. A seguito dell'esplosione dell'epidemia di AIDS, la riflessione teorica e politica ha messo in luce l'importanza dell'espressione pubblica del lutto come strategia di contrasto all'abiezione. Una morte che non è lecito commemorare rimane un cadavere fuori dalle mura, fuori dalla definizione di umano. Se, come abbiamo visto, la rinuncia 16 Oltre alle caratteristiche riguardanti tutte le altre categorie tutelate dalla legislazione sugli hate crimes. al desiderio omosessuale è un atto di forclusione che fonda che fonda il soggetto, la perdita dell'amore omosessuale è irrisolvibile, è un lutto di cui non si potrà mai addolorarsi perché è un attaccamento che non è mai esistito. La comunità ha cercato di rispondere a questa esigenza mettendo in atto varie strategie della memoria. La più conosciuta e diffusa è il Names Quilt Project, associazione che raccoglie le coperte che, come lapidi morbide, portano i nomi delle vittime dell'epidemia di AIDS; le coperte vengono periodicamente stese in pubblico e coprono intere piazze e stadi. Sul web l'iniziativa più importante è "Remembering our Deaths", un sito che raccoglie i nomi e le storie di quasi 400 persone transgender uccise a causa della propria identità di genere. Ogni anno a novembre, in tutto il mondo molte associazioni GLBTQI organizzano eventi per celebrare il “Transgender Day of Remebrance”. Tuttavia, oltre al desiderio di memoria, nella comunità GLBTQI circola anche una certa rabbia. L'espressione iperbolica della rabbia che si sprigiona da questi lutti inespressi sono le manifestazioni di ACT UP, un gruppo alquanto agguerrito attivo nei primi anni novanta. Act Up ha organizzato funerali politici e sparso le ceneri dei propri morti di AIDS sul prato della Casa Bianca. E' sempre a cura di Act Up l'opuscolo Queers Read This!. Una delle sezioni del pamphlet è intitolato “Odio gli etero” ed è un'espressione di risentimento violento: "They've taught us so well that we not only hide our anger from them, we hide it from each other. WE EVEN HIDE IT FROM OURSELVES" (Queer Nation, 1997). L'opuscolo, originariamente distribuito in fotocopia durante una manifestazione a New York nel 1990, circolò e si diffuse in tutta la nazione, dando inizio a una serie di iniziative analoghe, e ispirando altre organizzazioni nascenti, tra cui Queer Nation (che acquisterà negli anni seguenti notevole visibilità). Secondo un'ispirazione simile si tengono in Europa e negli Stati Uniti manifestazioni quali il “Gay Shame” (in evidente opposizione alla commercializzazione dei Gay Pride) e il “queeruption”17. La violenza è solitamente esclusa, anche sul piano retorico, dalle politiche identitarie, dai discorsi delle comunità di "minoranze"; alla base di questa scelta c'è sicuramente un rifiuto ideologico del valore della violenza, ma anche una volontà di riaffermare la propria diversità dall'aggressore, il rifiuto di combattere con gli stessi mezzi, di mettersi sullo stesso piano e passare così "dalla parte del torto"18. Pertanto, perlomeno a livello di retorica, la rivendicazione 17 Crf.: Le passate edizioni di queeruption si sono tenute a Londra, New York, San Francisco, Berlino, Amsterdam, Sydney, Barcelona, Tel-Aviv www.queeruption.org e www.gayshamesf.org 18 Sarebbe istruttivo in questo senso gettare uno sguardo comparativo sulla retorica della violenza nei movimenti per i diritti civili e umani degli afroamericani. Negli anni Settanta, quando il Dr. Martin Luther King predicava il porgi l'altra guancia, Malcolm X rivendicava l'uso di ogni mezzo necessario, violenza inclusa. Il progetto di Malcolm X non era terroristico, non si trattava cioè di proporre la violenza come strumento di lotta privilegiato, ma piuttosto di ammetterne la possibilità (possibilità che -peraltro- non venne mai attuata da Malcolm). Come ben sottolinea Alessandro Portelli nella sua introduzione all'autobiografia di Malcolm X: "gli oppressi non possono lasciare che le loro forme di lotta siano definite dalla legittimazione della controparte" (Malcolm X 2004, IV) della violenza è un atto di auto-determinazione; se la legittimità di un movimento è convalidata dallo stesso potere a cui si oppone, operare scelte illegittime è una mossa strategica che rafforza il senso di autonomia, la capacità di operare delle scelte. Se l'omosessualità getta nel panico il genere ha più senso dare l'impressione rassicurante di essere inoffensivi, di essere “normali”, o piuttosto rivendicare la propria pericolosità? Forse, bisognerebbe intendersi sul tipo di pericolo che si vuole prefigurare. Se il pericolo è quello di una violenza di pari brutalità, la sfida è persa in partenza, in termini morali e numerici. Ma se il pericolo rappresentato dal queer è il disvelamento delle instabilità che percorrono tutti i soggetti sessuati, allora è bene rassegnarsi all'idea che nessuna identità di genere è al sicuro. Riferimenti Bibliografici American Psychiatric Association 1973 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 2nd Edition. Arlington, American Psychiatric Publishing. Butler, J. 1997 The psychic life of power: theories in subjection. Stanford, Stanford University Press. trad. it. La vita psichica del potere. Roma, Meltemi, 2005 California Penal Code 2006 AB-1160 Gwen Araujo Justice for Victims Act. Section 1127h, Statutes of 2006 D'Emilio, J. 1998 Sexual politics, sexual communities : the making of a homosexual minority in the United States, 1940-1970. Chicago: University of Chicago Press. Herek, G.M., Cogan, J.C., & Gillis, J.R. 2002 “Victim experiences in hate crimes based on sexual orientation”. Journal of Social Issues, 58 (2), 319-339. International Lesbian and Gay Association 1999 World Legal Survey. http://www.ilga.info/Information/Legal_survey/ ilga_world_legal_survey%20introduction.htm Island, D. e Letellier, P. 1997 Men Who Beat the Men Who Love Them: Battered Gay Men and Domestic Violence. New York, Harrington Park Press. Jenness V, Broad K. 1994 Antiviolence activism and the (in)visibility of gender in the gay/lesbian and women’s movements. Gender and Society, 3 (8), 402-423. Kaufman, M. (scritto e diretto da) 2002 The Laramie Project. Cane/Gabay Productions, Good Machine e Home Box Office (HBO) MacKinnon, C. 1987 Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law. Cambridge, Harvard University Press. Malcolm X e Haley, A. 2004 Autobiografia di Malcolm X. Milano, BUR. Prima edizione 1964, The Autobiography of Malcolm X. New York, Grove Press Muska, S. e Olafsdóttir, G. (scritto e diretto da) 1998 The Brandon Teena Story. Bless Bless Productions National Coalition of Anti-Violence Programs 2004 2005 2006 Anti-lesbian, gay, bisexual and transgender violence in 2003. www.ncavp.org Anti-lesbian, gay, bisexual and transgender violence in 2004. www.ncavp.org Anti-lesbian, gay, bisexual and transgender violence in 2005. www.ncavp.org Peirce, K. (diretto da) 1999 Boys Don't Cry. Hart-Sharp Entertainment, Independent Film Channel e Killer Films Queer Nation 1997 The Queer Nation manifesto. New Haven, Beloved Disciple Press Rizzo, D (a cura di) 2006 Omosapiens. Studi e ricerche sugli orientamenti sessuali. Roma, Carrocci. Roof, R. 1996 Come As You Are. Sexualitity and Narrative. New York, Columbia University Press. Rubin, G. 1984 “Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality”. In Carole Vance, ed. Pleasure and Danger: Exploring Female Sexuality. New York, Routledge, pp. 267-319 Snow, D. e Benford, R. 2000 “Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment.” Annual Review of Sociology, 26 (1), 611-639. Supreme Court of the United States 2003 John Geddes Lawrence and Tyron Garner v. Texas, 539 U.S. 558 U.S. Department of Justice — Federal Bureau of Investigation 2006 Hate Crime Statistics 2005. http://www.fbi.gov/ucr/hc2005/ United States Code 2005 Hate Crimes Prevention Act of 2005, House of Representatives, 109th Congress, 1st Session United States Code 1990 Hate Crimes Statistics Act, House of Representatives, 101st Congress, 2nd Session Warner, M. 1993 Fear of a queer planet : queer politics and social theory. Minneapolis: University of Minnesota Press. Zimmerman, B. 1984 “The Politics of Transliteration: Lesbian Personal Narratives.” Signs, 9 (4), 663-682.
Scarica