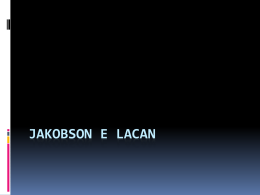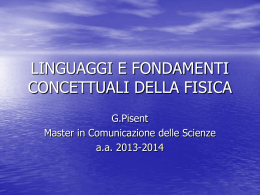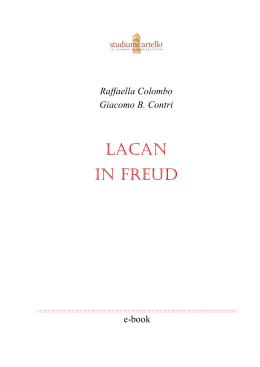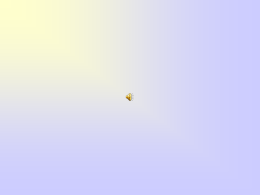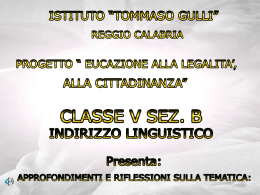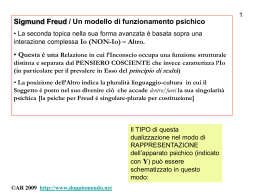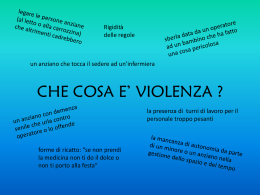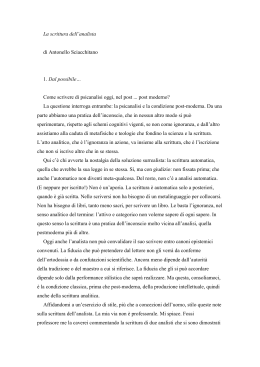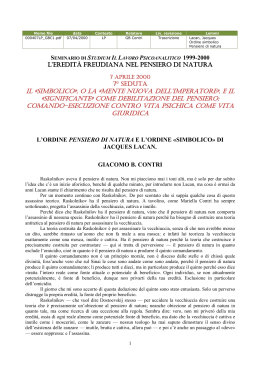ANNO X NUMERO 54 - PAG X IL FOGLIO QUOTIDIANO SABATO 5 MARZO 2005 UNA FOGLIATA DI LIBRI Anna Foa ERETICI. STORIE DI STREGHE, EBREI E CONVERTITI Il Mulino, 146 pp., euro 10,80 iamo nella Roma dei papi tra QuattroS cento e Seicento, e le storie raccontate, emerse nel corso di anni di ricerca in archivi e biblioteche, sono già oggetto di studi pubblicati in libri e riviste. L’autrice ha deciso di raccontarle di nuovo, scegliendo una diversa cifra narrativa. Come atto riparativo e liberatorio rispetto alle costrizioni e frustrazioni di un mestiere – quello di storico – che mette di continuo argini e steccati a fantasia e creazione, e che impedisce di dar voce al non detto, al non documentabile, Anna Foa introduce nelle sue storie la finzione di un Io narrante e riempie con l’immaginazione e la fantasticheria i vuoti lasciati delle fonti. Il tutto secondo una procedura trasparente e rigorosa di cui dà conto in una nota bibliografica in cui viene declinato ciò che è trama documentaria e ciò che invece è frutto di invenzione. Compie in tal modo un gesto che facilita la divulgazione di una disciplina come la storia che per troppi anni ha dimenticato di essere una pratica essenzialmente narrativa. Ma realizza anche un’operazione storiograficamente rilevante, mostrando che l’esercizio della “fiction historique” (con questa espressione Michel Foucault nominava il suo stile di lavoro storico in “Sorvegliare e punire”) può essere utile e talora necessario per mettere a fuoco una questione. Quando ciò che interessa non è solo lo studio di un periodo, ma piuttosto l’analisi di un problema, la finzione si rivela dispositivo prezioso per la pratica di una storia inventiva in cui la realtà non è né reinventata liberamente, né restituita fedelmente. Le incursioni nel campo delle probabilità e delle plausibilità agite dallo storico e non semplicemente alluse, svelano la complessità di un mestiere in cui non solo l’invenzione si confonde con l’interpretazione nell’intento di capire oltre che di restituire. La scansione stessa del tessuto narrativo assume un’importanza strategica, altrettanto eloquente dei contenuti che essa orchestra. Dalle scelte narrative dell’autrice emergono storie individuali e collettive che ci restituiscono l’evidenza di una quotidianità remota, intrisa di religione, violenza e cultura: dal primo e unico autodafé in stile spagnolo svoltosi a Roma il 29 luglio 1498, al bambino crocifisso nell’aprile del 1555 e alla creazione del ghetto romano nel luglio dello stesso anno, alle dotte conversazioni nel 1686 tra Cristina di Svezia che a Roma teneva corte e l’alchimista Francesco Giuseppe Borri, condannato per eresia e prigioniero a Castel Sant’Angelo. Ma sono anche storie che costituiscono spaccati delle maggiori problematiche del tempo – i rapporti tra la Chiesa e la minoranza ebraica, la repressione dell’eresia, i rapporti tra i generi, lo scontro tra conservazione e modernità –, e che riguardano il nesso tra potere e repressione: censure, processi, difese e accuse, esecuzioni, pentimenti. “Dando la parola, attraverso l’invenzione”, ai suoi personaggi Anna Foa ha quindi non solo raccontato, ma attraverso “le riflessioni e le certezze, i dubbi e le scelte” da lei attribuiti alla Chiesa di quei secoli, ha espresso “raccontando, essenzialmente delle interpretazioni”. (Angela Groppi) Jacques Le Goff IL CORPO NEL MEDIOEVO Laterza, 188 pp., euro 16 ascesi e il vizio, il magro e il grasso, l’astinenza e i bagordi, la punizione e l’ecL’ cesso. Il medioevo spiegato da Jacque Le Goff usando l’immagine di un “Combattimento tra carnevale e quaresima” dipinto da Bruegel nel 1559. O meglio, il luogo di un paradosso. Quello generato da un cristianesimo consolidato religione di Stato che mortifica il corpo, abominevole involucro dell’anima, e nello stesso tempo lo glorifica, tabernacolo dello Spirito Santo, memoria del sacrificio del Cristo. Veicolo del peccato originale e strumento di salvezza. Secondo Le Goff è qui che bisogna tornare per risalire a un’idea di corpo che oggi s’esprime nelle aspirazioni creatrici della genetica, nella diffusione di nuove epidemie, nell’esistenza di armi batteriologiche, nell’ossessione per certi canoni di bellezza o nella pulsione degli uomini a trasformarsi in bomba. Il primo segno riconoscibile del medioevo è la rinuncia alla fisicità. Scompaiono dalla vita sociale le terme, lo sport, il teatro viene bandito, la donna demonizzata, la sessualità controllata attraverso il matrimonio, il lavoro manuale svilito, l’omosessualità messa al bando, il riso disapprovato così come la lussuria e la gola. Tuttavia, mentre i Padri della Chiesa cercano d’imporre l’ideale monastico come modello di vita e predicano un disprezzo del mondo fatto di digiuni, sofferenze volontarie e castità, la popolazione delle campagne (il 90 per cento di quella europea) coltiva feste pagane cariche di vitalità: ebbrezza, banchetti, erotismo che non accetta regole. Una delle utopie dell’epoca è il paese di cuccagna, un paese immaginario dove non si lavora, abbondano ortaggi pronti per essere colti, siepi di salsicce che rinascono appena staccate, allodole già arrostite che cascano in bocca a felici mortali. Tutto è lusso e voluttà. Da un lato la quaresima mortifica la quotidianità, dall’altro il carnevale si scatena con i suoi eccessi. La stessa Chiesa nega la carne per meglio tendere verso Dio, assimilando lo spirituale all’immateriale, ma non può fare a meno di immaginare l’anima tutta materia straziata dalle torture di inferno e purgatorio. Poi mette in mostra la storia sacra come spettacolo di corpi nei misteri, magnifica con San Bonaventura la posizione eretta per- ché possiede lo stesso orientamento dell’anima dal basso verso l’alto, mentre Tommaso D’Aquino dichiara che le passioni dei sensi contribuiscono al dinamismo dello slancio spirituale. Sull’idea di organismo si forma lo Stato e la città moderna. Si comincia a parlare di medicina, anatomia, moda, gastronomia e buone maniere. Se c’è contraddizione tra anima e corpo, non diventa mai antagonismo. Il cadavere è putrida immagine della morte causata dal peccato originale e materia da onorare. Alimentato dal principio di un’anima che preesiste al corpo e del quale non è che la forma esteriore, il medioevo ritiene ogni individuo composto di un corpo materiale e mortale, e di un’anima immateriale e immortale. Corpo e anima sono indissociabili. Il Verbo si è fatto carne. Intanto ti scopri a pensare che nel Giappone degli anni Sessanta i sabba medievali hanno ispirato una danza che annulla la divisione tra materia e spirito appellandosi al caos primordiale per ricongiungere l’io e l’ombra. Mentre un Papa prigioniero del suo involucro troppo umano invita a riflettere sul modo migliore d’accettare questa cortina di carne, sempre mobile e tremante. (Maria Pia D’Orazi) Peter Galison GLI OROLOGI DI EINSTEIN LE MAPPE DI POINCARÉ Raffello Cortina, 394 pp., euro 29 al 1900 Albert Einstein lavora in IDintorno una stanza dell’Ufficio brevetti di Berna. fronte alla sua finestra la facciata della stazione, su cui fa bella mostra di sé una serie di orologi sincronizzati elettricamente. Le lancette avanzano simultanee, segnando su ogni quadrante la stessa, identica ora. Apparentemente uno spettacolo ordinario. In realtà la soluzione di un rompicapo che nei decenni precedenti aveva arrovellato e appassionato tecnici e scienziati. E di cui solo il genio di Einstein avrebbe colto le inaspettate implicazioni teoretiche. Dal punto di vista concettuale, infatti, nessuno si sognava di mettere in dubbio l’immagine stabilita da Isaac Newton: il tempo è un attributo naturale dell’universo. Poco importava se all’atto pratico questo tempo universale era sbriciolato in misurazioni infinite, ogni orologio regolato – più o meno – sul mezzogiorno locale. Ma differenze di pochi minuti da una località all’altra erano state fino ad allora irrilevanti. A scombinare le carte è l’avvento delle ferrovie e del telegrafo, con la necessità di valori certi, inequivoci, condivisi. La parola d’ordine di ferrovieri, politici, fisici, ingegneri diventa “eliminare l’anarchia del tempo”. Come era stato fatto per lo spazio. Nel 1889 infatti i francesi avevano esultato perché il mondo intero (in realtà mancavano l’Inghilterra e i suoi possedimenti, ma Parigi glissava) aveva accolto il loro metro come misura universale. Qui però arrancavano. Diversi tentativi di sincronizzare gli orologi parigini erano miseramente falliti. Il sogno di imporre al mondo il tempo dell’Eliseo svaniva, mentre suonava l’ora di Greenwich. A Londra avevano importato l’idea dei cugini americani dei fusi orari (nata dalle necessità di una ferrovia che attraversava quarantacinque meridiani diversi), e l’avevano estesa a tutto l’impero: i cavi sottomarini dettavano l’ora di Sua Maestà Britannica da un capo all’altro del mondo. Ma Parigi non demorde, la battaglia per un tempo “francese” continua sotto l’egida del “Bureau des Longitudes”. Ed è qui che entra in gioco Henri Poincaré. Era stato allievo dell’“École Polytechnique”, dove per antica tradizione pura riflessione e ricerca applicata erano strettamente intrecciate. Al “Bureau” ha il compito di disegnare mappe accurate dei possedimenti francesi. Ma per questo ha bisogno di dati perfetti sulla longitudine. E per ottenerli occorre una misura del tempo senza sbavature. Dalla sua riflessione nasce l’articolo del 1898 dedicato a “La misura del tempo”, in cui dimostra che la simultaneità è irriducibilmente una convenzione. Non è ancora la relatività, ma manca solo un passo. Lo compirà l’impiegato dell’ufficio brevetti di fronte agli orologi della stazione di Berna: se la simulta-neità è una convenzione, non c’è osservatore che possieda un tempo assoluto. Il “grande orologiaio” di Newton è spodestato, d’ora in poi bisognerà dichiarare a quale particolare orologio ci si riferisce. La relatività ha fatto il suo ingresso nel mondo. Peter Galison, professore di storia della scienza ad Harvard, ricostruisce le origini dell’idea che ha rivoluzionato la fisica moderna sullo sfondo dei frenetici cambiamenti che hanno segnato l’ultimo terzo dell’Ottocento. (Roberto Persico) evadere dal meschino ambiente familiare sono a loro volta degli spostati: poeti falliti, uno spacciatore cocainomane, un aspirante scienziato insoddisfatto. Ma la “grande casa” si trova all’Avana, il papà ufficiale è stato degradato in Angola, la mamma è un’argentina di buona famiglia piombata a Cuba per romantica esaltazione rivoluzionaria e rimastavi suo malgrado, a sentir tanghi per curarsi la nostalgia; e che un altro zio è esule a Miami, mentre la zia è uscita di testa in seguito all’amore frustrato per un dissidente. Se la casa di “Cent’anni di solitudine” è distrutta da un ciclone tropicale, se la famiglia della “Casa degli spiriti” è dispersa dal golpe di Pinochet, è invece la caduta del muro di Berlino col conseguente “periodo speciale” di stretto razionamento decretato dal regime il cataclisma epocale che spinge chi può a scappare dall’isola, sia tra i parenti va in contatto con ambienti cubani ufficiosi. Il quadro di squallore con cui il libro dipinge Cuba è in sé troppo diverso dai modi di una certa ambigua letteratura fiorita di recente sull’isola, e che fa critica sociale, salvo poi dipingere “quelli di Miami” come un branco di farabutti, e consigliare chi proprio non sopporta più il regime a preferire appunto l’introspezione all’opposizione diretta o alla fuga. (Maurizio Stefanini) Aa. Vv. LOCUS SOLUS. IL RITRATTO Bruno Mondadori, 112 pp., euro18 compare nel “ritratto” il volto (o la figura intera) di colui che, per comparirvi, si S era prima messo in posa. Lo dice la parola stessa, mentre lo (ri)chiama denunciando la Lacan, la parola come campo minato Se un appunto, imperdonabile, si può muovere alla pubblicazione del “Seminario, Libro V” di Jacques Lacan (Einaudi, pag. 529, euro 35), nella traduzione maniacalmente empatica di Antonio di Ciaccia, è quello di aver mancato per l’inezia di tre anni un lettore (e complice) fondamentale. Almeno uno, Carmelo Bene. Che per una vita, nella sua roulette russa del farsi teatralmente fuori, aveva cercato e infine trovato in Jacques Lacan il suo colpo in canna. Dal giorno in cui i due Incantatori si sfiorano e si mancano l’unica volta a Parigi, nel camerino dell’Opéra Comique, alla fine di un “Romeo e Giulietta” applauditissimo. Lui, Lacan, ieratico, molto elegante, nel suo abito blu notte. Carmelo Bene, madido di sudore, di spalle, davanti allo specchio, che si va struccando da Mercuzio, sul tavolo le foto dei comatosi di guerra di David Haraly. “Bon soir maître”. “Jacques Lacan (pas maître)”. Ancora Lacan. “Je veux relire tout Shakespeare”. E nulla più, oltre i vetri chiusi e i nasi spiaccicati di lacaniani e beniani adoranti. Quel dirsi tutto tacendo. Ascoltare Lacan è il campo minato. Lorenzaccio da Musset. Il suo idiota farfugliante, non si sa se più futile o più spaventato, la svolta per sempre lacaniana del già labile teatro beniano che infarta, definitivo, nel musicale disastro dell’eroe tragico in cui il desiderio coincide con l’annientamento e la parola con il suo scacco. Lager crivellato di buchi, sublime di rose e di spine, dove ci si condanna a sopravvivere nel terrore di una scena dove è impossibile dire “io sono”, quando l’effetto precede la causa e quanto avanza è lo scimmiesco gesticolare a bocca aperta nel vuoto di scena. Lorenzaccio che scende nella fossa a toccare con mano il proprio ben orchestrato cadavere. Se la parola di Lacan ha smesso di darsela a bere e insiste tuttavia a dare da bere agli assetati, decenni dopo, è perché il deserto avanza e la sete ha sempre più sete e c’è chi si è arreso per sempre all’ascolto. Tradurre in un italiano del farsi, farlo capire, il Lacan parlante, il Lacan bucaniere che si avventura nei buchi della parola, è vertigine pura, dentro una lingua che va, procede, sbanda, arretra, accerchia all’infinito la cosa, come il clown che rischia l’osso del collo per mettere il guinzaglio all’animale che per definizione, difetto di definizione (e assenza di collo) non si lascia prendere. Queste del quinto seminario sono le lezioni tenute nel 1957-58, il suo anno più fecondo e facondo, sul tema della formazione dell’inconscio. Diviso in quattro parti, è “la cattedrale” dell’insegnamento lacaniano, nella definizione di Jacques Alain Miller che ha curato il testo, messa a punto finale della sua interpretazione freudiana, riformulata a partire dalla lettura critica di Jakobson e di Saussure. Sette capitoli per giustificare l’affermazione che l’inconscio è strutturato come un linguaggio, lettura estrema che Lacan fa della tesi di Freud e che Freud non ha mai avuto l’audacia, o forse il dono, di formulare. “Il soggetto è tale a causa del suo rapporto con il significante”: non è ancora il Lacan temerario dei seminari successivi, il Lacan del salto nel vuoto del dire ciò che è impossibile da dire, e cioè il buco del simbolico. Ma è già un Lacan da grande safari, che mette in campo tutto il suo impressionante arsenale retorico per costruire l’agguato costante di parola, che va a incalzare, sfruculiare, molestare il sintomo messo alle corde. Da leggere a voce alta, suggerisce Di Ciaccia. Che disincarna il luogo dell’Altro e, nelle ultime pagine, schiude a sorpresa l’idea che il codice non include tutto il messaggio, non lo restituisce per intero. A partire dal Witz, il motto di spirito, il nuovo del dire, che Lacan prende molto sul serio e associa nel funzionamento alle formazioni dell’inconscio, sogni, lapsus, dimenticanze. La parola che scappa di bocca e ritorna come smacco e scacco nel soggetto straparlante. Un al di là del dire che non riuscirà mai a dire. Il soggetto che si realizza nel linguaggio ma è allo stesso tempo alienato nel linguaggio. Grandioso, in quanto certificato e restituito al mittente nella propria miseria. Lorenzaccio, Bene, Lacan. E‚ la cattedrale al suo meglio che frana. Giancarlo Dotto Karla Suárez SILENZI Guanda, 226 pp., euro 8 l primo dei silenzi del titolo è sul nome Iprima della protagonista, la ragazza che narra in persona la sua vita tra i 6 e i 26 anni: “bimba” per la madre, “flaca”, in spagnolo “secca”, per gli amici. Altri silenzi sono quelli che avvolgono i vari membri della “famiglia di pazzi” con cui la “bimba magra” vive, in una “casa grande”, schema piuttosto diffuso nella letteratura latinoamericana. Solo che qui le vicende che travolgono i protagonisti non sono epiche ma grottesche, e consistono soprattutto in incidenti e litigi che svelano all’improvviso alla “bimba” un bel po’ di retroscena imbarazzanti. Per esempio, che il papà ufficiale non è un eroe di guerra ma è stato degradato per codardia di fronte al nemico. Che la nonna, così sprezzante verso la convivenza non sancita da matrimonio dei suoi genitori, ha avuto a sua volta suo padre da una relazione extramatrimoniale con un negro. O che l’altro figlio dalla nonna tanto coccolato è un omosessuale. D’altra parte, anche gli amici tra cui la ragazza cerca di e Derrida – per acciuffare i personaggi, già inesorabilmente avviati su linee di fuga, afferrandoli ai rispettivi occhiali e cappello, la piega della cravatta e l’ombrello, la pipa e la seggiola su cui “farsi legare per impedire a se stesso” di sfuggire alle carte. Insomma, agli orpelli, gli ornamenti, i non accessori travestimenti che sono tutti passati alla storia con loro. Paradossale? Almeno quanto “l’operazione di verità” compiuta attraverso la ritrattistica di ogni tempo. Compiuta tra gli anni Sessanta e gli Ottanta dal consapevolissimo Adami. O, nell’antichità romana, attraverso l’itinerario “iniziatico” che Alberto Castoldi ripercorre scrutando il simulacro di Sileno nella Villa dei Misteri di Pompei, o spiando sotto il manto della “Velata” di Raffaello Sanzio (spogliatala, ci trova “La Fornarina”: stessi occhi, stesso sguardo, stessa dama). I “Giochi di specchi” del cinquecentesco Ludovico Buti, poi, descritti da Yves Hersant, rinunciano all’ovvietà del riflesso, e traducono, trasmutano, convertono. Divertono come le caricature di Tullio Pericoli che, nella “Galleria dei ritratti” visitata da Marco Belpoliti, squaderna dalle pagine di Robert Louis Stevenson la silhouette delle alture marchigiane. Ma non è una sorpresa: già lo sapeva Cosimo il Vecchio che, ricorda la Valtolina, commentava da lontano: “Ogni dipintore dipinge sé”. Alla fine, però, sempre lo si scopre: neanche (o nonostante?) si fosse “ritratto”. (Alessandra Iadicicco) a cura di Alessandro Triulzi DOPO LA VIOLENZA Àncora del Mediterraneo 332 pp., euro 25 a memoria crede prima che la ragione L ricordi”: una citazione di Faulkner introduce il saggio, che dà conto di un seminario tenutosi a Cortona nel 2002 e che dà una visione comparativa di alcuni percorsi di costruzione della memoria nel mondo contemporaneo, in particolare nelle società postcomuniste e post coloniali, “in cui la violenza è alla base stessa della costituzione dello Stato e della sua cultura di prevaricazione rivolta contro coloro che, colonizzati, perseguitati o emarginati dal potere centrale, non fanno parte della comunità nazionale o non sono percepiti come tali”. La memoria gioca sia il ruolo di strumento di potere sia quello di mezzo di aggregazione del gruppo nella costruzione della sua identità storica e culturale. Capita allora che “dopo la violenza” il suo ricordo porti a una rinnovata esplosione di violenza, e “il ricordo collettivo dei traumi del passato diventa ossessione che domina e determina i comportamenti di collettività che si sentono in pericolo e anticipano la violenza altrui”. Il processo di trasmissione della memoria negli ultimi decenni si è modificato grazie ai nuovi mezzi che permettono una diffusione trasnazionale e globalizzata degli eventi, con una sempre più forte capacità di presa sulla coscienza collettiva. La rivoluzione delle comunicazioni ha fatto sì che anche le “politiche della memoria” messe in atto da Stati, gruppi, individui abbiano un forte impatto nel difendere il proprio ruolo, il proprio operato, la propria identità. La memoria si è trasformata in un potente strumento di autoidentificazione, di produzione di senso storico per comunità e gruppi divisi e antagonisti e di legittimazione di chi è al potere. Si tratta di nuovi, seppur ambigui, linguaggi di potere, di nuove prassi politiche, in cui la violenza passata e subita assume una valenza simbolica e rituale che va ben oltre il semplice ricordo per quanto traumatico ma serve a giustificare nuove violenze. Così “la memoria della violenza può trasformarsi in ‘memoria condivisa’ quando vi sia alla base la volontà politica di riconoscere l’offesa arrecata all’umanità dell’una e dell’altra parte e quando la memoria si trasforma in diritto di mantenimento della propria identità storica e culturale e al ripristino delle gerarchie sociali e di potere che hanno preceduto e alimentato la violenza iniziale”. Raccontare il dolore, essere stato testimone di certi drammi, portare i segni sul proprio corpo delle violenze subite trasforma il singolo individuo in portavoce della nuova memoria consolatoria e riparatrice. Le popolazioni albanesi e serbe in Kosovo, le stragi giapponesi nella Cina occupata alla vigilia della seconda guerra mondiale, la memoria divisa dei reduci dai Gulag nella Russia post-krusceviana, e ancora le popolazioni sterminate come gli ebrei sopravvissuti alla Shoà in Israele, i tutsi e gli hutu superstiti degli eccidi in Rwanda e Congo orientale, i Mau Mau nel Kenia coloniale, Eritrei ed Etiopi: storie, drammi, ricordi di efferatezze subite o inflitte attraverso le quali si è andato costruendo e si costruisce l’ambiguo processo di costruzione di memoria collettiva per legittimare e giustificare il presente e per determinare il futuro. (Gaia Marotta) Georgius Agricola DE RE METALLICA. BERMANNUS Clueb, 691 pp., euro 70 della “flaca”, sia tra i suoi amici. E dunque, a lasciarla infine sola assieme a una gatta nella “grande casa”, a scrivere e a curarsi l’amarezza a colpi di introspezione. “Penso che in realtà sono sempre andata alla ricerca del silenzio”, conclude. “E’ uno stato indescrivibile. Uno si sente padrone di sé, responsabile di sé. Individuo”. Ma questa rivalutazione di un silenzio già strumento d’ipocrisia non chiude però il circolo. Un altro silenzio, forse il più sorprendente, è infatti quello sull’effettivo atteggiamento di Karla Suárez sul regime di Fidel Castro, mai direttamente menzionato nel libro. Ingegnere informatico, 36enne, l’autrice risiede infatti oggi a Roma, ma fino a tempi recenti risulta- fuga di chi “si ritrae” tra le quinte della cornice, si ritira ambiguo nelle trame della tela, arretra sottraendosi allo spettatore che, un passo indietro, lo cerca nella prospettiva del dipinto. Perfino una ritirata così manifesta doveva, come tutti gli inganni dell’arte, mascherarsi. E tanto più difficilmente deponibile sembrerebbe la maschera quando aderisce (sapevano i latini) al volto della “persona”. Corre tutto sul filo di questo inseparabile contatto, tra il viso umano e il suo artistico “travisamento”, il saggio che Amelia Valtolina ha composto come un racconto filosofico a chiave. Corre sul limite dei ritratti di Valerio Adami – Gandhi e Joyce, Freud e Benjamin, Alfieri interessante ricordare che l’ingegnere diventerà un eroe positivo solo nelE’ l’Ottocento”, scrivono Paolo Macini ed Ezio Mesini, curatori di quest’edizione di un classico della storia della scienza e della tecnica, il “De re metallica” (1556) di Georg Bauer (1494-1555). Eroe del pensiero laico e scientista della modernità europea, artefice e insieme simbolo del progresso materiale e morale delle società occidentali industrializzate: questo era l’ingegnere ancora agl’inizi del Novecento. E’ difficile, per gli studenti che in massa si riversano oggi nelle facoltà di ingegneria inseguendo la “professionalizzazione” e le capacità “ma- nageriali”, riallacciarsi a questo passato, nemmeno tanto lontano. Eppure, l’aura attorno all’ingegnere era frutto della consapevolezza che la spinta all’innovazione tecnica rappresentasse un carattere costitutivo dell’identità europea, inscindibile dalla sua tensione verso la libertà. Il libro ci offre una fortunata istantanea di quest’alleanza: sfilano in ordine sparso davanti a noi ruote idrauliche, pompe e meccanismi di ventilazione, fornaci e mantici "meccanici”, metodi di produzione dell’acido nitrico, procedure di raffinazione dei metalli e grafici di rilevamento topografico, insieme ai compiti dei direttori amministrativi, alla regolamentazione e alla gestione delle concessioni e delle compartecipazioni finanziarie, ai problemi di organizzazione del lavoro tecnico salariato e alla medicina del lavoro. “Istantanea” straordinaria perché il lavoro di Agricola fotografa – la fama del libro è dovuta anche alla ricca ed efficace collezione di illustrazioni – un momento di un’evoluzione in corso in Europa, ma la cui dinamica è difficile da cogliere, perché la conoscenza tecnico-pratica cresce e si trasmette, in parte ancora oggi, per lo più senza lasciare traccia scritta: è, parafrasando Schumpeter, “creazione che distrugge”. La riscoperta di questo libro non è un caso. Esso costituì una vivace manifestazione della consapevolezza dell’originalità culturale e del valore umanistico dell’alleanza fra tecnica e attività economica che si era venuta a stabilire sul suolo europeo. Nel 1912 fu pubblicata negli Stati Uniti una traduzione critica a cura di Lou Henry Hoover e del marito Herbert Clark Hoover, un ingegnere minerario futuro presidente degli Stati Uniti. Hoover, promotore dell’introduzione delle tecniche di gestione aziendale per razionalizzare il lavoro della pubblica amministrazione, rappresenta uno degli ultimi esempi di una lunga tradizione di coinvolgimento degli ingegneri nella sfera della vita pubblica o, come si usa dire oggi, nella società civile. Nella seconda metà del Novecento questo ruolo si è appannato, trascinato forse dall’odio di sé (per dirla con Furet) che montava nell’occidente industrializzato. E’ subentrato così il profilo grigio e senz’anima che oggi viene insieme richiesto e rimproverato al tecnico e all’ingegnere: essi devono limitarsi a far funzionare la struttura dei sistemi e delle reti di cui è composto il nostro mondo tecnologico. Gli studenti cui si accennava prima si piegano oggi a questo nuovo ruolo senza opporre gran resistenza. Macini e Mesini, ingegneri e professori dell’università di Bologna, completano il lavoro presentando l’originale latino e fornendo anche la prima traduzione italiana di un’opera divulgativa di Agricola, l’incantevole “Bermannus”, un dialogo sul mondo minerale. (Ana Millán Gasca) Matteo Ricci DELL’AMICIZIA Quodlibet, 212 pp., euro 24 na prodigiosa memoria. Fu questo il U tratto caratteristico di Matteo Ricci. Missionario, astronomo, letterato, cartografo, matematico, viaggiatore, s’innamorò a tal punto della Cina che, rasatosi la testa e indossato il saio da bonzo, ne valicò il confine camuffato da monaco buddista nel 1583, dopo quattro tentativi falliti. Il gesuita nato a Macerata non rimise più piede in Europa, trattenendosi fino al 1610, anno della morte, celebrata, per la prima volta nella storia, con gli stessi onori riservati ai mandarini, élite culturale dell’epoca. Supportato da un’imponente cultura enciclopedica riuscì ad impadronirsi con una velocità sorprendente dell’arma più immediata per penetrare nella cultura orientale: una perfetta conoscenza della lingua, e comprese che un’ulteriore chiave d’accesso sarebbe stata quella d’accreditare se stesso e la propria cultura nel nuovo paese, attraverso la divulgazione. Vi riuscì così bene da essere considerato dai cinesi come un classico della loro letteratura. Ancora oggi, a Pechino, la sua tomba è onorata come quella di un figlio d’occidente, divenuto in tutto e per tutto cinese. Il volume è un esempio significativo del continuo sforzo per accendere un dialogo tra occidente ed oriente, attraverso il volano di una corretta conoscenza reciproca. I cinesi scoprirono in questo modo che la loro tradizione mentiva nel presentarli come baricentro culturale del pianeta, mentre gli occidentali compresero che su tematiche fondanti un confronto sarebbe stato possibile. L’amicizia, considerata dagli orientali come uno dei cinque vincoli sociali naturali e il fondamento di tutti gli altri (come recitano i testi confuciani), poteva essere un giusto punto d’incontro. In quest’edizione compare non solo la ristampa fotografica dell’edizione cinese a stampa con traduzione italiana a fronte, ma, per la prima volta, anche il testo autografo della redazione italiana di Ricci, rinvenuto di recente alla British Library di Londra. Una raccolta di cento sentenze attinte dalla tradizione classica latina, greca, patristica e medioevale (Plutarco, Aristotele, Diogene Laerzio, Cicerone, Seneca, S. Agostino), adattate al gusto e alla possibilità di comprensione dell’interlocutore cinese, presentata da “un amico della Cina venuto da lontano”: “Io, Matteo, mi ritirai con ossequio, scrissi quello che avevo udito sin da fanciullo, composi un opuscolo sull’amicizia e lo presentai con rispetto”. “Il singolo uomo non può compiere ogni cosa; perciò il Signore del Cielo ha comandato agli uomini l’amicizia, affinché si prestassero reciproco aiuto”, dichiara una sentenza occidentale. Conferma di quanto padre Matteo Ricci fosse riuscito nel suo intento di dimostrare come le due culture potessero guardarsi allo specchio e arrivare a vedere lo stesso volto. (Paola Bacchiddu)
Scaricare