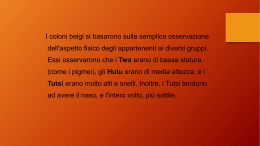“Desideriamo informarla che domani verremo uccisi con le nostre famiglie…” Serata di letture sulla violazione dei diritti dei popoli. Bellinzona, Biblioteca cantonale martedì 20 marzo 2007 alle 20:30 Nell’ambito della rassegna “La Svizzera e la persecuzione degli ebrei in Italia, 19381945” la BcB propone una serata di letture sul ripetersi sistematico di crimini nei confronti di popoli e etnie. Una lista sconfinata dalla quale abbiamo scelto alcuni esempi che vogliono dar conto di quanto la brutalità sia una peculiarità del tutto umana. Realtà e finzione costellano il nostro quotidiano di orrori e violenze. Ci siamo chiesti se fosse veramente il caso di aggiungerne altri. Abbiamo pensato che sì, che la memoria ha bisogno di storie per vivere. Storie che raccontano l’impossibile che può sempre succedere. Storie come antidoti. Moniti. Se nella letteratura non mancano le testimonianze delle vittime dei genocidi, è più difficile trovare le ragioni dei carnefici. Ci è sembrato molto importante dar voce anche a questi uomini che sono stati gli esecutori di soluzioni concepite nelle menti malate di politici e militari. Solo ascoltando queste voci abbiamo la possibilità di capire, almeno in parte, la banalità del male di cui scrisse Hanna Arendt. C’è stato, e purtroppo continua ad esistere, un funzionariato della morte che giustifica il suo agire con il candore supino di chi non ha fatto altro che ubbidire. Le testimonianze che ascolterete sono solo i frammenti di mille tragedie che purtroppo continuano a perpetrarsi. Di sicuro nella vostra personale geografia dei genocidi ne affiorano altre. Non le abbiamo dimenticate, pulsano continuamente nella vita reale, nelle parole, nelle immagini. I testi, preceduti da brevi contestualizzazioni storiche, sono raccolti in un’antologia scaricabile dal nostro sito. Pensiamo che queste letture siano proponibili anche ai giovani delle scuole medie e medie superiori. L’antologia è stata curata da Sarah Caccia e Theo Mossi 1. Antonio Scurati, Il sopravvissuto, Bompiani, Milano, 2005 2. Philip Gourevitch, Desideriamo informarla che domani verremo uccisi con le nostre famiglie. Storie dal Ruanda, Einaudi, Torino, 2000 3. Gitta Sereny, In quelle tenebre, Adelphi, Milano, 1975 4. Anna Politkovskaja, CECENIA. Il disonore russo, Fandango, Roma, 2003 5. François Bizot, Il cancello, Ponte alle grazie, Milano, 2001 6. Joe Sacco, Palestina occupata, Mondadori, Milano, 2006 7. Zlatko Dizdarevic, Giornale di guerra. Cronaca di Sarajevo assediata, Sellerio, Palermo, 1994 8. Horacio, Verbitsky, Il volo. Rivelazioni di un militare pentito sulla fine dei desaparecidos, Feltrinelli, Milano, 1996 9. Susan Sontag, Davanti al dolore degli altri, Mondadori, Milano, 2003 Antonio Scurati, Il sopravvissuto Andrea aprì il suo diario. Poche pagine lo separavano oramai dai fogli bianchi. Venerdì 11 maggio 2001 Per un professore di storia, maggio è il più crudele dei mesi. Sebbene il nuovo programma ministeriale preveda che l’intero ultimo anno sia dedicato allo studio del XX secolo, la prolissità della vicenda umana e gli arretrati dell’anno precedente congiurano sempre affinché non si riesca mai a doppiare il capo di Buona Speranza della seconda guerra mondiale. Così proprio al mese di maggio, stretto tra l’ansia dell’esame di Stato, l’isterismo del riepilogo finale e la malinconia dell’epilogo di un lungo ciclo di vita, spetta il compito di fare i conti con il genocidio. Perché, alla fine, di fare i conti si tratta. Per quanto ogni anno, giunto a dover spiegare l’epoca del male assoluto, mi proponga di evitare il mero catalogo degli orrori, tutto, inevitabilmente, si riduce sempre a questo. Per quanto mi sforzi di far comprendere le dimensioni concettuali del genocidio, insistendo sull’inestricabile intreccio tra la novità assoluta del suo evento e le costanti del mondo moderno, alla fine il mio tentativo di condurre un ragionamento viene sempre sopraffatto dall’enormità dell’ecatombe, dalla sua mera consistenza numerica. E allora, verso la metà di maggio dell’ultimo anno di scuola superiore, impigliandosi nel filo spinato dei campi di concentramento, lo studio della storia dell’umanità si riduce alla spuntatura di una lista di stermini. Un milione e mezzo circa di armeni morti in conseguenza delle deportazioni, o direttamente massacrati su ordine dei Giovani turchi, ufficiali nazionalisti dell’impero ottomano, tra il 1915 e il 1923. Trentamila morti causati dalla Rivolta dei boxers nell’anno 1900 in Cina, e poi quarantotto milioni di cinesi caduti sotto il regime di Mao tra il “grande balzo in avanti”, le purghe, la rivoluzione culturale e i campi di lavoro forzato, dal 1949 al 1975. Non meno di venti milioni i russi eliminati durante gli anni del terrore comunista di Stalin, sommando esecuzioni di controrivoluzionari e di prigionieri, vittime del gulag o della fame; a questi vanno aggiunti altri dieci milioni di russi caduti negli anni della seconda guerra mondiale nella lotta contro la barbarie nazista, in buona parte sterminati dall’esercito tedesco dopo esser stati catturati come prigionieri di guerra durante l’avanzata verso est. Sei milioni di persone annientate durante l’olocausto del popolo ebraico d’Europa, avviato da Hitler dopo l’avvento del nazismo in Germania (1933-1945), la gran parte di loro morta nei campi di sterminio durante la famigerata “soluzione finale” (1942-1945), senza contare zingari, omosessuali, menomati fisici e oppositori politici. Quasi un milione di comunisti indonesiani deliberatamente eliminati dalle forze governative nel periodo tra il 1965 e il 1967, a cui vanno aggiunti, per rimanere nella regione, duecentocinquantamila persone di Timor Est, abbattute da gruppi paramilitari filoindonesiani tra il 1975 e il 1999; un milione di cambogiani morti in soli quattro anni, tra il 1976 e il 1979, sotto il regime di terrore instaurato dai khmer rossi di Pol Pot. Un milione e novecentomila cristiani e animisti deceduti a causa del blocco imposto dal governo di Khartum all’arrivo degli aiuti umanitari destinati al Sudan meridionale; ottocentomila civili ruandesi massacrati a colpi si machete nel conflitto scoppiato tra hutu e tutsi nel 1994; un’analoga cifra è stimata per le vittime del vicino Burundi. Oltre un milione le vittime innocenti della violenza di Stato dei regimi sudamericani, da quelle della Rivoluzione messicana ai “desaparecidos” delle dittature militari negli ultimi decenni del XX secolo; quasi ottocentomila indios morti in un secolo in Amazzonia per le angherie e soprusi subiti. Un milione, tra cui cinquecentosessantamila bambini, gli iracheni morti a tutto il 1998 a causa dell’embargo internazionale e della politica di Saddam Hussein. A tutti questi vanno ancora sommate le vittime dei genocidi e delle “pulizie etniche” compiute nella ex Iugoslavia, in Liberia, Sierra Leone, Angola, Congo, Libano, Corea del Nord, Sri Lanka, Haiti, Tibet, Cecenia, Palestina, riguardo alle quali non si hanno ancora stime sicure. Ecco, questo è, ogni anno, il mese di maggio per un professore di storia in un liceo. RUANDA Il genocidio ruandese fu uno dei più sanguinosi episodi della storia del XX secolo. Dal 6 aprile alla metà di luglio del 1994 vennero massacrate sistematicamente tra le 800.000 e 1.000.000 di persone. Le vittime furono in massima parte di etnia Tutsi, che costituisce una minoranza rispetto agli Hutu. Le divisioni etniche del paese sono state opera principalmente del dominio coloniale europeo, prima tedesco e poi belga. In realtà Tutsi e Hutu fanno parte dello stesso ceppo etnico culturale Bantu e parlano la stessa lingua. Il genocidio terminò col rovesciamento del governo Hutu e la presa del potere, nel luglio del 1994, dell’RPF, il Fronte Patriottico Ruandese. Philip Gourevitch, Desideriamo informarla che domani verremo uccisi con le nostre famiglie. Storie dal Ruanda In Ruanda, tra la primavera e l’estate del 1994, più di ottocentomila persone sono state torturate e uccise. Gourevitch ha cercato di ricostruire ciò che è accaduto, andando oltre l’anatomia del genocidio e offrendo anche una ricostruzione delle cause, delle conseguenze e degli strascichi di quella tragedia. Il titolo di questo libro prende spunto da una lettera angosciante che alcuni pastori protestanti di etnia tutsi, assediati in una chiesa, scrissero ai loro superiori hutu. Nella provincia di Kibungo, nel Ruanda orientale, in una zona di pascoli e paludi in prossimità del confine con la Tanzania, si trova la collina di Nyarubuye. E c’è una chiesa dove intorno alla metà di aprile del 1994 vennero massacrati molti tutsi. Era trascorso un anno da quell’eccidio quando visitai Nyarubuye in compagnia di due ufficiali canadesi. Arrivammo a bordo di un elicottero delle Nazioni Unite, sorvolando a bassa quota le colline avvolte nella foschia mattutina da cui facevano capolino le verdi stelle degli alberi di banano. Atterrammo nel cortile della scuola parrocchiale, sull’erba alta incurvata dallo spostamento d’aria, e dal nulla si materializzò un soldato con un Kalashnikov, che ci strinse la mano con una cortesia severa e impacciata. Mentre i canadesi esibivano i permessi per la visita, varcai la porta di una delle classi. Il pavimento era ricoperto da non meno di cinquanta cadaveri, in fase avanzata di decomposizione ma ancora fasciati dagli abiti. Le loro cose distrutte erano sparse ovunque. E in vari punti erano rotolati dei crani mozzati dai machete. I cadaveri sembravano fotografie di cadaveri. Non puzzavano. Non brulicavano di mosche. Erano stati uccisi tredici mesi prima, e da allora non erano stati toccati. C’erano ancora brandelli di pelle sulle ossa, molte delle quali erano separate dai corpi, smembrati dagli assassini, o dagli animali – uccelli, cani o insetti. I corpi più integri sembravano proprio persone, ciò che erano una volta. Accanto alla porta giaceva una donna avvolta in un tessuto stampato a fiori. Dal corpo spuntavano le ossa spolpate delle anche, e tra le gambe divaricate era coricato lo scheletro di un bambino. Il tronco era vuoto. Non mi ero mai trovato in mezzo ai cadaveri. Cosa dovevo fare? Guardarli? Certo, volevo vederli; se ero arrivato fin lì, era proprio per vederli – a Nyarubuye i morti erano stati lasciati insepolti a scopo commemorativo. E ora eccoli, esposti allo sguardo nella loro intimità. Non che avessi davvero bisogno di vederli; sapevo già quello che era accaduto in Ruanda, e ci credevo. Ma anche ora che osservavo gli edifici e i cadaveri, che ascoltavo il silenzio che pervadeva quell’imponente basilica in stile italiano, e ammiravo i decadenti cespugli di fiori lussureggianti concimati dalla morte, tutto restava stranamente inimmaginabile. Era ancora necessario uno sforzo di immaginazione. Sapevo che quei cadaveri ruandesi sarebbero rimasti con me per sempre. Era questa la ragione che mi aveva spinto a visitare Nyarubuye: volevo restarne segnato – non dalla loro esperienza, ma dall’esperienza che avrei acquisito guardandoli. Erano stati uccisi in quel posto, ed eccoli lì, morti. Cos’altro c’era da vedere? La Bibbia enfiata dalla pioggia addosso a un cadavere; oppure, sparpagliate qua e là, le ghirlande di stoppie intrecciate che le donne ruandesi portano come corone per tenere in equilibrio gli enormi carichi che trasportano sulle teste; o la racchetta Converse che spuntava da un bacino. Il soldato con il Kalashnikov era un tutsi i cui genitori erano fuggiti in Uganda quando lui era bambino, negli anni ’60, in seguito a massacri come quello, anche se meno estesi. Nel 1994 era tornato a casa per combattere, e questo era quello che aveva trovato. Disse che in quella stanza c’erano soprattutto donne, e che, prima di essere uccise, erano state stuprate. Mi chiese cosa stessi guardando, e io abbassai lo sguardo sui miei piedi. Tra di essi, nella polvere, giaceva la testa arrugginita di un’ascia. Poche settimane prima, a Bukavu, in Zaire, nell’enorme mercato di un campo profughi, avevo osservato un uomo che macellava una vacca con un machete. Faceva il suo lavoro con grande abilità, menando con precisione forti fendenti che producevano un rumore secco e sibilante. L’urlo di raccolta degli assassini durante la carneficina era “Al lavoro!”. E in quell’occasione mi resi conto che macellare comportava davvero un duro lavoro. Furono necessari parecchi fendenti per mozzare la zampa della vacca. Quanti colpi ci volevano per fare a pezzi una persona? Considerando la mostruosità dell’accaduto, si è tentati di spiegare i massacri come una follia collettiva, un delirio di gruppo, un’epidemia d’odio sfociata in una bramosia criminale di massa, e di immaginare una cieca folla orgiastica, in cui ciascuno uccideva una o due persone. Ma, nel 1994, a Nyarubuye, e in migliaia di altre località di quel minuscolo paese, in alcune giornate nel giro di pochi mesi, centinaia di migliaia di hutu lavorarono come assassini rispettando turni regolari. C’era sempre ancora una vittima, e poi un’altra. Che cosa li sostenne dopo l’euforia del primo attacco, nella spossatezza fisica e nella desolazione quotidiana? La violenza di massa ha bisogno di organizzazione; non si manifesta per caso. Anche le rivolte e i tumulti hanno una regia, e un’operazione di sterminio estesa e prolungata richiede una grande pianificazione e grandi obiettivi. Va considerata come il mezzo che permette di approdare a un nuovo ordine e, per quanto possa essere criminale e oggettivamente stupida, l’idea alla base di questo ordine deve essere di estrema semplicità e al medesimo tempo assoluta. L’ideologia del genocidio è tutte queste cose insieme, e in Ruanda assunse un nome molto esplicito: “hutu power”. Per chi si accinge a sterminare sistematicamente un intero popolo – o un’etnia piccola e indifesa di circa un milione e duecentocinquantamila uomini, donne e bambini, come i tutsi in Ruanda – la sete di sangue è sicuramente di aiuto. Ma coloro che avevano progettato ed eseguito una carneficina come quella commessa appena oltre la soglia su cui mi trovavo non dovevano per forza provare piacere a uccidere; anzi potevano anche esserne disgustati. Però dovevano nutrire la ferma volontà di vedere morte le proprie vittime, averne un desiderio talmente forte da trasformarsi in una necessità. Mi restava ancora quindi molto da immaginare quando entrai nell’aula scolastica e mi feci strada tra i cadaveri con cautela. Quei morti e i loro assassini erano stati vicini di casa, compagni di classe, colleghi, talvolta amici o addirittura parenti. Nelle settimane prima della fine, i morti avevano assistito agli addestramenti delle milizie dei loro assassini, ed era ben noto che stavano preparandosi ad uccidere i tutsi; veniva ripetuto alla radio, lo si leggeva sui giornali, la gente ne parlava apertamente. Una settimana prima dell’eccidio di Nyarubuye erano stati compiuti i primi massacri nella capitale del Ruanda, Kigali. Gli hutu che avversavano l’ideologia dell’hutu power erano stati pubblicamente denunciati come “complici” dei tutsi, ed erano stati tra i primi a venire uccisi. A Nyarubuye i tutsi domandarono al sindaco, un esponente dell’hutu power, come fare per essere risparmiati, ed egli suggerì loro di rifugiarsi nella chiesa. Lo fecero, e pochi giorni dopo il sindaco tornò per ucciderli. Arrivò alla guida di una schiera di soldati, miliziani e abitanti del villaggio; distribuì le armi e diede l’ordine di eseguire il lavoro a dovere. Poteva limitarsi a questo, ma a quanto pare uccise anche alcuni tutsi con le sue mani. A Nyarubuye gli assassini ammazzarono per tutta la giornata. La notte tagliarono i tendini d’Achille ai sopravvissuti e andarono a festeggiare sul retro della chiesa, arrostendo su grandi falò il bestiame razziato alle vittime e bevendo birra. Poi, la mattina, ancora ubriachi e dopo quel tanto di sonno che erano riusciti a concedersi tra le grida delle loro vittime, gli assassini di Nyarubuye tornarono a uccidere. Giorno dopo giorno, minuto dopo minuto, tutsi dopo tutsi: si lavorò così in tutto il Ruanda. Ora anch’io ho visto quanto è successo, ho sentito raccontare come è successo e, dopo quasi tre anni di viaggi per il Randa e di incontri con i ruandesi, sono in grado di raccontarvelo. Ma continuo lo stesso a trovare qualcosa di incomprensibile nell’orrore – nell’idiozia, nell’inutilità, nell’assoluta erroneità – di quegli avvenimenti. Presumo che stiate leggendo perché desiderate uno sguardo ravvicinato, e presumo che anche voi siate turbati dalla vostra curiosità. Forse nell’esaminare con me quei fatti così estremi sperate di giungere a una qualche chiarificazione, a una presa di coscienza, a un barlume di autoconsapevolezza – a una morale, a una lezione, a un’indicazione su come comportarvi in questo mondo: insomma a una qualche informazione. Non escludo che questo possa avvenire, ma quando si parla di genocidio la distinzione tra il bene e il male è già chiara. La ragione principale per cui ho deciso di dare un’occhiata più da vicino alle storie del Ruanda è che ignorarle aumentava il mio disagio sull’esistenza e sul mio posto nel mondo. L’orrore, in quanto orrore, mi interessa perché solo possedendo un’esatta memoria del delitto è possibile comprenderne le conseguenze. I cadaveri di Nyarubuye erano belli. Non posso negarlo, lo scheletro è una bella cosa. La casualità delle forme stramazzate al suolo, la strana quiete percepibile nella loro brutale esibizione, erano cose belle, e la loro bellezza non faceva che rendere più osceno quel luogo. Non riuscivo a reagire in un modo sensato: repulsione, paura, dolore, lutto, vergogna, incomprensione, certo, ma niente di sensato. Mi limitavo a guardare e a fotografare, perché mi domandavo se nel momento in cui lo vedevo riuscivo davvero a vedere quello che stavo vedendo, e anche perché avevo bisogno di una scusa per guardare un po’ più da vicino. Attraversammo tutta la prima stanza e uscimmo dal lato opposto: c’era un’altra stanza e poi un’altra e un’altra e un’altra. Erano tutte piene di cadaveri, altri corpi erano sparpagliati sull’erba. A un certo punto udii uno scricchiolio. Il vecchio colonnello canadese stava incespicando davanti a me e vidi che senza accorgersene aveva urtato un teschio con un piede, spezzandolo. Per la prima volta dall’arrivo a Nyarubuye misi a fuoco le mie sensazioni: provavo verso quell’uomo una rabbia contenuta ma intensa. Poi udii un altro scricchiolio, e percepii una vibrazione sotto i piedi. Ne avevo calpestato uno anch’io. OLOCAUSTO L'ideologia hitleriana era imperniata su un radicale antisemitismo, senza però dare un chiarimento sul modo in cui questo avrebbe dovuto concretizzarsi. In una prima fase, il regime nazionalsocialista perseguì una politica di discriminazioni economiche e giuridiche in modo da rendere così difficile agli ebrei tedeschi la vita da indurli a emigrare. Le leggi emanate il 5 settembre 1935, note come leggi di Norimberga, definirono chi poteva far parte del popolo tedesco e chi invece ne doveva essere escluso. Solo dopo lo scoppio della guerra il regime, di fronte al grande numero di ebrei abitanti nei territori occupati, avviò le procedure per una soluzione radicale del problema attraverso lo sterminio. Non è dato sapere se e quando Hitler dette un preciso ordine in proposito; è plausibile ritenere che egli comunque avesse approvato in linea di massima i piani elaborati da A. Eichmann per conto delle SS. Circa 700.000 ebrei furono sterminati in forme non pianificate durante l'avanzata tedesca in Unione sovietica; altri nei ghetti polacchi e russi. Solo a partire dall'estate 1942 iniziarono a funzionare i campi di sterminio in cui gli ebrei, deportati da tutta Europa, venivano sistematicamente annientati per mezzo del gas. Si calcola che la soluzione finale, che gli ebrei chiamarono shoah, abbia provocato la morte di cinque-sei milioni di ebrei. Il termine olocausto viene anche usato per descrivere l'omicidio sistematico di altri gruppi che vennero colpiti nelle stesse circostanze dai Nazisti: i gruppi etnici Rom e Sinti (i cosiddetti zingari), comunisti, omosessuali, malati di mente, Testimoni di Geova, russi, polacchi ed altre popolazioni slave. Aggiungendo anche questi gruppi, il totale di vittime del Nazismo è stimabile tra i dieci e i quattordici milioni di civili. Gitta Sereny, In quelle tenebre Le tenebre a cui si riferisce questo libro sono quelle che circondano gli uomini ai quali fu affidato lo sterminio degli ebrei. Al centro di esse è la figura di Franz Stangl, poliziotto austriaco che, attraverso una carriera “normale” e agghiacciante, divenne capo del campo di Treblinka, in Polonia, dove più di un milione di persone trovò la morte. Nel 1970 Franz Stangl venne processato a Düsseldorf dopo essere stato scovato in Brasile. Al processo assiste la giornalista Gitta Sereny, che riesce ad ottenere diversi incontri. In questa esplorazione di come le debolezze e le paure di uomini come Stangl possano essere sfruttati per mandare avanti una macchina di morte quale fu Treblinka, la descrizione che egli mi fece della sua vita quotidiana al campo, e il modo in cui manipolava e reprimeva deliberatamente i suoi scrupoli morali, sono particolarmente illuminanti. Per tutti e tre i giorni in cui mi raccontò questa parte della sua storia, egli manifestò un intenso desiderio di cercare e di dire la verità. Questo bisogno, stranamente, era accentuato, anziché attenuato, dalla straordinaria insensibilità di gran parte delle sue spiegazioni e dei suoi racconti. Egli mi diceva la verità quale lui l’aveva vista ventinove anni prima, e continuava a vederla nel 1971, e nel far così, sia pure inconsapevolmente, mi diceva più della verità: mi rivelava i due uomini che egli era diventato al fine di sopravvivere. “Mi alzavo all’alba. I miei uomini erano inveleniti perché facevo la mia prima ronda alle cinque del mattino. Li facevo scattare. Prima controllavo le sentinelle e poi andavo al Totenlager.” “Che cosa faceva al Totenlager alle sei del mattino?”. “Era un’ispezione; andavo dappertutto. Alle sette facevo colazione. Dopo un po’ feci costruire il nostro forno. Avevamo un eccellente fornaio di Vienna. Faceva dei pasticcini deliziosi, e un pane buonissimo. Dopo di che , davamo il nostro pane militare ai lavoratori ebrei. Naturalmente”. “Naturalmente? Tutti facevano così?”. “Non lo so. Io facevo così. Perché no?”. “ Che cosa faceva dopo la prima colazione?”. “Alle otto circa andavo al mio ufficio.” “A che ora giungevano i trasporti?”. “Di solito verso quell’ora”. “E lei assisteva agli arrivi?”. “Non necessariamente. A volte ci andavo.” “Quanti prigionieri arrivavano a ogni trasporto?”. “Di solito circa cinquemila, qualche volta di più”. “Non parlò mai con qualcuno di costoro?” “Parlare? No. Naturalmente, come ho detto, io di solito lavoravo nel mio ufficio – c’era molto lavoro amministrativo da sbrigare – fino alle undici circa. Poi facevo un’altra ispezione, cominciando dal Totenlager. A quel punto erano già molto avanti nel lavoro, lassù”. Intendeva dire che per quell’ora le cinque o seimila persone che erano arrivate quel mattino erano già morte: il “lavoro” era la distruzione dei corpi, che prendeva la maggior parte del resto della giornata, e per diversi mesi continuò anche durante la notte. Questo lo sapevo, ma volevo indurlo a parlare più direttamente delle persone, e gli domandai dov’era la gente che era arrivata con il trasporto. La sua riposta continuò ad essere evasiva; continuava a evitare di parlare di loro come di gente. “Oh, per quell’ora, tutto era pressoché finito, al campo inferiore. Il trasporto veniva normalmente sbrigato in due o tre ore. Alle dodici facevo pranzo. Sì, di solito avevamo carne, patate, verdura fresca. Dopo facevo una siesta di mezz’ora. Poi un’altra ispezione e altro lavoro in ufficio”. “Che cosa faceva la sera?”. “Dopo cena , la gente sedeva qua e là a chiacchierare. Nei primi tempi usavano rimanere a bere per ore alla mensa. Ma io feci cessare questa consuetudine. Dopo d’allora, bevevano nelle loro stanze”. “E lei cosa faceva? Aveva qualche amico al campo?” “Nessuno. Nessuno con cui potessi parlare realmente.” “Mi ha raccontato delle sue routines quotidiane. Ma che cosa provava? Vi era qualcosa che le dava piacere, che la faceva sentire bene?”. “Mi interessava scoprire se qualcuno imbrogliava. Non mi curavo di chi fosse: la mia etica professionale mi diceva che se c’era qualcosa che non andava, io dovevo scoprirlo. Quella era la mia professione; mi piaceva. Mi appagava. E, sì, ponevo in questo la mia ambizione, non posso negarlo”. “Sarebbe esatto dire che si abituò alle liquidazioni?” Rifletté per un momento. “A dire la verità,” disse poi lentamente in tono pensieroso “si finiva per abituarcisi”. “Quanto ci volle? Giorni, settimane, mesi?” “Mesi. Mi ci vollero mesi, prima che riuscissi a guardare negli occhi uno di loro. Reprimevo ciò che provavo cercando di creare un luogo confortevole: giardini, nuove baracche, nuove cucine, tutto nuovo; barbieri, sarti, calzolai, falegnami. Vi erano centinaia di modi per sviare la mente da quello; io li usai tutti”. “Anche così, ci saranno stati dei momenti, magari la notte, al buio, in cui non avrà potuto evitare di pensarci, non è vero?” “Alla fine l’unico modo per sopportare la cosa era il bere. Mi portavo un bicchierone di acquavite a letto, ogni sera, e bevevo”. “ Mi pare che lei stia eludendo la mia domanda”. “No, non ne ho nessuna intenzione; naturalmente i pensieri venivano. Ma io li scacciavo. Mi concentravo sul lavoro; non facevo altro che lavorare”. “Sarebbe giusto dire che alla fine sentiva che in realtà quella gente non erano esseri umani?”. “Una volta, anni dopo, in Brasile, ero in viaggio,” disse con un’espressione profondamente concentrata “ il mio treno si fermò accanto a un mattatoio. Il bestiame nei recinti, all’udire il rumore del treno, trottò avvicinandosi alla barriera. Erano vicinissimi al mio finestrino, si spingevano l’un l’altro e mi guardavano. A quel punto pensai: mi ricorda la Polonia, era proprio così che appariva la gente, piena di fiducia, un momento prima che finisse nelle scatole…”. “Nelle “scatole” ha detto? Che cosa intende dire?”. Ma lui proseguì senza rispondermi, come se non mi avesse udito. “…dopo di allora non riuscii più a mangiare carne in scatola. Quei grossi occhi che mi guardavano…senza sapere che di lì a poco sarebbero stati tutti morti”. Fece una pausa. Aveva il volto tirato. In quel momento sembrò vecchio, esausto, vero. “E così, sentiva che non erano esseri umani?”. “Bestiame. Semplicemente del bestiame” alzò una mano e poi la lasciò ricadere in un gesto di disperazione. Le nostre voci erano cadute a un tono basso. Fu una delle poche volte, in quelle settimane di conversazioni, che non fece alcuno sforzo per mascherare la sua disperazione. “Quando pensa che cominciò a sentirli come bestiame?” “Credo che cominciò il giorno in cui vidi per la prima volta il Totenlager di Treblinka. Ricordo Wirth lì in piedi, accanto a quelle fosse piene di cadaveri lividi, nerastri. Non aveva più nulla a che fare con l’umanità…era una massa… una massa di carne che imputridiva. Wirth disse: “Che cosa dobbiamo farne di questo letame?”. Credo che inconsciamente fu da quel momento che cominciai a considerarli come bestiame”. “Vi erano tanti bambini, non le fecero mai pensare alle sue bambine, a come lei si sarebbe sentito se fosse stato al posto dei loro genitori?”. “No, non posso dire di aver mai pensato una cosa simile… Vede, raramente li vedevo come individui. A volte stavo in piedi sopra il muro, e li vedevo nel tubo. Ma – come posso spiegarlo – erano nudi, assiepati, e correvano sotto le sferzate…” non finì la frase. “ E non avrebbe potuto cambiare nulla di questo? Nella sua posizione, non avrebbe potuto far smettere la vestizione, le frustate, l’orrore di quei recinti?”. “ No, no, no. Era quello il sistema. L’aveva inventato Wirth. Funzionava. E dato che funzionava, era irreversibile”. CECENIA La storia del popolo ceceno è caratterizzata da un susseguirsi di eventi drammatici. Negli ultimi dieci anni il paese ha conosciuto due guerre, l’ultima attualmente in corso con la Federazione Russa. Le cause del conflitto sono complesse e rispecchiano le molteplici tensioni che attraversano tutto il Caucaso. Le principali componenti sono: l'affermarsi in territorio ceceno del potere delle bande armate, la crescente influenza del fondamentalismo islamico nella regione, l'importanza strategica del Caucaso per la Russia, i forti interessi economici legati al transito del petrolio negli oleodotti, la necessità di creare un "nemico esterno" per affermare con il pugno di ferro l'autorità del potere centrale di Mosca e dell'"uomo forte" chiamato alla guida del paese. A partire dal 1996, gli interessi delle bande armate cecene si scontrano con quelli di Mosca che vorrebbe affidare il controllo delle attività in Cecenia ai propri uomini di fiducia. I gruppi militari ceceni diventano sempre più potenti e questo conflitto di interessi continua ad inasprirsi. La popolazione civile è stata solo una pedina sacrificabile di questo scontro, schiacciata in mezzo a sporchi giochi di potere. I civili in Cecenia non hanno nessun tipo di protezione, anche perché la comunità internazionale, che dovrebbe tutelare i loro diritti, ha scelto invece di tutelare a tutti i costi gli scambi militari ed economici. Una guerra che dal 1994 ha causato circa 100.000 morti e più di 200 mila profughi. Anna Politkovskaja, CECENIA. Il disonore russo Anna Politkovskaja era stata più di quaranta volte in Cecenia per seguire la guerra. Aveva vissuto con i ceceni e condiviso il loro calvario. Incurante dei rischi e delle minacce, continuava a voler raccontare il conflitto. Aveva testimoniato dei saccheggi, degli stupri e degli omicidi perpetrati dai militari russi, e di come i combattenti ceceni stiano annegando nella delazione e nei regolamenti di conti. Il "viaggio all'inferno" di Anna Politkovskaja è un duro atto d'accusa contro la società russa, colpevole di tacere o acconsentire al genocidio, e contro il presidente Vladimir Putin, che ha bisogno di un nemico per far dimenticare i problemi reali del suo paese. Anna Politkovskaja è stata assassinata il 7 ottobre 2006. “Perché l’hai ucciso?” “Non lo so.” “Perché gli hai tagliato le orecchie?” “Non lo so.” “Perché gli hai fatto lo scalpo?” “Ma è un ceceno!” “Capisco”. Tratto dall’interrogatorio di un soldato di 19 anni della 22esima brigata del Ministero russo, di stanza in Cecenia nel corso dell’estate 2001. Contrariamente a quanto affermano medici, neurologi e psichiatri sulle nostre infinite possibilità, ogni uomo dispone di una resistenza morale limitata al di là della quale si apre il suo abisso personale. Non è necessariamente la morte. Ci possono essere situazioni peggiori, ad esempio la perdita totale della propria umanità, come unica risposta alle nefandezze della vita. Nessuno può sapere ciò di cui sarebbe capace in guerra. La Grozny di oggi fornisce all’uomo tutte le buone ragioni per cadere in questo abisso. Qui, è stato creato un mondo di totale irrazionalità militare, e anche se la guerra finisse domani, chissà, esso durerebbe ancora a lungo, per forza d’inerzia. In che cosa consiste questa irrazionalità cecena? Un uomo sensato, abituato sin dall’infanzia ai riferimenti della vita normale, non può capire l’origine degli eventi che straziano la Cecenia. Non importa che quest’ uomo sia ceceno o russo. Che sia un soldato, un militante della resistenza o un semplice cittadino che cerca di rimanere al di fuori di tutto per salvare la pelle. Dopo un certo periodo, in mancanza di risposte ragionevoli, la sua coscienza comincia a disgregarsi come un fungo marcio e la sua mente finisce in un vicolo cieco. Tuttavia non è follia, è un fenomeno diverso. E’ come se tutti i pilastri che hanno sostenuto la tua vita fino a quel momento fossero crollati. Comincia con l’impressione che anche tu potresti permetterti qualcosa in più di prima, che la morale non è altro che una stupidaggine inventata da ignoranti, mentre tu ormai sei portatore di una conoscenza particolare. All’inizio pensi ancora a quel “qualcosa in più”. Poi, poco a poco, il meccanismo che ti trattiene si allenta e sprofondi ogni giorno di più. A volte passeggio per le rovine della capitale cecena. Parlo con i suoi abitanti, li guardo negli occhi, ripenso alle loro storie e mi rendo conto che la mia mente rifiuta di credergli, contesta, respinge i loro racconti. Semplicemente per proteggersi. Ci credo e non ci credo, vorrei non farmi contaminare. Sono realmente qui, ma allo stesso tempo è come se fossi in un film… Non è possibile, urla la mia coscienza, che le nostre autorità si ostinino in modo così imbecille a opprimere quelli che vivono qui! Perché continuare a perseguitare abitanti che hanno già sopportato fardelli disumani per il solo fatto di essere rimasti in questa città? Perché far sentire loro ogni giorno – anzi ogni minuto – che non sono altro che feccia? E i soldati? Mandano qui ragazzi di diciotto o diciannove anni completamente ignoranti. A cosa serviranno queste lezioni impartite nella primavera della loro vita? E gli ufficiali? Come potranno, dopo, tornare alle proprie famiglie e crescere i loro figli? Solo per una birra Sultan Khajev, il giovane primario zoppo dell’ospedale n. 9 di Grozny, l’unico che funzioni dall’inizio della guerra, si appoggia pesantemente al bastone per riuscire a muoversi e scostare la coperta dal paziente del letto sotto la finestra. Lì giace una donna. Quel corpo sembra essere stato svuotato come un pollo e poi ricucito. E’ una visione insostenibile. Le linee tracciate dal bisturi non sono dritte: si ramificano come un albero genealogico. A tratti i punti di sutura hanno ceduto lasciando emergere piaghe purulente. La donna martoriata si chiama Aisha. Muove le labbra grigie cercando di parlare e, allo stesso tempo, tenta di fermare le gocce di sudore che le rigano il volto scivolando giù dai capelli rosso scuro. “Mi hanno sparato”, prova a spiegare Aisha con estremo sforzo. “Dio mio! Ma perché?” Ancora una volta cerco di capire. “Per una birra.” Due settimane prima, un giovane soldato russo, in servizio da nove mesi, aveva fatto sedere davanti a sé, sul letto, una donna di Grozny di sessantadue anni, Aisha Suleimanov, e le aveva sparato a bruciapelo cinque pallottole calibro 5.45, vietate da tutte le convenzioni internazionali. Si tratta di pallottole assolutamente disumane: attraversano il corpo con traiettorie bizzarre facendo esplodere gli organi al loro passaggio. Ecco cos’è successo ad Aisha, a casa sua, in un sobborgo di Grozny. Suo figlio le sta accanto all’ospedale. Mi guarda freddamente, come da una grande distanza. Mi odia e non lo nasconde. “Non tocca a voi avere pietà di noi…Non a voi!”. Un urlo muto e disperato che sembra inghiottire tutta la stanza in una specie di vortice. Noi siamo noi, i russi. Il figlio di Aisha stringe così forte la sbarra di ferro opaco del letto d’ospedale che le ossa sporgenti delle sue falangi diventano bianche. “E chi, allora?” Non sente la mia domanda. Ma Aisha ha voglia di parlare: ha bisogno di condividere la sua sofferenza, e così facendo di alleggerirla un po’, questa sofferenza immeritata, incomprensibile e quindi ancora più pesante da sopportare. “Eravamo già coricati…A un tratto, alle due del mattino, bussano alla porta. Qualcuno che bussa alla porta, a quell’ora, con il coprifuoco, non significa niente di buono. Ma siamo costretti ad aprire, sennò si rischia grosso. Perciò io e mio marito abbiamo aperto. Sulla porta ci sono due soldati. Dicono: ”Dateci una birra!”. Gli rispondo che non vendiamo birra. Insistono. Allora dico: “Da noi non c’è birra, le nostre leggi lo proibiscono”. Rispondono: “Bene, nonna”, e se ne vanno.” Aisha si sente male. Le sue labbra non sono più grigie ma blu. Un’ ondata di lacrime la sommerge. “Poi siamo tornati a letto. Più o meno un’ora dopo, mi sono svegliata con quei due soldati che andavano da una stanza all’altra. Frugavano ovunque. Ci hanno detto: “Stavolta siamo venuti per una zaciska (letteralmente significa pulizia)”. Ho subito capito che ci volevano punire perché avevamo rifiutato di dare loro la birra e mi sono pentita di non aver proposto dei soldi in cambio. Poi uno di loro è andato nella stanza dove dormivano i nostri nipotini: quattro mesi, un anno e mezzo e cinque anni. Ho avuto paura che violentassero mia nuora, perché li ho sentiti urlare. L’altro soldato ha ordinato a mio marito di seguirlo in cucina. Abas aveva ottantasei anni. Sento che gli propone dei soldi perché se ne vadano. E poi, a un tratto, un urlo. Il soldato aveva ammazzato mio marito con una coltellata. Uscito dalla cucina, mi ha portato in camera, ero pietrificata. Capisco tutto ma non riesco a opporre resistenza. Con un tono dolce e indicandomi il letto con la mano, mi dice: “Siediti lì, nonnina. Chiacchieriamo un po’”. E si è seduto di fronte a me. “Non siamo degli scellerati, è il nostro lavoro”. Gli ho detto: “Non fare nulla ai bambini”. “Non si preoccupi” e con queste parole, senza alzarsi dalla sedia, mi spara addosso. Mia nuora mi ha raccontato che, dopo, hanno chiuso la porta piano piano e sono andati via.” Aisha ha vissuto tutta la sua vita in Unione Sovietica e, nonostante la deportazione sotto Stalin e gli anni duri che sono seguiti, si considerava ormai una cittadina di quello stesso Stato che ha scatenato una guerra contro di lei e i suoi cari. Cerca senza riuscirci, come tanti altri anziani ceceni, di capire perché un soldato del suo stesso paese abbia tentato di ucciderla. Sono passate due settimane. Non sono riuscita a trovare l’assassino, Oleg Kuzmin, però ho trovato l’altro soldato che era venuto quella notte a casa dei Suleimanov. Sono rimasta colpita dal suo aspetto completamente anonimo, insignificante. Un uomo dei più ordinari. E’ anche vero che i suoi occhi erano vuoti forse per via dell’erba: cosa normalissima in Cecenia, dove barattare qualche cartuccia, senza chiedersi a cosa servirà, in cambio di un po’ di droga è la cosa più facile del mondo. “Hai visto quello che ha fatto Kuzmin a quella vecchia della periferia Michurin?” “Sì”. “Sai perché?” “Non ci hanno dato la birra”. “Ti pare una reazione normale?” Lui alza le spalle con indifferenza e tace. “E se l’avessero fatto a tua nonna? Per una birra?” L’ufficiale che assiste alla conversazione viene in aiuto del soldato: “Basta così. Puoi andare, ragazzo. Perché lo tormenta? Perché ricordi?” Sì! Proprio per questo. Perché ricordi. Perché gli venga un brivido, perché scoppi in lacrime. Perché ora come ora non si riesce ad agganciare la sua anima: è piatta come la steppa, senza la minima asperità… CAMBOGIA Nel 1970, le truppe americane e sudvietnamite invasero la Cambogia per sradicare le forze comuniste vietnamite. Il tentativo non sortì l'effetto desiderato, ma riuscì comunque a spingere i guerriglieri comunisti cambogiani, i khmer rossi, verso le regioni più interne. Seguì poi un periodo di feroce guerriglia che sconvolse l'intero paese e che portò, nel 1975, alla conquista di Phnom Penh da parte dei khmer rossi. Per i successivi quattro anni, sotto la guida di Pol Pot, si procedette all'eliminazione sistematica di due milioni di cambogiani (soprattutto quelli più istruiti) nel tentativo cruento di trasformare la Cambogia in una cooperativa agraria, di stampo maoista, dominata dalla classe agricola. La Cambogia divenne un immenso campo di lavori forzati; le famiglie furono separate e inviate nei campi di lavoro dove la fame, le precarie condizioni igieniche e la brutalità dei Khmer rossi erano quotidianità. I crimini perpetrati da Pol Pot restano ancora oggi una delle pagine più buie e brutali della storia. François Bizot, Il cancello Il libro racconta in prima persona la dolorosa esperienza di François Bizot. A 30 anni egli si trovava in Cambogia per effettuare delle ricerche su antiche tradizioni buddiste. Arrestato dai khmer rossi nell'ottobre del 1971, mentre la sanguinosa guerra civile comincia a divampare nel Paese, Bizot passò tre mesi in catene, in balia di uno dei più orribili carnefici del XX secolo, responsabile della morte di 40’000 persone. Lui e io facevamo gli stessi gesti. Avevamo un pezzetto di legno ciascuno con cui rimestavamo la base del fuoco, scottandoci le dita, lo sguardo perso nel guizzare delle fiamme. Dai bambù proveniva un vento freddo che arrossava le braci e spingeva il fumo dal lato di Duch, obbligandolo a voltarsi per respirare e a serrare gli occhi in una smorfia, ma il suo volto era calmo e sembrava rilassato. Forse la nostra discussione a tratti l’aveva indignato, ma l’aveva anche eccitato almeno quanto me. E questa soddisfazione che vedevo in lui mi rassicurava. <<Mi è sembrato di capire, da qualche frammento di conversazione, che dei prigionieri del nostro campo sono stati legati e picchiati…>> <<La maggioranza di quelli che arrivano qui>> spiegò lui dopo una pausa di silenzio, <<sono stati colti in flagrante delitto di spionaggio. È mia responsabilità interrogarli per sapere quali sono i loro contatti, che tipo di informazioni cercano, chi li paga. Uno solo di questi traditori può mettere a rischio tutta la nostra lotta. Credi siano disposti a rivelare di buon grado tutto ciò che sanno?>> <<Ma chi li picchia? Mi…>> <<Ah!>> mi interruppe Duch, <<la loro doppiezza mi disgusta in modo intollerabile! Il solo modo di procedere con loro è terrorizzarli, isolarli, affamarli. È molto dura. Devo fare violenza a me stesso. Ma tu non immagini neppure quanto le loro menzogne mi mandino fuori di me! Quando li sto interrogando e loro ricorrono a qualsiasi astuzia per non parlare, privando così il nostro comando di informazioni che sono magari di importanza capitale, allora io picchio! Picchio finché mi manca il respiro…>> Nella notte, il fuoco vacillò. Un’ombra sinistra gli attraversò il viso. Ero spaventato. Non avrei mai creduto che il professore di matematica, il comunista impegnato, il responsabile coscienzioso potesse essere al contempo lo sgherro che bastonava. In seguito riandai spesso con il pensiero a quella conversazione, su cui vegliava una stella funesta: quella notte di Natale si portò via gran parte della mia ingenuità, Fino a quel momento ero stato colpito dall’immagine rassicurante dell’aguzzino-mostro. Ora l’uomo di fede, che guardava davanti a sé con uno sguardo triste e velato di amarezza, mi appariva di colpo nella sua immensa solitudine. E mi sorpresi, nel momento esatto in cui ne scoprivo la crudeltà , a provare per lui dell’affetto. Ciò che mi attraeva nel suo modo di essere, che non aveva perso di vista la generosità, era forse quella costante sofferenza che segnava la sua figura e il suo volto; mentre lo guardavo mi vennero le lacrime agli occhi, come se si trattasse di un pericoloso predatore che non riuscivo a detestare. Ma non era semplicemente l’uomo, in lui, a rappresentare il pericolo? Perché in realtà non avevo di fronte un mostro degli abissi, ma un essere umano che la natura aveva condizionato ad ammazzare, affilando la sua intelligenza come i denti di uno squalo o di un lupo… facendo molta attenzione a non intaccare la sua psicologia. Così ben congegnato com’era, i suoi superiori potevano utilizzarlo efficacemente come rotella di un ingranaggio che lo sovrastava. Seguendo questi pensieri vedevo molto chiaramente come in lui la specializzazione tecnica avesse preso il sopravvento sull’aspetto morale. Il suo lavoro lo confinava dentro un grande meccanismo a cui non poteva più sfuggire. La paura regnava dentro di lui come dentro chiunque, dai dirigenti che frequentava al più umile soldato, si trattasse di gestire intrighi segreti, raggiri grotteschi o di prendere precauzioni istintive dettate, nella foresta, dalla semplice prudenza. A quell’epoca Duch non aveva ancora preso posto nel museo degli orrori. Aveva meno di trent’anni. Ma le traversie della vita, che decidono del destino di ognuno, lasciavano in lui campo libero a tutte le inclinazioni spontanee, sia torbide che pulite. In nome di quella che gli appariva in una buona causa, egli non temeva di addentrarsi irrimediabilmente nel labirinto paludoso dell’ideologia per coglierne i fiori ingannevoli che non si schiudono mai sotto il sole, e perdendo lui stesso la possibilità di tornare a guardare il cielo sopra di sé. Una volta presa la decisione, il suo ruolo sarebbe stato di obbedire al terrore sotto una tale coltre di oscurità e di silenzio che io mi domandavo se si fosse mai soffermato a valutare il potere atroce di cui era divenuto depositario. <<Compagno>> disse facendomi sussultare, <<un giorno anch’io avrò dei figli la cui lontananza mi farà star male, come succede a te… ma, per il momento, i miei unici valori sono quelli che conducono alla liberazione dei miei compatrioti. Il mio dovere è aiutare ciascuno a indirizzarsi verso una felicità semplice: che cosa si può desiderare di meglio nell’esistenza che una bicicletta, un orologio e una radio a transistors?>> Il riverbero del fuoco lo immergeva in una luce scarlatta, dando al suo volto ancora giovane un’espressione angelica. Mi soffermai a pensare che si trovassero in ogni rivoluzionario, proprio come lui, dei risvolti psicologici infantili. <<Guarda come vivo qui>> continuò. << Mi impegno a dare l’esempio: lavoro, austerità, sacrificio… mi sento completamente denudato. E vedo intorno a me la miseria che affligge tutti>>. <<Perdonami, compagno, ma nei territori che sfuggono al controllo dell’Angkar>> intervenni risolutamente, <<là dove le comunicazioni, i commerci, la vita, una certa libertà sono ancora possibili, la maggioranza delle persone possiede già un orologio, una bicicletta e una radio, se è questo ciò che vuoi… La miseria che comunque esiste anche laggiù tocca solo una piccola parte della popolazione>>. <<Ebbene, è soltanto peggio!>> sbottò di rimando, improvvisamente furioso. Capii che la mia osservazione aveva ridestato in lui una riflessione proibita, sulla quale non era possibile discutere. Quella risposta suonò talmente piccata da somigliare a una confessione. Qualcuno non ha forse sostenuto che l’uomo soffre più per le gioie degli altri che per le proprie afflizioni? <<Tok tok tok tok tok tok… To-ké! To-ké! To-ké!>> <<Cinque!>> dissi io aprendo le dita. <<Otto>> rispose Duch con una gaiezza affettata. <<To-ké!>> Il geco aggrappato ai bambù, che aveva lanciato il suo vibrante lamento nella notte, batté ancora solo fino a quattro… <<Compagno>> feci io rattristato, <<abbiamo perso tutti e due. Spero che non sia un cattivo presagio… riconosci almeno che tutte queste idee non sono frutto di elaborazione personale: le hai acquisite formandoti in scuole francesi, ti derivano dall’educazione occidentale che hai ricevuto. Ora, non soltanto vuoi applicarle a un tipo di società che non ha nulla a che vedere con le strutture che combatti, ma te ne servi anche per giustificare i delitti che ti circondano>>. <<Lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo è lo stesso ovunque!>> tuonò lui di nuovo. <<È vecchio come il mondo e travalica le nostre frontiere. Mi sembri un bel fifone per essere un francese. Non avete fatto anche voi la rivoluzione e fatto saltare centinaia e centinaia di teste? Forse che il ricordo di questi individui giustiziati vi ha impedito di glorificare, nei vostri libri di storia, gli uomini che allora fondarono una nuova nazione? È come per i monumenti di Angkor, di cui tutto il mondo ammira l’architettura e la maestà… chi pensa ancora a ciò che costò edificarli, alla vita degli innumerevoli individui morti per erigerli, con fatiche incessanti durante secoli e secoli? Poco importa la vastità del sacrificio; importa invece la grandezza dell’obiettivo che ci si prefigge di raggiungere>>. PALESTINA La questione palestinese resta una delle grandi questioni irrisolte dell'ultimo secolo, probabilmente una delle più complesse. Posizionata come un ponte fra tre continenti, la Palestina è stata oggetto dell’interesse di tutte le potenze internazionali fin dall’Ottocento: dagli Ottomani all’impero inglese, ai sionisti europei, alle superpotenze del dopoguerra. Nel corso del Novecento il suo territorio ha finito col diventare la casa di due popoli, quello palestinese e quello israeliano, che hanno talvolta saputo collaborare, ma che più spesso hanno subito le conseguenze della politica aggressiva dei militari e di chi deteneva il potere. Bisogna fare i conti, se non addirittura lottare, con due versioni radicalmente diverse della storia del paese profondamente radicate nella mente della maggior parte di chi lo abita. Esistono infatti due storiografie nazionali contrapposte, israeliana e palestinese. Dopo quasi un secolo di lotte, e centinaia di migliaia di morti per parte, abbiamo oggi, da un lato del muro, il popolo di Israele che vive nella costante paura e nella diffidenza generalizzata. Mentre dall'altro, il destino del popolo palestinese, che rimane tanto incerto quanto lo era all'inizio di questa tormentata tragedia storica,con ormai intere generazioni nate e cresciute all'interno dei campi profughi. Joe Sacco, Palestina. Una nazione occupata Tra la fine del 1991 e l'inizio del 1992 Joe Sacco ha trascorso due mesi in Israele e nei Territori Occupati, viaggiando e prendendo appunti. Ha vissuto nei campi palestinesi, condividendone la vita (o meglio, la sopravvivenza) in mezzo al fango, in baracche di lamiera arrugginita, tra coprifuoco e retate dell'esercito israeliano. Risultato del suo meticoloso lavoro d'inchiesta è questo volume che, combinando la tecnica del reportage di prima mano con quella della narrazione a fumetti, riesce a dare espressione a una realtà tanto complessa come quella del Medio Oriente. BOSNIA – HERZEGOVINA Nel febbraio del 1992, con un referendum popolare, la Bosnia-Erzegovina proclama la propria indipendenza, riconosciuta dalla comunità internazionale. Ciò scatena una sanguinosa guerra civile, in cui la comunità musulmana si trova contrapposta ai cattolici croati e agli ortodossi serbi (appoggiati dalle truppe dell'esercito federale), orientati a una suddivisione del nuovo Stato su basi etnico-religiose. Dopo aver conquistato con le armi oltre due terzi del Paese, i serbo-ortodossi proclamano una Repubblica serba di Bosnia (1994) alla quale il governo di Sarajevo risponde costituendo una Federazione musulmano-croata. Nonostante l'intervento dell’ONU a difesa delle popolazioni civili, il conflitto prosegue senza prospettive di conciliazione. I Serbi bosniaci, aiutati da unità paramilitari serbe, dettero inizio ad una campagna nel corso della quale costrinsero i musulmani bosniaci ad abbandonare le città e i villaggi dell’est e del nord della Bosnia. Esistono testimonianze documentate in merito a stermini di massa di musulmani ad opera dei serbi. Il mondo fu sconvolto dal veder concretizzarsi in Europa , per la prima volta dopo la Seconda Guerra mondiale, una persecuzione di tale ampiezza. Zlatko Dizdarevic, Giornale di guerra. Cronaca di Sarajevo assediata Il libro, scritto dal capo redattore del giornale Oslobodenje (Liberazione), testimonia i giorni dell'orrore e lo stato d'assedio a Sarajevo e racconta la cronaca della pulizia etnica e della sua logica da bestie tecnologiche. Quando il conflitto diventa armato anche in BosniaHerzegovina, nell'aprile del 1992, il giornalista inizia a scrivere brevi articoli, a volte sembrano quasi dispacci, nella città vittima del suo paesaggio, imprigionata dal fuoco che le viene scaraventato addosso dalle montagne. La torre gialla, 5 luglio 1992 In novanta giorni di guerra in Bosnia-Herzegovina e di assedio a Sarajevo abbiano visto di tutto. Ma quello che è avvenuto sotto i nostri occhi, a Sarajevo, nella via dei Donatori di sangue, al numero 21…Abbiamo seguito questo episodio, che oltrepassa probabilmente tutte le sfide immaginabili all’ordine internazionalmente convenuto, come a una partita di pallone, un film o un numero di circo. Una ventina di minuti di fuoco incessante su un grande edificio residenziale nel cuore della città. Il modo di procedere in questa giornata soleggiata di luglio, a qualche centinaio di chilometri da Roma, Venezia, Firenze, da Parigi, Vienna o Atene, rende superfluo qualunque riferimento ad un ordine internazionale. Questa volta il mondo incivilito che nelle guerre riconosce solo quello che vede, i fatti stabiliti, registrati e provati, non potrà trovare niente da ridire. Le telecamere hanno registrato e diffuso i venti minuti di cannoneggiamento di questo enorme palazzo giallo. Gli esperti militari sanno già che un “membro di una delle parti in conflitto” ha tirato contro quell’edificio con un cannone antiaereo da quaranta millimetri. Sanno anche che cinquantasei fori segnano la facciata dell’edificio, e non sono ancora stati contati quelli causati dall’ingresso diretto dei proiettili negli appartamenti. Gli inquilini del palazzo che resteranno in vita, simboli del surrealismo sarajevese, sanno altresì che fra il decimo e il diciottesimo piano nessun appartamento è stato risparmiato. I tiri, i buchi e il fumo si sono già visti mille volte a Sarajevo. Ma il modo di procedere è nuovo. Il pazzo furioso seduto dietro il cannone ha fatto il suo “lavoro” in modo tale che ogni interpretazione diventa superflua. Ha cominciato la sua festa di sangue freddamente, tirando all’inizio un po’ a casaccio e poi con una precisione diabolica. Ha cominciato dal diciottesimo piano, finestra per finestra, appartamento per appartamento, muro per muro. Lo faceva con una premeditazione sadica, lasciando alla gente di dentro giusto il tempo di dirsi che forse aveva finito, che sarebbero stati risparmiati. In questo preteso cuore dell’Europa, il cannone da quaranta millimetri ha tranquillamente sublimato tutto ciò che “quella gente” desidera “dire” al resto del pianeta: “Siamo noi a tirare, e allora? Mostrate pure a tutti la vostra cultura, qui si sa chi è il padrone della vita e della morte. E uno!- per i vostri punti di vista e le vostre risoluzioni. E due! – per i vostri caschi blu. E tre! – per tutto ciò che voi dichiarate permesso o non permesso”. Ciascuno dei cinquantasei buchi nella facciata del palazzo è un buco nel preteso “ordine delle cose” che noi credevamo reale. E’ una prova manifesta della vittoria del male e dell’impotenza del bene, del trionfo del caos sull’ordine, della disfatta dell’uomo davanti alla bestialità. Quando ci si vede compiere sotto gli occhi ciò che “non potrebbe avvenire in alcun luogo al mondo”, si è invasi da un sentimento di impotenza e di sgomento. La belva dietro al cannone ghigna sadicamente e sceglie con infinito piacere la finestra dell’appartamento in cui ucciderà una, due, cinque, non importa quante persone. Perché credevamo che “in nessun luogo al mondo “ ciò potesse accadere? Perché ci è stato insegnato a rispettare un certo ordine delle cose. Se un simile atto è possibile oggi, è perché questo “ordine delle cose” è morto a Sarajevo. Il funerale è uno dei più tristi del pianeta da decenni. Non per il numero delle vittime, ma per il numero di ideali seppelliti. Infine, nella storia della torre gialla c’è un punto senza importanza per il pazzo furioso, ma capitale per noi: da un mucchio di calcinacci, di cemento, di vetro e di metallo, hanno tirato fuori una creatura di dieci giorni. Sana e salva: perché ricordi quello che le sarà raccontato del suo decimo giorno di vita, e ne faccia ciò che meglio crederà. Purché non sprofondi , anche quel bimbetto, nel nuovo “ordine” mondiale. I detenuti di Sarajevo, 10 agosto 1992 Il mondo è molto scosso dopo aver scoperto l’esistenza dei campi ci concentramento in Bosnia-Herzegovina. Di fatto la gente è turbata perché le “indicazioni” sulla situazione dei campi potrebbero rivelarsi vere. Poiché l’Occidente è un universo empirista, bisogna ancora confermargli queste informazioni nero su bianco, perché le “indicazioni” siano accettate come qualcosa di tangibile. Comunque l’agitazione è grande. I signori della CNN, in una ricaduta di “Tempesta del deserto”, si sono messi a sostenere apertamente l’idea di un intervento militare. Alla cui conclusione un generale Patton entrerebbe nei campi portando, sotto la bandiera, la libertà americana. E’ evidente che la cosa si fa seria. Per due notti di seguito, finché c’era ancora elettricità, abbiamo guardato un’ora di programma televisivo americano consacrato a noi. Un’ora di programma non è cosa da poco se si calcola che ogni secondo del programma estivo della CNN costa milioni di dollari. Hanno dunque fiutato dei buoni affari e noi li ringraziamo. Qui la somma totale di sangue ha raggiunto una soglia che permetterà forse di passare all’azione. Quanto alla quantità di sofferenza, è già tale che ogni azione verrà troppo tardi. Non potremo più perdonare al mondo quello che è già avvenuto. E intanto come perdonare loro la storia dei campi che non volevano né vedere né riconoscere, benché saltasse agli occhi? La storia dei campi è cominciata, si è sviluppata e volge al termine qui, a Sarajevo, il più grande campo di concentramento al mondo. Nei campi che abbiamo conosciuto nei testi di storia si impediva alla gente di circolare liberamente: lo stesso succede qui. Non si dava ai detenuti che qualche boccone di cibo:qui, è lo stesso. Lì si privava di tutti i diritti enumerati nei documenti internazionali: anche qui. I collaborazionisti e i traditori, la quinta colonna, avevano delle possibilità di sopravvivere. I detenuti non avevano alcuna possibilità di stabilire un contatto con i loro parenti e gli amici rimasti fuori. Ogni tanto si riusciva a fare avere ai detenuti un pacchetto sventrato e una lettera censurata. Così succede qui. Infine, nei campi del passato, i detenuti erano uccisi secondo una “logica” criminale: vecchi, deboli, ebrei, comunisti, zingari, o perché colpevoli di qualche altra cosa. Qui non c’è neanche una logica. Ci assassinano tutti, senza alcun ordine, senza selezione. Di fatto siamo tutti colpevoli di non essere cetnici. Colpevoli di non riuscire a convincere il mondo che il nostro solo desiderio è di vivere secondo le norme internazionalmente riconosciute. Insomma, abbiamo scelto male il nostro tempo e il nostro luogo, secondo loro. Certo il momento non è forse opportuno. Ma quanto al luogo è buono e noi non intendiamo cercarcene un altro. Un indomabile orrore, 19 gennaio 1993 Che cosa non darei per sapere come andrà a finire! Ci resta dopotutto una piccola possibilità? O è tutto perduto? Era vano vivere sperando tutto il tempo che avremo, un giorno, soddisfazione, sia pure al prezzo di tante ferite? E ci saranno ancora giorni, speranze? E’ difficile oggi trattenere le lacrime, da occhi già quasi prosciugati, alla notizia di cosa è avvenuto a un ragazzino di undici anni: in una coda per l’acqua, vicino a Picara ai bordi della città, suo padre e sua madre sono stati ammazzati. Mentre scrivo, metà del personale dell’ospedale sta lottando per l vita di sua sorella, una ragazza di diciassette anni. Sul posto, il bambino si era messo a spruzzare con l’acqua , che aveva appena attinto, i corpi dei genitori morti. Non voleva rinunciare anche quando la sorella, ferita gravemente, gli ha detto:”Smetti Berin, smetti, sono morti”. Che cos’è quest’acqua che andiamo a cercare da mesi, ebeti, stranamente robotizzati, sconvolti? Perché? Che cos’è questa elettricità che aspettiamo già da quaranta ore? Che ne faremo, che cosa farà di noi, il giorno incerto in cui sarà tornata? Cambierà qualcosa per la donna che stamattina ha sbattuto la porta in faccia alle persone assetate e sfinite, quando l’acqua era appena stata ridata alla sua casa? Sembra che abbiano tolto alla gente di Belgrado i film di Disney. Sono convinto che, al contrario, si doveva ritrasmetterli dieci volte al giorno. Così i genitori di Berin sarebbero ancora in vita. Che cosa può cambiare? E’ troppo tardi per noi e i cambiamenti? Credevo che fosse diventato insensato parlare, scrivere, spiegare cose a quelli che non sono qui. Oggi, tra le macerie di “Oslobodenje”, abbiamo ricevuto due ufficiali britannici incaricati della sicurezza, abbigliati con cura. Sono venuti a verificare se l’autocisterna che contiene il petrolio stentatamente ottenuto potesse raggiungere la nostra pompa. E hanno constatato che non era possibile, mancando le condizioni di sicurezza. “Noi veniamo qui tutti i giorni, nonostante i tiri, e nessuno obietta che non sia possibile, per il pericolo” abbiamo detto agli ufficiali dell’armada della Regina. “Ma per noi è un’altra cosa” hanno risposto prima di andarsene. E’ vero. Ma noi? Di che rango siamo? Secondo, terzo, quarto? Certo non del primo. Tuttavia stentiamo a farci l’abitudine. Che cosa diventeremo? Quali cadaveri spruzzeremo con l’acqua fresca che ci hanno gentilmente fatto pervenire goccia a goccia? Poi, in risposta a tutta questa pena, Afan Ramic ha organizzato un vernissage. La sua mostra è un tentativo di fuga davanti alla verità che il suo unico figlio è morto, e che tutte le sue tele lasciate a Grbavica sono state, una per una, bruciate. Non avrebbero potuto portargli via di più. Qui i vernissage non vengono annunciati. Niente manifesti, non se ne parla prima. In modo che gli imbecilli non si mettano a sparare. Ma tutti quelli che potevano essere messi al corrente lo sono stati, e Sarajevo è tornata quella che conoscevamo. Sono venuti tutti: cattolici e ortodossi, universitari e comunisti, musulmani e calciatori, persone passate, presenti e future, fabbri e tornitori, ragazze in fiore e vecchi un po’ rimbambiti, pope, genitori e nipoti, baristi e pittori, musicisti e ubriachi. Tutti coi loro dubbi, inquietudini, tristezze. Ma tutti riuniti, allo stesso indirizzo, all’esposizione di Afan. E ci siamo sentiti bene fra noi, rassicurati. Perché comunque gli alberi germogliano da sé. L’acqua che scorre attorno alla città non può essere abolita. I telefoni, ci accorgiamo, non sono apparecchi indispensabili per chi vede le cose chiaramente. Berin , lui, non avrà più padre né madre. Bisogna pregare per sua sorella, e non dimenticare questa preghiera, e ciò che l’ha provocata. La memoria servirà ai nostri figli e ai loro figli, perché questa non è una guerra. E’ un orrore innominabile. E’ un buco nero nell’universo del senso. ARGENTINA Il 24 marzo 1976, un golpe attuato da una giunta militare conduce al potere il generale Jorge Rafael Videla, il quale impone la legge marziale. Migliaia di oppositori al regime sono illegalmente imprigionati, torturati e giustiziati . Inizia quella che divenne nota come Guerra Sporca. Il bilancio di questa violazione dei diritti dell'uomo è terribile : 2.300 omicidi politici, oltre 10.000 arresti politici e la scomparsa di 30.000 persone, note come desaparecidos. Horacio Verbitsky, Il volo. Rivelazioni di un militare pentito sulla fine dei desaparecidos Il volo è il resoconto agghiacciante dei crimini della dittatura argentina nell'angosciata confessione di Adolfo Scilingo, capitano della Marina militare, al giornalista Horacio Verbitsky. Dopo vent’anni di silenzio, Scilingo si decide a raccontare come, nel 1976, iniziò il più terrificante genocidio della storia dell’Argentina che portò alla sparizione di trentamila persone, tristemente ricordate nel mondo come i desaparecidos. Il paese delle ombre Molte volte ci aveva girato attorno senza decidersi a entrare nel pieno dei ricordi peggiori. Vi si era comunque molto avvicinato e non voleva tornare indietro, come se trovasse nella confessione un atroce conforto. Introdusse la questione spontaneamente, mentre stavamo parlando d’altro: “Lei mi ha chiesto che succedeva sugli aerei. Una volta che l’aereo si allontanava da terra, il medico che era a bordo somministrava loro una seconda dose, un calmante molto potente. Si addormentavano completamente…Ci sono particolari importanti, ma mi è difficile raccontarli. Quando ci penso vado fuori di testa. Una volta che avevano perso i sensi venivano spogliati e, quando il comandante dava l’ordine, si apriva lo sportello e venivano gettati di sotto nudi, a uno a uno. Questa è la storia. Macabra ma reale e che nessuno può smentire. Il sottufficiale teneva giù con il piede una specie di porta oscillante, per lasciare uno spazio di 40 centimetri. Da lì cominciavano subito dopo a scaricare i sovversivi. Data la situazione, nervoso com’ero, per poco non cado e vengo risucchiato dal vuoto.” Lei parla di due voli nello stesso mese. “Sì, a giugno o luglio del 1977. Il secondo volo fu un sabato. La mia famiglia abitava a Bahìa Blanca e io andavo a trovarli ogni quindici giorni. Il sabato e la domenica restavo a lavorare nella Scuola. In questo secondo volo vi erano anche degli ospiti speciali.” Che significa ospiti speciali? “Ufficiali di alto rango della Marina, che non partecipavano ma venivano in volo per farci coraggio.” Che facevano? “Niente. Era in qualche modo un sostegno morale al lavoro che stavamo svolgendo.” E gli ufficiali superiori come viaggiavano? “Viaggiavano seduti. Dopo, durante l’operazione, si mettevano in piedi e da lì guardavano”. Come portavate le persone addormentate fino allo sportello? “Venivano sollevati fino alla porta. Completamente addormentati. Nessuno ha sofferto nella maniera più assoluta.” Non c’è mai stata una qualche eccezione? (Questa domanda sembra metterlo in agitazione più delle altre, pensa e ripensa prima di rispondere.) “No, non che io sappia.” (…) Sapeva chi fossero quelle persone? Li aveva visti alla Scuola? “Non ne avevo la più pallida idea. E la cosa non mi interessava nemmeno. Ero completamente fiducioso riguardo le decisioni prese dai miei superiori.” Però, date le sue mansioni, non aveva qualche contatto… “No, no. Avevo soltanto un contatto sporadico con i detenuti. Parlare con loro, no. Li vedevo, insomma, non avevo un rapporto diretto.” Non sapeva chi fossero? “No, però non indagavo nemmeno. Non avevo il minimo dubbio sulla legittimità del nostro operato, come era giusto che fosse. Avevo ventotto anni e da dieci ero nella Marina. Ero tenente di vascello ed ero sufficientemente preparato e anziano per non avere dubbi sui superiori.” Il fatto non è dubitare del superiore, ma della formazione che avete ricevuto… “Questa era una cosa che non esisteva nemmeno. Eravamo convinti di uccidere il nemico. Ho creduto in modo assoluto a tutto ciò che facevo e ho eseguito gli ordini con totale convinzione. Questa è la guerra sporca che abbiamo vinto.” La stanza è in penombra. Il tempo si è fermato. Accesa la luce, Scilingo guarda l’orologio. Ora è ammutolito. Gli è difficile tornare dal paese delle ombre della sua memoria. Si congeda senza concordare un nuovo appuntamento. Dieci giorni dopo era pronto a continuare la confessione. I suoi figli lo sanno? “Mia moglie glielo ha raccontato poco alla volta. Ultimamente ho parlato con loro. Mia figlia, che ha quindici anni, ha una professoressa di educazione civica con la quale ha discusso la questione. Bene, in modo equilibrato. Ha detto che la sovversione metteva bombe e che per reprimerla le Forze Armate avevano commesso anche delle atrocità. Per parlare con lei ho cercato un po’ di materiale in biblioteca. Ho trovato un opuscolo delle Forze Armate sulla guerra contro la sovversione e mi sono vergognato. I rapimenti di militari sono stati veramente pochi, aveva ragione lei. Mia figlia sa tutto ciò che è successo. Ma quando deve fare un bilancio, dice che le Forze Armate hanno fatto cose peggiori. Arrivo a un punto in cui non trovo più spiegazioni. Non so se abbiano agito credendo di essere una Forza Armata, ma in realtà ci siamo comportati come una banda.” Non si era mai posto la domanda? “Non è che non mi sia posto la domanda come essere umano, non mi ero posto la questione da un punto di vista militare.” Qual è la differenza? “Come essere umano, di fronte al nemico, quando lei uccide deve farsi delle domande. Le ho raccontato che quando sono tornato dal primo volo stavo male. Veramente male. Ma anche se non mi sentivo bene non avevo dubbi che, da un punto di vista militare, avevo eseguito un ordine con piena convinzione.” Vuole parlarmi delle torture a cui ha assistito? “Un giorno ero al Circolo ufficiali della Scuola, nella zona del bar, arrivò il falso tenente Vaca e mi disse che aveva fatto arrestare una donna avvocato in un’indagine condotta da lui stesso. Mi disse che la stavano interrogando in quel momento e mi propose di andare con loro. Sono andato perché ero interessato a vedere quale potesse essere l’indagine compiuta dal tenente Vaca, visto che nutrivo seri dubbi. Quella veniva interrogata facendo uso dei metodi che, come si è detto in Parlamento, erano quelli applicati…In una parola la stavano torturando con una picana elettrica. Restai assai poco, non so se sono… un po’ tenero per queste cose. Era una donna. Da quello che ho sentito dalle persone che la stavano interrogando, non c’entrava niente. Me ne andai. Dopo un po’ chiesi di lei ed era scomparsa.” “Era scomparsa” cosa significa? “Beh, che era scomparsa.” Susan Sontag, Davanti al dolore degli altri Designare un inferno non significa, ovviamente, dirci come liberare la gente da quell’inferno, come moderarne le fiamme. E tuttavia, sembra di per sé utile ampliare le nostre conoscenze e prendere atto di quanta sofferenza causata dalla malvagità umana esiste nel mondo che condividiamo con gli altri. Chi continua a essere sorpreso dall’esistenza della perversità, chi è disilluso (o addirittura incredulo) di fronte alle prove delle crudeltà raccapriccianti che a mani nude gli uomini sono capaci di commettere ai danni degli altri esseri umani, non ha raggiunto la maturità morale o psicologica. Dopo una certa età, nessuno ha diritto a questo genere di innocenza, o di superficialità, a questo grado di ignoranza, o di amnesia. Oggi esiste un vasto repertorio di immagini che rende ancora più difficile mantenere una simile forma di carenza morale. Lasciamoci ossessionare dalle immagini più atroci. Anche se sono puramente simboliche e non possono in alcun modo abbracciare gran parte della realtà a cui si riferiscono, esse continuano ad assolvere una funzione vitale. Quelle immagini dicono: Ecco ciò che gli esseri umani sono capaci di fare, ciò che – entusiasti e convinti d’essere nel giusto- possono prestarsi a fare. Non dimenticatelo.
Scaricare