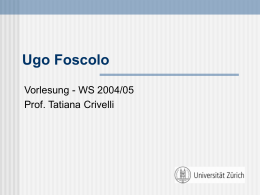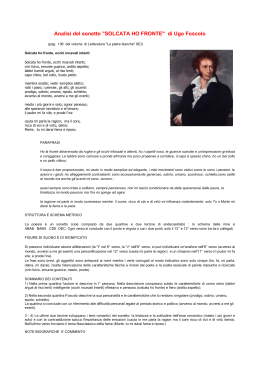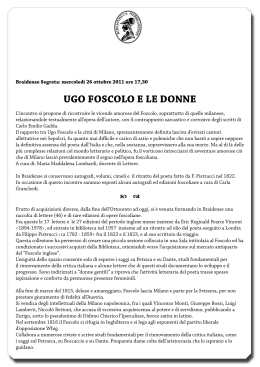Su Ugo Foscolo Un dialogo Pietro Baroni Edoardo Rialti Marino Biondi Domanda: Il titolo dell’XI edizione de I Colloqui Fiorentini è “Tu passeggerai sovra le stelle…”, citazione tratta da Dell’origine e dell’ufficio della letteratura. Orazione, che Foscolo tenne a Pavia nel 1809. Queste parole esprimono l’anelito irrinunciabile per la vita dell’uomo, che senza di esso non accetterebbe neppure di vivere, afferma tante volte Foscolo nelle sue opere. Tutta la sua poesia si attesta al livello di questo orizzonte, di questo destino, presentito e contemplato. Per questo orizzonte poetico Foscolo entra in collisione con la tradizione letteraria a lui precedente e contemporanea e con i suoi esponenti di spicco. Biondi: Nella vostra domanda sono esposte diverse linee della evoluzione del Foscolo poeta e del Foscolo teorico e docente della letteratura o meglio degli uffici e delle finalità della letteratura e al tempo stesso è implicita anche una tematica centrale nell’opera fondamentale Dei Sepolcri, carme in 295 endecasillabi sciolti di Ugo Foscolo, la cui editio princeps esce a Brescia, Per Nicolo Bettoni nel 1807, seguita nello stesso anno da un’edizione veronese con la prima edizione dei Sepolcri di Ippolito Pindemonte, destinatario dell’opera e suo ispiratore, almeno parziale. Oscilliamo quindi tra diverse opere: in questo caso tra i Sepolcri del 1807 e i discorsi sul ministero della letteratura del 1809, intorno al nucleo del valore fondante e propulsivo della illusione. Parliamo dell’autore formatosi nella dimensione di una ideologia illuministica, che non contempla l’ipotesi di una metafisica e di una trascendenza religiosa. Illusione ma nella immanenza, quindi, illusione che crea all’evidenza una tensione, un contrasto, forse una aporia. Direi che questa tensione, questo contrasto sono il cuore dell’intera poetica foscoliana. Voglio cominciare leggendo insieme a voi i versi, tratti dai Sepolcri, della prima strofa, del primo argomento, del primo ragionamento: All’ombra dei cipressi e dentro l’urne confortate di pianto è forse il sonno della morte men duro? Una domanda a cui la risposta era: “No, certo: il sonno della morte continuerà a essere duro, implacabile e inviolabile, sì come suole, e come pietra anche se ci sarà il conforto della tomba…”. I commentatori riportano vasta messe di prove letterarie a sostegno di quella durezza, a cominciare da Virgilio: «dura quies oculos et ferreus urget / Somnus» (dura quiete e ferreo sonno preme gli occhi). Sulla tradizionale durezza della morte, e i richiami alla poesia latina (specificamente a Virgilio e a Properzio, XIX elegia del I libro), ma anche oltre, dal momento che la stessa problematica era stata recepita, e prima dei Sepolcri, dalla cultura preromantica, ci sono le pagine di Vincenzo Di Benedetto, Lo scrittoio di Ugo Foscolo (Torino, Einaudi, 1990) Vero è ben, Pindemonte, anche la Speme, ultima dea fugge i sepolcri e involve tutte cose l’oblio nella sua notte e una forza operosa le affatica di moto in moto E qui sentiamo la formazione materialistica di Foscolo, la materia dominante e irresistibilmente residua, alla fine di ogni operazione di umanesimo. Quasi una ideologia della materia, anche secondo un certo magistero della ideologia illuministica francese. La materia che ha una sua storia; la storia della vicissitudine dei corpi come torsi mortali in perpetua trasformazione, che si trasmettono pur sempre ad altra vita, e ad altra vita ancora. E l’uomo e le sue tombe e l’estreme sembianze e le reliquie della terra e del ciel traveste il tempo. Ma è qui, proprio di fronte alla esposizione puntuale, rigorosa della sua ideologia materialistica, che consegna alla materia una eternità che non è dell’uomo, che Foscolo introduce il tema salvifico della sua poesia, il tema dell’illusione. Ma perché pria del tempo a sé il mortale invidierà l’illusion che spento pur lo sofferma al limitar di Dite? L’illusione è tema foscoliano, dal primo Ortis («le nostre passioni non sono in fine del conto che gli effetti delle nostre illusioni»). Illusione, chimera di irrealtà, ma necessaria. Jacopo, nel secondo Ortis, rivendica il suo valore: «Anziché spegner le faci che aggiornano la prospettiva teatrale, e disingannare villanamente gli spettatori, non è assai meglio calar del tutto il sipario, e lasciarli nella loro illusione?» Si legge nella lettera III della parte iniziale dell’ Oris 1798: «Il mio cuore cantava un inno alla natura, e la mia fantasia s’illudeva invocando le ninfe amabili custodi delle fontane. Illusioni! grida il filosofo. E non è tutto illusione? tutto! - Beati gli antichi che si credevano degni de’ baci di Venere […] ». «La difesa delle illusioni - commenta Di Benedetto - in contrasto con un atteggiamento puramente intellettualistico si sostanzia del vagheggiamento / recupero della cultura antica.» Ne consegue che l’illusione nell’accezione foscoliana ha dimensione diversa rispetto alla illusione-errore di Goethe (Wahan nel Werther), dove il Whan sta in rapporto al sentimento religioso e la devozione verso Dio (nelle lettere del 6 luglio 1771 e del 30 novembre 1772: «Noi dobbiamo trattare i bambini come Iddio tratta noi stessi, che ci rende più felici quando ci fa girare la testa con le più rosee illusioni»; «Possa morire dannato chi osa deridere un ammalato che fa un lungo viaggio sino ad una sorgente lontana la quale potrà solo aumentare i suoi mali e rendere più dolorosa la sua morte! chi si crede superiore ad un cuore angustiato, che fa un pellegrinaggio al Santo Sepolcro per alleviare le sofferenze della sua anima! […] E voi osate chiamare illusione tutto questo, voi mercanti di parole seduti sui vostri comodi cuscini? – Illusione! – O Dio! Tu vedi le mie lacrime!»; Goethe, I dolori del giovane Werther, con un saggio introduttivo di L. Mittner, trad. di A. Spaini, Torino, Einaudi, 1963, p. 44, p. 117). Più dolce che perigliosa sempre l’illusione, anche nei rapporti sociali, sempre velati di una patina di insincerità, per farli reggere alla realtà, e in ogni altra circostanza in cui l’uomo sia sopraffatto dal suo destino. Anche Goethe rivendica con forza il diritto all’illusione, e maledice i razionalisti scafati e spregiatori del dolore umano. Quasi che senza illusioni saremmo bruti, o filosofi cinici. Troppo deboli nella sofferenza ma anche troppo ruvidi e scarni per la civiltà, e per quel poco di gioia e felicità che pure dovrebbe toccarci. Tornando ai Sepolcri. Perché invidiare, perché togliere a sé, guardare con malevolenza, perché sottrarsi, - e qui parla a nome di tutti i suoi fratelli mortali - perché impoverirsi dell’illusione? Se essa ci è data a superstite rimembranza di noi, ad argine dell’oblio che inghiotte il vivente individuo e lo nega, se pur sia mai stato una volta. L’illusione «che spento pur lo sofferma al limitar di Dite». L’illusione, e anche la tomba, tomba custode e non tomba segregazione del nulla, intesa come rituale che accompagna la morte, che seppure morto lo trattiene al di qua della soglia degli inferi e alla soglia dell’oblio. Nei Sepolcri l’illusione esprime una volontà di affermare il diritto alla sopravvivenza del valore dell’uomo, la superstite eternità dell’eredità umana; eredità di cui s’incarica nella trasmissione, dapprima l’affetto dei propri cari, che continua la memoria dell’estinto il quale continua a vivere nell’amore dei suoi, almeno per un lasso di tempo. L’affetto e la memoria del caro estinto è il nucleo di ogni civiltà, perché, dice Foscolo, non c’è nessuna civiltà che non abbia conosciuto il beneficio del culto dei defunti. È come se dicesse che non esisterebbe civiltà se non coltivasse l’illusione che la tomba non sia soltanto un luogo di estinzione, ma un luogo di propulsione vitale, per lo meno della illusione. La seconda parte dei Sepolcri allarga questo processo propulsivo, a promuovere quel segmento effimero che è la vita dell’uomo; effimero, ma anche tanto ricco e concentrato da potersi anche trasmettere alle generazioni attraverso il verbo di poesia, che per Foscolo è poco meno che un vangelo. Omero è il patrono di tutti i Sepolcri, tutti li veglia il vecchio cieco, perché Omero metaforicamente risveglia dal loro sonno i protagonisti e gli eroi della vicenda umana. Omero è poesia e memoria. Epica della memoria. Memoria è poesia. Quindi illusione come elemento che riconsegna il tempo alla possibilità di uno sviluppo ulteriore e successivo rispetto a quello drammaticamente concesso dalla ideologia materialistica, dalla filosofia dei lumi che però s’intenebrano in morte perpetua, nella quale si è formato, ma in cui strettissimamente, come un prigioniero, si sente, e dalla quale cerca di uscire come da un abbraccio, pur vincolante, della logica e della ratio. In termini di categorie culturali potremmo dire che se il Romanticismo, quello storico, non la perdurante e astorica variante metaforica di esso, se questo Romanticismo, storicamente definito e circoscritto, nuova cultura dell’uomo dopo l’Illuminismo (e la Rivoluzione di Francia), ha un significato, ebbene è quello di aver generato la potenzialità altra dell’essere finito, magari come la grande illusione della sopravvivenza. Il Romanticismo è una categoria che consegna persino all’illusione un valore anche di carattere storico, radicandola nel terreno del destino umano. Non solo. La cultura del Romanticismo, con le Lettere sull’educazione estetica di Schiller, viene ad affermare anche una tesi che è condensabile in poche parole: «per dirla finalmente tutta, l’uomo gioca solo là dove è uomo nel senso più pieno della parola, ed è perfettamente uomo solo là dove gioca.» Quali giochi? In primo luogo i giochi della bella letteratura e dell’arte, giochi di civiltà. Illusioni e gioco. In Foscolo prevale largamente l’illusione, e il gioco si oscura del tutto. Non è certo homo ludens il nostro Niccolò Ugo. Ma anche l’illusione possiamo vederla come un gioco. Un gioco dello spirito, che apre spazi di libertà al destino della necessità, della finitudine. Una costruzione. Scrive uno studioso della cultura tedesca, in un prezioso libro Romantik (2007), che se il gioco apre spazi di libertà, e questo vale anche per la violenza, allora: «la cultura deve tenerne conto e “giocare” con essa, per esempio nella competizione ritualizzata, nella concorrenza, nelle battaglie di parole. Il suo universo simbolico offre sollievo dai casi seri, dalla morte e dalla vicendevole distruzione. Rende vivibile la convivenza fra gli uomini, che sono di per sé animali pericolosi. La massima della cultura deve essere: là dove le cose sono serie, se ne faccia un gioco.» (Rüdiger Safranski, Il Romanticismo, trad. di U. Gandini, Milano, Longanesi, 2011, pp. 38-39). L’educazione estetica. L’uomo è dunque creatura razionale, ma è anche creatura che sa costruire, con altra sapienza, il simulacro dell’illusione, e spingersi oltre le frontiere invalicabili del tempo e il limite organico, materialistico, finito, della sua natura. Su questa base che s’inarca verso l’alto, oltre l’orizzonte del mero accadimento, Foscolo, pur con tutte le sfumature non eroiche del carattere, il capriccio e il “peccato” della sua vita privata, eroismi dell’amor passione più che dell’armi (mi viene in mente una delle classiche e più popolari biografie del poeta, Vita amorosa ed eroica di Ugo Foscolo di Michele Saponaro, tessera novecentesca della leggenda eroico-erotica, edita da Mondadori nel 1938), diventa proprio lui l’archetipo nella letteratura del Risorgimento, il primo poeta e il primo autore che ha dato un segno di fede nella patria, quando la patria non esisteva, lui il veggente la presagiva, e faceva che fosse. Su questo primato di Foscolo, padre della patria, quando patria non era, insiste una bibliografia attuale, attivata anche dal centocinquantenario dell’Unità, e mi limito a citare il volume di Mariasilvia Tatti, Il Risorgimento dei letterati (Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2011), dove un profilo di Foscolo porta il titolo Foscolo, l’italiano e rammenta come anche uno dei detrattori più convinti come il Tommaseo, «animatore del fronte cattolico anti-foscoliano», ammetta in una lettera a Emilio De Tipaldo, che «un solo sentimento è in lui retto: l’amore di patria; il resto viziato dai pregiudizi del secolo decimottavo, e dalla mancanza di idee». Per quanto concerne l’accusata (da Tommaseo) mancanza di idee, il volume qui ricordato provvede a ribaltare l’assunto in un capitolo, Nazione italiana e tradizione classica nel pensiero critico di Ugo Foscolo, dove si fa vedere come la declinazione foscoliana del classicismo avvenga in modi non paradigmatici, né dogmatici, sì bene e piuttosto dialettici, poiché se il classicismo è, per definizione, una filiazione dalla cultura antica (la grecità, pressoché anagrafica in lui), esso deve essere ricondotto alla specificità italiana (e alla nazione), tanto da identificare il letterato con il patriota e la classicità come il fondamento etico politico della nuova nazione. Ed è una dimensione politica, un campo, va da sé, di contrasti, di controversie, che non conosce unanimismi. Quella di Foscolo è una consacrazione, per così dire, conflittuale, e vale di più anche per queste tensioni che la partecipano, una glorificazione che riesce ad attraversare intatta i fuochi dei contrasti (e delle divergenze estetiche, oltre che politiche), e a imporsi, alla fine, venendo sancita dalla storia patria, presso almeno due generazioni di patrioti (i giacobini, Camillo Ugoni, Giambattista Niccolini, Silvio Pellico, Giuseppe Mazzini, Carlo Cattaneo, Giuseppe Garibaldi, Francesco De Sanctis), e dalla storia della critica letteraria (ancora De Sanctis, cui si deve il saggio in onore del ritorno delle spoglie mortali del Foscolo in Santa Croce nel 1871). Naturalmente svetta il fatto di avere ricreato in poesia l’altare di Santa Croce, una chiesa francescana che divenne, in quanto fu fatta diventare, anche la chiesa (il santuario) della nazione, in fase di unificazione e poi di unità. Due religioni, due fedi, due storie, la millenaria e la civica, tanto recente (e fragile). Una classicità identitaria, basata sulla lingua e l’eloquenza, che si radicano nel passato e sanciscono un’appartenenza: «Però né potrei parlare se non italiano, né parlare se non secondo il mio cuore; quindi non potrei stare sotto le leggi d’un governo il quale trova necessario che la nazione abbia principj diversi da’ miei.» (De’ giuramenti, appendice ai Discorsi sulla servitù dell’Italia, una prosa che risale all’inizio dell’esilio). In un Risorgimento diviso e lacerato fra laicità e cattolicesimo, questa è una conquista indubbia di armonia, di convergenza. Per la quale il pur discusso Foscolo, l’uomo dalla storia controversa, carattere difficile e dalle frequenti intemperanze, sopravvive anch’egli in una memoria fors’anche, per una volta in questo paese, indivisa. Per la quadreria completa dei contributi interpretativi e di studio, è d’obbligo riferirsi alla monumentale Bibliografia foscoliana, opera di Giuseppe Nicoletti, fedele e provetto foscolista fiorentino (Edizione Nazionale delle Opere di Ugo Foscolo, Firenze, Felice Le Monnier, 2011). Quindi l’illusione diventa anche un’illusione civile e politica, un presagio, una profezia, un adempimento caldo e visionario. Da questo punto di vista la vicenda biografica di Foscolo è al tempo stesso esemplare e non esemplare. Non esemplare, perché il personaggio vive una vita non all’insegna della purezza adamantina, della rettilinea evoluzione, ma una vita piena di contrasti, di contraddizioni, di capricci, di angosce, che interrompono il percorso ideale. Ciononostante gli uomini del Risorgimento con forte e unisono istinto sentono che è lui il maestro, anche nelle sue cadute, anche nelle sue imperfezioni. Pietro: Resto sempre molto colpito dal fatto che Foscolo di fronte al giuramento imposto dall’Austria, dopo il ritorno di Napoleone dall’Elba, a tutti gli ex-ufficiali, scelga di non giurare e percorra la strada dell’esilio. C’è un’incoerenza in Foscolo, data dalla sua debolezza di essere umano, ma c’è anche una grande capacità di scommettere su un ideale di patria libera, che peraltro al tempo era molto utopica, che gli permette di fare scelte tanto radicali. Vale a dire che in Foscolo la questione dell’ideale non è oziosa, non è una posa, ma detiene un alto peso specifico. Biondi: Lei ha toccato il punto della biografia che consegna stabilmente Foscolo alla tradizione risorgimentale. Lo consegna sotto il profilo del libero uomo, del libero scrittore. Libero e fiero. Assertore di verità, contemplatore del vero, che è fulcro di pensiero e parola: «Ogni uomo sa che la parola - si legge nell’Orazione. Dell’origine e dell’ufficio della letteratura del 22 gennaio 1809 - è mezzo di rappresentare il pensiero; ma pochi si accorgono che la progressione, l’abbondanza e l’economia del pensiero sono effetti della parola.» Fra gli effetti supremi della parola, la poesia, per definizione creatrice, eternatrice. Mancando di segni, ogni sentire sarebbe barbarico tumulto, inespresso, e di fatto muto. L’aggettivo “libero” in questo caso precede l’esercizio stesso della scrittura. Già nelle lezioni pavesi, cui facciamo riferimento (e che segnaliamo: Orazioni e lezioni pavesi, nell’edizione Carocci del 2009, curata da Andrea Campana), Foscolo aveva teorizzato che lo scrittore può sorgere e ogni arte può fiorire e prosperare soltanto in un contesto di libertà e di dignità. E senza la prima, non si dà la seconda. Quest’endiadi, e affermazione di analisi e di metodo nello spirito più profondo del Risorgimento, verrà fatta propria da Mazzini, che in altri tempi, e con una patria non asservita e divisa, forse interamente alle lettere, e alla critica delle lettere, si sarebbe consacrato, ma che non aveva ritenuto legittima tale consacrazione in tempi e luoghi di servitù. Le lettere servili sarebbero state arcadia, elegante genuflessione (metastasiana) al potente, scarto di umanità da non prendersi neppure in considerazione. Ma libertà in servitù (il regno d’Italia amministrato dal viceré Eugenio di Beauharnais) significò non essere prono, l’essere dunque renitente ai fati del potere francese, e ribelle, o «testa calda», era considerato, certificato anche dal primo biografo, Giuseppe Pecchio, il poeta. Foscolo sotto questo profilo, lungo la catena genetica della libertà come costrutto basilare di energia spirituale da esplicare sia nelle arti sia nella politica, è stato anche, ponendosi in una sommità gerarchica, il maestro di Mazzini. Il quale fu a sua volta il maestro di tutti i risorgimentali, e il cantore ideologico di tutti i risorti, ma in questo nesso decisivo fra cultura e pragma ideologico-politico, fu Foscolo ad aver suggerito a Mazzini uno dei pilastri, non tanto della sua teoria della letteratura, che pure Mazzini possedeva, ma della funzione che prima si è foscolianamente chiamato ministero e che Foscolo chiamava davanti alla platea di Pavia l’ufficio delle lettere. La letteratura che non è un complesso di norme retoriche, ereditate una volta per sempre (il classicismo come sistema trasmesso e immutabile, il che cozzerebbe con la variabile natura umana, ché «tutti gli uomini hanno una maniera diversa di concepire e di sentire»), ma lezione di morale letteraria, in quanto la lettera deve «diffondere e perpetuare il pensiero». Tuttavia Mazzini aveva preso le distanze dal materialismo foscoliano (il radicalismo giacobino nel pensiero) e nella prefazione luganese del 1844 ai foscoliani Scritti politici inediti, raccolti a documentarne la vita e i tempi, si era preoccupato di distinguere le opinioni dell’ideologo dalla sincerità appassionata di quelle opinioni, come se le opinioni fossero censurabili (residui di illuminismo) ma non la passione che le incendiava e le trasfigurava in un rogo, conservando l’«unità potente, non mai tradita, dell’anima sua». L’anima era «incontaminata», e questo contava a fronte di un lascito di filosofia negativa da espungere. Queste distinzioni mazziniane dicono bene l’atteggiamento dei risorgimentali nei confronti di questa icona mai accolta con unanime consenso eppure posta su un altare. Discussa e venerata. Quale fosse la funzione dell’arte della letteratura nella società umana fu sempre per Foscolo un obiettivo di comprensione più piena, e quindi di ricerca, verrebbe da dire di scienza. La letteratura è creazione ma anche, vichianamente, scienza, percorso del sapere, itinerario di conoscenza - e conoscenza è osservazione - approfondimento della cognizione del sé associato o travagliosamente affiliato all’altro sé (società), nella complessa stratificazione dell’umano che cresce (e si evolve) dentro la storia. Complessa e altamente problematica, perché la visione che Foscolo ebbe della natura umana fu ben lungi dall’essere positiva e selvaticamente irenica (l’antiRousseau) e piuttosto inclinò, secondo la scuola italiana, al realismo, senza misericordia, di Machiavelli e di Hobbes. La libertà che Foscolo finì per incarnare in se stesso, nel suo stesso corpo fisico di poeta, assunse pertanto un altissimo valore simbolico, perché egli visse al centro di un ciclone storico che si condensò come un uragano, e come tale s’abbatté sui luoghi abitati e vissuti da lui e dai contemporanei. C’è anche un genio nella presenza, un genio dell’opportunità, della tempestività testimoniale: l’esserci, l’essere presente, come Vittorio Alfieri il 14 luglio del 1789 a Parigi, dimostra una certa vocazione a essere presenti nella storia, dove la storia si epifanizza. E così il Foscolo essendo presente nei luoghi della conquista giacobina, poté vedere e oscillare tra entusiasmo e delusione per Bonaparte e il bonapartismo, che egli abbracciò come sinonimo di libere istituzioni e liberi codici della cittadinanza, per poi ritrarsene. Ma quei liberi codici furono portati pericolosamente sulle baionette di un esercito invasore. Si trattò di una libertà esportata tramite un imperialismo che conosce aspetti di rapina. Così vivere il bonapartismo fu per tutti i giacobini italiani e per il giacobino Foscolo un’oscillazione tra entusiasmo e pena, adesione e distacco. Politicamente le ossa di Foscolo si sono formate in un continuo alternarsi delle umane sorti e dei poteri che si sono succeduti: Bonaparte scaccia l’antico regime, l’antico regime scaccia Bonaparte. Nel mezzo il libero uomo, Ugo Foscolo. Il quale testimonia, in un momento in cui l’Italia non c’è ancora, la potenza anche politica dell’illusione, a fronte di un paese dimidiato e umiliato anche da queste sostituzioni che fanno dell’Italia soltanto il territorio passivo per esercizi d’incarnazione di un potere contro l’altro. Il libero uomo Foscolo fonda un’istituzione sacra del Risorgimento: l’esilio. E questo spiega la sua forza di icona nell’immaginario degli uomini del Risorgimento più di qualunque altra immagine, nonostante la sua sia una biografia macchiata da molti individualismi, da capricci, da bizze, nonostante insomma egli non sia, e per fortuna sua, il santo risorgimentale. A Foscolo si deve la consacrazione di questo gesto, che da semplice spostamento geografico si trasforma invece in una entità di scuola e di formazione di un’altra generazione. Mi sia consentita una citazione, da Ezio Levi d’Ancona, settembre 1930, di grande suggestione: «gli esuli sono un poco i posteri del mondo contemporaneo ed assumono rispetto a questo una voce che - venendo dalla lontananza e attraverso gli squilibri della storia - ha talvolta il timbro della voce dei profeti». Un timbro di lontananza che si converte in un timbro di profezia. Il volume, da cui traggo queste parole, Gli esuli del Risorgimento di Agostino Bistarelli (Bologna, il Mulino, 2011) è ricco di esemplificazioni sull’istituto dell’esilio. La storia d’Italia, in forma d’esilio, da Dante («Tu lascerai ogni cosa diletta / Più caramente, è questo è quello strale / Che l’arco dell’esilio più saetta»; Paradiso, XVII, 55) al Settecento, al 1820-21, alle fasi successive del Risorgimento, che, come si vede, rilancia un costume antico, dantesco. Pertanto, come osserva Bistarelli, «lo studio degli esuli risorgimentali si deve necessariamente inquadrare, allora, in un contesto non solo spaziale (i luoghi di e i luoghi da) ma anche temporale: l’esilio diviene così una categoria interpretativa per molteplici approcci di studio.» (Introduzione, ivi, p. 12). Né possiamo dimenticare, con Josif Brodskij, che l’esilio è una condizione metafisica, che siamo in esilio, comunque e dovunque, che siamo, o dovremmo saperlo ammainando la nostra vanità, «un granello di sabbia nel deserto». Nel Risorgimento ci sono diverse generazioni: quella che si forma nell’esilio - e Foscolo è il suo archetipo, insieme a Mazzini, Rossetti e Berchet - e la generazione che si forma nelle carceri e l’icona di essa è Silvio Pellico. Anche se poi Pellico abbandona la politica e la sua esperienza del carcere diviene una via crucis per arrivare alla scoperta di Dio. Anche studenti fra gli esuli e nella popolazione degli esuli del 1821, si contano 91 studenti, venti dei quali provenivano dall’ateneo di Pavia, dove fra i professori «celebri e cari», oltre a Monti, Lomonaco, Giandomenico Romagnosi, Adeodato Ressi, v’era stato Foscolo. Altri vivranno il Risorgimento nella polvere della battaglie o nell’adesione all’epica garibaldina. Foscolo è il libero uomo che non accetta servitù, da qualsiasi parte essa venga imposta, ma sceglie, anche con un trionfo della propria individualità - egli non si lega mai a nessuna forma di consorteria - di approdare nella libera Inghilterra. L’esilio stabilisce anche la costruzione di una tradizione. La tradizione foscoliana si basa sulle biografie: Foscolo viene biografato. Ora un conto è avere una vita, un conto è avere una vita in biografia. Comincia con Foscolo la tradizione della vita biografata, che è un modo per trasmettere anch’essa un’illusione potente. Nella biografia, la vita sopravvive a se stessa. Nella tradizione su Foscolo nessuna delle sue biografie è puramente apologetica. A ben guardare, puramente apologetico non è neppure il cammeo foscoliano nel capitolo XI delle Confessioni di un italiano di Ippolito Nievo, dove un Foscolo «giovinetto quasi imberbe e di fisonomia tempestosa» se ne usciva alla ribalta con questa frase, giacobino-neoclassica: « - Cittadino, non disperare della virtù al pari di Bruto! […] Bruto disperò morendo, noi siamo per nascere!». Giovinetto «ruggitore e stravolto», levantino di Zante, figliolo di un chirurgo di vascello della Repubblica, di stanza a Venezia dopo la morte del padre, fino a quel momento commentava maliziosamente Nievo - non si era segnalato per stabilità di opinioni: «perché si bisbigliava che soltanto alcuni mesi prima gli fosse passato per capo di farsi prete; ma comunque la sia, di prete che voleva essere era diventato invece poeta tragico; e una sua tragedia, il Tieste, rappresentata nel gennaio allora decorso sul teatro di Sant’Angelo, aveva furoreggiato per sette sere filate.» E l’ironia del romanziere trascorre quasi in sarcasmo sull’«orsacchiotto repubblicano ringhioso e intrattabile», che molto si ammirava, e che tanto sul serio aveva preso il principio di uguaglianza da porsi, se lo avesse creduto, a scrivere una lettera di consiglio all’«Imperator delle Russie», stizzito se le imperiali orecchie non lo avessero ascoltato. Insomma un protagonista precoce e non del tutto al riparo dal rischio di vanità, oggi si direbbe, narcisistica. Ma il fatto che Foscolo fosse entrato nella storia da giovane (gioventù che è sì cara al romanticismo e al risorgimento), giovane men che ventenne, segretario diciannovenne della Municipalità, nella Venezia al tramonto, giovane trageda, giovane amante (Isabella Teotochi Albrizi), giovane propugnatore di libertà, indipendenza, tutto cuore, avido di sensazioni, ma anche «disprezzatore della fortuna, e della morte», bastava per farne un mito. Un libro di Christian Del Vento, Un allievo della rivoluzione. Ugo Foscolo dal «noviziato letterario» al «nuovo classicismo» (1795-1806), edito dalla Clueb di Bologna nel 2003, passa in rassegna partitamente ogni fase della mitizzazione di un poeta posto sempre al di là del contesto letterario. Come se si dovese sempre estrarre dalla letteratura di Foscolo una virtù civile, un pensiero politico, ed è eloquente la rimozione risorgimentale (che si deve a De Sanctis) della pura beatitudine clacisa delle Grazie. La sua biografia più importante, quella di Giuseppe Pecchio, Vita di Ugo Foscolo, edita a Lugano nel 1830, è una biografia critica, critica anche del suo estremismo o radicalismo visionario nella dimensione della politica, che Pecchio attribuiva fra l’altro al suo essere uomo antico, «rinchiuso sempre nell’antichità, come un antiquario in un museo», senza vera comprensione di cosa fossero «tempi moderni». Ciò nonostante, la figura di Foscolo regge anche a una tradizione critica. L’obiezione consiste nel fatto che gli anni londinesi di Foscolo non sono anni troppo impegnati nella militanza politica, ma nella scrittura critica (saggi su Petrarca e Dante, le Epoche della lingua italiana che si fanno leggere con il riscontro delle satiriche e pertanto ragionatrici Lettere scritte dall’Inghilterra), e ciò gli viene rimproverato. Perché la militanza politica è in questi anni paragonata a una vera e propria militanza religiosa. A una totalità, indivisa e infrangibile, che non può essere disattesa in ogni sua parte. Pietro: Mi interessa riprendere questo argomento da un altro punto di vista. Mi pare che tanta parte della sua “oscillazione” dipenda dal fatto che il suo pensiero ondeggi fra una costruzione dell’immagine di sé, finalizzata a un alto ideale e invece la percezione, la sequela di un ideale di sé che egli intuisce come dato. La sua oscillazione dipende dai due fuochi della costruzione dell’immagine di sé e invece della intuizione di un ideale oggettivo, interiore, da perseguire. Nella famosa lettera da Ventimiglia dell’Ortis, egli dà di sé una definizione: “Io sono un mondo in me stesso…”, che riecheggia quanto diceva lei ora: libero, assoluto, nel senso etimologico del termine, cioè privo di legami, avulso da ogni tipo di dipendenza. Ma la citazione continua e dice: “… e intendo di emanciparmi, perché mi manca la felicità che mi avete promesso”. Sta qui attaccando la società, rispondendo ad alcune obiezioni di Lorenzo al suicidio. È interessante questa seconda parte della frase. Prima “Io sono un mondo in me stesso”, che adombra l’idea di una volontà di sé come libero uomo, indipendente e assoluto. Ma la seconda parte della frase suggerisce la denuncia di una promessa non mantenuta. È come se Ortis / Foscolo dicesse: mi uccido perché la promessa di felicità che mi avete fatto non l’avete mantenuta e quindi non vi devo nulla, e quindi non sono in nulla legato a voi. Il criterio dunque è quello della felicità. Non mi avete reso quella felicità che mi avete promesso. È interessante questo aspetto, perché è come se Foscolo fosse consapevole di una promessa fatta da una società che aveva la pretesa di essere la società perfetta, di realizzare la felicità totale. Se questa promessa viene delusa non c’è alcuna possibilità di legame fra Foscolo e la società. Il barone Strassoldo, massima autorità della censura austriaca, nel suo rapporto su Foscolo lo definisce così: «Individuo pericoloso sotto ogni regime». Come un’insoddisfazione connaturata, come la percezione di un esilio non solo letterario e politico, ma ontologico ed esistenziale. Biondi: L’uomo libero è pericoloso sotto ogni forma di governo. Sospetto e malvisto, segnato a dito, isolato, allontanato. Esiliato anche in patria. L’argomento che lei introduce ora fa riflettere sulla funzione dell’Ortis. Questo romanzo, che appare un libro così giovanile, sentimentale e immaturo, non viene in realtà mai del tutto messo da parte. La sua storia redazionale è assai complessa, con tre tappe editoriali principali, il 1798 (Bologna), il 1802 (Milano, editio princeps, con modifiche sostanziali anche nella storia romanzesca), il 1816 (Zurigo), il 1817 (Londra), quasi vent’anni di vicende editoriali. Nell’edizione dell’Ortis, proposta nelle Opere della Einaudi Gallimard (Torino, 1995), la curatrice Maria Antonietta Terzoli opta per l’edizione zurighese del 1816, come la più completa del romanzo, anche per il corredo metatestuale. Il commento alla prima proposizione narrativa del romanzo, Da’ colli Euganei, 11 ottobre 1797: «Il sacrificio della patria nostra è consumato», vale a dire la cessione di Venezia all’Austria con il trattato di Campoformio, firmato solo poco dopo il 17 ottobre 1797, suggerisce che la scrittura di Jacopo si apra su una ripresa evangelica, il «Consummatum est» del Cristo morente (Giovanni, 19, 30), nesso segnalato da Gianfranco Contini in Letteratura italiana del Risorgimento. 1789-1861 (Firenze, Sansoni, 1986). Un libro che diviene, a prescindere dalle manipolazioni e dalle edizioni pirata (come quella confezionata per il librajo bolognese Jacopo Marsili dal letterato Angelo Sassoli), nel mentre accompagna il suo autore, e cambia il ritratto di Jacopo (cioè di Foscolo) nella pagina accanto al frontespizio. Come la vita. Ed è un libro che pure sembra grondare di morte. Di che parla? Di amanti infelici, si divulgò subito fra gli stampatori, indotti a farne commercio su questo solo paradigma della passione d’amore, ma Foscolo ebbe a precisare nella Notizia bibliografica che ci fu uno stampatore di Milano, il Mainardi, il quale rimase «sgomentato da’ tanti passi ne’ quali i governi d’allora erano affrontati a viso aperto» (Notizia bibliografica intorno alle «Ultime lettere di Jacopo Ortis» per l’edizione di Londra MDCCCXIV). Quindi romanzo politico. Nemico dei tiranni e tirannie. E vuoto andò il bianco delle lacune che segnalava i tratti pericolosi. Qualche esempio di invettiva: «I governi impongono giustizia; ma potrebbero eglino se per regnare non l’avessero prima violata? Chi ha derubato per ambizione le intere province, manda solennemente alle forche chi per fame invola del pane.» (Ventimiglia, 19 e 20 febbraro). E ancora, nella stessa lettera: «Ma gli Dei si vestirono in tutti i secoli delle armi de’ conquistatori; e opprimono le genti con le passioni, i furori, e le astuzie di chi vuole regnare.» E allora quale è la virtù? La virtù sconosciuta. La virtù che si chiama compassione: «Tu, o compassione, sei la sola virtù! tutte le altre sono virtù usuraje.» La soluzione del suicidio, che è un troncamento nichilistico, è una soluzione tardomimetica del modello goethiano, dei dolori del giovane Werther. Foscolo era ben consapevole dell’operazione che compie e per evitare l’accusa di plagio definisce i termini di una poetica della imitatio. Cosa ne scrive in Notizia bibliografica? «Altri stima che siccome il Werther rappresenta il suicidio quasi malattia crescente, incurabile di ceti individui; così l’Ortis intenda di raccomandarlo quasi rimedio di certi tempi, come se il troppo terror della morte avvezzasse i mortali a comperarsi la vita a prezzo d’infelicissima servitù.» Ma mentre i dolori del giovane Werther vengono poi da Goethe trascesi con la straordinaria poetica che sappiamo, attraverso il grande viaggio della vita, che sono Gli anni di viaggio di Wilhelm Meister, uno dei libri che rivelano l’esistenza nelle forme più profonde e la tolgono ai momenti puramente emergenziali, che si contrappone a una vita tutta fatta di picchi di grande effetto, i quali portano all’implosione di una vita che non è stata interpretata e svolta come sarebbe stato doveroso fare. C’è un peccato nel Romanticismo; c’è un peccato nel Werther e nell’Ortis, che tutti questi grandi artisti poi assolvono, progredendo, continuando nella costruzione. L’edificazione di Goethe è gigantesca e porta nelle dimensioni faustiane dell’oltre. Nel Foscolo l’Ortis è il breviario della gioventù e di una gioventù dolorosa. Il dolore è ovunque nella vita, nella storia. «I casi della vita sono varj e individuali, e non ammettono regola; - leggiamo ancora dalla Notizia bibliografica - ma le passioni, da’ gradi in fuori, e il dolore sono comuni a’ mortali.» Perché nell’Ortis oltre al dolore di una passione non ammessa, della passione tradita dai contesti, vorrei dire, perché la passione di Ortis viene corrisposta, ma sono altre le forze che si oppongono, c’è uno straordinario breve intenso talora delirante romanzo su quell’Italia, che è un’Italia deserta, povera, calpestata da armi straniere, una specie di necropoli a cielo aperto; dove, se non ci fosse l’amore ci sarebbe soltanto il viaggio sull’ara tombale di Petrarca o di Dante. C’è Santa Croce, non a caso ho parlato di una necropoli. L’Italia è una necropoli e l’unica necropoli che riesce a vivere paradossalmente è quella dei grandi del passato. Se nei Sepolcri Parini è attore di poesia, e di poesia notturna, con punte di macabra certo non voluta compiacenza («e forse l’ossa / Col mozzo capo gl’insanguina il ladro / Che lasciò sul patibolo i delitti»; Dei Sepolcri, vv. 75-77), qui nell’Ortis è ancora attore vivente, e il più eloquente dei poeti, poiché il più dolente, stabilendosi nel romanzo l’asse di equivalenza fra dolore ed eloquenza. A lui, generoso italiano, vecchio e storpio, reso quasi silente («il Parini non apria bocca; ma stringendomi il braccio, mi guardava ogni ora più fisso»), muto dal non occhieggiar barlumi all’orizzonte della patria, che Jacopo, nella pausa dei suoi furori, di gloria, di morte, dipinge il suo amore e con esso, in esso, Teresa, «come uno di que’ geni celesti i quali par che discendano a illuminare la stanza tenebrosa di questa vita.» (Milano, 4 dicembre). Incauto d’ingegno, dice nel corso di un dialogo convulso di Jacopo il Parini, saggio senza illusioni, mesto e forse sconfitto dai tempi, ma con lo sguardo che si raddolcisce, dopo essere stato distolto dal fango della città «d’evirati cantori allettatrice», solo verso il cielo, il Parini che introduce il tema del sepolcro: «E dove tu nelle pubbliche cose possa preservarti incontaminato dalla comune bruttura, oh! tu sarai altamente laudato; ma spento poscia dal pugnale notturno della calunnia; la tua prigione sarà abbondonata da’ tuoi amici, e il tuo sepolcro degnato appena di un secreto sospiro.» Prepotenza dello straniero, malignità degli uomini, corruzione dei tempi. Non c’è scampo nell’Ortis. Il primo Risorgimento viene tenuto a balia dalla disperazione, più che dalla speranza ed è la disperazione che, toccando il fondo della decadenza, risorge quasi per legge fisica e si riconverte in speranza. C’è sapienza, fredda e marmorea, in mezzo a tanto ribollire di passioni: «I mortali sono naturalmente schiavi, naturalmente tiranni, naturalmente ciechi.» Il Parini è la coscienza di Jacopo, uno Jacopo diventato vecchio, se solo fosse sopravvissuto, se all’onta subita dell’amore e della patria traditi avesse deciso di non opporre la morte volontaria, ma la più eroica pazienza della vita. Disperata Italia, prostituita (nelle lettere), corrotta (nel costume), dormiente in un sonno di morte. I Sepolcri foscoliani, che non dobbiamo dimenticare essere figli all’occasione del dibattito sulle sepolture che coinvolge la cultura europea nella seconda metà del Settecento, fissando due modelli, il francese (espulsione dei morti dal tessuto sociale dei vivi) e l’anglosassone (compresenza nei centri abitati di chiese e cimiteri), risvegliano la morte dall’inerzia e la schierano di nuovo a battaglia. In un libro recente, Laura Melosi ha ribadito l’esemplarità del discorso celebrativo foscoliano e la sua incidenza nell’immaginario delle generazioni laiche e democratiche dell’Ottocento, «presso le quali i Sepolcri sono talora arrivati a sostituire le Scritture come libro sacro della nuova religione civile dell’amor di patria: si pensi ai romanzi di Garibaldi, all’ultimo in particolare, Manlio, dove il personaggio del dottor Ferrari officia i riti di commemorazione dei caduti leggendo versi del carme.» (A perenne memoria. L’epigrafia italiana nell’Ottocento, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2011, … e serbi un sasso il nome, p. 77). Nell’Ortis è ancora cruda verità, irredenta anche da illusioni, e illacrimate sepolture si paventano. Ma nell’Ortis sopravvive un’Italia che costituisce anche l’immagine di molti viaggiatori: un paese descritto davvero come una landa deserta, una contrada silenziosa e senza più destini propri. È per certi aspetti analoga, se non la stessa, percezione che ha Leopardi nella sua disperazione recanatese. Nell’Ortis si rivela l’alto costo psicologico di questo vivere all’interno di un paese che attende come un re addormentato chi lo svegli dal suo sonno di morte. Penuria di occasioni di vita, una quiete mortale che si stende sulla terra italiana come un sudario. Allora il romanzo è da una parte un microcosmo di sentimenti e il libro di una gioventù che dovrebbe essere lasciata alle spalle e dall’altra Foscolo se lo porta sempre con sé. Perché? Perché in Foscolo c’è questa grande intuizione della maturità: si hanno tutte le età della vita, quando si sono conquistate, non si smettono più. Una volta che si è avuta la gioventù, la gioventù resta, e agisce. Poi c’è la maturità, la vecchiaia: Ortis e Didimo. C’è l’urlo della passione, la disperazione, la morte autoinflitta (che è poi una forma di straordinaria vitalità; il suicidio è una forma massima di protesta vitale); e c’è Didimo, che è una invenzione mirabile di Foscolo. L’uomo maturo che si esprime sempre con un sorriso impregnato di pianto: c’è sempre una lacrima fermata come un bassorilievo negli occhi di un uomo che ha vissuto. Quindi in Foscolo ci sono tutte le età della vita e infatti si porta il suo carico di opere con sé. Carico che poi non è così straordinariamente massiccio come, a esempio, in Leopardi. In Foscolo non c’è lo Zibaldone, perché evidentemente non c’è quell’attività mentale, che produce quel flusso massivo di pensiero. Edoardo: Professore, quando lei ha ripercorso l’attacco dei Sepolcri, fino a quella fortissima avversativa, quel “ma”. Una differenza che mi pare significativa fra Foscolo e Leopardi sta nel fatto che si evidenziano spesso due dinamiche incrociate: lo Jacopo Ortis inizia con l’«arido vero» («Tutto è perduto») e anche i Sepolcri («Il sonno della morte») e poi sopraggiunge il “ma”; le illusioni, continuamente, in questo moto precipitoso che porta al nulla, sorgono con questo mondo di grazia e di bellezza. Mentre in Leopardi si parte dall’illusione e si approda alla sconfitta dell’arido vero (A Silvia). In Foscolo permane l’accusa di questo elemento: si può anche partire dalla registrazione di un dato esistenzialmente disperante e continuamente però accusa che l’uomo dall’interno di questa dinamica vede sorgere dentro di sé l’aspirazione a questa vastità, che si colora di tantissimi tratti. Biondi: Il confronto con Leopardi non avviene tanto sul piano della altezza poetica, ma su quello di una diversa elaborazione del pensiero. Con Leopardi ci troviamo di fronte anche a un teoreta, capace di produrre un pensiero che non è mai separato, autonomo dalla vita, ma che ha una potenza noetica con cui anche gli storici della filosofia hanno dovuto fare i conti nel Novecento, riabilitando alla grande la filosofia dei non filosofi (di professione). E ammettere che c’è un grande filosofo nell’Ottocento italiano, che si chiama Giacomo Leopardi. Ma per tutto l’Ottocento questa identità filosofica non era stata presa in considerazione. Fino alla fine dell’Ottocento lo Zibaldone sembrava un accessorio alla poesia, un deposito non di pensiero, ma di pensieri, in moto perpetuo e anche stravagante (alla Montaigne). Invece ha una sua valenza filosofica specifica. Nel libro di Roberto Esposito, Pensiero vivente. Origine e attualità della filosofia italiana (Torino, Einaudi, 2010), le pagine su Leopardi (Niente in comune) ci fanno vedere una qualità intrinseca allo speculare italiano, la sua vitalità, una filosofia della vita o nella vita, non della mente, non solo della mente. In Leopardi è poi decisiva la sua critica alla «inflessione antropocentrica», che riacquista anche tonalità bruniane nella critica dell’umanesimo personalista e della unicità dei mondi. Nel caso di Foscolo ci troviamo di fronte, io credo, a un autore dalla mente meno speculativamente attrezzata, non così congegnata per il pensiero puro, il quale è portatore naturale, portatore spontaneo, anagrafico di classicità. Leopardi costruisce il classico, e lo fa rivivere dentro di sé. Si è detto, per metafora, che Leopardi è un uomo greco. Ma Foscolo è di fatto un uomo greco. Leggiamo nella biografia approntata da Mario Scotti per il Dizionario Biografico degli Italiani: «Il Foscolo non troncò mai o l'uno o l'altro ramo in cui avvertiva divisa la sua radice. La sua opzione per la patria degli avi paterni e per la lingua italiana non implicava il distacco dalla patria materna, dalle memorie e dagli affetti che vi si legavano. Il pensiero della Grecia affiora nella sua poesia non come momentaneo abbandono nostalgico, ma come riflesso di quella costante affettiva che animava le sue dichiarazioni di valenza politica e culturale, i suoi progetti operativi, il suo desiderio di concludere la vita nella terra delle sue origini.» Portava con sé all’origine la fulgida bellezza dell’ideale classico, più greco che latino, con quello che ciò comporta in una tradizione italiana che è ovviamente più latina che greca. Io penso che questa origine greca sia il sole che illumina anche la notte del Foscolo. Non a caso i Sepolcri s’illuminano con Omero, con la voce della poesia greca, che per lui, a differenza che per Leopardi, per il quale la grecità era un sogno o il raggio di una stella che nel frattempo si era eclissata, per Foscolo è e continua a essere un pianeta in cui lui è vissuto. La classicità è elemento vitale in Foscolo. È vita e biografia. Il classicismo di Foscolo, anche linguisticamente, è il più autentico, o meglio è autenticato dalle origini, senza essere solo astrattamente o illusoriamente regressivo. Il greco è la sua lingua. In Foscolo la luce è luce dell’origine, che trionfa anche nel buio delle sue notti e lo conduce fino all’ultimo giorno. La sua poesia è sempre irraggiata. Anche le Grazie lo sono. È vero che esse sono un punto d’arrivo che alcuni hanno giudicato stanco, formalistico, compiaciuto. Forse è così. Ma cosa sono le Grazie se non il riposare in eterno su una bellezza formale, che è stata una volta vissuta come percezione geografica, viva e vera, di cui restano solo gli emblemi poetici. Ciò che prima era sole, acqua, elementi, sono diventate forme pure. Dalla natura alla forma della cultura, che lascia impressa il suo sigillo, come sulle tombe la bellezza umana rivive nella composta armonia delle sculture canoviane. A volte si riconosce questa condizione in autori che venivano dalla Sicilia: in Quasimodo per esempio, o in Vittorini c’era qualcosa di analogo. Autori che venivano dalla Magna Grecia. E Quasimodo, traduttore dei Lirici greci, libro pubblicato nell’anno più cupo, il 1940. Il grecista Manara Valgimigli, cui non erano del resto sfuggiti errori e fraintendimenti anche gravi, aveva capito che in quelle versioni si tentava l’antico con una urgenza e una aggressività forte e genuina. Un classicismo veramente luminoso, questo che viene dalla sua sorgente; altro che illuminismo! L’Illuminismo non fa luce. Ahimè, è la fioca luce dell’intelletto. Indispensabile, lo sappiamo tutti, ma non fa luce. Infatti l’illuminismo davanti a una tomba è cieco. Cosa vede? Il nulla! La necroscopia, al massimo, la laboriosa indagine sulla morte. Pietro: Vorrei tornare su questo argomento, che credo sia il punto infuocato della questione. Lei diceva: l’illuminismo di fronte a una tomba è cieco. Il poeta (è questa la figura che Foscolo oppone al filosofo illuminista), il poeta di fronte alla tomba, che cosa vede, che il filosofo non vede? Lo chiedo a partire dalla famosa lettera dell’Ortis: «Illusioni! grida il filosofo. […] Illusioni! Ma intanto senza di esse io non sentirei la vita che nel dolore». Questo è l’unico punto del romanzo in cui non è Ortis/Foscolo che dice “illusioni”, ma la denuncia come affermazione di un filosofo, dal quale prende le distanze. Conferma che sono illusioni, eppure questo “ma intanto…” da tutta l’idea dell’avvertimento di una estraneità, di una differenza. Biondi: Anche qui vorrei riportarci alla poetica della illusione che trionfa e alla poesia degli ultimi versi dei Sepolcri. “E me, che i tempi ed il desio d’onore / fan per diversa gente ir fuggitivo”. “I tempi” sono le circostanze storiche in cui visse Foscolo. Veramente in questi anni s’incontrano, come in un grande sisma, tutta l’antichità dell’antico regime, il trono e l’altare e la modernità. Comincia qui il lungo percorso dentro il quale siamo noi stessi, perché questi sono percorsi plurisecolari, i tempi lunghi descritti per le civiltà del Mediterraneo da Braudel. Poi c’è il “desio d’onore”, che impedisce al libero scrittore le viltà montiane, le prudenze manzoniane. Manzoni è un artista per il quale abbiamo tutti venerazione, ma la cautela, la prudenza gli sono proprie. Quella prudenza che lo porta a chiudersi in casa il giorno del terribile delitto Prina e a maturare poi quel disgusto profondo nei confronti della storia che è suo caratteristico. Ma di questo abbiamo parlato altre volte. Qui c’è anche il “desio d’onore” del libero uomo Ugo Foscolo. Che è il ritratto, ripeto, che si tramanda negli scritti del Risorgimento da Mazzini a Carlo Bini, fino al ritratto di Foscolo a Venezia che ne fa Nievo nelle Confessioni di un italiano. È un ritratto di ammirazione, nonostante tutto, e lì si capisce che la gioventù del Risorgimento guardava a Foscolo, non a Leopardi. Anche nelle Confessioni Leopardi è visto con meno simpatia umana. Poi avrà un suo momento, ma è successivo. Leopardi ha parlato più a noi uomini del Novecento che non ai suoi coetanei. «Me ad evocar gli eroi chiamin le Muse / del mortale pensiero animatrici». È la religione foscoliana della poesia classica, per cui le Muse chiamino me ad evocare dalle loro tombe gli eroi, Muse che sono animatrici del pensiero mortale. Anche qui che il pensiero venga nutrito di poesia non è propriamente la posizione leopardiana. Perché il pensiero di Leopardi non è nutrito di poesia, ma di pensiero. Alcuni dicono che è un pensiero che distrugge se stesso. Perché è un pensiero che fa della contraddizione la sua terribile arma progressiva. Ma la poesia è il momento del sogno, quando il “pensiero dominante” bussa, allora il poeta si apre all’accoglienza. Ma in Foscolo sono le Muse che nutrono il pensiero. Il pensiero foscoliano è nutrito di poesia. Da questo punto di vista Foscolo è un poeta integrale, è un poeta totale, mentre Leopardi non è solo poeta. Tanto è vero che la critica leopardiana ha ecceduto talvolta nel non interpretare il poeta, ma nell’interpretare il pensatore. A un certo punto della storia di questi anni, erano più numerosi i corsi universitari sullo Zibaldone che non sui Canti. Il che ha creato anche un certo disorientamento. Ma effettivamente si poteva giustificare questa doppia titolarità disciplinare, perché in Leopardi ci sono entrambi questi paesaggi. Invece la mente foscoliana, se volete è anche una mente più semplice, essendo che è più vicina all’origine, quando le Muse alimentavano il pensiero. E il pensiero è un pensiero costruttivo, non decostruttivo, perché è chiamato a dare vita agli eroi che sono morti. Quindi è chiamato a ridare esistenza, tramite la tradizione, tramite il canto, alla lunga filiera degli eroi: “E tu onore di pianti, Ettore, avrai…”… Edoardo: Ed Ettore è uno sconfitto… Biondi: Certo, anche uno sconfitto; anche gli sconfitti nella Troade inseminata. “E tu onor di pianti, Ettore, avrai / ove sia santo e lagrimato il sangue / per la patria versato…”, ecco quindi anche la ricaduta risorgimentale, “… e finché il Sole / risplenderà su le sciagure umane.” Pietro: È una sorta anche di riscatto della sciagura stessa. Da un certo punto di vista che si parli di gioia o di dolore, di vittoria o di sconfitta e di morte, la fama, perpetrata dalla poesia, vince. Edoardo: “Bello di fama e di sventura…” Biondi: Sì, è così. Quest’ultimo verso, “finché il Sole / risplenderà sulle sciagure umane.”, è grandioso. È un verso carico di dolore, di pessimismo, perché le ultime parole sono le sciagure umane. La storia sono le sciagure dell’uomo e il sole guarda, illumina, risplende. Ma finché il sole risplenderà sulla sciagure umane ci saranno pur sempre le Muse, del pensiero mortale animatrici, a tenere vivo, vivo fino a quando il tempo concederà all’uomo creatura temporale, figlia del tempo. Fino a quanto il tempo concederà, perché il tempo nelle sue grandezze astronomiche, ci immette in quei vuoti siderali, che sembrano indifferenti all’uomo. Lì entriamo nella dimensione leopardiana (e kafkiana) dove si spingono gli esploratori senza ritorno. Qui invece è un sole, non astro remoto, ma un sole, che scalda… perché ci sono delle stelle che non scaldano più: nelle astronomiche grandezze leopardiane il sole, anche il sole ha smesso di scaldare. Gli astronomi dicono che il sole smetterà di scaldare fra cinque, dieci milioni di anni che sono le grandezze disumane e noi non partecipiamo a quel tipo di grandezza: per noi trent’anni sono la vita. Edoardo: Questa questione del sole torna nell’ultimo discorso diretto di Jacopo Ortis, che viene riportato dall’amico Lorenzo: «Pare anche a te che oggi la luce splenda più bella che mai?». È l’ultimo giorno della sua vita, ha deciso di uccidersi; comunque c’è il sole… Biondi: Luminismo e luce. Luminismo, che viene dai filosofi che hanno restituito al vero nudo e crudo la sua legittima posizione nel processo di conoscenza. Ma la luce è un’altra. Edoardo: Foscolo è come se impugnasse per tutto il tempo della vita questa cara vulnerabilità umana. L’illusione è cara, perché ti rende vulnerabile a essere ferito, ma unisce stranamente due cose. Da una parte è l’unica vera possibilità di comunione fra gli esseri umani: la compassione, che è ciò che nei Sepolcri muove Omero e chi lo ascolta – Jacopo Ortis dirà «Chi di noi morendo non ha lasciato un rimpianto?». D’altra parte, rispetto alla luce del filosofo che non scalda, c’è una presenza di elementi della realtà, che scaldano, fattivamente. Ad esempio l’affetto della madre, che, quando lo benedice alla fine del romanzo, gli dice: «Vivi, vivi». È una realtà positiva, che scalda l’animo di Ortis; oppure tutta la trama di rapporti che lo circondano (Lorenzo, il servo Michele, Teresa stessa, il padre di Teresa). Foscolo registra che nella realtà ci sono delle cose che scaldano, davvero! Biondi: Diciamo che Foscolo è il poeta della gioventù. Ecco un altro motivo della sua forte empatia verso i giovani del Risorgimento. Non è mai vecchio Foscolo. Non è mai stato vecchio (il Parini, lo abbiamo detto, nell’Ortis poté essere un suo specchio senile). Anche l’ultimo Foscolo, fors’anche per una certa sua scapigliatura londinese. Negli sbandamenti, di chi la testa a posto non l’aveva messa mai. Foscolo è sentito come il giovane. Il Risorgimento è fatto da giovani. E i giovani, è un fatto biologico, dentro ce l’hanno la pulsione di vita. La senilità non li riguarda. E Foscolo è sempre il poeta giovane, che porta dentro di sé tutte le passioni e i vizi, che sono l’aspetto di servitù delle passioni, quell’aspetto che asservisce, perché anche le passioni legano e Foscolo non si concepisce neppure senza passioni. Ecco perché io dico che le Grazie sono la prima contemplazione senza passione. A questo mi ha fatto pensare uno storico dell’arte, di cui ho letto un saggio su Canova, che è il modello della Grazie. Nel neoclassicismo canoviano c’è la perfezione della vita senza vita. Di fronte alle opere di Canova si resta sbigottiti da una bellezza, che però è mortuaria. Nelle Grazie c’è qualcosa della monumentalità funeraria, sepolcrale, che accompagna da sempre Foscolo. Perfezione della vita senza vita. Invece la vita Foscolo è abituato a sperimentarla nell’imperfezione delle sue passioni e nell’iniquità di certi suoi comportamenti: è l’amante aggressivo, infedele, ambizioso. Prima parlavamo della vulnerabilità umana. In Foscolo c’è l’imperfezione umana ed è questo che lo rende caro ai risorgimentali. Perché Foscolo è un uomo, non una statua. La grandezza di Manzoni è tanto più grande, perché non ha bisogno di nessun appeal, di cui Manzoni è totalmente sprovvisto. Eppure la sua grandezza resta inviolata, perché è tutta una grandezza mentale e profonda. Invece in Foscolo c’è l’appeal, la capacità seduttiva potente. Non a caso è stato un seduttore straordinario e un seduttore storico: egli seduce la generazione del Risorgimento. Mazzini, il più grande ideologo del Risorgimento, si portava Foscolo appresso e lo considerava un maestro. Garibaldi aveva i Sepolcri nel comodino del suo letto di Caprera e aveva imparato da Foscolo gli endecasillabi e scrisse il Poema autobiografico in endecasillabi che hanno una certa dignità formale. Il Risorgimento è letterario, giovane e passionale e Foscolo è la sua letteratura d’iniziazione, giovane e passionale. È veramente l’archetipo di quel tempo e anche per questa precisa temporalità storico-simbolica paga un fio alto nel nostro secolo, in cui non dico che sia superato, ma senz’altro è oscurato da Leopardi e da Manzoni. Pensate all’odio e all’insofferenza di Gadda nei confronti di Foscolo. Il guerriero, l’amazzone, lo spirito della poesia nel verso immortale del Foscolo. Conversazione a tre voci comincia con Donna Clorinda: «Mi dicono che era anche greco, proprio come gli antichi greci» (in Saggi giornali favole e altri scritti, II, a cura di C. Vela, G. Gaspari, G. Pinotti, F. Gavazzeni, D. Isella, M. A. Terzoli, Milano, Garzanti, 1992, p. 385). Gadda detestava Foscolo in modo viscerale, nevrotico. Lo chiamava il Basetta («No, il Basetta non ha il più pallido senso della forma»), poeta iperbolico e zacinzio, gli dava dello scimpanzè, del roditore, attribuendogli scaltrezza, teatralità e opportunismo, ne derideva l’enfasi e, insieme a Carducci, lo bollava per gli errori marchiani, definendolo, insieme al Carducci, «il più grande strafalcionista del lirismo italiano ottocentesco». A rammentarcelo è stata di recente una memoria gaddiana di Alberto Arbasino, L’ingegnere in blu, che consentiva naturalmente al gioco al massacro. Nel Novecento è andato di moda spezzare le reni a qualcuno. Gadda non tollerava la virilità foscoliana, che era l’energia di un uomo. Perché il Novecento… altro che vulnerabilità! Ha fatto della vulnerabilità una specie di resa eroica alla nevrosi. E al nevrotico è stato concesso tutto, perché la nevrosi non era criticabile, non parodiabile. Contro Foscolo c’è stato un revanscismo che Gadda ha interpretato a modo suo, facendo la satira di lui, come del maschio italiano, del gallo da pollaio, che è come tradurre la virilità delle passioni e il grande Romanticismo nel turpe disegno di un dongiovannismo da quattro soldi. Perché in Gadda la virilità era così periclitante, che questa immagine sembrava schiacciante e allora andava derisa. Il cavaliere andava disarcionato. Foscolo è stato duramente colpito da questo secolo così aspro, così malevolo, di cui questo Duemila assomiglia a un prolungamento. Pietro: Io credo che abbia inciso sul Novecento anche l’esito della storia dell’Ottocento. L’esito di quel grande ideale di patria, per come poi si è realizzato. Il Novecento ha vissuto la caduta del grande ideale ottocentesco, con degli eventi, a partire dalle due guerre mondiali, che hanno isolato la storia dell’Ottocento, dal punto di vista della fede nell’ideale, come una sorta di muro di Berlino, dai protagonisti del Novecento. Ma questo isolamento è avvenuto non per contrapposizione, ma per svelamento: è come se nel Novecento gli uomini abbiano visto l’esito deteriore delle premesse dell’Ottocento. Biondi: Questo è vero. La storia del Novecento ha rivelato un volto di neobarbarie che l’Ottocento, secolo che Leopardi definiva sciocco, cioè ingenuo, ignorava. L’Ottocento ha assistito a un progresso quasi continuo. Noi nel Novecento abbiamo capito che ogni progresso può essere traumaticamente interrotto e diventare terribile regresso. È per questo che l’Ottocento, come diceva Luigi Baldacci, è stato l’ultimo secolo che è andato d’accordo con se stesso. Non a caso ha scritto i romanzi più belli che ci siano, in cui i personaggi svolgono per intero la loro vita e la guerra e la pace vengono rappresentate. La grande narrativa viene tutta di lì. L’Ottocento è stato un grande secolo anche della fede, fede e fedi che il Novecento ha smentito. L’Ottocento è un secolo che ha creduto e Foscolo è stato il maestro di generazioni di Italiani che hanno creduto di fare di un paese, che era la necropoli dell’Ortis, uno Stato, bene o male, che si è retto, che speriamo si regga. Che è il nostro paese, l’unico che abbiamo e ce lo dobbiamo tenere caro. Ma questo Stato l’ha fatto l’Ottocento. Certo non solamente i protagonisti della passione, quelli vissuti nella tempesta emotiva del Romanticismo, ma anche i freddi, gli statisti, Cavour su tutti, estraneo per molti aspetti alla cultura, o meglio alla letterarietà, del Romanticismo, ma molto in sintonia con la cultura economica europea, e lui, gran viaggiatore, mai sceso a visitare Roma, per quanto, sufficientemente dotato per farne un simbolo di unità. Il Novecento non ha fatto altro che darle picconate, a quella costruzione, e il fascismo, per renderla più potente, l’ha completamente sfasciata. I poeti come Foscolo, che credono alle muse animatrici del pensiero, nel Novecento hanno trovato un deserto di ascolti. Io capisco meglio adesso, dopo molti anni, i maestri di questa facoltà, come Lanfranco Caretti, che era un foscolista di gran vigore e passione, più che un leopardista, mentre Leopardi, e il leopardismo, crescevano per noi assai più di Foscolo. Avverto con più senno che in Foscolo c’è una grande integrità di poesia che diventa pensiero, e questo gli dà uno straordinario equilibrio e, nelle Grazie, la suprema intatta per quanto illusoria bellezza del classicismo. Pietro: Per concludere mi colpiva quest’ultimo argomento, l’impopolarità di Foscolo oggi, fino al suo essere bersaglio di sarcasmi. I Colloqui Fiorentini, invece, sembrano registrare un’inversione di tendenza, perché i partecipanti saranno di più della scorsa edizione dedicata a Manzoni. È un’inversione di tendenza che ci interroga sulla natura di questo convegno. Biondi: Questo fenomeno non saprei come spiegarlo, se non per il convegno in sé, perché è certamente merito del Leopardi di due anni fa e del Manzoni di anno scorso, se si forma uguale attenzione o superiore per Foscolo. Io ritengo che oggi sia più difficile, o più laborioso, per le mediazioni che occorrono, spiegare Foscolo che non Leopardi, perché la poesia foscoliana è l’ultima grande poesia classica e il classico è difficile da comprendere fino in fondo, perché c’è una specie d’impalpabile confine tra la classicità e l’estinzione di se stessa. Non per niente il neoclassicismo ci porta in quella dimensione di perfezione senza vita che dicevamo prima. Il classico vive sempre in contrapposizione all’anticlassico, genera la turbolenza dell’anticlassico, che possiamo chiamare espressionismo o con altra “ismica” terminologia, ma è quello che nega la virtù formale, la sovranità della forma, instaurando al posto di un’egemonia monoformale un concorso di forme incrociate e fuse. Nello stesso tempo la bellezza classica, la bellezza foscoliana delle Grazie, per intenderci, è quella che ancora oggi impietrisce di ammirazione gli spettatori. Nella primavera del 2009, ho visitato l’ultima mostra di Canova a Forlì, al Museo San Domenico. Il pubblico era estasiato, veramente silenzioso, di fronte a questa meraviglia. Perché il Novecento lo ha abituato alla deformità, alla scomposizione della figura, alla decostruzione (e capiamo anche la bellezza della decostruzione), fino al punto che quando ci si trova di fronte alla bellezza ricomposta, come a un ritorno d’immagine che non ricordavamo più, si rimane sbigottiti. Questa esperienza è capitata anche, molti anni fa (1981), di fronte ai Bronzi di Riace, che cominciarono il loro viaggio museale da Firenze, quasi di nascosto. Poi la fama volò. Li ho visti in mezzo a un pubblico letteralmente impazzito, contagiato, che sembrava volesse reagire in questo modo: «Ma cosa ci hanno raccontato fino a adesso!?». Se la perfezione viene dal mare, da due relitti raccolti da un pescatore calabrese… Cosa ci hanno raccontato fino adesso? Cosa è stata l’impostura del Novecento? Non si era mai visto niente di più bello. E i Bronzi di Riace sono parenti atavici con il neoclassicismo di Foscolo e di Canova. Entrambi è la bellezza antica che vorrebbero riportare alla superfice del mare dell’oblio. E che cosa è questa bellezza? Lasciamo la parola a Winckelmann: «Pertanto sembra molto verosimile che nella forma dei bei corpi greci, come nelle opere dei maestri greci, vigesse una maggiore unità nella struttura, una maggiore nobiltà nella rispondenza delle parti, una maggiore pienezza delle misure, e mancassero invece la magrezza tesa e le tante cavità infossate del nostro corpo.» [J. J. Winckelmann, Pensieri sull’imitazione dell’arte greca nella pittura e nella scultura (1755-1756), in Il bello nell’arte. La natura, gli antichi, la modernità, Nuova edizione a cura di C. Franzoni, Torino, Einaudi, 2008, p. 15]. Cavità infossate, le rughe sul corpo dell’umanità. La Grecia giovinezza del mondo e la modernità come l’esito di una biologica caduta nel tempo. Edoardo: Mi pare che parte della cultura tardo ottocentesca e novecentesca abbia reagito alla declinazione sofistica dell’incanto della parola. Si è visto che cosa in nome di una purezza enunciativa si è in grado di fare. Non è un caso che la nazione più neoclassicista d’Europa, la Germania ottocentesca di Hölderlin, quella che costruiva Berlino come Atene, sia quella che poi ha concepito i campi di sterminio. Questo è un fattore che certamente ha suscitato una forte reazione e contrapposizione del Novecento. Ma d’altra parte noi oggi stiamo tornando a una congiuntura simile a quella di Foscolo, Leopardi e Manzoni, perché siamo alla fine di un cosmo interpretativo della realtà, che palesa tuttavia la necessità di punti di riferimento. Una delle cose che mi ha sempre colpito in Foscolo e Manzoni è questa enorme sete di paternità. Tanti uomini di fine Settecento e inizio Ottocento vivono a esempio nei confronti di Napoleone il tradimento di un grande padre liberatore. Biondi: Questa è anche l’illusione ottica di un giacobinismo senza patria propria. I giacobini italiani non sono i giacobini francesi. Sono i giacobini di un’altra nazione su cui il giacobinismo francese, che stabilisce una qualche forma di fraternità ideologica, si presenta però come dominatore. Il giacobinismo italiano è destinato a essere umiliato. E i giacobini italiani devono eroicamente resistere al nichilismo delle delusioni, altrimenti dovrebbero rinunciare in toto al portato ideologico della Rivoluzione Francese. Perché la Rivoluzione Francese arriva in Italia come forma di conquista imperiale. È dunque un’amara, contraddittoria, posizione quella da presidiare! Edoardo: L’altra cosa che mi colpisce è relativa ai Sepolcri, in cui mi pare che la religione del sepolcro sia come il tentativo d’impostare in senso orizzontale il cammino verticale di Dante. Cosa fa Omero quando interroga le tombe se non formalmente quello che fa Dante con le anime: gli chiede come hanno vissuto sulla terra. Anche qui è interessante la costante tensione di Foscolo a identificarsi con un modello, Alfieri, Parini, Dante stesso e al contempo una forte diversità rispetto al viaggio dantesco, il quale è un viaggio personale con la mediazione sempre di un punto autorevole, che sia Virgilio o Beatrice. Mentre Foscolo si pone come Omero, cioè da solo a interrogare le urne. Biondi: Infatti è Omero il personaggio scelto da Foscolo. La poesia nasce sulle tombe degli eroi. Anche qui la parola eroe ha perso il suo significato, ma soprattutto il suo peso, il valore. Pietro: Sa a chi piace la parola eroe, ancora? Ai bambini delle medie quando studiano l’epica, perché per loro “eroe” è ancora qualcosa. Poi tende a diventare posticcio, a essere avvertito come artificioso, monumentale. Biondi: Ecco, lei, Pietro, ha toccato un altro elemento che va a detrimento di Foscolo, oggi: la monumentalizzazione della memoria. Foscolo ha attivato con i Sepolcri la monumentalizzazione della memoria. Egli ha inventato Santa Croce: il pantheon italiano. È il più alto concentrato di sapienza italiana. E quando De Sanctis, Ministro della Pubblica Istruzione, fa il grande gesto di far ritornare Foscolo in Italia, si deve ricongiungere in qualche modo al luogo che Foscolo stesso ha creato. Da una chiesa francescana l’ha trasformata in un tempio di un altro culto: il culto nazionale del genio italiano. Ci sono tutti Galileo, Machiavelli, Gentile (tra i grandi del ’900 viene sepolto in Santa Croce). Le ossa del Foscolo tornano a Firenze nel 1871, in questa cerimonia che deve essere stata veramente di grande commozione. E il discorso di De Sanctis per l’occasione è grandioso: sono momenti molto alti. Che il Novecento ha buttato via. Per andare contro la retorica, ha gettato cose preziose, processi di costruzione della memoria che passavano anche attraverso l’eloquenza, di cui non si può fare totalmente a meno. Perché un codice è legato a certi momenti del collettivo. Foscolo è stato accompagnato alla tomba da cinque persone, fra cui c’era un esule cesenate che si chiamava Francesco Lelli Mami. L’altro giorno durante una cerimonia ho incontrato gli ultimi due esponenti della famiglia Lelli Mami, che sono padre e figlia e il padre ha scritto una piccola biografia dell’amico del Foscolo. Stiamo parlando di una famiglia aristocratica della Cesena dell’Ottocento, che è sopravvissuta fino a ora, legata in questo caso proprio fisicamente agli ultimi mesi della vita di Foscolo e testimone di quella morte illacrimata. Leggiamo l’accompagno funebre nel biografo Saponaro: «I funerali, funerali di povero, seguirono il 18 settembre, giorno quasi anniversario – undici anni – del suo arrivo in Inghilterra. Gli uomini famosi e fastosi che gli preparavano allora il carro trionfale non c’erano adesso intorno al suo cataletto. Dietro al feretro andavano, insieme con la figliola, cinque amici, il canonico Riego, il generale de Meester, il dottore Negri, Mami, e Roscoe. […] Fu sepolto nel piccolo cimitero di Chiswick, secondo la sua volontà. Sotto una nuda pietra. […] Verrà tra dieci anni a inginocchiarsi Giuseppe Mazzini.» (Parte seconda, Il dramma, p. 454). Pietro: Questo è un aspetto che mi ha sempre colpito. Facevo proprio questa mattina in classe A Zacinto e mi sono reso conto in un attimo che l’ha scritta venticinque anni prima di morire, ben prima di andare in esilio. È come una profezia, un presentimento. Biondi: È un’autoprofezia che si adempie, perché lui lo sa di essere un cuore inquieto, un nomade e che morirà solo, o quasi. Del resto, come tutti. Pietro: In fondo è un esilio esistenziale, non meramente politico. Biondi: Esistenziale e poi anche istituzionale. Un’istituzione politica dell’Ottocento, l’esilio, che poi viene riproposto nel Novecento con l’esilio antifascista e si continuano a chiamare esuli, in Francia e in America. Edoardo: Fino poi anche alle derive, per cui il termine esilio si svaluta. Biondi: Addirittura oggi non si dovrebbe più parlare di esilio. Quando Giuseppe Prezzolini andò in esilio, nel 1923, negò di essere in esilio. Disse che era stata una libera scelta. Prezzolini è una grande personalità, che è stata recuperata ultimamente. Essendo amico personale di Mussolini, nel ’23 decise di andarsene, perché così sarebbe stato libero, proprio secondo un’idea foscoliana. Andò in un paese di cui non conosceva la lingua e lì visse tutta la sua vita, a New York, fino al suo rientro in Italia nel 1962. Nel suo diario scrisse che era diventato amico delle nuvole, perché erano quelle che vedeva dalla sua casa newyorkese. E le nuvole vanno, vengono, non hanno patria, sono forse la patria di chi non ne ha più una. In Italia si sentì di nuovo suddito e se ne andò in Svizzera. Perché il libero cittadino va dove gli è garantita la libertà. Questo tipo di esilio, che si nega come tale, in realtà afferma che ogni paese è un paese degno di essere vissuto, se ti consente di essere un uomo libero nella tua dignità. Se il tuo paese non ti consente di essere tale, allora sei in esilio nel tuo paese, non altrove. L’esilio è materia da trattare con molta misura, proprio perché esule ha un significato soltanto nella dimensione che mette in gioco la tua libertà, allora sì, che si sceglie di andare altrove. Perché l’esilio ha anche questo significato: per proteggere la patria si rinuncia alla patria. Nel discorso di De Sanctis, il Foscolo che ritornava a Santa Croce, tra due ali di folla commossa, risarcisce l’illacrimata sepoltura. Durante la quale c’è questo personaggio che mi commuove, questo cesenate esule tra i cinque amici che lo aiutano nella miseria, in una certa decadenza anche umana di Foscolo. È un bellissimo personaggio. Si chiamava, lo ripeto, Francesco Mami. Pietro e Edoardo: Grazie, professore. Biondi: Grazie, a lei Pietro, a lei Edoardo. E non per il cerimoniale dei saluti. L’architettura del nostro dialogo si è retta sulle domande, ed erano le vostre.
Scarica