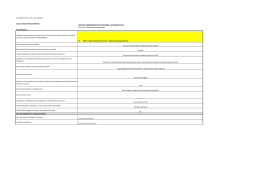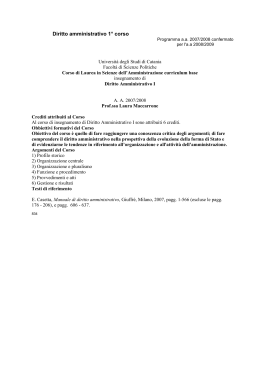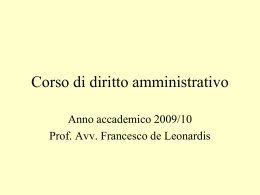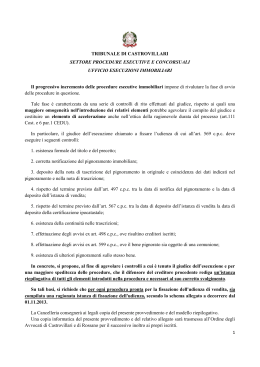www.ildirittoamministrativo.it
OSSERVATORIO SUL PROCESSO AMMINISTRATIVO
AGGIORNATO AL 30 GIUGNO 2011
A CURA DI DONATELLA TORREGROSSA
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 23 maggio 2011, n. 3078
Anche dopo l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, l’oggetto del
giudizio di ottemperanza non è qualsivoglia provvedimento amministrativo adottato
dopo la sentenza del giudice e relativo al contenzioso oggetto del pregresso giudizio di
cognizione, ma la verifica della corretta attuazione del giudicato (art. 34, co. 1, lett. e),
art. 112, co. 1, c.p.a.), e dunque la verifica se il soggetto obbligato ad eseguire la
sentenza vi abbia o meno dato puntuale esecuzione.
Anche dopo l’entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo, il
rapporto di incidenza fra autotutela amministrativa e giudicato del g.a. non deve essere
risolto aprioristicamente (con l’affermazione assoluta della prevalenza del secondo sul
primo), ma affidato in concreto al riscontro dell’esatta portata del medesimo giudicato
e del bene della vita riconosciuto; sicché, ove il giudicato non inibisca l’esercizio dei
tratti liberi dell’azione amministrativa (secondo la regola generale sancita adesso
dall’art. 34, co. 2, primo periodo, c.p.a.), ovvero ne consenta espressamente la
riedizione, è inconfigurabile una situazione di inottemperanza (nella triplice enfatica
epifania della mancata esecuzione, violazione o elusione).
Con la sentenza in esame il Supremo Consesso della giustizia amministrativa ha definito
l’ambito di operatività del ricorso per ottemperanza avverso i provvedimenti della P.A. violativi
o elusivi del giudicato adottati in esercizio del potere di autotutela.
L’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a., dispone che, in caso di accoglimento del ricorso di
ottemperanza, il giudice “dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato”.
Si tratta di un ulteriore ed eventuale contenuto di accertamento della sentenza resa in sede di
ottemperanza.
La disposizione va letta in combinato disposto con l’art. 21 septies Legge n. 241 del 1990
(introdotto dalla Legge n. 15 del 2005), che prevede la nullità del provvedimento
amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato, attribuendo per le relative
questioni la giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo.
1
www.ildirittoamministrativo.it
La norma, peraltro, lasciava aperta la questione interpretativa se detta nullità poteva essere fatta
valere anche in sede di ottemperanza ovvero fosse necessario esperire un ricorso ordinario
dinnanzi al giudice amministrativo, seppure in sede di giurisdizione esclusiva.
Sul punto si erano sviluppate due differenti linee interpretative.
Secondo un primo filone giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 2008, n. 2872) il
giudizio di ottemperanza era esperibile unicamente per le ipotesi di inerzia totale
dell’Amministrazione ovvero di esecuzione parziale del giudicato, dovendosi, invece, esperire
un ricorso ordinario di cognizione dinnanzi al giudice amministrativo nelle ipotesi di
provvedimenti adottati in violazione o elusione di giudicato, al fine di ottenere una pronuncia di
nullità, resa in sede di giurisdizione esclusiva.
A tale soluzione interpretativa si è contestato che avrebbe comportato un pregiudizio
dell’effettività della tutela giurisdizionale, determinando una dilatazione dei termini processuali
per l’ottenimento del bene anelato.
A fronte di tali considerazioni, la dottrina ha ritenuto che permanesse in ogni caso la possibilità
di esperire il ricorso per ottemperanza, essendo il riferimento alla giurisdizione esclusiva
finalizzato unicamente ad escludere la giurisdizione esclusiva del giudice ordinario allorquando
la situazione giuridica soggettiva incisa dal provvedimento nullo sia di diritto soggettivo.
A tale filone interpretativo ha aderito la più recente giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato,
sez. V, 8 febbraio 2010, n. 556), affermando che il giudizio di ottemperanza e quello di nullità
possono concorrere, in quanto hanno un diverso finalismo: in tema di rapporti tra l’azione volta
all’ottemperanza di un giudicato amministrativo e quella prevista innovativamente dall’art. 21septies della L. n. 241/1990, secondo cui le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti
amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo, “si rileva, innanzitutto, che i due rimedi possono concorrere in ragione del loro
diverso finalismo, che si traduce anche in una differente disciplina processuale. In particolare, il giudizio in
ottemperanza non ha per oggetto esclusivo gli atti, ma può investire anche i comportamenti, commissivi o omissivi,
dell’amministrazione; inoltre esso soggiace a peculiari regole processuali ed è espressione di una giurisdizione
estesa al merito, consentendo, per diritto vivente, anche la nomina di un commissario ad acta che agisca in
sostituzione dell’amministrazione inottemperante. Per contro, il giudizio sulla nullità del provvedimento per
violazione o elusione del giudicato, innovativamente introdotto dalla riforma del 2000, ancorché inerente
2
www.ildirittoamministrativo.it
l’esercizio di una potestà giurisdizionale esclusiva, concerne sempre un atto amministrativo (atteso che la nullità non
è predicabile di comportamenti) e ha natura di un processo di accertamento che segue il rito ordinario. È diverso poi
nelle due azioni il modo in cui è viene in rilievo l’eventuale invalidità del provvedimento adottato in violazione o
in elusione del giudicato, atteso che nell’ottemperanza il vizio dell’atto è esaminato in via indiretta e strumentale,
ovvero al fine di verificare se l’amministrazione abbia, o no, correttamente adempiuto l’obbligo promanante dal
comando giurisdizionale posto in esecuzione, mentre nel caso della radicale patologia di cui al predetto art. 21septies, il provvedimento costituisce sempre il principale e diretto oggetto della cognitio giurisdizionale”.
La disciplina processuale in tema di nullità del provvedimento amministrativo è adesso prevista
nell’art. 31, comma 4, c.p.a., in cui il legislatore, recependo l’orientamento più recente della
giurisprudenza amministrativa, ha statuito che “la domanda volta all’accertamento delle nullità previste
dalla legge si propone entro il termine di decadenza di centottanta giorni. La nullità dell’atto può essere sempre
opposta dalla parte resistente o rilevata d’ufficio dal giudice”.
In altri termini, il legislatore, facendo prevalere le esigenze di stabilità e certezza
sull’imprescrittibilità delle azioni di nullità, così come previsto dall’ordinamento civile, ha
previsto il termine decadenziale di 180 giorni per la proposizione della domanda di
accertamento della nullità del provvedimento, ammettendo, peraltro, l’imprescrittibilità delle
eccezioni di nullità, opponibili dalla parte resistente e rilevabili d’ufficio da parte del giudice.
Con particolare riguardo ai poteri di rilevamento del giudice, permane il dubbio interpretativo
circa i limiti del suo esercizio, che dovrebbero essere circoscritti, secondo quanto affermato da
copiosa giurisprudenza ordinaria, alle ipotesi di nullità rilevabili dagli atti di causa senza la
necessità di procedere ad ulteriori indagini.
Detto principio dovrebbe ritenersi operativo anche per il giudizio amministrativo.
L’art. 133, comma1, lett. a), n. 5, ha altresì previsto la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo con riferimento alle controversie in materia di “nullità del provvedimento
amministrativo adottato in violazione o elusione di giudicato”.
Infine, l’ultimo periodo dell’art. 31, comma 4, c.p.a. esclude che le disposizioni previste in tema
di declaratoria di nullità si applicano alle ipotesi di nullità di cui all’art. 114, comma 4, lett. b),
ossia per violazione o elusione di giudicato, per le quali restano ferme le disposizione sul
giudizio di ottemperanza.
3
www.ildirittoamministrativo.it
Peraltro, ai fini dell’esatto inquadramento della nozione di provvedimento violativo o elusivo di
giudicato, contro il quale può essere attivato il giudizio di ottemperanza nel termine di
prescrizione dell’actio iudicati, occorre un’ulteriore puntualizzazione. Afferma, infatti, il Consiglio
di Stato, nella sentenza in esame, che “l’intento del nuovo codice di concentrare nel giudizio di
ottemperanza tutte le questioni che sorgono dopo un giudicato, in relazione alla sua esecuzione, non si spinge,
però, sino al punto di affermare che qualsivoglia provvedimento adottato dopo un giudicato, e in conseguenza di
esso, debba essere portato davanti al giudice dell’ottemperanza; infatti il c.p.a. dispone che presupposto per il
giudizio è una inottemperanza, e che ci si rivolge al giudice dell’ottemperanza oltre che in caso di inerzia totale o
parziale, in caso di atti violativi o elusivi del giudicato. Laddove l’atto nuovo successivo al giudicato non sia
elusivo o violativo, ma autonomamente lesivo, perché copre spazi lasciati in bianco dal giudicato, va azionato il
rimedio del ricorso ordinario”.
In tal senso si è pronunciata la prima giurisprudenza successiva al c.p.a., la quale, a mente degli
artt. 74 e 114, co. 3, ha osservato che, “anche dopo l’entrata in vigore del codice del processo
amministrativo, l’oggetto del giudizio di ottemperanza non sia qualsivoglia provvedimento amministrativo
adottato dopo la sentenza del giudice e relativo al contenzioso oggetto del pregresso giudizio di cognizione, ma sia
la verifica della corretta attuazione del giudicato (art. 34, co. 1, lett. e), art. 112, co. 1, c.p.a.), e dunque la
verifica se il soggetto obbligato ad eseguire la sentenza vi abbia o meno dato puntuale esecuzione (cfr. Cons. St.,
ad. plen., 9 marzo 2011, n. 2, relativa a provvedimenti amministrativi e normativi sopravvenuti disciplinanti, a
valle degli effetti cassatori di un giudicato, la rinnovazione di operazioni concorsuali; sez. IV, 30 novembre
2010, n. 8363, relativa a provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 43 t.u. espr. in esecuzione di giudicato di
annullamento di atti ablatori; sez. VI, 15 novembre 2010, n. 8053, relativa a giudicato che si limita a
dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza di autorizzazione all’esercizio di attività
imprenditoriale, ritenendo illegittimo l’arresto procedimentale; in tutti questi casi è stata esclusa l’ammissibilità
dell’azione di ottemperanza)”.
In definitiva, le ipotesi di violazione o elusione di giudicato potranno configurarsi non solo
laddove dal giudicato discendano prescrizioni puntuali nei confronti dell’Amministrazione, ma
anche qualora, residuando un margine di discrezionalità in capo all’Amministrazione, questa lo
utilizzi riproducendo i medesimi vizi di legittimità già accertati nel pregresso giudizio ovvero
adotti un provvedimento che, al fine di pervenire al medesimo risultato, costituisca un
4
www.ildirittoamministrativo.it
manifesto sviamento di potere, in quanto esercita una potestà formalmente pubblica in palese
carenza dei presupposti che la giustificano.
Sulla scorta di tali considerazioni, il Collegio ha ritenuto nel caso di specie inammissibile la
domanda di parte ricorrente volta a sollecitare il controllo del giudice dell’ottemperanza
sull’esercizio, da parte della stazione appaltante, del potere di abrogazione ex nunc degli atti di
gara, per sopravvenute legittime ragioni di opportunità amministrativa (il mutamento degli
indirizzi di politica culturale e museale), nonché contabile – finanziaria (l’aumento dei costi di
manutenzione degli immobili, dei costi base dell’appalto, la necessità di procacciarsi la provvista
economica per gli investimenti futuri), in quanto l’Amministrazione, invero, non aveva
caducato il bando di gara (e gli atti conseguenti) con intento elusivo del giudicato ad essa
sfavorevole, bensì per garantire, alla luce delle obbiettive sopravvenienze sopra descritte, la
miglior tutela degli interessi pubblici di settore coinvolti, senza, peraltro, che fossero rinvenibili
preclusioni in tal senso nella sentenza di annullamento dell’aggiudicazione.
Più nello specifico, il Collegio ha affermato “tutti gli atti di gara, a partire dal bando per finire
all’aggiudicazione definitiva, possono formare oggetto di ritiro in via di autotutela decisoria in funzione di
riesame. Tale principio è stato consacrato dall’art. 11, co. 9, del d.lgs. n. 163 del 2006 – c.d. codice dei contratti
pubblici, inapplicabile ratione temporis – che nel disciplinare il termine finale per la stipulazione del contratto fa
comunque salvo il potere di autotutela dell’amministrazione: la disposizione chiarisce quale sia, per la stazione
appaltante, la portata del vincolo derivante dall’intervenuta aggiudicazione”.
In altri termini, l’Amministrazione non è incondizionatamente tenuta alla stipulazione del
contratto, ma l’impegno conseguente alla aggiudicazione definitiva può essere limitato solo
attraverso le procedure tipiche che regolano l’esercizio del potere di autotutela, ora codificate
dalla legge n. 241 del 1990, come novellata dal 2005.
Peraltro, precisa il Collegio, l’autotutela in materia di appalti pubblici non riguarda solo
l’aggiudicazione, ma anche gli altri atti di gara, e soggiace alle regole elaborate dalla
giurisprudenza ed ora codificate dalla Legge n. 15 del 2005: “già prima della l. n. 15 del 2005 e del
codice dei contratti pubblici, si è riconosciuto che nei procedimenti di gara, al di là degli atti tipici finalizzati allo
scopo di verificare la legittimità dell’iter di formazione del contratto (quali l’approvazione e l’eventuale controllo),
dovesse ritenersi vigente il generale principio dell’autotutela decisoria; pertanto, in aggiunta agli strumenti tipici di
verifica immediata dell’attività compiuta dall’amministrazione, deve ritenersi consentito l’esercizio del generale
5
www.ildirittoamministrativo.it
potere di riesame in un momento successivo alla conclusione del procedimento; dunque l’estrinsecazione del potere
di autotutela della p.a. non incontra alcun limite insuperabile nella convenzione intervenuta con il privato: i
diritti e i doveri delle parti derivanti dall’accordo non sottraggono l’atto amministrativo presupposto al potere di
autotutela pubblicistica (cfr. ex plurimis Cons. St., sez. V, 12 febbraio 2010, n. 743)”.
“L’immanenza del potere di autotutela decisoria – prosegue il Collegio - trova fondamento: a) nel principio
costituzionale di buon andamento ed imparzialità della funzione pubblica, senza che, a tal fine, occorra una
diffusa motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico; b) nel principio di diritto comune enucleato
dall’art. 1328 c.c., in base al quale la proposta di concludere il contratto (qual è l’atto di indizione della gara,
ancorché espressa in forma pubblicistica e subordinata all’osservanza delle regole procedimentali per la scelta del
contraente), è sempre revocabile fino a che il contratto non sia concluso (cfr. ex plurimis Cons. St., sez. V, 12
febbraio 2010, n. 743)”.
Tali caratteristiche del potere di autotutela decisoria, coordinate con i vincoli cassatori,
rinnovatori e conformativi scaturenti dal giudicato di annullamento degli atti di gara, hanno
portato nel caso di specie alla statuizione definitiva per cui “anche dopo l’entrata in vigore del nuovo
codice del processo amministrativo, il rapporto di incidenza fra autotutela amministrativa e giudicato del g.a. non
deve essere risolto aprioristicamente (con l’affermazione assoluta della prevalenza del secondo sul primo), ma
affidato in concreto al riscontro dell’esatta portata del medesimo giudicato e del bene della vita riconosciuto; sicché,
ove il giudicato non inibisca l’esercizio dei tratti liberi dell’azione amministrativa (secondo la regola generale
sancita adesso dall’art. 34, co. 2, primo periodo, c.p.a.), ovvero ne consenta espressamente la riedizione, è
inconfigurabile una situazione di inottemperanza (nella triplice enfatica epifania della mancata esecuzione,
violazione o elusione)”.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 27 maggio 2011, n. 3190
Il controinteressato all’accesso si caratterizza per elementi del tutto peculiari rispetto
alla figura generale di controinteressato ad ogni procedimento amministrativo. Difatti,
l’art. 22 Legge n. 241 del 1990, così come modificato dalla Legge n. 15 del 200, impone
di riconoscere la qualità di controinteressato non già a tutti coloro che, a qualsiasi
titolo, siano nominati o comunque coinvolti nel documento oggetto dell'istanza
ostensiva, ma solo a coloro che per effetto dell'ostensione vedrebbero pregiudicato il
loro diritto alla riservatezza.
La veste di controinteressato in tema di accesso è, perciò, una proiezione del valore
della riservatezza, e non già della mera oggettiva riferibilità di un dato alla sfera di un
certo soggetto.
6
www.ildirittoamministrativo.it
Deve ritenersi consentita nel giudizio di accesso l'integrazione della iniziale
motivazione dell'atto di diniego, in quanto occorre tener presente che il giudizio in
materia di accesso è sostanzialmente rivolto ad accertare la sussistenza o meno del
titolo all'accesso nella specifica situazione alla luce dei parametri normativi,
indipendentemente dalla maggiore o minore correttezza delle ragioni addotte
dall'Amministrazione per giustificarne il diniego.
La sentenza in esame risulta estremamente utile per comprendere l’esatta portata
dell’integrazione del contraddittorio e della motivazione da parte del P.A. nel giudizio
sull’accesso.
Con particolare riguardo al primo profilo processuale, il Collegio ha individuato i presupposti
affinché possa affermarsi la completezza del contraddittorio nel giudizio sull’accesso,
prendendo in esame, in particolar modo, la figura del controinteressato e il diritto di questo alla
comunicazione dell’istanza di accesso.
Punto di partenza dell’analisi condotta dal Supremo Consesso della giustizia amministrativa è il
disposto dell'art. 22, comma 1, lett. c), legge n. 241/1990 (come sostituito con la legge n.
15\2005), ai sensi del quale, per “controinteressati” in materia di accesso devono intendersi “tutti i
soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio
dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”.
Da tale previsione si desume facilmente che il controinteressato all’accesso si caratterizza per
elementi del tutto peculiari rispetto alla figura generale di controinteressato ad ogni
procedimento amministrativo: “la novella definizione appena riportata ha un’indubbia portata innovativa,
in quanto impone di riconoscere la qualità di controinteressato (cfr. sul punto C.d.S., VI, n. 3601 del 2007)
non già a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano nominati o comunque coinvolti nel documento oggetto
dell'istanza ostensiva, ma, appunto, solo a coloro che per effetto dell'ostensione vedrebbero pregiudicato il loro
diritto alla riservatezza. Non basta, perciò, che taluno venga chiamato in qualche modo in causa dal documento
in richiesta, ma occorre in capo a tale soggetto un quid pluris, vale a dire la titolarità di un diritto alla
riservatezza sui dati racchiusi nello stesso documento. La veste di controinteressato in tema di accesso è una
proiezione, perciò, del valore della riservatezza, e non già della mera oggettiva riferibilità di un dato alla sfera di
un certo soggetto”.
Le ragioni di tale peculiarità sono da ravvisarsi nella natura autonoma e speciale del
procedimento di accesso rispetto agli altri procedimenti, come risulta del resto dalla sua natura
vincolata e non discrezionale, in cui all’amministrazione è preclusa qualsiasi valutazione
7
www.ildirittoamministrativo.it
sull’individuazione dei controinteressati, nonché sulle modalità di esercizio del diritto di
accesso.
Difatti, l’amministrazione dovrà verificare l’esistenza di controinteressati esclusivamente alla
luce del diritto alla riservatezza, da cui discende che non tutti i dati riferibili ad un soggetto sono
per ciò stesso rilevanti, “ma solo quelli rispetto ai quali sussista, per la loro inerenza alla personalità
individuale, o per i pregiudizi che potrebbero discendere da una loro diffusione, una precisa e ben qualificata
esigenza di riserbo”.
Una volta che l’amministrazione abbia verificato la legittimazione del richiedente e l’assenza di
controinteressati, dovrà consentire l’accesso in forma piena e senza operare alcuna restrizione.
Di contro, laddove risulta l’esistenza di controinteressati, la P.A., a cui sia indirizzata la richiesta
di accesso, ai sensi dell’art. 3 D.P.R. n. 184/2006, dovrà darne comunicazione a detti
controinteressati. Questi ultimi potranno presentare opposizione e comprimere il diritto di
accesso solamente nell’ipotesi in cui il diritto alla riservatezza rilevabile sia di portata maggiore
rispetto al diritto di accesso.
Tali previsioni normative inerenti il procedimento amministrativo in materia di accesso
finiscono inevitabilmente per riverberare i loro effetti sul piano processuale, condizionando la
valutazione del giudice ai fini dell’accertamento dell’integrità del contraddittorio.
Difatti, la veste di contraddittori necessari nel giudizio sull’accesso potrà riconoscersi
esclusivamente solo a coloro che risultano titolari di un “diritto alla riservatezza”, che potrebbe
essere compromesso dall’esercizio del diritto di accesso.
Alla stregua di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha totalmente disatteso l’orientamento
giurisprudenziale che, antecedentemente alla novella dell’art. 22 legge n. 241/1990 avvenuta con
la legge n. 15/2005, tendeva a considerare come controinteressati tutti i soggetti determinati cui
– semplicemente – si riferivano i documenti richiesti in accesso, ossia tutti quei soggetti che,
indipendentemente da una lesione al loro diritto alla riservatezza, potevano subire per qualsiasi
ragione un pregiudizio ai loro interessi riconosciuti dall’ordinamento.
Ne è conseguito nel caso di specie che il Collegio ha ritenuto, a fronte dell’istanza di ostensione
documentale avanzata da un Comune alla società affidataria del servizio pubblico di
distribuzione del gas ai fini dell’avvio ad una gara tesa a pervenire ad un nuovo affidamento del
servizio pubblico, non configurabile la posizione di controinteressati in capo alle
8
www.ildirittoamministrativo.it
Amministrazioni comunali limitrofe consorziate: “si deve notare che nessuno degli elementi oggetto della
concreta richiesta di accesso risulta incorporare un qualsivoglia aspetto di riservatezza per le altre
Amministrazioni comunali consorziate; né potrebbe rivestire di per sé importanza il semplice fatto che l’impianto
serva anche le loro municipalità. I dati di cui si tratta sono per loro natura assai lontani dalla sfera personale,
non si sostanziano certo in informazioni "relative alla persona" degli enti in questione (cfr. l’art. 4, comma 1,
lett. b), del d.lgs. n. 196 del 2003), né risultano sotto alcun profilo concernere "gli interessi professionale,
finanziario, industriale e commerciale" (cfr. l’art. 24, comma 6, lettera d), della legge n. 241\1990) delle
medesime persone giuridiche pubbliche. Del tutto apodittica è, infatti, l’affermazione difensiva (memoria di Estra
Reti Gas del 3\2\2011, pag. 17) per cui la diffusione delle informazioni richieste "finirebbe per falsare lo
svolgimento delle procedure selettive nei Comuni vicini", asserto il cui carattere sostanzialmente immotivato (dal
punto di vista degli interessi comunali) é tanto più rivelatore per il fatto che l’obiezione si inserisce in una
dialettica processuale effusasi senza risparmio di energie. Lo stesso vale per l’opposizione all’accesso mossa dai
Comuni interpellati adducendo che questo avrebbe pregiudicato il corretto e regolare svolgimento della futura gara
di ambito (…). Concludendo, poiché l’accesso in quanto tale non risulta poter compromettere alcun "diritto alla
riservatezza" in capo ai Comuni limitrofi, ad essi non può riconoscersi veste di contraddittori necessari.
L’eccezione va pertanto respinta”.
Chiarita la portata della nozione di controinteressato nel giudizio sull’accesso, il Consiglio di
Stato è poi passato ad esaminare l’altro profilo processuale dell’integrazione della motivazione
in sede processuale.
Anche tale questione presenta peculiarità importanti, condizionati dalla natura speciale del rito
in materia di accesso, che la giurisprudenza prevalente inquadra nello schema logico del giudizio
sul rapporto: “osserva la Sezione che, secondo l’impostazione giurisprudenziale più coerente con
l’inquadramento del rito speciale in materia di accesso nello schema logico del giudizio sul rapporto,
l'integrazione della iniziale motivazione dell'atto di diniego deve ritenersi consentita in
questo particolare tipo di giudizio (C.d.S., V, 11 maggio 2004, n. 2966; IV, n.3620 del
2.7.2002). Infatti, occorre "tener presente che il giudizio in materia di accesso di cui all'art. 25 L. 7.8.1990
n.241, anche se si atteggia come impugnatorio nella fase della proposizione del ricorso, in quanto rivolto contro
l'atto di diniego o avverso il silenzio diniego formatosi sulla relativa istanza, ed il ricorso è da esperire nel termine
perentorio di 30 giorni (V. la decisione di questo Consiglio, A. P. n.16 del 24.6.1999), è sostanzialmente
rivolto ad accertare la sussistenza o meno del titolo all'accesso nella specifica situazione alla luce dei parametri
9
www.ildirittoamministrativo.it
normativi, indipendentemente dalla maggiore o minore correttezza delle ragioni addotte dall'Amministrazione
per giustificarne il diniego (V. la decisione di questo Consiglio sez. VI n. 2542 del 9.5.2002). Tanto è vero
che, anche nel caso di impugnativa del silenzio diniego sull'accesso, l'Amministrazione può dedurre in giudizio le
ragioni che precludono all'interessato di avere copia o di visionare i relativi documenti, e la decisione da assumere,
che deve comunque accertare la sussistenza o meno del titolo all'esibizione (ai sensi dell'ultimo comma del
menzionato art. 25), si deve formare tenendo conto anche di tali deduzioni(V., in materia di silenzio diniego su
istanza di accesso, la decisione di questo Consiglio, sez. IV, n.3620 del 2.7.2002)" (in termini C.d.S., V, n.
2966\2004 cit.)”.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 31 maggio 2011, n. 3252
I termini del processo amministrativo e i criteri di computo degli stessi sono
regolamentati dal combinato disposto degli artt. 155 c.p.c. e 52 c.p.a.
Quest’ultima disposizione, in particolare, statuisce, al comma 3, che “il termine fissato
dalla legge o dal giudice per l’adempimento è prorogato di diritto al primo giorno
seguente non festivo”; mentre, nel caso di termini che si computano a ritroso, ai sensi
del comma 4, “la scadenza è anticipata al giorno antecedente non festivo”.
Tale previsione, la quale si applica anche nell’ipotesi di giorni liberi, costituisce la
traduzione normativa di un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza tanto
amministrativa quanto civile, per cui il dies a quo, nelle ipotesi di conteggio a ritroso,
non va computato, mentre il dies a quem, se coincidente con un giorno festivo, va
arretrato al primo giorno non festivo antecedente e ciò al fine di non abbreviare il
margine temporale ritenuto necessario dal legislatore per approntare le difese in sede
processuale.
La proroga prevista per i giorni di scadenza festivi, ai sensi dell’art. 52, comma 5, c.p.a.,
si applica anche ai termini che scadano nella giornata del sabato. Peraltro, tale regola
“vale solo per i termini che si calcolano in avanti, e non anche per i termini che si
calcolano a ritroso”.
Dall’art. 54, comma 1., c.p.a. devono desumersi importanti ricadute sul piano
processuale, consistenti nello specifico nel fatto che a) i termini di deposito di
documenti, memorie e repliche sono imposti a pena di decadenza; b) il deposito tardivo
è possibile solo se c’è un autorizzazione del collegio che si atteggia a rimessione in
termini per errore scusabile, come ipotesi speciale di essa, di cui condivide i
presupposti; c) va comunque garantito il contraddittorio.
Essendo la revocazione una impugnazione a critica vincolata, il motivo di revocazione
ha la funzione di passaggio obbligato; ne consegue l’impossibilità di integrazione o
modificazione e, a maggior ragione, di introduzione di nuovi motivi nel corso del
giudizio se ciò non avvenga nel rispetto delle formalità di rito e del termine
decadenziale previsto.
10
www.ildirittoamministrativo.it
È inammissibile l’istanza di revocazione qualora il paventato travisamento di fatto,
costitutivo dell’abbaglio dei sensi, cade su una serie di circostanze che hanno costituito
punti controversi su cui la sezione si è espressamente pronunciata, e si traduce, in
realtà, in una diversa (asseritamente erronea) valutazione delle risultanze probatorie a
suo tempo acquisite al thema decidendum.
L’art. 26, comma 2, c.p.a. costituisce ipotesi speciale rispetto all’archetipo divisato
dall’art. 96, co. 3, c.p.c. (introdotto dalla l. n. 69 del 2009); quest’ultima norma, infatti,
non tipizza i presupposti applicativi della condanna officiosa della parte soccombente
al pagamento della somma equitativamente determinata.
Ne consegue che la previsione del pagamento della somma in esame: a) non riguarda le
spese di lite (quantificate con la condanna alle spese secondo la logica propria delle
disposizioni sancite dagli artt. 91 e 92 c.p.c.); b) non riguarda la responsabilità da lite
temeraria (tipizzata dai commi 1 e 2 dell’art. 96 c.p.c.); c) non riguarda la pretesa
sostanziale (sulla quale statuisce il contenuto dispositivo della sentenza). d) non è
configurabile quale sanzione pubblica atteso che il gettito non è devoluto all’erario e
non sono indicati i limiti o i criteri oggettivi di liquidazione.
La misura pecuniaria di cui all’art. 26, comma 2, c.p.a. costituirebbe un indennizzo per
il “danno lecito da processo”, cioè il nocumento che la parte vittoriosa ha subito per
l’esistenza e la durata del processo, anche se la controparte non ha agito o resistito in
mala fede o senza prudenza.
Costituiscono utili parametri di riferimento per la determinazione equitativa prevista dall’art.
26, comma 2, c.p.a. gli eventuali utili conseguiti a cagione della ingiusta attivazione o
resistenza nel processo e della sua durata, accanto ovviamente, a più tradizionali criteri,
come quello del valore della controversia ovvero al riferimento ad una percentuale delle
spese di lite sostenute dalla parte vincitrice.
La sentenza in esame si impone all’attenzione dell’interprete per l’indiscutibile rilievo pratico
delle questioni ivi esaminate.
In essa, infatti, il Consiglio di Stato procede ad un’attenta e compiuta disamina della disciplina
dei termini del processo amministrativo, così come risultante dalla combinazione degli artt. 155
c.p.c. e 52 c.p.a., quest’ultima recante talune precisazioni in tema di giorno festivo e di sabato, e
della normativa in tema di spese di giudizio per lite temeraria di cui all’art. 26, comma 2., c.p.a.,
riprendendo integralmente le argomentazioni a cui la medesima Sezione è recentemente
pervenuta con la sentenza n. 3083 del 23 maggio 2011.
Procedendo secondo l’ordine indicato nella sentenza, occorre, in via prodromica, prendere in
esame la questione interpretativa relativa all’individuazione dei termini del processo
11
www.ildirittoamministrativo.it
amministrativo ed ai criteri di computo degli stessi, aprendo una breve parentesi sulla relativa
normativa, così come disegnata dalla combinazione degli artt. 155 c.p.c. e 52 c.p.a.
Il richiamo alla normativa processualcivilistica discende – come chiarisce lo stesso Collegio
nella sentenza in rassegna - dal rinvio operato dall’art. 39, comma 1, c.p.a., a tenore del quale,
per quanto non tipizzato dal codice del processo amministrativo, trova applicazione la
disciplina dettata dal codice di procedura civile.
Ne consegue che, ai fini del computo dei termini, si applica la disciplina generale rinvenibile
nell’art. 155 c.p.c., valida per tutti i termini ordinatori e perentori.
Le norme ivi contenute devono essere, comunque, integrate con le recenti statuizioni applicabili
al processo amministrativo e indicate nell’art. 52 c.p.a., che disciplina specificamente le ipotesi
di scadenza dei termini in giorni festivi e nella giornata del sabato.
In particolare, per quanto riguarda le ipotesi in cui il giorno di scadenza sia festivo, l’art. 52
c.p.a. statuisce, al comma 3, che “il termine fissato dalla legge o dal giudice per l’adempimento è prorogato
di diritto al primo giorno seguente non festivo”; inoltre, nel caso di termini che si computano a ritroso,
ai sensi del comma 4, “la scadenza è anticipata al giorno antecedente non festivo”.
Tale previsione costituisce la traduzione normativa di un orientamento ormai consolidato nella
giurisprudenza tanto amministrativa quanto civile, per cui il dies a quo, nelle ipotesi di conteggio
a ritroso, non va computato, mentre il dies a quem, se coincidente con un giorno festivo, va
arretrato al primo giorno non festivo antecedente e ciò al fine di non abbreviare il margine
temporale ritenuto necessario dal legislatore per approntare le difese in sede processuale.
Difatti, come efficacemente chiarito dalla Cassazione nella sentenza 12 dicembre 2003 n. 19041
– richiamata nella sentenza in rassegna – la proroga al primo giorno seguente non festivo del
termine che scade in giorno festivo, “opera con esclusivo riguardo ai termini cosiddetti a decorrenza
successiva, e non anche per quelli che si computano “a ritroso” (quali, ad esempio, i termini per la tempestiva
costituzione del convenuto ex artt. 166, 416 c.p.c.), con l’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima
del quale deve essere compiuta una determinata attività processuale, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’effetto
contrario di una abbreviazione di quell’intervallo, in pregiudizio delle esigenze di difesa della (contro)parte
destinataria dell’iniziativa processuale (nel nostro caso, il ricorrente) e garantite con la previsione del medesimo
(Cass. 19041/2003; Cass. 16343/2002; Cass. 7331/2002; Cass. 5187/1977; Cass. 986/1966, tutte
conformi)”.
12
www.ildirittoamministrativo.it
In definitiva, nei termini a ritroso viene in rilievo uno spazio temporale incomprimibile a
garanzia del diritto di difesa della controparte interessata dell’iniziativa processuale, con
conseguente ammissibilità di una sua estensione, ma mai di una sua riduzione.
Tale principio – come affermato anche dal Consiglio di Stato nella sentenza de qua - opera
anche nell’ipotesi di giorni liberi, che escludono dal computo sia il giorno iniziale sia quello
finale. Anche in siffatte ipotesi, infatti, l’eventuale scadenza in giorni festivi non può
comportare una riduzione dell’arco temporale entro il quale la controparte può predisporre la
propria difesa, con la conseguenza di una sua estensione ulteriore a causa dello spostamento a
ritroso del giorno di scadenza.
Quanto al recepimento nel processo amministrativo della proroga della scadenza nella giornata
del sabato, introdotta nel rito civile dall’art. 2, comma 1, lett. f), legge 28 dicembre 2005, n. 263,
il nuovo codice del processo amministrativo ha determinato la soluzione del precedente
contrasto interpretativo, accogliendo l’orientamento favorevole veicolato dalla prevalente
giurisprudenza amministrativa e, da ultimo, patrocinato dal Consiglio di Stato, sez. IV, 18
febbraio 2008, n. 446, secondo cui anche nel processo amministrativo il sabato è equiparato ai
festivi.
Difatti, l’art. 52, comma 5, c.p.a. dispone che la proroga prevista per i giorni di scadenza festivi
si applica anche ai termini che scadano nella giornata del sabato.
Tale equiparazione opera però al solo fine del compimento degli atti processuali svolti fuori
dell’udienza che scadono di sabato, onde consentire agli avvocati di procedere ai relativi adempimenti,
concernenti i termini di notifica e deposito che scadono di sabato, il successivo lunedì; a tutti gli altri
effetti il sabato è considerato giorno lavorativo, anche per quanto attiene, dunque, alle attività di ufficiali
giudiziari e di addetti agli uffici ricorsi, come dispone espressamente l’art. 155 c.p.c. (tanto emerge
implicitamente dal decreto del presidente del Consiglio di Stato n. 83 del 2010 che ha disciplinato, con
decorrenza 1° ottobre 2010, gli orari di apertura al pubblico dell’ufficio ricevimento ricorsi e delle
segreterie delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato).
Peraltro, tale regola – come ben evidenzia il Collegio - “vale solo per i termini che si calcolano in
avanti, e non anche per i termini che si calcolano a ritroso; infatti l’art. 52, co. 5, c.p.a. estende al sabato solo la
“proroga di cui al comma 3”, ossia la proroga dei giorni che scadono di giorno festivo, e dunque non anche il
meccanismo di anticipazione di cui al co. 4; ne consegue che se un termine a ritroso scade di sabato, esso non va
13
www.ildirittoamministrativo.it
anticipato al venerdì, così come se il termine a ritroso scade di domenica, va anticipato al sabato e non al
venerdì”.
La norma così descritta, di indubbio impatto sotto il profilo pratico qualora ad essa venga
riconosciuta una portata generale che ne comporta l’applicabilità a tutte le fattispecie in cui è
prevista la scadenza di un termine perentorio, finisce inevitabilmente per riverberare i suoi
effetti sul piano dei termini per il deposito di memorie e repliche in vista dell’udienza di
discussione. Difatti, “il nuovo codice ha allungato tali termini, per meglio garantire lo studio degli atti
processuali ad opera del giudice e delle parti ed ha aggiunto l’istituto delle repliche (ammesso dalla precedente
prassi); pertanto le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza, memorie
fino a trenta giorni liberi e repliche fino a venti giorni liberi (art. 73, co. 1, c.p.a.); lo scopo della previsione è
quello di consentire alla controparte di disporre dei termini ivi previsti per visionare altrui documenti e memorie”.
La particolarità della ratio legis sottesa a tale innovazione normativa costituisce, a sua volta, la
chiave di spiegazione della previsione di cui all’art. 54, comma 1, c.p.a., a tenore del quale “la
presentazione tardiva di memorie o documenti, su richiesta di parte, può essere eccezionalmente autorizzata dal
collegio, assicurando il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, quando la
produzione nel termine di legge risulta estremamente difficile”.
Con siffatta previsione normativa il legislatore
recepisce l’orientamento, che ha
progressivamente preso quota all’interno della giurisprudenza, secondo cui deve ritenersi
perentorio il termine per il deposito di memorie, in quanto integrante “un precetto di ordine pubblico
processuale a garanzia dell’interesse del giudice a conoscere in tempo utile gli atti processuali (cfr., da ultimo,
Cons. St., sez. V, n. 5245 del 2009; sez. VI, n. 4699 del 2008)”.
In definitiva, dalla statuizione normativa dell’art. 54, comma 1., c.p.a. devono desumersi
importanti ricadute sul piano processuale, consistenti nello specifico nel fatto che “a) i termini di
deposito di documenti, memorie e repliche sono imposti a pena di decadenza; b) il deposito tardivo è possibile solo
se c’è un autorizzazione del collegio che si atteggia a rimessione in termini per errore scusabile, come ipotesi
speciale di essa, di cui condivide i presupposti; c) va comunque garantito il contraddittorio”.
Tale lettura interpretativa è stata ribadita dalla giurisprudenza successiva all’entrata in vigore del
codice, la quale anche alla luce del nuovo scenario processuale ha affermato che “tali termini sono
perentori a garanzia del contraddittorio e della corretta organizzazione del lavoro del giudice (cfr. Cons. St., sez.
V, 1 aprile 2011, n. 2032; sez. V, 29 marzo 2011, n. 1910; sez. VI, 16 febbraio 2011, n. 984)”.
14
www.ildirittoamministrativo.it
Acclarata, dunque, la natura perentoria dei termini per il deposito di memorie e documenti,
l’applicabilità ad essi della disciplina contenuta nell’art. 52 c.p.a. ha comportato nel caso
specifico una pronuncia di tardività del deposito della memoria difensiva della società
ricorrente: “il deposito della memoria difensiva della società ricorrente, avvenuto lunedì 18 aprile 2011 in vista
dell’udienza di discussione della presente controversia fissata per il giorno 17 marzo 2011, è tardivo perché
effettuato oltre il termine ultimo per legge individuato nel giorno sabato 16 aprile 2011”.
Sulla scorta di tali considerazioni il Collegio ha statuito che “dall’assodata tardività della memoria
depositata dalla società ricorrente, dalla insussistenza dei presupposti per la concessione dell’errore scusabile (alla
luce dei rigorosi principi da ultimo enucleati dall’adunanza plenaria di questo Consiglio n. 3 del 2010), nonché
dalla natura meramente illustrativa delle comparse conclusionali, discende l’inutilizzabilità processuale della
memoria depositata il 18 aprile 2011, in ordine all’integrazione o specificazione di fatti costitutivi di domande
ed eccezioni non ritualmente proposte, con tutte le ulteriori conseguenze connesse all’applicazione dell’art. 26
c.p.a. (cfr. Cons. St., sez. V, 1 aprile 2011, n. 2032; 29 marzo 2011, n. 1926)”.
Chiarita la disciplina applicabile ai termini per il deposito di memorie e documenti, il Collegio
ha preso in esame, in seconda battuta, l’istituto delle spese di giudizio in caso di lite temeraria,
così come disegnata dall’art. 26, comma 2, c.p.a., passando, peraltro, attraverso la disamina
dell’istituto della revocazione, di cui ha ribadito l’orientamento ormai granitico della
giurisprudenza amministrativa.
In particolare, con riferimento a quest’ultimo punto, il Collegio ha riaffermato la tesi
dell’inammissibilità della domanda di revocazione, esercitata al di fuori dei casi tipici ammessi
dalla legge: “essendo la revocazione una impugnazione a critica vincolata, il motivo di revocazione ha la
funzione di passaggio obbligato; ne consegue l’impossibilità di integrazione o modificazione e, a maggior ragione,
di introduzione di nuovi motivi nel corso del giudizio se ciò non avvenga nel rispetto delle formalità di rito e del
termine decadenziale previsto (cfr. ex plurimis Cons. St., sez. V, 13 febbraio 2009, n. 822; Cass., sez. lav., 9
giugno 1994, n. 5603; nella specie, per quanto sopra osservato, la precisazione del vizio revocatorio è avvenuta
irritualmente)”.
L’inammissibilità della domanda di revocazione discende, altresì, da due ulteriori
argomentazioni che pongono siffatta istanza in contrasto con la normativa sancita dall’art. 395
n. 3) e n. 4) c.p.c.: “in ogni caso il paventato travisamento di fatto, costitutivo dell’abbaglio dei sensi, cade su
una serie di circostanze che hanno costituito punti controversi su cui la sezione si è espressamente pronunciata, e
15
www.ildirittoamministrativo.it
si traduce, in realtà, in una diversa (asseritamente erronea) valutazione delle risultanze probatorie a suo tempo
acquisite al thema decidendum. Tanto contrasta con la previsione normativa sancita dall’art. 395 n. 4), c.p.c.
(cfr. ex plurimis, Cons. St., sez. V, 29 marzo 2011, n. 1910; Cons. giust. amm., 12 agosto 2010, n. 1108;
Cons. Stato, Sez. V, 27 marzo 2009, n. 1829; ad. plen., 11 giugno 2001, n. 3). Per completezza la sezione
rileva che appare ictu oculi inconfigurabile anche il vizio revocatorio previsto dal n. 3) dell’art. 395 c.p.c. venendo
in rilievo un documento formato successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata e, per giunta, privo
del carattere della decisività (cfr. ex plurimis Cons. St., sez. IV, 31 magio 2007, n. 2809, cui si rinvia a mente
dell’art. 74 c.p.a.). In conclusione la revocazione deve essere dichiarata inammissibile”.
La pronuncia di inammissibilità della revocazione, la quale è stata fondata – come chiarito dal
Collegio – “su ragioni manifeste e su consolidati indirizzi giurisprudenziali e interviene dopo che nei due gradi
fisiologici del giudizio, in cui si articola il processo amministrativo, tutte le domande e le doglianze proposte dalla
parte ricorrente sono state esaminate compiutamente”, ha aperto un varco di accesso alla disamina del
profilo delle spese di giudizio per lite temeraria.
A tal proposito, il nuovo codice del processo amministrativo stabilisce all’art. 26, comma 2, che
“il giudice, nel pronunciare sulle spese, può altresì condannare, anche d’ufficio, la parte soccombente al pagamento
in favore dell’altra parte di una somma di denaro equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su
ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati”.
La relazione illustrativa al c.p.a. esplicita che “per quanto attiene alle spese del giudizio si è operato il
richiamo delle pertinenti disposizioni del codice di procedura civile; inoltre è stato previsto che il giudice possa
condannare, anche d’ufficio, la parte soccombente al pagamento …..di una somma di denaro … quando la
decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati”.
È, pertanto, evidente - come chiarito dalla stesso Collegio ripercorrendo le argomentazioni
sviluppate nella sentenza n. 3083 del 23 maggio 2011 – che la disposizione in esame costituisce
“ipotesi speciale rispetto all’archetipo divisato dall’art. 96, co. 3, c.p.c. (introdotto dalla l. n. 69 del 2009);
quest’ultima norma, infatti, non tipizza i presupposti applicativi della condanna officiosa della parte soccombente
al pagamento della somma equitativamente determinata”.
Difatti, la norma sancita dall’art. 96, comma 3, c.p.c., a tenore del quale “in ogni caso, quando
pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte
soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”, risulta
indeterminata nei suoi presupposti potendo essere comminata in ogni caso di condanna del
16
www.ildirittoamministrativo.it
soccombente alle spese processuali (criticità assente nell’art. 26, comma 2, c.p.a., che anzi
consente la condanna solo in presenza di due ben individuate circostanze); generica nei criteri di
liquidazione che potrebbero ritenersi disancorati da ogni parametro di riferimento; equivoca in
ordine alla natura dello strumento; derogatoria rispetto al principio della domanda.
Le ragioni di ciò vanno ravvisate nello scopo immediato perseguito dalla norma di cui all’art.
96, comma 3, c.p.c., che è quello di approntare una soddisfazione in denaro alla parte risultata
vincitrice in un processo civile; cogliendosi solo in via indiretta l’ulteriore intento della legge di
arginare il proliferare di “cause superflue” che appesantiscono oggettivamente gli uffici
giudiziari ostacolando la realizzazione del “giusto processo” attraverso il rispetto del valore
(costituzionale ed internazionale) della ragionevole durata del processo.
In definitiva, “la previsione del pagamento della somma in esame:
a) non riguarda le spese di lite (quantificate con la condanna alle spese secondo la logica propria delle disposizioni
sancite dagli artt. 91 e 92 c.p.c.);
b) non riguarda la responsabilità da lite temeraria (tipizzata dai commi 1 e 2 dell’art. 96 c.p.c.);
c) non riguarda la pretesa sostanziale (sulla quale statuisce il contenuto dispositivo della sentenza).
d) non è configurabile quale sanzione pubblica atteso che:
I) il gettito non è devoluto all’erario (arg. ex artt. 123, co. 1, c.p.a.; 15, disp. att. c.p.a.; 246 bis, codice dei
contratti pubblici, introdotto dall’art. 4, co. 2, lett. ii), d.l. 13 maggio 2011, n. 70);
II) non sono indicati i limiti o i criteri oggettivi di liquidazione; sotto tale angolazione è evidente la differenza che
si coglie, a titolo esemplificativo e confinando l’analisi al solo ambito del processo amministrativo, con le
autentiche sanzioni previste dagli artt. 18, co. 7, 123, co. 1, c.p.a., 246 bis, codice dei contratti pubblici (tale
ultima norma è particolarmente significativa perché ancora il potere officioso di condanna del giudice
amministrativo ai medesimi presupposti stabiliti dall’art. 26, co. 2, c.p.a., ovvero <<… ragioni manifeste o
orientamenti giurisprudenziali consolidati>>)”.
Ricostruite le caratteristiche peculiari della misura pecuniaria prevista nell’art. 96, comma 3,
c.p.c., il Collegio ha sottolineato la necessità di individuare la natura giuridica della medesima
“non tanto per ragioni teoriche, quanto per le ricadute pratiche in ordine all’individuazione della disciplina cui
soggiace per gli aspetti diversi da quelli direttamente presi in considerazioni dal comma 3: si pensi
all’applicabilità o meno del t.u. sulle spese di giustizia, ovvero al problema della cumulabilità di tale somma con
eventuali sanzioni, pubbliche o private irrogabili dal giudice in occasione del processo, ovvero con il risarcimento
17
www.ildirittoamministrativo.it
del danno per lite temeraria liquidato ai sensi dei primi due commi del medesimo articolo”. A tal fine, ha
provveduto a ricostruire il quadro ermeneutico di riferimento, nel quale – scartata la natura di
sanzione pubblica - si contendono il campo tre diversi fronti dottrinali.
In particolare, secondo una prima linea interpretativa, la misura pecuniaria di cui all’art. 96,
comma 3, c.p.a. costituirebbe una forma speciale di responsabilità aggravata derogatoria del
regime generale sancito dall’art. 96, co. 1 e 2, c.p.c. (sotto il limitato profilo della mancanza della
domanda di parte e della prova specifica del danno subito), ma pur sempre sussumibile nel genus
della responsabilità civile da processo e dunque configurabile solo in presenza di tutti gli altri
elementi della fattispecie (temerarietà della lite, esistenza del danno nell’an, nesso di causalità fra
condotta illecita processuale e danno).
Tale tesi, peraltro, è stata disattesa dalla Sezione V, in quanto “la mera collocazione della disposizione
all’interno dell’art. 96 c.p.c. non significa che si possa prescindere dalle conseguenze derivanti dall’interpretazione
letterale e teleologica della norma; il contenuto del precetto si colloca in contrapposizione esplicita alle ipotesi
divisate dai primi due commi del medesimo articolo, prescinde da qualsivoglia riferimento a fattispecie di danno,
sfugge al principio della domanda che innerva il sistema della responsabilità civile”.
Una seconda linea interpretativa ha, invece, qualificato la misura pecuniaria di cui all’art. 96,
comma 3, c.p.a. come una pena privata inflitta officiosamente dal giudice per reprimere l’abuso
dello strumento del processo.
Anche tale tesi è apparsa non condivisibile dal Collegio, in quanto “il carattere officioso della
inflizione della pena privata non appare conforme alle caratteristiche generali dell’istituto che postula
normalmente la richiesta della parte interessata al giudice (come espressamente stabilito, ad es., dall’art. 114, co.
4, lett. c), c.p.a. che prevede, sulla falsariga di quanto stabilito dall’art. 614 bis c.p.c., una astreinte processuale
consistente in una sanzione pecuniaria per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato (lo stesso è a dire per molte
altre ipotesi di pene private previste dal nostro ordinamento, si pensi, a titolo di esempio, all’art. 70 disp. att. c.c.
in materia di violazioni dei regolamenti condominiali; all’art. 12 della legge sulla stampa, agli artt. 63 e 83
della legge sui marchi e brevetti). Inoltre non sembra che la norma in esame, per la sua collocazione sistematica,
la genesi storica ed il tenore testuale, abbia inteso introdurre una clausola generale repressiva dell’abuso del
processo. Sotto tale angolazione appare evidente la differenza con la norma sancita dall’ultimo comma dell’art.
385 c.p.c. (introdotto dalla l. n. 40 del 2006 e successivamente abrogato dalla l. n. 69 del 2009), che era stata
intesa dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità come foriera di una <<pena privata>> tesa a
18
www.ildirittoamministrativo.it
sanzionare la condotta necessariamente maliziosa della parte che, in violazione del dovere di solidarietà sancito
dall’art. 2 Cost., abbia illecitamente abusato dello strumento processuale del ricorso in cassazione (cfr. Corte
cost., 23 dicembre 2008, n. 435/ord.; Cass., sez. un., 11 dicembre 2007, n. 25831)”.
La tesi interpretativa abbracciata dal Collegio è, invece, quella secondo cui la misura pecuniaria
costituirebbe un indennizzo per il “danno lecito da processo”, cioè il nocumento che la parte
vittoriosa ha subito per l’esistenza e la durata del processo, anche se la controparte non ha agito
o resistito in mala fede o senza prudenza.
Tale tesi, infatti,“oltre a non collidere con la ratio e la lettera della norma, si inserisce armonicamente nel
sistema costruito dall’ordinamento nel suo complesso per rendere effettivo il principio di ragionevole durata del
processo; tale norma si affianca alle misure previste dalla c.d. l. Pinto (n. 89 del 2001), chiamando la parte che
abbia dato corso (o abbia resistito) ad (in) un processo oggettivamente ritenuto ingiustificabile a indennizzare la
controparte che è stata costretta a subirlo”.
Chiarita la natura giuridica della misura pecuniaria dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che si pone
quale archetipo rispetto a quella speciale disciplinata dall’art. 26, comma 2, c.p.a., il Consiglio di
Stato, in ultima battuta, ha preso in esame i criteri a cui deve ancorarsi il giudice per la
liquidazione della somma, che secondo quanto è disposto legislativamente, è affidata all’equità,
intesa nel tradizionale significato di criterio di valutazione giudiziario correttivo o integrativo,
teso al contemperamento, nella logica del caso concreto, dei contrapposti interessi rilevanti
secondo la coscienza sociale.
A tal proposito, il Collegio ha evidenziato che dalla più recente giurisprudenza della Corte di
Cassazione (cfr. Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2010, n. 11353 relativa a fattispecie di
liquidazione del risarcimento del danno all’immagine ammesso in una logica non meramente
compensativa del pregiudizio subito) sono stati individuati, quali utili parametri di riferimento,
gli eventuali utili conseguiti a cagione della ingiusta attivazione o resistenza nel processo e della
sua durata, accanto ovviamente, a più tradizionali criteri, come quello del valore della
controversia ovvero al riferimento ad una percentuale delle spese di lite sostenute dalla parte
vincitrice (in tal senso è la prassi forense civile formatasi in sede di prima applicazione dell’art.
96, comma 3, c.p.c.; in termini Cons. St., sez. V, 24 gennaio 2011, n. 241/ord.).
Il Collegio è pervenuto a tale esito interpretativo sulla base dell’assunto per cui, nel silenzio
della legge con riferimento all’individuazione dei parametri a cui agganciare la determinazione
19
www.ildirittoamministrativo.it
equitativa, “possono considerarsi ammissibili una molteplicità di criteri alcuni dei quali ispirati alla logica dei
danni punitivi di matrice anglosassone che ben si prestano ad assicurare, pur nell’alveo della responsabilità civile,
la (indiretta) funzione di deterrenza sanzionatoria del proliferare dei processi, sganciati come sono dalla
dimostrazione anche presuntiva di un pregiudizio da compensare (il riferimento è al rimedio del disgorgement che
consente all’interessato di colpire l’autore della condotta contra ius attraverso la retroversione degli utili
conseguiti)”.
Tale impostazione ha trovato ingresso nella summenzionata giurisprudenza della Corte di
cassazione.
Sulla scorta di tali considerazioni, il Collegio ha ritenuto applicabile, nel caso di specie, il criterio
tradizionale della “percentuale sulle spese della lite”, mancando elementi fattuali che avrebbero
consentito l’applicazione di parametri diversi.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, ordinanza 6 giugno 2011, n. 3406
Ai sensi dell’art. 18 c.p.a. la presentazione dell’istanza di ricusazione non determina
ipso iure la sospensione del processo, cosicché il collegio, investito della controversia,
può comunque disporre la prosecuzione del giudizio nel caso ravvisi la manifesta
inammissibilità o infondatezza di detta istanza.
Pertanto, il Collegio, quando ravvisi la manifesta inammissibilità o infondatezza
dell’istanza di ricusazione, può decidere, anche in composizione comprendente il o i
magistrati ricusati, dovendosi porre il problema del rinvio ad altra udienza (“previa
sostituzione del magistrato ricusato”), sia quando non si rinvengano ragioni fondanti la
declaratoria di inammissibilità o manifesta infondatezza dell’istanza (e quindi la stessa
deve essere compiutamente esaminata), sia quando il Collegio ha delibato
l’inammissibilità o la manifesta infondatezza dell’istanza, come si evince dal comma 8,
secondo periodo, in base al quale “l’accoglimento dell’istanza di ricusazione rende nulli
gli atti compiuti ai sensi del comma 4 con la partecipazione del giudice ricusato”,
norma che sarebbe priva di senso ove non si prevedesse una decisione successiva, ai
sensi del comma 5, alla immediata delibazione di cui al comma 4.
È manifestamente infondata l’istanza di ricusazione, come proposta ed integrata, in
quanto essa indica il motivo di ricusazione dei componenti del Collegio nel fatto stesso
di avere la qualifica di Consigliere di Stato, non ravvisando alcun motivo particolare di
interesse o di contrasto con una delle parti, tale da sorreggere la proposta ricusazione,
né potendosi ritenere rientranti nelle ipotesi di cui all’art. 50 c.p.c. (richiamato dall’art.
18 Cpa) meri rapporti derivanti dalla semplice appartenenza al medesimo ordinamento
giudiziario.
Il principio della pubblicità del giudizio che si svolge innanzi ad organi giurisdizionali,
pur costituendo un cardine dell’ordinamento democratico, fondato sulla sovranità
20
www.ildirittoamministrativo.it
popolare, sulla quale si basa l’amministrazione della giustizia, ai sensi dell’art. 101, co.
1, Cost., non trova un’applicazione assoluta, potendo essere limitato, oltre che
nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico, della sicurezza nazionale, dei minori o
della vita privata delle stesse parti del processo, anche nell’interesse stesso della
giustizia", come peraltro prevede il medesimo art. 6 CEDU, che, fatte salve le eccezioni
previste dallo stesso art. 6, è sufficiente l’assicurazione che "il processo debba
prevedere un momento di trattazione in udienza pubblica.
Le ipotesi di difesa “personale” devono essere considerate, nel nostro ordinamento,
eccezioni, proprio in considerazione della natura inviolabile del diritto di difesa e del
principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge.
L’ordinanza in rassegna offre l’occasione per la disamina di due istituti processuali
particolarmente interessanti: la ricusazione e la difesa personale.
Con particolare riguardo all’istituto della ricusazione, disciplinato attualmente dall’art. 18 c.p.a.,
prendendo in esame, il Collegio, nell’ordinanza de qua prende in esame due questioni di
particolare rilievo pratico: una, di carattere più tecnico, attinente alla procedura che il Collegio
deve seguire a fronte di un’istanza di ricusazione, l’altra concernente i presupposti.
Per quanto riguarda, invece, la difesa personale, il Collegio procede ad un’ampia panoramica
dello scenario normativo dell’istituto de quo.
Procediamo per gradi e catalizziamo la nostra attenzione sulle considerazioni sviluppate dalla
Sezione IV con riguardo all’istituto della ricusazione, anticipando l’analisi con un breve, ma
esaustivo, inquadramento normativo di siffatto istituto.
L’art. 18 c.p.a., concernente le cause di ricusazione applicabili al giudice amministrativo,
rinviano direttamente alle norme del codice di procedura civile.
La ricusazione può proporsi o tre giorni prima dell’udienza, quando siano noti i magistrati che
prenderanno parte all’udienza, ovvero, in caso contrario, nel corso della medesima udienza
prima della discussione.
Ai fini della presentazione della domanda di ricusazione non è obbligatorio il patrocinio di un
avvocato, potendo essere presentata direttamente dalla parte mediante il semplice deposito
dell’istanza in segreteria.
Inoltre, dalla lettura dell’articolo si desume facilmente – in perfetta corrispondenza con la
disciplina precedente – la non necessità della previa notifica della istanza di ricusazione alle
controparti.
21
www.ildirittoamministrativo.it
Si tratta, dunque, di una procedura meramente strumentale ed incidentale rispetto al giudizio e
la relativa ordinanza costituisce un provvedimento meramente ordinatorio, volto a verificare la
capacità processuale del giudice rispetto alla lite e non a comporre un conflitto di interessi tra le
parti del processo originario.
In applicazione del principio del giusto processo, si è previsto che la decisione definitiva
sull’istanza di ricusazione spetti a un collegio composto senza la presenza del giudice ricusato.
Inoltre, la nuova disciplina – in linea con l’interpretazione fornita dalla Corte costituzionale
nell’ordinanza, 18 marzo 2005, n. 115 dell’art. 52, comma 3, c.p.c. – stabilisce che la
presentazione dell’istanza di ricusazione non determina ipso iure la sospensione del processo,
cosicché il collegio, investito della controversia, può comunque disporre la prosecuzione del
giudizio nel caso ravvisi la manifesta inammissibilità o infondatezza di detta istanza.
Tale profilo è stato messo ben in evidenza nell’ordinanza in esame, precisando il Supremo
Consesso della giustizia amministrativa che “la soluzione adottata dal Codice è aderente al principio di
effettività della tutela giurisdizionale, in quanto tesa ad evitare che con una pluralità di successive istanze di
ricusazione venga paralizzata l’attività giurisdizionale, ed essa è altresì conforme a quanto espresso anche dalla
Corte Costituzionale, secondo la quale esiste un potere delibatorio del giudice della causa in ordine all’istanza di
ricusazione, onde evitare che atti di ricusazione pretestuosi comportino effetti di ritardo o paralisi del giudizio
(Corte cost., 18 marzo 2005 n. 115 e 23 luglio 2002 n. 388)”.
Pertanto, “il Collegio può decidere, anche in composizione comprendente il o i magistrati ricusati, dovendosi
porre il problema del rinvio ad altra udienza ("previa sostituzione del magistrato ricusato"), sia quando non si
rinvengano ragioni fondanti la declaratoria di inammissibilità o manifesta infondatezza dell’istanza (e quindi la
stessa deve essere compiutamente esaminata), sia quando il Collegio ha delibato l’inammissibilità o la manifesta
infondatezza dell’istanza, come si evince dal comma 8, secondo periodo, in base al quale "l’accoglimento
dell’istanza di ricusazione rende nulli gli atti compiuti ai sensi del comma 4 con la partecipazione del giudice
ricusato", norma che sarebbe priva di senso ove non si prevedesse una decisione successiva, ai sensi del comma 5,
alla immediata delibazione di cui al comma 4”.
Ne consegue, in definitiva, che il collegio giudicante, nell’ipotesi in cui venga presentata
un’istanza di ricusazione, deve procedere ad una sommaria delibazione circa la sua
ammissibilità, appurando che l’istanza sia stata ritualmente proposta, e non manifesta
infondatezza, verificando che sia stato adempiuto l’onere della prova: “diversamente opinando,
22
www.ildirittoamministrativo.it
lo strumento codicistico della ricusazione, finalizzato a salvaguardare l’imparzialità e la terzietà
del giudice, potrebbe scadere in un artificio per paralizzare sine die, e senza alcun ragionevole
fondamento, l’amministrazione della giustizia” (Cons. Stato, sez. IV, 1 febbraio 2001, n. 422).
Inoltre, precisa lo stesso Consiglio di Stato, il collegio dovrà procedere a tale sommaria
delibazione e disporre la prosecuzione del giudizio, qualora ritenga l’istanza inammissibile o
manifestamente infondata, in applicazione dei commi 4 e 5 dell’art. 18, anche in composizione
comprendente il o i magistrati ricusati, senza distinguere tra “l’ipotesi in cui destinatario dell’istanza
di ricusazione sia uno dei componenti del Collegio ovvero oggetto dell’istanza siano tutti i componenti del
Collegio”.
Peraltro, se la peculiarità dell’ipotesi in cui l’istanza di ricusazione coinvolge tutti i componenti
del Consiglio di Stato non preclude una pronuncia di inammissibilità o manifesta infondatezza,
con la conseguente prosecuzione del giudizio, a conclusioni diverse deve pervenirsi laddove il
collegio debba procedere ad una decisione definitiva sull’istanza di ricusazione.
Difatti, afferma la Sezione IV nell’ordinanza in esame “la previsione di cui all’art. 18, commi 5 e 8, secondo la quale occorre "in ogni caso", una decisione definitiva sull’istanza di ricusazione (anche in presenza di
una previa, sfavorevole delibazione della medesima) assunta dal Collegio "previa sostituzione del magistrato
ricusato, che deve essere sentito" - concerne la sola, specifica ipotesi in cui l’istanza di ricusazione riguardi un solo
magistrato del Collegio, ma non la maggioranza o (come nel caso di specie) la totalità dei suoi componenti, come
si evince dagli specifici riferimenti al "magistrato ricusato" o al "giudice ricusato", rispettivamente contenuti nei
commi 5 e 8”.
Alla stregua di tali e tante considerazioni, il Consiglio di Stato ha ritenuto manifestamente
infondata l’istanza di ricusazione, come proposta ed integrata, “in quanto essa indica il motivo di
ricusazione dei componenti del Collegio nel fatto stesso di avere la qualifica di Consigliere di Stato, non
ravvisando alcun motivo particolare di interesse o di contrasto con una delle parti, tale da sorreggere la proposta
ricusazione, né potendosi ritenere rientranti nelle ipotesi di cui all’art. 50 c.p.c. (richiamato dall’art. 18 Cpa)
meri rapporti derivanti dalla semplice appartenenza al medesimo ordinamento giudiziario”.
Inoltre, nel caso di specie in cui l’istanza di ricusazione coinvolge tutti i componenti del
collegio, “non sembra potersi far luogo ad ulteriore decisione sulla istanza di ricusazione, ai sensi dell’art. 18,
co. 5, in quanto la stessa, come già chiarito, si fonda su ragioni che concernono indifferentemente tutti i
componenti dell’attuale Collegio giudicante e del Consiglio di Stato, per cui non vi sarebbe mai un collegio esente
23
www.ildirittoamministrativo.it
da ricusazione, laddove, al contrario, l’art. 18, co. 6, prevede che "i componenti del collegio chiamato a decidere
sulla ricusazione non sono ricusabili".
Tanto premesso, il Consiglio di Stato ha poi proseguito nell’esame delle istanza di ammissione
alla difesa personale e all’udienza pubblica, anticipando, peraltro, l’analisi di tale profilo con
talune prese di posizione, di carattere strettamente procedurale.
In particolare, il Collegio, ha affermato che le istanze di difesa personale e di udienza pubblica
andrebbero comunque ritenute inammissibili, in quanto proposte direttamente da parte
ricorrente, “pur essendo lo stesso costituito a mezzo di difensore e dovendo gli atti del processo amministrativo,
salvo le eccezioni espressamente previste, essere sottoscritti da avvocato (abilitato al patrocinio innanzi alle
magistrature superiori, ove si tratti di giudizio innanzi al Consiglio di Stato: art. 22, commi 1 e 2 Cpa), e
sempre previo conferimento antecedente di procura”.
Peraltro, stante la particolarità delle richieste avanzate, il Collegio ha comunque ritenuto
opportuno procedere ad un esame delle stesse, “in evidente favor per il diritto alla tutela giurisdizionale
e senza che ciò possa configurare riconoscimento, anche implicito, di ammissione alla difesa personale, ribadita
anzi la necessità del ministero di avvocato abilitato”, pervenendo ad una pronuncia di infondatezza
delle medesime.
In particolare, il Collegio, dopo aver precisato che le istanze de quibus erano attinenti al giudizio
in grado di appello di accesso ai documenti amministrativi, con riferimento al quale l’art. 87,
comma 2, lett. c) c.p.a. prevede la trattazione in udienza in camera di consiglio, mentre l’art. 95,
comma 6, c.p.a. esclude che possa trovare applicazione nei giudizi di impugnazione l’art. 23
c.p.a., che ammette in materia di accesso la difesa personale delle parti, ha proceduto ad un
esame distinto delle istanze presentate, ponendo a base della propria statuizione di rigetto
importanti approdi del Giudice delle leggi.
Così, con riguardo al diritto all’udienza pubblica, il Collegio, richiamando recenti pronunce della
giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che “il principio della pubblicità del giudizio che si svolge
innanzi ad organi giurisdizionali, pur costituendo un cardine dell’ordinamento democratico, fondato sulla
sovranità popolare, sulla quale si basa l’amministrazione della giustizia, ai sensi dell’art. 101, co. 1, Cost., non
trova un’applicazione assoluta, potendo essere limitato, oltre che nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico,
della sicurezza nazionale, dei minori o della vita privata delle stesse parti del processo, anche nell’interesse stesso
della giustizia", come peraltro prevede il medesimo art. 6 CEDU (Cass. Sez. Un., 20 aprile 2004 n. 7585);
24
www.ildirittoamministrativo.it
che, fatte salve le eccezioni previste dallo stesso art. 6, è sufficiente l’assicurazione che "il processo debba prevedere
un momento di trattazione in udienza pubblica" (Cass. civ., sez. III, 18 luglio 2008 n. 19947)”.
E proprio esaminando l’applicazione nell’ordinamento nazionale dell’art. 6 CEDU, il cui pgf. 1
prevede che “ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza”, la Corte costituzionale
nella recentissima sentenza, 11 marzo 2011, n. 80 ha affermato, sulla scorta della giurisprudenza
della Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo, che “la valenza del controllo immediato del
quisque de populo sullo svolgimento delle attività processuali, reso possibile dal libero accesso
all’aula d’udienza, si apprezza in modo specifico quando il giudice sia chiamato ad assumere
prove, specialmente orali-espressive, e comunque ad accertare o ricostruire fatti; mentre si
attenua grandemente allorché al giudice competa soltanto risolvere questioni interpretative di
disposizioni normative”.
Sull’onda di tali considerazioni, il Collegio ha rigettato l’istanza di udienza pubblica, in quanto
“nel caso di specie, il giudizio verte su profili squisitamente tecnici, relativi alla ostensibilità (o meno) di
documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241/1990 e, peraltro, tale giudizio, come chiarito anche dalla
giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (Ad. Plen. n. 7/2006) non ha per immediato oggetto posizioni
giuridiche soggettive, posto che il cd. "diritto di accesso" può essere più propriamente qualificato come un "potere
di natura procedimentale volto in senso strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante (diritti o
interessi)", essendo assicurata, in tali ultimi casi, la trattazione in udienza pubblica”.
Quanto all’istanza di difesa personale, il Collegio ha chiarito che, “ai sensi dell’art. 24, comma
secondo, Cost., l’inviolabilità del diritto di difesa si caratterizza in primo luogo come diritto alla difesa tecnica,
che si realizza mediante la presenza di un difensore dotato dei necessari requisiti di preparazione tecnicogiuridica, in grado di interloquire con le controparti e con il giudice, di modo che le ipotesi di difesa "personale"
devono essere considerate, nel nostro ordinamento, eccezioni, proprio in considerazione della natura inviolabile del
diritto di difesa e del principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, e ciò è dimostrato anche dalle
disposizioni del c.p.p. che prevedono il diritto alla nomina del difensore di fiducia (art. 96), la nomina di
difensore d ufficio (art. 97), ovvero le disposizioni volte ad assicurare il patrocinio dei non abbienti (art. 98
c.p.p.; art. 14, all. 2 Cpa)”.
Tali considerazioni trovano un importante referente nella Corte costituzionale, la quale in
diversi arresti ha ribadito la natura eccezionale della difesa personale.
25
www.ildirittoamministrativo.it
In particolare, il Giudice delle leggi, con sentenza 3 ottobre 1979 n. 125, nell’escludere la cd.
autodifesa (ed escludendo, quindi, l’illegittimità costituzionale delle norme del c.p.p., che
prevedono la difesa tecnica obbligatoria) ha affermato che “è consentito al legislatore,
valutando la diversa struttura dei procedimenti, i diritti e gli interessi in gioco, le peculiari
finalità dei vari stati e gradi della procedura, dettare specifiche modalità per l'esercizio del diritto
di difesa, alla tassativa condizione, però, che esso venga, nelle differenti situazioni processuali,
effettivamente garantito a tutti su un piano di uguaglianza. Per il nostro ordinamento positivo, il
diritto di difesa nei procedimenti giurisdizionali si esercita, di regola, mediante l'attività o con
l'assistenza del difensore, dotato di specifica qualificazione professionale, essendo limitata a
controversie ritenute di minore importanza ovvero a procedimenti penali per reati cosiddetti
bagatellari la possibilità che la difesa venga esercitata esclusivamente dalla parte. Speculare alla
inviolabilità del diritto di difesa, è la irrinunciabilità di esso, quali che ne siano le concrete
modalità di esercizio, e, nel processo penale, l'imputato non può rinunziare ai diritti inviolabili
dei quali è titolare, né può disporre delle garanzie che gli derivano dalle norme costituzionali”.
E, altresì, con sentenza 22 dicembre 1980 n. 188, la Corte costituzionale ha ulteriormente
affermato che “spetta al legislatore, considerate le peculiarità strutturali e funzionali ed i diversi
interessi in gioco nei vari stadi e gradi del procedimento, il dettare le concrete modalità per
l'esercizio del diritto di difesa, alla condizione, s'intende, che esso venga, nelle diverse situazioni
processuali, garantito a tutti su un piano d'uguaglianza ed in forme idonee. Quanto alla difesa
tecnica, l'obbligatorietà della nomina del difensore non significa affatto un vincolo a svolgere
determinate attività processuali; ma significa semplicemente la predisposizione astratta di uno
strumento ritenuto idoneo a consentire, in qualsiasi momento, l'esercizio del diritto inviolabile e come tale irrinunciabile - di difesa, senza pregiudizio dell'elasticità dei rapporti fra imputato e
difensore e soprattutto senza pregiudizio della piena autonomia delle scelte difensive, positive o
negative, la cui incoercibilità rappresenta, oltre che un dato di fatto, l'immediato risvolto
dell'inviolabilità del diritto in questione”.
Infine, nella medesima sentenza, la Corte costituzionale ha precisato che l’art. 6 CEDU, il cui
pgf. 3, lett. c) prevede che ogni accusato ha diritto a difendersi da sé o avere l’assistenza di un
difensore di propria scelta, “vuole concorrere alla definizione di un "giusto processo", di un
"equo processo" fondato, tra l'altro, sulla uguaglianza delle parti, sulla "legalitè des armes",
26
www.ildirittoamministrativo.it
come si è espressa la Commissione Europea dei diritti dell'uomo. E la Commissione stessa ha
avuto occasione di affermare che il diritto all'autodifesa non è assoluto, ma limitato dal diritto
dello Stato interessato ad emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai
Tribunali (ric. 722/60). La medesima Commissione, esaminando un ricorso contro uno Stato il
cui ordinamento interno impone la rappresentanza di un avvocato di fronte al Tribunale
superiore, ha ritenuto che la disposizione in esame non obbliga gli Stati contraenti a garantire
agli imputati una assoluta libertà di accesso ai Tribunali di ultima istanza e che nulla si oppone
ad una diversa disciplina purché emanata allo scopo di assicurare una buona amministrazione
della giustizia (Ric. 727/60 e Ric. 722/60). Interpretazioni, queste, che sembrano perfettamente
coerenti con il principio di cui all'art. 24, secondo comma Cost. nella lettura datane da questa
Corte con la sent. n. 125 del 1979”.
In definitiva, il Collegio, avvalendosi delle coordinate interpretative fornite dalla giurisprudenza
costituzionale, è approdato al rigetto dell’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione alla difesa
personale, non ravvisandosi ragioni tali da far supporre la natura di diritto assoluto del diritto
personale, ma al contrario imponendosi nello scenario giurisprudenziale e normativo, tanto
nazionale, quanto sovranazionale, la necessità che il diritto di difesa si esplichi mediante un
difensore dotato dei necessari requisiti di preparazione tecnico-giuridica.
TAR LOMBARDIA MILANO, SEZ. III, 8 giugno 2011, n. 1428
Il Codice, superando l’assunto della tipicità delle azioni nel processo amministrativo
(peraltro già messo in discussione dalla giurisprudenza), prefigura un sistema “aperto”
di tutele, in cui sono ammesse pronunce dichiarative (art. 31), costitutive (art. 29),
condannatorie (art. 30). Per tale via, finalmente anche per il processo amministrativo, si
invera la garanzia costituzionale (art. 24 cost.) che, riconoscendo la giuridicità del
potere d’azione e la sua autonomia rispetto alla situazione giuridica sostanziale alla
quale pure è correlata, preclude al legislatore di rendere impossibile o comunque
difficoltosa la tutela delle posizioni soggettive manovrando la disciplina del processo.
Le previsioni di cui all’art. 34 comma 1, lett. c), che, nel precisare i contenuti della
sentenza, prevede anche l’adozione “delle misure idonee a tutelare la situazione
giuridica soggettiva dedotta in giudizio”, e successiva lett. e), a tenore del quale il
giudice dispone “le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato” prefigurano
un potere di condanna senza restrizione di oggetto, modulabile a seconda del bisogno
differenziato emerso in giudizio; ovvero, all’occorrenza, quale sbocco di una tutela
restitutoria, ripristinatoria ovvero di adempimento pubblicistico coattivo.
27
www.ildirittoamministrativo.it
La sentenza in esame dischiude scenari assai interessanti, in quanto, intervenendo sul tema
dell’accertamento “autonomo” del rapporto amministrativo, costituisce una delle prime
applicazioni, dopo l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, del potere del
giudice amministrativo di condannare la P.A. all’adozione del provvedimento a cui il ricorrente
anela.
In particolare, il TAR Lombardia nella sentenza in esame ha ricostruito con maestria e
chiarezza d’analisi la disciplina attuale dell’azione di esatto adempimento, sposando
l’orientamento interpretativo per cui, a seguito della riforma del codice amministrativo, deve
ritenersi ammissibile la tutela di accertamento dell’interesse legittimo, non più confinata alle
ipotesi in cui la posizione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio abbia consistenza di diritto
soggettivo.
A tal proposito, prima di addentrarci nella disamina della sentenza in esame, che offre
interessanti spunti di riflessione del nuovo quadro normativo, esigenze di completezza di analisi
ci impongono di volgere lo sguardo indietro, richiamando i passi fondamentali di una
importanza sentenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 717), la
quale può ritenersi antesignana dell’orientamento ora canonizzato dal Codice del processo
amministrativo e ben esplicitato nella sentenza in rassegna.
E, infatti, al di là del dato offerto dalle recenti previsioni codicistiche, il percorso interpretativo
svolto dal TAR Lombardia appariva percorribile anche in precedenza, come chiaramente lo
dimostra il Consiglio di Stato, che nella sentenza del 2009, intervenendo in materia di DIA, ha
riconosciuto al terzo un’azione di accertamento innanzi al giudice amministrativo, al fine di
ottenere una pronuncia declaratoria della insussistenza dei presupposti di legge per l’esercizio
dell’attività posta in essere dal privato.
In particolare, ha affermato la Sezione VI del Consiglio di Stato che sarebbe “una tutela non
effettiva quella che, sulla base di una aprioristica ed indimostrata negazione dell’azione di accertamento,
costringesse il terzo controinteressato rispetto all’attività edilizia iniziata sulla base della d.i.a. a presentare
un’istanza all’amministrazione volta all’esercizio del cd potere di autotutela per poi ricorrere, in caso di mancata
risposta, al giudizio contro il silenzio-rifiuto”.
Peraltro, la particolarità della sentenza va ravvisata nelle argomentazioni poste a sostegno di tali
conclusioni e volte a smantellare le motivazioni su cui si reggeva l’orientamento tradizionale
28
www.ildirittoamministrativo.it
negatorio dell’ammissibilità di un’azione di accertamento autonoma esperibile innanzi al giudice
amministrativo.
Più nello specifico, con riguardo alla ricostruzione dell’interesse legittimo come posizione
giuridica di rango inferiore rispetto al diritto soggettivo, si è evidenziato come la Corte
Costituzionale con la sentenza n. 204/2004 abbia sottolineato che l’art. 24 Cost. assicura
all’interesse legittimo le medesime garanzie assicurate al diritto soggettivo, quanto alla
possibilità di farli valere davanti al giudice, alla effettività della tutela ad essi accordabile e
all’adeguatezza dei poteri del giudice.
Con riferimento alla tradizionale considerazione per cui il giudizio amministrativo è un giudizio
sull’atto e non sul rapporto, il Consiglio di Stato ha affermato come tale impostazione non sia
più cosi pacifica.
Difatti, a seguito della normativa sopravvenuta - si pensi, al riguardo, al potere del giudice di
negare l’annullamento del provvedimento impugnato per vizi di violazione delle norme sul
procedimento, ove si accerti che detto provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto
diverso (art. 21octies L. 241/1990), oppure al potere del giudice amministrativo di valutare la
fondatezza della pretesa del privato nel giudizio avverso il silenzio–rifiuto (art. 2 comma 5 L.
241/1990) – il giudizio amministrativo rimane un giudizio sull’atto, ma in una versione
diversificata, in quanto il giudice amministrativo è chiamato a valutare la legittimità del rapporto
trasfuso nel provvedimento o del rapporto di cui il privato chiede la trasfusione in un
successivo atto amministrativo, in caso di perdurante inerzia della P.A.
Per quanto riguarda, invece, la limitatezza dei mezzi di prova a disposizione del giudice
amministrativo, si è sottolineato come siffatto assunto si sfalda alla luce delle modifiche
intervenute con la legge n. 205/2000.
Infine, in ordine al principio della tipicità si è efficacemente rilevato come nel processo civile,
analogamente al processo amministrativo, manca un esplicito riconoscimento normativo
dell’azione di accertamento. Ciò nonostante nel processo civile l’azione di accertamento è
pacificamente ammessa e la ragione va individuata nel fatto che tale potere è connaturato al
concetto stesso di giurisdizione, che implica appunto “ius dicere”.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento al processo amministrativo. Del resto,
la tipicità dell’azione di annullamento nel processo amministrativo, coerente con una
29
www.ildirittoamministrativo.it
concezione di quest’ultimo impostato sulla tutela degli interessi legittimi oppositivi, non è più
rispondente ad un sistema che ha attribuito piena dignità agli interessi legittimi pretensivi.
Tali considerazioni hanno ricevuto il suggello del Codice del processo amministrativo, il quale –
così si legge nella sentenza del TAR Lombardia in rassegna – “superando l’assunto della tipicità delle
azioni nel processo amministrativo (peraltro già messo in discussione dalla giurisprudenza), prefigura un sistema
“aperto” di tutele, in cui sono ammesse pronunce dichiarative (art. 31), costitutive (art. 29), condannatorie (art.
30). Per tale via, finalmente anche per il processo amministrativo, si invera la garanzia costituzionale (art. 24
cost.) che, riconoscendo la giuridicità del potere d’azione e la sua autonomia rispetto alla situazione giuridica
sostanziale alla quale pure è correlata, preclude al legislatore di rendere impossibile o comunque difficoltosa la
tutela delle posizioni soggettive manovrando la disciplina del processo. Garanzia, sul cui fondamento, la dottrina
processualcivilistica ha da tempo tratto il corollario del superamento di un sistema rigido di rimedi tipici in favore
di un principio di generale azionabilità degli interessi protetti, con tutti i mezzi dall’ordinamento consentiti. Il
richiamo (contenuto nel codice) all’esigenza di una tutela piena ed effettiva, in tal senso, conferma che anche il
giudice amministrativo è dotato di tutti i poteri necessari alla soddisfazione dei bisogni differenziati. Se
l’effettività della tutela giurisdizionale è la capacità del processo di far conseguire i medesimi risultati garantiti
dalla sfera sostanziale, anche l’interesse legittimo abbisogna della predisposizione dei rimedi idonei a garantire il
conseguimento dell’utilità “primaria” specificatamente oggetto dell’aspettativa riconosciuta dall’ordinamento”.
Un’importante riconoscimento in tal senso si è recentemente avuto ad opera dell’importante
sentenza dell’Adunanza Plenaria, 23 marzo 2011, n. 3, in cui “il Consiglio di Stato, nella sua più
autorevole composizione, ha chiaramente affermato (sia pure in obiter dictum) che il codice del processo ha
introdotto, anche in presenza di un provvedimento espresso di rigetto e sempre che non vi osti la sussistenza di
profili di discrezionalità amministrativa e tecnica, l’azione di condanna volta ad ottenere l’adozione dell’atto
amministrativo richiesto”.
In particolare, l’Adunanza Plenaria, pronunciandosi in materia di pregiudiziale amministrativa,
ha evidenziato che il riconoscimento dell’autonomia, in punto di rito, della tutela risarcitoria si
inserisce - in attuazione dei principi costituzionali e comunitari in materia di pienezza ed
effettività della tutela giurisdizionale richiamati dall’art. 1 del codice oltre che dei criteri di delega
fissati dall’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - in un ordito normativo che, portando a
compimento un lungo e costante processo evolutivo tracciato dal legislatore e dalla
giurisprudenza, amplia le tecniche di tutela dell’interesse legittimo mediante l’introduzione del
30
www.ildirittoamministrativo.it
principio della pluralità delle azioni: “la tesi della necessaria subordinazione della tutela risarcitoria alla
tutela di annullamento è, infatti, non in linea con la tendenza legislativa a superare il modello dell’esclusività
della tutela impugnatoria con la conseguente ammissione di tecniche di tutela dell’interesse legittimo anche
dichiarative (art. 21 septies della legge 7 agosto 1990, n. 241/1990, in materia di azione di nullità) e di
condanna (art 2, comma 8, di tale legge e art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, in tema di azione
nei confronti del silenzio non significativo; art. 7, comma 3, di tale legge, come mod. dalla legge n. 205 del 2000;
art. 21 bis della legge 1971, n. 1034, introdotto dalla stessa legge n. 205 del 2000, rispettivamente in materia
di tutela risarcitoria in generale e di danno da ritardo). Si deve, in particolare, osservare, a conferma del
superamento della centralità della tutela di annullamento ove siano percorribili altre e più appropriate forme di
tutela, che l’art. 21 octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 14 della legge 11
febbraio 2005, n. 15, ha statuito che il provvedimento amministrativo non è suscettibile di annullamento ove sia
affetto da vizi procedimentali o formali che non abbiano influito sul contenuto dispositivo dell’atto finale. Sullo
stesso solco si pone il citato art. 34, comma 3, del codice del processo amministrativo- richiamato, nel rito dei
contratti pubblici, dall’art. 125, comma 3- , il quale stabilisce che “quando nel corso del giudizio l’annullamento
del provvedimento non risulti più utile per il ricorrente il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste
l’interesse a fini risarcitori”. La diposizione consente che un’azione costitutiva di annullamento, non più
supportata dal necessario interesse, sia convertita in un’azione meramente dichiarativa di accertamento
dell’illegittimità, da far valere in un (anche successivo) giudizio di risarcimento. Si recepisce, in sostanza,
l’indirizzo ermeneutico, già tracciato da questo Consiglio (sez. V, 16 giugno 2009, n. 3849), secondo cui, a
fronte della domanda di annullamento inidonea a soddisfare l’interesse in forma specifica (nella specie veniva in
considerazione un provvedimento di espropriazione relativo ad aree non più restituibili in quanto
irreversibilmente trasformate), la pronuncia - nel caso in parola motivata con riguardo alla regula iuris sottesa
agli artt. 2058 e 2933 c.c. - deve limitarsi ad un accertamento dell'illegittimità, senza esito di annullamento, ai
soli fini della tutela risarcitoria invocabile con riguardo agli eventuali danni patiti per effetto dell'esecuzione del
provvedimento impugnato”.
In definitiva, dai dati normativi testuali contenuti nel Codice del processo amministrativo
emerge l’intenzione del legislatore di imboccare la strada dell’aticipità delle azioni, così come
recentemente affermata dalla giurisprudenza amministrativa.
Significativo, al riguardo, è l’art. 30 comma 1 c.p.a., che, contrariamente a quanto previsto nei
commi successivi che disciplinano le varie tipologie di azioni risarcitorie, contiene un
31
www.ildirittoamministrativo.it
riferimento all’azione di condanna, senza alcuna qualificazione restrittiva. L’ambito specifico di
applicazione della disposizione in commento sembra, pertanto, estendersi al di là dell’ambito
delle azioni risarcitorie, fino ad includere anche l’azione di condanna ad un facere specifico
consistente nell’emanazione di un provvedimento favorevole.
La disposizione, inoltre, precisa che l’azione di condanna atipica può essere proposta solo
“contestualmente ad altra azione”, vietando, di conseguenza, che essa possa essere esperita in via
autonoma.
L’autonoma proponibilità dell’azione di condanna è, infatti, ammessa esclusivamente nei casi di
giurisdizione esclusiva e “nei casi di cui al presente articolo”, ossia nelle ipotesi di condanna al
risarcimento del danno ingiusto, in forma generica o specifica, derivante dalla lesione di un
diritto soggettivo o di un interesse legittimo.
In tal senso, depone, altresì, l’art. 34, comma 1, lett. c) del Codice, che nel precisare i contenuti
della sentenza di condanna, prevede non soltanto il pagamento di una somma di denaro, anche
a titolo di risarcimento del danno (incluse le misure di risarcimento in forma specifica), ma
anche l’adozione “delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio”.
In ultimo, viene in rilievo la disposizione contenuta nella successiva lett. e) del medesimo
articolo, in base alla quale il giudice dispone “le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato”,
inclusa la nomina di un commissario ad acta con effetto dalla scadenza di un termine assegnato
per l’ottemperanza.
“Le due previsioni – come afferma il TAR - prefigurano un potere di condanna senza restrizione di oggetto,
modulabile a seconda del bisogno differenziato emerso in giudizio; ovvero, all’occorrenza, quale sbocco di una
tutela restitutoria, ripristinatoria ovvero di adempimento pubblicistico coattivo”.
Il Collegio, inoltre, si preoccupa di definire l’ambito di operatività della statuizione di condanna
atipica prevista dall’art. 34 c.p.a., precisando che la sua ammissibilità non può essere limitata ai
soli casi in cui il ricorrente pretenda l’esatto adempimento di obbligazioni rientranti nelle
materie devolute alla giurisdizione esclusiva.
Ad escludere una siffatta linea interpretativa sovvengono diverse considerazioni. In primo
luogo, il fatto che l’art. 34 c.p.a. “prevede che qualunque “situazione giuridica soggettiva” (quindi, anche di
interesse legittimo) possa essere tutelata mediante la condanna della p.a. ad adottare misure idonee a garantirne
la soddisfazione”.
32
www.ildirittoamministrativo.it
A ciò si aggiunge la considerazione “la pronuncia di condanna satisfattiva è già correlata ad una
corrispondente azione, in quanto l’art. 30 comma 1, configura l’azione di condanna in termini generali senza
distinguere fra condanna risarcitoria e condanna satisfattiva (appare, in tal senso, una inversione logica ritenere
che le disposizioni contenute nei commi successivi, riferite alla sola condanna al risarcimento del danno,
circoscrivano anche l’oggetto del primo comma)”.
“Ma ciò che non convince affatto – prosegue il Collegio - è l’assunto per cui il tipo di pronuncia che il giudice
può adottare ai sensi dell’art. 34 debba essere “supportata” da una corrispondente azione prevista negli articoli
precedenti”.
Difatti, precisa il TAR, la sede nella quale si definiscono e qualificano i bisogni di tutela e le
relative forme di tutela (restitutoria, satisfattiva, risarcitoria) non è certo la disciplina del
processo, bensì la legge sostanziale: “non a caso, nel codice di procedura civile, la distinzione delle azioni è
tratteggiata ai soli fini del regime della competenza, mentre non esiste una disciplina processuale delle azioni in
funzione dei diritti che con essa si fanno valere. Il codice del processo amministrativo, complice la peculiare
commistione tra “processo” e “sostanza” tipica degli strumenti di reazione avverso l’azione amministrativa
invalida, ha ritenuto opportuno enumerare all’art. 34 quei rimedi che, per quanto si trovino a stretto ridosso
della giurisdizione in quanto la loro concreta realizzabilità è assicurata dagli strumenti del processo, sono
tuttavia di pertinenza del diritto sostanziale; tale norma, pertanto, nel discernere le forme di tutela che
garantiscono il conseguimento delle utilità oggetto dell’aspettativa degli amministrati, rappresenta sul piano
sistematico ed ermeneutico il “prius”. L’art. 30 c.p.a., invece, da un parte, disciplina soltanto alcuni aspetti del
“veicolo” processuale del rimedio (i termini e la necessaria contestualità dell’azione di condanna ad altra azione,
salvo i casi di giurisdizione esclusiva e di condanna al risarcimento), che dunque costituiscono il “posterius”.
In definitiva, il rapporto tra l’art. 34 e l’art. 30 va propriamente invertito: dalla prima norma si
traggono quali rimedi sono a disposizione degli amministrati a tutela dei loro interessi; dalla
seconda alcuni specifici e complementari aspetti processuali (oltre che spezzoni di fattispecie
sostanziale).
Tale nuovo scenario processuale, così come descritto dal TAR Lombardia, costituisce la
traduzione normativa di un’evoluzione giurisprudenziale, caratterizzata da progressive “fughe in
avanti”, volte a superare i confini dell’impostazione tradizionale che escludeva la possibilità di
riconnettere alla sentenza amministrativa l’effetto di imporre una disciplina del rapporto tra
amministrazione e cittadino “sostitutiva” della disciplina dettata dall’atto annullato. Si reputava,
33
www.ildirittoamministrativo.it
infatti, che il giudice poteva conoscere del rapporto tra amministrazione e cittadino solo
attraverso lo “schermo” del problema di validità dell’atto amministrativo.
Tale impostazione “trovava conforto sia nella lettera dell’art. 45 t.u. Cons. St., secondo cui “la sentenza
amministrativa fa salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione”, sia nella collocazione istituzionale
(“nell’amministrazione”) di un giudice il cui intervento non poteva precludere la persistente disponibilità in capo
all’Autorità della disciplina dell’assetto degli interessi pubblici ed individuali. Tale “concorrenza” tra potere
amministrativo e potere giurisdizionale era, altresì, sottolineata dal fatto che l’esecuzione della sentenza doveva
avvenire “in via amministrativa” (art. 88 reg. proc. Cons. St.), quindi non negli stessi termini in cui il comune
cittadino è soggetto al giudicato civile”.
L’ordinamento processuale amministrativo, tuttavia, si è progressivamente affrancato dal
paradigma del mero accertamento giuridico di validità dell’atto, andandosi sempre di più a
sedimentare nella giurisprudenza sia “la visione che concepisce il giudizio amministrativo come strumento
di garanzia della legalità della azione amministrativa (e, conseguentemente, intende l’interesse legittimo come
“regola di coesistenza”, volta a conciliare l’interesse privato con quello pubblico)”, sia “l’idea di una
giurisdizione preordinata alla tutela di pretese sostanziali”.
L’abbattimento dell’impostazione tradizionale si è realizzato, in primo luogo, riconoscendo alla
sentenza un effetto non solo demolitorio, ma anche conformativo e ripristinatorio: “il giudice, si è
affermato, quando accerta l’invalidità dell’atto e le ragioni che la provocano, stabilisce quale è il corretto modo di
esercizio del potere e fissa la regola alla quale l’amministrazione si deve attenere nella sua attività futura.
Quanto più la sentenza è in grado di “convertire” l’insieme delle circostanze relative all’esercizio concreto di un
dato potere in un vincolo per l’Autorità, tanto più l’azione amministrativa successiva alla sentenza rappresenta
non la manifestazione di un potere “proprio” quanto la sua mera esecuzione”.
Peraltro, ha precisato il Collegio, “anche quando il contenuto ordinatorio della sentenza di accoglimento (di
per sé variabile in relazione al tipo di vizio riscontrato ed al tratto di potere dedotto in giudizio) consentiva una
ampia definizione della fattispecie sostanziale (giungendo, talvolta, finanche a prefigurarne l’assetto finale), esso
mai poteva tradursi in un espresso dispositivo di condanna, e ciò pur ammettendosi l’insorgere di un obbligo
pubblicistico in capo alla p.a. di ripristinare lo status quo ante e di conformarsi alle regole di azione statuite. La
“regola implicita, elastica, incompleta” della pronuncia sarebbe potuta divenire titolo esecutivo (ovvero,
statuizione concreta dei tempi e modi per adempiere all’obbligo) soltanto “progressivamente” nella successiva sede
del giudizio di ottemperanza”.
34
www.ildirittoamministrativo.it
Si trattava, dunque, di un’apertura interpretativa costretta a muoversi entro angusti spazi di
manovra, che non assicuravano al ricorrente l’effettività della tutela giurisdizionale. Da qui si
sono originate le successive tendenze legislative e giurisprudenziali, aventi il comune obiettivo
“di far convergere nel giudizio di cognizione, per quanto possibile, tutte le questioni dalla cui definizione possa
derivare una risposta definitiva alla domanda del privato di acquisizione o conservazione di un certo bene della
vita”.
Così, con particolare riguardo al profilo del sindacato giurisdizionale “è divenuta pacifica la
possibilità per il giudice di spingersi “oltre” la rappresentazione dei fatti forniti dal procedimento, nella
convinzione che quella degli apprezzamenti tecnici non sia un’area istituzionalmente “riservata” alla pubblica
amministrazione, giacché ciò che è precluso al giudice amministrativo è soltanto il giudizio di valore e di scelta che
“specializza” la funzione amministrativa, mentre l’interpretazione e l’accertamento dei presupposti della
fattispecie di cui il potere è effetto spetta al giudice; - le nuove tecniche di sindacato, punto di emersione della
“amministrazione di risultato” e della acquisita centralità che il bene della vita assume nella struttura
dell’interesse legittimo, hanno indotto il giudice ad un vaglio di ragionevolezza più penetrante rispetto al mero
riscontro di illogicità formale, in cui la qualificazione di invalidità dipende, più che dalla difformità rispetto ad
un parametro normativo, dalla devianza rispetto all’obiettivo il cui solo perseguimento legittima il potere della
Autorità”.
Analoghe aperture si sono avute anche sul fronte legislativo. In particolare, l’art. 21 octies,
comma 2, L. 241/90, che attribuisce alla p.a. la possibilità di introdurre nel processo anche fatti
non dedotti nell’atto o versati nel procedimento per dimostrare che il contenuto del
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, ha introdotto “la regola per cui il provvedimento
è valido (o, comunque secondo altra prospettazione, non è annullabile) quando la difformità dal diritto obiettivo
non abbia inciso sulla adeguata sistemazione degli interessi da esso operata”.
Ed ancora, “la codificata possibilità per il giudice amministrativo di accertare la fondatezza dell’istanza del
privato nell’ambito del giudizio sul silenzio è stata salutata come una conferma delle ricerche più avanzate su
oggetto e ruolo del processo (l’art. 2 comma 5 della l. 241/1990, ribadito dall’art. 31 c.p.a.)”.
Spetta, tuttavia, al codice del processo amministrativo il merito di avere abbandonato
definitivamente ogni residuo della concezione oggettiva del giudizio amministrativo di
annullamento come strumento di controllo dell’azione amministrativa, e di aver consolidato lo
spostamento dell’oggetto del giudizio amministrativo dall’atto, teso a vagliarne la legittimità alla
35
www.ildirittoamministrativo.it
stregua dei vizi denunciati in sede di ricorso e con salvezza del riesercizio del potere
amministrativo, al rapporto regolato dal medesimo, al fine di scrutinare la fondatezza della
pretesa sostanziale azionata, sempre che non vi si frapponga l’ostacolo dato dalla non
sostituibilità di attività discrezionali riservate alla pubblica amministrazione (così l’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato, 23 marzo 2011 n. 3; ma alle medesime conclusioni era pervenuta
anche una consistente parte della dottrina amministrativistica).
La nuova “visione” del processo sta, soprattutto, nell’aver radicato tra le attribuzioni del giudice
della cognizione il potere, una volta spendibile solo nella successiva sede dell’ottemperanza, di
disporre le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese,
ivi compresa la nomina di un commissario ad acta (art. 34 comma 1 lettera e): “le misure attuative,
talvolta, saranno limitate alla sola definizione dei modi di riesercizio del potere; altre volte, invece, quando
l’accoglimento della questione di legittimità non lasci residuare margine alcuno per soluzioni alternative, potranno
spingersi a statuire in via satisfattiva sulla spettanza del provvedimento richiesto; all’occorrenza, con la nomina
del commissario, le misure potranno anche essere esecutive e sostitutive”.
Dunque, il legislatore, con la previsione generale di cui all’art. 34 c.p.a., ha aperto le porte
all’ammissibilità nel processo amministrativo dell’azione di esatto adempimento, consentendo al
ricorrente di ottenere una pronuncia che ordina alla P.A. di emettere il provvedimento
ampliativo da essa illegittimamente denegato.
Si tratta, comunque, di un recupero non incondizionato, ma sottoposto a precisi limiti. Difatti,
il Codice pone importanti paletti, che hanno come scopo quello di salvaguardare l’autonomia
dell’azione amministrativa.
Al riguardo, viene in rilievo, in primo luogo, l’art. 7 comma 6 c.p.a., a tenore del quale, in sede
di giurisdizione di legittimità, il giudice amministrativo non può sostituirsi all’Amministrazione.
Ne deriva, pertanto, l’impossibilità per il giudice di adottare una sentenza di condanna
all’adozione di un determinato provvedimento ampliativo laddove residuino in capo
all’Amministrazione poteri di valutazione discrezionale.
In secondo luogo, il giudice amministrativo potrà limitarsi a condannare l’Amministrazione ad
emettere un certo provvedimento, ma non anche ad adottare direttamente l’atto richiesto,
poiché tale potere è consentito, ai sensi dell’art. 34 comma 1 lett. d), solo nelle ipotesi di
giurisdizione di merito.
36
www.ildirittoamministrativo.it
Infine, il Codice pone importanti limiti ai poteri decisori del giudice amministrativo, statuendo
al comma 2 dell’art. 34 il divieto di pronunciare “con riferimento a poteri amministrativi non ancora
esercitati”.
Nonostante le difficoltà interpretative della locuzione in esame, sembra che al divieto in parola
debba attribuirsi il significato per cui è preclusa qualunque forma di azione giurisdizionale
prima che la P.A. abbia provveduto o che sia scaduto il termine per provvedere. Una volta
verificatisi tali presupposti processuali, il giudice amministrativo può accertare se sussistono le
condizioni di fatto per l’emanazione del provvedimento favorevole illegittimamente omesso o
denegato con il solo limite di non potersi sostituire all’Amministrazione nell’effettuazione di
valutazioni discrezionali.
“È ben possibile, però – ha precisato il TAR Lombardia nella sentenza in rassegna - che anche una
attività “in limine litis” connotata da discrezionalità possa, a seguito della progressiva concentrazione in giudizio
delle questioni rilevanti (ad esempio, mediante il combinato operare di ordinanza propulsiva e motivi aggiunti),
risultare, all’esito dello scrutinio del Giudice, oramai “segnata” nel suo sviluppo. Il caso che ci occupa in concreto
ne offre un cospicuo esempio. Se pure non può dirsi attualmente condivisa dalla comunità giuridica l’opinione
secondo cui l’amministrazione esaurirebbe con il primo provvedimento di rigetto la propria discrezionalità (è la
tesi autorevolmente proposta da quanti interpretano il preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/90 come norma
obbligante l’amministrazione ad indicare, in sede di preavviso di rigetto e con il finale diniego, tutti i motivi
ostativi), essendo dai più riconosciuta (anche dopo un primo annullamento) la possibilità di emettere un nuovo
atto di diniego per motivi diversi da quelli indicati, tuttavia, deve ritenersi vincolata l’attività amministrativa
successiva al secondo annullamento sulla medesima istanza pretensiva. Quest’ultimo assunto si riallaccia a
quell’orientamento pragmatico e ragionevole della giurisprudenza amministrativa secondo il quale, in tali casi, il
punto di equilibrio fra gli opposti interessi va determinato imponendo all’amministrazione (dopo un giudicato da
cui derivi il dovere o la facoltà di provvedere di nuovo) di esaminare l’affare nella sua interezza, sollevando, una
volta per tutte, le questioni che ritenga rilevanti, dopo di ciò non potendo tornare a decidere sfavorevolmente
neppure in relazione ai profili non ancora esaminati (cfr. Cons. Stato, V, 134/99; Cons. Stato, VI,
7858/04). Le argomentazioni sopra ampiamente svolte sull’evoluzione del processo consentono di applicare il
medesimo principio anche nella consimile ipotesi in cui l’amministrazione venga reinvestita della questione a
seguito di “remand” (tecnica cautelare che si caratterizza proprio per rimettere in gioco l’assetto di interessi
definiti con l’atto gravato, restituendo quindi all’amministrazione l’intero potere decisionale iniziale)”.
37
www.ildirittoamministrativo.it
Sulla scorta di tali considerazioni il TAR Lombardia ha affermato la fondatezza della pretesa di
trasferimento avanzata dal ricorrente, annullando i dinieghi opposti dall’Amministrazione e
ordinando a quest’ultima l’adozione del relativo provvedimento di trasferimento.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 8 giugno 2011, n. 3505
Anche nell’ambito del processo amministrativo, in applicazione analogica dell'art. 83
c.p.c., la procura speciale alle liti si presume conferita soltanto per un determinato
grado del processo quando nell'atto non è espressa volontà diversa, mentre è ammesso
un unico mandato per lo svolgimento dell'intero processo, nei due gradi di merito, ove
tale volontà sia inequivocabilmente manifestata. Tale tesi non appare sconfessata
dall’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, che all’art. 24 disciplina la
procura speciale nell’ambito delle disposizioni generali, e non in relazione ai singoli
gradi del processo.
Con la sentenza in rassegna il Supremo Consesso della giustizia amministrativa ha affrontato la
questione della necessità o meno di una procura speciale per il ricorso in appello davanti a sé
medesimo.
Sul punto si registra un contrasto giurisprudenziale. Difatti, secondo un primo fronte
giurisprudenziale (Consiglio di Stato, sez. V, 22 giugno 1989, n. 389) per l’appello al Consiglio
di Stato occorre un nuovo mandato, dato che nel processo amministrativo, come anche nel
giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, vale il principio del conferimento di una nuova delega
per il superiore grado di giudizio.
Secondo altro filone interpretativo (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 gennaio 1990 , n. 62 e sez. V,
6 marzo 1990 , n. 262), sposato anche dalla giurisprudenza più recente (Consiglio di Stato, sez.
VI, 3 aprile 2007, n. 1514), e a cui aderisce la Sezione IV con la sentenza in esame, la procura
speciale ad litem conferita con riferimento al giudizio in primo grado può essere estesa al grado
di appello, ai sensi dell’art. 83 comma ultimo c.p.c., allorché la volontà del ricorrente sia in tale
direzione desumibile dal contesto della procura medesima, idonea a superare la presunzione
semplice o iuris tantum della sua limitazione al giudizio dinanzi al TAR.
In definitiva, alla luce del più recente indirizzo giurisprudenziale, deve affermarsi il principio di
diritto per cui anche nell’ambito del giudizio amministrativo “in applicazione analogica dell’art. 83
c.p.c., la procura speciale alle liti si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando
nell’atto non è espressa volontà diversa, mentre è ammesso un unico mandato per lo svolgimento dell’intero
38
www.ildirittoamministrativo.it
processo, nei due gradi di merito, ove tale volontà sia inequivocabilmente manifestata. Tale tesi non appare
sconfessata dall’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, che all’art. 24 disciplina la procura
speciale nell’ambito delle disposizioni generali, e non in relazione ai singoli gradi del processo”.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 15 giugno 2011, n. 3625
Ai fini dell’ammissibilità del ricorso collettivo, occorre che vi sia identità di situazioni
sostanziali e processuali e cioè che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto.
In caso di ricorso collettivo, è onere di ciascun ricorrente indicare il proprio status e le
spettanze rivendicate in relazione a tale posizione, in quanto, stante l'unicità del
giudizio amministrativo, il giudice non può limitarsi a pronunciare soltanto la
condanna al pagamento delle somme dovute in via generica, rimettendo ad altro
giudizio la quantificazione del dovuto, ma è tenuto a condannare la pubblica
amministrazione al pagamento del quantum spettante a ciascun interessato che abbia
proposto ricorso.
Con la sentenza in rassegna il Consiglio di Stato si pronuncia in tema di ricorso collettivo,
ribadendo l’orientamento espresso dalla giurisprudenza più recente, secondo cui l’ammissibilità
di tale ricorso, in quanto deroga al principio secondo il quale ogni domanda proposta al giudice
amministrativo deve essere fatta valere dal singolo titolare della situazione giuridica soggettiva
con separate azioni, richiede che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali e cioè che
le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto (Cons. Stato, V, 24 agosto 2010, n. 5928).
Inoltre, precisa ulteriormente il Collegio, in caso di ricorso collettivo col quale pubblici
dipendenti chiedono la condanna della pubblica amministrazione al pagamento di somme
dovute in ragione di un diverso trattamento economico, “l'indicazione per ciascun ricorrente della
relativa posizione di status (attuale posizione di servizio ed eventualmente posizioni pregresse, anzianità di
servizio, ecc.) e, ancor meglio, delle spettanze rivendicate rispetto a tale posizione, costituisce il necessario
presupposto per l’ammissibilità della loro azione diretta alla condanna della pubblica amministrazione, in
quanto, stante l'unicità del giudizio amministrativo, il giudice non può limitarsi a pronunciare soltanto la
condanna al pagamento delle somme dovute in via generica, rimettendo ad altro giudizio la quantificazione del
dovuto, ma è tenuto a condannare la pubblica amministrazione al pagamento del quantum spettante a ciascun
interessato che abbia proposto ricorso (Cons. Stato, V, 17 maggio 2005, n. 2447)”.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 16 giugno 2011, n. 3662
39
www.ildirittoamministrativo.it
La sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione può conseguire a qualsiasi
mutamento della situazione di fatto, oltre che di quella di diritto, purché idoneo a
rendere certa e definitiva la privazione di qualsiasi utilità, anche indiretta o strumentale,
in capo all’originario ricorrente per effetto di un ipotetico accoglimento della sua
domanda.
Con la sentenza in rassegna il Consiglio di Stato ha ribadito il consolidato orientamento
interpretativo secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione può
conseguire a qualsiasi mutamento della situazione di fatto, oltre che di quella di diritto, purché
idoneo a rendere certa e definitiva la privazione di qualsiasi utilità, anche indiretta o
strumentale, in capo all’originario ricorrente per effetto di un ipotetico accoglimento della sua
domanda (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. V, 10 settembre 2010, nr. 6549; id., 13 luglio 2010,
nr. 4540; id., 11 maggio 2010, nr. 2833).
Ne discende che, ai fini del verificarsi della situazione sopra richiamata, non è indispensabile
che il provvedimento originariamente impugnato sia sostituito da un nuovo provvedimento
definitivo, bastando che sia comunque certo il definitivo superamento della sua possibile
efficacia, in modo da determinare la suindicata privazione di utilità dell’impugnazione.
Alla stregua di tali principi giurisprudenziali il Supremo Consesso di giustizia amministrativa ha
dichiarato improcedibile l’appello incidentale proposto dall’Associazione Nazionale Italia
Nostra Onlus, sulla scorta di motivi sovrapponibili a quelli articolati dalla Regione Puglia
nell’appello principale proposto dalla medesima avverso la sentenza con la quale la Sezione di
Lecce del T.A.R. della Puglia ha respinto i ricorsi proposti dalla stessa Amministrazione e da
altri soggetti, tra cui anche l’associazione sopramenzionata.
Il Collegio è pervenuto a tale esito interpretativo in considerazione della rinuncia all’appello
ritualmente notificata e depositata dalla Regione Puglia, ai sensi dell’art. 84 c.p.a., a fronte
dell’accordo intervenuto fra le Amministrazioni interessate, con il quale è stata concordata una
modifica progettuale tale far venir meno l’interesse dell’Associazione Nazionale Italia Nostra
Onlus alla prosecuzione del giudizio, stante che l’impugnazione proposta da quest’ultima
appariva sostanzialmente sovrapponibile a quella della Regione Puglia, essendo fondata sulle
medesime ragioni di fatto e di diritto (violazione delle prerogative regionali in sede di
progettazione definitiva).
40
www.ildirittoamministrativo.it
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 10 giugno 2011, n. 3513
Per effetto delle importati modifiche intervenute con l’art. 69 Legge n. 69 del 2009
devono ritenersi superate le perplessità in ordine all’esperibilità del rimedio del ricorso
in ottemperanza al fine di ottenere la esecuzione del decreto decisorio del ricorso
straordinario.
La sentenza in rassegna prende in esame la questione della natura giuridica del ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica e del connesso profilo dell’ammissibilità del
giudizio di ottemperanza ai fini della esecuzione della relativa decisione, alla luce delle recenti
modifiche intervenute con l’art. 69 Legge n. 69 del 2009 e il nuovo Codice del processo
amministrativo.
Difatti, il ricorso straordinario ha subito un mutamento di volto per effetto delle modifiche
intervenute dall’art. 69 Legge n. 69/2009.
Detta norma, in primo luogo, riscrivendo l’art. 13 del D.P.R. 1199/1971, ha previsto che il
Consiglio di Stato, in sede di espressione del parere sul ricorso, può sollevare questione di
legittimità costituzionale: “ciò a definitivo superamento delle opposte considerazioni in passato espresse dalla
Corte costituzionale,nella decisione 17 dicembre 2004, n. 392 e che costituivano il più rilevante argomento per i
sostenitori della tesi della non piena giurisdizionalizzazione del ricorso straordinario”.
Detta legittimazione costituisce, dunque, una conseguenza della natura giurisdizionale del
Consiglio di Stato, come tale legittimato a sollevare una questione incidentale di legittimità
costituzionale.
In secondo luogo, l’art. 69, riformulando anche l’art. 14, commi 1 e 2 del DPR 1199/1971, ha
eliminato la possibilità dell’Amministrazione di discostarsi dal parere del Consiglio di Stato,
sottoponendolo al Consiglio dei Ministri.
Il parere del Consiglio di Stato acquisisce, dunque, natura vincolante rispetto alla proposta del
Ministro e alla conseguente decisione del Capo dello Stato.
Detta modifica rende il parere del Consiglio di Stato non più atto amministrativo consultivo,
bensì atto decisorio finale.
Tali innovazioni legislative hanno comportato il consolidamento in seno alla giurisprudenza e
alla dottrina della tesi della progressiva giurisdizionalizzazione piena del ricorso straordinario,
come sostenuto a più riprese dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana,
anche prima della riforma del 2009, e di recente ribadito nella sentenza 21 marzo 2011, n. 242.
41
www.ildirittoamministrativo.it
Il punto più avanzato di tale processo evolutivo è rappresentato dal riconoscimento in sede
comunitaria della possibilità di porre questioni pregiudiziali ai sensi dell’ art. 267 (ex art. 234) del
Trattato Ce (Corte giustizia CE, 16 ottobre 1997, n. 79).
Ne consegue che “il ricorso straordinario al Capo dello Stato costituisce un rimedio giustiziale che si colloca
in simmetrica alternativa con quello giurisdizionale ancorché di più ristretta praticabilità quanto al novero delle
azioni esperibili (Consiglio Stato , sez. III, 15 ottobre 2010 , n. 4609)”.
L’adesione alla tesi della giurisdizionalizzazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ha
comportato importanti ricadute in punto di ottemperanza, stante che la recente giurisprudenza
della Suprema Corte di Cassazione ha superato le perplessità che si opponevano alla esperibilità
del rimedio del ricorso in ottemperanza al fine di ottenere la esecuzione del decreto decisorio
del ricorso straordinario.(Cassazione civile, Sezioni Unite, 28 gennaio 2011, n. 2065).
In particolare, nella sentenza appena menzionata il Giudice di legittimità ha affermato che l'art.
112, nel dettare le "disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza", dispone, al comma 2,
che l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze del
giudice amministrativo passate in giudicato (lett. o) e, altresì, delle sentenze esecutive e degli
altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo (lett. b), oltre che delle sentenze passate
in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario (lett. c), nonché
delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non
sia previsto il rimedio dell'ottemperanza (lett. d) e dei lodi arbitrali esecutivi divenuti
inoppugnabili (lett. e).
In maniera corrispondente, il successivo art. 113, nell'individuare il giudice dell'ottemperanza,
dispone che il ricorso si propone, nel caso di cui all'art. 112, comma 2, lett. a) e b), al giudice
che ha emesso il "provvedimento" della cui ottemperanza si tratta (essendo competente il
tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con
motivazione del tutto conforme) (comma 1), mentre nei casi di cui all'art. 112, comma 2, lett. c),
d) ed e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha
sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza (comma 2), secondo un
sistema fondato sulla netta distinzione fra l'ottemperanza di sentenze e altri provvedimenti del
giudice amministrativo (art. 112, comma 2, lett. a) e 6)), per i quali è prevista la competenza del
giudice amministrativo che ha emesso la sentenza o il provvedimento, e quella di sentenze
42
www.ildirittoamministrativo.it
passate in giudicato, o altri provvedimenti ad esse equiparati, del giudice ordinario o di altri
giudici, nonché di lodi arbitrali divenuti inoppugnabili (art. 112, comma 2, lett. c), d) ed e)), per i
quali è competente il tribunale amministrativo regionale secondo il criterio di collegamento
previsto dall'art. 113, comma 2.
Nel sistema così delineato la decisione su ricorso straordinario al Capo dello Stato, resa in base
al parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato, si colloca nella ipotesi prevista alla
lettera b) dell'art. 112, comma 2, e il ricorso per l'ottemperanza si propone, ai sensi dell'art. 113,
comma 1, dinanzi allo stesso Consiglio di Stato, nel quale si identifica “il giudice che ha emesso
il provvedimento della cui ottemperanza si tratta”.
Del resto, conclude il Collegio, “non è arbitrario affermare che non è dubitabile che il petitum proposto in
sede di ricorso straordinario sia perfettamente equiparabile (e produca lo stesso effetto) ad una “domanda
giudiziale”. Difatti, “costituirebbe inammissibile antinomia, ed aporia in grado di mettere in crisi il disegno
legislativo duale ed alternativo sinora sommariamente descritto, un principio che negasse la possibilità di esperire
il rito dell’ottemperanza per ottenere che l’amministrazione si conformi a detto decisum (così sostanzialmente
svalutando la portata del giudizio impugnatorio in sede di ricorso straordinario qualificandolo “minus” rispetto a
quello esperibile innanzi agli organi giurisdizionali della giustizia amministrativa)”.
In definitiva, “l’effettività del parallelismo e dell’alternatività dei due rimedi impone che – nelle materie e
limitatamente alle domande per cui è proponibile ricorso straordinario- tale rimedio appresti un grado di tutela
non inferiore a quello conseguibile agendo giudizialmente. Ed in tale affermazione è compresa la possibilità di
esperire il ricorso per l’ottemperanza al fine di ottenere l’esecuzione del decreto presidenziale”.
43
Scarica