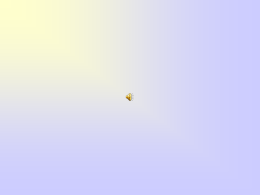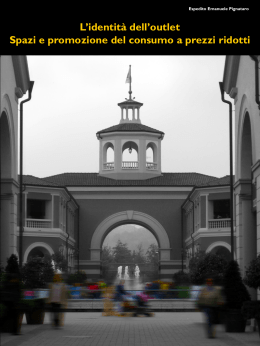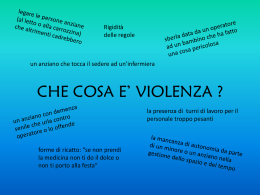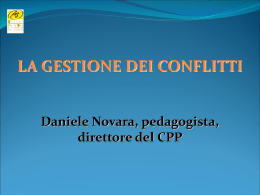Per una critica alla ideologia italiana Per una critica alla ideologia italiana #2 2012 #2 2012 TRIMESTRALE Conflitti Per una critica della ideologia italiana L’IMMAGINE DI COPERTINA Apparizioni: Angel soldier di Lee Yongbaek L’IMMAGINE DI COPERTINA Lee Yongbaek (Kimbo – Korea, 1966), lavora e vive a Seoul. Dopo aver conseguito il titolo di laurea presso il College of Fine Arts, Hongik University, Korea (1990), continua il suo percorso di studi in Germania nella Stattliche Akademie der bildende Keunste di Stoccarda. Attraverso l’utilizzo di differenti media, la sperimentazioni delle nuove tecnologiche, l’artista affronta tematiche sociali e politiche percorrendo l’universo contemporaneo e le sue contraddizioni. I suoi interventi, video, fotografici, installativi, transitano lungo il binario realtà-finzione, oltre il quale è possibile immaginare e ricostruire scenari attuali, tangibili dimensioni fantastiche. Artista di fama internazionale, è chiamato a rappresentare il suo Paese alla cinquantaquattresima edizione della Biennale di Venezia. di Massimiliano Di Franca Immersi in un incantevole distesa di fiori, dei soldati ci puntano, lucidissime armi fuoriescono da un ammaliante e inquietante tappeto floreale. L’artista coreano Lee YoungBaek chiamato a rappresentare il suo Paese alla 54 Biennale di Venezia, ricostruisce minuziosamente dei set fotografici e video, ricreando un metagiardino che nasconde uomini in divisa in procinto di spararci. Tutto accade a nostra insaputa, è troppo tardi quando scopriamo che dei militari ci tengono sotto mira, ma la tentazione di avvicinarsi supera ogni prudenza, anche a rischio di perdere la vita. Questo spaesante e innaturale giardino delle delizie ci riserva una magica trappola, una duplice visione, un doppio colpo. La meraviglia seguita dalla minaccia. Nei meandri bidimensionali di questa fotografia dai colori brillanti, tra i finti drappeggi di questo Eden, oltre l’appariscente flora sospesa e avvolgente, si mimetizzano uomini con posture da guerriglia. L’opera seduce lo spettatore riducendo la distanza che intercorre tra i due, il fruitore catturato da questa ambivalenza viene catapultato dentro 2 OUTLET l’opera al fine di comprenderne i differenti livelli di lettura, le molteplici velature, la mimesi. Assuefatti dal forte odore, rilasciato dai fiori e diffuso per tutto il sentiero che ci riporta dalla foto alla dimensione tridimensionale, continueremo a scrutare con attenzione ogni cosa, forse anche a guardarci le spalle da qualsiasi altro camaleontico soldato travestito da angelo. Siamo di fronte all’annunciazione di uno scontro, avvenuto tra due termini opposti che insieme danno il titolo a questa opera, la sacralità dell’angelo e la prepotente figura del soldato, disciolti sopra questo coloratissimo e ingannevole tappeto di fiori. Angel Soldier è l’accostamento di due entità aventi missioni contrapposte, voci inverse congiunte al fine di generare una dissonanza percettiva, un cortocircuito tra cielo e terra, dove l’assenza di tensione genera un conflitto, ma anche una presa di coscienza. Siamo di ritorno da uno spazio che abbiamo scoperto essere politico, sociale, mediatico, abbagliante e reale quanto finto. OUTLET 3 L’IMMAGINE DI COPERTINA L’IMMAGINE DI COPERTINA Lee Yongbaek Angel Soldier Photo #01 2011 Digital C-Print, Diasec 180x 225 cm Courtesy and copyright © the artist OUTLET Per una critica dell’ideologia italiana #2 2012 trimestrale Se prendete delle foto delle ultime rivolte che ci sono state sulla Spianata delle Moschee a Gerusalemme, in Cina, Bangladesh, Venezuela, Spagna, Turchia o ad Atene, vi troverete di fronte agli stessi visi mascherati, le stesse paure, la stessa rabbia e lo stesso fuoco. Si tratta, di fronte ai processi di globalizzazione che caratterizzano l’intero pianeta, di una sorta di messa in discussione complessiva dello spazio della rappresentanza politica: uno spazio che è la rivolta stessa a voler occupare. Alain Bertho direttore editoriale Massimo Ilardi direttore responsabile Piero Sansonetti Redazione Katia Ippaso (responsabile) Alessandro Antonelli Angela Azzaro Giorgio Cappozzo Andrea Colombo Nanni Riccobono OUTLE TT progetto grafico e impaginazione Claudia Mandolini photo editor Viviana Gravano Massimiliano Di Franca Hanno collaborato a questo numero Marco Bascetta Federico Tomasello Emilio Quadrelli Monia Cappuccini Luca Fondacci Alain Bertho Guido Caldiron Alessio Ceccherelli Roberto De Angelis Enzo Scandurra Carlo Cellamare Alberto Speroni Luisa Valeriani Paolo Vernaglione Carola Susani Giuseppe Manfridi Laura Eduati Fabrizio Violante Simona Bonsignori Le immagini sono di Christian Piana La copertina Lee Yongbaek www.outletrivista.it 6 OUTLET OUTLET 7 INDICE OUTLET #2 Conflitti 11 16 22 26 33 39 45 53 APERTURE * Il conflitto negli anni del consumo totale * I nostri contratti sono carta straccia * Le rudi razze pagane non sono scomparse * Rivolte * L’esclusione ovunque * Quali strade? Le nostre strade! * Italia burning Massimo Ilardi Marco Bascetta Andrea Colombo Federico Tomasello Emilio Quadrelli Monia Cappuccini Luca Fondacci 98 86 * Il conflitto dopo la guerra le immagini di Christian Piana Massimiliano Di Franca POSIZIONAMENTI 105 112 116 * Black bloc, ovvero della violenza divina * Il ritiro delle donne dal patto sociale * Epopea ultras Paolo Vernaglione Carola Susani Giuseppe Manfridi INTERVISTA * Il tempo della sommossa: a colloquio con il sociologo Alain Bertho Guido Caldiron 123 62 68 74 80 FOTOGRAFIE RICADUTE * Apologia del furto d’auto * Illegal social housing * Il ritorno dei luoghi nello scontro tra culture * Gli spazi contesi Alessio Ceccherelli Roberto De Angelis Enzo Scandurra Carlo Cellamare DIALOGHI 128 134 139 REPORTAGE * «Io ci metto un minuto a guadagnare 50 euro» Laura Eduati RILETTURE CRITICHE * Il gran rifiuto di Bianciardi lo scrivano * Se agli anni di piombo manca il piombo Katia Ippaso Fabrizio Violante CONFRONTI * Dormire nel lettone fa bene Simona Bonsignori * Non so se è barbaro, però mi piace Alberto Speroni e Luisa Valeriani 8 OUTLET OUTLET 9 APERTURE Il conflitto negli anni del consumo totale APERTURE GLI SCONTRI SOCIALI ESPLODONO OGGI NON PIÙ PER PREFIGURARE O COSTRUIRE IL FUTURO, MA PER APPROPRIARSI DEL PRESENTE E PER L’ACCESSO ALLA RICCHEZZA. di Massimo Ilardi C ome dare forma alle pratiche di libertà anarchiche, individualiste, antistituzionali, violente che attraversano la metropoli contemporanea: una delle questioni centrali per la politica sembra essere questa. Ma è proprio qui, su questa incapacità che si consuma la sua crisi. Non si tratta solo di crisi delle sue forme organizzative, della deriva del suo ceto dirigente, del crollo dei suoi istituti per la rappresentanza, si tratta di qualcosa di più: di mancanza di una cultura all’altezza dei tempi che la rendono insensibile a quel mondo della pura contingenza, della intensità dei desideri, dell’eccesso di presente che sono le modalità in cui le vite di uomini e donne si danno. Nell’era del consumo totale la libertà non è un viaggio interiore. Essere liberi non vuol dire “pensarsi” liberi o costruirsi una differente coscienza di sé: essere liberi è una pratica che si dispiega e si materializza immediatamente sul territorio contro ogni impedimento e contro ogni etica della responsabilità che ne vogliono ostacolare la marcia. L’idea di una libertà assoluta, collocata in un tempo e in un luogo neutro, è un’astrazione che non può valere neppure come un’idea regolativa o come principio guida. È a livello locale che si gioca la partita. Se dimentichiamo questo, precipitiamo di nuovo dentro la città del moderno, quando la mediazione politica era possibile perché erano 10 OUTLET OUTLET 11 APERTURE gli ordini simbolici universali a dettare le identità. Non è sul terreno del simbolico che si innesca oggi il conflitto tra ordine e disordine, ma su quello più effimero dei segni e dei marchi che saranno pure drogati dal consumo ma rimangono, piaccia o no, il luogo dove oggi l’immaginario collude con la realtà, dove le identità scompaiono e si impongono la pluralità delle appartenenze non più legate all’ideologia ma a culture e mentalità. A questo comportamento, che fonda la prima legge di movimento di una società del consumo, la politica non sa rispondere, si rifugia nell’ autoreferenzialità, trova più comodo accusare di antipolitica quello che si sottrae alle sue briglie e a un mondo di valori precostituiti, che prende corpo fuori della tutela non solo formale della legge e della legalità, che rinnega il passato trasmesso come pura eredità. Questi stessi valori, questa stessa legalità, questo stesso passato che invece la politica vuole ancora usare come fattori immutabili di coesione e di ordine. La politicizzazione del sociale, che per l’agire politico è lo strumento essenziale per esercitare egemonia, non avviene più, semmai sia avvenuta, attraverso l’utopia di un altro mondo possibile, ma dentro la capacità di tradurre in conflitto il mondo che già c’é. Ma che cos’è oggi il mondo? Non è forse disegnato dalla merce e dal consumo che hanno reso anacronistico ogni valore e, dunque, ogni istanza di forma? E l’uomo non coincide forse con l’individuo consumatore che distrugge sistematicamente comunità, identità, relazioni, affettività, forme di rappresentanza? Ma si dirà: è proprio di fronte a queste condizioni che la politica deve opporre la propria specificità, perché è dentro questa opposizione che trova il suo fondamento. È vero, ma è anche vero che proprio sulla misura di questo fondamento si gioca la possibilità di un ritorno del primato della politica. Perché se si ritiene che questo fondamento debba affondare le sue radici in culture universalistiche, indifferenziate, generiche, eternamente perdenti che presto si esauriscono e inaridiscono non riuscendo mai a praticare una egemonia culturale e tanto meno a cambiare i rapporti di forza a livello sociale – mi riferisco, ad esempio, all’ideologia del pacifismo, del lavorismo, del giustizialismo fino ad arrivare oggi al movimento dei cosiddetti “beni comuni – le possibilità di questo ritorno equivalgono a zero. Il conflitto esplode oggi non più per prefigurare o costruire il futuro ma per appropriarsi del presente e per accedere al consumo: se è così, la politica allora non può rappresentare contro l’anarchia della realtà l’idea di un tutto, “forma gloriosa” di una universalità che si erge ancora una volta a totalità di un intelletto “separato” dal mondo. Cosa si oppone al pensiero unico del sistema di mercato? Una forma assoluta che pretende di rappresentare il corpo mistico di un’idea che non si vuole incarnare nel mondo? La politica ha bisogno invece di soluzioni, di punti fermi che la inchiodino al suolo. Ha bisogno di territorializzare e di perimetrare, ha necessità di nominare i “luoghi” se vuole avere qualche pur minima possibilità di governarli. È un problema appunto che riguarda non i valori ma la cultura, una cultura che metta al centro proprio quello che la politica ha perso di vista, e cioè il 12 OUTLET APERTURE conflitto sociale. Occorre tornare a fare teoria, teoria dei conflitti e dei soggetti, teoria di parte che scavi dentro contesti materialmente determinati. I conflitti sociali sono di conseguenza il tema centrale di questo numero. E, d’altra parte, nelle metropoli del mondo, dopo Seattle (1999) e Genova (2001), quello che sembra emergere è proprio l’esplosione di nuove forme di conflittualità. Esse sono determinate: 1. dall’assenza dei movimenti e dei grandi soggetti istituzionali (partiti e sindacati). Non esiste nulla che possa saldare i diversi conflitti verso un’unica organizzazione o un unico scopo. A scatenarli sono ora piccoli gruppi unificati da interessi immediati e privi di motivazioni ideologiche, che puntano direttamente allo scopo senza acquisire mai struttura organizzativa stabile. Il conflitto diventa autonomo dai grandi soggetti, si sottrae alla loro pensabilità, non fa riferimento ad alcuna contraddizione generale e, dunque, si dichiara insondabile agli strumenti della razionalità politica. Non a caso, i protagonisti degli scontri non riescono mai a salire al ruolo di soggetti politici. Per questo vanno decifrati sociologicamente e non economicamente, proprio perché inadeguati a tradurre in politica la loro carica conflittuale. Incapaci di produrre soggettività politica, e cioè identità centrate, responsabili, durature, danno vita invece ad azioni, comportamenti, gesti che si esauriscono nel momento stesso del conflitto; 2. 3. dalla possibilità di individuare, nonostante questa frantumazione degli scopi e degli obiettivi, alcuni comportamenti che identificano i protagonisti delle lotte e che portano a definire una cultura in comune che distribuisce appartenenze e disegna mentalità: non il lavoro è al primo posto ma il consumo, non la democrazia ma la libertà, non la distruzione del sistema ma la violazione del suo ordine e delle sue gerarchie, non il tempo del futuro ma lo spazio del presente. Nessuna meta ideale, niente che assomigli a “qualcosa che non siamo e che dobbiamo essere”; dalla centralità che assume il territorio. Per due motivi: primo, perché la domanda di libertà, non quella astratta dei diritti ma quella materiale innescata dai desideri, cresce in un luogo concreto e in un tempo preciso e risponde sempre alle domande: chi sono i soggetti che la chiedono? dove la chiedono? come raggiungerla? quando? Secondo, perché nella metropoli dell’iperconsumo, priva di valori e di futuro e dove le utopie e i desideri si proiettano sul terreno per la loro immediata realizzazione, è solo la realtà tellurica che riconosce la “parte” e individua le differenze. Il soggetto perde la sua impotenza metafisica, si OUTLET 13 APERTURE APERTURE definisce unicamente in base alle sue continue dislocazioni territoriali. Quello che ne viene fuori é un territorio che si struttura esclusivamente in connessione ai diversi rapporti di forza che man mano vi si esercitano; 4. da una violenza incontrollata che sconfina, in molti casi, nella dimensione di una guerra civile a bassa frequenza. Questo sembra dar ragione a Hans Enzensberger quando affermava, già alcuni anni fa, che in realtà la guerra civile ha fatto il suo ingresso nelle metropoli contemporanee, una guerra civile molecolare dovuta alla perdita dei principi e dei grandi valori universali. Ogni discorso sul rifiuto o meno della violenza non può a questo punto che partire da qui: dal crollo della città del moderno che con il suo primato della politica mediava i conflitti, e dall’espansione della metropoli dell’iperconsumo che ha invece il suo fondamento nell’individuo e nella sua libertà di scelta. Afferma Mike Davis che la concezione riformista dello spazio pubblico, come emolliente del conflitto sociale e come fondazione di una polis, è ormai divenuta obsoleta quanto i precetti keynesiani del pieno impiego. Se non teniamo conto di tutto questo non solo non capiremo i conflitti ad alta intensità che hanno investito le metropoli in questi ultimi dieci anni, ma neanche quell’arcipelago spontaneo di pratiche di ribellione e di violenza senza nome che si dispiega nei territori urbani e che incarna una violenza priva di mediazioni, di spessore temporale, di una ideologia che la sostenga. Violenza come puro scontro esistenziale, senza compromessi, dove si può solo vincere o soccombere. L’altro non ha legittimità, può solo sparire. Scopo del conflitto diventa quello di provocare e di innescare il conflitto stesso. Una visione conflittuale assoluta che assegna non identità ma appartenenze, tanto lucida e consapevole da portare a ogni costo allo scontro. «Per questo le periferie mi interessano – dichiara J.G.Ballard – perché vedi accadere il futuro. Lì ti devi svegliare al mattino e devi decidere di compiere un atto deviante o antisociale, perverso, foss’anche prendere a calci il cane, per poter affermare la tua libertà». Violenza e libertà: un binomio difficile da separare. Ma su questo punto la violenza rimane l’unica forza in grado di fare chiarezza: la violenza crea caos ma è il ristabilimento dell’ordine a creare violenza e questo dilemma è irrisolvibile, afferma Wolfgang Sofsky; 5. dal passaggio dal conflitto come forma di relazione politica alla rivolta «come pratica di sottrazione e liberazione di spazi (anche immateriali) dal controllo e dalla gerarchia del comando politico, pratiche in cui i processi di appartenenza e soggettivazione passano spesso da dimensioni culturali e territoriali piuttosto che da ambiti economici» (F.Tomasello). Nella rivolta niente é rimandato al futuro, conta il momento del conflitto in cui la stessa realtà si esaurisce. Ogni rivolta ha dunque i suoi soggetti e i suoi obiettivi. Il sociale si frantuma in tante minoranze quante sono le 14 OUTLET Massimo Ilardi Insegna Sociologia Urbana all’Università di Camerino. Tra le sue ultime pubblicazioni: Il tramonto dei non luoghi (Meltemi 2007); Il potere delle minoranze (Mimesis 2010). Ha diretto la rivista Gomorra. culture che lo attraversano e la conflittualità endemica che ne consegue impedisce la formazione di una sfera pubblica. La lotta diventa anarchica, non rappresentabile dai partiti o dalle altre forme della politica. Ha ragione Alain Bertho quando afferma che esiste un filo rosso che accomuna queste rivolte nonostante la differenza delle latitudini e delle condizioni di vita. E questo filo rosso è tracciato da una violenza improvvisa e irriducibile, da un’assenza di coordinamento delle lotte, dalla giovane età dei rivoltosi, dal chiamarsi fuori da parte degli stessi giovani da qualsiasi rapporto con la politica e lo Stato, dall’obiettivo di abbattere e non di prendere il potere. Sono conflitti extraeconomici proprio perché gli unici in grado oggi, di fronte alla caduta di centralità e di legittimità del lavoro e della politica perché non più riconosciute a livello sociale, di mettere in crisi la governabilità del mercato che sul territorio vuole ridurre tutto a rapporto economico (che é il terreno dove si stabiliscono le gerarchie e i diversi livelli del potere dentro la società). Quando non sono più l’ideologia della lotta di classe o l’utopia di un nuovo mondo liberato dal profitto a politicizzarsi, ma il desiderio di libertà come diritto di foggiare liberamente la propria vita a proprio piacimento, é proprio il conflitto extraeconomico a determinare gli scenari della vita metropolitana. E in un’economia che a questo punto è messa fuori controllo dal desiderio, «il sociale non può più far comunicare l’economico e il politico, il quale a sua volta non può più fabbricare sociale a partire dall’economico. Tutto quello che era sociale è oggi un campo di rovine […]» (A.Touraine); 6. dal fatto incontrovertibile che sicurezza, controllo e libertà non vanno d’accordo, come non vanno d’accordo la costruzione di una società artificiale disegnata dal mercato e la cultura del consumo che innesca invece un vero e proprio processo di desocializzazione. Scrive Giovanni Sartori: «Il mercato é cieco di fronte agli individui, é individualisticamente daltonico; é invece una spietata macchina al servizio dell’insieme, della società». Non solo. Nella metropoli del consumo totale, voler bloccare i processi di distruzione attraverso i quali una moltitudine di individui consuma e dissolve quotidianamente e incessantemente non solo oggetti ed eventi, ma affettività, valori, interessi generali, forme di rappresentanza, istituzioni rischia di far crescere in maniera anomala e mostruosa una interiorità che alla prima occasione che le si presenta per tracimare, non può che farlo in modo violento e devastante. E dove può tracimare se non sulle strade della metropoli? OUTLET 15 APERTURE I nostri contratti sono carta straccia LA SOTTRAZIONE DELLE ÉLITE FINANZIARIE AL CONTRATTO SOCIALE ISTITUISCE UN POTERE PREDATORIO CHE CONSERVA TUTTAVIA LA PREROGATIVA DELLA SICUREZZA. LA MESSA IN QUESTIONE DI QUESTA PREROGATIVA È AL CENTRO DI OGNI RAGIONAMENTO SULLA VIOLENZA. di Marco Bascetta N el dibattito pubblico italiano il tema della violenza, quella politica o politicamente motivata, è andato incontro a un singolare destino: tanto più se ne evocava l’incombenza quanto meno trovava riscontro nella realtà dei fatti. Non vi è episodio, per quanto banale e insignificante, dalla scritta murale al lancio di uova e ortaggi, che i media e le forze politiche tutte non dichiarassero messaggero di un imminente ritorno del terrorismo, la bestia nera degli anni Settanta. L’assenza di una inclinazione significativamente violenta del conflitto sociale creava, per così dire, una sorta di disorientamento, di vuoto nel rapporto di potere tra governanti e governati, che i primi si sarebbero ingegnati a colmare con un notevole sforzo di fantasia, talvolta assecondato dal narcisismo di parte dei movimenti. Da tutti i pulpiti istituzionali si incitava ossessivamente a “non sottovalutare”, a “non abbassare la guardia” e dunque a oliare e accrescere gli strumenti di controllo e di repressione in attesa di un nemico che stava affilando i 16 OUTLET APERTURE coltelli in un’oscurità tanto fitta da non vedersene nemmeno l’ombra. Qualche plico esplosivo di provenienza “informale” (il che la dice lunga sulla consistenza e stabilità strategica dei bombaroli postali) non cambia in alcun modo il quadro di una situazione di conflittualità sociale tenuta sostanzialmente entro solidi argini. Quanto alle parole che sarebbero diventate pallottole, neanche le menti più labili sono mai riuscite a prendere sul serio i truculenti proclami dei guerrieri padani e di altri commedianti di diverso orientamento. Così, a una pedagogia di Stato che trasformava temperini in scimitarre e vetrine sfasciate e cassonetti incendiati nel reato di “saccheggio e devastazione”, con relative mostruose pene detentive (povero Attila surclassato da tifosi e manifestanti turbolenti), si accompagnava una totale censura sulla questione della violenza in termini politici, storici, sociologici o filosofici. L’interrogazione stessa sulle cause della violenza veniva interpretata come una sostanziale complicità con chi la esercitava. All’origine di tutto questo la guerra senza quartiere condotta negli anni Ottanta, a partire dagli Stati Uniti, contro le analisi sociologiche del crimine al grido di “non è la società, sono i criminali i soli responsabili del crimine”. Parola d’ordine che, transitando agevolmente dalla criminologia alla politica, si adattava perfettamente tanto alla tradizione puritana d’oltre Atlantico quanto alla crisi fiscale dello Stato e che avrebbe ispirato, dilagando per ogni dove, la teoria e la pratica della “tolleranza zero”, con un vasto dispiego di violenza poliziesca e giudiziaria, accompagnata dal massiccio taglio delle politiche sociali. I bastoni, si sa, sono sempre inversamente proporzionali alle carote e assai meno dispendiosi. Quanto al pensiero di una dimensione politica della violenza che istituisca o destabilizzi assetti e rapporti di forza, che incida in qualche modo sulla trasformazione della società, qualunque tentativo di accostarsi anche prudentemente al tema veniva sdegnosamente respinto come un rigurgito del “secolo del male”, il Novecento, sintomo di arretratezza e di incomprensione della immensa forza trasformatrice della nonviolenza, da una parte, e con la sacralizzazione della legalità e l’insostituibilità dei principi liberisti dall’altra. Questo clima di interdizione e di censura comincia, tuttavia, a mostrare qualche crepa. I grandi movimenti pacifici, di opinione o di lotta poco importa, non hanno avuto consistenti risultati da esibire nel primo decennio del nuovo secolo, fatta eccezione per qualche dote profetica di cui compiacersi, l’asimmetria crescente tra poteri forti e soggetti indeboliti non ha indotto alcun ripensamento, gli strumenti di ricatto e di controllo sulla forza-lavoro precaria non si sono accresciuti e inaspriti e la violenza degli Stati e dei mercati non incontra più nessun argine. Si fa allora strada l’idea che questa vocazione giurata alla non-violenza non sia concretamente in grado di contrastare l’arbitrio del potere e la sua arroganza, che l’asimmetria (come scelta non come circostanza storica) non sia propriamente una virtù. Molti indizi rivelano che l’autopercezione vittimaria, la reazione trattenuta, OUTLET 17 APERTURE rinviata o delegata all’intervento di un potere salvifico, fosse anche il mito della società civile o la riscossa giudiziaria, finiscono coll’alimentare, nella forma classica del ressentiment, populismi, nazionalismi e politiche identitarie. L’idea della violenza combinata con quella della delega, posta alle origini dello Stato moderno, contiene in sé tutti i veleni rinunciatari e subalterni distillati dal risentimento. Il quale, nella deriva autoritaria delle democrazie contemporanee, si rivela assai più potente della paura o dell’insicurezza che la dottrina poneva alle origini del contratto sociale. Ed è proprio a partire dalla rottura di questo contratto e dall’esaurirsi della sua secolare narrazione, che Luisa Muraro ripropone coraggiosamente in un recentissimo saggio (Dio è violent, Nottetempo) il tema della violenza al dibattito pubblico. Il ritorno della guerra come arbitrio regolatore dei rapporti internazionali, lo svuotarsi di quella promessa di progresso che aveva determinato la tenuta del contratto sociale moderno e il numero crescente degli esclusi dai suoi benefici, legittimano i contraenti a revocare la propria adesione. E a questo punto, di fronte a un potere con cui si è reciso il filo della delega e della rappresentanza, che si è sottratto o ci ha escluso dal contratto sociale, non ha senso presentarsi spogli di ogni forza o privi della consapevolezza che ogni esercizio della forza non può non contemplare lo sconfinamento nella violenza. Qualche istantanea tratta dal mondo della grande crisi può introdurci a un altro modo, forse ancora più radicale, di guardare alla fine del contratto sociale e all’ipocrisia dei continui appelli perché tutti “facciano la loro parte” nel salvare il Paese, l’Europa, l’euro o addirittura l’economia planetaria. Distinti signori che rovistano nei cassonetti, famiglie sfrattate accampate in automobile, malati condannati a morte da un tracollo finanziario, licenziati arrampicati per ogni dove nella speranza di rendere almeno visibile la propria sorte, artigiani e piccoli imprenditori suicidi per debiti. Sono i numerosi fuoriusciti dal basso dal contratto sociale. Ma quelli che contano di più, e determinano a proprio arbitrio la vita di tutti, sono i fuoriusciti dall’alto: i fondi d’investimento, le élite finanziarie, i banchieri, i cosiddetti mercati, il cui millantato automatismo maschera soggetti e ideologie, cultura e volontà di potenza che scorazzano in piena libertà nello spazio e nel tempo dell’economia globale. Impongono condizioni e non scendono a patti con nessuno, non vi è regola che non abbiano dato a sé stessi, non vi è giurisdizione o governo in grado di intaccarne gli interessi e contrastarne lo strapotere e la pervasività. Gli armatori greci, seconda industria del Paese, 16 per cento della flotta mondiale, hanno garantita per legge la detassazione degli immensi profitti accumulati in acque globali e dispongono di formidabili armi di ricatto che non hanno mancato di agitare quando Syriza minacciava di vincere le elezioni e abolire il privilegio. Ma ad Atene sono i pensionati, i salariati, i disoccupati a dover “fare la propria parte”, quelli che “hanno vissuto al di sopra dei propri mezzi”. In breve, i poteri economici globali agiscono al di fuori da ogni contratto 18 OUTLET APERTURE sociale o semplice compromesso, mentre il resto dell’umanità viene obbligato ad onorare il contratto stipulato, per via diretta o indiretta, pubblica o privata, con il capitale finanziario. Quanto più immateriali sono le fonti della rendita, tanto più materiali sono le condizioni imposte per garantirla. Ma perché mai un potere che agisce fuori dalla legge dei comuni mortali dovrebbe esserne protetto? Non dovrebbe forse essere la forza di una minaccia a determinare il rapporto tra gli esodati dal contratto sociale verso il basso e coloro che vi si sono sottratti dall’alto? L’esclusione dalla comunità, dalla legalità e dalla sicurezza costituiva quella sorta di condanna a morte differita che, nell’antico diritto germanico, prendeva forma nella “messa al bando”e faceva del bandito la preda per eccellenza. Qui la sottrazione delle élite finanziarie al contratto sociale istituisce invece un potere predatore, che conserva tuttavia la prerogativa della sicurezza. La messa in questione di questa prerogativa è al centro di ogni ragionamento sulla violenza. Non si tratta di un impossibile ripristino del patto sociale, ma, al contrario, di rifiutare ogni obbedienza dovuta alla sua rappresentazione. Anche i messi al bando dallo stato sociale, i fuoriusciti dal basso, hanno tutte le ragioni di farsi “banditi” e tentare di raccogliere le forze per riappropriarsi della ricchezza sottratta. Da prede possono sempre farsi predatori. Chiamiamola pure senza timore guerriglia di classe. Gli ottimisti di epoca paleo-liberale profetizzavano che gli affari avrebbero sostituito le guerre. Non è andata proprio così, anche se, all’apparenza, la guerra fredda è stata vinta con le armi della competizione economica (che comprendeva comunque diverse guerre guerreggiate nonché il cosiddetto equilibrio del terrore e i suoi costi spropositati), con un enorme dispiegamento di violenza, il cui risultato, fra altri, è il regno di Putin e un discreto numero di orrende Satrapie. Fatto sta che nel mondo contemporaneo nessuna distinzione è più possibile tra violenza economica e violenza fisica e politica, tra quale sia venuta prima e quale sia venuta dopo, quale il mezzo e quale il fine, questione che fu al centro della lontana polemica tra Engels e Duehring. Quest’ultimo sosteneva che all’origine della nostra storia vi è un atto violento di asservimento dal quale i rapporti economici sarebbero poi discesi (per spiegarcelo il professore ricorre a Robinson e Venerdì), mentre Engels sosteneva il contrario, e cioè che l’asservimento politico non era che una funzione strumentale dei rapporti economici che precedono come premessa e seguono come risultato l’esercizio della violenza. La quale non ha svolto alcun ruolo nell’istituzione della proprietà privata. Mentre per Duehring la violenza si presentava dunque come un male assoluto ad esclusivo uso del potere e a fondamento di un ordine sociale iniquo (cosa che non pochi continuano a pensare), Engels si lasciava aperta la strada ad un uso rivoluzionario della violenza, chiamata a sovvertire quell’ordine iniquo, liberando quanto si era prodotto nel suo grembo. Il fatto è che la violenza non è né un atto fondativo, né un mezzo, né la teleologica “levatrice della storia” (più intrigante sarebbe chiedersi se non sia ciò OUTLET 19 APERTURE che tutti escludono e cioè un fine), ma una relazione in buona misura indipendente dalla coscienza, dalla scelta e dalla definizione teorica dei soggetti che vi sono coinvolti. Se vogliamo, è un linguaggio che, per il solo fatto di essere inteso anche da chi non lo vuole parlare, pur disponendo degli strumenti per farlo, determina profondamente l’instaurazione, la natura e l’intensità del rapporto. Un ambiente, insomma, entro cui è necessario orientarsi e che non può essere cancellato con un atto di volontà. Il diritto stesso, con l’ammissione della legittima difesa, autorizza l’uso privato della violenza in un determinato contesto relazionale. È propriamente questo aspetto di relazione quello che la dottrina della non-violenza non riesce a percepire e i corifei della legalità repressiva si sforzano di occultare. Ed è ancora questa natura relazionale che ostacola, come numerose esperienze storiche testimoniano, quella ricerca di una giusta misura nell’impiego della forza/violenza a cui Muraro invita. In questo misconoscimento sta anche quella concezione identitaria cui dobbiamo l’ invenzione dei “violenti” per vocazione e le interpretazioni più fantasiose del black bloc, un fenomeno radicato, non in una qualsivoglia dottrina o inclinazione, ma nella precarietà come forma di vita da cui consegue un vissuto “informale” della militanza. La crisi mostra in altorilievo, nel cortocircuito immediato tra economia e violenza, la natura sopraffattrice dei rapporti sociali, e non più solo o essenzialmente per il dispositivo di sfruttamento che li sottende, ma per il governo diretto delle vite che la violenza economica esercita e in cui lo sfruttamento si articola. Laddove il braccio repressivo dello Stato non ha alcun bisogno di intervenire. E il termine stesso “violenza” è bandito. Nessuno annovererebbe, tra le morti violente, la morte di qualcuno privo o privato dei mezzi per farsi curare dalla perdita di un lavoro o di una polizza. Nessuno ha mai fatto il conto di quante esistenze vengano quotidianamente annientate, con fredda cognizione di causa, per garantire la rendita dei capitali finanziari, i profitti dell’industria chimica o farmaceutica e perfino quelli della proprietà intellettuale. Si parlerà di iniquità, di ingiustizia, di inefficienza, perfino di reati, ma molto difficilmente di violenza. Se la narrazione del contratto sociale volge al termine, quella del contratto tra debitori e creditori gode di ottima salute e ne ha preso il posto come garanzia che il mondo civile non esca dai suoi cardini. L’indebitamento, in quanto servitù volontaria, è esentato da ogni riferimento alla violenza. Il tabù è decisivo, la distinzione irrinunciabile. Se infatti fossero identificate come violenza la privazione e lo strangolamento economico di soggetti deboli o indeboliti, di intere società, si riconoscerebbe una sorta di ius resistantiae, un diritto di opporsi con l’uso della forza agli atti che minacciano le nostre condizioni di esistenza. Lo sfrattato di Karlsruhe che ha accolto a fucilate il fabbro e l’ufficiale giudiziario troverebbe un suo posto nella storia della resistenza sociale, come lo ha trovato il ragazzo tunisino datosi alle fiamme, esasperato da un arbitrio di polizia, innescando con il suo gesto le rivolte 20 OUTLET APERTURE Marco Bascetta Nato a Roma. Dagli anni ‘70 giornalista del manifesto. Dal 91 ha diretto la casa editrice manifestolibri. Ha collaborato con diverse riviste: Luogo comune, Derive e approdi, Posse. Nel 2003 ha diretto Global magazine. È autore de La libertà dei postmoderni (manifestolibri 2004) e, con Marco d’Eramo, di Moderato sarà lei! (manifestolibri 2008). Collabora con gli Altri. arabe. Per questo il concetto stesso di violenza economica e l’idea che il potere del denaro possa costringere e assoggettare, come qualsiasi altra forma di violenza fisica, politica e non, devono essere banditi a ogni costo. Chi dovesse infrangere questo divieto sarebbe subito accusato di ideologia, di non riconoscere l’ “oggettività” delle leggi di mercato e infine di essere un nostalgico della novecentesca lotta di classe. E non è certo il caso di prendersela a male E, tuttavia, l’inasprirsi della crisi ha cominciato a sdoganare il concetto di violenza economica e l’idea che ad essa potesse opporsi una violenza sociale che, almeno simbolicamente, ne aggredisse i dispositivi, i linguaggi, i dogmi. La Grecia è stata per un tempo interminabile teatro di scontri violenti e guerriglia urbana, i minatori spagnoli hanno catalizzato la rabbia dei cittadini di Madrid, le rivolte metropolitane si sono moltiplicate in Europa e in America, e in certi momenti gli uomini della City o di Wall Street hanno dovuto strisciare lungo i muri mimetizzati da anonimi cittadini. Ma di queste insorgenze c’è da dire che non hanno conseguito maggiori risultati dei grandi movimenti ispirati alla non-violenza. Non sono state considerate una minaccia abbastanza seria da doverci venire a patti. Il campanello di allarme non ha suonato abbastanza forte e la catena di corruzione, condizionamenti e ricatti che dalle élite sovranazionali discende ai governi nazionali, fino al pallido spettro delle forze politiche e delle loro clientele (soprattutto quelle dell’Europa mediterranea) ha sostanzialmente tenuto. Poteri grandi e piccoli si sentono relativamente al sicuro. E tuttavia il tabù è seriamente incrinato, il contenuto di violenza insito nei rapporti sociali si è fatto sempre più evidente e l’esperienza dell’ingiustizia si è estesa a livello di massa, così come il suo rifiuto. Tanto impotente resta, però, una violenza senza forza, quanto una forza troppo trattenuta dal tabù della violenza, illusa di potersi sottrarre, nel suo autismo etico, alla relazione violenta che ci sta schiacciando, mentre dovremmo, invece, trovare l’efficacia necessaria per affrontarla. Se possibile, con misura. Altrimenti, dovremo farlo in ogni caso. OUTLET 21 APERTURE Le rudi razze pagane non sono scomparse DA OLTRE UN DECENNIO LE INSORGENZE DI MOVIMENTO SI AFFANNANO A CERCARE DI RICREARE EX NOVO UNA GRANDE NARRAZIONE CAPACE DI REGGERE IL CONFRONTO CON QUELLE DEL PASSATO. MA SE PROVASSIMO A BATTERCI NEL PRESENTE E PER IL PRESENTE? di Andrea Colombo C ampagna elettorale 2008. Walter Veltroni, leader del neonato Partito democratico e astro tutt’altro che nascente della sinistra perbene italiana, organizza uno di quegli spettacolini propagandistici che per lui costituiscono l’anima e il cervello della politica. Massimo Calearo, industriale, ex presidente di Federmeccanica, un falco, e Paolo Nerozzi, ex dirigente della Cgil ed esponente della sinistra sindacale, braccio destro di Cofferati ai tempi alla battaglia sull’art.18, si stringono la mano sotto lo sguardo beato del segretario piddino. Dovrebbe essere una delle tante trovate che costellano la campagna elettorale furbetta, superficiale e guitta allestita da Walterino. Invece va oltre. Diventa una di quelle immagini che riassumono la pochezza e la miseria di un’epoca, il fischio di fine partita. In effetti, pur se nelle forme esagerate e sguaiate proprie della Seconda Repubblica italiana, quell’osceno abbraccio riassume e corona un processo di ben più vaste dimensioni: quello che, nell’arco di tre decenni, ha trasformato il conflitto sociale da motore dello sviluppo e pietra angolare dell’edificio sociale in parolaccia impronunciabi- 22 OUTLET APERTURE le, idea polverosa e rancida, sintomo increscioso e un po’ patetico di provincialismo fuori dal tempo. Il paradosso è manifesto. Da un secolo e passa non c’era mai stata una situazione in apparenza più favorevole al conflitto. Dai tempi di Charles Dickens, la divisione sociale non aveva mai raggiunto un tale parossismo orgiastico. Neppure nei regimi totalitari il comando sul lavoro era stato così ferreo e dittatoriale. Solo agli albori della rivoluzione industriale, l’assenza di diritti sociale era stata così vasta, generalizzata e dilagante. La trasformazione persino della parola “conflitto”, e a maggior ragione della sua concreta pratica, in termine inammissibile, si accompagna alla drastica cancellazione dal vocabolario comme il faut di almeno altre due parole scivolate col tempo nel novero delle oscenità impronunciabili: classe sociale e padroni. Né l’una né gli altri esistono più, e se esistono bisogna far finta di non accorgersene. Nel XXI secolo, il conflitto in quanto tale è sempre e comunque maleodorante. Ma è solo quello sociale propriamente detto, il fronteggiamento tra classi i cui interessi materiali divergono che va messo al bando, va espulso dalla concezione civile dei rapporti sociali e, se è il caso, represso con le cattive. Basti guardare le reazioni tra l’allibito e lo scandalizzato che campeggiano sui volti improvvisamente smarriti degli ospiti e dei conduttori di talk show nei rari esempi in cui la malsana e arcaica idea di classi in conflitto fra loro fa appena appena capolino. L’assenza di conflitto sociale (o una sua presenza fortemente sottodimensionata rispetto alle esigenze dei tempi e rispetto a quanto sarebbe lecito aspettarsi) è la chiave di volta della contemporaneità. Il suo aspetto enigmatico. Il sintomo inspiegato, la cui mancata comprensione è ostacolo insormontabile per qualsiasi velleità di sovvertire, se non lo stato presente delle cose, almeno una situazione che persino il più timido e prudente tra i socialisti moderati del passato avrebbe considerato insostenibile. L’immagine di una società finalmente pacificata, uscita fuori dalle secche per definizione aberranti del Novecento, è ovviamente bugiarda. La conflittualità, al contrario, si è estesa. Si è fatta dilagante e pervasiva, scomponendosi però in una miriade di conflitti parziali che hanno piano piano sostituito la simmetria ordinata del conflitto di classe. Giovani e anziani. Occupati e disoccupati. Precari e lavoratori a tempo indeterminato. Nativi e migranti. Uomini e donne. Settentrionali e meridionali. Dipendenti pubblici e privati. La nuova conflittualità diffusa si gioca quasi tutta in una sola metà campo, quella del lavoro. Per la squadra avversaria il gioco è sin troppo facile. Bisogna licenziare senza render conto a nessuno? Lo si fa per avvantaggiare i giovani, che se non trovano lavoro è tutta colpa degli attempati e della loro orgia di garanzie. Si taglia la spesa sociale? Colpa dei dipendenti pubblici, mangiapane a tradimento. Le donne non trovano lavoro e sono pagate due lire? Perché questo porco mondo è ancora del maschio. E così via. OUTLET 23 APERTURE Va da sé che una dimensione esistenziale segnata dalla negazione del conflitto con quella che dovrebbe essere la controparte e, contemporaneamente, da una conflittualità permanente col vicino di banco o con l’inquilino della porta accanto, comporta necessariamente la crescita esponenziale di un’aggressività cieca, pronta a sfogarsi dove capita, e capita spesso all’interno della famiglia. I Paesi, con il nostro fra i primi, che si sono lasciati alle spalle il barbaro secolo dei conflitti sociali e delle rudi razze pagane si ritrovano poi chissà come alle prese con omicidi domestici all’ordine del giorno, frequenti mattanze insensate in stile Columbine o Denver, scoppi di violenza omicida ai danni del taxista che ha investito il cane della fidanzata o del compagno di coda alla biglietteria che prova a fare il furbo. Non è ancora, da noi, la situazione dei ghetti d’America, con lo sterminio tra chi indossa bandane blu e chi le preferisce rosse, ma non è che ci manchi tantissimo. La “libanesizzazione” della conflittualità sociale e la sua ricollocazione tutta all’interno di un solo fronte amplificano la cancellazione del conflitto frontale di classe e la rendono difficilmente reversibile, però non la determinano. Ne sono piuttosto conseguenze. Perché i subordinati al comando perdessero di vista il loro reale antagonista e iniziassero a prendersela con chi gli stava accanto, è stato necessario non solo che si consumasse una sconfitta in campo aperto di portata più epocale che storica, e neppure soltanto che una rivoluzione industriale di portata paragonabile se non superiore alla prima devastasse tutte le forme che avevano consentito alle classi subalterne di costituirsi come soggetto sociale cosciente e agguerrito: tutto questo ha avuto certamente un peso immenso, ma per cancellare una pratica antagonista sviluppatasi nel corso di due secoli c’era bisogno di un colpo ancor più decisivo, sferrato direttamente contro le radici di quella coscienza antagonista. Che, a torto o a ragione, affondavano nella convinzione tutta ideologica di dover rappresentare un modello complessivamente alternativo, di prospettare, prefigurare e anzi di incarnare già come promessa e profezia un mondo totalmente altro, strutturalmente diverso. Per quanto nella pratica quotidiana si trattasse essenzialmente di mediare sulle condizioni immediate e materiali di vita e di lavoro, sullo sfondo campeggiava la valenza salvifica del conflitto di classe. Quando questo mito fondativo è venuto meno, quando la posta in gioco del conflitto sociale è apparsa per quel che in fondo era sempre stata, uno scontro durissimo per l’accesso alla ricchezza e al controllo della propria vita, l’impalcatura ideologica è venuta meno lasciando le classi subalterne orfane del mito sul quale avevano in buona misura fondato la propria capacità di rifiutare e fronteggiare l’assetto sociale dato. Le sempre più frequenti esplosioni di violenza che costellano la vita delle metropoli occidentali sotto forma di riots sembrano sconclusionate e puramente distruttive solo fino a che ci si ostina a volerle inquadrare nella cornice conflittuale del passato. Quella che pretendeva dai soggetti ribelli di 24 OUTLET APERTURE Andrea Colombo Nato a Roma, ex redattore del manifesto, ex portavoce del Prc al Senato, oggi redattore degli Altri, autore di Storia nera (Cairoeditore 2007) e Un affare di Stato (Cairoeditore 2008). Coautore di Giusva (Sperling & Kupfer 2012). non mirare solo al consumo e alla libertà ma di candidarsi a rifondare e salvare il mondo e solo a partire da questa ambizione gli riconosceva il diritto di contrattare una vita migliore senza aspettare che sorgesse il sole dell’avvenire. Se per il potere risulta così facile far passare per dissennato vandalismo ogni ribellione contro un ordine che sconfina ormai in aperta tirannia, è proprio perché le ribellioni del presente mancano della legittimazione etica che proveniva dal battersi in nome non solo del presente ma anche del futuro, e non per se stessi ma per la salvezza del genere umano. Come se un conflitto che avesse per posta in gioco il potere decisionale sulla propria esistenza e il diritto alla ricchezza fosse disdicevole e moralmente sospetto. Non certo a caso, d’altra parte, le accuse di ribellismo estetizzante e culto della violenza fine a se stessa furono mosse, quasi 35 anni fa, contro il primo movimento che metteva il diritto al lusso e al governo della propria esistenza al centro della propria ragion d’essere: quello del ‘77. Da oltre un decennio, da Genova e prima ancora da Seattle, le insorgenze di movimento si affannano invece a cercare di rintracciare o di ricreare ex novo una grande narrazione, capace di reggere il confronto con quelle di cui tanto avvertiamo la mancanza. Quella ricerca si è puntualmente risolta in un mesto inaridimento di quelle stesse insorgenze e della loro forza vitale. Non sarà che, invece di recuperare una grande narrazione all’interno della quale inscriversi, la conflittualità sociale del XXI secolo deve saper fare a meno di una narrazione e rinunciare alla legittimazione di progetto superiore? Elaborare quel lutto. Imparare a battersi nel presente e per il presente. Per il qui e per l’ora. OUTLET 25 APERTURE Rivolte LA DIFFICOLTÀ AD INTERPRETARE CERTI COMPORTAMENTI COLLETTIVI ETICHETTANDOLI COME BARBARI ED ESTRANEI ALLA NOSTRA CULTURA POLITICA, NASCE DALL’INCAPACITÀ DI METTERE IN CRISI LE CATEGORIE CHE USIAMO PER LEGGERE IL NOSTRO TEMPO. di Federico Tomasello A ll’ombra del baccano olimpionico si è recentemente consumato in U.K. il primo anniversario della rivolta che ha visto per alcuni giorni la gioventù delle più importanti città del Regno dedicarsi in massa al saccheggio e alla devastazione. Ben poche voci si sono occupate di commentare la ricorrenza. Si può forse affermare che trentacinque anni fa l’enorme black-out che mutò i consueti bagliori delle strade di New York nel fuoco della razzia e della sommossa segnava il momento a partire dal quale immagini di questo genere cominciavano le loro estemporanee comparse nell’infosfera globale. Da quell’estate 1977 esse hanno segnato talvolta apparizioni clamorose e dirompenti, come nella drammatica primavera losangelena del 1992, o nei 20 giorni di révolte des banlieues dell’autunno 2005. Eventi che scandiscono il ritmo del progressivo insediarsi dentro le metropoli occidentali di comportamenti collettivi che le penetrano fino a definirne una caratteristica quasi oggettiva, fino a determinarne alcuni segmenti di struttura urbana in funzione preventiva e difensiva1. Ad Alain Bertho va oggi il merito di una ricerca etnoantropologica in grado di svelare la penetrazione e la consistenza di questo genere di fenomeni nel nostro tempo: un sito web che segnala e restituisce in tempo 26 OUTLET APERTURE quasi reale il dispiegarsi dei fenomeni di rivolta metropolitana sui quattro angoli del pianeta2. Gli ha voluto dare il nome di Antropologia del presente, quasi a richiamare l’attenzione di antropologi troppo impegnati a studiare le popolazioni «selvagge» (ed educarle ai benefici della cultura democratica) per indagare la mutazione in atto dentro metropoli che si sentono ormai sotto l’attacco di nuovi «barbari» che esse stesse non smettono di generare e riprodurre. Riflettere su questo genere di fenomeni per una rivista che si propone la «critica della ideologia italiana» significa anzitutto provare a sottoporre alla lama della critica le principali posture da cui essi vengono osservati in certi ambienti nostrani. La prima e più diffusa postura tende a negare che ci si trovi di fronte a un fatto politico. Mira a ignorare questi comportamenti collettivi perché sono difficili da interpretare (in effetti essi sfuggono abbondantemente agli apparati categoriali con cui siamo stati abituati a leggere il reale, a partire dagli schemi stessi della razionalità strumentale), ma soprattutto perché risultano «estranei alla nostra cultura politica», dal momento che non esprimono alcun conflitto, non sono cioè in grado di determinare mutamenti di rapporti di forza, di alludere alla ricomposizione dello scontro in un equilibrio diverso e più avanzato, di dispiegare alcun orizzonte di alternativa, di protrarre la propria esistenza al di là della pura esteriorità dell’evento. Non vi è dubbio che sia così. Ma sono proprio tali elementi a svelare le linee di una tendenza in atto, e l’odierno imbarazzo nel convocare in Italia nuovi grandi “cortei nazionali” dopo il contagio manifestatosi il 14 dicembre 2010 e il 15 ottobre 2011 potrebbe forse suggerire l’urgenza della riflessione. Un primo elemento deve essere chiaro. Di fronte all’irrompere della violenza collettiva nel tessuto metropolitano non si tratta tanto di schierarsi, quanto di provare a compiere quell’esercizio elementare che consiste nel domandarsi in che misura tali fenomeni appartengano al nostro tempo e ci dicano qualcosa su di esso e sulle categorie che usiamo per interpretarlo. Non si tratta di tifare pro o contro tali comportamenti collettivi, quanto di interrogarsi su significati e consistenza degli scenari che essi manifestano, scenari in cui la violenza sembra prendere il posto del conflitto e la rivolta quello dei progetti di radicale trasformazione, in cui nessun grande contenitore politico e di senso sembra più reggere a quella particolare configurazione storica dello spazio urbano che chiamiamo metropoli per indicare non tanto una mera referenza spaziale, quanto un enorme dispositivo di relazioni, poteri e linguaggi. Non si tratta OUTLET 27 APERTURE di sostenere o organizzare, di prevenire o condannare l’irruzione della rivolta dentro questo tessuto. Essa semplicemente accade. Lo fa quando i termini dell’indignazione accedono alla dimensione dell’indicibile. Ovvero quando i termini del problema sono posti in modo tale che la violenza è ciò che più si avvicina alla forma della parola politica: la rivolta è esperienza materiale dell’abisso che separa bisogni, esigenze ed espressioni della metropoli contemporanea dall’apparato categoriale e linguistico del politico moderno. Questo il primo ostacolo che essa trova cercando di entrare nel salotto buono degli oggetti del discorso politico: la sua irriducibilità al più classico degli esercizi della modernità, la ricerca del soggetto su cui innestare i propri – eticamente irresistibili – progetti di riforma o di trasformazione radicale, la rabdomanzia di quel soggetto particolare su cui far leva per condurre il mutamento universale, dell’intero corpo sociale, di tutta la società. Questo universale – la società – ha consentito di dispiegare al suo interno l’elemento delle classi in conflitto fra loro e farvi agire grandi movimenti di uguaglianza ed emancipazione, ma allo stesso tempo esso – lungi dall’essere quel fondamento oggettivo e naturale dell’essere insieme degli uomini che vorrebbero far credere i sostenitori della naturalità delle oscillazioni dei mercati finanziari – incarna una tecnologia di governo, un dispositivo di controllo non opposto ma simmetrico e complementare a quelli dello Stato moderno (rimando sul tema alle suggestioni del Michel Foucault genealogista della governamentalità liberale). Le estemporanee apparizioni della rivolta metropolitana – trovandosi rispetto alla società nella posizione di una selvaggia quanto imbarazzante esteriorità – consentono di svelare e osservare il fuori di tale universale che da due secoli non ha smesso di colonizzare ogni ambito dell’umano agire collettivo. Le rivolte metropolitane non sono semplicemente impolitiche, esse sono anche antisociali, rappresentano una sorta di attentato contro la società proveniente da un esterno metaforico, virtuale, paradossale. Si situano al di fuori del corpo sociale poiché si sottraggono anche alle, pur dure, leggi del conflitto, le quali prevedono la possibilità di uno scontro anche vigoroso, ma in cui le controparti finiscono sempre per riconoscersi, avanzano rivendicazioni e con esse indicano l’esistenza di un terreno e di un linguaggio condivisi. Tutto ciò non si dà in eventi in cui questa paradossale posizione di esteriorità trova la più efficace rappresentazione discorsiva nella metafora dei barbari, dei «nuovi barbari» che vivono nei fatti al di fuori della società, ma che allo stesso tempo ne sono un inevitabile quanto “rivoltante” prodotto, esistono solo in relazione ad essa e alla volontà di appropriarsene distruggendo e saccheggiando. «Oggi i Barbari che minacciano la società non sono nel Caucaso o nelle steppe tartare, sono nei sobborghi delle nostre città manifatturiere»3, così l’editoriale del più autorevole giornale francese rispondeva nel 1831 alla prima rivolta operaia della storia moderna, a quella che la storiografia del movimento operaio indicherà come la prima parola della classe operaia in 28 OUTLET APERTURE quanto soggettività storico-politica. I centocinquant’anni successivi sono segnati da quell’enorme movimento di «civilizzazione della violenza» che ha trasformato quest’ultima in «conflitto fra le classi» e che ha preso il nome di movimento operaio (prendo tali concetti in prestito a Ètienne Balibar da una parte e a Mario Tronti dall’altra), producendo quegli immensi effetti di verità che hanno segnato, anche in forma di tragedia, tutto il XX secolo. Dall’ «assalto al cielo» alla guerra fredda, fino a dar forma alle stesse costituzioni democratiche sotto le quali ancora oggi viviamo, interamente costruite intorno ad un soggetto, il lavoratore dipendente salariato, oggi sempre più minoritario (costituzioni che perciò, invece di essere terreno privilegiato e quasi esclusivo delle «battaglie della sinistra», dovrebbero essere oggetto di progetti di riforma da parte di movimenti in grado di portare il punto di vista di tutte quelle soggettività ormai di fatto escluse dai loro sistemi di diritti e garanzie). Tutto questo movimento si è bruscamente interrotto ormai molti anni fa, la classe operaia è sostanzialmente scomparsa dall’ordine del discorso e la cosa più difficile è far accettare ai suoi orfanelli che la storia non si ripeterà, neppure in forma di farsa. Che l’invenzione o la scoperta di una nuova soggettività del lavoro o del non-lavoro non sarà sufficiente a riprendere quel cammino verso l’universale. Il «soggetto moderno» e quella sua poderosa declinazione che ha preso il nome di «classe operaia» sono i nomi di un dirompente movimento storico di emancipazione, di livellamento delle disuguaglianze, di accesso massivo al benessere, dei quali si tratta però oggi di indagare in maniera anche spietata i limiti. Primo fra tutti un insopportabile economicismo che ha condotto verso la progressiva elisione della libertà dal centro dell’orizzonte emancipativo, spostandolo tutto sul tema dell’uguaglianza e qui dislocando rivendicazioni e lotte quasi esclusivamente sul terreno del Welfare State in cui non si è stati più capaci di riconoscere anche un enorme dispositivo di disciplinamento e controllo. Siamo anche qui nell’ambito di quell’ «ideologia del lavoro» indagata nell’ultimo numero di questa rivista da Andrea Colombo come «strumento principe del controllo sociale», pietra angolare del sistema culturale nostrano in cui si incontravano gli elementi comuni alla politica cattolica e a quella comunista: «diffidenza per il consumismo, riprovazione etica per il lusso, esaltazione delle virtù frugali e familistiche proprie di una classe operaia senza grilli per la testa». Le rivolte che da oltre trent’anni segnano la condizione delle metropoli occidentali parlano esattamente dell’esaurimento di tali orizzonti e della necessità di disporsi su un terreno differente. È infatti solo con imbarazzanti forzature che esse possono essere ricondotte al familiare e rassicurante ambito della praxis, del lavoro, inesauribile miniera d’oro per il rabdomante della soggettività. È con fastidio che quest’ultimo constata come, anche in tempi di crisi economica e di precarietà, la rivolta, piuttosto che abitare il terreno delle condizioni economiche, prenda forma e si accenda dentro e contro l’abisso che separa la giustizia dalla legge e dalla forza chiaOUTLET 29 APERTURE mata ad applicarla (o sospenderla): leghi il proprio accadere alla morte di ragazzi i cui soli nomi – Mark Duggan, Zyed Benna, Bouna Traoré – bastano a designare una condizione metropolitana e postcoloniale segnata, fra l’altro, dalla spettrale e perenne confusione di norma ed eccezione. Qui l’insubordinazione collettiva non parla di lavoro e di sfruttamento, di uguaglianza, salario e tempo libero, e si dispiega invece sul terreno del consumo e della riappropriazione di merci e di spazi, dell’affermazione di forme di vita altrimenti invisibili e della libertà di movimento dentro il territorio metropolitano, alludendo in qualche modo anche alle tematiche del debito e dell’insolvenza nei termini qui efficacemente descritti da Marco Bascetta interprete della riflessione che Maurizio Lazzarato ha recentemente proposto sul tema. Alla postura che tende a negare lo statuto di «fatto politico», a contestare la rilevanza dei fenomeni qui in esame, si accompagna poi quella che pone invece l’accento sulla impossibilità di rinvenirvi un qualsivoglia «atto politico». I riot e le rivolte urbane sono in questo caso riconosciute come avvenimenti di grande portata perché testimoniano di importanti processi, i quali rappresentano il vero dato politico da indagare, quello che permette anche di operare il rassicurante spostamento di tutta la politicità al di fuori dei comportamenti collettivi di rivolta metropolitana. Si può arrivare a tale esito teorico percorrendo due strade diametralmente opposte. Da una parte la rivolta metropolitana viene spogliata di ogni politicità interpretandola come la punta dell’iceberg delle manifestazioni impolitiche di una «microviolenza soggettiva» che si dispiega quotidianamente nello spazio urbano ad opera di segmenti di pericolosità sociale – migranti, devianti, delinquenti etc. – e che richiede la risposta politica delle istituzioni. Dall’altra parte tali fenomeni sono invece considerati come reazione impolitica, quasi epidermica, biologica o meccanica, alla pressione costantemente esercitata dall’esterno dalla forza politica di una «macroviolenza oggettiva» che agisce a livello sistemico sulle popolazioni. Questo lo sfondo su cui ad esempio Slavoj Zizek propone di disporre l’interpretazione di rivolte metropolitane, da considerare come «passaggio impulsivo all’azione non traducibile in parole o pensieri che porta con sé un carico intollerabile di frustrazione», una violenza senza senso e autodistruttiva, accidentale e volgare, effetto della completa assenza di «mappe cognitive»4. Così ogni volta, non appena il fumo delle rivolte urbane comincia a diradarsi, eserciti di sociologi vengono posizionati sulla trincea del discorso pubblico per mostrare che non si è trattato del soggettivo gesto estremo di libertà di giovani intenti ad afferrare desideri e bisogni altrimenti negati, a sfondare tutte quelle frontiere materiali e immateriali che solcano in ogni direzione la metropoli contemporanea, ma del risultato di una serie di condizioni oggettive esposte in accurate indagini della congiuntura tese a mostrare la mancanza di lavoro, i deficit del sistema formativo, le insufficienze del modello di ricezione delle migrazioni, i difetti del 30 OUTLET APERTURE Federico Tomasello È dottorando in storia del pensiero politico all'Università di Bologna (studia forme e ragioni degli antagonismi e conflitti sociali nella Francia di prima metà Ottocento), partecipa al collettivo UniNomade 2.0, è fra i soci fondatori della libreriacafè La Cité a Firenze, città dove è cresciuto. Ha vissuto anche a Roma (per svolgervi attività politica a livello professionale), a Bologna e a Parigi. Sul tema della rivolta ha pubblicato La violenza collettiva della metropoli contemporanea. Sui significati politici di un'eccezione nel volume collettaneo Senza Asilo. Saggi sulla violenza politica, a cura di G. Bonaiuti (ombre corte 2011). sistema poliziesco e giudiziario. Analisi tanto attente ai singoli particolari da dimenticarsi che da qualche decennio tali fenomeni interessano in maniera sempre più significativa il nostro tempo a prescindere dalla congiuntura economica e abitano indifferentemente Paesi assai diversi nei meccanismi istituzionali di prevenzione dei conflitti e ricezione delle migrazioni. È comunque degno di nota come, provenendo da destra oppure da sinistra, si arrivi in ogni caso nel punto in cui si esclude che qualsiasi politicità possa nascondersi fra le pieghe e le forme delle violenze collettive metropolitane, nel punto in cui esse vengono evacuate dall’ambito della fenomenologia dei comportamenti collettivi oggetto di riflessione e progetti politici. Proprio per questo una “critica” della rivolta metropolitana diviene preziosa occasione di posizionarsi lungo il sempre labile confine che determina il dentro il fuori, il vero e il falso del politico, per poter così sondare la tenuta e l’estensione, le ragioni passate e presenti di tale frontiera. Riot, rivolte, tumulti urbani – così come molti altri comportamenti collettivi delle molte minoranze che abitano la metropoli del nostro tempo – divenOUTLET 31 APERTURE APERTURE tano allora occasione per mettere in discussione confini e frontiere entro cui la modernità ha disposto gli spazi della politica. Lo spettacolo che sta preparando le elezioni dell’anno a venire mostrano tutta l’urgenza di un tale sforzo. Si tratterebbe dunque di disporsi a indagare quei territori esterni, resti, eccedenze lasciati vuoti dal progetto politico della modernità, che oggi sembrano intaccarne le frontiere e crescervi in forma di voragine, quelle caratteristiche della moltitudine che non hanno partecipato al suo divenire-popolo, quell’«essere plebe» che non designa ceti sociali, ma comportamenti e ambiti di vita: «non esiste la plebe, c’è della plebe. C’è nei corpi e nelle anime, negli individui, nel proletariato e nella borghesia […] nel corpo sociale, nelle classi, nei gruppi, negli individui stessi»5. Si tratterebbe allora di ridimensionare tutte le genealogie socioeconomiche della soggettività per far posto anche a una dimensione «complessivamente umana» in cerca di linguaggi con cui parlare pubblicamente, alla possibilità cioè di ritrovare una dimensione antropologica del politico, irriducibile agli angusti spazi amministrativi in cui esso pare oggi compresso. L’esclusione ovunque UNA RIVISITAZIONE DEL PARADIGMA DI FOUCAULT: COME IL “FAR MORIRE” HA PRESO IL SOPRAVVENTO SUL “FAR VIVERE”. I MODELLI CIE O EX CPT, LUOGHI IN CUI LA LEGGE È SOSPESA, DIVENTANO VERI E PROPRIO DISPOSITIVI, ELEMENTI NORMATIVI DELLE NOSTRE SOCIETÀ. I borghesi hanno ottime ragioni per attribuire al lavoro una soprannaturale forza creativa, poiché proprio dalla natura condizionata del lavoro risulta che l’uomo, possessore soltanto della propria forza-lavoro, deve essere, in tutte le condizioni sociali e culturali, schiavo di altri uomini che si sono resi proprietari delle materiali condizioni di lavoro. (K. Marx, Critica al programma di Gotha) note 1 2 3 4 5 32 OUTLET Ancora prezioso in merito è il pionieristico Città di Quarzo. Indagando il futuro a Los Angeles di Mike Davis (manifestolibri 1992). http://berthoalain.com è l’indirizzo del sito, cui si affianca il testo, didascalico e compilativo Le temps des émeutes Bayard, Paris 2009. Editoriale del Journal des débats, 8 dicembre 1831 (in parte on line all’indirizzo http://aimablefaubourien.blogspot.it/2010/01/saint-marc-girardin -les-barbares-qui.html) S. Zizek, La violenza invisibile (Rizzoli 2007); Id., Considerazioni politicamente scorrette sulla violenza metropolitana, trad. it. (Forum 2007). M. Foucault, Poteri e strategie, in «aut aut», 164, 1978, p. 25: «Assumere questo punto di vista della plebe, che è quello dell’inverso e del limite rispetto al potere, è quindi indispensabile per fare l’analisi dei suoi dispositivi». di Emilio Quadrelli I ntorno al carcere, alla sua storia e funzione, sono state scritte intere biblioteche. È immaginabile che il lettore di questa rivista ne abbia una conoscenza abbastanza ampia. Diamo quindi per scontato gran parte di ciò che ci sta alle spalle e proviamo a tracciare alcune linee di ricerca e intervento a partire dal presente. Il carcere non è, come certa letteratura di genere (prendiamo su tutti i romanzi di Edward Bunker) ama mostrare, un mondo a sé con regole e retoriche diverse e distanti dai mondi sociali esterni, bensì la sintesi, portata sino alle estreme conseguenze, del mondo che lo circonda. Il carcere è esattamente lo specchio, neppure troppo deformato, del mondo cosiddetto normale. Questo, chiaramente, non significa che tra dentro e fuori non esistano differenze ma, più realisticamente, che le regole e i modelli della prigione sono i medesimi della società circostante. Parlare del carcere, quindi, significa parlare dei modelli sociali nei quali siamo immessi. Ciò è vero sia per quanto riguarda la società ufficiale e legittima, ossia quella che utilizza e gestisce il carcere, sia per quanto riguarda la parte deputata a subirlo e ad abitarlo. Il carcere, OUTLET 33 APERTURE non diversamente da qualunque altro ambito sociale, non può che essere l’effetto di una condizione storicamente determinata. Credo che sia importante, per iniziare a comprendere il mondo della prigione di oggi, prendere sommariamente in esame il modo in cui è mutuata negli ultimi anni la “questione sicurezza”. Penso sia noto a tutti come, solo pochi anni addietro, le retoriche relative alla sicurezza, insieme a tutte le autentiche ossessioni che si portavano appresso, fossero una delle argomentazioni politiche di maggior rilievo. Su di queste, indipendentemente dagli schieramenti politici, sono state costruite intere fortune pubbliche. Specialmente in prossimità di un qualche evento elettorale ogni candidato non faceva mancare la sua proposta finalizzata alla messa in sicurezza delle città e, in contemporanea, ogni governo o amministrazione in carica, in prossimità della scadenza del mandato, proprio sulla “questione sicurezza” veniva messo alla berlina dalle forze all’opposizione. Organi di stampa e media, nel frattempo, facevano a gara per mostrare e documentare l’insicurezza e la paura che attanagliava il cittadino medio. Repentinamente, l’insieme di queste argomentazioni sono scomparse dal dibattito pubblico e la “questione sicurezza” è pressoché stata espunta dal dibattito politico. In contemporanea è venuta meno quell’ansia di militarizzazione generalizzata delle città mentre, per altro verso, si è assistito a un intensificarsi della presenza delle forze dell’ordine coadiuvate dall’esercito in determinati comparti urbani strategici. Non solo simbolicamente questo significa il ritiro dello Stato da alcuni ambiti e la sua accentuazione su altri. In altre parole ciò a cui assistiamo è il venir meno di quello che Foucault ha chiamato lo stato di popolazione che nel binomio Stato/Nazione aveva trovato la sua sintesi migliore. Ma con ciò si inverte anche quel modello di governamentalità che a tale epoca aveva fatto da sfondo, ossia il far vivere e il lasciar morire. Cosa significava nello stato di popolazione il far vivere e il lasciar morire se non un’attenzione continua e costante al “benessere della popolazione”? Non era forse sulla popolazione, sulla sua salute, efficacia, efficienza e attitudine alla disciplina che si forgiavano i destini degli Stati/Nazione? E perché ciò fosse possibile non era forse necessario che il potere statuale si adoperasse per far vivere il maggior numero di individui mentre a essere lasciato morire doveva essere solo quella quota di popolazione “insana” che, in virtù di ciò, rappresentava un pericolo di infezione per il corpo sano della Nazione? In tale ottica lo Stato non poteva far altro che essere continuamente presente dentro e tra la popolazione al fine di attivare il più possibile i meccanismi dell’inclusione sociale. Di tutto ciò oggi si è perso completamente traccia e l’asserzione foucaultiana va esattamente rovesciata poiché il potere agisce esattamente al contrario: lasciar morire e far vivere. In tutto questo cosa centra la prigione? Molto poiché è proprio all’interno di questa istituzione che si esemplifica al meglio il lasciar morire divenuto oggi il modello di governo delle nostre società. Proprio nella prigione si assiste al radicale mutamento di paradigma che a lungo aveva fatto da sfondo alle nostre società e che, sempre facendo ricor- 34 OUTLET APERTURE so a Foucault, possiamo identificare come “modello disciplinare”. Ora, perché esista una governamentalità disciplinare occorre che vi sia un modello omogeneo a cui il soggetto deve uniformarsi e tale modello è forgiato dagli ordini discorsivi dominanti i quali, questo il punto, hanno pretese universalizzanti. La costruzione del cittadino è un’operazione di ingegneria sociale al cui realizzo sono chiamati diversi specialisti e molteplici saperi. Per questa tipologia di potere è impensabile che una qualunque cosa sfugga al suo controllo ma non solo. Questo tipo di potere è forgiato sui saperi del dettaglio, sull’attenta osservazione di tutti i comportamenti dell’individuo. La società disciplinare non può che essere una società permanentemente educativa e correttiva perché tutto deve essere omogeneizzato. In ciò si sostanzia il far vivere. Fuori da ciò vi è solo la dimensione del margine del malato e dell’anormale. Figure nei confronti delle quali il potere conduce, o almeno ha condotto, una battaglia in permanenza. La volontà di sapere ne è stata la migliore esemplificazione. Di tutto ciò, oggi, obiettivamente rimane ben poco. Anche in questo caso è bene fare mente locale sull’insieme di ordini discorsivi presenti fino a poco tempo addietro nei nostri mondi. Tutti avranno a mente come, a lungo, il termine devianza (con gli immancabili corollari quali disagio e malessere sociale), abbia svolto un ruolo egemone nei nostri mondi. Il mestiere di “acchiappa devianti” sembrava essere uno dei più sicuri e intoccabili e con questo un processo permanentemente espansivo di medicalizzazione della società. Anche in questo caso, come per la “questione della sicurezza”, repentinamente se ne sono perse le tracce. Le nostre società, dall’oggi al domani, hanno visto sparire devianza, disagio e malessere sociale. Quella sorta di accanimento terapeutico finalizzato al far vivere si è velocemente eclissato. Nell’affermarsi del lasciar morire la medicalizzazione della società non ha ragione di esistere. L’insieme di retoriche che hanno fatto da sfondo a un’intera epoca con tutti i saperi da questa messi in forma sono posti velocemente in soffitta. Ma che cosa implica, concretamente, tutto ciò? Significa che il potere ha cessato di agire in maniera dispotica sulle sorti dei singoli, oppure siamo di fronte alla messa in circolo di un dispotismo con diverse caratteristiche? Credo che la seconda sia la risposta esatta. Ma di quale potere stiamo parlando? Ed è esattamente qua che, a mio avviso, entra prepotentemente in ballo la “forma Cie”. A un primo sguardo i Cie o ex Cpt appaiono come la grande aporia che, all’improvviso, compare all’interno dei nostri mondi poiché pongono tra parentesi i cardini stessi dello stato di diritto. A uno sguardo solo un poco più attento, al contrario, questi si mostrano, in quanto dispositivi, come l’elemento al contempo normativo e paradigmatico delle nostre società. Il loro carattere eccezionale va colto per intero nel significato proprio a cui il termine eccezione rimanda e al conseguente affermarsi di una sovranità in grado di esercitare il tratto propriamente politico della decisione ovvero: Sovrano è colui che decide sullo stato di eccezione. Ma in che cosa consiste OUTLET 35 APERTURE il grado di eccezione dei Cie? Perché, per la loro messa in opera, occorre chiamare in causa proprio l’esercizio del potere sovrano e il suo potere decisionale? Perché un tale richiamo sia legittimo è necessario che il passaggio a cui si fa riferimento sia il prodotto di una crisi la quale, per definizione, implica una mutazione radicale di quanto normalmente e normativamente era operante e consuetudinario un attimo primo. Le parole hanno un peso e, pertanto, non possono e non vanno utilizzate con leggerezza. Ciò è tanto più vero quando si tirano in ballo argomentazioni le cui ricadute hanno conseguenze pratiche e ad ampio raggio non secondarie. Come è sufficientemente noto, i Cie rappresentano un autentico mostro giuridico poiché sono un luogo in cui la legge è sospesa. Al suo interno non sono rinchiusi individui accusati di un qualche reato ma masse senza volto che sono soggette a una forma particolare di detenzione proprio perché prive di individualità. Una forma di potere che nulla ha a che vedere con il mondo delle discipline ma che, piuttosto, riporta alla mente il mondo coloniale, il mondo dei grandi raggruppamenti, il mondo delle deportazioni di massa, del filo spinato dove il lasciar morire era il modello di governo delle potenze conquistatrici. L’indigeno è privo di individualità ed è trattato e governato niente più e niente meno come il branco animale. Questo mondo, oggi, è in qualche modo rimesso in circolo dentro le nostre metropoli. Perché? Che cosa rende possibile la reintroduzione di modelli che richiamano alla mente per intero l’epopea coloniale? Non dobbiamo mai dimenticare che il potere non agisce, se non di fronte a una minaccia di natura politica, in termini repressivi, bensì sempre in termini produttivi. Il potere non è interessato alla repressione bensì alla produzione: cioè alla messa al lavoro dei corpi e alla quantità di ricchezza che da questi è possibile estrarne. Il potere, in poche parole, è interessato al plusvalore. La sua organizzazione sociale è direttamente legata al modo di produzione e alle forme che questa assume. È dentro la produzione, pertanto, che dobbiamo andare a cercare il “segreto” di questo passaggio. È nel modo in cui si è ridefinito il rapporto tra capitale e forza lavoro salariata che, allora, possiamo comprendere il senso del passaggio in atto di cui il carcere attuale e i Cie sono, al contempo, lo specchio e la sintesi. È cogliendo questa generalizzazione della condizione di massa senza volto che diventa comprensibile il primeggiare del far morire dei nostri mondi. Ecco così che i mondi della prigione cominciano a essere più familiari di quanto, in apparenza, potrebbero sembrare. Chi, oggi, è deputato ad abitarli? Chi, oggi, non può che essere continuamente oggetto del “sistema della penalità”? Non occorrono inchieste sociologiche particolarmente raffinate per cogliere nel segno. Oggi il mondo della prigione è, né più e né meno, che la discarica sociale entro la quale sono parcheggiati gli attori sociali più deboli e privi di una qualche forma di protezione sociale ed economica. Si dirà: questa è un po’ la scoperta dell’acqua calda e, in effetti, così potrebbe apparire. Ma, all’interno di questa costante storica propria del mondo della 36 OUTLET APERTURE prigione, vi è una novità per nulla secondaria intorno alla quale è bene ragionare. Classicamente, e anche in questo caso il richiamo al Foucault di Sorvegliare e punire pare particolarmente centrato, il mondo della prigione è il luogo del crimine che, sotto il profilo sociale, è rappresentato da determinate classi o meglio ex classi sociali. Su questo aspetto Foucault non si discosta molto da Marx, poiché i mondi del crimine sono quelli propri dei marginali, i quali precipitano in tale condizione in quanto appartenenti a gruppi e classi sociali frantumate dai processi di modernizzazione. Il marginale, classicamente, può essere considerato una vittima della storia. I marginali, per lo più, sono sempre ex qualcosa. Ex artigiani soppiantati dal lavoro di fabbrica, ex operai specializzati soppiantati dal lavoro meccanico, ex domestici lasciati liberi da nobili ormai decaduti, ex commercianti caduti in disgrazia, ex contadini espropriati dalla concentrazione capitalista della proprietà terriera. Insomma, sotto qualunque spoglia si osservi il marginale troveremo sempre un mestiere, una professione per arrivare a uno status sociale che il moto storico ha reso superfluo e inutile. Una condizione che ha sempre riguardato una parte ampiamente minoritaria dei mondi sociali. Una parte, questo è l’aspetto che va tenuto fortemente a mente, che fuoriesce completamente dal ciclo produttivo. La linea di confine di tale condizione è un po’ sempre stata quella del disoccupato. Fino a quando costui rimane entro le file dell’esercito industriale di riserva la sua identità sociale non viene intaccata più di tanto ma, nel momento in cui la sua condizione si cronicizza, ossia è estromesso definitivamente dal ciclo produttivo, il suo status sociale rapidamente cade in frantumi. Da operaio in potenza si trasforma in marginale a tutti gli effetti finendo repentinamente con il perdere quell’insieme di legami e rapporti sociali tipici della sua classe. Di qua l’approdo ai mondi dell’esclusione con tutto ciò che questi si portano appresso. È proprio nella natura di questa condizione che, oggi, mi pare siano intervenute trasformazioni decisamente radicali. La condizione di margine e di marginalità oggi si è estesa a quote sempre più ampie di popolazione. Ciò che oggi si intravede è come l’essere marginale sia una condizione normale per le nostre società. Al proposito credo sia del tutto inutile, in questo contesto, dilungarsi sulla condizione di invisibilità e oggettiva esclusione e marginalizzazione in cui versano quote sempre più ampie e corpose di forzalavoro. Se, per un intera arcata storica, i meccanismi produttivi e militari potevano funzionare solo attraverso la costante inclusione sociale dei più – di qua il prodursi del modello disciplinare – oggi sembra sensato affermare che il meccanismo funziona esattamente in maniera opposta. Qua si apre un capitolo che sicuramente non può essere risolto in poche battute ma solamente introdotto, ossia le modifiche intervenute nella forma guerra nei nostri ordinamenti politici, economici e sociali. In ogni caso possiamo affermare che l’inclusione sociale è sempre stata la condizione propria, almeno sin dalle guerre napoleoniche, della potenza degli Stati/Nazione. Il potere e la forza di uno Stato, e successivamente di un OUTLET 37 APERTURE APERTURE Emilio Quadrelli Operaio, è nato a Genova. Tra le sue ultime pubblicazioni ricordiamo Autonomia operaia (Nda Press 2008); Lenin il pensiero strategico (La Casa Usher 2011); Cogliere l’occasione (Edizioni Politica e classe 2011); Per Lenin, con Giulia Bausano (Gwynplaine 2012); Algeria 1962-2012. Una storia del presente (La Casa Usher 2012). Scrive per il giornale informatico Contropiano. Quali strade? Le nostre strade! INDIGNADOS SPAGNOLI, PRIMAVERA ARABA, ESTATE EUROPEA, RIOT E #OCCUPY AMERICANI: UN ANNO DI ESPLOSIONI URBANE NEL PIANETA. IN UNA CONVIVENZA DI DIMENSIONE FISICA E VIRTUALE. gruppo di Stati, andando al sodo poggiava per intero sulla sua capacità produttiva industriale, quindi sulla quantità di salariati messi soddisfacentemente al lavoro, e sulla quantità e qualità delle masse proletarie deputate a indossare la divisa. In altre parole ecco il senso del far vivere. In un mondo che si regge su questo modello la marginalità e l’esclusione sociale non possono che essere l’altro e l’indicibile della norma sociale ed ecco il senso del lasciar morire. Ma se, tutto ciò, viene a decadere se, cioè, forza e potenza nel mondo attuale si esprimono in maniera diversa dal passato non diventa forse superfluo, per il potere, dedicare tempo e risorse al far vivere? Non diventa forse più economico il lasciar morire. Ecco che allora l’aporia e la mostruosità giuridica del Cie assume contorni diversi poiché la condizione di massa senza volto diventa esattamente ciò di cui il potere necessita. Questo mi sembra il nodo centrale intorno al quale teoria e prassi politica sono chiamati oggi a misurarsi. La logica che sottende il Cie è oggi reiterabile nei confronti di qualunque blocco e ambito sociale. Nessuno, la cui condizione rimandi a quella del subalterno, sembra esserne in potenza esente. Pertanto, per comprendere il mutamento di paradigma che attraversa le nostre società, occorre calarsi per intero dentro le modifiche “strutturali” che hanno attraversato e scompaginato radicalmente i nostri mondi. 38 OUTLET di Monia Cappuccini P rimavera araba, estate europea, autunno americano. Sebbene il ciclo delle rivolte globali non possa dirsi esaurito, a più di un anno di distanza dal suo inizio è possibile cominciare a tracciarne un profilo. Partiamo dalla fine, dagli esiti prodotti: dopo le proteste di Piazza Tahrir la delicata fase di transizione egiziana ha visto prevalere alle urne la formazione dei Fratelli Musulmani sul vecchio establishment militare fedele a Mubarak; alle prime elezioni libere dopo la cacciata di Ben Alì in Tunisia si è affermato il partito Ennhada d’impronta fondamentalista; l’ondata delle acampadas spagnole è stata seguita dalla disfatta elettorale dei socialisti e dalla vittoria del partito popolare; in America il movimento degli #occupy potrebbe rivelarsi la spina nel fianco per la rielezione di novembre di Barack Obama. Risultati non proprio in linea, se non addirittura in contraddizione, con la spinta al rinnovamento politico di cui queste mobilitazioni di massa si sono fatte portavoce. In nome e per conto del 99% esse chiedevano alla politica nuovi strumenti per fare fronte alla crisi, maggiore giustizia sociale e minor diseguaglianza economica, più trasparenza e partecipazione e, se poco o nulla hanno inciso in terOUTLET 39 APERTURE mini di “democrazia reale”, è invece sul piano dell’immaginario, delle pratiche urbane, di un rinnovato patto con la città e di un nuovo uso delle piattaforme informatiche che stanno formulando nuove domande. «Too big to fail»: le tappe dell’insorgenza 15 settembre 2008 – La banca americana Lehman Brothers annuncia il fallimento per effetto della crisi dei mutui subprime. Scoppia la bolla speculativa, è l’inizio della recessione globale. 6 dicembre 2008 – L’uccisione di Alexandros Grigoropulos, 15 anni, ad Atene acuisce un clima di forte tensione sociale. Tra il 2008 e il 2009 la crisi economica si ripercuote pesantemente sulla Grecia, destabilizzata al suo interno da corruzione ed evasione fiscale. Il Paese è stretto in una morsa: da una parte la Troika finanziaria (Ue, Bce e Fmi) vara un piano di salvataggio per scongiurare l’uscita del Paese dall’Eurozona; dall’altro una vasta opposizione sociale (inclusa la destra di Alba Dorata) contesta anche violentemente le misure di austerità chieste in cambio al governo ellenico per risanare il debito pubblico. 18 dicembre 2010 – Mohamed Bouazizi, tunisino di 26 anni, si dà fuoco sulla pubblica piazza dopo il sequestro della merce che vendeva come ambulante, lavoro su cui aveva ripiegato in mancanza di un’occupazione degna della sua laurea. Morirà il 5 gennaio ma il suo gesto disperato ha innescato già la miccia della rivolta dilagata anche in Algeria e in Egitto. È l’inizio della Primavera araba. 25 gennaio 2010 – Oltre cinquantamila manifestanti occupano Piazza Tahrir al Cairo per chiedere le dimissioni del presidente Hosni Mubarak, festeggiate poi l’11 febbraio. Il governo blocca l’accesso a Twitter e oscura la rete cellulare sulla piazza. Si verificano violenti scontri con l’esercito. 15 maggio 2010 – In cinquantotto città spagnole marciano gli Indignados. Con lo slogan “democracia real ya” reclamano una partecipazione attiva alla politica e il superamento del bipartitismo. Si accampano nelle piazze centrali delle principali città del Paese, Puerta del Sol a Madrid diventa il simbolo della protesta. 6 agosto 2011 – London burning. Per quattro giorni la capitale inglese è messa a ferro e fuoco da una rivolta violentissima partita dalla periferia di Tottenham fino al centro di Oxford Circus. Incendi, saccheggi e devastazioni si estendono ad altre città britanniche. 17 settembre 2011 – La protesta contro gli abusi del capitalismo finanziario prende corpo nel “ventre della bestia” con l’occupazione di Zuccotti Park a New York. Lanciata due mesi prima dalla rivista controculturale canadese Adbuster – e anticipata dalle mobilitazioni nel Winsconsin nel febbraio 2011 – la mobilitazione si estende in maniera virale ad altre città americane. 15 ottobre 2011 –È il Global Day of Action. Mobilitazioni contro la crisi e l’austerità si tengono in oltre un migliaio di città nel mondo. A Roma si verificano scontri violentissimi tra manifestanti e forze dell’ordine in Piazza San Giovanni. 40 OUTLET APERTURE «We are 99%» «Noi non siamo sognatori, siamo il risveglio da un sogno che si sta trasformando in incubo». Ha il sapore della profezia il saluto di Slavoj Zizek all’accampamento di Zuccotti Park dell’autunno scorso. Il sogno di un capitalismo “troppo grande per fallire”– e con sé quello dell’America dream - si è sgretolato sotto il collasso del sistema finanziario statunitense, in una sorta di implosione che ha archiviato ogni illusione emancipatoria legata all’attuale modello di sviluppo, costringendo persino i più accaniti sostenitori della Terza Via ad abbandonare ogni qualsivoglia idea di riforma dello stesso. Sotto le macerie niente: la caduta dei giganti ha segnato l’inizio di un incubo per buona parte della popolazione occidentale, a cui la crisi continua a chiedere il conto in termini di debito e di Welfare. «Se ci fottete, ci moltiplichiamo» è stato uno degli slogan della protesta del febbraio 2011 nel Winsconsin. Così è stato: la crescente pressione da parte dell’1% (ossia il potere finanziario) sugli Stati nazionali per iniezioni di capitali pubblici in suo soccorso ha favorito per parte della restante percentuale della popolazione mondiale il compattamento intorno a pratiche di democrazia del comune e per una maggiore giustizia sociale. Un’avanguardia, come l’ha definita David Harvey, che «parla del 99% senza esserlo» e che, lungi dall’essere ridotta a una semplice campagna moralizzatrice nei confronti del potere corrotto, si è riprodotta secondo un’eco transnazionale caratterizzata da alcuni tratti comuni. Anzitutto la composizione sociale, data dal «convergere e dal differenziarsi di un ceto politico medio declassato e un proletariato la cui povertà è direttamente proporzionale alla produttività» (Curcio e Roggiero, Occupy!, ombre corte). Giovani scolarizzati a medi e ad alti livelli perlopiù precari e disoccupati che denunciano la crisi della rappresentanza tradizionale e reclamano democrazia vera e maggiore partecipazione alla politica, quest’ultima estromessa nella sua funzione storica di governo del territorio dal dominio della finanza in ogni campo della vita sociale. Ancora, le pratiche di queste mobilitazioni si presentano tutte come urbane attraverso l’occupazione di piazze pubbliche e simboliche delle città, in cui si scorge «un’embrionale forma di produzione metropolitana e di organizzazione della vita in comune» (Curcio, Roggiero), accompagnata da una corrispondenza simbiotica nell’uso della rete e dei social network. E’ nella contraddizione tra l’austerità imposta dall’1% e la precarietà in cui versa il restante 99% che si configura la nuova struttura di potere data dalla rottura definitiva del patto tra politica e cittadini da cui prende forma il conflitto contemporaneo. In Grecia e a Londra esso si manifesta in maniera apertamente distruttiva nei confronti dei governi ritenuti responsabili e dei simboli del potere finanziario; negli altri casi – il movimento 15M e gli #occupy – la violenza viene neutralizzata dai metodi della disobbedienza civile e mediata dalla scoperta del comune e del viveOUTLET 41 APERTURE re insieme come formula sperimentale e alternativa al sistema economico dominante. Nonostante la novità di alcuni caratteri, il 99% non nasce dal nulla. La sua identità si inscrive nel solco delle contestazioni del Nuovo Millennio – dai no global, ai Nimby, dai common alle rivendicazioni di comunità specifiche (donne, migranti, studenti, lavoratori, Lgbt) – fino ai movimenti degli anni ‘60 e ‘70. Il rimando al “movimento dei movimenti” viene da sé seppur con i dovuti distinguo: come sottolinea Naomi Klein «la differenza più grande rispetto a un decennio fa è che nel 1999 avevamo di fronte un capitalismo al culmine di un boom economico frenetico. La disoccupazione era bassa, i portafogli azionari erano gonfi. I media erano ubriachi sul denaro facile, mentre oggi la forbice del divario coinvolge non più e non solo Paesi ricchi da quelli poveri ma gente sempre più ricca e poveri sempre più poveri, in proporzioni sbilanciate dei primi a scapito dei secondi». All’attivismo del 99% va il merito di aver restituito senso unitario alla narrazione globale dei reclaim che si sono susseguiti dopo Genova 2001, superando la retorica isolazionista a cui erano stati confinati. A differenza delle esperienze comunitarie degli anni ‘60 e ’70 invece non tentano la via di fuga ma irrompono nel tessuto cittadino, rivitalizzando il discorso sull’urbano dimenticato da tempo. «Whose streets? Our streets!» Piazze, parchi, luoghi adiacenti i centri nevralgici del potere: la riappropriazione dello spazio pubblico è avvenuta senza mediazioni grazie a una collettività che, occupando o distruggendo, ha travalica il recinto della legalità per agire in maniera politica e diretta sul territorio secondo processi né controllabili né prevedibili. Piazza Tahrir, Piazza Syntagma, le strade di Londra, Puerta del Sol, Zuccotti Park: la parabola transnazionale del 99% ha restituito valore sociale a spazi pubblici fortemente simbolici, utilizzati ora come «commons politici, luoghi per la discussione e il dibattito aperti su cosa il potere sta facendo e su come è meglio opporsi al suo raggio d’azione» (David Harvey). Paradossale ed emblematico del processo di riconversione di uno spazio urbano all’uso sociale è il caso di Zuccotti Park – «territorio fatto per il sistema finanziario globale e spazio occupato dal movimento per fare territorio» (Saskia Sassen) – formalmente di proprietà della società privata Brookfield Properties, fino a quando la clausola friendly del patto urbano tra cittadini e politica non è saltato con l’occupazione evidenziando la contraddizione tra neoliberismo e modello urbano. Nei parchi e nelle piazze occupate hanno preso vita delle micro-città ideali abitate per flussi e transiti e strutturate in spazi autorganizzati. È lì che si svolgono le assemblee generali e si riuniscono i gruppi di lavoro in modalità gestionali e decisionali basate sul consenso orizzontale; è lì che 42 OUTLET APERTURE Monia Cappuccini, Giornalista e antropologa, appassionata di culture giovanili, street art e conflitti urbani, è attualmente dottoranda di ricerca in Tecnica Urbanistica presso la Facoltà di Ingegneria alla “Sapienza” Università di Roma. il resto della città converge in maniera ambulatoria e partecipativa; è lì che si organizzano la cucina, la biblioteca, lo sportello legale, il media center, lo spazio meditazione e la tenda medica. Ciò che Piazza Tahrir aveva espresso in forma embrionale ha trovato la sua finalizzazione nel “Yes, we camp” degli #occupy, passando prima per le acampadas del movimento 15M spagnolo. Un reinventare la vita quotidiana accompagnato dal cambio di destinazione d’uso dello spazio pubblico realizzato dalle tendopoli che indicano un punto di rottura nei confronti dei processi di gentrification e del caro-affitti perpetrati dal liberismo economico nelle città. «La crisi dei subprime che ha innescato la crisi finanziaria ha prodotto un’epidemia di pignoramenti e sfratti senza precedenti. E non è un caso che l’esperienza delle tendopoli prima di Occupy Wall Street era quella dei senza casa» (David Harvey). La riappropriazione dell’urbano e del vivere comune si lega al debito e alla precarietà che negli #occupy si presta a diventare «una struttura affettiva» poiché «il nostro benessere individuale dipende dalla costruzione di strutture sociali ed economiche in grado di sostenere la nostra mutua dipendenza» (Judith Butler). OUTLET 43 APERTURE Hashtag state of mind – Lo spazio ibrido della protesta Le piazze e i parchi occupati da una parte, il web 2.0 dall’altra: gli uni non esisterebbero senza gli altri, dimensione fisica e virtuale concorrono entrambe allo scambio orizzontale inaugurando nuove modalità comunicative sul piano tattico e strategico che archiviano definitivamente il ruolo controinformativo assegnato finora agli strumenti tecnologici. «I nuovi media sono la forma costituente del movimento, la forma della sua socialità. Lo si vede dalla natura e dalla dinamica stessa del movimento che non a caso è stato paragonato a un “oggetto beta”, un prototipo mai completamente definito e in continua evoluzione in base all’interattività delle sue componenti» (Carpignano, Occupy!). Il simbolo del cancelletto (#) sintetizza la transnazionalità e la reticolarità dei movimenti: la diversità linguistica è ridotta ai minimi termini, la distanza fisica cessa di costituire un ostacolo allo scambio, le modalità comunicative in tempo reale facilitano e innescano l’organizzazione del conflitto sul territorio, la formula occupy si rende immediatamente riconoscibile e localizzabile a differenti latitudini del pianeta. È come se l’intelligenza collettiva fosse scesa dal piano immateriale con indosso la maschera di Guy Fawkes per mettere radici nel contesto metropolitano locale secondo la sua natura cosmopolita. L’uso politico dei social network – insieme alle operazioni di tango down del gruppo di hacker Anonymous – supera l’idea d’interazione tra strumenti digitali per costruire «una ecologia di pratiche e di progetti», la stessa che ha contribuito a trasformare, tweet su tweet, Piazza Tahrir in «un evento mediatico globale» (Saskia Sassen). La rete degli spazi urbani ingloba quella delle piattaforme virtuali in perfetta sincronia e come paradigma di una nuova forma di partecipazione politica e di coesione urbana: l’una si riferisce all’altra come modello concettuale, l’altra mantiene come referente la fisicità del movimento. Per la prima volta nella storia l’antagonismo sociale varca la frontiera del postumano assumendo comportamenti da cybercittadino in linea con i meccanismi online-offline che attraversano le città contemporanee. Mondo reale e virtuale concorrono a erodere lo spazio astratto egemonico e a creare uno spazio ibrido che, non riuscendo a controllare, le istituzioni contrastano con la censura e con l’oscuramento della connessione internet nelle piazze occupate. 44 OUTLET APERTURE Italia burning DALL’EMERGENZA RIFIUTI A NAPOLI ALLA VAL DI SUSA, DALLA RIVOLTA DI ROSARNO A QUELLA DI SAN GIOVANNI A ROMA. UNA MAPPATURA DEI TUMULTI CHE SONO SCOPPIATI SUL NOSTRO TERRITORIO. di Luca Fondacci* 2004-2010 – Acerra, Chiaiano, Pianura, Terzigno, Boscoreale: l’emergenza rifiuti a Napoli e dintorni si è trasformata negli ultimi anni in una questione di ordine pubblico. La lotte in difesa della salute e dell’ambiente hanno messo a nudo il sistema di malaffare e di inefficienza amministrativa in cui vive la città di Napoli dalla gestione del post-terremoto in poi, compresa l’era Bassolino, simbolo del Rinascimento napoletano, dimostratasi in assoluta continuità con il passato. Il primo comune ad esplodere sotto l’emergenza rifiuti è Acerra, dove nel 2004 circa trentamila abitanti si sono scontrati per giorni con la polizia in segno di protesta contro l’apertura di un inceneritore, tra i più grandi d’Europa, inaugurato poi nel 2009 da Silvio Berlusconi e successivamente acceso e spento più volte a causa di problemi ambientali non ancora risolti. Dopo Acerra è la volta di Pianura e Chiaiano, dove nel 2008 si ripete il copione dei violenti scontri scoppiati tra cittadini e forze dell’ordine. La scintilla si accende il 2 gennaio quando la polizia tenta di sgomberare, nel quartiere Pisani, il presidio che ostacola l’accesso dei camion nell’area designata allo stoccaggio delle ecoballe. Barricate, autobus dati alle fiamme, strade fortificate, lanci di molotov, devastazioni, assalti agli autocompattatori: nel mese di gennaio la protesta si estende all’hinterland napoletano finché non arriva l’esercito che interviene per ristabilire l’ordine e per permettere il passaggio dei camion per lo sversamento dei rifiuti. Ad aprile la protesta si sposta a Chiaiano, grande zona agricola inserita all’interno del Parco Metropolitano delle Colline di Napoli, dove si vuole realizzare una discarica. I disordini non si fanno attendere: il 29 aprile 10mila persone sfilano per le strade del quartiere di Marano, il 24 maggio le immagini della polizia che manganellaOUTLET 45 APERTURE no donne e bambini fanno il giro del mondo. Il periodo caldo si esaurisce ma le proteste proseguono. Nell’autunno del 2010 esplodono Terzigno e Boscoreale, teatri di nuovi disordini dopo la decisione del governatore Stefano Caldoro di aprire una nuova discarica in località Cava Vitello. Gli scontri nel napoletano hanno visto la partecipazione di settori della società mai aggregatesi prima: ultras, centri sociali, disoccupati organizzati, studenti e abitanti delle zone interessate, pezzi di camorra mossi dal business della munnezza. Nessun orizzonte ideologico condiviso, assoluta sfiducia nella politica e nell’operato delle istituzioni, è nell’azione che ognuno di essi sottolinea la propria identità e il proprio senso di appartenenza. Nel vuoto amministrativo e nei momenti di massima emergenza a Napoli e dintorni irrompe il potere delle minoranze, che dà vita a una coalizione inedita e ingovernabile agli occhi degli strumenti classici della politica. 2005-2012 – Il principio di territorialità e la rottura del patto di solidarietà tra cittadinanza e politica nazionale provoca la nascita di movimenti che vede in prima linea cittadini e amministratori locali contro la realizzazione di alcune grandi opere. I più significativi interessano le zone del nord, in particolare la Val di Susa per la linea dell’Alta velocità e Vicenza per l’allargamento della base Nato Dal Molin. Il movimento No Tav nasce spontaneamente con le assemblee pubbliche dei cittadini della Val di Susa, seguite da manifestazioni imponenti e presidi permanenti per impedire l’esproprio dei terreni interessati dal passaggio della linea ferroviaria Torino-Lione. In particolare la protesta si accende intorno a Venaus, dove nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2005 le forze dell’ordine irrompono violentemente contro i manifestanti che avevano occupato i terreni. Si registrano arresti e feriti, alcuni giorni dopo una marcia di protesta devia il suo percorso per un vecchio sentiero di montagna che sale verso Venaus, dove vengono divelte le recinzioni e occupate nuovamente le terre interessate dall’Alta Velocità. La ferma opposizione dei comitati No Tav porta al sequestro dei cantieri da parte della magistratura e all’istituzione per iniziativa del governo di un tavolo di confronto tecnico con i sindaci dei comuni coinvolti. Il 2006 è l’anno delle Olimpiadi invernali a Torino e il movimento si ripresenta con azioni di disturbo lungo il percorso della fiaccola olimpica, costringendo i teodofori ad evitare, per precauzione, il passaggio in Val di Susa. I lavori della linea Torino-Lione al momento sono fermi e l’Italia rischia sanzioni pecuniarie dalla comunità europea per lo stop. Nell’agosto 2010 intanto è stato presentato un nuovo progetto preliminare dell’opera, mentre stanno per cominciare i processi ai danni di una trentina di attivisti per gli scontri del 2005. Contemporaneamente, a Vicenza, monta la protesta cittadina contro l’accordo segreto siglato nel 2004 tra il governo italiano e americano per l’allargamento della base Nato Dal Molin. Pur riconoscendo la contrarietà dei vicentini, venuti a conoscenza del patto solo nel 2006, l’allora sindaco Hüllweck fa approvare in sede di consiglio comunale le richieste statunitensi, sostenute 46 OUTLET APERTURE anche dall’allora presidente del Consiglio Romano Prodi attraverso una dichiarazione ribattezzata dai vicentini “L’editto di Bucarest”. I comitati “No Dal Molin” passano dalle parole ai fatti: occupano i binari e la stazione ferroviaria, si piazzano con un tendone davanti alla base militare, organizzano manifestazioni cittadine che vedono la partecipazione di centinaia di migliaia di persone giunte da tutta Italia. Succede qualcosa con le elezioni amministrative nell’aprile del 2008, quando il centrosinistra riesce a vincere facendo leva sui temi legati alla costruzione della base americana. Il neo sindaco Achille Variati promuove una consultazione popolare, ma il referendum viene bloccato a quattro giorni dal suo svolgimento dal Consiglio di Stato, che accoglie il ricorso della presidenza del Consiglio dei ministri e del ministero della Difesa. Il movimento “No Dal Molin” non ci sta e indice una consultazione autogestita al termine della quale si conteranno quasi 25mila votanti (al di sotto del quorum necessario) e una vittoria dei no pari al 95% che non basterà a bloccare i lavori. Nel febbraio 2009 viene aperto il cantiere, decine di cittadini tentano di bloccare gli accessi all’aeroporto, ma 400 agenti in assetto antisommossa li respingono. Al momento i lavori continuano. 2 febbraio 2007 – Nonostante la similarità tra le due parole, oggi si parla di ultras e non più di ultrà. I primi sono ancorati alla vecchia tradizione folkloristica e passionale della curva (fumogeni, bandieroni, fuochi d’artificio, tamburi), i secondi adottano uno stile più vicino al modello inglese (sciarpe al collo, stendardi personalizzati, battimani e cori ripetuti a oltranza). I grandi gruppi che un tempo egemonizzavano le curve oggi si sono frammentati in sottogruppi o microgruppi, poco disposti a ricomporsi tra loro se non in occasione dei grandi incontri o in vista di scontri con tifoserie avversarie o, ancor di più, con la polizia. Gli ultras si oppongo alle leggi del calcio moderno e si sentono depositari della fede calcistica fuori dallo show business e dai diritti televisivi. Rivendicano piena libertà di agire, limitata e negata però da processi di criminalizzazione in atto nei loro confronti che hanno prestato le curve a veri e propri laboratori di nuovi strumenti repressivi: tessera del tifoso, Daspo, diffide e provvedimenti disciplinari che, di fatto, stanno esasperando il conflitto tra ultras e forze dell’ordine, contro le quali si scagliano dando vita a coalizioni inedite e senza appartenenza di bandiera o di fede calcistica. Ricorrente a tutte le tifoserie è l’uso dell’acronimo A.c.a.b (All cops are bastards), a suggello di un sentimento di odio diffuso e comune. In realtà nella maggior parte dei casi le violenze avvengono fuori dagli stadi, come dimostrano gli episodi più gravi di Filippo Raciti e Gabriele Sandri. Il 2 febbraio muore l’ispettore di Polizia Filippo Raciti, colpito all’addome da un corpo contundente durante gli scontri con gli ultras del Catania avvenuti all’esterno dello stadio a termine del derby siciliano con il Palermo. Le indagini portano all’arresto di Antonio Speziale (allora minorenne, condannato a 14 anni per omicidio preterintenzionale) e alla sospensione di un turno del campionato di calcio. OUTLET 47 APERTURE 11 novembre 2007 – Clamoroso il caso del tifoso laziale Gabriele Sandri, ucciso nell’autogrill di Badia al Pino – vicino Arezzo lungo l’A1 – l’11 novembre 2007 da un proiettile sparato ad altezza d’uomo dall’agente Luigi Spaccarotella, intervenuto per sedare una rissa tra un gruppo di tifosi laziali e juventini mentre si trovava nell’area di sosta nell’opposto senso di marcia. La notizia e la dinamica della morte di Sandri fanno il giro delle tifoserie e gli stadi di tutta Italia diventano teatri di scene di guerriglia urbana. Gli episodi più gravi si verificano a Roma, dove il posticipo serale di Roma-Cagliari viene sospeso a fronte dei disordini avvenuti nel pomeriggio nella zona intorno allo stadio. All’Olimpico si ritrovano ugualmente ultras della Roma e della Lazio, insieme mettono a ferro e fuoco l’area dello stadio e assaltano un commissariato, una caserma dei Carabinieri e il reparto volanti in Via Guido Reni. Qualche giorno dopo, nel quartiere bene della Balduina dove viveva Sandri, si celebrano i funerali del ragazzo ai quali partecipano migliaia di tifosi giunti da tutta Italia. Sulla cancellata della chiesa vengono appese le sciarpe di tutte le squadre del campionato; intorno un silenzio assoluto rotto solo da qualche sporadico coro che chiede giustizia per Gabbo. L’agente Spaccarotella è stato condannato in appello a 9 anni e 4 mesi per omicidio volontario. 12 aprile 2007 – In Via Paolo Sarpi, strada roccaforte della comunità cinese di Milano, gruppi di forze dell’ordine in assetto antisommossa si sono scontrati con circa quattrocento immigrati cinesi per un banale diverbio scaturito tra un vigile e una commerciante cinese. La sommossa fu la conseguenza di un clima di tensione sviluppato nel corso degli anni, e motivato dal fatto che una parte dei cinesi lì residenti sembrava essere clandestina e che parte delle merci scaricate e lavorate sembravano contraffatte; si discusse la possibilità di un’infiltrazione di alcune triadi della madre patria direttamente nelle attività dei commercianti e negli scontri. 29 Giugno 2007 – Scontri presso il laghetto di Villa Ada, dove era in corso di svolgimento, come ogni estate, la manifestazione musicale “Roma incontra il mondo”. Intorno all’una, come riferito da molti testimoni, una cinquantina di persone, armate di spranghe e con il volto coperto, hanno approfittato dell’apertura dei varchi posti all’entrata del parco dal lato di via di Ponte Salario, per dirigersi verso l’ingresso della manifestazione, rendendosi protagonisti di atti di vandalismo e violenze sulla folla che defluiva verso l’esterno, al termine del concerto in programma. Inneggiando al duce e con fare militaresco, il gruppo avrebbe tentato di forzare i blocchi nel frattempo predisposti dal servizio d’ordine del concerto, lanciando tra l’altro due bombe carta. Non riuscendo a penetrare all’interno della manifestazione, i pestaggi si sono allora concentrati su quegli spettatori del concerto rimasti fuori dal perimetro protetto dalle transenne. Solo l’arrivo del VIII Battaglione “Lazio” dei carabinieri, ha potuto interrompere l’aggressione, mettendo il gruppo, probabilmente vicino agli ambienti neofascisti romani. Molte erano le voci che si rincorreva- 48 OUTLET APERTURE Luca Fondacci È membro del Centro Ricerche Urbane della Università degli Studi di Ferrara. È specializzato in analisi e strategie fattibili nel quadro di interessi particolari articolati e a volte contrapposti, sotto la regia di operatori pubblici e privati. no nei giorni scorsi su una possibile incursione da parte dei “fascisti”. L’ipotesi che appare più probabile è quella di una atto di ritorsione per una questione di natura territoriale, presumibilmente per “punire” chi aveva osato ospitare un concerto militante di sinistra nel “loro” quartiere. Uno degli organizzatori dell’evento, ha raccontato che negli ultimi giorni aveva più volte denunciato che c’erano stati danneggiamenti alle auto parcheggiate all’esterno della villa. 18 settembre 2008 – Il 18 settembre 2008 a Castelvolturno un gruppo scissionista del clan dei Casalesi, facente riferimento a Giuseppe Setola, firma la cosiddetta strage di San Gennaro, che lascia dietro di sé sette morti: il pregiudicato Antonio Celiento, gestore di una sala giochi affiliato dei Casalesi, e sei immigrati africani, tutti ritenuti poi innocenti, che si trovavano davanti alla sartoria bersaglio della sparatoria. Il massacro, attuato con modalità inedite e con un impressionante volume di fuoco, scatena la reazione dei connazionali delle vittime, che il giorno successivo mettono a ferro e fuoco la città di Castelvolturno. Gridano “Vogliano giustizia!”, chiedono che gli esecutori della strage vengano arrestati, puntano il dito contro chi li accusa di spaccio e di azioni criminose. Uno degli immigrati presenti nella sartoria e sopravvissuto alla strage diventerà il principale accusatore del clan omicida, a cui verrà contestata anche l’aggravante di avere agito con finalità di discriminazione ed odio razziale, per il pregiudizio di razza in base al quale voleva assoggettare l’intera comunità al proprio volere. 7-9 gennaio 2010 – Tra il 7 e il 9 gennaio 2010 violenti scontri a sfondo razziale sconvolgono la cittadina calabrese di Rosarno, dove vivono 5mila immigrati di 23 nazionalità diverse. Sfruttati e sottopagati, quasi tutti si occupano della raccolta degli agrumi, gestita dalle ‘ndrine locali. Il pomeriggio del 7 gennaio alcuni sconosciuti sparano diversi colpi con un’arma ad aria compressa su tre immigrati di ritorno dal lavoro. La sera stessa un gruppo di africani protesta per l’accaduto, scontrandosi con la polizia, fatto che si ripeterà OUTLET 49 APERTURE la mattina successiva in maniera più violenta nel corso della manifestazione di almeno 2mila immigrati per le strade di Rosarno. È la rivolta degli schiavi: assalti ai negozi, auto distrutte, cariche della polizia; la popolazione della cittadina calabrese, armata di mazze e bastoni, decide di farsi giustizia da sola, ingaggiando una caccia all’uomo senza precedenti. Spedizioni punitive, agguati, gambizzazioni, distruzione di automobili e incendio del capannone dove vivono i migranti: il bilancio dopo due giorni di scontri sarà di 53 persone ferite (18 poliziotti, 14 rosarnesi e 21 immigrati, 8 dei quali ricoverati in ospedale); la calma viene ristabilita solo con il trasferimento forzato dei nordafricani nei Cie di Napoli e Bari, che avviene sotto gli applausi della popolazione. 13 febbraio 2010 – Dal pomeriggio a notte inoltrata in Via Padova, quartiere etnico di Milano, si fronteggiano gruppi di nordafricani e di sudamericani. All’origine dello scontro la morte di un giovane egiziano, accoltellato da un sud americano, a seguito di un diverbio nato sull’autobus tra un gruppo di latinos e un altro di tre amici africani, due egiziani e un ivoriano. A mezz’ora dalla morte del giovane egiziano scoppia la rabbia dei suoi connazionali e amici: un centinaio di loro, che presidiava il luogo dove si trovava il cadavere, ha cominciato a fronteggiare la polizia, per poi sparpagliarsi nelle vie laterali dove ha cominciato a spaccare tutto ciò che trovava lungo la strada. Auto ribaltate, vetrine sfondate, motorini rovesciati e gruppi di nordafricani che, in assembramenti di 20-30 persone, si sono dati alla caccia di peruviani ed ecuadoriani. Alla rabbia iniziale ha fatto seguito una vera e propria guerriglia urbana, difficilmente contenuta dalla polizia. A coronamento di una situazione ingestibile, un mese dopo il Comune ha imposto il coprifuoco alle ore 22 per i locali ritenuti sospetti, nella fattispecie phone center e take away. Quello di Milano rappresenta un caso isolato ma è significativo della criticità che la zona vive ormai da qualche anno. Si tratta infatti di un quartiere in pieno centro cittadino, dove gli abitanti originari hanno traslocato a favore delle nuove comunità di immigrati, che qui hanno trovato dimora e aperto esercizi commerciali, intorno ai quali hanno preso piede attività illecite, quali lo spaccio di droga, che hanno esasperato i residenti rimasti. Di quartieri simili nelle città italiane ne esistono diversi – vedi Piazza Vittorio all’Esquilino a Roma o la Chinatown pratese – e solo ora stanno emergendo problemi di convivenza, non solo tra migranti e residenti di sempre, ma tra le stesse comunità etniche che si ritrovano a vivere fianco a fianco, senza diritti in luoghi spesso lasciati al degrado. A Via Padova per la prima volta in Italia il conflitto etnico ha scatenato morte e violenza, costituendo un pericoloso precedente per un paese fondato sulla migrazione ma non sul riconoscimento dei diritti di cittadinanza per le minoranze. 14 Dicembre 2010 – In Parlamento si vota la fiducia al governo Berlusconi sulla base di una mozione presentata da Futuro e Libertà e dall’Udc. In aula 50 OUTLET APERTURE scoppia la bagarre, fuori dal Parlamento si danno appuntamento gli studenti (già in mobilitazione contro la Riforma Gemini), i centri sociali, gli immigrati, i comitati dell’Aquila, i precari, i cittadini di Terzigno, i metalmeccanici della Fiom e altre parti dell’opposizione civile. Appena la Camera respinge la mozione di sfiducia, il centro di Roma viene messo a ferro e fuoco. Profanata la zona rossa, nelle vie intorno ai palazzi del potere si scatena la guerriglia urbana, come non si vedeva da un paio di decenni a Roma. Auto date alle fiamme, vetrine e bancomat in frantumi, blindati incendiati, sassaiole, bombe carta, lancio di uova e di fumogeni, assalti a reparti della mobile: per due ore piazza del Popolo diventa teatro di violenti scontri, mentre nelle strade intorno le forze dell’ordine sono impegnate a fronteggiare altri gruppi sparsi di manifestanti. A fine giornata si conteranno 57 feriti tra gli agenti e 40 tra i manifestanti, 100milioni di danni e 41 fermati. Qualche giorno dopo, il 22 dicembre, in Parlamento si vota il ddl Gelmini e gli studenti tornano a manifestare in tutta Italia, annunciando questa volta azioni a sorpresa: a Palermo e Milano si verificano scontri con la polizia; a Roma un lungo corteo sfila lungo la Tangenziale est, arteria della città, dove il movimento non aveva messo piede prima di allora. 15 Ottobre 2011 – Un pomeriggio di guerriglia. Quella che doveva essere una protesta pacifica per manifestare contro la crisi economica e contro i costi della politica si è trasformata in un incubo per la Capitale. Gli Indignati, che avevano promosso il corteo e che erano partiti con le migliori intenzioni, con cori e bandiere colorate, sono stati sconfitti da 500 giovani incappucciati e armati di bastoni, mazze, bombe carta e fumogeni che si sono infiltrati facendo degenerare la giornata di mobilitazione. I violenti scontri in piazza San Giovanni, luogo storico delle manifestazioni sindacali e democratiche, e in altre aree della capitale lungo il percorso del corteo sono stati il culmine di una serie di incidenti iniziati intorno alle 15 in via Cavour, con bandiere bruciate, auto e cassonetti dati alle fiamme, violenze contro chi contestava la violenza. Un centinaio i feriti ricoverati in ospedale. Cinque ore di battaglia urbana con le forze dell’ordine prese d’assalto da una pioggia di sassi e sampietrini lanciati dal black bloc. In via Cavour erano state distrutte intorno alle 15.30 le vetrine di un supermercato e di due banche. Poi in via Labicana, prese d’assalto l’ex agenzia delle Entrate e una filiale della Banca popolare del Lazio all’incrocio con via Merulana. Aggredite due troupe di Skytg24: a un operatore è stata tolta la telecamera, poi distrutta. Intanto i teppisti entravano in un’agenzia di lavoro interinale al Colosseo, devastandola. E dopo lo sgombero di piazza San Giovanni intorno alle venti, la battaglia ha sconvolto il quartiere Esquilino, mentre il black bloc si dirigeva verso la stazione ferroviaria Termini. Gli ultimi scontri con barricate di auto e cassonetti incendiati in via Merulana hanno impegnato ancora fino a tarda sera le forze dell’ordine. *ha collaborato Monia Cappuccini OUTLET 51 A colloquio con il sociologo Alain Bertho Il tempodella sommossa INTERVISTA «CERCANDO DI CONTROLLARE E “NORMARE” TUTTO CIÒ, GLI STATI FINISCONO PER ESSERE DEI PERTURBATORI PIUTTOSTO CHE DEI REGOLATORI DELLA SITUAZIONE. ED È CONTRO QUESTE FORME DI CONTROLLO CHE CRESCONO GIÀ OGGI LE NUOVE RIVOLTE E LE NUOVE FORME DI CONFLITTO». di Guido Caldiron «L a sommossa è perlopiù un vero e proprio faccia a faccia degli individui con lo Stato, a partire dalla questione dei principi e delle fondamenta dell’azione pubblica. Svelando la condizione reale della politica istituzionale, la sommossa può forse indicare lo spazio necessario di una interlocuzione. In attesa di questa interlocuzione, o semplicemente in assenza di quest’ultima, è lo scontro che prende forma. Nell’epoca in cui la produzione di ricchezza è affidata sempre più al cognitivo e all’immateriale, quando le forme di dominio sembrano passare soprattutto per il controllo delle idee, delle immagini e dell’informazione, ecco dunque il ritorno del corpo, della sua esibizione, della sua messa in pericolo nell’espressione della sommossa». Docente di Antropologia all’Institut d’Etudes Européennes e direttore della scuola di dottorato in Scienze sociali all’Università di Paris 8 a Saint Denis, Alain Bertho è uno dei maggiori sociologi francesi, autore di OUTLET 53 INTERVISTA una decina di saggi che spaziano dal controllo sociale nelle aree urbane ai nuovi movimenti giovanili, fino alla guerra, è tra gli studiosi che meglio e più a lungo hanno studiato le banlieue francesi e le numerose rivolte che vi hanno avuto luogo negli ultimi trent’anni. Da questo laboratorio privilegiato di osservazione sui nuovi fenomeni sociali, Bertho ha poi mosso negli ultimi anni verso una sorta di analisi comparativa dell’insieme delle rivolte urbane e giovanili che attraversano il mondo della globalizzazione e, ora, della crisi. Prima tappa di questo nuovo ciclo di studi, la pubblicazione nel 2009 di Le temps des émeutes (Bayard Editions), un volume che mettendo in parallelo quanto accaduto nell’ultimo decennio in Europa, dalla Genova del 2001 all’Atene di oggi, con fenomeni simili che si sono prodotti a varie latitudini, dal Tibet alla Cina, passando per l’America Latina e l’Iran, definisce quella odierna come l’“era della sommossa”. Secondo Bertho, al di là delle modalità e dalle forme assunte dalle rivolte giovanili e urbane scoppiate in tutto il mondo negli ultimi anni, questi fenomeni ci parlano infatti di una realtà per molti versi simile: quella costruita dalla globalizzazione economica e dalla rivoluzione produttiva postfordista che hanno trasformato l’intero spazio urbano in una immensa area produttiva e, per questa via, anche nel “luogo” del conflitto. «Gli émeutes (le sommosse) – spiega Bertho nel libro – non rappresentano né il riemergere di forme arcaiche di rivolta, né il prolungamento senza fine di ciò che gli storici hanno chiamato “le emozioni popolari”. Sono, al contrario, uno dei volti che definiscono l’epoca in cui viviamo e una delle chiavi di lettura, nella loro dimensione, sia soggettiva che globalizzata, del presente». Non solo. All’interno dell’odierno mondo globalizzato, le sommosse rappresentano una sorta di «sequenza dello scontro», qualcosa di paragonabile a ciò che un tempo si sarebbe definito come un “ciclo rivoluzionario”. La rivolta delle banlieue francesi del 2005 e il riot londinese dell’estate del 2011, e ciò che vi ha fatto seguito in molte altre metropoli, finiscono così per assumere agli occhi di Bertho caratteristiche paragonabili, con le dovute proporzioni, alla Primavera dei popoli del 1848, alla Rivoluzione del 1917 e alle sue conseguenze internazionali, o agli avvenimenti del Sessantotto. Il fatto che queste vicende siano spesso derubricate come puri fenomeni di ordine pubblico, cioè che non abbiano alcuna relazione diretta le une con le altre o non sembrino esprimere, al di là dell’incendio di qualche macchina, del saccheggio di un negozio o dello scontro con le forze dell’ordine, alcuna rivendicazione o alcun esplicito “messaggio” politico, non sembra turbare né suggerire maggiore cautela allo studioso francese. Rispondendo all’analisi corrente che legge nelle rivolte urbane un malessere sociale che la politica dovrebbe tentare di tradurre in rivendicazioni e proposte, Bertho conclude affermando invece l’assoluta novità di questo fenomeno. 54 OUTLET INTERVISTA «L’émeute – spiega — non enuncia un limite del campo politico che dovrebbe aprirsi per integrare nuove rivendicazioni, nuove sfide e nuovi attori sociali. In realtà, siamo in presenza di qualcosa di più profondo che indica l’esaurimento dello spazio pubblico moderno e delle forme di azione collettiva che vi si sono dispiegate fin qui. Possiamo ipotizzare che questa famosa “traduzione politica” sia oggi semplicemente impossibile. Questi giovani sembrano infatti dirci che le loro rivendicazioni e la loro richiesta di ascolto da parte dello Stato non passano per la politica, ma per un “faccia a faccia” che può essere anche violento». Ed è in questo “confronto” dei giovani con lo Stato, quasi un’istantanea tratta da ogni rivolta urbana, che sembra prendere corpo ciò che Bertho definisce come «lo spazio necessario di un’interlocuzione»: una sorta di rifondazione dello spazio pubblico che passa per i corpi e per le strade, negando legittimità a quella rappresentanza politica che non appare più in grado di incontrare buona parte della società e certamente non i settori giovanili e quelli più soggetti alle forme di esclusione. Se gli émeutes «non comunicano», nessuno sembra del resto davvero interessato ad ascoltarli. Le temps des émeutes ha rappresentato solo una prima fotografia di questi fenomeni che il sociologo francese continua a monitorare attraverso il suo blog, berthoalain.wordpress.com. Secondo lei siamo entrati nel “tempo della sommossa”, vale a dire? Con questa espressione mi riferisco al fatto che viviamo in un’epoca contrassegnata un po’ ovunque nel mondo dalla “rivolta”. Nel mio blog descrivo queste rivolte, tra loro anche molto diverse, il cui numero non ha mai smesso di crescere negli ultimi anni. Si tratta perciò di un fenomeno non occasionale, ma che, al contrario, “segna” in modo netto l’epoca in cui viviamo. Si tratta di rivolte che hanno il significato che può aver avuto nell’Ottocento la Comune di Parigi o nel Novecento la Rivoluzione bolscevica o il Sessantotto. A differenza del passato, le rivolte di oggi si caratterizzano però per alcune particolarità. La prima è rappresentata dal fatto che non stiamo parlando di un unico movimento, ma di fenomeni tra loro molto diversi, che sono accumulabili solo per il fatto che si manifestano attraverso la rivolta. La rabbia che genera questi émeutes ha infatti origini differenti e perciò risulta impossibile accumunare e leggere allo stesso modo i tanti fenomeni sociali di cui ci parla. Da questa condizione deriva una sorta di “invisibilità”: si parla ogni volta di quello che accade in questo o quell’angolo del mondo, mai di un qualcosa di complessivo e stabile. L’altra particolarità è rappresentata dal fatto che queste rivolte sono destinate a durare nel tempo, non si esauriscono in un periodo limitato ma finiscono per caratterizzare stabilmente la vita di una determinata società. Ciò detto, il paradosso sta nel fatto che, al di là delle differenze apparenti, OUTLET 55 INTERVISTA queste rivolte si esprimono con un vocabolario simbolico tra loro molto simile e dicono, spesso nello stesso modo, delle cose chiare al potere. Se prendete delle foto delle ultime rivolte che ci sono state sulla Spianata delle Moschee a Gerusalemme, in Cina, Bangladesh, Venezuela, Spagna, Turchia o ad Atene, vi troverete di fronte agli stessi visi mascherati, le stesse paure, la stessa rabbia e lo stesso fuoco. Si tratta, di fronte ai processi di globalizzazione che caratterizzano l’intero pianeta, di una sorta di messa in discussione complessiva dello spazio della rappresentanza politica: uno spazio che è la rivolta stessa a voler occupare. In Francia anche la sinistra sembra negare la natura politica delle sommosse che avvengono nelle banlieue. Si tratta di vicende che vengono derubricate come “questioni di ordine pubblico”. Perché? Non è vero che gli émeutes nelle banlieue non dicono nulla, che siano degli atti di violenza o di vandalismo fine a se stessi. Le rivolte nelle banlieue dicono molte cose e, soprattutto, se i giovani che vi partecipano arrivano a doversi ribellare con queste modalità, significa che non trovano alcun altro modo possibile per “prendere la parola”. Per questo credo che la prima cosa di cui ci parlano queste rivolte sia proprio la crisi dello spazio della rappresentanza politica così come si è andato definendo per tutto il XIX e il XX secolo. La cultura politica della sinistra che si è formata negli scorsi secoli proprio attraverso le rivolte e la volontà di cambiare la società, si è progressivamente trasformata nell’idea che per cambiare la società si dovesse prendere il potere, che si trattasse di farlo con la rivoluzione o attraverso le elezioni poco importa. Vale a dire che è attraverso lo Stato che si pensava di cambiare il mondo e la vita delle persone. Il risultato è che oggi la politica si gioca per molti aspetti tutta all’interno dello Stato, nella conquista di una maggioranza o di una quota elettorale, in quella che per molti giovani delle classi popolari appare come una sorta di bolla separata e lontana dal resto della società. Come se esistessero due lingue: da un lato quella dello Stato e della politica, dall’altro quella della società. E’ passato qualche anno dall’uscita di Le temps des émeutes, trova che le sue analisi abbiano trovato conferma in quanto accaduto nel frattempo? Direi di sì. Nel senso che il processo che avevo cominciato ad osservare allora non ha fatto che crescere e allargarsi. Per scrivere quel testo avevo fatto riferimento a circa 350 sommosse: nel 2100 ne ho “registrate” oltre 1280, nel 2011 oltre 1780 e nei primi sei mesi del 2012 le cronache ne segnalano già molte di più dello scorso anno. Si tratta di un fenomeno che continua a crescere e ad allargarsi sul piano geografico, coinvolgendo un numero sempre più grande di Paesi, e che scaturisce da condizioni tra loro diverse ma con elementi simili e ricorrenti quanto alle modalità che 56 OUTLET INTERVISTA assume. Spesso all’origine di queste rivolte troviamo così la morte di un giovane, morte in cui la polizia e le forze dell’ordine sono in qualche modo implicate – come accaduto nel 2011 a Londra –, o i tagli a un servizio essenziale o l’aumento improvviso di un genere di prima necessità, come è accaduto quest’anno con il costo dell’elettricità in Algeria o in alcune zone del Pakistan e in Sudan. In questi ultimi anni le cose hanno però conosciuto anche un’altra evoluzione. In molte realtà abbiamo infatti assistito a una sorta di “generalizzazione della rivolta” che ne ha modificato le stesse caratteristiche iniziali. Dal fatto che non si potesse che far sentire in questo modo la propria voce – come accade ad esempio quando un giovane resta ucciso per mano degli agenti –, si è spesso passati a un vero e proprio “contagio” della rivolta che ha finito per riproporre con questa modalità anche delle forme per così dire più “tradizionali” del conflitto. Una rivolta generalizzata emerge sempre più di fronte a Stati che, spesso a causa del debito contratto nei confronti di organizzazioni economiche internazionali, non hanno più la capacità di ascoltare o anche solo di considerare l’opinione dei loro cittadini. Questi Stati perdono così qualunque legittimità e non hanno più, proprio perché sono stretti nei vincoli di una situazione debitoria o di dipendenza economica, nessuna possibilità di negoziare con i movimenti sociali e popolari. E questa è una condizione che non viene contraddetta dal colore politico di un determinato governo o regime: il modo d’agire resta sempre lo stesso. Si tratta di un potere che non fa alcuna concessione, e che al massimo sceglie la strada della repressione. Ha “tenuto” così il potere francese di fronte alla grande mobilitazione del 2010 contro la riforma delle pensioni, come “tiene” da mesi quello del Quebec contro le manifestazioni degli studenti prima – che protestavano per l’aumento del 75% delle tasse universitarie – e contro il vero movimento popolare che ne è scaturito poi. E lo stesso è accaduto nell’ultimo anno in Cile di fronte al movimento cresciuto nelle scuole superiori e nelle università. Siamo di fronte a un potere che non concede più alcuno spazio alla mediazione, alla trattativa, per non dire a qualche concessione. Questa situazione spinge le mobilitazioni che nascono spesso in forma tradizionale, o ancora “inquadrate” da partiti, sindacati o associazioni, ad uscire dagli argini e a trasformarsi progressivamente in vere e proprie sommosse. È per questa via che si può affermare oggi che la condizione dell’émeutes è divenuta in qualche modo comune. Non solo. Pur nel caso in cui non ci si trova di fronte a scontri, accade però che la mobilitazione di questa o quella categoria del mondo del lavoro, anche se guidata dai sindacati, assuma quelli che possono essere evocati come dei simboli della rivolta, primo fra tutti “il fuoco”: fuochi accesi in mezzo alla strada o cose messe a bruciare di traverso, lungo una carreggiata. Ecco che quella manifestazione sindacale finisce per assomigliare a una rivolta urbana, a una vera e propria sommossa. OUTLET 57 INTERVISTA Questo significa che nello spazio di qualche anno, con lo sviluppo della crisi finanziaria e economica internazionale, le sommosse hanno cominciato ad incidere in modo diverso sulla realtà circostante, ad imporsi in qualche modo nello spazio politico tradizionale? Credo si possa dire che, perlomeno fino al 2011 – poi spiegherò perché lo scorso anno abbia cambiato molte cose in proposito –, gli émeutes si caratterizzavano per essere delle rivolte senza parole, non tanto perché chi vi partecipava non avesse niente da dire, ma perché non c’era nessuno a cui dirlo, nessuno in grado di ascoltare. Le rivolte non avevano alcun interlocutore davanti a sé. Ma, in modo davvero strabiliante, proprio il 2011 ha segnato in qualche misura il ritorno della parola: una parola collettiva che ha saputo imporsi nello spazio pubblico e che ha fatto addirittura vacillare il potere di molti Stati, e penso in questo caso soprattutto alla cosiddetta “Primavera araba”. In altri termini, abbiamo assistito in questo ultimo anno (che considero di svolta), alla costruzione di un “noi”, magari momentaneo e legato ogni volta a situazioni particolari, in grado però di incidere profondamente sulla realtà circostante. E si tratta di un “noi” che non si definisce attraverso le formule tradizionali della politica: sinteticamente si può dire che ad esempio né in Tunisia, né in Egitto questo processo si sia compiuto all’ombra delle bandiere rosse come di quelle verdi. Simboli di queste rivolte non sono stati né i riferimenti alla tradizione rivoluzionaria del movimento operaio, né i simboli religiosi, bensì la bandiera nazionale, che ha riunito, in entrambi i casi, un intero popolo contro lo Stato. E questa, credo, sia la caratteristica dominante dell’evoluzione che queste forme di rivolta stanno conoscendo in varie parti del mondo. Prendiamo il caso del Senegal, una realtà che ho seguito nell’ultimo anno con particolare attenzione, dove il movimento “Y’en a marre”, composto soprattutto da giovani, intellettuali e artisti, ha puntato proprio a ridefinire la nozione stessa di “popolo senegalese”, chiedendo un nuovo ruolo dei cittadini nei confronti del potere politico. Perché questo processo, questo “noi” collettivo che prende forma intorno alla rivolta, si mostri completamente, c’è bisogno che i giovani, e sopratutto i giovani dei settori popolari di quella società, superino il tentativo di stigmatizzazione nei loro riguardi operato da tutti gli Stati. In caso contrario, la rivolta è schiacciata, repressa e soffocata.È quanto è capitato in Gran Bretagna nel corso del 2011. Prima c’è stato un forte movimento studentesco che si è costituito contro l’aumento dei costi dell’Università – e che è arrivato a saccheggiare la sede centrale del partito conservatore a Londra –, quindi, solo qualche mese dopo, una rivolta urbana, scaturita dalla morte di un giovane per mano delle forze dell’ordine. In questo caso le due rivolte sono rimaste totalmente separate e non hanno saputo contribuire alla costruzione di un vero “noi”. E la stessa cosa era accaduta già nel 2005 in Francia dove 58 OUTLET INTERVISTA la rivolta delle banlieue era stata marginalizzata dallo Stato, e questo anche grazie alla complicità di una parte delle forze politiche di sinistra e dei sindacati. Perciò, perché si possa tornare davvero a parlare di “politica” di fronte allo Stato, bisogna che si congiungano le diverse forme di rivolta che si stanno esperimendo specie tra i giovani, – ad esempio studenti e giovani delle periferie – e che prenda corpo un nuovo “noi”. Altrimenti si rischia che le rivolte continuino, anche in forme molto violente, ma senza intaccare minimanete i meccanismi di funzionamento dello Stato. Nella prospettiva della sommossa, quanto pesa la messa in gioco dei corpi? Si ha quasi l’impressione che la violenza che accompagna le rivolte urbane ne rappresenti uno degli aspetti centrali, essenziali. Si ha l’abitudine di dire che a caratterizzare la sommossa sia la violenza espressa da parte chi vi partecipa. In realtà la prima violenza compiuta da chi scende in strada è rappresentata dal mettersi a rischio, dai pericoli a cui si espone nel partecipare alla rivolta stessa. Si tratta di un pericolo spesso molto forte, che varia da Paese a Paese e da un continente all’altro. Può trattarsi di un pericolo di carattere fisico, giudiziario, o le due cose allo stesso tempo. In Siria si rischia direttamente la vita, in Francia o Italia è più facile subire una condanna giudiziaria, anche se i pericoli fisici non sono assenti. In ogni caso, chi partecipa a una rivolta sa di rischiare qualcosa, ma sembra dimenticarlo nel momento in cui decide di passare all’azione. In questo senso la repressione non rappresenta mai un deterrente sufficiente per chi decide di prendere parte a una rivolta, sa che la subirà, ma non sembra temerla. Ed è questa dimensione estrema che ci dice dell’emergenza della rivolta nel mondo di oggi: se non ci fosse bisogno di mettere a rischio la propria stessa vita, si proverebbe a dire le cose in un altro modo, con un altro linguaggio. Ma è proprio perché non c’è un altro modo per farsi ascoltare che la rivolta diventa necessaria. Del resto, proprio dalla Primavera araba degli ultimi due anni, ci viene un altro esempio di come la rivolta metta in gioco fino in fondo chi vi partecipa. Penso a quelle forme di sacrificio supremo, di auto-immolazione con il fuoco – la morte in questo modo di un giovane ha fatto da detonatore alla rivolta tunisina –, che altro non sono se non delle rivolte individuali. E episodi simili si erano registrati anche in Cina. Questa rivolta estrema e individuale aprirà poi la strada in tutti questi casi alla rivolta collettiva. La messa in gioco della propria vita diventa perciò la condizione stessa perché abbia luogo la rivolta. Se le rivolte definiscono l’orizzonte di un nuovo spazio pubblico, come immaginare il futuro, attraversato da quali forme di conflitto? I nuovi movimenti che si sono prodotti negli ultimi anni in diverse OUTLET 59 INTERVISTA Guido Caldiron Studioso delle nuove destre e delle culture giovanili, giornalista di Liberazione, ha pubblicato diversi saggi, tra cui I fantasmi della République (2011), L’impero invisibile (2010), La destra sociale (2009), Populismo globale (2008), tutti editi dalla manifestolibri. parti del mondo testimoniano dell’esistenza di capacità collettive atte a far funzionare “il sociale” anche al di fuori dell’intervento pubblico o della regolamentazione poliziesca. Vale a dire al di fuori dello Stato. E questa è una delle caratteristiche dei nuovi dispositivi produttivi contemporanei. Poi c’è un altro elemento: per far funzionare questa nuova dinamica, c’è bisogno di capacità e conoscenze che sono nelle società stessa, di cui cioè lo Stato non ha né il monopolio né il controllo. Cercando di controllare e “normare” tutto ciò, gli Stati finiscono per essere dei perturbatori piuttosto che dei regolatori della situazione. Ed è contro queste forme di controllo che crescono già oggi le nuove sommosse e le nuove forme di conflitto. 60 OUTLET RICADUTE RICADUTE Apologia del furto d’auto VIDEOGIOCO DI SUCCESSO DEMONIZZATO DA POLITICI E GENITORI, GTA (GRAND THIEF AUTO) CONSENTE UNA (RI)APPROPRIAZIONE SENZA REGOLE DEL TERRITORIO. SE LA METROPOLI REALE NON OFFRE PIÙ LE POSSIBILITÀ DI DUE SECOLI FA, LA METROPOLI VIRTUALE CONSENTE DI FARE TUTTO: RUBARE, GUIDARE SENZA LIMITI, MORIRE RIMANENDO VIVI, FARE I CATTIVI. di Alessio Ceccherelli D a quando è apparsa nel mercato dei videogiochi, la serie di Grand Theft Auto, o Gta, della Rockstar Games, ha riscosso un enorme successo. Dal 1997 ad oggi ha superato abbondantemente i 100 milioni di copie, dato di per sé significativo, ma che lo diventa ancor di più se ad esso si aggiungono le vendite del mercato nero e le pratiche di file sharing che girano, vorticosamente, intorno all’industria videoludica. Il motivo per cui Gta sale spesso agli onori della cronaca, però, non risiede nella sua capacità di vendita, né nelle entusiastiche recensioni della stampa specializzata. Gta si presenta al pubblico di giornali e televisioni come uno dei giochi più violenti e diseducativi che siano mai stati creati, e non mancano mai – ad ogni uscita di un nuovo numero della serie – articoli di psicologi preoccupati, dichiarazioni di inorriditi rappresentanti di associazioni di genitori, interpellanze parlamentari di politici di ogni credo. Scopo del gioco è, infatti, farsi una reputazione da criminale nella città, assolvendo a missioni di ogni genere (dalla rapina, al recupero crediti, al pestag- 62 OUTLET RICADUTE gio, all’omicidio) per diversi “committenti” che cambiano a seconda della versione del gioco: italiani mafiosi, giapponesi della Yakuza, colombiani del Cartello, cinesi della Triade, gang afroamericane, e molti altri. Detto così, ci sarebbe di che dare ragione alle rimostranze elencate. Il problema è che Gta, come qualsiasi altro videogioco, come qualsiasi altro prodotto culturale di qualsivoglia forma estetica, non può essere identificato – soltanto – nella sua trama e nella sua ambientazione. Se così fosse, dovremmo parlare dell’Ulisse di Joyce come della giornata di un personaggio che tradisce la propria moglie sapendo di essere a sua volta tradito, che si masturba alla vista della biancheria intima di una ragazza che poi scopre essere zoppa, e che finisce con l’andare in un bordello dove incontra un altro personaggio del romanzo spesso in preda a fantasticherie allucinate. Si può ridurre a questo il capolavoro dello scrittore irlandese? Ridurre un’opera alla sua trama è sempre limitante, anche quando si tratta di videogiochi. Sì, perché i videogiochi rappresentano ormai da molti anni un medium maturo, perfettamente in grado di raccontare storie complesse, trasmettere emozioni, coinvolgere l’immaginario dei suoi “utenti”. Alcuni titoli (Heavy Rain e L.A. Noire, tanto per fare qualche esempio recente) hanno ottenuto il plauso anche di buona parte della critica non specialistica, soprattutto per la notevole qualità e complessità narrativa, ponendosi come – ennesimo – punto d’incontro tra videogiochi e cinema. Esiste ormai, del resto, una sorta di continuità di immaginario tra film e videogames, tanto che i primi preparano il campo ai secondi, e questi colmano vuoti narrativi che il cinema – per limiti tecnici o di sceneggiatura – non riesce a coprire. Ma le liaisons intermediali del videogioco non si fermano certo al cinema. Anche la letteratura comincia a subirne l’influenza, in un processo di rimediazione che molto spesso inizia e finisce proprio nelle opere letterarie (viene in mente Il signore degli anelli che dà forma e sostanza all’immaginario fantasy del seguitissimo gioco online World of Warcraft, il quale a sua volta fa da base ad un universo letterario che ha già prodotto molti romanzi). E neanche l’arte, quella figurativa o plastica per intenderci, è da meno: non solo perché le textures che compongono gli sfondi digitali dei videogames hanno raggiunto un livello di raffinatezza che si può definire senza indugi “artistico”, ma anche perché i videogiochi sono ormai oggetti d’arte, ispirando le opere di vari artisti (qualche nome per i curiosi: Miltos Manetas, John Haddock, Enrico Mitrovich). Le critiche portate a Gta, comunque, non riguardano soltanto la trama. Quanto viene rinfacciato ad alcuni videogiochi è quello di far agire giovani e meno giovani su contenuti di scarso valore etico, abituandoli dal punto di vista emotivo-comportamentale – e, sostiene qualcuno, anche da quello cognitivo – alla violenza, alla scorrettezza, ad un linguaggio triviale. Sembrerebbe, insomma, che chi gioca a questo tipo di giochi passi da rapine e omicidi virtuali ai loro corrispettivi reali, allevando una generazione di volgari criminali in erba. Gli studi che sostengono questa consequenzialità tra virtuale e reale OUTLET 63 APERTURE RICADUTE sono molti e, ovviamente, molto accreditati dall’establishment politico e mass-mediale. Esistono a dire il vero altri studi – anche più numerosi – che sostengono l’esatto contrario, ovvero che la virtualità faciliti la sublimazione degli istinti di violenza e del desiderio di assoluta libertà (di comportamento e di linguaggio), senza provocarli o acuirli, ma anzi convogliandoli nella loro dimensione digitale. In generale, però, la vulgata che passa è quella del videogioco traviatore, del videogioco feccia. Ma è la solita storia che si ripete da secoli, ad ogni novità, ad ogni innovazione che rompe gli equilibri precedenti: è successo con la forchetta, bandito per anni come strumento del diavolo, figuriamoci con un medium così potente sotto ogni punto di vista: narrativo, estetico, ludico. Come detto, Grand Theft Auto è pienamente impostato su un immaginario violento, scorretto e triviale: a parte le missioni che si devono portare a termine per progredire nella storia del gioco, il linguaggio usato è quello delle gang di strada, la guida dei veicoli porta quasi inevitabilmente a trasgredire le regole del codice della strada, falciando pedoni, andando contro senso, distruggendo tutto ciò che si può distruggere. Addirittura, in alcuni titoli della serie, è possibile far salire sulla macchina una prostituta assistendo così ad un movimento sussultorio che lascia poco spazio all’immaginazione. Apriti cielo. Su questo si sono scagliati con veemenza le associazioni di genitori di praticamente tutti gli Stati in cui il gioco è stato distribuito. Gta, però, va oltre questo aspetto contenutistico. E ci mancherebbe. Altrimenti non si spiegherebbe l’enorme successo avuto, sia in termini di quantità (le copie vendute) che di continuità (i 15 anni passati dal primo titolo della serie). Il gioco è realizzato in modo impeccabile, dal punto di vista grafico, narrativo, sonoro, di giocabilità: a partire da Gta III, e via via sempre di più, il giocatore può interagire in modo esteso ed articolato con l’universo videoludico creato. La metropoli in cui ci si trova ad agire è curata nei minimi dettagli ed è viva, nel senso che gli oggetti, i palazzi, le persone, sono per la gran parte in grado di restituire feedback di varia natura, come raramente si vede negli altri videogiochi: i passanti ci parlano, in molti locali si può entrare, gli oggetti si rompono e si deformano se urtati con la macchina o se ci si butta una bomba. Le città che fanno da sfondo ai vari titoli, Liberty City e Vice City su tutte, sono chiaramente ispirate a New York e Miami, mentre lo Stato di San Andreas sembra costituito da un mix di California e Nevada, con le città di Los Santos (cioè Los Angeles), San Fierro (San Francisco), e Las Venturas (Las Vegas). A partire proprio da San Andreas, inoltre, è possibile curare il proprio personaggio in modo molto particolareggiato: si può andare in palestra e irrobustirsi, entrare in un fast food e mangiare fino ad ingrassare, correre e dimagrire, andare dal parrucchiere e scegliere decine di acconciature, comprare vestiti in un negozio di abbigliamento, farsi tatuare in un tattoo shop. Le possibilità di interazione sono molteplici e incredibilmente variegate (in alcuni locali si può addirittura giocare a vecchi videogiochi, in una specie di attorcigliamento metamediale), restituendo uno straordinario senso di 64 OUTLET RICADUTE realtà. Una realtà che, però, non fa il verso a quella “vera”, come in qualche modo fanno The Sims o Second Life, ma che è disegnata su un immaginario che richiama in modo più o meno esplicito i film di Francis Ford Coppola, di Martin Scorsese, di Spike Lee, di Micheal Mann, di Clint Eastwood, film in cui il conflitto (sia esso una scalata al potere della criminalità organizzata o lo scontro tra gang) rappresenta il motore narrativo, lo sfondo semantico (si pensi a Taxi Driver o a Gran Torino). Le metropoli di Grand Theft Auto sono infatti metropoli che – come quelle reali a cui si ispirano – vivono di conflitti, e basano sul conflitto le loro storie. Già i personaggi che il giocatore deve impersonare sono predisposti allo scontro, rappresentanti di realtà emarginate: l’italiano Tommy Vercetti di Gta Vice City, l’afroamericano CJ di Gta San Andreas, il bosniaco Nikolaj “Niko” Bellic di Gta IV, il cinese Huang Lee di Gta Chinatown Wars, sono praticamente costretti, dalle proprie origini, a intraprendere quella strada fatta di scorribande, rapine e omicidi. È una visione senz’altro stereotipata dei gruppi etnici raccontati, uno stereotipo che come detto nasce soprattutto dall’immaginario cinematografico; ma si tratta di una visione che – soprattutto – descrive il contesto metropolitano non più come luogo dalle infinite possibilità, come poteva accadere nell’800, ma come spazio di inevitabili conflittualità in cui l’elemento istituzionale e quello civico non hanno alcun potere sulla lotta anarchica tra le tante gang e le tante mafie presenti sul territorio. Al di là di personaggi di politici e poliziotti corrotti, l’unica rappresentate dello Stato – la polizia – ne esce inevitabilmente schiacciata, ridicolizzata, incapace di mantenere l’ordine e far rispettare le regole, elemento addirittura fastidioso che in alcune missioni cerca di mettere i bastoni tra le ruote alle intenzioni di chi sta giocando. Le domanda poste da Massimo Ilardi nel primo numero della rivista, sul perché la forma odierna dell’azione conflittuale sia disegnata dalla libera appropriazione, dal desiderio di libertà e dall’appartenenza culturale, trova in questa serie di videogiochi un’incredibile conferma: l’ambiente in cui il giocatore si trova a vivere risponde esattamente a queste dinamiche ed è su di esse, del resto, che si basa l’avanzamento nella storia del gioco. Si provi ad andare, a piedi o in macchina, in quartieri di gang nemiche: il vostro personaggio sarà implacabilmente bersaglio di spari e/o di spedizioni punitive. Non si scappa. Il territorio di Gta, sempre per riprendere le provocazioni di Ilardi, si mostra come la consacrazione di “particolarismi e individualismi in lotta perenne tra loro”. Probabilmente è proprio su questa (ri)appropriazione di uno spazio d’azione vasto e particolareggiato, senza regole e con confini laschi, predisposto al desiderio di libertà di ciascuno, che il gioco basa il suo successo. Se la metropoli reale non offre più le possibilità di due secoli fa, la metropoli virtuale consente di fare tutto, digitalizzandolo davanti agli occhi: rubare senza conseguenze le macchine più potenti e desiderate (Porsche, Ferrari, Corvette, Limousine), guidare ogni tipo di veicolo, dalla bicicletta all’aereo, vagare per OUTLET 65 RICADUTE RICADUTE Alessio Ceccherelli. Si aggira – precariamente – tra aule, corridoi e studi di alcune università (Roma Tor Vergata, Roma Sapienza, Cagliari). Si occupa di mediologia e del rapporto tra apprendimento e (nuove) tecnologie, con particolare attenzione agli strumenti presenti in internet e ai videogiochi. Tra le sue pubblicazioni: Oltre la morte. Per una mediologia del videogioco (2007) e L’intelligenza dei missili. L’educazione di oggi tra interiorità ed esteriorizzazione (2011). 66 OUTLET ore nelle strade osservando lo scorrere delle ore e dei giorni senza bisogno di dormire, morire in tutti i modi possibili con la certezza di ritrovarsi di nuovo vivo e vegeto (con la barra dell’energia di nuovo a 100) per poter ricominciare da capo, come nel film con Bill Murray. Fare i cattivi. Grand Theft Auto è indubbiamente il videogioco più adeguato a questo tipo di discorso, ma non rappresenta un unicum. Non solo perché esistono altri titoli di ambientazione metropolitana che gli fanno più o meno il verso (vengono in mente Mafia e Scarface, ma anche un altro grande successo della Rockstar Games, Red Dead Redemption, che sposta lo stile di gioco di Gta nel Far West dei primi anni del ‘900), quanto perché – in fin dei conti - è il videogioco in sé ad essere impostato sul conflitto. Si pensi ai cosiddetti First Person Shooter, dove si viene calati in uno spazio in cui l’unico modo per andare avanti nel gioco è sparare, e il cui contesto è molto spesso quello di un conflitto realmente esistito (dalla Seconda Guerra Mondiale, al Vietnam, all’Afghanistan). Si pensi agli strategici, in tempo reale o a turni, in cui si deve guidare un esercito o un popolo o un gruppo di uomini e li si deve far lottare con opposte fazioni. E si pensi ai giochi di ruolo, anch’essi caratterizzati da razze e popoli in lotta tra di loro. Ma al di là di titoli e generi specifici, il videogioco funziona – narrativamente – proprio perché propone al giocatore una serie di ostacoli, di problemi, di criticità da risolvere. È per questo che esso viene riconosciuto, anche dai detrattori, come campo d’azione privilegiato di problem solving, soprattutto in una prospettiva didattica. Spesso, però, questi problemi si identificano in varie forme di conflitto, costituendo sia una valvola di sfogo, un’opportunità di liberare il desiderio, sia una sfida contro un sistema (la matrice informatica che ci impone i suoi vincoli) e contro se stessi (il superamento dei propri limiti). Se così non fosse, non si venderebbero decine di milioni di copie, e non si aspetterebbe con ansia la storia successiva. Non necessariamente un videogioco è in grado di farlo, ma un videogioco ben progettato sì, e oggi come oggi la qualità media raggiunta consente quel tipo di dinamica. Esistono – è vero – titoli idioti (a partire dal famigerato Custer’s Revenge del 1983, dove l’unica cosa che andava fatta era stuprare una vergine indiana), ed esistono giochi mal progettati, in cui il rapporto tra tensione emotiva e giocabilità è sbilanciato a favore del primo, provocando nervosismo e frustrazione invece di divertimento. Ma, in generale, si tratta di eccezioni, che comunque vengono punite dal mercato. Anche in questo caso vige la banale regola del consumo: se funziona si vende, altrimenti no. Sulla qualità del conflitto virtuale c’è un’ultima riflessione da fare. Che rapporto si pone tra questo sistema di conflict setting e i contesti conflittuali reali? Fino a che punto i videogiochi si pongono come alternativa sublimatoria e quanto, invece, fanno da specchio e da amplificazione alla situazione reale? Sarebbe interessante un’analisi sociologica dei giocatori di Grand Theft Auto: hai visto mai che, alla fine, si viene a scoprire che esso svolge un ruolo di non poco conto nel mantenere lo status quo, portando acqua al mulino di quel potere che – per contro – sembra esserne tanto schifato? OUTLET 67 RICADUTE Illegal social housing SOVRAFFOLLAMENTO, COABITAZIONE, AUMENTO DEGLI SFRATTI PER MOROSITÀ. IL DISAGIO ABITATIVO IN ITALIA È IL PIÙ GRAVE RISPETTO AGLI ALTRI PAESI D’EUROPA. LE CIFRE E LE CAUSE DI UN’ANOMALIA. di Roberto De Angelis S e i riot fossero l’indicatore dei livelli di conflitto urbano, dovremmo dedurne che le nostre città sono territori tutto sommato pacificati rispetto ad esempio a Parigi e Londra. Eppure la retorica securitaria evoca i moti incendiari delle banlieues riferendosi a migranti e in particolare ai rom. Il conflitto urbano nostrano non esplode in maniera magmatica ma perché si configura in pratiche illegali e antagoniste continue e diffuse. Basti considerare la pratica delle occupazioni per contrastare l’esclusione abitativa. Secondo gli stessi dati Eurostat il disagio abitativo in Italia è il più grave rispetto agli altri Paesi dell’Europa occidentale. Sovraffollamento e coabitazione, abita- 68 OUTLET RICADUTE zioni con carenza dei requisiti essenziali per il 7,3% corrispondente ad 1,6 milioni di famiglie rispetto al totale di 22 milioni. La situazione più grave riguarda varie aree metropolitane. A Roma a fronte di 140.000 appartamenti tenuti sfitti, più di 50.000 famiglie si trovano in condizioni di estrema precarietà. Più di 30.000 sono in graduatoria per ottenere una casa popolare. Molte migliaia hanno usufruito dei contributi comunali per pagare il fitto, ma i fondi hanno subito un drastico ridimensionamento. Gli sfratti sono avvenuti soprattutto per morosità, per l’impossibilità di far fronte ad un canone di affitto tra i più elevati d’Italia (un bilocale ha un costo medio di 1000 euro nei vari quartieri della periferia romana). Questa situazione era precedente alla crisi che dal 2008 che non ha fatto che rendere ancora più insostenibile la questione delle abitazioni. In passato Roma era stata interessata da un forte abusivismo edilizio, determinato non solo dalla speculazione, ma anche da necessità diffuse. Borghetti e baraccopoli avevano costituito una città spontanea illegale edificata dagli emigrati che erano accorsi dalle varie regioni del centro-sud nel dopoguerra per la ricostruzione della capitale. Ai giorni nostri il conflitto urbano connesso al disagio abitativo si configura in due modalità: 1) ancora con pratiche illegali per certi aspetti simili per l’occupazione di suolo pubblico o privato e la realizzazione di nuovi borghetti-bidonville; 2) occupazioni di appartamenti sfitti, ma soprattutto di interi edifici dismessi come uffici, scuole, fabbriche, ospedali, attuate tramite Comitati di lotta che organizzano e sostengono un vero e proprio movimento per il diritto alla casa. Gli attori sociali coinvolti sono ovviamente diversi dal passato, trattandosi in gran parte di migranti stranieri provenienti un po’ da tutto l’ecumene, le nuove classi subalterne del post-fordismo nei paesi mediterranei.È importante sottolineare che i Comitati di lotta hanno la capacità di attivare processi di una virulenza sorprendente che sembrano evocare le forme del conflitto degli anni ’70 per certi aspetti, con la differenza di riuscire nel contempo a svolgere un ruolo di mediazione continuo con le istituzioni, pur in una fase di egemonia dell’ideologia neo-liberista presso le stesse forze politiche della sinistra. L’occupazione di edifici dismessi a fini abitativi si è verificata anche in varie metropoli europee, ma ha coinvolto soprattutto settori giovanili della controcultura o artisti che hanno allestito atelier collettivi. Niente di paragonabile al proliferare diffuso dei Centri sociali occupati e autogestiti che hanno saputo resistere alla repressione e alla istituzionalizzazione. Comunque le differenze tra l’atelier di 59 Rue de Rivoli di Parigi ormai in tutte le guide turistiOUTLET 69 RICADUTE che, e il Forte Prenestino, ad esempio, esemplificano bene l’anomalia italiana anche nello scenario controculturale. Come si è indicato, la pratica delle occupazioni per fine abitativo può essere di terreni o di edifici. Farò solo degli accenni al primo caso perché richiederebbe uno spazio di trattazione adeguato. In tutta Italia sono sorte baraccopoli autocostruite da migranti, anche di grandi dimensioni per contenere più di mille persone, sino ai primi anni ’90. Sorsero nelle aree urbane o in quelle prossime alle fonti di lavoro, come nel caso di Villa Literno, per la raccolta del pomodoro. In seguito i migranti furono costretti a ridursi in insediamenti più piccoli, assai più numerosi, meno visibili, ma soggetti a sgomberi forzati continui. Si pensi per il caso dei rom romeni che la giunta Moratti a Milano ha messo in atto più di 400 sgomberi. Lo stesso ha rivendicato la giunta Alemanno a Roma, in continuità con quanto il sindaco Veltroni di centro-sinistra aveva già realizzato sistematicamente. Per questa politica non solo Amnesty International, ma la stessa Unione Europea, hanno sanzionato l’Italia per grave violazione continuata dei diritti umani. Ci sono state alcune eccezioni in fatto di tolleranza verso queste forme di insediamento, per ragioni di mera opportunità. A Roma staziona una popolazione di circa 6.000 persone titolari di protezione internazionale, con lo status di rifugiati politici o con la protezione umanitaria. Una buona parte di loro sono costretti a sopravvivere in condizioni allucinanti. Da più di dieci anni nella tendopoli sorta su un binario morto della stazione Ostiense, si raccolgono più di 150 giovani profughi dalla guerra in Afghanistan; numerosi profughi eritrei insieme ad altri migranti sopravvivono nella tendopoli-bidonville di ponte Mammolo. 1. Comitati di lotta per la casa & Squatters transnazionali Avevo svolto un’indagine etnografica all’interno dell’occupazione dell’ex ospedale oncologico “Regina Elena”, durata due anni e sgomberata nel settembre 2009. Fu un’occupazione di tre edifici in stato di totale abbandono, gestiti da tre diversi Comitati di lotta: Il Coordinamento cittadino di lotta per la casa, Action ed il Comitato obiettivo casa. Nell’edificio di Action c’erano 85 nuclei familiari, 150 adulti e una ventina di bambini: in pratica c’era tutto lo spettro della presenza migrante. C’erano rifugiati politici dall’Eritrea, algerini, senegalesi, ucraini, romeni, rom sino ai latino-americani degli ultimi flussi. La presenza degli italiani era ristretta al 20-30%, come nelle altre occupazioni. La maggior parte delle persone avevano un lavoro, per lo più nel commercio o nel basso terziario. Si trattava non di marginali, ma di soggetti inclusi, spesso con una vera busta-paga e con livelli scolastici anche medio-alti. Per poter avere la possibilità di entrare in una occupazione bisogna iscriversi ed entrare in una lista. Ad occupazione realizzata viene messo in piedi un Comitato di gestione che coordini tutte le attività necessarie a rendere abitabile un edificio costruito con altre funzioni. Si era arrivati all’ex ospedale dopo aver lasciato un ufficio, perché fornito di più bagni e di 70 OUTLET RICADUTE ambienti riadattabili a cucina. Gli spazi vennero rigorosamente assegnati secondo le necessità del gruppo familiare. Tutti avevano l’obbligo di intervenire alle assemblee e di fare un turno di sorveglianza-portierato attivo per 24 ore. Si dovevano difendere anche le altre occupazioni, soprattutto quando erano in pericolo. In occasione ad esempio di un tentativo di sgombero bisognava partecipare ad eventuali manifestazioni, scioperi e picchetti. I più attivi nell’occupazione erano membri di Action, ma risiedevano nell’ex ospedale come tutti gli altri. I migranti provenivano spesso da Paesi con regimi autoritari e nell’occupazione, a loro detta, avevano avuto un’importante occasione di socializzazione democratica. Il regolamento interno prevedeva l’espulsione per gli autori di prevaricazioni o violenze, soprattutto nei confronti delle donne, o anche il rifiuto a partecipare alle attività di servizio. Il ruolo dei Comitati di lotta spesso è stato ignorato da quanti hanno esaltato le occupazioni come laboratori sociali innovativi anche sul piano dei rapporti interculturali. Insomma l’autogestione sarebbe stata impossibile senza il sostegno-controllo da parte di Action che ha comminato espulsioni, impedito continuamente che si aggregassero marginali o che una certa micro-ciminalità s’infiltrasse. La Commissione sicurezza di Roma capitale nel 2010 aveva svolto una mappatura degli stabili di proprietà pubblica e privata occupati abusivamente: circa 70 occupazioni non autorizzate; qualcuna resiste da più di 10 anni. Merita una menzione particolare l’occupazione dell’ex salumificio Fiorucci sulla via Prenestina, organizzata dai Blocchi precari metropolitani. Oltre a migranti ed italiani sono presenti un centinaio di rom romeni sgomberati dall’insediamento di via di Centocelle. Tale presenza cozza contro il Piano nomadi dell’amministrazione comunale che prevedeva per i rom esclusivamente la possibilità di risiedere in campi e dunque di continuare ad essere segregati etnicamente. La presenza dentro Metropoliz è stata possibile grazie all’impegno dell’associazione Popìca, che aveva in precedenza curato che questi rom si assumessero in prima persona la responsabilità dell’accompagnamento a scuola dei figli senza ricorrere ai pulmini del volontariato. In questo modo si sarebbero potute attivare delle relazioni virtuose tra genitori e gadgè. Il sostegno del polo scolastico Iqbal Masiq, tra i più avanzati a Roma nell’accoglienza di migranti e rom, ha prodotto dei risultati d’inclusione sorprendenti anche se questi rom sopravvivono a malapena attraverso il riciclaggio. Benché ristrette a qualche caso, le occupazioni di edifici per fini abitativi, organizzate da gruppi di estrema destra sono una novità di questi ultimi anni. Hanno seguito forme giovanili di occupazione di spazi con certe similitudini con i Centri sociali. L’occupazione di un palazzo di via Napoleone III da parte di CasaPound è la più conosciuta. In essa vengono ospitate famiglie con disagio abitativo. Gli occupanti sono cittadini italiani e non vengono coinvolti in attività di autogestione come negli altri esempi portati in precedenza.È interessante notare che mentre i Comitati di lotta come Action OUTLET 71 RICADUTE hanno scelto una linea di azione e di “discrezione ideologica”, l’estrema destra fa continui riferimenti espliciti contro l’usura capitalistica e le politiche speculative e liberiste imposte ai nostri governi da strutture sovrane come il Wto e la Banca mondiale. Il Comitato di Action è impegnato anche al sostegno dell’occupazione di singoli veri appartamenti in complessi di edilizia di grandi enti, quando se ne presenta l’occasione. Si tratta di abitazioni che non hanno assegnatari, dunque non si nuocerebbe ad altri in condizioni di bisogno. In questi casi si configurano situazioni paradossali. Con gli occupanti che continuano a pagare i bollettini del fitto del vecchio assegnatario, in certi casi defunto, e che debbono essere difesi dai periodici tentativi dell’ufficiale giudiziario che si presenta dietro denuncia. Ho intervistato varie famiglie nei palazzi di proprietà Inpdap nella zona di don Bosco. 2. Cani sciolti & occupy Il movimento più importante delle occupazioni per fini abitativi è sostenuto dai Comitati di lotta per la casa, non va trascurata la pratica di occupazione illegale di appartamenti che si verifica in maniera autonoma con il solo sostegno delle reti familiari. Si tratta di modalità di subentro ai regolari assegnatari molto diffuse nei grandi complessi di edilizia pubblica, contesti nei quali si concentra il disagio sociale più acuto. In genere vengono occupati e trasformati in abitazione anche i locali progettati come servizi in comune: cantine, sottoscala, vani garage. Non esistono, come si vuol far credere comunemente, organizzazioni criminali, che speculino su queste pratiche, c’è invece uno straordinario sistema di auto-regolazione che permette a parte delle povertà urbane di garantirsi risorse per la sopravvivenza. Anche a Ponte di Nona come a Tor Bella Monaca tutte le parti degli edifici destinate ad usi vari sono state occupate e trasformate abusivamente in abitazioni. Nel serpentone di Corviale un intero piano è occupato da lungo tempo. Il blitz recente condotto a nel quartiere di Scampia a Napoli da 170 vigili urbani ha accertato che su 522 appartamenti delle Vele solo il 20% delle famiglie risultavano come legittime assegnatarie, le altre occupavano illegalmente le case. Paventando uno sgombero, centinaia di persone simultaneamente si erano riversate di fronte alla sede del municipio. Per evitare tumulti si chiarì che si era trattato solo di un censimento. Non è stato realizzato un censimento attendibile delle case popolari Ater, perché è all’ordine del giorno la pratica del “subentro” alla morte di qualche anziano o la vendita informale del diritto ad occupare l’abitazione. Per opportunità politica, per non sollevare forme di protesta imprevedibili, anche il sindaco di Roma Alemanno, che si è dichiarato nemico giurato di tutte le occupazioni abusive e si sta distinguendo per il continuo sgombero degli insediamenti abusivi dei rom, non mostra lo stesso zelo per le pratiche di occupazioni illegali continue nel patrimonio di edilizia pubblica. Famiglie allargate dispongono in genere di una o più abitazioni di edilizia 72 OUTLET Roberto De Angelis Insegna Sociologia delle relazioni etniche alla “Sapienza” Università di Roma. Tra le sue pubblicazioni: Iperurbs, Roma. Visioni di conflitto e di mutamenti urbani (Derive e Approdi 2005); La periferia perfetta (Franco Angeli 2006). pubblica o di un posto in uno dei residence di assistenza alloggiativa, come legittimi assegnatari o occupanti, spazi nei quali possono all’occorrenza convivere più nuclei familiari, alternarsi e da questa base di sicurezza tentare nuove occupazioni. Se da una parte l’amministrazione comunale teme le conseguenze in termini di conflitto nel redigere un censimento attendibile degli abitanti delle case popolari, dall’altra è determinata a realizzare mega-progetti di semplice demolizione o di demolizione-ricostruzione non solo di edifici, ma di un intero quartiere seguendo la chimera della rigenerazione urbana con la semplice sostituzione edilizia. I ponti IX, X e XI del Laurentino 38 sono stati abbattuti nel 2006. In questo modo il sindaco Veltroni ha voluto contrastare il “degrado”. I ponti ospitavano occupanti per lo più stranieri. Il ponte V continua ad ospitare numerose famiglie italiane. Gli spazi dei ponti non erano stati progettati come abitazioni e dunque erano stati riadattati. Con la sostituzione edilizia si vorrebbe ovviare al degrado dei grandi insediamenti di edilizia residenziale pubblica. Tra il ’98 ed il 2003 sono state abbattute tre Vele di Napoli e altrettanto viene auspicato per lo Zen di Palermo, Corviale di Roma o Quarto Oggiaro di Milano. A Roma l’amministrazione di centro destra si è impegnata nell’abbattimento delle torri di Tor Bella Monaca per sostituirle con palazzine basse. Come se il contenitore potesse compensare la sofferenza sociale determinata dalla concentrazione di soggetti che scontano disoccupazione e sotto-ccupazione gravissima, costretti a barcamenarsi tra attività legali ed illegali. Ma la nuova Tor Bella Monaca “stile Garbatella” sarà soprattutto business in linea con il forsennato consumo di suolo operato dalle grande imprese di costruzione: i residenti da 28.000 dovrebbero passare a 44.000, i metri quadrati da 228.000 a 678.000. Per concludere bisogna almeno fare un accenno alle miriadi di piccole occupazioni invisibili a scopo abitativo messe in atto anche negli interstizi più impensabili non da homeless, ma ancora una volta da migranti inclusi. All’uopo ad esempio si erano riadattati a dormitorio e cucina indifferentemente nicchie della subway di via Gregorio VII o della palafitta iper-moderna della tangenziale, alle quali si poteva accedere solo arrampicandosi. OUTLET 73 RICADUTE Il ritorno dei luoghi nello scontro tra culture DIAGNOSI DEI RAPPORTI ATTUALI TRA CITTADINI, AMMINISTRAZIONI E POLITICI: IL PUNTO DI VISTA DI UN URBANISTA. SE NELLE TRAGEDIE GRECHE LE RAGIONI DI OGNI PERSONAGGIO ESPRIMEVANO UNA VISIONE DEMOCRATICA DELLA RES PUBBLICA, NELLE CONTRAPPOSIZIONI CONTEMPORANEE PREVALGONO SISTEMI SCORRETTI. di Enzo Scandurra “C onflitto”. È una parola-chiave molto impegnativa che non solo attraversa la storia degli uomini, ma anche tutti i campi disciplinari: dalla psicanalisi all’economia, alla psicologia e, per quanto mi compete, allo sviluppo e all’amministrazione delle città. È a questo specifico campo che farò riferimento in questo articolo. Possiamo distinguere due tipi di conflitti: il primo, tra “il progettista” e l’Amministrazione politica che gli affida l’incarico di sistemare, organiz- 74 OUTLET RICADUTE zare una porzione di spazio urbano e il secondo, in genere ad opera compiuta, tra i cittadini e l’Amministrazione della cosa pubblica. Accennerò brevemente al primo per concentrare l’attenzione sul secondo. Nella mitologia che accompagna le grandi realizzazioni architettoniche e urbanistiche italiane, e le grandi opere in generale, il progettista spesso dichiara: «Non è una mia colpa. Il progetto è ben studiato ma gli amministratori e i politici lo hanno modificato sabotandolo». Si tratta dell’affermazione dei progettisti che hanno elaborato il progetto nel tentativo di autoassolversi di fronte al suo fallimento. È una storia, questa, ricorrente come testimoniano, ad esempio, i casi dello Zen a Palermo, delle Vele a Secondigliano, del Laurentino38 e di Tor Bella Monaca a Roma. Per non parlare di quella leggenda che vuole che il progettista di Corviale, l’architetto Mario Fiorentino, si sia suicidato appena uscito da una riunione cui aveva partecipato in veste di accusato per un progetto (Corviale) poco gradito. In realtà i progettisti non sono così innocenti come dichiarano. Essi, nel momento in cui scelgono il ruolo di consiglieri del “principe” (e in questo si allontanano dalla esigenze dei cittadini) finiscono col rendersi “complici” del disegno, quale che sia, dei politici e degli amministratori che condizioneranno i loro progetti piegandoli ad esigenze da loro non previste e, spesso, indesiderate. Accanto a questo “conflitto” c’è n’è un altro, più rilevante. È quello che vede contrapposti cittadini ad amministratori e politici. Una volta realizzato il progetto o, ancora prima in fase di scelte strategiche, gli abitanti coinvolti si sentono delusi e abbandonati dagli “amministratori avidi” che non li hanno ascoltati e che hanno tradito le aspettative riposte. È anch’essa una storia che si ripete quasi sempre come se le “due esigenze” fossero tra loro inconciliabili e irriducibili. Ma quali sono le ragioni di questo conflitto che risulta spesso come inevitabile? Nell’attuale panorama politico ed economico questo secondo conflitto appare sempre più marcato e certamente esso riflette la crisi in cui versa la democrazia rappresentativa che attraversa tutto l’Occidente e che si manifesta con l’esigenza dei cittadini di una partecipazione più diretta alla gestione della cosa pubblica. Tali tensioni sociali, inoltre, sono sempre più acute a causa dello svuotamento del ruolo della politica ad opera dell’egemonia del capitale finanziario. Mentre, infatti, i flussi dell’economia finanziaria si sottraggono sempre di più al controllo della politica e OUTLET 75 RICADUTE RICADUTE Enzo Scandurra Professore di Sviluppo sostenibile per l’ambiente e il territorio alla “Sapienza” di Roma (Facoltà di Ingegneria). Tra i suoi libri: Le basi dell’urbanistica, (Editori Riuniti 1987); L’ambiente dell’uomo. Verso il progetto della città sostenibile (Etaslibri 1995); La città che non c’è. La pianificazione al tramonto (Dedalo 1999); I futuri della città. Teorie a confronto, in collab. (Franco Angeli 1999); Gli storni e l’urbanista. Progettare nella contemporaneità (Meltemi 2001); Città morenti e città viventi (Meltemi 2003), Storie di città curatela (Interculture 2007); Un paese ci vuole. Ripartire dai luoghi (Città Aperta 2007); Ricominciamo dalle periferie. Perché la sinistra ha perso Roma, con M. Ilardi (manifestolibri 2009). degli Stati nazionali, essa – la politica – rimane ancorata ai territori locali disponendo di margini di manovra sempre più ristretti anche in forza della crisi economica1. Così che la politica rinuncia a coltivare disegni ambiziosi ed è, al tempo stesso, sempre più incalzata dalla pressione dei cittadini che viene dal basso. Costoro, a loro volta, guardano ai politici come agli appartenenti a una casta privilegiata che si autoriproduce senza soluzioni di continuità mentre il capitale finanziario resta libero di scorazzare indisturbato (non a caso un osservatore acuto come Franco Cassano lo definisce un “delitto perfetto”). Due elementi appaiono dunque modificare il quadro dell’attuale rapporto cittadini-politica rispetto agli anni passati. Da una parte la caduta di autorità della politica, non solo spodestata dal capitale finanziario, ma anche orfana delle vecchie ideologie che le permettevano di farsi perdonare un comportamento spesso 76 OUTLET “disinvolto” (vedi la rilevanza che ha assunto nell’opinione pubblica la questione morale). Dall’altra parte i cittadini e le loro associazioni non sono sempre “innocenti”. L’ideologia fiancheggiatrice il neoliberismo ha prodotto, in tutti questi anni, quella grande narrazione dell’affermazione individuale che impedisce che si crei una egemonia culturale e politica dal basso in grado di incalzare i politici. Così la politica cerca alla bene e meglio di trovare situazioni contingenti e parziali alle pressioni dei cittadini offrendo in questo modo il fianco alle proteste sempre più dirette. E’ interessante l’analisi che di questi fenomeni svolge Carlo Galli2 : «E’ come se il patto di cittadinanza originario – che implica la cessione di alcuni diritti individuali alle istituzioni, perché queste, legittimate dalla propria natura rappresentativa, possano progettare e realizzare il bene comune, o almeno la pubblica utilità – venisse revocato. I singoli, i piccoli gruppi, si riprendono il diritto di far valere direttamente le proprie ragioni, di salvaguardare il proprio utile particolare, delegittimando i pubblici poteri. Oppure, è come se lo spazio politico cessasse di essere liscio, omogeneo, continuo – quale, appunto, è stato costruito giuridicamente dalla sovranità moderna, e quale l´ha confermato la democrazia, introducendovi il principio di uguaglianza –: è come se i luoghi, le comunità locali, ritrovassero vita autonoma e rivendicassero la propria “differenza” contro l´universale, contro il Leviatano». Questa analisi, come suggerisce lo stesso Carlo Galli, offre due possibili e antagonistiche interpretazioni. Da un lato il diffondersi di un sentimento di antipolitica. Secondo questa visione gli amministratori della res publica altro non sarebbero che oppressori, profittatori, faccendieri che trarrebbero solo benefici personali dalla realizzazione dell’opera. Dalla parte opposta, i cittadini vanterebbero solo diritti, senza più ritenersi vincolati dal rispetto di doveri collettivi e individuali. Tuttavia questo atteggiamento può anche essere letto con altro sguardo. Esso può anche essere interpretato come una emancipazione collettiva dei cittadini che riprendono su di loro la gestione del territorio e la soluzione dei problemi, senza più concedere deleghe in bianco ai loro rappresentanti. Dunque, secondo questa seconda interpretazione, non ci troveremmo di fronte a cittadini egoisti e irresponsabili ma, al contrario, di fronte ad un atteggiamento davvero civico, partecipativo e comunitario, che si afferma sul fallimento della politica ufficiale. Un po’ come nelle tragedie greche si confrontano due “ragioni” irriducibili. Da una parte quella dei territori e dei loro abitanti che non emettono più deleghe in bianco nei confronti dei politici che pure hanno contribuito ad eleggere, dall’altra la “ragione” degli amministratori pubblici che dovrebbero (il condizionale è quanto mai d’obbligo) possedere una visione più ampia comprendente gli interessi collettivi. In ogni caso il conflitto in esame mette in gioco direttamente il concetto di democrazia che va ridefinito ogni volta con circostanziate argomentazioni da una parte quanOUTLET 77 RICADUTE to dall’altra. È interessante quanto afferma ancora Carlo Galli, ovvero che: «la politica non è mai un gioco sempre a somma positiva per tutti, e che proprio per questo vantaggi e svantaggi devono essere equamente distribuiti; e che alla politica, non alla sua negazione, spetta il compito di organizzare il rapporto a misura d´uomo fra gli spazi privati e pubblici. Perché l´uomo abita tanto la casa (e il suo cortile) quanto la polis e l´agorà». Detto in altri termini, il problema teorico del conflitto tra cittadini e politici è in gran parte insanabile. Tuttavia questo non ci esime dallo schierarci a favore dell’uno o dell’altro dei contendenti. Si tratta allora di esaminare concretamente le ragioni addotte dalle differenti parti a favore o meno dell’opera o dell’intervento da realizzare o realizzato. Uno dei conflitti recenti più “alti” e interessanti nel contesto italiano è quello della costruzione della Tav in Val di Susa. Giustamente Guido Viale3 la definisce la “Guerra dei due mondi”, poiché in effetti si scontrano due visioni diametralmente opposte: «Quello in atto in Valle di Susa è un autentico “scontro di civiltà”: la manifestazione di due modi contrapposti e paradigmatici di concepire e di vivere i rapporti sociali, le relazioni con il territorio, l’attività economica, la cultura, il diritto, la politica. Per questo esso suscita tanta violenza da parte dello stato – inaudita, per un contesto che ufficialmente non è in guerra – e tanta determinazione – inattesa, per chi non ne comprende la dinamica – da parte di un’intera comunità. Quale che sia l’esito, a breve e sul lungo periodo, di questo confronto impari, è bene che tutte le persone di buona volontà si rendano conto della posta in gioco: può essere di grande aiuto per gli abitanti della Valle di Susa; ma soprattutto di grande aiuto per le battaglie di tutti noi». E, in effetti, solo osservando attentamente i termini di questo conflitto ci si può rendere conto di come stiano le cose. Analizzando le contrapposte visioni (quando queste vengono esplicitamente dichiarate e messe in campo con buonafede) si ha la sensazione, come nelle tragedie greche sopra ricordate, che il conflitto è insanabile. Da una parte ci sono le “ragioni” di una comunità, di cittadini attivi che hanno una elevata conoscenza e coscienza del territorio da loro abitato, mai inteso semplicemente come suolo da fecondare alle ragioni di un fantomatico “sviluppo”. Un territorio che costituisce un’unità indissolubile con la vita della comunità. Dall’altra si invocano le ragioni della “crescita” e dello sviluppo europeo in nome del quale andrebbero sacrificate quelle dei valligiani. Fin qui una storia di un conflitto ineludibile come quello tra Creonte (che difende le leggi della città) e Antigone (che si appella alla philìa) nella tragedia di Sofocle. Ma se nelle tragedie greche le due “ragioni” sono irriducibili l’una all’altra, ovvero se nessuno dei due contendenti in conflitto può vantare una “ragione” superiore rispetto a quella dell’avversario, nei casi reali, come ad esempio la Val di Susa, alcuni comportamenti di una delle parti dei contendenti appaiono scorretti e predeterminati. Mi riferisco, in questo caso, solo per citarne una, all’affermazione del ministro 78 OUTLET RICADUTE Cancellieri quando sostiene: «Discutiamo; ma il progetto va comunque avanti». Qui si svela la violenza con la quale le grandi opere vengono imposte ad una comunità che ha saputo dimostrare di essere capace di autogoverno. C’è un’ultima riflessione, ma non meno importante, da svolgere, sebbene non ne resti lo spazio adeguato per farlo. Molte amministrazioni e molti politici si sentono più “democratici” in quanto sostenitori di pratiche chiamate di “partecipazione” che tenderebbero a compensare i limiti della democrazia rappresentativa. Questa parola – partecipazione – è diventata lo slogan di governo (insieme all’altra dello “sviluppo sostenibile”) di molte amministrazioni. Ovviamente i casi andrebbero analizzati e valutati uno ad uno perché diverse sono le circostanze in cui questo processo avviene. Ciò che a me preme sottolineare (pur incorrendo nel rischio di generalizzazione) è che molto spesso si tratta di pratiche strumentali che tendono a normalizzare il conflitto, ovvero che assumono il “conflitto” come un dato politico negativo da rimuovere secondo un’ottica “neutrale” dove le differenze e le sofferenze tendono a scomparire. note In proposito è interessante l’articolo di Franco Cassano: Egonomia. Così l’individuo senza società ha cancellato la politica su La Repubblica del 1 marzo 2012. 2 C.Galli, Nimby. Quando la parola d’ordine è “non nel mio cortile”, su La Repubblica del 15 marzo 2012 3 G. Viale, La guerra dei due mondi, su il manifesto del 4 marzo 2012 1 OUTLET 79 RICADUTE Gli spazi contesi IL CETO MEDIO VUOLE RAGGIUNGERE LO STATUS SOCIALE DELLE CLASSI PIÙ ABBIENTI. LA PROTESTA SI ESAURISCE QUI. SENZA CRITICA POLITICA. ACCETTANDO IL MODELLO DI ABITAZIONE SOSTENUTO DAL MARKETING. RICADUTE zione di idee attraverso il conflitto, ma è il luogo dell’affermazione e dell’imposizione di idee (quelle insite nel modello del capitalismo avanzato, con tutte le sue implicazioni in termini culturali e di modelli sociali) attraverso una pseudo-discussione che distoglie dai problemi reali, e che afferma una cornice di riferimento indiscutibile e “naturale” (quella degli interessi e del mercato). Il progetto non è radicato nel conflitto innovatore, ma nella reazionaria e repressiva “mediazione degli interessi”. Così, nel rapporto tra operatore privato e amministrazione pubblica e istituzioni, spesso c’è solo una contrattazione degli oneri pubblici da coprire, da una parte, e delle plusvalenze economiche e finanziarie da raggiungere e garantire, dall’altra. La cornice politica e culturale non è in discussione; l’idea della città come bene di consumo e merce di mercato, luogo di realizzazione dei profitti e non certo di costruzione di una polis, è condivisa ed è considerata spesso il motore di un’economia, che, in fin dei conti, non può che essere predatoria e senza prospettiva, come la dimensione dell’invenduto – ad esempio, a Roma – e le bolle finanziarie e immobiliari stanno a testimoniare. L’amministrazione pubblica è culturalmente e politicamente collusiva. In questo contesto, la partecipazione, da interessante strumento di integrazione tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta, è stata spesso strumentalizzata ai fini della costruzione del consenso (Cellamare, 2007) ed è diventata una forma di “cuscinetto sociale” che attutisce il conflitto, impedendo che arrivi con la dovuta forza nei luoghi decisionali. Tant’è vero che sempre più frequentemente gli abitanti disertano o contestano i “luoghi della partecipazione”. di Carlo Cellamare 1. Progetto urbano senza conflitto N el progetto urbano il conflitto è oggi assente. Vi alberga uno pseudo-conflitto che maschera i problemi reali e distrae da un confronto su una politica urbana di sostanza e su un’idea di città da condividere (o meno). Perché il progetto urbano non è più il “luogo” politico, sociale e culturale dove si confrontano le idee di città e dove si sperimentano le innovazioni, dove un gruppo politico e culturale (ed il progettista di cui è espressione) prova a superare il territorio e la cultura prevalente, portando il conflitto dentro il territorio e dentro la politica. Quel terreno – gli spazi residuali che lasciava il riformismo – non c’è più. Il conflitto è oggi intorno agli interessi, alle valenze economico-finanziarie, agli accordi tra i proprietari. È tutto interno ed auto-referenziale, che non ha alcun rapporto con la società, vi è estraneo. Il progetto urbano è un’operazione immobiliare e finanziaria, non è un “progetto di città” (o men che meno “di società”), non elabora idee. O, meglio, non è il luogo dell’elabora- 80 OUTLET 2. Il conflitto nella trasformazione urbana: Roma Quando poi il progetto o le politiche urbane piombano sulla città, lì allora esplode il conflitto, proprio perché non c’è stato alcun terreno di confronto precedente. Si tratta, però, di uno scontro rabbioso, che non cerca la discussione e la costruzione di alternative, ma si oppone tout court. La città è il luogo privilegiato del conflitto, anzi si costruisce attraverso di esso. Se non viene ridotto al contrasto (e alla mediazione) tra interessi economici, o comunque privati e particolari, il conflitto rivela spesso un carattere profondo e si sviluppa intorno a dimensioni che sono politiche, culturali e simboliche. Se pensiamo agli “spazi contesi”, come può essere ad esempio piazza Madonna de’ Monti nel rione Monti a Roma (Cellamare, 2008), qui si confrontano sia gli interessi economici degli esercenti, che interpretano lo spazio come un’opportunità di valorizzazione economica, sia le idee diverse di città e le posizioni che a quella interpretazione dello spazio si oppongono. Qui il conflitto, da parte degli abitanti, è giocato contro le politiche urbane che interpretano le piazze come “salotti” da valorizzare appunto economicamente, e che considerano il centro storico come il OUTLET 81 RICADUTE RICADUTE Riferimenti bibliografici Carlo Cellamare, Le insidie della partecipazione, in AA.VV. 2007; C. Cellamare, Modello Roma. L’ambigua modernità (Odradek 2008); C. Cellamare, Fare città. Pratiche urbane e storie di luoghi (Eleuthera 2008); C. Cellamare, Progettualità dell’agire urbano. Processi e pratiche urbane, (Carocci 2011); Enzo Scandurra, La Grande Narrazione romana, in il manifesto, 10.7.2012; Georg Simmel, Der Konflikt der modernen Kultur. Ein Vortrag (Duncker & Humblot, Munchen-Leipzig 1918). Carlo Cellamare Docente di Urbanistica alla “Sapienza” di Roma, svolge ricerche, a carattere interdisciplinare, sul rapporto tra urbanistica e vita quotidiana, sui processi di progettazione urbana e ambientale, sul rapporto tra territorio e sviluppo locale, sulla partecipazione. Ha pubblicato, tra gli altri: Fare città. Pratiche urbane e storie di luoghi (Eleuthera 2008); Progettualità dell’agire urbano. Processi e pratiche urbane (Carocci 2011). distretto del commercio e del turismo. Oltre ad essere politico è un conflitto anche culturale e simbolico perché, da una parte, sostiene una diversa idea della convivenza (la “piazzetta” come luogo dell’incontro e della socialità tra diversi, in autonomia), dall’altra, si oppone ad uno snaturamento e ad una banalizzazione del valore (anche simbolico) che quella piazza ha nella storia e nella vita del rione, ma anche per le altre comunità presenti, come quella ucraina, che l’ha eletta a luogo di riferimento nella città e vi svolge i propri incontri e i propri riti più importanti. Se il conflitto caratterizza e attraversa la città, possiamo però riconoscere una sua profonda evoluzione, almeno a Roma, con caratteri oggi molto diversi da contesto a contesto. In particolare, ci troviamo in una situazione ben diversa da quella degli anni ’70, anni in cui il problema delle borgate e della riqualificazione delle periferie era centrale e scottante, motivo di crisi così come di vittoria per le giunte capitoline. Era anche un conflitto che si legava a più profondi problemi sociali, quello della casa in particolare e quello del lavoro; e si trasformava in una mobilitazione sociale diffusa. Le manifestazioni di quei tempi erano espressione allo stesso tempo della lotta per la casa, della richiesta di servizi nelle periferie, della difesa del lavoro. 82 OUTLET Il conflitto aveva un carattere socialmente diffuso e fortemente politico, mirato ad un cambiamento nelle politiche pubbliche. Certo, non è detto (come ci faceva notare Pasolini) che ci fosse una diffusa coscienza politica. Nei racconti di oggi degli abitanti si riconosce nelle mobilitazioni di allora anche una strumentalizzazione politica di un problema sociale diffuso, quello della casa. Tant’è vero che, nella misura in cui è cresciuta la riqualificazione delle periferie ad opera delle stesse giunte di centro-sinistra, i “borgatari” sono diventati piccola e media borghesia, se non economicamente e come status sociale, sicuramente come modello sociale di riferimento cui aspirare. E proprio in quelle periferie il centro-sinistra ha poi perso. Oggi, quei riferimenti politici e culturali si sono ulteriormente disgregati, come molta letteratura (pensiamo a Il contagio di Walter Siti, ma anche ad altri) ci mostra. Sia nelle periferie abusive che nella “città del mercato”, il lavoro sul campo di oggi ci mostra un prevalere di obiettivi di up-grading sociale: i conflitti sono spesso concentrati sul perseguimento e sul raggiungimento di standard urbani e di uno status sociale delle classi più abbienti, da parte del ceto medio che vi abita. Raramente vi è una discussione delle politiche urbane, o del modello di sviluppo della città, anzi in qualche modo si aderisce a quel modello di abitare sostenuto dal marketing urbano. Oppure si eleva la richiesta di raggiungere alcuni standard che la pubblicità associava ai quartieri promossi e alle case vendute, ma che, in realtà, proprio in forza di quel modello a cui si è aderito, non potrà permettere di raggiungere (frustrando la possibilità di soddisfare una maggiore qualità dell’abitare). Il conflitto perde, in questi casi, il suo carattere politico. Così come, se è vero che si sposta sul territorio (che diventa la proiezione dei desideri personali e sociali), è altrettanto vero che ne è discutibile il contenuto culturale e politico. D’altra parte, abbiamo ancora un insieme di conflitti, profondi e drammatici, legati al problema della casa, all’esclusione sociale, alle discriminazioni, ai problemi dei migranti; di cui le occupazioni sono l’espressione più evidente. Essi rimettono in discussione profondamente l’idea di convivenza e la politica della città, ma rimangono marginali; anzi vengono marginalizzati, se non repressi. Sono questioni che non diventano un problema condiviso dall’intera città. E, allo stesso tempo, lo stato di necessità all’interno di questi contesti (come le occupazioni) impedisce una maturazione del conflitto in termini culturali e politici vasti e di portata urbana. Rispetto a questi ultimi, i conflitti più diffusi, quelli propri della periferia abusiva e della “città del mercato”, hanno più il carattere di perseguimento di un up-grading sociale, di raggiungimento di status sociali propri delle classi più abbienti. Sono lotte che perdono il carattere di critica alla politica della città prevalente, anzi sono espressione di un’adesione a quel modello di sviluppo urbano. Abbiamo, poi, tutta una serie di scontri portati avanti da comitati e associaOUTLET 83 RICADUTE zioni locali, che si radicano in una matura critica al modello di sviluppo urbano. Sono molto diffusi sul territorio della città e spesso riescono a “fare rete”, affrontando problemi a livello cittadino o a livello di settore urbano. L’esperienza della Rete di Mutuo Soccorso ne è l’espressione più ricca ed interessante. Certo è che, forse anche in forza della crescente frammentazione sociale, si tratta di esperienze che non riescono a maturare a livello della costruzione di una politica urbana complessiva alternativa. Rimane, per molti versi, una somma di vertenze locali e sarebbe, invece, molto interessante se queste realtà «mettessero in comune la loro vera carica antagonista per diventare protagonisti di una svolta di reale discontinuità» (Scandurra, 2012). Infine, riconosciamo sempre più frequentemente un conflitto rabbioso, indiscriminato, senza quartiere, che diserta e contesta i “luoghi della partecipazione” e contesta anche le amministrazioni “amiche”. Potrebbe apparire irragionevole, perché spesso sostenuto da una “non riflessione” sui contenuti, ma è tanto più rabbioso e irragionevole perché misura la distanza della decisione, dei contenuti e delle istituzioni dai territori e dai loro vissuti. Non è un conflitto contro “quel” progetto, è un conflitto senza quartiere “contro” l’istituzione, contro l’ingerenza, contro il piombare dall’alto, contro l’assenza di politica. Ed è tanto più rabbioso perché rispetto ad una macchina oppressiva, potente, irragionevole (quella sì irragionevole) l’unica possibilità (che peraltro raccoglie tutte le forze e le adesioni delle appartenenze) è quella del conflitto “basale”, dell’opposizione tout court. 3. Il conflitto come costruzione della città Il progetto perché si possa chiamare tale deve essere espressione di un conflitto. Oggi lo scontro non è sul progetto, ma sulla trasformazione della città; è regredito su questo terreno, perché non esiste più quello della mediazione politica e del confronto. Il conflitto invece ha (o può avere) un potente ruolo costruttivo e creativo, se il progetto avesse la capacità di portarlo sul territorio. Evidentemente deve trovare altri terreni e altri strumenti che non siano quelli del riformismo o dell’egemonia politica e culturale, e quindi del progetto tradizionale (Cellamare, 2011). Simmel (1918) affida al conflitto un ruolo fondamentale nell’evoluzione della società (e della città), espressione delle tendenze e delle controtendenze sempre presenti e sempre in azione nelle organizzazioni sociali. Nella sua interpretazione della società, la vita assume di volta in volta, storicamente, le diverse forme di organizzazione. Queste tendono a strutturarsi e, a lungo andare (anche sotto l’azione di interessi particolari), ad irrigidirsi, andando a contrastare lo stesso fluire della vita. La vita tenderà quindi a superare quelle forme, quelle forme organizzative (siano esse istituzioni o altro), e a crearne di nuove. Il conflitto caratteristico della modernità, della cultura moderna, è allora proprio quello tra forma e vita. 84 OUTLET DIALOGHI DIALOGHI Non so se è barbaro, però mi piace IMMAGINARIA CONVERSAZIONE TRA CAYCE POLLARD E RROSE SÉLAVY1 SUL CONCETTO DI BARBARICO DENTRO E FUORI IL SISTEMA DELL’ARTE. COME LE AVANGUARDIE, IL CINEMA, LE GRANDI ESPOSIZIONI E I COLLEZIONISTI, MA ANCHE LE SERIE TV E I SOCIAL NETWORK, HANNO USATO E SPOSTATO OGNI VOLTA I CONFINI TRA UN IO CIVILIZZATO E L’ALTRO DA SÉ. di Franco Speroni e Luisa Valeriani CP: Vogliamo dare un’etichetta ai barbari? RS: Etant donnés a) identità culturale molto forte et b) senso del confine… i barbari sono toujours les Autres. Per i Greci barbaro era chi non parlava la lingua comune alle diverse città greche. Per i Romani quelli che vivevano ai margini del cosmo imperiale, difficili da contenere, per le spinte delle popolazioni nomadi. Dunque il concetto implica l’intrusione in un confine da parte di chi ne è fuori. Nuovi barbari potremmo essere noi che parliamo linguaggi differenti senza territorio, ma la parola non mi piace, è molto ambigua… implica una forte e pericolosa territorializzazione. CP: Allora la barbarie è una variabile dipendente dal punto di vista da cui guardi? RS: Nei film di Denys Arcand come Le Déclin de l’empire américain 86 OUTLET DIALOGHI (Canada 1986) e Les Invasions Barbares (Canada, Francia 2003), un insieme valoriale antropologico distingueva i padri dai figli. Dal punto di vista della comunità di intellettuali riuniti in una villa di campagna come gli Asolani del Bembo, barbari erano i figli dediti ad una vita attiva, tesa al guadagno, apparentemente impermeabile a ogni forma di complessità. Viceversa per i figli erano dissonanti i comportamenti dei genitori, la cui differenza valoriale si esprimeva nei gusti, nelle inclinazioni sessuali, in una qualità di vita radicalmente Altra. CP: I barbari allora sono come sequenze che appaiono in modo irregolare e imprevedibile. Proviamo a riconoscerne il pattern. Una sequenza è anche il film di Alberto Sordi Le vacanze intelligenti (Italia 1978), che ci porta nella scena dell’arte. I due protagonisti, Sordi e Anna Longhi, visitano da barbari la Biennale di Venezia, scoprendo un mondo valoriale inconciliabile con il proprio; ma altrettanto barbare, nel senso di irruzione catastrofica di valori altri, erano le istallazioni in cui si imbattevano. Il film infatti inscenava ironicamente un conflitto che peraltro apparteneva davvero alle cronache d’epoca: Gino De Dominicis nella Biennale del 1972 aveva fatto scandalo esponendo un ragazzo down, coerentemente alla sua idea che «è il pubblico che si espone all’arte, e non viceversa». RS: Entrambi barbari, dunque. Però la Biennale propone novità, mentre chi è vittima di agenzie culturali conservatrici (chiesa, scuola di base) non vede l’enorme apertura che gli è offerta, tanto è stato reso impermeabile a ciò che è fuori di sé. Ricostruiamo il pattern, come dici: le avanguardie artistiche hanno sempre funzionato come barbari, rispetto a quelle agenzie culturali. Barbaro fu Courbet accampando il suo Pavillon du Realisme di fronte all’Expo del 1855 e predicando un’art vivant contro i soggetti storicomitologici-religiosi proposti dall’Accademia. Gericault con Le Radeau de la Méduse era sembrato tanto barbaro nella sua denuncia della corruzione del potere, che gli fu negato il Louvre. Barbara fu l’esigenza di essere del proprio tempo e di… fare della propria vita un’opera d’arte. Dal punto di vista del pensiero dominante, le avanguardie sono sempre barbare perché portano novità dirompenti e trasformanti. Manet con l’Olympia scandalizza Napoleone III e si inimica i critici d’arte, laddove un Cabanel vince il premio del Salon perché sa aggiornare il vecchio linguaggio della pittura… Manet rompe e Cabanel riforma… Manet esprime la trasformazione antropologica, barbara, dei nuovi consumatori metropolitani. CP: Tutto però poi è assorbito dalla cultura ufficiale e diventa logo. É accaduto anche a Manet, e poi qualche altro barbaro lo ha liberato dall’etichetta di emblema moderno della pittura, e gli ha ridato la capacità di far provare sensazioni. Non sarà un po’ troppo estensiva, questa etichetta di barbaro? Che cosa era l’Olympia? Il mito di Venere in un corpo-carne concreto, realizzato appropriandosi del funzionamento della pubblicità per stimolare il desiderio, ma senza il logo. Un’operazione da cool hunter, più che da barbaro… OUTLET 87 DIALOGHI RS: Negli anni Cinquanta Bataille pubblicò un saggio su Manet, ricorrendo alla categoria dell’informe. Vale la pena di tornare adesso su questo informe per due motivi: individua il “farsi barbaro” come passaggio dalla forma all’informe; e ci fa capire perché l’arte contemporanea è di per sé barbara, fino a coincidere con la più recente metafora di Yves Michaud, de l’Art à l’état gazeux (2003). Dice Bataille: «Un dictionnaire commencerait à partir du moment où il ne donnerait plus le sens mais les besognes des mots. Ainsi informe n’est pas seulement un adjectif ayant tel sens mais un terme servant à déclasser, exigeant généralement que chaque chose ait sa forme. Ce qu’il désigne n’a ses droits dans aucun sens et se fait écraser partout comme une araignée ou un ver de terre. Il faudrait en effet, pour que les hommes académiques soient contents, que l’univers prenne forme. La philosophie entière n’a pas d’autre but: il s’agit de donner une redingote à ce qui est, une redingote mathématique. Par contre affirmer que l’univers ne ressemble a rien et n’est qu’informe revient à dire que l’univers est quelque chose comme une araignée ou un crachat». Yve-Alain Bois e Rosalind Krauss nella mostra organizzata al Centre Pompidou nel 1996, e dedicata a L’informe. Mode d’emploi, hanno interpretato l’arte contemporanea come un processo in cui agiscono diverse spinte desunte dal lessico batailliano (bas matérialisme, horizontalité, entropie, battement), e che conduce dal donner le sens a les besognes des mots: l’arte non costruisce più società, ma segnala ciò che la società non riesce ad assimilare, e che può essere perciò considerato bisogno barbaro, altro. CP: Dunque, riconoscere il pattern dell’informe serve a capire il funzionamento balbuziente (barbaro secondo l’etimologia) dell’arte contemporanea, che è un processo complesso coinvolgente sempre più soggetti, fino a costituirsi come rete di relazioni simbiotiche. Quando nel 1955 Bataille spiegava come Manet avesse reso informe la Venere di Urbino, l’Olympia era già un pilastro della cultura ufficiale moderna, così come il Tiziano da lui cannibalizzato lo era stato per il Rinascimento. Il pattern del bas matérialism che Bataille riconosce si posiziona tra due modes d’emploi l’informe: quello di Jean Dubuffet (Olympia, 1950) che trasforma il dipinto di Manet in un vero e proprio crachat, una carne spiaccicata sul suolo, e quello di Cy Twombly che riduce la sua Olympia (1957) al gesto performativo di un graffito su muro. Fuck Olympia e Morte, scrive Twombly su uno sfondo monocromo: Olympia diventa parola-gesto. Come Manet aveva fatto un manifesto senza il logo, così Twombly fa un dipinto senza pittura. Muore il monumento, nasce il consumatore. L’enunciato esortativo è una specie di marketing virale. Spiega cosa lo spettatore-fruitore deve fare con l’Arte, di cui Olimpia è l’emblema: fuck, appropriarsene in modi barbari, distruttivi, possessivi, carnali. Non so se questo è barbaro, però mi piace… RS: Il Fuck di Twombly attua esattamente la definizione di Bataille: non 88 OUTLET DIALOGHI costruisce un senso, ma rende il bisogno di parole (e di cose). Le mode d’emploi di quell’enunciato ha preso storicamente due strade apparentemente lontane, ma assai simili. Quella del collezionismo d’autore, dal Fuchs di Benjamin al Citizen Kane di Orson Welles, e più in generale del museo prima del suo ruolo pubblico, quando collezionare era anzitutto esigenza di appropriazione. Il collezionista si comporta non da critico d’arte, ma da artista, cioè mette insieme oggetti d’affezione in modo informe. Anche se ogni collezione arreca prestigio al collezionista, il motore che lo spinge è il Fuck Olympia, un’appropriazione desiderante. L’altra strada è quella del consumatore culturale che mescola arte, edonismo, turismo e museo, secondo la felice espressione di art à l’état gazeux. Nell’era del triomphe de l’esthétique, spiega Michaud, un’arte gassosa indica che dei soggetti desiderosi di qualità e di benessere hanno reso i consumi culturali ubiqui e sensuali. Cayce, tu diresti che nell’epoca del capitalismo cognitivo ogni consumatore si comporta da collezionista; io avrei detto che cerca di fare della propria vita un’opera d’arte. CP: Tuttavia queste strade non portano dalla stessa parte: non tutti i collezionisti sono Guggenheim e non tutti i fruitori sono edonisti. Senza contare che l’edonista moderno potrebbe avere anche problemi economici, oltre che etici, nel costruire il proprio lifestyle. Io credo di essere un soggetto fluttuante, eppure far togliere tutte le etichette dai miei capi ha il suo prezzo. E non puoi cavartela come Pierre Bourdieu (La distinction, 1979) dicendo che un soggetto così costruisce il suo stile di vita collezionando sensazioni, se non può farlo con oggetti del desiderio troppo costosi. RS: Eppure invece nell’arte contemporanea avviene proprio questo. La Postproduction, tanto per citare Nicolas Bourriaud (2002) nasce sempre da un’appropriazione desiderante, quasi carnale, fucking, nei confronti di un qualche modello o forma o processo già esistente. Pensa alla foto di Jeff Koons dedicata al Dejeuner sur l’Herbe di Manet (1991). Qui Koons fucks contemporaneamente Manet e… Marcel, même (l’ex broker ha capito bene l’Étant donnés!), trasformando ogni metafora in pornografia esplicita e antisimbolica. Ma nessun barbaro è mai l’ultimo: al momento è stato superato dalla coppia di artisti Ondrej Brody e Kristofer Paetau che hanno messo in rete dal 7/2/07 (www.undo.net) una performance erotica omaggio a Le Dejeuner sur l’Herbe. CP: Quasi ogni atto davvero vitale nasce da un’appropriazione desiderante, si tratti di arte o anche del quotidiano. Ma le istituzioni culturali si comportano come gli accademici di Bataille, vogliono che l’informe della vita abbia forma, e sono pronte a procurargli la redingote matematica; direi di più, fornire redingote è il senso della loro gestione. Proprio come accade nella moda, il sistema dell’arte ha imparato presto a metabolizzare il barbaro facendone un brand: etichette! Il prezzo del resto non corrisponde mai al prodotto, ma all’esperienza che consente; e OUTLET 89 DIALOGHI indossare capi firmati, debitamente etichettati, può essere un’esperienza costosissima. Inoltre il volume enorme del business che ruota intorno al sistema richiede la sensibilità (e il lavoro) del cool hunter verso ciò che è fuori, che è ancora informe. RS: Comunque i maggiori alleati di quegli artisti barbari, così come dei consumatori desideranti, sono le grandi fondazioni private e i grandi collezionisti, e io lo so bene! I Guggenheim, i Frick, i Whitney hanno appassionatamente raccolto, da veri mecenati all’antica, fino a costruire musei e istituzioni generosamente finanziate. Collezionisti come Yvon Lambert o François Pinault, o Dakis Joannou e la sua Fondazione Deste ad Atene, sono veri e propri amici degli artisti che hanno promosso, come del resto per me Walter e Louise Arensberg, e più recentemente un Saatchi per gli arrabbiati inglesi; spesso da mecenati si sono trasformati in curatori, direttori scientifici delle proprie opere, impresari e investitori, sia in valori estetici che finanziari. Visitare queste collezioni coincide per il consumatore desiderante con l’esperienza estetica che procura un singolo artista. CP: Ma le dinamiche in gioco hanno a che fare con la barbarie, o con il governo dei capitali? O forse con entrambi? Tu trovi una funzione destabilizzante in tutto il sistema dell’arte perché, rispetto ad altre agenzie culturali, magnati e galleristi sono progressisti e illuministi, sono un pezzo importante di The Rise of Creative Class, analizzata da Richard Florida (2002). Ma allora l’etichetta barbaro perde ogni connotazione eversiva e catastrofica, o informe. Il mondo delle fondazioni e delle gallerie private che parla un linguaggio internazionale accoglie il nuovo perché sa trasformarlo in denaro e in potere. Ma perché chiamarlo barbaro? Non potrebbe invece esserci, fuori della mediazione dei sistemi, qualcosa capace di rompere il meccanismo dal di fuori, che introducesse processi diversi rispetto al modello collaudato del mediatore culturale che organizza e smista, garantendo in fin dei conti che ogni delirante eversione rientri nei ranghi? Che a stabilire il criterio dei valori sia il mercato delle aste o il critico famoso o il collezionista-affarista, per quanta intelligenza delle cose possano essi esprimere, non cambiano il dato di fatto di esercitare un ruolo di controllo e di mediazione, che mi sembra incompatibile con l’informe. Ma assumere su di sé il ruolo di diffusori dei grandi temi epocali, da quelli sul genere, al post-umano, alle possibilità creative delle nuove tecnologie, come certamente molte agenzie del sistema dell’arte fanno, mi sembra un comportamento più da cool hunter che da barbaro… Ogni sistema ha bisogno di rinnovarsi, perché tutto proceda come prima; se non ingloba il barbaro dentro di sé, non riesce neppure a rinnovarsi; se non si apre finisce per implodere su di sé. Se odio le etichette e amo il mio lavoro intuitivo è perché mi rendo conto che le etichette sono la redingote matematica con cui le imprese della moda rivestono il gusto informe. I marchi riducono in franchising 90 OUTLET DIALOGHI ogni creazione capace di suscitare attenzione con continuità, e questo vale in ogni campo, arte compresa. RS: Dunque, non facciamo anche del barbaro un’etichetta, d’accordo, ma un dispositivo destabilizzante sì, e allora concorderai che coincide spesso col sistema dell’arte. Il problema è sempre quello di chi e come si costruisce un dispositivo. É l’autorialità della gestione, di un’opera come di un processo, di un artista come di un curatore, che andrebbe messa en abîme: solo soggetti capaci di operare un ribaltamento di questo tipo, se esistono, mi sembrano lavorare davvero per l’informe. Ma in fondo bisogna sempre tener conto dei mezzi di cui si dispone e delle forze in campo. Dici bene, il sistema dell’arte è una realtà ambigua, fatta di discutibili meccanismi di cooptazione o di esclusione. Però anche quando gli artisti si organizzano da soli non è che sappiano fare molto meglio: magari gli mandi una proposta differente, come Fountain (1917) e loro la censurano senza neanche dirtelo. Oggi è in voga un mainstream accademico e giornalistico che contrappone arte e comunicazione, qualità e spazzatura, come se la qualità fosse nelle cose e non in chi le guarda. Tuttavia dobbiamo prendere atto che il sistema internazionale dell’arte sa presentare il nuovo, ciò che è eversivo rispetto agli orizzonti culturali dello stesso mainstream. Dobbiamo ricordarci sempre dei mezzi e delle forze in campo, e allora ci rendiamo conto che ancora non siamo per niente fuori del mercato delle emozioni, pur nello stato gassoso di cui dice Michaud. E il sistema internazionale dell’arte sa offrire al consumatore culturale emozioni bataillianamente informi. Anzi: è solo attraverso questo processo che, forse, progressivamente si sta superando la funzione mediatrice delle forme simboliche. CP: Sì, ma se l’ambiguità è nella funzione del sistema, poco importa che quella funzione sia svolta da artisti organizzati o da curatori. Il barbaro servirà sempre e solo ad oleare quel sistema, esattamente come le mie scoperte rendono più cool le etichette che le utilizzano. Per questo, ripeto, amo il mio lavoro e odio le etichette: è una sorta di schizofrenia che Bateson ha spiegato bene, e che si applica benissimo alla relazione barbaro/socializzazione. Tutte le agenzie culturali sono predisposte a socializzare la novità. Mi chiedo però se, ad esempio, le piattaforme comunicative ed espressive dei nuovi media non possano essere, per la loro natura, inafferrabili da ogni sistema socializzante. Quando, da cacciatrice, sono risalita alla fonte delle sequenze, l’organizzazione che doveva tenere segreta la creatrice e contemporaneamente pubblicizzarne il lavoro non aveva previsto né i numeri di pubblico, né l’ossessione, generata in rete, di risolvere il mistero. RS: Le nuove tecnologie stanno accelerando il superamento delle forme verso una immersività informe, senza un pattern estetico equivalente, perché agiscono viralmente da uno a uno. Lo sai benissimo, ovvio. Ma questo processo di contaminazione richiede ai soggetti tempo disponibile, OUTLET 91 DIALOGHI voglia di partecipare, energie da spendere mentre il tempo concreto dei fruitori, in realtà, rimane distinto in tempo del lavoro e tempo della festa, perciò sono ancor oggi convinta che il nuovo che sovverte passa prima per l’immaginazione che per l’azione. Perciò, penso di poter dire che non ci si libera dell’autorità delle forme simboliche se non attraverso altre che favoriscono una progressiva inesorabile gassosità. Per giunta il mercato dell’arte è così elastico, che è capace di trasformare la trivialità dei nuovi media in un pullulare di eventi artistici, riciclandoli in moda… ma senza tutto ciò, dove, come, quando potremmo immaginare una prospettiva altra rispetto a quella in cui siamo costretti? CP: Non intendevo svalutare l’immaginazione… Le tecnologie sono semplici protesi senza l’immaginario con cui le abitiamo. E sono felice di vivere praticamente on line, senza la distinzione di tempi di cui parli. Ma per tornare al nodo che ci interessa, potremmo dire che il sistema dell’arte contemporanea oggi è una fetta di industria culturale allo stato gassoso, dopo l’industria culturale moderna di massa, per un consumatore anche lui allo stato gassoso. Le emozioni che procura sono come quelle delle fiction tv più innovative e dirompenti per temi e per linguaggio. Serie televisive come Dexter, Sex and the City, o Nip/Tuck, o ancora 24, tanto per citarne alcune, creano fan piuttosto che un pubblico: vale a dire che il tipo di partecipazione che mettono in moto è di tipo identitario, tribale, dionisiaco, del tutto assimilabile al turista desiderante dello stato gassoso dell’arte. Il gusto forte, eversivo, barbaro anche nella proposta di temi insoliti o addirittura indigesti (il protagonista di Dexter è un serial killer, voce narrante e quindi punto di vista della narrazione), fa coincidere il sistema dei valori dell’arte con quello dell’industria culturale postmoderna. RS: Vero. In entrambi troviamo l’incontro con l’Altro attraverso l’immediatezza, che è una tendenza a eliminare la mediazione metaforica, comune sia a quei format che alle esperienze dell’arte contemporanea. CP: Ecco, mi chiedo se già in tali proposte non ci sia una qualche forma di addomesticamento del barbarico contenuto nelle nuove tecnologie… Forme di rimediazione dell’immediatezza del web… Mi sembra che la riforma dei format e dei palinsesti, così come l’audacia di alcuni curatori di musei (penso a Thomas Kren che ha addirittura perso il posto per la sua politica culturale da Guggenheim) sia della stessa natura di quanto accade a Hollywood e in generale tra i colossi dell’entertainment, dove hanno cominciato a rinnovarsi arruolando immaginari e comportamenti prodotti dagli abitanti delle piattaforme virtuali. Sono strategie non molto diverse da quelle dei miei datori di lavoro: anch’io scopro tendenze perché i marchi possano inglobarle, o fiuto se un nuovo marchio avrà successo o no (e sono molto curiosa di quanto accade agli avatar di Second Life). RS: Forse quello che tu chiami addomesticamento è il senso della Storia, o semplicemente del Tempo. Lo spirito d’avanguardia che oggi riemerge qua e là in tanti settori, dalle mode alla pubblicità alle arti stesse, serve appunto 92 OUTLET DIALOGHI a fare in modo che questo senso della storia non sembri o, peggio, non sia, ineluttabile. Comunque, temi indigesti e sapori forti sono in generale fenomenologie dell’immediatezza, anche prima dei nuovi media. Prendi ad esempio lo scandalo suscitato dal Piss Christ di Andres Serrano (1989), quando alcuni senatori repubblicani, tra cui John McCain, fecero addirittura un’interrogazione parlamentare contro il finanziamento pubblico a un’opera che consideravano blasfema, senza neppure interrogarsi sul senso spirituale di quel crocefisso dentro un liquido organico, figura di batailliana discesa nell’umano, di immersione nel mondo come bas matérialisme. CP: Mi sembra un po’ quello che è accaduto tra Manet e Napoleone III; anche in quel caso era il potere politico a non capire ciò che un’agenzia culturale come il Salon in fondo proponeva, pur accettandolo a fatica. Nel caso di Nora, che conosco meglio, la sua vita esisteva solo se si concentrava sui suoi cut up digitali, ma se nessuno avesse riconosciuto le sequenze in rete lei non avrebbe avuto alcuna vita; davvero un caso di arte estrema, processualmente segnata dai conflitti politici. RS: Forse questi esempi di esperienze estreme, nell’arte e nella fiction, possono farci riprendere il discorso sul regime vigente delle emozioni, in rapporto alle attese che provengono dalle nuove tecnologie. Pensiamo a cosa sta portando il web 2.0. Fa coincidere il ruolo di creatore e fruitore, diffondendo dinamiche immersive, non solo metaforiche. Pratiche di connettività e di cooperazione nelle piattaforme virtuali di Second Life, o nei social network come Facebook o Twitter hanno divulgato un’estetica fatta di esperienza sensibile nella condivisione sociale. CP: In un regime di rete il puro esserci è un valore; per funzionare non ha bisogno di dare all’Altro la visibilità dell’irruzione. Anche il modo in cui irrompe è diverso, non ha diretta visibilità sociale, ma irrompe nei comportamenti del singolo, nelle sue emozioni, indicibili all’esterno. Le piattaforme digitali forse non hanno più bisogno dello scandalo dei barbari, e questa potrebbe essere la vera novità. L’essere connessi è una qualità che permea la vita, e le pulsioni, le attese, sono forme di addiction. L’esserci può talvolta caricarsi di intensità indicibili non per irruzioni nuove, ma per come riusciamo a toccare, a tradurre in proprio, rimescolare e condividere, i frammenti di mondi che ci coinvolgevano anche prima, dalla musica all’arte al cinema al video, per le emozioni con cui riusciamo a connetterli. Ho conosciuto Peter solo dopo aver vissuto insieme al suo nickname un’avventura quasi mistica e sciamanica, un coinvolgimento completo nella ricerca, nel rischio di sé. La partecipazione può essere assoluta, talvolta… La bellezza diventa bellezza al buio, tra te e me, bellezza per te e per me (Alberto Abruzzese, 1998). Nel regime metropolitano invece è importante che sia dicibile, collettivizzabile, l’emozione, lo choc visivo, l’irruzione spettacolare dell’altro; la bellezza richiede di coagularsi in una qualche sintesi, anche mentre il suo consumatore vive uno stato gassoso. É OUTLET 93 DIALOGHI DIALOGHI Franco Speroni e Luisa Valeriani Docenti di Storia dell’Arte nelle Accademie di Belle Arti, hanno insegnato Sociologia delle Arti alla “Sapienza Università di Roma”. Negli ultimi venti anni i loro studi e le loro pubblicazioni hanno cercato di analizzare le trasformazioni della cultura visuale attraverso un approccio mediologico. vero peraltro che le nuove tecnologie stanno cambiando noi, ma il nostro bisogno di investimento emotivo sulle cose resta. E l’industria culturale postmoderna ne approfitta, aggiornandosi sul fandom e sulla serialità con le dinamiche del barbaro, delle emozioni provocate da qualcosa che irrompe e crea scandalo. Il Piss Christ o le scariche di adrenalina del serial tv 24 irrompono con la forza dei barbari, esattamente come accadeva alla Ruota di bicicletta, te la ricordi? RS: Me la ricordo benissimo. Infatti, sono forme di rottura che sollecitano, insisto, più che una mediazione, una riformattazione valoriale. Per questo spesso il regime dei musei ha ancora potenzialità barbare, nonostante le retoriche pedagogiche che gli si vogliono comunque attribuire. Tra Carsten Höller e Sir Nicolas Serota, direttore della Tate Modern, c’è stato un felice connubio per l’istallazione Test Site (2006) che ha trasformato la Turbin Hall nell’equivalente di un luna-park, richiedendo al fruitore di ri-settare la fruizione del museo: da uno sguardo contemplativo sulla forma all’immersione totale del corpo. Citando Roger Caillois, Höller definisce 94 OUTLET come «un panico voluttuoso su una mente altrimenti lucida» gli scivoli costruiti per la Galleria, che hanno trasformato la purezza della Colonna infinita (1938) di Brancusi in un dispositivo adrenalinico. Calarsi giù dal quarto o quinto piano della Tate dentro quei tubi trasparenti a metà tra le montagne russe e la posta pneumatica è un’esperienza talmente adrenalinica che, per farla, devi prima firmare una liberatoria per il museo da qualsiasi danno di salute te ne possa derivare. C’è già l’immersività del web 2.0, c’è ancora il loisir metropolitano, e il tutto è tenuto insieme da un panico voluttuoso che mi sembra non appartenere alle piattaforme digitali. Questo panico voluttuoso, chi l’ha sperimentato se lo porterà dentro di sé, come un virus che cambierà il suo punto di vista sulle cose e che nessun sistema potrà ricondurre all’ordine delle forme. CP: Capisco molto bene cosa intendi, ma contesto che nelle piattaforme digitali non si provi voluttà. Direi piuttosto che la voluttà si socializza in modo diverso, magari nei blog. Anche in questo senso forse il web ci porta fuori delle dinamiche dualistiche: non la vertigine voluttuosa, ma la contrapposizione barbaro/socializzazione non appartiene più al regime della connettività. Invece, la barbarie di cui parli somiglia molto a quello che accade nel connubio tra il sistema Moda e il sistema Arte. Quanto più barbaro è il creativo, tanto meglio è per il sistema. Pensa al rapporto tra Fondazione Prada e tanti artisti contemporanei, da Francesco Vezzoli a Rem Koolhaas; o a quello tra la Fondazione Trussardi e Maurizio Cattelan per l’istallazione dei cosiddetti Bambini impiccati; o anche alla Louis Vuitton, che inaugura il proprio spazio con Vanessa Beecroft e affida a Frank Gehry la sede della Fondazione. Come se il lusso coincidesse con il linguaggio estremo del barbaro, perché entrambi trasgrediscono il luogo comune e si iniettano viralmente nel tessuto sociale. Del resto le sfilate di Vivienne Westwood, o di Jean-Paul Gaultier, fino alle performance-evento di Viktor & Rolf, sono eventi estetici assai vicini agli effetti barbari che ha l’arte quando è vertigine voluttuosa. RS: Non saprei quanto la vertigine voluttuosa dell’arte contemporanea sia socializzabile. Più o meno è una scarica adrenalinica individuale, magari provata collettivamente o moltitudinariamente, che non costruisce società ma soggetti tendenzialmente simili agli artisti: torna la vecchia dedica di Baudelaire al lettore, suo pari e fratello. Voluttà barbara provocano le istallazioni di Félix Gonzales-Torres, o i dispositivi interattivi di Rafael Lozano-Hemmer: Esthétique relationnelle, l’ha chiamata Nicolas Bourriaud (1999). Estetica relazionale significa che al fruitore non è richiesto solo uno sguardo distante, ma partecipazione immersiva, esperienza diretta dell’evento. Questo disorienta tutti coloro che, magari per eccessiva acculturazione nelle forme di modellizzazione esercitate dalla storia dell’arte, fanno fatica ad orientarsi senza usare i parametri cui sono abituati: gli accademici pedagoghi, come diceva sprezzante ancora Baudelaire, parlando delle emozioni provate all’Esposizione Universale. OUTLET 95 DIAOLOGHI CP: Teniamo però conto del fatto che i nuovi luoghi del consumo differiscono dalla metropoli delle Avanguardie. Non c’è più una cultura dello schermo che convoglia l’attenzione verso un punto focale prospettico valido per tutti, come accadeva nella cultura di massa. Oggi al centro c’è il corpo del fruitore-consumatore. Se vado da Colette in rue Saint-Honoré o da Carla Sozzani in Corso Como 10, non entro semplicemente in uno spazio espositivo/boutique ma sperimento me stessa, stimolo intuizione e gusto, aziono la mia creatività. RS: Questa tua creatività è proprio quella dell’artista relazionale, del consumatore di stili, dell’abitante del web; diversi modi di essere artista senza il canone dell’arte, diversi modi espressivi della cultura del fan. Fatticità anziché prodotto. Il tuo lavoro di cool hunter è paradigmatico di quanto accade nell’intero mondo dell’industria culturale postmoderna, dove i pubblici si trasformano in fandom. Sono forme di consumo vocazionale neotribale, tutte proprie della Convergence Culture (Jenkins, 2006). Certo, almeno descrivendoli dobbiamo distinguere, per riconoscerli, fenomeni tipici della creatività grassroots, del fandom, dell’hactivism, o dell’arte relazionale, rispetto a quelli in cui il godimento estetico si esprime in lifestyle, disseminandosi nella scelta di oggetti, luoghi, esperienze che trasferiscono la qualità nel quotidiano, per riappropriarsene senza stacchi effettivi tra alto e basso: qualità che si edonizza nella scelta del design di un habitat, in una vacanza di nicchia, nel ristorante cool di un museo o nel Bar à eaux dove sostare nella pausa dello shopping o dell’happy hour. Ciò che accomuna questi comportamenti è una sorta di feticismo “liberato” dalla tara di perversione attribuitagli dal Moderno e vissuto invece come shift, indicatore di mobilità emozionale polivalente. CP: Dunque, chi utilizza Star Wars per partecipare al concorso ufficiale del fan cinema di Lucas, o produce fan fiction su YouTube contrapponendo Jack Bauer vs Chuck Norris, o personalizza con cura estrema il proprio avatar su Second Life somiglia a chi consuma sushi solo in ambienti zen, o si arreda casa in stile Bauhaus, soggiorna nei centri benessere, in viaggio cerca hotel e musei progettati da architetti o stilisti, e magari compra le scarpe solo da Barney’s, come Carrie Bradshaw, o indossa solo giacconi Buzz Rickson’s come me! Lusso e fai-da-te coincidono, non a livello di opportunità economiche ma a livello di feticismo dei consumi, di passione fandom, di etica appropriazionista barbara contro le estetiche tradizionali dello schermo e i suoi circuiti produttivi. Sono forme di dandysmo diffuso nell’era della performatività secolarizzata. RS: Sei d’accordo che nell’ambito della creatività estetica la barbarie, cioè – come abbiamo convenuto all’inizio – l’irruzione di un linguaggio nuovo, presenta oggi una doppia faccia? Da un lato la condivisione della webness, nelle declinazioni più feticiste del fandom o in quelle più situazioniste dell’hactivism; dall’altro, la sperimentazione della qualità – solo apparentemente ancora “moderna” – del consumatore edonista, 96 OUTLET DIAOLOGHI attraverso gli apparati del design, del museo, del turismo. Da un lato l’asse della connettività e della socievolezza, dall’altro quello del feticismo e della gassosità. CP: Sono d’accordo che l’irruzione del nuovo presenti quella doppia faccia di barbarismi nei campi di cui parli. E in tal senso occorre un vero salto di qualità nell’individuare il pattern delle sequenze, dato che i processi culturali sono molto più trasversali rispetto alla distinzione on/off line, e richiedono perciò una sensibilità capace di superare la divisione schematica reale/virtuale, vero/falso, apparizione/sparizione. Tuttavia, non credo che quella della barbarie sia l’ultima parola, credo invece che sia anch’essa condannata al conflitto perenne inclusione/esclusione, barbarie/civilizzazione. Non farei la cool hunter, farei l’artista, se fossi convinta di poter ancora far vedere attraverso un qualche esempio luminoso l’oltre cui tutti dovrebbero arrivare. Però vivo sulla mia pelle come solo dentro le piattaforme digitali le esperienze si diversifichino al punto da non poter essere più ricondotte a dinamiche collettive, e forse neppure più tribali, ma del tutto soggettive. Sono in gioco processi e desideri diversi non perché sono diversi i linguaggi, ma perché sono diverse le piattaforme. Tuttavia, non mi sento di fare pronostici. Forse, avremo più risposte osservando il presente che verrà, quando potremo parlare di Facebook come possiamo parlare oggi dell’Olympia in tutte le sue declinazioni successive, in tutti i tocchi barbarici che ha sperimentato sotto i nostri occhi, e mani. RS: Mah…per esperienza diretta non credo che l’artista miri ad un oltre, forse aspira, come tutti, semplicemente ad esserci, magari con più coraggio o incoscienza e, se è andata bene, dopo si dice che ha avuto fortuna. Quello dell’oltre semmai è un problema della Storia, che pure ha un senso, a pensarci bene… tuttavia concordo con quello che dici delle parole che non significano nulla in sé. Barbarie non sarà certo l’ultima parola, ma l’esigenza che la fa pronunciare come indicazione di un’urgenza… beh, quella sì… credo che conterà sempre. note 1 Cayce Pollard è la cool hunter protagonista del romanzo di William Gibson Pattern Recognition (2003); Rrose Sélavy è lo pseudonimo scelto da Marcel Duchamp come alter ego femminile, con cui ha firmato diversi ready-made. OUTLET 97 IL FOTOGRAFO Il conflitto dopo la guerra Le immagini di Christian Piana IL FOTOGRAFO Christian Piana (Stazzano - Alessandria, 1978) diplomato nel 2002 presso lo Ied Arti Visive di Roma in fotografia. Lavora come fotografo free lance dedicandosi principalmente a reportage sociali in Perú, Bolivia, Brasile, BosniaHerzegovina e Kosovo. Nel 2005 si trasferisce a Sao Paulo del Brasile dove inizia l'attivitá di arte educatore di multimidia e comunicazione comunitaria in varie organizzazioni popolari, associazioni non governamentali e spazi culturali pubblici della cittá di São Bernardo e Santo André (periferie sud di São Paulo). Tra il 2006 e il 2010 coordina l'unita di São bernardo do Campo del proggetto federale Casa Brasil, progetto sostenuto dal Ministero della Cultura e Ministera della Scienza e Tecnologia, che prevede azioni di comunicazione comunitaria e media attivismo. Nel 2009 fonda e coordina la Casa Editrice Popolare “Lamparina Luminosa” premiata come “Ponto de Cultura” dal Ministero della Cultura, che pubblica libri di narrativa, poesia e giornalismo letterario, con attenzione specifica alla cultura popolare brasiliana. di Massimiliano Di Franca La domanda più comune in Bosnia è: tu, dove vai? Un’interrogazione precisa che arriva agli occhi di Christian Piana e che ha vagato come un mina dal 1995, termine del conflitto in BosniaErzegovina, fino al 2003 anno in cui il fotografo decide di partire e recarsi sul posto di guerra. Un ordigno si aggira sui paesaggi dell’ex Jugoslavia, come a dire che la lotta non è mai finita. Piccole scintille esplodono in memoria di un dolore che si muove su questo scenario in bianco e nero, all’interno del quale la gente si chiede dove andare. Christian Piana ricostruisce su carta fotografica, a distanza di 10 anni la storia di un conflitto, seguendo con particolare attenzione i racconti che sguardi e gesti di quel presente disegnano sul territorio. Tuona la voglia di libertà, di costruzione di un progetto sociale capace di generare un percorso che prevede differenti vie di scampo. Lontane dal concetto di fuga indotta dalla disperazione, vicine all’immagine di possibilità. Dai tagli sugli edifici, generati dai mortai, è difficile sporgersi e provare ad evitare il percorso scalfito dall’invisibile scia dei proiettili. Dalla profondità di queste immagini, di questo fotoracconto, appare lontana questa nuova condizione, l’opportunità di costruire un altro tragitto dove il semplice atto di camminare richiede uno sforzo fisico e mentale troppo grande da riempire. Gli accordi di Dayton, stipulati dai politici del Paese, tra il 1 novembre e il 26 98 OUTLET novembre 1995, sanciscono la fine apparente della guerra, ma l’inizio di un nuovo conflitto sociale che il popolo si ritrova a vivere e a respingere. Nei due mesi in cui Christian Piana vive a Grbavica, convive dentro questo tempo fermo, immobile, scandito ancora dallo scoppiettio delle fiamme, le stesse che hanno divorato il Parlamento, struttura e scheletro di un corpo politico assente, distante dalle vie e le vite del popolo sopravvisuto. Un sospiro freddo spinge al di là dell’obiettivo del fotografo delle immagini precarie e senza tregua.È settembre, e Christian Piana parte da Roma con l’intento di abitare e mettere in luce i rapporti e le trame sfilacciate che intercorrono tra la comunità e il territorio pubblico. Anche nel silenzio si celano i conflitti, da dentro questa assenza, a distanza di tempo, quando tutto sembra sia passato, il fotografo illumina le finestre e le ferite di questa città. «Non so descrivere i sentimenti che mi divorarono nel momento in cui misi i piedi in quella città, non so se era paura, stupore o rabbia, ma qualsiasi cosa fosse mi fece subito capire che la guerra era stata qualcosa di più del silenzio dei vicini e del minestrone anche alla domenica»2. 2 Christian Piana, Il giorno in cui sparirono tutti, ilgiornochesparironotutti.blogspot.it OUTLET 99 Sarajevo Il palazzo del Parlamento bruciato nel corso della guerra Sarajevo I funerali del presidente Izetbegovic Courtesy and copyright © the artist Sarajevo Un tram del centro. Durante la guerra i tram erano i primi obbiettivi dei cecchini Sarajevo Una donna all'uscita del mercato Sarajevo Un mercato in periferia Srebrenica Durante la guerra le fabbriche erano usate come caserme militari Srebrenica Il funerale collettivo di 107 vittime di cui sono stati Srebrenica Un anziano in cerca della tomba dei cari. riconosciuti i corpi. Le stime ufficila contano 7.000 caduti durante la conquista di Srebrenica, ma sono circa 20.000 le persone che risultano scomparse Il 12 luglio '95 le forze serbe comandate dal generale Ratko Mladic conquistano la città sterminando la popolazione civile POSIZIONAMENTI POSIZIONAMENTI Black bloc, ovvero della violenza divina DAGLI ANNI SESSANTA FINO AD OGGI, LA FIGURA BLACK SINTETIZZA DI VOLTA IN VOLTA I DIVERSI PROFILI ASSUNTI NELLA STORIA DALLA FORZA LAVORO: OPERAIA, STUDENTESCA, PRECARIA. UN MODELLO DI “HOMO SACER” CHE SI PRECLUDE L’ACCESSO ALLA POLITICA E TENDE ALL’ESTREMITÀ INACCESSIBILE DI UNA TRASCENDENZA ASSOLUTA. di Paolo Vernaglione OUTLET 105 POSIZIONAMENTI I l 13 luglio la Cassazione ha confermato le condanne al carcere per 10 ragazzi che, secondo l’accusa, a Genova 2001 avrebbero devastato e saccheggiato. Nessuno di loro era un black bloc. Il procuratore ha tra l’altro motivato la richiesta di condanna con la “partecipazione psichica” ai danneggiamenti. Partecipazione psichica: un reato biopolitico sanzionato con un articolo del codice fascista Rocco. La settimana precedente la Cassazione ha condannato a pene lievi i responsabili dell’ordine pubblico che hanno massacrato centinaia di persone alla scuola Diaz, torturato nella caserma di Bolzaneto e costruito prove false. Nessuno di questi entrerà in carcere. Per la giustizia (sic!) italiana valgono di più un bancomat e una vetrina rotta che un migliaio di teste rotte e di torture. La figura del black bloc, in cui culmina il terrore dello Stato, pronto a reprimere tutte le forme di conflitto, è apparsa la prima volta in occasione delle proteste contro il Wto a Seattle nel 1999. Da allora, una generazione irrappresentabile nel paradigma del “politico” e non soggetta ad alcuna Costituzione si è evoluta, diventando reale. Evocato dai media negli anni ‘90, tra i controvertici di Napoli e Genova 2001, rincorsi dalle polizie europee che non riuscendo a fermarli se la prendevano con le reti pacifiste, il blocco nero si è imposto come pratica autoreferenziale di conflitto che deflagra ove il capitalismo finanziario si mostra in tutta la debole potenza dello spread e del debito. La significativa trasformazione dal piano simbolico e della comunicazione con cui tv e giornali hanno criminalizzato il ribellismo “giovanile” allergico alla mediazione politica, al piano di realtà del soggetto “nero”, ci porta ad indagarlo con un criterio diverso rispetto a quello valevole per i conflitti del XX secolo. E allora: nasce e si sviluppa, a partire dai primi anni Sessanta un “sapere operaio”, frutto delle trasformazioni tecnologiche del modo di produzione, perché si forma un soggettività operaia che comprende anche studenti, donne, tecnici e una nuova borghesia cresciuta nella ricostruzione postbellica. Le lotte sul salario e per un libero sapere culminano negli anni 1968-1969 nel rifiuto complessivo del modello di sviluppo capitalista e in forme di conflitto non convenzionali, stigmatizzate dai partiti comunisti e dai sindacati in Europa (e particolarmente in Italia dal Pci), come estranei alla tradizione del movimento operaio. La cecità politica nel leggere il ’68 come momento rivoluzionario determina l’espulsione di quadri e dirigenti dal Partito comunista e afferma il centralismo democratico come prassi di mediazione dei conflitti interni ed esterni alle organizzazioni operaie. Forme di conflitto praticate da partiti e sindacati erano finalizzate al riconoscimento di diritti politici e sociali sanciti nel Welfare State. Lo stato sociale realizza così garanzie strappate con scioperi generali, picchetti e autorganizzazione. La mediazione poli- 106 OUTLET POSIZIONAMENTI tica emerge negli scorsi anni Settanta dal modello di fabbrica fordista, in cui la specializzazione del lavoro si accompagna alla costituzione della rappresentanza. Il grande ciclo di lotte aperto alla metà degli anni Sessanta si chiude con il ’77, che urla il rifiuto del lavoro. Il proletariato metropolitano dimostra con occupazioni, espropri, autoriduzioni, come pratiche di conflitto estese a macchia di leopardo si rivelino adeguate alla crisi del capitalismo. In Italia quel movimento viene prontamente criminalizzato con le leggi speciali antiterrorismo, che risolvono con teoremi giudiziari (che hanno l’avallo politico del Pci), una conflittualità di massa dirompente. Agli inizi degli scorsi anni Ottanta il panorama cambia, con le sconfitte operaie in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Iniziano i processi di liberalizzazione dell’economia, di privatizzazione e dissoluzione dello stato sociale: la disoccupazione è strutturale e la modernizzazione tecnologica è comandata da un capitale che risponde alla forte soggettivazione sociale con tagli ai servizi, blocco dei salari, fine della politica dei redditi e la complessiva disarticolazione individualistica e proprietaria dei conflitti sociali. La modernizzazione capitalista realizza così un paradigma di conflitto diverso da quello post-bellico, laddove con la crisi delle organizzazioni operaie e dei partiti salta la mediazione tra lavoro e capitale. Lo Stato infatti non è più il luogo di composizione dei diversi interessi di classe. Il conflitto amico-nemico si frammenta e si atomizza; una microfisica del potere disloca dispositivi di controllo in flussi che vanno verso una deterritorializzazione, di cui la metropoli è il centro di gravità. L’economia deregolamentata diviene sempre più liquida e “di carta”. Tra la fine degli anni Ottanta e i primi Novanta si annuncia allora un’inedita costituzione di soggettività, fondata su un’asimmetrica relazione tra saperi, poteri e soggetti. I saperi diventano produttivi, sono “intelletto generale”, produzione immediata di ricchezza sociale di cui il capitale si appropria attraverso la rendita. I poteri si disarticolano e centuplicano la loro efficacia diventando mobili e imprevedibili nel catturare mode e modi delle subculture antagoniste. I soggetti d’altra parte non traducono più in prassi politica le differenze sociali, di classe e di genere, realizzando invece un’ibridante collage della modernità, il cui tratto emblematico è niente di meno che l’esibizione della natura umana. Essa fa segno, come Paolo Virno ha in più occasioni ribadito, verso il “già da sempre” metastorico in cui vive il capitalismo post-fordista. Ma tale costituzione del dominio, per attuarsi, ha bisogno di un “proprio ora” storico, una contingenza per natura irriducibile alla mediazione. Esaurita la funzione dello stato sociale come spazio di confronto tra amico e nemico, le forze produttive divenute globali, dispongono il conflitto nell’immediatezza delle occasioni di profitto: deregolamentazione dell’ecoOUTLET 107 POSIZIONAMENTI nomia, delocalizzazione, appropriazione dei beni comuni essenziali. Il dispositivo di sovranità approntato è la governance dei beni e delle vite, cioè il controllo amministrativo diffuso, capillare, micrologico dell’esistenza. Nel governo della vita il capitalismo si mostra per ciò che è, senza veli e apparati simbolici. Nell’intreccio inestricabile di storia e metastoria, “già da sempre” condizionale e “proprio ora” contingente l’attuale modo di produzione esibisce la natura umana, cioè l’insieme delle facoltà umane di linguaggio e di pensiero. L’antagonismo muta altrettanto rapidamente pelle e significato: non più lotta dialetticamente realizzata nella sintesi politica dello Stato, bensì alterità radicale, ai limiti dei linguaggi verbale e gestuale. Si tratta dell’emergenza dell’intelletto generale: l’insieme delle facoltà psicofisiche che si presentano nell’arena globale, ovvero nello scontro di classe come forze produttive immediate. Lavoro vivo e sapere vivo sono espressioni della produzione di ricchezza che si danno “proprio ora” in figure sociali che riepilogano la storia dei conflitti tra classi, cioè lo scontro tra salario e capitale. La figura black è sintesi dei diversi profili assunti nella storia dalla forza lavoro: operaia, studentesca, precaria, ma scartandone le traiettorie, contestandone identità e appartenenze, sovvertendo la tendenza all’organizzazione, sconvolgendone la costituzione di soggettività, si preclude l’accesso alla politica e rimane prigioniera del paradigma maschile del “politico”. Il black bloc, che si lascia dietro la miriade diffusa di occupazioni squatters e riappropriazioni di spazi, impersona dunque il tratto costitutivo della “politica mondiale”, in cui si intrecciano orizzonte trans-individuale e individuazione singolare. In questo senso assume la violenza come assoluto della differenza – come differenza delle differenze. La genealogia black non può essere quella tradizionale del partigiano, (dalla guerriglia antinapoleonica spagnola del 1806 alla guerra di movimento nella prima guerra mondiale), ridotto da Schmitt all’ordinamento statale nel disperato tentativo di neutralizzarne la carica rivoluzionaria, bensì quella dell’alterità senza confini, in cui si mostra la giuntura tra il pieno della produzione e il vuoto del desiderio in cui si realizza, in una lingua non codificata, un’esteriorità tutta interna al capitalismo. Il black bloc è il partigiano non integrabile, soggetto infinito della vita trans-individuale e tuttavia implicato nella dinamica di classe e nella concreta produzione di ricchezza. La nuova costituzione soggettiva, che niente ha più a che fare con il paradigma amico/nemico in cui è incardinata la sovranità, risiede in un altro paradigma, che separa teologia e politica, diritto e religione e in cui si intrecciano vita e produzione. Questo orizzonte è stato indagato da Giorgio Agamben nella figura dell’homo sacer, soggetto sottratto alla religione e alla politica, che nasce dall’oscuro profilo della sacertà latina, nella zona di dissoluzione della ritualità e della legalità. 108 OUTLET POSIZIONAMENTI L’homo sacer infatti, a differenza dell’interpretazione neutralizzante che l’antropologia e la sociologia ne hanno dato tra la fine del XIX e il XX secolo, non vive affatto nell’ambigua interpretazione della teologia politica, perché non coincide con il soggetto del rito religioso che a partire dal cristianesimo assumerà la foggia del capro espiatorio, riepilogando la storia umana. Renè Girard ha dimostrato in maniera indiretta come questa figura sia il punto di giunzione tra teologia e politica, poiché rappresenta, nella figura del Cristo, l’intersezione di violenza divina e violenza umana. Il capro espiatorio, vittima innocente, realizzerebbe la demitizzazione delle religioni arcaiche presso cui era sacrificata una vittima ritenuta colpevole. La violenza “mitica” di una comunità si traduce da allora nella protesta di una vittima che si incarica della totalità della prassi umana. La violenza mondiale sarebbe dunque limitata dal capro espiatorio, che giustifica inoltre la derivazione trascendente del potere politico. Ma secondo questa ipotesi la violenza divina si trasformerebbe tout court in violenza umana, ed essendo tale mutazione senza residui incarnata nella figura del capro espiatorio, la procedura eliminerebbe l’irriducibile violenza creatrice del diritto in cui la legittimità di un ordinamento si mantiene, a prescindere dalle forme di legalità che esso realizza. Se insomma viene meno la giustizia quale condizione metastorica della prassi umana e tutto si risolve nell’esercizio della violenza per conservare l’ordinamento giuridico, le diverse forme di conflitto nelle differenti epoche storiche non sarebbero altro che variazioni nell’esercizio del potere per realizzare l’invarianza della sovranità statale. A differenza del capro espiatorio, che dismette la violenza divina riducendola alle umane sembianze del dominio, l’homo sacer è la figura della nuda vita non sacrificabile e uccidibile, in cui, con Agamben, riconosciamo un terzo profilo della sovranità, ulteriore rispetto a quello teologico come a quello giuridico-politico. Sacer esto è infatti il potere singolare del soggetto, in due significati del concetto: come soggetto subordinato (uccidibile) e come produttore di sé (non sacrificabile) e delle proprie condizioni di esistenza, in cui “già da sempre” e “proprio ora” si delinea l’esistenza umana. L’homo sacer, situandosi nella zona di indistinzione tra diritto e teologia, occupa uno spazio estraneo alla statualità e al rito, contestandoli in nome della violenza divina, cioè in nome della costituzione di una prassi assoluta. In questo senso la “sacertà” accede alla violenza divina che Walter Benjamin contrappone alla violenza mitica creatrice e conservatrice del diritto. Nell’ambivalenza del concetto di violenza divina – come violenza condizionale, eccedente il senso umano di giustizia, ma anche come violenza a cui fa segno ogni diritto e ogni ordinamento giuridico in quanto effetto di mitica violenza – riconosciamo la doppia articolazione dell’homo sacer (non sacrificabile e uccidibile) nel luogo fisico e storico di costituzione della legittimità. OUTLET 109 POSIZIONAMENTI Questo spazio è la zona di indistinzione in cui forze produttive e rapporti di produzione, sovranità ed esistenza materiale, legittimità e legalità risultano indiscernibili. In questo spazio la figura black occupa, in nome della nuda vita, l’estremità inaccessibile di una trascendenza assoluta, totalizzante nella prassi ma nulla politicamente. La non sacrificabilità dell’homo sacer fa infatti segno per noi verso un luogo “terzo” rispetto allo scontro tra capitale e lavoro, politica e vita biologica, metastoria e storia. L’uccidibilità enuncia invece la condizione materiale degli attuali rapporti di produzione, in cui il lavoro è immiserito “fino alla morte”, la precarietà conduce al suicidio, la privatizzazione dell’esistenza produce un bando sovrano che espelle coloro che, estranei ai conflitti “messi in forma”, sono rubricati come “costi” umani e sociali. La “sacertà black” costituisce dunque il piano di esistenza della messa a morte di una vita che, non considerata produttiva, tenta di sottrarsi al dominio. Ma allo stesso modo la latitanza assoluta rispetto all’ordinamento, assoggetta il black bloc alla propria non sacrificabilità, con il paradossale effetto di costituire un piano di soggettivazione del capitale. Lungi dall’essere il reprobo contro cui si rivolge la violenza “mitica” dello Stato, che culmina nell’uccidibilità; ma lungi anche dall’essere la figura trascendente del capro espiatorio che si accolla i peccati dell’umanità, la figura black impersona un’inarrivabile giustizia assoluta, che, nella zona di indistinzione di umano e divino, diviene strumento di potenze che lo eccedono. Ora, nel mutato ordinamento internazionale in cui la politica estera si risolve in operazioni di polizia internazionale; in cui le prerogative dello Stato riguardo alle garanzie sociali sono appropriate da istituzioni globali non elette che dettano tempi e modi del governo del mondo, e in cui la rappresentanza e la mediazione sociale sono saltate, nell’ingente cattura del comune operata dalla rendita e valorizzata dalla speculazione – i soggetti di conflitto sono estranei al patto sociale delle democrazie compiute. Mentre la figura del black bloc, nel precludersi l’individuazione sociale, risulta estranea alla pratica politica. Malgrado ciò, “siamo tutti black bloc”. 110 OUTLET POSIZIONAMENTI Paolo B. Vernaglione Riferimenti bibliografici Giorgio Agamben, Homo Sacer. Il potere sovrano e la nuda vita (Einaudi 1995); Walter Benjamin, “Per la critica della violenza”, in Angelus Novus. Saggi e frammenti, trad.it. (Einaudi 1976); René Girard, Violenza e religione. Causa o effetto?, trad.it. (Raffaello Cortina Editore 2011); Carl Schmitt, Teoria del partigiano. Integrazione al concetto del Politico. trad.it. (Adelphi 2005); Paolo Virno, E così via, all’infinito. Logica e antropologia (Bollati Boringhieri 2010) Insegnante di filosofia. Editor della casa editrice manifestolibri. Autore di: Il Sovrano, L’Altro, la Storia (manifestolibri 2006); Un’idea di democrazia (Elabora edizioni 2006); Dopo l’umanesimo (Quodlibet 2009). È tra i fondatori del Laboratorio Filosofico “SofiaRoney”. OUTLET 111 POSIZIONAMENTI Il ritiro delle dal donne patto sociale A PARTIRE DAGLI SCRITTI DI ANNA BRAVO E LUISA MURARO, UNA RIFLESSIONE SU POLITICA, FEMMINISMO E TRASCENDENZA. FRAMMENTI DI UN DISCORSO SCABROSO CHE METTE IN CAMPO LA QUESTIONE DELL’OMICIDIO E LA NECESSITÀ DI FAR TORNARE SPENDIBILE LA FORZA. di Carola Susani L a violenza e le donne? O addirittura: la violenza e il femminismo? Il volumetto di Luisa Muraro Dio è violent, edito pochi mesi fa da Nottetempo, non parla di questo. Pone una questione diversa. Se immaginiamo, dice, che la società si regga in virtù di un contratto sociale, oggi quel patto è andato a pezzi. Il contratto sessuale, preesistente, anche quello letto nelle dinamiche storiche tra uomini e donne e proiettato in un passato indefinito, è andato grazie a Dio in pezzi da tempo. In un momento storico come questo (e lo definisce attraverso fatti concreti di scollamento e insicurezza), sostiene Muraro, non ha più senso delegare la forza, anche nella sua espressione più diretta, la violenza, alla struttura istituzionale del potere, occorre richiamarla indietro. Ritrarsi dal patto. Far tornare la forza di nuovo spendibile. Certamente è un discorso che riguarda le donne e gli uomini. Eppure. Senza la storia della differenza, senza la storia del femminismo italiano questo discorso nei termini in cui lo fa Muraro, non sarebbe concepibile. 112 OUTLET POSIZIONAMENTI Nella cronologia interna al libro di Luisa Muraro c’è la prima guerra mondiale ma non c’è la democrazia rappresentativa. Il patto visibile, le costituzioni degli Stati democratici, e il loro ruolo fondativo dopo la seconda guerra mondiale, in particolare la nostra costituzione italiana, non sono un elemento in gioco. La democrazia come struttura di canalizzazione del conflitto, Muraro non la chiama in causa. Non affronta la questione della democrazia parlamentare, legittimata anche dal voto di gran parte delle donne italiane, e che ha visto negli anni una quantità di donne apparire sulla scena pubblica, di fatto coimplicate nei termini della politica italiana così come l’abbiamo conosciuta. Certo, coimplicate come Ecati triformi, per un terzo aderenti, per due terzi sempre altrove. Luisa Muraro preferisce non entrare nella questione. È possibile, e anche interessante, mi sembra, leggere, come fa Muraro, questo momento storico come momento di inefficacia del contratto sociale, in cui il potere, al quale è stato attribuito l’uso della forza, non è più in grado di garantire sicurezza a chi gliel’ha delegata. Dunque è il caso che chi ha delegato la forza, se la riprenda. La questione è stringente: esistono momenti nella storia, momenti di frattura, di crisi, in cui alcuni e alcune, che non sono il potere costituito, si fanno carico, si assumono la responsabilità di riprendersi la forza e di metterla in azione, anche sotto forma di violenza. Sono le rivoluzioni violente che abbiamo conosciuto. Eppure, Muraro non parla di questo. Non esattamente. Parla della violenza di Dio e del nostro ruolo rispetto ad essa. Ma cosa intende? Trovo che giocare con Dio in un discorso che prende le distanze dalle religioni positive non solo renda fertile il discorso, lo faccia crescere, lo liberi dalla stentatezza, aridità di un pensiero prigioniero del noto, ma sia una semina coraggiosa, perché con una semina così, non sai mai cosa al dunque andrai a raccogliere. È fertile, per come la vedo io, immaginare Dio come la libertà, ma se Dio è libertà, è una libertà che non mi appartiene, che non controllo – la libertà non mia, io la chiamo – che si manifesta. Chiunque provi a ingabbiare Dio in un sistema di norme e dogmi, finisce per impantanarsi in continue aporie. Che si ostini a farlo, che con una finzione violenta trasformi Dio nel piedistallo di un sistema di potere, è un problema suo, e nostro. Molto meno, di Dio. Dio è violent, come si fa a negarlo? Ma noi, donne e uomini, che cosa c’entriamo con la violenza di Dio? Perché quella violenza viene chiamata in causa in un discorso che ha tutta l’aria di essere politico, anzi rifondativo del politico? Perché: dove va la politica quando non c’è più la polis, quando la polis è smantellata? Questa nuova condizione crepuscolare della politica, è l’occasione di un’attesa, l’annuncio di un’alba. C’è alle porte la possibilità di un nuovo patto, altro e diverso? Muraro non parla di questo. Immaginarci alle soglie di un nuovo patto, imporrebbe un tema, il tema dell’assunzione di responsabilità rispetto al patto, il tema del farsi carico, che è proprio quello che Muraro si scrolla via di dosso. OUTLET 113 POSIZIONAMENTI POSIZIONAMENTI Carola Susani scrive racconti e romanzi, è redattrice di Nuovi argomenti, collabora con gli Altri. Il suo ultimo romanzo,Eravamo bambini abbastanza, è uscito a marzo di quest’anno per Minimum fax. La questione della responsabilità ha attraversato il pensiero della differenza. L’irresponsabilità politica delle donne, considerato lo stato dei rapporti politici tra donne e uomini, considerato lo stato profondo della società e della politica che quei rapporti disegnavano, era una condizione, una condizione che si trasformava in un valore. Chiamare le donne a fare la propria parte in uno specifico cambiamento storico, a farsene carico accanto agli uomini, ad assumersi una responsabilità in uno specifico contesto politico, proprio mentre il femminismo attuava un cambiamento prima impensabile liberando il gioco più profondo delle donne e degli uomini, chiamava come risposta uno sberleffo, una risata. Il femminismo, il pensiero della differenza, hanno portato una frattura tale, una tale discontinuità (Ida Dominijanni dice: un taglio), da costringere a un ripensamento di tutti i termini. Accanto al tema della violenza, e prima ancora, c’è il tema della responsabilità, del suo ripensamento. Quando uscì su Genesis il saggio di Anna Bravo, Noi e la violenza. Trent’anni per pensarci, era il 2004 (l’intervista di Simonetta Fiori apparve su Repubblica nel 2005). Nel libro, Anna Bravo accusava il femminismo (le femministe e lei stessa) di aver eluso il tema della violenza, nell’affrontare l’aggressione e la sofferenza del feto nell’aborto, nel mancare di riflettere sulle connivenze verso il terrorismo. Ancora più che l’accusa di aver esercitato la violenza, a provocare una reazione così accesa fu il fatto che Anna Bravo chiamasse le femministe, sia quelle più 114 OUTLET implicate con la politica dell’estrema sinistra sia le altre, all’assunzione di una responsabilità, a un farsi carico dell’agire, delle pratiche, delle eventuali connivenze con la violenza. Nel testo di Anna Bravo, che la violenza sia il polo nero del discorso lo si dà per scontato, lei d’altra parte sposa la non-violenza, lo fa pienamente e con coscienza. Luisa Muraro sembra risponderle a distanza di tempo. La violenza, nel saggio di Muraro, non è affatto il polo negativo del discorso, è semplicemente l’espressione estrema della forza. Forza e violenza rientrano di peso nel gioco, sono spendibili da tutte e da tutti, una volta che la polis è andata a pezzi. Ma non è proprio un gioco. Dobbiamo tenere conto del fatto che quando parliamo di violenza non parliamo di un’astrazione, parliamo dell’uccisione di qualcuno, a meno di non volere limitare la nostra idea di violenza a tirare qualche sasso o spaccare due vetrine. Capita in particolari momenti storici di dover mettere in conto di morire o di uccidere qualcuno, quando si è con le spalle al muro, quando non si può fare altrimenti. Uno di questi momenti, per molte e per molti, è stato la Resistenza. Muraro ci sta dicendo che questo è uno di quei momenti? Ci sta dicendo che bisogna mettere nel conto l’uccisione di qualcuno e la nostra stessa possibilità di rimanere uccisi? Che dobbiamo farcene carico? Non esattamente. Muraro chiama in causa la violenza di Dio. La violenza di Dio si manifesta continuamente, si fa strumento degli oggetti, della natura, delle tecnologie, degli uomini e delle donne. Di Dio, se vogliamo metterlo in gioco, concepirlo come se fosse in azione nel mondo, siamo in grado di vedere solo la libertà, che spesso prende la forma della violenza. La responsabilità di Dio (molti l’hanno chiamata provvidenza), ci sfugge, non è alla nostra portata, noi non vediamo il disegno. Muraro ci dice che bisogna accettare di essere strumenti di Dio e che Dio è violent. Cosa ci consente questa nuova visione delle donne e degli uomini e del loro agire? Ci consente di scantonare dall’annosa questione dei mezzi e dei fini, di proporre l’idea di un’azione che non cada in capo a nessuna donna e a nessun uomo, un agire senza responsabili. Chi è più irresponsabile di Dio? Come si può imputare qualcosa a Dio? Sebbene, a volte, qualcuno, per bocca di Rachele o di Giobbe, ci abbia provato. Può darsi che nella responsabilità ci sia un peso insostenibile – per Muraro sembra che sia un peso superiore persino al peso dell’esercizio della violenza –, può essere che pensarsi responsabili sia contiguo e parente al pensarsi onnipotenti, che ci sia dunque in questo un problema. Tuttavia scrollarsi di dosso la responsabilità non mi sembra che sia la soluzione. Pensarsi strumento della violenza di Dio non ha su di me una eco buona, tiene in sé un elemento baldanzoso, vitalistico, palingenetico persino, che non trovo rassicurante. Né vuole rassicurarmi, credo. Certo è che la questione della responsabilità, del suo ripensamento, rimane aperta e necessaria come non mai. Preliminare a ogni ragionamento su violenza e non-violenza. OUTLET 115 POSIZIONAMENTI Epopea Ultras IL RACCONTO IN PRIMA PERSONA DI UNO SCRITTORE CHE HA COMINCIATO A SEGUIRE IL CALCIO COME TIFOSO E AL FENOMENO HA DEDICATO TESTI TEATRALI E ROMANZI. TRACCE DI UNA CULTURA UMANISTICA CHE SI È DISSOLTA IN UNA SOCIETÀ CHE HA AZZERATO LA CONTIGUITÀ FISICA CON L’EVENTO. di Giuseppe Manfridi I n mezzo alla curva ci sono stato, e per anni e anni, aggregato a gruppi e no; ho fatto trasferte nei vagoni del “commando” ma pure da lupo solitario, in macchina su e giù per l’Italia, e anche per l’Europa; sino a Ballymena, tanto per dire, mirando a partite di poco senso (primi turni di Coppa Uefa o roba del genere) a cui l’impresa di essere lì, di starci, di non fallire la mia presenza in loco, un senso però lo dava, e a maggior ragione sapendo che sarei stato tra pochi e con pochi a far tumulto; un paio di volte mi hanno pure caricato di malagrazia su dei furgoncini che nei vocabolari del secolo scorso avevano un nome che oggi significa tutt’altro: cellulari, li usava la polizia e avevano forma per l’appunto di piccole celle mobili (parlo al passato, ma per nostalgia semantica; esistono ancora); conosco, anzi conoscevo, certi anditi di San Siro, certi punti 116 OUTLET POSIZIONAMENTI di fuga che neanche un interista o un milanista; ma parliamo di decenni fa, poi, coi Mondiali del Novanta, tutti gli stadi li hanno rifatti e le mie antiche competenze si sono rivelate d’improvviso carta straccia; ricordo di aver fatto piantine del settore ospiti di Marassi e del Dall’Ara ad alto grado di affidabilità, e, si badi, senza poter contare su ausili informatici ancora inesistenti; piccoli capolavori di grafica mnestica che quando non potevo essere con gli altri smerciavo a prezzo di vanagloria manco fossero il tracciato dei cunicoli sotterranei di un carcere turco, tipo quella sudicia cartina che in Fuga di mezzanotte fomenta il sogno di un’evasione impossibile dalla colonia penale di Istanbul; ho appreso le regole del branco al pari di Tim Parks che nel suo memoriale Prigionieri di una fede traduce in romanzo la cronaca di un anno trascorso a seguire le frange estreme del tifo veronese (non del Chievo, che a tutt’oggi rimane un fervida realtà rionale, ma dell’Hellas Verona) sbattendosi in giro dappertutto e in ogni modo, purché sempre nell’epicentro del mucchio, nell’ardore del fuoco, al vertice del rischio. Ma tutto ciò, col mio raccontare gli ultrà o col raccontare di me che per anni questo ho fatto e nelle forme più diverse (dalla narrativa al teatro in versi, dal monologo squinternato e iperrealista all’epos di una sceneggiatura cinematografica), c’entra poco. C’entra molto, semmai, con la mia giovinezza; con la mia giovinezza sì; con uno strano e forse immotivato desiderio di appartenenza, con la smania di prendere a spallate la patina borghese che segnava il mio status di ragazzetto pulitino, figlio unico di genitori capaci di costruirsi a fatica una realtà lontana dalla ristrettezze che, in tempi prima di guerra e poi di dopoguerra, avevano minacciato entrambe le famiglie di provenienza. Al loro impegno, al loro amore debbo un privilegio sociale che però, essendo nato e cresciuto in un quartiere periferico, quasi mi indispettiva e addirittura mi umiliava esponendomi al quotidiano dileggio dei miei compagni di combriccola stradarola, pischelli resi ben più famelici e scaltriti dal disagio di una precarietà costante, che non era la mia. Unica loro certezza, l’incertezza. E come loro, avrei voluto essere a rischio perenne e giornaliero anch’io, non per masochismo, ovvio, ma per brama di affinità; per non sentirmi, diciamo così, in esilio. Condizione, questa, che maggiormente mi affliggeva e che, dunque, contrastavo anche a costo di spingermi nel vasto territorio della dissennatezza anarcoide. D’altronde, il mio slancio politico era di troppo corto respiro per riuscire a compromettere il perbenismo da cui mi sentivo endemicamente infetto, ci voleva qualcosa di più forzato, di più scandaloso, di più scenografico e inurbano. Ci volevano gli spalti e le gradinate, e quella strana forma di ideologia implausibile che l’amore per una squadra contempla, ma quasi senza trasmettere informazioni chiare circa chi lo nutre e lo professa. Nel senso che se dici di essere di destra, la gente prende atto, ti capisce e ti identifica, e capisce altresì di quale ipotetico conflitto sei portatore; lo sa e si regola. Parimenti, se ti dichiari di sinistra. Questione di feritoie da cui si punta lo sguardo sul paesaggio, e che a seconda della porzione del paesaggio che quella data feritoia mostra, trasforma il PaeOUTLET 117 POSIZIONAMENTI saggio in un paesaggio piuttosto che in un altro. Ma col tifo calcistico è diverso. A rigor di logica, scegliere una squadra fra tutte e proclamare senza remore quanto la si ami non dovrebbe essere di per sé un indizio della propria sensibilità morale, né suggerire a terzi una certa lettura filosofica del mondo a scapito di altre. Né, tantomeno, se ne dovrebbe dedurre una qualsivoglia inclinazione spirituale. Eppure, c’è fede e fede. C’è quella del pensiero e c’è quella del cuore. E c’è poi la fede che le mescola l’una all’altra, e questa per me è la vera fede. Quella dei màrtiri, chiunque essi siano, anche se canaglie. I martiri canaglie: non ci piace saperlo o ricordarlo, ma ce ne stanno. Tra gli ultrà ne ho conosciuti, e non perché abbiano pagato a caro prezzo il loro aver fatto quel che d’abitudine facevano – scassare, provocare perturbare, compromettere la quiete delle domeniche come si deve – bensì, perché avevano messo in conto qualsiasi remissione possibile in cambio di un nonnulla. Sì, un nonnulla. Tale era il loro scassare e perturbare, tranne quando l’offesa produceva danno, e il danno tragedia. Di rado, ma accadeva. Io facevo così, scassavo e perturbavo. Perlomeno, stavo con chi viveva di un simile strampalato progetto esistenziale sentendosi retribuito dal puro e semplice senso di sé, dal poter dire: eccomi, ci sono anch’io!. Una strana puerizia, un assurdo infantilismo, contrassegnava quest’attitudine al caos facendo presumere che la colpa fosse venialissima, tanto da apparentarsi all’innocenza. Sia pure pericolosa. Un concetto che avevo assorbito, quello dell’innocenza pericolosa, pur di non ritenere totalmente vacua la galassia di valori in cui vorticavano le mie emozioni di tifoso. Un tifoso come pochi, dicevano. Lo vedi quello? Lui sì che è un tifoso come pochi! Un vero ultrà. Mi piaceva essere chiamato così. Ultrà, da “oltre”. Qualcuno che sta oltre. Né qui, né lì, ma oltre sia qui che lì. Come, in fondo, i poeti, e a me scrivere poesie era un’altra cosa che piaceva. Una definizione, dunque, che contemplava la mia totalità di individuo, per di più convinto di testimoniare così facendo, e così essendo, la propria passione, e, di concerto con essa, la propria fede e la propria ideologia. Tutto, insomma. Tutto ciò che è indispensabile a comporre una coscienza civile, ancorché irregolare, scorretta, e nella sua scorrettezza, tremendamente umana. Fin quando accadde qualcosa. Non Paparelli. Fu dopo Paparelli che accadde qualcosa. Anni e anni dopo Paparelli: nell’85. Il caso Paparelli lo interpretai e lo vissi per quel che di fatto fu: un omicidio preterintenzionale, laddove certi omicidi preterintenzionali mi appaiono più feroci e gravi di altri premeditati. L’ottusità non è un attenuante, all’opposto: è un vizio dell’anima che, pascendosi di sé, aggrava ogni intenzione fornendola di una sua specifica consapevolezza. L’ottusità è un tratto della volontà, e come tale andrebbe giudicata. Un razzo che attraversa uno stadio perché vada dove vuole, magari a svanire poeticamente in cielo o magari a piantarsi nel cranio di un povero padre di famiglia nella cruenza del sangue versato, è ottusità in atto, ottusità insipiente; l’ottusità di una dinamica inerte il cui Big Bang è nella sonnolenza di un’ottusità senziente. Quella di un assassino che è stato tanto infame, tanto grotte- 118 OUTLET POSIZIONAMENTI sco, tanto ottuso, da consentirsi il lusso di non prevedersi assassino. Paparelli fu la vittima di un sottobosco parassitario del vero bosco, e la sua morte mi sembrò quasi una realtà avulsa dallo stadio che l’accolse, anche se io ero lì, come lì erano i giocatori che giocarono comunque la partita e i cronisti che miscelarono il resoconto di un vilipendio umano col racconto dei due gol che servirono a siglare l’uno a uno finale, e pensarla in un certo modo mi aiutò a chiamarmi fuori da qualcosa in cui invece, oggi lo comprendo eccome, ero immerso fino al collo. I parassiti di una forma di vita fanno parte di quella forma di vita, c’è poco da fare. Ne fanno parte e la fomentano. Ma dovettero passare anni perché sentissi tutto il peso di certe correità. Dovette arrivare l’85, dovette arrivare Haysel. Dovettero arrivare 39 morti. «Tu non lo sai, Giovà, dov’è che stanno! / Te lo dico io dov’è che stanno! / Stanno seduti sulle loro tombe / e di quelle bandiere ne faranno / bare da rimboccare ai loro morti». Trentanove morti juventini sdraiati uno affianco all’altro fuori dallo stadio belga coperti dalle bandiere che si erano portati appresso per tifare la loro squadra nella Coppa Campioni contro il Liverpool. Nell’ultima gara, direbbe Saba. Non sono juventino. Quella partita la stavo seguendo in diretta televisiva. Tifando logicamente Liverpool. Per astio, per frustrazione, per fame di conflitto, per ideologia. Se preferite, mettiamola così: per una mia specifica percezione del reale, in cui il dato avverso, il principio di ostilità, è concepito come pedina stabile sulla scacchiera. Al contempo in quei giorni stavo traducendo una commedia minimalista di Barry Keeffe intitolata God save the Queen, testo che racconta di tre fanciulli tifosi del Manchester United rimasti senza biglietto per la finale della Coppa d’Inghilterra. L’autore è assai abile nel raffigurare, per tramite di una situazione focale, l’intero scenario di tre vite ai margini, con tutto il loro portato di sogni e di bisogni. A quella commedia mi stavo dedicando con ammirazione e affetto, ma quando la morte si sprigionò dal video ne fui travolto e cambiai rotta decidendo di tralasciare il mio compito e comporre una tragedia. In versi endecasillabi, i cui primi suonano così: «Fra Juve e Toro voi chi preferite? / Forse il Toro. E fra Genoa e Sampdoria?». A termine della prima scena si arriva alla sequenza già citata che rievoca quei cadaveri sepolti nella loro terra patria: nei colori che tingevano i loro cuori. Scrivere mi ha fatto comprendere ciò che intendevo significare, ossia la gravità della costrizione linguistica che imprigiona e nevrotizza i gesti delle tribù da stadio. I miei personaggi li ho obbligati a esprimersi in modo coatto, senza possibilità di alternative metriche, al pari della massa, che quando parla, non parla in prosa ma in versi, per inni e filastrocche, governata dal regime univoco, non colloquiale, dei cori e degli slogan. È perciò che i teppisti di Teppisti! li ho immessi in uno slogan pressoché infinito, all’interno del quale confliggere è impossibile, nonostante confliggere sia la loro vocazione suprema. Così, condannati all’ergastolo di un rap senza requie, che altro potranno fare se non da ultimo, giunti al diapason massimo dell’ecciOUTLET 119 POSIZIONAMENTI tazione, infrangere con l’oscenità sterminatrice della violenza attiva una gabbia di parole incapaci di condurre ad alcuna catarsi? Tant’è, si uccideranno e uccideranno. Come ad Heysel, anche se il mio testo, lo ammetto, non è in grado di spiegare Heysel ma a malapena se stesso. Negli anni a seguire, l’esegesi antropologica del fenomeno ultrà (parola ormai retrocessa nella lista impura dei termini compromessi) ha preso il sopravvento sino alla più compiuta esemplificazione del film che così si intitola. Ultrà, appunto. Con la regia prodigiosa di Ricky Tognazzi. È ancora lo stadio il luogo identificativo per eccellenza, dove le tifoserie provvedono a spettacolarizzare il loro oltranzismo e dove i vecchi capibranco continuano a mantenere un carisma connesso a un codice specifico, a un gergo tradizionale che è un misto di memorie individuali e collettive: chi ha parato il culo a chi, e quante puncicature, e quanti scalpi conquistati! Cioè a dire sciarpette altrui, striscioni e consimili trofei; porzioni, insomma, dell’anima avversa tradotta in simulacri da trafugare e vilipendere. Le imprese del gruppo vorrebbero combinarsi a quelle della squadra, amplificarle, se non addirittura sostituirsi ad esse; ma siamo al travalico di un tramonto epocale. Nel nuovo millennio è ancora la televisione a raccontare le mutazioni di un fenomeno tutt’altro che cristallizzato. Penso alla morte di Raciti a Catania e ancor di più al derby di Roma sospeso per volere di entrambe le fazioni, concordi nell’imporre in mondovisione la messa in opera del loro potere decisionale. Con un pragmatico gioco di parole potremmo parlare di concordia nell’imporre la discordia. Una questione intrisa di intelligenza politica, direi. E, più di recente, penso ai giocatori del Genoa costretti, per ignominia, a levarsi le maglie rossoblù in mezzo al campo, sotto le minacce di una gradinata furente. Il tutto, in diretta Sky e Mediaset. Dinanzi agli sguardi esterefatti di innumerevoli telespettatori, molti dei quali uniti in parcellizzati gruppi di ascolto casalinghi; quei gruppi mondani e salottieri, un po’ ignavi e molto suscettibili, in cui si è frantumata e persa l’antica cultura degli spalti, espiantata dalle curve, trascinata fuori, all’esterno, sotto specie di altro flagello, di guerriglia urbana, e sottomessa al governo di cani sciolti spesso incapaci di declinare la formazione della squadra per cui ostentano fanatismo. Ciò non significa che il peggio di oggi sia un peggio più grave del peggio di ieri. E comunque, intendo dire altro. Non è l’esserne tagliato fuori a suggerirmi nostalgie invereconde. È facile, sempre, camuffare col rimpianto quel che non si sa e di cui non si è protagonisti, e che ci offende poiché ostile a un mondo che per noi rappresentava l’antitesi della nostra senilità. Il punto è che la cultura ultrà non ha più spazio di esistenza in un habitat dove chi osserva l’evento è il vero evento. Perciò la cultura ultrà è come la pittura figurativa: se non morta, ormai insensata essendo (essendo stata) in buona sostanza umanistica, dacché implica (implicava) la compresenza fisica col fatto. Quella pasoliniana partecipazione al rito che sapeva recuperare una scintilla di sacralità nel febbrile affermarsi di un’assemblea pagana. 120 OUTLET POSIZIONAMENTI Giuseppe Manfridi Drammaturgo e romanziere. Gran parte della sua produzione è dedicata allo sport e al calcio in particolare, a partire dall’atto unico Ultrà e da Teppisti! (1985), passando per La partitella (1990) e La riserva (rappresentato nel 2002 allo stadio di San Siro). Collabora alla sceneggiatura del film Ultrà (regia di Ricky Tognazzi), vincitore dell’Orso d’argento al Festival di Berlino del 1991. Per Limina pubblica il romanzo Epopea Ultrà (2009) e Tra i legni – i voli taciturni di Dino Zoff (2011). Negli stessi anni la casa editrice La Mongolfiera pubblica i primi cinque atti di Diecipartite, portati in scena dallo stesso Manfridi e che consistono in altrettanti racconti teatrali di partite della Roma. Dal 2004 collabora al quotidiano sportivo Il Romanista. OUTLET 121 REPORTAGE REPORTAGE «Io ci metto un minuto a guadagnare 50 euro» GLI ADOLESCENTI CHE CRESCONO NELLE CASE-FAMIGLIA PROVANO UNA FORMA QUASI INTIMA, PRIVATA, DI CONFLITTO: DEVO O NON DEVO ACCETTARE UN NUOVO MODO DI VIVERE? E SE LO FACCIO, DOVRÒ RINNEGARE I MIEI GENITORI? REPORTAGE di Laura Eduati «Q uanto ci metti a fare 50 euro? Io ci metto un minuto. Vendo qualche pasticca, e il minuto successivo ne vendo altre e sono altri 50. Dimmi, tu riesci a guadagnare trecento euro in mezza giornata?». Guido ha 17 anni, Guido non è il suo vero nome. Da quattordici settimane vive in una casa-famiglia alla periferia di Roma. Il Tribunale per i minorenni lo ha condannato ad un anno di reclusione per spaccio, ma i giudici hanno scelto di affidarlo ai servizi sociali affinché possa seguire un percorso educativo. Dovrebbe concludere il biennio della scuola dell’obbligo, e questo è lo scoglio minore. La faccenda più complicata è insegnargli a rispettare le regole della casa: pulire la stanza, lavare i piatti quando è il suo turno, smetterla di urlare bestemmie a Shamir, il ragazzo bengalese arrivato senza famiglia in Italia, e che ha ricevuto la notizia della morte della madre dagli operatori. Shamir è riservato e triste, il bersaglio perfetto del bullismo dei suoi coinquilini. Non sceglie mai quale programma guardare alla televisione, alla fine però si è entusiasmato pure lui per la versione 122 OUTLET OUTLET 123 REPORTAGE americana di X Factor e cerca di seguire la trama di film d’azione e thriller che qui vanno per la maggiore. Insieme con il wrestling. Come minore non accompagnato, deve studiare e attendere il diciottesimo anno d’età, quando gli toglieranno il permesso di soggiorno e avrà soltanto sei mesi di tempo per scongiurare lo status di clandestino. Perché nelle case-famiglia finiscono tre categorie di adolescenti: coloro che hanno compiuto reati come Guido, i migranti non accompagnati come Shamir e ragazzi strappati da genitori ai quali viene tolta la patria potestà come Valentino (la madre faceva prostituire le sorelle e il padre è irreperibile). Valentino potrà decidere di ristabilire un contatto con loro soltanto dopo i 18 anni. Eppure la voglia di dire almeno «ciao» alla madre è forte, nonostante tutto. Paradossalmente, gli operatori trovano più arduo instaurare una relazione con i ragazzi condannati per un reato, che per semplicità vengono chiamati “i penali”. «È molto difficile recuperarli. La maggioranza torna alla delinquenza non appena esce dalla casa famiglia. Specialmente i rom. Questo accade perché tutti, o quasi tutti, si danno al furto o allo spaccio in quanto il padre o la madre, o anche entrambi, sono coinvolti nella microcriminalità. Nel caso dei giovani dei campi nomadi non è soltanto tutta la famiglia a spingere verso il reato, bensì l’intero clan. Messi di fronte alla scelta di cambiare, i rom scelgono sempre il campo. Come gli altri, sono cresciuti senza capire che rubare un motorino è sbagliato, e che per vivere bisogna lavorare. Incredibilmente, è molto più semplice avviare una buona relazione e ottenere maggiori risultati con i ragazzi condannati a pene più alte, perché hanno l’opportunità di rimanere qui a lungo e accedere al percorso educativo con successo». Due mesi nella casa famiglia, insomma, non lasciano il segno. Un anno, invece, può essere un tempo utile. E i conflitti sono all’ordine del giorno. Gli ospiti sono sedicenni e diciassettenni pieni di energia, ormoni e rabbia. Litigano per un nonnulla, giocano pesantemente per ottenere il ruolo di leader, arrivano anche a darsele di santa ragione, a spaccare oggetti, ad insultare gli operatori. Succede ogni giorno. «È normale che vogliano sfogare la loro rabbia, ed è meglio che lo facciano nella casa famiglia piuttosto che altrove», osserva una operatrice tirocinante in psicologia. L’importante, dicono le persone che lavorano nella struttura, è contenere la loro smania distruttiva e l’unico modo «è guadagnare la loro fiducia» con la presenza costante e senza giudicare il loro passato. Quando due ragazzi cominciano a riempirsi di cazzotti, l’operatore deve intervenire senza rabbia, senza sentirsi un fallito perché avviene una rissa sotto i suoi occhi, deve avere l’autorità necessaria per chiedere loro di smetterla. A volte le botte non c’entrano. Fabrizio, per esempio, chiede continuamente vestiti nuovi, una marca di gel migliore, un paio di scarpe costosissime. Insiste dalla mattina alla sera, si lamenta che nella casafamiglia le lenzuola fanno schifo e che la televisione è troppo piccola. 124 OUTLET REPORTAGE Julian, invece, ha cominciato a rientrare tardi. Lo fa perché vuole rimanere più a lungo con la fidanzata, gli hanno spiegato che a mezzanotte i responsabili della casa-famiglia sono obbligati a comunicare alla questura l’eventuale assenza di un ospite. Questo però non riguarda i penali, che possono lasciare la struttura soltanto se accompagnati. Sono loro a finire nei guai quando scappano. Scappano perché non sopportano le regole della casa, scappano perché non credono che valga la pena conoscere meglio gli operatori, scappano come se evadessero. A quel punto intervengono nuovamente i giudici e ordinano la carcerazione, ovvero il fallimento. Gli operatori sono contenti quando i ragazzi capiscono che questa significhi veramente una opportunità e cominciano a fidarsi. La fiducia è durissima da conquistare, perché quando arrivano sono convinti di non valere nulla, di avere ricevuto il peggio, di essere cresciuti in famiglie sbagliate. «Tutti, quasi senza eccezione, sono nati da genitori pratici nella delinquenza. Non parliamo di disagio sociale puro e semplice, parliamo proprio di persone che vivono commettendo reati. È difficile incontrare un ragazzo che non abbia un padre ex detenuto, pregiudicato o una madre implicata in affari poco puliti». Eppure, questi adolescenti non metterebbero mai apertamente in dubbio la bontà della propria famiglia. Il conflitto è soprattutto intimo: devo o non devo accettare un nuovo modo di vivere? E se lo faccio, dovrò rinnegare i miei genitori? Spacciare o compiere furti negli appartamenti serve ad avere soldi facili da spendere immediatamente, ed è soltanto questo l’obiettivo. L’ultimo modello di I-phone, una ricarica da decine di euro per ascoltare musica dal cellulare, un nuovo taglio di capelli, scarpe da 200 euro che nel giro di qualche giorno vengono regalate al migliore amico perché sorge il bisogno insopprimibile di comperarne un altro paio, cene offerte, pasticche, discoteche di grido. «Noi, che prendiamo poche centinaia di euro al mese per vivere con loro, veniamo giudicati perdenti. Faticare è una ipotesi che raramente prendono in considerazione. Vogliono tutto e lo vogliono subito, ma questo accade perché pensano di valere meno di zero, e che non riuscirebbero a conquistare nulla se scegliessero di smetterla con i reati». Gianni sta cominciando a capire che può cavare qualcosa di buono dalla sua vita. È qui perché i genitori non si prendevano cura di lui, il resto non lo vuole raccontare. Nel giorno della consegna del diploma di terza media era così emozionato che ha saltato la colazione e fino al giorno successivo non ha toccato cibo. Dicono, gli operatori, che ha chiesto un paio di pantaloni buoni ed è rimasto chiuso in bagno molte decine di minuti prima di uscire con i capelli improvvisamente spioventi e non sparati in aria come al solito, e la riga laterale come quella di un bravo studente secchione. Gianni litiga spesso con Guido. Non si sopportano. A causa delle loro litigate, gli operatori sono stati costretti a sopprimere la paghetta OUTLET 125 REPORTAGE Laura Eduati Già inviata di cronaca per Liberazione, collabora per gli Altri. Si occupa di tematiche sociali. Nel 2011 ha pubblicato Stato d’Italia (Postcart ed.), volume che raccoglie i reportage di www.reportageitalia.it per due settimane di seguito. Una paghetta simbolica: 10 euro. «Se rompono qualche cosa, sanno che non riceveranno quei soldi finché non sarà ripagato l’intero importo dell’oggetto rotto. È una punizione. Ma non esiste invece il premio. Il premio è ottenere quello che spetta loro se si comportano bene: una certa elasticità da parte dei responsabili della casafamiglia, la facoltà di tornare un poco più tardi la sera, la disponibilità a tollerare alcune piccole mancanze in vista dell’educazione complessiva». Il messaggio è chiaro: il conflitto diminuisce man mano che accetti le regole della casa. Ed ogni rapporto è differente dall’altro. Dopo due mesi, sei mesi, un anno o tre anni, l’esperienza finisce. E questi bambini-ragazzi devono vedersela da soli. Shamir compirà diciotto anni il prossimo febbraio e piange se pensa che, dopo, non potrà contare su nessuno. Guido spesso provoca gli operatori urlando che tornerà a spacciare e che il suo problema non è vendere droga bensì una madre cattiva e manipolatrice (non usa il termine “manipolatrice”, ma quello è il significato), e certamente ha ragione. Valentino sa che non appena diventerà maggiorenne prenderà un autobus per andare a rivedere sua madre, ma non lo dirà alle sorelle che vivono sparpagliate negli istituti di accoglienza, perché non vuole ferirle. Intanto Maru, il ragazzo rom che era arrivato nella casa-famiglia perché condannato per furto negli appartamenti e poi tornato alla sua vita di sempre nel campo, ogni tanto arriva rombante con il suo motorino, gli occhiali Ray-Ban a specchio e le mèches nei capelli. Non ha ancora avuto il coraggio di parcheggiare, scendere e affacciarsi per salutare. Semplicemente percorre avanti e indietro la piccola strada che porta alla casa-famiglia, sperando che qualcuno si accorga della sua rumorosa presenza. 126 OUTLET RILETTURE CRITICHE RILETTURE CRITICHE Il gran rifiuto di Bianciardi lo scrivano NE LA VITA AGRA E NELL’AUTOBIOGRAFIA DEL SUO AUTORE, LA TRACCIA DI UNA LUCIDA DISUBBIDIENZA SPINTA FINO ALL’ESTREMO: IL MOMENTO IN CUI LO SCRITTORE TOSCANO, DISTURBATO DAL PROPRIO STESSO SUCCESSO, DISSE NO A MONTANELLI E AL CORRIERE DELLA SERA. di Katia Ippaso L e storie vanno lette tutte dalla fine. E bisognerebbe rinunciare a dire la propria se si è sicuri che non si arriverà a vederla, questa fine. Tutto il resto non è che opinione, commercio, spettacolazione. Sarà un punto di vista estremista, ma è di questo che qui stiamo parlando, di estremismo, di roccia non levigata che a occhio nudo non è facile scorgere, ancora più difficile comprendere. Ci si deve proprio sbattere la testa, per incontrarla. Arrivare alla fine del mondo. E da lì osservare il resto. Uno come Luciano Bianciardi, per esempio, ci è andato, alla fine del mondo, e non ha fatto neanche molta strada: un biglietto di sola andata Grosseto-Milano. Nella Milano dei miracoli che non sono quelli regalati da Totò il buono (il soggetto di Zavattini per il film di De Sica) ai suoi straccioni, ma i miracoli dei consigli d’amministrazione, degli imperi aziendali e editoriali, dei grattacieli che si alzano e inglobano le vite, una ad una, la Milano della indifferenza e del servilismo, ecco in quella Milano del boom economico un uomo arriva un giorno con la sua solenne incazzatura, sgobba giorno e notte per campare, scrive un libro che vorrebbe usare come una bomba ma un fragoroso applauso la disinnesca, fino a che la favola si trasforma da 128 OUTLET RILETTURE CRITICHE bianca in nera e tutti i riflettori si spengono, per accendersi su qualche nuovo prodigio da sacrificare sul marmo del grande banchetto intellettuale. Al funerale di Luciano Bianciardi c’erano in tutto quattro persone con i cappotti chiusi. Uno era Cesare Vacchelli. L’altro Sergio Pautasso: «Finché campo non dimenticherò lo squallore di quel funerale». Le altre due non se le ricorda nessuno1. Era il mese di novembre del 1971. Bianciardi aveva 49 anni. Ecco come muore un uomo che fino a qualche anno prima era stato incoronato re per via di un solo libro, La vita agra. Facile dire che sia morto di alcolismo, per autocombustione. Il referto medico – cerrosi epatica – dice la verità che si può dire. Altrettanto facile sarebbe quella diagnosi sociale che genericamente accusa coloro che non c’erano e l’avevano dimenticato in così poco tempo. Riaprire il “caso Bianciardi” ci aiuta invece a leggere diversamente quello che ci è successo. Perché in questo suo lento spaventoso “morire” («Sto crepando, ma ci metto troppo. Morire è difficilissimo, cosa devo fare? » diceva a Giovanni Arpino), cruda epifania del suo stesso vivere, si può osservare il disegno su carta di un dispositivo sofisticatissimo capace di annullare ogni capacità di conflitto: modello non plateale, condiviso, accettato e riprodotto su larga scala, che in questi cinquant’anni si è andato perfezionando al punto da cancellare il manuale d’istruzione che lo scrittore toscano stava, a suo modo, decodificando, ma il cui segreto ci ha lasciato intendere attraverso certe sue prove “testimoniali”: i suoi pochi, scarni, intimissimi libri che per nostra fortuna restano. Bianciardi muore dolorosamente, in silenzio, dopo aver assunto sulla propria pelle la deriva: esce di scena per sperpero totale di sé, per nausea, consunzione. Una morte interiore, correlativo di una vita interiore. E siamo dell’idea che a causa o in virtù del modo in cui se ne è andato, Bianciardi sia stato destinato a tornare dentro quel perimetro in cui lui voleva stare e che non in vita gli offrirono, lusingandolo in tutti i modi, di scavalcare. Sommessamente, la sua letteratura, la sua carica dinamitarda, ha finito con lo scomparire, e sopravvivere solo tra i cultori, diciamo i collezionisti. La sua figura d’anarchico disobbediente non è rimasta nell’immaginario collettivo, al pari, per esempio, di quella di Pier Paolo Pasolini, che è finito in quell’altro e speculare modo: ucciso da morte violenta. E se conforta pensare che gli sia stato risparmiato l’aggettivo “branciardiano” da appiccicare ai seguaci e agli imitatori – destino che invece è toccato ai “pasoliniani”, che ancora si contendono l’eredità per esporre il titolo sui loro altari cultural-nobiliari –, al tempo stesso impressiona vedere come il nitore intellettuale con cui questo scrittore di provincia (individuo umbratile, intrattabile, ironico, inassimilabile a nessun partito o sistema o casa o famiglia) ha visto e nominato l’orrore conradiano celato dietro la patina della criminale apatia giornaliera, si sia OUTLET 129 RILETTURE CRITICHE confuso e disperso nella nebbia milanese – metonimia dell’Italia produttiva e torva – dentro la quale finì i suoi giorni: nebbia falsa come tutto il resto. La chiamano nebbia. Se la coccolano, te la mostrano, se ne gloriano come di un prodotto locale. E prodotto locale è, solo non è nebbia2. Ma lui in fondo ne sarebbe stato fiero di questo oblio, di questa clamorosa svista, consapevole del fatto che quando un aggettivo prende il posto di un nome non può rimanere niente dell’uomo che quel nome porta e della sua indomabile, purissima rabbia: L’aggettivo agro sta diventando di moda, lo usano giornalisti e architetti di fama nazionale. Finirà che mi daranno uno stipendio solo per fare la parte dell’arrabbiato3. Già con Il lavoro culturale (1957) e L’integrazione (1959) Bianciardi aveva nutrito con una scrittura piana la sua visione implacabile, ironica, beffarda, di quella classe intellettuale italiana che avrebbe assimilato ogni vita dissenziente. Riavvolgendo il nastro della memoria, ripartiamo allora da là dove tutto è cominciato: la vita di provincia a Grosseto, i cineclub dalle fazioni divise tra eruditi, archeologici e giovani iconoclasti, questi ultimi innamorati della città stessa, della sua allargata e sbilenca spirale che dal centro si irradiava in periferia. È qui che incontriamo gli austeri funzionari di partito, i professori miopi e razzisti, i professionisti delle conferenzespettacolo, i “noti critici”, i manichini del “lavoro culturale” che si equivalgono tutti e vanno ad un certo punto sostituiti, con solennità meccanicistica, usando alcune parole d’ordine: “elemento”, “organizzazione”, “lavoro di massa”: «E Martini è al lavoro culturale?». «No, è al lavoro di massa, al posto di Gianni. Gianni va alla pace e Giorgetti alle cooperative. All’organizzazione resta Stefano». «E al lavoro culturale? Per ora nessuno. Poi manderanno un elemento del meridione, credo».4 Per descrivere questo processo di assimilazione, Bianciardi ricorse all’artificio retorico dello sdoppiamento. Procedimento che volle ripetere con L’integrazione, lasciando all’immaginario fratello Marcello il compito di rappresentare il rifiuto delle regole marce della produzione e riservando a Luciano l’accettazione ai fini della sopravvivenza. La questione della sopravvivenza – e quindi del ricatto del lavoro – è la 130 OUTLET RILETTURE CRITICHE questione cruciale anche de La vita agra, dove il personaggio si riunisce in un solo corpo e un solo nome, aderendo quasi perfettamente alla vita che lo stesso Bianciardi fece a Milano, quando, semplicemente campando, si fece testimone e quasi complice di un massacro invisibile, senza sangue: In questi anni ho visto tre amici miei morire, due suicidi. Credi che qualcuno abbia pianto? No, li hanno scancellati, li hanno dimenticati il giorno dopo5. Certo, se hai bisogno di una mano qualcuno te la dà. Ma prima fa il conto: vuol sapere se tirandoti a galla, domani tu sarai in grado di dare una mano a lui. Altrimenti ti lasciano tranquillamente affogare […] Non c’è solidarietà, solo omertà, cricca, mafia, società d’affari6. Ma Bianciardi non si limitò a vedere l’orrore fuori di sé. Scrivendo La vita agra, parlò inesorabilmente di se stesso, della tentazione forte di complicità che sfiora un lavoratore culturale qualsiasi che ad un certo punto si mette per esempio (come fece lui) a fare il traduttore e lo scrittore per mantenere se stesso e le sue due famiglie. Infiacchendosi ogni giorno di più e arrivando fino al punto da veder scomparire ogni traccia di quella suprema incazzatura di chi avrebbe dovuto (nella finzione) far saltare il «il torracchione di vetro e cemento», per vendicare i 43 minatori morti ammazzati a Ribolla, la miniera di lignite della Montecatini che esplose il 4 maggio 1954, e su cui Bianciardi scrisse il reportage I minatori della Maremma: La missione mia era questa. Far saltare tutt’e quattro i palazzi e, in ipotesi secondaria, occuparli, sbattere fuori le circa duemila persone che ci lavoravano, chine sul fatturato, sui disegni tecnici e sui testi delle umane relazioni, e poi tenerli a disposizione di altra gente […] Toccava a me7. Nessun minatore verrà però mai vendicato. La realtà delle morti consegnate dai padroni si sbiadisce nel ritmo indifferente dei giorni di efficiente produzione, mentre avanza il lento, notturno inesorabile morire dello scrittore (e del suo alter ego). Preso nell’affare della sopravvivenza, del lavoro servile/culturale e del successo che deriva dalla macchina celibe dell’integrazione, la più sofisticata produttrice di morte al lavoro. La pubblicazione de La vita agra (1962)8 e la risposta immediata che ne seguì, avrebbero fatto felice qualsiasi scrittore: tutti, tranne Bianciardi. Dopo aver scritto un elzeviro zeppo di vocaboli anestetizzati e fuorvianti («La vita agra è uno dei libro più belli, più vivi, più stupefacente, più pittoreschi che io abbia letto negli ultimi anni»), Indro Montanelli offrì OUTLET 131 RILETTURE CRITICHE RILETTURE CRITICHE Katia Ippaso Giornalista e scrittrice di teatro. Tra le sue pubblicazioni: il romanzo Nell’ora che è d’oro (Giulio Perrone Editore), e i libri-reportage Le voci di Santiago e Amleto a Gerusalemme (Editoria e spettacolo). Lavora per gli Altri e fa parte della redazione di Alternative per il socialismo. allo scrittore toscano un mucchio di soldi per iniziare una collaborazione con Il Corriere della sera. Bianciardi ci pensò tre giorni. E poi disse no. Si, proprio così: rifiutò la collaborazione con Il Corriere. Avevo scritto un libro incazzato e speravo che si incazzassero anche gli altri. E invece è stato un coro di consensi, privati e pubblici9. Il mondo va così, cioè male. Ma io non ci posso fare nulla. Quel che potevo l’ho fatto, e non è servito a niente. Anziché mandarmi via da Milano a calci nel culo come meritavo, mi invitano a casa loro10. Non ricordiamo, a memoria, un gesto più sovversivo di questo negli ultimi cinquant’anni di vita culturale italiana. Il rifiuto di Bianciardi al Corriere della Sera è, per quanto ci riguarda, la cosa più vicina alla disobbedienza di Bartlebly lo scrivano (il protagonista del racconto di Melville), a quella sentenza scavata nella pietra, I would prefer not to, che racchiude il nocciolo duro di ogni resistenza umana, il segreto di un uomo irriducibile alla tirannia della produzione e del lavoro, uno che piuttosto si lascia morire ma non collabora. Chi sarebbe oggi in grado di fare, oltre Bartlebly appunto, un gesto simile? Naturalmente, la cosa non finì lì. Bianciardi rifiutò Il Corriere ma accettò di scrivere per Il Giorno e, curiosamente, anche per Abc, Kent, Executive, L’Automobile e Playmen. Andò per un po’ a feste e presentazioni ufficiali, ma presto si ritirò per dedicarsi solo all’alcol. Simile a Bartlebly, che decise di abbandonare ogni attività e lasciarsi morire senza dare spiegazioni. Di Bianciardi, che non è un personaggio letterario, noi conosciamo però anche l’origine, il punto di partenza, quella clamorosa incazzatura che lo portò a testimoniare, a scrivere, a dire fermamente, come disse nella Vita agra, «Io mi oppongo!». Perché in quelle pagine, scritte orami cinquant’anni, c’è la pulsazione più autentica di un disubbidiente che 132 OUTLET decise di non collaborare (Preferirei di no, appunto), assumendo sul suo stesso corpo, corpo vivente e corpo morente, il sogno di un «neocristianesimo a sfondo disattivistico e copulatorio». Con trenta omicidi ben pianificati io ti prometto che farei il vuoto in Italia. Ma il guaio è il dopo, perché in quel vuoto si ficcherebbero automaticamente altri specialisti della dirigenza. […] Lo so, sarebbero più onesti, più seri, ma per ciò appunto più pericolosi. Farebbero crescere le medie, sul serio, la produttività, i bisogni mai vista prima. E la gente continuerebbe a scarpinare, a tafanarsi, più di prima, a dannarsi l’anima […] La rivoluzione deve cominciare da ben più lontano, deve cominciare in interiore homine. Occorre che la gente impari a non muoversi, a non collaborare, a non produrre, a non farsi nascere nuovi bisogni, e anzi rinunziare a quelli che ha […] E un giorno saranno loro, gli attivisti, a ridursi in un’isola; poche decine di longobardi febbrili aggrappati a rotelle e volani, con gli occhi iniettati di sangue […]. Il problema del tempo libero non si porrà più, essendo la vita intera una continua distesa di tempo libero […]. Scomparsa la carta, non avremo né monete né giornali né libri […]. Cessato ogni rumore metalmeccanico, suonerà dovunque la voce dell’uomo e della bestia […]. Non esistendo la famiglia, i rapporti sessuali saranno liberi, indiscriminati, ininterrotti e frequenti, anzi continui […]. Nell’attesa che ciò avvenga, e mentre vado elaborando le linee teoriche di questo mio neocristianesimo a sfondo disattivistico e copulatorio, io debbo difendermi e sopravvivere11. note Come ricostruisce Pino Corrias in Vita di un anarchico (Feltrinelli 1993). 2 Luciano Bianciardi, La vita agra (Rizzoli 1962, Bompiani 1995/2012). 3 Cosi scriveva Bianciardi ad un amico nel 1962. 4 Luciano Bianciardi, Il lavoro culturale (Feltrinelli 1957), p.64. 5 Dalla lettera dell’aprile 1961 a Mario Terrosi. 6 ibidem. 7 Luciano Bianciardi, La vita agra, cit. p.41. 8 Due anni più tardi, nel 1964, Carlo Lizzani filmà la versione cinematografica del libro, protagonista Ugo Tognazzi. 9 Lettera alla sorella, 14 dicembre 1962 10 Lettera a Terrosi. 11 L. Bianciardi, La vita agra, pp.158-163. 1 133 RILETTURE CRITICHE Se agli anni di piombo manca il piombo DA MALEDETTI VI AMERÒ A ROMANZO DI UNA STRAGE, UNA RILETTURA DELL’OPERA DI MARCO TULLIO GIORDANA. PUR ISPIRANDOSI A PETRI, IL CINEASTA MILANESE TENDE AD UNA RICOSTRUZIONE CONFUSA E INNOCUAMENTE DIDATTICA DELLA STORIA RECENTE. UNICA ECCEZIONE I CENTO PASSI. di Fabrizio Violante I n una lontana intervista Elio Petri affermava che fare un film politico «significa affrontare un tema politico, non in senso elettoralistico, naturalmente, di propaganda per un partito o per l’altro, ma studiare la struttura di una situazione politica, di un avvenimento politico, rivelandola allo spettatore, dal momento che è politica tutto ciò che riguarda la nostra vita di ogni giorno, e che ci condiziona». Non sono pochi gli autori che nel nostro cinema si sono mossi in questa direzione e tra questi, almeno nelle intenzioni, il regista milanese Marco Tullio Giordana sembra proprio aver fatto sua la lezione di Petri. Giordana è da sempre interessato ai conflitti sociali e politici, alle insofferenze generazionali, ai traumi della storia patria degli ultimi quarant’anni e nei suoi film si è dato il non facile compito di restituirli alla memoria. Il suo è quindi un cinema appassionato e utile, anche se discontinuo, nel senso che soffoca spesso la ricostruzione nell’emotività, nel ricatto sentimentale, nella insopportabile ricerca della pacificazione della rabbia. 134 OUTLET RILETTURE CRITICHE Prendiamo in considerazione i due film che costituiscono gli estremi (almeno per ora) della sua carriera cinematografica, l’esordio di Maledetti vi amerò (1979) e l’ultimo Romanzo di una strage (2012). In mezzo ci sono il deludente La caduta degli angeli ribelli (1981) – melodramma ambizioso quanto vacuo, che racconta un’improbabile storia di amour fou tra un terrorista in crisi e una borghese stanca delle convenzioni –, il tonfo di Appuntamento a Liverpool (1988) – insostenibile storia di vendetta di una giovane donna che ha perso il padre negli scontri tragici allo stadio Heysel di Bruxelles –, Pasolini, un delitto italiano (1995) – sentita ma poco incisiva ricostruzione del processo per l’omicidio di Pier Paolo Pasolini. Il più maturo I cento passi (2000) – che rievoca la vita e l’assassinio di Peppino Impastato –, seguito dal “rullipetragliano” La meglio gioventù (2003) – agiografico e sopravvalutato film fiume (sei ore, pensate in realtà per la messa in onda televisiva) che omaggia gli spiriti più positivi che hanno animato una generazione maltrattata dalla storia – e, infine, Quando sei nato non puoi più nasconderti (2005) – inutile dichiarazione filmica al buonismo terzomondista. Film, come si vede, spesso modesti, seppur giusti nella volontà di fare i conti con le vicende di un Paese che ha festeggiato il suo primo secolo e mezzo di storia, ma che rimane ancora fondamentalmente immaturo. Maledetti vi amerò (1979), che nelle intenzioni del suo autore doveva rappresentare una inedita, lucida presa di coscienza dei fallimenti della generazione della contestazione a dieci anni dai furori del ’68, è interessante nello spunto di partenza, ma più banale e sfilacciato nello svolgimento, che sconta le poche idee di sceneggiatura e i tanti, troppi luoghi comuni in cui spesso inciampano i dialoghi. Al centro della vicenda un giovane militante della rivoluzione mancata che, espatriato per un lustro in America latina, ritorna finalmente nella sua Milano. Renato Svitol, questo l’ironico e significativo nome del protagonista (che ha la faccia giusta e stropicciata di Flavio Bucci), si ritrova in una realtà inevitabilmente più complessa di quella che si era lasciato alle spalle, in un Paese confuso, macerato da fenomeni che sembrano incontrollabili come il terrorismo e la droga. Lo sguardo del regista si solidifica in quello di Svitol, che in più scene guardiamo sfogliare, non si capisce bene se più annoiato o sconcertato, la stampa degli ultimi anni, eco e memoria delle lotte, delle stragi, dei morti di eroina, degli assassini di Pasolini e di Moro: decine di cadaveri della storia recente che l’uomo ricalca su fogli bianchi, tracciando a matita i contorni di fantasmi che dalla sua distanza appaiono tutti uguali. Il protagonista è come il veterano di una guerra perduta, che ritrova ma non riconosce più i vecchi compagni, tutti ormai mollemente adagiati tra le braccia di un conformismo borghese che stride insopportabilmente con le tensioni ideali e i conflitti trascorsi. Non trovando requie nella società del riflusso, inviluppato nella ricerca di una nuova identità che non riesce a OUTLET 135 RILETTURE CRITICHE dargli senso, Svitol sceglie allora un ultimo gesto esemplare, lasciandosi “suicidare” per mano armata della sola persona che gli ha fin lì offerto uno scampolo di sincera solidarietà, il poliziotto che nella prima scena lo aveva interrogato al suo rientro in Italia. Patetico e gratuito il finale, con il corpo esangue del protagonista, in un’alba romana distratta e solitaria, a pochi passi dai luoghi del ritrovamento del cadavere di Moro. Svitol non ha saputo darsi altro destino che quello della ennesima vittima di una violenza senza attenuanti. Giordana sfoglia confusamente le pagine della storia italiana recente, che pure ha vissuto sulla propria pelle, dimostrando idee sincere ma anche, e questo sarà sempre il difetto del suo cinema, l’incapacità di aggredire la carne viva dei tempi e dei protagonisti che mette in scena, stemperando conflitti e rabbie in una narrazione che accumula senza emozione (e senza convinzione, soprattutto dello spettatore) ironia e melodramma, citazioni cinefile e letterarie, domande e nessuna risposta. Troppo attento a non prendere posizioni aprioristiche, sacrifica la forza dei personaggi, svilisce la ribellione nell’espiazione autodistruttiva. Tensione tematica e narrativa non sempre collimano, così il film si ingolfa più volte tra battute sarcastiche e sottolineature liriche fin troppo enfatiche. In bilico tra registri diversi, il regista idealizza il passato nel deserto del presente, cura i dolori con le nostalgie, suicida emblematicamente la propria generazione nella figura del protagonista (come fu detto da certa critica coeva) e si ritrova incredibilmente premiato al festival di Locarno. Romanzo di una strage è invece la prima ricostruzione sul grande schermo della madre di tutte le stragi, prima tappa di quella strategia della tensione che tanto compromise la vita pubblica italiana, “liberamente” interpretata (romanzata, appunto) dagli sceneggiatori (ancora, ahinoi, Rulli e Petraglia) e dal regista. Pur lasciando da parte l’opinabilità della fonte – l’indagine giornalistica di Paolo Cucchiarelli, che propone la tesi della doppia bomba –, quello che proprio non ci piace del film è che, nonostante le trame e gli intrighi che portarono all’attentato e ai morti di piazza Fontana a Milano, e le complicità e i depistaggi che accompagnarono le indagini grondassero sangue e mistero quanto e più di un romanzo pulp, gli autori abbiano preso finalmente in mano una materia tanto incandescente per trarne poi niente più che una pellicola didascalica, buona solo per un dibattito scolastico. Il film parte dall’esplosione nella Banca Nazionale dell’Agricoltura del 12 dicembre 1969 e si conclude con l’omicidio del commissario Calabresi il 17 maggio 1972. Al centro della narrazione proprio il personaggio del commissario (cui dà corpo un fin troppo trattenuto Valerio Mastandrea), ritratto al di là di ogni giudizio ideologico, come un integerrimo funzionario dello Stato che, scosso dalla morte tragica dell’anarchico Pinelli, matura una sempre più imbarazzante insofferenza verso il proprio ruolo. Il Calabresi “inventato” dal film scopre la verità sulla strage, la verità sulle 136 OUTLET RILETTURE CRITICHE Fabrizio Violante Architetto e critico cinematografico, si interessa del rapporto tra la settima arte, l'architettura e le dinamiche urbane. Autore di saggi e articoli di architettura e di cinema, è redattore di riviste di settore, nonchè del sito www.archphoto.it. Ha collaborato a ricerche e corsi universitari di Sociologia urbana, promuove attività culturali ed editoriali e ha partecipato, in veste di critico e giurato, a numerosi festival cinematografici. complicità degli organi del Potere e confessa alla moglie di voler lasciare la polizia. Anche Moro è rappresentato nella doppiezza lacerante della consapevolezza della verità e dell’asservimento alla ragione di Stato, così come Pinelli, saldo nel suo rifiuto della violenza ma vacillante di fronte all’ostilità dei suoi compagni. Per centoventisei minuti la pellicola alterna così fatti reali e ricostruzioni realistiche nel tentativo dichiarato di spiegare ai più giovani cosa successe in quei giorni infausti a cavallo degli anni Sessanta e Settanta. Certo, un film non può che essere un’interpretazione immaginaria della realtà, e non si può certo accusare Giordana per aver scelto la forma del romanzo (il punto di partenza esplicito è il celebre articolo pasoliniano Il romanzo delle stragi), semmai al contrario gli imputiamo proprio di non essere stato abbastanza romanzesco, di non emozionare cioè. La sua sincerità artistica e morale imprigiona il film in un’oggettività troppo programmatica, così la “riproduzione” degli anni di piombo manca appunto del piombo, della carne e del sangue, della rabbia che animava quell’epoca di conflitti esasperati, cedendo tutto lo spazio alla funzione “didattica”. I suoi personaggi non hanno corpo, né metaforico né simbolico, ma solo un destino tragico che tutti già conosciamo. Eppure, al di là delle critiche, se è vero che la distruzione della memoria è il più efficace passo verso il baratro dell’incapacità di dare senso al presente, di decifrare la propria identità civile, non possiamo che accontentarci anche dei tentativi di Giordana, in attesa di un cinema che sappia finalmente essere “politico”, nel senso migliore che hanno saputo dare al genere autori come Rosi e Petri. OUTLET 137 CONFRONTI Dormire nel lettone fa bene IN CONFRONTO CON IL TEMA INTRODOTTO DA LAURA EDUATI NEL PRECEDENTE NUMERO DI OUTLET 1, DOVE SI RACCONTAVA LA CRESCENTE TENDENZA DELLE MADRI A DORMIRE CON I PROPRI FIGLI (ANCHE ADOLESCENTI) ALLONTANANDO I PADRI DALLA SFERA INTIMA, SI PONE QUI IN PRIMO PIANO IL FENOMENO DEL CO-SLEEPING, PRATICA ACCREDITATA DALLA COMUNITÀ SCIENTIFICA PEDIATRICA. di Simona Bonsignori CONFRONTI M i piace confrontarmi con il pezzo di Laura Eduati, Se le mamme dormono con i figli, apparso sullo scorso numero di Outlet, per evidenziare che il co-sleeping, fenomeno niente affatto italiano, è ormai una pratica sdoganata dalla comunità scientifica pediatrica e psicopedagogica occidentale. E’ vero che esiste un tabù culturale sul dormire con i figli, eppure fino a non molti anni fa il problema non si poneva neppure; la questione sembra più appartenere alle società ricche dove il privilegio sta nell’avere uno spazio tutto per sé. Come si dormiva, infatti, all’inizio del secolo scorso? Come si dorme in altre parti del mondo? Infine, come dormono i cuccioli? Insieme. L’antropologia non ci insegna come il sonno condiviso sia presente in tutti i mammiferi per la tutela della sopravvivenza della specie? Esistono molti studi che dimostrano che dormire insieme ai figli è un investimento nel loro futuro, mentre nessuno sembra provare il contrario. Abituare i bambini a dormire da soli, infatti, è un’usanza moderna, retaggio di una cultura ottocentesca decisamente orientata all’adulto maschio (famiglia patriarcale con educazione dei figli molto rigida). E se nelle classi più povere dormire insieme era una necessità, in quelle più abbienti i figli semplicemente non dovevano interferire con la vita degli adulti e venivano affidati alle cure di terzi. OUTLET 139 CONFRONTI Lo sviluppo degli studi sull’infanzia ha, però, evidenziato che la cultura del distacco e della divisione degli spazi, tanto cara a Freud, non considera che per diventare adulti autonomi si deve passare da un’infanzia di dipendenza e cura. Il tempo necessario sarà quello della crescita. Occorre dunque abbandonare luoghi comuni: è importante tener conto che i traguardi di autonomia sono obiettivi dei bambini, non dei genitori. La forzatura degli adulti può, infatti, essere vissuta come trauma: dormire da soli, togliere il pannolino, stare fermi a tavola. Se ci concedessimo il tempo dell’osservazione e dell’attesa, ci accorgeremmo di quante istanze verso l’autonomia ci pongono loro istintivamente. E sono certamente di più di quelle che noi adulti siamo in grado di gestire! Al contrario, di fronte a un bambino “educato” ci chiediamo mai se quel comportamento è frutto della sua esperienza, delle sue istanze di autonomia – “faccio da solo” –, oppure rappresenta l’accettazione passiva di una regola non compresa? Secondo una ricerca della Stony Brook University di New York, pubblicata sulla rivista Pediatrics nel 2011, non ci sarebbe nessuna differenza comportamentale tra chi ha dormito solo o con i genitori. La sensazione di protezione che deriva dalla loro presenza è un calmante formidabile contro le ansie che si affacciano nella vita dei piccoli. E i bambini fanno sogni d’oro. Ma c’è di più. Lo sostiene Margot Sunderland, una delle massime autorità in materia di psicologia infantile e direttrice del Center for Child Mental Health di Londra, la prima ad andare contro la scuola di pensiero dominante per aver preso una posizione netta sul co-sleeping. Nel 2006, la ricercatrice ha pubblicato uno studio (Margot Sunderland The Science of Parenting), reso possibile anche dai progressi compiuti negli ultimi vent’anni sulla conoscenza dello sviluppo del cervello dei bambini, in cui dimostra che da soli i piccoli accumulano ansia e stress mentre dormire nel lettone rende più probabile che essi diventino degli adulti calmi, sani ed emotivamente equilibrati. E consiglia: «Lasciateli dormire con voi fino a cinque anni». Anche Thomas Berry Brazelton, un altro notissimo pediatra americano, è convinto che la nostra cultura, nell’ignorare la titanica impresa di crescere, sia troppo esigente nel chiedere a un bambino di imparare a dormire da solo. Eppure, oggi va per la maggiore il metodo Estivill (Fate la nanna, di Eduard Estivill e Silvia De Béjar). Un libro di pazzi, non leggetelo. È un programma di condizionamento per costringere il piccolo ad addormentarsi da solo e, dopo giorni di pianti estenuanti, alla fine ci si riesce, ma a quale prezzo? Il bimbo sarà talmente esausto da rinunciare per abbandono. Ma quando un bambino piange comunica un disagio, fa il suo mestiere. E ha il diritto di vedere appagato il suo bisogno perché se non trova risposta sperimenta abbandono e paura. Dunque dormire nel lettone fa bene, non provoca disagi psicologici nel bambino né incide sul suo sviluppo psicologico e relazionale, anzi, quest’armonia aiuta persino la madre nella produzione del latte. Ma quanto la presenza dei figli nel lettone condiziona la vita di coppia? 140 OUTLET CONFRONTI Simona Bonsignori Giornalista, dirige la manifestolibri, casa editrice de il manifesto. Scrive sulla rivista Leggendaria. La vicinanza notturna è da anni contestata da un’altra “corrente” di psicologi e medici che accusano il co-sleeping di minare la stabilità della coppia privandola dell’intimità. È coerente con questo una certa moda attuale che considera i bisogni dei bambini secondari rispetto a quelli dei genitori, in nome della serenità della coppia. Eppure il bisogno di contatto non appartiene anche all’adulto, appunto? Allora dormire insieme come può causare disagio familiare e relazionale? Anche il grande zoologo ed etologo Morris invita le madri, in uno dei suoi libri (Desmond Morris, Baby, 2008), a imitare il comportamento animale e a dormire con i propri piccoli per soddisfare meglio i loro bisogni, con buona pace di Freud. Negli anni Settanta abbiamo destrutturato la famiglia, scardinato i ruoli (Divorzio, L. 898/1970 detta Fortuna-Baslini), attribuito diritti e doveri a chi non li aveva (Riforma del diritto di famiglia, L.151/1975). Anche la maternità non è più stata un destino (L. 194/1978 sull’interruzione volontaria della gravidanza) ma una scelta (contraccezione). A questo punto spuntava la “coppia nuova”, individualista e temporanea, non più vincolata a un progetto ma tenuta insieme da complicità e affinità sempre più spesso sostituite da programmi (cosa fare il weekend, con chi trascorrere le vacanze, dove e se abitare insieme ma sempre in via provvisoria). Insomma, negli ultimi 40 anni i rapporti di coppia sono radicalmente mutati, divenendo sempre più liberi ma anche disimpegnati. La coppia, oggi, non ha come orizzonte primario né la famiglia né, tantomeno, la procreazione – la cui istanza si trasforma spesso nella crisi della relazione stessa –, ma non si esaurisce neppure nella sessualità e nei sentimenti. Mi azzardo a dire che è un’esperienza che si consuma con l’evento che l’ha generata se non segue un progetto. Spesso, dunque, il figlio diventa quel progetto mancante ma, tante volte, è troppo o troppo tardi. Per questo non caricherei la responsabilità della perdita dell’intimità alla presenza dei figli nel lettone. Se è vero che, spesso, la coppia ha già esaurito tutti gli altri espedienti per rimanere tale. Certo è importante che questa ospitalità non sia vissuta come una rinuncia, perché allora comprometterebbe il benessere di tutti. Certamente una formula universale non esiste. Dormire nel lettone per crescere bene non è necessario, ma è importante sapere che non è dannoso. note 1 Il reportage di Laura Eduati, Se le mamme dormono con i figli, si può leggere anche sul nostro sito: www.outletrivista.it OUTLET 141 Per una critica alla ideologia italiana Per una critica alla ideologia italiana Finito di stampare nel mese di settembre 2012 Editore Queer s.r.l. Sede legale Via Ravenna 34, 00161 Roma Stampa Iacobelli Srl, Roma Distribuzione Italia Press-di Registrazione al Tribunale di Roma N. 209/2009 del 18 Giugno 2009 visita outletrivista.it glialtrionline.it ALTRI MARCO BASCETTA/ALAIN BERTHO/SIMONA BONSIGNORI/GUIDO CALDIRON MONIA CAPPUCCINI/ALESSIO CECCHERELLI/CARLO CELLAMARE ANDREA COLOMBO/ROBERTO DE ANGELIS/MASSIMILIANO DI FRANCA LAURA EDUATI/LUCA FONDACCI/MASSIMO ILARDI/KATIA IPPASO GIUSEPPE MANFRIDI/CHRISTIAN PIANA/EMILIO QUADRELLI ENZO SCANDURRA/ALBERTO SPERONI/CAROLA SUSANI FEDERICO TOMASELLO/LUISA VALERIANI/FABRIZIO VIOLANTE PAOLO VERNAGLIONE ALTRI COMPIEGHE n° 2 Non vendibile separatamente dal settimanale gli Altri in edicola Direttore responsabile Piero Sansonetti Prezzo Outlet euro 5,00 settimanale gli Altri escluso Prezzo Outlet + settimanale euro 7,00
Scaricare