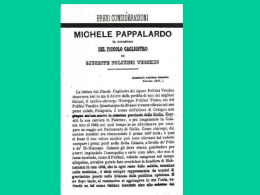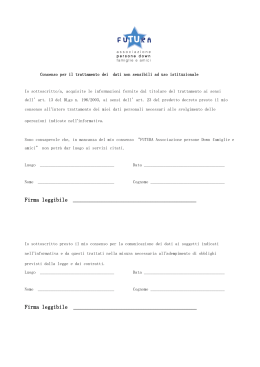1 RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE Indice 1. TEST HIV - CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 2468/2009 Pag. 2 2. TRIB. ROMA SEZ. II, 21-07-2009 DIAGNOSI TARDIVA, VIOLAZIONE DEL CONSENSO E RISARCIMENTO DEL DANNO pag. 4 3. TRIB. SALERNO, SEZ. II, 12 AGOSTO 2011, N. 1689. IL CONSENSO INFORMATO NON E' NECESSARIO PER I TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI" pag.6 4. TRIB. VERONA 10.01.2011 - SE NON MI INFORMI MI RISARCISCI (all’esito di una prognosi postuma) pag. 7 5. Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2009, n. 20806 - "NELLA "ROUTINE" SOLO L'IMPREVISTO SOLLEVA IL MEDICO DALLA RESPONSABILITÀ" pag. 11 6. CASSAZIONE CIVILE , SEZ. I, SENTENZA 16.10.2007 N° 21748 - DIRITTO ALLA VITA – EUTANASIA – LEGITTIMITÀ - LIMITI pag. 13 7. CASSAZIONE CIVILE , SEZ. III, SENTENZA 15.09.2008 N° 23676 MEDICO, OPERAZIONE, CONSENSO DELLA VITTIMA, TESTIMONE DI GEOVA, NECESSITÀ pag. 31 8. CASSAZIONE, SEZIONE III CIVILE, SENTENZA 10 GENNAIO - 2 OTTOBRE 2012, N. 16754 DANNNI CIVILI - NASCITA INDESIDERATA DI MINORE MALFORMATO - OMESSA INFORMAZIONE DA PARTE DEL MEDICO CIRCA PIU' EFFICACI ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI PRENATALI - RESPONSABILITA' - SOGGETTI DANNEGGIATI pag. 37 9. CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE SENTENZA 28 LUGLIO 2011, N. 16543 pag. 67 10. TRIBUNALE DI BARI, SECONDA SEZIONE CIVILE, SENTENZA, n. R.G. affari contenziosi 2576/2004 pag. 79 LA DECISIONE CHE FISSA I CRITERI RISARCITORI – CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, 9.2.2010, N. 2847 pag. 82 11SS 11 2 1. TEST HIV - CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 2468/2009 Consenso Informato e sieropositività Anche nei casi di necessità clinica, il paziente deve essere informato del trattamento a cui lo si vuole sottoporre, ed ha il diritto di dare o di negare il suo consenso, in tutti i casi in cui sia in grado di decidere liberamente e consapevolmente; si potrebbe prescindere solo nei casi di obiettiva e indifferibile urgenza del trattamento sanitario, o per specifiche esigenze di interesse pubblico (rischi di contagio per i terzi, od altro). Svolgimento del processo: Con atto di citazione notificato il 30.9.1997 A. V. ha convenuto davanti al Tribunale di Perugia il prof. L. C. e l’Azienda SSL … omissis … della Regione Umbria, chiedendo il risarcimento dei danni nella misura di lire 1 miliardo perché - essendo stato ricoverato il … omissis … presso l’Ospedale … omissis … per un forte attacco febbrile con diagnosi di leucopenia - era stato sottoposto al test anti-HIV, senza che gli fosse stato richiesto il consenso. Il test, eseguito senza rispettare l’anonimato, aveva dato esito positivo e la cartella clinica - recante anche la registrazione di dati sensibili non rilevanti, fra cui la sua omosessualità - era stata custodita senza alcuna riservatezza, sì che le notizie relative alla sua salute si erano diffuse all’interno e all’esterno dell’Ospedale, con suo grave pregiudizio personale e patrimoniale, considerato che, di conseguenza, egli aveva anche dovuto chiudere la sua attività commerciale. I convenuti hanno resistito alla domanda, affermando di avere agito nell’esclusivo interesse del paziente, al fine di giungere al più presto alla diagnosi per intraprendere la terapia necessaria; che l’esecuzione del test senza il preventivo consenso del paziente si era resa necessaria; tanto che, se egli non avesse acconsentito, gli si sarebbe dovuto rifiutare il ricovero o si sarebbe dovuta chiedere alle competenti autorità l’autorizzazione al trattamento sanitario obbligatorio. Hanno affermato che l’anonimato è richiesto solo nei casi di indagini epidemiologiche; che la cartella clinica era stata conservata in sala infermieri e che era nota al solo personale medico e infermieristico. Il Tribunale di Perugia ha respinto la domanda e la Corte di appello di Perugia ……omissis)… ha respinto l’appello….(omissis)… …(omissis) …il V. propone ricorso per cassazione … Afferma il ricorrente che l’art. 5, 3° comma, legge n. 135/1990 cit. - secondo cui nessuno può essere sottoposto a test anti HIV senza il suo consenso, “se non per motivi di necessità clinica, nel suo interesse” - va interpretato nel senso che si può prescindere dal consenso del paziente solo nei casi in cui egli sia del tutto impossibilitato a prestarlo; che solo tale interpretazione è in linea con quella della Corte costituzionale - secondo cui gli accertamenti sanitari che comportano prelievi ed analisi trovano un limite invalicabile nel rispetto della dignità e della riservatezza della persona che vi è sottoposta (sentenza n. 218 del 1994) - e con le analoghe disposizioni del Garante della privacy e dei principi della deontologia medica. Ove egli fosse stato informato, avrebbe potuto disporre che il test venisse eseguito presso altro Ospedale, in luogo, in cui non fosse conosciuto, considerato che non vi era alcuna urgenza di procedervi. ………(omissis)….Il motivo è fondato. Va condivisa l’opinione del ricorrente secondo cui la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 5, 3° comma, legge n. 135/1990 porta a ritenere che il consenso del paziente al test HIV - così come ad ogni altro trattamento a cui debba essere sottoposto - deve essere richiesto in ogni caso in cui ciò sia possibile, senza pregiudizio per le esigenze di cura del paziente stesso o per la tutela dei terzi. Ed invero, se nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, salvo espressa disposizione di legge (art. 32 Cost.), il malato ha il diritto di essere preventivamente e tempestivamente informato delle indagini cliniche e delle cure alle quali lo si vuol sottoporre, in tutti i casi in cui possa esprimere liberamente e consapevolmente la sua volontà. Seguendo l’interpretazione dell’art. 5 adottata dalla sentenza impugnata - secondo cui le necessità cliniche sarebbero di per sé sufficienti a consentire di prescindere dalla preventiva informazione del malato - verrebbe sostanzialmente vanificato il diritto di quest’ultimo di accettare o rifiutare le cure. 3 Alla personale valutazione dell’interessato si sostituirebbe quella dei medici, i quali sono portati a somministrare comunque i trattamenti ritenuti opportuni, qualunque ne sia l’onere od il peso (sotto ogni profilo) per il paziente. Va soggiunto che - anche quando il trattamento si riveli indispensabile, per legge o nell’interesse pubblico - va riconosciuto al malato quanto meno il diritto di scegliere i tempi, i modi o i luoghi dell’intervento, in ogni caso in cui ciò sia possibile. Anche a tal fine è necessario che egli venga preventivamente informato ed interpellato. … (omissis)… violazione dell’art. 5, 1° comma, legge 135/1990, il ricorrente lamenta che erroneamente la Corte di appello abbia escluso l’indebita violazione della privacy ed abbia ritenuto che l’obbligo di mantenere l’anonimato, con riguardo ai campioni prelevati per le analisi, sia prescritto dalla legge solo in relazione alle indagini epidemiologiche. Giustamente la Corte di appello ha ritenuto che l’art. 5, 1° comma, imponga l’anonimato solo per le indagini epidemiologiche. Ciò non consente di escludere, tuttavia, che anche per le indagini cliniche debba essere rispettata quanto meno la riservatezza del paziente, adottando tutte le misure idonee a far sì che natura ed esito del test, dati sensibili raccolti nell’anamnesi, e accertamento della malattia, siano resi noti solo entro il ristretto ambito del personale medico e infermieristico adibito alla cura e vengano custoditi adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che altri, ed in particolare il pubblico, possano venire a conoscenza delle suddette informazioni. Ciò dispone espressamente il citato 1° comma dell’art. 5, legge n. 135/1990, secondo cui gli operatori sanitari che vengano a conoscenza di un caso di AIDS sono tenuti ad adottare tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona assistita. La Corte non ha positivamente accertato se le modalità di custodia della cartella clinica siano state tali da prevenire concretamente il rischio che i terzi potessero prendere visione del documento, custodendolo in luogo non accessibile, neppure occasionalmente o di fatto, da parte del pubblico. A fronte della precisa disposizione dell’art. 5, sarebbe stato onere del personale ospedaliero dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee allo scopo. Il rilievo della Corte di merito, secondo cui la cartella era stata lasciata in sala infermieri, locale riservato al personale sanitario, non è di per sé sufficiente, in mancanza di dimostrazione che a detta sala veniva effettivamente impedito l’accesso del pubblico. … La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, affinché decida sulle domande attrici uniformandosi ai seguenti principi di diritto: “L’art. 5, 3° comma, legge 5 giugno 1990 n. 135 - secondo cui nessuno può essere sottoposto al test anti HIV senza il suo consenso, se non per motivi di necessità clinica, nel suo interesse - deve essere interpretato alla luce dell’art. 32, 2° comma, Cost., nel senso che, anche nei casi di necessità clinica, il paziente deve essere informato del trattamento a cui lo si vuole sottoporre, ed ha il diritto di dare o di negare il suo consenso, in tutti i casi in cui sia in grado di decidere liberamente e consapevolmente”. “Dal consenso si potrebbe prescindere solo nei casi di obiettiva e indifferibile urgenza del trattamento sanitario, o per specifiche esigenze di interesse pubblico (rischi di contagio per i terzi, od altro): circostanze che il giudice deve indicare nella motivazione”. “A norma dell’art. 5, 1° comma, legge cit., è onere del personale sanitario dimostrare di avere adottato tutte le misure occorrenti allo scopo di garantire il diritto del paziente alla riservatezza e di evitare che i dati relativi all’esito del test ed alle condizioni di salute del paziente medesimo possano pervenire a conoscenza dei terzi”. 4 2. TRIB. ROMA SEZ. II, 21-07-2009 DIAGNOSI TARDIVA, VIOLAZIONE DEL CONSENSO E RISARCIMENTO DEL DANNO La produzione, in cartella clinica e quindi in giudizio, di stereotipati moduli di consenso informato spesso composti da decine di fogli ed a sigillo della DEFINITIVA BUROCRATIZZAZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE ALLA CURA, non può valere al sanitario per vincere l'onere di dimostrare l'effettiva e corretta informazione e, soprattutto, che l'informazione è stata funzionale all'esercizio sacrosanto del paziente di autodeterminarsi consapevolmente alla cura, grazie all'informazione ricevuta; e che, la sua violazione, è certamente sintomo di difetto della diligenza nell'adempimento della prestazione, di cui all'art. 1176, II comma, c.c. che di per sé sola può significare inadempimento contrattuale e risarcimento del danno. Va inoltre rigettata la richiesta di declaratoria di inammissibilità della domanda di risarcimento del danno derivante da violazione dell'obbligo di informazione che grava sul medico affinché egli ottenga dal proprio paziente il c.d. consenso informato ai trattamenti sanitari, in quanto, secondo la impostazione difensiva, si tratterebbe di domanda nuova introdotta in sede di memoria ex art. 183 c.p.c.. Si ritiene sul punto che la corretta informazione del paziente sulle alternative terapeutiche e la puntuale rappresentazione dei rischi e vantaggi relativi al trattamento cui sottoporsi rientrano a pieno titolo nel contenuto della prestazione professionale dei sanitari del Po. dal cui asserito inadempimento derivano le pretese risarcitone azionate in citazione, cosicché la deduzione di questa ulteriore condotta omissiva ad essa afferente - che tra l'altro non determina alcuna modifica in termini quantitativi del petitum - sembra dover essere più correttamente intesa quale precisazione della domanda originaria e come tale va dichiarata ammissibile….(omissis)… Al riguardo, va rilevato che … affetto da leucemia linfoide acuta e in cura presso il Po. di Roma , veniva sottoposto a far data dal 31.5.2001 a trattamento di chemioterapia antiblastica secondo il protocollo scientifico Gimema Lal, nell'ambito del quale era altresì previsto un ciclo di chemioterapia di mantenimento con somministrazione di Methotrexate… Dall'assunzione di detto farmaco è derivato l'insorgere di un'aracnoidite chimica a fronte della quale, nonostante si trattasse di complicanza prevedibile, i sanitari avrebbero ritardato la diagnosi con ciò determinando, secondo la prospettazione attorea, il prodursi di un grave danno neurologico, sfociato in una irreversibile paraplegia. …omissis…Questo giudice, peraltro, richiamandosi ai più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, qualifica come contrattuale la responsabilità del medico al pari di quella della struttura sanitaria, con tutto quello che ciò comporta in termini prescrizione, grado della colpa e ripartizione dell'onere della prova. D'altra parte, la giurisprudenza ha ormai da tempo elaborato un sistema ad hoc in materia di responsabilità medica, contrattuale o extra - contrattuale che la si voglia considerare, nella prospettiva di rafforzare la tutela del paziente, soggetto debole per definizione: per quanto riguarda, in particolare, la disciplina processuale dell'onere della prova, colui che lamenti di aver subito un danno ingiusto dall'attività professionale del sanitario è tenuto a provare esclusivamente la propria condizione precedente all'intervento medico, il nesso causale tra il peggioramento dello stato di salute e la prestazione del sanitario - o comunque il mancato raggiungimento del risultato programmato - e, ove eccepito, la non speciale difficoltà dell'intervento ex art. 2236 c.c.. In presenza di tali elementi, infatti, è possibile argomentare in via presuntiva l'imputabilità dell'evento pregiudizievole alla condotta colposa del sanitario sul quale, pertanto, ricade l'onere di provare di aver eseguito la prestazione con diligenza, ossia che l'esito negativo dell'intervento ovvero del trattamento terapeutico è derivato da un evento imprevisto o imprevedibile o comunque non accettabile secondo l'ordinaria 5 diligenza professionale ex art. 1176, secondo comma c.c.. Tanto premesso, in ordine al caso de quo, do va rilevato che: Ne consegue che la responsabilità diretta dell'ente (e quella del medico, inserito organicamente nella organizzazione del servizio), sono disciplinate in via analogica dalle norme che regolano la responsabilità in tema di prestazione professionale medica in esecuzione di un contratto d'opera professionale (segnatamente dalla disposizione di cui all'art. 2236 c.c.). Le conseguenze dannose residuate dalle cure praticate devono peraltro trovare integrale ristoro anche in considerazione della fondatezza della domanda risarcitoria proposta dall'attrice sul presupposto della omessa preventiva acquisizione del "consenso informato". La esigenza di un consenso informato, indipendentemente dalla esistenza di un vincolo contrattuale o legale obbligatorio, si desume dall'art. 13 Cost. dovendosi ricondurre all'esercizio del diritto di libertà personale la scelta del paziente di sottoporsi o meno alle cure mediche. L'onere della prova del consenso informato, poi, grava sul medico e sulla struttura sanitaria nell'ambito della quale è stata svolta l'attività professionale ed alla quale il professionista è legato da un rapporto di dipendenza ovvero nell'organizzazione della quale il medico è inserito organicamente o presta la propria attività tecnica. …..omissis….Ne deriva che, non essendo stato raggiunto il "risultato - informativo" (che deve, appunto riguardate la descrizione dell'intervento, la rappresentazione dei rischi e dei vantaggi connessi all'atto operatorio), deve ravvisarsi, per ciò stesso un illecito, contrattuale o extracontrattuale, rimanendo del tutto irrilevante (sic. esplicitamente: Cass. III 6.10.1997 n. 9705 Mu. c/ Fi. in Giur. It. 98 pag. 1816; Cass. III 24.9.1997 n. 9374 ric. Università Studi Genova c/ Si. ed altri, id., rv. 508192) l'accertamento della eventuale assenza di errori nella esecuzione della prestazione professionale. 6 3. TRIB. SALERNO, SEZ. II, 12 AGOSTO 2011, N. 1689. IL CONSENSO INFORMATO NON E' NECESSARIO PER I TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI" Il fondamento costituzionale del principio del consenso informato, rinvenibile negli artt. 2, 13 e 32 della Carta Costituzionale; il Tribunale ha rilevato come proprio quest’ultima norma, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, oltre che come interesse della collettività, prevede la possibilità di trattamenti sanitari obbligatori, sottoponendoli a riserva di legge. Trattandosi, nella specie, di trattamento sanitario obbligatorio non occorreva, secondo il Tribunale di Salerno, il consenso informato del paziente per disposizione di legge. Il fondamento della responsabilità per violazione del consenso informato poggia tanto sul disposto dell'art. 32 comma 2 della Costituzione, (a norma del quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge), quanto su quello dell'art. 13 della Costituzione, (che garantisce l'inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica), e dell'art. 33 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (che esclude la possibilità d'accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità; ex art. 54 cod. pen.). Tali norme, nell’imporre la necessità del consenso, prevedono altresì l’eccezione a tale principio, laddove è la stessa legge ad imporre il trattamento sanitario, prescindendo dal consenso dell’interessato, ovvero questi non sia in grado di prestare il consenso per le sue condizioni. ……Con atto di ……. R. L., esponendo che …… era stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio con somministrazione continua di medicinali che avevano comportato la perdita di cognizione personale e dell'ambiente esterno, senza l'urgenza "salvavita" e senza il suo consenso, con omissione di informazione e con violazione del diritto di autodeterminazione sancito dagli artt. 13 comma 1 e 32 comma 2 Cost., e che la terapia somministratagli coattivamente aveva determinato l'insorgere della patologia denominata "induratio penis plastica", conveniva in giudizio l'Azienda Ospedaliera ……. per ottenere il risarcimento dei danni subiti. …omissis…Ciò posto, l'attore pone a fondamento della domanda risarcitoria proprio la sottoposizione a trattamento sanitario senza il suo consenso e la somministrazione coattiva di farmaci non urgenti né necessari da parte dei sanitari. Sotto il primo profilo, va osservato quanto segue. I1 principio del consenso informato - il quale esprime una scelta di valore nel modo di concepire il rapporto tra medico e paziente, nel senso che detto rapporto appare fondato prima sui diritti del paziente e sulla sua libertà di autodeterminazione terapeutica che sui doveri del medico - ha un sicuro fondamento nelle norme della Costituzione: nell'art. 2, che tutela e promuove i diritti fondamentali della persona umana, della sua identità e dignità nell'art. 13, che proclama l'inviolabilità della liberta personale, nella quale "è postulata la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo" (Corte cost. sentenza n. 471 del 1990); e nell'art. 32, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, oltre che come interesse della collettività, e prevede la possibilità di trattamenti sanitari obbligatori, ma li assoggetta ad u na riserva di legge, qualificata dal necessario rispetto della persona umana e ulteriormente specificata con l'esigenza che si prevedano ad opera del legislatore tutte le cautele preventive possibili, atte ad evitare il rischio di complicanze. Ipotesi di trattamento obbligatorio e costituito dal caso del paziente che, per malattia mentale, non sia in grado di sottoporsi volontariamente ai trattamenti necessari, sicché la valutazione di tale necessità è rimessa ai sanitari ed al sindaco quale autorità sanita ria ex art. 34 ss. 1. 23 dicembre 1978 n. 833, ed alla successiva convalida dell'autorità giudiziaria. Nella specie, si verte proprio in ipotesi di trattamento sanitario obbligatorio previsto e regolato dagli artt. 1 e 2 della l. n. 180/78 e artt. 33-34-35 della legge 23.12.1978 n. 833 e, pertanto, il trattamento prestato al R. prescindeva dal suo consenso per disposizione di legge. Inoltre, cessato il trattamento sanitario obbligatorio, il R. continuava la degenza volontariamente, sottoscrivendo la dichiarazione inserita nella cartella clinica. …omissis... 7 4. TRIB. VERONA 10.01.2011 SE NON MI INFORMI MI RISARCISCI (all’esito di una prognosi postuma) …Con atto di citazione notificato il 27.04.04, M. C. ha convenuto in giudizio l'Azienda Ospedaliera ….. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa dell'intervento di di embolizazione e radiochirurgia eseguito presso ……, a seguito di una caduta improvvisa accompagnata da vertigine, era stata ricoverata presso l'Ospedale ….. per degli accertamenti, all'esito dei quali le era stata diagnosticata una malformazione congenita artero venosa cerebrale e le era stato consigliato di rivolgersi ad un centro specializzato per il trattamento della patologia; si era quindi rivolta alla divisione di neurochirurgia dell'Ospedale … ed il relativo personale sanitario le aveva consigliato di sottoporsi ad un intervento di embolizzazione e successiva radioterapia; il … era stata ricoverata presso l'Ospedale ….. e le era stato fatto sottoscrivere un foglio con alcune indicazioni sommarie sull'intervento…dopo l'intervento aveva iniziato ad accusare dei disturbi intensi (marcata riduzione dell'udito, vomito, cefalea, difficoltà di deambulazione, pressione alta) ed era stata sottoposta a degli esami che avevano accertato la presenza di "multipli minuti esiti di lesioni micro infartuali"; ….era stata perciò trasferita presso il centro di rieducazione ……. dove aveva iniziato un programma di riabilitazione; ciò nonostante, aveva continuato ad accusare dei gravi disturbi uditivi e neurovegetativi a causa dei quali non era più stata in grado di provvedere alle necessità quotidiane più elementari (impossibilità di provvedere autonomamente all'igiene personale, alla vestizione, all'acquisto e alla preparazione dei pasti); nel settembre del 2001 la Commissione medica le aveva riconosciuto l'invalidità civile totale e invalidità lavorativa del 100% permanente oltre al diritto a ricevere un'indennità di accompagnamento. Sulla base di tali deduzioni l'attrice, lamentando una responsabilità del personale medico sanitario per non aver correttamente eseguito l'intervento concordato e per non averla correttamente informata sui rischi a questo connessi, ha chiesto la condanna dell'Azienda Ospedaliera convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza della lesione dell'integrità psico-fisica riportata a seguito dell'intervento, a titolo di responsabilità sia contrattuale sia extracontrattuale. …La domanda proposta dall'attrice ha ad oggetto, quale petitum, il risarcimento del danno conseguente alla lesione dell''integrità psico-fisica subita a seguito dell'intervento del 2/5/01, ed è fondata su una duplice causa petendi: a) la colpa professionale del personale sanitario nella scelta e nell'esecuzione dell'intervento; b) la violazione da parte del personale sanitario dell'obbligo di informare l'attrice di tutte le conseguenze e i rischi dell'operazione e quindi di acquisire il suo consenso pieno e consapevole all'esecuzione dell'intervento. In particolare, sotto entrambi i profili, la domanda dell'attrice deve ritenersi fondata sulla responsabilità contrattuale della convenuta e più precisamente sulla violazione degli obblighi scaturenti a suo carico dal contratto di natura atipica (c.d "di spedalità") che si instaura tra la paziente e la struttura ospedaliera al momento dell'accettazione della domanda di ricovero (sulla nozione e gli effetti del contratto atipico di spedalità v., da ultimo, Cass. 8826/07). Da tale contratto infatti derivano a carico della convenuta un'obbligazione principale di cura ed assistenza, la cui violazione è dedotta in relazione al profilo sub a), e una serie di obbligazioni strumentali ed accessorie, la prima delle quali consiste nell'obbligo (la cui violazione è dedotta in relazione al profilo sub b) di fornire alla paziente in modo completo ed esaustivo tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che il personale sanitario intende praticare o l'intervento chirurgico che intende eseguire, con la specificazione dei rischi della terapia e dell'intervento, nonché della sua omissione (sul contenuto dell'obbligo di informazione gravante sul personale sanitario, v, da ultimo, Cass. n. 15698/10; sulla natura contrattuale della responsabilità conseguente alla sua violazione, in quanto obbligazione scaturente dal rapporto contrattuale, v. Cass n. 2847/10). Con specifico riguardo alla violazione dell'obbligo di informazione, va peraltro precisato che, come chiarito dal più recente orientamento di legittimità (v. Cass. n. 2847/10), i danni non patrimoniali 8 astrattamente risarcibili, purché derivanti da una lesione di apprezzabile gravità (secondo i canoni delineati dalle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nn. 26972/08 e 26974/08), possono essere di duplice natura: 1) quelli conseguenti alla lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente (la cui autonomia ontologica viene ormai riconosciuta dalla giurisprudenza e dalla dottrina, attraverso il richiamo dell'art. 2 Cost., che promuove e tutela i diritti fondamentali della persona, dell'art. 13 Cost, che stabilisce l'inviolabilità della libertà personale, e dell'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea -avente valore cogente nel nostro ordinamento a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona avvenuta il 01.12.09- in cui è sancito l'obbligo di rispettare il consenso libero ed informato dell'interessato nell' esercizio dell'attività medica) 2) quelli conseguenti alla lesione del diritto all'integrità psico-fisica del paziente, tutelato dall'art. 32 Cost.. In particolare, la risarcibilità dei primi può essere riconosciuta anche se non sussista lesione della salute (cfr. Cass., n. 2468/2009) o se la lesione della salute non sia causalmente collegabile alla lesione di quel diritto (perché l'intervento o la terapia sono stati scelti ed eseguiti correttamente), sempre che siano configurabili conseguenze pregiudizievoli (di apprezzabile gravità, se integranti un danno non patrimoniale) che siano derivate dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in sé stesso considerato (ci si riferisce prevalentemente al turbamento e alla sofferenza che deriva al paziente sottoposto ad atto terapeutico dal verificarsi di conseguenze del tutto inaspettate perché non prospettate e, anche per questo, più difficilmente accettate: v. Cass. n. 2847/10). Invece, "la risarcibilità del danno da lesione della salute che si verifichi per le non imprevedibili conseguenze dell'atto terapeutico necessario e correttamente eseguito secundum legem artis, ma tuttavia effettuato senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, necessariamente presuppone l'accertamento che il paziente quel determinato intervento avrebbe rifiutato se fosse stato adeguatamente informato", con l'ulteriore precisazione che "il relativo onere probatorio, suscettibile di essere soddisfatto anche mediante presunzioni, grava sul paziente: (a) perché la prova di nesso causale tra inadempimento e danno comunque compete alla parte che alleghi l'inadempimento altrui e pretenda per questo il risarcimento; (b) perché il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico; (c) perché si tratta pur sempre di stabilire in quale senso si sarebbe orientata la scelta soggettiva del paziente, sicché anche il criterio di distribuzione dell'onere probatorio in funzione della "vicinanza" al fatto da provare induce alla medesima conclusione; (d) perché il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione di opportunità del medico costituisce un'eventualità che non corrisponde all'id quod plerumque accidit" (v. ancora in questi termini Cass. n. 2847/10). Nel caso di specie la violazione dell'obbligo di informazione è stata invocata dall'attrice, quale secondo profilo della causa petendi, a sostegno della domanda di risarcimento del danno derivante dalla lesione del diritto alla salute, sicché non rileva il diverso danno derivante dalla lesione del diritto all'audoterminazione in sé (sull'autonomia dei due diritti e sulla conseguenza diversità della domanda risarcitoria v. anche Cass. n. 18513/07). Ciò chiarito, occorre quindi accertare: 1) se vi sia stata una lesione del diritto alla salute dell'attrice in conseguenza dell'intervento eseguito presso la struttura ospedaliera riconducibile alla convenuta; 2) se tale lesione sia causalmente riconducibile ad un comportamento colposo del personale sanitario nella scelta o nell'esecuzione dell'intervento; 3) ovvero (nel caso in cui tale comportamento colposo non sia riscontrabile) se tale lesione sia riconducibile ad una violazione dell'obbligo di informazione gravante sul personale sanitario (più precisamente, se, una volta accertato la violazione di detto obbligo, l'attrice non si sarebbe sottoposta all'intervento che ha determinato la lesione del diritto alla salute, qualora fosse stata adeguatamente informata circa le sue conseguenze). Per ciò che concerne il primo punto, la CTU collegiale espletata nel corso del giudizio… 9 ha quantificato nel 65 % il danno biologico subito dalla parte in conseguenza dei postumi permanenti su evidenziati (incidenti sulla capacità uditiva, di comunicazione e do deambulazione) e in 150 giorni il periodo di invalidità temporanea. Gli accertamenti e le conclusioni dei CCTTUU sul punto appaiono immuni da censure di carattere logico o tecnico (tanto che non sono stati specificamente contestati dalle parti) e possono essere quindi posti a base della decisione. Si può quindi procedere al secondo accertamento concernente la configurabilità di un comportamento colposo del personale sanitario nella scelta e nell'esecuzione dell'intervento che ha determinato la su descritta lesione. Al riguardo …. deve quindi escludersi la configurabilità di una condotta colposa del personale sanitario nella scelta e nell'esecuzione dell'intervento dedotto in giudizio. Si può quindi procedere al terzo accertamento concernente la configurabilità della violazione del dovere informativo e della sua incidenza causale sulla lesione dell'integrità psico-fisica conseguita all'intervento. Al riguardo va premesso che la CTU collegiale espletata nel corso del giudizio….ha accertato che: l'insulto ischemico intraoperatorio rappresentava un rischio elevato dell'intervento, prevedibile (anche se non nell'entità delle conseguenze specifiche), ma non evitabile; - non vi sono studi attendibili sull'evoluzione delle MAV in caso di mancata esecuzione di interventi correttivi (come quello praticato all'attrice), soprattutto perché di regola il paziente cui viene diagnosticata la MAV si sottopone ad intervento; - i pochi studi esistenti sull'evoluzione delle MAV in caso di mancata esecuzione dell'intervento correttivo riguardano una popolazione selezionata, poco rilevante dal punto di vista numerico; - gli autori che si sono occupati di tali studi sottolineano che piccoli MAV (come quello dell'attrice) presentano un rischio di risanguinamento pari al 52 % del casi in 5 anni e che il rischio di mortalità in occasione di una seconda emorragia è pari al 20 %; - gli effetti del risanguinamento della MAV, anche se non tali da terminare l'evento letale, provocano importanti disabilità, poiché riguardano l'area tronco-crerbrale. …omissis….Sulla base di tali accertamenti l'obbligo informativo gravante sul personale sanitario (inteso nei termini su esposti: v. Cass. n. 15698/10) avrebbe dovuto riguardare non solo la descrizione del tipo di intervento suggerito (e delle ragioni che lo rendevano preferibile agli altri praticabili), ma anche la rappresentazione: 1) dei rischi derivanti dalla sua esecuzione (ed in particolare, tra gli altri, il rischio elevato, anche in caso di esecuzione corretta, di un insulto ischemico intraoperatorio, con la conseguenza di possibili disabilità nella comunicazione e nella deambulazione, anche importanti, pur se non prevedibili nell'entità specifica); 2) dei rischi in caso di mancata esecuzione dell'intervento (ed in particolare la mancanza di studi attendibili, la possibilità, o probabilità fino al 52% secondo alcuni autori, di un risanguinamento della MAV, ed i possibili effetti di un risanguinamento della MAV, dal decesso, indicato da alcuni autori con una percentuale del 20 %, alle varie disabilità dipendenti dall'area tronco-cerebrale). Ribadito che l'onere della prova dell'adempimento dell'obbligo informativo grava sulla struttura ospedaliera (Cass. n. 2847/10), nel caso di specie tale prova (con specifico riferimento al contenuto dell'obbligo informativo su evidenziato) non può ritenersi acquisita. In questa prospettiva va evidenziato che: a) non è stato prodotto alcun modulo scritto riportante il contenuto delle informazioni fornite all'attrice e l'acquisizione del suo consenso; b) la testimonianza dei medici (A. P. e P. Z.) che hanno tenuto i colloqui nel corso dei quali è stato acquisito il consenso dell'attrice e la testimonianza dei medici (P. Z. e A. B.) che hanno eseguito in concreto l'intervento stesso, non sono valutabili, in quanto i testimoni, come tempestivamente eccepito dall'attrice, sono privi di legittimazione a deporre, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., avendo un 10 interesse attuale e diretto in relazione all'accertamento giurisdizionale, tale da giustificare la loro partecipazione al giudizio c) non sono stati allegati ulteriori elementi di prova sul punto. Rimane da compiere il giudizio di prognosi postuma, necessario per accertare la sussistenza di un nesso causale tra l'inadempimento dell'obbligo informativo e la lesione dell'integrità subita dall'attrice per effetto dell'intervento. Occorre quindi chiedersi se l'attrice, qualora avesse ricevuto tutte le informazioni su esposte, avrebbe rifiutato o meno di sottoporsi all'intervento. Si tratta di un giudizio delicato, caratterizzato da difficoltà assimilabili a quelle affrontate dalla giurisprudenza che si è occupata della ricostruzione della volontà presuntiva di rifiutare l'assistenza sanitaria di pazienti in condizioni neurovegetative. Tale giudizio, in particolare, deve essere basato principalmente su valutazioni presuntive, indirizzate dalla considerazione generale del comportamento della persona media nelle stesse condizioni, ma soprattutto dalla considerazione specifica della volontà dichiarata dall'interessato in condizioni simili o, in mancanza, della sua personalità, delle sue inclinazioni e delle sue contesto di vita. Nel caso di specie, peraltro, l'attrice ha omesso del tutto queste allegazioni specifiche sulla sua situazione personale, sicché il giudizio presuntivo non può che concentrarsi sulla considerazione generale del comportamento della persona media nelle stesse condizioni. Bisogna in altri termini chiedersi cosa avrebbe fatto una persona media nelle stesse condizioni, debitamente informata, di fronte all'alternativa tra la scelta di un intervento risolutivo della patologia, ma con rischio elevato di un evento ischemico intraoperatorio tale da determinare disabilità imprevedibili nell'entità, e la scelta di non sottoporsi all'operazione, con il rischio (possibile o probabile secondo alcuni autori) di un risanguinamento improvviso (ossia non prevedibile sotto il profilo temporale) e non prevenibile, tale da determinare il decesso o comunque disabilità imprevedibili nell'entità. In questa prospettiva acquistano rilievo: l'istinto di sopravvivenza e lo spirito di conservazione dell'essere umano, l'indiscutibile rilievo (come speranza) della possibilità di un intervento risolutivo del problema senza conseguenze, la naturale difficoltà ad affrontare (in caso di mancata sottoposizione all'intervento) la prospettiva di una vita residua del tutto incerta, in quanto caratterizzata dalla "spada di Damocle" consistente nel rischio, da un momento all'altro, di un episodio emorragico con effetto letale o comunque inabilitante. Sulla base di tale considerazione deve ritenersi maggiormente probabile, secondo l'id quod plerumque accidit, la scelta di sottoporsi all'intervento proposto in ogni caso (anche nell'ipotesi di esatto adempimento dell'obbligo informativo). …. Pertanto, ribadita la carenza di allegazioni specifiche sulla personalità e sul contesto di vita dell'attrice, il giudizio di prognosi postuma effettuato induce ad escludere il nesso di causalità tra l'inadempimento all'obbligo informativo e la scelta di sottoporsi all'intervento con le relative conseguenze. La domanda dell'attrice deve quindi giudicarsi infondata e va rigettata. 11 5. Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2009, n. 20806 - "NELLA "ROUTINE" SOLO L'IMPREVISTO SOLLEVA IL MEDICO DALLA RESPONSABILITÀ" Accolto, nella specie, il ricorso di un paziente che in seguito a un banalissimo intervento di cataratta aveva perso quasi totalmente la vista dall’occhio destro. Durante la prima operazione si era verificata, infatti, un’emorragia ciliare – che in realtà si poi è scoperto essere di tipo espulsivo – a causa della quale il “camice bianco” è stato costretto sospendere l’intervento per poi riprenderlo quattro giorni dopo con esito infausto. Ma ormai l’occhio era compresso irrimediabilmente. 975/09). Consenso. Il medico – puntualizza Piazza Cavour – ha l’obbligo di informare il paziente anche sui rischi minimi quando è in gioco un bene delicatissimo come la vista. Spetta poi al professionista provarne l’adempimento. Con citazione …. ingegnere, conveniva dinanzi al Tribunale di Bologna … chiedendone la condanna al risarcimento dei danni - che quantificava in lire un miliardo e cento milioni - per la quasi totale perdita della vista in conseguenza del duplice intervento chirurgico di cataratta subito all'età di sessantasei anni, sull'occhio destro, eseguito dal convenuto ………. Il convenuto contestava la responsabilità, deducendo che l’attore doveva rigorosamente provare il danno. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda ………………il P. però non aveva adempiuto all'obbligo di informare il paziente delle eventuali complicanze, essendogli anzi stata assicurata la mancanza di qualsiasi rischio, né il contrario provava la testimonianza del medico C. perché non aveva partecipato alla visita e al colloquio tra il paziente ed il P., essendosi limitato ad una visita successiva, e comunque aveva attestato esser stata fornita un'informazione generale ed astratta, perciò inidonea ad assolvere all'obbligo di un esauriente adempimento dell'obbligo di informativa del paziente; g) nemmeno per il secondo intervento il P. aveva adempiuto all'obbligo dell'informazione perché il C. era da poco uscito dall'anestesia e perciò non in era grado di recepire pienamente le informazioni fornitegli e comunque il secondo intervento era stato, secondo i C.T.U., conseguenza necessaria del primo, e pertanto l'obbligo di informativa in relazione a questo secondo intervento doveva esser collegato al primo. Il Dott. P., come evidenziato nei gradi di merito, ha diagnosticato un'emorragia ciliare durante il primo intervento, ed un'emorragia retinica durante il secondo intervento e se perciò la seconda emorragia è diversa dalla prima, bisogna trovarne le cause, che secondo il C.T.P. sono state le manovre incongrue del P. nel corso del secondo intervento atteso che l’emorragia ciliare si risolve con la restitutio in integrum e che se il sangue sovracoroidale avesse provocato la rottura spontanea della retina per degenerazione, il P. all'inizio del secondo intervento lo avrebbe trovato in camera vitrea, mentre il sanguinamento è stato successivo, e quindi di natura iatrogena, ed infatti il prof. D. M. ha riscontrato un'ampia lacerazione retinica che poteva esser stata cagionata soltanto da errate manovre di inesperto in operazioni vitreoretiniche. Ma su questo punto la Corte di merito nulla ha argomentato e il collegio peritale si è limitato ad affermare che “dopo il primo intervento la probabilità di una recidiva era più elevata” senza rispondere ai quesiti posti ai C.T.U.: se il P. aveva adeguata competenza tecnica per il primo e per il secondo intervento, tenuto conto anche delle conseguenze del primo; se il secondo intervento poteva esser eseguito a distanza di pochi giorni dal primo; se erano state poste in essere le cautele atte ad evitare le complicanze verificatesi; se erano evitabili e prevedibili le complicanze del secondo intervento; quali cause avevano determinato la seconda emorragia. ….Il consenso informato, espressione del diritto personalissimo, di rilevanza costituzionale, all'autodeterminazione terapeutica, è un obbligo contrattuale del medico perché è funzionale al corretto adempimento della prestazione professionale, pur essendo autonomo da esso. Nel caso di specie i giudici di primo grado hanno accertato che il Dott. P. aveva garantito al C. il positivo esito dell'intervento - tanto che il Tribunale ha ritenuto che l'obbligazione assunta è stata di 12 risultato - non soltanto perché di routine, ma anche perché il paziente era in buone condizioni di salute, aveva sessantasei anni, e gli occhi erano sani. Quindi nessun rischio di esito negativo era stato prospettato e questo è il consenso prestato dal C., con la conseguenza che, al fine di valutare se il predetto obbligo è stato correttamente adempiuto, i giudici di appello hanno omesso di accertare se, avuto riguardo alle conoscenze scientifiche di quel momento, non era prevedibile, neppure come rischio ridotto, ma incidente gravemente sulle ulteriori complicanze (Cass. 364/1997), la rottura della capsula posteriore quale complicanza delle manovre per eseguire l’intervento di cataratta, si da non poterne preventivamente informare il C. - tenuto conto anche alle sue condizioni personali, sociali, culturali - ed ottenere l’eventuale consenso anche al conseguente, successivo trattamento che si sarebbe reso necessario, con i relativi rischi. Accertato poi dai giudici di merito che, verificatasi detta dislocazione di parti del nucleo all'interno della camera vitrea, il Dott. P. decise di eseguire una vitrectomia anteriore, cambiando di conseguenza la procedura operatoria, i giudici di appello hanno escluso la violazione dell'obbligo del consenso informato pur senza evidenziare alcuna necessità di procedere senza indugio e perciò senza poter attendere che il C. si risvegliasse dall'anestesia generale e potesse prestare il preventivo consenso, né specificare le ragioni per cui il Dott. P. non informò comunque la moglie ed i parenti dell'evento dannoso verificatosi e delle successive manovre tecniche che si accingeva a praticare, diverse da quelle originariamente concordate. Ne consegue che la Corte di merito, avendo dedotto l'osservanza del Dott. P. di informare il C. in relazione ai rischi sia del programmato intervento di cataratta, sia delle manovre resesi necessarie in conseguenza delle prime complicanze intraoperatorie dallo stesso diagnosticate dalla circostanza che il predetto oculista, verificatasi la prima emorragia, comunicò che non poteva terminare l'intervento di cataratta, ma che era proseguibile di lì a qualche giorno, ha violato il principio secondo il quale sussiste la responsabilità del medico per violazione dell'obbligo contrattuale di porre il paziente nella condizione di esprimere un valido ed effettivo consenso informato in tutte le fasi operative (Cass. 364/1997, cit., 24742/2007). 4.2 - In relazione poi al secondo intervento, intrapreso malgrado l'alta probabilità di recidiva dell'emorragia espulsiva - secondo i C.T.U., come evidenziato in sentenza - la Corte di merito ritiene assolto l'obbligo informativo del P., malgrado egli abbia, in conseguenza dell'erronea diagnosi della prima emorragia - ciliare anziché espulsiva - erroneamente rappresentato i rischi a cui avrebbe sottoposto il C. non informandolo dell'alta probabilità di recidiva dell'emorragia e delle scarse probabilità di riuscita dell'intervento stesso. Ne consegue che, essendo viziato il consenso ottenuto, era onere del P. provare l'incolpevole errore della diagnosi della prima emorragia, e altresì dimostrare di aver, pur in tale erroneo presupposto, informato il C. dell'intervento di particolare difficoltà (vitrectomia posteriore, non essendo riuscita quella anteriore) che si accingeva a praticare, in una condizione in cui, come messo in luce dalla sentenza impugnata, la estesa lacerazione ed il distacco di retina erano prevedibili poiché “le membrane cicatriziali epiretiniche determinate dalle complicazioni operatorie già verificatesi... sono condizioni patologiche naturali che... solitamente di per sé giustificano la lesione retinica” (pagg. 23 - 24 della sentenza impugnata), in modo da metterlo in condizioni di effettuare una scelta chirurgica consapevole anche in relazione all'operatore. Quindi il motivo va accolto. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso incidentale e accoglie il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Firenze. Diritto alla vita, eutanasia, legittimità, limiti 13 6. CASSAZIONE CIVILE , SEZ. I, SENTENZA 16.10.2007 N° 21748 - DIRITTO ALLA VITA – EUTANASIA – LEGITTIMITÀ - LIMITI Chi versa in stato vegetativo permanente è, a tutti gli effetti, persona in senso pieno, che deve essere rispettata e tutelata nei suoi diritti fondamentali, a partire dal diritto alla vita e dal diritto alle prestazioni sanitarie, a maggior ragione perché in condizioni di estrema debolezza e non in grado di provvedervi autonomamente. La funzionalizzazione del potere di rappresentanza, dovendo esso essere orientato alla tutela del diritto alla vita del rappresentato, consente di giungere ad una interruzione delle cure soltanto in casi estremi: - quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre che la persona abbia la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una vita fatta anche di percezione del mondo esterno; e sempre che tale condizione (tenendo conto della volontà espressa dall’interessato prima di cadere in tale stato ovvero dei valori di riferimento e delle convinzioni dello stesso) sia incompatibile con la rappresentazione di sé sulla quale egli aveva costruito la sua vita fino a quel momento e sia contraria al di lui modo di intendere la dignità della persona; - quando la ricerca della presunta volontà della persona in stato di incoscienza – ricostruita, alla stregua di chiari, univoci e convincenti elementi di prova, non solo alla luce dei precedenti desideri e dichiarazioni dell’interessato, ma anche sulla base dello stile e del carattere della sua vita, del suo senso dell’integrità e dei suoi interessi critici e di esperienza – assicura che la scelta in questione non sia espressione del giudizio sulla qualità della vita proprio del rappresentante, ancorché appartenente alla stessa cerchia familiare del rappresentato, e che non sia in alcun modo condizionata dalla particolare gravosità della situazione, ma sia rivolta, esclusivamente, a dare sostanza e coerenza all’identità complessiva del paziente e al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona. Ove l’uno o l’altro presuppoto non sussista, il giudice deve negare l’autorizzazione, dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa. Da quanto sopra deriva che, in una situazione cronica di oggettiva irreversibilità del quadro clinico di perdita assoluta della coscienza, può essere dato corso, come estremo gesto di rispetto dell’autonomia del malato in stato vegetativo permanente, alla richiesta, proveniente dal tutore che lo rappresenta, di interruzione del trattamento medico che lo tiene artificialmente in vita, allorché quella condizione, caratterizzante detto stato, di assenza di sentimento e di esperienza, di relazione e di conoscenza – proprio muovendo dalla volontà espressa prima di cadere in tale stato e tenendo conto dei valori e delle convinzioni propri della persona in stato di incapacità – si appalesi, in mancanza di qualsivoglia prospettiva di regressione della patologia, lesiva del suo modo di intendere la dignità della vita e la sofferenza nella vita. (1) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. – Con ricorso ex art. 732 cod. proc. civ., ZZZ YYY, quale tutore della figlia interdetta XXX YYY, ha chiesto al Tribunale di Lecco, previa nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 78 cod. proc. civ., l’emanazione di un ordine di interruzione della alimentazione forzata mediante sondino nasogastrico 14 che tiene in vita la tutelata, in stato di coma vegetativo irre-versibile dal 1992. Il curatore speciale, nominato dal Presidente del Tribunale, ha aderito al ricorso. Il Tribunale di Lecco, con decreto in data 2 febbraio 2006, ha dichiarato inammissibile il ricorso ed ha giudicato manifestamente infondati i profili di illegittimità costituzionale prospettati in via subordinata dal tutore e dal curatore speciale. Né il tutore né il curatore speciale – hanno statuito i primi giudici – hanno la rappresentanza sostanziale, e quindi processuale, dell’interdetta con riferimento alla domanda dedotta in giudizio, involgendo essa la sfera dei diritti personalissimi, per i quali il nostro ordinamento giuridico non ammette la rappresentanza, se non in ipotesi tassative previste dalla legge, nella specie non ricorrenti. Inoltre, la mancata previsione normativa di una tale rappresentanza è perfettamente aderente al dettato costituzionale, e la lacuna non può essere colmata con una interpretazione costituzionalmente orientata. Peraltro, anche ove il curatore o il tutore fossero investiti di tale potere, la domanda – ad avviso dei primi giudici - dovrebbe essere rigettata, perché il suo accoglimento contrasterebbe con i principi espressi dall’ordinamento costituzionale. Infatti, ai sensi degli artt. 2 e 32 Cost., un trattamento terapeutico o di alimentazione, anche invasivo, indispensabile a tenere in vita una persona non capace di prestarvi consenso, non solo è lecito, ma dovuto, in quanto espressione del dovere di solidarietà posto a carico dei consociati, tanto più pregnante quando, come nella specie, il soggetto interessato non sia in grado di manifestare la sua volontà. In base agli artt. 13 e 32 Cost. ogni persona, se pienamente capace di intendere e di volere, può rifiutare qualsiasi trattamento terapeutico o nutrizionale fortemente invasivo, anche se necessario alla sua sopravvivenza, laddove se la persona non è capace di intendere e di volere il conflitto tra il diritto di libertà e di autodeterminazione e il diritto alla vita è solo ipotetico e deve risolversi a favore di quest’ultimo, in quanto, non potendo la persona esprimere alcuna volontà, non vi è alcun profilo di autodeterminazione o di libertà da tutelare. L’art. 32 Cost. porta ed escludere che si possa operare una distinzione tra vite degne e non degne di essere vissute. 2. – Avverso tale decreto ha proposto reclamo alla Corte d’appello di Milano il tutore, chiedendo che, previa opportuna istruttoria sulla volontà di XXX, a suo tempo manifestata, contraria agli accanimenti terapeutici e, ove occorra, incidente di costituzionalità, venga ordinata l’interruzione dell’alimentazione forzata di XXX, in quanto trattamento invasivo della sfera personale, perpetrato contro la dignità umana. Il curatore speciale, costituitosi, ha chiesto l’accoglimento dell’impugnazione, ed ha proposto egli stesso reclamo, da intendersi anche come reclamo incidentale. Il pubblico ministero ha concluso per la reiezione del reclamo, ritenendo condivisibili le argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento del provvedimento impugnato. 3. – La Corte d’appello di Milano, con decreto in data 16 dicembre 2006, in riforma del provvedimento impugnato, ha dichiarato ammissibile il ricorso e lo ha rigettato nel merito. 3.1. – La Corte ambrosiana non condivide la decisione del Tribunale in punto di inammissibilità della domanda, giacché i rappresentanti legali di XXX domandano che sia il giudice a disporre l’interruzione dell’alimentazione e dell’idratazione artificiali, sul presupposto che tale presidio medico costituisca un trattamento invasivo dell’integrità psicofisica, contrario alla dignità umana, non praticabile contro la volontà dell’incapace o, comunque, in assenza del suo consen-so. Secondo la Corte territoriale, ai sensi del combi-nato disposto degli artt. 357 e 424 cod. civ., nel potere di cura della persona, conferito al rappresentante legale dell’incapace, non può non ritenersi 15 compreso il diritto-dovere di esprimere il consenso informato alle terapie mediche. La “cura della persona” implica non solo la cura degli interessi patrimoniali, quanto - principalmente – di quelli di natura esistenziale, tra i quali vi è indubbiamente la salute intesa non solo come integrità psicofisica, ma anche come diritto di farsi curare o di rifiutare la cura: tale diritto non può trovare limitazione alcuna quando la persona interessata non è in grado di determinarsi. La presenza in causa – indicata come necessaria dalla Corte di cassazione con l’ordinanza 20 aprile 2005, n. 8291 – del curatore speciale che si è associato alla richiesta del tutore supera ogni problema di possibile conflitto tra la tutelata ed il tutore. E, in considerazione dello stato di totale incapa-cità di XXX e delle gravi conseguenze che la sospensione del trattamento in atto produrrebbe, il tutore o, in sua vece, il curatore speciale deve adire il giudice per ot-tenerne l’interruzione. 3.2. - Nel merito, la Corte d’appello osserva che XXX – la quale non può considerarsi clinicamente morta, perché la morte si ha con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo – si trova in stato vegetativo permanente, condizione clinica che, secondo la scienza medica, è caratteristica di un soggetto che “ventila, in cui gli occhi possono rimanere aperti, le pupille reagiscono, i riflessi del tronco e spinali persistono, ma non vi è alcun segno di attività psichica e di partecipazione all’ambiente e le uniche risposte motorie riflesse consistono in una redistribuzione del tono muscolare”. Lo stato vegetativo di XXX è immodificato dal 1992 – da quando ella riportò un trauma cranico-encefalico a seguito di incidente stradale – ed è irreversibile, mentre la cessazione della alimentazione a mezzo del sondino nasogastrico la condurrebbe a sicura morte nel giro di pochissimi giorni. La Corte territoriale riferisce che dalle concordi deposizioni di tre amiche di XXX – le quali avevano rac-colto le sue confidenze poco prima del tragico incidente che l’ha ridotta nelle attuali condizioni emerge che costei era rimasta profondamente scossa dopo aver fatto visita in ospedale all’amico Tizio, in coma a seguito di un sinistro stradale, aveva dichiarato di ritenere preferibile la situazione di un altro ragazzo, Caio, che, nel corso dello stesso incidente, era morto sul colpo, piuttosto che rimanere immobile in ospedale in balia di altri attaccato ad un tubo, ed aveva manifestato tale sua convinzione anche a scuola, in una discussione apertasi al riguardo con le sue insegnanti suore. Secondo i giudici del reclamo, si tratterebbe di dichiarazioni generiche, rese a terzi con riferimento a fatti accaduti ad altre persone, in un momento di forte emotività, quando XXX era molto giovane, si trovava in uno stato di benessere fisico e non nella attualità della malattia, era priva di maturità certa rispetto alle tematiche della vita e della morte e non poteva neppure immaginare la situazione in cui ora versa. Non potrebbe dunque attribuirsi alle dichiarazioni di XXX il valore di una personale, consapevole ed attuale determinazione volitiva, maturata con assoluta cognizione di causa. La posizione di XXX sarebbe pertanto assimilabile a quella di qualsiasi altro soggetto incapace che nulla abbia detto in merito alle cure ed ai trattamenti medici cui deve essere sottoposto. La Corte d’appello non condivide la tesi – sostenuta dal tutore ed avallata dal curatore speciale – secondo cui, di fronte ad un trattamento medico - l’alimentazione forzata mediante sondino nasogastrico - che mantiene in vita XXX esclusivamente da un punto di vista biologico senza alcuna speranza di miglioramento, solo l’accertamento di una precisa volontà, espressa da XXX quando era cosciente, favorevole alla prosecuzione della vita ad ogni costo, potrebbe indurre a valutare come non degradante e non contrario alla dignità umana il trattamento che oggi le viene imposto. Innanzitutto perché, in base alla vigente normativa, XXX è viva, posto che la morte si ha con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo. In secondo luogo perché – al di là di ogni questione inerente alla natura di terapia medica, di accanimento terapeutico (inteso come cure mediche svincolate dalla speranza di recupero del paziente) o di normale mezzo di sostentamento che si possa dare alla alimentazione forzata cui è sottoposta XXX – è indiscutibile che, non essendo XXX in grado di alimentarsi altrimenti ed essendo la nutrizione con sondino nasogastrico l’unico 16 modo di alimentarla, la sua sospensione condurrebbe l’incapace a morte certa nel volgere di pochi giorni: equivarrebbe, quindi, ad una eutanasia indiretta omissiva. Secondo i giudici del gravame, non vi sarebbe alcuna possibilità di accedere a distinzioni tra vite degne e non degne di essere vissute, dovendosi fare riferimento unicamente al bene vita costituzionalmente garantito, indipendentemente dalla qualità della vita stessa e dalle percezioni soggettive che di detta qualità si possono avere. “Se è indubbio che, in forza del diritto alla salute e alla autodeterminazione in campo sanitario, il soggetto capace possa rifiutare anche le cure indispensabili a tenerlo in vita, nel caso di soggetto incapace (di cui non sia certa la volontà, come nel caso di XXX) per il quale sia in atto solo un trattamento di nutrizione, che indipendentemente dalle modalità invasive con cui viene eseguito (sondino nasogastrico) è sicuramente indispensabile per l’impossibilità del soggetto di alimentarsi altrimenti e che, se sospeso, condurrebbe lo stesso a morte, il giudice – chiamato a decidere se sospendere o meno detto trattamento – non può non tenere in considerazione le irreversibili conseguenze cui porterebbe la chiesta sospensione (morte del soggetto incapace), dovendo necessariamente operare un bilanciamento tra diritti parimenti garantiti dalla Costituzione, quali quello alla autodeterminazione e dignità della persona e quello alla vita”. Detto bilanciamento – a giudizio della Corte d’appello – “non può che risolversi a favore del diritto alla vita, ove si osservi la collocazione sistematica (art. 2 Cost.) dello stesso, privilegiata rispetto agli altri (contemplati dagli artt. 13 e 32 Cost.), all’interno della Carta costituzionale”; tanto più che, alla luce di disposizioni normative interne e convenzionali, la vita è un bene supremo, non essendo configurabile l’esistenza di un “diritto a morire” (come ha riconosciuto la Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza 29 aprile 2002 nel caso Pretty c. Regno Unito). 4. – Per la cassazione del decreto della Corte d’appello il tutore ZZZ YYY, con atto notificato il 3 marzo 2007, ha interposto ricorso, affidato ad un unico, complesso motivo. Anche il controricorrente curatore speciale Avv. Franca Alessio ha proposto ricorso incidentale, sulla base di due motivi. Il ricorrente ed il ricorrente incidentale hanno, entrambi, depositato memoria in prossimità dell’udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. – Con l’unico mezzo illustrato con memoria - denunciando violazione degli artt. 357 e 424 cod. civ., in relazione agli artt. 2, 13 e 32 Cost., nonché omessa ed insufficiente motivazione circa il punto decisivo della controversia – il tutore, ricorrente in via principale, chiede alla Corte di affermare, come principio di diritto, “il divieto di accanimento terapeutico, e cioè che nessuno debba subire trattamenti invasivi della propria persona, ancorché finalizzati al prolungamento artificiale della vita, senza che ne sia concretamente ed effettivamente verificata l’utilità ed il beneficio”. Qualora tale risultato ermeneutico sia precluso per effetto degli artt. 357 cod. civ. e 732 cod. proc. civ., ovvero di altre norme di legge ordinaria, il ricorrente chiede che sia sollevata questione di legittimità costituzionale di tutte tali norme legislative, per violazione degli artt. 2, 13 e 32 Cost., da cui si assume discendere la piena operatività del divieto di accanimento terapeutico. Secondo il ricorrente, la Corte d’appello di Milano avrebbe frainteso e travisato completamente il significato da attribuirsi alla indisponibilità ed irrinunciabilità del diritto alla vita. Il predicare l’indisponibilità del diritto alla vita, a differenza di quel che accade per altri diritti costituzionali e fondamentali, si riallaccia al fatto che, nella mappa del costituzionalismo moderno, esso costituisce un diritto diverso da tutti gli altri: la vita è indispensabile presupposto per il godimento di qualunque libertà dell’uomo e, proprio per questo, non può ammettersi che la persona alieni ad altri la 17 decisione sulla propria sopravvivenza o che il diritto si estingua con la rinuncia. E tuttavia, l’indisponibilità ed irrinunciabilità del diritto alla vita è garantita per evitare che soggetti diversi da quello che deve vivere, il quale potrebbe versare in stato di debolezza e minorità, si arroghino arbitrariamente il diritto di interrompere la vita altrui; ma sarebbe errato costruire l’indisponibilità della vita in ossequio ad un interesse altrui, pubblico o collettivo, sopraordinato e distinto da quello della persona che vive. Del resto – ricorda il ricorrente – la Corte costituzionale ha precisato che nella tutela della libertà personale resa inviolabile dall’art. 13 Cost. è postulata la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo. E la giurisprudenza della Corte di cassazione, nel ricostruire di recente come fonte di responsabilità del medico il solo fatto di non avere informato il paziente, o di non averne sollecitato ed ottenuto previamente l’assenso per il trattamento, ha chiarito che qui siamo fuori dall’ipotesi in cui il consenso dell’avente diritto vale come esimente da responsabilità giuridica per chi ha agito praticando la cura invasiva della sfera individuale: il consenso libero ed informato è piuttosto percepito come un requisito intrinseco perché l’intervento di chi pure sia professionalmente competente a curare risulti di per sé legittimo. Il che – ad avviso del ricorrente – sottolinea come il diritto alla vita, proprio perché irrinunciabile ed indisponibile, non spetti che al suo titolare e non possa essere trasferito ad altri, che lo costringano a vivere come essi vorrebbero. Ciò che la Corte ambrosiana avrebbe trascurato è che, nel caso di XXX YYY come in qualunque altro caso di trattamenti praticati dal medico o da altri sulla persona per mantenerla in vita, a venire in rilievo non è il diritto alla vita, ma “solo ed esclusivamente la legittimità della decisione di un uomo, che solitamente e per fortuna nel caso nostro è un medico professionalmente competente, di intervenire sul corpo di una persona per prolungarne la vita”. Ad avviso del ricorrente, la garanzia del diritto alla vita è più complessa per soggetti incapaci di intendere e di volere, come XXX YYY, che non per chi abbia coscienza e volontà. Per chi sia cosciente e capace di volere, invero, la prima garanzia del proprio diritto alla vita risiede nella libertà di autodeterminazione rispetto all’ingerenza altrui, ove pure consista in una cura da erogarsi in nome del mantenimento in vita. Lo stesso tipo di garanzia non è sostenibile per chi sia in stato di incapacità. La giurisprudenza ha da tempo individuato, come criterio di azione, l’autolegittimazione dell’intervento medico, in quanto dedito a curare e dotato all’uopo di convenienti capacità ed attitudini professionali. Secondo il ricorrente, resterebbe l’esigenza, di rango costituzionale, che il trattamento invasivo della persona, quando non sia e non possa essere assentito da chi lo subisce, sia erogato sotto il diretto controllo dell’autorità giudiziaria, in quanto sicuramente ricadente nell’ambito di applicazione dell’art. 13 Cost. La Corte d’appello di Milano avrebbe svolto, sotto questo profilo, un ragionamento alquanto contraddittorio. Per un verso, nel dichiarare ammissibile il ricorso del tutore, la Corte territoriale non avrebbe negato ed avrebbe anzi ammesso la necessità che il trattamento di cura invasivo della persona di XXX sia sottoposto al controllo dell’autorità giudiziaria; mentre, nel contempo e per altro verso, la stessa Corte avrebbe poi rifiutato, giudicando nel merito, di rilevare ogni e qualunque limite all’intervento del medico, quando il trattamento di cura incida sul diritto alla vita. Questa contraddizione, ad avviso del ricorrente, sarebbe frutto di una impostazione radicalmente errata, giacché l’autolegittimazione del medico ad intervenire, anche per trattamenti incidenti sul bene della vita, deve arrestarsi quando i trattamenti medesimi configurino ciò che costituisce accanimento terapeutico. Secondo il codice di deontologia medica (art. 14), il medico deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un 18 miglioramento della qualità della vita. In questo si rispecchiano l’idea di non accanirsi in trattamenti “futili”, presente nell’esperienza anglosassone, o le prescrizioni della riforma del Codice della salute francese introdotte dalla legge 2005-370 del 22 aprile 2005, sulla sospensione e la non erogazione, a titolo di “ostinazione irragionevole”, di trattamenti “inutili, sproporzionati o non aventi altro effetto che il solo mantenimento artificiale della vita”. Sicché, quando il trattamento è inutile, futile e non serve alla salute, sicuramente esso esula da ogni più ampio concetto di cura e di pratica della medicina, ed il medico, come professionista, non può praticarlo, se non invadendo ingiustificatamente la sfera personale del paziente (artt. 2, 13 e 32 Cost.). Il ricorrente contesta la tesi – fatta propria dalla Corte di Milano – secondo cui, poiché la conservazione della vita è un bene in sé, qualsiasi trattamento volto a tale scopo non potrebbe configurare accanimento. Difatti, in frangenti come quello in cui si trova XXX, non è lo spegnersi, bensì il protrarsi della vita ad essere artificiale, ad essere il mero prodotto dell’azione che un uomo compie nella sfera individuale di un’altra persona la quale, solo per tale via, viene, letteralmente, costretta a sopravvivere. Si sostiene che anche per i trattamenti tesi al prolungamento della vita altrui, come per qualunque altro trattamento medico, deve essere verificato se essi rechino un beneficio o un’utilità al paziente o non incorrano nel divieto di accanimento terapeutico. Ad avviso del ricorrente, il divieto di ostinazione in cure per cui non sia accertabile ed accertato un beneficio o un miglioramento della qualità della vita non sarebbe in contraddizione con il divieto di trattamenti diretti a provocare la morte: giacché una cosa è che il medico non debba uccidere, neppure sotto le mentite spoglie del curare; altra cosa è che il medico possa e debba astenersi da quei trattamenti che, pur suscettibili di prolungare il vivere, fosse accertato non rechino beneficio o utilità per il paziente, nel sottrarlo all’esito naturale e fatale dello stato in cui si trova e nel forzarlo a mantenere talune funzioni vitali. Nel ricorso si sostiene che il diritto alla vita è in uno - e non è contrapponibile, come viceversa vorrebbe la Corte d’appello milanese - con la garanzia dell’individualità umana di cui agli artt. 2, 13 e 32 Cost. Il modo normale di garantire l’individualità di un uomo è l’autodeterminazione; ma quando, come nel caso di XXX, l’autodeterminazione non è più possibile, perché la persona ha perso irreversibilmente coscienza e volontà, bisogna perlomeno assicurarsi che ciò che resta dell’individualità umana, in cui si ripone la “dignità” di cui discorrono gli artt. 2, 13 e 32 Cost., non vada perduta. E tale individualità andrebbe perduta qualora un’altra persona, diversa da quella che deve vivere, potesse illimitatamente ingerirsi nella sfera personale dell’incapace per manipolarla fin nell’intimo, fino al punto di imporre il mantenimento di funzioni vitali altrimenti perdute. Il divieto di accanimento terapeutico – si sostiene – nasce proprio da qui: esso nasce affinché l’intervento del medico, artificiale ed invasivo della sfera personale di chi è incapace e perciò inerme, sia entro i confini dati dall’autolegittimazione del medico come professionista, il quale, come tale, deve curare e quindi recare un tangibile vantaggio al suo paziente. Siffatta accurata verifica della utilità o del beneficio del trattamento per chi lo subisce andrebbe fatta proprio e soprattutto quando il trattamento miri a prolungare la vita, poiché “proprio e soprattutto quando il trattamento stesso miri a prolungare la vita, il medico, come professionista, si spinge al massimo dell’intromissione nella sfera individuale dell’altra persona, addirittura modificando, o quanto meno spostando, le frontiere tra la vita e la morte”. Certamente non ci si deve permettere, neppure ed anzi a maggior ragione per chi sia incapace o abbia minorazioni, di distinguere tra vite degne e non degne di essere vissute. Il che non toglie, tuttavia, che vi siano casi in cui, per il prolungamento artificiale della vita, non si dia riscontro di utilità o beneficio alcuno ed in cui, quindi, l’unico risultato prodotto dal trattamento o dalla cura è di 19 sancire il trionfo della scienza medica nel vincere l’esito naturale della morte. Tale trionfo è però un trionfo vacuo, ribaltabile in disfatta, se per il paziente e la sua salute non c’è altro effetto o vantaggio. Non è la vita in sé, che è un dono, a potere essere mai indegna; ad essere indegno può essere solo il protrarre artificialmente il vivere, oltre quel che altrimenti avverrebbe, solo grazie all’intervento del medico o comunque di un altro, che non è la persona che si costringe alla vita. La Corte d’appello di Milano, ad avviso del ricorrente, avrebbe inoltre finito con il travisare e distorcere il significato dell’istruttoria effettuata durante il giudizio, nel quale è stato appurato, per testi, il convincimento di XXX, anteriormente all’incidente che l’ha ridotta in stato vegetativo permanente, che sarebbe stato “meglio” morire piuttosto di avere quella che “non poteva considerarsi vita”. I convincimenti di XXX sarebbero stati chiesti e sarebbero stati oggetto di istruttoria non perché taluno potesse pensare che essi, manifestati in un tempo lontano, quando ancora XXX era in piena salute, valgano oggi come manifestazione di volontà idonea, equiparabile ad un dissenso in chiave attuale dai trattamenti che ella subisce. L’accertamento dei convincimenti di XXX, quando ancora poteva manifestarli, sarebbe stato richiesto e fatto, invece, perché la Corte d’appello, nel pronunciarsi sul mantenimento dell’idratazione e dell’alimentazione artificiali, potesse valutare e ponderare ogni elemento disponibile. Lo stato vegetativo permanente (SVP) in cui giace XXX è uno stato unico e differente da qualunque altro, non accostabile in alcun modo a stati di handicap o di minorità, ovvero a stati di eclissi della coscienza e volontà in potenza reversibili come il coma. Nello stato di SVP, a differenza che in altri, può darsi effettivamente il problema del riscontro di un qualunque beneficio o una qualunque utilità tangibile dei trattamenti o delle cure, solo finalizzate a posporre la morte sotto l’angolo visuale biologico. 2.1. – Con il primo motivo, illustrato con memoria, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 357 e 424 cod. civ., in relazione agli artt. 2, 13 e 32 Cost., il curatore speciale, ricorrente in via incidentale, chiede che sia affermato come principio di diritto il divieto di accanimento terapeutico. Ripercorrendo le medesime argomentazioni contenute nel ricorso principale, nel ricorso incidentale si sottolinea come XXX non sia in grado di esprimere alcun consenso riguardo ad atti che si configurano come invasivi della sua personale integrità psico-fisica, e si richiama la giurisprudenza costituzionale sull’attinenza della tutela della libertà personale a qualunque intromissione sul corpo o sulla psiche cui il soggetto non abbia consentito. Si pone l’accento sulla tutela della dignità umana, inscindibile da quella della vita stessa, come valore costituzionale, e si invoca, tra l’altro, l’art. 32 Cost., che preclude trattamenti sanitari che possano violare il rispetto della persona umana. Si sostiene che, quando il trattamento è inutile, futile e non serve alla salute, sicuramente esso esula da ogni più ampio concetto di cura e di pratica della medicina, ed il medico, come professionista, non può praticarlo, se non invadendo ingiustificatamente la sfera personale del paziente. 2.2. – Il secondo mezzo del ricorso incidentale denuncia omessa ed insufficiente motivazione circa il punto decisivo della controversia e chiede che la Corte si pronunci in ordine al principio che nessuno debba subire trattamenti invasivi sulla propria persona, ancorché finalizzati al prolungamento artificiale della vita, senza che ne sia concretamente ed effettivamente verificata l’utilità ed il beneficio. Ad avviso del ricorrente in via incidentale, l’osservanza del divieto di accanimento terapeutico doveva essere assicurata dalla Corte d’appello di Milano nell’accezione del divieto di attività svincolata dalla speranza di recupero del paziente, indipendentemente dall’essere il trattamento in questione finalizzato al mantenimento in vita. Anche nella memoria si sottolinea che la Corte d’appello erroneamente avrebbe, dopo averle ammesse, ritenuto ininfluenti le testimonianze delle amiche di XXX. Secondo il ricorrente in via incidentale, un’eventuale dichiarazione circa la propria volontà a non essere mantenuti in vita durante lo stato vegetativo permanente non può che essere formulata ex ante, da chi si trovi ancora in piena salute e perfettamente in grado di comprendere e di volere, non avendo alcuna rilevanza il fatto che la ragazza, allora, fosse in giovane età. Non sarebbe condivisibile il giudizio della Corte d’appello secondo cui le determinazioni di XXX avrebbero avuto valore solo nell’attualità della 20 malattia. 3. – Il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc civ., essendo entrambe le impugnazioni proposte contro lo stesso decreto. 4. – Trattandosi dell’impugnazione di un provvedimento depositato il 16 dicembre 2006 - quindi nella vigenza del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), in base alla disciplina transitoria recata dall’art. 27, comma 2 - il ricorso per cassazione per violazione di legge comprende la possibilità di dedurre, altresì, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi del novellato art. 360 cod. proc. civ. Le proposte impugnazioni vanno pertanto scrutinate anche là dove prospettano il vizio di cui al numero 5 del citato art. 360 cod. proc. civ. 5. – I motivi in cui si articolano il ricorso principale ed il ricorso incidentale, stante la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente. Essi investono la Corte - oltre che del quesito se la terapia praticata sul corpo di XXX YYY, consistente nell’alimentazione e nella idratazione artificiali mediante sondino nasogastrico, possa qualificarsi come una forma di accanimento terapeutico, sull’asserito rilievo che si verserebbe in fattispecie di trattamento invasivo della persona, senza alcun beneficio od utilità per la paziente che vada oltre il prolungamento forzoso della vita, perché oggettivamente finalizzato a preservarne una pura funzionalità meccanica e biologica – anche della questione se ed in che limiti, nella situazione data, possa essere interrotta quella somministrazione, ove la richiesta al riguardo presentata dal tutore corrisponda alle opinioni a suo tempo espresse da XXX su situazioni prossime a quella in cui ella stessa è venuta, poi, a trovarsi e, più in generale, ai di lei convincimenti sul significato della dignità della persona. Quest’ultima questione è preliminare in ordine logico. Dall’esame di essa, pertanto, conviene prendere le mosse. 6. – Occorre premettere che il consenso informato costituisce, di norma, legittimazione fondamento del trattamento sanitario: senza il consenso informato l’intervento del medico sicuramente illecito, anche quando è nell’interesse del paziente; la pratica del consenso libero informato rappresenta una forma di rispetto per la libertà dell’individuo e un mezzo per perseguimento dei suoi migliori interessi. e è e il Il principio del consenso informato – il quale esprime una scelta di valore nel modo di concepire il rapporto tra medico e paziente, nel senso che detto rapporto appare fondato prima sui diritti del paziente e sulla sua libertà di autodeterminazione terapeutica che sui doveri del medico – ha un sicuro fondamento nelle norme della Costituzione: nell’art. 2, che tutela e promuove i diritti fondamentali della persona umana, della sua identità e dignità; nell’art. 13, che proclama l’inviolabilità della libertà personale, nella quale “è postulata la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo” (Corte cost., sentenza n. 471 del 1990); e nell’art. 32, che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo, oltre che come interesse della collettività, e prevede la possibilità di trattamenti sanitari obbligatori, ma li assoggetta ad una riserva di legge, qualificata dal necessario rispetto della persona umana e ulteriormente specificata con l’esigenza che si prevedano ad opera del legislatore tutte le cautele preventive possibili, atte ad evitare il rischio di complicanze. Nella legislazione ordinaria, il principio del consenso informato alla base del rapporto tra medico e paziente è enunciato in numerose leggi speciali, a partire dalla legge istitutiva del Servizio sanitario 21 nazionale (legge 23 dicembre 1978, n. 833), la quale, dopo avere premesso, all’art. 1, che «La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana», sancisce, all’art. 33, il carattere di norma volontario degli accertamenti e dei trattamenti sanitari. A livello di fonti sopranazionali, il medesimo principio trova riconoscimento nella Convenzione del Consiglio d’Europa sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, resa esecutiva con la legge di autorizzazione alla ratifica 28 marzo 2001, n. 145, la quale, all’art. 5, pone la seguente “regola generale” (secondo la rubrica della disposizione): «Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé». Dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, adottata a Nizza il 7 dicembre 2000, si evince come il consenso libero e informato del paziente all’atto medico vada considerato, non soltanto sotto il profilo della liceità del trattamento, ma prima di tutto come un vero e proprio diritto fondamentale del cittadino europeo, afferente al più generale diritto all’integrità della persona (Capo I, Dignità; art. 3, Diritto all’integrità della persona). Nel codice di deontologia medica del 2006 si ribadisce (art. 35) che «Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente». Il principio del consenso informato è ben saldo nella giurisprudenza di questa Corte. Nelle sentenze della III Sezione civile 25 gennaio 1994, n. 10014, e 15 gennaio 1997, n. 364, si afferma che dall’autolegittimazione dell’attività medica non può trarsi la convinzione che il medico possa, di regola ed al di fuori di taluni casi eccezionali (allorché il paziente non sia in grado, per le sue condizioni, di prestare un qualsiasi consenso o dissenso, ovvero, più in generale, ove sussistano le condizioni dello stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen.), intervenire senza il consenso o malgrado il dissenso del paziente. Più di recente, Cass. civ., Sez. III, 14 marzo 2006, n. 5444, ha precisato che “la correttezza o meno del trattamento non assume alcun rilievo ai fini della sussistenza dell’illecito per violazione del consenso informato, essendo del tutto indifferente ai fini della configurazione della condotta omissiva dannosa e dell’ingiustizia del danno, la quale sussiste per la semplice ragione che il paziente, a causa del deficit di informazione, non è stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni”: il trattamento eseguito senza previa prestazione di un valido consenso è in violazione “tanto dell’art. 32, secondo comma, della Costituzione, quanto dell’art. 13 della Costituzione e dell’art. 33 della legge n. 833 del 1978, donde la lesione della situazione giuridica del paziente inerente alla salute ed all’integrità fisica”. “La legittimità di per sé dell’attività medica – ribadisce Cass. pen., Sez. IV, 11 luglio 2001-3 ottobre 2001 – richiede per la sua validità e concreta liceità, in principio, la manifestazione del consenso del paziente, il quale costituisce un presupposto di liceità del trattamento medicochirurgico. Il consenso afferisce alla libertà morale del soggetto ed alla sua autodeterminazione, nonché alla sua libertà fisica intesa come diritto al rispetto della propria integrità corporea, le quali sono tutte profili della libertà personale proclamata inviolabile dall’art. 13 Cost. Ne discende che non è attribuibile al medico un generale ‘diritto di curare’, a fronte del quale non avrebbe alcun rilievo la volontà dell’ammalato che si troverebbe in una posizione di ‘soggezione’ su cui il medico potrebbe ad libitum intervenire, con il solo limite della propria coscienza; appare, invece, aderente ai principi dell’ordinamento riconoscere al medico la facoltà o la potestà di curare, situazioni soggettive, queste, derivanti dall’abilitazione all’esercizio della professione sanitaria, le quali, tuttavia, per potersi estrinsecare abbisognano, di regola, del consenso della persona che al trattamento sanitario deve sottoporsi”. 6.1. – Il consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale. 22 Ciò è conforme al principio personalistico che anima la nostra Costituzione, la quale vede nella persona umana un valore etico in sé, vieta ogni strumentalizzazione della medesima per alcun fine eteronomo ed assorbente, concepisce l’intervento solidaristico e sociale in funzione della persona e del suo sviluppo e non viceversa, e guarda al limite del «rispetto della persona umana» in riferimento al singolo individuo, in qualsiasi momento della sua vita e nell’integralità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive. Ed è altresì coerente con la nuova dimensione che ha assunto la salute, non più intesa come semplice assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico e psichico, e quindi coinvolgente, in relazione alla percezione che ciascuno ha di sé, anche gli aspetti interiori della vita come avvertiti e vissuti dal soggetto nella sua esperienza. Deve escludersi che il diritto alla autodeterminazione terapeutica del paziente incontri un limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene della vita. Benché sia stato talora prospettato un obbligo per l’individuo di attivarsi a vantaggio della propria salute o un divieto di rifiutare trattamenti o di omettere comportamenti ritenuti vantaggiosi o addirittura necessari per il mantenimento o il ristabilimento di essa, il Collegio ritiene che la salute dell’individuo non possa essere oggetto di imposizione autoritativo-coattiva. Di fronte al rifiuto della cura da parte del diretto interessato, c’è spazio – nel quadro dell’“alleanza terapeutica” che tiene uniti il malato ed il medico nella ricerca, insieme, di ciò che è bene rispettando i percorsi culturali di ciascuno – per una strategia della persuasione, perché il compito dell’ordinamento è anche quello di offrire il supporto della massima solidarietà concreta nelle situazioni di debolezza e di sofferenza; e c’è, prima ancora, il dovere di verificare che quel rifiuto sia informato, autentico ed attuale. Ma allorché il rifiuto abbia tali connotati non c’è possibilità di disattenderlo in nome di un dovere di curarsi come principio di ordine pubblico. Lo si ricava dallo stesso testo dell’art. 32 della Costituzione, per il quale i trattamenti sanitari sono obbligatori nei soli casi espressamente previsti dalla legge, sempre che il provvedimento che li impone sia volto ad impedire che la salute del singolo possa arrecare danno alla salute degli altri e che l’intervento previsto non danneggi, ma sia anzi utile alla salute di chi vi è sottoposto (Corte cost., sentenze n. 258 del 1994 e n. 118 del 1996). Soltanto in questi limiti è costituzionalmente corretto ammettere limitazioni al diritto del singolo alla salute, il quale, come tutti i diritti di libertà, implica la tutela del suo risvolto negativo: il diritto di perdere la salute, di ammalarsi, di non curarsi, di vivere le fasi finali della propria esistenza secondo canoni di dignità umana propri dell’interessato, finanche di lasciarsi morire. Il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere scambiato per un’ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, esprimendo piuttosto tale rifiuto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale. E d’altra parte occorre ribadire che la responsabilità del medico per omessa cura sussiste in quanto esista per il medesimo l’obbligo giuridico di praticare o continuare la terapia e cessa quando tale obbligo viene meno: e l’obbligo, fondandosi sul consenso del malato, cessa – insorgendo il dovere giuridico del medico di rispettare la volontà del paziente contraria alle cure – quando il consenso viene meno in seguito al rifiuto delle terapie da parte di costui. Tale orientamento, prevalente negli indirizzi della dottrina, anche costituzionalistica, è già presente nella giurisprudenza di questa Corte. 23 La sentenza della I Sezione penale 29 maggio 2002-11 luglio 2002 afferma che, “in presenza di una determi-nazione autentica e genuina” dell’interessato nel senso del rifiuto della cura, il medico “non può che fermarsi, ancorché l’omissione dell’intervento terapeutico possa cagionare il pericolo di un aggravamento dello stato di salute dell’infermo e, persino, la sua morte”. Si tratta evidentemente – si precisa nella citata pronuncia – di ipotesi estreme, “che nella pratica raramente è dato di registrare, se non altro perché chi versa in pericolo di vita o di danno grave alla persona, a causa dell’inevitabile turbamento della coscienza generato dalla malattia, difficilmente è in grado di manifestare liberamente il suo intendimento”: “ma se così non è, il medico che abbia adempiuto il suo obbligo morale e professionale di mettere in grado il paziente di compiere la sua scelta e abbia verificato la libertà della scelta medesima, non può essere chiamato a rispondere di nulla, giacché di fronte ad un comportamento nel quale si mani-festa l’esercizio di un vero e proprio diritto, la sua astensione da qualsiasi iniziativa di segno contrario diviene doverosa, potendo, diversamente, configurarsi a suo carico persino gli estremi di un reato”. La soluzione, tratta dai principi costituzionali, relativa al rifiuto di cure ed al dovere del medico di astenersi da ogni attività diagnostica o terapeutica se manchi il consenso del paziente, anche se tale astensione possa provocare la morte, trova conferma nelle prescrizioni del codice di deontologia medica: ai sensi del citato art. 35, «in presenza di documentato rifiuto di persona capace», il medico deve «in ogni caso» «desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona». Inoltre tale soluzione è legislativamente sancita in altri ordinamenti europei. Significativo in questa direzione è l’art. 1111-10 del code de la santé publique francese, inserito dalla legge n. 2005-370 del 22 aprile 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, a tenore del quale «Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, décide de limiter ou d’arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l’avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical». Né la configurabilità di un dovere dell’individuo alla salute, comportante il dovere del paziente di non rifiutare cure e terapie che consentano il mantenimento in vita, può ricavarsi dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 29 aprile 2002, nel caso Pretty c. Regno Unito. La Corte di Strasburgo afferma che l’art. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali protegge il diritto alla vita, senza il quale il godimento di ciascuno degli altri diritti o libertà contenuto nella Convenzione diventa inutile, precisando che tale disposizione, per un verso, non può, senza che ne venga distorta la lettera, essere interpretata nel senso che essa attribuisca il diritto diametralmente opposto, cioè un diritto di morire, né, per l’altro verso, può creare un diritto di autodeterminazione nel senso di attribuire a un individuo la facoltà di scegliere la morte piuttosto che la vita. Siffatto principio – che il Collegio condivide pienamente e fa proprio – è utilizzato dalla Corte di Strasburgo non già per negare l’ammissibilità del rifiuto di cure da parte dell’interessato, ma per giudicare non lesivo del diritto alla vita il divieto penalmente sanzionato di suicidio assistito previsto dalla legislazione nazionale inglese ed il rifiuto, da parte del Director of Public Prosecutions, di garantire l’immunità dalle conseguenze penali al marito di una donna paralizzata e affetta da malattia degenerativa e incurabile, desiderosa di morire, nel caso in cui quest’ultimo le presti aiuto nel commettere suicidio. Coerentemente con tale impostazione, la stessa sentenza della Corte europea ha cura di sottolineare: che, in campo sanitario, il rifiuto di accettare un particolare trattamento potrebbe, inevitabilmente, condurre ad un esito fatale, e tuttavia l’imposizione di un trattamento medico senza il consenso di un paziente adulto e mentalmente consapevole interferirebbe con l’integrità fisica di una persona in maniera tale da poter coinvolgere i diritti protetti dall’art. 8.1 della Convenzione (diritto alla vita privata); e che una persona potrebbe pretendere di esercitare la scelta di morire rifiutandosi di acconsentire ad un trattamento potenzialmente idoneo a prolungare la vita. Analogamente, secondo la sentenza 26 giugno 1997 della Corte Suprema degli Stati Uniti, nel caso Vacco e altri c. Quill e altri, ciascuno, a prescindere dalla condizione fisica, è autorizzato, se capace, 24 a rifiutare un trattamento indesiderato per il mantenimento in vita, mentre a nessuno è permesso di prestare assistenza nel suicidio: il diritto di rifiutare i trattamenti sanitari si fonda sulla premessa dell’esistenza, non di un diritto generale ed astratto ad accelerare la morte, ma del diritto all’integrità del corpo e a non subire interventi invasivi indesiderati. 7. – Il quadro compositivo dei valori in gioco fin qui descritto, essenzialmente fondato sulla libera disponibilità del bene salute da parte del diretto interessato nel possesso delle sue capacità di intendere e di volere, si presenta in modo diverso quando il soggetto adulto non è in grado di manifestare la propria volontà a causa del suo stato di totale incapacità e non abbia, prima di cadere in tale condizione, allorché era nel pieno possesso delle sue facoltà mentali, specificamente indicato, attraverso dichiarazioni di volontà anticipate, quali terapie egli avrebbe desiderato ricevere e quali invece avrebbe inteso rifiutare nel caso in cui fosse venuto a trovarsi in uno stato di incoscienza. Anche in tale situazione, pur a fronte dell’attuale carenza di una specifica disciplina legislativa, il valore primario ed assoluto dei diritti coinvolti esige una loro immediata tutela ed impone al giudice una delicata opera di ricostruzione della regola di giudizio nel quadro dei principi costituzionali (cfr. Corte cost., sentenza n. 347 del 1998, punto n. 4 del Considerato in diritto). 7.1. – Risulta pacificamente dagli atti di causa che nella indicata situazione si trova XXX YYY, la quale giace in stato vegetativo persistente e permanente a seguito di un grave trauma cranicoencefalico riportato a seguito di un incidente stradale (occorsole quando era ventenne), e non ha predisposto, quando era in possesso della capacità di intendere e di volere, alcuna dichiarazione anticipata di trattamento. Questa condizione clinica perdura invariata dal gennaio 1992. In ragione del suo stato, XXX, pur essendo in grado di respirare spontaneamente, e pur conservando le funzioni cardiovascolari, gastrointestinali e renali, è radicalmente incapace di vivere esperienze cognitive ed emotive, e quindi di avere alcun contatto con l’ambiente esterno: i suoi riflessi del tronco e spinali persistono, ma non vi è in lei alcun segno di attività psichica e di partecipazione all’ambiente, né vi è alcuna capacità di risposta comportamentale volontaria agli stimoli sensoriali esterni (visivi, uditivi, tattili, dolorifici), le sue uniche attività motorie riflesse consistendo in una redistribuzione del tono muscolare. La sopravvivenza fisica di XXX, che versa in uno stato stabile ma non progressivo, è assicurata attraverso l’alimentazione e l’idratazione artificiali somministratele attraverso un sondino nasograstrico. XXX è stata interdetta ed il padre è stato nominato tutore. 7.2. – In caso di incapacità del paziente, la doverosità medica trova il proprio fondamento legittimante nei principi costituzionali di ispirazione solidaristica, che consentono ed impongono l’effettuazione di quegli interventi urgenti che risultino nel miglior interesse terapeutico del paziente. E tuttavia, anche in siffatte evenienze, superata l’urgenza dell’intervento derivante dallo stato di necessità, l’istanza personalistica alla base del principio del consenso informato ed il principio di parità di trattamento tra gli individui, a prescindere dal loro stato di capacità, impongono di ricreare il dualismo dei soggetti nel processo di elaborazione della decisione medica: tra medico che deve informare in ordine alla diagnosi e alle possibilità terapeutiche, e paziente che, attraverso il legale rappresentante, possa accettare o rifiutare i trattamenti prospettati. Centrale, in questa direzione, è la disposizione dell’art. 357 cod. civ., la quale – letta in connessione con l’art. 424 cod. civ. –, prevede che «Il tutore ha la cura della persona» dell’interdetto, così investendo il tutore della legittima posizione di soggetto interlocutore dei medici nel decidere sui 25 trattamenti sanitari da praticare in favore dell’incapace. Poteri di cura del disabile spettano altresì alla persona che sia stata nominata amministratore di sostegno (artt. 404 e ss. cod. civ., introdotti dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6), dovendo il decreto di nomina contenere l’indicazione degli atti che questa è legittimata a compiere a tutela degli interessi di natura anche personale del beneficiario (art. 405, quarto comma, cod. civ.). A conferma di tale lettura delle norme del codice può richiamarsi la sentenza 18 dicembre 1989, n. 5652, di questa Sezione, con la quale si è statuito che, in tema di interdizione, l’incapacità di provvedere ai propri interessi, di cui all’art. 414 cod. civ., va riguardata anche sotto il profilo della protezione degli interessi non patrimoniali, potendosi avere ipotesi di assoluta necessità di sostituzione della volontà del soggetto con quella della persona nominata tutore pure in assenza di patrimoni da proteggere. Ciò avviene – è la stessa sentenza a precisarlo – nel caso del soggetto “la cui sopravvivenza è messa in pericolo da un suo rifiuto (determinato da infermità psichica) ad interventi esterni di assistenza quali il ricovero in luogo sicuro e salubre od anche il ricovero in ospedale” per trattamenti sanitari: qui il ricorso all’(allora unico istituto dell’)interdizione è giustificato in vista dell’esigenza di sostituire il soggetto deputato a esprimere la volontà in ordine al trattamento proposto. E, sempre nella medesima direzione, possono ricordarsi le prime applicazioni dei giudici di merito con riguardo al limitrofo istituto dell’amministratore di sostegno, talora utilizzato, in campo medico-sanitario, per assecondare l’esercizio dell’autonomia e consentire la manifestazione di una volontà autentica là dove lo stato di decadimento cognitivo impedisca di esprimere un consenso realmente consapevole. E’ soprattutto il tessuto normativo a recare significative disposizioni sulla rappresentanza legale in ordine alle cure e ai trattamenti sanitari. Secondo l’art. 4 del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 211 (Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico), la sperimentazione clinica degli adulti incapaci che non hanno dato o non hanno rifiutato il loro consenso informato prima che insorgesse l’incapacità, è possibile a condizione, tra l’altro, che «sia stato ottenuto il consenso informato del legale rappresentante»: un consenso – prosegue la norma – che «deve rappresentare la presunta volontà del soggetto». Ancora, l’art. 13 della legge sulla tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza (legge 22 maggio 1978, n. 194), disciplinando il caso della donna interdetta per infermità di mente, dispone: che la richiesta di interruzione volontaria della gravidanza, sia entro i primi novanta giorni che trascorso tale periodo, può essere presentata, oltre che dalla donna personalmente, anche dal tutore; che nel caso di richiesta avanzata dall’interdetta deve essere sentito il parere del tutore; che la richiesta formulata dal tutore deve essere confermata dalla donna. Più direttamente – e con una norma che, essendo relativa a tutti i trattamenti sanitari, esibisce il carattere della regola generale – l’art. 6 della citata Convenzione di Oviedo – rubricato Protection des personnes n’ayant la capacité de consentir – prevede che «Lorsque, selon la loi, un majeur n’a pas, en raison d’un handicap mental, d’une maladie ou pour un motif similaire, la capacité de consentir à une intervention, celleci ne peut être effectuée sans l’autorisation de son représentant, d’une autorité ou d’une personne ou instance désignée par la loi», precisando che «une intervention ne peut être effectuée sur une personne n’ayant pas la capacité de consentir, que pour son bénéfice direct». E – come esplicita il rapporto esplicativo alla Convenzione – quando utilizza l’espressione «pour un motif similare», il citato art. 6 si riferisce alle situazioni, quali, ad esempio, gli stati comatosi, in cui il paziente è incapace di formulare i suoi desideri o di comunicarli. Ora, è noto che, sebbene il Parlamento ne abbia autorizzato la ratifica con la legge 28 marzo 2001, n. 145, la Convenzione di Oviedo non è stata a tutt’oggi ratificata dallo Stato italiano. Ma da ciò non consegue che la Convenzione sia priva di alcun effetto nel nostro ordinamento. Difatti, all’accordo valido sul piano internazionale, ma non ancora eseguito all’interno dello Stato, può 26 assegnarsi – tanto più dopo la legge parlamentare di autorizzazione alla ratifica – una funzione ausiliaria sul piano interpretativo: esso dovrà cedere di fronte a norme interne contrarie, ma può e deve essere utilizzato nell’interpretazione di norme interne al fine di dare a queste una lettura il più possibile ad esso conforme. Del resto, la Corte costituzionale, nell’ammettere le richieste di referendum su alcune norme della legge 19 febbraio 2004, n. 40, concernente la procreazione medicalmente assistita, ha precisato che l’eventuale vuoto conseguente al referendum non si sarebbe posto in alcun modo in contrasto con i principi posti dalla Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, recepiti nel nostro ordinamento con la legge 28 marzo 2001, n. 145 (Corte cost., sentenze n. 46, 47, 48 e 49 del 2005): con ciò implicitamente confermando che i principi da essa posti fanno già oggi parte del sistema e che da essi non si può prescindere. 7.3. - Assodato che i doveri di cura della persona in capo al tutore si sostanziano nel prestare il consenso informato al trattamento medico avente come destinatario la persona in stato di incapacità, si tratta di stabilire i limiti dell’intervento del rappresentante legale. Tali limiti sono connaturati al fatto che la salute è un diritto personalissimo e che – come questa Corte ha precisato nell’ordinanza 20 aprile 2005, n. 8291 – la libertà di rifiutare le cure “presuppone il ricorso a valutazioni della vita e della morte, che trovano il loro fondamento in concezioni di natura etica o religiosa, e comunque (anche) extragiuridiche, quindi squisitamente soggettive”. Ad avviso del Collegio, il carattere personalissimo del diritto alla salute dell’incapace comporta che il riferimento all’istituto della rappresentanza legale non trasferisce sul tutore, il quale è investito di una funzione di diritto privato, un potere incondizionato di disporre della salute della persona in stato di totale e permanente incoscienza. Nel consentire al trattamento medico o nel dissentire dalla prosecuzione dello stesso sulla persona dell’incapace, la rappresentanza del tutore è sottoposta a un duplice ordine di vincoli: egli deve, innanzitutto, agire nell’esclusivo interesse dell’incapace; e, nella ricerca del best interest, deve decidere non “al posto” dell’incapace né “per” l’incapace, ma “con” l’incapace: quindi, ricostruendo la presunta volontà del paziente incosciente, già adulto prima di cadere in tale stato, tenendo conto dei desideri da lui espressi prima della perdita della coscienza, ovvero inferendo quella volontà dalla sua personalità, dal suo stile di vita, dalle sue inclinazioni, dai suoi valori di riferimento e dalle sue convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche. L’uno e l’altro vincolo al potere rappresentativo del tutore hanno, come si è visto, un preciso referente normativo: il primo nell’art. 6 della Convenzione di Oviedo, che impone di correlare al «bénéfice direct» dell’interessato la scelta terapeutica effettuata dal rappresentante; l’altro nell’art. 5 del d.lgs. n. 211 del 2003, ai cui sensi il consenso del rappresentante legale alla sperimentazione clinica deve corrispondere alla presunta volontà dell’adulto incapace. Non v’è dubbio che la scelta del tutore deve essere a garanzia del soggetto incapace, e quindi rivolta, oggettivamente, a preservarne e a tutelarne la vita. Ma, al contempo, il tutore non può nemmeno trascurare l’idea di dignità della persona dallo stesso rappresentato manifestata, prima di cadere in stato di incapacità, dinanzi ai problemi della vita e della morte. 7.4. – Questa attenzione alle peculiari circostanze del caso concreto e, soprattutto, ai convincimenti espressi dal diretto interessato quando era in condizioni di capacità, è costante, sia pure nella diversità dei percorsi argomentativi seguiti, nelle decisioni adottate in altri ordinamenti dalle Corti nelle controversie in ordine alla sospensione delle cure (ed anche dell’alimentazione e idratazione artificiali) per malati in stato vegetativo permanente, in situazioni di mancanza di testamenti di vita. Nel leading case in re Quinlan, la Corte Suprema del New Jersey, nella sentenza 31 marzo 1976, adotta la dottrina – seguita dalla stessa Corte nella sentenza 24 giugno 1987, in re Nancy Ellen Jobes – del substituted judgement test, sul rilievo che questo approccio è inteso ad assicurare che 27 chi decide in luogo dell’interessato prenda, per quanto possibile, la decisione che il paziente incapace avrebbe preso se capace. Allorché i desideri di un capace non siano chiaramente espressi, colui che decide in sua vece deve adottare come linea di orientamento il personale sistema di vita del paziente: il sostituto deve considerare le dichiarazioni precedenti del paziente in merito e le sue reazioni dinanzi ai problemi medici, ed ancora tutti gli a-petti della personalità del paziente familiari al sostituto, ovviamente con riguardo, in particolare, ai suoi valori di ordine filosofico, teologico ed etico, tutto ciò al fine di individuare il tipo di trattamento medico che il paziente prediligerebbe. Nella sentenza 25 giugno 1990 nel caso Cruzan, la Corte Suprema degli Stati Uniti statuisce che la Costituzione degli USA non proibisce allo Stato del Missouri di stabilire “a procedural safeguard to assure that the action of the surrogate conforms as best it may to the wishes expressed by the patient while competent”. Nella sentenza 17 marzo 2003, il Bundesgerichtshof – dopo avere premesso che se un paziente non è capace di prestare il consenso e la sua malattia ha iniziato un decorso mortale irreversibile, devono essere evitate misure atte a prolungargli la vita o a mantenerlo in vita qualora tali cure siano contrarie alla sua volontà espressa in precedenza sotto forma di cosiddetta disposizione del paziente (e ciò in considerazione del fatto che la dignità dell’essere umano impone di rispettare il suo diritto di autodeterminarsi, esercitato in situazione di capacità di esprimere il suo consenso, anche nel momento in cui questi non è più in grado di prendere decisioni consapevoli) – afferma che, allorché non è possibile accertare tale chiara volontà del paziente, si può valutare l’ammissibilità di tali misure secondo la presunta volontà del paziente, la quale deve, quindi, essere identificata, di volta in volta, anche sulla base delle decisioni del paziente stesso in merito alla sua vita, ai suoi valori e alle sue convinzioni. Nel caso Bland, l’House of Lords 4 febbraio 1993, utilizzando la diversa tecnica del best interest, perviene alla conclusione (particolarmente articolata nel parere di Lord Goff of Chieveley) secondo cui, in assenza di trattamenti autenticamente curativi, e data l’impossibilità di recupero della coscienza, è contrario al miglior interesse del paziente protrarre la nutrizione e l’idratazione artificiali, ritenute trattamenti invasivi ingiustificati della sua sfera corporea. 7.5. – Chi versa in stato vegetativo permanente è, a tutti gli effetti, persona in senso pieno, che deve essere rispettata e tutelata nei suoi diritti fondamentali, a partire dal diritto alla vita e dal diritto alle prestazioni sanitarie, a maggior ragione perché in condizioni di estrema debolezza e non in grado di provvedervi autonomamente. La tragicità estrema di tale stato patologico – che è parte costitutiva della biografia del malato e che nulla toglie alla sua dignità di essere umano – non giustifica in alcun modo un affievolimento delle cure e del sostegno solidale, che il Servizio sanitario deve continuare ad offrire e che il malato, al pari di ogni altro appartenente al consorzio umano, ha diritto di pretendere fino al sopraggiungere della morte. La comunità deve mettere a disposizione di chi ne ha bisogno e lo richiede tutte le migliori cure e i presidi che la scienza medica è in grado di apprestare per affrontare la lotta per restare in vita, a prescindere da quanto la vita sia precaria e da quanta speranza vi sia di recuperare le funzioni cognitive. Lo reclamano tanto l’idea di una universale eguaglianza tra gli esseri umani quanto l’altrettanto universale dovere di solidarietà nei confronti di coloro che, tra essi, sono i soggetti più fragili. Ma – accanto a chi ritiene che sia nel proprio miglior interesse essere tenuto in vita artificialmente il più a lungo possibile, anche privo di coscienza – c’è chi, legando indissolubilmente la propria dignità alla vita di esperienza e questa alla coscienza, ritiene che sia assolutamente contrario ai propri convincimenti sopravvivere indefinitamente in una condizione di vita priva della percezione del mondo esterno. 28 Uno Stato, come il nostro, organizzato, per fondamentali scelte vergate nella Carta costituzionale, sul pluralismo dei valori, e che mette al centro del rapporto tra paziente e medico il principio di autodeterminazione e la libertà di scelta, non può che rispettare anche quest’ultima scelta. All’individuo che, prima di cadere nello stato di totale ed assoluta incoscienza, tipica dello stato vegetativo permanente, abbia manifestato, in forma espressa o anche attraverso i propri convincimenti, il proprio stile di vita e i valori di riferimento, l’inaccettabilità per sé dell’idea di un corpo destinato, grazie a terapie mediche, a sopravvivere alla mente, l’ordinamento dà la possibilità di far sentire la propria voce in merito alla disattivazione di quel trattamento attraverso il rappresentante legale. Ad avviso del Collegio, la funzionalizzazione del potere di rappresentanza, dovendo esso essere orientato alla tutela del diritto alla vita del rappresentato, consente di giungere ad una interruzione delle cure soltanto in casi estremi: quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre che la persona abbia la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una vita fatta anche di percezione del mondo esterno; e sempre che tale condizione – tenendo conto della volontà espressa dall’interessato prima di cadere in tale stato ovvero dei valori di riferimento e delle convinzioni dello stesso – sia incompatibile con la rappresentazione di sé sulla quale egli aveva costruito la sua vita fino a quel momento e sia contraria al di lui modo di intendere la dignità della persona. Per altro verso, la ricerca della presunta volontà della persona in stato di incoscienza – ricostruita, alla stregua di chiari, univoci e convincenti elementi di prova, non solo alla luce dei precedenti desideri e dichiarazioni dell’interessato, ma anche sulla base dello stile e del carattere della sua vita, del suo senso dell’integrità e dei suoi interessi critici e di esperienza – assicura che la scelta in questione non sia espressione del giudizio sulla qualità della vita proprio del rappresentante, ancorché appartenente alla stessa cerchia familiare del rappresentato, e che non sia in alcun modo condizionata dalla particolare gravosità della situazione, ma sia rivolta, esclusivamente, a dare sostanza e coerenza all’identità complessiva del paziente e al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona. Il tutore ha quindi il compito di completare questa identità complessiva della vita del paziente, ricostruendo la decisione ipotetica che egli avrebbe assunto ove fosse stato capace; e, in questo compito, umano prima che giuridico, non deve ignorare il passato dello stesso malato, onde far emergere e rappresentare al giudice la sua autentica e più genuina voce. Da quanto sopra deriva che, in una situazione cronica di oggettiva irreversibilità del quadro clinico di perdita assoluta della coscienza, può essere dato corso, come estremo gesto di rispetto dell’autonomia del malato in stato vegetativo permanente, alla richiesta, proveniente dal tutore che lo rappresenta, di interruzione del trattamento medico che lo tiene artificialmente in vita, allorché quella condizione, caratterizzante detto stato, di assenza di sentimento e di esperienza, di relazione e di conoscenza – proprio muovendo dalla volontà espressa prima di cadere in tale stato e tenendo conto dei valori e delle convinzioni propri della persona in stato di incapacità – si appalesi, in mancanza di qualsivoglia prospettiva di regressione della patologia, lesiva del suo modo di intendere la dignità della vita e la sofferenza nella vita. 7.6. - Non v’è dubbio che l’idratazione e l’alimentazione artificiali con sondino nasogastrico costituiscono un trattamento sanitario. Esse, infatti, integrano un trattamento che sottende un sapere scientifico, che è posto in essere da medici, anche se poi proseguito da non medici, e consiste nella somministrazione di preparati come composto chimico implicanti procedure tecnologiche. Siffatta qualificazione è, del resto, convalidata dalla comunità scientifica internazionale; trova il sostegno della giurisprudenza nel caso Cruzan e nel caso Bland; si allinea, infine, agli orientamenti della giurisprudenza costituzionale, la quale ricomprende il prelievo 29 ematico – anch’esso “pratica medica di ordinaria amministrazione” – tra le misure di “restrizione della libertà personale quando se ne renda necessaria la esecuzione coattiva perché la persona sottoposta all’esame peritale non acconsente spontaneamente al prelievo” (sentenza n. 238 del 1996). 8. – Diversamente da quanto mostrano di ritenere i ricorrenti, al giudice non può essere richiesto di ordinare il distacco del sondino nasogastrico: una pretesa di tal fatta non è configurabile di fronte ad un trattamento sanitario, come quello di specie, che, in sé, non costituisce oggettivamente una forma di accanimento terapeutico, e che rappresenta, piuttosto, un presidio proporzionato rivolto al mantenimento del soffio vitale, salvo che, nell’imminenza della morte, l’organismo non sia più in grado di assimilare le sostanze fornite o che sopraggiunga uno stato di intolleranza, clinicamente rilevabile, collegato alla particolare forma di alimentazione. Piuttosto, l’intervento del giudice esprime una forma di controllo della legittimità della scelta nell’interesse dell’incapace; e, all’esito di un giudizio effettuato secondo la logica orizzontale compositiva della ragionevolezza, la quale postula un ineliminabile riferimento alle circostanze del caso concreto, si estrinseca nell’autorizzare o meno la scelta compiuta dal tutore. Sulla base delle considerazioni che precedono, la decisione del giudice, dato il coinvolgimento nella vicenda del diritto alla vita come bene supremo, può essere nel senso dell’autorizzazione soltanto (a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre che la persona abbia la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, concordanti e convincenti, della voce del rappresentato, tratta dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona. Allorché l’una o l’altra condizione manchi, il giudice deve negare l’autorizzazione, dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato, dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa, nonché dalla mera logica utilitaristica dei costi e dei benefici. 9. – Nei limiti appena tratteggiati, il decreto impugnato non si sottrae alle censure dei ricorrenti. Esso ha omesso di ricostruire la presunta volontà di XXX e di dare rilievo ai desideri da lei precedentemente espressi, alla sua personalità, al suo stile di vita e ai suoi più intimi convincimenti. Sotto questo profilo, la Corte territoriale – a fronte dell’indagine istruttoria, nella quale è stato appurato, per testi, che XXX, esprimendosi su una situazione prossima a quella in cui ella stessa sarebbe venuta, poi, a trovarsi, aveva manifestato l’opinione che sarebbe stato per lei preferibile morire piuttosto che vivere artificialmente in una situazione di coma – si è limitata a osservare che quei convincimenti, manifestatisi in un tempo lontano, quando ancora XXX era in piena salute, non potevano valere come manifestazione di volontà idonea, equiparabile ad un dissenso in chiave attuale in ordine ai trattamenti praticati sul suo corpo. Ma i giudici d’appello non hanno affatto verificato se tali dichiarazioni – della cui attendibilità non hanno peraltro dubitato -, ritenute inidonee a configurarsi come un testamento di vita, valessero comunque a delineare, unitamente alle altre risultanze dell’istruttoria, la personalità di XXX e il suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona, alla luce dei suoi valori di riferimento e dei convincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici che orientavano le sue determinazioni volitive; e quindi hanno omesso di accertare se la richiesta di 30 interruzione del trattamento formulata dal padre in veste di tutore riflettesse gli orientamenti di vita della figlia. Tale accertamento dovrà essere effettuato dal giudice del rinvio, tenendo conto di tutti gli elementi emersi dall’istruttoria e della convergente posizione assunta dalle parti in giudizio (tutore e curatore speciale) nella ricostruzione della personalità della ragazza. 10. – Assorbito l’esame della questione di legittimità costituzionale, i ricorsi sono accolti, nei sensi di cui in motivazione e nei limiti in essa indicati. Ne segue la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa ad una diversa Sezione della Corte d’appello di Milano. Detta Corte deciderà adeguandosi al seguente principio di diritto: «Ove il malato giaccia da moltissimi anni (nella specie, oltre quindici) in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l’applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell’interesse del paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti: (a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona. Ove l’uno o l’altro presuppoto non sussista, il giudice deve negare l’autorizzazione, dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa». 11. – Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 52, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), a tutela dei diritti e della dignità delle persone coinvolte deve essere disposta, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’omissione delle indicazioni delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza. P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, li accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa a diversa Sezione della Corte d’appello di Milano. Dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza. 31 7. CASSAZIONE CIVILE , SEZ. III, SENTENZA 15.09.2008 N° 23676 MEDICO, OPERAZIONE, CONSENSO DELLA VITTIMA, TESTIMONE DI GEOVA, NECESSITÀ Medico - operazione – consenso della vittima – Testimone di Geova – necessità – precisazioni – urgenza – pericolo di vita Nell'ipotesi di pericolo grave ed immediato per la vita del paziente, il dissenso del medesimo deve essere oggetto di manifestazione espressa, inequivoca, attuale, informata. Esso deve, cioè, esprimere una volontà non astrattamente ipotetica ma concretamente accertata; un'intenzione non meramente programmatica ma affatto specifica; una cognizione dei fatti non soltanto “ideologica”, ma frutto di informazioni specifiche in ordine alla propria situazione sanitaria; un giudizio e non una “precomprensione”: in definitiva, un dissenso che segua e non preceda l'informazione avente ad oggetto la rappresentazione di un pericolo di vita imminente e non altrimenti evitabile, un dissenso che suoni attuale e non preventivo, un rifiuto ex post e non ex ante, in mancanza di qualsivoglia consapevolezza della gravità attuale delle proprie condizioni di salute. E ciò perché, a fronte di un sibillino sintagma “niente sangue” vergato su un cartellino, sul medico curante graverebbe in definitiva il compito (invero insostenibile) di ricostruire sul piano della causalità ipotetica la reale volontà del paziente secondo un giudizio prognostico ex ante, e di presumere induttivamente la reale “resistenza” delle sue convinzioni religiose a fronte dell'improvviso, repentino, non altrimenti evitabile insorgere di un reale pericolo di vita, scongiurabile soltanto con una trasfusione di sangue. Di talché, come la validità di un consenso preventivo ad un trattamento sanitario non appare in alcun modo legittimamente predicabile in assenza della doverosa, completa, analitica informazione sul trattamento stesso, così la efficacia di uno speculare dissenso ex ante, privo di qualsiasi informazione medico-terapeutica, deve ritenersi altrettanto impredicabile, sia in astratto che in concreto, qualora il paziente, in stato di incoscienza, non sia in condizioni di manifestarlo. Svolgimento del processo G.M., nel convenire in giudizio dinanzi al tribunale di X. la locale USL n. ****, espose che, nel gennaio del 1990, in conseguenza di una serie di trasfusioni di sangue praticategli nell'ospedale di **** nonostante egli, in qualità di testimone di Geova, fosse contrario, per motivi religiosi, a tale pratica terapeutica (circostanza emergente da un cartellino, che egli portava con sé, recante la dicitura "niente sangue"), aveva subito danni morali e biologici. Di questi chiese, pertanto, l'integrale risarcimento, ivi compresi quelli conseguenti ad una infezione virale da epatite B da lui contratta a seguito del trattamento terapeutico ricevuto. La USL, nel costituirsi, osservò, in limine, che, non essendo stato possibile ottenere il consenso del paziente, era stata richiesta ed ottenuta una autorizzazione dal locale procuratore della Repubblica, e rilevò altresì, a sostegno del proprio assunto difensivo volto ad escludere ogni responsabilità dei sanitari, che il paziente era stato condotto presso il nosocomio in stato di perdita di conoscenza ed in pericolo di vita, peraltro scongiurabile attraverso una trasfusione di sangue. Venne disposta ed esperita una consulenza medico legale, che dichiarò necessarie gran parte delle trasfusioni al fine di salvare la vita del paziente, nonché idoneo il sangue trasfuso, con conseguente estraneità dell'intervento terapeutico alla trasmissione del virus dell'epatite sì come lamentato dal G.. L'adito tribunale, in accoglimento della domanda attorea, condannò la USL al risarcimento dei danni, distinti, nella specie, secondo una duplice qualificazione, la prima definita morale esistenziale, la seconda biologica. 32 La sentenza fu impugnata dalla convenuta dinanzi alla corte di appello di Trieste, la quale, riunitone il gravame con quello incidentale proposto dal G., osservò, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità: 1) che la circostanza secondo cui, nel periodo di degenza funzionale all'esecuzione delle trasfusioni, il paziente versava in stato di incoscienza o semi incoscienza (e comunque in una condizione tale da non poter essere assolutamente informato della situazione clinica) doveva ritenersi pacifica; 2) che non appariva seriamente contestabile la configurabilità, nel nostro ordinamento, di un diritto, costituzionalmente garantito, a non subire trattamenti sanitari indesiderati (ad eccezione dì quelli predeterminati per legge); 3) che a tale, astratta configurabilità in aure conseguiva la insuperabile liceità di un dissenso manifestato, per motivi religiosi, alle trasfusioni di sangue; 4) che a fronte di tale diritto del paziente si poneva, peraltro, il potere/dovere dei medici ospedalieri di apprestare tutte le cure idonee ad evitare ogni pregiudizio grave e immediato alla salute del medesimo; 5) che, in particolare, nella ipotesi dì pericolo grave e immediato per la vita del paziente, il dissenso di costui al trattamento necessario doveva essere manifestato in maniera chiara, attuale, informata; 6) che l'esistenza di tale dissenso non poteva, nella specie, ritenersi legittimamente predicabile per il solo fatto che il G. portasse con sé un cartellino recante la scritta "niente sangue": tale circostanza poteva, difatti, al più esprimere, al riguardo, una volontà non concreta ma astratta, non specifica ma programmatica, non informata ma ideologica, e, soprattutto, passata, preventiva, non attuale; 7) che nessun valore legale poteva, nella specie, essere attribuito alle informazioni fornite ai sanitari dai parenti del G., così come del tutto ininfluente doveva specularmene ritenersi l'anomalo intervento autorizzativo promanante (quasi in guisa di assoluzione preventiva) dalla locale procura della Repubblica; 8) che del tutto irrilevante si appalesava, inoltre, il numero delle trasfusioni eseguite ai fini risarcitori invocati dal paziente; 9) che dalle risultanze della CTU emergeva, ancora, come il nesso di causalità tra le trasfusioni e l'infezione da epatite B non potesse dirsi in alcun modo sussistente, potendo la malattia accusata dal Gassato due mesi dopo le trasfusioni ben essere stata conseguenza di altre vicende, quali l'uso di cose in comune con persone infette, rapporti sessuali, cure dentali, scarsa igiene ecc.. La sentenza della corte territoriale è stata impugnata da G. M. con ricorso per cassazione sorretto da 4 motivi di gravame. Resiste con controricorso la gestione liquidatoria della soppressa USL **** di X.. Parte ricorrente ha depositato tempestiva memoria. Motivi della decisione Va preliminarmente esaminata la questione procedurale riproposta dinanzi a questa corte dalla controricorrente in ordine al preteso difetto di legittimazione passiva della gestione liquidatoria della 33 soppressa USL. Essa è priva di giuridico fondamento, giusta una più che consolidata giurisprudenza di questa corte regolatrice formatasi in tema di interruzione del processo (e pluribus, Cass. 21378/2005; 19947/2004; 11269/2004; 9911/1998), a mente della quale la perdita di capacità processuale di una parte non spiega effetti nei confronti delle altre parti se l'evento interruttivo non sia dichiarato in udienza, ovvero notificato fuori udienza, alle controparti medesime: emerge, di converso, dalla lettura della sentenza di appello (f. 10) che la difesa della gestione liquidatoria ebbe a costituirsi inqualità di appellante nel giudizio di secondo grado senza mai sollevare questioni di legittimazione passiva o di estinzione del giudizio per perdita della capacità processuale della parte assistita. Dall'esame del merito del ricorso principale emerge la fondatezza del terzo motivo, mentre le restanti doglianze svolte dalla difesa del G. non possono trovare accoglimento. Con il primo motivo, si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia: rilevanza rifiuto di del trattamento medico espresso in precedenza da paziente in stato di incoscienza. Con il secondo motivo, si denuncia, ancora, contraddittorietà e comunque insufficienza della motivazione su punti decisivi della controversia: numero e necessità delle trasfusioni - mancato intervento di emostasi. Con il quarto motivo, si denuncia, infine, violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 13 Cost., comma 1 e art. 32 Cost., comma 2. I motivi, benché caratterizzati da indiscutibile vis argomentativa, e da non trascurabili suggestioni etiche, non possono essere accolti. Dal loro complessivo contenuto (che ne rende legittimo l'esame congiunto, attesane la intrinseca connessione logico-giuridica), emerge una serrata critica della sentenza impugnata - sotto il profilo tanto della violazione di legge quanto del deficit di motivazione -che si sostanzia nel contestare al giudice del merito la mancata considerazione del dissenso a qualsiasi attività trasfusionale espresso dal paziente attraverso il cartellino recante la scritta "niente sangue". Le articolate e complesse motivazioni poste a fondamento di tale doglianza non colgono nel segno. Essi si infrangono, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d'appello nella parte in cui questi ha ritenuto di esaminare e raffrontare il comportamento dei medici con quello del paziente secondo un'indagine di tipo diacronico, scandendo i tempi del (negato) consenso secondo una condivisibile analisi "progressiva" della sua rilevanza contenutistica sub specie della necessità, nella specie non predicabile, di una manifestazione espressa, inequivoca, attuale, in relazione alla gravita della situazione medica prospettatasi fin dal momento del ricovero in ospedale. Suggestivamente osserva in proposito il ricorrente che sarebbe "precisamente in previsione di situazioni di drammatica emergenza, nelle quali non si sarebbe trovato in grado di manifestare direttamente a voce la sua contrarietà a tale trattamento terapeutico che G.M. si è munito del famoso documento attestante il suo rifiuto assoluto di subire trasfusioni di sangue", soggiungendo ancora che "la scelta di premunirsi di tale apposito documento, sottoscritto personalmente e controfirmato da testimoni" avrebbe "precisamente lo scopo di rendere sempre noto ed inequivocabile, in qualsiasi situazione ci si venga a trovare, il dissenso motivatamente espresso ad una determinata pratica medica, quale che sia la situazione in cui se ne determini la necessità e 34 qualunque sia la conseguenza di tale scelta"; e si rammenta, in proposito, che, ai sensi del D.M. sanità 15 gennaio 1991, art. 19 "la trasfusione di sangue necessita del consenso informato del ricevente"; che, ai sensi del cit. D.M., art. 12, "il ricevente la trasfusione ... è tenuto ad esprimere per iscritto il proprio consenso o dissenso; che, infine, la L. n. 145 del 2001, nel ratificare la convenzione del consiglio d'Europa sulla protezione dei diritti dell'uomo riguardo all'applicazione della biologia e della medicina, all'art. 5 stabilisce che "un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato, aggiungendo poi, all'art. 8, che, allorquando, in una situazione di urgenza, il consenso appropriato non può essere ottenuto, si potrà procedere immediatamente a qualsiasi intervento medico indispensabile per il beneficio della salute della persona interessata, ma precisando poi, all'art. 9, che i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione". Tali doglianze non possono essere condivise. Va in premessa osservato come il collegio non intenda punto negare il più generale principio (di indubbia rilevanza costituzionale, cheemerge, tra l'altro, tanto dal codice di deontologia medica quanto dal documento 20.6.1992 del comitato nazionale per la bioetica) in forza del quale va riconosciuto al paziente un vero e proprio diritto di non curarsi, anche se tale condotta lo esponga al rischio stesso della vita. Né pare seriamente contestabile quanto sostenuto da un'attenta dottrina in tema di consenso informato nella trasfusione di sangue, e cioè che, in subiecta materia., deve ritenersi diversa, rispetto ai casi ordinari, la fattispecie in cui sia il testimone di Geova, maggiorenne e pienamente capace, a negare il consenso alla terapia trasfusionale, essendo in tal caso il medico obbligato alla desistenza da qualsiasi atto diagnostico e terapeutico. E ciò perché il conflitto tra due beni - entrambi costituzionalmente tutelati - della salute e della libertà di coscienza non può essere risolto sic et simpliciter a favore del primo, sicché ogni ipotesi di emotrasfusione obbligatoria diverebbe per ciò solo illegittima perché in violazione delle norme costituzionali sulla libertà di coscienza e della incoercibilità dei trattamenti sanitari individuali (così, un rifiuto "autentico" della emotrasfusione da parte del testimone di Geova capace - avendo, in base al principio personalistico, ogni individuo il diritto di scegliere tra salvezza del corpo e salvezza dell'anima - esclude che qualsiasi autorità statuale - legislativa, amministrativa, giudiziaria - possa imporre tale trattamento: il medico deve fermarsi). Vero è piuttosto che la questione di diritto sottoposta all'esame di questa corte nel caso di specie ha ad oggetto la reale efficacia del "non consenso" sì come manifestato dal paziente sul piano tanto cronologico quanto contenutistico-formale. E' convincimento del collegio, in sintonia con quanto in proposito opinato dalla corte territoriale, che, nell'ipotesi di pericolo grave ed immediato per la vita del paziente, il dissenso del medesimo debba essere oggetto di manifestazione espressa, inequivoca, attuale, informata. Esso deve, cioè, esprimere una volontà non astrattamente ipotetica ma concretamente accertata; un'intenzione non meramente programmatica ma affatto specifica; una cognizione dei fatti non soltanto "ideologica", ma frutto di informazioni specifiche in ordine alla propria situazione sanitaria; un giudizio e non una "precomprensione": in definitiva, un dissenso che segua e non preceda l'informazione avente ad oggetto la rappresentazione di un pericolo di vita imminente e non altrimenti evitabile, un dissenso che suoni attuale e non preventivo, un rifiuto ex post e non ex ante, in mancanza di qualsivoglia consapevolezza della gravita attuale delle proprie condizioni di salute. 35 E ciò perchè, a fronte di un sibillino sintagma "niente sangue"vergato su un cartellino, sul medico curante graverebbe in definitiva il compito (invero insostenibile) di ricostruire sul piano della causalità ipotetica la reale volontà del paziente secondo un giudizio prognostico ex ante, e di presumere induttivamente la reale "resistenza" delle sue convinzioni religiose a fronte dell'improvviso, repentino, non altrimenti evitabile insorgere di un reale pericolo di vita, scongiurabile soltanto con una trasfusione di sangue. Di talché, come la validità di un consenso preventivo ad un trattamento sanitario non appare in alcun modo legittimamente predicabile in assenza della doverosa, completa, analitica informazione sul trattamento stesso, così la efficacia di uno speculare dissenso ex ante, privo di qualsiasi informazione medicoterapeutica, deve ritenersi altrettanto impredicabile, sia in astratto che in concreto, qualora il paziente, in stato di incoscienza, non sia in condizioni di manifestarlo scientemente, e ciò perché altra è l'espressione di un generico dissenso ad un trattamento in condizioni di piena salute, altro è riaffermarlo puntualmente in una situazione di pericolo di vita. Con ciò non si vuole, peraltro, sostenere che, in tutti i casi in cui il paziente portatore di forti convinzioni etico-religiose (come è appunto il caso dei testimoni di Geova) si trovi in stato di incoscienza, debba per ciò solo subire un trattamento terapeutico contrario alla sua fede. Ma è innegabile, in tal caso, l'esigenza che, a manifestare il dissenso al trattamento trasfusionale, sia o lo stesso paziente che rechi con sè una articolata, puntuale, espressa dichiarazione dalla quale inequivocamente emerga la volontà di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita, ovvero un diverso soggetto da lui stesso indicato quale rappresentante ad acta il quale, dimostrata l'esistenza del proprio potere rappresentativo in parte qua, confermi tale dissenso all'esito della ricevuta informazione da parte dei sanitari. Per tale ragione non sembra potersi attribuire pregio all'obiezione - pur specificamente mossa dal ricorrente - secondo la quale il cartellino recante la scritta "niente sangue" - che il paziente, come si è detto, recava con sé al momento del ricovero - avrebbe la specifica funzione di indirizzare il medico verso un comportamento omissivo rispetto all'ipotesi del trattamento trasfusionale: se l'affermazione ha una sua logica e una sua coerenza con riferimento al possibile stato di incoscienza del ricoverato, essa non consente l'ulteriore inferenza che conduca a presumerne una sorta di implicita efficacia tout court, estesa, cioè, anche all'ipotesi del concreto pericolo di vita che il paziente stesso si troverebbe a correre in assenza di trasfusione, mentre è proprio con riferimento a questa specifica evenienza che - va ripetuto - il (non) consenso deve manifestarsi nella sua più ampia, espressa, consapevole, inequivoca forma. Del pari condivisibile appare la motivazione della sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto irrilevante il numero delle trasfusioni eseguite (due delle quali, a detta del consulente, non sarebbero state nella specie imposte da un imminente pericolo per la vita del paziente). Va difatti ribadita la legittimità dell'osservazione secondo cui i sanitari, una volta determinatisi ad intervenire con le trasfusioni (mostrando, in proposito, un evidente travaglio morale come comprovato dalla - peraltro irrilevante - richiesta di autorizzazione alla locale procura della Repubblica), le avevano poi compiute secondo protocolli terapeutici non sindacabili sotto il profilo invocato dal ricorrente, essendone evidentemente irrilevante il numero ai fini per i quali è processo. Con il terzo motivo, si denuncia, infine, contraddittorietà e comunque insufficienza della motivazione su di un punto decisivo della controversia - prova del nesso causale fra trasfusioni effettuate e insorgenza dell'infezione da epatite virale di tipo B. Lamenta la difesa del ricorrente che, nell'escludere il nesso causale tra le trasfusioni di sangue ricevute dal paziente e il contagio da virus dell'epatite B, la corte territoriale abbia valutato la CTU con riferimento, pressoché unico, alle attestazioni circa la qualità dei donatori provenienti dalla stessa azienda citata in giudizio. 36 Il motivo è fondato. Questa corte regolatrice ha, di recente, avuto modo di rimeditare funditus il problema della causalità civile, per affermare, prima con la sentenza 21619/2007 di questa stessa sezione, poi con la pronuncia 581/2008 delle sezioni unite, che la regola probatoria in subiecta materia non può essere considerata quella dell'alto grado di probabilità logica e di credenza razionale, bensì quella del"più probabile che non". Nel caso di specie, è del tutto evidente che la relazione probabilistica tra i fatti di trasfusione e l'evento di danno costituito dal contagio del virus dell'epatite B sia assai più alta rispetto a tutte le ipotesi individuate come possibili (ma, in realtà, assai improbabili, oltre che oggetto di mere ed indimostrate congetture del giudice del merito) dalla sentenza impugnata, la cui contraddittorietà emerge altresì dall'avere, da un canto, considerata decisiva la circostanza della negatività sierologia dei donatori, e dall'altro omesso del tutto di valutare che tale negatività (come la stessa sentenza riconosce al folio 17) non desse alcuna garanzia di non infettività, esistendo una "finestra diagnostica" corrispondente ad un periodo variabile da 6 a 12 mesi (mentre l'insorgenza del virus nel G. seguì di soli 2 mesi la vicenda trasfusionale). Il ricorso va pertanto accolto con riferimento al solo terzo motivo e rigettato nel resto. P.Q.M. Rigetta il primo, secondo e quarto motivo del ricorso, accoglie il terzo, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d'appello di Trieste in altra composizione. 37 8. CASSAZIONE, SEZIONE III CIVILE, SENTENZA 10 GENNAIO - 2 OTTOBRE 2012, N. 16754 DANNNI CIVILI - NASCITA INDESIDERATA DI MINORE MALFORMATO OMESSA INFORMAZIONE DA PARTE DEL MEDICO CIRCA PIU' EFFICACI ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI PRENATALI - RESPONSABILITA' - SOGGETTI DANNEGGIATI Il risarcimento del danno c.d. da nascita indesiderata, scaturente dall’errore del medico che, non rilevando malformazioni congenite del concepito, impedisca alla madre l’esercizio del diritto di interruzione della gravidanza, spetta non solo ai genitori del bimbo nato malformato, ma anche ai suoi fratelli. Nel caso in cui il medico ometta di segnalare alla gestante l'esistenza di più efficaci test diagnostici prenatali rispetto a quello in concreto prescelto, impedendole così di accertare l'esistenza d'una una malformazione congenita del concepito, quest’ultimo, ancorché privo di soggettività giuridica fino al momento della nascita, una volta venuto ad esistenza ha diritto, fondato sugli art. 2, 3, 29, 30 e 32 Cost., ad essere risarcito da parte del sanitario del danno consistente nell’essere nato non sano, rappresentato dell'interesse ad alleviare la propria condizione di vita impeditiva di una libera estrinsecazione della personalità. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.- Nel febbraio del 1999 M. B. O. e M. O., in proprio e nella qualità di genitori esercenti potestà sulle figlie minori G., L. e M., convennero in giudizio dinanzi al tribunale di Treviso il ginecologo P. D. e la USSL 8 di X., esponendo: · Che la signora B., appena consapevole del proprio stato di gravidanza, si era rivolta al dott. D. chiedendo di essere sottoposta a tutti gli accertamenti necessari ad escludere malformazioni del feto; · Che la nascita di un bimbo sano era stata rappresentata al sanitario come condizione imprescindibile per la prosecuzione della gravidanza; · Che il dott. D. aveva proposto e fatto eseguire alla gestante il solo “Tritest”, omettendo di prescrivere accertamenti più specifici al fine di escludere alterazioni cromosomiche del feto; · Che nel settembre del 1996 era nata la piccola M., affetta da sindrome di Dawn. Il ginecologo, nel costituirsi, contestò analiticamente tutti gli addebiti, chiedendo nel contempo l’autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice. Si costituì in giudizio anche l’azienda sanitaria, lamentando, in rito, la nullità del libello introduttivo attoreo (per mancata specificazione delle ragioni di fatto e di diritto sui quali era fondata la domanda risarcitoria) e la carenza di legittimazione attiva delle minore, eccependo poi, nel merito, il regime - cd. in extra moenia - nel quale il medico aveva, da libero professionista, assistito l’attrice. L’azienda contestò, ancora nel merito, la stessa fondatezza della pretesa risarcitoria, per resistere alla quale chiese anch’essa il differimento della prima udienza, onde chiamare in causa le proprie compagnie assicurative succedutesi nel rapporto di garanzia durante l’anno 1996. L’Assitalia (compagnia assicuratrice del dott. D.), nel costituirsi, aderì in toto alle difese del proprio assicurato. 38 Le Assicurazioni Generali (originaria assicuratrice della USL) eccepì, all’atto della costituzione in giudizio, la cessazione degli effetti della polizza stipulata con la struttura sanitaria nel 30 giugno 1996; declinò ogni responsabilità vicaria per i fatti successivi a tale data; fece proprie, nel merito, le difese della propria garantita - salva richiesta, in caso di condanna del sanitario, di essere da questi rimborsata di quanto eventualmente tenuta a corrispondere agli attori. La RAS (succeduta alle Generali nel rapporto assicurativo con l’unità sanitaria) eccepì, in limine, la non operatività della polizza, per essere la vicenda di danno lamentata dagli attori riferibile ad un’epoca anteriore alla data del suo subingresso alla precedente compagnia, contestando poi nel merito le pretese risarcitorie nell’an, nel quantum, nel quivis. Il giudice di primo grado, previa declaratoria di difetto di legittimazione attiva della minore M. O., respinse la domanda dei genitori e dei fratelli. 2.- La corte di appello di Venezia, investita del gravame proposto dagli attori in prime cure, lo rigettò: - sul punto del ritenuto difetto di legittimazione attiva di M. O., facendo propri alcuni passi della motivazione della sentenza 14888/2004 con la quale questa Corte di legittimità aveva respinto una analoga richiesta, affermando il principio di diritto a mente del quale verificatasi la nascita, non può dal minore essere fatto valere come proprio danno da inadempimento contrattuale l’essere egli affetto da malformazioni congenite per non essere stata la madre, per difetto di informazione, messa in condizione di tutelare il di lei diritto alla salute facendo ricorso all’aborto; - con riferimento alla pretesa risarcitoria dei familiari, fondata sul preteso inadempimento contrattuale del sanitario, ritenendo quest’ultimo del tutto esente da colpa. Nel rigettare la detta pretesa, la corte lagunare osserverà, in particolare: - che, nella specie, la sola indicazione del cd. “tritest” quale indagine diagnostica funzionale all’accertamento di eventuali anomalie fetali doveva ritenersi del tutto giustificata, alla luce dell’età della signora B. (al tempo dei fatti soltanto ventottenne) e dell’assenza di familiarità con malformazioni cromosomiche, onde l’esecuzione di un test più invasivo come l’amniocentesi (che la partoriente conosceva “per sentito dire”) avrebbe potuto essere giustificata soltanto da una esplicita richiesta, all’esito di un approfondito colloquio con il medico sui limiti e vantaggi dei test diagnostici, mentre non risultava né provato né allegata la richiesta di sottoposizione a tale esame; - che l’accertamento di una malformazione fetale “non è di per sé sufficiente a legittimare un’interruzione di gravidanza”, posto che, nella specie, tale interruzione sarebbe stata praticata nel secondo trimestre, mentre la sussistenza dei relativi presupposti di legge, ex art. 6 della legge n. 194/1978 non era neppure stata adombrata dagli attori, onde nessuna prova poteva dirsi legittimamente acquisita al processo in ordine alla esposizione della donna a grave pericolo per sua la vita o per la sua salute fisica o psichica in caso di prosecuzione della gravidanza nella consapevolezza della malformazione cromosomica del feto; - che lo “spostamento” della quaestio iuris sul versante della carenza di informazione, operato in sede di appello, doveva ritenersi del tutto estraneo e diverso rispetto alla fattispecie sì come originariamente rappresentata in funzione risarcitoria: non era stata, difatti, censurata, con il libello introduttivo, la privazione del diritto di scelta della puerpera a causa di esami fatti male o non fatti, bensì l’inadempimento della prestazione sanitaria 39 richiesta dalla signora B. al dott. D.. 3.- La sentenza è stata impugnata da tutti i componenti della famiglia O. con ricorso per cassazione articolato in sei motivi. Resistono con controricorso P. D., le Assicurazioni Generali, l’Ina Assitalia, L’Allianz, l’Azienda sanitaria USSL 8 di Y.. Le parti ricorrenti e le resistenti Assitalia e Allianz, hanno depositato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Devono essere in limine esaminate le due preliminari questioni processuali poste al collegio dalla difesa della controricorrente USSL 8. Entrambe appaiono prive di pregio. - Quanto alla erronea spendita della veste di rappresentanti legali delle due figlie - divenute nelle more maggiorenni - da parte dei genitori (circostanza che, in sé considerata, renderebbe il ricorso inammissibile, secondo quanto opinato da Cass. ss.uu. 15783/2005), va rilevato come, al di là ed prescindere da tale, erronea qualificazione a loro stessi ascritta da parte dei coniugi B./O., tanto L. quanto G. B. hanno personalmente sottoscritto la procura speciale apposta in calce al ricorso per cassazione, onde la impropria indicazione di una (ormai spirata) rappresentanza legale dei genitori si risolve, ai fini della regolare costituzione in giudizio, in un irrilevante flatus vocis, atteso che il nome delle ricorrenti viene legittimamente indicato e speso in proprio dal difensore altrettanto legittimamente fornito di procura alle liti; - Quanto alla pretesa carenza di poteri rappresentativi in appello degli stessi coniugi O. riguardo alla figlia L., la vicenda deve ritenersi coperta da giudicato implicito ai sensi del disposto dell’art. 346 c.p.c.: la corte territoriale, difatti, dopo aver affrontato la questione della legittimazione attiva - escludendola - di M. O. (ff. 9 ss. della sentenza impugnata), rigetterà l’appello nel merito, senza affrontare il tema (pur rilevabile ex officio, essendo stato sollevato, a torto o a ragione, una questione di legitimatio ad causam e non di mera titolarità del rapporto sostanziale) della rappresentanza dei genitori con riferimento alla posizione processuale di L. O. - la cui domanda verrà conseguentemente rigettata per motivi di merito (il cui esame presuppone positivamente superata il vaglio delle questioni pregiudiziali e/o preliminari di rito da parte del giudice procedente). Sarebbe stato pertanto necessario proporre, da parte degli interessati, un ricorso incidentale avente ad oggetto il relativo capo implicito della sentenza; impugnazione nella specie non proposta, senza che la relativa eccezione contenuta nel controricorso possa ritenersi “convertita” in censura incidentale per l’assenza dell’essenziale requisito dell’istanza di riforma della sentenza di secondo grado impugnata. Non merita, infine, accoglimento l’eccezione, sollevata da più d’una della parti controcorrenti, di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. nella formulazione anteriore alla novella del 2009, atteso che la sentenza impugnata risulta depositata il 2 novembre 2010 (epoca successiva all’abrogazione della norma sui quesiti di diritto, pertanto inapplicabile nella specie ratione temporis), mentre la doglianza di difetto autosufficienza del ricorso appare contraddetta ictu oculi dalla semplice lettura dell’odierna impugnazione (cui, piuttosto, potrebbero al più muoversi censure – peraltro irrilevanti sul 40 piano giuridico - di segno contrario). 2.- Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 346 c.p.c. - Vizio logico di motivazione. Il motivo è fondato. Risulta espresso e non equivoco, nel corpo dell’atto di citazione di primo grado (che i ricorrenti riportano, per quanto rilevante in parte qua, al folio 15 dell’odierno atto di impugnazione), il riferimento “alla valutazione sul livello di consenso informato che il referto relativo al tritest determina, non essendovi alcun modo per una paziente incolta di medicina di riuscire a comprendere la relativa finalità, e che ad esso non era possibile affidarsi con certezza per sapere se vi fossero o non vi fossero le paventate anomalie”; onde il successivo atto di appello del tutto legittimamente denuncerà (a fronte di una sentenza di primo grado che inesattamente imputa all’attrice “di non aver dimostrato di avere espressamente richiesto l’effettuazione di accertamenti invasivi diversi”) la mancata informazione, da parte dei competenti sanitari, circa la complessiva attendibilità del test prescelto a dispetto della precisa richiesta della gestante di venir resa partecipe di eventuali malattie genetiche del feto e della altrettanto espressa intenzione, in tal caso, di non portare a termine la gravidanza. A tanto consegue la impredicabilità di qualsivoglia “spostamento del thema decidendum dal primo al secondo grado” erroneamente rilevato dalla corte di appello, la cui pronuncia deve, sul punto, essere cassata. 3.- Con il secondo motivo, si denuncia: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 c.c. per mancato accertamento dell’inadempimento contrattuale rispetto alla richiesta di diagnosi e al dovere di fornirla e di dare corretta informazione circa l’inidoneità degli esami previsti in funzione della diagnosi richiesta; mancata motivazione sul punto; b) violazione dell’art. 32 comma 1 e 2 Cost. c) violazione dell’art. 2697 c.c. in ordine al riparto degli oneri probatori relativi al’adempimento del dovere di informazione preventiva circa i limiti oggettivi di affidabilità delle metodiche alternative alla diagnosi suggerite Il motivo è fondato. Risulta provato (anche all’esito della mancata contestazione, sul punto, da parte del medico oggi resistente, non potendosi ritenere tale la generica affermazione di stile, contenuta nell’atto di costituzione in giudizio del dott. D., volta alla “contestazione analitica di tutti gli assunti di parte attrice”) che la gestante avesse espressamente richiesto un accertamento medico-diagnostico per esser resa partecipe delle eventuali malformazioni genetiche del feto, così da poter interrompere la gravidanza. Oggetto del rapporto professionale medico-paziente doveva, pertanto, ritenersi, nella specie, non un accertamento “qual che esso fosse”, compiuto all’esito di una incondizionata e incomunicata discrezionalità da parte del sanitario, bensì un accertamento doppiamente funzionale alla diagnosi di malformazioni fetali e (condizionatamente al suo risultato positivo) 41 all’esercizio del diritto di aborto. Ne consegue la non conformità a diritto della motivazione del giudice territoriale nella parte in cui ritiene (folio 15 della sentenza impugnata) “non provato e neppure allegato che la signora B. avesse chiesto di essere sottoposto a tale esame” (l’amniocentesi), motivazione che illegittimamente capovolge il riparto degli oneri probatori tra le parti del processo: - onere della paziente sarebbe stato, difatti, quello di provare la richiesta della diagnosi di malformazioni funzionale all’esercizio del diritto di interruzione della gravidanza in caso di esito positivo; - onere del medico, di converso, risultava quello di provvedere ad una completa informazione circa le possibilità (tutte le possibilità) di indagini diagnostiche, più o meno invasive, più o meno rischiose, e circa le percentuali di falsa negatività offerte dal test prescelto (test in ipotesi da suggerire, ma non certo da eseguire sic et simpliciter, in guisa di scelta sostitutiva e di assunzione del rischio parimenti sostitutivo), onde consentire alla gestante una decisione il più aderente possibile alla realtà della sua gestazione. Ne consegue una responsabilità del medico predicabile non soltanto per la circostanza dell’omessa diagnosi in sé considerata (ciò che caratterizzerebbe il risarcimento per un inammissibile profilo sanzionatorio/punitivo, in patente contrasto con la funzione propria della responsabilità civile), ma per la violazione del diritto di autodeterminazione della donna nella prospettiva dell’insorgere, sul piano della causalità ipotetica, di una malattia fisica o psichica. Deve pertanto ritenersi configurabile, nella specie, l’inadempimento alla richiesta di diagnosi sì come funzionale all’interruzione di gravidanza in caso di positivo accertamento di malformazioni fetali (in senso non dissimile, sia pur con riferimento a diversa fattispecie, di recente, Cass. 15386/2011), alla luce dell’ulteriore considerazione costituita dalla (incontestata) circostanza dell’altissimo margine di errore che il test selezionato dal ginecologo offriva nella specie (margine pari al 40% dei cd. “falsi negativi”), onde il suo carattere, più che di vero e proprio esame diagnostico, di screening del tutto generico quanto alle probabilità di malformazione fetale. 4.- Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. con riferimento alla presunzione di volontà di esercizio del diritto di interruzione di gravidanza da parte di donna risultata portatrice di patologia permanente dopo il parto della scoperta malformazione fetale. Il motivo è fondato. Non risulta conforme a diritto, difatti, la motivazione della corte lagunare nella parte in cui (folio 16 della sentenza impugnata) si opina “non esservi prova alcuna che, anche se a conoscenza della malformazione cromosomica del feto, la signora B. avrebbe potuto interrompere la gravidanza”. E ciò perché, prosegue il giudice lagunare, “non vi è alcun elemento dal quale desumere – ovviamente con giudizio ex ante – che la prosecuzione della gravidanza avrebbe esposto la signora a grave pericolo di vita o grave pericolo per la sua salute fisica o psichica”. A prescindere dalla considerazione per la quale tale affermazione si pone in contrasto con un principio già affermato in passato, anche di recente (sia pur con le precisazioni operate da Cass. 22837/2010, come rileva al folio 23 del controricorso la resistente Generali), da questa 42 corte regolatrice – per tutte, Cass. 6735/2002, Pres. Carbone, Rel. Vittoria (risulta erronea la citazione, contenuta al folio 21 del ricorso, della pronuncia 6365/2004, avente diverso oggetto) a mente dei quali in tema di responsabilità del medico per omessa diagnosi di malformazioni del feto e conseguente nascita indesiderata, l'inadempimento del medico rileva in quanto impedisce alla donna di compiere la scelta di interrompere la gravidanza. Infatti la legge, in presenza di determinati presupposti, consente alla donna di evitare il pregiudizio che da quella condizione del figlio deriverebbe al proprio stato di salute e rende corrispondente a regolarità causale che la gestante interrompa la gravidanza se informata di gravi malformazioni del feto, principi la cui portata verrà esaminata ed approfondita dal collegio nel corso dell’esame del quinto motivo di ricorso, è qui sufficiente osservare come, nel caso di specie, a fronte di una precisa istanza diagnostica della signora B. espressamente funzionale ad una eventuale interruzione della gravidanza, appare di converso ricorrere l’opposta presunzione - ovviamente predicabile ex ante sul piano della causalità ipotetica ex lege 194/78 - di una patologia materna destinata ad insorgere a seguito della scoperta della paventata malformazione fetale (patologia poi puntualmente insorta sotto forma di danno biologico psichico, come accertato in sede di consulenza medico-legale, ad indiretta conferma - sia pur ex post e sia pur con carattere non dirimente ai fini del giudizio prognostico - della esattezza della presunzione de qua). 5.- Con il quarto motivo, si denuncia: a) violazione e falsa applicazione dei limiti soggettivi di legittimazione attiva all’azione di risarcimento danni ex art. 1218 e 2043 c.c. conseguenti all’inadempimento di obbligazione assistenziale verso una gestante. b) Violazione dell’art. 1 c.c. e della legge 194/78 che attribuiscono la titolarità di diritti al feto solo al momento della nascita. Revisione critica della giurisprudenza in materia anche alla luce degli orientamenti espressi dalla Corte Suprema con la sentenza n. 10741/2009. c) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. con riferimento alla mancata pronuncia in ordine alla legittimazione attiva degli attori diversi dalla signora B. e di M. O. La doglianza deve essere accolta. Rinviando all’esame del quinto motivo la questione della cd. “legittimazione attiva” di M. O., va in questa sede affermato il principio di diritto secondo il quale la responsabilità sanitaria per omessa diagnosi di malformazioni fetali e conseguente nascita indesiderata va estesa, oltre che nei confronti della madre nella qualità di parte contrattuale (ovvero di un rapporto da contatto sociale qualificato), anche al padre (come già affermato da Cass. n. 14488/2004 e prima ancora da Cass. 6735/2002), nonché, a giudizio del collegio, alla stregua dello stesso principio di diritto posto a presidio del riconoscimento di un diritto risarcitorio autonomo in capo al padre stesso, ai fratelli e alle sorelle del neonato, che rientrano a pieno titolo tra i soggetti protetti dal rapporto intercorrente tra il medico e la gestante, nei cui confronti la prestazione è dovuta. L’indagine sulla platea dei soggetti aventi diritto al risarcimento, difatti, già da tempo operata dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento al padre (di recente, ancora, da Cass. n. 2354/2010), non può non essere estesa, per le stesse motivazioni predicative della legittimazione dell’altro genitore, anche ai fratelli e alle sorelle del neonato, dei quali non può non presumersi l’attitudine a subire un serio danno non patrimoniale, anche a prescindere dagli eventuali risvolti e delle inevitabili esigenze assistenziali destinate ad 43 insorgere, secondo l’id quod plerumque accidit, alla morte dei genitori. Danno intanto consistente, tra l’altro (come meglio si avrà modo di specificare di qui a breve, esaminando la posizione di M. O.) nella inevitabile, minor disponibilità dei genitori nei loro confronti, in ragione del maggior tempo necessariamente dedicato al figlio affetto da handicap, nonché nella diminuita possibilità di godere di un rapporto parentale con i genitori stessi costantemente caratterizzato da serenità e distensione; le quali appaiono invece non sempre compatibili con lo stato d’animo che ne informerà il quotidiano per la condizione del figlio meno fortunato; consci - entrambi i genitori - che il vivere una vita malformata è di per sé una condizione esistenziale di potenziale sofferenza, pur senza che questo incida affatto sull’orizzonte di incondizionata accoglienza dovuta ad ogni essere umano che si affaccia alla vita qual che sia la concreta situazione in cui si trova - principio cardine non di una sola, specifica morale, ma di una stessa ed universale Etica (e bioetica) della persona, caratterizzata dalla insostituibile centralità della coscienza individuale. 6.- Con il quinto motivo, si denuncia violazione degli artt. 1218, 2043, 1223, 2056 c.c. con riferimento: · Alla dannosità dell’handicap congenito per il bambino nato · Al diritto del medesimo al risarcimento · Al rilievo causale dell’inadempimento dell’obbligo di diagnosi precoce nei confronti della madre. Il motivo è fondato. Viene posto al collegio il delicato problema della titolarità di un diritto al risarcimento del danno in capo al minore handicappato, nato - a seguito della omessa rilevazione, da parte del sanitario, della malformazione genetica - da una madre che, contestualmente alla richiesta dell’esame diagnostico, abbia manifestato la volontà di non portare a termine la gravidanza nell’ipotesi di risultato positivo del test. La questione chiama l’interprete, fin dai tempi del diritto romano classico, ad una complessa indagine sulla natura giuridica (e sulle sorti) dei diritti riconosciuti a colui qui in utero est (Dig., 1.5.7.). Essa oscilla, nella sua più intima sostanza, tra semplicistiche trasposizioni della abusata fictio romanistica che rimanda al conceptus come soggetto pro iam nato (habetur) quotiens de eius commodis agatur (aforisma storicamente confinato, peraltro, nell’orbita dell’acquisto di diritti patrimoniali condizionati all’evento nascita), e contrastate adesioni alla sua rappresentazione sicut mulier portio vel viscerum (espressiva della teoria cd. pro choice, cara a tanta parte della giurisprudenza nordamericana in termini di diritto soggettivo assoluto della donna a decidere della sorte del concepimento e del concepito). La questione induce, in limine, ad indagare sulla qualità da attribuire al concepito nella sua dimensione rigorosamente giuridica, attraverso un’analisi scevra da facili quanto inevitabili suggestioni di tipo etico o filosofico, onde predicarne la natura di soggetto di diritto ovvero, del tutto specularmente, di oggetto di tutela sino al momento della sua nascita. Non è questa la sede per ripercorrere funditus, in via interpretativa, le tappe di un complesso itinerario di pensiero segnato da norme ordinarie e costituzionali non meno che da (reali o presunte) “clausole generali” - quali quella della centralità della persona -, itinerario 44 funzionale a scelte di teoria generale dell’ermeneutica tra giurisprudenza dei concetti e giurisprudenza degli interessi di cui è compiuta e approfondita traccia (sia pur non del tutto condivisibile tanto nelle premesse metodologiche quanto nelle conseguenti conclusioni) nella sentenza di questa stessa sezione n. 10741/2009. Ma da tale itinerario il collegio non può, d’altro canto, del tutto prescindere, proprio al fine di condurre a non insoddisfacente soluzione giuridica la questione di cui in premessa, ripercorrendone, sia pur brevemente, le tappe essenziali, attesi gli espliciti riferimenti operati dalle parti dell’attuale procedimento proprio alla sentenza n. 10741/2009. L’analisi delle affermazioni contenute in quella pronuncia deve, peraltro, essere preceduta dall’esame dei principi di diritto contenuti nella sentenza n. 14488/2004 di questa sezione, predicativa, come è noto: - della irrisarcibilità del danno da nascita malformata lamentato in proprio dal neonato; - della speculare limitazione di tale diritto a due soli soggetti, rappresentati dalla madre e dal padre del bambino malformato. 6.1.-. Nella vicenda di cui questa Corte ebbe ad occuparsi nel 2004, genitori affetti da talassemia non vennero informati dal medico, durante la gravidanza, del rischio che anche la nascitura potesse risultarne contagiata, e perciò convennero in giudizio il professionista chiedendone la condanna al risarcimento del danno patito sia da loro che dalla figlia nata talassemica. Il giudice di merito riconobbe e liquidò il risarcimento dei danno subiti da entrambi i genitori per l'omissione del medico, che aveva così precluso un'eventuale interruzione della gravidanza, negando peraltro il medesimo diritto alla neonata, la cui malattia venne ritenuta non evitabile né rimediabile. La corte di legittimità, sollecitata alla rivisitazione di tale dictum, confermerà nell’an quella pronuncia, argomentando diffusamente su questioni la cui delicatezza trascende non poco il compito dell’interprete, inducendolo a riflettere (come è stato suggestivamente osservato in dottrina) sul “miserabile ruolo del diritto” che, nel riconsiderare tanto gli spazi concessi alla giurisprudenza quanto quelli di esclusiva pertinenza del legislatore, affronta in questi ultimi anni, con i soli strumenti suoi propri e perciò solo del tutto inadeguati, l’inedita dimensione della responsabilità sanitaria del ventunesimo secolo nei suoi aspetti più problematici, quando cioè essa oscilla tra la vita (non voluta) e la morte (voluta, per espressa dichiarazione o per silenziosa presunzione). L’iter motivazionale della Cass. n. 14488/2004 è scandito dai seguenti passaggi argomentativi: a) nel bilanciamento tra il valore (e la tutela) della salute della donna e il valore (e la tutela) del concepito, l’ordinamento consente alla madre di autodeterminarsi, ricorrendone le condizioni richieste ex lege, a richiedere l'interruzione della gravidanza. La sola esistenza di malformazioni del feto che non incidano sulla salute o sulla vita della donna non permettono alla gestante di praticare l'aborto: il nostro ordinamento non ammette, dunque, l'aborto eugenetico e non riconosce né alla gestante né al nascituro, una volta nato, il diritto al risarcimento dei danni per il mancato esercizio di tale diritto (della madre); b) la legge n. 194 del 1978 consente invece alla gestante d'interrompere la gravidanza solo 45 quando dalla prosecuzione della gestazione possa derivare, anche in previsione di anomalie o malformazioni del concepito, un reale pericolo per la sua salute fisica o psichica, ovvero per la sua vita; c) prevale, in seno agli ordinamenti stranieri, la tendenza a rigettare la domanda proposta in proprio dal nato malformato e ad accogliere quella dei genitori relativamente ai danni patrimoniali e non patrimoniali; peraltro, la Corte di Cassazione francese in assemblea plenaria, nel celebre arrét Perruche del 27.11.2001, operando un revirement rispetto alla precedente giurisprudenza, affermò che, "quando gli errori commessi da un medico e dal laboratorio in esecuzione del contratto concluso con una donna incinta impedirono a quest'ultima di esercitare la propria scelta di interruzione della gravidanza, al fine di evitare la nascita di un bambino handicappato, questi può domandare il risarcimento del danno consistente nel proprio handicap, causato dai predetti errori". A tale pronuncia fece immediato seguito l’intervento del legislatore (loi Kouchner 303/2002), che escluse qualsivoglia pretesa risarcitoria dell'handicappato per il solo fatto della nascita “quando l'handicap non è stato provocato, aggravato o evitato da errore medico”; d) la tutela giuridica del nascituro, pure prevista dal nostro ordinamento, è peraltro regolata in funzione del diritto del concepito a nascere (sano), mentre un eventuale diritto a non nascere sarebbe un diritto adespota in quanto, a norma dell'art. 1 c.c., la capacità giuridica si acquista al momento della nascita, ed i diritti che la legge riconosce a favore del concepito (artt. 462, 687, 715 c.c.) sono subordinati all'evento della nascita, ma appunto esistenti dopo la nascita. Nella fattispecie, invece, il diritto di non nascere, fino alla nascita, non avrebbe un soggetto titolare dello stesso, mentre con la nascita sarebbe definitivamente scomparso; e) sotto altro profilo, ma nella stessa ottica, ipotizzare il diritto del concepito malformato di non nascere significa concepire un diritto che, solo se viene violato, ha, per quanto in via postuma, un titolare, ma se tale violazione non vi è (e quindi non si fa nascere il malformato per rispettare il suo diritto di non nascere), non vi è mai un titolare. Il titolare di questo presunto diritto non avrà mai la possibilità di esercitarlo (non esisterebbe un soggetto legittimato a farlo valere): non può farlo valere, ovviamente, il concepito, ancora non nato; non potrebbe farlo valere, altrettanto ovviamente, il medico; non potrebbe essere esercitato neppure dalla gestante. Il suo diritto all'aborto non ha, infatti, una propria autonomia, per quanto relazionata all'esistenza o meno delle malformazioni fetali, come invece nella legislazione francese, ma si pone in una fattispecie di tutela del diritto alla salute: il diritto che ha la donna è solo quello di evitare un danno serio o grave, a seconda delle ipotesi temporali, alla sua salute o alla sua vita. Per esercitare detto diritto, nel bilanciamento degli interessi, l'ordinamento riconosce la possibilità alla donna di interrompere la gravidanza, ed è la necessità della tutela della salute della madre che legittima la stessa alla (richiesta di) soppressione del feto scriminandola da responsabilità (se l'interruzione della gravidanza, al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 4 e 6 l. n. 194/1978, accertate nei termini di cui agli artt. 5 ed 8, costituisce reato anche per la stessa gestante ex art. 19 stessa legge); f) il nostro ordinamento positivo tutela il concepito - e quindi l'evoluzione della gravidanza esclusivamente verso la nascita e non verso la non nascita, per cui, se di diritto vuol parlarsi, deve parlarsi di diritto a nascere. Già la Corte Costituzionale, con la sent. 18.2.1975, n. 27, dichiarando costituzionalmente illegittimo l'art. 546 c.p. nella parte in cui non prevedeva che la gravidanza potesse essere interrotta quando la sua prosecuzione implicava danno o pericolo grave, medicalmente accertato e non altrimenti evitabile, per la salute della madre, aveva precisato che anche la tutela del concepito ha "fondamento costituzionale" nell'art. 31 comma 2° della Costituzione, che "impone espressamente la protezione della maternità" e, più in generale, nell'art. 2, che "riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali 46 non può non collocarsi, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito". La successiva legge 22.5.1978, n. 194, significativamente intitolata "norme per la tutela sociale della maternità" oltre che "sull'interruzione volontaria della gravidanza", proclama all'art. 1 che "lo Stato .... riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio"; inizio che, come si evince dal combinato disposto con gli articoli successivi, va riferito al momento del concepimento (e non tanto, o non solo allo scadere del novantesimo giorno dal concepimento, cui fa riferimento il successivo art. 4); g) va poi osservato che, se esistesse detto diritto a non nascere se non sano, se ne dovrebbe ritenere l'esistenza indipendentemente dal pericolo per la salute della madre derivante dalle malformazioni fetali, e si porrebbe l'ulteriore problema, in assenza di normativa in tal senso, di quale sarebbe il livello di handicap per legittimare l'esercizio di quel diritto, e, poi, di chi dovrebbe ritenere che detto livello è legittimante della non nascita. Infatti, anche se non vi fosse pericolo per la salute della gestante, ogni qual volta vi fosse la previsione di malformazioni o anomalie del feto, la gestante, per non ledere questo presunto diritto di "non nascere se non sani", avrebbe l'obbligo di richiedere l'aborto, altrimenti si esporrebbe ad una responsabilità (almeno patrimoniale) nei confronti del nascituro una volta nato. Quella che è una legge per la tutela sociale della maternità e che attribuisce alla gestante un diritto personalissimo, in presenza di determinate circostanze, finirebbe per imporre alla stessa l'obbligo dell'aborto (salvo l'alternativa di esporsi ad un'azione per responsabilità da parte del nascituro). Nei primi commenti alla sentenza, la dottrina non mancò di osservare come il riconoscimento di un diritto al risarcimento accordato anche al padre - terzo rispetto al contratto intercorso tra il medico e la gestante, e privo di qualsivoglia os ad eloquendum nella sua decisione d'interrompere la gravidanza -, con riferimento agli "effetti protettivi" del contratto verso i terzi comunque esposti ai pregiudizi conseguenti all'inadempimento del sanitario, indebolisse la soluzione del diniego dell'analoga pretesa fatta valere dai genitori a nome della figlia nata, che a più forte ragione doveva ritenersi ricompresa nella cerchia dei suddetti terzi danneggiati. Lo stesso riferimento alla non-imputabilità dell’evento (per via dell'inevitabilità della malformazione) all'omissione del medico venne sotto vari aspetti sottoposta a critica, volta che tale riferimento non appariva poi idoneo ad escludere non solo l'affermata responsabilità del medico verso la madre (in quanto) privata della possibilità di autodeterminarsi nella prosecuzione della gravidanza, ma anche quella nei confronti del padre, sebbene non legittimato in alcun modo ad interloquire sull'interruzione della gestazione (e ciò nondimeno, "egualmente protetto dal contratto originario"). Per altro verso, l'argomento cardine utilizzato per negare il risarcimento richiesto (anche) dalla figlia – costituito dalla conclamata inesistenza nel nostro ordinamento di un diritto a non nascere se non sano, in quanto "posizione non meritevole di tutela" – venne definito “affermazione meramente retorica - e quindi elusiva del grave problema posto a quel tempo al collegio, da riassumersi nel quesito se una persona nata con una malformazione che ne segna la vita e di cui sicuramente non è responsabile abbia o meno diritto a chiederne conto a qualcuno, considerato che il nostro ordinamento, per un verso, favorisce, sì, la procreazione, ma in quanto "cosciente e responsabile", ex art. 1 l. n. 194/1978, mentre, d’altro verso, tutela (come ribadisce la stessa sentenza) il diritto del concepito a nascere sano. Né la mancata previsione legale di un diritto a non nascere venne ritenuto argomento spendibile (“come avrebbe mai potuto l’ordinamento prevedere un simile diritto?”): se, come è ovvio, ogni tutela giuridica deve essere, per necessità logica, riferita ad un soggetto esistente, l'unica alternativa in ordine all'ammissibilità di una siffatta tutela non era tra non nascere o nascere malato, bensì tra nascere sano o nascere malato. 47 Sotto altro profilo, perplessità vennero sollevate perché, nel discorrere di una pretesa assenza dell'interesse protetto, la sentenza postulava una valutazione di "non ingiustizia" del danno estranea all'ambito della responsabilità contrattuale, (lasciando così il fanciullo handicappato senza alcuna tutela nei casi di abbandono, di cattiva amministrazione o di premorienza dei genitori). Si osservò, significativamente, come la questione non consistesse nell'affermare o nel negare pretesi diritti di nascere (o di non nascere, o di non "nascere handicappato") o di morire (o di non morire), né di valutare quanto valga il "non-essere" rispetto all'"essere” (handicappato), posto che il vivere una vita malformata è di per se una situazione esistenziale negativa, onde il danno ingiusto risarcibile - provocato da un'azione comunque colpevole altrui – consisterebbe nell’obiettività del vivere male indipendentemente dalle alternative a disposizione, espungendo dalla sfera del rilevante giuridico una concezione del danno come paragone con la vita sana perché questa vita sana non ci sarebbe stata: a seguito della nascita, si è sostenuto, “la questione non è più quella della sua venuta al mondo, ma soltanto quella del suo handicap”. Poco convincenti apparvero, infine, le ulteriori obiezioni che paventavano un potenziale quanto “innaturale” diritto risarcitorio del minore esercitabile nei confronti della madre che, correttamente informata dal medico sui rischi della nascita, avesse liberamente deciso di generare un figlio invalido - ovvero del padre contro la madre: danni in realtà irrisarcibili per l'assenza di una condotta colposa, se il fatto di dare la vita, o la rinuncia, da parte della madre, a interrompere la gravidanza, non possono mai essere considerati in termini di colpa né di ingiustizia del danno. L'atto della procreazione è frutto di una scelta che spetta, giuridicamente, soltanto ai genitori; ma la donna è, inevitabilmente, il solo legittimo destinatario del diritto a decidere se procedere o no all'interruzione della gravidanza. Ancor meno convincenti apparvero, agli occhi della più attenta dottrina, le osservazioni contenute in sentenza circa la disciplina dell'interruzione della gravidanza allo scopo di individuare "il bene giuridico protetto dalle norme che sanzionano l'aborto", considerato che annettere il risarcimento del danno prenatale nei confronti del fanciullo nato handicappato al territorio della responsabilità contrattuale indurrebbe ad opinare che “il bébé préjudice sia risarcibile nei riguardi del neonato quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento (o dell'inesatto adempimento) dell'obbligazione d'informazione, senza che assuma rilievo la valutazione della condotta in termini di ingiustizia del danno”. Onde il voler rifiutare di ammettere che un handicap sia, per l'andicappato medesimo, un "danno" venne definito “un puro e semplice sofisma", se è non la "vita" dell'handicappato che si tratta di assimilare a un danno, ma proprio il suo handicap. Altro limite rilevato dalla dottrina con riguardo alla motivazione della sentenza ebbe riguardo a quella che venne (del tutto condivisibilmente) ritenuta da più parti la questione giuridica essenziale, quella, cioè, del rapporto di causalità. La sentenza, difatti, non affrontò specificamente il problema del nesso eziologico (diversamente da quanto accaduto in Francia, dove sia la giurisprudenza del Consiglio di Stato e delle Corti d'appello, sia gli autori che contestarono la decisione della Cassazione sul caso Perruche motivarono la soluzione negativa sull'assenza del legame eziologico tra l'inadempimento e il danno), mentre la questione del nesso di causalità per il danno patito dal fanciullo handicappato - si disse -, lungi dal poter derivare da una analisi conseguente alla cd. biologisation du droit , andava riguardata sotto un profilo rigorosamente giuridico, così come accade ad esempio in caso di contagio da trasfusione, ove la causa “biologica” della malattia è certamente il virus HIV o HCV, ma nessuno dubita che la responsabilità vada imputata, sulla base di un criterio di causalità giuridicamente rilevante, a quel soggetto (pubblico o privato) che, con la sua colpevole omissione, abbia provocato, reso possibile o non impedito il contagio. 48 6.2.- Con la sentenza n. 10741/2009, questa Corte di legittimità, nuovamente investita della questione della risarcibilità in proprio del nascituro, sia pur sotto il diverso profilo della rilevanza - in guisa di conseguente danno ingiusto - di una attività commissiva (oltre che omissiva) del sanitario, dopo aver premesso che il nascituro o il concepito devono ritenersi dotato di autonoma soggettività giuridica (specifica, speciale, attenuata, provvisoria o parziale che si voglia), perché titolari, sul piano sostanziale, di alcuni interessi personali in via diretta, quali il diritto alla vita, e quelli alla salute o integrità psico-fisica, all'onore o alla reputazione, all'identità personale, affermò il principio di diritto secondo il quale, stante la soggettività giuridica del concepito, al suo diritto a nascere sano corrisponde l’obbligo dei sanitari di risarcirlo (diritto al risarcimento condizionato, quanto alla titolarità, all'evento nascita ex art. 1, comma 2, c.c., ed azionabile dagli esercenti la potestà) per mancata osservanza sia del dovere di una corretta informazione (ai fini del consenso informato) in ordine ai possibili rischi teratogeni conseguenti alla terapia prescritta alla madre (e ciò in quanto il rapporto instaurato dalla madre con i sanitari produce effetti protettivi nei confronti del nascituro), sia del dovere di somministrare farmaci non dannosi per il nascituro stesso. Il collegio ebbe poi cura di precisare, sia pur in guisa di mero obiter dictum, che quest'ultimo non avrebbe avuto diritto al risarcimento qualora il consenso informato circa il rischio di malformazioni prenatali fosse stato funzionale soltanto alla interruzione di gravidanza da parte della donna, dando così ulteriore continuità al principio di diritto espresso dalla sentenza n. 14488/2004. L’iter motivazionale della sentenza del 2009 – all’esito di una lunga e approfondita riflessione che, premesse alcune considerazioni di teoria generale del diritto, specie in tema di fonti e di interpretazione, giunge alla conclusione della attuale configurabilità, in seno all’ordinamento, di una posizione di autonoma soggettività in capo al nascituro – si caratterizza per i seguenti passaggi argomentativi: a) il mancato esercizio di una doverosa informazione a ciascuno dei coniugi circa potenzialità dannosa di un farmaco somministrato alla futura madre per stimolarne funzione riproduttiva aveva precluso loro di scegliere, con avvertita coscienza dei rischi, farne uso o meno, con conseguente responsabilità del medico nei confronti di entrambi, quanto destinatari delle informazioni colpevolmente omesse; la la di in b) l’esistenza di un danno ingiusto risarcibile era, nella specie, predicabile anche con riguardo alla posizione del neonato portatore di handicap e perciò vittima, dopo il suo concepimento (secondo le accertate risultanze in fatto della vicenda) degli effetti nocivi del farmaco prescritto, attesa la molteplicità e concordanza degli indici normativi volti a riconoscere la soggettività giuridica del nascituro, titolare, come tale, del diritto (tra gli altri) alla salute, azionabile a fini risarcitori a seguito della effettiva nascita; c) il diritto al risarcimento così riconosciuto al figlio nato in conseguenza di una terapia nociva non contraddice la esclusione di ogni tutela risarcitoria nel diverso caso della mancata informazione (sui rischi di malformazione del feto) incidente sulla decisione della madre di interrompere, in tal caso, la gravidanza, attesa la già affermata inconfigurabilità nel nostro ordinamento, di un diritto a non nascere se non sano. La grande novità della sentenza, rispetto al precedente costituto dalla pronuncia n. 6735 del 2002 (che ammise al risarcimento anche il padre del bambino nato malformato), consiste nel riconoscimento che gli effetti protettivi del rapporto obbligatorio (contrattuale o da cd. "contatto sociale") instaurato tra la paziente e i sanitari che la assistono durante la gestazione si producono non solo a favore del marito, bensì anche del figlio. Per la prima 49 volta questo giudice di legittimità si è spinto, sia pur sotto un diverso profilo rispetto a quello che oggi occupa il collegio, a valutare l'incidenza della nascita di un bambino in condizioni menomate sul piano dell'esistenza dell'intera famiglia, e non più solo della coppia, riconoscendo un autonomo diritto al risarcimento anche al protagonista principale di una vicenda di danno prenatale. 6.2.- La soluzione della questione di diritto affrontata nella sentenza n. 10741/09, al pari di quella oggi sottoposta all’esame del collegio, non sembra, peraltro, postulare né imporre come imprescindibile l’affermazione della soggettività del nascituro, soluzione che sconta, in limine, un primo ostacolo di ordine logico costituito dalla apparente contraddizione tra un diritto “a nascere sano” (un diritto, dunque, alla vita, che si perpetuerebbe nel corso della gestazione) e la sua repentina quanto inopinata trasformazione in un diritto alla salute di cui si invocherebbe tutela solo dopo la nascita. In premessa, l’accurata analisi, gli approfonditi riferimenti e gli spunti critici riservati in sentenza alla giurisprudenza cd. normativa, nell’ottica di una rinnovata funzione “creativa” della speculare Interessenjurisprudenz, ne lascia poi impregiudicato l’interrogativo circa la collocazione di quest’ultima nell'ambito della gerarchia delle fonti – salvo a voler riservare alle sole fonti “poste” tale preordinazione gerarchica, onde la giurisprudenza normativa sarebbe singolarmente fuori da quell'assetto. Se quest'ultimo appare a prima vista l’approdo più agevole sul piano dogmatico, per altro verso non sembra seriamente discutibile che, così opinando, il giudice civile, laddove ritenga nell’interpretare la legge alla luce dei valori costituzionali che essa non tuteli (o non tuteli a sufficienza) una situazione giuridica di converso meritevole, interviene a creare una corrispondente “forma” giuridica di tutela, eventualmente in contrasto con la legge stessa, ma senza subire alcun sindacato di costituzionalità, in quanto il sistema non prevede un meccanismo immediato di sindacato della costituzionalità degli orientamenti pretori salvo che questi riguardino la stretta interpretazione di una o più norme di legge esistenti (e sempre che un giudice sollevi la questione di costituzionalità secondo il consueto procedimento di cognizione incidentale). Il problema – che non può essere approfondito in questa sede se non nei limiti in cui la risoluzione del caso concreto lo impone e che attinge all'equilibrio stesso tra i poteri dello Stato, oltre che al modo di essere, e dunque di evolversi, dell'ordinamento giuridico – induce l’interprete ad interrogarsi sui limiti del suo intervento in seno al tessuto normativo e al di là di esso, senza mai omettere di considerare che, di interpretazione contra legem (non diversamente che per la consuetudine), non è mai lecito discorrere in un sistema (pur semiaperto) di civil law, che ammette e legittima, esaurendone in sé la portata innovativa, l’interpretazione estensiva e l’integrazione analogica, anch’essa condotta pur sempre ex lege ovvero ex iure. Non altro. Non oltre. Merito della sentenza è senz’altro quello di aver distinto tra due situazioni apparentemente simili, ma in realtà, sul piano giuridico, tra loro assai diverse. Al contrario di quanto avviene nel caso di prescrizione di farmaci teratogeni, la errata o mancata diagnosi non rileva ex se, sul piano eziologico, con riguardo alla genesi della patologia sofferta dal bambino, vicenda per la quale i genitori possono conseguentemente lamentare, nei confronti dei sanitari, la sola omissione di informazione circa lo stato di salute del feto per avere tale difetto di informazione di fatto impedito alla madre di potersi determinare ad un aborto terapeutico nei termini e alle condizioni previste dalla legge. Meno condivisibile appare, per le ragioni che in seguito meglio si approfondiranno, il 50 principio, ribadito in obiter, della irrisarcibilità del danno direttamente subito dal neonato, che ad avviso del collegio perpetua lo stesso equicovo concettuale immanente alla sentenza n. 14488/2004: quello secondo il nato non ha comunque diritto ad alcun risarcimento del danno per essere venuto alla vita, in quanto privo della titolarità di un interesse a non nascere. La contraddizione in materia di diritti del concepito sta proprio, da un lato, nel considerarlo (a torto o a ragione), in fase prenatale, soggetto di diritto e perciò centro di imputazione di alcuni diritti, della personalità e patrimoniali - da far valere solo se ed in quanto nato -; dall'altro, nel riservargli, alla nascita un trattamento di non-persona, disconoscendone sostanzialmente gli aspetti più intimi e delicati della sua esistenza. La concezione della vita come oggetto di tutela, da parte dell’ordinamento, in termini di “sommo bene”, di alterità normativa superiorem non recognoscens - di talché non potrebbe in alcun modo configurarsi un interesse a non nascere giuridicamente tutelato (al pari di un interesse a non vivere una non-vita, come invece condivisibilmente riconosciuto da questa stessa corte con la sentenza 16 ottobre 2007, n. 21748) - è percorsa da forti aneliti giusnaturalistici, ma è destinata a cedere il passo al raffronto con il diritto positivo. Decisiva appare, difatti, la considerazione secondo cui, al momento stesso in cui l'ordinamento giuridico riconosce alla madre il diritto di abortire, sia pur nei limiti e nei casi previsti dalla legge, si palesa come incontestabile e irredimibile il sacrificio del “diritto” del feto a venire alla luce, in funzione della tutela non soltanto del diritto alla procreazione cosciente e responsabile (art. 1 della legge n. 194 del 1978), ma dello stesso diritto alla salute fisica o anche soltanto psichica della madre. Mentre non vi sarebbe alcuno spatium comparationis se, a confrontarsi, fossero davvero, in una comprovata dimensione di alterità soggettiva, un (superiore) diritto alla vita e un (“semplice”) diritto alla salute mentale. E’ questo l’insegnamento, oltre che del giudice delle leggi, della stessa Corte internazionale di Strasburgo che, con (ancora inedita) sentenza dell’agosto di quest’anno, ha dichiarato la sostanziale incompatibilità di buona parte della legge 40/2004 in tema di fecondazione assistita (che, comunque, consentiva anche nell’originaria formulazione il sacrificio di due dei tre embrioni fecondati in vitro), per (illogicità e) contraddittorietà, proprio con la legge italiana sull’interruzione della gravidanza, così mettendo in discussione ab imo la stessa ratio ispiratrice di quella normativa, già considerevolmente vulnerata in non poche disposizioni dalla Corte costituzionale nel 2009. Troppo spesso si dimentica che una norma statuale di rango primario, più volte legittimata dal vaglio della Corte costituzionale, riconosce alla madre il diritto ad interrompere la gravidanza quando questa si trovi "in circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito" (così testualmente l’art. 4 della legge n. 194 del 1978). Appare di indiscutibile efficacia la scelta lessicale di un legislatore che descrive la situazione giuridica soggettiva attribuita alla gestante in termini di diritto alla procreazione cosciente e responsabile, a lei rimesso in termini di assoluta quanto inevitabile esclusività. Il diritto alla procreazione cosciente e responsabile è, dunque, attribuito alla sola madre, per espressa volontà legislativa, sì che risulta legittimo discorrere, in caso di sua ingiusta lesione, non di un diritto esteso anche al nascituro in nome di una sua declamata soggettività 51 giuridica, bensì di propagazione intersoggettiva degli effetti diacronici dell’illecito (come incontestabilmente ammesso nei confronti del padre) - salvo l’indispensabile approfondimento (che di qui a breve seguirà) sul tema della causalità in relazione all’evento di danno in concreto lamentato dal minore nato malformato. Altra e diversa questione è quella se la facoltà riconosciuta ex lege alla madre di interrompere volontariamente la gravidanza - consentendole di porre fine, con la propria manifestazione di volontà, allo sviluppo del feto - possa ritenersi rappresentativa di un esclusivo interesse della donna, e non piuttosto anche del nascituro. Questione, peraltro, di stampo etico, filosofico, religioso, che pone all’interprete interrogativi destinati a scorrere su di un piano metagiuridico di coscienza, ma non impone la ricerca di risposte né tampoco di soluzioni sul piano del diritto positivo, postulando che l'interesse alla procreazione cosciente e responsabile non sia solo della madre, ma altresì del futuro bambino, e ciò anche quando questo si trovi ancora nel ventre materno. La titolarità del relativo diritto soggettivo, riconosciuto espressamente dall'art. 1 della legge n. 194 del 1978, non può che spettare, si ripete, alla sola madre, in quanto solo alla donna è concessa (dalla natura prima ancora che dal diritto) la legittimazione attiva all'esercizio del diritto di procreare coscientemente e responsabilmente valutando le circostanze e decidendo, alfine, della prosecuzione o meno di una gravidanza che vede la stessa donna co-protagonista del suo inizio, ma sola ed assoluta responsabile della sua prosecuzione e del suo compimento. Il rigoroso meccanismo legislativo, in consonanza con quello di natura, esclude tout court la possibilità che il bambino, una volta nato, si dolga nei confronti della madre, come pure si è talvolta ipotizzato seguendo gli itinerari del ragionamento per assurdo, della scelta di portare avanti la gravidanza accampando conseguentemente pretese risarcitorie. E' la madre, infatti, che, esercitando un diritto iure proprio (anche se, talvolta, nell'interesse non soltanto proprio, pur essendo tale interesse confinato nella sfera dell’irrilevante giuridico), deciderà presuntivamente per il meglio: né potrebbe darsi ipotesi contraria, a conferma della mancanza di una reale soggettività giuridica in capo al nascituro. A tanto consegue la non condivisibilità, sul piano strettamente giuridico, della ricostruzione delle singole situazioni soggettive (della madre, del padre, dei componenti il nucleo familiare, del neonato stesso) che postulino in premessa l’esistenza, in capo al nascituro, di un diritto a nascere sano, contrapposto idealmente ad un non diritto “a non nascere se non sano". Altra questione, del tutto fuori dall’orbita del diritto, è quella che vede tuttora discutersi a vario titolo sulla scelta legislativa di consentire alla madre di scegliere se proseguire o meno la gravidanza in presenza di determinate condizioni. Compiuta una simile opzione normativa da parte del legislatore ordinario, e ricevuta ripetuta e tranquillante conferma della sua conformità al dettato costituzionale da parte del giudice delle leggi, l’interprete è chiamato non ad un compito “creativo” di pretese soggettività limitate, ma all’accertamento positivo di un diritto, quello della madre, e di un interesse, quello del nascituro (una volta in vita), oggetto di tutela da parte dell’ordinamento, alla procreazione cosciente e responsabile. Sarà poi destinata alle considerazioni che di qui a breve seguiranno l’analisi della questione centrale della causalità, la questione, cioè, se ledere un siffatto interesse abbia come conseguenza diretta ed immediata quella di porre il nascituro malformato in condizioni di diseguaglianza rispetto agli altri nascituri, e se tale condotta lesiva sia o meno concausa del suo diritto al risarcimento, da valutare anche sotto il profilo del suo inserimento in un ambiente familiare nella migliore delle ipotesi non preparato ad accoglierlo. Sgombrato il campo dall'equivoco che si annida nella poco felice locuzione "diritto a non nascere se non sano", e ricondotta la vicenda alla sua più corretta dimensione giuridica, il 52 principio di diritto che appare predicabile è quello secondo il quale la propagazione intersoggettiva dell’illecito legittima un soggetto di diritto, quale il neonato, per il tramite del suo legale rappresentante, ad agire il giudizio per il risarcimento di un danno che si assume in ipotesi ingiusto (tuttora impregiudicata la questione del nesso causale e dell’ingiustizia del danno lamentato come risarcibile in via autonoma dal neonato). Ritiene, pertanto, il collegio che la protezione del nascituro non passi necessariamente attraverso la sua istituzione a soggetto di diritto - ovvero attraverso la negazione di diritti del tutto immaginari, come quello a “non nascere se non sano”, locuzione che semplicemente non rappresenta un diritto; come non è certo riconducibile ad un diritto del concepito la più ferma negazione, da parte dell’ordinamento (non soltanto italiano), di qualsiasi forma di aborto eugenetico. E’ tanto necessario quanto sufficiente, di converso, considerare il nascituro oggetto di tutela, se la qualità di soggetto di diritto (evidente astrazione rispetto all’essere vivente) è attribuzione normativa funzionale all’imputazione di situazioni giuridiche e non tecnica di tutela di entità protette. Nessuna rilevanza, in positivo o in negativo, pare assumere all’uopo il pur fondamentale principio della centralità della persona, universalmente riconosciuto e tutelato a qualsiasi livello normativo, ma inidoneo ex se a rientrare nel novero delle vere e proprie “clausole generali” (quali quelle della correttezza, della buona fede, della funzione sociale della proprietà, della giusta causa del licenziamento, della cooperazione del creditore all’adempimento del debitore, della solidarietà passiva, tutte espressamente previste, esse sì, per via normativa). La centralità della persona (al di là della significazione che si attribuisce al termine “persona”, la cui etimologia evoca peraltro l’originario significato latino di maschera del teatro) è qualcosa di più e di diverso rispetto ad una semplice clausola generale, è un “valore assoluto”, rappresentabile esso stesso come proiezione di altre norme (tra le altre, gli art. 2 e 32 della Costituzione) e come autentico fine dell’ordinamento.. Per altro verso, una corretta e coerente attuazione dei principi cardine della giurisprudenza degli interessi (a mente della quale la correttezza della decisione del giudice dipende dalla altrettanto corretta valutazione dello scopo delle norme, anche a prescindere dalla relativa struttura semantico-contenutistica, secondo una ricerca del relativo significato in una dimensione teleologica, diversamente da quanto propugnato dalla giurisprudenza dei concetti, che procede invece per progressiva astrazione da norme di sistema valutandone soltanto il corrispondente significante) sembra condurre alla conclusione che tutte le norme, costituzionali e ordinarie, volte a disciplinare il delicato territorio del concepimento considerino il concepito come un oggetto di tutela necessaria, essendo la soggettività – come s’è detto – un’astrazione normativa funzionale alla titolarità di rapporti giuridici. Ne è conferma tanto lo storico dictum della Corte costituzionale (di cui alla sentenza del 18 febbraio 1975, n. 27, predicativa del fondamentale principio della non equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare) quanto le già ricordate disposizioni sull’interruzione di gravidanza che, se realmente postulassero un confronto tra due diverse soggettività giuridiche, e cioè fra due soggetti di diritto portatori di interessi e istanze contrapposte, non potrebbero mai operare una comparazione tra una malattia psichica e una vita privilegiando la prima, dovendosi di converso lasciar ovvio spazio alla vita in quanto valore supremo superiorem non recognoscens. Sotto un ulteriore profilo, non appare seriamente predicabile l’attuale esistenza, in capo al concepito, dei pur rinvenuti “interessi personali quali il diritto all’onore, alla reputazione, all’identità personale”, situazioni soggettive che presuppongono una dimensione di relazioni 53 sociali (la reputazione, l’identità personale) ovvero una consapevolezza di sé (l’onore), che, ipso facto, difettano tout court al concepito sul piano naturalistico prima ancora che su quello giuridico. Non si intende, con ciò, mettere in discussione quanto recentemente opinato da una attenta dottrina quando osserva che, malgrado il nascituro, da un punto di vista terminologico, non sia una figura rintracciabile nella nostra Costituzione, ciò non significa che non possa essere ricondotto nell'ambito di tutela ad essa proprio. Quando la Costituzione – si afferma – riconosce l'idoneità a essere titolare di situazioni giuridiche attive e passive solo a chi è partecipe della qualità e dignità di uomo, non può che fare riferimento al carattere biologico del soggetto, dal che deriva l'innegabilità del riconoscimento in capo al nascituro dei diritti inviolabili dell'uomo previsti dall'art. 2 della Carta fondamentale, che esalta l'imprescindibile legame di tali diritti con la natura umana. Tale conclusione troverebbe “puntuale conferma” negli art. 2, 30, 31, 32 e 37 Cost., mentre le stesse espressioni che fanno riferimento alla maternità, contenute negli artt. 31, comma 2 e 37 comma 1, si saldano logicamente con la normativa per cui la maternità viene in rilievo come situazione esistenziale “plurima” da salvaguardare, in quanto la tutela giuridica si dirige sia verso la madre sia nei confronti del figlio, e si estende dalla gestante al nascituro. Dalla rassegna delle disposizioni del codice civile – si sostiene ancora - può inoltre evincersi che l'attribuzione delle situazioni giuridiche imputabili al concepito, delle quali solo quelle di natura patrimoniale sarebbero subordinate all'evento nascita, implica necessariamente la valutazione del medesimo come centro di interessi suscettibili di tutela. La locuzione “centro di interessi suscettibile di tutela” è peraltro espressione anfibologica, dalla quale è lecito dedurre tanto la conclusione (non necessaria) della soggettività giuridica del nascituro, quanto quella, più realisticamente aderente al dato normativo ed alla stessa concezione del soggetto in termini di fattispecie (come illuminantemente opinato, oltre sessant’anni fa, da uno dei più illustri esponenti della civilistica italiana), in termini, cioè, di oggetto di tutela “progressiva” da parte dell’ordinamento, in tutte le sue espressioni normative e interpretative. Al là di alcune recenti e poco condivisibili formulazioni lessicali (si pensi alla tecnica normativa adoperata dal legislatore della legge 40/2004 sulla procreazione assistita, la cui improprietà anche terminologica ha cagionato, come si è avuto modo di osservare in precedenza, un inevitabile intervento abrogans di buona parte della sue disposizioni, mentre ancora più recente risulta l’intervento, parimenti tranchant, della Corte di giustizia europea, che ne ha evidenziato la patente contraddittorietà), l’intero plesso normativo, ordinario e costituzionale, sembra muovere nella direzione del concepito inteso come oggetto di tutela e non anche come soggetto di diritto. Solo a seguito dell’evento nascita, difatti, la fattispecie scrutinata dalla sentenza 10741/2009 si presentò non diversamente da un ordinario caso di danno alla salute: la lesione inferta al concepito si manifesta e diviene attuale al momento della nascita, la situazione soggettiva tutelata è il diritto alla salute, non quello a nascere sano. Chi nasce malato per via di un fatto lesivo ingiusto occorsogli durante il concepimento non fa, pertanto, valere un diritto alla vita né un diritto a nascere sano né tantomeno un diritto a non nascere. Fa valere, ora per allora, la lesione della sua salute, originatasi al momento del concepimento. Oggetto della pretesa e della tutela risarcitoria è, pertanto, sul piano morfologico, la nascita malformata, su quello funzionale (quello, cioè, del dipanarsi della vita quotidiana) il perdurante e irredimibile stato di infermità. Non la nascita non sana. O la non nascita. 6.3.- I principi sinora esposti risultano già in gran parte affermati da questa corte nella 54 sentenza n. 9700 del 2011. La pronuncia afferma, difatti, il principio di diritto secondo il quale chi sia nato successivamente alla morte del padre può ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali verificatisi contemporaneamente alla nascita e/o posteriormente ad essa, essendo irrilevante la non contemporaneità fra la condotta dell'autore dell'illecito (che ben può realizzarsi durante la fase del concepimento) e il danno (che ben può prodursi successivamente, come già opinato da questa stessa corte, in sede penale, con la sentenza n. 11625 del 2000). Nella specie, si dissero risarcibili i danni subiti dal minore, a partire dal momento della nascita, in conseguenza dell’uccisione del padre avvenuta in epoca anteriore alla nascita stessa, al tempo in cui il minore era soltanto concepito. Così modificata la tesi espressa da questo stesso giudice di legittimità con una risalente pronuncia (Cass. n. 3467 del 1973, affermativa del carattere eccezionale, e dunque di stretta interpretazione, delle disposizioni di legge che, in deroga al principio generale dettato dall'art. 1, comma 1 c.c., prevedono la tutela dei diritti del nascituro), La Corte ritenne irrilevante la questione della soggettività giuridica del concepito, ed comunque impredicabile una sua giuridica configurazione al fine di affermare il diritto del nato al risarcimento “non potendo, d'altro canto, quella soggettività evincersi dal fatto che il feto è fatto oggetto di protezione da parte dell'ordinamento”, in evidente e consapevole adesione all’insegnamento della civilistica classica, uno dei cui più autorevoli esponenti ebbe efficacemente ad evidenziare come la soggettività giuridica trovi il suo normale svolgimento nella capacità giuridica (impregiudicata la questione della soggettività indipendente dalla capacità degli enti impersonali, che rileva piuttosto sotto il profilo dell’attitudine alla titolarità di rapporti giuridici attivi e passivi, in guisa di soggetti di diritto - e dal diritto espressamente contemplati e disciplinati sul piano funzionale - come attualmente esistenti, a differenza del nascituro). D’altronde, non è senza significato la circostanza per la quale sono rimasti privi di seguito, non essendo mai stati discussi neppure in commissione, i due disegni e le due proposte di legge presentati nel corso dell’attuale legislatura, sia al Senato che alla Camera, volti a modificare l’art. 1, comma 1, c.c. sostituendone il testo originario nel senso che “ogni essere umano ha la capacità giuridica fin dal momento del concepimento”. La sentenza 9700/2011 evidenziò ancora, con argomentazioni che questo collegio interamente condivide, come il diritto di credito di natura risarcitoria appartenesse alla figlia in quanto nata orfana, e come tale destinata a vivere senza la figura paterna, mentre la circostanza che il padre fosse deceduto prima della sua nascita per fatto imputabile a responsabilità di un terzo assumeva significato nella sola misura in cui condotta ed evento materiale costituenti l'illecito si erano già verificati prima che ella nascesse, ma non anche che prima di nascere ella potesse avere acquistato il diritto di credito al risarcimento. Questo, difatti, postula la lesione di una situazione giuridica tutelata dall'ordinamento, da identificarsi, nella specie, con il diritto al godimento del rapporto parentale, diritto certamente inconfigurabile prima della nascita, così come solo successivamente alla nascita si verificano le conseguenze pregiudizievoli che dalla lesione del diritto derivano. Del rapporto col padre – si legge ancora in sentenza - la figlia è stata privata nascendo, non prima che nascesse. In precedenza, esistevano solo le condizioni ostative al suo insorgere per la già intervenuta morte del padre che la aveva concepita: ma la mancanza del rapporto interpersonale, del legame emozionale che connota la relazione tra padre e figlio è divenuta 55 attuale quando la figlia è venuta alla luce. In quel momento si è dunque verificata la propagazione intersoggettiva dell'effetto dell'illecito “per la lesione del diritto della figlia (non del feto) al rapporto col padre, e nello stesso momento è sorto il suo diritto di credito al risarcimento, del quale è dunque diventato titolare un soggetto fornito della capacità giuridica per essere nato”. La sentenza esclude, infine, che possa revocarsi in dubbio l’esistenza di un nesso di causalità fra illecito e danno, inteso questo come insieme di conseguenze pregiudizievoli derivate dall'evento (morte del padre): il figlio cui sia impedito di svilupparsi nell’ambito di questo rapporto genitoriale ne può riportare un pregiudizio che costituisce un danno ingiusto indipendentemente dalla circostanza che egli fosse già nato al momento della morte del padre o che, essendo solo concepito, sia nato successivamente (in tal senso, già Cass. 22 novembre 1993, n. 11503 e Cass. 9 maggio 2000, n. 5881, pur se non condivisibilmente contraddette, di recente - con motivazione, peraltro, meramente assertiva - da Cass. 21 gennaio 2011, n. 1410). Pur se non direttamente investita della questione che occupa invece oggi il collegio, la sentenza in discorso avrebbe concluso, con un breve quanto significativo obiter dictum, nel senso che, nelle modalità di insorgenza del diritto al risarcimento, il caso scrutinato non si differenziava da quello della lesione colposamente cagionata al feto durante il parto (dunque prima della nascita), da cui derivi, dopo la nascita, il diritto del nato al risarcimento per il patito danno alla salute (danno da lesione del diritto alla salute, dunque, e non già del cosiddetto "diritto a nascere sano", che costituisce soltanto l'espressione verbale di una fattispecie costituita dalla lesione provocata al feto, ma che non è ricognitiva di un diritto preesistente in capo al concepito, che il diritto alla salute acquista solo con la nascita), aggiungendo poi che, “in altro ambito, null'altro che espressiva di una particolare fattispecie è la locuzione diritto a non nascere se non sano, alla cui mancanza, in passato, si è correlata la risposta negativa al quesito relativo al se sia configurabile il diritto al risarcimento del nato geneticamente malformato nei confronti del medico che non abbia colposamente effettuato una corretta diagnosi in sede ecografica ed abbia così precluso alla madre il ricorso all'interruzione volontaria della gravidanza, che ella avrebbe in ipotesi domandato”. Onde “la diversa costruzione che il collegio ritiene corretta consentirebbe invece, nel caso sopra descritto, una volta esclusa l'esigenza di ravvisare la soggettività giuridica del concepito per affermare la titolarità di un diritto in capo al nato, di riconoscere il diritto al risarcimento anche al nato con malformazioni congenite e non solo ai suoi genitori, come oggi avviene, sembrando del tutto in linea col sistema e con la diffusa sensibilità sociale che sia esteso al feto lo stesso effetto protettivo (per il padre) del rapporto intercorso tra madre e medico; e che, come del resto accade per il padre, il diritto al risarcimento possa essere fatto valere dopo la nascita anche dal figlio il quale, per la violazione del diritto all'autodeterminazione della madre, si duole in realtà non della nascita ma del proprio stato di infermità (che sarebbe mancato se egli non fosse nato)”. La pronuncia del 2011, pur senza affermarlo espressamente, ascrive pertanto la vicenda risarcitoria alla categoria dei danni futuri: a quei danni, cioè, che al tempo della consumazione della condotta illecita non si sono ancora (o non si sono del tutto) prodotti pur in presenza di elementi presuntivi idonei a ritenere che il pregiudizio si produrrà (in argomento, funditus, Cass. 4 febbraio 1992, n. 1147), senza che osti a tale ricostruzione il dato letterale dell'art. 2043 c.c., che discorre di condotta dolosa o colposa che cagiona "ad altri" un danno ingiusto, ma non esige per questo l'attuale esistenza del danneggiato al tempo della condotta lesiva. 56 6.4.- Va peraltro precisato come fermo convincimento del collegio sia quello per cui l’evaporazione della questione della soggettività giuridica del concepito non conduca punto a rinnegare l'evoluzione subita, in materia, dal nostro ordinamento dal 1942 ad oggi, tanto alla luce delle norme costituzionali, quanto del ruolo sempre più incisivo delle fonti sovranazionali. Non ignora, difatti, il collegio che l'interpretazione dell'art. 1 c.c. non può prescindere da un dato storico certo, quello secondo il quale il codice del 1942 nasce dalla fusione delle leggi civili con i principi fondamentali del diritto commerciale, e dalla conseguente unificazione dei testi normativi rappresentati dal codice di commercio e da quello civile. La struttura portante del codice così unificato corre dunque lungo l’asse dei rapporti intersoggettivi di tipo patrimoniale piuttosto che attraversare il territorio dei diritti della persona e della personalità. E’ del pari innegabile che nell'attuale periodo storico, caratterizzato ab imis dalla entrata in vigore della Costituzione repubblicana, la persona - la sua libertà, la sua dignità - assurge via via a rango di primo motore immobile dell’ordinamento giuridico e della sua interpretazione. Lo stesso giudice delle leggi, con specifico riguardo alla posizione del concepito, ne consacrerà a più riprese un inviolabile interesse alla protezione, sua e della sua vita (particolarmente significativa, al riguardo, la pronuncia 10 febbraio 1997, n. 35). Né può seriamente dubitarsi che l’evoluzione legislativa abbia introdotto una congerie di norme che prendono in considerazione il concepito in quanto tale, come ha avuto cura di evidenziare la citata sentenza n. 10741 del 2009. Ma tale, apprezzabile, condivisibile e probabilmente inevitabile evoluzione del costume legislativo ed interpretativo non conduce, ipso facto, all’approdo necessario della soggettività del concepito. Non convince, difatti, la pur suggestiva riflessione recentemente svolta da un’attenta dottrina su di un piano rigorosamente normativo (e dunque a prescindere da considerazioni etiche, filosofiche, teologiche) a sostegno della teoria della soggettività del nascituro. Essa si fonda sulla generale portata precettiva dell’art. 320, comma 1, c.c. – che attribuisce ai genitori la rappresentanza non solo dei figli nati, ma anche dei nascituri, onde “nell'interpretazione di un linguaggio tecnico come è quello giuridico, non sarebbe revocabile in dubbio che ogni forma di rappresentanza, ivi compresa quella legale, è effettivamente tale se c'è alterità soggettiva fra rappresentante e rappresentato e, dunque, se il rappresentato è il soggetto giuridico in nome del quale il rappresentante agisce”. L’argomento in realtà prova troppo, perché le stesse norme sulla rappresentanza, in ragione della predicata alterità soggettiva, esigono in capo al rappresentato non soltanto la capacità giuridica, ma altresì quella di agire, limitando al rappresentante la sola capacità di intendere e di volere (se tale rappresentanza è conferita dall’interessato). Ne consegue che la “rappresentanza” disciplinata dall’art. 320 sì come riferita al nascituro è istituto affatto peculiare, di portata sicuramente eccezionale, altrettanto certamente limitato al campo dei diritti patrimoniali. E ciò proprio in conseguenza di quella che altra, pensosa dottrina ha dal suo canto definito “la singolarità della relazione tra madre e nascituro, che fa di ogni decisione riguardo al figlio una decisione della madre”, in una relazione non di alterità ma di immedesimazione, questa sì, realmente “organica” (come implicitamente affermato nell’ordinanza 31.3.1988 n. 389 della Corte costituzionale, che dichiarò, con motivazione tranchant, del tutto inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della 57 legge 194 nella parte in cui non riconosceva rilevanza alla volontà del padre). Per altro verso, lungi dall’apparire “irrazionale”, appare perfettamente compatibile con la concezione del nascituro inteso come oggetto di tutela e non come soggetto di diritto la disposizione dell'art. 578 c.p. - che punisce la madre che non solo cagiona la morte del proprio neonato subito dopo il parto, ma anche del feto durante il parto, prima che questo si distacchi definitivamente dal proprio organismo -, poiché non pare seriamente discutibile la piena equiparazione delle due situazioni sul piano naturalistico prima ancora che giuridico, una volta che il parto abbia avuto inizio. L’indiscutibile e indiscussa rilevanza giuridica del concepito nel nostro ordinamento, pur a volerne condivisibilmente predicare, come parte della dottrina esige a gran voce, un innegabile “carattere generale”, non limitato né limitabile ad ipotesi puntuali, non ha pertanto come ineludibile conseguenza la creazione ex nihilo di una sua soggettività, ma si sostanzia, si ripete, nel riconoscimento, ben più pregnante e pragmatico, della sua qualità di oggetto speciale di tutela da parte dell’ordinamento. Così affrancando il discorso giuridico (come osserverà, di recente, una avveduta dottrina) “dai pantani della soggettività, onde assegnare al concepito garanzie di difesa senza obbligare l’interprete alla necessità pregiudiziale di attribuirgli qualità soggettive nel significato e con le conseguenze che il diritto riconosce a tale concetto”, e finalmente liberi “dalle categorie metafisiche costituite dalla triade concettuale personalità, soggettività, capacità”, la questione della protezione del concepito non si discosta da quella della protezione dell’essere umano, nel senso che sarà compito di un essere umano già vivente assicurare tutela a chi (come magistralmente insegnato dalla Corte costituzionale) essere umano deve ancora diventare. E’ sotto questo profilo che va fermamente respinta l’opinione di chi, dalla risarcibilità del danno da nascita malformata, pretende di inferire l’esistenza (e la rilevanza giuridica) di un diritto ad essere abortito quale rivendicazione propria del nascituro/soggetto di diritto, alla stregua di un preteso principio costituzionale di parità di trattamento, tutte le volte che tale diritto all’aborto sarebbe stato esercitato dalla madre se opportunamente informata della malformazione su sua esplicita richiesta. Sostenere – come a più riprese è stato sostenuto, specie in seno alla dottrina francese all’indomani della sentenza Perruche - che, se alla madre è consentito evitare la nascita in vista di una possibile malattia psichica, sarebbe del tutto contrario al principio di uguaglianza negare il medesimo diritto al minore, risulta una evidente aporia, proprio perché il diritto vantato dal minore non è affatto volto alla sua soppressione “ora per allora”, né tantomeno alla rivendicazione di dover nascere sano ovvero di dover non nascere se non sano in attuazione di una ipotetica quanto inconcepibile eugenetica postnatale, ma alla riparazione di una condizione di pregiudizio per via di un risarcimento funzionale ad alleviarne sofferenze e infermità, talora prevalenti sul valore della vita stessa. 7.- All’esito della ricognizione tanto delle pronunce più significative rese in subiecta materia da questa corte, quanto del sempre fondamentale contributo della dottrina (ancor più necessario tutte le volte che il diritto è chiamato ad affrontare tematiche che trascendono la funzione sua propria e gli strumenti di analisi di cui dispone), sembra potersi avviare ad appagante soluzione la questione processuale sottoposta all’esame del collegio nella sua dimensione rigorosamente giuridica, e altrettanto rigorosamente ancorata al dato normativo (e dunque scevra da facili suggestioni etiche, filosofiche, o anche solo “creative”). Vanno conseguentemente analizzati tutti gli elementi della fattispecie concreta onde inferirne la legittima riconducibilità alla fattispecie astratta dell’illecito aquiliano in tutti i suoi elementi di struttura così come descritti dall’art. 2043 c.c.. Premesso che l’analisi delle 58 questioni relative ai criteri di valutazione del danno, che pur completerebbe l’indagine, è preclusa dall’estraneità del tema al presente giudizio, il collegio ritiene necessario condurre l’esame della fattispecie con riguardo: · al soggetto legittimato ad agire (rectius alla legittimazione soggettiva attiva); · all’oggetto della tutela; · all’evento di danno; · al nesso causale; · alla colpa dell’agente; · ai presupposti normativi della richiesta risarcitoria (gli artt. 4 e 6 della legge n. 194 del 1978) · ai presupposti fattuali della domanda risarcitoria (la richiesta di diagnosi funzionale all’aborto da parte della gestante); · alla titolarità del diritto di rappresentanza nell’esercizio del diritto al risarcimento (e all’eventuale conflitto di interessi con i genitori); · al riparto degli oneri probatori. La Corte non ritiene, difatti, del tutto appagante, nel dar vita ad un così significativo revirement rispetto alle pronunce del 2004 e del 2009, né l’evocazione di quella sensazione di sotterfugio cui ricorrerebbe la giurisprudenza per riconoscere il risarcimento in via indiretta all’handicappato, né la pur suggestiva considerazione volta a rilevare la contraddizione logica del riconoscere il risarcimento del danno ai genitori e non riconoscerlo al minore nato con la malattia, contraddizione resa ancor più evidente se il risarcimento è riconosciuto non solo alla gestante, poiché è stato leso il suo diritto ad interrompere la gravidanza, ma anche al marito della stessa (che non ha un tale diritto), sol perché è diventato padre di un bambino anormale. 7.1.- La legittimazione soggettiva. Alla luce delle considerazioni che precedono, non sembra seriamente discutibile la predicabilità di una legittimazione attiva del neonato in proprio all’azione di risarcimento. Superate le suggestioni rappresentate dall’ostacolo “ontologico” – l’impossibilità per un essere vivente di esistere come soggetto prima della sua vita – e convertita in questione giuridica la posizione del soggetto che, attualmente esistente, avanza pretese risarcitorie (ciò che sposterebbe il piano dell’analisi non sul versante della legittimazione soggettiva astratta, ma della titolarità concreta del rapporto controverso) e prescindendo del tutto, per il momento, dall’analisi degli ulteriori elementi della fattispecie (id est il diritto leso, l’evento di danno, la sua ingiustizia, il nesso di causalità), va riconosciuto al neonato/soggetto di diritto/giuridicamente capace (art. 1 c.c.) il diritto a chiedere il risarcimento dal momento in cui è nato. Sul piano giuridico (che, non va dimenticato, è dimensione meta-reale del pensiero, nella quale le stesse categorie spazio/tempo si annullano o si modificano, se si pensa al commercio elettronico o alla retroattività della condizione sospensiva) nulla sembra diversificare la situazione soggettiva dell’avente diritto al risarcimento conseguente alla nascita malformata da quelle tradizionali pratiche testamentarie di diritto comune attraverso 59 le quali vengono riconosciuti e attribuiti diritti ad una “persona” che ancora deve nascere. Né rileva, ai fini della predicabilità di tale legittimazione soggettiva, la specularità del senso dell’operazione - poichè non di una volontà ascendente che istituisce un soggetto che nascerà si tratta, bensì di un soggetto che, alla sua nascita, istituisce retroattivamente sé stesso, divenendo così titolare di un diritto soggettivo nuovo, il cui esercizio non richiede, peraltro, la finzione di un soggetto di diritto prenatale. Soggetto “autore” del minore malformato non è, pertanto, l’ascendente, il testatore, il donante, ma sé stesso. Ben più che un nuovo diritto soggettivo, il riconoscimento di tale legittimazione istituisce un nuovo soggetto autonomo, al punto che la qualità innata della sua vita diviene un diritto esigibile della persona, senza che – come è stato assai suggestivamente scritto – “questo nuovo soggetto di diritto divenga un mostro senza passato”. E senza che, va aggiunto, la sua pretesa risarcitoria appaia una mostruosità senza passato, confondendo il tempo della vita con il tempo della costruzione (e della finzione) giuridica. 7.2.- L’interesse tutelato. L’assemblea plenaria della corte di cassazione francese, nell’ammettere la legittimità della richiesta risarcitoria in proprio del piccolo Nicolas Perruche, si limitò ad osservare che questi aveva effettivamente subito un pregiudizio risultante dall’handicap particolarmente grave da cui era afflitto, specificando che la causalità non potesse, nella specie, essere ridotta alla sua dimensione scientifica o logica, ma andasse intesa in senso “giuridico”. La sentenza, vivacemente contestata, pose e pone tuttora un problema di non poco momento: quello, cioè, di individuare con esattezza la situazione soggettiva di cui si lamenta la lesione, onde ricondurla al conseguente evento di danno che, da quella lesione, ebbe a generarsi (per poi ricondurre ancora la condotta colpevole alla lesione della situazione soggettiva ed all’evento valutato in termini di contra ius). E’ convincimento del collegio che la domanda risarcitoria avanzata personalmente dal bambino malformato trovi il suo fondamento negli artt. 2, 3, 29, 30 e 32 della Costituzione. Il vulnus lamentato da parte del minore malformato, difatti, non è la malformazione in sé considerata - non è, in altri termini, l’infermità intesa in senso naturalistico (o secondo i dettami della scienza medica), bensì lo stato funzionale di infermità, la condizione evolutiva della vita handicappata intese come proiezione dinamica dell’esistenza che non è semplice somma algebrica della vita e dell’handicap, ma sintesi di vita ed handicap, sintesi generatrice di una vita handicappata. E’ violato il dettato dell’art. 32 della Costituzione, intesa la salute non soltanto nella sua dimensione statica di assenza di malattia, ma come condizione dinamico/funzionale di benessere psicofisico - come testualmente si legge nell’art. 1 lettera o) del d.lgs. n. 81 del 2008, e come recentemente riaffermato da questa stessa Corte con la sentenza 16 ottobre 2007, n. 21748. Deve ancora ritenersi consumata: - la violazione della più generale norma dell’art. 2 della Costituzione, apparendo innegabile la limitazione del diritto del minore allo svolgimento della propria personalità sia come singolo sia nelle formazioni sociali; - dell’art. 3 della Costituzione, nella misura in cui si renderà sempre più evidente la 60 limitazione al pieno sviluppo della persona; - degli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione, volta che l’arrivo del minore in una dimensione familiare “alterata” (come lascia presumere il fatto che la madre si fosse già emotivamente predisposta, se correttamente informata della malformazione, ad interrompere la gravidanza, in previsione di una sua futura malattia fisica o psichica al cospetto di una nascita dichiaratamente indesiderata) impedisce o rende più ardua la concreta e costante attuazione dei diritti-doveri dei genitori sanciti dal dettato costituzionale, che tutela la vita familiare nel suo libero e sereno svolgimento sotto il profilo dell’istruzione, educazione, mantenimento dei figli. Tali situazioni soggettive, giuridicamente tutelate e giuridicamente rilevanti, sono pertanto riconducibili non alla sola nascita né al solo handicap, bensì alla nascita ed alla futura vita handicappata intesa nella sua più ampia accezione funzionale, la cui “diversità” non è discriminata in un giudizio metagiuridico di disvalore tra nascita e non nascita, ma soltanto tutelata, rispettata ed alleviata per via risarcitoria. Non è a discorrersi, pertanto, di non meritevolezza di una vita handicappata, ma una vita che merita di essere vissuta meno disagevolmente, attribuendo direttamente al soggetto che di tale condizione di disagio è personalmente portatore il dovuto importo risarcitorio, senza mediazioni di terzi, quand’anche fossero i genitori, ipoteticamente liberi di utilizzare il risarcimento a loro riconosciuto ai più disparati fini. Non coglie dunque nel segno la ulteriore critica, mossa dai sostenitori della non risarcibilità autonoma del danno da nascita malformata, che nega ogni legittimazione ad agire al minore in nome di un preteso rispetto della sua dignità sull’assunto per cui qualificare la nascita in termini di pregiudizio costituirebbe una mancanza di rispetto alla dignità del minore. Tralasciando ogni considerazione in ordine ad una tale concezione della dignità umana (dichiaratamente ostile al soggettivismo della modernità dei diritti dell’uomo, e funzionale ad un’idea che non di diritto dell’uomo in quanto individuo si discorra, bensì di diritti del genere umano come tali opponibili allo stesso individuo onde assoggettarlo ad obblighi verso questa generica qualità umana che lo trascende, con conseguente negazione del fondamentale rapporto dell’individuo con sé stesso in una non negoziabile dimensione di suitas), va osservato che un vulnus alla propria dignità così concepito confonde la dimensione giuridica della richiesta individuale di risarcimento di un pregiudizio altrettanto individuale da parte della vittima di quel pregiudizio con la dimensione etica dell’attentato pregiudizievole non al sé individuale, ma ad una pretesa alterità trascendente che alberga nel singolo essere umano in quanto rappresentante di un genere. Al di là della condivisibilità sul medesimo piano dell’etica di tale concezione, è innegabile che essa si pone del tutto fuori dal territorio segnato dalle norme giuridiche e dalla relativa interpretazione. Deve pertanto concludersi che l’interesse giuridicamente protetto, del quale viene richiesta tutela da parte del minore ai sensi degli articoli della Carta fondamentale dianzi citati, è quello che gli consente di alleviare, sul piano risarcitorio, la propria condizione di vita, destinata a una non del tutto libera estrinsecazione secondo gli auspici dal Costituente: il quale ha identificato l’intangibile essenza della Carta fondamentale nei diritti inviolabili da esercitarsi dall’individuo come singolo e nelle formazioni sociali ove svolgere la propria personalità, nel pieno sviluppo della persona umana, nell’istituzione familiare, nella salute. 61 Non assume, pertanto, alcun rilievo “giuridico” la dimensione prenatale del minore, quella nel corso della quale la madre avrebbe, se informata, esercitato il diritto all’interruzione della gravidanza. Se l’esercizio di questo diritto fosse stato assicurato alla gestante, la dimensione del non essere del nascituro impedisce di attribuirle qualsivoglia rilevanza giuridica. Come accade in altro meno nobile territorio del diritto, e cioè in tema di nullità negoziale, l’interprete si trova al cospetto non già di una qualificazione giuridica negativa di un fatto (che ne consentirebbe uno speculare parallelismo con la corrispondente qualificazione positiva), bensì di una inqualificazione giuridica tout court. Ciò che è giuridicamente in-qualificato non ha cittadinanza nel mondo del diritto, onde la assoluta irrilevanza dell’affermazione secondo la quale “nessuno potrebbe preferire la non vita alla vita”, funzionale ad un “dovere di vivere” - ancora una volta relegato entro i confini di una specifica visione e dimensione etica delle vicende umane priva di seri riscontri normativi, come già affermato da questa Corte, in tema di diritti di fine vita con la già ricordata sentenza del 2007 - che in nessun caso può costituire legittimo speculum, sul piano normativo, del diritto individuale alla vita. Il ragionamento apparentemente sillogistico, elaborato da gran parte della dottrina francese all’indomani del caso Perruche, secondo cui “sarebbe insanabilmente contraddittorio considerare che il bambino handicappato, una volta nato, possa usare la sua acquisita qualità di soggetto di diritti per chiedere il risarcimento del danno risultante dal fatto di non essere stato abortito dalla madre, cosa che gli avrebbe impedito di diventare soggetto di diritti”, perde ogni ragionevole senso alla luce di quanto sinora esposto circa l’aspetto soggettivo ed oggettivo della vicenda: l’obiezione caratterizza, difatti, l’enunciato in termini di esigenza meramente logico-discorsiva, che non impone al soggetto un obbligo di vivere, ma un dovere linguistico di non affermare nulla che possa portarlo a predicare sé stesso come inesistente. Tutto ciò resta ai margini del discorso giuridico, così come estraneo al diritto positivo, se non nei limiti del suo altrettanto positivo recepimento in norme (ove esistenti), è una considerazione razionale della natura dell’uomo che ne implichi un obbligo di vivere, avendo di converso l’ordinamento positivo eletto ad essenza dei diritti dell’uomo, prima ancora della dignità (diversamente dall’ordinamento tedesco, in conseguenza della storia di quel popolo) la libertà dell’individuo, che si autolimita nel contratto sociale, ma resta intatta nei confronti di sé stesso, in una dimensione dell’essere che legittima alfine anche il non fare o il rifiutare. 7.3.- L’evento di danno. Sgombrato il campo dall’equivoco costituito dalla pretesa equazione “diritto di nascere o di non nascere/diritto al risarcimento da nascita malformata” (pare utile rammentare che la stessa corte di cassazione francese, il 13 luglio 2001, pochi mesi prima dell’arret Perruche, aveva respinto un ricorso che trasponeva erroneamente il pregiudizio “sul fatto stesso di essere in vita”), risulta innegabile come l’esercizio del diritto al risarcimento da parte del minore in proprio non sia in alcun modo riconducibile ad un impersonale “non nascere”, ma si riconnetta, personalmente e soggettivamente, a quella singola, puntuale e irripetibile vicenda umana che riguarda quel determinato (e altrettanto irripetibile) soggetto che, invocando un risarcimento, fa istanza al giudice di piena attuazione del dettato costituzionale dianzi evocato, onde essere messo in condizione di poter vivere meno disagevolmente, anelando ad una meno incompleta realizzazione dei suoi diritti di individuo singolo e di parte sociale scolpiti nell’art. 2 della Costituzione. E’ pertanto un vero e proprio “dibattito sulle ombre” quello volto a sostenere che tale 62 facoltà, in guisa di diritto a sé stessi, potrebbe attuarsi soltanto attraverso due modalità dell’impossibile, il non essere dell’essere ovvero l’essere del non essere. Riflessioni, si ripete, di indiscutibile spessore filosofico. Ma irrilevanti sul piano giuridico se, tra natura e diritto (come lo stesso giusnaturalismo ammette), si erge il triplice filtro costituito dalla legislazione, dalla giurisdizione, dalla interpretazione. E’ dunque confinata nella sfera dell’irrilevante giuridico ogni questione formulata fuori da tale dimensione, in particolare quella (incontrollabile dal diritto) del possibile e del nonpossibile ontologico. La legittimità dell’istanza risarcitoria iure proprio del minore deriva, pertanto, da una omissione colpevole cui consegue non il danno della sua esistenza, né quello della malformazione di sé sola considerata, ma la sua stessa esistenza diversamente abile, che discende a sua volta dalla possibilità legale dell’aborto riconosciuta alla madre in una relazione con il feto non di rappresentante-rappresentato, ma di includente-incluso. Una esistenza diversamente abile rettamente intesa come sintesi dinamica inscindibile quanto irredimibile, e non come algida fictio iuris ovvero arida somma algebrica delle sue componenti (nascita+handicap=risarcimento), né tantomeno come una condizione deteriore dell’essere negativamente caratterizzata, ma situazione esistenziale che, in presenza di tutti gli elementi della fattispecie astratta dell’illecito, consente e impone al diritto di intervenire in termini risarcitori (l’unico intervento consentito al diritto, amaramente chiamato, in tali vicende, a trasformare il dolore in denaro) affinchè quella condizione umana ne risulti alleviata, assicurando al minore una vita meno disagevole. Consentendo, alfine, per il tramite del diritto, ciò che un logica astrattamente giusnaturalitica vorrebbe viceversa negare. L’evento di danno è costituito, pertanto, nella specie, dalla individuazione di sintesi della “nascita malformata”, intesa come condizione dinamica dell’esistenza riferita ad un soggetto di diritto attualmente esistente, e non già destinata “a realizzare un suicidio per interposto risarcimento danni”, come pure s’è talvolta opinato. 7.4.- Il nesso di causa. La esistenza di un nesso di causalità giuridicamente rilevante tra la condotta del sanitario e l’evento di danno lamentato a seguito della violazione di un interesse costituzionalmente protetto del minore (questione che apparve immediatamente come la più problematica dell’intera vicenda risarcitoria all’indomani della sentenza Perruche, e che non venne affrontata funditus dalle due sentenze di questa corte che, nel 2004 e nel 2009, esclusero sotto altro aspetto l’esistenza di un autonomo diritto al risarcimento in capo al minore) può ricevere soddisfacente soluzione all’esito della ricognizione dell’evento di danno così come appena operata. Si sono correttamente sostenute, in proposito, tanto la irrilevanza di un nesso causale tra l’omissione di diagnosi e la nascita - attesa la inconfigurabilità di quest’ultima in termini di evento dannoso -, quanto la inesistenza di tale nesso tra la condotta omissiva e l’handicap in sé considerato, atteso che la malformazione non è conseguenza dell’omissione bensì del presupposto di natura genetica, rispetto al quale la condotta del sanitario è muta sul piano della rilevanza eziologica. Rilevanza che, di converso, appare sicuramente predicabile una volta identificato con 63 esattezza l’evento di danno nella nascita malformata intesa nei sensi poc’anzi esposti. Tale evento, nella più volte illustrata proiezione dinamica dell’esistente, appare senz’altro riconducibile, secondo un giudizio prognostico ex post, all’omissione, volta che una condotta diligente e incolpevole avrebbe consentito alla donna di esercitare il suo diritto all’aborto (sì come espressamente dichiarato al medico nel caso di specie). Una diversa soluzione, sul piano causale, si risolverebbe nell’inammissibile annullamento della volontà della gestante, senza che, in proposito possano assumere rilievo ipotesi alternative confinate, nella specie, in una dimensione dell’improbabile – e dunque del giuridicamente irrilevante – circa la eventualità (come ipotizzata dalla corte territoriale) di un futuro mutamento di decisione da parte della gestante stessa in ordine alla pur programmata interruzione condizionata di gravidanza. Va pertanto affermata, sul piano del nesso di condizionamento, la equiparazione quoad effecta tra la fattispecie dell’errore medico che non abbia evitato l’handicap evitabile (l’handicap, si badi, non la nascita handicappata), ovvero che tale handicap abbia cagionato (come nella ipotesi scrutinata dalla sentenza 10741/2009) e l’errore medico che non ha evitato (o ha concorso a non evitare) la nascita malformata (evitabile, senza l’errore diagnostico, in conseguenza della facoltà di scelta della gestante derivante da una espressa disposizione di legge). Facoltà il cui esercizio la gestante aveva, nella specie, espressamente dichiarato di voler esercitare, donde l’evidente paralogismo che si cela nella motivazione della corte territoriale nel momento in cui onera la odierna ricorrente dell’incombente di provare quello che risultava già provato ed acquisito agli atti del processo. 7.5.- La condotta colpevole Si è già avuto modo di evidenziare, nel corso dell’esame del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, come la colpevolezza della condotta si sia, nella specie, manifestata sotto il duplice profilo della non sufficiente attendibilità del test in presenza di una esplicita richiesta di informazioni finalizzate, se del caso, all’interruzione della gravidanza da parte della gestante, e dal difetto di informazioni circa la gamma complessiva delle possibili indagini e dei rischi ad essa correlati, onde sull’argomento non appaiono necessarie ulteriori precisazioni. 7.6.- Gli oneri probatori L’esistenza di una espressa e inequivoca dichiarazione della volontà di interrompere la gravidanza in caso di malattia genetica, quale quella espressa dalla gestante nel caso di specie, esime il collegio da ogni ulteriore valutazione circa la evidente e determinante rilevanza di tale volontà. Ritiene tuttavia la Corte che, all’esito della disamina che precede, un chiarimento sul tema degli oneri probatori si renda opportuno; con l’ovvia premessa che il problema della prova che all’interruzione della gravidanza della donna si sarebbe determinata se fosse stata informata si porrà esclusivamente nel caso in cui il convenuto ne contesti l’assunto (anche implicitamente contenuto nell’atto di citazione) Nell’ipotesi in cui tale volontà non sia stata espressamente manifestata dalla gestante, difatti, la presunzione di cui sembra legittimo discorrere sul piano dell’inferenza logica di un’intenzione (l’interruzione di gravidanza) desumibile da una condotta significante (la sola richiesta di accertamento diagnostico), ha indubbio carattere di presunzione semplice. 64 Essa costituisce, cioè, l’unico elemento indiziante di una volontà che si presume orientata verso un determinato esito finale. Da tale elemento indiziante il giudice di merito è chiamato a desumere, caso per caso, senza il ricorso a generalizzazioni di tipo statistico (o di cd. probabilità a priori), le conseguenti inferenze probatorie e il successivo riparto dei relativi oneri. Il giudice di merito dovrà in altri termini accertare e valutare, secondo il suo prudente apprezzamento, così come disposto dall’art. 116 del codice di rito, se, tenuto conto di tutte le circostanze del singolo caso concreto, tale presunzione semplice - che può essere legittimamente ricondotta a quella vicenda probatoria definita dalla giurisprudenza di questa corte come “indizio isolato” (la richiesta di accertamento diagnostico) del fatto da provare (l’interruzione di gravidanza) - possa o meno essere ritenuta sufficiente a provare quel fatto. La rilevanza di tale presunzione andrà, inoltre, valutata da quello stesso giudice anche in relazione alla gravità della malformazione non diagnosticata). Di volta in volta, escluso qualsivoglia automatismo probatorio, le parti, preso atto della situazione processuale di partenza costituita dall’esistenza di una vicenda probatoria “di indizio isolato” rispetto al fatto da provare (conseguentemente presunto o presumibile), sono chiamate a fornire al giudice gli elementi, che potranno dipanarsi anche sul piano della prova logica, funzionali a dirimere la questione del se le circostanze concrete e specifiche della concreta vicenda processuale consentano una valutazione di sufficienza o meno di quella presunzione semplice. La questione, assai delicata, della materiale possibilità di ricostruzione dell’efficacia probatoria della presunzione semplice in seno al processo, hic et inde, da parte dei difensori di ciascuna parte, trova risposta, ancora una volta, nella specificità ed unicità di quello stesso processo: i fatti così come narrati, le circostanze come di volta in volta evidenziate, le stesse qualità personali delle parti agenti e resistenti (così esemplificando in modo di certo non esaustivo l’elenco degli elementi utili alla formazione di un convincimento) potranno indurre i protagonisti del processo ad integrare o svilire la portata della presunzione semplice che, diversamente da una semplice equazione, non sempre può indurre alla automatica significazione “richiesta di diagnosi=interruzione di gravidanza” in caso di diagnosi di malformazioni. In mancanza assoluta di qualsivoglia ulteriore elemento che “colori” processualmente la presunzione de qua, il principio di vicinanza della prova e quello della estrema difficoltà (ai confini con la materiale impossibilità) di fornire la prova negativa di un fatto induce a ritenere che sia onere di parte attrice integrare il contenuto di quella presunzione con elementi ulteriori (di qualsiasi genere) da sottoporre all’esame del giudice per una valutazione finale circa la corrispondenza della presunzione stessa all’asserto illustrato in citazione. Non sembra, difatti, predicabile sempre e comunque la legittimità del ricorso ad un criterio improntato ad un ipotetico id quod plerumque accidit perchè, in assenza di qualsivoglia, ulteriore dichiarazione di intenti, non è lecito inferire sempre, sic et simpliciter, da una richiesta diagnostica la automatica esclusione del’intenzione di portare a termine la gravidanza. Ciò è a dirsi, oltre che sotto il profilo del corretto riparto degli oneri probatori in ipotesi di fatto negativo da dimostrare (Cass. sez. un. 13533/2001), anche sotto quello, non meno 65 rilevante, di evitare di trasformare un giudizio risarcitorio (e la natura stessa della responsabilità civile) in una sorta di vicenda para-assicurativa ex post, consentendo sempre e comunque, mercé l’automatica allegazione della presunzione semplice in discorso, di introdurre istanze risarcitorie anche se la volontà della gestante sarebbe stata diversamente orientata. Diverrebbe, in tal caso, vicenda processuale non incerta, ma già segnata ab origine nel suo vittorioso esito finale, quella che finisce per rendere automatico ogni risarcimento all’esito di una semplice richiesta diagnostica nonostante la impossibilità della prova di un fatto negativo da parte del convenuto (la volontà di non abortire nonostante la diagnosi infausta). 7.7.- La rappresentanza del minore La questione centrale che pone il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in proprio in capo al minore, quanto al suo conseguente esercizio per mezzo dei suoi legali rappresentanti - specie quando la intensità del suo handicap gli impedisce e gli impedirà in futuro qualunque espressione di volontà -, ruota attorno al pur ipotizzato conflitto di interessi che potrebbe investire i soggetti della vicenda risarcitoria. Sono state già esposte in precedenza le ragioni poste a fondamento dell’esclusione di ogni potenziale conflitto, e della insostemibilità di ogni ipotetica rivalsa da parte del minore nei confronti della madre. A quest’ultima, e a lei soltanto, è rimessa la facoltà di decidere, in solitudine, della prosecuzione o meno della gravidanza. La dimensione diacronica della vicenda risarcitoria mostra, così, tutta la sua rilevanza sul piano del diritto, volta che, vulnerata la facoltà di decidere per tale interruzione, il rapporto di immedesimazione rappresentativa, anch’esso spettante per legge alla madre (oltre che al padre), consente a quest’ultima di invocare un risarcimento per la nascita malformata del figlio. Possono in tal guisa trovare soluzione le stesse aporie più volte denunciate in dottrina circa la legittimità di una richiesta risarcitoria avanzata dal padre (oltre che dalla madre) del minore malformato e non anche da quest’ultimo, aporie che non avrebbero potuto, peraltro, costituire esse sole giustificazione e motivazione, in punto di diritto, della soluzione oggi adottata. *** 8.- Il sesto motivo risulta assorbito nell’accoglimento di quelli che lo precedono, dovendo il giudice del merito provvedere ad una completa revisione della disciplina delle spese processuali, il cui precedente regolamento deve intendersi (a prescindere da qualsiasi considerazione sul quantum), ipso facto caducato nell’an. 9.- In applicazione dei suindicati principi di diritto, il giudice del rinvio, da designarsi nella stessa Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, nel regolare anche le spese del giudizio di legittimità, è chiamato a rivalutare ex novo la fondatezza della richiesta risarcitoria sia della minore, sia dei suoi familiari. P.Q.M. 66 la Corte accoglie il primo, secondo, terzo, quarto e quinto motivo del ricorso, dichiara assorbito il sesto, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Venezia in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 10.1.2012 67 9. CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE SENTENZA 28 LUGLIO 2011, N. 16543 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 2 dicembre 2003, il Tribunale di Roma dichiarava la responsabilità di C.V. e dell'ASL (OMISSIS) in ordine ai danni subiti da N.C. e M.P. in relazione ai postumi di un intervento di laparotomia sulla N. per diagnosticata cisti paraovarica sinistra e alla situazione di anemia insorta a causa dell'intervento, perché, ebbe statuire il Tribunale, i sintomi dell'infezione, che si erano evidenziati sin dal giorno successivo alle sua dimissioni dalla struttura ospedaliera Sandro Pertini in cui fu ricoverata il 19 dicembre 1998 ed operata il (OMISSIS), furono scoperti con ritardo quando l'infezione, da cui era affetta la N., si era già trasformata in peritonite. In sostanza, il giudice di prime cure riteneva la responsabilità del C., ginecologo-ostetrico, che aveva in cura la N. sin dal 1990 per non aver evidenziato le lesioni intestinali nel corso dell'intervento, nonostante che questo fosse stato modificato da intervento in endoscopia a laparotomico, e per essere stato il sanitario negligente nella osservazione del decorso postoperatorio. Nell'occasione la soc. Assitalia s.p.a., chiamata in causa dal C., veniva condannata a manlevare la ASL (OMISSIS) e veniva respinta la domanda volta dai coniugi M. nei confronti della dott.ssa B. che aveva coadiuvato il C. nell'intervento. Su gravame della N. e del M., in via principale, e dell'Assitalia e del C., in via incidentale, la sentenza è stata confermata dalla Corte di appello di Roma il 1 settembre 2009, che rigettava tutti gli appelli e provvedeva sulle spese. Nel corso del giudizio di appello veniva depositata la sentenza del Tribunale penale di Roma, che su querela della N., il 20 gennaio 2004 aveva dichiarato la responsabilità penale del C. per lesioni colpose e la sentenza del 21 giugno 2005 della Corte di appello penale di Roma che aveva assolto il C. dal reato ascrittogli di lesioni colpose sotto il profilo della insufficienza di prove, come espressamente dichiarato in quella sentenza. Avverso siffatta decisione propongono ricorso per cassazione gli originari attori, affidandosi, se non si erra, a 19 motivi, parte dei quali esposti sotto molteplici profili. Resistono con controricorso l'Azienda Unità sanitaria locale (OMISSIS), la Ina-Assitalia s.p.a. e il C., che ha proposto ricorso incidentale, affidandosi a due motivi. Il C., l'Ina-Assitalia, l'Azienda USL (OMISSIS) hanno depositato rispettive memorie. Motivi della decisione I due ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.p.c. 1.- Per un'analisi del complesso ricorso in punto di fatto va rilevato quanto segue. Dagli atti di causa si evince che sin dal 1990 la N. era paziente del dr. C., ginecologo-ostetrico, in quanto affetta da una malformazione uterina, alla quale il C. assicurò di porre rimedio attraverso una metroplastica laparotomia, che venne effettuata il 19 febbraio 1992. Nel 1994 alla quindicesima settimana la N. abortì e il C. consigliò un intervento in laparoscopia presso 68 altro sanitario specializzato in tale tecnica e che eseguì l'intervento il 23 febbraio 1996 con la totale eliminazione del problema. Sempre nel 1996 una indagine ecografica rivelava la presenza di una sacca liquida paraovarica di cui fu data contezza al medico, che non ritenne nè opportuno nè necessario effettuare alcun intervento. Nel giugno del 1997 la N. abortì di nuovo, per cui nel novembre 1997 il C. consigliò di intervenire. Alle domande della N. e del marito sulla efficacia ed il rischio dell'intervento il C. assicurò che lo stesso sarebbe stato eseguito con una semplice laparoscopia presso l'Ospedale Sandro Pertini. La N. si ricoverò il 12 gennaio 1998 con diagnosi di "cisti paraovarica sinistra", senza nessuna ulteriore visita ed accertamento ecografico, ed in data 14 gennaio 1998 entrò in sala operatoria, ove in considerazione della situazione rivelatasi endoscopicamente, l'intervento si trasformò da laparoscopia in laparatomia e all'esito, il referto della cartella clinica riportava "laparotomia- viscerolisi- resezione ovarica bilaterale". La paziente nel decorso postoperatorio accusò dolori al basso ventre e difficoltà respiratorie, di cui venne informato il C. dal marito. Il 18 gennaio 1998 le venne comunicato che sarebbe potuta uscire il giorno successivo, ovvero il 19 gennaio, come avvenne. Il 20 gennaio 1998 il marito avvertì il C. che la moglie aveva forti dolori al fianco sinistro e febbre a 38 gradi. Sia i dolori che la febbre aumentarono il 23 gennaio 1998. La donna, su consiglio della guardia medica, alle tre del mattino del 24 gennaio 1998 fu condotta all'Ospedale S. Camillo di Roma e dopo gli accertamenti, tra cui una TAC addominale e pelvica, fu ricoverata perchè risultata affetta da peritonite acuta diffusa. Le venne praticata una laparotomia mediana sopra e sotto ombelicale, svuotamento dell'emiperitoneo ed altro, con prognosi sanitaria di giorni tre. Il chirurgo ebbe a riferire che la infezione era dovuta verisimilmente al precedente intervento del 14 gennaio che aveva provocato diverse lesioni e non se ne sarebbero potuto escludere altre con nuove manifestazioni morbose. Infatti, il 31 gennaio 1998 venne effettuato sulla N. nuovo intervento chirurgico dovuto alla presenza dell'accesso di Douglas con microperforazione del colon traverso, per cui si procedette ad una laparotomia mediana, ombelicopatico-sutura della perforazione, toilette del caso, drenaggio, chiusura per piani. Solo in questo secondo intervento si potè rilevare la presenza della microlesione al colon. Il giorno 11 febbraio 1998 la N. venne dimessa. Il giorno 1 giugno 1998 la N. sporgeva querela per lesioni colpose contro il C. 69 Il Tribunale in sede penale dichiarava il C. responsabile del delitto ascrittogli con sentenza del 20 gennaio 2004. La Corte di appello penale di Roma con sentenza del 21 giugno 2005 assolveva il C. sotto il profilo dell'insufficienza di prove, così come si legge nella motivazione. Sulla base di una consulenza medico-legale della fine del 1998, che concludeva per la responsabilità colposa del C., cui si attribuiva negligenza ed imperizia, i coniugi N. e M. con atto di citazione del 23 luglio-2 agosto 1999 chiamavano in giudizio il C., la ASL (OMISSIS), nonchè l'aiuto del C., la dott.ssa B., onde ottenere il risarcimento dei danni per responsabilità professionale e deontologica. Il Tribunale di Roma accertava la responsabilità del C. solo per i fatti-reati addebitatigli, ovvero, per la condotta omissiva tenuta nel decorso postoperatorio ed, esclusa la responsabilità della B., condannava il sanitario, l'ASL e condannava l'Assitalia, chiamata in garanzia, a tenere indenne la ASL. La decisione gravata dai coniugi trovava conferma nella sentenza oggi impugnata. 2.-Ciò premesso in fatto, passando ai complessi ed articolati motivi del ricorso principale, in via preliminare osserva il Collegio che gli stessi vanno esaminati in relazione alle questioni trattate e non già secondo l'ordine numerico che non sembra corretto per mero errore materiale. Ancora in via preliminare va osservato che la censura concernente documenti, ritenuti dal giudice dell'appello irritualmente dedotti e quella relativa alle domande, anch'esse ritenute a torto nuove vanno disattese. Infatti, come emerge dalla decisione in modo testuale, la sentenza penale non si riferisce alla imperizia nell'esecuzione degli interventi operatori eseguiti dal C., bensì all'inerzia dell'imputato - il C. - nella sorveglianza della situazione della N. nonostante fossero sorte complicazioni durante l'intervento di laparoscopia che avevano comportato la conversione della laparoscopia in laparatomia ed in presenza di importanti perdite ematiche. In altri termini si trattava di documenti e domande che non erano pertinenti al complesso oggetto della domanda proposta in sede civilistica. Il giudice dell'appello, in sede penale, ebbe a valutare anche il comportamento della N. e, facendo rigorosa applicazione dei criteri di individuazione del nesso di causalità nei reati omissivi, giunse alla conclusione che permaneva " un insuperabile dubbio sulla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta colposamente omessa dal dott. C. in merito alla situazione che aveva trovato all'atto della laparotomia e l'evento lesivo consistito nella perdita, dovuta a necrosi, dell'ovaia sinistra e comportante l'indebolimento permanente della capacità di procreare" (p. 3 e p. 7 sentenza penale di appello). In merito, poi, agli altri documenti, se da un lato i ricorrenti deducono che parte di essi erano già stati consegnati al CTU, di primo grado, dietro sua richiesta e prodotti nella comparsa conclusionale in primo grado ed ivi catalogati, dall'altro si limitano a parlare di integrazione di una "mera difesa volta a negare l'esistenza di fatti posta a fondamento della domanda avversa" (p. 10 ricorso) e, pur indicando per ordine numerico i documenti prodotti, non solo non ne riproducono, almeno per sintesi, alcuni contenuti, ma come fa notare il C. (p. 15 controricorso) alcuni di essi costituiscono nuova produzione non ammessa in appello. 3. - Con il primo e secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente per la loro interconnessione, circa il contenuto della domanda in primo grado e di quella proposta in 70 appello, unitamente ai documenti prodotti, i ricorrenti lamentano, in estrema sintesi, che il giudice dell'appello avrebbe erroneamente interpretato il contenuto e l'ampiezza della domanda formulata con conseguente carenza dell'inquadramento e della individuazione della fattispecie e violazione dell'art. 112 c.p.c. Infatti, sarebbero state sostituite le domande proposte con una diversa e più limitata, fondata su di una più ristretta e , quindi, discrepante "causa petendi" e su di una realtà non dedotta in giudizio dalle parti. Il giudice dell'appello non avrebbe tenuto conto che era stato posto in rilievo che il C. da una operazione di laparoscopia alla N. era passato ad una laparotomia non autorizzata e, ciò facendo, avrebbe effettuato una resezione cuneiforme delle ovaie (con conseguente asportazione di parte di essa), mentre , a seguito delle gravi conseguenze riportate, nel successivo intervento chirurgico presso l'Ospedale S. Camillo, alla N. venne asportato del tutto l'ovaia sinistra. In merito a questo profilo osserva il Collegio che non si rinviene affatto nella sentenza impugnata il denunciato vizio di error in procedendo nè di violazione dell'art. 112 c.p.c. A parte la inconferenza del richiamo al D.Lgs. n. 546 del 1993, art. 36, il giudice dell'appello ha correttamente affermato, nell'attuare un accurato esame dell'articolato motivo di censura dedotto dagli appellanti, che l'azione risarcitoria proposta in primo grado era strettamente correlata ad un danno da lesioni personali che si "assume essere stato cagionato alla N. per errore operatorio dovuto ad imperizia del chirurgo ( C.) causativo di una microlesione al colon, provocata nel corso di un intervento di rimozione di una cisti paraovarica(che aveva comportato anche la lesione delle ovaie) inopinatamente,-assumevano gli attuali ricorrenti, eseguita dal C. con una tecnica diversa da quella precedentemente stabilita ed in assenza di consenso informato circa il normale intervento laparotomico eseguito in luogo della concertata laparoscopia". Questo argomentare è in perfetta linea con quanto richiesto nell'atto di citazione e perciò esaminato dal giudice di prime cure, aggiungendosi che le pretese si riferivano anche alla responsabilità del chirurgo e dell'Azienda circa la carenza di assistenza postoperatoria, che avrebbe determinato un aggravamento dello stato di salute per via dell'insorta peritonite e dei due successivi interventi subiti dalla N. in altro nosocomio. Non solo, per quanto il giudice dell'appello si è fatto carico di evidenziare che l'intervento laparoscopico fu eseguito correttamente, condivìdendo le considerazioni del CTU e quelle del Consulente di parte, secondo il quale il trattamento laparoscopico prescelto era astrattamente adeguato rispetto al caso specifico della paziente (p. 30 ricorso). Quindi, nessuna interpretazione autonoma e distinta da quanto richiesto e nessuna violazione dell'art. 112 c.p.c. 4. - La censura sulla mancanza di consenso informato in riferimento all'intervento di laparoscopia e che si conclude con il relativo quesito a p. 16 del ricorso va disattesa. Di vero, ed in linea di principio, va ribadito il costante orientamento di questa Corte, in virtù del quale costituisce violazione del diritto inviolabile all'autodeterminazione (artt. 2, 3 e art. 32 Cost., comma 2) l'inadempimento da parte del sanitario dell'obbligo di richiedere il consenso informato al paziente nei casi previsti (S.U. n. 26972/08; Cass. n. 2847/10). Infatti, il diritto al consenso informato è un vero e proprio diritto della persona e trova 71 fondamento in quelle norme costituzionali sopra richiamate, nell'art. 5 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997, ratificata dall'Italia con L. 28 marzo 2001, n. 145, nell'art. 3 della Carta di Nizza del 7 dicembre 2000 ed ora giuridificata, nella L. 21 ottobre 2005, n. 219, 'art. 3 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati), nella L. 19 febbraio 2004, n. 40, art. 6 (Norme sulla procreazione medicalmente assistita), nella L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 33 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), oltre che nell'art. 30 del Codice deontologico, ma che soprattutto trova fondamento nell'a priori della dignità di ogni essere umano, che ha trovato consacrazione anche a livello internazionale nell'art. 1del Protocollo addizionale alla Convenzione sulla biomedicina del 12 gennaio 1998 n. 168. Come argomenta il giudice delle leggi, in virtù di queste previsioni normative il consenso informato svolge la funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute, al punto che deve essere ritenuto un principio fondamentale in tema di tutela della salute (Corte cost. sent. n. 438, par. 4, in motivazione). In virtù del "diritto vivente", in altri termini, così come costituito dalle statuizioni costituzionali e da questa Corte, nonchè dall'osmosi tra attività interpretativa, da un lato, e norme interne ed internazionali, dall'altro, per gli interventi sanitari sul paziente emerge l'obbligo dello Stato e delle sue istituzioni, tra cui il giudice, a mantenere al centro la dimensione della persona umana nella sua concreta esistenzialità, in quanto connaturata da dignità, che presiede ai diritti fondamentali, senza la quale tali diritti potrebbero essere suscettibili di essere soggetti a limiti da svilire ogni loro incisività e che costituisce valore assiologico che informa l'ordinamento giuridico nella sua totalità e, quindi, a maggior ragione ogni norma ordinaria. Se, quindi, l'homo juridicus è ormai homo dignus, come, condividendo autorevole dottrina e prendendo spunto dalle varie disposizioni sui diritti umani, ha ritenuto questa Corte con sentenza n. 7237/11 (in motivazione) la giurisprudenza di cui alle sent. n. 3847/11; n. 9315/10; n. 21748/07 riceve un ulteriore rafforzamento per ipotesi del genere. Ciò rimarcato, per quanto concerne la presente censura che si appunta sulla mancata di consenso informato in merito all'intervento di laparoscopia, il Collegio rileva che sin dall'atto di citazione si ricavava: 1) che il C. aveva in cura la N., che presentava una malformazione uterina, sin dal 1990; 2) nel 1992, per porre rimedio alla malformazione il C. il 19 febbraio 1992 effettuò un intervento di metro plastica laparotomia; 3) nel 1994 alla quindicesima settimana la N. abortì e il C. consigliò un intervento di laparoscopia presso altro sanitario, specializzato in questa tecnica, che fu eseguito il 23 febbraio 1996 con totale eliminazione del problema, a dire degli attori; 4) nel 1996 una indagine ecografica rilevava la presenza di una sacca liquida paraovarica, di cui il C. fu reso edotto, ma per la quale non ritenne opportuno intervenire; 5) nel 1997 la N. abortì di nuovo per cui nel dicembre 1997 il C. consigliò di intervenire. Alle richieste delucidazioni della N. e del marito sulla qualità e le conseguenze dell'intervento il C. osservò che si trattava di una semplice laparoscopia (va ricordato che già una volta la N. 72 aveva subito lo stesso intervento, ad opera di altro sanitario, su indicazioni del C.); 6) l'intervento fu programmato ed il 12gennaio 1998 la N. si ricoverò presso l'Ospedale Sandro Pertini di Roma ASL (OMISSIS), con la diagnosi di cisti paraovarica sinistra; 7) il 14 gennaio 1998 entrò in sala operatoria e l'intervento da laparoscopico si trasformò in laparatomico. Quello che si sottolinea nell'atto di citazione di primo grado è che la N. aveva prestato consenso solo ad una tecnica non invasiva in modo traumatico e per l'aspirazione di una massa liquidale (p. 10 atto di citazione). Queste circostanze evidenziate nell'atto introduttivo, la programmazione dell'intervento, ovviamente concordato, la chiara espressione di volontà di sottoporsi soltanto ad un intervento dalla tecnica non invasiva sono tutti elementi che depongono nel senso che vi sia stato - per facta concludentia -, rectius senza nessun atto scritto, un effettivo e consapevole consenso informato in merito alla sola laparoscopia. Ne consegue che va disattesa la censura sul punto, il cui rigetto, aggiungasi per completezza, non contrasta con quanto in linea di puro diritto affermato per l'innanzi. Infatti, ciò che rileva e costituisce una condicio sine qua non è che il paziente sia messo in condizioni di assentire al trattamento sanitario con volontà consapevole delle implicazioni, attraverso una informazione adeguata che permetta allo stesso di avere piena conoscenza della natura, della portata ed della estensione, dei rischi, dei risultati conseguibili e delle eventuali conseguenze negative. In altri termini, il diritto fondamentale alla tutela della salute, per cui la N. doveva essere compiutamente informata risulta rispettato. Non solo, ma le informazioni date per programmare l'intervento erano esatte e corrette dal punto di vista scientifico in ordine alla assenza di rischi, atteso che ad analogo intervento, che ebbe esito positivo, a dire della stessa N. un po' di tempo prima, ella si era sottoposta (v. ex adverso Cass. n. 24742/07). Peraltro, la microlesione intestinale che gli attuali ricorrenti addebitano all'intervento laparoscopico fu rilevata solo in occasione del secondo intervento al San Camillo, in seguito alla peritonite insorta dopo l'intervento al Sandro Pertini e lo stesso perito, incaricato nel procedimento penale instaurato nei confronti del sanitario, ebbe a manifestare fondata incertezza sul se quell'intervento laparoscopico avesse potuto procurare la lesione, la cui esistenza non era emersa nemmeno in occasione del primo intervento al San Camillo, pur non potendo essere esclusa - ritiene il giudice dell'appello-, contrariamente a quanto asserito dal Tribunale. Ed, infine, non vi è prova - in ordine all'intervento laparoscopico- che vi siano altri specifici errori chirurgici nell'espletamento dello stesso (v. p. 6 sentenza di primo grado) , anche per quanto accertato dal CTU, il quale faceva rilevare nelle sue conclusioni che si trattava di "un'infezione subdola con sintomatologia tardiva, che avrebbe potuto essere diagnostica se la paziente fosse rimasta ricoverata sotto osservazione all'Ospedale Sandro Pertini" (p.8 sentenza impugnata). 5.-Di qui l'assorbimento delle censure indicate al n. 7 del ricorso (errore chirurgico e responsabilità del medico, sulla rilevata, successivamente, microlesione) sia sotto il profilo della contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 5, sia sotto quello, in estrema sintesi, dell'onere della prova e del rispetto del criterio del più probabile che non (p. 32-37 del ricorso), sia sotto quello dell'errore chirurgico e sua incertezza (p. 37-40 del ricorso), perchè, in buona sostanza, si contrappongono alle valutazioni del CTU, condivise dal giudice del merito, quelle del Consulente di parte e lo stesso CTU Torregrossa ebbe a sostenere che la perforazione 73 intestinale non venne nè sospettata nè conosciuta dall'operatore (p. 39 del ricorso). Sul punto, comunque, la motivazione della sentenza è immune da censura, con l'ulteriore assorbimento dei motivi così come indicati al punto 8 (errore chirurgico e sua incertezza sotto il duplice profilo circa errore chirurgico e sua incertezza e sulla infezione che ha provocato la peritonite), considerato che la microlesione ebbe ad evidenziarsi solo in un secondo momento e il rapporto eziologico fu ipotizzato solo nel secondo intervento al San Camillo. Né si può ritenere apodittica l'affermazione di cui a p. 7 della sentenza impugnata, circa la non infrequenza di complicanze e la compatibilità con la natura dell'intervento chirurgico subito dalla N. e di cui alla stessa p. 7 ultimo capoverso, attesa la condivisione da parte del giudice del merito della CTU e di quanto dichiarato sia dal Consulente della difesa nel processo penale e dal Consulente del P.M., di cui ampi stralci sono riportati nel controricorso (p. 26-32 controricorso). Ed, inoltre, va precisato che, contrariamente a quanto nella censura si deduce, non risponde al vero che vi sia stata una omessa ed insufficiente motivazione su questo punto, stante anche il richiamo alla decisione di primo grado, che ebbe ad escludere ogni errore specifico e non essendo risultato certo il nesso eziologico con l'intervento eseguito in laparoscopia, come da relazione del CTU, che non ha esulato dal suo compito, come,invece, sostengono i ricorrenti. Pertanto, non risulta conferente, anche in relazione alla tenuta della cartella clinica, il richiamo a quell'orientamento giurisprudenziale che ha trovato, di recente, conferma in Cass. n. 10060/10. 6.- Vanno, peraltro, disattesi i motivi (così numerati) da 10 (errore chirurgico ed emorragia sotto i triplici profili indicati) e quello pure indicato con il n. 10 (errore chirurgico e sua riparazione) nel suo duplice profilo. In queste censure, ed in estrema sintesi, i ricorrenti lamentano l'errore tecnico del chirurgo. Al riguardo, sia la sentenza impugnata che quella di primo grado hanno escluso qualsiasi errore sia per la tecnica laparoscopica sia per quanto concerne l'intervento laparotomico, considerata la particolare tenacia di aderenze imponenti, che portarono anche alla resezione ovarica bilaterale e che non fu rilevata ecograficamente se non come cisti ovarica, mentre in effetti si era rivelata essere una complessa massa aderenziale, che coinvolgeva, tra l'altro, il sigma, l'ovaio e la tuba sinistra. Si è trattato di interventi (sia quello laparoscopico che quello laparotomico) eseguiti in conformità alle metodiche medico- chirurgiche, come accertato dal CTU, per il quale tecnicamente il campo di intervento del trocar, per mezzo del quale venne effettuata la laparoscopia non attingeva in alcun modo il colon traverso. Infine, circa la censura sulla CTU Torregrossa (indicata con il n. 12 nel ricorso), di cui si era chiesta la rinnovazione, stante l'asserito contrasto con altre consulenze di parte acquisite, va detto che le conclusioni del CTU escludevano alcuna imperizia o negligenza del sanitario e, quindi, ogni nesso eziologico. Il giudice del merito ne prende atto con motivazione che si sottrae alla denunciata censura. 7.-Sgombrato il campo dalle censure che riguardano il consenso informato per la 74 laparoscopia e la correttezza dell'intervento anche di laparotomia nel senso che entrambi furono eseguiti secondo le opportune metodiche e senza alcuna imperizia o negligenza, osserva il Collegio che il ricorso va accolto lì dove assumono i ricorrenti che alla N. non fosse stato richiesto il necessario consenso informato per l'intervento di laparatomia. Come, infatti, emerge dalla letteratura scientifica, ed è noto, la laparotomia è un intervento completamente diverso dalla laparoscopia e consiste, in genere, nell'incidere l'addome per chiarire la causa di una malattia non diagnosticata o quando il chirurgo si trova a trattare una malattia nota, di cui altri esami non siano riusciti ad evidenziare la causa dei sintomi e dei segni che la malattia presenta. Ci si trova, quindi, in presenza di un intervento assolutamente autonomo, non frequentemente determinato dalla urgenza e non già, ma il discorso non cambia, in presenza di modalità diverse dello stesso intervento. Come già posto in rilievo, la mancanza di richiesta del consenso informato costituisce violazione del diritto inviolabile della persona a vedere tutelato il suo diritto alla salute con la dignità propria dell'essere persona. La richiesta va sempre e comunque fatta a meno che non si tratti di caso di urgenza o di trattamento sanitario obbligatorio. Per intervenire motu proprio occorre, sia in virtù del codice di deontologia del 3 ottobre 1998-nonchè di quello del 16 dicembre 2006 - art. 35 - sia delle norme ordinarie, internazionali e costituzionali sopra richiamate, che si verifichi durante l'intervento programmato ed assentito un fatto nuovo che ponga a repentaglio la vita del paziente e venga ritenuto medicalmente indispensabile. Anche in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell'arte, dal quale siano derivate conseguenze dannose, qualora tale intervento non sia stato preceduto da adeguata informazione, nel caso in esame addirittura inesistente informazione, l'inadempimento dell'obbligo di informazione assume una valenza causale sul danno o sui danni subiti dal paziente. La N. aveva assentito alla laparoscopia e rifiutava ogni intervento dalla tecnica invasiva. Il C., atteso che la sua era una responsabilità contrattuale e non extracontrattuale allo scopo di ottenere il consenso informato a fronte della allegazione della N. dell'inadempimento di tale obbligo di informazione, non ha adempiuto all'onere di provare di avere adempito a tale obbligazione (Cass. n. 2847/10), con conseguente legittima richiesta risarcitoria da parte della sua paziente (Cass. n. 10741/09). Al riguardo, già la sentenza del Tribunale poneva in evidenza che " il fatto che sia stato necessario cambiare le modalità di intervento nel corso dello stesso, essendo emerso delle complicazioni, costituisce una questione da considerare dal momento che, non trattandosi di un intervento essenziale per la sopravvivenza della paziente, essendo finalizzato solo alla rimozione di eventuali cause che potevano rendere più difficile il concepimento, in una situazione già anatomicamente e morfologicamente complessa, in assenza di ragioni specifiche, l'intervento avrebbe dovuto essere interrotto al fine di consentire all'attrice di esprimere il suo consenso, anche perchè secondo il C. l'intervento fino a quel momento eseguito non aveva posto in essere condizioni che imponevano il secondo intervento al fine di porre riparo ad eventuali situazioni pericolose" (p. 10 sentenza del Tribunale). 75 Da parte sua il giudice dell'appello con la svolta consulenza medico- legale ha accertato, in base alla documentazione clinica di riferimento, che la decisione di un cambiamento della tecnica di intervento fu determinata dalla emersa presenza di aderenze così numerose e serrate la cui rimozione non era praticabile con la recente e meno invasiva tecnica della laparoscopia, stabilita con la paziente in relazione al quadro suffragato dalle ecografie; il che indusse il chirurgo (a seguito di una scelta discrezionale del momento) a trasformare l'intervento endoscopico in una prudenziale laparotomia allo scopo di visualizzare meglio gli organi interni e la provenienza di una perdita ematica, che si era verificata nella fase iniziale dell'intervento. Il mutamento di tecnica chirurgica, ritenuto necessario dal C., per ragioni pratiche che l'incaricato CTU nella sostanza condivide risulta essere stato, peraltro, eseguito conformemente alle buone tecniche operatorie e non vi è prova che abbia cagionato danni da errori ed imperizia" (p. 6-7 sentenza impugnata). Queste considerazioni che emergono dalle due decisioni dimostrano ictu oculi che l'intervento laparotomico con la conseguente viscerolisi e resezione ovarica bilaterale non presentava carattere di urgenza, non richiedeva un intervento senza consenso, ma fu dovuto solo ad una scelta discrezionale del sanitario, che, secondo il Tribunale, aveva cercato, così facendo, ovvero interrompendo l'intervento laparoscopico e motu proprio attuando la laparotomia, di evitare alla paziente la necessità di una ulteriore anestesia. E' certo che l'iniziativa di intervento tradizionale fu adottata discrezionalmente dal sanitario e, quindi, non per necessità di salvare la vita della paziente. Nulla ostava a che, ripresasi la N. dalla anestesia, il C. richiedesse ed ottenesse nei precisi limiti in cui è ammesso, il consenso informato. Simile omissione ha concretato la violazione della normativa vigente e cogente e, quindi,ha violato il diritto irretrattabile della persona alla libera autodeterminazione per tutelare la sua salute. Ne consegue che va accolto il quarto motivo, rectius vanno accolte tutte le censure che conce mono la violazione del diritto violato, ovvero quelle sulla effettuata laparotomia e conseguente viscerolisi e resezione cuneiforme bilaterale, con conseguente assorbimento dei motivi concernenti le varie voci di danno e le spese sia mediche che correlate di cui ai n. 9 a 20 (così indicati nel ricorso), precisandosi che per quanto concerne la censura circa le spese e il cd. diritto di manleva, effettivamente nessuna domanda è stata proposta dai ricorrenti nei confronti della Compagnia assicuratrice . L'accoglimento del ricorso in questi limiti importa la cassazione dell'impugnata sentenza. Il giudice del rinvio valuterà le domande proposte dagli attuali ricorrenti alla luce del principio secondo cui il diritto al consenso informato, in quanto diritto irretrattabile della persona va comunque e sempre rispettato dal sanitario, a meno che non ricorrano casi di urgenza, rinvenuti, a seguito di un intervento concordato e programmato e per il quale sia stato richiesto e sia stato ottenuto il consenso, che pongano in gravissimo pericolo la vita della persona, bene che riceve e si correda di una tutela primaria nella scala dei valori giuridici a fondamento dell'ordine giuridico e del vivere civile, o si tratti di trattamento sanitario obbligatorio. Tale consenso è talmente inderogabile che non assume alcuna rilevanza per escluderlo che 76 l'intervento absque pactis sia stato effettuato in modo tecnicamente corretto, per la semplice ragione che a causa del totale deficit di informazione il paziente non è posto in condizione di assentire al trattamento, per cui nei suoi confronti, comunque, si consuma una lesione di quella dignità che connota nei momenti cruciali - la sofferenza fisica e/o psichica la sua esistenza. 8.-Nel passare all'esame del ricorso incidentale il Collegio osserva quanto segue. Con il primo motivo il ricorrente incidentale lamenta che erroneamente il giudice dell'appello nel confermare la sentenza del Tribunale non avrebbe tenuto conto della sentenza assolutoria in sede penale, che ha escluso il nesso eziologico tra l'intervento del sanitario e le lesioni dedotte in lite con riguardo al decorso postoperatorio, posto che la N. non si sottopose a visita e rifiutò persino di sottoscrivere la liberatoria a favore dell'ospedale, dimettendosi con la ferita aperta. In altri termini, il C. censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto sussistere senza ombra di dubbio la violazione da parte sua dei generici doveri di prudenza ed attenzione che avrebbero dovuto essere posti nel decorso postoperatorio. La censura, che riporta analiticamente le varie cadenze temporali soprattutto in relazione alla presenza del C. e alla sua osservanza all'ordine di servizio, non coglie nel segno. Di vero, il giudice dell'appello, che nell'argomentare ha mostrato di condividere la impostazione data dal Tribunale, ha affermato che vi era stata "una carente assistenza ospedaliera" e la responsabilità del sanitario (concorrente con quella contrattuale della ASL) in questo caso era ravvisabile non in quanto chirurgo, esecutore dell'intervento, ma come aiuto dell'Ospedale Pertini, dove la N. restò ricoverata per alcuni giorni dopo l'intervento. Si è trattato, infatti, di una macroscopica sottovalutazione della situazione della degente, non eludibile con le generiche allegazioni addotte dal C. circa la sua fungibilità con i molti altri medici di quel reparto e con i limiti obiettivi della sua presenza ospedaliera per via degli avvicendamenti e delle turnazioni (p. 8-9 sentenza impugnata). Il fatto che avesse in cura la N. da anni e, quindi, conoscesse meglio di qualunque altro i problemi ginecologici di salute della propria paziente, avendola operata, e, quindi, proprio per questo fosse più direttamente al corrente del trauma postoperatorio e dello stato di debilitazione fisica in cui la N. versava, dovuto anche alle complicanze connesse con il ben più complesso intervento chirurgico che egli effettuò in luogo della laparoscopia, nonchè alla perdita notevole di sangue ed alla anemia emersa dalle analisi effettuate durante e dopo l'intervento sono tutti elementi che avrebbero dovuto indurre il C., al di là dei formali condizionamenti derivanti dalle normali turnazioni (cui fa cenno il ricorrente incidentale), anche per il tramite dei colleghi di reparto, ad un più attento monitoraggio della evoluzione della fase operatoria, anche al fine di valutare la sussistenza delle condizioni per le dimissioni in piena sicurezza della paziente, che si rifiutò di sottoporsi ad un controllo medico prima di lasciare l'ospedale, ma non fu ostacolata dal dimettersi. L'infezione latente, diagnosticabile con doverose approfondite indagini cliniche che non furono effettuate dal C. e, comunque, da lui non indicate, sono sintomatiche di una grave omissione che già il Tribunale aveva avuto modo di evidenziare, indipendentemente dall'esito del processo penale che, giova ricordarlo, terminò con una sentenza, sostanzialmente e dichiaratamente in motivazione, di assoluzione per insufficienza di prova. 77 Infatti, con la sentenza del 21 giugno 2005 la Corte di appello penale di Roma, all'esito della valutazione delle contrapposte posizioni, facendo rigorosa applicazione dei criteri di individuazione del nesso di causalità nei reati emissivi, con richiami a decisioni di questa Corte, ha rinvenuto la permanenza di "un insuperabile dubbio sulla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta colposamente omessa del dott. C. e l'evento lesivo" (p. 7 sentenza penale). Collegando, quindi, le motivazioni di cui alle decisioni rese in sede civile con quella di cui alla decisione penale emerge chiaramente che la doglianza del C. va disattesa, essendovi in quella civile di appello ed ora impugnata sul punto una applicazione corretta sia dei principi giuridici che della motivazione in punto di responsabilità per omissione (v. diversa per il caso ma corretta nella massimazione Cass. n. 867/08). 9.-Con il secondo motivo il C. evidenzia che "di sicuro per mero errore materiale, il Tribunale non dichiarava la manleva della chiamata in causa Assitalia anche nei confronti del prof. C., il quale aveva tempestivamente informato sin dal 19 giugno 1998 il proprio assicuratore", precisando, inoltre, che in primo grado la Compagnia assicuratrice era stata condannata a rimborsare alla ASL (OMISSIS) quanto corrisposto agli attori in esecuzione della sentenza (p. 17 sentenza di primo grado), per cui la condanna doveva estendersi anche a suo favore. Proposta in appello la doglianza, il giudice dell'appello l'ha disattesa sul rilievo che non vi era in atti copia della polizza (p. 44-45 controricorso). La censura merita accoglimento. Di vero, il giudice dell'appello riconosce che non vi è stata alcuna pronuncia al riguardo, ma contraddittoriamente ritiene che non era stata depositata la polizza assicurativa a sostegno della garanzia, dopo avere posto in rilievo che la Compagnia era stata ritualmente chiamata in causa e si era costituita e difesa, come risulta anche in questa sede, ove ha depositato controricorso e memoria e come si evince dalla sentenza di primo grado. E', infatti, evidente che non avendo contestato la chiamata in causa, deve dedursi che il C. fosse assicurato con la Compagnia, che nelle conclusioni avanti al Tribunale, chiese solo il rigetto della domanda e non sollevò alcuna eccezione in ordine alla esistenza della polizza. Si può, quindi, ragionevolmente dedurre che effettivamente si sia trattato di dimenticanza da parte del Tribunale, cui avrebbe dovuto porre rimedio il giudice dell'appello perchè specificamente investito della questione e su di essa nell'attuale controricorso tace l'INAAssitalia che era tenuta ad esibire la polizza o a disconoscerne la esistenza. Pertanto, risulta errata la decisione proprio lì dove ritiene elementi non sufficienti per valutare la domanda il mancato deposito della polizza e il fatto che non risulti essere stato restituito il fascicolo di primo grado dell'intimata società Assitalia, depositato prima dell'interruzione del procedimento a causa del decesso del suo procuratore costituito. 10. - L'esame dei due riferiti ricorsi conduce, quindi, ad affermare: 1) che vanno disattesi il primo e secondo motivo del ricorso principale; 2) che va affermato che per l'intervento in laparoscopia risulta sussistente il consenso informato per cui, risultano assorbite , in quanto irrilevanti, le censure di cui tratta lo stesso ricorso in merito ad esso intervento e ciò a prescindere dal conseguente loro rigetto; 3) che il consenso informato si configura come espressione del diritto alla dignità della persona nel trattamento della sua salute ed, in quanto tale, diritto fondamentale ed irretrattabile, che non può essere gestito discrezionalmente dal sanitario se non per casi di 78 urgenza o di trattamento sanitario obbligatorio; 4) che nel caso in esame tale consenso non è stato richiesto nè espresso dalla paziente per l'intervento in laparotomia, che non presentava carattere di urgenza; come, peraltro, riconosciuto sia dal Tribunale che dalla Corte territoriale; 5) che gli interventi di laparoscopia e di laparotomia furono eseguiti correttamente dal sanitario, seguendo le appropriate metodiche, tanto che la microlesione al colon fu evidenziata soltanto nel secondo intervento al San Camillo subito dalla paziente e la sua datazione e la sua causa sono rimaste incerte anche secondo le risultanze della CTU, in quanto non sono emersi elementi univoci circa la sua sicura derivazione dall'intervento del C., per cui tutto si è fermato nell'incertezza, condivisa anche dal perito incaricato in sede penale; 6)che la CTU, cui aderisce la sentenza impugnata, non necessitava di alcuna rinnovazione; 7) che il C. tenne una condotta gravemente omissiva circa la vigilanza sulla evoluzione della salute della paziente dopo l'intervento laparotomico; 8) che la mancanza di consenso informato sull'intervento laparotomico comporta l'assorbimento delle censure concernenti le voci di danno e le spese, in quanto su tutto ciò valuterà il giudice del rinvio; 9) che va accolto il secondo motivo di ricorso incidentale, stante la insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto da parte del giudice dell'appello. Conclusivamente, il ricorso principale va accolto nei limiti indicati, così come va accolto il secondo motivo del ricorso incidentale e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie per quanto di ragione il ricorso principale; accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, che rigetta nel resto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione. 79 10. TRIBUNALE DI BARI, SECONDA SEZIONE CIVILE, contenziosi 2576/2004 SENTENZA, n. R.G. affari FATTO Risulta in fatto, e non è contestato, che L. G., in data 19.05.2000, fu sottoposta presso la Casa di cura Anthea S.r.l., e ad opera della dott.ssa T. M. S., ad intervento chirurgico di mastoplastica additiva e mastopessi. Ciò premesso, nel presente giudizio la L. ha spiegato domanda, nei confronti della T. e della Anthea S.r.l., di risarcimento dei danni subiti in ragione dei deludenti risultati estetici dell'intervento chirurgico, sull'assunto che l'operazione aveva portato ad un aspetto estetico finale peggiore dello stato preoperatorio. Il giudizio ha, altresì, ad oggetto la domanda di risarcimento del danno per difetto di una completa informazione della L. in ordine ai potenziali risultati dell'intervento e la domanda di garanzia spiegata dalla T. nei confronti dell'Assitalia in virtù di polizza assicurativa. Deve rilevarsi, in via preliminare, che l'Anthea S.r.l. e l'Assitalia hanno eccepito per motivi diversi la nullità dell'atto di citazione per mancata individuazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda ex art. 163 n. 4 c.p.c. Sul punto giova rilevare che l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio. Nel caso di specie, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione delle ragioni della domanda, essendo necessario, per simile valutazione, che la causa petendi sia del tutto omessa o risulti assolutamente incerta, ipotesi che non ricorre quando tale elemento sia individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo presente che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni. poichè è sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo. Come è infondata l'eccezione dell'Anthea S.r.l. risultando dall'atto nel suo complesso evidenti le contestazioni nei confronti di questa sollevate dall'attrice, ovvero l'asserita corresponsabilità per l'esito non soddisfacente dell'intervento chirurgico compiuto nei locali della clinica convenuta, così altrettanto priva di pregio risulta l'analoga eccezione dell'Assitalia, posto che risultano evidenti le doglianze dell'attrice in merito all'allegato deludente esito dell'intervento di mastopessi (scivolamento della protesi, asimmetria delle mammelle ecc... ). Ha altresì rigettata l'eccezione proposta dall'Assitalia S.p.A. di inammissibilità della domanda di garanzia formulata della T. sull'assunto che il rischio garantito era solo quello relativo ad eventuali danni estetici e fisiognomici causati dalla esecuzione dell'intervento e non quello conseguente alla mancata rispondenza del risultato previsto e sperato. L'eccezione trova espressa smentita nel tenore letterale della polizza che copriva tutti i rischi conseguenti alla attività medico chirurgica della assicurata "compresi i danni estetici e fisiognomici" è anche priva di pregio giuridico essendo evidente che il mancato raggiungimento del risultato sperato rileva, ai fini della copertura assicurativa, nei limiti in cui corrisponda ad un errore del medico: circostanza, questa, sottesa alla pretesa azionata dalla attrice. Tanto premesso, il presente giudizio verte sull'accertamento della responsabilità professionale della T., e conseguentemente della clinica Anthea S.r.l., nei cui locali si è svolto il denunciato intervento di mastopessi, sotto un duplice profilo: per l'assenza della necessaria diligenza professionale e per la mancata acquisizione del consenso pienamente informato della paziente odierna attrice. Quanto al primo profilo posto che, secondo l'orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, ove l'istante deduca di aver subito un danno in ragione di una prestazione medico-chirurgica, a prescindere dal fatto che convenga in giudizio il singolo professionista o la struttura all'interno della quale ha subito il trattamento, si è in presenza di una ipotesi di responsabilità contrattuale, essendosi costituito un rapporto negoziale basato quanto meno sul contatto sociale va rilevato in generale che in tema di risarcimento del danno, il chirurgo, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti alla propria attività professionale, è tenuto ad 80 una diligenza che non è solo quella del buon padre di famiglia ex art. 1176. primo comma, cod. civ., ma e quella specifica del debitore qualificato, come prescritto dall'art. 1176, secondo comma, cod. cit.. la quale comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica. Del rispetto di tali regole ed accorgimenti ha dato atto il C.T.U. nella parte del suo elaborato (pag. 5) in cui rileva che la dott.ssa T. ha utilizzato quella che al momento dell'operazione era la tecnica più innovativa e che gli effetti indesiderati patiti dalla paziente (lo scivolamento della protesi o la piccola raccolta infiammatoria) non sono stati causati da un errore del chirurgo, la cui perizia è stata dimostrata dal soddisfacente decorso post-operatorio. Il C.T.U., alle cui conclusioni, che si ritengono logiche e coerenti, le parti non hanno opposto contrarie argomentazioni, ha quindi escluso la sussistenza del nesso causale tra la tecnica operatoria prescelta dalla T. e l'insorgenza delle predette complicanze. e ha evidenziato l'adeguatezza delle tecniche scelte dal chirurgo per l'intervento richiesto. Esclusa sul punto la responsabilità professionale della T. il C.T.U. ha invece avvalorato le allegazioni della parte attrice in merito alla incompletezza delle informazioni fornite a quest'ultima circa le complicanze dell'intervento e circa la possibilità di un risultato esteticamente meno confacente alle sue aspettative. Ad avviso del consulente, infatti, la possibilità dello scivolamento della protesi e della raccolta infiammatoria - che hanno complicato e compromesso il risultato dell'intervento e che non sono derivati da un errore del chirurgo, ma dall'assunzione da parte dell'attrice di una terapia con corticosteroidi interferente sulla sintesi dei tessuti e predisponente alle infezioni - potevano e dovevano formare oggetto di dettagliata informazione da parte del chirurgo. Sul punto la parte convenuta si è limitata ad eccepire la completezza delle informazioni fornite alla paziente come risultanti dal modulo allegato alla cartella clinica, fornito dalla clinica Anthea e regolarmente sottoscritto dalla paziente. L'eccezione è priva di pregio visto che quello esibito non è altro che un modulo standard, come confermato anche dal teste sentito all'udienza del 12.06.2006 in qualità di direttore sanitario della clinica, contenente, in quanto tale, informazioni necessariamente generiche, senz'altro prive della specificità richiesta dalla giurisprudenza e necessaria perché vi sia una manifestazione di consenso del paziente realmente consapevole. Sul punto la Cassazione con numerose decisioni (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 1950/1967, 1773/1981, 9705/1997 in tema proprio di chirurgia estetica, 5444/2006), ha affermato che "la mancata richiesta del consenso costituisce autonoma fonte di responsabilità qualora dall'intervento scaturiscano effetti lesivi per il paziente. per cui nessun rilievo può avere il fatto che l'intervento medesimo sia stato eseguito in modo corretto" (così Cass., n. 9374/1997). Ciò sull'implicito rilievo che, in difetto di "consenso informato" da parte del paziente, l'intervento terapeutico costituisce un illecito, sicché il medico risponde delle conseguenze negative che ne siano derivate quand'anche abbia correttamente eseguito quella prestazione. Tuttavia, nel caso specifico occorre porsi il problema se, perché il medico risponda del danno alla salute, occorre che sussista nesso causale tra mancata acquisizione di consenso consapevole e il pregiudizio lamentato dal paziente. La questione è stata recentemente esaminata dalla Cassazione e risolta in senso positivo (cfr. Cass. n. 2847 del 9.2.2010). Infatti, è stato affermato che occorre domandarsi, come in ogni valutazione controfattuale ipotetica, se la condotta omessa avrebbe evitato l'evento ove fosse stata tenuta: se, cioè l'adempimento da parte del medico dei suoi doveri informativi avrebbe prodotto l'effetto della non esecuzione dell'intervento chirurgico dal quale, senza colpa di alcuno lo stato patologico è poi derivato. E poiché l'intervento chirurgico non sarebbe stato eseguito solo se il paziente lo avesse rifiutato, per ravvisare la sussistenza di nesso causale tra lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente (realizzatosi mediante l'omessa informazione da parte del medico) e lesione della salute per le pure incolpevoli, conseguenze negative dell'intervento, deve potersi affermare che il paziente avrebbe rifiutato l'intervento ove fosse stato compiutamente informato, giacché altrimenti la condotta positiva omessa dal medico (informazione, ai fini dell'acquisizione di un consapevole consenso) non avrebbe comunque evitato l'evento (lesione della salute). In 81 altri termini, la risarcibilità del danno da lesione della salute che si verifichi per le non imprevedibili conseguenze dell'intervento chirurgico correttamente eseguito secundum legem artis, ma tuttavia effettuato senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, necessariamente presuppone l'accertamento che il paziente quel determinato intervento avrebbe rifiutato se fosse stato adeguatamente informato. La Cassazione rileva sul punto che "il relativo onere probatorio grava sul paziente: (a) perché la prova di nesso causale tra inadempimento e danno comunque compete alla parte che alleghi l'inadempimento altrui e pretenda per questo il risarcimento; (b) perché il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico; (c) perché si tratta pur sempre di stabilire in quale senso si sarebbe orientata la scelta soggettiva del paziente, sicché anche i l criterio di distribuzione dell'onere probatorio in funzione della "vicinanza" al fatto da provare induce alla medesima conclusione; (d) perché il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione di opportunità del medico costituisce un'eventualità che non corrisponde all'id quod plerumque accidit". Nel caso di specie, dunque, la domanda risarcitoria va rigettata non avendo l'attrice fornito la prova che, se correttamente ed esaustivamente informata, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento contestato. È pur vero che una siffatta prova può darsi anche in via presuntiva. Tuttavia, in via astratta può affermarsi che corrisponde a massima di esperienza che, a fronte di un intervento con finalità prettamente estetiche, il rischio di un peggioramento generale dell'aspetto costituisce uno degli aspetti generalmente presi in considerazione dal paziente, potendo anche rappresentare un valido deterrente. Ciò tuttavia, non è sufficiente per ritenere certo o altamente probabile che il rischio di un risultato estetico non pienamente soddisfacente induca qualsiasi paziente a desistere dall'intervento. Pertanto, non può affatto darsi per scontato che l'attrice non avrebbe comunque accettato il rischio delle conseguenze pregiudizievoli poi di fatto verificatesi, pur di raggiungere l'obiettivo estetico che si era riproposto. Va altresì evidenziato che anche nella ipotesi di prova presuntiva il danneggiato è onerato della allegazione di tutti ali elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei secondo i requisiti di gravità precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c. a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto. Nel caso di specie detta allegazione è del tutto assente. Al rigetto della domanda principale consegue il rigetto della domanda di garanzia. In ragione della complessità della questione trattata vi sono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di lite. P.Q.M. Definitivamente decidendo sulla domanda spiegata da L. G. nei confronti di T. M. S. e Casa di cura Anthea S.r.l. con atto di citazione notificato il 24 ed il 24 febbraio 2004 e sulla domanda di garanzia speigata da T. M. S. nei confronti della Assitalia con atto di chiamata in causa notificato il 31 luglio 2004 così provvede: - Rigetta tutte le domande - Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite. 82 11. CASSAZIONE Svolgimento CIVILE, SEZ. III, del 9.2.2010, N. 2847 processo 1. - Nel omissis del omissis L. S. agì giudizialmente nei confronti di G. Sb., che il omissis la aveva sottoposta ad intervento chirurgico per cataratta asportandole il cristallino dell'occhio destro, e ne chiese la condanna ai risarcimento dei danni per le complicanze (cheratite corneale bollosa) e le lesioni che affermò esserne conseguite. Il convenuto resistette. Con sentenza n. 2095 del 2002 il tribunale di Napoli, in esito a due consulenze tecniche d'ufficio, rigettò la domanda. Escluse in particolare che, a seguito del trapianto di cornea cui l'attrice si era poi sottoposta altrove, fossero residuati esiti permanenti dalla cheratite insorta dopo l'intervento di asportazione della cataratta; ritenne che lo stesso fosse necessario e che era stato eseguito correttamente, nel rispetto delle norme proprie della scienza medica; affermò che della mancanza di “consenso informato” avrebbe dovute dare prova la paziente e che tale prova era mancata. 2. - La corte d'appello di Napoli, decidendo con sentenza n. 242 del 2005 sul gravame della soccombente, ha riformato la sentenza sul seguente, sostanziale, testuale rilievo: “Non avendo lo Sb., sul quale incombeva l'onere di provare la presenza di un consenso informato (Cass., 23/2001, n. 7027) né affermato, né tanto meno provato, di aver informato la S. dei rischi prevedibili dell'intervento e di aver ricevuto il consenso di quest'ultima, va affermata - come richiesto dalla S. in primo grado, fin dal 26/2/1998 - la responsabilità del sanitario per i danni derivanti dall'intervento effettuato in difetto di detto consenso, nessun rilievo avendo la circostanza che l'intervento medesimo sia stato eseguito in modo corretto (Cass., 24/9/1997, n. 9374)” (pagina 6 della sentenza). Ha poi ritenuto che “il riconoscimento della responsabilità dello Sb. per carenza di consenso informato comporta la condanna dello stesso al risarcimento dei danni patiti dalla S. per l'invalidità temporanea, per le sofferenze patite per l'insorgenza della cheratite bollosa e per le spese affrontate per il successivo trapianto corneale, necessario ad eliminare la cheratopatia”; ed ha soggiunte che “l'assenza di specifici motivi di impugnazione della sentenza del Tribunale nella parte in cui non è stata riconosciuta la persistenza di una invalidità pur dopo il trapianto di cornea, determina l'inammissibilità della richiesta di risarcimento del danno biologico e per la assunta invalidità, e per il relativo danno morale” (pagina 3 della sentenza). Ha dunque liquidato il danno in euro 74.040, condannando il convenuto al pagamento della predetta somma, oltre agli accessori ed alle spese del doppio grado. 3. - Avverso la sentenza ricorre per cassazione G. Sb., affidandosi a quattro motivi illustrati pure da memoria. Resiste con controricorso L. S., che propone anche ricorso incidentale fondato su un unico motivo, avversato dallo Sb. con controricorso. Motivi della decisione 83 1. - I ricorsi IL vanno riuniti RICORSO in quanto proposti avverso PRINCIPALE la (del stessa sentenza. medico). 1.1. - Il primo motivo del ricorso dello Sb. investe la decisione in relazione alla ripartizione dell'onere della prova in materia di consenso informato, deducendosi violazione e falsa applicazione degli artt. 1337, 2697 e 2043 c.c. per avere la corte d'appello ritenuto che la prova dell'intervenuto consenso consapevole della paziente all'intervento dovesse essere data dal medico. Si afferma che il consenso del paziente inerisce alla fase che precede il contratto di prestazione d'opera professionale: si verterebbe dunque in ipotesi di responsabilità precontrattuale che, in quanto tradizionalmente inquadrata. nell'alveo della responsabilità aquiliana, è governata dalla regola secondo la quale la prova del fatto illecito deve essere data dal creditore. 1.2. - Il motivo è infondato alla luce dell'ormai definitivo approdo secondo il quale l'intervento stesso del medico, anche solo in funzione diagnostica, dà comunque luogo all'instaurazione di un rapporto di tipo contrattuale. Ne consegue che, effettuata la diagnosi in esecuzione del contratto, l'illustrazione al paziente delle conseguenze (certe o incerte che siano, purché non del tutto anomale) della terapia o dell'intervento che il medico consideri necessari o opportuni ai fini di ottenere, quante volte sia possibile, il necessario consenso del paziente all'esecuzione della prestazione terapeutica, costituisce un'obbligazione il cui adempimento deve essere provato dalla parte che l'altra affermi inadempiente, e dunque dal medico a fronte dell'allegazione di inadempimento da parte del paziente. 2. - Col secondo motivo è denunciato ogni possibile tipo di vizio della motivazione in punto di affermata prevedibilità della patologia corneale insorta dopo l'intervento chirurgico di asportazione della cataratta, affermandosi che tale prevedibilità è meramente postulata dalla corte territoriale e non supportata da argomenti idonei a contrastare le diverse conclusioni cui erano addivenuti i due consulenti tecnici. Si sostiene, mediante riferimento ai riprodotti passi delle relazioni dei due ausiliari, che il primo aveva affermato che “non vi era alcuna controindicazione all'intervento chirurgico per cataratta con inserimento del cristallino in camera posteriore” e che “l'innesto di cui sopra, oltre ad avere indicazione, era una necessità”; e che la relazione del secondo consulente, in riferimento all'intervenuto scompenso corneale con formazione di bolle, aveva ritenuto che l'evento era “non certo prevedibile, in quanto non erano stati individuati elementi di questo prodromici”, del pari concludendo nel senso della necessità dell'intervento. 2.1. - Anche questa censura è infondata. La conclusione della corte sulla prevedibilità della cheratite bollosa sopravvenuta all'intervento è correlata all'affermazione del primo c.t.u. che la “cheratite bollosa che insorge dopo l'intervento per cataratta è divenuta oggi una malattia molto diffusa”, essendo i relativi casi passati dal 2 al 21,2% del 1990 (secondo un trattato di chirurgia della cornea del 1994) ed all'ulteriore, saliente rilievo che la normale bilateralità della cornea guttata dalla quale la paziente era affetta e la circostanza che il medico non ne avesse mai attestato la presenza neanche all'occhio sinistro “benché la stessa sia di facile accertamento ..., prevedendo un ulteriore intervento di cataratta all'occhio sinistro dopo 15 o 20 gg. da quello all'occhio destro, lascia ragionevolmente presumere che lo Sb., pur consapevole della presenza di cornea guttata ad entrambi gli occhi, abbia taciuto tale circostanza alla S., programmando un duplice intervento - ai due occhi distintamente - con tutte le cautele del caso, senza tuttavia informare 84 la S. di una conseguenza più che probabile dell'intervento medesimo (vedi bibliografia allegata alla produzione di parte appellante)” (così la sentenza impugnata a pagina 7, capoverso). La conclusione è logicamente coerente, sufficiente e niente affatto contraddittoria, non essendo univocamente sintomatica del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. la circostanza che altri passi delle relazioni di consulenza avrebbero potuto indurre a conclusioni diverse. Tanto, in relazione al principio secondo il quale la scelta delle risultanze probatorie cui conferire determinante rilievo e l'interpretazione del risultato di una complessa attività intellettiva, quale può essere quella demandata al c.t.u., competono al giudice del merito, che nella specie ha dato puntuale conto dei passi della relazione e delle ulteriori risultanze sui quali ha fondato il proprio convincimento. Va soggiunto che, laddove la controricorrente S. prospetta che, in realtà, la seconda consulenza tecnica d'ufficio aveva concluso nel senso che la cornea guttata non era stata addirittura diagnosticata (pagina 5 del controricorso, in fine), evoca una possibilità che avrebbe potuto dar luogo ad una responsabilità da omessa diagnosi e da conseguente inadeguatezza della terapia chirurgica in concreto praticata; ma che, in difetto di censura da parte sua della motivazione della sentenza nella parte in cui il giudice del merito è addivenuto alla conclusione opposta (- il ricorso incidentale concerne un profilo del tutto diverso -), non è suscettibile di alcuna delibazione ulteriore, per essersi formato il giudicato sul punto. 3. - Col terzo motivo la sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e ss., concernenti i criteri di determinazione dei danni risarcibili, e per vizio di motivazione su punti decisivi. Sulla premessa che era stata acclarata l'assenza di qualsiasi profilo di colpa professionale nell'esecuzione dell'intervento chirurgico di asportazione della cataratta, il ricorrente rileva che l'avere la corte d'appello riconosciuto il risarcimento per le “lunghe sofferenze e le enormi spese” derivate alla paziente dalla cheratite bollosa conseguita all'intervento postula che l'evento di danno ascritto all'azione dell'oculista sia appunto la cheratite bollosa; mentre, essendo stata al medico ascritta esclusivamente la violazione del suo obbligo d'informazione, non le conseguenze della lesione del diritto alla salute potevano venire in considerazione ai fini risarcitori, ma solo quelle connesse alla lesione del diverso ed autonomo diritto alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente “sul se sottoporsi o meno all'intervento (artt. 2, 13, 32, secondo comma, Cost.)”, peraltro ritenuto necessario in relazione alle condizioni della paziente. Per addossare al medico le conseguenze negative dell'intervento, necessario e correttamente eseguito, sarebbe occorso addivenire alla conclusione che la paziente non vi si sarebbe sottoposta se fosse stata adeguatamente informata, non potendosi altrimenti affermare la sussistenza di nesso di causalità tra la violazione (omessa informazione) e il bene giuridico che si assume leso (la salute). Ma tale indagine non era stata compiuta; se lo fosse stata - conclude il ricorrente - la indiscutibile necessità dell'intervento avrebbe univocamente indotto la corte d'appello alla conclusione che ad esso la paziente si sarebbe sottoposta quand'anche fosse stata adeguatamente informata. 3.1. - Il problema che si pone è il seguente: a) se delle conseguenze pregiudizievoli per la salute di un intervento chirurgico necessario e correttamente eseguito il medico debba rispondere per il solo fatto di non avere informato il paziente della possibilità che quelle conseguenze si verificassero; b) o se, per dirle risarcibili, deve potersi affermare che il paziente all'intervento non si sarebbe 85 sottoposto se fosse stato informato. Effettivamente questa corte, con la sentenza citata nella sentenza impugnata e con numerose altre decisioni (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 1950/1967, 1773/1981, 9705/1997 in tema di chirurgia estetica, 5444/2006) ha affermato che “la mancata richiesta del consenso costituisce autonoma fonte di responsabilità qualora dall'intervento scaturiscano effetti lesivi, o addirittura mortali, per il paziente, per cui nessun rilievo può avere il fatto che l'intervento medesimo sia stato eseguito in modo corretto” (così Cass., n. 9374/1997). Ciò sull'implicito rilievo che, in difetto di “consenso informato” da parte del paziente, l'intervento terapeutico costituisce un illecito, sicché il medico risponde delle conseguenze negative che ne siano derivate quand'anche abbia correttamente eseguito quella prestazione. Non risulta però scrutinato ex professo il problema specifico che ora si pone: se cioè, perché il medico risponda del danno ala salute, occorre che sussista nesso causale tra mancata acquisizione di consenso consapevole e quel tipo di pregiudizio. Né tanto meno, ovviamente, è stato mai affermato che dal nesso causale possa prescindersi (anzi, vi è stato fatto esplicito riferimento da numerose altre decisioni, fra le quali Cass., n. 14638/2004 e, da ultimo, Cass., n. 10741/2009). Ora, la sussistenza di nesso eziologico non va indagata solo in relazione al rapporto di consequenzialità tra intervento terapeutico (necessario e correttamente eseguito) e pregiudizio della salute, che è addirittura scontato e che costituisce il presupposto stesso del problema che s'è sopra sintetizzato, il quale neppure sorgerebbe se il pregiudizio della salute non fosse conseguenza dell'intervento. La sussistenza di quel nesso va verificata in relazione al rapporto tra attività omissiva del medico per non aver informato il paziento ed esecuzione dell'intervento. La riduzione del problema al rilievo che, essendo illecita l'attività medica espletata senza consenso, per ciò stesso il medico debba rispondere delle conseguenze negative subite dal paziente che il consenso informato non abbia prestato, costituirebbe una semplificazione priva del necessario riguardo all'unitarietà del rapporto ed al reale atteggiarsi della questione, la quale non attiene tanto alla liceità dell'intervento del medico (che è solo una qualificazione successiva), ma che nasce dalla violazione del diritto all'autodeterminazione del paziente, essendo al medico anzitutto imputabile di non averlo adeguatamente informato per acquisirne il preventivo, consapevole consenso. Ché, se lo avesse fatto ed all'esecuzione dell'intervento (con le modalità rappresentategli) il paziente avesse in ipotesi acconsentito, sarebbe palese l'insussistenza di nesso di causalità materiale tra il comportamento omissivo del medico e la lesione della salute del paziente, perché quella lesione egli avrebbe in ogni caso subito. Rispetto alle conseguenze su tale piano pregiudizievoli occorre allora domandarsi, come in ogni valutazione controfattuale ipotetica, se la condotta omessa avrebbe evitato l'evento ove fosse stata tenuta: se, cioè, l'adempimento da parte del medico dei suoi doveri informativi avrebbe prodotto l'effetto della non esecuzione dell'intervento chirurgico dal quale, senza colpa di alcuno, lo stato patologico è poi derivato. E poiché l'intervento chirurgico non sarebbe stato eseguito solo se il paziente lo avesse rifiutato, per ravvisare la sussistenza di nesso causale tra lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente (realizzatosi mediante l'omessa informazione da parte del medico) e lesione della salute per le, pure incolpevoli, conseguenze negative dell'intervento (tuttavia non anomale in relazione allo sviluppo del processo causale: Cass., n. 14638/2004; deve potersi affermare che il paziente avrebbe rifiutato l'intervento ove fosse stato compiutamente informato, giacché altrimenti la condotta positiva omessa dal medico (informazione, ai fini dell'acquisizione di un consapevole consenso) non avrebbe comunque evitato l'evento (lesione della salute). 86 Tra le due sopra prospettate, la soluzione corretta in diritto è dunque la seconda. 3.2. - Il diritto all'autodeterminazione è, del resto, diverso dal diritto alla salute (Cass., n. 10741/2009 e Cass., n. 18513/2007, che ha qualificato come mutamento della causa petendi il porre a fondamento dell'azione di risarcimento danni conseguenti ad intervento chirurgico il difetto di consenso informato, dopo aver fondato tale azione sulla colpa professionale). Esso rappresenta, ad un tempo, una forma di rispetto per la libertà dell'individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi, che si sostanzia non solo nella facoltà di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma altresì di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, atteso il principio personalistico che anima la nostra Costituzione, la quale vede nella persona umana un valore etico in sé e ne sancisce il rispetto in qualsiasi momento della sua vita e nell'integralità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive (Cass., n. 21748/2007). Secondo la definizione della Corte costituzionale (sentenza n. 438 del 2008, sub. n. 4 del “Considerato in diritto”) il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'art. 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 Cost., i quali stabiliscono rispettivamente che «la libertà personale è inviolabile» e che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge». Afferma ancora la Consulta che numerose norme internazionali (che è qui superfluo richiamare ancora una volta) prevedono esplicitamente la necessità del consenso informato del paziente nell'ambito dei trattamenti medici. La diversità tra i due diritti è resa assolutamente palese dalle elementari considerazioni che, pur sussistendo il consenso consapevole, ben può configurarsi responsabilità da lesione della salute se la prestazione terapeutica sia tuttavia inadeguatamente eseguita; e che la lesione del diritto all'autodeterminazione non necessariamente comporta la lesione della salute, come accade quando manchi il consenso ma l'intervento terapeutico sortisca un esito assolutamente positivo (è la fattispecie cui ha avuto riguardo Cass. pen., sez. un., n. 2437 del 2009, concludendo per l'inconfigurabilità del delitto di violenza privata). Nel primo caso il consenso prestato dal paziente è irrilevante, poiché la lesione della salute si ricollega causalmente alla colposa condotta del medico nell'esecuzione della prestazione terapeutica, inesattamente adempiuta dopo la diagnosi. Nel secondo, la mancanza di consenso può assumere rilievo a fini risarcitori, benché non sussista lesione della salute (cfr. Cass., n. 2468/2009) o se la lesione della salute non sia causalmente collegabile alla lesione di quel diritto, quante volte siano configurabili conseguenze pregiudizievoli (di apprezzabile gravità, se integranti un danno non patrimoniale) che siano derivate dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in se stesso considerato (cfr., con riguardo al caso di danno patrimoniale e non patrimoniale da omessa diagnosi di feto malformato e di conseguente pregiudizio della possibilità per la madre di determinarsi a ricorrere all'interruzione volontaria della gravidanza, la recentissima Cass., n. 13 del 2010 e le ulteriori sentenze ivi richiamate). Viene anzitutto in rilievo il caso in cui alla prestazione terapeutica conseguano pregiudizi che il paziente avrebbe alternativamente preferito sopportare nell'ambito di scelte che solo a lui è dato di compiere. Non sarebbe utile a contrastare tale conclusione il riferimento alla prevalenza del bene “vita” o del bene “salute” rispetto ad altri possibili interessi, giacché una valutazione comparativa degli interessi assume rilievo nell'ambito del diritto quando soggetti 87 diversi siano titolari di interessi configgenti e sia dunque necessario, in funzione del raggiungimento del fine perseguito, stabilire quale debba prevalere e quale debba rispettivamente recedere o comunque rimanere privo di tutela; un “conflitto” regolabile ab externo è, invece, escluso in radice dalla titolarità di pur contrastanti interessi in capo allo stesso soggetto, al quale soltanto, se capace, compete la scelta di quale tutelare e quale sacrificare. Così, a titolo meramente esemplificativo, non potrebbe a priori negarsi tutela risarcitoria a chi abbia consapevolmente rifiutato una trasfusione di sangue perché in contrasto con la propria fede religiosa (al caso dei Testimoni di Geova si sono riferite, con soluzioni sostanzialmente opposte, Cass., nn. 23676/2008 e 4211/2007), quand'anche gli si sia salvata la vita praticandogliela, giacché egli potrebbe aver preferito non vivere, piuttosto che vivere nello stato determinatosi; così, ancora, non potrebbe in assoluto escludersi la risarcibilità del danno non patrimoniale da acuto o cronico dolore fisico (sul punto cfr. Cass., n. 23846/2008) nel caso in cui la scelta del medico di privilegiare la tutela dell'integrità fisica del paziente o della sua stessa vita, ma a prezzo di sofferenze fisiche che il paziente avrebbe potuto scegliere di non sopportare, sia stata effettuata senza il suo consenso, da acquisire in esito alla rappresentazione più puntuale possibile del dolore prevedibile, col bilanciamento reso necessario dall'esigenza che esso sia prospettato con modalità idonee a non ingenerare un aprioristico rifiuto dell'atto terapeutico, chirurgico o farmacologico. E nello stesso ambito dovrebbe inquadrarsi il diritto al risarcimento per la lesione derivata da un atto terapeutico che abbia salvaguardato la salute in un campo a discapito di un secondario pregiudizio sotto altro pure apprezzabile aspetto, che non sia stato tuttavia adeguatamente prospettato in funzione di una scelta consapevole del paziente, che la avrebbe in ipotesi compiuta in senso difforme da quello privilegiato dal medico. Viene, in secondo luogo, in rilievo la considerazione del turbamento e della sofferenza che deriva al paziente sottoposto ad atto terapeutico dal verificarsi di conseguenze del tutto inaspettate perché non prospettate e, anche per questo, più difficilmente accettate. L'informazione cui il medico è tenuto in vista dell'espressione del consenso del paziente vale anche, ove il consenso sia prestato, a determinare nel paziente l'accettazione di quel che di non gradito può avvenire, in una sorta di condivisione, della stessa speranza del medico che tutto vada bene e che non si verifichi quanto di male potrebbe capitare, perché inevitabile. Il paziente che sia stato messo in questa condizione - la quale integra un momento saliente della necessaria “alleanza terapeutica” col medico - accetta preventivamente l'esito sgradevole e, se questo si verifica, avrà anche una minore propensione ad incolpare il medico. Se tuttavia lo facesse, il medico non sarebbe tenuto a risarcirgli alcun danno sotto l'aspetto del difetto di informazione (salva la sua possibile responsabilità per avere, per qualunque ragione, mal diagnosticato o mal suggerito o male operato; ma si tratterebbe - come si è già chiarito - di un aspetto del tutto diverso, implicante una “colpa” collegata all'esecuzione della prestazione successiva). Ma se il paziente non sia stato convenientemente informato, quella condizione di spirito è inevitabilmente destinata a realizzarsi, ingenerando manifestazioni di turbamento di intensità ovviamente correlata alla gravità delle conseguenze verificatesi e non prospettate come possibili. Ed è appunto questo il danno non patrimoniale che, nella prevalenza dei casi, costituisce l'effetto del mancato rispetto dell'obbligo di informare il paziente. Condizione di risarcibilità di tale tipo di danno non patrimoniale è che esso varchi la soglia della gravità dell'offesa secondo i canoni delineati dalle sentenze delle Sezioni unite nn. da 26972 a 26974 del 2008, con le quali s'è stabilito che il diritto deve essere inciso oltre un certo livello minimo di tollerabilità, da determinarsi dal giudice nel bilanciamento tra principio di solidarietà e di tolleranza secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinate 88 momento storico. Non pare possibile offrire più specifiche indicazioni. Anche in caso di sola violazione del diritto all'autodeterminazione, pur senza correlativa lesione del diritto alla salute ricollegabile a quella violazione per essere stato l'intervento terapeutico necessario e correttamente eseguito, può dunque sussistere uno spazio risarcitorio; mentre la risarcibilità del danno da lesione della salute che si verifichi per le non imprevedibili conseguenze dell'atto terapeutico necessario e correttamente eseguito secundum leges artis, ma tuttavia effettuato senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, necessariamente presuppone l'accertamento che il paziente quel determinato intervento avrebbe rifiutato se fosse stato adeguatamente informato. 3.3. - Il relativo onere probatorio, suscettibile di essere soddisfatto anche mediante presunzioni, grava sul paziente: (a) perché la prova di nesso causale tra inadempimento e danno comunque compete alla parte che alleghi l'inadempimento altrui e pretenda per questo il risarcimento; (b) perché il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico; (c) perché si tratta pur sempre di stabilire in quale senso si sarebbe orientata la scelta soggettiva del paziente, sicché anche il criterio di distribuzione dell'onere probatorio in funzione della “vicinanza” al fatto da provare induce alla medesima conclusione; (d) perché il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione di opportunità del medico costituisce un'eventualità che non corrisponde all'id quod plerumque accidit. 3.4. - Se, nella specie, l'intervento sarebbe stato rifiutato dalla paziente ove il medico le avesse puntualmente rappresentato le sue possibili conseguenze è scrutinio che la corte d'appello ha del tutto omesso; e questo perché è incorsa nell'illustrato errore di diritto laddove ha ritenuto che della lesione della salute il medico dovesse rispondere per il solo difetto di un consenso consapevolmente prestato (che è locuzione più propria di quella corrente, giacché “informato” non è il consenso, ma deve esserlo il paziente che lo presta). Il motivo è conclusivamente fondato nella parte in cui è prospettata violazione di legge. Non anche nella parte in cui è denunciato vizio della motivazione, essendo stato l'apprezzamento di fatto sulle ipotetiche determinazioni della paziente precluso dalla assorbente (benché erronea) soluzione in diritto adottata. 4. - Col quarto motivo (erroneamente indicato anch'esso come terzo a pagina 19 del ricorso) è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 185 c.p. e 1223 e ss. c.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., nella parte in cui la corte d'appello ha liquidato, in aggiunta alle altre voci di danno (biologico da invalidità temporanea e patrimoniale), anche “il danno morale, tenuto conto delle sofferenze patite a seguito dell'insorgenza della cheratite bollosa e del successivo intervento chirurgico”. Si afferma, sotto un primo profilo, che il danno morale soggettivo può essere riconosciuto solo in presenza di una figura di reato, nella specie insussistente. E si sostiene, sotto altro profilo, che l'assenza di nesso causale tra violazione del dovere di informazione e cheratite bollosa insorta dopo l'intervengo, cui erano collegate le sofferenze patite dalla paziente, avrebbe imposto la soluzione opposta per le medesime ragioni indicate nel terzo motivo di ricorso. 4.1. - Il primo profilo di censura è infondato alla luce del principio secondo il quale la violazione di un diritto fondamentale della persona, qual è quello all'autodeterminazione in ordine alla tutela per via terapeutica della propria salate, comporta la risarcibilità di ogni tipo di pregiudizio non patrimoniale che ne sia causalmente derivato (Cass., Sez. un., nn. 26972, 26973 e 26974 del 2008, cui s'è allineata la giurisprudenza successiva). 89 Il secondo profilo è invece fondato per le ragioni già esposte in sede di esame del terzo motivo di ricorso, avendo la corte liquidato il danno morale soggettivo in esclusiva correlazione al ravvisato pregiudizio della salute, considerato risarcibile per una ragione errata in diritto. IL RICORSO INCIDENTALE (della paziente). 5. - Si duole la ricorrente L. S. che la corte d'appello abbia ritenuto inammissibile la domanda di risarcimento del danno da invalidità permanente per mancanza di specifici motivi di impugnazione sul punto, sostenendo che poiché la domanda di risarcimento era stata riproposta in appello, il gravame aveva necessariamente investito l'intero thema decidendum. 5.1. - Il motivo è manifestamente infondato. La ricorrente ha del tutto prescisso dalla circostanza che il giudice di primo grado aveva specificamente escluso che, in esito al successivo intervento di trapianto di cornea, fossero residuati postumi permanenti. E nella succinta illustrazione del motivo non si assume che tale specifica ratio decidendi sia stata oggetto di altrettanto specifica censura, come sarebbe stato necessario. CONCLUSIONI 6. - Rigettati il primo ed il secondo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale, vanno conclusivamente accolti, nei sensi sopra chiariti, il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale. La sentenza è cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio per un rinnovato apprezzamento del fatto alla luce dei principi enunciati e - in caso di conclusione sfavorevole alla paziente sulla risarcibilità del danno da pregiudizio temporaneo della salute, per difetto di nesso eziologico fra la condotta omissiva del medico e le complicanze conseguite all'intervento chirurgico - per l'apprezzamento ulteriore relativo alla eventuale sussistenza di uno spazio risarcitorio correlato alla sola lesione del diritto all'autodeterminazione, in relazione peraltro alle conseguenze che ne fossero in ipotesi derivate e non ravvisabile in ragione della lesione del diritto in se stessa considerata (secondo i principi enunciati dalle più volte citate sentenze delle Sezioni unite, che hanno ribadito l'inconfigurabilità del cosiddetto “danno evento”). Il giudice del rinvio, che si designa nella stessa corte d'appello in diversa composizione, regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi, rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale, accoglie per quanto di ragione il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale, cassa in relazione alle censure accolte e rinvia, arche per le spese del giudizio di legittimità, alla corte d'appello di Napoli in diversa composizione.
Scaricare