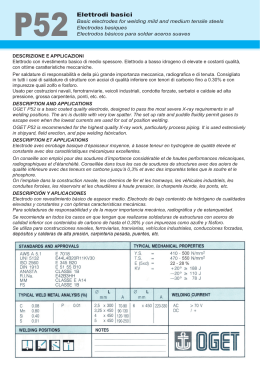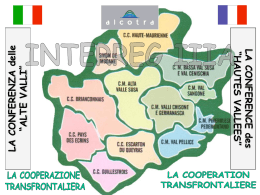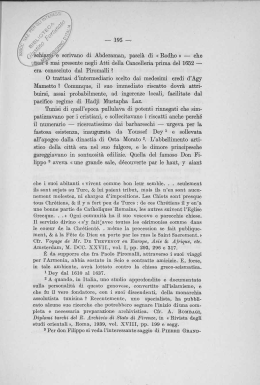STUDI E TESTI 55 CARMINELLA BIONDI Ces esclaves sont des hommes Lotta abolizionista e letteratura negrofila nella Francia del Settecento Prefazione di Corrado Rosso PISA EDITRICE LIBRERIA GOLIARDICA 1979 1 Il titolo è tratto da M. Lamiral réfuté par lui-même, ou Réponse aux opinions de cet auteur, sur l’abolition de la Traite des Noirs que la France ne doit point différer de faire au Sénégal. Par un ami des Blancs et des Noirs [François-Xavier Lanthenas], [Parigi], 1790, p. 9: «...les marchands (...) se mettent peu en peine de faire enseigner une morale qui auroit appris, depuis long-temps, que ces esclaves sont des hommes, et qu’ils ne doivent point être traités par leurs semblables, comme des bêtes, en les achetant et les livrant comme des marchandises ». Abbiamo conservato la grafia originale, anche quando presenta varianti all’interno di una stessa opera. Il corsivo, salvo diversa indicazione, è nostro. 3 La servitude, telle qu’un volcan destructeur, dessèche, brûle, engloutit tout ce qui l’environne: la liberté, au contraire, mène toujours à sa suite le bonheur, l’abondance et les arts. (Henrion de Pansey, Mémoire pour un nègre qui réclame sa liberté, 1770). 4 Prefazione Qualche anno fa, presentando il primo volume della vasta ricerca intrapresa da Carminella Biondi sulla schiavitù nel Settecento, mettevamo in rilievo il rigore e il coraggio con cui l’autrice denunciava il rovescio tenebroso del cosiddetto « secolo dei Lumi »: con sorpresa, con stupore, con orrore scoprivamo quanto fitta fosse la trama di complicità e di connivenze grazie alle quali, anche presso gli ambienti più al di sopra di ogni sospetto, la tratta e la schiavitù trovavano una collocazione rispettata (e persino dignitosa) nell’età delle riforme e del razionalismo ugualitaristico. In questo secondo volume, maturato attraverso un lungo e intenso travaglio, l’autrice non cessa di stupirci insegnandoci a vedere quanto meno ci aspettavamo. Demitizzante e rabbrividente era stato il primo volume, altrettanto sconvolgente è questo secondo, dedicato – credevamo – a una « riabilitazione » del secolo, almeno da questo punto di vista. Infatti, in Mon frère, tu es mon esclave! Carminella Biondi studiava le dottrine e gli atteggiamenti pratici che avevano permesso l’odioso fiorire dello schiavismo nel secolo dei « philosophes »; in questo secondo volume l’autrice si riprometteva d’indagare le origini e lo sviluppo di quel movimento abolizionista che avrebbe cancellato un’onta così grave, di dimensioni davvero planetarie. Certamente Carminella Biondi è stata fedele al suo progetto, soltanto che, ancora una volta, ci lascia col fiato sospeso. Infatti il libro non finisce, – come sembrava – con un « lieto fine ». Le pagine della Biondi non si concludono col decreto del 4 febbraio 1794, con cui la Convenzione Nazionale dichiara abolita la schiavitù. Ma c’è un « resto » che arriva, e questo resto è nientemeno che il decreto di Napoleone, del 1802, con cui si torna come prima, e la schiavitù viene ripristinata... Abolire l’abolizionismo è operazione estremamente grave, perché ormai gli orrori della schiavitù non beneficiano più né d’ignoranza né d’indulgenza, tanto sono stati, lungo quasi tutto il secolo, smascherati e bollati a fuoco. Ma, in realtà, questo colpo di scena non ci coglie impreparati. L’autrice svolge una ricerca troppo critica per abbandonarsi al mito di un movimento abolizionista profondamente conscio delle sue ragioni e guidato da una concezione limpidamente ugualitaria, serenamente umana. Fatte le debite eccezioni, molto spesso gli abolizionisti ora sono vittime di una negrofila bontà zuccherosa da muover il riso o da suscitare il disgusto, ora sono semplicemente dei ragionieri più o meno fisiocratici che hanno rifatto i calcoli e si accorgono che schiavitù e tratta funzionano male (o non funzionano per niente): cioè non rendono. Nella schiera di coloro che hanno avuto una parte nel denunciare il pessimo funzionamento della schiavitù, accanto cioè a missionari come Du 5 Tertre e Labat, a pensatori come Montaigne e Montesquieu, a un « giornalista » come Prévost, a una romanziera moralmente poco specchiata come Aphra Behn (l’autrice di Oronoko, lo « schiavo regale ») ecc., Carminella Biondi non esita a mettere in primo piano un molto prosaico e del tutto obliato funzionario-burocrate come Poivre (il nome è già tutto un programma!) i cui viaggi presso i coloni, comprendenti ispezioni e discorsi « sovversivi » (una sovversione che veniva da Parigi...) hanno forse fatto di più, in favore dell’abolizione, che non l’azione nobilissima dell’abbé Grégoire... Nella sua puntigliosa e irrinunciabile ricerca di chiarezza, l’autrice finisce per trovarsi più a suo agio presso un sanguigno e manesco missionario come Labat (anche lui commerciante in schiavi) che non presso abolizionisti più convinti e intransigenti, ma infinitamente meno sinceri verso l’umanità dei negri. Si poteva facilmente pensare, durante i lunghi anni in cui Carminella Biondi costruiva pezzo per pezzo il suo complesso mosaico, inseguendo e controllando testimonianze di ogni genere (dai testi giuridici alla narrativa, al teatro), che il suo libro conducesse a una sorta di apologia del Settecento. All’errore sarebbe successa l’espiazione, l’abolizionismo vincitore avrebbe fatto dimenticare lo scandalo di troppe chiusure interessate, di troppi silenzi, di troppo cinismo: avrebbe fatto scendere un sipario di luce su tanta, incommensurabile, umana sofferenza. Invece le nostre orecchie non odono alcuna nota trionfale. La musica è in sordina, ed è quasi una marcia funebre. Questo libro, che sembrava nascere come una storia dell’abolizionismo, cioè di un colossale ravvedimento, ne effettua anche e soprattutto il processo. In molti casi l’abolizionismo è un oscillare ambiguo dalla condanna all’approvazione (entro certi limiti) come nello sfingetico Montesquieu, cui l’autrice dedica una sostanziosa e meditata parte del suo libro. In altri casi l’abolizionismo, più che un moto di animi liberi che vogliono anche per gli altri, la libertà è il risultato meccanico della convergenza di un insieme d’interessi che il passare del tempo rende sempre meno eludibili. Basterà che interessi opposti si facciano strada e l’abolizione sarà abolita con un solo tratto di penna... Per liberare davvero bisogna amare o, almeno, conoscere. L’abolizionismo può ben aver creato gli strumenti legali dell’affrancamento, ma questi da soli, astratti dalle persone cui devono applicarsi, non bastano, come, d’altra parte, non bastano i buoni sentimenti senza l’usbergo e la sanzione della legge. Ci voleva una conoscenza profonda dei negri e della loro realtà umana, un apprezzamento scevro di pregiudizi dei loro costumi e delle loro qualità. Soltanto chi viveva con loro li poteva davvero conoscere. I migliori abolizionisti sarebbero potuti essere i coloni, se questi non fossero stati tragicamente acciecati dall’interesse e dalla paura. Gli storici della guerra di secessione hanno osservato che se il Sud poté resistere così a lungo alle preponderanti forze nordiste, ciò fu in gran parte anche perché il fronte interno moralmente non cedette, in quanto i negri (uomini e donne) sostituirono validamente nelle famiglie i combattenti lontani: situazione paradossale, ma che insegna esser sempre la vera liberazione una forma d’integrazione in un sistema di vita e di valori. Altrimenti liberare vuol dire astrattezza e alienazione. Un Labat che trattava i negri come « mele » – per usare il linguaggio colorito dell’autrice – cioè come oggetti 6 interscambiabili, era per altro in grado di apprezzarne l’amor proprio sottile ed esigente, la bellezza fisica, la pelle liscia come velluto, l’intelligenza e il coraggio: non a torto la Biondi vede nell’atteggiamento di questo curioso missionario trafficante schiavista l’inizio di una autentica liberazione. Perciò l’insegnamento più vitale che si può trarre da questo libro scritto con estrema e « scorticante » sincerità – per servirci di un aggettivo caro all’autrice – prescindendo dai notevoli contributi ch’esso porta alla conoscenza di un secolo non ancora abbastanza studiato da tale punto di vista, è che il movimento abolizionista non è stato una progressione in linea retta né un’operazione politica condotta da una sola parte. Ci sono volute le rivolte dei negri, le sollevazioni, le fughe, il « marronnage »; c’è voluta, soprattutto, da parte dei bianchi, come anche presso i negri, una vera e propria rivoluzione negli animi e nei sentimenti, oltreché nelle leggi. Questa rivoluzione – ci fa capire benissimo Carminella Biondi – ora con fresca ed esaltante speranza, ora con liberatrice ironia, – è certamente scoppiata nel Settecento ma ha raggiunto solo taluni dei suoi obiettivi. Non è finita nemmeno oggi. E’ una rivoluzione che continua. Corrado Rosso 7 PREMESSE PER UN DISCORSO ABOLIZIONISTA 8 I PRIMI MISSIONARI DELLE ANTILLE FRANCESI DI FRONTE ALLA SCHIAVITÙ La Francia entra a far parte delle grandi potenze schiaviste relativamente tardi rispetto ad altri paesi europei. Soltanto a partire dal 1674, infatti, le Antille, che devono la loro prosperità all’impiego di manodopera servile, passano alle dipendenze dirette del governo francese, mentre fino a quella data erano conquista e proprietà di privati: filibustieri, bucanieri o grandi signori che li avevano ingaggiati al loro servizio. Questo nuovo acquisto impegna il governo nell’elaborazione di un corpo di leggi speciali, allo scopo di legalizzare una situazione che è illegale secondo le leggi vigenti in Francia, dove non è permessa la schiavitù, mentre l’organizzazione coloniale delle Antille si regge sull’impiego di schiavi negri importati dall’Africa. Nasce a questo fine, nel 1685, il Code Noir continuamente aggiornato anche nel corso del secolo seguente, destinato appunto a regolare l’uso di questi emigrati involontari dalla pelle nera. La Francia, come del resto tutte le potenze schiaviste, deve così riconoscere come legale nelle Antille una condizione che è illegale sul territorio metropolitano, illegale per un francese o un europeo, e accettabile soltanto se concerne un gruppo etnico diverso trapiantato in America con i sistemi ed i pretesti più vari, ma in ogni caso non applicabili (almeno su vasta scala) entro i confini della « civile » Europa (1). La Francia deve cioè, in ultima analisi, approvare il sopruso e la violenza, tentando poi di mascherarli con una parvenza di legalità. È una situazione ambigua e difficile da sostenere, soprattutto quando le voci di protesta si faranno più decise, e più precise, documentate, incalzanti le ragioni della condanna. È però una situazione che offre, almeno agli inizi, profitti considerevoli e che crea a poco a poco un reticolato assai fitto di industrie e di commerci in tutta la Francia. Vengono così relegati in secondo piano, col passare del tempo, non solo gli eventuali scrupoli residui, ma persino il problema del profitto reale, essendo ormai la produzione coloniale una sorta di punto di riferimento di buona parte del commercio e dell’industria francesi, e quindi la base di un edificio immenso che sarebbe stato fortemente scosso una volta intaccate queste fondamenta. La lotta degli abolizionisti sarà perciò lunga e difficile e la prima abolizione, 9 decretata nel 1794, in pieno fervore rivoluzionario, dopo tergiversazioni e rinvii senza una preparazione adeguata e sotto la spinta della rivolta negra di San Domingo, sarà piuttosto il frutto di un entusiasmo generoso che lo sbocco meditato di una riflessione matura da parte del potere politico sulla realtà nazionale e coloniale (2). Le proteste cominciano comunque a farsi insistenti ben prima del periodo rivoluzionario, a mano a mano che la realtà della tratta e della schiavitù sono meglio conosciute anche da coloro che non vi sono coinvolti. E si fanno infine coordinate proprio negli anni immediatamente precedenti alla Rivoluzione, che sono anche gli anni di maggior splendore delle colonie francesi fondate sulla schiavitù negra. Sono le voci più disparate, di uomini di legge e di chiesa, di philosophes o di economisti, di funzionari governativi o di letterati e persino, in qualche rara occasione, di ex-negrieri (3). Ma, prima che la protesta abolizionista assuma queste proporzioni e che il problema dilaghi fino ad insinuarsi nelle opere più insospettabili e meno idonee a trattarlo con un minimo di serietà e di competenza (pur essendo animate dalle migliori intenzioni), assistiamo al suo lento maturarsi proprio anche in seno a scritti nati con tutt’altro scopo. Fra questi, un posto di primo piano spetta, ad esempio, agli scritti dei missionari che danno, in linea di massima, il loro assenso alla tratta e alla schiavitù quali strumenti di salvezza eterna (4), ma che non possono non registrare moti di pietà per la misera sorte degli schiavi o suscitare compassione e anche rivolta nel lettore di fronte alla descrizione di condizioni di vita tanto crudeli. Nelle loro opere è inoltre chiaramente affermato che gli schiavi negri sono figli di Dio, alla stessa stregua dei bianchi, e non esseri dalla natura incerta a metà strada tra l’uomo e l’animale, come certe relazioni di viaggio lasciano intendere o come è detto spesso, in maniera esplicita, negli scritti degli schiavisti allo scopo di poter pretendere tutto da questi uomini, senza dover loro nulla. Se la salvezza eterna basta per giustificare agli occhi dei missionari la vendita e l’asservimento di un « idolatra », è chiaro che molti lettori europei, non riconoscendo valido lo stesso fine, non troveranno alla schiavitù negra alcun’altra giustificazione che il bruto profitto. Il testo dei missionari può prestarsi così ad una chiave di lettura totalmente diversa e fungere da molla che fa scattare un atteggiamento di protesta contro la schiavitù. Ma anche soltanto in base alla lettura voluta dai missionari stessi, queste opere costituiranno uno stimolo a guardare con interesse la vicenda degli uomini di colore che, attraverso la schiavitù (ed il battesimo), escono da una realtà nebulosa e leggendaria per entrare a far parte della realtà dell’uomo bianco. È infatti un fenomeno importante che la vita dell’Europeo si apra ad incorporare 10 questa realtà diversa dalla sua, dapprima in maniera totalmente negativa e utilitaristica (fatta eccezione di pochi), poi nelle forme positive di una ricerca sull’uomo, verso una nuova definizione che tenga conto di questi apporti così diversi, non certo ignorati in passato, ma distanti e troppo poco pressanti per sollecitare una soluzione. Le relazioni dei missionari hanno dunque svolto, sia pure in forme distorte dai fini della loro missione, un’insostituibile opera informativa, premessa indispensabile ad ogni forma di critica. Si devono a loro anche le prime voci di pietà, se non di condanna della schiavitù. Essi hanno infatti preceduto o seguito i mercanti di schiavi in Africa ed impiantato in America le loro missioni in mezzo alle abitazioni dei coloni, servendosi generalmente degli stessi mezzi di sussistenza, vale a dire lo sfruttamento di un terreno ad opera di schiavi negri. Conoscono quindi, per esperienza diretta e prolungata nel tempo, la condizione in cui questi sono costretti a lavorare e la loro testimonianza va tenuta in gran conto, pur facendo le dovute riserve trattandosi di parti in causa. Nella misura in cui hanno dunque fatto opera di informatori e avanzato le prime pur parziali critiche, i missionari possono avere una loro collocazione alle origini del pensiero abolizionista. La loro posizione è indubbiamente ambigua: condannano e giustificano ad un tempo, o meglio, denunciano un male senza affrontarne con decisione le cause e finiscono per riscattarlo in nome di un bene futuro, ma la denuncia esiste, il problema è posto, ed i lettori che entrano, anche grazie alle loro opere, in contatto con il mondo africano ed americano ne prenderanno a poco a poco coscienza. Fra le relazioni di missionari che sono vissuti accanto agli schiavi e ai coloni nelle Antille francesi, al momento della loro « nascita » e agli albori del loro prodigioso sviluppo, due ci sembrano particolarmente interessanti: l’Histoire générale des Antilles del padre domenicano Jean-Baptiste Du Tertre (5) e il Nouveau voyage aux isles de l’Amérique dovuto anch’esso ad un padre domenicano, Jean-Baptiste Labat (6). La prima rispecchia la situazione delle Antille francesi ancora disgiunte dalla corona, con pochi schiavi e scarso sfruttamento del territorio, la seconda una situazione ben diversa, con un già notevole numero di schiavi e uno sviluppo in piena ascesa. Un momento in cui si cerca di fugare gli ultimi dubbi sulla legittimità di servirsi di schiavi negri, soprattutto se la loro provenienza sia incerta (7), per creare una macchina perfetta in cui anche la distruzione dell’uomo sia un ingranaggio ben oliato e per nulla stridente. Fin dal 1654 il padre Du Tertre, pur giustificando la schiavitù negra in nome della salvezza eterna, nella sua Histoire générale des isles de S. Christophe, de la 11 Guadeloupe, de la Martinique et autres dans l’Amérique (prima versione dell’Histoire des Ant-isles), condannava il modo disumano in cui erano trattati gli schiavi e la loro riduzione a strumenti animali: « Nos habitans traitent ces pauvres miserables ni plus ni moins que nous traitons les chevaux en France: ils en tirent du travail autant que la nature leur en peut permettre; s’ils les sollicitent dans leurs maladies, c’est plutost de peur de perdre ce qu’ils valent et leur service, que par compassion qu’ils ayent de leurs maux (...). Plusieurs les battent tous pour les fautes d’un particulier. Après qu’ils ont tout le corps meurtry et déchiré, ils les lavent avec de l’eau, du sel, et du piment, ce qui leur cause autant de douleur que les coups qu’ils ont receu » (8). Ci sono persino momenti, in questa prima Histoire générale, in cui la sua scarsa simpatia per la schiavitù non sembra trovare un contrappeso sufficiente nella convinzione che si tratti di un mezzo per condurre tante anime nuove a Dio. Per cui, sotto molti aspetti, la prima versione della sua opera è certamente più critica della versione definitiva, nella quale vengono contestati aspetti negativi della istituzione, oppure vengono mossi rilievi di carattere morale o umanitario, ma non ci sono attacchi diretti ai coloni che coinvolgano globalmente la schiavitù, come può capitare di scoprire invece in questo « abbozzo »: « ...on persuadera plutost aux riches du monde de renoncer à leurs moyens, qu’aux habitans des Indes de ne point tenir d’esclaues, et d’abolir le honteux commerce, vendition et achapt de leurs semblables, je dis mesme des chretiens et regenerez des eaux salutaires du sacrement de Baptesme comme eux... » (9). Non solo non troveremo più una critica così precisa ed espressa senza attenuanti, ma addirittura l’incipit del secondo capitolo del Traité VIII, dedicato agli schiavi, nella stesura definitiva farà pensare, come vedremo più oltre, quasi ad una sorta di ritrattazione o di autocritica. Anche nella stesura definitiva si ritroverà comunque una grande lucidità nel denunciare i mali legati alla schiavitù, pur senza arrivare alla sua proscrizione. Du Tertre deplorerà la mancanza di umanità nei padroni, il potere assoluto che questi possono esercitare sugli schiavi (10), (non esistevano ancora le sia pur blande e inascoltate limitazioni del Code noir), la durezza delle punizioni (11), delle quali peraltro sostiene la necessità, la scarsità del nutrimento (12) e l’imposizione di un 12 lavoro eccessivo (13). Ma per tutto questo non trova altro rimedio se non quello di consigliare ai padroni una maggiore umanità (14), pur sapendo, o almeno sospettando, che si tratta di discorsi inutili, incapaci di agire sulla realtà e di mitigare le sofferenze di vite che potrebbero divenire ancora più atroci se l’interesse riuscisse infine a regnare da solo sulle colonie. Leggiamo a conclusione del capitolo dedicato agli schiavi: « ... ie plains bien les esclaves, où il n’y a point de Religieux qui estendent leur charité sur eux iusqu’apres leur mort; et si iamais l’interest regne dans les lsles, il est certain qu’ils n’auront plus de soulagement » (Ib., p. 539). Non è certo estraneo a questo rilievo l’intento di valorizzare la presenza del missionario nelle colonie, la sua funzione di barriera spirituale (e talvolta materiale) contro il dominio del profitto, ma esso apre anche spiragli su condizioni di vita spaventose, perché la realtà coloniale è di fatto unicamente dominata dall’interesse. C’è però un momento in cui, al di là della maggiore o minore umanità dei padroni e al di là delle condizioni di lavoro imposte agli schiavi, quindi ben al di là del rimedio da lui stesso proposto, Du Tertre scopre il vizio di fondo della schiavitù per il quale non valgono giustificazioni. Dopo aver elencato il caldo terribile e il cattivo carattere dei sorveglianti fra i mali peggiori che affliggono lo schiavo, egli conclude: « Mais ce qui rend leur travail le plus pénible et le plus fâcheux à mon advis, c’est l’infructuosité de ce travail; car ils savent bien que toutes leurs sueurs vont au profit de leurs Maistres, et que quand ils leur amasseroient des montagnes d’or, il ne leur en reviendra jamais rien, et que quand ils vivroient des siecles entiers, et qu’ils travailleroient davantage qu’ils ne font, ils ne retireroient pas un sol de profit de toutes leurs peines » (Ib., p. 524). La sua posizione dunque, almeno in alcuni momenti di particolare lucidità, trascende la semplice espressione di riserve nei riguardi di un sistema o la critica dei suoi abusi, per individuare il male alle radici. Eppure il padre Du Tertre è possessore di schiavi, o almeno la sua missione ne possiede, si rallegra del fatto che la schiavitù ha «engendré à Iesus Christ et à 13 l’Eglise» più di quindicimila uomini, e che questi restino fedeli alla religione abbracciata fino alla morte, anche grazie alla condizione di schiavitù nella quale vivono. Ma quel che è peggio, il Traité VIII, dedicato appunto agli Esclaues des Antilles de l’Amérique, si apre con una giustificazione dei coloni che, come si è detto, sembra una ritrattazione di certe accuse che lui stesso aveva loro mosse in precedenza: « Ie ne pretens pas traiter icy, en Iurisconsulte de la nature de la servitude, et de la qualité du Domaine que l’homme acquiert sur son semblable, par l’achapt, par la naissance, et par le droit de guerre (15): mais seulement iustifier nos habitans du reproche injurieux, que plusieurs personnes, plus pieuses que sçavantes, leur font, de ce qu’ils traitent des chrestiens comme des esclaues, les achetant, les vendant, et en disposant, dans un Païs où ils viuent selon les loix de la France, qui abhorre la seruitude sur toutes les Nations du Monde, et où tous les esclaues recouvrent heureusement la liberté perduë, si-tost qu’ils y abordent, et qu’ils en touchent la terre» (Ib., p. 483). Bisogna riconoscere che la difesa dei coloni, così chiaramente enunciata ad apertura di discorso, si trasforma spesso in requisitoria a loro carico; resta comunque vero che, fatta eccezione dei singoli rilievi, il comportamento dei coloni trova, in linea di principio, giustificazione agli occhi del buon domenicano. Ma, indipendentemente dagli intenti del padre Du Tertre, il brano ci sembra di un interesse straordinario, perché dimostra una resistenza dell’opinione pubblica all’impiego di schiavi negri nelle colonie possedute dai Francesi nelle Antille fin dal loro nascere e prima ancora che divenissero possedimenti francesi. E, soprattutto, prima che divenissero quella ricca fonte di guadagno che ha tacitato per quasi un secolo molte « buone coscienze ». La condanna sembra articolarsi in due punti: 1) non è lecito che dei cristiani rendano schiavi altri cristiani; 2) non è lecito che questo accada in un territorio alle dipendenze della Francia, le cui leggi riconoscono a tutti la libertà. Si sollevano cioè abiezioni dì natura religioso-morale e di natura legale: alle prime si incaricheranno di rispondere i teorici della schiavitù coadiuvati da uomini di Chiesa, alle seconde risponderà il governo con l’emanazione del Code noir, che non chiuderà le porte alla critica, ma ne smusserà per un certo periodo la vitalità e la portata. Tutto rientra dunque nell’ordine: la schiavitù conduce a Dio ed è regolarmente codificata (16). 14 D’altra parte, come fa rilevare Du Tertre e come diranno in seguito tutti gli schiavisti francesi, ci si può sempre sentire in pace con la coscienza pensando che i mali sopportati dagli schiavi nelle Antille sono assai minori di quelli che subiscono nella loro terra di origine, per cui la schiavitù in America è da loro sentita come una condizione ottimale: « ...car soit que leur Climat soit ingrat, ou qu’ils negligent par paresse d’en cultiver la terre, ils s’estiment plus heureux d’estre esclaves parmy nous, quand ils y sont passablement nourris, et qu’on les traite avec douceur, que d’être libres en leur pays où ils meurent de faim... » (Ib., p. 535) (17). L’aggettivo heureux, pur sembrando fuori luogo in un contesto come quello evocato da Du Tertre, ritorna spesso sotto la sua penna. Egli afferma infatti a più riprese che lo schiavo negro, trattato bene e ben nutrito, è felice e che nulla gli è più indifferente del lontano paese d’origine: « ...On peut dire que toute la terre est leur patrie, car pourveu qu’ils trouvent à boire et à manger, tous les Pays leur sont indifferens (...) ils ne sont pas moins joyeux dans leur servitude, que s’ils estoient parfaitement libres... » (Ib., p. 527) (18). Gli schiavi si accontentano dunque di una vita animale relativamente facile e la cosa può essere persino credibile, entro certi limiti, soprattutto se si tiene conto della terribile esperienza vissuta sulle navi negriere e degli esempi di crudeltà che vedono attorno a loro. Va detto infatti che Du Tertre insiste molto sulla grande sventura di coloro che incontrano un padrone od un sorvegliante cattivo: allora è una infelicità senza attenuazioni e senza speranza. Nell’insieme, tutto sommato, lo spettacolo dell’infelicità deve essere di gran lunga più comune se Du Tertre, in questo suo continuo oscillare fra la pietà provata per gli schiavi ed il bisogno di giustificare e capire le ragioni dei padroni bianchi, commisererà l’offesa e l’ingiustizia subita dai popoli di razza negra con parole che non ammettono l’esistenza di una possibile felicità: 15 « C’est veritablement en la personne des Nègres, que nous deplorons les miseres effroyables qui sont attachées à la seruitude (...) et comme si la noirceur de leur corps estoit le caractere de leur infortune, on les traite en esclaves, on les nourrit comme on veut, on les pousse au travail comme des bestes, et l’on en tire de gré ou de force jusqu’à leur mort, tout le service dont ils sont capables » (Ib., p. 493) (19). Il complesso atteggiamento del domenicano di fronte alla schiavitù coloniale, la sua onestà nel rilevare i possibili vantaggi ed i grandi limiti, la volontà di giustificarla in qualche modo e, nel contempo, l’umana e religiosa pietà di fronte alla sofferenza, sono sintomatici delle perplessità che essa ha suscitato negli animi onesti fin dal suo nascere (anche quando hanno finito, per ragioni diverse, coll’accettarla). Proprio per questo l’opera di Du Tertre ha qualità che si ritroveranno difficilmente in seguito nelle relazioni dei missionari, quando la terribile macchina dello sfruttamento coloniale avrà preso velocità. Fra queste, va posta in rilievo la ricerca costante di obiettività nella descrizione della vita nelle colonie e, in particolare, della condizione servile. Bisogna inoltre precisare che, nonostante i limiti su cui si è posto l’accento, l’opera di Du Tertre è più severa nei confronti della schiavitù di tante altre di missionari o di viaggiatori laici scritte anche molti anni più tardi. Un lettore abolizionista avrebbe potuto reperirvi molti argomenti da usare a sostegno della sua causa. Ben diverso è l’atteggiamento del padre Labat, vissuto nelle Antille tra la fine del ‘600 e i primi anni del ‘700, che pubblica la sua opera una cinquantina d’anni dopo Du Tertre, all’inizio del secolo dei Lumi e della grande ascesa delle colonie schiaviste. Labat è un personaggio straordinario, che balza fuori vivo e corpulento dal Nouveau voyage aux isles de l’Amérique, un diario avvincente come un romanzo d’avventure, di cui l’autore è il « grande protagonista » (20). È un uomo che ama l’azione, il coraggio e l’efficienza fisica, che ha capito la logica del complesso e difficile mondo coloniale, retto da regole inapplicabili in Europa: un mondo in cui il filibustiere è un suddito onorato alla stregua di qualsiasi altro funzionario che renda servizio alla patria. Non ci stupisce quindi incontrare il padre Labat su una nave di filibustieri che solca il Mar dei Caraibi e leggere la descrizione molto vivace (in cui non si coglie l’ombra di una riserva) di scene di attacco, spoliazione ed affondamento di navi spagnole ed inglesi. Ma, dopotutto, si trattava di una forma di lotta approvata dal 16 governo e un buon religioso non poteva che dare la sua benedizione, soprattutto se amava l’avventura e la lotta. E non vi è dubbio che egli le amasse immensamente: si deve a lui la fortificazione della Guadalupa contro gli inglesi e assistiamo alla sua indignazione quando il luogotenente generale francese, che doveva dirigere le operazioni militari, si mostra poco combattivo ed inefficiente (21). Dei dettami della fede sembra essere particolarmente sensibile soltanto al « pudore », di cui si preoccupa spesso nei suoi scritti, per il resto ama la vita, la buona compagnia, la caccia, la buona tavola, il vino, e sa rendere così bene queste gioie, in maniera così sana che, alla fine, nonostante la sua abilità di uomo d’affari e di guerriero più che di missionario, o forse proprio per questo carattere insolito di missionario, non possiamo non lasciarci trascinare da quella simpatia che sembrano provare per lui tutti coloro che gli vivono accanto. Il suo atteggiamento nei confronti della schiavitù e degli schiavi è, come si è detto, completamente diverso da quello del padre Du Tertre. Intanto non prova alcun bisogno di giustificare i coloni e la schiavitù, che appare nella sua opera come un aspetto del tutto normale della vita nelle Antille. Basta leggere le prime righe del capitolo dedicato agli schiavi per averne la conferma: « Il arriva à la Martinique à la fin du mois de Mai un vaisseau chargé de Negres venant de la côte de Juda en Guinée (...). Comme dans l’Assemblée que nous avions tenuë avant l’arrivée du nouveau Superieur general, j’avois été autorisé pour acheter le nombre de Negres que je jugeois à propos, et que je serois en état de payer, je partis sur le champ pour me rendre à la Basseterre afin de conferer avec le Superieur general, sur l’occasion qui se presentoit d’avoir des Esclaves dont nous avions un extrême besoin pour nôtre Habitation et encore pour l’execution du couvent (...) » (22). Poche dissertazioni astratte, poche riflessioni si incontrano nel libro di Labat, ma molti fatti che parlano da soli. Tutto vi appare ordinato, tutto molto normale. Gli avvenimenti e le situazioni che potrebbero gettare ombra sono liquidati in fretta, senza dar loro il tempo di lasciare sedimenti o di far nascere problemi. Ad un certo punto, se proprio non ci si mantiene molto vigili, non ci si accorge neanche più che certi fatti sono mostruosi e che tanta freddezza e levigata assenza di problemi potrebbe persino essere « amoralità ». Ad esempio, parlando dei modi in cui gli Europei si riforniscono di negri sulle 17 coste africane, egli fa anche riferimento alle guerre fra tribù, riconoscendo con la massima freddezza che, nella maggior parte dei casi, esse sono appunto fomentate allo scopo di procurarsi schiavi da vendere ai mercanti bianchi (23). Non è neppure troppo severo con coloro che riescono a procurarsi schiavi per mezzo di furti, e del resto in questo caso la condanna è indipendente dall’« oggetto » rubato, e sarebbe la stessa se invece di uomini si trattasse di mele. Un’ulteriore dimostrazione che per lui la schiavitù coloniale non costituisce un problema, la riscontriamo nel modo in cui la sua opera si fa eco dei dubbi sorti fra i coloni circa la legittimità di servirsi di schiavi la cui provenienza sia dubbia, di schiavi, in una parola, che siano stati rubati. Come si sa i coloni, che non dovevano sentirsi con la coscienza in pace, sottoposero il loro dubbio ai dottori della Sorbona i quali, per il tramite del teologo Fromageau, risposero, sia pure con sfumature, che non era lecito servirsi di questi schiavi (24). Il verdetto non fu accolto dai coloni ed abbiamo la netta impressione che Labat, pur avendo condannato il furto di schiavi, stia dalla parte dei padroni e che ritenga inutile liberare il negro rubato una volta che sia giunto sulle colonie. Lui stesso ci parla di uno schiavo della missione che si trovava in queste condizioni, senza porsi certo il problema se fosse lecito o meno tenerlo. Dopo averci riportato la reazione dei coloni in termini che svelano anche in parte la sua posizione, egli passa poi tranquillamente a parlare del prezzo degli schiavi sulle coste africane! Questo atteggiamento dei coloni e dei missionari ci sembra la definitiva liquidazione degli ultimi scrupoli: ormai, di mano in mano che i profitti aumenteranno, diminuiranno le possibili esitazioni. C’è però in questo missionario che si muove male, o rifiuta di muoversi, sul piano delle astrazioni e dei princìpi, una tal carica di simpatia umana che gli permette di sorprendere, con una felicità forse unica nel panorama delle relazioni dei missionari e dei viaggiatori, uno squarcio della vita degli schiavi non solo assai vivo e quasi per nulla umiliante, ma persino, saremmo tentati di dire, « avvincente ». E per avvincente non intendiamo abbellito in forma mistificatoria per gabbare il lettore europeo e orientarlo verso un’interpretazione voluta di una realtà con la quale non può avere contatti diretti, ma avvincente perché è un mondo ricreato dalla simpatia di un uomo che sa cogliere la bassezza, talvolta, ma più spesso la grandezza, l’abilità, l’arguzia, l’intelligenza e la bontà di coloro che gli stanno accanto, anche se si tratta di negri schiavi. Ai suoi occhi infatti essi non cessano di essere uomini a causa della loro condizione subordinata. Certo, suggerisce di trattarli bene più per interesse che per dovere umanitario o carità cristiana (25), raramente è mosso a pietà dalla loro sofferenza, ma la pietà può 18 essere un sentimento ambiguo e persino umiliante e, del resto, Labat non dimostra di provarne neppure per quei bianchi che sembrerebbero trovarsi in condizioni di suscitarla. In un mondo dove la lotta per la vita è durissima, la pietà gli sembra forse un lusso inutile. È invece capace di dare virilmente, da uomo a uomo, senza affettazione o condiscendenza, la sua ammirazione ad un gesto di coraggio o ad un comportamento che egli giudica eroico. Cita infatti parecchie imprese degne di encomio compiute da schiavi armati in difesa delle colonie francesi contro gli attacchi dell’Inghilterra, in particolare alla Guadalupa nel 1703, «où l’on peut dire qu’ils détruisirent plus d’ennemis que tout le reste de nos Troupes» (Ib., p. 62). In questa occasione Labat non esita ad umiliare pubblicamente, davanti al governatore dell’isola, un soldato francese che voleva farsi grande con le armi strappate da uno schiavo ad un ufficiale inglese, facendogli notare che se le voleva non aveva che da guadagnarsele, proprio come aveva fatto lo schiavo (26). È un bel gesto che ci dimostra come, nonostante le storture derivategli da una società che legittimava lo sfruttamento di un gruppo etnico, anche attraverso la denigrazione sistematica, egli sapesse rispettare e far rispettare quegli uomini che riteneva meritevoli (evidentemente secondo un suo codice che può essere discutibile), indipendentemente dal loro colore e dalla loro condizione. Questo non gli impedisce, come già si è detto, di accettare tranquillamente non soltanto la schiavitù, ma anche le pene corporali che essa comporta in caso di trasgressione delle regole. Eppure molte altre pennellate che compongono il quadro da lui tracciato sulla vita ed il carattere dei negri nelle colonie americane sono nate da una simpatia non annullata dalla violenza che egli stesso, come europeo e possessore di schiavi, opera nei loro confronti. L’uso degli schiavi non lo spinge, insomma, alla denigrazione. Forse proprio perché non ha dubbi o rimorsi può guardare con obiettività gli uomini di cui si serve da padrone assoluto. Li definisce intelligenti, eloquenti, fieri, generosi, fraterni e solidali fra loro fino alla morte, coraggiosi di fronte al pericolo e capaci di sopportare in silenzio le più atroci sofferenze. Riconosce persino in loro, d’accordo su questo punto con quanto aveva già detto il padre Du Tertre, degli oculati uomini d’affari: « ...ces Negres entendent assez bien leurs interêts et (...) ils ont plus d’esprit, et plus de bon sens, que nous ne nous l’imaginons » (Ib., p. 41). 19 Il valore di questo riconoscimento acquista tutto il suo peso se si pensa ai giudizi degli schiavisti, che tendevano a presentare i negri come incapaci di organizzare minimamente la loro vita e, quindi, di badare a se stessi. Labat ci presenta inoltre la società servile non come una massa omogenea, unificata nell’annullamento, ma come un insieme suddiviso in ranghi, come qualsiasi altro gruppo sociale, con distinzioni e priorità al cui rispetto si bada molto: « J’ai souvent pris plaisir à voir un Negre Charpentier de nôtre maison de la Guadeloupe lorsqu’il dînoit. Sa femme et ses enfans étoient autour de lui, et le servoient avec autant de respect que les domestiques les mieux instruits servent leur Maître; et si c’étoit un jour de Fête ou de Dimanche, ses gendres et ses filles ne manquoient pas de s’y trouver, et de lui apporter quelques petits presens. Ils faisoient un cercle autour de lui, et l’entretenoient pendant qu’il mangeoit. Lorsqu’il avoit fini, on lui apportoit sa pipe, et pour lors il leur disoit gravement allez manger vous autres. Ils lui faisoient la reverence, et passoient dans une autre chambre, où ils alloient manger tous ensemble avec leur mere » (Ib., p. 54). Leggendo questa colorita scenetta di « vita patriarcale », chi penserebbe di avere davanti quello stesso negro incatenato e gettato in una stiva nauseabonda che ci è capitato più volte di incontrare nelle relazioni di viaggiatori o negrieri europei? Fatte le debite differenze, pensiamo piuttosto alla corte del re Sole! Labat giudica il comportamento del suo carpentiere molto più saggio di quello di tanti uomini bianchi che non sanno incutere alcun senso di rispetto nelle loro mogli. Si può dunque concludere che i negri visti da Labat sono vivi, desiderosi di migliorare la loro condizione salendo quei gradini che esistono anche all’interno della « società » servile. In una parola, desiderosi di riscattarsi dall’umiliazione imposta dall’uomo bianco, con tutti i mezzi a loro disposizione. Si tratta di mutamenti minimi, nell’ambito di una condizione che resta misera per tutti, ma non per questo meno ambiti e perseguiti con minor zelo. In questa prospettiva gli schiavi negri non sono visti come una massa che si adagia, ma come uomini che cercano ogni giorno il loro riscatto, magari anche solo sul piano dell’amor proprio. A questo proposito Labat racconta che il suo giovane schiavo negro era sempre felicissimo quando poteva annunciargli che c’era alla porta un povero mendicante bianco, insistendo con grande piacere sull’aggettivo povero: 20 « Quand je lui avois donné ce que je voulois envoyer au pauvre, il ne manquoit pas de lui dire, en le lui présentant, tenez, pauvre Blanc. Voilà ce que mon Maître vous envoie: et lorsqu’il croyoit que je le pouvois entendre, il le rappelloit pour lui donner quelque chose du sien, afin d’avoir le plaisir de l’appeller encore pauvre Blanc. Il croyoit après cela s’être vengé de tout ce que je lui avois dit, ou fait de mortifiant » (Ib., p. 59). Ed è davvero un po’ vendicato, soprattutto se si tiene conto del fatto che Labat parla delle mortificazioni che gli ha imposte, con i fatti e con le parole, come se fosse la cosa più ovvia di questo mondo, senza provarne il minimo senso di colpa. Bisogna però riconoscergli il dono di evocare con simpatia e vivezza i vari momenti della vita dello schiavo, anche se non c’è mai reale volontà di partecipazione e di comprensione dei suoi problemi. Il comportamento del negretto nei confronti del mendicante bianco, sarebbe infatti per Labat, in ultima analisi, dettato da una grande vanità, alla cui spinta riconduce anche un altro episodio, forse ancora più gustoso del precedente. Quando Labat non era contento del lavoro dei suoi schiavi, era solito dir loro che al tempo in cui anch’egli era nero e schiavo aveva servito bene il suo padrone, ragion per cui era diventato bianco. Il colore bianco era così presentato come il risultato di una « promozione ». Un bel giorno uno dei suoi schiavi gli rese abilmente la pariglia. Dopo che il padre Labat lo aveva aiutato a risolvere le difficoltà di un incastro a coda di rondine, egli trovò una formula di apprezzamento abilissima, che ribalta il rapporto tra i colori stabilito dal domenicano, a vantaggio dei negri: « Je n’avois jamais voulu croire que vous eussiez été Negre (…) mais après cet ouvrage j’en suis persuadé: car il n’y a point de Blanc qui eût assez d’esprit pour le faire » (Ib., pp. 59-60) (27). Un’altra forma di rivincita per gli schiavi, sempre stando al testo di Labat, consiste nel considerare i bianchi come la pietra di paragone di tutti i peggiori difetti: « C’est la coûtume de tous les Negres de donner aux Blancs toutes les mauvaises qualitez qui peuvent rendre une personne méprisable, et de dire, que c’est leur fréquentation, et leurs mauvais exemples qui les gâtent. De sorte que s’ils voyent quelqu’un d’entr’eux, qui jure, qui s’enyvre, ou qui fasse quelque mauvaise 21 action, ils ne manquent pas de dire de lui, avec mépris: c’est un miserable, qui jure comme un Blanc, qui s’enyvre comme un Blanc, qui est voleur comme un Blanc, etc. » (Ib., p. 60). Labat ha saputo davvero fissare sulla carta tutto un mondo colorito e vivo, tanto che oggi, a distanza di secoli, ci sentiamo pienamente coinvolti. I suoi schiavi non suscitano pietà, non accettano passivamente la vita che viene loro imposta, non sono animali da lavoro, ma uomini vivi, che si riscattano come possono dalla loro condizione, con orgoglio, con arguzia, con violenza, con coraggio e disprezzo della morte. Certo, sono anche pieni di difetti, come tutti gli uomini: non hanno pudore, sono vanitosi e superbi, spesso anche ladri, ma amano la vita, i colori, la danza: la schiavitù non li ha annientati. Sono uomini forti. E sono anche belli. Nel suo culto della forza e dell’azione, quindi della salute e del vigore fisico, questo uomo vigoroso, che è uscito illeso da malattie micidiali, ha saputo esaltare, con semplicità, la bellezza dei negri: « J’en ai vû des deux sexes faits à peindre, et beaux par merveille. Ils ont la peau extrêmement fine, le velours n’est pas plus doux » (Ib., p. 61). Tutto questo ha però anche un rovescio. Poiché la schiavitù ha perso quasi completamente i suoi connotati ripugnanti, il testo di Labat potrebbe allora trasformarsi nella più efficace delle perorazioni in suo favore, soprattutto per il fatto che i negri vi si sono così bene adattati, senza perdere nulla della loro umanità e della loro voglia di vivere. Quindi potrebbe non avere più senso una lotta condotta per liberarli. Del resto sembra che sappiano cavarsela assai bene da soli, senza bisogno di avvocati che difendano la loro causa: un’interpretazione personale, da parte loro, degli eventi e dei comportamenti dei padroni diventa un mezzo per riscattarsi dalle umiliazioni che impongono loro. Inoltre, se questi sono ingiusti e crudeli i negri si danno alla macchia o si vendicano ricorrendo ai veleni o ai buoni uffici di uno stregone (Labat crede negli stregoni, emissari del demonio). Se invece i padroni sono buoni e giusti, lo schiavo non chiede di meglio che servirli e, se necessario, morire per loro. Questo è indubbiamente l’aspetto negativo dell’opera di Labat, tanto più negativo quanto maggiore è il senso di sicurezza e di pulizia che promana dalla sua 22 presentazione della realtà coloniale. Ma lo si è detto fin dall’inizio che questo aspetto negativo esiste, dal momento che i missionari non hanno mai preso posizione contro la schiavitù e che la loro opera non ha come fine la liberazione dei negri. A noi premeva cogliere in questi testi, al di là dell’ideologia portante, che è di marca schiavista, quegli aspetti che hanno forse potuto, in qualche modo, e magari molto più tardi, agire in favore dello schiavo negro e della sua liberazione. Ne abbiamo rilevati molti anche in un’opera come quella di Labat, che ci aveva in un primo tempo urtati per il freddo calcolo del profitto che è sempre alla base del comportamento da lui adottato nei confronti dei suoi schiavi e dei consigli di cui è prodigo sui modi migliori di dirigere il proprio « gregge » (28). La sua tipologia del negro schiavo riesce però a riscattarlo in parte, tanto più se si pensa che nel corso del ‘700, persino filosofi come Voltaire non saranno immuni dal pregiudizio dell’inferiorità del negro, e non lesineranno accostamenti più o meno espliciti alla scimmia. Allora l’atteggiamento di Labat ci sembrerà, per certi aspetti, straordinario. Per lui il negro è eloquente, intelligente, capace di ironia ed è anche bello e gradevole: ricordiamo che ha paragonato la sua pelle al velluto. Ma anche sotto questo profilo Labat non è immune da contraddizioni: ha infatti tradotto in francese la Istorica descrizione di padre Cavazzi da Montecuccolo, contenente una delle più negative tipologie dell’uomo negro uscite dalla penna di un missionario, il quale non ha saputo vedere intorno a sé che tenebra e assenza di valori, almeno fino all’arrivo dei predicatori bianchi: « Prima che la luce del Santo Vangelo penetrasse a dissipare dalle cieche menti dei Conghesi la vana superstizione de’ falsi Dei, erano quegl’infelici cotanto soggetti alla tirannia del comune Inimico che per tutte quelle Regioni esiggeuano illimitatamente, e senza ostacoli, un nefando, e deplorabile tributo di Anime, e di Corpi... » (29). Labat, sia pure a volte con interventi mitigatori, ha contribuito a far conoscere in Francia un testo di questo tenore. Eppure nel suo Nouveau voyage aux Isles de l’Amérique era riuscito, riportando il dialogo tra un missionario ed un sacerdote (o stregone) negro, a trasmetterci una spiegazione convincente e persino « nobilitante » di uno dei culti africani più difficili da capire per un Europeo, e per molti decisamente rivoltante, come il culto del dio-serpente: «... le Createur connaissant parfaitement les dispositions des Creatures sorties de ses mains, sçavoit trop bien quelle étoit la vanité et la superbe de l’homme, 23 pour ne pas prendre tous les moyens les plus propres pour l’humilier; qu’il n’en paroissoit point de plus efficace, que de l’obliger de ramper devant un serpent, qui est le plus méprisable, et le plus méchant de tous les animaux. Que si ce premier Estre eût choisi un homme pour être le dépositaire de ses secrets, et pour faire entendre ses volontez aux autres hommes; cet homme auroit bien-tôt oublié la bassesse de son extraction, il auroit peut-être voulu aller de paire avec son souverain, ou tout au moins se mettre au dessus de tous les autres hommes (...) l’homme, n’apprenant les volontez de son Createur, que par la bouche et l’entremise d’une Creature si abjecte, est forcé de reconnoître son néant, et combien il est éloigné de la moindre perfection de celui auquel il auroit la témérité de se comparer s’il ne le tenoit dans un état d’humiliation continuelle » (30). Dopo questa spiegazione forse non ci verrà voglia di darci alla ofiolatria, ma dobbiamo confessare che non ci pare più così assurdo che altri lo facciano o lo abbiano fatto. Il racconto ci sembra possa avere allora un valore simbolico: se si guarda attorno a sé con la volontà di capire senza falsi pregiudizi o idee preconcette, si può veramente comprendere anche l’estrema diversità ed aiutare gli altri a vedere più chiaro. È quanto è riuscito spesso a fare Labat che però, traducendo Cavazzi, ha adottato l’ottica di un uomo il quale guarda invece intorno a sé soltanto per far tabula rasa di tutto, al fine di preparare il terreno alla parola evangelica. L’atteggiamento dei missionari di fronte allo sfruttamento coloniale e alle sue vittime è dunque complesso e contraddittorio. Esso ha certamente contribuito al mantenimento della schiavitù ed al suo consolidamento, ma proprio per la sua complessità e contraddittorietà ha offerto, in un modo o nell’altro, molti spunti al pensiero abolizionista. Del resto bisogna sempre tener presente che all’epoca in cui scrivono Du Tertre e Labat non esistono ancora decise posizioni di condanna della schiavitù, ci sono soltanto delle caute e parziali riserve espresse da giuristi e filosofi che dissertano però in astratto, senza neppure essere coscienti (sembra) che la Francia, e più generalmente l’Europa, hanno degli schiavi. Note 24 (1) Casi di persone rapite o ingaggiate con l’inganno per essere spedite nelle colonie non sono ignoti in Europa, come pure ingaggi volontari con alienazione della propria libertà per un certo periodo, fino ad estinzione del debito contratto per pagare il viaggio e l’equipaggiamento (Cfr. il nostro Mon frère, tu es mon esclave! Teorie schiaviste e dibattiti antropologico-razziali nel Settecento francese, Pisa, 1973, pp. 108-109). In genere l’impegno assunto dagli operai europei prima della partenza era di trentasei mesi, da qui il nome di trente-six-mois con cui venivano indicati in Francia. (2) Si potrà forse obiettare che molti dei grandi avvenimenti storici non hanno avuto caratteristiche diverse e preparazioni più adeguate, ma non è questo il punto. Volevamo soltanto rilevare che anche nel periodo rivoluzionario gli uomini politici hanno accordato scarso interesse al problema della schiavitù. (3) E’ il caso di John Newton, capitano negriero divenuto più tardi pastore protestante, che ha narrato la sua esperienza in una serie di lettere pubblicate anonime a Londra nel 1764: An Authentic Narrative of Some Remarquable and Interesting Particulars in the Life of *** communicated in a Series of Letters to the Rev. Mr Haweis, cfr. D. P. Mannix e M. Cowley, Carico nero. Una storia del commercio degli schiavi in Atlantico (1518-1865), (1962), tr. it. Milano, 1964, pp. 193-202; D. B. Davis, Il problema della schiavitù nella cultura occidentale, (1966), tr. it., Torino, 1971, pp. 439-440. (4) Su questo aspetto dell’opera dei missionari, cfr. il nostro Mon frère, tu es mon esclave!... cit., pp. 33-50, in cui, tra l’altro, gli stessi testi sono letti in chiave schiavista. Sul ruolo svolto dai missionari, in qualità di storici delle vicende coloniali, cfr. G. Chinard, L’Amérique et le rêve exotique dans la littérature française aux XVIIe et XVIIIe siècles, Parigi, 1934, pp. 32-33. (5) Parigi, 1667-1671, 4 tomi in 3 voll. La grafia originale è Histoire générale des Antisles. (6) Parigi, 1722, 6 voll., L’Aia, 1724, 6 voll.; ibidem 2 voll. Le nostre citazioni sono tratte dall’edizione del 1724 in 2 voll. Ricordiamo che del testo esiste una recente traduzione italiana (ridotta e resa di agevole lettura anche per un pubblico non specialistico) di Paola Angioletti Marciano per la casa editrice Le Maschere, Firenze, 1960. (7) Cfr. infra. (8) Parigi, 1654, pp. 475-476. (9) Ibidem, p. 473. (10) « Le domaine que les Maistres ont sur leurs Esclaves est si absolu, et ils en ont une propriété si entiere, que non seulement ils leur appartiennent cōme un bien qu’ils ont acquis par le titre d’achapt: mais qu’ils ont encore le même droit sur les enfans mal-heureux qui naissent de leurs mariages, cōme sur un fruict qui croist dans une terre dont ils sont Seigneurs » (Histoire générale des Antilles, cit., II, p. 504). (11) Il fatto di condannare l’eccessiva severità di certi padroni non significa però che egli non ritenga utili e persino indispensabili le punizioni corporali: « Leur humeur arogante et superbe (degli schiavi), oblige nos habitans de ne laisser passer aucune faute, à cause des consequences dangereuses qui pourroient suivre de l’impunité (...). Sans cette rigueur, il seroit impossible de les conserver; car l’on a veu par mille experiences, que l’impunité les rend insupportables (...) » (Ibidem, p. 529). (12) « Les uns sōt mieux nourris que les autres, mais à dire le vray, ils sōt tous nourris d’une maniere tout à fait pitoyable, de sorte que s’ils n’avoient l’adresse de se pourvoir euxmesmes, il patiroient infiniment » (Ibidem, p. 513; cfr. anche pp. 514 e 516). 25 (13) « Si le travail auquel Dieu engagea le premier homme, est un chastiment de sa rebellion et si la iustice vengeresse y a tellement obligé les mal-heureux enfans de ce Pere coupable, que Iob asseure qu’il ne leur est pas moins naturel, que le vol à l’oyseau: on peut dire que les Negres souffrent la plus rigoureuse peine de cette révolte. On peut aisément juger de la rigueur de leur travail, par la forte passion que nos habitans témoignent pour amasser du bien: car comme ils ne viennent dans les Isles que pour cela, ils tirent de leurs Négres tout le service qu’ils peuvent. C’est pourquoy ils les font travailler non seulement depuis le matin jusqu’au soir: mais encore une grande partie de la nuict (...) » (Ibidem, p. 523). Come risulta dalle parole di Du Tertre, ci troviamo proprio di fronte allo « sfruttamento intensivo » da parte del padrone di un bene che deve rendere il più possibile, nel più breve tempo possibile. (l4) « Ie ne puis finir ce paragraphe sans exhorter les habitans des Antilles, par les belles paroles de saint Ambroise, et de les prier comme ce grand Prelat faisoit les Maistres Chrétiens de son tēps, de traiter leurs esclaves avec charité, parce qu’encor bien que la fortune les ayt rendus leurs serviteurs, ces pauvres miserables ne laissent pas d’estre leurs freres par la grace du Baptesme, qui les a fait enfans de Dieu » (Ibidem, p. 534). (15) Mentre Du Tertre non sembra mettere in discussione le appropriazioni « legittime » di schiavi, includendo fra queste anche l’acquisto, è severissimo nei confronti di quei mercanti che non si fanno scrupolo di ricorrere al furto per completare il loro carico, servendosi, se è necessario, dei più vili inganni: « ...on m’a dit qu’un certain Capitaine en ayât attiré plusieurs (di negri) dans son vaisseau à force de boisson et de presens, pendant que ces pauvres gens ne songeoient qu’à se bien divertir; le Pilote ayant levé l’ancre, si-tost que le Navire fut sous voile, on les saisit, et chargea de chaisnes, et qu’ils furent amenés aux Isles, où ils furent vendus en qualité d’esclaves » (Ibidem, p. 494, cfr. anche p. 495). (16) Su questo aspetto del problema cfr. il nostro Mon frère..., cit., cap. I. (17) Cfr. anche L’Histoire naturelle et morale des Iles Antilles, del ministro protestante Rochefort, pubblicata a Rotterdam, anonima, nel 1658. Abbiamo letto il testo nell’edizione di Lione del 1667, in 2 voll.: « Si ces pauvres esclaves tombent entre les mains d’un bon Maître, qui ne les traite pas avec une trop grande rigueur, ils preferent leur servitude à leur premiere liberté : et s’ils sont mariez, ils multiplient à merveille dans les païs chauds » (II, p. 136). L’opera di Rochefort è stata spesso considerata un’imitazione di quella di Du Tertre. (18) Il gesuita padre Charlevoix non sembra essere del tutto d’accordo con Du Tertre per quanto concerne il « cosmopolitismo » degli schiavi. Dopo aver espresso la sua preferenza per l’uso di engagés bianchi, i famosi trente-six-mois, destinati ad essere liberi una volta spirato il termine del contratto, egli conclude: « Peut-on compter sur des esclaves, qui ne nous sont attachés que par la crainte, et pour qui la Terre même où ils naissent, n’a jamais le doux nom de Patrie? » (Histoire et Description générale de la Nouvelle France, Parigi, 1744, 5 voll., III, p. 415). (19) Cfr. anche p. 494: « Ie ne sçay ce que cette nation a fait; mais c’est assez que d’estre noir, pour estre pris, vendu, et engagé à une servitude facheuse qui dure toute la vie ». (20) Il ritratto che precede l’edizione parigina del 1742 del Nouveau voyage corrisponde in pieno all’immagine che ci si fa di lui attraverso la sua opera: un grosso faccione da monaco gaudente, con un naso enorme e bitorzoluto. Chinard (op. cit., p. 252) è più propenso a vedere in lui l’anima di un soldato che quella di un missionario: « Ce brave missionaire a l’âme et le cœur d’un troupier français. Labat ne recule ni devant l’anecdote gaillarde, ni devant le mot cru. On oublierait tout à fait qu’il est prêtre, comme lui-même semble le faire 26 très souvent, si l’on ne trouvait parfois des notations très simples et très sincères qui nous montrent que ce joyeux compère, cette sorte de curé de Meudon colonial était un chrétien convaincu, ne s’embarrassant guère de subtilités théologiques et croyant de la foi simple du charbonnier». (21) L’attacco degli Inglesi a cui fa riferimento Labat è del 1703. (22) Labat, Nouveau voyage..., ed. cit., tomo II, parte IV, cap. 7°, p. 37. (23) « Les seconds sont des prisonniers de guerre, qu’ils font sur leurs voisins, avec lesquels ils sont dans une guerre continuelle, qui n’a point d’autre but que ces pillages ou enlevemens de personnes, qu’ils font par surprise, sans en venir presque jamais à une guerre ouverte... » (Ibidem, p. 39). (24) Per una trattazione più approfondita dell’argomento cfr. il nostro Mon frère..., cit., pp. 38-41. (25) O almeno, una ragione non esclude l’altra. Parlando di quei coloni che fanno subito lavorare gli schiavi comperati, senza lasciarli « acclimatare», egli afferma: « C’est n’avoir point du tout de charité, ni de discretion, et n’entendre rien en ses propres interests, que d’en agir en cette maniere. Ces pauvres gens sont fatigués d’un long voyage (...). Ils sont extenuez de la faim et de la soif, qui ne manquent jamais de les faire souffrir beaucoup pendant la traversée, sans compter le déplaisir où ils sont d’être éloignez de leur Pais, sans esperance d’y retourner jamais » (Ibidem, p. 48). Sembra veramente sensibile ai mali degli schiavi, ma non dimentica il suo interesse di padrone. Si potrebbero citare infiniti esempi di questo tenore dal testo di Labat. (26) Ad onor del vero bisogna ricordare che lo schiavo era suo e che quindi potrebbe non essere del tutto assente dal suo comportamento un tipo deteriore di orgoglio, come quello del possessore di cavalli o di cani di razza. (27) Il testo di Labat è ricco di questi aneddoti spiritosi. Fra gli altri uno ci sembra particolarmente riuscito: un giorno Labat fu avvertito che sette o otto negretti (maschi e femmine) « faisoient des actions qui passoient leur âge ». Li colse sul fatto e ordinò alla cuoca di frustarli. Nel frattempo sopraggiunse un vecchio negro che, conosciuta la ragione della punizione, chiese al domenicano se il giovane che aveva mandato come apprendista da un bottaio gli aveva già portato del lavoro. Labat rispose naturalmente che era troppo presto, non avendo il giovane ancora imparato il mestiere e allora il vecchio negro gli fece notare che si stava comportando stupidamente con i negretti : « ...tu les marieras, et tu vouldras qu’ils te fassent des hiches, c’est-à-dire, des enfans, tout aussi-tôt, et comment veux-tu qu’ils les fassent, s’ils n’ont pas appris tout doucement quand ils étoient jeunes » (Ibidem, pp. 56-57). (28) Chinard, che apprezza in Labat le doti di « coloriste et de dessinateur », è molto severo nel giudicare il suo atteggiamento nei confronti degli schiavi: « ...il ne regarde ses nègres que comme de gracieux animaux, tout au plus; pour eux il n’a ni sympathie, ni admiration. Sa bienveillance est une bienveillance de propriétaire; il les traite comme des bêtes assez difficiles à conduire qui coûtent cher et qu’on est forcé de ménager si l’on veut en retirer du profit » (op. cit., p. 266). Sulla base del saggio di L. Hearn (Two years in the French West Indies), Chinard riporta un fatto abbastanza curioso concernente il padre domenicano: sembra infatti che i negri della Martinica lo « evochino » ancora come spauracchio, giudicandolo un crudele bourreau, destinato ad errare di notte nelle montagne dell’isola per espiare le sue colpe. Sembra anche che le madri tengano a freno i loro bambini con la minaccia : « Je vais appeler le Pé Labat », divenuto dunque una specie di « lupo » martinicano. 27 (29) Giovanni Antonio Cavazzi, Istorica descrizione de’ trè regni Congo, Matamba, et Angola situati nell’Etiopia inferiore occidentale e delle Missioni apostoliche esercitateui da Religiosi Capuccini, Bologna, 1687, Libro I, p. 69. La traduzione, come ben indica il titolo, è libera e il testo francese è arricchito da notizie sia pur parcamente attinte ad altre fonti: Relation historique de l’Ethiopie occidentale: contenant la Description des Royaumes de Congo, Angolle, et Matamba, traduite de l’Italien du P. Cavazzi, et augmentée de plusieurs relations portugaises des meilleurs auteurs, avec des notes, des cartes géographiques, et un grand nombre de figures en taille-douce, Parigi, 1732, 5 voll. (30) Labat, op. cit., II, p. 42. 28 CRITICA DEI «CONQUISTADORES » Alla nascita ed al progresso di una coscienza abolizionista ha contribuito in maniera determinante, anche se indiretta, un ripensamento critico, talvolta anche molto severo, della scoperta del Nuovo Mondo e dell’uso che gli Europei hanno fatto di questa scoperta. Il dibattito sulla legittimità dell’operazione portata avanti dagli Spagnoli in America, operazione che ha comportato la decimazione degli aborigeni, non inizia con il secolo dei Lumi, ma nasce con la conquista e l’accompagna nel tempo. Basti ricordare, nel Cinquecento, la lunga disputa tra Bartolomeo de Las Casas, il « padre degli Indiani », propugnatore di una colonizzazione pacifica, e Juan Ginés Sepúlveda, sostenitore, al contrario, del diritto, o meglio, del dovere cristiano di diffondere la fede con tutti i mezzi, ivi compresa la guerra santa (1). La disputa ebbe il suo momento cruciale nel convegno di Valladolid del 1550-51, che riuniva una commissione di teologi con il compito di esaminare le posizioni dei due contendenti. La commissione esitò a lungo prima di esprimere un giudizio che risultò poi, sia pure in maniera non del tutto chiara, favorevole alle tesi di Las Casas. Ma questo risultato non ebbe alcun effetto nella pratica e non cambiò il comportamento degli Spagnoli in America: l’asservimento di popoli e la distruzione di ambienti naturali continuarono senza ostacoli. Ed anche Las Casas continuò inutilmente, almeno sul piano dei risultati pratici, la lotta fino alla fine dei suoi giorni, sorretto da una fede incrollabile nella bontà della sua azione e da un grande amore per un popolo di « innocenti » che si andava estinguendo sotto i suoi occhi. È dunque evidente che la cattiva coscienza nei confronti della conquista americana si è insinuata negli animi dei conquistatori stessi, o almeno di una parte di essi, fin dai suoi inizi, proprio a causa delle numerosissime vittime che ha calpestato ovunque per farsi strada. In quegli stessi anni, anche grandi pensatori e letterati di altre nazioni non implicate nell’impresa mettevano in discussione il fondamento « giuridico » di queste conquiste, il mito della civilizzazione dei popoli barbari e la legittimità di imporre la propria religione ricorrendo all’appoggio delle armi. 29 Fra i critici più autorevoli, ed anche più severi, ricordiamo Montaigne, che mette in dubbio la barbarie degli indigeni americani, almeno se paragonata a quella degli Europei (2). Egli condanna in particolare il prezzo che gli Spagnoli hanno fatto loro pagare, per ottenere frutti di così poco conto: « Combien d’apprentissage il eust esté aisé de faire d’ames si neuves, si affamées d’apprentissage, ayant pour la plus part de si beaux commencemens naturels! Au rebours, nous nous sommes servis de leur ignorance et inexperience à les plier plus facilement vers la trahison, luxure, avarice et vers toute sorte d’inhumanité et de cruauté, à l’exemple et patron de nos mœurs. Qui mit jamais à tel pris le service de la mercadence et de la trafique? Tant de villes rasées, tant de nations exterminées, tant de millions de peuples passés au fil de l’espée, et la plus riche et belle partie du monde bouleversée par la négotiation des perles et du poivre: mechaniques victoires. Jamais l’ambition, jamais les inimitiez publiques ne pousserent les hommes les uns contre les autres à si horribles hostilitez et calamitez si miserables » (3). Oltre all’idea che l’Europa non è stata, nei confronti dei popoli americani e cioè di popoli ritenuti barbari e selvaggi, una maestra di civiltà, ma una micidiale corruttrice, troviamo qui, espresso in forma lucida ed incisiva, il rifiuto di imprese commerciali lordate del sangue di tanti uomini ospitali ed inermi. Anche Ronsard, paragonando l’esistenza degli indigeni americani ad una mitica età dell’oro, mette in risalto il carattere negativo dell’intervento europeo, che ha comportato (nel migliore dei casi) l’introduzione di divieti e regole che avevano già resi infelici gli abitanti del Vecchio Mondo: « Laisse-les, je te pri’, si pitié te remord, Ne les tourmente plus et t’enfuy de leur bord. Las! si tu leur apprens à limiter la terre, Pour agrandir leurs champs ils se feront la guerre, Les procez auront lieu, l’amitié defaudra, Et l’aspre ambition tourmenter les viendra Comme elle fait ici nous autres, pauvres hommes, Qui par trop de raison trop miserables sommes; Ils vivent maintenant en leur âge doré (...). Vivez heureuse gent, sans peine et sans souci, Vivez joyeusement: je voudrois vivre ainsi »(4). 30 Si tratta certamente di un’immagine poetica di maniera, e altrettanto lontana dalla realtà quanto quella denigratoria e cupa che i conquistadores presentavano del Nuovo Mondo nelle loro relazioni o nei loro racconti. Essa denuncia tuttavia, in maniera esplicita, l’assenza di fiducia, da parte di Ronsard, nella missione civilizzatrice dell’Europa. Da qui, il suo invito utopistico a non degradare un mondo che non ha ancora « abusato della ragione ». In ultima analisi, sia Ronsard che Montaigne rifiutano di riconoscere come positivo nei confronti degli indigeni l’intervento degli Europei in America, ridimensionando così, fin dagli inizi dell’impresa, uno dei moventi destinato a crearle una facciata rispettabile, dietro la quale si tentava di nascondere uno dei più colossali etnocidi della storia. La contestazione della conquista americana o quanto meno la sua presentazione sotto angolature non sempre lusinghiere e la conseguente mitizzazione della vita idilliaca che si conduceva sulle altre sponde dell’Atlantico, prima dell’arrivo di Colombo, non sono quindi - è inutile ricordarlo - primizie della revisione critica operata dai pensatori dell’epoca dei Lumi, ma è bensì vero che proprio in quest’epoca la contestazione ha trovato un terreno più fertile ed un pubblico meglio preparato a recepirla. La rimessa in discussione delle imprese europee in America (e negli altri continenti) pone le basi di una critica più consapevole e documentata dei sistemi su cui si fonda il profitto coloniale. Del resto, il rifiuto della violenza come strumento di colonizzazione e di evangelizzazione, anche se concerne in maniera specifica i popoli d’America, ha ovviamente una portata più generale e coinvolge tutto il comportamento europeo, perché è il rifiuto di un modo di essere, di pensare e di concepire la propria funzione all’interno del processo storico. L’Alzire, ou les Américains (1736) di Voltaire sintetizza bene almeno alcuni aspetti di questo orientamento che ottiene in Francia (e non solo in Francia), nel corso del secolo, consensi sempre più vasti: è la tragedia della sopraffazione materiale e morale che ha accompagnato il cammino degli Spagnoli in America, sotto l’egida di princìpi religiosi che non soltanto hanno giustificato le peggiori atrocità, ma le hanno persino alimentate. Forse l’argomento scelto da Voltaire (la conquista del Perù da parte degli Spagnoli) non è che un pretesto per attaccare la Chiesa e le storture prodotte da un’errata interpretazione dei doveri del cristiano, come sembra abilmente indicare il Discours préliminaire (5), ma la condanna della conquista non risulta per questo meno efficace. Il dialogo di apertura tra il vecchio Alvarez ed il figlio Gusman che prende, 31 dopo di lui, in mano le redini del Perù, pone di fronte due modi di concepire le imprese coloniali. Gusman vuole che il popolo vinto impari il rispetto per il vincitore bianco, e per giungere a questo scopo non conosce che una legge, quella del terrore: « Empêchons, croyez-moi, que ce peuple orgueilleux Au fer qui l’a dompté n’accoutume ses yeux, (…) Il faut toujours qu’il tremble, et n’apprenne à nous voir Qu’armés de la vengeance ainsi que du pouvoir ». (I, 1) (6). Egli è convinto che gli Incas siano dei bruti incapaci di distinguere clemenza e debolezza e, soprattutto, che sia dovere dei conquistatori distruggere l’idolatria con tutti i mezzi per imporre la religione cattolica. Ed infatti l’accettazione della religione dei vincitori viene offerta, da Gusman agli Incas prigionieri, in cambio della vita. È un vero e proprio ricatto morale: « .......... quitter l’idolâtrie Est un titre en ces lieux pour mériter la vie: (…) Je veux que ces mortels, esclaves de ma loi, Tremblent sous un seul Dieu, comme sous un seul roi » (I, 1). A questa concezione dei doveri del conquistatore cattolico, si oppone quella del vecchio Alvarez che ha assistito con dolore alla distruzione di un popolo, perpetrata anche in nome di una religione di cui sono stati travisati i precetti (7). È un doloroso riconoscimento degli errori commessi, anche sotto la spinta di un’avidità insaziabile: «Ah! Dieu nous envoyait quand de nous il fit choix, Pour annoncer son nom, pour faire aimer ses lois: Et nous, de ces climats destructeurs implacables, Nous, et d’or et de sang toujours insatiables, Déserteurs de ces lois qu’il fallait enseigner, Nous égorgeons ce peuple au lieu de le gagner » (I, 1). Ne consegue un confronto fra le parti dal quale lo Spagnolo esce in netto svantaggio, perdendo così la sua aureola di benefattore dell’umanità, di dispensatore 32 di beni spirituali, destinati a migliorare la vita di tanti popoli: « Les Espagnols sont craints, mais ils sont en horreur: Fléaux du nouveau monde, injustes, vains, avares, Nous seuls en ces climats nous sommes les barbares. L’Américain, farouche en sa semplicité, Nous égale en courage et nous passe en bonté » (I, 1). Alvarez tenta di convincere il figlio che nessuna vera conversione si potrà mai ottenere con la forza, perché la legge del dio cristiano è una legge d’amore e non di sopraffazione. Deve perciò essere divulgata con la parola e con l’esempio, non con le armi alla mano. Si tratta di due modi diversi di concepire l’intervento degli Europei in America, senza peraltro mettere in discussione il principio stesso dell’intervento. Quest’ultimo tipo di critica, più radicale, non è tuttavia assente nella tragedia di Voltaire, anche se non è formulato in maniera chiara e decisa. Sono ovviamente i protagonisti indigeni della vicenda che mettono in discussione i diritti accampati dagli invasori Spagnoli. Zamore, pretendente di Alzire, figlia del vecchio re del Perù, si scaglia contro la religione cristiana, per il trionfo della quale gli Spagnoli dicono di combattere, ed Alzire stessa condanna le pretese degli stranieri alla sovranità sul suo popolo: « Tu vois de ces tyrans la fureur despotique; Ils pensent que pour eux le ciel fit l’Amérique, Qu’ils en sont nés les rois ……………» (IV, 3) (8). Sappiamo che l’atteggiamento di Voltaire (e non soltanto di Voltaire) nei confronti della conquista, come di ogni intervento europeo presso i popoli a diverso livello di civiltà, non è sempre lineare, o almeno, la condanna della violenza e dei soprusi non è mai disgiunta in lui da un’inconfessata, ma talvolta anche esplicita, convinzione che colui il quale subisce è, tutto sommato, inferiore a colui che riesce ad imporre la sua legge. Leggiamo infatti nell’Essai sur les mœurs, a proposito delle conquiste europee in America: 33 « L’expérience a encore appris quelle supériorité les Européens ont sur les Américains, qui, aisément vaincus partout n’ont jamais osé tenter une révolution, quoiqu’ils fussent plus de mille contre un... » (9). Ma nell’Alzire, rappresentata a Parigi nel gennaio del 1736, gli indigeni sono presentati come nobili e coraggiosi e gli Spagnoli come dei tiranni brutali (ad eccezione della conclusione edulcorata in cui Gusman, in punto di morte, riconosce i suoi errori), le cui azioni non possono trovare giustificazione in una fede malintesa. E non è di scarso rilievo il fatto che tutto questo sia detto in un’opera di teatro, perché sappiamo che sulla scena le accuse sembrano acquisire maggior forza, grazie alla recitazione ed alla cassa di risonanza costituita dal pubblico, numeroso alla rappresentazione dell’Alzire, che fu tragedia di un certo successo. Alle critiche di Voltaire si possono affiancare quelle di tutti i grandi pensatori del secolo, anche se il loro atteggiamento resta spesso oscillante fra una posizione di netto rifiuto delle conquiste europee e, in senso lato, della colonizzazione, ed una posizione di accettazione più o meno sfumata, in un tentativo di conciliare gli opposti, vale a dire gli ideali, da un lato, e gli interessi materiali dell’Europa dall’altro. A questa oscillazione se ne affianca, nei philosophes, una analoga riguardante il « selvaggio », presentato spesso come il polo ideale dell’uomo civile, ma più in funzione di una critica alla civiltà europea che dietro la spinta di una reale convinzione della sua positività. Per questo, nei passi o negli scritti di carattere ideologico l’indigeno americano viene posto su di un piedistallo, che gli stessi autori, od altri, distruggono quando si tratta di affrontare la stessa realtà in chiave storica. Il fenomeno è dunque complesso e non è questa la sede per affrontarlo, anche perché è troppo generale e resta, tutto sommato, ai margini della nostra indagine, senza contare che esistono già pregevoli lavori specifici sull’argomento. A noi interessa, servendoci di alcune voci autorevoli, scelte senza alcuna pretesa di esaustività, ricreare un clima, porre l’accento su atteggiamenti ed orientamenti ideologici che hanno favorito l’affermarsi del pensiero abolizionista e possono quindi aiutarci a seguirne le tappe. Fra i pensatori che hanno contribuito a rimettere in discussione le conquiste europee, un posto di rilievo spetta a Montesquieu che, fin dalle Lettres persanes, aveva espresso un giudizio severo sull’operato degli Spagnoli in America, o meglio, aveva giudicato severamente ogni tipo di colonizzazione, privilegiando, fra gli esempi negativi, quello degli Spagnoli in America (10). Questo giudizio negativo 34 espresso su ogni forma di colonizzazione, sembra mitigare la condanna dei conquistadores, poiché il loro comportamento riprovevole non sarebbe altro che il risultato inevitabile di un’impresa sbagliata in partenza, e, proprio per questo, realizzabile soltanto in negativo (11). Ma l’attenuazione è soltanto apparente, perché l’esempio spagnolo è scelto per appoggiare la condanna della colonizzazione su un fatto di un’evidenza incontrovertibile: « Les Espagnols, désespérant de retenir les nations vaincues dans la fidélité, prirent le parti de les exterminer et d’y envoyer d’Espagne des peuples fidèles. Jamais dessein horrible ne fut plus ponctuellement exécuté. On vit un peuple aussi nombreux que tous ceux de l’Europe ensemble disparaître de la Terre à l’arrivée de ces barbares, qui semblèrent, en découvrant les Indes, n’avoir pensé qu’à découvrir aux hommes quel était le dernier période de la cruauté (...). Juge par là combien les conquêtes sont funestes, puisque les effets en sont tels: car enfin, ce remède affreux était unique » (12). È un testo degno di nota, anche perché in seguito Montesquíeu ridimensionerà questa posizione « anticolonialista », introducendo delle distinzioni: condannerà infatti gli eccessi e gli errori della conquista, piuttosto che la conquista stessa (13). Così, mentre nelle Lettres persanes aveva giudicato negativamente l’operato degli Spagnoli, convinto comunque che una volta invischiati nell’impresa non avrebbero potuto agire diversamente, nell’Esprít des lois ribadisce la sua critica, rendendoli però totalmente responsabili degli errori commessi. Ammette, in sostanza, che la conquista avrebbe potuto compiersi con risultati positivi, sia per i conquistatori che per i vinti, come leggiamo nel passo che segue, vivacizzato da un sottile gioco di antitesi: « Quel bien les Espagnols ne pouvaient-ils pas faire aux mexicains? Ils avaient à leur donner une religion douce; ils leur apportèrent une superstition furieuse. Ils auraient pu rendre libres les esclaves; et ils rendirent esclaves les hommes libres. Ils pouvaient les éclairer sur les abus des sacrifices humains; au lieu de cela ils les exterminèrent. Je n’aurais jamais fini si je voulais raconter tous les biens qu’ils ne firent pas, et tous les maux qu’ils firent » (X, 4) (14). Ma sia che si tratti di una condanna globale della colonizzazione che di una condanna specifica di quella spagnola, Montesquieu stigmatizza, in ogni caso, la violenza e lo sfruttamento di cui sono fatti oggetto gli indigeni, cosicché la critica alla conquista americana finisce col trasformarsi in una requisitoria violenta contro ogni 35 forma di sfruttamento dei popoli, ed in particolare dei popoli non europei. Il legame tra condanna delle imprese spagnole in America e condanna della schiavitù negra è dunque molto stretto e non vi è dubbio che nascano entrambe da uno stesso orientamento ideologico (15). Su di un tono che ci ricorda per molti aspetti (pur essendo assai più crudo) il Ronsard del Discours contre fortune, anche Diderot, nel Supplément au voyage de Bougainville (1772, ma pubblicato nel 1796), fa dire ad un vecchio tahitiano tutto il suo orrore per l’intrusione distruttiva degli Europei: « ‘Pleurez, malheureux Taïtiens! pleurez; mais que ce soit de l’arrivée, et non du départ de ces hommes ambitieux et méchants: un jour, vous les connaîtrez mieux. Un jour ils reviendront, le morceau de bois que vous voyez attaché à la ceinture de celui-ci, dans une main, et le fer qui pend a côté de celuilà, dans l’autre, vous enchaîner, vous égorger, ou vous assujettir à leurs extravagances et à leurs vices; un jour vous servirez sous eux, aussi corrompus, aussi vils, aussi malheureux qu’eux (...)’. Puis s’adressant à Bougainville, il ajouta: Et toi, chef des brigands qui t’obéissent, écarte promptement ton vaisseau de notre rive: nous sommes innocents, nous sommes heureux; et tu ne peux que nuire à notre bonheur » (16). Idealizzazione, certo, ma priva di ogni ingenuità e lucidamente elaborata per porre sul banco degli imputati gli Europei ed il loro metodo di approccio agli altri popoli (17). Concludiamo questo rapido excursus sulle polemiche settecentesche intorno alle conquiste spagnole in America, realizzato con scelte e tagli di cui conosciamo i limiti (18), con un testo che ci sembra particolarmente significativo: Les Incas (1777) di Marmontel. In esso la critica del comportamento spagnolo diventa tagliente invettiva contro la mentalità schiavista europea, che non ha esitato a strumentalizzare persino la religione ai suoi fini (19). L’intento dell’opera è chiaro fin dall’epigrafe: « Accordez à tous la tolérance civile, non en approuvant tout comme indifférent, mais en souffrant avec patience tout ce que Dieu souffre, et en tâchant de ramener les hommes par une douce persuasion » [Fénélon (sic), Direction pour la conscience d’un roi]. Il comportamento di tutti i Sovrani europei nei confronti degli abitanti del 36 Nuovo Mondo è stato colpevole, a giudizio di Marmontel, ma più di tutti gli altri, lo è stato il comportamento del papa che ha « generosamente » concesso terre sulle quali non aveva alcun diritto (20), alimentando un fanatismo religioso che è stato il responsabile delle maggiori atrocità commesse dai « combattenti per la fede » (21). A questo fanatismo si sono aggiunti un’avidità senza limiti ed un desiderio sfrenato di ottenere tutto in fretta, senza dare nulla in cambio e senza fare alcuna fatica: « Fainéans et avares, ils voulurent avoir, dans leur oisiveté superbe, des esclaves et des trésors » (22). Sulla falsariga della relazione di Las Casas (23), Marmontel evoca fatti spaventosi ed atrocità impensabili, come le famose gesta del cane Bezarillo, addestrato per la caccia agli Indiani, e ricorda che in breve tempo gli Spagnoli sono quasi riusciti a spopolare un intero continente. Ed è proprio a Las Casas, personaggio di primo piano nell’opera, che l’autore fa pronunciare un implacabile atto d’accusa contro la schiavitù. Gli Incas possono perciò essere considerati come uno dei più notevoli contributi che la critica della conquista americana ha portato alla causa abolizionista; un testo-cerniera che denuncia lo stretto legame tra due tipi di etnocidio, soltanto apparentemente diversi: quello americano e quello africano. Anche se vi si parla di Indiani, e soltanto incidentalmente di negri, si tratta in realtà di una condanna di portata generale e, d’altro canto, i modi in cui è formulata ci spingono a credere che Marmontel avesse presente la situazione coloniale del suo tempo ed intendesse, di fatto, colpire la schiavitù negra: « Juste ciel, l’esclavage, la honte et le scandale de sa religion, est le seul moyen de l’étendre! Ah! c’est lui qui la déshonore, qui la rend odieuse, et qui la détruiroit, si l’enfer pouvoit la détruire. Il fut cruel chez tous les peuples; il est atroce parmi nous. Vous le savez, vous avez vu le fils arraché à son père, la femme à son époux, la mère à ses enfans, vous avez vu jeter dans le fond d’un vaisseau des troupeaux d’hommes enchaînés, y croupir entassés, consumés par la faim; vous avez vu ceux qui sortoient de cet exécrable tombeau, pâles, abattus de foiblesse, aussitôt condamnés aux travaux les plus accablans. Et c’est-là, diton, le seul moyen de gagner les esprits! En a-t-on tenté d’autre? a-t-on daigné les éclairer? (...). On veut qu’ils vivent et qu’ils meurent comme des animaux stupides » (24). 37 L’allusione agli schiavi gettati come gregge sul fondo di navi paragonate ad una tomba, dalla quale escono consunti dalla fame e dalla stanchezza, pur non essendo anacronistica in bocca a Las Casas, in quanto gli Indiani venivano realmente trasportati da un’isola delle Antille all’altra o dal continente nelle isole, ci sembra comunque si attagli meglio alla tratta dei negri. La descrizione fa infatti pensare ad un lungo viaggio, sfibrante e micidiale come era appunto quello delle navi negriere attraverso l’Atlantico. Inoltre, l’allusione alla nave come ad una tomba è tipica degli scritti di protesta contro la tratta, appunto perché nel corso del lungo viaggio, fatto in condizioni tremende, la nave si trasformava spesso per gli schiavi, ma non soltanto per loro, in luogo di morte. La requisitoria, affidata da Marmontel a Las Casas, continua serrata; nessuna scappatoia è lasciata al possessore di schiavi, perché non può esistere alcuna giustificazione per un atto contro natura. Associarvi la religione è non soltanto inumano, ma blasfemo. La fede cattolica vuole soltanto cuori consenzienti: « Non mes amis, point de milieu: il faut renoncer au nom d’hommes, abjurer le nom de chrétiens, ou nous interdire à jamais le droit de faire des esclaves. Cet avilissement honteux, où le plus fort tient le plus foible, est outrageant pour la nature, révoltant pour l’humanité, mais abominable sur-tout aux yeux de la religion. Mon frère, tu es mon esclave, est une absurdité dans la bouche d’un homme, un parjure et un blasphème dans la bouche d’un chrétien » (Il corsivo è dell’autore) (Ib., p. 144). Marmontel non è tenero con la posizione assunta dalla Chiesa, che ha lasciato il suo vessillo confondersi con quello dei conquistatori, facendone dei « conquérans pour la foi »; egli stabilisce perciò una netta distinzione fra operato della Chiesa e religione cattolica, che è una religione di amore e di tolleranza. I suoi ministri ne hanno dimenticato i precetti, accentrando la loro attenzione unicamente su quel famigerato compelle intrare (25) che è stato il cavallo di battaglia in molte imprese vessatorie portate avanti sotto la spinta (reale o pretestuosa) di ideali religiosi. Dalla critica alle conquiste spagnole nel Nuovo Mondo, si arriva dunque, inevitabilmente, ad una critica di più vasta portata contro ogni forma di violenza e di sfruttamento, soprattutto nei confronti di popoli meno evoluti e quindi meno preparati a cogliere il pericolo dietro la mano che si tende per offrire doni o scambiare merci lucide e colorate come splendidi giocattoli. La condanna delle gesta spagnole in America è dunque una pietra miliare sulla strada che porta alla lotta per l’abolizione della schiavitù negra: era perciò 38 indispensabile farvi riferimento, sia pure per sommi capi, anche nel tentativo di ricreare nella sua complessità l’atmosfera all’interno della quale si sono formati ed hanno cominciato ad operare i pensatori abolizionisti. Si tratta in sostanza dei diversi aspetti di uno stesso atteggiamento di revisione critica del ruolo che l’uomo bianco si è assegnato. Allo spirito di questa revisione si può ricondurre anche l’esaltazione dell’indigeno americano e la fortuna del mito del buon selvaggio, che fanno parte dello sfondo su cui gli abolizionisti cominciano a muoversi. Va subito detto che il negro non è quasi mai avvertito come selvaggio (26). Delle tribù che vivono all’interno dell’Africa si sa ancora ben poco nel Settecento, al punto che si parla seriamente dell’esistenza di amazzoni e di tribù bianche, mentre gli abitanti delle coste, che entrano in contatto con gli Europei, hanno un’organizzazione socio-politica e non vivono certo come selvaggi, anche se il loro grado di civiltà è ad uno stadio diverso da quello del bianco. Questa posizione non li favorisce nella riflessione dei philosophes: hanno perso la purezza di vita del selvaggio e non hanno ancora acquisito i lumi della civiltà. Non sono insomma né carne né pesce e come termine di paragone (perché a tale funzione è in realtà ridotto il selvaggio mitizzato) non servono a nulla. Non è dunque infrequente trovare in una stessa opera l’idealizzazione del selvaggio americano accanto ad un’immagine avvilente del negro (27). Ma nella misura in cui l’interesse per il selvaggio costituisce (sia pure nei limiti indicati) l’elemento di rottura di un eurocentrismo esasperato, esso apre anche le porte della riflessione europea su altri popoli che, per il fatto di trovarsi in condizioni di vita non poi molto dissimili da quelle degli americani, beneficiano dei risultati di un confronto da cui sembravano esclusi. Inoltre, se è vero che in molti casi si tratta di un’apertura soltanto apparente verso il mondo esterno, in quanto essa serve unicamente a reperire strumenti di critica da rivolgere contro la società europea, resta nondimeno vero che ormai nessuna riflessione sull’uomo e sulla società è concepibile senza tener conto di queste forme di vita, così diverse da quelle del Vecchio Mondo. I fini di questa ricerca impegnano i pensatori in uno sforzo di obiettività che può condurre, nel corso del secolo, da un lato ad un ridimensionamento del mito del buon selvaggio come rappresentante di un sistema di vita ideale la cui semplicità sarebbe sinonimo di bonheur, dall’altro ad uno sforzo di conoscenza e di documentazione che segnano l’ingresso nella storia di popoli meno evoluti. E con essi di tutta una serie di problemi strettamente connessi a modi di vita così diversi ed al loro impatto con la vita europea. Il problema dell’asservimento e dello sfruttamento di questi popoli non è certo uno dei minori che si impongono alla riflessione ed alla coscienza degli Europei. 39 Ecco perché la tratta e la schiavitù negra diventano nel corso del secolo una tappa obbligata della riflessione sull’uomo e sulla civiltà. L’interesse per la vita dei selvaggi ha una funzione propedeutica nel ripensamento critico delle imprese dei bianchi nel mondo. Note (1) Su questa disputa e sulla costante volontà dei sovrani spagnoli di vedere chiaro nei modi di portare avanti la conquista cfr. L. Hanke, Colonisation et conscience chrétienne au XVIe siècle, tr. fr., Parigi, 1957; Las Casas et la défense des Indiens, Parigi, 1971, scelta di testi e presentazione a cura di M. Bataillon e A. Saint-Lu. L’opera è corredata di una buona scelta bibliografica. Utili testi di carattere propedeutico sulla scoperta e le conquiste degli Spagnoli in America possono essere considerate le seguenti scelte antologiche di passi tratti da autori coevi e spesso protagonisti della conquista: J. Cassou, La scoperta del Nuovo Mondo, tr. it., Novara, 1966; M. Mahn-Lot, La scoperta dell’America, tr. it., Milano, 1971; R. Romano, I conquistadores: meccanismi di una conquista coloniale, tr. it., Milano, 1974. Sulle testimonianze dei « vinti » cfr. M. Léon-Portilla, Il rovescio della conquista. Testimonianze azteche, maya e inca, tr. it., Milano, 1974. Fondamentale il lavoro di A Gerbi, La natura delle Indie Nove. Da Cristoforo Colombo a Gonzalo Fernández de Oviedo, Milano-Napoli, 1975. (2) Una rimessa a punto del concetto di barbarie era già stata operata da Las Casas nella Apologética Historia (naturalmente non conosciuta da Montaigne, dal momento che la prima edizione parziale è del 1875). In quest’opera, che è la più inesorabile fra quelle scritte dal vescovo di Chiapas per denunciare il comportamento degli Spagnoli in America, Las Casas distingue quattro tipi di barbarie, dimostrando come in certi casi essa non sia altro che sinonimo di diversità: « Così queste genti di queste Indie, come noi le stimavamo barbare, così anch’esse, non comprendendoci, ci tenevano per barbari, vale a dire per stranieri. Da questo è derivato un grande errore in molti di noi, laici, ecclesiastici e religiosi, nei riguardi di queste nostre nazioni indiane : cioè che, essendo esse di lingue diverse che non intendiamo, né conosciamo a fondo, e di costumi differenti, a quelli che dalla nostra nazione vennero a queste terre, di qualsiasi professione o qualità siano, dopo che queste genti hanno perduto le loro organizzazioni politiche, e le regole di vita e di governo che avevano, perché noi li mettemmo in così gran disordine e li abbiamo ridotti di numero in modo tale che sono rimasti completamente annichilati, coloro che li trovano in questo stato pensano che la confusione e la prostrazione in cui vivono ora, esistettero sempre e siano derivate dalla loro natura barbarica e dal disordine politico, sebbene noi con verità possiamo affermare che essi hanno veduto in noi non pochi altri costumi per cui, con piena ragione, possiamo noi essere stimati da loro come barbarissimi: e non tanto come barbari di questa seconda specie che vuol dire 40 strano, bensì della prima, come ferocissimi, durissimi, crudeli e abbominevoli ». Citiamo dall’edizione italiana ridotta, pubblicata con il titolo: La leggenda nera, a cura di A. Pincherle, Milano, 2a ed. 1972, p. 228. (3) Montaigne, Essais, III, 6: Des coches, ed. A. Thibaudet, Parigi, 1946, p. 883. Su questo aspetto dell’opera di Montaigne vedi A. Scaglione, A note on Montaigne’s «Des cannibales» and the humanist tradition, in First images of America. The impact of the new world on the old, a cura di F. Chiappelli, Berkeley-Los Angeles-Londra, 1976, pp. 63-70. (4) Ronsard, Discours contre fortune. A Odet de Colligny, Cardinal de Cahstillon, in Œuvres complètes a cura di G. Cohen, Parigi, 1966, II, pp. 407-408. Sulla posizione di Ronsard e dei poeti del Cinquecento nei confronti del Nuovo Mondo cfr. L’Amérique et les poètes français de la Renaissance. Textes présentés et annotés par R. Le Moine, Ed. dell’Università di Ottawa, 1972. (5) « On a tâché dans cette tragédie, toute d’invention et d’une espèce assez neuve, de faire voir combienn le véritable esprit de la religion l’emporte sur les vertus de la nature. La religion d’un barbare consiste à offrir à ses dieux le sang de ses ennemis. Un chrétien mal instruit n’est souvent guère plus juste. Etre fidèle à quelques pratiques inutiles, et infidèles aux vrais devoirs de l’homme; faire certaines prières, et garder ses vices; jeûner, mais haïr, cabaler, persécuter, voilà sa religion. Celle du chrétien véritable est de regarder tous les hommes comme ses frères (...) ». Voltaire, Alzire, ou les Américains, in Chefsd’œuvre dramatiques, Parigi, 1808, 4 voll., II, p. 79. (6) Alzire, ed. cit., p. 97. (7) Un atteggiamento analogo si ritrova in Helvétius, De l’homme, sezione III, cap. 16° (Causes de la différence des opinions en Morale, Politique et Métaphysique), nelle pagine dedicate alla virtù: « Quelle autre idée pouvoient s’en faire les Espagnols (della virtù), lorsque l’Eglise leur permettoit d’attaquer Montézuma et les Incas, de les dépouiller de leurs richesses et de s’asseoir sur les trônes du Mexique et du Pérou. Les moines, Maîtres alors de l’Espagne, eussent pu la forcer de restituer aux Mexiquains et aux Péruviens leur or, leur liberté, leur Pays et leur Prince: ils pouvoient du moins hautement condamner la conduite des Espagnols. Que firent alors les Théologiens? Ils se turent. Ont-ils en d’autres tems montré plus de justice? Non ». (Citiamo dall’edizione di Londra in 2 voll. Il primo porta la data del 1775, il secondo quella del 1774. La citazione è tratta dal I vol., pp. 194-195). (8) Anche nelle Lettre d’une Péruvienne (1747) di Mme de Graffigny è duramente condannato il comportamento degli Spagnoli, che hanno distrutto « la Città del Sole » e resi schiavi i suoi abitanti. (9) Voltaire, Essai sur les mœurs, cap. CXLV, ed. a cura di R. Pomeau, Parigi, 1963, 2 voll., II, p. 335. Questo non gli impedisce di esprimere, nello stesso capitolo, sulla base di una lettura di Las Casas, la sua pietà nei confronti degli infelici Indiani: « ...malheureux sauvages (...) poursuivis comme des daims dans le fond des forêts, dévorés par des dogues, et tués à coups de fusil, ou surpris et brûlés dans leurs habitations » (Ibidem, p. 339). Sull’atteggiamento di Voltaire nei confronti dei selvaggi cfr. C. Rosso, Montesquieu, Voltaire et la cueillette des fruits au Canada, ou l’inégalité par le dénigrement, in Studi sull’uguaglianza. Contributi alla storia e alla tipologia critica di un’idea nell’area francese, I, a cura di C. Rosso, Pisa, 1973, pp. 32-53. (10) Montesquieu, Lettres persanes, Lettera CXXI, ed. a cura di P. Vernière, Parigi, 1967, pp. 254-258. (11) « Comment auraient-ils pu retenir tant de millions d’hommes dans l’obéissance? 41 Comment soutenir une guerre civile de si loin? Que seraient-ils devenus, s’ils avaient donné le temps à ces peuples de revenir de l’admiration où ils étaient de l’arrivée de ces nouveaux Dieux et de la crainte de leur foudre? Quant aux Portugais, ils prirent une voie tout opposée: ils n’employèrent pas les cruautés. Aussi furent-ils bientôt chassés de tous les pays qu’ils avaient découverts » (Ibidem, p. 257). (12) Ibidem. (13) Cfr., ad esempio, anche il «Dossier» de l’Esprit des lois, in Œuvres complètes, ed. a cura di R. Caillois, Parigi, 1949-51, 2 voll., II, pp. 1004-1010, in cui si legge, tra l’altro: « Nous avons vu dans les établissements que les Anglois et les Hollandois ont faits dans les deux Indes, qu’ils se sont établis en Asie et en Amérique, sans s’affoiblir en Europe, et qu’ils n’ont perdu que ce qu’ils avoient de trop. Nous avons vu que les Espagnols et les Portugais se sont affoiblis ici, en se fortifiant là-bas; qu’ils n’ont point-augmenté leur puissance, mais l’ont divisée, et l’ont portée là où il ne falloit pas» (p. 1008). Non si tratta qui di un giudizio negativo sulla colonizzazione; ma su di un errato modo di attuarla. (14) Sulle « scorrettezze » di comportamento degli Spagnoli nei confronti degli Indiani e sulla futilità dei motivi in base ai quali si sono sentiti autorizzati a renderli schiavi cfr. anche i capitoli 3° e 4° del libro XV dell’Esprit des lois, che esamineremo attentamente più oltre. Vedi anche il libro XXVI, cap. 22°, in cui Montesquieu giudica con severità il comportamento degli Spagnoli nei confronti del re degli Incas. (15) Che i due fenomeni, anche sul piano storico, siano strettamente legati è cosa ovvia. L’inizio del capitolo 5° (libro XV) dell’Esprit des lois sintetizza assai bene questa realtà: « Les peuples d’Europe ayant exterminé ceux de l’Amérique, ils ont dû mettre en esclavage ceux de l’Afrique, pour s’en servir à défricher tant de terres ». (16) Diderot, Supplément au voyage de Bougainville, in Œuvres, ed. a cura di A. Billy, Parigi, 1951, pp. 959-960. (17) Sull’atteggiamento di Diderot nei confronti della schiavitù e della colonizzazione vedi infra. (18) Polemiche del resto già ben altrimenti approfondite da altri critici, ai quali rinviamo. Noi vi facciamo riferimento qui soltanto in funzione propedeutica alla nostra indagine sulla schiavitù negra. Su questo dibattito cfr. A. Gerbi, La disputa del Nuovo Mondo. Storia di una polemica (1750-1900), Milano-Napoli, 1955; G. Gliozzi, Adamo e il Nuovo Mondo, Firenze, 1977. (19) Les Incas, pubblicati soltanto nel 1777, erano già stati in parte letti in pubblico fin dal 1770, epoca in cui Grimm ne dà un giudizio positivo sulla Correspondance littéraire, cfr. E. D. Seeber, Anti-slavery opinion in France during the second half of the eighteenth century, Baltimora, 1937, p. 41. Abbiamo letto il testo di Marmontel in un’edizione di Lione del 1810, in 3 voll. (20) « Un pape y mit le sceau de la puissance apostolique, dont, l’étendue étoit alors sans bornes: il traça une ligne d’un pôle à l’autre, et de sa pleine autorité il partagea le Nouveau Monde entre deux couronnes exclusivement. Il (...) donnoit tout l’Occident à l’Espagne, et autorisoit ses rois à subjuguer, avec l’aide de la divine clémence, et amener à la foi chrétienne les habitans de toutes les îles et terre ferme qui seroient de ce côté-là. La bulle est de l’année 1493 (...) de tous les crimes des Borgia, cette bulle fut le plus grand » (Prefazione, pp. XXIIXXIII). (Il corsivo è dell’autore). Per un’analoga condanna in Raynal cfr. infra. (21) « Est-il concevable en effet que la douceur, la patience, l’humilité des Indiens, l’accueil si tendre et si touchant, qu’ils avoient fait aux Espagnols, ne les eussent point 42 désarmés, si le fanatisme ne fût venu les endurcir et les pousser au crime? (...) Les forcenés! en égorgeant, en faisant brûler tout un peuple, ils invoquoient Dieu et ses saints. Ils élevoient treize gibets et y attachoient treize Indiens, en l’honneur, disoient-ils, de Jésus-Christ et des douze apôtres. Etoit-ce impiété ou fanatisme? ». (Ibidem, pp. XXI-XXII). (22) Ibidem, p. V. (23) Nella prefazione, in nota, Marmontel fa riferimento alla Découverte des Indes occidentales, tradotta in francese e pubblicata a Parigi nel 1687. Las Casas è il vero protagonista dell’opera ed è a lui che l’autore affida il compito di portare avanti la sua veemente requisitoria. Uno studio sulla fortuna di Las Casas in Francia nel ‘700 sarebbe utile per chiarire l’ampiezza di diffusione della sua opera e i modi in cui è stata letta. Malouet, sostenitore della schiavitù negra nelle colonie, ha visto in Las Casas unicamente colui che per primo suggerì di importare negri in America, al fine di frenare la decimazione degli Indiani (cfr. il nostro Mon frère..., cit., pp. 75-76). Gli abolizionisti lo hanno esaltato, vedendo in lui l’iniziatore della lotta che essi stanno portando avanti e, quasi tutti, lo citano con rispetto nelle loro opere. I critici della colonizzazione si richiamano alla sua testimonianza, per denunciare le crudeltà commesse dagli Europei nel Nuovo Mondo. Voltaire, che non si lascia sfuggire nessuna occasione per denunciare l’intolleranza e i misfatti della Chiesa, cercherà nelle opere di Las Casas la conferma delle male azioni di questa nel Nuovo Mondo : « Ce témoin oculaire dépose à la postérité que souvent on faisait sommer par un dominicain et par un cordelier les malheureux (indiani) de se soumettre à la religion chrétienne et au roi d’Espagne; et après cette formalité qui n’était qu’une injustice de plus, on les égorgeait sans remords » (Essai sur les mœurs, cap. CXLV, ed. cit., II, p. 339). L’abbé Grégoire, instancabile difensore della causa dei negri e dei mulatti, fa persino un’Apologie de Barthélemy de Las Casas, évêque de Chiappa letta all’Institut il 22 floreale dell’anno VIII. Raynal, su un presunto monumento innalzatogli dagli indigeni americani, ridivenuti padroni delle loro terre, fa scrivere queste parole: «DANS UN SIÈCLE DE FÉROCITÉ, LASCASAS, QUE TU VOIS, FUT UN HOMME BIENFAISANT » (citiamo dall’edizione di Ginevra del 1780, vol. IV, libro, 8°, p. 341). (24) Marmontel, op. cit., I, pp. 141-42. (25) Leggiamo, sempre nella prefazione di Marmontel, che mentre Las Casas voleva che la fede fosse diffusa unicamente con mezzi pacifici, « Sépulvéda lui opposta le Compelle intrare, et le Deutéronome, où il est dit: ‘Quand vous vous présenterez pour attaquer une place, vous offrirez d’abord la paix aux habitans, et s’ils l’acceptent, et qu’ils vous livrent les portes de la ville, vous ne leur ferez aucun mal, et vous les recevrez au nombre de vos tributaires; mais s’ils prennent les armes pour se défendre, vous les passerez tous au fil de l’épée, sans épargner les femmes ni les enfans’ » (p. XXVIII, nota). I passi biblici cui fa riferimento Marmontel sono rispettivamente il XXII, 1-15 del Vangelo secondo San Matteo: Le nozze regali, e il XX, 10-14 del Deuteronomio. Tutto il Deuteronomio è del resto caratterizzato da un costante stimolo alla conquista, alla lotta per la fede ed allo sterminio di coloro che non vogliono accoglierla pacificamente. Sul rifiuto del compelle intrare come regola del comportamento della Chiesa è appena il caso di ricordare il famoso testo di Pierre Bayle: Commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ: contrains-les d’entrer, in cui l’autore (protestante, convertito e relapso) rifiuta il principio delle conversioni forzate e rivendica il diritto alla « coscienza errante ». Sulla presa di posizione di Bayle, cfr. C. Rosso, Illuminismo, felicità, dolore. Miti e ideologie francesi, Napoli, 1969, p. 26 e passim; sul 43 pensiero religioso di Bayle cfr. soprattutto G. Cantelli, Teologia e ateismo. Saggio sul pensiero filosofico e religioso di Bayle, Firenze, 1969. (26) Ad eccezione, talvolta, di quelli che erano considerati i più rozzi, arretrati e grossolani fra i negri. Cfr., ad esempio, Buffon, De l’homme, ed. a cura di M. Duchet, Parigi, 1971, p. 286: « Ces Hottentots sont, au reste, des espèces de sauvages fort extraordinaires (...) ». Sul complesso problema del « selvaggio » nella riflessione europea ci limitiamo ad indicare alcuni testi, corredati di una ricca bibliografia; E. Balmas, La scoperta dell’America e le lettere francesi del Cinquecento. Buon selvaggio e terzo mondo, Milano, 1971; G. Gliozzi, La scoperta dei selvaggi. Antropologia e colonialismo da Colombo a Diderot, Milano, 1971; S. Landucci, I filosofi e i selvaggi (1580-1780), Bari, 1972. (27) Cfr., per un esempio piuttosto convincente, Delisle de Sales, Philosophie de la nature (1770). Abbiamo consultato il testo nell’edizione del 1804 (10 tomi in 5 volumi): nel IV volume, in un brano intitolato Le Parisien et le Caraïbe, quest’ultimo si esprime nei seguenti termini : « Moi, je suis un homme, mais vous autres, avec votre taille de cinq pieds, vos sens énervés et votre vie de trente ans, qu’êtes-vous? Y aurait-il par hasard des hommes de la grande et la petite espèce (...)? Le Caraïbe est-il l’homme de la nature, et le Parisien l’homme dégénéré? » (p. 35). Mentre, poco oltre, Delisle parla in maniera assai meno lusinghiera del negro: « La dégradation la plus fatale que le climat produise dans les Nègres, regarde la faiblesse de leur intelligence (...). L’air embrasé qu’un Africain respire sans cesse, a bientôt vicié en lui le faisceau des fibres sensibles, fait évaporer la partie balsamique du sang, et en oblitérant l’organe de la mémoire, préparé les voies à cette inertie de l’esprit qui diffère si peu de la stupidité » (V, p. 314). Su Delisle de Sales cfr il nostro Il «Drame raisonnable» di Delisle de Sales: gli ultimi saranno i primi?, in Studi sull’uguaglianza I, a cura di C. Rosso, cit., pp. 54-64. 44 LE RIVOLTE DEGLI SCHIAVI « J’ai vû des Noirs traités avec la dernière cruauté, uniquement pour satisfaire la barbare fantaisie d’un Inspecteur, qui est celui qui d’ordinaire ordonne les punitions. J’ai vû leur corps tout couvert de sang, leur dos dépouillé de la peau, du poivre pilé et du sel jettés dans leurs blessures, et des bâtons de cire d’Espagne entiers fondre et tomber goute à goute sur eux. Est-il étonnant que des tourmens si affreux les portent à se révolter! » (1). Il negro aveva piegato il capo sotto il giogo della schiavitù, mentre l’indigeno americano non aveva voluto, o potuto farlo, soggiacendo alla distruzione, piuttosto che all’obbedienza ed ai lavori forzati. Era così nata la leggenda che i popoli africani fossero destinati alla schiavitù e avessero quindi trovato nelle colonie americane la loro condizione ottimale. In realtà, la passività del negro, su cui hanno tanto insistito con compiacenza gli schiavisti, non è mai stata altro che un sofisma propalato a scopo pubblicitario per difendere lo sfruttamento coloniale(2). Certo, il trattamento disumano (come fa rilevare il testo da noi citato, ed anche altri che vedremo in seguito) ha avuto un peso determinante nello spingere alla rivolta, ma il fenomeno è ben più complesso e le sue motivazioni sono molteplici e difficilmente ricostruibili a distanza di secoli (3). Quello che ci preme far rilevare è che l’accettazione passiva da parte del negro non è mai esistita: forme di ribellione (individuale o di gruppo) e di rifiuto della condizione imposta sono infatti coeve alla nascita delle colonie, anzi, si potrebbe quasi dire che la precedono in quanto molte insubordinazioni e rivolte hanno reso difficile il soggiorno dei mercanti sulle coste africane e i viaggi delle navi negriere attraverso l’Atlantico. Le valutazioni, sempre molto approssimative, della frequenza di rivolte sulle navi e della loro entità sono state fatte dagli studiosi della tratta (4). Un indice abbastanza indicativo potrebbe comunque essere considerato il Journal de l’Affricain, in cui l’ufficiale e scrivano di bordo, Dam Joulin, annota gli avvenimenti giornalieri di un viaggio triangolare (Nantes-Africa-Antille~Nantes) nella prima metà del ‘700 (5). Vi leggiamo: 45 « SAMEDI 15 NOVEMBRE 1738 (...) Nous avons accosté le navire anglais (…) Le capitaine, le second et le lieutenant ont essuyé une terrible révolte; leurs captifs les ont obligés à se sauver avec leurs gens dans leurs chaloupes et canots ». « JEUDI 27 NOVEMBRE 1738 (...) Les nègres se sont révoltés (...) plusieurs de nos gens se trouvent rudement blessés, la plupart à la tête, et je suis du nombre ». « VENDREDI 6 FEVRIER 1739 (...) Leurs nègres (di un brigantino inglese) ont réussi à se déferrer cette nuit avec l’intention d’égorger tous les blancs. Ils en ont cependant réduit quelques-uns et les ont enferrés aux deux pieds et aux deux mains, cramponnés sur le pont, enchaînés par le cou quatre par quatre. Ils ont aussi été informés par un négrillon que les nègres se sont emparés de deux ciseaux à froid, de deux marteaux armés, et ils se sont tous armés de couteaux flamands. Ainsi les anglais vont rester toute la nuit sous les armes jusqu’à demain » (6). In un solo viaggio, forse particolarmente sfortunato, Dam Joulin è testimone (e in parte vittima) di tre tentativi di rivolta, che si concludono, come accade sempre, con la sconfitta degli schiavi, seguita da punizioni severissime. Neppure l’equipaggio esce però mai indenne da queste rivolte: la nave di Joulin perde infatti il capitano e un marinaio. Le ribellioni hanno quasi sempre luogo quando il viaggio non è ancora cominciato e il capitano sta completando il carico. C’è infatti ancora speranza, per lo schiavo, se la rivolta ha per lui esito positivo, di raggiungere la costa e di ritornare alla propria casa, mentre le insubordinazioni in alto mare sono più un estremo gesto dettato dalla disperazione che un tentativo di salvezza. Ma, accanto a queste forme di ribellione collettiva ed « attiva » che presuppongono un minimo di organizzazione ed il verificarsi di circostanze esterne favorevoli, si hanno numerosi casi di rivolta individuale e « passiva », che si concretizza in un rifiuto della nuova condizione, mediante il rifiuto della vita (7). Numerosi sono infatti i casi di prigionieri che tentano di gettarsi in mare, se la sorveglianza si allenta e non sono strettamente incatenati, o che cercano la morte per soffocazione con un sistema che mal comprendono gli Europei e che consiste nell’ostruire le vie respiratorie « ingoiando » la lingua. Numerosissimi poi i casi di schiavi che si rifiutano di mangiare, votandosi ad una fine lenta e terribile (8), il che ci può aiutare a capire con quale determinazione e forza disperata erano decisi a rifiutare la loro nuova condizione ed un futuro di cui ignoravano tutto, ma che, a giudicare dal 46 presente, non aveva nessuna probabilità di essere accettabile. Questo rifiuto è indubbiamente motivato da un complesso di stimoli, il minore dei quali non è certamente la paura; non si può quindi vedere in esso una denuncia volontaria e cosciente della strumentalizzazione di cui i negri sono fatti oggetto. È però il riflesso di un’impossibilità di adattamento e di accettazione, è la smentita più chiara delle mistificazioni schiaviste operate nell’ambito della caratterologia razziale. Certe rivolte a bordo delle navi negriere, esemplari per la loro tenacia e per la loro crudezza, hanno suscitato l’interesse degli scrittori nel corso dei secoli: basti pensare all’Oroonoko di Aphra Behn (1688) in cui molti negri decidono di lasciarsi morire di fame, o al terribile Tamango (1829) di Mérimée, in cui la rivolta degli schiavi, cruenta e spaventosa, è evocata con una forza che riesce ancora oggi ad essere sconvolgente. Le rivolte sulle navi accompagnano la storia della tratta dalle origini fino alla sua scomparsa progressiva nel corso dell’800, ed hanno trovato in ogni epoca un’eco assai vasta nelle opere di pensatori e letterati. Non meno frequenti e con esiti sostanzialmente identici le rivolte sul suolo coloniale (9). Anche i tipi di rivolta sono press’a poco gli stessi, con la differenza che la ribellione individuale può avere qui come sbocco, oltre la morte, anche la fuga. Le colonie si popolano così, col passare degli anni, di gruppi sempre più numerosi e pericolosi di schiavi che vivono alla macchia e si sostentano, nella maggior parte dei casi, col frutto di furti notturni o assalendo in massa le piantagioni più isolate. Queste varie forme di insubordinazione, a cui devono aggiungersi molte vendette private, talvolta anche orribili (10), non costituiscono un grave problema fino a quando restano sporadiche ed il rapporto fra la massa servile e i padroni bianchi si mantiene nei termini di una sproporzione ragionevole. Ma diventano pericolose quando si manifestano nelle varie colonie a ritmo ravvicinato, in proporzioni considerevoli e allorché il rapporto numerico fra bianchi e neri (a cui si possono aggiungere i mulatti che aumentano considerevolmente col passare degli anni) registra divari sempre più impressionanti. È quanto avviene nel corso del ‘700, che non a torto Gaston-Martin ha definito l’« ère des négriers » (11), perché è veramente il periodo in cui l’importazione di schiavi in America raggiunge le vette più alte, al punto che il commercio degli schiavi diviene il centro attorno al quale ruota buona parte del commercio e dell’industria francese. Sono gli anni in cui si consolida la floridezza delle Antille ed in particolare di San Domingo e di conseguenza si rafforza anche nei coloni, e in tutti coloro che sono coinvolti nel commercio coloniale, la fiducia nella bontà dei metodi 47 adottati. Sono anche gli anni di grande sviluppo dei porti sull’Atlantico coinvolti nel «commercio triangolare»: « Nantes se modernise; c’est l’époque des beaux hôtels particuliers de la Fosse et de l’île Feydeau. Les armateurs sont d’importants personnages, portant des cannes à pomme d’or et l’épée. Beaucoup sont cultivés, voire philosophes. Les Montandoin appellent leurs navires: le Jean-Jacques, le Voltaire, l’Ingénu, le Contrat social. On verra plus tard le Necker, le Mirabeau et la Révolution » (12). Il fenomeno va assumendo nel corso del secolo proporzioni tali da attirare anche l’attenzione critica di pensatori, letterati, uomini di scienza ed economisti: cosicché il periodo di maggior floridezza dello sfruttamento schiavista è anche il periodo che ha scatenato le più accese recriminazioni. Negli anni che precedono la Rivoluzione, le colonie francesi continueranno ad essere straordinariamente redditizie, almeno per i privati europei, ma ormai le voci di dissenso si faranno sentire ovunque e quello che sembrava un risultato definitivamente acquisito dovrà essere difeso dai coloni con ogni mezzo. Ma, al di là di ogni intervento dall’esterno, le colonie nascondevano, sotto la loro apparente floridezza, un male endemico che le rodeva dal di dentro come un tarlo, il cui lento lavorio veniva ogni tanto in superficie e rendeva sempre più difficili le tamponature. Affogare le rivolte nel sangue non era certo una soluzione, ma serviva piuttosto a rinvigorire il male. Alla durezza e alla brutalità i negri rispondevano, non appena se ne presentava l’occasione, con lo stesso linguaggio, o con la pigrizia, l’incuria, il sabotaggio, la vendetta. Tutto ciò aveva finito col creare un clima di tensione costante nelle colonie: i bianchi avevano paura, i negri mordevano il freno e talvolta lo spezzavano, creando momenti di vero panico. C’era chi cominciava ad avere il sospetto di vivere su di una polveriera, ma preferiva non scendere alla radice dei problemi e cullarsi nell’idea che, con un po’ di buona volontà e di clemenza nella conduzione degli schiavi, tutto sarebbe potuto tornare tranquillo. I negri, dal canto loro, stavano prendendo lentamente e vagamente coscienza della loro situazione e alle rivolte di pochi isolati cominciarono a sostituirsi, nel corso del ‘700, alcune rivolte in cui è possibile cogliere una sia pur rozza trama organizzativa. La preparazione di queste rivolte manca spesso di chiarezza, di lungimiranza, di reale valutazione dei propri mezzi e delle proprie forze, ma ha già i connotati di una ri- 48 vendicazione di gruppo. Alla formazione di questa embrionale coscienza di una lotta da condurre in comune contribuisce in maniera decisiva l’esperienza del « marronnage », cioè di una vita comune « alla macchia », condotta in condizioni difficili e precarie, ma proprio per questo capace di stringere legami molto solidi fra i suoi membri. Legami che del resto finiscono coll’essere imposti anche in maniera coercitiva, in quanto una comunità marronne non permetterà mai a nessuno dei suoi membri di ritornare alla piantagione, perché la sua salvezza dipende proprio dalla capacità di mantenere segreti i diversi luoghi che si sceglie come rifugio: il negro che ritorna a vivere fra i bianchi è per forza di cose una futura spia. Molti capi di rivolte si sono fatti le ossa alla macchia, dove sono riusciti a radunare una banda di altri fuggiaschi e a sobillare gli schiavi rimasti nelle piantagioni attraverso una rete di contatti segreti, cui a volte non sono estranei riti magici, nel corso dei quali si suggellano, nelle tenebre, patti di fratellanza e di lotta. Si tratta certo di una coscienza assai vaga e confusa, che ha bisogno di essere sollecitata dal sortilegio o attraverso riti religiosi, ma esempi di sollecitazioni di questo tipo non sono estranei neanche a forme di ribellione (o di contestazione) più evolute. Il pericolo maggiore che presentano queste rivolte consiste nel fatto che, essendo la spinta all’azione più fanatica che ragionata, essa ha una grande forza dirompente, ma scarse possibilità di reggere di fronte alle misure controffensive: può così provocare il massacro brutale di tutti i bianchi di una proprietà e la distruzione di una o più piantagioni, ma si conclude, nella maggior parte dei casi, anche con la morte dei rivoltosi o con la loro miserevole resa, seguita da punizioni esemplari. La figura più straordinaria di capo carismatico nelle Antille francesi, prima della rivolta di San Domingo del 1791, è quella di Macandal (o Makandal) che «sorge» nell’isola intorno al 1750. Sembra che anche in schiavitù avesse già un ascendente fortissimo sugli altri schiavi: dopo aver abbandonato la piantagione ed essersi rifugiato in una caverna non lontano dai luoghi abitati, così da poter mantenere i contatti con un certo numero di schiavi nelle diverse piantagioni, ogni sua richiesta divenne legge. Era riuscito a creare, da solo, una fitta rete di contatti che gli permetteva di agire contemporaneamente in un raggio assai ampio di territorio. Abilissimo nel preparare veleni, era proprio di questo mezzo che si serviva per scatenare intorno a sé il panico fra i bianchi: « Il veleno strisciava nella Plaine du Nord, invadendo pascoli e stalle. Nessuno sapeva come trovasse la strada tra l’erba e l’alfalfa, si mescolasse nelle balle di 49 biada, capitasse nelle mangiatoie. Fatto sta che mucche, buoi, manzi, cavalli e pecore morivano a centinaia e il fetore delle carogne ovunque aleggiava, onnipresente » (13). Poi, a poco a poco, il veleno si insinuò nelle case e cominciò a colpire le persone, mentre nell’ombra il potere di Macandal diveniva sempre più solido e vasto. Nel 1758 si sentì pronto per sferrare un’offensiva di propozioni molto più ampie: aveva deciso di avvelenare l’acqua di Cap Français e di assaltare la città mentre gli abitanti si contorcevano negli spasimi della morte. L’organizzazione di questa rivolta, rimasta sotterranea, era stata lunga, paziente ed anche molto abile; l’adesione degli schiavi, cieca e totale (proprio perché Macandal era sentito come una sorta di messia onnipotente), dava buone garanzie di riuscita. Ma l’impresa aveva ormai raggiunto proporzioni notevoli ed il segreto diveniva sempre più difficile da mantenere, così Macandal fu tradito da uno schiavo sottoposto alla tortura. Fu catturato ed arso vivo sulla piazza di Cap Français: i negri non credettero alla sua morte e furono convinti che sarebbe ricomparso, magari sotto forma di qualche animale, poiché nessuna metamorfosi gli era impossibile (l4). Forse la paura dei bianchi e la venerazione dei negri hanno ingigantito la figura di Macandal e le dimensioni della sua impresa, sta di fatto che egli è rimasto come una specie di simbolo della liberazione negra, dotato di qualità superumane grazie anche all’appoggio di divinità protettrici della lontana terra d’origine. Ma, come ha fatto rilevare Debbasch, i Macandal sono pochi (15) e del resto anche i Macandal falliscono, tanto è difficile, all’interno del potere bianco, creare un’organizzazione clandestina capace di dare un minimo di garanzia di successo alla rivolta. Organizzare significa programmare in un certo tempo e la clandestinità è sempre per sua natura molto precaria e teme le lunghe scadenze. Cosicché la forma di « rivolta » più largamente diffusa nelle colonie resta il marronnage che, tra l’altro, fuori dalla cerchia dei bianchi, permette quell’organizzazione e quindi quel tirocinio all’organizzazione e al comando che è impossibile nelle piantagioni. Debbasch, che ha studiato con pazienza e competenza, soprattutto attraverso un lungo spoglio di documenti di archivio, il fenomeno del marronnage nelle Antille francesi, ha posto l’accento sul ruolo svolto dalle comunità di fuggitivi nella formazione di una coscienza libertaria e sociale. Il marronnage contribuisce, come le rivolte vere e proprie, a minare le basi della società coloniale: non per nulla nel corso del ‘700, i legislatori hanno finito coll’accomunare i due fenomeni nelle loro ordinanze e istruzioni ai coloni. Li hanno cioè sentiti come le due facce di un unico, 50 pericoloso atteggiamento distruttivo dei « valori » su cui si fondavano la sicurezza e la prosperità coloniale (16). La lotta che i coloni hanno sempre condotto contro le bande marronnes si spiega dunque, in parte, con il pericolo immediato che esse rappresentavano per le piantagioni isolate e vicine alla zona in cui avevano trovato rifugio, ma anche con l’esigenza di distruggere dei focolai di insubordinazione, che divenivano inevitabilmente centri di richiamo per gli schiavi, fino a costituire, col tempo, un vero pericolo per la sopravvivenza della colonia. L’esempio della Guiana olandese è illuminante sotto questo profilo: il marronnage, più difficile da controllare sul continente che nelle isole, più povere di zone franche, vi assunse col tempo dimensioni tali da identificarsi con una vera e propria rivolta, che coinvolse buona parte della colonia e per periodi così lunghi da comprometterne l’esistenza. Il capitano inglese Stedman, partito con un gruppo di militari olandesi per la Guiana, nel 1773, allo scopo di rafforzare le difese della colonia contro le bande marronnes, prima di narrare i fatti di cui è stato protagonista o spettatore, fa una storia dei difficili rapporti tra negri e bianchi che hanno sempre caratterizzato la vita della colonia. Profondamente e umanamente sensibile alla triste condizione dello schiavo negro, aperto alla comprensione e quindi lontano dal tono agiografico, ma anche dalla condanna irrazionale, Stedman ha più volte bollato la crudeltà dei padroni bianchi (17) vedendo in essa, oltre che nella natura stessa della schiavitù (18), una forte spinta alle insurrezioni, per non dire una giustificazione della rivolta negra. Nel tracciare una storia della colonia, Stedman ricorda che i primi accordi con i negri fuggitivi risalgono al 1680 e che già intorno al 1726-28 le bande avevano raggiunto proporzioni consistenti e compivano pericolose scorrerie nelle piantagioni. Il gruppo più forte era quello che si era stabilito sulle rive del fiume Sarameca, da cui appunto prendeva il nome. Ogni sforzo per sottometterlo o distruggerlo fu vano, cosicché i coloni, « ... ne pouvant supporter plus long-temps les dépenses de cette guerre et les fatigues qu’il falloit essuyer en poursuivant leurs ennemis dans les bois, rebutés de plus par les pertes énormes que leur causoient les fréquentes invasions des nègres et par la terreur continuelle qui en étoit la suite, se décidèrent enfin à traiter la paix avec eux » (19). La pace fu fatta nel 1749 e il capo dei ribelli, il mulatto Adoe, ricevette dal governatore, come simbolo di indipendenza, un « Jet à pomme d’argent, sur lequel étoient gravées les armes de Surinam » (Ib., p. 80). Il fatto ci sembra molto significativo: un gruppo negro, adottando quella che 51 potremmo definire la tecnica della guerriglia, aveva raggiunto, intorno alla metà del ‘700, forza sufficiente per costringere una potenza coloniale a trattare, in condizione di inferiorità, e per imporre il riconoscimento della propria indipendenza. Certo non si può attribuire a queste bande una vocazione di liberatori del popolo negro dalla schiavitù. Trattano unicamente il riconoscimento del loro gruppo e non si pongono il problema della condizione dei loro fratelli, anzi, in genere, nelle clausole dei vari trattati di pace fra potere bianco e comunità marronnes c’è l’impegno di queste ultime a restituire, dietro compenso, gli schiavi fuggiti che cadessero nelle loro mani. Ma c’è comunque nella loro azione, pur nei limiti che si impone essa stessa o che le vengono imposti dalle circostanze esterne, un’esigenza di libertà, la scoperta della forza che può rappresentare il gruppo unito nella lotta, la nascita, insomma, di una coscienza comunitaria se non proprio di una coscienza sociale. Il rapporto fra coloni e comunità marronnes nella Guiana olandese non migliorerà dopo questo accordo, anche a causa della instabilità e della trasformazione delle varie bande, nonché della formazione di sempre nuovi gruppi effimeri ed incontrollabili, proprio anche a causa della loro precarietà. Molto spesso la colonia si ritroverà così sull’orlo della paralisi e vivrà momenti di grande terrore. Quando il marronnage assume proporzioni consistenti ha quasi il carattere di una rivolta permanente, con punte più o meno ravvicinate di forte distruttività: la fuga, anche ammesso che sia dovuta unicamente a ragioni di ordine pratico, conduce quasi sempre, in un secondo tempo, alla lotta per il mantenimento della acquisita libertà. Ci sembra chiaro che, laddove è stato possibile, il negro, ben lontano dall’accettare passivamente la sua condizione, ha scelto la via difficile della vita alla macchia e si è fatto nemico del padrone bianco, sopportando tutto pur di costringerlo a capitolare. E il caso della Guiana non è unico: una situazione analoga si è verificata anche in Giamaica (20). Scoperta da Colombo nel 1494, quest’isola era stata possedimento spagnolo fino al 1655, quando fu conquistata dagli inglesi, il cui diritto sulla colonia fu sancito dal trattato di Madrid del 1670. Al momento della conquista molti negri si rifugiarono nelle foreste, costituendo fin dagli inizi del dominio inglese un nucleo indipendente. Questi marrons vivevano razziando le abitazioni dei coloni situate vicino alla zona in cui avevano trovato rifugio, spargendo intorno terrore e distruzione. Costituivano inoltre un’attrattiva costante per gli schiavi rimasti nelle piantagioni. Il fenomeno era già abbastanza grave alla fine del 600, ma lo divenne ancor più nel corso del ‘700, al punto che intorno al 1730-35, vaste zone di terreno fertile erano state abbandonate e l’isola era tutta un fermento di scontentezza e di disagio a causa dell’insicurezza in cui vivevano i coloni. 52 Gli Inglesi, visto inutile ogni tentativo di sottomettere i ribelli con la forza, decisero di scendere a patti: li riconobbero come comunità libera, dando loro un capo che dipendeva direttamente dal governatore dell’isola, e inviando in mezzo a loro un certo numero di bianchi a scopo di controllo. Anche in questo caso l’accordo si è reso indispensabile per il mantenimento della colonia (o almeno del suo aspetto positivo per la madrepatria). Il commento a questa lotta condotta dai negri e ai suoi risultati ci sembra giusto lasciarlo fare a Hans Sloane, che ha saputo cogliere immediatamente il significato profondo e simbolico degli avvenimenti (anche se il tono può sembrare retorico): « Que ne peut point l’amour de la liberté sur le cœur des hommes! Ces fugitifs souffroient depuis près de cent ans plus de misere, que peut-être aucun peuple n’ait jamais éprouvé. Toujours aux mains avec des ennemis supérieurs, ils vivoient nuds, exposés à toutes les injures de l’air se nourrissoient de racines et de fruits sauvages, et se voyoient réduits à risquer tous les jours leur vie pour conserver leur liberté. Trouve-t-on des exemples d’une plus grande constance chez les Romains même? Ces fameux Conquerans de l’univers, quoique toujours triomphans, devinrent enfin la proie d’un seul de leurs Citoyens: et des esclaves malheureux et persécutés soutiennent leur indépendance jusqu’au bout, et la rendent stable à la fin par un accord glorieux pour eux » (21). È un riconoscimento forse un po’ altisonante, anche per il confronto con il popolo romano che può sembrare esagerato e fuori luogo, benché se ne spieghi la ragione con la volontà di nobilitare l’azione degli schiavi accostandola, in forma privilegiata, a quella di un popolo di eroi e conquistatori. Ma per quanto il tono possa risultare caricato, il giudizio è lucido e pertinente: un gruppo di negri, all’interno dello strapotere bianco, ha ottenuto il riconoscimento della propria indipendenza con un accordo che gli fa davvero onore. E del resto, in una società che vedeva in questi ribelli dei criminali, non si poteva, per riconoscere i loro meriti, servirsi del tono dimesso: Sloane ha trovato l’intonazione giusta per valorizzare un’impresa denigrata dai più. Le Antille francesi, basate come la Guiana e la Giamaica, sullo sfruttamento degli schiavi negri non avevano mai avuto difficoltà così serie nel controllo della manodopera servile, fino alla famosa rivolta, scoppiata a San Domingo nel 1791 in seguito agli avvenimenti parigini, e conclusasi con la perdita della colonia definitivamente conquistata dagli schiavi, che vollero cancellare ogni ricordo del passato cambiando persino il nome in quello di Haiti. Fino a quella data ci furono sporadiche rivolte di lieve entità, ad eccezione di 53 quella di Macandal, cui già si è accennato, ed anche il fenomeno del marronnage, pur essendo quasi coevo alla nascita delle colonie, non è mai divenuto una seria minaccia per la loro sopravvivenza. Anche se qui, come altrove, non è mai stato domato. Leggiamo, ad esempio, in Moreau de Saint-Méry, a proposito della colonia di San Domingo, un lungo elenco dei vani tentativi fatti dai bianchi per distruggere la comunità del Maniel, detta anche del Bahoruco, la più forte della colonia, al confine con la parte spagnola dell’isola, che offriva uno sbocco e un rifugio interessato (22). Alla fine anche qui si cercheranno le vie dell’accordo, che però non sarà, come nei casi precedenti, imposto da ragioni di sopravvivenza, ma da mire espansionistiche dei coloni verso le zone ancora incolte intorno al rifugio dei marrons. Accordo meno umiliante dunque per i bianchi, ma pur sempre simbolico di uno scacco, delle incrinature di un sistema fondato sulla forza da un lato e la sottomissione totale dall’altro. Rivolte e marronnage hanno dunque costellato la storia delle colonie americane fondate sulla schiavitù, aumentando in proporzione all’aumento della massa servile e quindi della sua sproporzione con i padroni bianchi, ed anche in ragione dell’accresciuto numero di negri creoli, nati cioè in America, e quindi esenti da quell’impatto sconvolgente con un mondo sconosciuto, che rendeva timorosi e incapaci di agire i negri trasferiti in massa e con la forza dal loro paese natio. I negri non hanno dunque mai accettato passivamente la schiavitù, non erano nati per vivere come schiavi e la lotta non sarà prerogativa unica della penna abolizionista, ma procederà parallela sulle due sponde dell’Atlantico, nella teoria e nella prassi, che coincideranno però più nei fini da raggiungere che nei metodi. Gli abolizionisti, in linea di massima, non saranno infatti mai d’accordo con un metodo di lotta violenta, scegliendo invece la via di una lenta programmazione e di una abolizione progressiva. Non approveranno perciò le rivolte degli schiavi, ma se ne serviranno come spauracchio, per dimostrare l’urgenza dei problemi posti dalla schiavitù e la necessità di intervenire drasticamente e non con palliativi più o meno inutili e dannosi. Ma ci sarà anche chi vedrà nell’azione diretta degli schiavi, l’unica strada verso la liberazione: per questi pochi le rivolte sono il segno positivo di un riscatto che non tarderà a coronare gli sforzi sporadici e generalmente inefficaci dei vari gruppi di schiavi. Le rivolte degli schiavi contribuiscono dunque ad attirare l’attenzione sulla gravità dei problemi sollevati dalla schiavitù e sulla necessità di soluzioni rapide: non solo dunque gli schiavi negri non subiscono passivamente la subordinazione ai padroni bianchi, ma neppure ricevono in modo inerte la loro liberazione, anche se il 54 campo operativo in cui possono muoversi resta, per forza di cose, assai limitato. Note (1) Histoire de la Jamaïque, traduite de l’Anglois par M ***, ancien Officier des Dragons, Londra, 1751. Nella scheda del catalogo della biblioteca universitaria di Bologna, l’autore indicato è Hans Sloane, il traduttore è Raulin. Si tratta della traduzione non del noto Voyage to the Islands Madera, Barbados, Nieves, S. Christopher and Jamaica (...), Londra, 1707-1725, 2 voll. in folio, più 2 voll. di stupende tavole, ma della New History of Jamaica, pubblicata da Sloane a Londra nel 1740 (cfr. M. Duchet, Anthropologie et histoire au siècle des lumières, Parigi, 1971, p. 142; l’opera della Duchet è stata ristampata, in edizione « snellita », da Flammarion nel 1978). Sullo sfruttamento letterario del tema della rivolta nel secondo Settecento cfr. infra. (2) Leggiamo in R. Bastide (Le Americhe nere, 1967, tr. it. Firenze, 1970, p. 76): « ... l’immagine dello ‘schiavo buono’, Oncle Rémus, Père Jean, che accettava la sottomissione, devoto ai padroni, allegro e felice, non è altro che un’immagine forgiata dai bianchi per giustificarsi - o non è valida, in ogni caso, se non per gli schiavi domestici. Tutti gli storici, oggi, concordano nel sottolineare, invece, la tenace e continua resistenza che gli africani hanno opposto al sistema che era loro imposto con la forza ». Cfr. anche E. Marienstras, Les mythes fondateurs de la nation américaine, Parigi, 1976. (3) Y. Debbasch, che ha studiato accuratamente il fenomeno del marronnage, cioè della fuga del negro dalle piantagioni e della sua vita clandestina in rifugi isolati (Le Marronnage. Essai sur la désertion de l’esclave antillais, «Année sociologique», 1961, pp. 1-112, ibidem, 1962, pp. 117-195), ha fatto giustamente rilevare che le uniche fonti di informazione di cui disponiamo sono quelle bianche che, per infinite ragioni, possono tutt’al più rendere con la maggior obiettività possibile i fatti, ma non sono in grado di coglierne le motivazioni. Sul problema del marronnage e della rivolta, nonché sul modo in cui sono recepite oggi dalla storiografia e dalla letteratura negro-africana cfr. B. Mouralis, L’image de l’indépendance haïtienne dans la littérature négro-africaine, « Revue de littérature comparée », 1974, n. 34, pp. 504-535. Molto importante anche l’opera di J. Fouchard, Les marrons de la liberté, Parigi, 1972. (4) Cfr., ad esempio, D. P. Mannix e M. Cowley, Carico nero. Una storia del commercio degli schiavi in Atlantico (1518-1865), (1962) tr. it., Milano, 1964, in particolare pp. 166169: « Ci sono resoconti particolareggiati di cinquantacinque ammutinamenti avvenuti a bordo di navi tra il 1699 e il 1845, senza parlare degli accenni ad almeno un centinaio di altri. E quasi altrettanto lungo è l’elenco di navi `tagliate fuori’ dagli indigeni, spesso come rappresaglia per il rapimento di uomini liberi. Dai resoconti non si direbbe che gli Africani si lasciassero docilmente trasportare attraverso l’Atlantico » (p. 167). Va detto che i dati, per forza di cose, non sono attendibili, anche perché bisognerebbe, prima di arrivare ad un minimo di approssimazione, fare uno spoglio di tutti i giornali di bordo di navi negriere. Questo richiede ancora lunghe e pazienti ricerche, una coordinazione vastissima, e i risultati saranno sempre approssimativi, anche per il fatto che molto materiale è ormai perduto o irreperibile. I dati riportati da Mannix sono probabilmente molto inferiori alla realtà. Cfr. anche Ph. Curtin, The Atlantic Slave Trade. A Census, University of Wisconsin Press, 1969 e H. Deschamps, Histoire de la traite des noirs de l’antiquité à nos jours (1971), tr. it., Milano, 1974. (5) Il testo è pubblicato da J. Mousnier in Journal de la traite des noirs, Parigi, 1957, 55 pp. 33-126. (6) Ibidem, p. 35; pp. 36-40; p. 77. (7) Anche questo tipo di rivolta può diventare collettiva, quando la decisione di rifiutare il cibo, ad esempio, è presa in gruppo, magari da schiavi provenienti dallo stesso villaggio o da una tribù vinta in battaglia. E’ una situazione drammatica, destinata a suscitare l’interesse degli scrittori : fin dalla fine del ‘600, la scrittrice inglese Aphra Behn presenta una situazione analoga nel suo Oroonoko, or the Royal Slave (1688) : « Privé de tous moyens capables de le délivrer de la vie, le malheureux Prince résolut de se laisser mourir de faim (...). Cette nouvelle n’inquiéta pas peu le Capitaine, et d’autant plus, que tous ceux de la suite du Prince paroissoient être dans l’intention d’en faire de même ». Citiamo dalla traduzione francese di Laplace, Parigi, 1745, parte prima, pp. 92-93. Sulla tendenza dei negri a lasciarsi morire per disgusto e tristezza, appena imbarcati sulle navi negriere cfr. anche Régine Pernoud, L’Amérique du Sud au XVIIIe siècle. Mélanges anecdotiques et bibliographiques, « Cahiers d’histoire et bibliographie », n. 3, Mantes, 1942, p. 65. (8) Il rifiuto del cibo comportava però conseguenze spesso ben più terribili della morte. Leggiamo in Deschamps (tr. it., p. 131): «… spesso il suicida rifiutava di mangiare, allora gli veniva aperta la bocca con uno speciale apparecchio, lo speculum oris, per infilarvi il cibo. Alcuni capitani si accontentavano di avvicinare alle labbra un tizzone ardente per obbligare ad aprire la bocca. I ferri, le manette, il dado per stringere i pollici e lo speculum oris venivano venduti insieme ad altre forniture navali presso gli shipshandlers di Liverpool ove Clarkson potè procurarsene un’intera collezione ». (9) Per avere un’idea approssimativa della loro frequenza e soprattutto del loro manifestarsi sin dalle origini della colonizzazione americana cfr. la « Chronologie » che segue l’antologia Esclaves et planteurs dans le Sud américain au XIXe siècle, curata da M. Fabre, Parigi, 1970. Per quanto concerne il secondo Settecento, troviamo dati abbastanza impressionanti nelle « Ephémérides du citoyen », 1771, VI, p. 231: «… nous voyons par les papiers publics qu’il ne se passe point d’année sans qu’un assez grand nombre d’habitations et de possesseurs soient immolés, dans les Colonies angloises, hollandoises, portugaises, espagnoles et françoises, à la vengeance des nègres marrons ou révoltés ». (10) Leggiamo in Régénération des colonies, ou moyens de restituer graduellement aux hommes leur état politique, et d’assurer la prospérité des Nations; et moyens pour rétablir promptement l’ordre dans les colonies Françaises (Parigi, 1792) di Antoine-Jean-Thomas Bonnemain: « Aussi voit-on souvent des nègres tyrannisés, méditer en silence les moyens d’assouvir leur vengeance. Tantôt ils empoisonnent leur maître, tantôt leurs propres camarades, tantôt les bestiaux; aussi a-t-on vu des atteliers entiers périr en peu de tems... » (p. 16). Il testo è riprodotto nella raccolta La Révolution française et l’abolition de l’esclavage. Textes et documents, pubblicata dalle Editions d’Histoire Sociale (EDHIS), Parigi, 1968, 12 voll., V, 1. Tutti gli autori, schiavisti o abolizionisti, fanno riferimento nelle loro opere ad episodi di vendetta da parte degli schiavi. Particolarmente crudo ci sembra un avvenimento narrato da Raynal nella sua Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce des Européens dans les deux Indes (prima ed. 1770). Citiamo dall’edizione di Ginevra del 1780 in 10 voll.: « Un autre (schiavo) avoit été mis légèrement à la torture pour une faute de peu d’importance, dont même il n’étoit pas coupable. Son ressentiment le décide à se saisir de la famille de son oppresseur et à la porter sur les toits. Le tyran veut rentrer dans l’habitation, et est lancé à ses pieds le plus jeune de ses enfans. Il lève la tête, et c’est pour voir tomber le second. A genoux et désespéré, il demande en 56 tremblant la vie du troisième. La chûte de ce dernier rejetton de son sang accompagnée de celle du nègre lui apprend qu’il n’est plus père ni digne de l’être » (vol, VI, p. 166). Sull’autenticità del fatto riportato da Raynal, e non solo da lui, è però legittimo avanzare seri dubbi, dal momento che una storia analoga la si legge già in Bodin, il quale a sua volta ne attribuisce la paternità a Gioviano Pontano « … un esclaue voyant son seigneur absent barre les portes, lie la femme du seigneur, prend ses trois enfans, et se mettant au plus haut de la maison, si tost qu’il voit son seigneur, il luy gette sus le paué l’un de ses enfans... ». Il resto dell’aneddoto è come quello narrato da Raynal, con la differenza che prima di gettare il terzo figlio, lo schiavo convince il padrone a tagliarsi il naso, nella speranza di salvarlo. (Bodin, Les six livres de la République, I, 5, citiamo dall’edizione di Lione del 1580, rist. Bologna, 1970, pp. 45-46). (11) E’ il titolo del secondo dei cinque libri in cui è suddivisa la sua Histoire de l’esclavage dans les colonies françaises, Parigi, 1948 ed anche il sottotitolo di un’altra opera dello stesso autore: cfr. nota seguente. (12) H. Deschamps, op. cit., p. 88. Sullo sviluppo di Nantes, il più importante dei porti negrieri nel ‘700, cfr. anche Gaston-Martin, Nantes au XVIIIe siècle. L’ère des négriers (1714-1774), d’après des documents inédits, Parigi, 1931; Père Rinchon, Les armements négriers au XVIIIe siècle, d’après la correspondance et la comptabilité des armateurs et capitaines nantais, Bruxelles, 1956; J. Meyer, L’armement nantais dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, Parigi, 1969 (corredato di una ricca bibliografia). (13) La citazione è tratta da Il regno di questa terra di Alejo Carpentier, tr. it., Milano, 1959, p. 29, un romanzo ambientato ad Haiti nell’epoca napoleonica. Alejo Carpentier, romanziere cubano figlio di padre bretone, è famoso per la sua abilità nel ricostruire, con vivezza, pur nel rispetto delle fonti che dimostra di conoscere molto bene, momenti della storia coloniale. Ha scritto infatti anche un Siglo de las luces, tr. fr., Parigi, 1962, straordinaria evocazione della vita nelle Antille francesi nel periodo della Rivoluzione. Nell’introduzione all’edizione francese, di Jean Blanzat, leggiamo: «… ce n’est pas seulement sur la Révolution aux Antilles que Le Siècle des Lumières nous donne à méditer, mais sur la Révolution française en général et par-delà sur toute Révolution humaine. On est frappé par la précision et la minutie de la documentation réunie sans doute pour la première fois par Alejo Carpentier. Si son livre, cependant suppose un travail d’historien, il ne cesse à aucun moment d’être un roman» (p. 6). Vogliamo infine ricordare di Carpentier lo stupendo Passi perduti, tr. it., Milano, 1977: un drammatico confronto fra mondo civile e mondo primitivo, nel vano sforzo di ritornare alle origini per ritrovare una vita autentica. (14) Su Macandal cfr. anche Moreau de Saint-Méry, Description de la partie française de l’isle de Saint-Domingue (1797-1798), ristampata nella « Bibliothèque d’histoire coloniale » a cura di B. Maurel e E. Taillemite, Parigi, 1958, 3 voll., II, pp. 629-631; Y. Debbasch, op. cit., 1961, pp. 39-40; C. L. R. James, I Giacobini neri. La prima rivolta contro l’uomo bianco, (1963), tr. it., Milano, 1968, pp. 26-27; K. Irvine, The Rise of the coloured Race, Londra, 1972, p. 223 (la prima edizione è stata fatta in America nel 1970). (15) Op. cit., p. 39. (16) Ibidem, 1962, p. 123. (17) I. G. Stedman, Voyage à Surinam et dans l’intérieur de la Guiane, contenant la Relation de cinq Années de Courses et d’Observations faites dans cette Contrée intéressante et peu connue; avec des Détails sur les Indiens de la Guiane et les Nègres (1796), tr. fr., Parigi, Anno VII, 3 voll. L’edizione francese è seguita da un Tableau de la Colonie 57 Française de Cayenne, ad opera del traduttore P.-F. Henry. Citiamo, fra i tanti esempi, il discorso di un capo dei ribelli: « Nous désirons que vous disiez à votre gouverneur et à votre conseil (...) que s’ils veulent ne plus voir de révoltes, ils doivent prendre garde que les planteurs traitent mieux des hommes qui sont leur propriété, et ne les abandonnent pas à la conduite de commandeurs et d’intendans adonnés au vin, qui punissent les nègres avec autant d’injustice que de barbarie... » (I, p. 88). Nel rendere del tutto responsabile della fuga il cattivo trattamento subìto dagli schiavi nelle piantagioni, il capo dei ribelli svuota la ribellione stessa di ogni contenuto che possa far pensare alla nascita di una coscienza sociale. (18) Ibidem, p. 3: « Tout pays où l’esclavage domestique est établi, doit fréquemment s’attendre à des insurrections et des troubles, principalement lorsque les esclaves forment la majorité des habitans... ». (19) Ibidem, p. 79. (20) Gli schiavisti e i coloni francesi non mancavano di far rilevare come questi avvenimenti che funestavano le colonie straniere, lasciando più o meno indenni le loro, fossero la dimostrazione lampante che il loro trattamento degli schiavi era il più umano di tutti. (21) H. Sloane, Histoire de la Jamaïque, cit., parte seconda, pp. 134-35. Sugli echi suscitati in Europa dalle rivolte giamaicane intorno al 1735, cfr. infra il capitolo dedicato all’analisi della Harangue d’un chef nègre, pubblicata sul « Pour et contre » di Prévost. (22) Moreau de Saint-Méry, op. cit., II, pp. 1131-1136. 58 L’INFLUENZA INGLESE 59 RIVOLTA E « MARRONNAGE » IN UN TESTO DEL « POUR ET CONTRE » DI PRÉVOST ∗ Uno dei primi echi letterari delle rivolte di schiavi sul suolo americano giunge in Francia, attraverso l’Inghilterra, per il tramite dell’abate Prévost che traduce, per il « Pour et contre » (1) il discorso (o meglio quello che viene spacciato per tale) del capo di una comunità di schiavi ribelli in Giamaica, apparso su di un periodico inglese (2). È la chiara dimostrazione che le azioni di forza compiute dagli schiavi attirano immediatamente l’attenzione dell’Europa, anche se la prima ricezione di questi eventi è piuttosto quella riservata a fatti romanzeschi e leggendari, che una seria presa di coscienza della gravità del fenomeno (3). Presentando il suo Discours d’un nègre révolté à la Jamaïque, Prévost avverte subito i suoi lettori che si tratta della traduzione di un testo inglese di cui egli si è limitato a dirozzare la forma, per adattarlo ai gusti del pubblico francese. Lascia anche capire che non crede si tratti di un discorso realmente pronunciato da un capo negro in Giamaica, ma piuttosto di un testo confezionato da qualche giornalista inglese: « … on ne courra jamais grand risque à le placer au rang des romans » (p. 353). Il brano è quanto meno esplosivo: il capo dei rivoltosi della Giamaica, Moses Bom Sam, si rivolge ai fratelli schiavi che hanno abbandonato le piantagioni per seguirlo nelle zone impervie e meno praticabili dell’isola, affinché prendano coscienza della loro condizione e organizzino, con metodo e pazienza, la lotta che dovrà porre fine alla schiavitù. Prévost afferma che il discorso ha suscitato molto interesse in Inghilterra e, dal momento che si tratta di un testo « curieux », egli ha pensato bene di farlo conoscere anche in Francia. Non c’è da parte sua nessun commento impegnato che ci aiuti a capire la posizione che egli assume di fronte al problema della schiavitù. Si ha persino l’impressione che non si renda conto della gravità dell’argomento portato sul tappeto ∗ Già apparso su « Spicilegio moderno », 1974, n. 3, con il titolo: Metamorfosi e palingenesi dello schiavo in un testo del «Pour et contre» di Prévost. 60 e del carattere « rivoluzionario » del testo che egli pubblica, a meno che non abbia voluto mantenersi di proposito sul tono leggero, per non insospettire i lettori o non suscitare le reazioni di quella larga parte della ricca borghesia che traeva cospicui proventi dal commercio coloniale, ritenendo, forse a giusta ragione, che un discorso di questo tipo fosse di per sé tanto eloquente da non aver bisogno di alcun commento (4). Quale che sia la posizione di Prévost (5), sta di fatto che ai lettori francesi del 1735 veniva offerto un brano in cui la soluzione al problema della schiavitù era assunta in proprio dagli schiavi, con una disciplina, un rigore e una determinazione che a quell’epoca non trovavano riscontro in nessuna presa di posizione di pensatori francesi. Si tratta forse di un romanzo, come ha fatto notare Prévost, ma non poi così fantasioso ed assurdo da allontanare del tutto il sospetto di una sorta di premonizione. Ci sembra che valga la pena di esaminarlo con attenzione, perché considerato in se stesso, e cioè indipendentemente dal commento di Prévost, è il pezzo più chiaramente e più efficacemente antischiavista pubblicato in Francia nella prima metà del Settecento. Anzi, si può dire che sia una delle più belle riabilitazioni dello schiavo negro apparse in Francia nel corso di tutto il secolo, in quanto non è, o non è soltanto, un’esaltazione del suo coraggio, ma anche e soprattutto della sua saggezza. Il negro presentato in questo testo è la netta antitesi di quello fatto conoscere attraverso numerose relazioni di viaggio e, in particolare, attraverso gli scritti dei sostenitori della schiavitù, che insistevano sul suo stupido vivere alla giornata e quindi sulla sua totale incapacità della sia pur minima programmazione. Qui ci troviamo invece di fronte ad un uomo che guarda lontano, senza lasciarsi prendere la mano dall’odio o dall’impazienza. Moses Bom Sam ci viene presentato come un ex-schiavo che ha ottenuto la libertà per aver salvato la vita del padrone (6). Nel nuovo stato non si è abbandonato alla gioia egoistica della sua promozione sociale, ma si è sforzato di meditare sulla triste condizione degli uomini della sua razza e di studiare il sistema di vita dei bianchi e la loro natura, per scoprire le cause della loro superiorità. Da questo esame scaturisce la conferma di quanto aveva già creduto di intuire quando ancora viveva schiavo: « … ce n’est point la différence du génie, mais l’éducation et le seul hazard, qui donnent aux Blancs cette supériorité dont ils abusent pour mépriser les Noirs pour les fouler aux pieds » (Ib., p. 343). I bianchi non sono dunque uomini più coraggiosi, più forti o più saggi dei negri, ma semplicemente più fortunati. Tutta la loro forza deriva dall’educazione, dagli 61 strumenti che mette a loro disposizione il progresso tecnico, dall’astuzia e dall’organizzazione. Sul piano fisico poi sono nettamente inferiori ai negri: « Quel avantage croyent-ils tirer de leur fade et dégoutante blancheur, sur la couleur noble et majestueuse que nous avons reçûë de la nature? Si la délicatesse est un mérite nous avons la peau aussi douce que leur velours. Est-il question des qualités vraiment viriles? Considérez vos tailles, et vos forces. En quoi vous surpassent-ils? » (Ib., p. 343) (1). Con un atteggiamento modernissimo, Moses Bom Sam vuole invitare il « popolo » negro ad assumere con fierezza la propria négritude (8): il negro è bello e forte, la sua pelle è morbida come il velluto, mentre il bianco è debole e il suo colore è scialbo e disgustoso. Troviamo qui l’esatta contropartita dei testi degli schiavisti: il confronto stabilito da una diversa prospettiva getta una luce nuova sui protagonisti della vicenda coloniale. Molto abilmente, prima di invitare i fratelli umiliati alla lotta, il capo negro li invita a prendere coscienza del carattere episodico e casuale della loro umiliante odissea, imposta da una serie di circostanze esterne sfavorevoli. Questa umiliazione può aver generato sfiducia ed anche reale senso di inferiorità, ma non può aver intaccato la forza della razza negra e tarpato le ali al suo desiderio di libertà. Egli si sforza insomma di ridare fiducia ai suoi fratelli per convincerli che sono ancora in grado di prendere la strada del riscatto. Detto questo, pone in discussione il diritto di asservirli che si sono arrogati i bianchi: nei libri sacri, dettati dal dio che essi pretendono di adorare, si dice che tutti gli uomini sono figli di un unico padre e nascono con la stessa libertà e gli stessi diritti. Vi si racconta anche che Mosé ha liberato il popolo ebreo dalla schiavitù, quindi i bianchi non possono richiamarsi a questi testi per giustificare il loro operato. Diranno forse che lo schiavo negro appartiene loro in nome delle leggi che regolano gli scambi economici, dal momento che lo hanno regolarmente pagato ma, anche volendo accettare un principio così aberrante che equipara l’uomo ad una merce, in nome di quale diritto estendono la loro appropriazione ai figli e ai più lontani discendenti? Chiariti i termini del rapporto fra padrone bianco e schiavo negro, Moses Bom Sam cerca di risvegliare nei suoi ascoltatori l’indignazione e il desiderio di riscossa, evocando il quadro della loro miseria e delle innumerevoli sofferenze, imposte con brutalità ed ingiustizia, ma soprattutto cercando di far loro capire quanto sia vile 62 ancorarsi ad una passività che coinvolge l’avvenire di intere generazioni: « Et voilà l’héritage que vous avez à laisser à vos enfans! (...) Ces tristes victimes apprennent bientôt ce qu’ils ont à attendre de nous (...) nous n’avons que de la honte à laisser à notre Postérité; la honte de notre lâcheté, qui nous fait supporter si longtems les horreurs d’un si fier esclavage et qui nous les fait perpétuer, en laissant après nous une Race infortunée pour succéder à nos misères » (Ib., p. 347). Moses Bom Sam (o chi per lui) dimostra in questo discorso di essere un fine psicologo: sa che sarebbe controproducente porre subito l’accento sulle responsabilità dello schiavo che accetta passivamente la sua condizione, perché significherebbe aggiungere umiliazione all’umiliazione. Ma non può neppure tacere questa responsabilità se vuole che i suoi fratelli acquisiscano piena coscienza dei loro doveri e per questo prepara abilmente il terreno, risvegliando dapprima la loro fierezza e la loro indignazione, attraverso un confronto demitizzante con i padroni bianchi e ritracciando il quadro degli orrori di cui questi si sono resi colpevoli. Li mette insomma di fronte alle loro responsabilità soltanto dopo averli riabilitati ai loro stessi occhi. Questo non significa però che i negri debbano cedere all’odio e al desiderio di vendetta, abbandonandosi a slanci velleitari destinati a restare senza esito: devono rifiutare ogni atteggiamento passivo, rivoltarsi contro una condizione che li fa oggetti e strumenti di lavoro, ma anche imparare a combattere il bianco con le sue stesse armi, la più forte delle quali è l’organizzazione: « Pensons d’abord moins à tirer vengeance de nos maux passez qu’à cimenter les fondemens de notre liberté et de notre repos. Lorsque nous aurons confirmé nos forces par- l’exercice et la discipline, nous parviendrons bientôt à nous faire redouter; et comme tout ce qui reste d’esclaves de notre couleur ne manquera point de se dérober comme nous à la tyrannie, et de trouver les moyens de nous rejoindre, notre nombre achevera de nous rendre invincibles » (Ib., p. 348). Il buon esito della loro azione dipenderà dunque da tre elementi: l’esercizio della 63 propria forza, la disciplina e il numero. Per il momento i negri sono superiori soltanto sotto il profilo numerico e, anche supposto che questo bastasse per cacciare i bianchi dalla colonia, resterebbe aperto il grande problema del dopo. I mezzi tecnici, navi, macchinari ecc., sarebbero inutili nelle mani dei rivoltosi che non saprebbero farne uso, inoltre la mancanza di coesione e di disciplina li metterebbe in breve alla mercé di nuovi nemici. Prima di passare all’azione è dunque necessario un lungo tirocinio in tutti i campi ed in particolare in quello dell’autogoverno. Gli schiavi negri, fuggiti con lui nelle zone incolte della Giamaica, dovranno insomma riuscire a creare uno stato autonomo all’interno di quello dei bianchi, e renderlo forte ed autosufficiente: « Défrichons nos terres. Cultivons-les pour nous et pour notre postérité. Mais pensons d’abord à nous faire des Loix, et ne les cultivons pas avec moins d’ardeur et de soin. Une juste soumission doit paroître douce en sortant d’un injuste esclavage. Si l’Ennemi entreprend de nous forcer dans cette retraite, qu’il nous trouve à l’épreuve de ses efforts: et s’il nous laisse en paix, faisons lui confesser par notre tranquillité que nous sommes aussi bons qu’ils nous a été cruel » (Ib., pp. 350-351) (9). La presa di posizione è lucidissima e serena: niente è lasciato in balia di stimoli di rivincita immediata, dell’odio o dell’improvvisazione. Non si cerca la lotta (anche se si è pronti a combattere), ma il raggiungimento di una posizione di competitività con il bianco. Questo raggruppamento ben organizzato dovrà infatti divenire un centro di raccolta di tutti gli schiavi della colonia e sarà destinato a trasformarsi, col tempo, in uno stato forte con il quale i coloni dovranno scendere a patti. A quel punto, si potranno stabilire fra i due gruppi, un tempo antagonisti, rapporti regolari di scambio, con evidente vantaggio per entrambe le parti. Il cammino che porta a questi risultati è però lungo e difficile, e deve essere intrapreso con pazienza, lungimiranza e spirito di sacrificio: « Ne précipitons rien. Qu’on nous méprise, qu’on nous croye foibles et misérables, pourvû qu’on nous laisse le tems d’établir notre nouvel Etat sur des fondemens solides. L’édifice croîtra. Vous lui ferez prendre une forme qui s’attirera quelque jour du respect et de l’admiration; et soyez sûrs que tôt ou tard vos Ennemis vous embrasseront, en dépit de votre couleur, lorsqu’ils auront tout à craindre de votre colère, et qu’ils trouveront leur intérêt et leur sûreté dans votre amitié » (Ib., p. 311). 64 L’interesse di questo testo ci sembra fuori discussione, anzi, nel suo genere, è unico fra gli scritti che affrontano criticamente il problema della schiavitù nel Settecento. Rappresenta una via intermedia tra la posizione della maggior parte degli abolizionisti e quella di quei pochi che si fanno apologisti della rivolta negra. Dei primi condivide il tono violento nella condanna della schiavitù, ma anche la misura e la cautela nell’esecuzione del processo di liberazione e soprattutto la volontà che questa avvenga, nella misura del possibile, in forma incruenta e senza comportare la distruzione delle colonie e l’espulsione dei bianchi. Ai secondi, e cioè agli apologisti della rivolta, lo accomuna la funzione determinante che in questo processo è affidata al Negro. Se, come nei riformisti, è presente il concetto di una sua necessaria trasformazione da «,schiavo » ad « uomo », l’idea di fondo è però sostanzialmente diversa: si tratta qui di autoformazione, di autodisciplina, il che ovviamente pone il negro ad un livello ben diverso da quello in cui lo collocano in ultima analisi, quasi tutti gli abolizionisti. Le sorti future delle colonie sono nelle sue mani e non più in quelle del bianco. Ma a differenza degli apologisti della rivolta, c’è nel testo di Prévost la ferma volontà di evitare lo scontro cruento ed ogni forma di conclusione violenta dell’avventura coloniale. Particolarmente significativo, sotto questo profilo, ci sembra l’ultimo passo da noi citato, che costituisce la conclusione dell’arringa di Moses Bom Sam. Essa termina con la parola amitié che ben rivela questa volontà di conciliazione finale e un concetto di lotta intesa non come strumento di vendetta, di conquista o di sopraffazione, ma come strumento indispensabile di pace. Se per certi aspetti il brano può sembrare utopico, per la sua fiducia illimitata nelle possibilità di uomini impreparati che si propongono di costruire uno Stato forte dal nulla, per altro verso, sotto questa fiducia un po’ semplicistica fa capolino il realismo disincantato di chi conosce bene le leggi che regolano i rapporti tra gli uomini e gli Stati ed è ben consapevole che si deve cercare, innanzitutto, di creare i presupposti di una sintesi fra le due opposte forze, che componga tutte le divergenze in un accordo di interesse reciproco. Se la buona volontà e la comprensione sono infatti sentite come indispensabili per giungere all’amitié, è anche detto chiaramente che premesse non meno indispensabili di questo « abbraccio » finale sono una posizione di forza da parte dei negri, e la considerazione che esso conviene ad entrambe le parti. Accanto alla fiducia nelle qualità raziocinanti dell’uomo è quindi messa realisticamente in evidenza la componente materiale e utilitaristica che costituisce la base di ogni equilibrato rapporto sociale. Un’amitié stabilita su basi diverse vedrebbe sempre da un lato il dominatore e dall’altro il dominato, colui che impone le sue leggi e colui che deve 65 accettarle. Si tratterebbe perciò di un’amitié puramente formale dietro la quale coverebbero l’antagonismo costante e un clima latente di lotta. Sotto un’altra prospettiva la soluzione proposta da Prévost si rivela quanto mai interessante: tra le due strade contemplate dagli abolizionisti, quella del riformismo gestito dai bianchi e quella della rivolta aperta degli schiavi, egli prospetta un’altra via (che gli eventi hanno poi confermato come la più realistica), la quale prevede come momento iniziale ed irrinunciabile, per la liberazione degli schiavi negri, la fase del marronnage. Anche il marronnage, in quanto denuncia del rapporto coloniale, denuncia non verbale ma, a suo modo, violenta, è una forma di rivolta: lo schiavo decide infatti di abbandonare la piantagione e di andare a vivere lontano dal consorzio degli uomini, perché in esso non c’è spazio per lui come persona, ma unicamente come oggetto usato a fini che non lo concernono. È però un’atto di rivolta strettamente individuale (o che coinvolge soltanto un piccolo gruppo), a cui è estranea ogni volontà di denuncia di un patto sociale che travalichi la persona singola, e destinato a restare sterile se esso non comportasse, per i negri fuggiaschi, la possibilità di formare un nucleo (o di aggregarsi ad uno già costituito) che può convogliare la protesta singola verso forme di lotta organizzata. In ogni rivolta negra sul suolo americano ed in particolare nelle isole delle Antille, i gruppi di negri marrons hanno avuto una funzione di primo piano, per non dire determinante. Nella maggior parte dei casi quindi, il marronnage ha veramente costituito la fase iniziale di ogni forma di rivolta, come momento indispensabile per la formazione di una sia pur vaga coscienza sociale, che poteva difficilmente trovare spazio all’interno della piantagione. Ma accanto a questo aspetto di momento preliminare che lo caratterizza in rapporto ad una forma di liberazione che non sia più soltanto fuga, ma conquista di uno spazio vitale riconosciuto, il marronnage ha, almeno in certi casi, assunto su di sé l’intero processo di emancipazione, portando i negri fuggiaschi a quella posizione di competitività che ha costretto i bianchi a scendere a patti, proprio come si auspicava nel testo presentato da Prévost. L’esempio più clamoroso di un risultato di questo tipo si è avuto, come si è detto, nel corso del Settecento, nella Guiana olandese dove, dopo un braccio di ferro durato moltissimi anni, i bianchi sono stati costretti, per scongiurare la rovina della colonia, a scendere a patti (1761) con le comunità marronnes (10). Gli ex-padroni bianchi avevano dunque dovuto riconoscere l’esistenza di comunità negre libere e se la realizzazione di queste non era così perfetta come quella vagheggiata da Moses Bom Sam, stava però a dimostrare che la strada da lui indicata era la più idonea per ottenere risultati concreti. Sotto questo profilo il testo del « Pour 66 et contre » rivela la sua profonda adesione alla realtà storica, sia pur vista in una prospettiva in parte idealizzata, e costituisce una sintesi molto efficace del problema della schiavitù e dei suoi possibili esiti. In questa visione di una riscossa dal basso, decisa e moderata ad un tempo, risiede la sua più grande originalità. Se poi teniamo conto della data di pubblicazione, il 1735, non possiamo non restare stupiti dell’audacia e della chiarezza con cui è formulata la rivendicazione: è fuor di dubbio che ci troviamo di fronte ad uno dei testi più arditi apparsi in Francia nella prima metà del Settecento (11). Note (1) N. XC, 1735, tomo IV. Per notizie sul « Pour et Contre » di Prévost rinviamo al più completo fra gli studi apparsi recentemente, corredato di bibliografia, che è quello di Jean Sgard, Le «Pour et contre» de Prévost, Parigi, 1969. Esso comprende un’introduzione, un elenco completo degli articoli, diviso per argomenti, con l’indicazione dell’anno e del numero, e due preziosi indici: quello degli autori citati nel periodico e l’« Index rerum ». Sulla continuità e l’intimo legame che caratterizza tutta la produzione di Prévost, giornalista, romanziere e storico (in particolare dei paesi extra-europei) ci sembra molto illuminante un saggio di Michèle Duchet, L’Histoire des voyages: originalité et influences, presentato al Colloque d’Aix-en-Provence del 20 e 21 dicembre 1963, i cui Atti sono stati pubblicati nel 1965 a cura della Faculté des Lettres d’Aix-en-Provence. (2) Il « Discorso » era apparso su più di un periodico inglese: dapprima il « Prompter » del gennaio 1735, poi il « London Magazine » ed infine il « Gentleman’s Magazine » dello stesso mese. Per notizie più dettagliate sull’argomento e per un confronto del testo di Prévost con l’originale inglese cfr. L. - F. Hoffmann, En marge d’un article du «Pour et contre»: Prévost et l’esclavage colonial, in Essays on the age of enlightenment in honor of Ira O. Wade, Ginevra-Parigi, 1977, pp. 155-168. (3) Il discorso non vale però per il « Prompter »: « En deux mots, le Prompter justifie la publication du Discours par le désir de mettre ses lecteurs en garde contre l’esclavage des Antilles : l’esclavage est économiquement néfaste : les Africains occupent des emplois qui pourraient être réservés aux chômeurs indigents de la Métropole. L’esclavage est dangereux (...) ». (Hoffmann, op. cit., p. 156). Sul carattere esplosivo della situazione in Giamaica intorno al 1735, cfr. H. Sloane, Histoire de la Jamaïque, cit., parte II, p. 132. (4) Bisogna anche tener conto del fatto che la vita del periodico è stata molto difficile: Prévost ha sempre dovuto lottare con una censura pronta a chiudergli la bocca. Come ben rileva Jean Sgard, « Il s’est constamment retranché derrière le pour et contre, derrière des emprunts, des comptes rendus, des traductions, des nouvelles objectives; il ne s’exprime jamais que par personne interposée. Dès qu’une idée, une attitude critique ou une forme de 67 sensibilité lui paraît intéressante et audacieuse, il a tendance à décliner toute responsabilité (...) Mais en même temps, il ne choisit que ce qu’il aime... » (op. cit., p. 51). Forse la conclusione è un po’ categorica: è possibile che in certi momenti sia stato costretto a prendere quello che aveva sottomano per fare uscire il numero, ma è certamente giusto affermare che la scelta o la traduzione di un testo piuttosto che di un altro, era per lui un mezzo per esprimere la sua opinione. E del resto lo stesso Hoffmann ha giustamente fatto rilevare che Prévost ha scelto di tradurre il Discours del capo negro e non la sua contestazione apparsa sul « Gentleman’s Magazine » del febbraio 1735, contestazione che egli conosceva, poiché né dà notizia nell’introduzione al discorso. (5) Tenteremo di formulare un giudizio sul suo atteggiamento nei confronti della schiavitù nel capitolo seguente, dopo aver preso in esame l’Histoire générale des voyages. (6) La Duchet, (Anthropologie..., cit., p. 139) inserisce Moses Bom Saam (è la grafia del testo originale) in un elenco di schiavi rivoltosi, quindi di personaggi realmente esistiti e non immaginari, mentre Hoffmann (op. cit., p. 155) sostiene esattamente il contrario: « Moses est imaginé par l’auteur de son Discours apocryphe. C’est-à-dire par un abolitionniste britannique anonyme ». (7) Il corsivo, anche nelle citazioni che seguono, è nostro. (8) Quale importanza abbia avuto nella storia del riscatto dei popoli negri di tutto il mondo un concetto, per altro oggi fortemente contestato, come quello di négritude è cosa universalmente nota. Ci limitiamo perciò ad indicare qui alcuni testi di riferimento: L. Kasteloot, Négritude et situation coloniale, Yaoundé, 1970; S. Adotevi, Négritude et négrologues, Parigi, 1972; M. Carrilho, Sociologia della negritudine, Napoli, 1974. (9) Hoffmann ha confrontato attentamente il testo di Prévost con l’originale, giungendo alla conclusione che tutte le modifiche apportate dal traduttore sono di ordine « ideologico » e tendono, probabilmente per ragioni tattiche, ad attenuare il testo inglese: « Il s’agissait – dice infatti Hoffmann – de réveiller l’opinion publique, en attendant de la mobiliser » (op. cit., p. 168). Gli esempi portati da Hoffmann per documentare questo processo di edulcorazione operato da Prévost sono, in linea di massima, molto convincenti; alle volte però, come è il caso del passo da noi citato, non sembra tanto facile individuare le motivazioni del traduttore. Citiamo la versione originale della prima parte del passo: « Let us plant, and possess, for Posterity, Cultivating Law, too, as well as Land, and by submitting to Government, become too generous for Slavery ». (Hoffmann, p. 164). (10) Cfr. J. G. Stedman, Voyage à Surinam et dans l’intérieur de la Guïane, cit. (11) L’arringa del « Pour et contre » è stata riprodotta da R. P. Jameson nel suo Montesquieu et l’esclavage. Étude sur les origines de l’opinion anti-esclavagiste en France au XVIIIe siècle, Parigi, 1911, pp. 206-212. Il critico giudica il testo poco « remarquable » dal punto di vista letterario e indica come modello, soprattutto per la prima parte, il discorso di Antonio del Giulio Cesare di Shakespeare, mentre ne mette in rilievo il carattere nuovo nell’impostazione del problema della schiavitù: è la prima volta che uno scrittore lo affronta ponendosi dal punto di vista dello schiavo. Egli ritiene anche che questo testo sia uno dei primi segni dell’infiltrazione in Francia del pensiero abolizionista inglese, che dovrà in seguito assumere un’importanza sempre più rilevante. Ci ricorda inoltre che fu giudicato degno di essere ristampato nel Choix des anciens Mercures et autres journaux, una raccolta di 109 volumi, pubblicati tra il 1759 e il 1765 (Tomo 54, p. 75). 68 L’« HISTOIRE GÉNÉRALE DES VOYAGES » « De tous les événemens qui ont excité l’admiration du genre humain dans les derniers siecles, on peut dire qu’il n’y en a point d’aussi merveilleux que les voyages et les découvertes des Européens; soit qu’on y considere les progrès du Commerce et de la Navigation, les trésors immenses dont l’Europe s’est enrichie, les miracles de valeur et de prudence qui ont immortalisé les Chefs d’une si belle entreprise, l’étendue de leurs conquêtes, et la grandeur de leurs établissemens; soit enfin la connoissance qu’ils acquirent d’un monde inconnu jusqu’alors, et beaucoup plus grand que celui dont on croyait connoître les bornes. Cette découverte fut comme une nouvelle création » (1). È l’inizio dell’Histoire générale des voyages tradotta dall’inglese da Prévost (2) su richiesta di « Monseigneur le Chancelier », che gli ha fatto l’onore di sceglierlo per questa impresa, giudicata tanto importante da non interrompere le comunicazioni del traduttore con l’Inghilterra neppure in tempo di guerra. Il passo rispecchia bene l’interesse degli uomini del ‘700 per le imprese di viaggio ed i vantaggi in ogni settore che ne conseguono per l’Europa, anche sotto il profilo delle conoscenze. In particolare l’ampliamento degli orizzonti della storia umana, che è sentito come una ricreazione del mondo, in quanto porta appunto alla luce paesi ed uomini nuovi. Ma, come si è visto, l’accento è posto anche sui vantaggi materiali, perché è indubbio che se « Monsieur le Chancelier » si è occupato dell’impresa aveva lo scopo di suscitare l’interesse dei Francesi per le vicende coloniali ed eventuali investimenti nel settore. Ci troviamo dunque di fronte ad un’opera « ufficiale » e tanto ci basta per non aspettarci decise posizioni di rottura e quindi di condanna delle imprese europee, anzi, il suo scopo è piuttosto apologetico, si presenta come l’epopea della « ricreazione » del mondo da parte degli Europei. Ma non si tratta neppure di un’impresa bassamente commerciale o volgarmente propagandistica: è un lavoro serio, uno sforzo per fare il punto dello scibile in materia di paesi extra-europei, e più generalmente per aggiornare e completare le pagine della storia moderna con capitoli 69 su argomenti inediti o ancora poco conosciuti. Leggiamo infatti nelle primissime pagine dell’opera: « ... le récit de toutes ces découvertes forme une des plus curieuses parties de l’Histoire moderne, par la multitude et la grandeur des événemens (...). D’ailleurs, comme l’arrivée des Européens apporta beaucoup de changemens dans tous les lieux, et parmi tous les Peuples dont ils firent la conquête, les impressions qui se firent de part et d’autre, et les effets qu’elles produisirent, font un autre objet de curiosité qui mérite la plus exacte relation » (I, p. 4). La traduzione di Prévost è fatta sulle dispense che giungono ogni settimana fresche di stampa da Londra, cosicché il piano generale dell’opera e la sua strutturazione gli sono noti soltanto per averli letti nella Prefazione e nell’Introduzione dei compilatori inglesi. Questo lo fa sentire a disagio, ed abbiamo l’impressione che morda il freno e mal si adatti al ruolo di semplice traduttore all’oscuro di tutto: « C’est ici néanmoins que je ne suis pas libre de cacher mes regrets sur la nécessité où je me trouve de suivre pas à pas des compilateurs Etrangers, et de m’assujettir servilement à leur plan. Non que je le condamne... » (I, p. XXXVIII). Cosicché egli sarà molto felice quando potrà annunciare nell’Avertissement dell’VIII volume (ed. in 4°), la cessazione dell’impresa inglese e la possibilità di strutturare la parte seguente dell’opera secondo criteri che gli sembrano più razionali e corretti, anche grazie all’esperienza acquisita e, forse, proprio anche grazie agli errori dei compilatori precedenti. Va detto subito che i risultati non sono sempre al livello di quanto l’autore ci fa sperare. L’Histoire des voyages ha avuto un grandissimo successo (3), come leggiamo anche nell’Avertissement del III volume (IX ed. in 12°); se ne è fatta subito un’edizione in 12° (che è quella da noi consultata) ed è apparsa l’anno seguente un’edizione olandese, « désavouée » dall’autore, ma segno anch’essa dei favori del pubblico (4). L’importanza dell’Histoire des voyages e del ruolo da essa svolto nell’ambito dell’informazione settecentesca è già stato messo ben in evidenza dalla Duchet, la quale attribuisce all’opera di Prévost il merito di aver contribuito a trasformare il gusto dei Francesi ed a sviluppare il loro interesse per questo tipo di letteratura, grazie anche alla larga parte fatta all’attualità: « L’Histoire des voyages a 70 certainement contribué à accélérer une évolution, qui dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, tend à faire des récits de voyages une littérature de consommation courante... » (5). Non sarà dunque senza interesse vedere quale immagine della vita africana e dei popoli neri, in Africa ed in America, è stata trasmessa ai lettori francesi ed europei della seconda metà del ‘700, da un’opera tanto importante e tanto diffusa ed imitata, perché con ogni probabilità questa indagine ci permetterà di avvicinarci, con un’approssimazione abbastanza accettabile, all’immagine tipo che l’uomo del ‘700, di media e buona cultura, non implicato nell’avventura coloniale, si faceva dell’uomo nero, senza aver avuto con lui e con il suo mondo alcun contatto diretto. Questo non deve farci pensare che l’Histoire des voyages presenti dei popoli neri un’immagine generica, banalizzata e soprattutto standardizzata. È vero che dall’insieme della raccolta, al di là delle infinite differenze si può ricomporre, e certamente il lettore del ‘700 ha ricomposto, un’immagine globale dell’uomo nero, ma è anche altrettanto vero che nell’Histoire i singoli gruppi etnici, le tribù, le nazioni, piccole o grandi che siano, sono attentamente descritte e differenziate, attraverso un metodo di comparazione costante, che mette in luce conformità e diversità, là dove il primo sguardo inesperto dell’Europeo vedrebbe forse soltanto uniformità. Dunque, uno degli aspetti più positivi dell’opera, vista nel suo insieme, è questo rispetto delle individualità africane, che è garanzia di obiettività, se non nei risultati, almeno negli intenti. È ovvio che non avendo i compilatori inglesi e neppure Prévost una conoscenza personale dei luoghi e dei popoli descritti, la possibilità di essere obiettivi nei risultati è molto limitata: tutti i loro sforzi sono però andati in questo senso, soprattutto attraverso l’accostamento di fonti, anche contraddittorie, su di uno stesso argomento, al fine di dare al lettore la possibilità, se non di farsi un’idea precisa e personale, almeno di essere guardingo di fronte alle troppo facili generalizzazioni o a grossolane immagini denigratorie. Grazie a questo metodo, il lettore sa che su di un determinato argomento esiste una polifonia o una cacofonia di interpretazioni che è indispensabile conoscere se ci si vuole accostare il più possibile alla vera realtà dei paesi e dei popoli descritti. Dalle pagine dell’Histoire des voyages balza così un’immagine dei popoli africani e del loro ambiente viva, varia e movimentata, in cui i compilatori, se non sono riusciti a scansare completamente il pericolo di inevitabili cristallizzazioni in stereotipie o certe deformazioni dovute all’ottica irrimediabilmente colonialista della maggior parte dei viaggiatori europei in Africa, sono riusciti però a riprodurre un mondo con le sue caratteristiche, le sue peculiarità, i suoi problemi, le sue aspirazioni 71 ed i suoi limiti. Ma soprattutto rivivono davanti ai nostri occhi le cerimonie, le danze, l’insieme dei riti che sono il centro spirituale della vita di questi popoli e ne costituiscono la connotazione culturalmente qualificante, è ciò grazie anche alle qualità dello stile in cui Prévost, che ha amato e conosciuto avventure di ogni tipo, ha reso e ci ha trasmesso questi infiniti aspetti poco noti di una grandiosa avventura dell’umanità. Si tratta indubbiamente di una messa a punto dello scibile settecentesco in campo storico-geografico, per cui giustamente Jean Sgard ha potuto paragonare l’impresa di Prévost all’Encyclopédie (6), e Michèle Duchet, riprendendo il concetto, definire l’Histoire des voyages un « dictionnaire raisonné » delle conoscenze storicogeografiche ed un « tableau » completo dei costumi e delle civiltà (7), ma non bisogna dimenticare il gusto del narratore per il racconto ben fatto, per l’aneddoto evocatore, per la ricreazione di un mondo spesso più affascinante, per il lettore europeo, delle più ricche invenzioni romanzesche (8). Ed è proprio grazie al profondo interesse per gli uomini e le loro passioni che Prévost finisce sempre col valorizzare i suoi personaggi, anche quelli apparentemente negativi, per cui emana dall’insieme dell’opera una visione complessa, variata, ricca e per ciò stesso profondamente umana ed avvincente di tutti i popoli e più particolarmente, nell’ottica che ci interessa, dei popoli neri (9). La superiorità stilistica della traduzione nei confronti del testo originale è incontrovertibile, anche quando, come nella maggior parte dei casi, gli interventi del traduttore sembrano poco consistenti. A questa forza evocativa della parola non si può mancare di aggiungere quella delle numerose illustrazioni che corredano il testo, sia che si tratti di carte geografiche, che collocano in un contesto preciso i fatti narrati, sia che si tratti di riproduzioni di costumi, cerimonie, tipi umani o strutture urbanistiche, che favoriscono l’immedesimazione del lettore europeo con quella realtà che l’opera vuole offrire alla sua conoscenza. Alcune di queste immagini sono straordinariamente eloquenti e trasmettono il quadro di un mondo patriarcale, dove la vita sembra un’oasi di pace e di poesia. Tale è, ad esempio, la riproduzione di una città dei Fulani, dinanzi alla quale si resta come incantati: ha una pianta circolare, e già questo basta a dare una sensazione di sicurezza e di completezza, l’idea di un mondo autosufficiente e perfettamente funzionale. Al centro ci sono le case: quattro file di cilindri con un cono al di sopra, più due cilindri con cono ai lati esterni, fiancheggiate da omini in pose svariate e generalmente con bastoni in mano, il tutto circondato da una palizzata circolare con un solo ingresso. Tra le file di case e la palizzata vi sono i campi di cotone; fuori della palizzata, sul lato destro e disposta a semicerchio vi è una coltivazione di granoturco, sul lato sinistro un grande allevamento di bestiame con 72 animali che brucano o si riposano. Tutto respira la calma e l’armonia ed in noi si fa pressante la tentazione di identificare la città dei Fulani con il mitico Eden o con l’Eldorado, con tutto quanto, insomma, ha balenato dinnanzi ai nostri occhi di perfetto in ciò che concerne la vita dell’uomo e la sua organizzazione sociale. La descrizione della popolazione e dei suoi modi di vita conferma questa impressione positiva (anche se non mancano connotazioni negative, che concernono però soltanto il rapporto con gli estranei ed avidi Europei): « Avec un air assez délicat, ils ne laissent pas d’être bons fermiers, et capables de se procurer d’abondantes moissons de millet, de coton, de tabac, de pois et d’autres légumes, et d’entretenir un grand nombre de bestiaux, dont la plus grande partie sert à leurs propres besoins (...) » (vol. VIII, p. 83). Amano la caccia, ma anche la musica e la danza, le loro donne hanno in genere « l’esprit vif, les manieres douces et polies ». Le loro uniche qualità negative, come si è detto, si manifestano nei confronti dei mercanti europei, che essi non esitano ad ingannare, pur di avere quelle merci che scatenano le loro voglie. Prévost non ne trae nessuna lezione morale, ma l’esempio dei Fulani potrebbe avere il valore di un simbolo: il simbolo di un popolo che si è costruito un mondo semplice ed ordinato, in cui trova tutto quello di cui ha bisogno e nel quale ha modo di esplicare il meglio di sé, fino all’arrivo dell’uomo bianco che lo alletta con cianfrusaglie risplendenti e risveglia le sue potenzialità di « fripon » e di « trompeur ». La presentazione di questo popolo si chiude con la storia del principe Sambaboa, cui il re tenta di strappare il diritto di successione al trono in favore del proprio figlio (ricordiamo che presso molte popolazioni africane l’eredità al trono spetta al figlio della sorella del re). Sambaboa è un eroe bello, onesto e valoroso che non ha nulla da invidiare ai grandi d’Europa: « Il étoit d’une belle figure. Ses inclinations étoient nobles; son caractere doux et libéral, et son courage éprouvé dans la guerre, qu’il entendoit parfaitement » (vol. VIII, p. 88). L’idea che questi uomini possano essere adatti soltanto a fare gli animali da soma degli Europei in America non può in alcun modo sfiorare il lettore che, siamo convinti, è piuttosto propenso a dimenticare questo aspetto della loro odissea per lasciarsi invece trascinare dalle vicende affascinanti della loro vita, sulla loro terra. 73 Non tutte le storie dei popoli neri che si addensano nella collezione di Prévost sono limpide come quella dei Fulani; alcune sono cupe, macabre, grottesche, meschine o crudeli, ma hanno tutte una loro profonda ricchezza umana che, pur nella diversità di costumi, di culture, di esperienze, le riconduce al comune denominatore dell’infinita complessità dell’uomo e delle sue creazioni. Mai, neppure nelle descrizioni di quelle tribù più primitive, rimaste ancorate alla bruta natura, si fa all’uomo, in questa Histoire, l’affronto supremo di confonderlo con gli animali in mezzo ai quali vive, in maniera quasi indifferenziata. L’insieme costituisce un panorama ricco e suggestivo del continente africano, o meglio delle sue zone costiere, perché l’interno resta ancora, per tutto il ‘700, un mondo misterioso in cui si possono collocare popolazioni bianche od uomini con la coda (10). Dopo aver messo in rilievo l’importanza che viene data all’esatta descrizione dei luoghi e dei popoli e alle loro specificità, in rapporto alle popolazioni vicine, possiamo tentare di vedere se il quadro d’insieme ne risulta negativo o positivo. Questa sintesi è tanto più indispensabile se si pensa che l’immagine dei popoli neri veicolata dagli schiavisti era quasi sempre monolitica e tutta al negativo, per cui si sente la necessità di metterla a confronto con un’immagine globale che ne costituisca, almeno in parte, il correttivo. Tentiamo di ricostruire quest’immagine che si viene delineando attraverso i volumi dell’Histoire, nella sua globalità, partendo cioè dal fisico per giungere al morale. Il procedimento non sembri ozioso: ad una troppo insistita descrizione della bruttezza fisica corrisponde quasi inevitabilmente, nelle relazioni dei viaggiatori, una valutazione negativa sul piano morale, quasicché l’una fosse la premessa dell’altra. E lo è di fatto, in quanto il descrivere uomini diversi da sé unicamente come brutti, o peggio ancora repellenti, è il sintomo inequivocabile di una incomprensione della diversità che investe inevitabilmente anche la sfera spirituale. Ora, l’immagine complessiva dei popoli neri che si può ricavare dall’opera ci sembra si collochi ad equa distanza dal travisamento denigratorio come dall’apologia acritica (del resto praticamente inesistente in questo periodo in cui non è ancora nata una letteratura negrofila). Si parla spesso di una bella corporatura, di un bel colore, tanto più bello quanto più è scuro, di denti bianchissimi, ma soprattutto, a più riprese, quasi un ritornello che percorre l’opera, della « peau douce » degli uomini neri, e più particolarmente delle donne, sul cui fascino veniamo spesso intrattenuti (l1). Per dare un esempio concreto di questi ritratti fisici, prendiamo a caso la descrizione di una qualsiasi delle popolazioni africane; si tratta di uno dei gruppi etnici della Costa d’Oro. La descrizione è dovuta alla penna di Barbot, che a giudizio dei compilatori dell’Histoire, è lo scrittore a cui si deve la relazione più completa riguardante questa 74 parte dell’Africa. Il ritratto è interessante perché mostra come nel tracciare l’immagine di un popolo africano si abbiano sempre presenti due punti di riferimento obbligati, espliciti o sottintesi: l’uomo bianco da un lato, che costituisce il modello, anche se inconfessato, e l’uomo nero fortemente connotato dall’altro. La maggiore o minore distanza dall’uno all’altro polo è un dato importante nella valutazione della bellezza, eccezion fatta per il colore, che gioca a favore quanto più è scuro, soprattutto negli uomini. Il ritratto sembra però tracciato con la preoccupazione della massima obiettività ed è, nel suo complesso, lusinghiero, soprattutto per quell’evocazione della pelle « douce et unie » che, legata all’idea dell’estrema pulizia, dà la sensazione di un fisico gradevole ed attraente: « Les Négres de la Côte d’Or sont généralement d’une taille moyenne et bien proportionnés dans leur forme. Ils ont le visage ovale, les yeux étincellans, les oreilles petites et les sourcils épais. Leur bouche n’est pas trop large, leurs dents sont blanches et bien rangées, leurs lèvres fraîches et vermeilles, sans être aussi épaisses que celles des Négres d’Angola; et le nez moins plat aussi que dans la plupart des régions de l’Afrique (...). Leur peau, sans être parfaitement noire est douce et unie (...). Ils se lavent fort soigneusement tout le corps, matin et soir, et l’oignent d’huile de palmier » (vol. XIII, p. 281-86) (12). Persino gli Ottentotti, sovente descritti come creature brutte ed animalesche, a causa delle quali sembrava del tutto lecito fissare per l’uomo nero, nella scala degli esseri, un posto intermedio fra il bianco e la scimmia, sono trattati qui senza nessun accento denigratorio, anzi, direi che il ritratto è nel complesso piuttosto positivo: « Les deux sexes sont bien proportionnés dans leur taille. Ils ressemblent aux Négres par la grandeur des yeux, la platitude du nez et l’épaisseur des lévres; avec cette différence qu’on emploie l’art pour leur aplatir le nez dans l’enfance (...). On voit fort peu de Hottentots tortus et difformes. Ils sont robustes, agiles, et d’une légereté surprenante. Un cavalier bien monté suit à peine le pas d’un hottentot » (vol. XVIII, pp. 3-4). Da questa loro agilità nella corsa, che è qui rappresentata come una qualità, si arrivava (e si arriverà) sovente negli scritti schiavisti o in quelli di viaggiatori implicati nel commercio coloniale, alla conclusione che la natura degli Ottentotti era più animalesca che umana (13). Alla correzione dell’immagine fisica, come già si è detto, si accompagna quasi sempre anche una correzione del ritratto spirituale di un popolo e, sovente, come in questo caso, la volontà di raddrizzare una verità distorta è 75 espressa in maniera precisa. E si tratta di una reintegrazione della verità che va sempre a vantaggio dei popoli descritti, i quali si presentano così nell’Histoire come un credibile impasto di brutto e di bello, di bene e di male; anche quei popoli che erano stati, e saranno ancora in seguito, descritti come irrimediabilmente brutti, viziosi e idioti. Così, a proposito degli Ottentotti, terminata la descrizione fisica, leggiamo: « A l’égard des qualités de leur esprit, quoiqu’ils ayent été représentés par quelques Ecrivains comme une race d’hommes livrés à toutes sortes de vices, des Ecrivains moins anciens et mieux informés nous assurent que ce reproche est une exagération, si ce n’est tout-à-fait une calomnie » (vol. XVIII, pp. 4-5) (il corsivo è nostro). Segue la descrizione di una serie di difetti e di vizi, il più tipico dei quali è la paresse, ma poi interviene subito il correttivo dell’altra faccia della medaglia, ed è una faccia così riccamente istoriata da far pensare ad un conio fatto in occasione di un premio di bontà: « Au reste leurs vertus sont la partie la plus distinguée de leur caractere; surtout la bienveillance, l’amitié, l’hospitalité. Les Hottentots ne respirent que la bonté et l’envie de s’obliger mutuellement. Ils en cherchent continuellement l’occasion. Un autre implore-t-il assistance? Ils courent pour l’accorder. Leur demande-t-on leur avis? Ils le donnent sincèrement. Voient-ils quelqu’un dans le besoin? Ils se retranchent tout pour le secourir. Un plaisir des plus sensibles pour les Hottentots est celui de donner. A l’égard de l’hospitalité, ils étendent cette vertu aux Européens étrangers. En voyageant autour du Cap, on est sûr d’un accueil ouvert et caressant dans tous les villages où l’on se présente. Enfin, la bonté des Hottentots, leur intégrité, leur amour pour la justice et leur chasteté, sont des vertus que peu de Nations possèdent au même degré. Une simplicité charmante accompagne toutes leurs actions. On en voit beaucoup qui refusent d’embrasser le Christianisme par la seule raison qu’ils voient régner parmi les Chrétiens l’avarice, l’envie, l’injustice et la luxure» (Ib., pp. 7-8). 76 Ci sembra valesse la pena di non operare tagli: in mezzo a tante descrizioni assai poco lusinghiere degli Ottentotti, ci sarebbe sembrato arbitrario accorciare l’elenco delle loro virtù. E soprattutto non abbiamo ritenuto opportuno eliminare la conclusione che dà al brano il suo significato più pieno. Intanto facciamo rilevare come anche questo ritratto si muova fra i due poli a cui si è precedentemente fatto riferimento: la descrizione fisica inizia con un confronto con i « nègres », la caratterizzazione spirituale si chiude con un confronto con i bianchi e nel caso specifico con coloro che dovrebbero rappresentare il « meglio » dei bianchi, cioè i cristiani. Nel rifiuto da parte degli Ottentotti del cristianesimo, sentito, almeno sulla base degli esempi che hanno davanti agli occhi (14), come una fonte di corruzione, è racchiuso un giudizio fortemente negativo nei confronti dei bianchi e di qualsiasi rapporto possa essere stabilito con essi. All’immagine animalesca dell’Ottentotto si contrappone qui non soltanto il ritratto di un popolo dotato come tutti di pregi e di difetti, ma addirittura, senza alcuna intenzione apologetica, lo si fa uscire, almeno sotto il profilo morale, vittorioso da un confronto con l’Europeo, di cui viene rifiutato l’esempio corruttore. Il caso degli Ottentotti potrebbe dunque essere considerato esemplare dell’ottica adottata dai compilatori dell’Histoire des voyages e da Prévost, che si sforzano davvero di dare maggior credito alle fonti che essi ritengono meglio informate e perciò più attendibili (15) ed in ogni caso di valutare con metro nuovo le realtà così diverse di cui si fanno i divulgatori presso i lettori europei. La volontà di spiegare il perché di certi comportamenti o di certe abitudini, anche apparentemente aberranti, rivoltanti o assurde se giudicate unicamente secondo canoni eurocentrici, è costantemente presente e porta, in molti casi, se non a giustificare, almeno a capire, e a volte persino a riconoscere che certi costumi sono un prodotto inevitabile dell’ambiente o il frutto di una grande saggezza. Così, ad esempio, per continuare il discorso degli Ottentotti, l’Histoire cerca di spiegare con gli ardori del clima certe abitudini che li rendono quasi inavvicinabli, quali l’uso di una specie di mastice con cui si impiastricciano i capelli, che finisce col creare sul loro capo un cumulo di sporcizia della foggia di un berretto, o l’impiego di un grasso, spesso rancido ed assai fetido, con cui si ungono il corpo anche più volte al giorno: in un’ottica diversa si sarebbe insistito sulla sporcizia di questo popolo, mentre nell’Histoire non vi è nulla di tutto questo, anzi come si è detto si cerca di trovare una spiegazione plausibile a questa quotidiana immersione nel « fango ». Per contro non si fa nessuno sforzo per capire quale sia il significato di una loro festa che può, a tutta prima sconcertare od irritare, ma che non manca di una sua logica anche abbastanza scoperta, tanto che ci stupisce non si sia almeno cercato di individuarla: si tratta della « cerimonia di 77 affrancamento » del giovane dalla famiglia: « Après la cérémonie qui constitue les Hottentots dans la qualité d’hommes, ils peuvent sans scandale maltraiter leurs peres et leurs meres. C’est un honneur pour eux de ne pas les menager; et loin de s’en plaindre, les femmes approuvent elles-mêmes cette insolence. Si l’on entreprend de faire sentir aux anciens l’absurdité d’une si odieuse pratique, ils croient résoudre la difficulté en répondant que c’est l’usage » (vol. XVIII, p. 6). La cerimonia ci sembra un simbolo efficacissimo della difficoltà e nello stesso tempo della necessità del distacco del giovane dalla famiglia, distacco che non può perciò avvenire senza urti e ribellioni, come ben indicano le offese recate ai genitori nel giorno in cui esce dalla loro tutela per essere dichiarato « uomo ». Al contrario, tutto il paragrafo dedicato al « Serpent de Juida et son culte » è la presentazione di un culto africano, fatta con grande vivacità e simpatia. Si danno spiegazioni più o meno mitologiche sull’origine del culto stesso (l’animale avrebbe salvato il popolo in occasione di una guerra) o utilitaristiche (avendo una grande « antipathie » per i serpenti velenosi, li distrugge ovunque li incontra). In entrambi i casi è dunque considerato come una valida difesa contro la morte, per cui non risulta più così assurda la sua divinizzazione. E del resto questi serpenti sono così « belli e dolci », che verrebbe voglia di adorarli per questa sola ragione: « Cette espece a la tête grosse et ronde, les yeux beaux et fort ouverts, la langue courte et pointue comme un dard, le mouvement d’une grande lenteur, excepté lorsqu’elle attaque un serpent vénimeux. Elle a la queue petite et pointue, la peau fort belle. Le fond de la couleur est un blanc sale, avec un mélange agréable de raies et de taches jaunes, bleues et brunes. Ces serpents sont d’une douceur surprenante » (vol. XIV, p. 365) (16). È davvero una descrizione degna di un dio! Nessun atteggiamento di commiserazione, disprezzo o, quanto meno, sufficienza da parte dei compilatori nei confronti di questo culto, che sarebbe potuto trasformarsi in un’arma denigratoria di facile impiego. Un atteggiamento analogo, ricordiamo, era stato adottato anche da Labat. La descrizione di riti, cerimonie, feste, culti è ricca, precisa e minuziosa nel corso della raccolta, cosicché un mondo rinasce di fronte ai nostri occhi in ciò che ha di più 78 peculiare e prezioso: la sua eticità, il suo rapporto con il mistero, la sua visione della sopravvivenza dopo la morte terrena. L’opera mette anche bene in evidenza gli strappi prodotti in questa compagine spirituale dall’arrivo dei bianchi, con le loro « meraviglie », il luccichio delle loro navi, delle loro armi, delle loro perline di vetro, con l’orgia colorata delle loro stoffe e con il fuoco delle loro bevande, cianfrusaglie abbacinanti per chi non le aveva mai viste. Non c’è da stupirsi se, sotto la spinta di tanta apparente ricchezza, anche le fedi mutano e se certune di queste popolazioni sono condotte a farsi un’immagine manichea del mondo, nella quale al loro dio spetta il regno delle tenebre: « A diverses questions que le même voyageur (Artus) leur fit sur la nature de Dieu, ils répondirent qu’il étoit noir et méchant, qu’il prenoit plaisir à leur causer mille sortes de tourmens au lieu que celui des Européens étoit un Dieu très-bon, puisqu’il les traitoit comme ses enfans » (vol. XIII, p. 460). Si sentono meno ben trattati degli Europei che considerano, almeno nel primo periodo del loro incontro, come i felici possessori di beni e di abilità di cui non sono stati gratificati dal loro dio. Nasce quindi l’idea che quella dei bianchi sia una situazione privilegiata rispetto alla loro, e privilegiata a tal punto da dar luogo, presso alcune popolazioni africane persino ad una nuova, significativa concezione del « paradiso » che si identifica infatti con una metamorfosi da nero a bianco: « Ils (gli abitanti del Capo Verde) prétendent que leurs morts deviennent bientôt blancs, et font ensuite le commerce comme les Européens » (vol. IX, p. 385). Se è vero che nel paradiso trasferiamo tutto quanto avremmo voluto ed era impossibile avere in vita, il comportamento di queste popolazioni rientra perfettamente nella regola. Accanto all’evocazione delle feste o all’attenta analisi delle varie forme di culto, con scrupolosa enunciazione delle ipotesi avanzate dai diversi viaggiatori nel tentativo di spiegarne l’origine, ci sono dettagliate descrizioni delle cerimonie di corte o fra personaggi d’alto rango che, talvolta, non sono indegne delle più raffinate corti europee. E non sono certo meno complicate e rigorose, con abbondante dispendio di 79 mezzi, tempo ed energie: « Un Ambassadeur de quelque Prince voisin s’arrête sur la frontiére, pour faire porter à la Cour la premiere nouvelle de son arrivée. On lui dépêche un Officier, qui l’amene dans un Village voisin de la Cour, où il attend que les préparatifs soient faits pour l’audience. Le jour marqué, il est conduit par un grand nombre d’Officiers et de Gardes, revêtus de leurs plus beaux habits, l’arc en main et le carquois sur l’épaule. Cette marche se fait au bruit d’instruments, avec des danses et des sauts continuels. En arrivant près du Palais, l’Ambassadeur est reçu entre deux lignes de Quojas (è il nome della popolazione) armés, au long desquelles il pénetre jusqu’à la salle du conseil » (vol. XII, p. 373). Non sono scene da Mille e una notte, ma è certo che nel corso dell’Histoire passano davanti ai nostri occhi infinite storie avvincenti come le pagine di un romanzo. Il fiore più bello di questo ricco e variegato giardino selvaggio è Job Ben Solomon, dotato di un’intelligenza e di una saggezza che hanno suscitato il rispetto e l’ammirazione di colti lords inglesi. La sua storia è arcinota: è raccontata con poche varianti in molte relazioni di viaggio settecentesche ed è quasi impossibile non incontrare il suo nome anche nei più recenti studi sulla tratta e la schiavitù, tanto esemplare è la sua vicenda e luminoso il simbolo della sua figura. Job era figlio del capo di una città dei Fulani, la città di Bunda, fondata dal nonno e divenuta prospera anche grazie ad una legge che vietava la schiavitù dei maomettani e dichiarava libero qualsiasi seguace di questa religione vi avesse cercato rifugio. I seguaci di religioni diverse potevano invece, come negli altri stati africani, essere fatti schiavi, ed è appunto mentre si reca a vendere degli schiavi sulle rive del Gambia che il giovane Job è, a sua volta, preso ed imbarcato su una nave negriera. Giunto nel Maryland fu venduto come schiavo, fuggì dalla piantagione, ma fu ripreso ed imprigionato. Per sua fortuna fu visitato in prigione dal viaggiatore inglese Bluet (o Bluett) che, stupito della sua intelligenza e della sua cultura, tornato a Londra, si recò da James Oglethorpe, allora funzionario della Compagnia Reale Aficana, per mostrargli una lettera scritta da Job al padre, in lingua araba. Fu fatta tradurre ad Oxford, dopodiché Oglethorpe, entusiasta, pagò il riscatto del giovane schiavo e lo fece trasportare a Londra, dove però non poté aspettare il suo arrivo, dovendo partire per un viaggio. Job vi giunse nel 1733 e vi ebbe ottima accoglienza: fu ricevuto a corte e trovò un protettore influente nel duca di Montague, che lo invitò spesso nella sua casa di 80 campagna. Restò a Londra quattordici mesi, poi chiese ed ottenne di ritornare in patria, dove il suo arrivo destò grande scalpore: era la prima volta che un uomo, partito come schiavo su di una nave negriera, faceva ritorno ed era anche la prova che i bianchi non venivano a comperare schiavi per mangiarli, come si sussurrava con terrore fra le popolazioni africane. Durante il soggiorno a Londra dettò a Bluet le sue memorie, che apparvero nel 1734. La descrizione di Job, riportata nell’Histoire, è dunque dovuta alla penna di Bluet, ma è confermata da Francis Moore che accompagnò il giovane, dopo il suo ritorno, lungo le rive del Gambia. La citiamo quasi per intero, per non togliere nulla al quadro delle qualità e prodezze del nostro eroe, ed anche per dare al lettore di oggi un’idea più precisa del come i lettori dell’Histoire vennero resi edotti dell’esistenza di un tal « prodigio »: « Les qualités naturelles étoient excellentes. Il avoit le jugement solide, la mémoire facile et beaucoup de netteté dans toutes ses idées (...). Tous ses discours portoient le caractere du bon sens, de la bonne foi, et d’un amour ardent pour la vérité, avec un désir passionné de la trouver. Sa pénétration se fit remarquer dans une infinité d’occasions. Il concevoit sans peine le méchanisme des instruments. Après lui avoir fait voir une pendule et une charrue, on lui en montra les pieces séparées, qu’il réjoignit lui-même sans le secours de personne. Sa mémoire étoit si extraordinaire, qu’ayant appris l’Alkoran par cœur à quinze ans il en fit trois copies de sa main en Angleterre, sans autre modele que celui qu’il portoit dans sa tête, et sans se servir même de la premiere copie pour faire les deux autres (...). Son humeur étoit un heureux mélange de gravité et d’enjouement, une douceur constante, raisonnée d’un degré convenable de vivacité, et cette sorte de compassion générale qui rend le coeur sensible à tout (...). Cependant ses inclinations douces et religieuses n’excluoient pas le courage... » (vol. IX, pp. 339-340) (17). Insomma, l’Histoire, almeno nei volumi dedicati all’Africa (perché il discorso è diverso quando si tratterà delle Antille), si fa veicolo di storie di popoli e di uomini i cui caratteri, le cui vicende ed i cui sistemi di vita hanno potuto, talvolta, essere utilizzati per scusare il comportamento europeo e dunque la tratta e la schiavitù, ma che, nella maggior parte dei casi, si leggono come le pagine di una complessa e varia storia generale dell’umanità, bella ed interessante anche nelle sue componenti più 81 nuove ed apparentemente meno significative. In questo panorama ampio e documentato non mancano neppure gli elementi per concorrere alla composizione di una storia della condizione femminile o della donna in senso lato che qui, come altrove, è quasi sempre il gradino più basso della scala sociale, pur essendo dotata, come fanno rilevare molti viaggiatori, non soltanto di bellezza, ma anche di maggiore « esprit » degli uomini. Varrebbe la pena di dedicare a questo aspetto così importante della vita africana, vista attraverso l’Histoire, uno spazio ben più ampio, di ricostruire la storia di queste donne che preparano il pranzo per i loro mariti, per poi mangiare i resti in cucina (vol. IX, p. 384), o vendono se stesse per riscattarsi dalla dipendenza paterna ed avere la possibilità di « comperarsi » un marito di loro gradimento (XII, p. 311): ci basti rilevare che anche la loro vicenda è seguita con attenzione e contribuisce in maniera rilevante al fascino e alla completezza di questa storia (‘s). Come è già stato rilevato, abbiamo cercato di cogliere il tono generale del testo e la volontà di obiettività che si riscontra anche nell’accostamento di giudizi e relazioni nettamente antitetiche, e abbiamo posto l’accento su quegli aspetti dell’opera che rivelano rispetto e simpatia per l’uomo, quale che sia il suo colore ed il suo grado di civiltà, ma non mancano ovviamente anche gli abituali ingredienti dell’ottica schiavista o dell’eurocentrismo prevaricatore: se ne potrebbe fare una ricca antologia falsando però, ci sembra, l’atmosfera dell’opera. Bisogna comunque tener presente che anche questi aspetti esistono, per non stupirsi dell’atteggiamento assunto nella raccolta di fronte alla tratta ed alla schiavitù coloniale (qui però il discorso di Prévost si separa nettamente da quello dei compilatori inglesi). Arriviamo così al problema che abbiamo volutamente lasciato da parte fino a questo momento, per non prestare attenzione che alla ricostruzione di un mondo considerato indipendentemente, o quasi, dall’impatto con i bianchi; ora invece è proprio di questo impatto che vogliamo interessarci e della tragedia che ne è nata, fra i cui aspetti non minori, come si è detto, bisogna registrare lo stravolgimento di abitudini, valori, fedi, insomma di interi sistemi di vita. Il fatto che i viaggiatori settecenteschi si trovino comunemente d’accordo nel riconoscere che, almeno secondo i canoni morali europei, i maggiori vizi delle popolazioni africane si riscontrano fra gli abitanti delle coste e in particolare nei loro rapporti con i bianchi, ci sembra sia abbastanza significativo. Come pure il fatto che la descrizione forse più cruda dell’Histoire concerne i mulatti che vivono in Africa, il prodotto più sradicato, corrotto e corruttibile di un incontro che non fu felice (19). Come viene registrato il fenomeno della tratta nei volumi dell’Histoire dedicati all’Africa? Intanto bisogna subito dire che gli è riservato uno spazio di trattazione specifica irrisorio: una ventina di pagine dell’edizione in 12°, tratte da un unico 82 autore, Snelgrave, buona parte delle quali è poi dedicata ad un aspetto particolare del fenomeno, che è quello della rivolta sulle navi negriere. Si potrebbe quasi dire che l’argomento sia ritenuto secondario. In varie altre parti dei volumi dedicati all’Africa sono numerosi i riferimenti alla tratta e alla schiavitù, ma sono tutti piuttosto sbrigativi ed asettici, come se si parlasse di cosa ovvia, ma non particolarmente interessante. Ma forse la parola « asettici » non è esatta, perché il contesto spesso sembra scusare o rendere meno condannabile il commercio degli Europei, con l’insistenza sul fatto che sono gli Africani stessi che si vendono fra loro. Espressamente la tratta non è giustificata né condannata, almeno nel testo di Prévost, che a questo proposito ci riserva infatti una grossa sorpresa. Confrontando la traduzione francese con l’originale scopriamo che Prévost è stato fedelissimo tranne che in un punto: ha eliminato le note e si dà il caso che queste note smontassero ad una ad una le giustificazioni di Snelgrave a favore della tratta. Ci si può chiedere perché i compilatori inglesi abbiano scelto un testo favorevole alla tratta se erano su posizioni diverse. Non si può dare una risposta sicura, ma è certo che non era facile trovare all’epoca relazioni di viaggio in cui la tratta fosse condannata in maniera decisa, e del resto una scelta di questo tipo è una garanzia della volontà di obiettività dei compilatori, che volevano fare della raccolta uno specchio fedele delle relazioni di viaggio, senza rinunciare completamente alle loro opinioni. Il loro atteggiamento negativo nei confronti della tratta spiega forse anche il fatto che le abbiano riservato uno spazio così ristretto, ed abbiano preferibilmente parlato di rivolte (che sono una forma di contestazione da parte delle stesse vittime), per non essere costretti a prendere posizioni più impegnative di quelle che potevano essere scaricate in brevissime note. In ogni caso, Prévost ha pensato bene di eliminarle. Sia chiaro, non è la prima volta che interviene sui testi e, in particolare, che sopprime delle note, ma di questa soppressione ha dato giustificazioni che non sembrano convenire al caso in questione. Rispondendo infatti agli editori olandesi, che lo avevano appunto accusato di intervenire sui testi con tagli arbitrari, in particolare per quanto concerneva le note, egli sostiene che l’accusa non ha alcun fondamento in quanto ha lasciato cadere soltanto note ritenute inutili o tali che « les honnêtes gens auraient trouvé choquantes » (vol. IX, p. IV). Ora, siccome non ci sembra che le note di cui si parla rientrino nella seconda categoria, dobbiamo ritenere che, nel migliore dei casi, Prévost le abbia ritenute inutili. Sarebbe il segno di una grande leggerezza di fronte ad un problema che non aveva ancora scosso in profondità le coscienze degli uomini del ‘700, ma che già si poneva a coloro che si trovavano ad affrontare o soltanto a sfiorare l’argomento, come ben indica l’intervento dei compilatori inglesi e come indicano, 83 del resto, tutte le relazioni di viaggiatori che, anche se appoggiano la tratta e la schiavitù, ritengono necessario dare delle spiegazioni. Un’ipotesi di questo tipo, e cioè che Prévost non avesse idee ben chiare sull’argomento e forse se ne interessasse scarsamente non è del tutto improbabile e potrebbe trovare conferma nel modo in cui ha affrontato, in maniera più specifica, il problema della schiavitù, parlando di San Domingo, come vedremo in seguito. Ma altre ipotesi sono possibili: Prévost stava curando l’edizione di una raccolta di viaggi per incarico ufficiale, al fine di incrementare gli investimenti di beni e di uomini nel settore coloniale, e può quindi aver lasciato cadere quelle note, ben consapevole della loro importanza, per non incappare nei rigori della censura o semplicemente nei rimproveri del suo « datore di lavoro ». Al limite, potremmo anche pensare che la soppressione gli sia stata imposta, sappiamo infatti che il cancelliere d’Aguesseau controllava da vicino la traduzione, o al contrario, che Prévost l’abbia decisa spontaneamente semplicemente perché, senza spuntare una lancia in favore della tratta e della schiavitù, non era neppure favorevole alla sua abolizione. La posizione di Prévost non è facile da enucleare, ma, in ultima analisi, siamo propensi a pensare che l’ambiguità nasca dall’assenza di una linea definita che lo portava a manipolare testi scottanti, evitando il più possibile di bruciarsi le dita. La lettura del volume dedicato a San Domingo, il più importante nella prospettiva della nostra ricerca, non soltanto perché il problema della schiavitù vi è affrontato direttamente ed in maniera piuttosto ampia ma anche perché, essendo da tempo cessata la pubblicazione inglese (20), ci troviamo infine di fronte alle scelte di Prévost, non sembra infatti autorizzarci ad una definizione più precisa. In realtà il volume è una grossa delusione: Prévost ha imparato così bene il mestiere di compilatore, che riesce a restare quasi totalmente assente dalla sua opera (21). Inoltre il lavoro di compilazione è frettoloso ed i giudizi più disparati vengono accostati, senza tener conto dell’insieme o liquidando il problema con l’affermazione che « il n’est pas aisé d’accorder toutes ces contrariétés » (LIX, p. 160). Si tratta della cucitura di brani tratti da Labat e da Charlevoix: la parte dedicata alla popolazione nera dell’isola, e quindi direttamente o indirettamente alla schiavitù, è piuttosto ampia, ma non va oltre le posizioni dei due missionari, anzi, direi che nei tagli operati sui testi originali e nella fusione di ottiche diverse si ha l’impressione di un peggioramento del quadro d’insieme. I pochi interventi di Prévost non migliorano certo la situazione: citiamo l’esempio più infelice (o più ottuso?) che è anche la conclusione del paragrafo dedicato all’argomento. Dopo aver riportato due aneddoti tratti da Labat a proposito degli espedienti usati dai coloni per evitare il suicidio e soprattutto il suicidio in massa, dei loro schiavi (22), Prévost conclude con 84 un’osservazione di Labat a cui ne aggiunge una sua personale: « Le P. Labat, qu’on donne pour garant de ces deux faits, ajoute que si ces remedes paroissent bizarres, ils ne laissent d’être proportionnés à la porté d’esprit des Negres, et de convenir à leurs préventions: mais de quantité d’autres exemples, qui prouvent leur dégradation au dessous de l’espece humaine, et qui semblent justifier par conséquent la rigueur avec laquelle on les traite, il n’y en a point de plus étrange que la disposition ou le même voïageur les représente, à l’égard du Christianisme qu’ils paroissent embrasser » (LIX, pp. 192-193) (23). Il comportamento in questione, si dice in una nota, consiste nel fatto che i neri abbandonano il Cristianesimo appena non si vedono più costretti a professarlo: lo schiavo nero è quindi giudicato al di sotto della specie umana soltanto perché rifiuta una fede posticcia che gli è stata più o meno imposta (se non altro con coercizioni di tipo psicologico). Per questa stessa ragione non sembra neppure fuori luogo la durezza con cui viene trattato, quella stessa durezza fatta oggetto, all’inizio del paragrafo di una condanna così categorica che la prima, brevissima, impressione era quella di trovarsi di fronte ad un testo antischiavista. Vale la pena di citare questo inizio nettamente antitetico rispetto alla conclusione, sia per dimostrare la non infondatezza del nostro giudizio sulla posizione scarsamente impegnata (in un senso o nell’altro, ci sembra) di Prévost, sia perché, tutto sommato, data la diffusione dell’opera, quali che siano i suoi limiti, una denuncia della condizione dello schiavo nelle colonie era, in ogni caso, un fatto importante e suscettibile di non restare senza eco. Anche se si tratta di una denuncia in cui affiorano punte di disprezzo, nella crudezza dei termini usati per qualificare la condizione di questi uomini o di incomprensione totale nel riconoscimento delle loro possibilità, come indica la conclusione del brano che citiamo: « A l’égard des Negres, on convient qu’ici comme dans les autres Iles, rien n’est plus misérable que leur condition. Il semble que ce Peuple soit le rebut de la Nature, l’opprobre des Hommes, et qu’il ne differe guere des plus vils Animaux. Sa condition du moins, ne le distingue pas des Bêtes de charge. Quelques coquillages sont toute sa nourriture: ses habits sont de mauvais haillons qui ne le garantissent ni de la chaleur du jour, ni de la trop grande fraîcheur des nuits (...). Ses maisons ressemblent à des Tanieres d’Ours, ses lits sont des claies plus 85 propres à briser le corps qu’à procurer du repos, ses meubles consistent en quelques Calebasses, et quelques petits plats de bois ou de terre. Son travail est presque continuel; son sommeil fort court. Nul salaire. Vingt coups de fouet pour la moindre faute. C’est à ce fatal état qu’on a su réduire des Hommes qui ne manquent point de raison pour comprendre qu’ils sont nécessaires à ceux qui les traitent si mal » (vol. LIX, pp. 156-157). È un uso davvero limitato della loro ragione, ma del resto cos’altro potrebbero mai farne se veniamo informati subito dopo che, nonostante questa terribile condizione, godono di ottima salute e che, possedendo perciò il più grande dei beni, hanno tutto, dal momento che « leur caractere les rend insensibles à la privation des autres »? Dopodiché veniamo anche informati sulla triste condizione del padrone che deve adattarsi a servizi che « la crainte seule arrache » e a gesti di rispetto « auxquels le cœur n’a jamais de part », insomma a sopportare questo « mal nécessaire » per il quale non si conoscono rimedi: « Malheureux, dit le P. Charlevoix, celui qui a beaucoup d’esclaves, c’est la matiere de bien des inquiétudes, et une continuelle occasion de patience: malheureux qui n’en a point du tout; il ne peut absolument rien faire: malheureux qui en a peu, il faut qu’il souffre tout de peur de les perdre et tout son bien avec eux » (Ib., p. 158). Mentre poco oltre ci si dice con estrema freddezza e mettendo tutto su un piano di crudo profitto: « On a vu à Saint-Domingue, des negres de Monomotapa et de l’Ile de Madagascar; mais leurs Maîtres en ont tiré peu de profit. Les premiers périssent d’abord, et les seconds sont presque indomptables » (Ib., p. 159). Nella descrizione dei costumi e della vita « privata » degli schiavi delle Antille, Prévost riproduce con tagli o sintesi il testo di Labat e così ritroviamo nell’Histoire quasi tutti gli aneddoti che avevamo citato a proposito di quest’ultimo, forse a volte 86 soltanto un po’ meno coloriti o vivaci, per cui risultano inevitabilmente più spenti anche i protaganìsti delle vicende. In ogni caso sono ben lungi dall’apparirci come il « rebut de la nature », ed hanno invece le qualità degli uomini forti, coraggiosi o saggi. Per contro non mancano gli abituali richiami alle conseguenze di una maledizione divina, a cui la stessa tradizione africana farebbe riferimento, e neppure le consuete valutazioni non più in base ai meriti personali degli uomini e dei popoli, come era accaduto nei volumi dedicati all’Africa, ma soltanto in base alle prestazioni servili che se ne possono ricavare: « Ces Misérables avouent, dit-on, qu’ils se regardent eux-mêmes comme une Nation maudite. Les plus spirituels, qui sont ceux du Sénégal, racontent, dit-on, sur une ancienne tradition dont ils ne connoissent pas l’origine, que ce malheur leur vient du péché de leur premier Pere, qu’ils nomment Tam (!). Ils sont les mieux faits de tous les Negres, les plus aisés à discipliner, et les plus propres au service domestique... » (Ib., p. 58). Giunti al termine del nostro esame possiamo tentare di formulare un’ipotesi sul ruolo svolto dall’Histoire nella vicenda coloniale. È probabile che abbia assolto al compito che ufficialmente le era stato assegnato di incrementare l’interesse e gli investimenti nel commercio coloniale, una voce importante del quale erano appunto gli schiavi; per un verso quindi, non prendendo alcuna posizione contro la tratta e la schiavitù, può aver contribuito ad incrementarle: è il risultato più probabile a breve termine, se pur la tratta e la schiavitù, che stavano arrivando in quegli anni forse al loro periodo di maggior floridezza, prima di iniziare il declino, avevano bisogno di aiuti dall’esterno. Per altro verso l’Histoire ha svolto una funzione di primo piano nell’ambito dell’informazione, sia per l’ampiezza del materiale raccolto, sia per la diffusione dell’opera, sia infine per il metodo di compilazione adottato, tanto criticato dallo stesso Prévost per le inevitabili ripetizioni che comportava, ma tanto utile per le contraddizioni che metteva in luce, accostando relazioni diverse su di uno stesso argomento. Per quanto concerne più particolarmente i popoli neri, pur non superando le abituali chiusure quando essi sono visti unicamente in rapporto alla schiavitù, i cui aspetti disumani vengono però condannati, l’immagine globale che se ne ricava è ricca, vitale e nel complesso positiva, per cui non ci sembra arbitrario concludere che, a lungo termine, l’Histoire ha potuto svolgere un suo ruolo nella campagna antischiavista. 87 Resta da ribadire l’influenza esercitata in questo campo dall’Inghilterra che è, per quasi tutto il ‘700, su posizioni più avanzate rispetto alla Francia nella lotta antischiavista, come si è potuto rilevare anche nella presente raccolta, sia tenendo conto degli interventi del traduttore, sia considerando la relativa « arretratezza » nei confronti del problema di quei volumi che sono unicamente dovuti alla penna di Prévost, al quale va in ogni caso il merito di avere fatto, in più occasioni, da divulgatore (anche se non sempre fedelissimo) di un’immagine più positiva dei popoli africani, che andava faticosamente elaborandosi in Inghilterra fin dalla prima metà del Settecento. Note (1) Prévost, Histoire générale des voyages ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre, qui ont été publiées jusqu’à présent dans les différentes langues de toutes les nations connues, ecc., Parigi, Didot, 1746-1759, 16 voll. in 4° e 64 voll. in 12°. Quest’ultima è l’edizione da noi consultata, ad eccezione dei volumi dedicati alle Antille, che abbiamo consultato in un’edizione, sempre in 12°, iniziata tre anni più tardi, dalla veuve Didot. La raccolta ha una suite dovuta a Meusnier de Querlon, Rousselot de Surgy ed altri, che porta a 20 voll. l’edizione in 4° e ad 80 voll. l’edizione in 12°. (2) Il titolo originale della raccolta, più nota dal nome dell’editore, come « Collezione Astley », è il seguente: A new general Collection of Voyages and Travels: consisting of the most esteemed Relations, wich have been hither to published in any Language: comprehending every Thing remarkable in its Kind, in Europe, Asia, Africa, and America, ecc., Londra, Thomas Astley, 1745-1747, 4 voll. in 4°. Della raccolta è stata fatta una recente ristampa anastatica dalla Frank Cass and Company Limited, Londra, 1968. (3) Come si è detto ne fu fatta un’edizione che la Duchet ha definito « de poche », ristampata in « confezione » meno elegante tre anni dopo. Nel 1747 si iniziò anche un’edizione olandese in 4°, sconfessata da Prévost, perché interveniva sul suo testo reintegrando, con severe critiche, i tagli da lui fatti sull’originale. Infine nel 1780 La Harpe curerà un Abrégé de l’histoire générale des voyages in 32 voll., Parigi, 1780-1801 (soltanto i primi 21 voll. sono un compendio della raccolta di Prévost). Di questo Abrégé fu subito fatta una traduzione italiana, pubblicata a Venezia a partire dal 1781 con il titolo Compendio della storia generale de’ viaggi di M. de la Harpe, accademico parigino, dall’editore Formaleoni. (4) Del resto, gli editori olandesi, pur non risparmiando critiche a Prévost, sono anche pronti a riconoscere i meriti della sua opera, soprattutto a partire dal momento in cui organizza lui stesso la materia, dopo la cessazione della pubblicazione inglese: « Ce seroit faire preuve d’un très-mauvais goût; si après avoir critiqué M. Prévost, nous ne lui rendions pas la justice qui lui est dûe. Le fond de son Ouvrage, ne pouvoit être mieux traité qu’il l’est dans ce nouveau Volume... « Avertissement » des Editeurs de Hollande, vol. XIII (1755), 88 p. VIII. (5) M. Duchet, op. cit., p. 90. (6) J. Sgard, Prévost de l’ombre aux lumières, in « Studies on Voltaire and the eighteenth century » 1963, n. XXIV-XXVII, pp. 1484-1485. (7) M. Duchet, op. cit., p. 91. (8) Del rapporto esistente tra il Prévost romanziere ed il Prévost compilatore di una raccolta di viaggi dice la Duchet: « Romancier du hasard et du destin, il a toujours aimé les péripéties empruntées au récit de quelque voyageur. Sensible au romanesque du dépaysement, il a fait de ses romans des ‘gestes’ aventureuses (...). Le voyage est donc à la fois pour lui le symbole et le lieu du romanesque: le fantastique, le merveilleux, le monstrueux même y ont droit de cité; œuvre de fiction, le roman dit l’étrangeté du réel; le voyage est donc d’essence romanesque » (op. cit., pp. 87-88). (9) Diciamo subito che un discorso a parte va fatto per le Antille, dove il nero è visto inevitabilmente, come nella maggior parte degli scritti dell’epoca, soprattutto in funzione delle sue prestazioni di schiavo. (10) La stessa Histoire des voyages pone l’accento su questa mancanza di conoscenze su buona parte del continente africano: « On doit présumer, de la confusion, des doutes, des contradictions qui se trouvent dans les Ecrivains qui nous les ont représentées, qu’il y a quantité de Régions considérables dont le nom est inconnu à l’Europe. En un mot l’Afrique est presqu’ignorée en comparaison de l’Asie et de l’Amérique, quoiqu’elle leur soit à peine inférieure pour la variété et le mérite de ses productions » (vol. IX, pp. 410-411). Nella traduzione Prévost introduce una nozione di merito che è assente dal testo originale («… for Variety of curious Productions », ristampa anastatica citata, vol. II, p. 254). (11) Citiamo qualche esempio: « Leurs femmes (dei Fulani) ont la taille d’une beauté extraordinaire et les traits du visage fort réguliers » (vol. IX, p. 448); « On voit des Négresses aussi bien faites, et d’une taille aussi fine que les plus belles femmes de l’Europe. Elles ont la peau extrêmement douce, et communément plus d’esprit que les hommes » (vol. X, p. 32). In quest’ultimo caso il « galante abate » le ha fatte anche più belle di quanto non risultassero nel testo originale, sia rendendo più lusinghiero il confronto con le dame europee, sia trasferendo l’idea della dolcezza dal piano spirituale a quello fisico: « There are Negresses as well shaped and finely limbed as any of the European Ladies: They have a better Genius than Man, and are extremely smooth » (ed. cit., II, p. 275, il corsivo è dell’autore). (12) Le descrizioni lusinghiere di popolazioni africane sono numerose, ricordiamo fra le tante quella dei Sereri (vol. VII, pp. 442-443), degli Issini (XI, p. 286) di molte popolazioni della Costa d’Oro o della Costa degli Schiavi, dell’isola di Madagascar, ecc. (13) Proprio in quegli anni Buffon lo definirà «vilain peuple» (De l’homme, 1749, ed. curata da M. Duchet, Parigi, 1971, p. 287). Ma basti ricordare, fra tutti, l’esempio di E. Long (The History of Jamaica, or General survey of the antient and modem State of that Island, Londra, 1774, 3 voll.) : « Has the Hottentot, from this portrait, a more manly figure than the orang-outang? I suspect that he owes, like the orang-outang, the celerity of his speed to the particular conformation of his foot; this by the way, is only my conjecture, for he has not undergone anatomical investigation » (vol. II, p. 365). Sull’accostamento nero-scimmia nel ‘700 rinviamo al nostro già citato Mon frère..., cap. II, pp. 152-184 e passim. Esprime invece un giudizio molto positivo sugli Ottentotti François Le Vaillant, che ha fatto un viaggio nell’Africa meridionale negli anni 1780-1785, di cui ci ha lasciato una relazione : Voyage (...) dans l’intérieur de l’Afrique (...) par le cap de Bonne-Espérance, dans les années 1780-1785, 89 Parigi, 1792, 2 voll. Abbiamo letto il testo in una ristampa della traduzione del patrizio veneto F. Contarini (Primo viaggio di F. Le Vaillant nell’interno dell’Africa), fatta dall’editore Martello, Milano, 1968, 3 voll. Una buona parte del secondo volume è dedicata agli Ottentotti, presentati positivamente persino per quanto concerne la bellezza fisica, mentre quasi tutte le relazioni di viaggio erano d’accordo nel descriverli come una delle popolazioni più brutte dell’Africa. Leggiamo in Le Vaillant, a proposito delle donne ottentotte: « Le femmine, più in dilicato, hanno però lo stesso carattere del volto; sono ben fatte del pari, hanno le poppe benissimo collocate, e di bellissima forma nella giovanile età, picciole le mani e ben fatti i piedi, sebbene camminino affatto scalze. Dolce è il metallo della voce, e dolce si fa lo stesso linguaggio passando per quelle fauci; gestiscono moltissimo quando parlano, cosicché ne fa parere assai sciolte e graziose le braccia» (II, p. 270). (14) D’altra parte, i missionari che dovrebbero costituire dei punti di riferimento e delle guide sono spesso inadatti al compito che è stato loro affidato, perché sono scelti non in base alle loro qualità, ma ai loro difetti: « Si les Sociétés ecclésiastiques du Portugal ont quelque Sujet scandaleux, dont elles veulent se défaire, c’est à S. Jago qu’elles trouvent le moyen de l’envoyer » (vol. VII, p. 177). (15) La Duchet ha fatto rilevare che «la méthode des ‘réductions’ devient l’outil d’une véritable critique des sources (...) », per cui Prévost può essere considerato colui che « inaugure en France la critique des relations de voyages... » (op. cit., p. 91). Del resto basta leggere l’Avertissement posto in capo al tomo XIII (ed, in 4°), quando Prévost già da tempo è passato dal ruolo di traduttore a quello di organizzatore della raccolta, per avere un’idea precisa del modo in cui ha reagito di fronte alle relazioni che devono costituire la base della sua Histoire des voyages. (16) Anche di fronte al culto di un grillo nell’isola di Madagascar troviamo la stessa volontà di capire: « Rennefort, surpris de ne pas trouver des principes de religion plus développés dans les habitans de Madagascar, voulut sçavoir d’un de leurs Sçavans, sur quoi il fondoit l’adoration d’un aussi vil animal que celui qu’ils nourrissent dans leurs olys. L’Ombiasse, tel est le nom par lequel on les distingue, lui répondit fort gravement que dans le sujet ils respectoient le principe, et qu’il falloit déterminer un sujet pour fixer l’esprit. Cette réponse causa de l’admiration à Rennefort (...). Il refusa de donner plus d’étendue à son explication; mais il soutint qu’on pouvoit donner à une figure la vertu du véritable Etre » (vol. XXXII, pp. 363-64). Sul culto del serpente presso i popoli africani ed i negri trapiantati in America cfr. R. Bastide op. cit., e A. Métraux, Le Voudu haïtien, Parigi, 1958, tr. it., Torino, 1971. (17) Per una lunga indagine sulla storia e la fortuna del personaggio cfr. D. Grant, The fortunate slave: an illustration of african slavery in the early eighteenth century, Londra, 1968, cap. IV: The sale and redemption of Job, pp. 61-118. Un ritratto di Job Ben Solomon è messo in antiporta all’opera di Grant. (18) Sono numerosi anche gli elementi che potrebbero essere utilizzati per una storia generale della prostituzione, ed in particolare della posizione che le diverse società riservano alla donna che la esercita. (19) « On trouve sur la Côte d’Or, comme dans les autres parties de la Guinée, une sorte d’hommes qui s’appellent Mulâtres; race qui vient du Commerce des Européens avec les femmes du Pays. Cette espece bâtarde forme un tas de brigands, qui n’ont aucune notion de fidelité et d’honneur, ni pour les Négres ni même entr’eux. Ils prennent le nom de Chrétiens, quoiqu’ils soient les plus grands Idolâtres de la Côte. La plûpart de leurs femmes servent 90 publiquement aux plaisirs des Européens, et se livrent secretement aux Négres. En un mot cette race est composée de tout ce qu’il y a de mauvais dans les Européens et dans les Négres. Elle en est comme le cloaque. Les hommes sont fort laids : et les femmes encore plus, sur tout lorsqu’elles avancent en âge» (vol. XIII, p. 304). (20) La pubblicazione inglese si arresta al tomo VII, mentre la trattazione di San Domingo è contenuta nel vol. XV dell’edizione francese in 4° (LIX dell’ed. in 12°). (21) Precisiamo che questo giudizio negativo concerne in particolare la composizione frettolosa del volume dedicato alle Antille, perché i precedenti sono ad un livello diverso. (22) In uno di questi aneddoti si racconta che un colono inglese, avendo saputo che i suoi schiavi si volevano impiccare tutti insieme in un boschetto per ritornare insieme, dopo la morte, in Africa, si recò sul luogo munito a sua volta di una corda e di tutti gli arnesi della piantagione affermando di voler fare anche lui il viaggio con i suoi schiavi, dal momento che aveva comperato una piantagione in Africa ed aveva bisogno anche laggiù di manodopera preparata. Fece anche capire che laggiù il lavoro sarebbe stato ben più duro. Riuscì così a spaventarli ed a farli rinunciare alla morte. Nell’altro il colono mutila invece i corpi degli schiavi che si sono dati la morte, cosicché essi non avranno più il coraggio di « ritornare » alla loro terra dopo aver perduto l’integrità fisica. (23) A questo punto, La Harpe, che riproduce nel suo Abrégé il paragrafo alla lettera, limitandosi ad inserire le note nel testo, interviene lasciando cadere gli apprezzamenti di Prévost (cfr, vol. XV, p. 414). Per altri accostamenti nero-animale, di cui Prévost è però responsabile unicamente come traduttore, sia pure non dissenziente, nel « Pour et contre » cfr. il nostro Mon frère..., pp. 154-56. 91 OROONOKO, LO SCHIAVO REGALE Dieci anni dopo la pubblicazione della requisitoria di Moses Bom Sam sul « Pour et contre » di Prévost, e cioè nel 1745, viene tradotta In Francia un’altra opera inglese, scritta una sessantina di anni prima e destinata ad avere un successo straordinario, come testimoniano le numerose edizioni e la sua presenza massiccia nelle biblioteche private francesi (1): si tratta del romanzo Oroonoko, or the Royal Slave di Aphra Behn, pubblicato per la prima volta in Inghilterra nel 1688. L’accostamento al testo del « Pour et contre » non è soltanto di comodo, dovuto al fatto che in entrambi i casi si tratta di un testo tradotto dall’inglese, ma c’è un motivo che li accomuna, e cioè l’invito allo rivolta da parte di un negro ai suoi fratelli schiavi dei bianchi. La traduzione del romanzo della Behn è opera dell’abate PierreAntoine de La Place, che si è preso molte libertà con il testo originale, eliminando i particolari e le scene più realistiche e trasformando completamente la tragica conclusione, che vedeva la morte del protagonista e della donna amata, in una bella favola a lieto fine, evidentemente allo scopo di compiacere il gusto dei « teneri » lettori francesi del tempo (2). La nostra analisi avrà come oggetto questo testo « a quattro mani », perché è quello conosciuto o almeno, meglio e più diffusamente conosciuto, dai lettori francesi nel corso di tutto il Settecento. Indicheremo tuttavia, di volta in volta, quando lo riterremo opportuno, gli interventi più pesanti del traduttore o quegli interventi che ci sembrano, comunque, significativi sotto il profilo ideologico. Prima di iniziare questo esame vorremmo però ricordare che un altro Oronoko (sia pure di dimensioni ridotte) si era messo a circolare in Francia nello stesso anno, grazie all’abate Le Blanc, che inseriva nelle suo Lettres d’un François la traduzione di due scene della pièce che Southerne aveva ricavato, nel 1696, dal romanzo della Behn (3). Ci soffermeremo su queste scene a conclusione dell’analisi condotta sul romanzo, per sottolineare un ulteriore apporto alla causa abolizionista che, nello stesso 1745, attraverso una via un po’ complicata, i Francesi debbono all’opera della Behn. L’intera pièce di Southerne fu poi tradotta in francese nel 1751 da Fiquet Du Bocage. 92 La trama del romanzo è piuttosto semplice, e si ripeterà più tardi, sia pure spesso con personaggi meno prestigiosi, fino alla nausea nei romanzetti negrofili della fine del ‘700: un principe nero è catturato con l’inganno da un capitano negriero sulle coste africane e finisce schiavo in America. Tutta la vicenda ruota attorno a questo perno. Strutturalmente l’opera si compone di due parti: la prima, più breve narra la storia dell’eroe nella sua terra di Coromantine, sulla Costa d’Oro (4), e termina con la cattura ed il viaggio attraverso l’Atlantico, la seconda racconta la vita di Oronoko nella colonia inglese del Surinam (passata pochi anni più tardi nelle mani dell’Olanda). La Behn non ci presenta un’immagine idealizzata dell’Africa, come faranno invece, più tardi, quasi tutti i suoi imitatori abolizionisti. Con ciò non si intende parlare di realismo a proposito di Oroonoko, ma semplicemente rilevare che non c’è nella scrittrice alcuna aprioristica volontà apologetica della vita africana, da contrapporre alla vita americana ed europea. I due protagonisti della storia, Oronoko (usiamo la grafia della traduzione francese) ed Imoinda, prima di essere vittime dell’avidità e della malafede dei bianchi, sono vittime della dispotica organizzazione tribale, che fa del re il padrone assoluto della persona dei propri sudditi. Il vecchio re dei Coromanti, nonno di Oronoko, innamorandosi di Imoinda e facendo di lei una sua « proprietà » tramite l’invio del velo regale, separa per sempre i due giovani e scatena la tragedia. Essi non sapranno infatti vivere separati e sfideranno le leggi, realizzando la loro unione nell’harem dove Imoinda è prigioniera. Imoinda dovrebbe pagare can la vita l’« orrenda » colpa, ma il vecchio sovrano, ben cosciente della violenza commessa nei confronti dei due innamorati, decide all’ultimo momento di allontanarla dalla corte, vendendola ad un mercante negriero. Essendo però la schiavitù pena infamante, indegna di una sposa regale, sia pure colpevole, egli giudica opportuno lasciar credere a tutti che Imoinda è stata punita con la morte. Oronoko, che ha accettato di continuare a vivere dopo la presunta morte di Imoinda, soltanto perché vede l’esercito, di cui è capo, in gravissima difficoltà di fronte al nemico, sarà poco dopo imbarcato a sua volta, con l’inganno, su di una nave negriera a bordo della quale era stato invitato con il suo seguito per una festa. La nave, dopo aver levato l’ancora, fa rotta per il Surinam. Il principe Oronoko, splendido in guerra ed in pace, giace incatenato nella stiva di una nave destinata al trasporto di merce umana. Dopo avere invano tentato di liberarsi dalle catene, decide, assieme al suo seguito, di lasciarsi morire di fame. Il capitano negriero, non volendo correre il rischio di vedersi sfuggire di mano una così ricca preda, con scuse, promesse di liberazione e giuramenti fatti in nome del suo dio, 93 riesce infine a far desistere Oronoko dalla sua temibile decisione. Come pegno della sua buona fede, lo scioglie dalle catene, lo riveste degli abiti principeschi e lo invita alla sua tavola, non lesinando lodi ed adulazioni. Si tratta, ovviamente, di una menzogna protratta e raffinata. Appena sbarcato, Oronoko sarà venduto come schiavo, ma il portamento e gli abiti regali lo segnaleranno immediatamente come un « uomo a parte ». Sarà perciò trattato con ogni rispetto da Trefry, che amministra le piantagioni del governatore e che ha comperato lo schiavo per lui. Conosciuta la sua storia, Trefry gli promette che farà di tutto, dopo il ritorno del governatore dall’Europa, per farlo liberare e rinviare nella sua terra. Nel frattempo, Oronoko, pur non essendo costretto come gli altri schiavi al lavoro dei campi, deve subire l’umiliante prassi del mutamento di nome che, almeno per una volta, si rivelerà in un certo senso profetico: sarà infatti chiamato Cesare, e sotto questo nome guiderà di lì a poco una rivolta di schiavi. Come in ogni storia romanzesca di buon conio, Oronoko ritrova Imoinda, che non ha mai smesso di essergli fedele nonostante la corte serrata di schiavi negri e padroni bianchi. Si sposano, aspettano un figlio, ma non vivono felici e contenti perché li rode il sospetto della malafede dei bianchi e la paura che il figlio possa, nonostante le diverse promesse, divenire uno schiavo. Il governatore è ancora lontano, il rimpatrio promesso è sempre rinviato: il malvagio Byam, vice-governatore della colonia, declina la responsabilità di una decisione che potrebbe costituire un pericoloso precedente. Nella versione francese, il traduttore imbastisce anche una complicata storia incentrata sulla meschina passione di Byam per Imoinda, che si esterna con ricatti, violenze fisiche e morali e che sarebbe la vera ragione del procrastinato rimpatrio dei due giovani sposi. Questi rinvii sembrano sempre più pericolosi ad Oronoko, che decide di passare all’azione: fomenta allora una ribellione fra i suoi compagni di schiavitù, destinata però a fallire, con conseguenze funeste a lunga ed a breve scadenza, per lui e per molti di coloro che lo hanno seguito. Gli schiavi fuggiti in massa dalle piantagioni sono infatti raggiunti e sconfitti: Oronoko viene frustato a sangue. È una punizione infamante per un principe: Byam che l’ha ordinata deve morire. Prima però di compiere un’azione che si concluderà in ogni caso con la sua morte, Oronoko decide di uccidere la giovane sposa, per non lasciarla in balia dei bianchi con il figlio che porta dentro di sé. Ma sul cadavere della sposa cade egli stesso ormai privo di forze: sarà recuperato quasi morente e condannato al rogo. Di fronte ad una morte tanto atroce egli saprà restare del tutto impassibile. Le pagine conclusive di questa tragica storia sono immerse in un’atmosfera di cupa e barbara grandezza. Nella versione francese, invece, nel momento in cui Oronoko sta per uccidere 94 Imoinda, sopraggiunge Byam ed inizia fra i due una lotta senza esclusione di colpi, che sembra, in un primo tempo, risolversi a favore di Byam. Un amico della coppia prende allora sulle spalle Imoinda svenuta e la nasconde in un villaggio di Indiani, dove Oronoko la raggiungerà più tardi e dove infine avranno notizia del ritorno del governatore e della sua decisione di rimandarli liberi in patria. Tutto lascia presumere che d’ora in poi vivranno davvero felici e contenti. Si tratta, al limite, di una banale storia di amori contrastati da mille traversie che trionfano di tutto e di tutti (o si concludono nella tragedia) come siamo abituati ad incontrarne nelle letterature di ogni tempo e paese. Anche gli eroi sono di maniera, sfolgoranti nella loro bellezza fisica e spirituale, incontaminati ed incontaminabili, pur attraverso le peggiori esperienze. Ma sono anche schiavi negri sottratti alla loro terra d’Africa, e in questo consiste la loro originalità: sono forse i primi eroi-schiavi della letteratura europea moderna e rappresentano il punto d’incontro di due realtà apparentemente inconciliabili: il mondo « meschino » dello schiavo e l’Olimpo degli eroi da romanzo. Se dal punto di vista della finzione e della tecnica romanzesca, quindi, non si può parlare di vera e propria originalità, anche se Oroonoko viene giudicato dai critici uno dei migliori romanzi della Behn, sotto il profilo « ideologico » è invece una novità assoluta. Nella storia dell’atteggiamento europeo nei confronti dei popoli negri rappresenta infatti un grado di « apertura » che si ritroverà, almeno in Francia, soltanto negli anni caldi dell’ultimo ‘700 e, per di più, in romanzi fortemente orientati in senso antischiavista, mentre l’orientamento del romanzo della Behn è assai incerto da questo punto di vista e, nel complesso, forse più consenziente che critico nei riguardi della schiavitù. Va rilevato ad onor del vero che anche altri scritti, in particolare relazioni di viaggio, del secolo XVII sono meno prevenuti nei confronti dei popoli africani e degli schiavi negri sul suolo americano di quanto non lo siano molti scritti del ‘700, apparsi in un’epoca in cui il processo di mercificazione si è andato facendo più intenso, fino ad assumere dimensioni abnormi per il volume del traffico negriero, dei prodotti coloniali e per la disciplina crudele che la sproporzione tra bianchi e negri ha a poco a poco introdotto in tutte le colonie schiaviste. Sta di fatto che nel corso del ‘700 il negro è spesso collocato a fianco della scimmia e, nel migliore dei casi, sempre ad un gradino al di sotto del bianco anche dagli esponenti di una pseudo-scienza antropologica, che possiede dati incerti e sistemi di elaborazione di questi dati di chiara matrice eurocentrica. Nell’opera della Behn ci troviamo invece di fronte ad una corte africana che ricorda, per molti aspetti, lo sfarzo e la raffinatezza di una corte orientale e, per altri, 95 forme di etichetta tipiche delle corti europee: il principe Oronoko va « rendre visite aux Gentilshommes Anglois, et aux Négocians » che il commercio attira sulle coste africane, ed apprende così l’inglese e lo spagnolo. Avendo avuto un istitutore francese è in grado di parlare e capire tre lingue europee. Frequenta inoltre le feste che il vecchio monarca « donnoit fréquemment à ses Mâitresses », assieme agli altri dignitari del regno: « ... ils furent introduits dans la chambre du Roi, avec tous ceux qui attendoient. Il venoit de demander sa musique, et quelques unes de ses maîtresses, pour danser devant lui » (5). Sembra quasi di leggere un brano delle memorie di Saint-Simon! Certo, accanto a queste forme di vita raffinata ve ne sono altre più rozze e barbare: « Le Coramantien, païs qui tire son nom des Noirs qui l’habitent, est l’une des Côtes où le commerce des Esclaves est le plus avantageux: parce que cette Nation, qui est extrêmement brave et belliqueuse, ayant toujours guerre avec ses voisins, a souvent occasion de faire des prisonniers; et que, suivant leurs Loix, tous ceux qui sont pris en guerre, et qui n’ont pas de quoi payer leur rançon, sont vendus comme Esclaves » (Ib., I, pp. 12-13), ma nell’insieme, il quadro di questo regno della Costa d’Oro non è molto diverso da quello di qualsiasi altro regno, con le sue componenti cortigiane e militari, le sue crudeltà e le sue prepotenze regali. I due protagonisti poi, Oronoko ed Imoinda, non hanno nulla da invidiare a quanto di meglio abbia mai visto la luce in un qualsiasi paese del mondo, sia sotto il profilo fisico che spirituale. Dopo aver decantato le doti di guerriero di Oronoko, la sua finezza di comportamento in tutte le occasioni, la sua intelligenza e le eccelse qualità del cuore, l’autrice completa il suo personaggio con una lusinghiera descrizione fisica: « Il étoit médiocrement grand mais d’une taille si exactement proportionnée, que le plus habile Sculpteur auroit eu peine à former une figure d’homme plus réguliere, et plus élégante. Son visage n’étoit pas de cette couleur noire et rouillée, si ordinaire à sa Nation: mais plutôt semblable à une ébeine parfaite, ou 96 au jais le mieux poli. Ses yeux étoient grands, bien coupés, et extrêmement perçans. Ce qu’ils avoient de blanc, égaloit la neige. Il en étoit de même de ses dents. Son né, n’avoit aucun des défauts qui nous choquent dans les Négres. Sa bouche étoit belle, ses lévres fines et vermeilles, quoique presque tous les Négres les ayent grosses, et recourbées vers le menton. Il résultoit enfin, de l’assemblage entier des traits de son visage, quelque chose de si noble, et de si parfait, qu’à la couleur près, rien dans la nature, n’étoit plus beau, ni plus séduisant » (Ib., I, pp. 18-20). È un ritratto degno di una certa attenzione: Aphra Behn pretende di narrarci una storia vera e di aver conosciuto i protagonisti della vicenda, di fronte alla quale ha assunto semplicemente l’atteggiamento dello storico imparziale (6), ma, anche supponendo che quanto afferma sia vero, un tale ritratto ci fa pensare che non abbia resistito completamente alla tentazione, del resto assai lecita in un romanziere, di dare una ritoccatina ai fatti e ai personaggi, per elevarli al livello di perfezione che un « vero eroe » da romanzo non può non possedere. Molte delle notizie relative alla vita della Behn restano ancora incerte e non è sicuro che sia veramente stata nelle Indie occidentali, anche se l’opinione più corrente è che vi abbia veramente vissuto. Bisogna però riconoscere che le idee dei biografi sono talvolta un po’ confuse. Nel Dizionario letterario degli autori, edito da Bompiani, leggiamo ad esempio: « passò l’adolescenza in Africa, nella calda e colorita Surinam » (sic) (7). Ciò che afferma lei stessa non può, ovviamente, essere considerato come probante, in quanto tutto è permesso alla finzione romanzesca e del resto rientra perfettamente nei canoni dell’estetica coeva (almeno francese, e la Behn era imbevuta di cultura francese) che vede fiorire la moda dei romanzi-memoria, cioè di quel genere romanzesco che cerca credibilità presso il suo pubblico, presentandosi come la trascrizione pura e semplice di fatti di cui il romanziere è stato protagonista o spettatore (8). Dunque Oronoko, come ogni eroe di romanzo che si rispetti, è bello e seducente (9). Ma quando si tratta di trascrivere questa bellezza sulla carta per i lettori europei, la scrittrice sente il bisogno di levigare i tratti per renderli assai più vicini a quelli dell’uomo bianco che a quelli africani, sottolineando anzi fortemente le caratteristiche che lo diversificano da questi ultimi. Persino il colore è diverso da quello « si ordinaire à sa Nation », anche se resta inevitabilmente nero, il che costringe la Behn a licenziare il ritratto del suo eroe con l’ombra di un rammarico, facente capolino nella riserva che conclude la descrizione: « à la couleur près ». È ben vero però, che nel corso della descrizione anche il nero viene recuperato come componente che 97 concorre alla bellezza, perché si tratta, ovviamente, di « ébeine parfaite » o di « jais le mieux poli »! Insomma, i pregi fisici di questo eroe nero sono dati da una serie di caratteristiche che lo rendono in tutto simile al bianco, eccezion fatta per il colore. Certo, questa trasformazione ha il suo peso: sta chiaramente ad indicare che un eroe bello, seducente, nobile, anche se nero, non può avere il naso schiacciato e le labbra grosse, perché altrimenti all’occhio dell’Europeo potrebbe non risultare più un personaggio del tutto credibile. Oronoko diventa dunque eroe soltanto in seguito a questa metamorfosi snaturante alla quale lo ha sottoposto la scrittrice prima di darlo in pasto ad un pubblico europeo o forse anche prima di accettarlo come protagonista di un suo romanzo. Il personaggio nero diventa così il prodotto di un incrocio tra la realtà africana ed i modelli di bellezza europei. Subisce cioè, idealmente, una violenza da parte del bianco, ancor prima che questi lo strappi, con l’inganno, alla sua terra. Ma l’autrice ama il suo eroe, coglie ogni occasione per metterne in luce le doti di coraggio, onestà, generosità, finezza, intelligenza, sincerità, per lodare la buona educazione che ha ricevuta (10), ricorrendo spesso, per contrasto, ad un confronto con il mondo bianco che va tutto a vantaggio del suo eroe, per cui la libertà che si è presa con la sua faccia ci sembra, in fondo, un peccato veniale. Anzi, bisogna davvero esserle riconoscenti per averci tramandato, da un’epoca che aveva la tendenza a massificare gli schiavi negri in un gregge, un’immagine così fulgida e maestosa di eroe nero. È il simbolo immortale di una grandezza che non è prerogativa dei soli bianchi, ma anche dei negri quando si verifichino le condizioni che permettono all’uomo di sviluppare le sue potenzialità. In questo senso Oronoko è il primo portabandiera della causa abolizionista. Lo stesso può dirsi della fedele e dolce Imoinda: « Je ne peindrai ses charmes qu’en disant, qu’elle étoit en femme ce que le Prince étoit en homme; et que sa vertu surpassoit ses attraits. J’ai vû les plus distingués de nos Blancs, soupirans pour elle, exprimer à ses pieds leurs vœux et leurs désirs, sans pouvoir parvenir à la rendre sensible » (Ib., I, pp. 20-21). Questa eroina che, in territorio coloniale e senza alcuna speranza di rivedere mai più Oronoko, riesce a tenere a bada, grazie soltanto alla nobiltà del suo carattere ed alla severità del suo portamento, uno stormo di pretendenti bianchi, signori e padroni persino del suo corpo, è anch’essa, a suo modo, un simbolo di libertà. Simbolo che si precisa e assume dimensioni eroiche alla fine del romanzo, 98 quando, in occasione della rivolta di schiavi fallita, resta al fianco di Oronoko affermando, come lui, che è meglio morire combattendo « que de se rendre à des gens, sans honneur, et sans foi » (II, 91). O ancora quando Oronoko, umiliato dalle frustate di Byam, le lascia capire che non può vivere senza vendicarsi e Imoinda gli chiede di associarla alla sua morte: « Ne crains pas (...) que j’ose te donner, aujourd’hui des conseils indignes de toi: je sens trop, que ce seroit en vain, et que ton parti est pris!... Fais donc mon cher César (11), tout ce que l’honneur, et ta naissance, exigent!... (...) Tu vas, dis-tu, te venger? C’est à dire que tu vas mourir! Parce que soit que ton projet réussisse, ou non, ta mort est également certaine? Conçois-tu, cher époux, toute l’horreur, que la certitude d’une pareille pensée, doit jetter dans l’ame d’une femme qui t’aime autant que moi? Et si tu le conçois, es-tu assez inhumain, pour avoir dédaigné de m’associer à ton sort?... » (Ib., II, p. 115). E quando Oronoko esiterà piangente a trafiggere il cuore della donna amata, sarà proprio Imoinda ad incitarlo al coraggio, ricordandogli che non esiste altra scelta per la sua virtù ed il di lui onore. Gioia, terrore, ammirazione agitano allora l’animo di Oronoko di fronte al coraggio ed alla grandezza d’animo della sua sposa: « Quoi! (...) cher et unique objet de mes vœux les plus ardens, c’est toi qui ranimes mon courage! C’est toi qui me presses de plonger ma main dans ton sang! O Ciel! O Dieux! Quelle vertu fut jamais plus digne de votre protection?...» (Ib., II, p. 117). Il tono è caricato e retorico, ma la sostanza del discorso è chiara: un uomo che abbia a cuore la sua dignità ed il suo onore non può accettare di piegarsi sotto la frusta, ed una compagna degna di lui non può che seguire i suoi princìpi. Dunque le regole che guidano un uomo sono le stesse, sia esso bianco o nero, e non possono essere violate senza che venga intaccata la sua umanità. Sotto questo profilo, ed a questo livello, non esiste disuguaglianza razziale: indipendentemente dal colore gli uomini possono essere grandi o meschini. Questo non significa che agli occhi di Oronoko non vi siano uomini vili e deboli che meritano la condizione di schiavo, ma non ne fa ovviamente una questione di razza, quanto piuttosto di qualità o limiti personali. Nelle tarde imitazioni di Oroonoko su cui avremo modo di soffermarci più oltre, 99 assistiamo in genere, ad un manicheismo che è assente dal testo della Behn. Mentre gli schiavisti presentano tutto ciò che è nero come negativo e ciò che è bianco come positivo nei romanzi negrofili del tardo Settecento si ricorrerà al procedimento opposto: i bianchi sono sempre vili oppressori ed i neri sono buoni, generosi, virtuosi ecc. Nel romanzo della Behn, anche se la palma della malvagità e della doppiezza spetta ai bianchi, neppure i negri, eccezion fatta di Oronoko e di Imoinda che sono gli eroi protagonisti e come tali votati alla perfezione dalla tradizione letteraria, sono privi di difetti ed esenti da colpe: il vecchio re dei Coromanti, mosso dalla sua insana passione senile per Imoinda, di cui conosce l’amore ricambiato per il nipote Oronoko, scatena la tragedia e si pente soltanto quando ormai non è più tempo. Più tardi, nella colonia inglese, Oronoko scoprirà con umiliazione la vigliaccheria in quegli stessi compagni di sventura che avevano accettato di spezzare, dietro la sua guida, le catene della schiavitu. Non soltanto lo abbandoneranno dopo le prime scaramucce, ma si piegheranno a divenire gli strumenti della sua punizione: Pour comble d’horreur, il vit encore ces mêmes esclaves, qui quelques heures auparavant, le regardoient comme un Dieu libérateur, forcés d’épuiser, pour son châtiment, le reste de vigueur, que les travaux de ce jour, et la punition qu’ils venoient de recevoir eux-mêmes, leur laissoit encore! Sa constance ne tint pas contre ce dernier trait » (Ib., II, p. 99). Il nonno ed i compagni di schiavitù, in modi diversi, tradiscono dunque Oronoko come lo tradiscono il capitano negriero ed il vicegovernatore del Surinam. Per altro verso egli ha (nel testo francese) due uomini del suo seguito che gli sono fedeli fino alla morte e trova sul territorio coloniale amici sinceri fra i bianchi, che cercano in ogni modo di preservarlo dalla sventura e di riparare i torti subiti. Non esiste quindi in quest’opera, che non nasce da esigenze di lotta ideologica ed in cui l’ideologia non soffoca personaggi e vicende, una contrapposizione netta di Bene e Male che si identifichi con una contrapposizione antropologica o assiologica di colori, come avviene comunemente nei testi sia dei filoschiavisti che degli antischiavisti. Dall’insieme della vicenda, dalla descrizione partecipe di ambienti e di costumi africani dalla scelta di eroi di colore, risulta però inevitabilmente un orientamento critico nei confronti del mondo europeo e coloniale. Ed in particolare un atteggiamento di viva simpatia non soltanto nei confronti dei popoli africani che sono, nella visione di Aphra Behn, assai lontani dalla semplicità dei popoli primitivi, ma soprattutto nei confronti degli indigeni americani, che vivono nella purezza incontaminata di una natura non ancora corrotta dalla violenza dell’uomo. Il suo primitivismo, nato, sempre stando alle sue affermazioni, da constatazioni 100 personali, potrebbe essere paragonato, facendo un salto in avanti nel tempo, a quello di Rousseau. Ma è in realtà ben diverso, come diversi sono i tempi e lo spirito. Potremmo dire che è più ingenuo (non c’è in lei quella raffinata ingenuità, quella « sprezzatura » che sarà tanta parte del talento del Ginevrino) e perciò più efficace. Più efficace perché più vero. Questa donna dai gusti forse un po’ ambigui, dalla vena licenziosa (pensiamo al suo teatro), cercava la verità. Forse non nel modo migliore. Si sa che fu spia del governo e spia scontenta: sembra che le sue informazioni non venissero prese abbastanza in considerazione dal governo inglese in guerra con l’Olanda. Qualcosa del genio di Defoe dà qualche non trascurabile barbaglio già in lei. E anche Defoe militerà nel servizio segreto... Possiamo pertanto dire che il primitivismo di Aphra Behn è candido perché più vero rispetto a quello più o meno sofistico di Rousseau. Ma non è certo il candore delle nevi immacolate. Questo « candore » inclina un po’ verso l’idillio: « Cette nation, en un mot, me représentoit exactement le premier état d’innocence, avant que l’homme apprît à pécher; d’où j’ai conclu, que la simple nature est le moins dangereux de tous les guides; et que si nous observions seulement ce qu’elle permet, ses inspirations toutes simples, nous instruiroient beaucoup mieux, que tous les préceptes d’invention humaine. La Religion même, dans ce païs là, ne serviroit qu’à en bannir l’heureuse tranquillité qu’on y doit à l’ignorance; et l’établissement des loix, leur apprendroit plutôt à connoître le mal (...) qu’elles ne leur serviroient à l’éviter (...) » (Ib., I, pp. 7-8) (12). A conferma di questa semplicità e di questa naturale correttezza nell’agire, la Behn riporta un aneddoto più eloquente di qualsiasi lunga descrizione di usi e costumi: poiché il governatore della colonia non si era recato ad un appuntamento nel giorno fissato, e non aveva dato sue notizie, gli indigeni ne celebrarono la morte con riti funebri solenni ed un digiuno generale, perché « Ils croyoient fermement, que lorsqu’un homme a donné sa parole, la mort seule pauvoit le dispenser de la tenir! » (Ib., I, p. 8). Avendolo incontrato dopo un certo tempo gli chiesero come era chiamato in Europa un uomo che mancava ad una promessa. Il governatore rispose senza esitazione che lo chiamavano « un mal-honnête homme », appellativo infamante, soprattutto per un gentiluomo. Allora uno degli indigeni lo apostrofò senza mezzi termini: « Gouverneur, tu es donc un mal-honnête homme! ». A questo mondo così limpido, lineare, che non conosce doppiezza, fa da 101 contrasto l’ambiguità del mondo dei bianchi, in cui tutto è aleatorio e in cui non sempre le azioni corrispondono ai princìpi professati e alla parola data (non possiamo non pensare alla famosa « lingua biforcuta » con cui gli Indiani, nella migliore tradizione fumettistica, definiscono i bianchi). Su questa sfiducia nella parola del bianco e nei valori in nome dei quali egli dice di agire o fa le sue promesse, quale che sia il mestiere esercitato o la posizione sociale che occupa, si insiste spesso nel romanzo. Quando Oronoko scende dalla nave negriera sulla quale è stato rapito e mantenuto in vita grazie a una litania di menzogne, dopo aver lanciato al capitano uno sguardo fiero e sprezzante, prende commiato da lui con queste parole: « Adieu, Monsieur: Ce que je vais souffrir, est peu de chose, en comparaison des lumières que j’acquiers, par rapport au fond qu’on doit faire, et sur vous, et sur le Dieu, au nom duquel vous avez juré! » (Ib., I, p. 103) (Corsivo nel testo). Più tardi, in seguito al fallimento della rivolta, o meglio della fuga di schiavi da lui capeggiata, Oronoko, userà parole altrettanto dure e sferzanti, che concernono ancora una volta il dio dei bianchi e le loro dubbie promesse. Al vice-governatore Byam, che lo esorta a deporre le armi, assicurandogli che sarà rinviato con la prima nave in partenza per l’Africa, risponde con disprezzo: « Je t’écouterois peut-être, (...) si je ne te connoissois pas; et si après avoir été tant de fois trompé par les Blancs, je pouvois encore me laisser séduire par leurs promesses. Tu prendras, au besoin, ton Dieu pour garant de ta foi? Mais, j’ai déjà trop éprouvé, à mes dépens, que ce frein n’est pas capable de te retenir! je me rendrois sans peine, à l’ennemi le plus barbare, pourvû que je lui connusse des sentimens d’honneur, et d’humanité. Mais à vous autres?... Non, ne l’espérez pas. Jamais Amériquain, s’il veut m’en croire, n’aprochera d’un Européen, et ne commercera avec lui, que les armes à la main. Il est perdu s’il vous écoute avec confiance! » (Ib., II, pp. 94-95) (13). In occasione di un viaggio di Oronoko, della scrittrice-protagonista e di altre persone all’interno della colonia, la Behn si compiace nella descrizione di un villaggio indiano, che non ha nessun contatto con il mondo dei bianchi, e nel quale si vive una vita comunitaria di tipo arcaico, in cui il prestigio è legato alle qualità ed al coraggio degli individui, cioè al valore delle azioni e non a quello delle parole. 102 Questo porta i guerrieri a dimostrazioni così eccessive del loro disprezzo del dolore e della morte che i risultati sono spaventevoli, ma significativi di quanto siano tenute in scarso conto le perorazioni verbali. Quando scoppia una guerra il vecchio comandante che non è più in grado di combattere sceglie due fra i soldati che ritiene migliori e chiede a ciascuno di loro quali garanzie possa offrire per meritare la fiducia del popolo e l’onore di comandare l’esercito: « Alors, celui qu’on interroge le premier, se léve; et sa réponse, est, de se couper le nés, qu’il jette au milieu de l’assemblée, avec autant d’insensibilité que de dédain. Celui qu’on interroge ensuite, cherche a surpasser son rival, en se coupant les lévres, ou en s’arrachant un œil. Il arrive même souvent, que cette barbare concurrence se termine, par la mort de l’un, ou de l’autre champion: quelquefois même de tous les deux » (Ib., II, pp. 47-48). È una scena agghiacciante ma non priva di barbarica grandiosità, la cui nota dominante è il disprezzo della morte e l’insensibilità di fronte alla sofferenza fisica e alla mutilazione del proprio corpo. La stessa grandezza, forse ancor più convincente, che ritroveremo nella suggestiva conclusione del testo originale, in cui Oronoko affronta la pena del rogo e la progressiva mutilazione delle proprie membra senza lanciare un lamento o dare altri segni di debolezza: « He had learn’d to take tobacco; and when he was assured he should die, he desir’d they would give him a pipe in his mouth, ready lighted; which they did: And the executioner came, and first cut off his members, and trew them into the fare; after that, with an ill-favour’d knife, they cut off his ears and his nose, and burn’d them; he still smoak’d on, as if nothing had touched him; then they hack’d off one of his arms, and still he bore up, and held his pipe; but at the cutting off the other arm, his head sunk, and his pipe dropt and he gave up the ghost, without a groan, or a reproach » (14). Nessuno dei personaggi bianchi « positivi », né la narratrice, né Trefry, che amministra la piantagione di Param-house in assenza del governatore e che dimostra di possedere un animo delicato e sensibile alle sofferenze e alle straordinarie doti di Oronoko, né il colonnello Martin, che si lega di sincera amicizia allo schiavo regale, 103 possono stare alla pari, per grandezza, nobiltà, intensità di sentimenti e per coerenza tra i princìpi e le azioni, con questi personaggi « primitivi ». Perciò la conclusione del testo originale è molto più logica e convincente della scipita traduzione francese: Oronoko che ha eretto a sua religione il senso dell’onore ed il culto della gloire (la parola honneur, in particolare ritorna nel testo con una frequenza degna di nota) non poteva sopravvivere alla punizione infamante della frusta. Oronoko muore dunque per restare fedele ai suoi principi. La sua morte, che assume dimensioni quasi mitiche, completa la figura dell’eroe e la trasforma nel simbolo di un sacrificio in nome della libertà e della dignità umana. E, nel caso specifico, in un simbolo di lotta per la liberazione dei popoli africani schiavi. A questo proposito, però, è necessaria una precisazione: sul valore simbolico di Oronoko non vi è nulla da obiettare, ed è quindi fuori discussione che l’opera della Behn sia un contributo alla causa abolizionista ed abbia agito in tal senso anche al suo apparire in Francia (15). Ne fanno fede, se non altro, le numerose imitazioni tutte di orientamento chiaramente abolizionista e negrofilo (16). Questo non significa però che il testo della Behn sia animato da una precisa e convinta ideologia antischiavista. Intanto, ci parla del commercio degli schiavi senza sentire il bisogno di esprimere la minima riserva. Eppure sembra porre con enfasi l’accento sul fatto che gli Inglesi, pur avendo assoggettato gli indigeni americani, non hanno « pas attenté à leur liberté ». E sul valore della libertà ritornerà in più occasioni nel testo, ma quando si tratta di spiegare il modo in cui i coloni si procurano la manodopera, ci dà una descrizione del tutto asettica di questo commercio vergognoso, come se si trattasse di cosa ovvia: « Les Habitans, qui avoient besoin d’Esclaves, faisoient un marché avec un Capitaine de Navire, et convenoient de lui compter vingt livres Sterlin, ou environ, pour chaque Nègre qu’il leur livreroit, dans telle plantation. Lorsque les Vaisseaux chargés d’Esclaves arrivoient, ceux qui avoient contracté alloient à bord, et chacun tiroit son lot » (Ib., I, p. 11). Lo stesso atteggiamento si ritrova a proposito della vendita degli schiavi sulle coste africane. Oronoko ed Imoinda fanno eccezione, ma appunto perché si tratta di personaggi eccezionali ed i modi in cui sono ridotti in schiavitù escono dall’« ortodossia »: l’una è venduta dallo stesso re per aver macchiato il velo regale, l’altro è preso con l’inganno. Del resto, lo stesso Oronoko era andato da colei che doveva essere sua sposa con un gruppo di schiavi in trofeo e, poco prima di essere invitato nella nave spagnola che doveva strapparlo alla sua patria, aveva venduto 104 « beaucoup d’Esclaves à cet Espagnol » e lo aveva colmato di doni, per testimoniargli la sua stima. Si tratta dunque di un commercio più che legittimo, nella concezione di entrambi gli operatori, e la Behn non sente alcun bisogno di mettere in discussione un rapporto di scambi così ben avviato. Nel testo francese poi, Oronoko, nonostante le brutte esperienze della traversata atlantica e della vita nella colonia, promette al capitano olandese che lo riporterà in patria una «cargaison complette »! Nella conclusione tragica del testo originale manca, ovviamente, questa assenza di catarsi che getta un’ombra sull’eroe ed è davvero di cattivo gusto. C’è però un avvenimento nel romanzo che è senz’altro il più importante sotto il profilo che qui ci interessa e con il quale siamo già venuti in contatto, pur senza focalizzarlo: si tratta della fuga di tutti gli schiavi della piantagione di Param-house, istigata e capeggiata da Oronoko. È un avvenimento che merita un’attenzione particolare per essere considerato nel suo giusto significato, perché si potrebbe correre il rischio di sminuirlo o forse, ancor più, di sopravvalutarlo. Contiene tutte le premesse di un riscatto sociale e razziale, ma il contesto, come già si è visto, ne sminuisce la portata; inoltre i moventi che spingono Oronoko a scuotere la massa dei suoi compagni di schiavitù, se così si può dire, visto che egli non esce mai dalla casa dei padroni e non fa alcun lavoro manuale, non sembrano del tutto disinteressati. Egli infatti, ad un certo momento, non fidandosi più delle promesse dei bianchi, decide di fuggire con Imoinda, ma la strada per arrivare alla costa per vie non battute è lunga ed impervia: soltanto un folto gruppo di fuggiaschi può offrire qualche garanzia di riuscita alla fuga. Ci troviamo dunque di fronte all’azione di un personaggio d’élite, che trascina in un’impresa velleitaria una massa di schiavi inconsapevoli, usati perciò più come strumento di riscatto personale che fatti muovere in nome di una giustizia sociale, anche se la ragione esplicitata è ovviamente questa, ed anche se Oronoko, nel momento in cui invita i suoi fratelli alla lotta, spinto dalla sfiducia nei confronti dei bianchi, è pienamente sincero. Però il suo atteggiamento resta sempre quello di un uomo che considera i suoi compagni di schiavitù da un gradino superiore, sul quale lo collocano la sua qualità di principe africano e la posizione di privilegio riconosciutagli anche dai proprietari bianchi. Prima di invitare alla rivolta gli schiavi della piantagione di Param-house egli sente perciò la necessità di farsi preparare adeguatamente il terreno, per risvegliare negli animi sfigurati dalla schiavitù e rassegnati al peggio la consapevolezza della miseria e della vergogna che stanno vivendo: « Réveille ces malheureux, accablés sous le faix de leur infortune! Ranime en eux, ces sentimens naturels à tout homme né libre! Peins-leur l’état misérable, 105 dans lequel ils languissent! Fais naître, dans leur cœur abattu, l’espoir d’une liberté, qui est prochaine, s’ils sçavent se taire! Prépare-les enfin à un événement inattendu, qui doit briser leurs fers. Et dès que tu les verras disposés à paroître hommes, viens d’abord m’en avertir: Je me charge du reste » (Ib., II, p. 70) (17). Il brano denuncia i limiti della partecipazione di Oronoko alla condizione dei suoi compagni di schiavitù: essi hanno accettato la loro situazione e si sono ancorati nella passività, mentre la sua acquiescenza momentanea non ha spento in lui il desiderio di libertà. Egli è rimasto un uomo attivo, che vuol essere l’artefice della propria sorte. Ma al di là di questo atteggiamento «aristocratico », che caratterizza tutte le azioni del principe africano, ci sono anche momenti di commossa partecipazione alla sofferenza dei compagni di schiavitù e di sincera ribellione alla vista di uomini della sua razza trasformati in bestie da altri uomini vili e più disprezzabili di loro. Anche se il discorso che Oronoko rivolgerà agli schiavi è dettato, almeno in parte, da ragioni che potremmo definire egoistiche, resta nondimeno vero che ne risulta una condanna della schiavitù coloniale espressa con veemenza ed in termini che ne mettono a nudo tutti i risvolti vergognosi ed infamanti. Dapprima la condanna espressa da Oronoko è rivolta contro coloro che subiscono passivamente la schiavitù: « Il leur représenta, avec les couleurs les plus vives, les travaux attachés à l’esclavage: Espece de travaux ajouta-t-il, plus convenables à des bêtes qu’à des hommes. Encore, crioit-il avec feu, si c’étoit pour quelques jours, pour quelques mois, pour quelques années mêmes?... Mais c’est pour toujours. Jamais de fin à vos infortunes!... S’il en résultoit, du moins, quelqu’honneur personnel ou quelque gloire pour la patrie? Mais non! L’état d’oppression dans lequel vous gémissez, votre exactitude à remplir vos devoirs, votre obéissance même, tout est opprobre pour vous, parce que votre état dégrade l’humanité » (Ib., II, pp. 75-76). Poi, con un linguaggio tanto ardito come mai si era sentito prima e che si incontrerà di nuovo in Francia soltanto molto più tardi negli scritti dei più accesi abolizionisti, la Behn si accanisce, per bocca del suo personaggio, contro i coloni bianchi. Daremo in nota anche il testo originale che è, a nostro giudizio, forse ancor più tagliente e più efficace della traduzione francese: « Eh, de quel droit? Par quelles loix, mes chers compagnons, devons-nous être 106 esclaves, d’un peuple inconnu? Nous ont-ils vaincus à la guerre? Est-ce notre défaite, qui leur a donné des droits sur nous?... Non; c’est leur argent, c’est la trahison, qui les rend nos maîtres! Vendus, comme des animaux étrangers, ce sont des hommes qu’on assujettis, aux fonctions les plus viles, pour enrichir de misérables vagabonds, forcés, peut-être de fuir leur patrie, pour éviter les châtimens dûs à leurs crimes! Ne les entendez-vous pas, chaque jour, se reprocher leurs mauvaises actions les uns aux autres, et s’imputer des traits, qui feroient horreur au Sauvage le plus féroce? Continuerons-nous, mes amis, d’obéir à une race d’hommes si méprisables? Leur connoissez-vous des vertus capables de leur donner quelque supériorité sur nous? » (Ib., II, pp. 76-77) (18). (Il corsivo è nostro). Il dittico che porta da un lato l’immagine degli schiavi negri innocenti ridotti ad animali da soma, frustati e vilipesi e dall’altro quella dei bianchi americani crudeli ed egoisti, feccia che l’Europa ha espulso con ignominia dalle proprie viscere, che si sono appropriati di altri uomini con il vile denaro e pretendono, in nome di esso, di esercitare su di loro il diritto di vita e di morte, diventerà in seguito un luogo comune, come tanti altri che concernono lo schiavo negro. Ma al momento in cui appare l’opera della Behn, in Francia nel 1745, ed ancor più in Inghilterra, sessant’anni prima, una condanna espressa in questi termini ha certamente un peso notevole. Non solo viene messa in rilievo la miseria di coloro che sono costretti per tutta una vita, senza la pur vaga ombra di uno scopo motivante, a piegare il capo di fronte alle imposizioni più umilianti, ma si attaccano anche i padroni bianchi, scoprendo con crudezza le loro magagne, le loro bassezze, il fardello di colpe e di delitti che si portano sulle spalle dalla madrepatria, la quale li ha rinnegati e mandati lontano da sé. In una parola, si incide il bubbone del mondo putrescente di questi misérables vagabonds, di questa race d’hommes (...) méprisables e degeneri (degenerate race). Va tenuto ovviamente conto della situazione particolare in cui queste accuse vengono mosse: si tratta di uno schiavo, sia pure di condizione privilegiata, che si rivolge ad un gruppo di altri schiavi ai quali deve « far violenza » con un linguaggio capace di risvegliare nei loro animi l’ardire della ribellione, anche, e soprattutto, offuscando l’immagine del bianco, gettandolo brutalmente a terra dal piedistallo che gli offre la sua posizione di potere. Si tratta dunque della requisitoria di uno schiavo contro la schiavitù o forse, piuttosto, contro coloro che la accettano passivamente o la impongono in forme vergognose: Oronoko non sembra infatti mettere minimamente in discussione la schiavitù, qualora essa sia, ad esempio, la conseguenza di una sconfitta sul campo di 107 battaglia, perché in questo caso la superiorità del padrone è effettiva, come è effettiva, sul piano delle forze, l’inferiorità di colui che è stato sconfitto. Non sappiamo perciò fino a che punto la posizione di Oronoko rispecchi quella della Behn. Abbiamo visto che in altre parti del romanzo la narratrice non si pone neppure il problema, anche in situazioni in cui sembrava inevitabile spendere una parola pro o contro la schiavitù. Ma sembra anche impossibile che uno scrittore schiavista, sia pure trovandosi nella necessità di rappresentare una rivolta di schiavi, e di dare al suo personaggio tutta la nobilità e la verosimiglianza possibile, si sarebbe mai piegato ad usare un linguaggio così spietato contro i padroni bianchi. Ci pare perciò di poter arguire che se l’opera della Behn non è sorretta da una coerente e decisa ideologia antischiavista, non è comunque neppure animata da simpatia nei confronti della schiavitù coloniale. Il primitivismo della scrittrice, accostato a questa e ad altre prese di posizione del suo eroe contro il mondo ed i costumi dei bianchi, fa pensare in ogni caso ad una voluta e cosciente posizione critica nei confronti della civiltà europea e della sua malacopia americana: la viltà, la crudeltà e la falsità, ammantate di belle maniere, sono una prerogativa soltanto dell’uomo bianco. Del resto esempi di ambiguità, o forse semplicemente di non rigorosa coerenza di fronte al problema della schiavitù, si ritroveranno più tardi anche in scritti decisamente abolizionisti. È il caso, ad esempio, dell’Histoire philosophique di Raynal che presenta, in questo senso, notevoli analogie con il testo della Behn: la parte storica, infatti, è spesso una registrazione impersonale e passiva dei fatti, di fronte ai quali uno scrittore abolizionista dovrebbe invece decisamente prendere posizione, poi ci sono le grandi « tirate » ideologiche che non sempre trovano il loro armonico inserimento nel contesto. Se poi si pensa alla cautela con cui, circa nello stesso periodo, il padre Du Tertre esprimeva le sue riserve assai contenute, il testo della Behn non può non suscitare la nostra ammirazione. Anche se esiteremmo a collocarla tra i percursori del socialisme utopique, come ha fatto Lichtenberger, dobbiamo riconoscere a questa donna coraggiosa, la prima fra tutte le scrittrici che si sia guadagnata da vivere con i proventi della sua penna, di aver scritto un libro di carattere pionieristico, sia per la scelta degli eroi che per la condanna della schiavitù, inserita in un incitamento alla ribellione contro il padrone bianco che è, come abbiamo avuto occasione di rilevare a proposito del testo apparso sul « Pour et contre » di Prévost, un tipo di protesta usato con molta cautela dagli stessi abolizionisti. La presenza in questi due testi, entrambi introdotti in Francia dall’Inghilterra, di un tema comune e piuttosto insolito come quello dell’istigazione alla rivolta, ci 108 impone un tentativo di confronto, per rilevare analogie e differenze, al fine di determinare la loro probabile influenza nel processo di maturazione di un’opinione antischiavista in Francia. Ci limiteremo al rilevamento dei caratteri comuni, accantonando il problema delle possibili filiazioni ed influenze reciproche: la requisitoria di Oronoko potrebbe aver costituito, in qualche misura, il modello del discorso di Moses Bom Sam, la cui traduzione francese, a sua volta, potrebbe essere stata conosciuta e tenuta presente dal traduttore di Oroonoko (c’è, ad esempio, nel testo francese un’allusione alla necessità di mutare gli schiavi in uomini, prima della rivolta, che è assente dal testo della Behn, mentre è presente nel discorso del « Pour et contre »). Una ricerca di questo tipo rischierebbe però di essere fuoriviante e di scarsa utilità, sia in assoluto, sia in particolare, ai fini della nostra indagine. Il primo elemento in comune fra i due testi è dato dalla similitudine di condizione degli ideatori e fomentatori della rivolta, anche se i moventi, come si è potuto rilevare, non coincidono: altruistici e nati dalla chiara coscienza di alti fini sociopolitici in Moses Bom Sam, più egoistici, velleitari ed in parte irresponsabili in Oronoko. Inoltre la condizione di entrambi i personaggi è privilegiata, per ragioni diverse, e permette loro di rivestirsi di quell’alone carismatico, capace di smuovere anche le masse più amorfe. Insomma, ci troviamo in entrambi i casi di fronte ad una spinta libertaria che parte dalla massa servile, ma dietro istigazione di uomini che con quella massa non si identificano completamente. Sono esempi di tentativi di autoliberazione nati fuori del condizionamento dei bianchi, ma determinati dalla presenza di individui che sono usciti od hanno potuto restare fuori dalla massa, grazie anche a forme diverse di europeizzazione (conoscenza della lingua degli europei, dei loro costumi, della loro organizzazione, ecc). Nell’un caso come nell’altro, si ha insomma l’impressione che la massa servile non saprebbe generare dalle sue viscere il capo capace di condurla alla liberazione: sul suolo coloniale, per lottare col bianco bisogna giungere a conoscerne bene le « armi », anche attraverso una sorta di contaminazione. Altro motivo che accomuna i due testi, sia pure per un breve tratto, perché gli scopi ultimi sono ancora una volta diversi, è quello della fuga dalla comunità dei bianchi: la rivolta si concretizza non in una distruzione della piantagione e nell’uccisione dei coloni, ma in una scissione del rapporto di dipendenza, mediante l’allontanamento. Lo scopo di Moses Bom Sam è di creare una società autonoma, capace di competere con quella dei bianchi, quello di Oronoko semplicemente di arrivare alla costa e sequestrare una nave per poter far ritorno in Africa, ma nell’un caso come nell’altro la rivolta aperta su terreno « nemico » è scartata come un suicidio deciso a priori. Raggiunto e costretto a combattere, il manipolo dei seguaci di 109 Oronoko è infatti sconfitto in un batter di ciglio. Anche nella conclusione i due testi, nella traduzione francese, sembrano, apparentemente, assai vicini: lo sforzo di Moses Bom Sam tende all’amitié, il romanzo di Oronoko si conclude con abbracci, proteste d’amicizia, invii di doni agli amici coloni, dopo il ritorno in Africa. In entrambi i casi si potrebbe aver l’impressione che, superate le divergenze e le lotte, una simbolica amicizia unisca infine bianchi e neri. Ma le due realtà sono profondamente diverse: l’« amicizia » a cui tende Moses Bom Sam è veramente un incontro fra due popoli di uguale dignità, quella che unisce Oronoko ai coloni bianchi è un’amicizia fra privilegiati, fra padroni, bianchi o neri che siano, e si fa sulla pelle delle vittime di sempre: Oronoko promette al capitano che lo riporta in patria un carico di schiavi. Il seguito lo possiamo immaginare. Il testo del « Pour et contre » ci presenta insomma, attraverso la ribellione, lo sforzo comune, da parte di uomini che da tempo immemorabile conoscevano soltanto l’acquiescenza, verso la ricerca di forme di vita più dignitose, Oronoko narra invece la storia di un personaggio d’élite che, in una situazione di schiavitù « nominale », lotta per non perdere i suoi privilegi e la sua dignità di principe e di eroe (la sua e quella dei suoi congiunti). A questi fini, personali e privati, è subordinato tutto il suo agire, il che non esclude, naturalmente, che lo sforzo per portare altri compagni di schiavitù al suo livello di « coscienza » sia sincero e assuma un significato che trascende le motivazioni iniziali e reali, per mutarsi in una rivendicazione di diritti umani conculcati ed in un pamphlet contro il bianco sfruttatore ed infido. Inoltre, l’eroe nero Oronoko, con il suo fascino, le sue qualità, le sue doti carismatiche ed il suo amore per la libertà, si trasforma inevitabilmente in simbolo e come personaggio simbolico si carica di un significato cristallino che le motivazioni limitanti del suo agire non riescono ad intaccare. L’influenza del romanzo della Behn in Francia nel secondo Settecento fu notevole, come dimostrano un gran numero di romanzetti negrofili il cui modello è, senza ombra di dubbio, Oroonoko. Nel quindicennio che precede la metà del Settecento, la Francia importa dunque dall’Inghilterra due opere che non avevano alcun corrispettivo autoctono, entrambe caratterizzate dalla minaccia di una rivolta negra e da un confronto demistificante tra il mondo nero ed il mondo bianco, insomma due opere piuttosto esplosive e destinate ad avere in Francia un seguito spesso assai La Place (o Laplace), merita dunque una sua collocazione di prestigio all’interno meno ardito, salvo rare eccezioni. Il testo della Behn, tradotto e ritoccato dall’abate del movimento abolizionista, per la scelta dell’eroe ed il modo in cui vi è trattato il tema della rivolta negra, anche se il problema della schiavitù non vi è posto con chiarezza, se non esistono prese di 110 posizione contro di essa da parte dei personaggi bianchi del romanzo, se la figura di Oronoko resta elitaria e la sua partecipazione alla condizione dei compagni è pressoché inesistente. Queste limitazioni trovano, nello stesso anno, una certa compensazione nelle due scene della pièce di Southerne, tradotte dall’abate Le Blanc nelle sue Lettres d’un François. In esse è presente una commiserazione esplicita della condizione di schiavo (in assoluto, e non regale, anche se per quest’ultimo è riservata una commiserazione speciale) da parte di Inglesi che vivono nella colonia: LUCY Tous ces Malheureux sont-ils esclaves? BLANDFORD Ils sont tous vendus, eux et leur Postérité. LUCY Quel triste sort! » (19). Inoltre, Oronoko si mostra più sensibile alle sofferenze che dovranno subire i suoi compagni di sventura: « Je vous remercie, Monsieur, mais je ne puis retenir mes larmes ... mes pauvres amis sont dans les fers, leurs chaînes sont pésantes. Ils n’auront pas trouvé un si bon Maître» (Ib., II, p. 168). L’« umanità » fa però discendere il protagonista dal piedistallo dell’eroe forte e splendido, rendendolo persino un po’ piagnucoloso, quasi uno zio Tom in anticipo, ideato da una Beecher Stowe ante litteram… Note (1) D. Mornet, in Les enseignements des bibliothèques privées (1750-1780), « R.H.L.F. » 1910, pp. 449-496, p. 461, colloca Oronoko fra i nove romanzi più letti in Francia intorno alla 111 metà del Settecento. (2) Amsterdam, 1745. Nella versione francese il protagonista viene defraudato di una o e si chiama semplicemente Oronoko. (3) Abbiamo letto il testo in una « nouvelle édition » delle lettere che si intitola Lettres de Monsieur l’abbé Le Blanc, historiographe des bastimens du roi, Amsterdam, 1751. Le scene sono contenute nella lettera LVI, vol. II. Nella prefazione l’autore ci informa che, dopo la prima edizione del 1745, se ne sono fatte, a sua insaputa, molte altre, soprattutto in Olanda e in Inghilterra. (4) Sui Coromanti cfr. D. P. Mannix, op. cit., pp. 40-2. (5) Oronoko, tr. fr. citata I, pp. 48-49. (6) « I do not pretend, in giving you the history of this royal slave, to entertain my reader with adventures of feign’d hero, whose life and fortunes fancy may manage at the poet’s pleasure; nor in relating the truth, design to adorn it with any accidents, but such as arrived in earnest to him: And it shall come simply into the world, recommanded by its own proper merits, and natural intrigues... ». Abbiamo letto il testo nella versione originale in Shorter Novels: seventeenth Century, a cura di Ph. Henderson, Londra, s.d.. Il testo di Oroonoko, preceduto da una breve notizia sull’autore, vi occupa le pp. 147-224. La citazione è a p. 147. (7) I, 1956, p. 214. Cfr. anche il Dizionario letterario delle opere e dei personaggi, stesso editore, vol. V, pp. 319-320, in cui la trama della storia di Oroonoko è ritracciata in maniera piuttosto approssimativa. Per notizie più attendibili sulla vita e le opere della scrittrice vedi F. M. Link, Aphra Behn, New York, 1968. Vi si parla di Oroonoko alle pp. 139-142. Sulle controverse notizie concernenti la sua vita cfr. anche l’Introduzione di M. Antonini all’edizione di The City Heiress da lei curata, Bologna, 1978. (8) « I was myself an eye-witness to a great part of what you will find here set down; and what I coud not be witness of, I receiv’d from the mouth of the chief actor in this history, the hero himself, who gave us the whole transactions of his youth... » (p. 147). (9) « Il étoit d’ailleurs si avantageusement partagé des dons de la nature, tant pour le corps que pour l’esprit, que sa vûe inspiroit à la fois l’estime et le respect, dans le cœur de ceux même qui ne le connaissoient pas » (p. 14). (10) « On étoit encore plus surpris, de voir briller en lui, cette noble générosité, et ce caractere liant qui distingue toujours les gens bien nés. Il est vrai, qu’une partie de sa gloire en étoit dûe aux soins d’un François, homme d’esprit et de courage, qui ayant trouvé dans le Prince, un sujet propre à faire un jour un grand homme, s’étoit appliqué à perfectionner son éducation » (pp. 16-17). (11) Ricordiamo che Cesare è il nome dato ad Oronoko quando arriva come schiavo in Guiana. I nomi di eroi romani o di personaggi biblici erano di largo impiego. (12) Lichtenberger assegna al primitivismo della Behn un ruolo rilevante: « Certes, il serait exagéré de vouloir sérieusement faire d’elle la mère de Rousseau et la grand’mère de l’anarchie: il n’en est pas moins assuré que ce fut elle qui la première orienta bruyamment la littérature dans une voie nouvelle qui n’a pas encore cessé d’être parcourue ». (Mistress Afra Behn, la première « authoress» et son roman «Oroonoko», in Le socialisme utopique. Études sur quelques précurseurs inconnus du socialisme, Parigi, 1898, pp. 7-40, rist. Slatkine, 1970). (13) Il testo originale è ancora più crudo : « But Caesar told him, there was no faith in the white men, or the gods they adored; who instructed them in principles so false, that honest men could not live amongst them; though no people professed so mach, none performed so little: That he knew what he had to do when he dealt with men of honour; but with them a 112 men ought to be eternally on his guard, and never to eat and drink with Christians, without his weapon of defence in his hand; and, for his own security, never to credit one word they spoke » (p. 212). (14) Oroonoko, versione originale, cit., p. 223. (15) Swinburne l’ha definita « the first literary abolitionist (...) on record in the history of fiction » (Studies in Prose and Poetry, Londra, 1915, p. 95, citato in E. D. Seeber, Antislavery opinion in France during the second half of the eighteenth century, Baltimora, 1937, p. 28). (16) Sull’influenza di Oroonoko in Francia nel Settecento, cfr. E. D. Seeber, «Oroonoko» in France in the XVIIth century, in « Publications of Modern Language Association », LI, 1935, pp. 935-959. (17) Il corsivo è nel testo. Tutta la parte riguardante la preparazione degli schiavi è aggiunta da Laplace. (18) « And why (said he) my dear friends and fellow-sufferers, should we be slaves to an unknown people? Have they vanquished us nobly in fight? Have they won us in honourable battle? And are we by the chance of war become their slaves. This wou’d not anger a noble heart; this would not animate a soldier’s soil: no, but we are bought and sold like apes or monkeys, to be the sport of women, fools and cowards; and the support of rogues and runagades, that have abandoned their own countries for rapine, murders, theft and villanies. Do you not ear every day how they upbraid each other with infamy of life, below the wildest savages? And shall we render obedience to such a degenerate race, who have no human vertue left, to distinguish them from the vilest creatures? » (p. 207). A proposito soprattutto dei primi coloni, gli abolizionisti insisteranno spesso, nel corso di tutto il Settecento, sul fatto che sono i « rifiuti » dell’Europa. Anche questo diventerà così un luogo comune della letteratura abolizionista. Lo troviamo persino in un curioso Dictionnaire languedocien-français del 1798, di cui Gaston Bazalgues, assistente all’Università Paul Valéry di Montpellier, ha trovato (e riprodotto in fotocopia con una breve introduzione) il manoscritto della prima parte. I riferimenti alle Antille sono numerosi nel dizionario e Bazalgues ritiene giustamente che l’autore (sconosciuto) sia persona che vi ha vissuto. La voce Coulou (couleur) è interamente dedicata ai rapporti ed ai pregiudizi razziali nelle colonie, pregiudizi assurdi in uomini la cui origine è assai dubbia: « Anciennement, à la découverte de ce pays, et long-tems après, on n’envoya que des (...) hommes notés d’infamie, des filles et des femmes prostituées; on les unit, et delà la souche de la plupart de ces Créoles vains et présomptueux » (p. 239). (19) Lettres de Monsieur l’abbé Le Blanc, cit., II, p. 259. Della pièce di Southerne l’abbé Le Blanc dice: « Oroonoko est du nombre de ces Pièces remarquables par les Tableaux vrais et Pathétiques qui font un si grand effet» (Ib., p. 257). 113 MONTESQUIEU: CRITICI ED EPIGONI 114 MONTESQUIEU E IL PROBLEMA DELLA SCHIAVITÙ La posizione di Montesquieu nei confronti della schiavitù è stata attentamente esaminata dal Jameson nel lungo e documentatissimo saggio che porta appunto il titolo di Montesquieu et l’esclavage. Essai sur l’origine de l’opinion antiesclavagiste en France au XVIIIe siècle (1). Il lavoro di Jameson è ovviamente incentrato su un’analisi attenta del libro XV dell’Esprit des lois (2), preparata da un ampio excursus sull’atteggiamento del pensiero occidentale nei confronti della schiavitù, a partire dall’antichità fino a Montesquieu, e completata da una rapida (e perciò non del tutto esauriente) rassegna degli echi negativi e positivi suscitati dall’impostazione che il pensatore della Brède ha dato al problema della schiavitù. Quello di Jameson resta ancor oggi un testo di base, ma porta evidenti i segni del tempo e si dimostra abbastanza fragile proprio in quello che sarebbe dovuto essere il fulcro della ricerca e cioè l’esame del libro XV, che risulta invece più erudito che veramente significativo. Mentre tutta l’ampia parte che avrebbe dovuto costituire soltanto la premessa si rivela ancora come una preziosa fonte di informazioni, dalla quale non si può prescindere per uno studio sull’origine del pensiero antischiavista in Francia. Infine, anche se dopo il 1911 non è più stato pubblicato nessun lavoro specifico su questo aspetto dell’opera montesquiviana (3), sono usciti molti lavori sul problema della schiavitù, sui rapporti dell’Europa con il terzo mondo, sull’atteggiamento della cultura occidentale nei confronti dei modi di realizzare questi rapporti e sull’opera di Montesquieu in genere in cui, in misura più o meno ampia, si affronta il problema della schiavitù: ci sono cioè presupposti che giustificano, ci sembra, un nuovo tentativo di approccio ai testi montesquiviani in questa prospettiva. D’altro canto, uno studio del pensiero antischiavista francese del ‘700 che non tenga conto dell’opera di Montesquieu rischia di trascurare un cardine della problematica, le fondamenta su cui l’edificio abolizionista è potuto crescere con relativa rapidità. Tutti i pensatori che hanno trattato l’argomento dopo Montesquieu, esplicitamente o implicitamente, in forma critica o di consenso, hanno avuto presente 115 la sua opera. C’è chi ha visto in lui il primo pensatore che ha avuto il coraggio di prendere chiaramente posizione contro la schiavitù, chi gli ha rimproverato questo atteggiamento, chi infine lo ha accusato di ambiguità, di contraddittorietà o almeno di incoerenza e di mancanza di coraggio, per non aver decisamente affrontato il problema nel suo aspetto più urgente, che era quello della schiavitù coloniale, e di essersi rifugiato nel passato, dando alla sua analisi una prospettiva più storica che ideologica, o comunque astratta e scarsamente efficace. Le stesse incertezze di giudizio si ritrovano spesso anche nei critici di oggi (4). C’è infine chi, sul piano della documentazione storica, gli ha rimproverato inesattezze e deformazioni dei fatti e delle informazioni (5). Vale la pena vedere da vicino perché la posizione di Montesquieu abbia suscitato echi così contrastanti, che vanno dall’ammirazione entusiastica fino all’accusa di ambiguità, di superficialità e persino anche al sospetto di opportunismo. Non v’è dubbio che il libro XV si apra con una decisa presa di posizione antischiavista: « Il [l’esclavage] n’est pas bon par sa nature: il n’est utile ni au maître ni à l’esclave: à celui-ci, parce qu’il ne peut rien faire par vertu; à celui-là, parce qu’il contracte avec ses esclaves toutes sortes de mauvaises habitudes, qu’il s’accoutume insensiblement à manquer à toutes les vertus morales, qu’il devient fier, prompt, dur, colère, voluptueux, cruel » (XV, 1) (6). Secondo Montesquieu, la schiavitù è dunque uno strumento di corruzione sia del padrone che dello schiavo: di questi perché, non essendo più libero delle sue azioni, non è in condizione, e di conseguenza perde anche la capacità, di operare in base ad una scelta morale; del primo perché il potere, o meglio, il possesso assoluto che può rivendicare nei confronti di un uomo lo abitua ad un tipo di rapporto, e quindi di vita, in cui a poco a poco si perde il senso di ogni valore morale. Condanne di tono analogo servono però spesso anche d’avvio a trattati nettamente schiavisti, i cui autori, dopo essersi associati agli avversari della schiavitù nel riconoscimento dei suoi aspetti negativi sotto il profilo morale, passano poi a sostenere la sua utilità sul terreno pratico o, quel che è peggio, la sua inevitabilità all’interno dei rapporti sociali. Si tratta insomma, in questi casi, o di una sorta di captatio benevolentiae o di una preventiva spartizione dei rispettivi settori di influenza. Ad esempio, l’incipit del trattato schiavista di Linguet (7) merita di essere citato 116 per il senso di orrore che ne promana nei confronti di quella schiavitù di cui egli si farà poi il sostenitore, sia pure non compiaciuto: « Ce mot (quello di schiavo) emporte la destruction de tous les droits de l’humanité pour l’être auquel il est appliqué. Ce n’est plus un homme: c’est, suivant les occurrences, un instrument insensible ou une bête de charge agissante. Il ne peut plus voir par ses yeux; il ne peut plus suivre que les mouvemens d’une volonté étrangère. Tant qu’il reste dans cet état, son existence même n’est pas à lui... » (8). D’altra parte, anche l’inizio del Mémoire sur l’esclavage des nègres di Malouet (9), scritto per migliorare, e quindi rafforzare, la schiavitù coloniale pone proprio l’accento sul potere di corruzione che essa esercita nei confronti dei padroni: « L’esclavage et le traitement des Nègres, en Amérique, présente des idées tristes à tout homme sensible et sans enthousiasme; c’est une occasion de scandale et de déclamation pour les Ecrivains politiques, qui traitent des principes et des droits de la Société; c’est véritablement pour les Colons un moyen de corruption et de désordre... ». Letti senza conoscere nulla dei rispettivi autori i tre passi possono essere ragionevolmente considerati come risultanti da una sostanziale identità di visione del problema, mentre la realtà che li sottende è ben diversa. Non è certo senza importanza il fatto che gli ultimi due autori citati scrivano posteriormente a Montesquieu, l’uno (Linguet) in aperta l’altro in velata polemica con lui; è infatti legittimo supporre che un tale inizio delle loro opere sia stato opportunamente scelto al fine di dimostrare come la morale abbia poco a che fare con i problemi sociopolitici e soprattutto come le premesse di Montesquieu non portino necessariamente alle conclusioni alle quali egli è giunto. Tutto questo sta però anche a dimostrare che una premessa, sia pure così decisamente critica, non può da sola esaurire l’atteggiamento di un pensatore nei confronti della schiavitù: soltanto il contesto potrà rivelarne il carattere programmatico o semplicemente strumentale. Che in Montesquieu il passo, contrariamente agli altri autori citati, abbia un valore programmatico, lo si può rilevare da quanto segue. Dopo avere infatti 117 contestato la schiavitù sotto la spinta di ragioni morali, egli vuole anche dimostrare l’infondatezza delle argomentazioni di carattere giuridico che ne costituiscono la base e, a proposito della schiavitù coloniale, la meschinità dei pregiudizi e la mistificazione dei valori che ne hanno resa possibile la nascita e l’accettazione in larghi strati dell’opinione pubblica. La premessa trova così in lui un coerente sviluppo nell’impostazione data al resto del discorso. Con una considerazione di carattere morale si apre anche il secondo capitolo, in cui l’autore prende in esame i princìpi che hanno dato origine alla schiavitù e l’hanno regolata nella legislazione romana, alla quale si sono in seguito richiamati tutti i giuristi ed i pensatori politici del mondo occidentale. Egli pone l’accento sulle storture, in materia di legislazione, a cui sono stati indotti i giureconsulti romani, quando hanno creduto di rispondere ad esigenze umanitarie creando un corpo di leggi che contemplassero e regolassero la schiavitù: « On ne croirait jamais que c’eût été la pitié qui eût établi l’esclavage, et que pour cela elle s’y fût prise de trois manières. Le droit des gens a voulu que les prisonniers fussent esclaves, pour qu’on ne les tuât pas. Le droit civil des Romains permit à des débiteurs que leurs créanciers pouvaient maltraiter, de se vendre eux-mêmes; et le droit naturel a voulu que des enfants, qu’un père esclave ne pouvait plus nourrir, fussent dans l’esclavage comme leur père » (XV, 2). Le ragioni adottate dai giureconsulti romani per legalizzare la schiavitù sono, a parere di Montesquieu, prive di senso. Dire infatti che la schiavitù è un mezzo, in periodo di guerra, per salvare il prigioniero dalla morte significa non tener conto di una delle regole fondamentali della guerra che consiste, appunto, nel diritto di uccidere soltanto in caso di necessità: ora, è evidente che se invece di uccidere un uomo lo si fa prigioniero, il caso di necessità non sussiste, di conseguenza le ragioni addotte non possono essere considerate valide. Prima di passare all’analisi della confutazione montesquiviana degli altri punti, è opportuno ricordare le posizioni assunte dai giuristi e pensatori di fama che lo hanno preceduto, almeno negli ultimi secoli, al fine di porre in giusta luce il carattere innovativo della sua riflessione (10). Sia Grozio che Pufendorf, sia Hobbes che Locke hanno accettato il principio della schiavitù del vinto, pur intendendo in modi diversi il passaggio dalla prigionia alla schiavitù. Per Hobbes, ad esempio, il prigioniero di guerra diventa servo del vincitore soltanto quando accetta di cedere la libertà in cambio della vita: alla base della schiavitù c’è dunque, secondo Hobbes, non la 118 semplice vittoria, ma un patto che presuppone il consenso del vinto (Leviatano, II, XX, 5). Mentre Locke, che non riconosce all’uomo la possibilità di alienare la propria libertà, accetta la schiavitù soltanto come una sorta di imposizione, una continuazione dello stato di guerra: « Questa è la condizione perfetta della schiavitù, che non è altro che uno stato di guerra continuato tra un conquistatore legittimo e un prigioniero; perché una volta che intervenga fra di essi un contratto e si faccia un accordo per legittimare il potere da un parte e l’obbedienza dall’altra, lo stato di guerra e di schiavitù cesserebbe fin tanto che dura il contratto, perché, come si è detto, non si può con un accordo trasmettere a un altro ciò che non si ha in proprio, cioè a dire il potere sulla propria vita » (11). Grozio, che fa continuamente appello alla clemenza, all’umanità, all’equità, tanto da tralasciare nelle sue innumerevoli citazioni del testo biblico quei passi che potrebbero suonare come autorizzazione o invito alla severità dei padroni (12), preferisce certamente il riscatto alla schiavitù, ma non condanna quest’ultima, ritenendola conseguenza legittima di una giusta guerra (13). Su una posizione analoga si allinea anche Pufendorf. C’è però un pensatore che molto prima di Montesquieu e spesso in maniera più decisa e coerente di lui ha condannato la schiavitù, dopo averne a lungo analizzato le ragioni a favore e quelle contrarie: si tratta di Jean Bodin. Contro una delle argomentazioni più inattaccabili, e cioè la durata nel tempo e la qualità dei consensi alla schiavitù, che chiamava come prova a favore perfino la stessa esistenza delle monarchie (14), Bodin oppone una distinzione netta tra fenomeni naturali e fatti umani: « Et quant à ce qu’on dit que la seruitude n’eust pas duré si longuement, si elle eust ésté contre nature: cela est bien vray ‘es choses naturelles, qui de leur proprieté suyuent l’ordonnance de Dieu immuable: mais ayant donné à l’homme le chois du bien & du mal, il contreuient le plus souent à la défense & choisit le pire contre la loy de Dieu et de nature. Et l’opinion deprauee en luy a tant de pouoir, qu’elle passe en force de loy, qui a plus d’autorité que la nature, de sorte qu’il n’y a si grande impieté, ni meschanceté, qui ne soit estimee, & iugee vertu et pieté » (p. 35). Quanto ad altri sofismi portati in campo per giustificare l’obbedienza e la 119 sottomissione completa, come un sano tirocinio al comando, perché soltanto colui che ha saputo obbedire sa anche comandare, Bodin li brucia senza mezzi termini, sostenendo « qu’il n’y a rien qui plus ravale et abastardisse le cœur bon et genereux, que la seruitude... » (p. 46). Ma l’attacco più violento Bodin lo lancia contro la schiavitù dei vinti, perché la si è voluta mistificare come una scelta umanitaria, mentre è soltanto una crudele scelta d’interesse: « De dire que c’est une charité louable garder le prisonnier qu’on peut tuer, c’est la charité des voleurs et corsaires, qui se glorifient d’auoir donné la vie à ceux qu’ils n’ont pas tués (...) encore moins y a de charité de garder les captifs, pour en tirer gain, et proffit comme de bestes. Et qui est celuy, qui espargne la vie du vaincu, s’il en peut tirer plus de proffit en le tuant, qu’en luy sauuant la vie? » (pp. 35-36). La critica alla schiavitù da parte di Bodin, se da un lato è il prodotto di una visione pessimistica dell’uomo, portante il peso della colpa di Adamo, e trae quindi sostanza da motivazioni arcaiche, d’altro lato sembra tanto moderna da far pensare a Pierre Bayle ed alla sua critica della tradizione e dell’universalità e continuità dei consensi come malleveria di verità ed attendibilità delle nostre conoscenze e delle nostre credenze. E del resto, segno della modernità di Bodin e della sua attenzione ai fenomeni del suo tempo, è la preoccupazione con cui assiste all’impiantarsi della schiavitù nei paesi scoperti di recente e la lucidità con cui ha denunciato i pericoli che possono derivare anche alla stessa Europa dallo scorretto comportamento spagnolo (all’epoca la Francia non era ancora « implicata » nel traffico negriero e non aveva colonie in America): « ... Les Espagnols, ayant conuerti les Neigres à la religion chrestienne, les retiennent neantmoins, & toute leur posterité comme esclaues. Et quoy que l’Empereur Charles V. eust affranchi tous les esclaues des Indes Occidentales par edict general, faict l’an M.D.X.L. neantmoins pour les rebellions des ministres & gouuerneurs, & l’auarice des marchands, & mesme du Roy du Portugal, qui en tient des haraz comme de bestes, il a esté impossible de l’executer (...) Voilà l’occasion d’auoir renoué les seruitudes par tout le monde, hormis en ce quartier d’Europe, qui en sera bien tost rempli, si les Princes n’y mettent bon ordre: car on ne fait maintenant plus grande traffique, mesme en Orient... » (p. 44) (l5). 120 Fuori dei condizionamenti con cui ha dovuto inevitabilmente fare i conti Montesquieu, per quanto attiene alla schiavitù coloniale, Bodin si è mostrato, ci sembra, meno esitante di lui nella condanna. Del resto già per Bodin la schiavitù è negativa sotto tutti i profili, sia per il padrone che per lo schiavo: l’unica eccezione che egli sembra ammettere è una sorta di « schiavitù d’elezione » (cui si fa riferimento nei testi sacri) di colui che, dopo aver servito un padrone per sei anni, come voleva la tradizione ebraica, decide, per libera scelta, di restare con lui. Ma Bodin non sembra credere molto a questa eventualità, come dimostra la citazione di questo antico proverbio: « autant d’ennemis que d’esclaues » (16). Montesquieu, nel libro XV, non fa alcun riferimento a Bodin, ma non cita neppure nessuno degli illustri predecessori che avevano prima di lui dibattuto il problema della schiavitù (17). Anche per quanto riguarda la contestazione degli altri due punti su cui la legislazione antica aveva fondato l’istituto della schiavitù, Montesquieu non si muove su un terreno totalmente vergine. Se nessuno infatti dei pensatori cui abbiamo più sopra accennato (ad eccezione di Bodin) aveva globalmente preso posizione contro la schiavitù, c’erano già tuttavia dei punti controversi. Locke, ad esempio, aveva negato, con parole di cui si ritrova certamente eco in Montesquieu, che un cittadino potesse rinunciare alla propria libertà: « ...l’uomo non avendo il potere della propria vita, non può per contratto e con il proprio consenso, rendersi schiavo di alcuno, né porsi sotto il potere assoluto e arbitrario di un altro, che gli possa togliere la vita quando vuole. Non si può conferire ad altrui un potere maggiore di quello che si possiede » (18). Il n’est pas vrai qu’un homme puisse se vendre (...). S’il n’est pas permis de se tuer, parce qu’on se dérobe à sa patrie, il n’est pas plus permis de se vendre. La liberté du citoyen est une partie de la liberté publique (XV, 2). Come si può vedere, quindi, Locke aveva preceduto su questo punto Montesquieu, che avrà comunque il merito di precisare e rafforzare la condanna e, soprattutto, di inserirla in un sistema di rifiuto globale della schiavitù. Infine, anche il terzo punto e cioè la schiavitù per eredità, la cui confutazione Montesquieu fa derivare dalle due precedenti («... si un homme n’a pu se vendre encore moins a-t-il pu vendre son fils qui n’étoit pas né. Si un prisonnier de guerre ne peut être réduit en servitude, encore moins ses enfants », XV, 2), non aveva mancato di suscitare almeno alcune perplessità. 121 Grozio, ad esempio, ammette che il figlio di uno schiavo possa essere tenuto in schiavitù per ripagare il padrone delle spese causate dal suo mantenimento (e questo potrebbe richiedere anche un’intera vita), ma riconosce, almeno in linea di principio, che costui ha diritto alla libertà dopo aver ripagato il padrone. Non si tratta perciò per Grozio di un diritto di eredità da parte del padrone nei confronti del figlio di un suo schiavo, ma di un « giusto » rimborso delle spese che il mantenimento del bambino gli ha occasionato. Inoltre, se il padrone lo maltratta, lo schiavo può abbandonarlo. Questo non significa rifiutare la posizione classica, ma certamente orientarla in un senso che potrebbe risultare meno pesante: un diritto ereditario non ha infatti limiti di tempo, mentre si possono ragionevolmente fissare, in teoria, i tempi di un rimborso. Alcuni anni prima della pubblicazione dell’Esprit des Lois c’era stato tuttavia un pensatore francese, che aveva decisamente condannato il destino riservato ai figli degli schiavi. Si tratta di Richer d’Aube che, nell’Essai sur les principes de droit et de morale (1743), si era espresso in termini assai espliciti: « On ne peut trouver de légitime fondement à l’esclavage d’un enfant vendu par son père, ni à celui des enfants, qui ne sont esclaves que parce que leurs pères et mères l’étoient ou du moins leurs mères » (19). Come ci si può rendere conto, si tratta di limitazioni e resistenze marginali o comunque parziali (eccezion fatta di Jean Bodin e, in parte, di Locke); il grande merito di Montesquieu sta nell’averle riunite in un sistema organico di chiara ispirazione antischiavista. Nel confrontare le leggi che sanzionano la schiavitù con tutte le altre che sono alla base della vita associata, Montesquieu pone l’accento sul carattere negativo delle prime, in rapporto alla società stessa, in quanto ne violano il principio fondamentale: la legge deve infatti tutelare gli interessi di tutti, anche di colui che è punito per averla violata, mentre la legge che legittima la schiavitù non potrà mai essere utile allo schiavo, perché è fatta unicamente contro di lui e non a suo favore. Un uomo che si trova a vivere in queste condizioni è dunque escluso dalla società e non esiste perciò nessuna legge civile che possa vietargli la fuga, poiché le leggi civili non lo concernono. La posizione di Montesquieu ci sembra molto chiara, anche se la conclusione del capitolo (« Il [lo schiavo] ne peut être retenu que par une loi de famille, c’est-à-dire, la loi du maître ») ha giustamente suscitato alcune perplessità nel Jameson, che l’ha giudicata suscettibile di usi pericolosi. Il contesto nel quale è inserita fa pensare ad una denuncia, da parte di Montesquieu, di una situazione che aliena lo schiavo alla società, tuttavia non è infondato il rilievo mosso dal Jameson 122 sulla gravità dei risultati a cui può portare il modo ambiguo in cui la denuncia è formulata: « La portée de cette phrase est moins défavorable à l’esclavage qu’on ne pourrait croire à première vue. Est-ce que Montesquieu veut laisser aux maîtres une liberté entière de régenter leurs affaires selon leur gré? (...) Quand même les esclaves ne seraient pas dans la société, il vaut mieux que les lois civiles interviennent pour les protéger; pourquoi donc pas pour les punir? » (p. 311). Non è però questo, a nostro avviso, il senso da dare alla frase di Montesquieu; ci sembra piuttosto che essa debba interpretarsi come la dimostrazione lampante della negatività di un’istituzione pubblica che può reggersi unicamente su leggi private. Dopo aver esaminato, nel secondo capitolo, le origini della schiavitù presso i Romani, Montesquieu cerca di cogliere, nei capitoli seguenti, quelle della schiavitù coloniale e dedica un intero capitolo, il quinto, alla schiavitù negra. Può sembrare poco in un libro di diciannove capitoli, soprattutto se si tiene conto del fatto che il terzo ed il quarto sono molto brevi e che l’argomento era dei più vivi e brucianti. Si può anche avere l’impressione che egli abbia voluto eludere il problema attuale, o comunque affrontarlo soltanto dietro lo schermo protettivo che gli offriva la lontananza nel tempo e nello spazio. È anche possibile che questa componente non sia estranea alla strutturazione del libro XV, ma se si leggono attentamente i tre capitoli, ci si renderà conto che, con un procedimento di sintesi efficacissimo, sorretto da un’ironia tagliente, Montesquieu ha posto l’accento sui punti cruciali del problema ed ha colpito senza esitazione. Si potrà forse obiettare che anche l’ironia è una forma di schermo, un mezzo per aggirare gli ostacoli, per sdrammatizzare una situazione e quindi, in ultima analisi, per non lasciarsi coinvolgere totalmente, una forma di elusione insomma, e l’obiezione può non essere priva di fondamento. Ma anche se così fosse, il solo fatto che Montesquieu abbia sentito la necessità di prendere le distanze dalla materia trattata, ci sembra dimostri quanto egli si senta coinvolto, anche emotivamente, non solo per un senso di umana solidarietà verso le vittime, ma anche per una profonda delusione nel rilevare il peso che pregiudizi e falsi valori avevano avuto e continuavano ad avere nel dirigere la condotta degli uomini. Ed è proprio su questi pregiudizi che egli appunta la sua attenzione e dirige la ferula della sua ironia. Ma il procedimento a cui ha fatto ricorso Montesquieu in questi capitoli (e in nessun altro del libro XV), potrebbe anche non essere il risultato, più o meno inconscio, di un bisogno di prendere le distanze dalla materia trattata, quanto piuttosto la lucida scelta dello strumento più efficace di cui disponesse lo scrittore. Se 123 esiste infatti un caso in cui si possa dire che la materia ha creato o ha trovato la « sua » forma, è proprio questo: quale mezzo più efficace dell’ironia potrebbe colpire uomini che hanno fondato il loro diritto di appropriarsi dei beni e della persona di altri uomini sul disprezzo, la derisione, il pregiudizio della superiorità? Al disprezzo egli risponde con il disprezzo, alla derisione con la derisione, e la presunta superiorità degli Europei crolla sotto questi colpi. Chi potrebbe infatti sostenere che esista una reale differenza tra uomini che si muovono e agiscono soltanto per impossessarsi di qualche pezzo di metallo dorato ed altri, i quali non sanno che farsene, ma che ricercano invece perline o collane di vetro? Si tratta in ogni caso di falsi valori, che trovano una spiegazione logica della loro diversità nella diversità di strutturazioni sociali e di civiltà, ma egualmente meschini e risibili, per cui operare in nome dell’uno piuttosto che dell’altro non autorizza a ritenersi superiori e quindi arbitri dei destini dell’umanità. Montesquieu è stato lucidissimo nel denunciare il « razzismo » (20), di ogni natura, che sta alla base dell’oppressione e dell’asservimento dei popoli operato dagli Europei: « J’aimerais autant dire que le droit de l’esclavage vient du mépris qu’une nation conçoit pour une autre, fondé sur la différence des coutumes » (XV, 3). Richiamandosi all’autorità di uno storico spagnolo, Lopez de Gómara (21), egli propone un episodio della conquista spagnola come simbolico della mentalità con cui gli Europei si sono accostati ai popoli del Nuovo Mondo: nella città di Santa Marta, in Columbia, gli Spagnoli trovarono gli indigeni con panieri pieni di granchi, lumache, cavallette e cicale, raccolte a scopo alimentare e « en firent un crime aux vaincus »: « L’auteur avoue que c’est là-dessus qu’on fonda le droit qui rendit les Américains esclaves des Espagnols: outre qu’ils fumaient du tabac, et qu’ils ne se faisaient pas la barbe à l’espagnole » (Ib.). Montesquieu conclude tristemente, osservando che le conoscenze rendono gli uomini « doux », la ragione li rende umani, mentre i pregiudizi sono soltanto strumenti di chiusura, non ultimo fra di essi il pregiudizio religioso. La connivenza della Chiesa e le storture di tipo religioso hanno infatti costituito un supporto insospettato e saldissimo alla conquista e all’asservimento dei popoli: 124 « J’aimerais autant dire que la religion donne à ceux qui la professent un droit de réduire en servitude ceux qui ne la professent pas, pour travailler plus aisément à sa propagation » (XV, 4). Proprio questa interpretazione dei « doveri » del cristiano incoraggiò i delitti dei distruttori dell’America e costituì una base al diritto di rendere schiavi altri popoli, « car ces brigands, qui voulaient absolument être brigands et chrétiens, étaient très dévots ». Come sintomatico di questa mentalità, Montesquieu riporta un aneddoto raccontato dal padre Labat nel suo Nouveau voyage aux îles de l’Amérique (1722), secondo il quale Luigi XIII, dopo aver esitato a lungo prima di concedere ai coloni francesi l’autorizzazione a servirsi di schiavi negri, si arrese, infine quando lo convinsero che era la strada più sicura per ottenerne la conversione (22). Sulla strumentalizzazione della religione e sull’opportunismo del suo uso, e quindi delle sue interpretazioni, Montesquieu si era già soffermato abbastanza crudamente nelle Lettres persanes: « Il y a longtemps que les princes chrétiens affranchirent tous les esclaves de leurs Etats, parce que, disaient-ils, le christianisme rend les hommes égaux. Il est vrai que cet acte de religion leur était très utile: ils abaissaient par là les seigneurs, de la puissance desquels ils retiraient le bas peuple. Ils ont ensuite fait des conquêtes dans des pays où ils ont vu qu’il leur était avantageux d’avoir des esclaves; ils ont permis d’en acheter et d’en vendre, oubliant ce principe de religion qui les touchait tant. Que veux-tu que je te dise? Vérité dans un temps, erreur dans un autre » (Lettera LXXV). Dopo aver criticato globalmente i pregiudizi (talvolta soltanto maschera degli opportunismi) che hanno condotto gli Europei all’assoggettamento di altri popoli, Montesquieu dedica l’intero capitolo quinto, il più lungo dei tre, alla schiavitù negra, che rappresentava indubbiamente ai suoi tempi il fenomeno schiavistico più grave. Certo, egli avrebbe potuto elencare le ragioni portate avanti dagli schiavisti e confutarle per dimostrarne, come aveva fatto con le teorie dei giureconsulti romani, l’infondatezza e la superficialità. Ciò gli avrebbe forse risparmiato certe critiche che gli sono state mosse per aver trattato scherzosamente un argomento serio, o l’ingiuria (postuma) di una lettura del testo in chiave schiavista (23), ma la condanna sarebbe poi risultata più decisa ed efficace? In un processo di sintesi davvero straordinario, Montesquieu è riuscito, ricorrendo all’ironia e all’espediente di far parlare un « supposto » sostenitore della schiavitù, a condensare, in un discorso brevissimo e martellante, l’essenziale delle dottrine schiaviste e la loro più feroce critica, sgorgante 125 dall’interno e corrosiva come vetriolo. Gli è bastato, per far questo, orientare dapprima i lettori verso un’interpretazione corretta del testo, dando loro una chiave di lettura con un incipit di senso inequivocabile: « Les peuples d’Europe, ayant exterminé ceux de l’Amérique, ils ont dû mettre en esclavage ceux de l’Afrique, pour s’en servir à défricher tant de terres » (XV, 5). Poi citare semplicemente le teorie approntate a sostegno della schiavitù coloniale, con leggerissime deformazioni, ma così minime da poter venir male interpretate, se il passo viene estrapolato dal suo contesto. Ne risulta una delle pagine critiche più incisive che Montesquieu abbia scritto. Egli vi denuncia l’avidità ed i pregiudizi razziali, religiosi e culturali che hanno condotto gli Europei alla legittimazione di tutti gli abusi perpetrati nei confronti dei popoli africani. Fa rilevare l’abisso profondo ed incolmabile esistente tra la « qualifica » di cristiani e un comportamento che ne è la più evidente smentita. Pone i sovrani europei di fronte alle loro responsabilità servendosi, in questa denuncia serrata e globale, del procedimento logico più rigoroso e collaudato, quello del sillogismo, che va però letto con segno rovesciato: « De petits esprits exagèrent trop l’injustice que l’on fait aux Africains. Car, si elle était telle qu’ils disent, ne serait-il pas venu dans la tête des princes d’Europe, qui font tant de conventions inutiles, d’en faire une générale en faveur de la miséricorde et de la pitié? » (XV, 5). Fino a questo punto, cioè fino al capitolo quinto, l’atteggiamento di Montesquieu non presenta incertezze: tutte le giustificazioni portate avanti per legittimare la schiavitù, nel mondo antico e nel mondo moderno, sono, a suo parere, sofismi che non reggono ad un semplice esame obiettivo e disinteressato. A partire dal capitolo sesto, lo storiografo e l’uomo di legge prendono la mano all’ideologo e si può aver l’impressione che nel rifiuto si insinuino ora delle attenuanti. Ma se questa è la prima impressione che si può ricevere da una lettura non approfondita, ad un esame più attento ci si rende conto che la sostanza del discorso non cambia, anche se la nuova prospettiva in cui è visto il problema attenua indubbiamente il linguaggio critico. Finché si trattava infatti di esaminare le origini « ideologiche » della schiavitù, Montesquieu ne aveva mostrato senza esitazioni la meschinità e l’infondatezza ma, quando si passa a considerare le cause « naturali », la condanna non ha più senso. Si 126 tratta piuttosto di vedere quale è la loro influenza reale e in che misura possono essere responsabili di un certo tipo di organizzazione sociale. È appena il caso di ricordare quanta importanza abbia attribuito Montesquieu all’influenza delle condizioni ambientali sulla organizzazione dei popoli. Non bisogna inoltre dimenticare il titolo del libro XV, Comment les lois de l’esclavage civil ont du rapport avec la nature du climat, che sembra privilegiare le cause naturali rispetto a tutte le altre nell’esaminare il fenomeno della schiavitù, anche se poi il problema dell’influenza climatica occupa uno spazio brevissimo del libro. Vi sono infatti dedicati soltanto i capitoli settimo ed ottavo, che costituiscono più un approccio all’argomento che una trattazione approfondita ed esauriente di esso. Il discorso resta infatti aperto: all’interdipendenza tra clima e schiavitù prospettata all’inizio del settimo capitolo, si oppongono, a chiusura dell’ottavo, le ragioni dell’intelletto (o del cuore?) che spezzano ogni forma di determinismo e propendono per una scissione del rapporto, individuando la causa vera di ogni forma di schiavitù non nelle condizioni ambientali, ma nella cattiva legislazione. Ciò non toglie che, pur nell’incertezza dell’atteggiamento e nella cautela usata da Montesquieu per evitare di dare alla schiavitù un fondamento naturale, il discorso d’apertura del capitolo settimo non possa autorizzare ad una tale conclusione. Forse è proprio perché si è reso conto di questo pericolo che, nonostante il titolo dato al libro XV, ha rinviato la trattazione dell’argomento al settimo capitolo e l’ha liquidato molto in fretta alla fine dell’ottavo, senza riuscire ad evitare, o forse inserendo di proposito, una divergenza così notevole tra il discorso d’apertura e quello di chiusura da dar l’impressione dell’elisione reciproca e quindi, di fatto, della non-trattazione del soggetto. Ci sembra che l’atteggiamento sia dettato a Montesquieu dal bisogno di schivare il pericolo che le sue argomentazioni possano favorire la causa della schiavitù coloniale. Ma sulla pagina scritta tutte le letture diventano possibili, soprattutto se il testo lascia un margine di indeterminatezza, per poco che si isolino o si forzino certi elementi del discorso, e nel testo di Montesquieu non mancano elementi che possono essere usati ai fini di una difesa della schiavitù. Basti pensare alla sicurezza con cui enuncia la sua tesi sull’interdipendenza tra clima e schiavitù all’inizio del settimo capitolo. Essa viene progressivamente sfumata nel corso del capitolo medesimo e decisamente smentita in quello seguente, ma, isolato dal contesto, il passo d’apertura del capitolo settimo, può certamente apparire come un deciso appoggio alla tesi climatica, a cui si ricorreva per giustificare la schiavitù negra: 127 « Il y a des pays où la chaleur énerve le corps, et affaiblit si fort le courage que les hommes ne sont portés à un devoir pénible que par la crainte du châtiment. L’esclavage y choque donc moins la raison » (XV, 7) (24). Era un’affermazione grave in un paese schiavista, che individuava nel clima caldo delle Antille la ragione incontrovertibile della necessità di ricorrere all’impiego di manodopera negra, e nella pigrizia del negro (anch’essa, del resto, prodotta dal clima) la giustificazione delle catene e della frusta. Non ci stupisce dunque che gli schiavisti abbiano potuto trovare in Montesquieu, che per altro verso ha così severamente condannato la schiavitù, un’autorità di sicuro prestigio a cui richiamarsi in materia di giustificazione climatica. A partire dalla decisa affermazione iniziale del capitolo settimo, Montesquieu ricorre però a un processo di costante attenuazione, attraverso precisazioni, limitazioni ed esempi, al fine di evitare quella che gli sembra la più pericolosa delle interpretazioni, e cioè che la schiavitù sia un fenomeno sociale fondato sulla natura. Il riferimento a cause naturali richiama infatti inevitabilmente la concezione aristotelica degli « schiavi per natura » e Montesquieu se ne rende conto, facendo lui stesso l’accostamento per precisare il senso del suo discorso, in opposizione ad Aristotele: « Aristote veut prouver qu’il y a des esclaves par nature, et ce qu’il dit ne le prouve guère. Je crois que, s’il y en a de tels, ce sont ceux dont je viens de parler. Mais, comme tous les hommes naissent égaux, il faut dire que l’esclavage est contre nature, quoique dans certains pays il soit fondé sur une raison naturelle... » (XV, 7) (25). Il testo non riesce a spogliarsi totalmente di un senso di incertezza e di ambiguità: esistono cause naturali che possono spiegare il nascere della schiavitù senza tuttavia toglierle il suo carattere di istituzione « innaturale ». È possibile che cause naturali diano origine a sistemi sociali contro natura? Il problema esiste, e per risolverlo Montesquieu deve spostare il discorso ad un livello diverso ed introdurre un nuovo elemento che muti i termini del rapporto, facendo delle cause naturali non più le forze prime che operano nella formazione di un tipo di organizzazione sociale, ma semplicemente un humus fecondo sul quale possono impiantarsi, con maggior possibilità di riuscita, le cause reali. In questo modo lo stretto rapporto di dipendenza fra clima e schiavitù, enunciato 128 all’inizio del settimo capitolo, è scisso a conclusione dell’ottavo, per mettere in luce la causa vera che si nasconde dietro la facciata delle condizioni ambientali e delle conseguenti diversità psico-fisiologiche: « Parce que les lois étaient mal faites on a trouvé des hommes paresseux: parce que ces hommes étaient paresseux, on les a mis dans l’esclavage » (XV, 8). La pigrizia, cioè la tendenza di certi uomini o di certi popoli ad evitare ogni tipo di occupazione e quindi a fissarsi all’interno di una società come una sorta di cancro parassita, che sembra giustificare la coercizione come solo mezzo di recupero, non è quindi originata da cause naturali, ma da errati interventi dell’uomo, non è il prodotto di un guasto fisico, ma di un guasto spirituale e morale. Ed è sulla base di questi errori che si stabilisce una strutturazione aberrante della vita sociale: le condizioni naturali possono tutt’al più favorirne la nascita. Nel corso di due brevi capitoli Montesquieu ha dunque totalmente rovesciato le sue posizioni iniziali, fino a togliere reale consistenza ad una causa che sembrava aver tanto peso da rendere persino meno odiosa un’istituzione contro natura? Il discorso è molto più complesso anche per Montesquieu, che cerca di uscire dalla contraddizione senza tuttavia riuscirvi completamente, anche perché un certo dubbio sulla possibile interdipendenza tra schiavitù e condizioni ambientali, nonostante le conclusioni negative, sussiste in lui (26). E del resto, negare totalmente questa interazione non avrebbe significato per lui rimettere in discussione i princìpi che sono alla base dell’Esprit des lois? È un dilemma grave. La sua umanità si rifiuta (o vorrebbe rifiutarsi) di legare la schiavitù a condizioni ambientali, perché farlo significherebbe, in ultima analisi, ammettere che esistono uomini o popoli ai quali è più consona la schiavitù che la libertà, anche se ciò avviene, contrariamente a quanto aveva affermato Aristotele, per ragioni esterne alla loro natura. Ma la sua serietà di ricercatore e di studioso gli impone di lasciare un margine al dubbio sulle ragioni che lo spingono a cercare al di fuori delle condizioni climatiche le cause della schiavitù: obbedisce nel far ciò alla voce dell’intelletto, e cioè ad una visione obiettiva della realtà, o ad una visione « affettiva »? Il dubbio è così espresso: « Je ne sais si c’est l’esprit ou le cœur qui me dicte cet article-ci. Il n’y a peutêtre pas de climat sur la terre où l’on ne pût engager au travail des hommes libres » (XV, 8) (27). 129 È un terreno sul quale lo scrittore sembra muoversi a disagio, e questo potrebbe spiegarci perché ha liquidato in fretta un aspetto del problema che, stando al titolo del libro, avrebbe dovuto costituire il perno della discussione. Insomma, Montesquieu riconosce l’esistenza di cause naturali che possono favorire il nascere della schiavitù, senza tuttavia giustificarla, restando essa sempre un misfatto contro natura di cui l’uomo è totalmente responsabile. A ben guardare dunque, il suo atteggiamento di severa condanna non è venuto meno neppure in questi capitoli e tuttavia, all’interno di essi, non sono poche le incertezze e le affermazioni che possono dar adito ad interpretazioni permissive in senso schiavista, quali il già ricordato incipit nel capitolo settimo, o quello dell’ottavo: « Il faut donc borner la servitude naturelle a de certains pays particuliers de la terre. Dans tous les autres, il me semble que, quelque pénibles que soient les travaux que la société y exige, on peut tout faire avec des hommes libres » (XV, 8). È il riconoscimento di una diversità ambientale che permette atteggiamenti diversi nei riguardi della schiavitù: di esclusione assoluta da un lato, di accettazione dall’altro. Per annullare il significato inequivocabile di queste affermazioni non basta più purtroppo che il discorso generale arrivi persino a metterle in dubbio e a svuotarle di senso. Sono là, sono una breccia aperta nel compatto muro che Montesquieu aveva opposto alla schiavitù. Ed una breccia assai pericolosa perché la giustificazione climatica era il cavallo di battaglia degli schiavisti coevi ed una delle più difficili da smantellare, in quanto spostava il dibattito dal piano ideologico a quello dei dati di fatto, a cui non si potevano opporre parole, ma altri dati di segno opposto. Dati che, in buona fede, non era molto facile reperire, senza una lunga esperienza di vita coloniale. Eppure Montesquieu, come risulta già dalle Lettres persanes, non aveva mai approvato lo spreco di vite che aveva occasionato la scoperta dell’America e il conseguente spopolamento dell’Africa, anche se i termini della critica possono già sembrare discutibili: « Ce qu’il y a de singulier, c’est que cette Amérique, qui reçoit tous les ans de 130 nouveaux habitants, est elle-même déserte et ne profite point des pertes continuelles de l’Afrique. Ces esclaves, qu’on transporte dans un autre climat y périssent à milliers (...). Il n’y a rien de si extravagant que de faire périr un nombre innombrables d’hommes pour tirer du fond de la terre de l’or et de l’argent... » (28). Vi ritroviamo la consueta condanna dei falsi valori in nome dei quali si muovono gli uomini, ma i termini usati per condannare dei veri e propri genocidi sono, a dir poco, stupefacenti. La morte di migliaia di uomini diventa sotto la penna di Usbek un fatto « singulier » e « extravagant ». Dunque, fin dai tempi delle Lettres persanes, Montesquieu aveva preso le sue distanze dagli schiavisti, anche se gli si può rimproverare, proprio fin da allora, di non essere stato più deciso nella condanna. Questo può cominciare a spiegarci le ragioni delle opposte interpretazioni a cui si è prestata l’opera di Montesquieu. Il resto del libro XV si muove ancora tutto fra la condanna decisa dell’ideologo: « Le cri pour l’esclavage est donc le cri du luxe et de la volupté, et non pas celui de l’amour et de la félicité publique » (XV, 9). e l’analisi puntigliosa dello storico, comportante anche l’esame di problemi che la presa di posizione dell’ideologo sembrava rendere superflui e persino « blasfemi », quali ad esempio le precauzioni da prendere, da parte del legislatore, per evitare gli abusi e i pericoli della schiavitù. Precauzioni che tendono inevitabilmente a rinsaldarla, invece che a distruggerla. Passando dal terreno ideologico e dei princìpi, a quello dei fatti, l’ottica di Montesquieu sembra totalmente mutata: non si tratta più di vedere se la schiavitù è giusta o ingiusta, una volta che sia data per scontata la sua esistenza. Si tratta piuttosto di vedere come lo Stato possa regolarla nella maniera meno gravosa ed umiliante per lo schiavo, ma anche meno pericolosa per il padrone e la comunità. In questo modo Montesquieu finisce col prendere in esame tutta una serie di accorgimenti che favoriscono il mantenimento della schiavitù e la sottomissione dello schiavo. Si esaminano cioè, nei restanti capitoli del libro XV, tutti i mezzi, « legali » che permettono allo Stato di impedire allo schiavo di mettere in atto quello che era stato riconosciuto come un suo diritto alla fine del secondo capitolo, dove leggevamo: « Quelle loi civile pourrait empêcher un esclave de fuir, lui qui n’est point dans la société, et que par conséquent aucunes lois civiles ne concernent? » (XV, 2). 131 Insomma, dopo aver sostenuto che nessuna legge civile può concernere lo schiavo, Montesquieu passa in esame tutta una serie di provvedimenti e precauzioni da prendere, da parte del legislatore, per proteggere e contenere gli schiavi. La contraddizione è vistosa, ma più nell’apparenza che nella sostanza: lo Stato che accetta la schiavitù deve ovviamente cercare il modo di rendere l’istituzione migliore e più sicura possibile. Le questioni di principio non lo concernono più visto che, optando per un tipo di organizzazione piuttosto che per un altro, ha già superato la fase delle scelte (supposto che queste, dato un certo tipo di governo, siano possibili). D’altro canto, a quest’ottica egoistica degli Stati schiavisti, che Montesquieu presenta in qualità di storico, resta validamente contrapposta quella dello schiavo che la rifiuta, sentendosi libero di adottare a sua difesa i mezzi che riterrà più idonei: la guerra di Spartaco non cessa di essere legittima (22). E tuttavia, anche a voler giustificare le apparenti contraddizioni, presentando una posizione come emanante dall’ideologo e l’altra come il frutto delle ricerche storiche dell’autore (se pure questa scissione è legittima), non si riesce a ricomporre in un insieme organico e cristallino il pensiero di Montesquieu intorno alla schiavitù ed, in particolare, il suo atteggiamento nei confronti della schiavitù coloniale. Certo l’ha condannata, ma ne ha poi esaminato quasi freddamente alcuni degli aspetti più crudeli, ancora pienamente attuali nelle colonie: « Quand la loi permet au maître d’ôter la vie à son esclave, c’est un droit qu’il doit exercer comme juge, et non pas comme maître: il faut que la loi ordonne des formalités qui ôtent le soupçon d’une action violente » (XV, 16). Dunque, di fronte ad una legge che permette al padrone di uccidere il proprio schiavo, Montesquieu non si mette su una posizione di rifiuto e di condanna, ma si limita ad invocare delle formalità che ne assicurino la corretta esecuzione, che le impediscano cioè di diventare una legge che protegge la violenza privata e l’omicidio. È un atto di ingenuità da parte di Montesquieu, che aveva poco prima assai lucidamente riconosciuto che nessuna legge civile può concernere lo schiavo? Di fatto, per quante formalità possa accumulare il legislatore, esse non avranno mai altro che un potere minimo o nullo: il padrone a cui è riconosciuto il diritto di uccidere uno schiavo troverà sempre il modo di eludere limitazioni e formalità, o di ricoprire con le formalità richieste un puro e semplice assassinio. Ed anche nella migliore delle ipotesi, nel caso cioè che un padrone voglia veramente rispettare tutte le formalità con cui il legislatore avrà voluto limitare i 132 poteri che la legge gli conferisce, quale affidamento si deve fare sulla giustizia di un singolo, e per giunta parte in causa? È vero che Montesquieu tende soltanto a correggere, in senso positivo, una legge già esistente in materia, come è vero che tende ad essere storico il più possibile obiettivo, ma tutto questo non impedisce che il discorso resti abbastanza crudo e non toglie il sospetto che l’autore non avrebbe tanto facilmente ceduto il diritto di far giustizia ad un uomo singolo, se l’ « oggetto » in causa non fosse stato uno schiavo. Non mancano altri punti che possono lasciare perplessi o delusi, soprattutto dopo la netta presa di posizione iniziale contro la schiavitù, che non sembrava dettata unicamente da un esame obiettivo dei fatti, ma anche da un’esigenza di carattere profondamente umano, come si poteva rilevare anche nell’indignata ironia con cui aveva bollato la schiavitù negra. Ritrovare a pochi capitoli di distanza l’ « humanité » chiamata in causa a scopi utilitaristici fa un certo effetto, anche se si tratta di un espediente che si ritroverà, in seguito, in molti scritti dei più convinti abolizionisti: « L’humanité que l’on aura pour les esclaves pourra prévenir dans l’Etat modéré les dangers que l’on pourrait craindre de leur trop grand nombre » (XV. 16). La lista dei rilievi potrebbe continuare, ma non cambierebbe nulla, ci sembra, alla fisionomia di una posizione che, nonostante alcune incertezze, alcune ambiguità e molti silenzi, si caratterizza nel suo complesso come decisamente contraria alla schiavitù, in ogni sua forma ed a qualsiasi latitudine. Esistono soltanto per Montesquieu forme e luoghi in cui essa si presenta come meno ripugnante e negativa, ma mai, in nessun caso, egli ne ha riconosciuto l’utilità, neppure sul piano materiale, mentre ne ha riconosciuto senza mezzi termini tutta la nocività sul piano spirituale e morale. Il libro XV non è omogeneo, la composizione in tempi diversi può, forse, spiegare in parte l’assenza di omogeneità, anche se siamo più propensi ad attribuirla alla complessità della materia trattata ed ai dubbi dell’autore. La stessa mancanza di omogeneità la si coglie, del resto, anche dall’insieme di tutta la sua opera, in materia di schiavitù, colonie e paesi extra-europei. Per tentare di fissare un’evoluzione del pensatore, nel corso degli anni, di fronte al problema della schiavitù, il punto di riferimento più solido è il capitolo nono, aggiunto soltanto nell’edizione postuma del 1757. Possiamo presumere che, assieme alla lettera scritta, nel 1750, a Grosley per rispondere ad alcune critiche che questi aveva mosso in particolare al libro XV, esso rappresenti il frutto della riflessione 133 ultima di Montesquieu sul problema, e quindi il punto d’arrivo di una travagliata ricerca di chiarezza. La lettera e il capitolo costituiscono, possiamo dire, un tutto unico in quanto è proprio un passo della risposta a Grosley che forma, quasi senza alcuna rielaborazione, il capitolo stesso. Montesquieu vi ribadisce la sua convinzione che « Il vaut mieux des gens payés à la journée que des esclaves » e il suo rifiuto di ogni forma di schiavitù, in quanto frutto dell’egoismo privato e non della ricerca della pubblica felicità. Se la scelta dello schiavo e del padrone fosse affidata al destino e tirata a sorte, « Ceux qui parlent le plus pour l’esclavage l’auroient le plus en horreur... » (XV, 9) (30). È il segno inequivocabile della sua negatività sul piano sociale, che Montesquieu cerca di rendere nella maniera più efficace, coinvolgendo direttamente il suo lettore in qualità di parte in causa. Il capitolo nono si chiude con l’indicazione di un metro di giudizio delle cose sociali che sarebbe suscettibile di spezzare le basi oltre che della schiavitù, di ben altre strutture fondate sull’ingiustizia: « Dans ces choses, voulez-vous savoir si les désirs de chacun sont légitimes, examinez les désirs de tous ». Note (1) Parigi, 1911. Per un’analisi della struttura e dello stile del libro XV cfr. O. Ducrot, Montesquieu et l’esclavage, I e II, in La preuve et le dire, Parigi, 1973, pp. 185-208. La prima parte del saggio, scritta in collaborazione con J. Depresle, era già apparsa su « Langue française », dic. 1971, pp. 93-97. (2) Ricordiamo che il libro XV è intitolato: Comment les lois de l’esclavage civil ont du rapport avec la nature du climat. (3) Sul problema della schiavitù in Montesquieu esiste ora una « doctoral dissertation » presso la State University of New York at Binghamton: J. J. Lafontant, Montesquieu et le problème de l’esclavage, 1976. (4) Sulle critiche mosse a Montesquieu, cfr. infra. (5) Cfr., ad esempio, Voltaire, Commentaire sur l’Encyclopédie, art. Esprit des lois. Sull’attendibilità delle fonti e sulla correttezza dei modi in cui Montesquieu ha fatto uso delle informazioni, cfr. M. Dodds, Les récits de voyages sources de l’Esprit des lois de Montesquieu, Parigi, 1929, dove, a proposito della schiavitù, si rimprovera a Montesquieu di aver edulcorato il problema, ignorandone gli aspetti più scottanti : « La description de 134 l’esclavage, donnée dans l’Esprit des lois, n’a rien de révoltant, et ne dispose personne à le considérer comme un des plus terribles maux de l’humanité » (p. 121). (6) Sulla crudeltà che caratterizza i rapporti tra padrone e schiavo, Montesquieu si era già soffermato nelle Considérations, dove, inaspettatamente e apparentemente fuori luogo, ma prendendo lo spunto dalla schiavitù nel mondo romano, aveva formulato un interrogativo sferzante nei confronti dei coloni europei del suo tempo: « Les Romains, accoutumés à se jouer de la nature humaine, dans la personne de leurs enfants et de leurs esclaves, ne pouvaient guère connaître cette vertu que nous appelons humanité. D’où peut venir cette férocité que nous trouvons dans les habitants de nos colonies, que de cet usage continuel des châtiments sur une malheureuse partie du genre humain? Lorsque l’on est cruel dans l’état civil, que peut-on attendre de la douceur et de la justice naturelles? » (cap. XV). (7) Théorie des Loix civiles. La prima edizione è del 1767. Abbiamo consultato l’opera nell’edizione riveduta e aumentata in Œuvres, Londra, 1774, 5 voll., in cui occupa i voll. IIIV. (8) Il volume dedicato alla schiavitù è il V. (9) Neuchâtel, 1788. L’opera è composta di due parti, scritte in tempi diversi. La prima è del 1775, la seconda, che porta il titolo di Nouvelles observations è invece del 1788. Per un’analisi di quest’opera rinviamo al nostro Mon frère... (10) Per una trattazione più ampia degli antecedenti rinviamo all’opera del Jameson. (11) Due trattati sul governo, a cura di L. Pareyson, Torino, 1948, Secondo trattato, p. 253. (12) Grozio fa infatti riferimento all’Ecclesiastico, XXXIII, 25, per ricordare al padrone il suo dovere di nutrire lo schiavo (De iure belli et pacis, libro III, cap. XIV, 6), ma non cita i duri versi seguenti, neppure nel paragrafo quarto dello stesso capitolo, dedicato alle pene di cui può far uso il padrone. Il passo dell’Ecclesiastico, intitolato appunto " Disposizioni per gli schiavi ", è il seguente: « Foraggio e bastone e pesi per l’asino, pane, disciplina e lavoro per il servo. (E’ il verso cit. da Grozio) Imponi al servo di lavorare e non avrai molestia, se lo lascerai senza lavoro cercherà di fuggirti. Giogo e briglie piegheranno il collo duro al giumento, per il servo che opera male occorrono tormenti e flagelli... ». (Da rilevare, per inciso, l’accostamento animale da soma/servo). Proprio all’ultimo versetto da noi citato aveva fatto invece riferimento San Tommaso nella Somma Teologica (II-II, questione 65, art. 2) in cui si afferma che è « permesso percuotere soltanto a chi ha un potere sulla persona che viene percossa (...) il padre e il padrone hanno rispettivamente la facoltà di percuotere il figlio e lo schiavo, allo scopo di correggerli e di educarli ». (13) Grozio, op. cit., libro III, cap. XIV, paragrafi 1-2 (14) « Et si c’estoit contre nature qu’un homme eust puissance sur l’autre de la vie & de la mort, il n’y auroit ny Royaumes, ny seugneuries qui ne fussent contre nature, veu que les Rois et les Monarques ont mesme puissance sur tous leurs subjects... » (J. Bodin, Les six livres de la République, 1575. Abbiamo consultato l’opera nell’edizione di Lione, 1580, rist. Bologna, 1970, p. 35). (15) Quanto poi al fatto che gli Spagnoli sono dei buoni padroni e che gli arbìtri nei confronti degli schiavi possono essere evitati, Bodin solleva degli interrogativi che saranno ancora attualissimi nel Settecento: « Et qui feroit la poursuite de la mort d’un esclaue? qui en 135 oyroit la plainte qui en feroit la raison n’ayant aucun interest ? » (p. 45). (16) Bodin sostiene infatti che per scegliere liberamente un rapporto personale così stretto, come quello che lega lo schiavo al padrone, bisognerebbe che fra i due caratteri vi fosse un’intesa praticamente inesistente in natura. (17) Sul ruolo svolto da Bodin nella formazione di Montesquieu cfr. P. Errera, Un précurseur de Montesquieu: Jean Bodin, in « Annales » dell’Académie Archéologique de Belgique, Anversa, 1896; E Fournol, Bodin prédécesseur de Montesquieu, Parigi, 1896 (thèse de droit); per il problema della schiavitù in particolare, vedi A. Valdarnini, Riforma sociale in Montesquieu, « Rassegna di scienze sociali e politiche », (Firenze), 1° luglio 1890, pp. 452-469. (18) Locke, op. cit., p. 252. (19) Articolo CCCLXIII. (20) Al « Colloque sur l’idée de race dans la pensée politique française - XVIIIe et XIXe siècles » (di cui ci sono stati gentilmente inviati gli interventi dattiloscritti), organizzato dal Centre d’Etudes de la pensée politique contemporaine de l’Université de Provence, Centre d’Aix, tenuto ad Aix nei giorni 22 e 23 marzo 1975 e a Marsiglia il giorno 24, Pierre Guiral ha tuttavia presentato una relazione su Montesquieu précurseur de l’idée d’inégalité des races. La relazione si conclude con un interrogativo concernente non una possibile influenza di Montesquieu sul futuro « razzismo » francese, che è data qui per scontata, ma il tipo di razzismo a cui l’opera di Montesquieu avrebbe dato l’avvio: « On pourrait se demander si le racisme français dont Montesquieu jette avec nonchalance les fondements idéologiques n’est pas dans large mesure anti-latin » (p. 6). Le basi ideologiche di questo razzismo sono da ricercarsi, secondo Guiral, nella teoria climatica e nella marcata simpatia che egli ha mostrato nel corso di tutta la sua opera per i popoli del Nord, ai quali ha sempre riconosciuto, esplicitamente od implicitamente, una certa superiorità nei confronti dei popoli meridionali. (21) Historia general de las Indias (Medina, 1553, tradotta in francese nel 1569). Sull’interpretazione non ortodossa del testo da parte di Montesquieu cfr. M. Dodds, op. cit., pp. 127-129 e la nota di S. Cotta alla sua traduzione dell’Esprit des lois, Torino, 1965, p. 407. (22) Cfr, anche Mes pensées, in Œuvres complètes, ed R. Caillois (coll. Pléiade), I, p. 1469. (23) Cfr. infra. (24) Per quanto concerne la teoria dei climi rinviamo al testo più recente che se ne è occupato: P. Vernière, Montesquieu et l’Esprit des lois ou la raison impure, Parigi, 1977. (25) A questo proposito osserva Sergio Cotta (Montesquieu e la scienza della società, Torino, 1953) che esiste in Montesquieu una divisione concettuale tra leggi di natura e leggi fondate sulla natura delle cose. « Le prime ‘non possono essere delle leggi locali’ poiché rispondono ad ‘un costume necessario’, sono ‘invariabili, perché dipendono da una realtà invariabile’ (...), sono pertanto leggi universali, ma, per essere tali, devono rispondere a princìpi non solo essenziali all’uomo (che tale è anche la ragione) ma immutabili, come sono le sue caratteristiche fisiche. Le leggi fondate sulla natura delle cose sono invece naturali anch’esse ma, riferendosi a usanze particolari, non sono né universali, né invariabili, né necessarie (pp. 368-369). (26) Il capitolo settimo del libro XV non è infatti il solo luogo in cui si esprima l’idea di un’influenza negativa del clima caldo sul carattere dei popoli, è però il luogo più pericoloso, come ha intuito lo stesso Montesquieu, perché può divenire la discriminante tra schiavitù e libertà. 136 (27) A proposito di questo dilemma Barni nota che « Montesquieu cherche à expliquer par des raisons naturelles ce qu’il condamne au nom de la raison: ses explications ne détruisent pas ses principes, et lui-même semble en avoir honte... » (Histoire des idées morales et politiques en France au XVIIIe siècle, Ginevra, 1865, rist. Slatkine, 1967, tomo I, p. 207). (28) Lettres persanes, lettera CXVII. Citiamo dall’edizione curata da P. Vernière, Parigi, 1960, pp. 249-250. (29) Montesquieu, Mes pensées (XXI, Esclavage), cit., p. 1469: « La guerre de Spartacus étoit la plus légitime qui ait jamais été entreprise. Malheur à ceux qui font des lois que l’on peut violer sans crime ». (30) Su di un analogo rovesciamento dei ruoli in Marivaux, per giungere alla comprensione dell’altro e quindi alla catarsi personale, tappa indispensabile sulla via dell’uguaglianza, rinviamo al nostro «L’île des esclaves» di Marivaux come psicodramma sociale, in Studi sull’uguaglianza. Contributi alla storia e alla tipologia critica di un’idea nell’area francese, II, a cura di C. Rosso, Pisa, 1975, pp. 83-106. Per un tentativo di immedesimazione nella realtà dell’altro, e nel caso specifico del nero, compiuto ai nostri giorni cfr. J. H. Griffin, Black like me, tr. it., Nero come me, Milano, 1978. L’autore, un medico psichiatra profondamente sensibile al problema della segregazione razziale, si trasforma, con l’aiuto del trucco, della lampada e di un medicinale, in nero e vive per un certo tempo l’esperienza della segregazione razziale. Un’esperienza sconvolgente che lo aiuta a capire, da un lato, la disperata realtà dei negri americani, dall’altro, i limiti di ogni processo mentale di identificazione con una condizione di vita che non è la nostra. 137 REAZIONI DEGLI SCHIAVISTI, USI IMPROPRI E FRAINTENDIMENTI DELL’« ESPRIT DES LOIS » « Sur ce point (la schiavitù) il a vraiment donné le signal, et, le premier dans son siècle, rappelé aux hommes les principes outragés par cette abominable institution » (1). Ed il signal non è stato lanciato a vuoto. Anzi, ha suscitato risonanze e dissonanze sempre più numerose, che non si sono ancora spente neppure ai giorni nostri, segno della problematicità del codice in cui il segnale è stato emesso, ma anche della sua straordinaria vitalità. Persino autori che hanno criticato con durezza l’Esprit des lois ed in particolare il modo in cui Montesquieu vi ha affrontato il problema della schiavitù, hanno riconosciuto, anche se in termini non proprio lusinghieri, il carattere stimolante dell’opera, come ad esempio risulta da questa parafrasi ironica della prefazione montesquiviana, dovuta alla penna dell’abate Debonnaire: « Dans le nombre infini de choses que ce livre contient, les inepties mêmes donnent quelquefois occasion de faire des réflexions instructives » (2). Ed anche Jameson, in fondo, con un linguaggio ben diverso ed in una prospettiva tutt’altro che denigratoria, porrà l’accento sul potere di stimolazione che hanno certamente avuto i limiti stessi dell’opera: « Le caractère peu décisif du livre était de nature à susciter des dissertations plus ordonnées, plus systématiques, plus chaleureuses » (p. 339). È dunque anche grazie a quell’ambiguità tanto spesso rimproverata al libro XV, che le polemiche ferveranno e che si assisterà « aux origines d’un débat passionné » (ivi), destinato a coinvolgere tutto il ‘700, fino alla vigilia della Rivoluzione. 138 Jameson – e con lui buon numero degli studiosi che si sono occupati del problema della schiavitù nel pensiero francese – riconosce perciò a Montesquieu una posizione chiave, facendone il promotore di quell’ampio dibattito che, dopo aver coinvolto giuristi, uomini politici, philosophes e letterati, porterà alla proscrizione della tratta ed all’abolizione della schiavitù. La posizione assegnata da Jameson a Montesquieu è sostanzialmente esatta ed accettabile ancor oggi, a patto di tenere presente il ruolo svolto dagli avvenimenti coloniali e dai problemi pratici sempre più complessi da essi suscitati, che postulavano soluzioni ogni giorno più urgenti, anche se costantemente procrastinate, dai competenti organi amministrativi (3). A patto cioè di tenere presente la pressione esercitata dagli eventi storico-politici sull’ideologia concernente le colonie e la schiavitù. E a patto ancora di non dimenticare che nel momento in cui appare l’Esprit des lois, c’è già in Francia, in particolare sotto l’influenza di opere venute dall’Inghilterra, come si è cercato di dimostrare nei capitoli precedenti, un terreno pronto ad accogliere questo dibattito. Senza contare ancora che, sempre in Francia, il problema della legittimità della schiavitù era già stato clamorosamente sollevato dai quesiti posti dai coloni alla Sorbona, alla fine del ‘600, mentre nel 1734 Jean-François Melon aveva suscitato un certo scalpore, sostenendo, nel suo Essai politique sur le commette, l’utilità dell’impiego di manodopera servile anche nei paesi europei (4). A patto, infine, di tenere presente che l’interesse specifico nei confronti della tratta e dell’asservimento dei popoli africani procedeva a misura della diffusione di relazioni di viaggio sempre più numerose e circostanziate (5), ma anche a misura dell’accrescersi del fenomeno che andava assumendo dimensioni imponenti e preoccupanti e sollevando, accanto all’interesse commerciale per gli uomini di colore, fortunatamente, anche un interesse scientifico per il fenomeno della diversità. Particolarmente sensibile alla questione del colore nero, negli anni in cui Montesquieu elaborava l’Esprit des lois, sembra essere stata proprio l’Accademia di Bordeaux, nei cui archivi si trova una Dissertation sur l’origine de la couleur des hommes del 1739, di un R. P. Bénoît Jérôme dell’ordine dei benedettini di Madrid (6), mentre il titolo per il concorso del 1741 proposto dalla stessa Accademia è una sorta di inchiesta antropologica: « La cause physique de la couleur des nègres, de la qualité de leurs cheveux, et de la dégénération de l’une et de l’autre ». Stando alle ricerche fatte dal Jameson negli archivi dell’Accademia, si presentarono almeno sedici concorrenti, provenienti da ogni parte d’Europa, il che sembrerebbe indicativo di un certo interesse, documentato del resto dalla scelta stessa dell’argomento da parte di un’Accademia (7). 139 Ma si tratta degli elementi sparsi di un problema vasto e complesso ai quali l’opera di Montesquieu serve da catalizzatore, rendendo ormai impossibile ogni approccio elusivo e costringendo coloro che si accosteranno al problema dopo di lui, a prendere posizione e, soprattutto, ad un lavoro di informazione e chiarificazione destinato non soltanto ad approfondire i termini giuridici e teorici del dibattito, ma anche a mettere allo scoperto il vero volto della schiavitù coloniale e la sua terribile carica distruttiva. La presenza di Montesquieu, al di là delle opere di critica specifica all’Esprit des lois ed al libro XV, è chiaramente rintracciabile, anche in assenza di riferimenti espliciti, in quasi tutti gli scritti, persino di mediocre letteratura alla moda, che dibattono o sfiorano il problema della schiavitù fino alla vigilia della Rivoluzione, quando la sua influenza, come vedremo più oltre, conosce un rapido declino. Il carattere complesso, più antologico che sistematico del libro XV, ha sollevato le reazioni più svariate, per cui è difficile ridurle a sintesi. Ci è sembrato tuttavia possibile ricondurle a quattro tipi essenziali: 1° - Critica da parte dei sostenitori della schiavitù. 2° - « Usi impropri » e fraintendimenti dell’opera ed in particolare del capitolo 5° sull’Esclavage des nègres. 3° - Critica, da parte di alcuni avversari della schiavitù, alla posizione non sufficientemente decisa assunta da Montesquieu. 4° - Elogio della maggior parte degli antischiavisti che hanno sostanzialmente ripreso ed approfondito le sue tesi. Prima di passare ad un’analisi dei quattro tipi di critica, ci pare interessante rilevare che fra gli scritti specifici nati attorno all’Esprit des lois negli anni ‘50, per criticarne, correggerne o lodarne l’impostazione e le tesi, sono, tutto sommato, una percentuale minima quelli che appuntano la loro attenzione sul problema della schiavitù, a meno che non si tratti di quelle critiche sistematiche, che procedono ad un’analisi dei singoli libri e nelle quali perciò la trattazione del problema diventa inevitabile. Ci sembra questo un segno abbastanza chiaro che l’interesse dei primi critici dell’Esprit des lois risiede altrove e che l’attenzione nei confronti della questione schiavista, relativamente scarsa al momento della pubblicazione dell’opera, va accentuandosi nel giro di alcuni anni, attorno ad un problema che, come ha ben mostrato la Duchet, sta sempre più a cuore anche agli organi amministrativi. Nelle pagine che seguono prenderemo in esame i primi due tipi di approccio al testo montesquiviano, rimandando l’analisi degli altri due ad un capitolo successivo. Fra i primi che sollevarono alcune obiezioni al libro XV va ricordato l’erudito 140 Pierre-Jean Grosley, i cui rilievi, abbastanza trascurabili almeno se paragonati a critiche ben più serrate e sistematiche, sono destinati ad occupare un posto privilegiato a causa della risposta di Montesquieu a cui offrirono l’esca. Grosley, facendo riferimento al capitolo 20° del libro XVIII, in cui Montesquieu presenta i Tartari come conquistatori crudeli ed assetati di sangue, conclude che da parte loro, rendere schiavo il nemico sarebbe un atto di pietà, e quindi che vi sono casi in cui realmente la schiavitù è dovuta alla pietà del vincitore. A ciò Montesquieu obietta che non di azione conforme a pietà si deve parlare, in questo caso, ma di azione meno contraria all’umanità di quanto non lo sia l’uccisione del vinto. Il secondo punto contestato da Grosley concerne la vendita della propria persona: nel caso, ad esempio, del debitore che estingue, vendendosi, un debito precedentemente contratto, l’alienazione della libertà comporta un prezzo di cui già si è beneficiato. Montesquieu, con una risposta più solida sotto il profilo umano che giuridico, si limita a far rilevare che il debitore insolvibile, cedendo se stesso, dà una cosa inestimabile in cambio di una cosa da nulla. In sostanza, si limita a ribadire quanto aveva già sostenuto nell’Esprit des lois, senza apportare ulteriori argomentazioni a sostegno della sua tesi, ritenendo probabilmente che quanto già aveva detto in proposito fosse sufficientemente chiaro. All’obiezione mossa al tipo di schiavitù presentata nel capitolo 6°, più simile, secondo Grosley, a quella dei clienti romani o dei vassalli feudali che ad una schiavitù vera e propria, Montesquieu replica in maniera abbastanza strana e scarsamente convincente: « Je n’ai point cherché au chap. VI du livre XV l’origine de l’esclavage qui a été, mais l’origine de l’esclavage qui peut ou doit être » (8). Ricordiamo che il capitolo in questione è intitolato Véritable origine du droit de l’esclavage e l’obiezione di Grosley non era fuori luogo, mentre la risposta di Montesquieu sembra far riferimento ad una mitica regola astratta che sembrerebbe presiedere all’insorgere della schiavitù, regola però che i fatti non rispettano o che comporta infinite eccezioni, stando anche alle analisi dei capitoli precedenti dello stesso Esprit des lois. Infine all’appunto fatto da Grosley a proposito (o meglio a sproposito) del capitolo 18° (attuale 19°), sulla necessità di esaminare se non sia più facile intraprendere grandi opere con schiavi che con operai liberi, Montesquieu risponde che sono sempre preferibili questi ultimi per poi passare a quella decisa condanna della schiavitù che fa di lui un precursore del pensiero abolizionista nella Francia del 141 Settecento. Gli schiavisti che hanno mosso critiche all’Esprit des lois si possono dividere essenzialmente in due categorie, a seconda degli interessi che li muovono e quindi del taglio che danno ai loro giudizi e degli aspetti dell’opera su cui dirigono la loro attenzione, o che ignorano come secondari. Un fermier général come Claude Dupin, a cui stanno certamente a cuore i princìpi e le regole astratte, ma che non ignora gli interessi contingenti, si sforzerà di contestare la correttezza delle tesi generali montesquiviane, accusando l’autore di superficialità per aver liquidato, con un sommario giudizio negativo, una questione come quella della schiavitù che era sembrata problematica a molti grandi pensatori, ma si sforzerà soprattutto di difendere quella situazione coloniale di cui potrebbero essere minacciate le basi. Appunterà perciò la sua attenzione sui capitoli 5° e 7°, liquidando il primo dei due come mancante di serietà: « ...or le chapitre des Nègres est démonstrativement une lettre persanne » (9) e ricavando dal secondo l’invalidazione di tutto il discorso portato avanti da Montesquieu contro la schiavitù, nonché una solida base a sostegno della schiavitù coloniale: « Mais quoi qu’il en soit, la servitude étant, suivant son exposé, naturelle à certains pays, comme la liberté l’est à d’autres, nos désirs, nos souhaits ne peuvent détruire, empêcher ni suspendre ce qui est produit par la nature et conforme aux loix, à l’ordre et au cours ordinaire de cette nature (...). L’esclavage étant l’ouvrage de la nature les Loix n’ont rien à faire parce que n’ayant aucun pouvoir sur la cause elles n’en auraient plus sur les effets » (10). Non è nostra intenzione entrare nel merito della correttezza di lettura del testo criticato, bensì semplicemente mettere in luce la possibilità di un suo uso che non fu certamente voluto dall’autore, ma al quale il testo stesso dava inevitabilmente adito. Sull’« uso improprio » ed i fraintendimenti a cui in particolare questi due capitoli, dell’Esprit des lois hanno dato luogo, fino ai giorni nostri, ritorneremo a conclusione della nostra analisi. L’altra categoria di censori, proprio perché non difendeva una situazione precisa, con caratteristiche specifiche, ha espresso la critica più solida delle teorie generali di Montesquieu e condotto la più puntuale ed accanita analisi dei limiti e dei « paralogismi » (come dice Strube) montesquiviani. A questa categoria appartengono anche le opere più consistenti, qualitativamente e quantitativamente, a cui la critica del libro XV abbia dato origine. Alludiamo in particolare alle Lettres russiennes di 142 Strube de Piermont (11) ed alla Théorie des lois civiles di Linguet (12), il cui terzo volume è interamente dedicato ad un dibattito sulla schiavitù, incentrato attorno ad una contestazione minuziosa del libro XV. Né Strube né Linguet si interessano di schiavitù coloniale, l’uno e l’altro sono anzi decisi nel condannare qualsiasi discriminazione fatta in nome del clima o della razza (13), destinata ad intaccare quei principi generali che essi credono di aver individuati alla base dei rapporti sociali. Linguet affronta il problema della schiavitù da teorico delle leggi civili, per il quale il rapporto di comando/dipendenza, che trova la sua estrema realizzazione nel rapporto padrone/schiavo, è un problema cruciale. Strube si prefigge una difesa del dispotismo russo (che egli si rifiuta però di definire tale) ed a questo fine ritiene preliminarmente indispensabile dimostrare, accanto alla legittimità della schiavitù politica, anche quella della schiavitù civile. Nell’uno e nell’altro autore quindi la difesa della schiavitù fa parte di un discorso teorico generale, il cui interesse è preminente rispetto al problema specifico. Strube si rende conto che nessuna posizione in difesa della schiavitù è ormai più sostenibile, dopo la pubblicazione dell’Esprit des lois, se non si smantellano le argomentazioni in esso portate avanti: « ... puisque Mr. de M. s’est déclaré contre cet état il ne conviendroit pas de laisser sans réponses les raisons qu’il allègue pour le condamner » (p. 31). A questo punto prende l’avvio la contestazione più minuziosa, almeno a nostra conoscenza, che sia stata fatta del libro XV. La definizione stessa di schiavitù formulata da Montesquieu solleva una duplice obiezione, innanzitutto perché non contempla le azioni degli schiavi (ricordiamo che Strube usa sempre i termini serf e servitude) come « luogo » sul quale si esercita il potere del padrone (14), poi perché il giudizio negativo espresso a proposito della schiavitù sotto il profilo morale risulta del tutto infondato, visto che essa è sempre esistita presso i popoli più virtuosi della terra. Anzi, da questo punto di vista Strube si trova d’accordo con quei « Savans aussi éclairés que sincères » che hanno disapprovato l’abolizione della schiavitù negli stati più civili d’Europa. Passando in seguito, come Montesquieu, dagli effetti alle cause della schiavitù, egli rileva un uso improprio, da parte dell’autore, del diritto romano o comunque 143 un’errata interpretazione di esso per quanto attiene alle motivazioni che avrebbero dato origine alla schiavitù presso i Romani. Strube sostiene infatti che non si può parlare di pietà che arresta la mano del vincitore stanco di uccidere, ma piuttosto di « avidité du gain » che spinge il vincitore a salvare la sua vittima, il che ovviamente indebolisce, pur non inficiandole, tutte le argomentazioni di cui Montesquieu si serve, a partire da questa base, di cui Strube dimostra la fragilità. Fra le cause che possono trasformare un uomo libero in uno schiavo, rilevate da Strube nell’Esprit des lois, ve n’è una di troppo, dovuta ad un’errata interpretazione del confronto, stabilito da Montesquieu nel secondo capitolo, tra le leggi che condannano a morte un criminale e quelle che riducono un uomo in schiavitù. Strube ha infatti pensato che Montesquieu avesse contemplato il caso della schiavitù come strumento di punizione di un crimine ed allora non riesce a capire perché l’autore giudichi la morte del criminale come il risultato di una legge creata per difenderlo, e muti totalmente opinione se la punizione non è più la condanna a morte, ma la schiavitù (15). Per quanto concerne le cause che hanno dato origine alla schiavitù presso i Romani, realmente messe in luce da Montesquieu, le obiezioni di Strube sono molto circostanziate. A proposito della schiavitù di guerra, l’autore delle Lettres russiennes sostiene che non esiste altro diritto riconosciuto all’infuori di quello contemplato nella massima « In hostem omnia licent », per cui, come già ha sostenuto Grozio, è soltanto « un motif d’utilité » quello che spinge a salvare il vinto per renderlo schiavo. E si tratta di un’operazione perfettamente legittima, in cui ognuno trova il suo tornaconto. Del resto, come si deve intendere l’affermazione di Montesquieu, secondo la quale, il diritto di guerra nei confronti dei prigionieri « est de s’assurer tellement de leurs personnes, qu’ils ne puissent plus nuire »? È indubbio che intende debbano essere tenuti in prigione e non è questa forse una condizione peggiore della schiavitù? Montesquieu ha, secondo Strube, confuso in più occasioni le regole del diritto con quelle dell’umanità: « Il n’y a en effet que les régies du droit rigoureux, qui ne varient point. Celle de l’humanité changent sans cesse selon les tems, les circonstances et les progrès, que les hommes font dans les connoissances et dans les mœurs » (p. 50). A proposito della seconda causa, e cioè della schiavitù per debiti, Strube pone l’accento sull’errore compiuto da Montesquieu nel richiamarsi alle leggi romane, in quanto queste non permettono al debitore di vendersi al creditore, ma unicamente di 144 mettersi a sua disposizione fino ad estinzione del debito. Non si tratta perciò di quella « servitude parfaite » di cui si parla nell’Esprit des lois. Alla nullità del contratto di vendita della propria persona, a causa, come sostiene Montesquieu dell’impossibilità, da parte di colui che è divenuto schiavo, di essere possessore e quindi di godere del prezzo pattuito, Strube oppone la testimonianza di San Clemente, secondo il quale molti cristiani si vendevano per nutrire i poveri e quindi disponevano del prezzo ricavato dalla loro vendita. L’altra ragione addotta da Montesquieu a sostegno della nullità di un tale contratto, e cioè che la libertà non ha prezzo, trascina Strube in una disquisizione filologica sul vero significato della parola prix (16). Poiché il prezzo di un prodotto è una questione di valutazione fra i due contraenti, che possono sottovalutare o sopravvalutare l’oggetto di scambio a seconda delle reciproche necessità, è possibile fissare un prezzo anche alla libertà, purché le persone che stipulano il contratto si trovino d’accordo. Però, in questo caso, Montesquieu sembra avere l’appoggio della tradizione, visto che già presso i Romani si giudicava inapprezzabile il valore della libertà. Cosicché Strube si arrampica sugli specchi, impegnandosi in una nuova disquisizione filologica, molto meno riuscita della precedente, nel tentativo di far assumere alla parola inestimable un significato che ne sembra la negazione: « Cela fait assez voir que les jurisconsultes Romains en soutenant que la liberté est une chose inestimable, n’ont voulu dire autre chose, sinon que la liberté d’un homme ne pouvant être estimée que par lui-même, ou de son gré, il n’est pas permis aux juges d’en fixer le prix... » (p. 59). Con il che egli riconduce il problema ad un contratto stipulato fra due privati, come se la libertà fosse una merce qualsiasi. Quando si tratta, infine, di esaminare il caso della schiavitù ereditaria, il compito di Strube diventa di una facilità estrema, avendo egli già dimostrato l’infondatezza degli antecedenti dai quali Montesquieu aveva fatto discendere l’illegittimità di questo tipo di schiavitù. Dal momento che il bambino è stato nutrito dal padrone, egli deve appartenere a lui in nome di quel « droit parfait et rigoureux » che regola inderogabilmente i rapporti tra gli uomini: « On accordera qu’un homme, qui ne se charge que sous cette condition de l’éducation d’un enfant prêt à périr, n’a point d’ame (...). Mais en même tems 145 on répondra que lors qu’il s’agit de la légalité d’une action, on n’a égard qu’aux régies du juste, et qu’on laisse celles de l’humanité, ou du Droit imparfait, à la Morale... » (p. 62). Anche a questo proposito è dunque implicita in Strube l’accusa nei confronti di Montesquieu di avere indebitamente mischiato regole appartenenti ad ordini diversi. Dopo aver smontato le tesi montesquiviane concernenti le cause della schiavitù, egli si applica a contestare alcune delle sue considerazioni generali e particolari sulla schiavitù, puntando fra l’altro il suo tiro sulla famosa affermazione: « L’esclavage est aussi opposé au Droit civil qu’au Droit naturel » (XV, 1), per mettere in rilievo come sia difficile sostenere che una cosa autorizzata dalle leggi civili, sia contraria al diritto civile, a meno che non debba intendersi che è contraria allo spirito di questo diritto, interpretazione di cui Strube si affretta a dimostrare l’infondatezza. Un trattamento analogo viene da lui usato anche per dimostrare l’insostenibilità di quanto segue immediatamente nel testo di Montesquieu, e cioè l’affermazione che nessuna legge può impedire allo schiavo di fuggire, visto che è ai margini di ogni società e dipende unicamente dalla volontà del padrone. A ciò Strube ribatte che, trovandosi il padrone a far parte della società, anche lo schiavo che gli appartiene ne fa necessariamente parte ed inoltre che è assurdo affermare che le leggi civili non possono concernere gli schiavi, poiché la storia di tutti i popoli offre esempi di tali leggi. Strube analizza con pazienza, e molto spesso con acribia, i primi capitoli del libro XV quasi frase per frase, per cui sarebbe troppo lungo continuare a seguirlo, tanto più che già sono stati messi in luce gli aspetti chiave della sua critica. Riassumiamo perciò i tre punti in cui egli stesso sintetizza la sua posizione nei confronti del libro XV e dell’argomento che vi si tratta: 1° - All’affermazione di Montesquieu secondo cui la schiavitù può convenire soltanto a certi paesi, Strube controbatte che lo stesso discorso potrebbe applicarsi alla libertà e, sfruttando a suo vantaggio il relativismo montesquiviano, trae queste pericolosissime conclusioni generali, che vanno ovviamente a sostegno della sua tesi, di cui il discorso sulla schiavitù civile è soltanto, come si è detto, una premessa: « Cette raison ne prouve donc autre chose, sinon que la liberté et la servitude des personnes dont il s’agit, ou du bas peuple, sont en elles mêmes indifférentes à la société, et que tout dépend des mœurs ou des loix, qui peuvent les rendre utiles ou dangereuses dans tous les Etats, où elles existent actuellement » (p. 82). 146 2° - Riconosciuto impossibile il ritorno allo stato di natura e quindi all’uguaglianza naturale, bisogna accettare l’evidenza che « il doit y avoir des hommes, qui veuillent servir, avec d’autres qui veulent être servis » (p. 83), per cui alle leggi non resta che regolare nel migliore dei modi questo rapporto necessario. 3° - Al legislatore spetta dunque soltanto il compito di fissare le modalità di questa servitude, rendendola conforme al bene dei padroni e degli schiavi, nonché a quello della società. L’opera di Strube è molto erudita ed infarcita di riferimenti ad autori e leggi dell’antichità classica, senza trascurare gli autori moderni che facevano autorità in materia, e cioè Grozio e Pufendorf. Le contestazioni mosse a Montesquieu sono spesso assai sottili e colpiscono a segno, mettendo in luce le contraddizioni dell’Esprit des lois o certe affermazioni discutibilissime dal punto di vista strettamente giuridico, o ancora il carattere esclusivamente morale ed umanitario di certe posizioni, mentre Strube sottolinea che il « diritto perfetto » è tragicamente rigoroso ed inumano: « Summum ius, summa iniuria ». La critica di Strube ci sembra particolarmente importante per far luce, da un lato, sul peso che era andato assumendo nel giro di alcuni anni la posizione di Montesquieu nei confronti della schiavitù, dal momento che si ritiene necessario contestarla in maniera così puntuale, dall’altro, sul tipo di lettura che è stata fatta del libro XV. Risulta chiaro infatti che, nonostante tutte le ambiguità su cui si è ripetutamente posto l’accento, i sostenitori della schiavitù lo hanno giudicato un testo decisamente antischiavista (almeno nella maggior parte dei casi). Queste conclusioni trovano del resto conferma nell’ampia critica di cui lo farà oggetto alcuni anni più tardi anche Linguet, partendo da presupposti analoghi a quelli di Strube, e cioè dalla rousseauiana convinzione che la società sia nata sulla morte dell’uguaglianza naturale. È questo un dato che bisogna sempre avere presente, sostiene Linguet, se non si vuole correre il rischio di muoversi nei meandri di un umanitarismo privo di contatti con il reale e perciò incapace di agire su di esso, ancorato com’è ad una serie di generose ma inutili condanne, seguite dalla progettazione di altrettanto inutili castelli senza fondamenta. Sia per Linguet che per Strube al legislatore non resta che gestire la disuguaglianza sociale, nei modi e nelle forme che ritiene più idonei, o meglio, nei modi e nelle forme che la situazione gli impone, dal momento che un’insormontabile necessità regola i rapporti sociali. In fondo, Linguet, non sembra far altro che portare alle estreme conseguenze 147 quella terribile forza derivante dalla « nature des choses », alla quale Montesquieu si è rifiutato di sottoporre in assoluto le leggi, dopo averla posta a loro base, come ben indica l’umano dilemma che lo travaglia e che forse ci può aiutare a capire, perché non abbia potuto superare certe ambiguità nel trattare della schiavitù civile: « Je ne sais si c’est le cœur ou l’esprit qui me dicte cet article-ci » (libro XV, cap. 8°). Infatti, mentre la tradizione, la realtà coloniale del suo tempo e gli stessi princìpi che aveva posto alla base della sua opera sembrano coalizzarsi in difesa della schiavitù, Montesquieu si orienta, in maniera sempre più decisa con il passare degli anni, verso la sua condanna, attingendo la sostanza della sua critica, come ha rilevato Strube, più a ragioni morali ed umanitarie che a ragioni di diritto. Abbiamo già esaminato a lungo le tesi di Linguet e le critiche da lui mosse all’Esprit des lois nel nostro Mon frère, tu es mon esclave! (17), per cui ci limiteremo in questa sede a richiamare il tono generale della sua critica e le obiezioni di maggior peso. La prima accusa mossa da Linguet è quella di superficialità, già mossa anche da Strube e da altri, e di impiego assai discutibile della « plaisanterie »; inoltre egli sostiene che Montesquieu ha attribuito una portata generale a fatti particolari, come si può vedere nei capitoli 6° e 7°: « Il n’y a certainement là rien d’instructif, ni rien même qui revienne au sujet. M. de Montesquieu nous montre de petites particularités fort douteuses peutêtre, ou du moins très-indifférentes, il s’attache à des détails relatifs à tel ou tel peuple, et qui, quand ils seroient vrais, seroient absolument sans conséquence pour les autres » (V, p. 47). Dopo questa critica generale, egli si applica a contestazioni più puntuali dei due capitoli ed in particolare dell’affermazione che la libertà non vale nulla presso i Moscoviti, affermazione che prestava facilmente il fianco a critiche, soprattutto se pensiamo che poco prima lo stesso Montesquieu aveva definito la libertà « inestimable ». In sostanza, nessuna delle ragioni presentate da Montesquieu per spiegare l’origine della schiavitù è veramente generale e sufficiente, secondo Linguet: l’unica verità di portata generale espressa dall’autore è che gli uomini nascono liberi ed uguali, per cui la schiavitù è contraria alla natura, ma non si potrebbe dire la stessa cosa di tutto quanto circonda l’uomo sociale? Non è in rapporto alla natura che si deve esaminare la schiavitù, ma in rapporto alla natura della società e si vedrà allora che ben lungi dall’opporvisi, essa ne fa parte integrante, poiché la società è nata sulla degradazione dei princìpi naturali e morirebbe se fossero reintegrati. 148 Detto questo, ci sembrano di scarso interesse, in questo contesto, i procedimenti specifici di cui si è servito Linguet per dimostrare, partendo dal testo montesquiviano, la giustezza delle « regole classiche » su cui si è fondata la schiavitù, mentre ci sembra fondamentale ricordare che, quali che siano le argomentazioni specifiche usate, esse riconducono sempre ad una motivazione di base unica che è la necessaria esistenza di dominatori e dominati. Come già si è detto, né Strube né Linguet hanno un particolare interesse per la schiavitù coloniale, per cui ignorano del tutto il capitolo 5° dedicato alla schiavitù negra; se si soffermano sul ruolo attribuito da Montesquieu al clima, è soltanto per ricavarne un appoggio ad un discorso più generale, come ha fatto Strube, o per dimostrarne l’arbitrarietà come fa Linguet: « Enfin il y a des pays chauds où l’on ne travaille que par force, et où les maîtres ne domptent que par de mauvais traitements la paresse qui se refuse à la fatigue, je le veux. Qu’en résulte-t-il? Que ces maîtres ont pu devenir durs en voyant la mollesse de leurs esclaves, mais non pas que ce soit cette mollesse qui ait engendré la servitude » (V, p. 53). Va detto per l’esattezza che neppure un difensore della schiavitù coloniale come Malouet (18), che pure pone l’accento sulla difficoltà di adattamento dei lavoratori europei nelle colonie americane, fa leva in maniera troppo accentuata sulla teoria climatica, limitandosi ad appoggiare la sua difesa del lavoro nero coatto con lo scontato richiamo alla paresse dei negri. Per Malouet che, soprattutto nella prima parte del suo Mémoire, scritto nel 1775, ha certamente come punto di riferimento l’Esprit des lois (oltre al Contrat social di Rousseau), l’affermazione da controbattere, a causa della sua portata generale ma anche della sua relativa fragilità, è quella in cui Montesquieu definisce la schiavitù in rapporto al diritto naturale. Malouet infatti conviene con Montesquieu che la schiavitù è contraria al diritto naturale, ma aggiunge subito dopo « dans la personne de celui qui le connoît et le respecte », il che rende possibile tutte le eccezioni e serve perfettamente la sua causa, che è la difesa non della schiavitù in senso assoluto, ma unicamente della schiavitù coloniale, cioè della schiavitù di uomini che quel diritto non conoscono e non rispettano. Con una posizione non molto dissimile a quella di Strube e di Linguet, almeno nella struttura portante della sua difesa, anch’egli sostiene il carattere inevitabile della 149 disuguaglianza sociale, nonostante essa sia ingiusta se si voglia fare riferimento ad un ipotetico diritto naturale, « car il y a lésion dans le contrat immémorial que les riches ont fait avec les pauvres » (p. 26). C’è in Malouet un solo riferimento esplicito a Montesquieu, che sembra suggerire, assieme ad un elogio della sua grandezza, anche una velata accusa di astrattismo, in quella brusca collocazione al centro di una realtà che egli aveva dipinto in termini ironici: « … je crois que ceux-ci (i neri schiavi), jusqu’à ce qu’il s’élève parmi eux un Montesquieu, sont encore plus rapprochés de la condition d’hommes raisonnables, en devenant nos Laboureurs, qu’en restant dans leur pays, soumis à tous les excès du brigandage et de la férocité » (p. 22). Accanto a Malouet, fra i sostenitori della schiavitù coloniale che hanno come punto costante di riferimento l’opera di Montesquieu va ricordato Hilliard d’Auberteuil che si esita, tuttavia, a definire schiavista, tanto profonda è l’avversione che egli mostra in linea di principio per un’istituzione che sembra difendere suo malgrado (19). Dopo aver liquidato in fretta il discorso scontato sulla migliore condizione dei negri sul suolo americano che nella loro terra d’origine, soprattutto se trovano un buon padrone, e sui vantaggi che derivano dal loro impiego, Hilliard si dilunga in calorosi elogi della razza negra, che sono un’anomalia in un sostenitore della schiavitù e lo qualificano come uno scrittore « a mezzo » fra gli opposti orientamenti (20). A questi elogi egli affianca giudizi negativi sulla schiavitù in generale e sulla durezza di quella che viene imposta nelle colonie, giudizi che sono, se non proprio citazioni esatte, parafrasi molto vicine al testo montesquiviano: « Le pays où regne l’esclavage, est l’écueil de l’homme qui n’a que les apparences de la vertu. L’habitude de se faire obéir rend le maître fier, colere, injuste, cruel, et lui fait insensiblement manquer à toutes les vertus morales » (I, p. 136). « A Saint-Domingue, quiconque est Blanc maltraite impunément les Noirs. Leur situation est telle, qu’ils sont esclaves de leurs maîtres et du public. Dans le tort que l’on fait à un esclave, les Juges sont dans l’usage de ne considérer que la diminution de son prix. On devrait au contraire punir sévèrement celui qui a maltraité l’esclave d’un autre: il est horrible d’ajouter la perte de la sûreté à celle 150 de la liberté » (I, p. 145). In quest’ultimo passo, solo lievemente modificato per adattarlo alla situazione, è facilmente riconoscibile il confronto stabilito da Montesquieu, nel capitolo 17°, tra la schiavitù di Atene e quella di Sparta. L’uso che ne fa Hillard d’Auberteuil a proposito della schiavitù coloniale dimostra come, sia pure attraverso il paravento del passato dietro il quale si è spesso accusato, e non a torto, Montesquieu di nascondersi, la sua critica sia perfettamente efficace anche spostata da quel contesto ed applicata alla realtà del suo tempo (21). D’Auberteuil, fraintendendo certamente lo spirito del testo montesquiviano, come farà più tardi anche Jameson, respinge l’affermazione che lo schiavo « n’est point dans la Société », vedendo in essa il trionfo dell’arbitrio assoluto, di cui egli ha potuto constatare fin troppo bene il dominio delittuoso nelle colonie. Riconosce però che il Code noir non riesce ad impedire nessun sopruso nei confronti degli schiavi e chiude il suo discorso con un appello all’umanità che è un riconoscimento implicito dell’inefficacia delle leggi a favore dello schiavo, e quindi, indirettamente, del suo collocarsi ai margini della società. Che Montesquieu sia stato, in modi diversi, anche usato a sostegno della schiavitù e della schiavitù coloniale in particolare, non vi sono dubbi. È quello che abbiamo definito un « uso improprio » dell’Esprit des lois, a cui devono aggiungersi fraintendimenti reali, che continuano purtroppo fino ai nostri giorni, causati dall’ironia dell’autore così sottile da risultare, sembra, impercettibile. A proposito di uso improprio, non sappiamo se in buona o malafede, c’è un aneddoto abbastanza impressionante raccontato da Condorcet (22): in Giamaica si tiene un’assemblea molto importante che deve decidere se ai mulatti liberi debbano venire riconosciuti o meno gli stessi diritti dei bianchi. L’orientamento generale dell’assemblea è favorevole al riconoscimento, quando la situazione viene totalmente capovolta dall’« intervento » di Montesquieu: « L’assemblée penchoit vers ce parti, lorsqu’un zélé défenseur de la chair blanche, s’avisa d’avancer que les Nègres n’étoient pas des êtres de notre espèce, et de le prouver par l’autorité de Montesquieu: alors il lut une traduction d’un chapitre de l’Esprit des loix sur l’esclavage des Nègres. L’assemblée ne manqua point de prendre cette ironie sanglante contre ceux qui tolérent cet exécrable usage, ou qui en profitent, pour le véritable avis de l’auteur de l’Esprit des loix; et les mulâtres de la Jamaïque restèrent dans l’oppression » (nota pp. 35-36) (23). 151 Non è difficile credere all’autenticità di questo aneddoto, anche se è certamente esagerata l’attribuzione di una responsabilità così grave a Montesquieu nell’oppressione dei mulatti giamaicani: è certo che la decisione dell’assemblea non sarebbe stata diversa, anche senza il suo- involontario intervento, resta comunque il fatto che la sua autorità è stata usata in difesa di una causa contro la quale egli aveva combattuto. Ironia del destino o di un colono senza scrupoli? E la storia si ripete. In un pessimo romanzetto dei primi anni dell’800, Les colons 24 ( ) la cui trama serve soltanto da pretesto ad una lezione di « sana moderazione » schiavista, l’autore, A. B. Pinière, si rivolge all’Esprit des lois per ricavarne un appoggio di duplice natura, concernente da un lato la moderazione predicata da Montesquieu al momento di formulare nuove leggi, dall’altro il relativismo che vuole si rispettino le particolarità di ogni singolo paese dal punto di vista istituzionale: « ... avant d’accueillir les innovations, de quelque genre qu’elles soient, il faut bien s’assurer qu’elles n’aient rien de contraire à l’ensemble des idées, des mœurs, des habitudes et des intérêts du peuple à qui l’on veut les faire adopter » (p. 11). Riconosciamo uno dei principi cari a Montesquieu, usato qui a fini decisamente reazionari, poiché serve a Pinière per respingere ogni intervento in materia coloniale, e quindi per difendere la schiavitù. Il richiamo al relativismo ed all’influenza climatica serve in maniera ancora più specifica agli stessi fini: « La position topographique d’un état, le génie de ses peuples, la nécessité de prevenir des convulsions intestines ou de se mettre en mesure de défense à l’égard des voisins, l’influence du climat, l’aspect des mœurs primitives et des habitudes du citoyen, décident le législateur. Vous vous plaindrés qu’il ait souscrit à quelques usages que le cœur reprouve, lorsqu’au fond il n’aura fait que choisir de deux maux le moindre... » (pp. 13-14). Questo esame di alcuni testi di orientamento schiavista nati in risposta all’Esprit des lois, o postulanti un suo appoggio, è ben lontano dall’essere esaustivo: si tratta anzi di una ricerca ancora tutta da fare, soprattutto per quanto concerne i riferimenti sporadici all’opera, anche in testi di difficile accesso, come ad esempio quelli degli archivi coloniali che potrebbero dare risultati insperati. Nel saggio di Jean Tarrade, 152 che ha studiato i progetti di riforma coloniale elaborati da un apposito comitato, alla fine dell’Ancien régime, scopriamo che il primo principio posto alla base della riforma è di stampo inconfondibilmente montesquiviano: 1° - « Les loix doivent être puisées dans la nature des choses et faites pour la nature des choses... » (25). Pensiamo tuttavia che, anche così incompleta, la nostra indagine metta sufficientemente in luce l’importanza che i sostenitori della schiavitù hanno riconosciuto all’opera di Montesquieu e lo sforzo da essi costantemente compiuto per contestarla o piegarla ai loro disegni. Concludiamo la nostra analisi con un rapido scandaglio delle errate interpretazioni cui ha dato luogo il capitolo 5° del libro XV. Sono tutte del tipo a cui si è accennato più sopra nell’aneddoto di Condorcet, ma mentre in quel caso era possibile pensare ad una volontaria mistificazione del testo, nelle opere che prenderemo ora in esame, l’errore è certamente involontario. Precisiamo, a scanso di equivoci, che non si tratta più di autori schiavisti e che il loro inserimento in questa sede è stato suggerito sia dall’analogia che la loro interpretazione del testo montesquiviano presenta con quello che ne abbiamo definito un « uso improprio », sia dalla convinzione che la lettura di fraintendimenti fatti in buona fede possa aiutare a capire e a spiegare i meccanismi di fraintendimenti voluti a fini strumentali. Ricordiamo infine che la scoperta di questi testi è stata per noi casuale e non frutto di un’indagine specifica, per cui risulta largamente incompleta e, quindi, più adatta a comprovare l’esistenza di un fenomeno che le sue reali proporzioni. Un’ultima precisazione riteniamo importante, anche se potrebbe essere resa superflua dall’analisi che segue: non sappiamo se casualmente o in rispondenza alle reali caratteristiche del fenomeno (ma questa seconda ipotesi sembra la più attendibile), tutti gli autori da noi esaminati, che non hanno saputo cogliere l’ironia di Montesquieu, sono stranieri. Un’indagine specifica correggerebbe forse in parte questi risultati, ma è certo che la barriera linguistica ha costituito un limite notevole all’esatta comprensione dell’ironia montesquiviana, unita però, soprattutto negli ultimi esegeti, ad una imperdonabile superficialità di lettura. In un’edizione napoletana dello Spirito delle leggi del 1777 (26), ristampa, come indica l’editore stesso, di un’edizione precedente, con note di quattro tipi (27), troviamo, da parte di quelli che sono definiti nella prefazione i « savi Revisori », una reazione piuttosto indignata di fronte al presunto razzismo del capitolo 5°: « Qui il MONTESQUIEU la tira troppo, quando niega a’ Negri fino la stessa umanità ed il senso comune. Deciderà forse dell’umanità il color bianco, o nero? La leggiadria o deformità del volto produrrà la bontà o perversità dell’animo? E 153 poi un uomo nero proporzionato non è bello nel suo genere? Noi non sappiamo fin dove arriverebbero i Negri, se fossero educati nelle lettere. Certamente secondo l’Elvezio potrebbero troppo avanti passare » (nota al cap. 5°, libro XV, vol. II, p. 81). Particolarmente degna di rilievo, fra le note al libro XV, in questa edizione, è la nota al capitolo 12°, dovuta alla penna dell’abate Genovesi, che sembra sostenere l’inevitabilità della disuguaglianza sociale: « Come in tutti i paesi il povero è fatto per servire al piacere del ricco e del potente » (II, p. 87). Abbiamo però l’impressione che questa nota abbia più il carattere di una disincantata presa di coscienza, che quello di un’affermazione di principio (28). Ricordiamo che la critica generale mossa dal Genovesi a Montesquieu, a proposito della schiavitù, concerne le cause. Secondo l’abate infatti « ella è effetto delle cause morali, non delle fisiche » (nota al cap. 11°, II, p. 86). Esitiamo ad inserire in questa indagine, la critica settecentesca di Dalmazzo Vasco, a causa della difficoltà di interpretazione corretta di un termine chiave di essa, a proposito del capitolo 5°, e precisamente della parola « corbellare ». Ci limitiamo perciò a trascrivere il passo che sembrerebbe, nella prima parte prendere sul serio il discorso di Montesquieu a proposito della schiavitù negra, a meno che l’interlocutore contestato non sia l’ipotetico schiavista a cui Montesquieu dà ironicamente la parola. Dalmazzo cita alcuni brani del capitolo 5°, per poi passare al commento: « 337. Cattiva raggione: perché hanno rovinato gl’uni acquistano il diritto di maltrattar gl’altri? Coltivare le terre? O che? Come, erano loro quelle terre? E, se le volevano coltivare, lo facessero da sé, oppure si servissero di chi volevano, ma non mai della forza e della schiavitù. 338. Dunque, se qualche nazione trovasse più comodo, per aver a buon prezzo un qualche genere, ci venisse a ridurre in schiavitù, ci avrebbe un buon diritto. 339. Qui si vede che l’autore corbella davvero » (29). Si potrebbe però avanzare anche un’altra ipotesi: visto che l’ultima considerazione di Dalmazzo si riferisce al passo in cui Montesquieu afferma che gli schiavi in questione hanno il naso così schiacciato da non poter muovere a 154 compassione, è possibile che egli ne abbia colto l’ironia, senza estenderla al resto del capitolo. Conveniamo però che si tratta di un’ipotesi assai poco probabile, tanto il procedimento di lettura risulterebbe strano. Dalmazzo è contrario ad ogni forma di schiavitù, eccezion fatta di quella che viene istituita come strumento di pena, nel qual caso « è un diritto giusto » (note al capitolo 1°, p. 300), anche se la punizione è affidata a privati. Su molti punti egli si trova d’accordo con Montesquieu, per cui il suo commento è spesso soltanto una parafrasi od una chiarificazione di quanto era già implicito nell’Esprit des lois, come si può vedere, ad esempio, dal suo commento al capitolo 8°, che ha per titolo: Inutilité de l’esclavage parmi nous: « La schiavitù è contro natura in tutti i paesi del mondo e in tutti i paesi può esservi come pena. In alcuni paesi, e per il clima, e per il lungo uso si è resa meno sensibile, ossia gli uomini vi sono talmente incalliti che la sentono meno e sono meno capaci di formare il progetto di scuotere il giogo: ma questo non giustifica mai la schiavitù e chi ve la mantiene senza necessità» (p. 303). Ritroviamo in questa netta opposizione alla schiavitù da parte di Dalmazzo, quel pericoloso richiamo alla necessità che è il cavallo di battaglia degli schiavisti, i quali su un presunto stato di necessità fanno appunto leva per sostenere che la situazione nelle colonie è intoccabile. In attesa di una ricerca specifica, e quindi più approfondita ed attendibile di quella da noi indirettamente condotta, che faccia luce su questo aspetto della « fortuna » dell’Esprit des lois, concludiamo accennando alle bévues del nostro secolo, che sono anche le più difficili da spiegare e da accettare. Davis parla di un’edizione americana della nota traduzione settecentesca di Thomas Nugent, rivista da J. V. Prichard, stampata a New York nel 1900, che porta il seguente commento al capitolo 5°: « Gli argomenti di cui sopra costituiscono uno straordinario esempio dei pregiudizi di cui anche uno spirito liberale può essere schiavo » (30). Abbiamo potuto consultare il testo in una ristampa del 1959 (31) e, sembra incredibile, il commento è esattamente lo stesso: a distanza di quasi sessant’anni il nuovo editor non è intervenuto per correggerlo. Appunti analoghi muove, nel 1938, Hermann Knust: non cogliendo l’ironia del 155 capitolo 5°, egli ne trae lo spunto per denunciare i limiti della concezione egualitaria montesquiviana: « In einzelnen philosophischen Ansichten zeigt er sich zeitgebunden. So wiederholt er die Ideen des 18. Jahrhunderts und bemerkt: ‘Tous les hommes naissent égaux (XV, 7)’, während er zwei Seiten vorher von den Negern meint: ‘Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes’. Er bietet nun allen seinen Scharfsinn auf, um diesen schreienden Widerspruch wegzudeuten. Er lehnt Hobbes’ Meinung vom ursprünglichen Kriegszustand ab, la guerre de tous contre tous » (32). Infine, ci è capitato di leggere recentemente un’opera dal titolo invitante, I tabù della dottrina sociale cristiana (33), un capitolo della quale è dedicato, in una sintesi rapidissima, sulla scia del Davis, al problema della schiavitù. Vi abbiamo incontrato una nota di questo tenore: « Per quanto riguarda l’illuminismo occorre, in ogni caso, evitare mitizzazioni, perché il processo culturale che esso rappresentò fu molto complesso. Se Voltaire era contro la schiavitù, la posizione, molto più influente, di un Montesquieu rivelava un atteggiamento straordinariamente favorevole al razzismo, su cui fondava la schiavitù, negra specialmente » (p. 52). Segue la traduzione di tutto il capitolo 5°. È forse l’interpretazione che lascia la bocca più amara, innanzitutto per il fatto di essere tanto vicina a noi, che pensavamo non potessero più esistere dubbi sul vero significato di questo testo così sfortunato. Ed infine perché, al di là del fraintendimento di un problema e di un autore specifici, viene usata come paradigma della chiusura illuminista. Note (1) J. Barni, op. cit., I, p. 199. (2) Abbé Louis Debonnaire (o De Bonnaire), L’Esprit des Loix quintessencié. Par une suite de lettres analytiques, (s.l.) 1751, 2 voll. (L’opera fu pubblicata anonima). (3) Cfr. M. Duchet, op. cit., pp. 125-136 e 151-160. (4) Rinviamo al nostro Mon frère, tu es mon esclave! : per quanto concerne i quesiti posti 156 alla Sorbona, pp. 38-41; per quanto concerne le teorie di Melon, pp. 27-28. (5) Inoltre, le collezioni del tipo di quella di Prévost mettono alla portata di un pubblico sempre più vasto opere altrimenti difficilmente reperibili, soprattutto mancando la traduzione in lingua francese. (6) In questa dissertazione Jameson crede di poter riconoscere la traduzione di un testo precedentemente scritto in spagnolo dal padre « Benoît Jérôme Feijóo y Montenegro» (op cit., pp. 177-179). (7) Cfr. op. cit., p. 180. Va detto per l’esattezza che Jameson ha sottolineato l’atmosfera generale in cui si inserisce il libro XV, privilegiando però i testi giuridici o letterari, rispetto ai fatti storici. (8) Montesquieu, Correspondance in Œuvres complètes, tomo III, ed. André Masson, Parigi 1955, p. 1294. (9) Claude Dupin, Réflexions sur quelques parties d’un livre intitulé de l’Esprit des lois, Parigi, 1749, 2 voll. II, p. 346. (L’opera apparve anonima). (10) Citato da Jameson, op. cit., p. 344, che ha consultato un’edizione in 3 voll. del 17571758, quindi fatta sulla seconda redazione dell’opera di Dupin, che non abbiamo potuto consultare. Sul complesso problema della redazione di questa critica cfr. C. Rosso, Montesquieu moraliste. Des lois au bonheur, tr. fr. aumentata, Bordeaux, 1971 (Ed. it. Pisa, 1965), Ia appendice: Montesquieu et Dupin. Un éreintement manqué, pp. 283-316. (11) F. H. Strube de Piermont, Lettres russiennes, s.l., 1760, ora ristampate a cura di C. Rosso, Pisa, 1978, postface di C. Biondi, Montesquieu, Strube et l’esclavage, pp. 191-209. (La postface è qui in parte ripresa). (12) La prima edizione è del 1767. Abbiamo consultato l’opera nell’edizione riveduta ed aumentata delle Œuvres, Londra, 1774, 5 voll., III-V. Su Linguet cfr. Ginevra Conti Odorisio, S.N.H. Linguet dall’Ancien Régime alla Rivoluzione, Milano, 1976. (13) Si legge in Strube : « La seule chose, sur quoi un examen impartial de la diversité des hommes ne laisse aucun doute, c’est que dans tous les pays du monde, il est des hommes si peu avantagés des dons de la nature qu’il ne paroissent propres qu’a vivre sous la tutèle des autres, et à mériter le secours dont ils ont besoin, par les travaux ou les services qui demandent plus de force et de patience que de génie et d’application. Ce sont les hommes de qui l’on peut dire avec Aristote qu’ils naissent esclaves... » (pp. 80-81). Come si può vedere Strube, risalendo ad Aristotele, sostiene che vi siano uomini destinati dalla natura ad essere schiavi di altri, ma ciò indipendentemente dal clima o dalla razza. Anche Linguet critica le discriminazioni razziali: « Il est défendu à tous les blancs de mettre un blanc à la chaîne pour leur profit. Il leur est bien permis d’acheter et de vendre des Noirs qui ne leur doivent rien: mais la couleur olivâtre ou cendrée de la peau, est pour ceux qui ont le bonheur d’en être doués, un Talisman qui les préserve même quand ils ont des dettes, du péril d’être compris dans ce commerce » (op. cit., V, p. 208). (14) A dire il vero il rilievo di Strube non è chiarissimo; pensiamo voglia mettere l’accento sui limiti entro i quali si esercita il potere del padrone. (15) « Ce raisonnement, je l’avouë m’a étonné, tant les idées que l’A. y réunit, contrastent mal ensemble. Il est certain qu’un châtiment n’est juste et permis, si la loi, qui l’inflige au criminel, n’a été faite en faveur de tous ceux qui se trouvent avec lui dans la même société, et que sous ce regard le criminel n’a pas moins joui de cette loi que tous ses concitoyens. Mais cette régie embrasse sans doute toutes les punitions. On a seulement douté si la peine de mort est juste, parce que tout châtiment devant servir principalement à la cor- 157 rection du coupable, cette fin cesse lorsqu’on ôte la vie; et l’on a eu recours à un principe particulier. On a soutenu qu’un homme qui commet certains crimes atroces, comme des meurtres etc. doit être regardé comme ennemi de la société, et comme digne par là d’être traité comme tel. Les peines capitales sont donc justes, non seulement comme peines, mais encore comme homicides. Il en est de même de celle qui prive un citoyen de sa liberté » (pp. 64-65). (16) Ci sembra interessante accostare a questa disquisizione sul valore della libertà, le osservazioni di Destutt de Tracy sullo stesso argomento, nel Traité d’économie politique (Parigi, 1823): « Voudrait-on encore, avant de quitter ce sujet, appliquer à ce premier de tous les biens, la liberté, l’idée de valeur que nous avons vu naître nécessairement de l’idée de bien? et demanderait-on quelle est la valeur de la liberté? Il est évident que, la liberté totale d’un être sentant et voulant n’étant autre chose que la puissance d’user à son gré des facultés qu’il a, la valeur entière de cette liberté est égale à la valeur entière de l’emploi des facultés dont on lui interdit l’exercice, et que la valeur de ce qui lui en reste est la même que celle des facultés dont il conserve l’usage; et enfin il est manifeste encore que, quelque foibles que soient les facultés d’un être animé, la perte absolue de sa liberté est une perte vraiment infinie pour lui, et à laquelle il ne peut mettre aucun prix, puisqu’elle est absolument tout pour lui, qu’elle est l’extinction de toute possibilité de bonheur, qu’elle est la perte de la totalité de son être, qu’elle ne peut admettre aucune compensation, et qu’elle lui enlève la disposition de tout ce qu’il pourrait recevoir en retour» (pp. 46-47). A parte il calcolo minuzioso del valore di libertà, la posizione di Destutt è assai vicina a quella di Montesquieu. (Nel testo citato il corsivo è dell’autore). (17) Cfr. pp. 53-70. (18) Mémoire sur l’esclavage des Nègres, Neuchâtel, 1788. Su Malouet cfr. il nostro Mon frère..., pp. 20-26 e passim. (19) Considérations sur l’état présent de la colonie française de Saint-Domingue. Ouvrage politique et législatif présenté au Ministre de la Marine par Mr. H. Dl. Parigi, I vol. 1776, II vol. 1777. (20) Leggiamo, fra l’altro, nelle sue Considérations: « … aucune espece d’hommes n’a plus d’intelligence... » (I, p. 132); « ... ils sont plus courageux qu’il n’appartient à des hommes soumis à l’esclavage... » (I, p. 141) : « Ils ne sont pas, comme on voit, dépourvus d’intelligence, et les Ecrivains qui leur ont supposé des facultés bornées, les ont jugés trop légérement. Ils sont au contraire adroits et spirituels; ils méritent l’attention du sage, car s’ils n’ont pas toutes les vertus, ils sont exempts de bien des vices » (I, p. 142). (21) Anche Dalmazzo Vasco (cfr. infra), nel suo commento all’Esprit des Lois, in Opere, a cura di Silvia Rota Gribaudi, Torino, 1966, p. 303, paragona la schiavitù degli Iloti a quella dei negri d’America. (22) Condorcet, Réflexions sur l’esclavage des nègres, Neuchâtel e Parigi, 1788, pp. 35-36 nota (la prima edizione è del 1781). L’opera fu pubblicata sotto lo pseudonimo di « Schwartz, pasteur du Saint Evangile à Bienne ». Abbiamo consultato il testo nella raccolta La Révolution française et l’abolition de l’esclavage. Textes et documents, Parigi, 1968, 12 voll. La raccolta pubblicata dalle Editions d’Histoire sociale (useremo in seguito per indicarla la sigla EDHIS), riunisce ottantasei testi, di varie dimensioni, quasi tutti di orientamento abolizionista, pubblicati in Francia negli anni della Rivoluzione, ed in quelli immediatamente precedenti e successivi. L’opera di Condorcet si trova nel VI volume. (23) Stando a quanto afferma il Davis (op. cit., p. 442), ma non ci è stato possibile 158 controllare l’esattezza dell’affermazione, anche Gordon Turnbull autore di An Apology for Negro Slavery: Or the West Indian Planters vindicated from the Charge of Inhumanity (2a ed., Londra 1786), si sarebbe ispirato a Hume e a Montesquieu. (24) Di A. B. Pinière, Parigi, 1804. (25) J. Tarrade, L’administration coloniale en France à la fin de l’Ancien Régime: Projets de réforme, in « Revue historique », gennaio-marzo 1963, pp. 103-122, p. 116. (26) Spirito delle leggi del signor di Montesquieu con le note dell’abate Antonio Genovesi, Napoli 1777. In un’edizione di Milano del 1894 (Silvestri, 4 voll.) che si avvale di questa edizione napoletana, leggiamo nell’avvertenza che si tratta di una delle migliori pubblicate in Italia. (27) 1° – le note di Montesquieu; 2° – le note, tradotte dal francese, di un anonimo autore di Riflessioni; 3° – le note dell’abate Antonio Genovesi; 4° – le note di quelli che vengono definiti i « savi Revisori » dell’edizione. In realtà queste ultime sono dovute alla penna del solo Salvatore Ruggiero, cfr. E. de Mas, Montesquieu, Genovesi e le edizioni italiane dello «Spirito delle leggi», Firenze, 1971, p. 63. (28) Sul commento di Genovesi cfr. E. de Mas, op. cit., in particolare pp. 149-157. Sugli echi in Italia dell’opera di Montesquieu cfr. anche S. Rotta, Montesquieu nel Settecento italiano. Note e ricerche, in Materiali per una storia della cultura giuridica, a cura di G. Tarello, vol. I, Bologna 1971. (29) Francesco Dalmazzo Vasco, Note allo « Spirito delle leggi » di Montesquieu, in op. cit., pp. 301-302. Su di lui cfr. C. Rosso, Vasco e Montesquieu nella prigione di Ivrea, in La politica della ragione. Studi sull’Illuminismo francese, a cura di P. Casini, Bologna, 1978, pp. 71-106. (30) Op. cit., p. 453. (31) The Spirit of Laws by Baron de Montesquieu, translated by Th. Nugent with an Introduction by F. Neumann, New York, 1959 (la prima ristampa è del 1949). La nota nel testo originale è la seguente : « The above arguments form a striking instance of the prejudice under which even a liberal mind can labor » (nota al capitolo 5°, vol. I, p. 239). (32) Montesquieus «Esprit des lois» im Lichte nationalsozialistischer Weltanschauung, in « Neuphilologische Monatsschrift », 1938, p. 178. (33) R. Orfei, Roma, 1974. Il corsivo è nostro. 159 « L’ESPRIT DES LOIS » NEL SETTECENTO ANTISCHIAVISTA Quasi tutti gli oppositori settecenteschi della schiavitù, almeno fino alla Rivoluzione, perché poi la situazione cambia radicalmente, hanno visto in Montesquieu un precursore e molti di essi hanno costruito le loro dissertazioni sul canovaccio da lui offerto, arricchendolo di argomentazioni nuove, legando un discorso che egli aveva voluto frammentario, riducendo il posto occupato dal passato nell’Esprit des lois, lasciando cadere quanto poteva risultare controproducente ai fini della loro lotta, ma restando insomma assai vicini al modello. Questo significa che gli abolizionisti del ‘700 hanno letto l’Esprit des lois come un testo antischiavista e che, nella maggior parte dei casi, non si sono mostrati né troppo esigenti né troppo severi nei confronti dell’autore e non gli hanno rimproverato quell’ambiguità su cui hanno insistito, e non senza motivo, tutti i critici moderni. Evidentemente agli antischiavisti dell’epoca (e ci riferiamo sempre al periodo che precede la Rivoluzione) che cercavano faticosamente una linea di lotta, non facile in un paese che possedeva colonie lavorate da schiavi ed aveva elaborato un Code noir, la posizione di Montesquieu non è sembrata né timida né troppo indecisa, ed è risultata chiara la sua condanna di fondo della schiavitù. Ci sono naturalmente alcune eccezioni, casi cioè in cui si è rimproverato all’autore di non aver assunto una posizione sufficientemente chiara e decisa ed altri, come vedremo nel corso dell’indagine, in cui si è trovato che lo scherzo era di cattivo gusto e fuori luogo, a proposito del dramma negro. Fra coloro che lo hanno accusato di mancare di chiarezza, un posto di primo piano spetta all’abbé Debonnaire, non tanto per l’interesse delle critiche mosse al libro XV, quanto piuttosto per il tono irriverente in cui sono mosse e la minuzia di analisi che le sorregge. L’Esprit des lois quintessencié dell’abbé Debonnaire è abbastanza noto per esentarci da una presentazione: ci limitiamo a ricordare che si tratta di una critica in forma epistolare e che in ogni lettera viene esaminato un libro dell’Esprit des lois, ad eccezione della prima, in cui si analizza la prefazione. Il libro XV è perciò preso in esame, e metodicamente stroncato, nella lettera sedicesima. I rilievi mossi da Debonnaire al libro sono di duplice natura e concernono, da un 161 lato, i presupposti su cui si regge, dall’altro il metodo di composizione e quindi di approccio alla materia che non tiene sempre conto di quei presupposti. Per quanto concerne i primi, egli critica aspramente, come molti altri uomini di chiesa e non in quegli anni, la teoria climatica, che sostituisce a principi morali princìpi puramente fisici, ed anche i modi poco decisi con cui Montesquieu ha espresso le sue critiche alla schiavitù, in parte condizionato proprio da quei presupposti. Per quanto concerne il metodo, Debonnaire ne rileva l’incoerenza con i princìpi enunciati dall’autore, ma poiché quei princìpi erano, come si è visto, respinti dall’abate, la sua critica al metodo si trasforma spesso in una valutazione positiva dei contenuti del libro, anzi, si può dire che soltanto ciò che è in contrasto con le tesi di fondo di Montesquieu trovi grazia ai suoi occhi. Così, ad esempio, mentre dimostra, a dire il vero abbastanza facilmente, come il clima non abbia nulla a che fare con l’argomento trattato nel libro XV, almeno come ve lo ha trattato Montesquieu, si trova d’accordo con quest’ultimo quando afferma che è soltanto la legge del più forte a tenere legato lo schiavo, il quale ha perciò il pieno diritto di scuotere un giogo ingiusto. L’abate approva anche il modo in cui Montesquieu ha parlato della schiavitù negra: « L’Auteur qui sent l’absurdité de cette manière de raisonner, se retranche à ne la combattre qu’indirectement, par une ironie aussi persuasive qu’ingénieuse... » (1). Mentre trova sconveniente che l’autore dell’Esprit des lois, a proposito della schiavitù di guerra, abbia fatto dello spirito sulla parola pietà, e sente addirittura il bisogno di scomodare la divinità per dare maggiore efficacia alla condanna della schiavitù per debiti che aveva trovato, a suo avviso, in Montesquieu un critico non sufficientemente lucido: « ...il [il debitore] ne peut volontairement se rendre esclave, et nulle Loi civile ne peut lui permettre ce que Dieu lui défend. C’est sur ce principe, qu’il ne peut en conscience reconnaître un maître despotique, dont les volontés pourroient être contraires à celle de son maître suprême. L’obéissance aveugle ne peut se promettre sans impiété » (I, p. 441). Di fondamentale importanza è qui il fatto, ancora abbastanza raro al momento in cui scrive Debonnaire, che egli ricorra a Dio non per sostenere, ma per condannare la 162 schiavitù. In definitiva, secondo Debonnaire, Montesquieu non è stato sufficientemente deciso nella condanna della schiavitù ed è stato poi del tutto incoerente nei confronti dei princìpi che egli stesso aveva posto alla base della sua indagine: una critica, tutto sommato, abbastanza accettabile per quanto riguarda i contenuti. I suoi limiti peggiori sono da ricercarsi nei termini violenti di una grossolana ironia, molto spesso superficiale, di cui l’abate si serve per attaccare l’Esprit des lois: « C’est un Roman bigarré, dont on pourra dire qu’on la (sic) lu, quand on en aura pris la peine, et supporté l’ennui » (I, p. 452). « Il continue à s’amuser dans des espaces à peu près aussi vuides, au moins du côté de l’utilité des observations » (ivi). « Continuerai-je M. de vous égaïer ou de vous affadir, par une scrupuleuse Analyse de tant d’insipides ou de si burlesques pensées... » (I, pp. 456-457). C’è invece un rilievo che ci sembra importante, non tanto in relazione al testo montesquiviano, quanto piuttosto in riferimento alle posizioni schiaviste in genere, che facevano della « necessità » uno dei pilastri delle loro teorie. Dopo aver rimproverato a Montesquieu di dare l’impressione che gli eunuchi siano in Oriente un male necessario, Debonnaire commenta: « Jamais les hommes sages n’applaudissent à cette pensée. La necessité ne connoît point de loi; mais la sagesse ne connoît point de maux que la Loi doive tolérer, comme nécessaires quand ils outragent la nature » (I, pp. 461-462). Sembra una risposta ante litteram alle posizioni dei vari Malouet, Linguet ecc., e persino a tante esitazioni dei primi uomini della Rivoluzione. Infine nella lettera diciassettesima, in cui esamina il libro XVI, Debonnaire paragona Montesquieu a Don Chisciotte che combatte contro i mulini a vento ed è felice, perché crede di avere sconfitto dei giganti. Anche Montesquieu, nel tentativo di stabilire un rapporto tra clima e schiavitù, ha preso un abbaglio, scambiando la causa con l’effetto, ed anch’egli, come Don Chisciotte sembra essere contento, visto che continua sullo stessoo terreno anche nel libro seguente. Ma eccezion fatta del caso clamoroso di Debonnaire, i primi abolizionisti fanno dell’Esprit des lois, se non sempre un modello, certamente un punto di avvio del loro discorso. 163 Una posizione di primo piano è riservata a Montesquieu nell’Encyclopédie, i cui orientamenti antischiavisti sono però tutt’altro che netti, come dimostra, ad esempio, il caso della voce Nègre (2). Con ciò non si vuole ovviamente affermare che l’Encyclopédie è favorevole alla schiavitù, ma piuttosto che non ha sufficientemente messo a fuoco il problema e trascrive, spesso pedissequamente, testi precedenti di orientamento anche assai dubbio. Questo discorso non vale però per la voce Esclavage, redatta da Jaucourt (3) nella quale, dopo un excursus storico, la condanna è espressa, spesso sulla falsariga del testo montesquiviano, senza la minima incertezza: «... l’esclavage n’est pas seulement un état humiliant pour celui qui le subit, mais pour l’humanité même qui est dégradée. Les principes qu’on vient de poser étant invincibles, il ne sera pas difficile de démontrer que l’esclavage ne peut jamais être coloré d’aucun motif raisonnable, ni par le droit de guerre (...), ni par le droit d’acquisition, ni par celui de naissance (...); en un mot, rien au monde ne peut rendre l’esclavage légitime » (4). La seconda parte della voce è quasi esclusivamente composta di passi dell’Esprit des lois, concatenati in un discorso chiaramente antischiavista, anche se a volte la trascrizione letterale del modello può risultare debole rispetto al tono generale del discorso, più nettamente critico nei confronti della schiavitù, fino a dar l’impressione, in certi casi limite, che esista una leggera discrepanza tra l’affermazione di Jaucourt e la citazione di Montesquieu. Ad esempio, dopo aver affermato che nulla può giustificare la schiavitù, Jaucourt si sofferma ad esaminare se non vi siano dei casi in cui essa possa derivare dalla « nature des choses ». La risposta che egli dà al dubbio da lui stesso sollevato è un tipico esempio di questa sfasatura di tono tra la sua posizione e quella montesquiviana, che vengono però abbinate come se si collocassero esattamente sullo stesso piano. Va detto subito che la citazione, per essere adattata, viene profondamente « corretta » dall’introduzione di un paroisse, che non riesce però a creare una sutura del tutto convincente: « Cependant n’y a-t-il point des cas ni de lieu où l’esclavage dérive de la nature des choses? Je réponds I°. à cette question qu’il n’y en a point; je réponds ensuite, avec M. de Montesquieu, que s’il y a des pays où l’esclavage paroisse fondé sur une raison naturelle ce sont ceux où la chaleur énerve le corps... » ecc. (p. 878). 164 Segue la citazione del noto passo di Montesquieu che sembra ammettere un’eccezione all’interno di una così decisa posizione di rifiuto, anche se la conclusione della voce ribadisce poi in termini inequivocabili il carattere negativo di ogni ragione su cui si fondi la schiavitù: « Concluons que l’esclavage fondé par la force, par la violence, et dans certains climats par l’excès de la servitude, ne peut se perpétuer dans l’univers que par les mêmes moyens » (p. 878). Va però rilevato un aspetto molto importante del testo di Jaucourt e cioè la totale assenza di riferimenti alla schiavitù coloniale. In questo egli si mostra dunque assai più cauto di Montesquieu, che aveva almeno lanciato la freccia dell’ironia. Persino il panorama storico che apre la voce si arresta al XV secolo, con l’eccezione di una lunga nota dedicata alla situazione polacca, al fine di « redresser », dice Jaucourt, tante idee « désavantageuses » che circolano su questo paese. Si ha comunque la netta sensazione che non si tratti soltanto di una questione di prudenza, smentita, sembrerebbe, dal taglio deciso della posizione assunta da Jaucourt, quanto piuttosto di assenza di focalizzazione dell’aspetto essenziale del problema, come dimostrerebbe anche l’accettazione nell’Encyclopédie della voce acritica e, tutto sommato, denigratoria, dedicata ai Negri da Formey. È quasi certo comunque che anche la prudenza ha forse la sua parte, in quanto è scontato che è molto più facile essere intransigenti sul piano dei princìpi, che attaccare errori e abusi precisi. Quali che siano i limiti della voce dell’Encyclopédie nei confronti della schiavitù coloniale (5), resta il fatto che Montesquieu è servito a confezionare un testo nettamente antischiavista sul piano dei princìpi, dunque il suo ruolo nella lotta settecentesca contro la schiavitù viene fin d’ora riconosciuto, amplificato e consolidato dal suo farsi voce di « dizionario » con i limiti, ma anche i vantaggi che questo comporta, non ultimo il contatto con un pubblico più vasto, che accede al sapere attraverso opere di carattere divulgativo, sia pure di alto livello. Montesquieu si avvia a diventare, anche grazie ad una cassa di risonanza tanto importante, il campione dell’antischiavismo francese, almeno per circa un ventennio. Dato per scontato che il discorso teorico generale degli abolizionisti francesi del ‘700 riprende lo schema e, spesso, con varianti di scarso rilievo, le argomentazioni dell’Esprit des lois (ma abbiamo già ricordato anche che col passare degli anni l’attenzione degli abolizionisti si appunta sempre meno sui discorsi teorici, e sempre più invece sulla situazione concreta), ci limiteremo a rilevare, con un procedimento indifferenziato che può essere certamente discutibile, ma serve bene ad una 165 ricognizione generale del fenomeno, in scritti di genere assai diverso, che comprendono saggi eruditi, ma anche racconti e persino poesie, i riferimenti espliciti od impliciti ma chiaramente leggibili, a Montesquieu. Si tratterà insomma di una sorta di rapida antologia critica di citazioni montesquiviane o di riconoscimenti da parte degli uomini del suo tempo dell’azione svolta dall’autore nel settore della lotta contro la schiavitù, che ci sembra potrà risultare di grande utilità per individuare la portata ed i limiti del rayonnement dell’Esprit des lois in questo ambito specifico. È anche qui impossibile pretendere all’esaustività, ma l’indagine da noi condotta pensiamo sia abbastanza vasta per permetterci di ricostruire nella maniera più convincente e più attendibile l’influenza dello scrittore sugli uomini del suo secolo, sempre, ovviamente, nell’ambito dei problemi che qui ci interessano. Non sappiamo se Voltaire abbia presente il capitolo 5° dell’Esprit des lois quando traccia il quadro della schiavitù coloniale e colpisce, con la sua ironia, i sofismi di cui l’Europa e la Chiesa si sono servite per asservire gli Africani, nel rapido ritratto dello schiavo di Surinam in Candide (1759), ma pensiamo lo abbia certamente presente quando, a conclusione dell’Histoire des voyages de Scarmentado (1756), fa dire ad un corsaro africano che ha fatto prigionieri degli Europei: « Vous avez le nez long, et nous l’avons plat; vos cheveux sont tout droits, et notre laine est frisée; vous avez la peau de couleur de cendre, et nous de couleur d’ébène; par conséquent nous devons, par les lois sacrées de la nature, être toujours ennemis. Vous nous achetez aux foires de la côte de Guinée, comme des bêtes de somme (...) aussi quand nous vous rencontrons et que nous sommes les plus forts, nous vous faisons esclaves, nous vous faisons labourer nos champs, ou nous vous coupons le nez et les oreilles. On n’avait rien à répliquer à un discours si sage » (6). Sappiamo, dall’articolo Esclaves del Dictionnaire philosophique, che Voltaire ha apprezzato il modo in cui Montesquieu ha « peint l’esclavage des nègres avec le pinceau de Molière » e che ha approvato il suo atteggiamento generale (salvo appunti su aspetti particolari) nei confronti della schiavitù, come risulta dal Commentaire sur «L’esprit des lois» (1777), nel quale esprime il più alto riconoscimento dello sforzo compiuto da Montesquieu: « Si quelqu’un a jamais combattu pour rendre aux esclaves de toute espèce le droit de la nature, la liberté, c’est assurément Montesquieu. Il a opposé la raison 166 et l’humanité à toutes les sortes d’esclavages: à celui des nègres qu’on va acheter sur la côte de Guinée pour avoir du sucre dans les îles Caraïbes; à celui des eunuques... » (7). Lo stesso Commentaire (come del resto l’articolo Esclaves del Dictionnaire philosophique) mette però anche in luce i limiti dell’interesse di Voltaire nei confronti della schiavitù coloniale: subito dopo l’incipit citato, tutto il commento diventa infatti una perorazione in difesa di quei lavoratori europei che sono ancora schiavi dei conventi, in nome del cosiddetto diritto di manomorta, mentre non una sola parola è spesa in favore degli schiavi negri. Passando da Voltaire a Rousseau, c’è appena bisogno di ricordare che il capitolo dedicato al problema della schiavitù nel Contrat social (1762) è tutto montesquiviano sia nella strutturazione che nel modo di argomentare, anche se l’assenza di quella frammentarietà che caratterizza la disposizione della materia nell’opera di Montesquieu, e la sintesi operata da Rousseau, hanno dato al suo discorso un carattere di maggiore incisività. Inoltre, la teoria del contratto ha fornito a tutta l’argomentazione un solido piedistallo critico: poiché il contratto tra padrone e schiavo è tutto a vantaggio dell’uno ed a danno dell’altro, esso è nullo, quindi diritto e schiavitù sono una contraddizione di termini e si elidono vicendevolmente. La novità non consiste tanto nel rilevamento della nullità del contratto, già presente in Montesquieu, quanto piuttosto nella forza che il riconoscimento di questa nullità acquista all’interno di una concezione socio-politica che ruota tutta attorno all’idea di contratto. Di stampo nettamente montesquiviano è anche la contestazione mossa da Rousseau a Grozio a proposito della schiavitù di guerra: la guerra non dà alcun diritto che non sia necessario al suo scopo e cioè la distruzione dello Stato nemico. Ora, non appena il vinto depone le armi cessa di essere un nemico o uno strumento del nemico e nessuno può più avanzare diritti sulla sua vita: « Ces principes ne sont pas ceux de Grotius; ils ne sont pas fondés sur des autorités de poètes; ils dérivent de la nature des choses et sont fondés sur la raison » (8). Infine anche il riconoscimento del diritto alla fuga dello schiavo e la denuncia dell’assenza di ogni valore morale alla base delle azioni di uomini totalmente dipendenti da altri erano già presenti in Montesquieu. L’idea che lo schiavo non fa parte di alcuna società la ritroviamo anche nel 167 Commerce de l’Amérique par Marseille di Chambon (9), in cui l’autore contesta le tesi di Melon, accusandolo di avere fatto coincidere subordinazione e schiavitù, riducendo così ogni forma di dipendenza all’asservimento totale: « Un peu moins d’esprit et un peu plus de raisonnement, lui auroit fait connoître que la subordination est véritablement la force et le lien de la société, sans lesquels les plus sages loix sont vaines; mais que cette subordination est libre dans l’ordre de tout Gouvernement policé, et que l’esclavage n’est que l’abus d’un pouvoir arbitraire que la subordination ne donnera jamais » (II, pp. 242-43). Del resto, il capitolo dedicato alla schiavitù (10) si apre con un omaggio a Montesquieu: « L’illustre Montesquieu traite de cette matiere dans le second tome de l’Esprit des Loix. Son jugement est d’un grand poids; mais quelque forte que soit l’expression de son pinçeau philosophique, je tiendrai la parole, et je ne ferai que l’Historien » (II, p. 186). E da storico quale egli si vuole, Chambon esamina imparzialmente tesi contro ed a favore della schiavitù, senza rinunciare tuttavia, a conclusione del panorama storico, che si limita per altro agli scrittori del suo tempo, ad esprimere, sia pure in maniera velata, la sua riprovazione di un rapporto basato unicamente sulla violenza. Nell’analizzare i testi contrari alla schiavitù, egli si limita quasi esclusivamente all’Esprit des lois e alla voce Esclavage dell’Encyclopédie, per cui si può dire che, essendo quest’ultimo testo composto in gran parte di passi montesquiviani, è a Montesquieu che egli affida, in ultima analisi, il ruolo di portavoce dell’orientamento antischiavista. Questa disamina quasi asettica di Chambon è per noi molto importante, perché dimostra come nella Francia del 1764 la voce più autorevole nel campo degli antischiavisti sia ancora ed unicamente quella di Montesquieu. Anche da parte di coloro che accettano le sue posizioni, la lettura della sua opera non è sempre esente da errori: Chambon, non sappiamo se a causa di un’errata interpretazione del capitolo 2° (libro XV), o di una lettura filtrata attraverso l’Encyclopédie, fa dire a Montesquieu che nello stato di natura la schiavitù per crimini sembra trovare una sua giustificazione, mentre l’affermazione è di Jaucourt, il quale, a sua volta, può essere stato portato a formularla da una interpretazione inesatta dello stesso capitolo (questo errore di lettura, ricordiamo, era stato commesso 168 anche da Strube). Contrariamente all’Encyclopédie ed al Commerce de l’Amérique par Marseille di Chambon, l’Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes (11) di Raynal, che si occupa inevitabilmente a lungo di schiavitù coloniale, sembra non dare grande peso all’opera di Montesquieu. È certo che il modo in cui questi ha affrontato la schiavitù negra non poteva offrire a Raynal argomentazioni valide, anche se lo approva in maniera esplicita, traendone lo spunto per una delle tesi più ardite che siano contenute nella prima edizione della sua opera: « Montesquieu n’a pu se résoudre à traiter sérieusement la question de l’esclavage. En effet c’est dégrader la raison que de l’employer, on ne dira pas à défendre, mais à combattre même un abus si contraire à la raison. Quiconque justifie un si odieux système mérite du philosophe un silente plein de mépris, et du nègre un coup de poignard » (ed. del 1770, V, pp. 167-68). È l’unico riferimento a Montesquieu di un certo interesse che si trovi nell’Histoire philosophique, riferimento che viene eliminato nell’edizione del 1780. È l’indizio di un progressivo declino di popolarità, a mano a mano che l’interesse degli studiosi si appunta in maniera più specifica sulla schiavitù negra? È possibile, anche se i riferimenti intorno a quella data restano ancora piuttosto numerosi. Si può però rilevare, forse, una differenza di « qualità »: intorno a quegli anni i rinvii a Montesquieu si trovano quasi esclusivamente in testi di carattere strettamente letterario, nei quali l’approccio al problema è quasi sempre più superficiale che in scritti di tipo socio-politico o storico-filosofico. Quali che siano le ragioni che hanno spinto Raynal ad eliminare il passo relativo a Montesquieu, è certo che negli anni ‘70 egli non giudicava negativamente il modo in cui il pensatore della Brède aveva affrontato la questione della schiavitù negra, sembrandogli anzi il solo che si addicesse ad un filosofo. Ben diversamente reagirà alcuni anni più tardi Bernardin de Saint-Pierre, nel suo Voyage à l’Ile-de-France (1773), trovando molto sconveniente l’uso dello scherzo a proposito di una vicenda tanto drammatica: « Je suis fâché que des philosophes qui combattent les abus avec tant de courage, n’aient guère parlé de l’esclavage des noirs que pour en plaisanter » (12). 169 La critica concerne con ogni probabilità sia Montesquieu che Voltaire, le opere dei quali facevano tra l’altro scuola da questo punto di vista. Fra gli scritti che affrontano il problema servendosi dell’arma dell’ironia, ci sembra particolarmente efficace, nel suo tentativo di denunciare la mancanza di logica nelle argomentazioni degli schiavisti, L’Arétin ou la Débauche de l’esprit en fait de bon sens (1763) dell’abbé Dulaurens (13), un capitolo del quale porta il significativo titolo: Les Négres. Nous avons tort, mais il nous faut du sucre, che è già la denuncia di una mostruosa contraddizione. In un dialogo fra un missionario ed un negro, questi, con apparente ingenuità, mette in risalto i sofismi di ogni tipo con cui lo si imbonisce e la loro patente antinomia con la realtà che viene invece costretto a vivere. La denuncia si esprime anche mediante i discorsi fatti pronunciare al missionario, che sono un pastiche di Montesquieu e di Voltaire: « Mais, répond le Pere jacobin, selon nos vieilles Ecritures, vous ne pouvez point sortir d’Adam. Notre premier pere étoit blanc ou étoit noir: vous voyez qu’il faut que la porte soit ouverte ou fermée; Mr. de la Négrerie, vous avez de la laine sur le tête, et moi j’ai du poil (...) vous voyez bien que vous n’appartenez pas de bon droit à l’espece humaine » (14). Il missionario è qui contemporaneamente portavoce degli schiavisti e della religione, che possono ben usare lo stesso linguaggio e lo stesso emissario. Una decina di anni più tardi il poeta Bertin faceva dell’« excellent persiflage » 15 ( ) su argomenti analoghi a quelli trattati da Montesquieu e da Voltaire, ed in particolare sul confronto fra l’Europeo ed il negro: « (...) d’un Dieu bienfaisant et sage Nous seuls annonçons le dessein: L’Européen est son ouvrage; Mais le nez plat d’un Africain Ne saurait être à son image » (16). La battuta è ormai quasi diventata un luogo comune. Troviamo una ripresa dei capitoli terzo e quarto del libro XV, con un’ironia molto smorzata, nell’Esprit des usages et des coutumes des différens peuples di Démeunier (17), che rivela già fin dal titolo la paternità montesquiviana: 170 « ... tout concourt à ôter la liberté aux Américains (...) On trouva près de SainteMarthe, des paniers de cancres, de limaçons, de cigales, de sauterelles; Lopes de Vega avoue qu’on reproche d’ailleurs aux Américains de fumer du tabac, et de ne pas faire leur barbe; et que le droit, qui les rendit esclaves des Espagnols, fut fondé sur ces crimes » (II, pp. 119-120). Montesquieu fa riferimento a due autori spagnoli: Lopez de Gomara e Garcilaso de la Vega, che vengono qui fusi, con un processo di contaminazione dovuto con ogni probabilità al fatto che Démeunier pensava al poeta. Come è possibile vedere dagli esempi citati, anche il filone dell’ironia, se non ha dato frutti di grande livello da nessun punto di vista, ha però contribuito in una certa misura al dibattito sulla schiavitù e le discriminazioni razziali, agganciando in alcuni casi autori che, forse, assai difficilmente si sarebbero accostati a questi problemi. Nello stesso anno 1770 in cui si stampa la prima edizione dell’Histoire des deux Indes di Raynal, l’avvocato Pierre-Paul-Nicolas, barone di Henrion de Pansey, difendeva la causa di un negro nato libero nelle colonie e fatto poi di nuovo schiavo, in seguito ad una serie di soprusi dai quali, in quanto negro, gli era stato impossibile difendersi. Ora, sbarcato con il padrone in Francia, egli chiede il riconoscimento dei suoi diritti. Henrion sostiene che, poiché « nul n’est esclave en France » (18), il negro Roc dovrebbe venire dichiarato libero non appena ha toccato il suolo francese, anche se non fosse già stato libero nelle colonie, a maggior ragione egli ha perciò diritto ad una libertà di cui già godeva prima di venire in Francia (19). A conclusione del suo Mémoire, dopo aver lodato i Quaccheri che hanno reso la libertà ai loro schiavi, egli rivolge un invito al potenti d’Europa, servendosi di un passo tratto dal capitolo 5° del libro XV; il passo pur restando critico, ha perso nel nuovo contesto, tutta la sua causticità, assumendo però quasi il tono di un’imposizione o di un invito pressante: « Les Princes d’Europe, qui font tant de Conventions inutiles, en feront-ils une enfin en faveur de la miséricorde et de la pitié » (p. 28). In nota si dà la referenza precisa del passo citato, ma Montesquieu è presente anche altrove nel testo, senza alcun riferimento esplicito. Ad esempio, a sostegno della sua condanna della schiavitù coloniale, Henrion scrive in una nota: 171 « Tout est funeste dans l’esclavage; il rend le maître cruel, vindicatif, orgueilleux; il rend l’esclave lâche, fourbe, hipocrite (sic)... » (p. 26). Un anno più tardi i Fisiocratici renderanno omaggio all’autore dell’Esprit des lois, dalle pagine delle « Ephémérides », per bocca di Dupont de Némours: « MONTESQUIEU, dont les traits successifs, rapides et brillants semblent des fleches enflammées, a le premier attaqué par le ridicule les prétendus raisonnements, non moins absurdes qu’atroces, que les oppresseurs des négres emploient pour en faire excuser l’esclavage » (20). L’autore attribuisce a Montesquieu il ruolo di iniziatore nella lotta contro la schiavitù negra e, con la bella immagine delle « flèches enflammées », riconosce ai modi in cui egli ha sferrato l’attacco una straordinaria carica distruttiva. Dupont, che scrive nel 1771, cita dopo Montesquieu soltanto altri tre autori che si sono distinti in questa lotta: Jaucourt, l’abbé Baudeau (21) e Saint-Lambert, di cui le « Ephémérides » avevano recensito il racconto Ziméo (22), di impostazione negrofila (23). Se autori come Voltaire, Raynal, Dupont de Némours e persino il caustico abbé Debonnaire hanno apprezzato il modo in cui Montesquieu ha affrontato lo scandaloso problema della schiavitù negra e le insostenibili ragioni su cui questa si regge, Doigny de Ponceau, nella prefazione del suo poema Discours d’un Nègre à un Européen (24), lo critica duramente non tanto, come aveva fatto due anni prima Bernardin de Saint-Pierre, per essersi servito del tono scherzoso, quanto piuttosto per aver trascurato l’aspetto più importante del problema: « Comment l’immortel auteur de l’Esprit des Loix a-t-il pu négliger le plus bel épisode de son Ouvrage? Etoit-ce dans quelques lignes jéttées qu’il pouvoit remonter à la cause de l’avilissement du Nègre, redemander sa liberté à l’oppression, et faire frémir le Sibarite, dont la sensualité meurtrière épuise le luxe d’un autre Monde au prix du sang de tant de malheureux? » (25). Per fortuna, secondo Doigny, in seguito Raynal ha riparato i torti e colmato le lacune di Montesquieu. Per contro, intorno agli anni ‘80, nelle note di Garat che corredano il poema Les 172 Mois di Roucher (26) ed in quelle che Grée aggiunge al suo poema sulla Navigation (27) si fa ancora appello all’autorità di Montesquieu per mettere in luce le scorrettezze degli Europei nei confronti dei negri e degli indigeni americani, e per appoggiare un discorso generale di condanna della schiavitù. Nelle note dei Mois, leggiamo fra l’altro: « Les loix civiles, dit Montesquieu, annullent les ventes pour une lézion d’outre moitié. Or quelle plus énorme lézion que celle d’une vente, où un homme tout entier se donne pour rien? » (28). Anche nel denunciare i limiti della moralità religiosa europea, Garat si limita a parafrasare, sia pure piuttosto confusamente, Montesquieu: « Ainsi vous croyez d’être des chrétiens et vous ne les jugez pas dignes d’être des hommes » (ivi, p. 133). Si arriva così alle soglie della Rivoluzione, epoca in cui il peso dell’opera di Montesquieu è diventato ormai assai labile, anche se nei discorsi sempre più rari di carattere teorico sulla schiavitù in generale, si può forse intuire, a monte, la sua presenza. È però sempre più difficile trovare riferimenti espliciti all’Esprit des lois: si individuano certamente alcune affinità di argomentazione, a partire dalle quali però è assai arduo stabilire un qualsiasi rapporto di dipendenza di un’opera da un’altra. L’ultima argomentazione di tipo indubbiamente montesquiviano che abbiamo incontrata nella lettura di testi antischiavisti dell’ultimo decennio del secolo, è dovuta alla penna dell’abate Sibire nella cui Aristocratie négrière del 1789 (29), leggiamo: « Le droit de tuer n’appartient au vainqueur que dans une seule circonstance, celle où la mort d’autrui est le seul moyen d’éviter la sienne propre. Hors le cas de nécessité indispensable c’est un assassinat... » (p. 45). L’unica differenza di un certo peso, tra il discorso di Montesquieu e quello di Sibire è data dal fatto che, nel linguaggio iperbolico e barocco di quest’ultimo, la necessità è diventata « indispensable ». Anche la sua condanna della schiavitù per debiti resta sostanzialmente quella di Montesquieu (cfr. p. 21). Nello stesso 1789 troviamo anche l’ultimo (o quasi) riferimento esplicito all’Esprit des lois, nel More-Lack di Lecointe-Marcillac (30), che è uno dei più solidi ed appassionati processi alla tratta ed alla schiavitù negra, oltre che una ricchissima 173 miniera di aneddoti, citazioni e referenze bibliografiche. Vi si parla dell’Esprit des lois nel capitolo XV, dedicato agli scrittori celebri che hanno contestato la schiavitù, di cui l’« illustre et vertueux Montesquieu » appunto apre la serie. Lecointe-Marsillac cita un passo del libro XV (capitolo 13°), a proposito dell’abbrutimento degli schiavi costretti a vivere « enchaînés parmi des êtres libres » (31), ed anche un passo del capitolo 5°, lasciando però cadere il tono ironico e dando al suo discorso un carattere di condanna più categorica che nel testo originale: « Il faut, pour agir de la sorte envers eux, supposer nécessairement que les Nègres ne sont pas des hommes, ou faire imaginer que nous ne sommes pas des Chrétiens » (Ib.). In precedenza, Marcillac aveva posto il nome di Montesquieu fra quelli amati dagli schiavi negri, inserendolo in un elenco abbastanza strano: « John Hume, Whitefield, Adamson, William Smith, la Reine Elisabeth, Montesquieu, Louis XIII et l’Impératrice des Russies... » (p 30). Ma a quest’epoca il riconoscimento del ruolo svolto da Montesquieu nella lotta per la causa abolizionista è già abbastanza raro. A partire dal 1788, anno della fondazione della « Société des Amis des Noirs » (di cui ci occuperemo più oltre), che raggruppa buona parte di coloro che hanno a cuore la situazione degli schiavi neri nelle colonie, quasi tutto quello che viene pubblicato in Francia contro la tratta e la schiavitù è patrocinato da questo gruppo, che svolge, nel giro di quattro o cinque anni un lavoro immenso in questo settore. Lavoro non soltanto teorico, ma anche pratico, in quanto difende la causa dei neri ed in particolare dei mulatti in seno alle varie assemblee rivoluzionarie. Una parte, di questo lavoro è stata riunita e ristampata nel 1968 nella raccolta La Révolution française et l’abolition de l’esclavage, di cui occupa ben cinque volumi su dodici (VI-X), a loro volta composti di trentadue testi, arricchiti di numerose « Pièces justificatives ». Si tratta insomma di quanto di più importante è stato scritto a difesa dei negri alla vigilia e nei primi anni della Rivoluzione. Nel corso di uno spoglio attento di tutti questi testi, non solo non abbiamo trovato alcun riferimento esplicito a Montesquieu, ma non siamo neppure stati in grado di trovare alcun indubbio riferimento sottinteso. E del resto, in tutta la raccolta, composta di ben ottantasei testi (32), se si eccettuano quelli già citati dell’abbé Sibire, di Lecointe-Marsillac e dell’avvocato Henrion de Pansey, troviamo soltanto un altro rinvio esplicito a Montesquieu, ma abbastanza confuso e soprattutto fortemente 174 critico. Lo si deve al creolo Milscent autore dell’opera Du régime colonial (33), la cui seconda parte è costituita da un Essai sur l’amélioration du sort des esclaves, nel quale l’autore sostiene che nessuno si è mai occupato convenientemente del problema, neppure Montesquieu e Raynal: « Les moyens que propose l’abbé Raynal sont insuffisans ou impraticables; Montesquieu n’indique que l’abolition de l’esclavage par une réticence absolue; le moyen est non-seulement dangereux à l’ordre et à la prospérité des colonies, mais encore contre toute équité, contre le droit de propriété dont on ne pourroit impunément dépouiller le maître de l’esclave » (EDHIS, XI, 6, p. 25). Milscent è sensibile alla durezza della condizione degli schiavi e favorevole all’abolizione della schiavitù, ma, come tutti coloro che scrivono dopo la rivolta nera di San Domingo (1791), a maggior ragione se vivono nelle colonie, è anche profondamente sensibile alla scabrosità del problema, soprattutto quando si tratta di trovare delle soluzioni pratiche. Dunque, negli anni della Rivoluzione, che hanno portato non soltanto alla proscrizione della tratta, ma anche all’abolizione della schiavitù (1794), Montesquieu sembra non abbia esercitato più alcuna influenza e non compare più nelle liste degli autori che contano e fanno perciò autorità in materia. Ad esempio, a conclusione di una Liste des ouvrages sur la traite et l’esclavage, pubblicata nel 1790 (34) a cura della « Société des Amis des Noirs », in cui vengono successivamente elencate le opere francesi ed inglesi sull’argomento, è aggiunto un N.B. per ricordare opere di un certo interesse scritte in precedenza: « Il est d’ailleurs beaucoup d’auteurs, dans les ouvrages desquels on trouve d’excellens fragmens sur ce sujet, tels MM. l’abbé Raynal, Bernardin de SaintPierre, Dupont, etc. » (EDHIS, VIII, 2, p. 4). Montesquieu, se pure si è pensato a lui, si perde nell’anonimato di un eccetera, come i nomi di secondaria importanza. È il luogo in cui la sua assenza ci sembra più clamorosa. Ve ne sono però altri in cui si fa notare per ragioni analoghe. Ad esempio, in una nota dell’introduzione che Antoine Dyannière premette alla sua traduzione dall’inglese dell’opera Réflexions sur la traite et l’esclavage des nègres dello scrittore nero Ottobah Cugoano (35), vengono 175 citati alcuni scrittori francesi che hanno in precedenza combattuto la schiavitù negra, e fra essi, neppure questa volta, compare Montesquieu: « Les Anglais publient maintenant une foule d’ouvrages en faveur des Nègres; et l’Europe leur applaudi (sic). Mais je dois rappeler que l’auteur des notes sur les pensées de Pascal, M. de Saint-Lambert, dans le conte de Ziméo, M. l’abbé de Raynal, dans son histoire philosophique, etc. M. Garat, dans une note du poëme des Mois, M. le chevalier de saint-Pierre dans son voyage à l’Isle de France, et surtout M. Schwartz ont écrit avec beaucoup de force contre l’esclavage des Nègres » (EDHIS, X, p. VII). Ricordiamo che Schwartz era lo pseudonimo di cui si era servito Condorcet per pubblicare le sue Réflexions sur l’esclavage des nègres (1781 e ristampate nel 1788). Come si può vedere Raynal e Bernardin de Saint-Pierre, menzionati in entrambi i casi, godono ancora di una certa autorità (e i riferimenti a Raynal, soprattutto, sono piuttosto numerosi); da parte di Dyannière poi c’è il richiamo ad autori meno prestigiosi, le cui opere avevano però una certa diffusione in quegli anni (l’opera di Roucher soprattutto era ancora molto recente). Ci sembra inutile continuare la ricerca delle assenze, che doveva però essere fatta per fissare il più esattamente possibile i limiti del rayonnement montesquiviano e, quindi, dell’influenza della sua opera sull’atteggiamento antischiavista nel ‘700. Detto ciò, dobbiamo però precisare che in questi scritti, spesso arroventati nel fuoco degli scontri diretti fra « amici dei neri » e coloni, i riferimenti ad autori del passato sono sempre assai scarsi, anche perché, come già si è rilevato, la dissertazione astratta resta secondaria, e la discussione si accentra su fatti concreti, quali la reale condizione degli schiavi nelle colonie ed i modi per porvi in pratica, ed al più presto, rimedio, per cui il « silenzio » su di un autore è certamente di minor peso che in altri contesti. Un silenzio così totale resta comunque abbastanza impressionante. Anche l’indagine da noi condotta attraverso tutta la letteratura negrofila, nata nell’ultimo decennio del secolo, alla ricerca di Montesquieu, ha dato risultati negativi. Fermo restando il discorso iniziale sul carattere non esaustivo di questa ricerca, possiamo tentare di trarre ugualmente una conclusione, che ci sembra trovi una base abbastanza solida nell’ampiezza della campionatura esaminata. Prendendo come filo conduttore l’opera di Montesquieu si può tracciare una storia dell’antischiavismo settecentesco in Francia fino verso la fine degli anni Settanta, dopodiché la sua influenza sembra farsi sempre più labile fino a divenire nulla negli anni della Rivoluzione. La sua azione resta quindi legata a quella che è certamente la fase preparatoria della vera e propria lotta contro la schiavitù coloniale e si arresta alle 176 soglie di quella battaglia a cui aveva preparato il terreno, quando la decisione nella condanna e la richiesta pressante di interventi, sia pure programmati nel tempo, non trovano più nell’Esprit des lois un punto di riferimento valido. Ci sembra comunque sia emerso dalla nostra indagine, con sufficiente evidenza, che una storia dell’antischiavismo settecentesco non possa prescindere dal riconoscere a Montesquieu una posizione di primissimo piano. Note (1) Abbé L. Debonnaire, op. cit., I, p. 443. (2) A proposito di questa voce rinviamo all’appendice del nostro Mon frère tu es mon esclave! (3) Volume V. Citiamo dall’edizione di Livorno del 1772. Ricordiamo che lo stesso volume si apre con un elogio di Montesquieu, dovuto alla penna di d’Alembert. (4) Ib., p. 877. (5) Ricordiamo che la voce Esclave, che segue Esclavage, è costituita da un testo molto dotto, ed esclusivamente giuridico, in cui è sintetizzata la legislazione romana e sono riportati i più importanti articoli del Code noir, nella maniera più asettica possibile. Non solo non vi si esprime nessuna condanna della schiavitù, ma non vi è neppure la minima inflessione che faccia intuire una latente critica inespressa. (6) Voltaire, Romans et contes, ed. H. Bénac, Parigi, 1958, p. 95. (7) Voltaire, Œuvres complètes, Parigi, 1860, vol. 23°, p. 365. (8) Citiamo dall’edizione curata da H. Guillemin, Parigi, 1963, p. 58. (9) Avignone, 1764, 2 voll. Il titolo completo è il seguente : Le commerce de l’Amérique par Marseille, ou Explication des lettres-patentes du Roi, portant reglement pour le commerce qui se fait de Marseille aux Isles Françoises de l’Amérique, données au mois de février 1719 et des lettres-patentes du Roi, pour la liberté du commerce à la côte de Guinée, données à Paris au mois de janvier 1716, avec les reglemens que ledit commerce a occasionés. Par un citadin (l’opera fu pubblicata anonima). Tutto quanto concerne la tratta e la schiavitù è contenuto nel secondo volume. (10) Vol. II, pp. 186-245. (11) Per tutto quanto concerne le edizioni ed i collaboratori dell’Histoire philosophique cfr. infra il capitolo dedicato a Raynal. (12) Bernardin de Saint-Pierre, Voyage à l’Ile-de-France, in Œuvres complètes a cura di L. Aimé-Martin, Parigi, 1818-26, 16 voll., I, p. 162. (13) Il luogo di edizione scherzosamente indicato è «Rome, aux dépens de la congrégation de l’Index», ma è possibile che l’opera sia stata invece stampata ad Amsterdam. Fu ristampata col titolo di Arétin moderne nel 1776, in 2 voll. (14) La nostra citazione è tratta da Seeber, op. cit., p. 83. (15) Per usare i termini dell’editore dell’« Almanach des Muses » del 1772, sul quale fu 177 per la prima volta pubblicata la poesia Aux sauvages di Bertin. (16) Bertin, Œuvres complètes, Parigi, 1824, p. 282. (17) Londra e Parigi, 1776-1780, 3 voll. (18) Per il problema costituito dalla presenza sul territorio metropolitano di schiavi neri che seguivano il padrone cfr. L. Vignols, Les esclaves coloniaux en France aux XVIIe et XVIIIe siècles et leur retour aux Antilles, Rennes, 1911. (19) Mémoire pour un nègre qui réclame sa liberté, Parigi, 1770, ristampato nella collezione La Révolution française et l’abolition de l’esclavage, cit., I, 1. (20) « Ephémérides du citoyen », 1771, tomo VIII, p. 76. (21) L’abbé Baudeau aveva condannato la schiavitù dalle stesse pagine delle « Ephémérides » (Vedi, come suggerisce del resto lo stesso Dupont, le « feuilles volantes des 3, 6, 10 et 13 Octobre 1766, qui ont précédé les Ephémérides actuelles », ibidem, p. 77). (22) Cfr. Tomo VI, 1771, pp. 178-216. (23) Nello stesso anno 1771 veniva pubblicata l’Analyse raisonnée de l’Esprit des lois di Stefano Bertolini (noi abbiamo consultato il testo nell’edizione pisana del 1784), nella quale si elogia l’umanità con cui l’autore ha trattato del rapporto tra leggi e natura del clima, in particolare a proposito della schiavitù. Bertolini si stupisce perciò che tanti critici si siano scatenati contro Montesquieu « sur ce chapitre ». Il commento di Bertolini, nella prospettiva che ci interessa, è scarsamente degno di nota, limitandosi quasi esclusivamente ad una parafrasi o a citazioni del libro XV; riteniamo però che anche la semplice citazione, in un contesto di globale approvazione di un’opera, sia già di per sé un riconoscimento di cui bisogna tenere conto. Più interessanti sono le «Notes» à l’Esprit des lois, rimaste manoscritte (Archivio di stato di Firenze, Ms. 777-783, il libro XV è annotato nel vol. 780), anch’esse però più ricche dal punto di vista bibliografico ed erudito che da quello degli interventi personali dell’annotatore (ma qui la cosa si spiega trattandosi dei preliminari di una ricerca). (24) Parigi, 1775. Il titolo è seguito dall’indicazione « Pièce qui a concouru pour le prix de l’Académie Françoise, en 1775 » e nell’Avertissement Doigny ci informa che l’Accademia stessa ne ha « fait une mention honorable ». Per questo autore come per quelli che seguono: Garat, Roucher e Grée cfr. infra. (25) Avertissement, pp. IV-V. (26) Parigi, 1779. Le note che ci interessano sono quelle relative al secondo canto. (27) Parigi, 1781, poema in quattro canti. Il nome dell’autore non è indicato, però la dedica agli ufficiali di marina è firmata da Grée. Le note, molto critiche nei confronti della tratta e della schiavitù, occupano le pagine 69-71. (28) Roucher, op. cit., p. 131. (29) Ristampato in EDHIS, II. (30) Ristampato in EDHIS, III. (31) Ibidem, p. 90. L’immagine di Montesquieu è rafforzata in Lecointe-Marcillac dall’aggiunta di « enchaînés », che rende in modo ancor più immediato il senso di avvilimento e di impotenza. (32) Alcuni sono però testi di leggi, decreti o persino canzoni, nei quali un riferimento a Montesquieu o ad altro autore è comunque impensabile. (33) Parigi, 1792. In EDHIS, XI, 6. (34) EDHIS, VIII, 2. (35) Londra e Parigi, 1788, EDHIS, X. 178 LA LOTTA PER L’ABOLIZIONE 179 GLI AUDACI ANNI SESSANTA Tra la fine degli anni ‘50 e gli inizi degli anni ‘70, la critica al sistema schiavista si va facendo più sistematica e comincia ad investire settori che fino a questo momento erano sembrati inattaccabili come, ad esempio, quello economico. Anche nell’ambito degli organismi di governo si cominciano ad inventariare le perdite ed i pericoli legati a questo sistema di sfruttamento coloniale. Verso la fine degli anni Sessanta, il fronte degli oppositori alla schiavitù è già piuttosto consistente e, soprattutto, abbastanza vario da poter coinvolgere, sia pure anche solo sentimentalmente, settori di pubblico normalmente estranei a dibattiti di questo tipo e di questa portata. Non è però ancora un fronte massiccio come sarà, più tardi, quello che troverà il suo centro di coordinamento nella Société des Amis des Noirs (1788). In questo periodo, infatti, ad eccezione dei Fisiocratici che conducono una lotta abbastanza coordinata, anche grazie al fatto che essa fa parte di un loro piano di politica economica generale, molti degli interventi contro la schiavitù coloniale hanno quelle caratteristiche di insicurezza, di ambiguità o di visione settoriale dei problemi che accompagnano le prime battute di una campagna di lotta. Ma hanno, talvolta, anche tutta la veemenza e la forza di convinzione degli scritti di chi si è da poco convertito ad una causa o si è trovato di fronte, nelle sue indagini sull’uomo e sul cammino del progresso, all’altissimo costo in vite umane che quest’ultimo ha comportato, soprattutto per coloro che di quel progresso non hanno mai beneficiato. È un computo che si sente il bisogno di fare sempre più spesso, per evitare il rischio di coprire il risvolto criminale di tante imprese europee nel mondo, di cui si è presentato troppo a lungo soltanto il volto edificante. Nel 1755, il Code de la nature di Morelly, che è un articolato pamphlet contro la tirannide, indica un corretto metodo di « colonizzazione », rispettoso dei valori esistenti presso i popoli primitivi, sui quali si devono semplicemente innestare conquiste e valori della civiltà, nella salvaguardia dei princìpi naturali che sono alla 180 base dei rapporti umani. Da questi princìpi si deve anche partire per interpretare correttamente i concetti di libertà e di dipendenza di cui tanto si parla, fra mille fraintendimenti. È fuor di dubbio che libertà non significa indipendenza assoluta, poiché gli uomini nascono in uno stato di reciproca dipendenza e debbono perciò di volta in volta aiutare ed essere aiutati, soccorrere ed essere soccorsi, a seconda delle loro doti e debolezze, possibilità o miserie. Questo non significa, ovviamente, che esistano e debbano esistere individui destinati a comandare ed altri ad obbedire, in una parola che esistano padroni e schiavi legati da un rapporto irreversibile. Nessun uomo è nato per servirne, senza contropartita, un altro. Questo è però accaduto, in ispregio alle regole del diritto naturale, producendo una serie di anomalie e di « vizi » che si finisce coll’imputare agli uomini e quindi alla natura, mentre sono in realtà delle istituzioni. Ad uno di questi « vizi », la pigrizia, non stupisce che Morelly abbia dedicato un intero capitoletto della seconda parte della sua opera (1), poiché su di essa si è fondato il diritto di spingere coercitivamente gli uomini all’azione. La si è dunque indicata come la causa di leggi tiranniche e della schiavitù, mentre non è che il prodotto di un’ingiusta divisione dei compiti nella vita associata. La pigrizia è dunque, come già aveva intuito Montesquieu, il risultato di leggi sbagliate e non la causa di esse (2). Morelly traccia anche, in maniera più dettagliata di Montesquieu, il processo che porta inevitabilmente alla pigrizia, come risposta obbligata a violazioni imposte alla natura dell’uomo. Per sua natura questi è infatti portato ad alternare armoniosamente azione e riposo, mentre le leggi hanno arbitrariamente scisso i due momenti, votando una parte dell’umanità all’azione continua e l’altra parte, che da quell’azione trae sostentamento, al riposo più completo. Si crea così una situazione di squilibrio che spinge gli uni a fare il meno possibile e gli altri a ricercare un’occupazione alternativa fittizia nel « faticoso tumulto dei piaceri ». Questa chiarificazione del concetto di pigrizia, considerata in termini generali ed in rapporto a tutta l’umanità, senza possibili diversificazioni razziali o climatiche, è una pietra, scagliata indirettamente contro la schiavitù negra e le discriminazioni su cui era cresciuta e si reggeva. Pur senza attaccare direttamente la schiavitù coloniale, Morelly crea, nel Code de la nature, le premesse per un sistema socio-politico alieno da ogni forma di dipendenza che non sia appunto quella del servizio reciproco fra i membri di una società. L’aver fatto del rifiuto della schiavitù parte integrante e portante di un sistema organico, conferisce alla presa di posizione uno spessore ed una capacità d’urto ben 181 maggiori di quelli che potrebbe avere in una trattazione specifica e settoriale. Presuppone inoltre, per essere contestata fruttuosamente, una stroncatura preliminare dell’intero sistema, che non è certo immune da pericolose fragilità, come tutte le utopie, ma che richiede comunque un intervento di demolizione organizzato ed a livelli diversi da quelli su cui si muovono i fautori della schiavitù coloniale. L’apporto del Code de la nature alla causa abolizionista, anche se indiretto, è di notevole peso, tenuto conto soprattutto del fatto che alla stessa epoca altre opere, non esclusa l’Encyclopédie, manifestavano posizioni assai meno nette ed organicamente elaborate attorno al nodo della schiavitù. Pochi anni dopo, nel 1758, Helvétius abbasserà il tiro, attaccando (anche se in maniera sporadica) la schiavitù sia sul piano dei princìpi che su quello specifico della tratta e dello sfruttamento nero nelle colonie americane. In una lunga nota al capitolo terzo del primo Discours di De l’esprit, significativamente dedicato a De l’ignorance, egli pone l’accento sullo scempio di vite umane provocato dal commercio e, più particolarmente, dal commercio con il Nuovo Mondo: « L’humanité qui commande l’amour de tous les hommes, veut que dans la traite des Negres je mette également au rang des malheurs et la mort de mes compatriotes, et celle de tant d’Africains, qu’anime au combat l’espoir de faire des prisonniers et le désir de les échanger contre nos marchandises. Si l’on suppute le nombre d’hommes qui périt, tant par les guerres que dans la traversée d’Afrique en Amérique; qu’on y ajoute celui des Negres qui, arrivés à leur destination, deviennent la victime des caprices, de la cupidité et du pouvoir arbitraire d’un maître; et qu’on joigne à ce nombre celui des citoyens qui périssent par le feu, le naufrage, ou le scorbut (...): on conviendra qu’il n’arrive point de barrique de sucre en Europe qui ne soit teinte de sang humain » (3). Non si può certo parlare, a proposito di Helvétius, di un calcolo delle perdite di natura economica, del tipo che incontreremo nel giro di pochi anni negli scritti dei Fisiocratici, ma ci troviamo pur sempre di fronte ad un bilancio paurosamente negativo degli scambi fra Europa e colonie americane. Un bilancio su cui sono registrate anche numerose perdite dell’Europa, e quindi della civiltà. Altrove Helvétius non lesina critiche alla religione cattolica che adatta con molta disinvoltura le sue massime alla situazione, chiamando zelo cristiano quello stesso comportamento che presso i pagani definisce barbarie e crudeltà. Proprio partendo dal comportamento degli Europei nei confronti dei popoli negri 182 Helvétius arriva a considerazioni assai pessimistiche sulla concezione del diritto presso i sovrani europei e la Chiesa cattolica, ed in ultima analisi sul reale progresso dei rapporti umani: « Si l’Eglise et les Rois permettent la traite des Negres; si le Chrétien (...) bénit le négociant qui court la côte d’Or ou le Sénégal pour échanger contre des Negres les marchandises dont les Africains sont avides (...) c’est que sauf les traités particuliers et des usages généralement reconnus auxquels on donne le nom de droit de gens, l’Église et les Rois pensent que les peuples sont les uns à l’égard des autres précisément dans le cas des premiers hommes avant qu’ils eussent formé des sociétés, qu’ils connussent d’autres droits que la force et l’adresse, qu’il y eût entr’eux aucune convention, aucune loi, aucune propriété, et qu’il pût par conséquent y avoir aucun vol et aucune justice » (Ib., p. 323). È un giudizio molto severo, che non investe più soltanto il commercio europeo, ma chiama in causa tutto un modo di concepire e di gestire il governo temporale e spirituale dei popoli, facendo ancora leva su forze elementari e primitive, che segnano un regresso nell’evoluzione dello spirito umano. È una posizione analoga a quella di Buffon che, nella condanna della schiavitù coloniale, si mostra particolarmente sensibile al processo di degradazione dei popoli europei cui essa ha dato l’avvio, oltre, ovviamente, alla sofferenza di coloro che ne sono le vittime (4). Quanto poi al dibattuto problema dell’influenza climatica sulla formazione dei popoli e sulla loro attitudine al comando o all’obbedienza, quindi ad essere padroni o schiavi, Helvétius prende una posizione personalissima ed anche, sembrerebbe, assai discutibile che ha però il merito di stroncare con decisione quell’interdipendenza tra condizioni climatiche, mollezza di carattere e pigrizia che era servita da ottimo concime alla messe dello sfruttamento coloniale. Tutto viene da lui ricondotto a cause storiche, ed in ciò non vi è nulla di strano o di particolarmente nuovo, eccezion fatta per il modo in cui il processo storico è ricostruito, nel passato, o prospettato nel futuro: « Après avoir inutilement épuisé les causes physiques pour y trouver les fondemens du despotisme oriental, il faut bien avoir recours aux causes morales, et par conséquent à l’histoire. Elle nous apprend qu’en se poliçant les nations perdent insensiblement leur courage, leur vertu, et même leur amour pour la liberté, qu’incontinent après sa formation toute société, selon les différentes circonstances où elle se trouve, marche d’un pas plus ou moins rapide vers 183 l’esclavage. Or les peuples du midi s’étant les premiers rassemblés en société, doivent par conséquent avoir été les premiers soumis au despotisme, parce que c’est à ce terme qu’aboutit toute espece de gouvernement, et la forme que tout Etat conserve jusqu’à son entiere destruction » (Ib., I, pp. 73-74). È un passo che ci è sembrato giusto citare per intero, per non mutilare una visione del processo evolutivo dell’umanità che, nella sua iperbolica sfiducia in una reale crescita politica e sociale, assume toni apocalittici. Il passo va naturalmente ricollocato nel contesto generale dell’opera di Helvétius, che ne mitiga di molto la portata pessimistica. La conclusione stessa ne indica una chiave di lettura meno impegnativa e più strumentale: « Ce n’est donc qu’à la différente constitution des Empires, et par conséquent aux causes morales, qu’on doit attribuer toutes les différences d’esprit et de caractere qu’on découvre entre les nations » (Ib., I, p. 76) (5). È una trasparente volontà di contestare tesi di fondo montesquiviane, per il largo posto che in quelle si è fatto all’influenza di « cause fisiche » nel governo dei popoli, ed ha il merito di cancellare quanto poteva essere rimasto di ambiguo, nell’opera del pensatore della Brède, su possibili rapporti di interdipendenza tra clima e schiavitù. Helvétius rifiuta infatti di stabilire tra i caratteri e le capacità dei popoli differenze sostanziali e durevoli, ponendo invece l’accento su diversità episodiche, dovute a cause che sono identiche per tutti, sia pure in tempi diversi, e prima fra tutte l’assenza di libertà. Come aveva del resto già intuito Montesquieu, l’assioma degli schiavisti secondo cui certi popoli o certi individui sono nati per essere schiavi va rovesciato: è la condizione di schiavitù che trasforma gli uomini per adattarli alle sue esigenze. Se sono mediocri, o sembrano inferiori ai padroni, è soltanto la schiavitù o la tirannia che li ha resi tali. Sembra una posizione ovvia sotto la penna di un filosofo attorno agli anni ‘60 e sarà in effetti destinata a divenire uno dei tanti luoghi comuni negli scritti degli abolizionisti (in Helvétius il problema ha però dimensioni politiche e non solo sociali e antropologiche). In realtà basta pensare a tante posizioni ambigue emerse dall’Encyclopédie e soprattutto a quanto scrive Voltaire nell’Essai sur les mœurs in quegli stessi anni (e non elimina nelle successive elaborazioni dell’opera) per dare il giusto valore alla posizione antidiscriminante di Helvétius. Voltaire, che bolla la schiavitù negra ed apparentemente la discriminazione razziale nel 1759, in Candide, scrive nell’Essai (la cui prima edizione è del 1756), dopo aver sostenuto la diversa origine delle razze: 184 « La nature a subordonné à ce principe ces différents dégrés de génie et ces caractères des nations qu’on voit si rarement changer. C’est par là que les nègres sont les esclaves des autres hommes. On les achète sur les côtes d’Afrique comme des bêtes, et les multitudes de ces noirs, transplantés dans nos colonies d’Amérique, servent un très petit nombre d’Européens » (6). Anch’egli, come Helvétius, si oppone all’idea che le diversità esistenti tra i popoli siano dovute al clima, ma in un’ottica chiaramente discriminatoria ed antistoricizzante, poiché non sembra esistere alternanza possibile fra popoli padroni e popoli schiavi, come aveva sostenuto Helvétius, bensì un rapporto irreversibile di dominio/dipendenza. Del resto, l’idea dell’inferiorità genetica dei popoli africani è ribadita da Voltaire, di lì a pochi anni, nel 1765, nella Philosophie de l’histoire, che costituirà l’introduzione dell’Essai sur les mœurs nelle edizioni successive. Nel paragrafo dedicato alle Différentes races d’hommes, egli scrive, a proposito dei negri, che gli occhi rotondi, il naso schiacciato, le grosse labbra, « la mesure même de leur intelligence, mettent entre eux et les autres espèces d’hommes des différences prodigieuses » (7). Pur avendo in più occasioni condannato la schiavitù, Voltaire si è ancorato a posizioni antropologiche che consolidavano proprio la peggiore schiavitù dell’epoca moderna. Va anche detto che, almeno stando alle nostre attuali conoscenze, Voltaire è il solo dei grandi pensatori del Settecento che nella seconda metà del secolo abbia espresso un giudizio così negativo nei confrontii dei popoli negri, senza valutare fino in fondo, sembrerebbe, le conseguenze che un tale giudizio comportava sul piano della realtà sociale, in un paese che possedeva colonie lavorate da schiavi negri. O valutandole comunque a cuore molto leggero, se ha potuto scrivere, ancora nell’Essai sur les mœurs: « Nous n’achetons des esclaves domestiques que chez les nègres. On nous reproche ce commerce: un peuple qui trafique de ses enfants est encore plus condamnable que l’acheteur; ce négoce démontre notre supériorité; celui qui se donne un maître était né pour en avoir » (8). Il fatto dunque che tra condizione servile e mediocrità degli individui Helvétius abbia stabilito una correlazione molto stretta, ma di segno diametralmente opposto, in un’opera tra l’altro tanto letta e discussa, è di notevole interesse per la crescita di 185 una coscienza abolizionista. Anche il tono degli aneddoti sui negri che egli inserisce nella sua opera non è privo di significato (ricordiamo, tra l’altro, che Voltaire non disdegnava di far riferimento ad aneddoti in cui donne negre si accoppiano con le scimmie). In uno degli aneddoti riportati da Helvétius, un ministro racconta al suo vicino di tavola una storiella africana che giudica molto spiritosa: è il resoconto di una seduta di governo presso una tribù dell’Africa, nel corso della quale i notabili del regno stanno attorno al re seduti dentro degli orci riempiti di acqua: « Mais vous ne riez pas? dit le Ministre au Seigneur le plus près de lui. C’est, répondit-il, que je vois tous les jours quelque chose de plus plaisant encore. Quoi donc? reprit le Ministre. C’est un pays ou les cruches seules tiennent conseil » (Ib., I, p. 48). È un aneddoto simpatico ed ha il pregio di dire in breve e spiritosamente il rifiuto di ogni pregiudizio di superiorità razziale. Nel 1764 viene pubblicata in Francia un’opera importante, già da noi citata, il Commerce de l’Amérique par Marseille di Chambon (9). Importante non tanto in quanto segni una svolta nell’approccio ai problemi coloniali o una nuova tappa della lotta abolizionista, ma soprattutto in quanto fa il punto sulla situazione, riassumendo, con grande senso di obiettività, tutti gli aspetti del problema come si presenta al momento della composizione dell’opera. L’autore sintetizza le posizioni dei sostenitori della schiavitù e dei suoi oppositori e conclude, esprimendo molto discretamente le sue personali simpatie: « ... j’ai rapporté les divers sentimens sur l’esclavage, sans me décider; ce n’est pas que je sois indifférent, sur une question si intéressante pour l’humanité. J’ai cru qu’exposer l’origine de l’esclavage, les maximes qui l’autorisent et les loix dures et humiliantes qui ont accablé la condition des Esclaves, et qui ne semblent avoir été faites que par la tyrannie, c’étoit faire connoître ma pensée et l’éloignement de mon cœur, non-seulement pour l’injustice mais encore pour tout ce qui en porte le caractère » (II, 214). Di seguito pubblica il testo del Code noir e tutte le modificazioni che vi sono state apportate nel corso del primo ‘700, per cui, oltre che attraverso le discussioni 186 teoriche, i suoi lettori possono farsi un’idea precisa della schiavitù negra anche sulla base delle leggi che la regolano. Leggi di cui Chambon ammira, o dichiara di ammirare, la saggezza, pur esternando il suo stupore che, nonostante la protezione di queste leggi, si continui ad importare un numero così elevato di schiavi dall’Africa e non si riesca invece a far riprodurre i negri in America. Ne consegue, inevitabilmente, una critica del trattamento riservato agli schiavi negri nelle colonie, che rende preferibile la morte o la fuga nei boschi, alla vita nelle piantagioni ed una critica dei pregiudizi razziali portati in campo per giustificare simili inumani trattamenti: « Nous devrions faire réflexion que ce sont nos frères (...) Que leurs affreuses misères excitent donc notre compassion. Notre indignation est déplacée; nous avons plus reçu qu’eux. Que notre reconnoissance anime notre humanité (...). Oui: les Nègres sont fourbes, traîtres, séditieux, violens, yvrognes, paresseux, impudiques, magiciens, voleurs, etc. Nos pères n’étoient pas meilleurs, et si nous ne leur ressemblons pas, c’est un effet de la miséricorde de Dieu sur nous, qui peut faire luire sa lumière sur les Nations les plus corrompues et les plus criminelles, quand sa colère sera apaisée » (II, pp. 241-242). Non è quindi la differenza di razza che ne fa degli esseri corrotti (cosa che Chambon sembra accettare senza esitazione), ma il diverso stadio di sviluppo nel quale ancora vivono rispetto ai bianchi, quell’assenza di « lumières » che già aveva ottenebrato la vita degli antenati europei. L’inferiorità dei negri non è dunque di origine genetica, ma storica e la differenza è fondamentale: significa infatti che non sono incapaci di virtù, ma semplicemente che non ne conoscono ancora i princìpi. È un tipo di argomentazione che si incontra spesso sotto la penna degli abolizionisti anche se preferiscono, come più confacente alla causa, far dipendere, come già ha fatto Helvétius, i « vizi » degli schiavi negri dalla loro condizione, a dimostrazione del fatto che in una situazione innaturale non può fiorire che la corruzione a tutti i livelli. Lo stesso Chambon riconosce, del resto, che l’assenza di libertà porta alla disperazione e conseguentemente alla rivolta, per questo critica con una asprezza che non gli è abituale la difesa della schiavitù fatta da Melon nell’Essai politique sur le commerce (1734), rimproverandogli in particolare di avere identificato una subordinazione necessaria all’ordine sociale con la schiavitù, che ne è invece la negazione. Dal passo citato risulta però anche che la posizione di Chambon è sostanzialmente diversa da quella di altri abolizionisti settecenteschi, in quanto fa discendere i lumi destinati a dissipare le tenebre dei popoli direttamente da Dio, per un atto di misericordia che spegne la sua collera di fronte alla corruzione, il che 187 sembrerebbe ripetere, sia pure in un’ottica diversa, la storia della schiavitù come giusta condanna dei negri corrotti. Ma non è così. Se per un verso Chambon è convinto che il diverso grado di sviluppo dei popoli sia dovuto agli ìmprescrutabili disegni divini, per altro verso gli fa orrore l’idea che il popolo privilegiato da Dio si faccia persecutore dei fratelli meno fortunati che « les ténèbres de l’ignorance et la contagion du vice livrent aux passions déréglées » (II, p. 241). Posto che gli uomini sono tutti fratelli, figli di uno stesso Dio, egli si sente egualmente solidale nei confronti dei negri e dei bianchi, come dichiara in una parafrasi dell’homo sum di Terenzio, adattata così alla situazione: « Je suis homme, et je dois prendre la défense de l’homme, qu’il soit noir ou blanc, la couleur n’y fait rien... » (II, p. 244). Ma oltre al merito di aver fatto il punto sulla riflessione settecentesca concernente la schiavitù e di aver affiancato a quella dei philosophes la sua voce di cattolico in difesa dei negri schiavi, a Chambon spetta anche il merito di aver tentato una sintesi del vasto e complesso dibattito attorno all’origine delle razze ed alle cause del colore nero, mostrando così, in un quadro globale, le infinite sfaccettature del problema della schiavitù coloniale, che coinvolge storia, politica, filosofia, morale, religione e scienza, in un intricato rapporto di reciproche interferenze. Come ci si può ben aspettare, Chambon riconduce tutto, in ultima analisi, ai segreti impenetrabili della divinità, ma la cosa che a noi interessa nella prospettiva di questa indagine, è la decisione con cui ha sostenuto l’irrilevanza, all’interno della specie, di poche diversità esteriori ed il lunghissimo, severo, meticoloso attacco alla teoria poligenetica di Voltaire, nella quale vedeva, oltre ad un blasfemo affronto alla religione, anche una pericolosa frattura all’interno del genere umano. Si può veramente concludere che il Commerce de l’Amérique par Marseille rappresenta una summa, piuttosto dettagliata, degli orientamenti francesi fino al 1764 in materia di schiavitù coloniale e di ricerche antropologiche connesse al problema. Una summa su cui si innesta, pur con inevitabili esitazioni, una fraterna, religiosa difesa dell’umanità oppressa. Nello stesso anno 1764 in cui appare il Commerce de l’Amérique, Gabriel Mailhol pubblica, anonimo, una sorta di romanzo filosofico di intonazione ironica sul modello di Candide (a cui si fa riferimento nel testo), Le philosophe nègre et les secrets des Grecs. Ouvrage trop nécessaire, come lo definisce lo stesso autore (10). Protagonisti della vicenda sono un narratore, bianco, ed un negro che accetta di mettersi al suo servizio in qualità di scudiero, dopo aver rifiutato la proposta « indécente » di essere suo servo. L’incontro avviene a Colonia. 188 Il negro Tintillo racconta la sua storia che, almeno nella prima parte è quella ben conosciuta del trasporto nelle colonie americane e della vita che egli vi conduce come schiavo. Il tono dell’opera e anche i mezzi di cui si serve l’autore per attaccare, attraverso il racconto del suo negro filosofo, una serie di aberrazioni del comportamento europeo e, più generalmente, dell’uomo, è ben evidenziato nei passi che seguono. La precisione infinitesimale dei dati o la loro esagerazione ed il processo dell’accumulo con l’introduzione, talvolta, di oggetti anomali sono i procedimenti satirici che predilige, un po’ alla maniera di Candide: « Des ruisseaux de sang coulèrent: ils entraînerent dans leurs flots, pêle-mêle, jambes, bras, cuisses, oreilles, nés, et tout ce qu’on avoit la bonté de se couper, pour complaire à des Marchands d’Europe » (11). « Ils vinrent donc se rendre maîtres de tant d’infortunés. Nous en reçumes en échange de bonnes barres de fer, de petits couteaux, quinze tonneaux d’eau-devie, quarante chauderons, une infinité de grains de verre infilés, dix barils de poudre, cinq fusils, deux volumes de Musique, vingt-deux sonnettes, et trentecinq grélots » (Ib., p. 38). Ma sotto il discorso ironico, o parallelo ad esso, si porta avanti un dibattito dei più seri, almeno nella prima parte dell’opera, perché nella seconda ci si muove invece nell’ambito di una scadente imitazione di Candide e la critica ai costumi europei risulta molto meno convincente di quella alla tratta ed alla schiavitù. Come si conviene ad un philosophe del Settecento che ama servirsi dell’ironia, la condanna, da parte di Tintillo, dei pregiudizi e dei falsi valori della civiltà europea assume spesso toni montesquiviani: « Voilà comme les hommes qui ont le bel avantage de posséder la raison, traitent en ces pays-là les hommes, parce que ces derniers préferent le fer à l’or, parce qu’ils sont d’une autre couleur, et qu’ils n’ont pas le nez aquilin » (Ib., pp. 66-67). Seguendo una trama destinata a divenire luogo comune letterario, Tintillo è figlio di un re africano ed educato da un europeo. In colonia viene perciò impiegato non nel lavoro dei campi, ma come bibliotecario del padrone, un « buon francese » che lo tratta quasi come un amico e più tardi lo porterà con sé in Europa. Qui vivrà molte avventure, in attesa di ritornare alla terra d’origine. 189 È un viaggio di formazione, alla maniera di Candide, ma in ordine inverso, poiché si procede dal Nuovo al Vecchio mondo. Le esperienze più formative, e purtroppo anche le più crudeli, egli le vive comunque in colonia. Un giorno in cui il padrone lo aveva condotto a caccia con sé, Tintillo scopre con orrore che la selvaggina a cui si deve dare la caccia è rappresentata dai suoi fratelli marrons, e si ribella con veemenza: « Eh quoi! Monsieur, lui repliquai-je avec courroux il se pourroit que dans ce pays on iroit ainsi gayement à la chasse aux hommes? Vous êtes plus féroces que nos lions et nos tigres: s’ils dévorent quelquefois vos semblables, ce n’est ordinairement que losqu’ils en sont attaqués... » (Ib., pp. 71-72). E tuttavia, pur conoscendo bene la validità delle ragioni che hanno spinto i suoi compagni schiavi alla fuga dalle piantagioni, e prima fra tutte l’ansia di libertà che è in ogni uomo, Tintillo non ne approva il comportamento, facendo leva su motivazioni che lasciano perplessi, soprattutto in bocca ad un negro schiavo. Tanto perplessi da sentire la necessità di aggiungere che il tono ci sembra perfettamente serio: è il solito discorso indirizzato ai negri rivoltosi, ma questa volta di segno contrario. Tintillo vuole infatti convincerli a ritornare alle piantagioni. Fra le ragioni che porta sul tappeto c’è la più vieta delle giustificazioni schiaviste: i padroni bianchi hanno pagato dei vinti nelle lotte tribali (destinati ad essere sgozzati) per farne dei lavoratori nelle loro colonie, per cui « Ceux de nous qui ont refusé de remplir en partie cette charge, se sont rendus, je crois, coupables de vol » (Ib., p. 81). È tanto incredibile sulle labbra di uno schiavo, da far nascere in noi il sospetto di non aver saputo cogliere il guizzo ironico che rovescia il senso letterale del discorso e di essere stati convolti in una beffa ai danni degli schiavisti, così sottile da lasciarci nel dubbio. L’altra motivazione di cui si serve Tintillo per convincere i marrons a far ritorno alle piantagioni, può essere discutibile, ma è certamente meno ambigua e problematica della precedente, perché si basa su di un calcolo delle convenienze. Egli è infatti convinto che nel marronnage non vi sia via di salvezza per i negri schiavi: « Quelquefois, dépourvus d’alimens nécessaires ils sont obligés de devenir brigans et souvent meurtriers. Ils terminent ainsi leurs tristes jours, tirés comme sangliers, ou pris, et roués comme des assassins. O mes amis, quel train de vie! et l’agréable dénouement! » (Ib., p. 81). 190 Abbiamo l’impressione che, servendosi del suo philosophe nègre, Mailhol voglia agire su due fronti, attaccando per un verso, con decisione, la tratta e la schiavitù, ma demandando ogni intervento destinato a mutare la situazione al padrone bianco. Quando i marrons accettano di ritornare alle piantagioni Tintillo prospetta loro una sorta di miraggio: « Oui mes amis, vous en serez enchantés; et vous mériterez avec le tems qu’un bon Maître, satisfait de vos services vous rende la liberté, vous aide, vous marie, et peut-être vous enrichisse » (Ib., p. 83). Resta pur sempre il sospetto che Tintillo non parli sul serio, come spingerebbe, per certi versi, a credere la risposta data al padrone che elogia le sue qualità diplomatiche: « Aussi m’attends-je, quelque jour (...) à devenir le plénipotentiaire du genre humain. Je veux alors pacifier pour jamais tous les frères de la grande famille, l’Afrique, l’Asie, l’Europe, l’Amérique, les Blancs, les Noirs, les Bruns, les fourrés, les habillés, les nuds, les batisés, les circoncis, les poilras et les barbes » (Ib., p. 86). È davvero quasi impossibile tracciare una linea di demarcazione netta tra il tono serio e lo scherzo, tanto più che a volte, come in questo caso, lo scherzo ci sembra ben più serio del più serio dei discorsi. Sotto il cumulo delle diversità reali ed assurde, messe sullo stesso piano, si coglie infatti l’aspirazione profonda ad un incontro di pace fra gli uomini. Risulta perciò abbastanza difficile dare, in definitiva, una collocazione precisa all’opera di Mailhol nell’ambito della lotta abolizionista, ma non v’è dubbio che, anche mettendo in conto le incertezze, le contraddizioni e certe ambiguità nate da giochi dell’ironia insufficientemente chiari, l’opera nel suo complesso ha un mordente che le conferisce una notevole forza critica. Tanto più che non vi si colpiscono soltanto falsi valori o istituzioni mistificate dell’uomo bianco, ma anche una serie di miti che egli si è creato ed ai quali si richiama e si ispira nell’atto di accostarsi ai popoli di razza e civiltà diversa. Il primo di questi miti che viene intaccato è quello della superiorità del bianco; l’operazione è condotta non ricorrendo a disquisizioni teoriche, destinate quasi sempre ad agire con troppa lentezza, ma a fatti di un’evidenza immediata. Ad esempio, al momento di un naufragio durante il viaggio tra le Antille e la Francia, nel 191 quale il padrone di Tintillo trova la morte, il negro è il solo di un gruppo di superstiti, che hanno trovato scampo su di una scialuppa, ad essere in grado di reperire i punti cardinali, e quindi di orientare il cammino: « Trois de mes compagnons crurent que je me mocquois d’eux, et dirent qu’ils n’avoient jamais vu d’ourse que dans les bois. Les autres branlans la tête commencerent à imaginer qu’un homme noir pouvoit, une fois dans sa vie, en sçavoir plus qu’un homme blanc; et ils résolurent tous entre eux de me laisser doresnavant la direction de la route » (Ib., p. 93). Dove le convenzioni sociali non hanno più alcun valore e le scelte sono imposte dalla necessità, Tintillo si rivela immediatamente un capo in grado di prendere in mano e portare a buon fine un’impresa quanto mai difficile. Anche il mito che fa dell’uomo bianco (almeno nei confronti dei popoli primitivi) il solo essere capace di concepire una religione di tipo superiore viene qui messo in discussione. Tintillo porta dentro di sé, nelle sue peregrinazioni, il sogno di un culto elevatissimo da far adottare al suo popolo, semmai tornerà in patria: grazie ad esso l’uomo comunica direttamente con l’Essere Supremo sotto le volte di un tempio fatto ad immagine dell’universo e dotato di congegni complicatissimi che dell’universo ripetono il moto, suscitando nei fedeli ammirazione ed amore per il Creatore. Il negro Tintillo, figlio di re, schiavo, scudiero e filosofo, si mostra dunque in svariate occasioni all’altezza del bianco o ad esso superiore, grazie anche alle sue capacità di giudicare con ironico distacco uomini ed eventi, che lo mette in una posizione di vantaggio nei loro confronti. Naturalmente, ai fini della nostra indagine non ha alcuna importanza sapere se il personaggio è reale o assurdo, mentre è importante vedere in che modo e con quali mezzi è stato usato come strumento di lotta. L’ironia fa anche del Philosophe nègre un’opera unica nel suo genere, perché la narrazione di una storia di tratta e schiavitù predilige generalmente i toni patetici e melodrammatici, eccezion fatta per alcuni casi, come, ad esempio, il Candide di Voltaire, in cui però la storia in questione è soltanto episodica e deve, del resto, seguire un’intonazione prefissata. La predilezione per i toni melodrammatici e strappalacrime è ben evidenziata in altri due romanzi con protagonisti africani, scritti negli anni immediatamente successivi: Ziméo di Saint-Lambert (1769) e le Lettres africaines di Butini (1771). Il fine resta in ogni caso lo stesso: attaccare la tratta e la schiavitù, servendosi di un intreccio romanzesco. Le due storie sono strutturate attorno ad uno dei motivi che sarà fra i più sfruttati della letteratura negli anni seguenti: una vicenda d’amore nata 192 in Africa, contrastata dalla tratta e dalla schiavitù e destinata a concludersi felicemente nelle colonie americane. Ricordiamo che la strada era stata brillantemente aperta fin dal lontano 1688 dall’Oroonoko di Aphra Behn. Siccome per ragioni di economia distributiva di una materia che diventa sempre più ricca, complessa e refrattaria ai frazionamenti, abbiamo rinviato ad un capitolo successivo l’analisi del pensiero fisiocratico nei confronti della schiavitù, dobbiamo premettere che le posizioni emergenti dalle due opere sono assai vicine a quelle dei Fisiocratici, come testimoniano anche le calorose recensioni apparse sulle « Ephémérides du citoyen ». La tesi di fondo, secondo cui la schiavitù è negativa innanzitutto sul piano economico, è di chiara matrice fisiocratica, anche se troverà in breve posto in tutti gli scritti abolizionisti e persino nelle riflessioni di certi funzionari coloniali. È quindi necessario ricollocare le due opere nel contesto in cui sono nate, per valutarne appieno agganci e rifrazioni su settori diversi della cultura del momento, e quindi, in ultima analisi, per valutarne la portata reale. Le « Ephémérides » avevano dedicato un ampio resoconto, nel 1769, alle Saisons di Saint-Lambert, impegnandosi a parlare, in altra occasione, dei racconti che le seguivano, ed in particolare del terzo di essi, Ziméo. L’occasione si presenta appunto nel 1771, al momento della ristampa del poema e dei racconti. Oltre a riassumere la commovente storia, le « Ephémérides » ne pubblicano anche ampi stralci, ed in particolare, le riflessioni sulla schiavitù dei negri con cui Saint-Lambert ha concluso il suo racconto. Scegliendo una conclusione di questo tipo, l’autore denuncia in maniera esplicita il vero senso dell’operazione che egli ha voluto compiere servendosi di un intreccio romanzesco. Il breve racconto, a parte le riflessioni finali che anche tipograficamente sono staccate dal contesto, è un piccolo gioiello di abilità creativa, che riesce ad assorbire nel giro di un minimo di pagine, salvaguardando la credibilità ed una certa godibilità della vicenda narrata, tutto quanto ha attinenza alla tratta ed alla schiavitù, e non soltanto in termini patetici e sentimentali, come vuole il genere, ma anche in termini problematici. Il modello narrativo è sicuramente Oroonoko di Aphra Bhen, anche se qui i pannelli del dittico sono invertiti, poiché l’azione inizia subito in Giamaica ed è soltanto in un secondo tempo che il protagonista ci racconta il suo passato africano. La Giamaica viene dipinta come la terra di elezione del marronnage e della rivolta e non c’è da stupirsi, perché, come nota il narratore (George Filmer), il trattamento degli schiavi, salvo rare eccezioni, è crudele e disumano: « ... je remarquois je ne sais quoi de dur et de féroce dans leur physionomie et 193 dans leurs discours (dei coloni); leur politesse n’avoit rien de la bonté; je les voyois entourés d’esclaves qu’ils traitoient avec barbarie. Je m’informois de la manière dont ces esclaves étoient nourris, du travail qui leur étoit imposé, et je frémissois des excès de cruauté que l’avarice peut inspirer aux hommes » (12). La rivolta scoppia in alcune piantagioni dell’interno guidata da quel capo che i negri chiamano con il nome africano di Ziméo ed i coloni con il nome di John che essi stessi, secondo la prassi, gli hanno imposto al suo arrivo nella colonia, e che egli ha subito rifiutato non appena ha spezzato le sue catene, come primo passo verso la riappropriazione di sé e verso la libertà (13). Mentre tutti i coloni tremano all’avvicinarsi dei rivoltosi guidati da John-Ziméo e fanno incatenare i loro schiavi per paura di essere attaccati su due fronti, il buon Wilmouth coglie ancora una volta i frutti del trattamento « paterno » che ha sempre riservato ai suoi schiavi, i quali giurano appunto di perire al suo fianco per difenderlo e salvare la piantagione. Ma non ce ne sarà bisogno: la fama della bontà di Wilmouth è giunta anche ai rivoltosi e Ziméo sa rispettare gli amici dei suoi fratelli che soffrono. In breve scoprirà ben altri motivi per essere riconoscente a Wilmouth e al suo ospite George Filmer. Questi aveva incontrato su un’isola spagnola dei Caraibi una giovane negra con un bambino ed un vecchio a cui era stata tagliata una gamba per aver osato difendere, contro il padrone, l’onore della giovane. Li aveva comperati per sottrarli ad un trattamento tanto crudele e condotti nella piantagione dell’amico. La casa di Wilmouth diventerà così il luogo privilegiato di una patetica e gioiosa agnizione: Marien la giovane liberata da Filmer, è Ellaroé, sposa di Ziméo, il bambino è suo figlio ed il vecchio il padre di Ellaroé. La scena a lieto fine preparata dal doloroso racconto che Ziméo ha fatto a Wilmouth delle sue sventure, scioglie efficacemente la vicenda; la famiglia riunita si ritira nelle montagne dell’interno, sede dei negri marrons. I protagonisti sono presentati in maniera lusinghiera, sia sotto il profilo fisico che sotto quello morale, siano essi schiavi come Ellaroé ed il padre o divenuti liberi per un atto di ribellione come Ziméo, il quale, nel momento stesso in cui distrugge le piantagioni e massacra i coloni bianchi, chiede la comprensione e la pietà dei buoni, per un gesto così crudele al quale è stato costretto dalla situazione disumana della vita coloniale. Il racconto delle sue vicende è perciò punteggiato, come un leitmotiv, dall’invocazione: « hommes de paix, n’éloignez pas vos cœurs du malheureux Ziméo ». Saint-Lambert non risparmia nulla per rendere il suo personaggio, nonostante la durezza con cui ha punito i coloni bianchi, degno di interesse e di 194 simpatia per il lettore europeo. Ce lo descrive bello, nobile, infelice: « Ziméo étoit un jeune homme de vingt-deux ans: les statues de l’Apollon et de l’Antinoüs n’ont pas des traits plus réguliers et de plus belles proportions. Je fus frappé sur-tout de son air de grandeur. Je n’ai jamais vu d’homme qui ne parût, comme lui, né pour commander aux autres (...) ses yeux exprimoient la bienveillance et la bonté (...) » (Ib., p. 235). La storia della sua vita è tragica: è la tipica tragedia degli uomini d’Africa da quando gli Europei ne hanno fatto una merce di scambio, ed è un atto d’accusa nei confronti dei bianchi, paragonati a più riprese, nel corso del racconto, alle tigri feroci ed ai leopardi. Ricordiamo che anche Tintillo, il nègre philosophe, li aveva dipinti negli stessi termini. Figlio di un principe africano, Ziméo è strappato, assieme ad altri giovani, alla sua terra con l’inganno da mercanti spagnoli che li avevano irretiti con musiche e doni, proprio mentre era sul punto di portare a termine la sua formazione e di unirsi all’amata Ellaroé. Pur sconvolto dall’inganno e da una traversata drammatica in cui assiste a scene di antropofagia da parte dei suoi infelici compagni, resi disperati dalla fame, egli è tuttavia disposto a perdonare, perché la sua sventura gli ha permesso di unirsi alla donna amata e di averla sempre vicina. Sono giovani e la gioia di amarsi ha in certi momenti il sopravvento sull’orrore della situazione che stanno vivendo. Giunti nelle Antille ritrovano il padre di Ellaroé trasportato su un’altra nave, ma la gioia di ritrovarsi sarà di breve durata: Ziméo verrà definitivamente separato da loro e da questo momento nascerà il ribelle. Le scene d’orrore, quelle patetiche e quelle tenere sono ben dosate ed alternate per tener desta l’attenzione del lettore intorno ad una vicenda che è, in realtà, una trasposizione appena romanzata della triste odissea di qualsiasi schiavo negro catturato o comprato sulle terre africane. Indipendentemente dalle conclusioni che vengono aggiunte al racconto e che ne indicano, se ce ne fosse bisogno, la chiave di lettura, questo è già di per sé un atto d’accusa ed un’analisi in negativo della schiavitù e si capisce perché le « Ephémerides » ne abbiano fatto gli elogi e ne abbiano pubblicato ampi stralci: Ziméo che risparmia il buon colono Wilmouth, per il quale del resto tutti i suoi schiavi sono disposti a morire, mentre trucida i coloni « cattivi » è una dimostrazione ad effetto del principio enunciato dai Fisiocratici secondo cui interesse (il vero interesse) ed umanità coincidono nei rapporti sociali. Le lacrime, gli 195 amori, le pennellate esotiche sono soltanto l’imbellettatura di un discorso che si vuole molto serio in difesa dei negri schiavi. Nelle riflessioni che seguono, fedele alla linea adottata nel racconto che ci presenta eroi di notevole prestigio, Saint-Lambert deplora l’ingiusta massificazione denigratoria che gli Europei hanno imposto ai popoli africani, calunniando le loro vittime dopo essere stati crudeli nei loro confronti. Contro la generalizzazione delle caratteristiche fisiche e morali, egli sostiene la necessità di distinzioni, in particolare fra le qualità che sono dovute alla natura e quelle che sono il risultato della schiavitù. Quanto poi alla tanto decantata superiorità dei bianchi, essa è dovuta alle « circostances et non pas (à) la nature de l’espèce », per cui non è una superiorità d’« esprit », ma di conoscenze, che si sono accresciute rapidamente grazie a scoperte casuali come quella della bussola e della stampa. Inoltre, il continente africano sembra essere più giovane degli altri e la natura vi è così prodiga dei suoi doni che la ragione, come avviene presso i popoli « du midi », fa progressi meno rapidi. Del resto i popoli africani non sono più arretrati di quanto lo fossero, alla fine del Medioevo, gli Europei che non devono perciò andare verso di loro per sfruttarli e calpestarli, ma per guidarli sulla via della crescita: « Portons-leur nos découvertes et nos lumières: dans quelques siècles ils y ajouteront peut-être, et le genre humain y aura gagné. N’y aura-t-il jamais de prince qui fonde des colonies avec des vues aussi grandes? N’enverrons-nous jamais des apôtres de la raison et des arts? Serons-nous toujours conduits par un esprit mercantile et barbare, par une avarice insensée qui désole les deux tiers du globe, pour donner au reste quelques superfluités » (Ib., p. 258). Si va elaborando a poco a poco un programma coloniale alternativo, di stampo illuminista, per dare all’incontro con i popoli un carattere veramente positivo, in cui si scambiano le « cose » che contano, per contribuire insieme al progresso dell’umanità. Noi oggi sappiamo purtroppo che, dietro la maschera del popolo-guida, l’Europeo ha portato avanti aggressioni altrettanto feroci. Le riflessioni di Saint-Lambert si concludono con una calorosa difesa del diritto naturale, il solo che permetta ai popoli di avere « une morale, de bons gouvernements et des mœurs » e di essere perciò « meilleurs, plus puissants, plus tranquilles ». Un diritto che non permette a nessuno di « tenir un seul homme dans l’esclavage » (Ib., p. 259). Ricordiamo che anche Morelly si era espresso in termini analoghi. Insomma, Saint-Lambert, nel giro di una trentina di pagine, ha imbastito contro 196 la schiavitù un discorso capace di far presa a tutti i livelli e sui lettori più svariati, dando nel contempo un quadro attendibile ed efficace della situazione reale dei fatti e dei problemi concernenti le colonie europee lavorate da schiavi. Di fronte a questa argomentazione così ben strutturata, sembrano avere scarsa importanza i pochi versi dedicati al problema nelle Saisons (14), anche se essi daranno luogo ad una vera e propria moda poetica, la cui povertà ideologica sarà ampiamente compensata dalla diffusione e dalla capacità di toccare le corde del sentimento (15). Oggi, grazie alle ricerche di Michèle Duchet, sappiamo che SaintLambert è stato legato, non si sa esattamente a partire da quale data, al Bureau des Colonies ed ha scritto, tra l’altro, nelle vesti di consulente governativo, delle Réflexions sur les moyens de rendre meilleur l’état des nègres ou des affranchis de nos colonies, per le quali la Duchet propone la data del marzo-aprile 1787 (16). Trattandosi di elaborare un piano di risanamento coloniale che possa essere tradotto in pratica, Saint-Lambert si mostra un po’ più cauto di quanto non avesse fatto nelle pur controllatissime riflessioni che seguivano Ziméo. Vi sostiene tuttavia, con decisione, alcuni princìpi fondamentali dei rapporti sociali che non differiscono in nulla da quelli già enunciati nelle riflessioni precedenti. Ed il fatto importante, che indica bene il percorso compiuto dal pensiero abolizionista in un ventennio, sta proprio in questo trasferimento di posizioni da un’opera letteraria, in cui tutti gli ardimenti sono possibili, ad un documento elaborato su richiesta e per conto del Governo. Tra l’altro, esso ci rivela come, alla vigilia della Rivoluzione, le vecchie posizioni coloniali siano ormai in netto declino e quale peso abbiano avuto le argomentazioni economiche dei Fisiocratici (che trovano in funzionari ed amministratori un terreno pronto ad accoglierle), nel trasformare l’ottica coloniale degli anni Settanta/Ottanta: « Je commencerai par faire quelques observations sur la despeche, et d’abord pour admirer cette belle maxime, la politique bien entendue se rapproche plus communément qu’on ne le croit de l’humanité qui réfléchit. J’irais peut-être plus loin et je dirais que toute politique qui blesse l’humanité est une politique détestable et qui est punie tôt ou tard » (17). La dépêche è certamente una delle relazioni provenienti dalle colonie, punto di riferimento obbligato di Saint-Lambert nell’elaborazione delle sue Réflexions. Ci troviamo di fronte ad un linguaggio incredibile in un testo ufficiale, un linguaggio di cui i Fisocratici non rinnegherebbero la paternità, ma che non sarebbe stonato neppure in un saggio di filosofia morale- o sulle labbra di un sacerdote nella predica domenicale. Inoltre, quel che più conta, non si tratta di un linguaggio vuoto, usato per 197 seguire una moda o per coprire la politica di sempre, bensì del riflesso tangibile di un reale mutamento negli orientamenti coloniali. Mutamento che non è ovviamente il risultato di spinte umanitarie, bensì dettato da ragioni di sicurezza e dalla necessità di ricercare utili reali per lo Stato, oltre quello di pochi privati: l’« umanità » costituisce un ottimo supporto in vista di queste mete. Il concetto di umanità assume dunque presso amministratori e funzionari un carattere quasi prevalentemente strumentale, che non ha negli scritti di altri abolizionisti, ma il risultato è in molti casi lo stesso. Si assiste così nel ventennio che precede la Rivoluzione al ripercuotersi quasi immutato, attraverso opere più o meno impegnate, di una serie di luoghi comuni, sia detto senza alcuna sfumatura negativa, di un discorso abolizionista che si vuole convincente sul piano dei princìpi e su quello operativo. Di questo discorso fanno, a poco a poco, parte integrante lo spauracchio della rivolta ed il calcolo dell’alto costo e della scarsa produttività della manodopera negra, per giungere alla conclusione che l’abolizione della schiavitù, naturalmente ben programmata e fatta nei modi e nei tempi opportuni, è un’operazione redditizia da tutti i punti di vista. È anche la posizione che emerge dall’altra opera elogiativamente recensita, sia pure con qualche riserva, sulle « Ephémérides » nel 1771, alludiamo alle Lettres africaines di Butini, un romanzo epistolare di argomento analogo, se non proprio identico, a quello di Ziméo. La tesi di fondo è sintetizzata in apertura della lettera XXV che costituisce, assieme alla seguente, un vero e proprio trattato antischiavista, interpolato, in maniera piuttosto arbitraria, proprio al centro della vicenda, e non alla fine, come aveva fatto Saint-Lambert, probabilmente per evitare che il lettore chiuda il libro quando l’argomento cessa di essere avvincente. È ben vero che Butini vuol essere onesto con il suo lettore e lo avverte, in una nota, che se cerca soltanto di divertirsi può saltare due lettere, ma è anche vero che in questo modo lo costringe ad un gesto comunque più difficile da compiere della semplice chiusura di libro alla fine della storia. Anche il personaggio che scrive queste lettere, il vecchio amico del « buon colono », coprotagonista, assieme agli eroi negri, della vicenda, è del tutto episodico e può scomparire senza scompaginare le fila del racconto, dopo aver fatto il suo bel discorso. La tesi, ormai nota, è quella fisiocratica: umanità ed interesse procedono parallelamente in perfetta sintonia, ma viene qui espressa in una formula che ne mette in luce il carattere di maggiore efficacia persuasiva a paragone di una condanna della schiavitù di tipo filosofico-moralistico: « Un homme instruit par son cœur et étranger à la politique, pourroit vous dire: brisez, ô vous qui aspirez au titre d’homme juste, brisez les fers de vos Nègres, 198 détruisez l’effet d’une violence dont vous êtes au moins le complice, et rendezles à leur patrie et à leurs plaisirs. Il ne vous serait pas facile de répondre à son langage, et pourtant je ne l’emploirai pas: voici le mien. Qu’on accorde une liberté absolue aux Nègres, qu’on métamorphose les esclaves en artistes, on procurera le profit des maîtres, de l’état considéré sous le double rapport de métropole et de colonie, enfin celui des esclaves » (18). L’azione, come quella di Ziméo, si svolge parte in Africa e parte in Giamaica. Fra le ragioni portate in campo a difesa della coltivazione con uomini liberi, c’è anche la possibilità di coltivare le terre dell’interno, rimaste incolte a causa del pericolo di diserzione degli schiavi, rappresentato dalla lontananza tra quelle terre e la piantagione. Non stiamo ad elencare gli altri motivi di interesse derivanti dalla coltivazione con uomini liberi, perché sono quelli già noti. Anche per Butini, dunque, « L’intérêt est le nœud dont s’est servie la nature, afin de lier les humains » (Ib., pp. 167-68). In effetti, poiché esiste una sorta di catena che lega i vari esseri, per cui gli uni finiscono coll’influire sugli altri, la negatività a cui sono ridotti gli schiavi negri ricade inevitabilmente anche sui bianchi. Come aveva del resto già rilevato Montesquieu, la schiavitù agisce negativamente sullo schiavo e sul padrone. Il discorso di Butini ha però una sfumatura diversa, in quanto parla soprattutto di negatività dal punto di vista utilitaristico, piuttosto che da quello morale. La storia che incastona le due lettere-saggio è la commovente odissea di Phédima e Abensar che, dopo infinite peripezie e tanti tragici eventi, riescono finalmente a realizzare il loro amore. Anche qui però, indipendentemente dalle due lettere dedicate specificamente al problema della schiavitù, risulta subito chiaro che la storia serve soltanto a trasmettere un’appassionata condanna dello sfruttamento europeo. L’impasto è dosato in maniera assai meno abile di quanto non lo fosse in Ziméo, ed ogni occasione è buona per perorare la causa: Quando Abensar ritrova Phédima schiava in Giamaica e vuole egli stesso farsi schiavo per essere al suo fianco, questa lo richiama ad una visione realistica della condizione che si dice disposto ad abbracciare senza esservi costretto: « ... et savez-vous quel est le sort d’un esclave? Fût-il tombé dans les mains du meilleur des maîtres? Il n’est plus qu’un automate, qu’une machine, qu’un homme dégénéré, dont tous les mouvemens sont subordonnés à des volontés étrangères (...) Il porte partout les marques de sa bassesse, et il est en bute à 199 toutes les railleries, quelquefois aux insultes des hommes libres, dont le dernier le foule aux pieds. Mais que sera-ce, s’il tombe entre les mains d’un tyran? Alors malheur à l’esclave qui oppose une résistance légère à ses désirs (...) » (Ib., pp. 138-39). Abensar allora, secondo un copione scontato, va in cerca della morte o della libertà unendosi ai negri marrons e divenendo il loro capo. C’è un aspetto delle proposte di emancipazione avanzate da Butini, nella lettera XXVI, che è poco comune ed ha suscitato le riserve di Dupont de Nemours nella lunghissima recensione-sintesi che ne ha presentato sulle « Ephémérides ». Contrariamente alle tappe di soluzione del problema che gli abolizionisti propongono di solito, Butini suggerisce infatti di abolire la schiavitù, ma di far continuare la tratta per importare dall’Africa manodopera pagata, fino ad esaurimento dei bisogni coloniali. Dupont sottolinea l’ingiustizia ed i pericoli di una soluzione di questo tipo pur ribadendo, nella conclusione della sua analisi, gli elogi al giovane scrittore per il contributo portato alla causa abolizionista. Come era avvenuto per Ziméo, le « Ephémérides » riproducono i passi salienti, sotto il profilo ideologico, delle Lettres africaines che beneficiano così di una duplice via di diffusione ed entrano a far parte dell’organizzazione di lotta dei Fisiocratici. Note (1) Morelly, Code de la nature, ou le véritable esprit des lois. Abbiamo consultato il testo nella traduzione italiana a cura di Enzo Piscitelli, Torino, 1952, ed in un’edizione francese anonima del 1760, s.1., ma con l’indicazione: « Partout chez le vrai sage». Il capitolo si intitola Véritable cause de la paresse (IIe partie, pp. 60-62). (2) « ... en un mot, le vice qu’on nomme paresse, ainsi que nos passions fougueuses, tire son origine d’une infinité de préjugés, enfans très légitimes de la mauvaise constitution de la plupart de nos sociétés que la Nature répudie (...). L’homme n’est donc naturellement paresseux, mais l’est devenu, ou ce qui est la même chose, il a contracté de l’aversion pour toute occupation vraiment utile » (Ib., p. 61). (3) Citiamo dall’edizione di Amsterdam del 1761, 2 voll., I, p. 31. (4) Cfr. Buffon, De l’homme, ed. cit.: « Comment des hommes à qui il reste quelque sentiment d’humanité peuvent-ils adopter ces maximes, en faire un préjugé, et chercher à légitimer par ces raisons les excès que la soif de l’or leur fait commettre? » (p. 284). Cfr. su questo aspetto dell’opera di Buffon il nostro Mon frère..., cit., pp. 41-46. 200 (5) In De l’homme (postumo) 1772 (ed. cit., II, p. 271) leggiamo tuttavia: « Une des principales causes de l’ignorance et de l’inertie des Africains est la fertilité de cette partie du monde: elle fournit presque sans culture à tous les besoins ». Helvétius ricondurrebbe dunque a cause climatiche, o comunque naturali, ciò che nell’Esprit aveva attribuito soltanto a cause storiche. Nel capitolo seguente, che si intitola De la puissance de la paresse, egli sostiene ancora che « les hommes en général sont paresseux... » (p. 272) e che « L’oisiveté est dans les hommes la cause sourde des plus grands effets » (p. 273). (6) Ed. cit., II, p. 335. (7) Ibidem, I, p. 6. Il concetto viene ripreso, con maggiore crudezza, nel cap. CXLI, in cui tratta Des découvertes des Portugais: «La forme de leurs yeux n’est point la nôtre. Leur laine noire ne ressemble point à nos cheveux, et on peut dire que si leur intelligence n’est pas d’une autre espèce que notre entendement, elle est fort inférieure. Ils combinent peu, et ne paraissent faits ni pour les avantages ni pour les abus de notre philosophie» (II, p. 306). (8) Essai sur les mœurs, cit., II, p. 805. I commentatori dell’edizione di Kehl (« en général Condorcet et Decroix », come ricorda Pomeau) rovesciano il discorso, mostrando l’altra faccia della medaglia, quella che Voltaire non ha saputo, o non ha voluto, vedere: « Certainement le roitelet nègre qui vend ses sujets, celui qui fait la guerre pour avoir des prisonniers à vendre, le père qui vend ses enfants, commettent un crime excécrable; mais ces crimes sont l’ouvrage des Européens, qui ont inspiré aux noirs le désir de les commettre, et qui les paient pour les avoir commis. Les Nègres ne sont que les complices et les instruments des Européens; ceux-ci sont les vrais coupables » (Ib., nota 2). (9) Avignone, 1764, 2 voll. (10) L’opera fu pubblicata anonima. Londra, 1764. I « Greci » sono coloro che imbrogliano al gioco, perché sembra che l’arte d’imbrogliare sia nata dinnanzi all’assedio di Troia, dove i Greci non sapevano come passare il tempo (cfr. parte IIa, cap. VI). (11) Ibidem, I, p. 35. (12) Citiamo dall’edizione di Amsterdam, 1769, p. 227. In quegli stessi anni, lo svizzero Jacques-Vincent Delacroix riportava da San Domingo l’immagine di un’eguale crudeltà nei confronti degli schiavi: « Personne n’ignore avec quelle férocité leurs tyrans les font punir pour la moindre faute. Ce traitement affreux qu’ils subissent dans la situation la plus humiliante, les livre à une douleur si cruelle, qu’il n’y a pas un blanc qui pût la supporter sans mourir sous les coups, s’ils étoient ainsi multipliés. Depuis long-temps on craint que le nombre des Nègres augmentant tous les jours, ils ne se rendent maîtres de l’Isle, et n’exterminent les blancs ». Se non si sono ancora rivoltati è perché hanno un’âme basse e perché la lunga schiavitù li ha abituati a chinare il capo ed a prediligere vendette da tramarsi nell’ombra. (Mémoires d’un américain, avec une description de la Prusse et de l’Isle de Saint-Domingue. Par l’auteur des Lettres d’Assi à Zurac et de celles d’un Philosophe sensible, Losanna, 1771, 2 voll. Il passo citato è tratto dalle pagine 8182 del 2° volume). (13) Sulla spersonalizzazione che viene imposta agli schiavi (o ai servi) attraverso il mutamento del nome o l’impiego di appellattivi irrispettosi cfr. C. Biondi, « L’île des esclaves » di Marivaux come psicodramma sociale, in Studi sull’uguaglianza. Contributi alla storia e alla tipologia critica di un’idea nell’area francese, a cura di Corrado Rosso, Pisa, 1975, II, pp. 85-106. A questo proposito, la Duchet fa giustamente rilevare che «le nègre n’existe littérairement qu’ avec un nom africain, c’est à dire comme nègre marron (ou comme Oroonoko échappant aux rites de l’étampage et de la dépersonnalisation). Le nègre n’est une 201 personne, et donc un personnage, que dans et par la révolte. Celui qui n’est que victime reste anonyme, tel le nègre de Surinam » (Anthropologie et histoire..., cit, p. 168). (14) Del resto, nell’Essai sur le luxe (1764), che doveva costituire l’anno dopo l’articolo sul lusso dell’Enciclopedia, e la cui attribuzione a Saint-Lambert è oggi ormai certa (cfr. La polemica sul lusso nel Settecento francese, a cura di C. Borghero, Torino, 1974, p. 173), le posizioni nei confronti della schiavitù sembrano di totale indifferenza. Vi leggiamo: « La France en laissant tomber son Agriculture et ses Manufactures de premiere et seconde nécessité, auroit encore des branches de commerce abondantes en richesses : le commerce de l’Inde, le sucre et le caffé (sic) des Colonies... » (pp. 22-23). A quest’epoca, come si può vedere, Saint-Lambert non mette neppure minimamente in discussione non solo la schiavitù, ma neppure il rendimento delle colonie lavorate da schiavi. (15) I versi delle Saisons sono davvero scarsamente rilevanti, rispetto al testo di Ziméo (ovviamente dal punto di vista della lotta abolizionista). Nel primo canto, dedicato al Printemps, troviamo una condanna assai blanda della schiavitù, espressa in versi abbastanza banali e per giunta leggermente denigratori: « Chez le Nègre indolent, au farouche Iroquois Allez porter nos arts, nos plaisirs et nos loix. Policez le barbare, éclairez le sauvage; Ah ne leur portez plus la mort et l’esclavage ». (Citiamo dall’edizione di Amsterdam del 1773, i versi sono a p. 7). La denigrazione nei confronti dei popoli non Europei, e nel caso specifico dell’indigeno americano, la ritroviamo anche nel quarto canto, l’Hiver, dove si può leggere: «Il est triste, indolent, sans mœurs et sans bonté. Son ame s’endurcit dans sa stupidité. Nul besoin n’éveillant sa sombre léthargie Ainsi que sans lumières, elle est sans énergie» (p. 180). I versi offrono, per fortuna, lo spunto a note più solide, in cui si pone in maniera più severa il problema se debbano considerarsi eventi favorevoli o funesti per l’umanità, la scoperta dell’America e quella del passaggio del Capo di Buona Speranza. L’autore afferma subito che la domanda deve essere rivolta agli indigeni americani e alle popolazioni africane. Dei primi non esiste quasi più traccia: « les restes de cette race ont été mis en pièces sur les étaux des Bouchers, pour servir de nourriture aux chiens des Conquérants » (p. 210). Quanto agli altri, « les plus doux des hommes », che vivevano un tempo in pace fra loro, sono ora costantemente in lotta, per avere schiavi da scambiare con le merci europee: « Or je sais comment ces prisonniers sont traités dans nos isles à sucre, et dans les colonies des Portugais et des Espagnols » (p. 210). Saint-Lambert auspica che, col passare degli anni, queste scoperte diventino un bene per tutta l’umanità. Su Saint-Lambert cfr. L. de Nardis, SaintLambert. Scienza e paesaggio nella poesia del Settecento, Roma, 1961. Parlare di Saisons significa immediatamente pensare a Thomson. Per l’influenza che egli ha esercitato sulla poesia francese del Settecento rinviamo ai lavori di Margaret Cameron, L’influence des «Saisons» de Thomson sur la poésie descriptive en France (1759-1810), Parigi, 1927; e di E. D. Seeber, Antislavery opinion in the poems of some early French followers of James Thomson, in « Modern Language Notes », L, 1935, pp. 427-434. Per l’influenza esercitata dall’autore inglese su settori che non hanno nulla a che vedere con la poesia, cfr. A. Freer, Ricerche sull’« Encyclopédie ». Jaucourt e Thomson, Pisa, 1972. (16) Pubblicate dalla Duchet, a seguito di un saggio dal titolo Esclavage et humanisme en 202 1787: un mémoire inédit de Saint-Lambert sur les gens de couleur, in « Annales historiques de la Révolution française », 1965, n. 3, pp. 344-360 e riprese in Anthropologie et histoire..., cit., pp. 177-193. (17) Ibidem, p. 181. (18) Butini, Lettres africaines, ou histoire de Phédima et d’Abensar, Londra (et se trouve à Paris), 1771, p. 151. 203 FISIOCRATICI, AMMINISTRATORI, FUNZIONARI-FILOSOFI Gli attacchi più massicci alla schiavitù da parte dei Fisiocratici vengono lanciati dalle pagine delle « Ephémérides », soprattutto dopo il 1768, quando la direzione del periodico passa dalle mani dell’abate Baudeau, convertito nel frattempo alla dottrina fisiocratica, a quelle di Dupont de Nemours. Ma fin dal 1756, prima ancora della formazione del gruppo fisiocratico, il marchese di Mirabeau, che ne avrebbe fatto parte, dimostrava nell’Ami des hommes i pericoli e gli svantaggi che derivavano alle colonie dal fatto di essere coltivate da schiavi. Partendo dall’idea base che lo Stato sia come un albero di cui l’agricoltura costituisce le radici, la popolazione il tronco, l’industria i rami ed il commercio le foglie, egli sostiene che se le radici ed il tronco non sono floridi, tutto l’albero sarà misero, se le radici ed il tronco sono malati, anche il resto dell’albero sarà malato. In questa schematizzazione delle funzioni rispettive delle varie componenti in seno alla struttura dello Stato è iscritta la condanna dell’organizzazione coloniale, che affida la coltivazione della terra a mani servili: « On a imaginé de faire transporter des esclaves dans nos colonies Méridionales, pour les assujettir à la culture de la terre, c’est-à-dire, de mettre au dernier rang l’art et le travail qui doivent être au premier dans l’estime des hommes » (1). Risulta chiaro che, indipendentemente dalla forza o dall’abilità con cui l’attacco alla schiavitù viene portato avanti, ci troviamo di fronte ad una situazione del tutto nuova. Non si tratta più, infatti, di un attacco isolato, ma strettamente coordinato ad un piano generale di politica economica. Non sono ragioni morali, religiose, sociali od umanitarie quelle invocate da Mirabeau per combattere la schiavitù, ma ragioni di sana amministrazione delle colonie, destinate a languire su radici putrescenti se non si provvederà in fretta ad approntare la cura. E la sola cura esistente per questo tipo di malattia è la creazione di condizioni che rendano inutile e persino nocivo l’impiego di schiavi. 204 Ogni forma di schiavitù è negativa, secondo Mirabeau, ma quella che l’Europa ha creato ed incrementato nelle sue colonie americane è del tipo peggiore, perché fa coincidere la condizione servile con diversità fisiche che ne possono divenire la giustificazione o sono state, in ogni caso, usate a tal fine. Gli schiavi negri sono stati portati in America da un luogo « selvaggio », dove vivono ancora allo « stato bruto », o comunque mossi da un instinct che è estraneo all’Europeo, per cui quest’ultimo li considera inferiori e si sente autorizzato a gettarli in stalle, alla stregua di animali, ed a sfiancarli di lavoro: « ... et de cet ordre d’habitudes et d’usages naît, au sein de la loi de fraternité, et dans un siècle qui s’estime éclairé par excellence, la plus dure, et, j’ose dire, la plus impie des servitudes » (Ib., III, p. 285). Il peggio, poi, sta nel fatto che ci si trova di fronte ad una condizione che non permette alcun intervento, se non indiretto, perché in qualsiasi modo si tenti di migliorarla, non si farà che provocare inconvenienti ancora più rovinosi. Se si appesantisce il giogo degli schiavi si impedisce loro di moltiplicarsi, con la conseguenza che si dovrà continuare a spendere un patrimonio per importarli dall’Africa. Se saranno trattati con maggiore dolcezza, aumenterà il numero dei meticci ed i negri si faranno artigiani, con il rischio che la colonia passi a poco a poco nelle loro mani: « Il y a même un préjugé établi parmi plusieurs d’entre ceux-ci; que Dieu a livré d’abord cette terre à la race rouge, ensuite aux blancs, et enfin aux noirs, et l’on voit des cantons dans les Isles où ils se sont déjà soustraits à l’obéissance. Loin de sentir le péril de ce genre de révolution, qui frape néanmoins tout le monde, il semble qu l’on court au-devant, et l’on pousse le délire à cet égard, jusqu’à introduire avec soin les nègres dans les colonies de terre ferme, qui n’en connoissent pas l’usage » (Ib., III, pp. 286-287). Va aggiunto che Mirabeau non faceva discendere questa analisi della situazione coloniale, e le critiche conseguenti, unicamente da una concezione astratta di corretta politica economica, o da informazioni di seconda mano più o meno attendibili: egli conosceva bene la questione coloniale in genere e quella degli schiavi in particolare, grazie alle lettere del fratello nominato governatore della Guadalupa nel 1753, e quindi in posizione qualificata per avere un quadro globale della situazione. Su questa corrispondenza si è già soffermata Michèle Duchet e rinviamo al suo lavoro per un’analisi più dettagliata (2). Ci limitiamo a citarne qualche passo, utile, ci 205 sembra, non soltanto per aiutarci a capire le posizioni prese dal marchese nell’Ami des hommes, ma anche per darci una prima indicazione degli orientamenti che andavano emergendo, fin da quegli anni, presso i funzionari coloniali, o almeno presso i più illuminati di essi, capaci di superare una visione settoriale ed angusta dei problemi che incontravano nello svolgimento delle loro funzioni: « Je suis à portée de bien connaître l’esclavage et toute son étendue, car celui de ce pays-ci est le plus fort qu’il y ait jamais eu, non dans le droit, mais bien dans le fait; l’on a assez suivi les lois romaines sur l’esclavage; mais la couleur y ajoute une indélébilité physique... » (3). Contrariamente a quanto avviene a coloro che vivono nelle colonie, il chevalier di Mirabeau è convinto che lo schiavo debba essere considerato e trattato non alla stregua di un animale, ma come un uomo. Per quanto poi lo concerne personalmente, egli crede anzi di doverlo « considérer comme un frère » (4). È un’opinione di gran peso, espressa da un governatore delle colonie, ed uno dei sintomi più netti che la macchina coloniale è in revisione. Quanto poi alla « razza schiava » di cui ha un’esperienza diretta come governatore e come uomo, poiché i servizi della sua casa sono sbrigati da schiavi negri, egli è convinto che ogni pregiudizio nei suoi confronti sia ingiusto: « L’on a dans ce pays-ci et l’on emporte assez communément une prévention contre les nègres qui est injuste. Je regarde ce peuple-là comme tout à fait le même que nous, à la couleur près. Je doute même que l’esclavage ne nous rendît pas pire que lui » (5). Dunque, quando il marchese di Mirabeau afferma che facendo coltivare la terra delle colonie da schiavi negri si è messa all’ultimo rango la prima delle « arti », l’agricoltura, non esprime, come si potrebbe pensare, un giudizio razzistico, ma piuttosto, sulla scia del fratello, un giudizio negativo su una condizione che pone gli uomini a livelli inferiori alle mansioni che vengono loro affidate. Non solo è convinto, e lo abbiamo già rilevato, che la negatività della schiavitù sia irrimediabile, comunque si gestisca il lavoro servile, cioè con dolcezza o con durezza, ma anche che sia impossibile porre rimedio alla situazione con una legge di abolizione della schiavitù che provocherebbe il caos nelle colonie. La schiavitù si può abolire soltanto rendendola inutile: « ... je n’entreprendrai pas de bannir l’usage des nègres; mais voulez-vous le 206 borner, et bien-tôt le rendre inutile? Encouragez la culture des terres dans les colonies. Vous ne le pouvez qu’en rendant les colonies florissantes, et j’ai démontré que vous ne pouviez les rendre telles, que par une liberté entière d’importation et d’exportation » (Ib., III, p. 287). L’abolizione dell’exclusif, cioè dell’obbligo per le colonie di avere rapporti di scambio soltanto con la madrepatria, contro cui lotteranno a più riprese (ed a fini diversi) anche i coloni, sarebbe dunque per Mirabeau la prima tappa del cammino che porta all’abolizione della schiavitù negra. Gli specialisti di politica economica potranno forse discutere sull’attendibilità delle teorie del marchese e sull’efficacia delle soluzioni proposte, ma è fuor di dubbio che la sua idea di una abolizione della schiavitù, derivante da un processo di nullificazione della presunta necessità della medesima, ci sembra una delle proposte più sagge e delle più realistiche che siano state formulate per trasformare veramente il volto delle colonie, senza interventi coercitivi più o meno efficaci. Ammiratore, talvolta anche critico, di Montesquieu che aveva conosciuto a Bordeaux, egli ne adotta una delle massime, che sarà cara anche ai Fisiocratici: « Les pays ne sont pas cultivés en raison de leur fertilité, mais en raison de leur liberté » (6), ed è proprio sulla base di questa massima che si oppone alla schiavitù in maniera molto più decisa di quanto non avesse fatto lo stesso Montesquieu. L’idea che la giustizia e l’umanità sono gli strumenti della più redditizia politica economica è già presente nella sua opera, prima di diventare il filo conduttore della politica antischiavista dei Fisiocratici (7). Nel 1760 l’Ami des hommes aveva già raggiunto la quinta edizione ed aveva valso a Mirabeau l’amicizia di Quesnay e quindi l’ingresso nel gruppo fisiocratico che si andava riunendo attorno a quest’ultimo proprio in quegli anni, in seguito alla pubblicazione del Tableau économique (1758). Questo ingresso costa a Mirabeau la ritrattazione di alcune idee espresse nell’Ami des hommes, concernenti i ruoli rispettivi della popolazione e dell’agricoltura nella produzione della ricchezza degli Stati. Più tardi Dupont de Nemours elogerà il gesto di Mirabeau come un atto generoso, dettato da onestà di cuore e nobiltà d’animo (8). Nelle Réflexions sur la formation et la distribution des richesses (1766), anche Turgot, dopo aver definito la schiavitù un sistema che viola tutti i diritti dell’umanità e tutte le leggi dell’ordine e della morale, ne dimostra la scarsa utilità sotto il profilo economico per un’infinità di ragioni che vanno dall’assenza di interesse e quindi di applicazione al lavoro degli schiavi, alle spese continue occasionate dai nuovi acquisti per mantenere a livello il personale delle piantagioni, continuamente eroso 207 dall’alta mortalità degli schiavi stessi. A conti fatti, secondo Turgot, si spende un capitale considerevole per una manodopera scadente, senza calcolare l’enorme distruzione di uomini che il commercio negriero comporta (9). Dato il significato che hanno nella concezione economica dei Fisiocratici l’agricoltura ed i prodotti della terra, la condanna dell’impiego di manodopera servile acquista all’interno del loro sistema il peso della denuncia di un errore di fondo nell’organizzazione sociale, con perdite a tutti i livelli. È un fatto capitale, perché si sposta il dibattito da un terreno teorico, sia pure arricchito dai più diversi tipi di argomentazione, ad un terreno concreto sul quale si possono, tra l’altro, usare le stesse armi degli schiavisti con sorprendenti effetti di neutralizzazione dei colpi. I Fisiocratici si servono infatti di tabelle di calcoli minuziosi, ma di segno contrario rispetto a quelle degli schiavisti, poiché non registrano gli utili, bensì le perdite occasionate dall’impiego di schiavi negri nelle colonie. Anche supposto che si possa mettere in dubbio l’attendibilità dei loro calcoli, essi dimostrano, se non altro, che le cifre non sono meno soggette di altri elementi ad interpretazioni divergenti e quindi anche ad essere usate nei modi più diversi. Ma a parte questa funzione critica esercitata all’interno di un settore come quello dei calcoli che sembrava davvero la roccaforte degli schiavisti, bisogna dire che l’elenco delle perdite occasionate dalla schiavitù ha delle basi concrete (anche se le cifre possono essere discutibili) e poggiate su conoscenze serie della realtà coloniale, grazie anche ad esperienze personali dirette, come quelle di Mercier de la Rivière, intendente alla Martinica, o all’amicizia di funzionari coloniali, che già cominciavano ad alludere a queste perdite nelle loro relazioni ufficiali (10). Le « Ephémérides du citoyen », soprattutto dopo il 1768 quando sotto la direzione di Dupont de Nemours diventano il portavoce ufficiale della dottrina fisiocratica, sono la sede privilegiata della campagna antischiavista. Campagna che si tiene però sempre strettamente ancorata ad una visione generale dei problemi economici, socio-politici e morali che sono alla base dei rapporti fra gli uomini e che costituiscono agli occhi dei Fisiocratici un tutto inscindibile: « L’injustice est une mauvaise ménagère; elle achète tout trop cher. C’est la justice qui ne paie rien (...) qu’à son prix. C’est la bienfaisance qui a tout à bon marché. La Science de l’Economie politique démontre chaque jour ces principes à ceux qui la cultivent; c’est parce qu’elle les démontre rigoureusement qu’elle est une Science; et c’est parce que ces principes mènent directement au bonheur de tous les hommes, et sont conformes à la dignité de nostre espece, qu’elle est une 208 Science respectable » (11). I minuziosi calcoli che seguono, per individuare il costo della cosidetta « manodopera gratuita », non fanno che confermare la validità di questo principio. Sono pagine zeppe di numeri che, per la prima volta, attaccano la fortezza schiavista dal lato apparentemente imprendibile e vi fanno squarci ben difficilmente rimarginabili, aprendo così la breccia alla marea di critiche destinate, in sinergia con le numerose rivolte di schiavi, a smantellarla nel giro di poco più di un ventennio. Dai calcoli fatti da Dupont de Nemours, che tengono conto del prezzo d’acquisto degli schiavi, della loro alta mortalità, del nutrimento, abbigliamento, spese di difesa contro il marronnage, del costo degli strumenti da lavoro distrutti dall’incuria, dall’incapacità o dalla volontà di vendetta degli schiavi, delle spese per il rigido controllo che si deve costantemente esercitare su di loro ecc., risulta che il lavoro di uno schiavo negro viene a costare più di quello di qualsiasi operaio europeo: « Nous demandons à présent si, existant comme il existe en Europe, vingt à vingt-cinq millions d’ames qui ont à peine dix écus ou trente livres par an pour subsister, il manqueroit jamais d’hommes libres qui fussent disposés à aller gagner quarante deux sols par jour, valant vingt-huit sols de France dans les Isles? nous demandons s’il est besoin pour avoir des ouvriers à ce prix, de faire violence à personne » (Ib., VI, pp. 236-237). Del resto, si potrebbero avere gli stessi prodotti, a molto minor costo e senza far violenza a nessuno, facendoli coltivare direttamente in Africa e stabilendo così con i popoli africani un commercio meno vergognoso e più redditizio (12). L’ingiustizia, la violenza, la crudeltà non solo non rendono nulla sul piano economico, ma risultano anzi un lusso quanto mai costoso, per cui tutta l’operazione della schiavitù coloniale, oltre ad essere odiosa, è anche idiota. Certo, a questi calcoli se ne potranno opporre altri di segno contrario, si potranno portare in campo ragioni di opportunità o di sicurezza, legate alla storia maledetta delle colonie americane (13), che consigliano il mantenimento della schiavitù, ma la battaglia si sta ormai combattendo ad armi pari e non sarà più tanto facile per i coloni accusare gli abolizionisti di essere dei sognatori, assolutamente incapaci di comprendere la realtà. Le « Ephémérides » non si sono limitate ad attaccare soltanto sul terreno economico, anche se questo è il settore su cui hanno concentrato la loro lotta, ma, con una tattica avvolgente, hanno svaligiato un intero arsenale ed impiegato le armi più svariate, dalla politica alla morale, alla religione, chiedendo persino a prestito alla letteratura le sue storie più commoventi, per conquistare alla causa coloro che non si 209 intendono di economia o rimangono insensibili di fronte alle cifre. Lo spunto per gli interventi più massicci contro la schiavitù, quelli del 1771, dovuti alla penna di Dupont de Nemours, è proprio offerto dalla recensione delle opere sopra citate di Saint-Lambert e di Butini. Legato ai Fisiocratici, e portatore dell’ormai noto messaggio di politica coloniale umanitaria, è anche Pierre Poivre, inviato in qualità di intendente all’Ile-de-France nel 1767 ed autore di Voyages d’un philosophe, pubblicati per la prima volta nel 1768, ed anch’essi recensiti in maniera lusinghiera sulle « Ephémérides » di quell’anno. Il titolo dell’opera è degno di attenzione, perché indica già l’ottica con cui Poivre si è accostato (o si è sforzato di accostarsi) a quei popoli che era stato incaricato di amministrare. Il principio, di inconfondibile stampo fisiocratico, su cui si basa per giudicare i popoli e gli Stati ed al quale conforma le sue azioni, è semplice e chiaro: « L’état de l’agriculture a toujours été le premier objet de mes recherches chez les différens peuples que j’ai vus au cours de mes voyages (...) si les terres sont bien cultivées et couvertes de riches moissons, alors on peut en général être assuré que le pays où l’on se trouve est bien peuplé, que les habitans sont policés et heureux; que leurs mœurs sont douces, que leur gouvernement est conforme aux principes de la raison (...). Lorsqu’au contraire j’ai abordé chez une nation qu’il falloit chercher au milieu des forêts, et au travers des ronces qui couvroient ses terres (...) alors je ne doutois plus d’être chez un peuple malheureux, féroce ou esclave » (14). Come Poivre dice esplicitamente, la terra è avara soltanto per i tiranni e per gli schiavi, mentre prodiga tesori « dès qu’elle est libre, remuée par des mains libres, cultivée par des hommes intelligens » (p. 8). L’avversione di Poivre per la schiavitù, anche in quanto operazione economica sbagliata, non potrebbe essere espressa in maniera più chiara. Ma la parte più straordinaria di questi Voyages d’un philosophe, inserita nell’opera a partire dall’edizione del 1769, sono i Discours che egli ha pronunciato, ufficialmente, di fronte ai suoi amministrati riuniti nella sede del governatorato, al momento di iniziare lo svolgimento delle sue funzioni. Poivre, che si qualifica subito, ad apertura di discorso, come « commissaire de sa majesté », inviato per contribuire al « bonheur » della colonia, non lascia alcun dubbio sul carattere ufficiale di quanto si appresta a dire. E siccome quanto si appresta a dire è, senza eufemismi, una condanna della schiavitù, il fatto non può non porre una serie di interrogativi. E primo 210 fra tutti quello concernente l’autonomia del funzionario inviato in colonia nei confronti degli organi centrali. È naturale che i funzionari, pur ricevendo istruzioni al momento della partenza e nel corso della loro permanenza nelle colonie, avessero una certa autonomia che permetteva loro non soltanto di prendere decisioni gravi in caso di necessità, ma anche di dare una loro impronta alla conduzione della colonia sotto la loro guida. Sembrerebbe però improbabile che fosse lasciata loro facoltà di muoversi liberamente di fronte ad un problema di fondo, quale è appunto, anche sotto il profilo amministrativo, quello della schiavitù in colonie che su di essa sono cresciute e si reggono. Le ipotesi possibili sono perciò soltanto due: o Poivre ha pronunciato quei discorsi esprimendo soltanto suoi orientamenti personali, senza tenere alcun conto delle istruzioni o, quanto meno, dei consigli del Bureau des Colonies, oppure negli ambienti dell’ammistrazione centrale non doveva essere vista con antipatia una terapia d’urto che portasse i coloni su posizioni meno retrive, meno arroganti e meno individualistiche di quelle su cui si arroccavano da decenni. La seconda ipotesi sembrerebbe la più probabile, sia sulla base di quanto hanno messo in luce le ricerche della Duchet, sia per il fatto che i Discours vengono pubblicati senza subire censure o condanne. Ricerche d’archivio più approfondite sulle posizioni assunte dai funzionari coloniali in quegli anni e sulle direttive che ricevevano al momento di partire per le colonie, potranno certamente chiarire meglio la posizione di Poivre nei confronti dell’amministrazione centrale e, quindi, il suo grado di indipendenza. Quello che si può dire fin d’ora è che, a nostra conoscenza, quella di Poivre è una delle prese di posizione più ardite che sia stata pronunciata da un funzionario contro la schiavitù, davanti ad una riunione di coloni, e resa di pubblico dominio attraverso la stampa. Il significato di questo intervento va perciò ben oltre quello di un qualsiasi altro abolizionista, che fabbrica i suoi testi a tavolino ed al quale è facile rimproverare le astrazioni, derivanti da ignoranza della realtà coloniale e dei relativi problemi. La presa di posizione di Poivre impone invece al lettore l’obbligo di una riflessione più attenta ed all’avversario uno sforzo di confutazione che lo costringe ad accettare di battersi su di un terreno che può diventare scivolosissimo. Questo non significa che il discorso di Poivre si tenga sempre strettamente ancorato alla realtà, anzi a volte sconfina persino nell’utopia, ed il philosophe ha spesso il sopravvento sul funzionario, il quale ha però a sua volta il merito di frenare con dati concreti i voli del philosophe e di mettere il dito sui vizi reali dell’organizzazione coloniale e, nel caso specifico, su quelli dell’Ile-de-France. 211 Naturalmente Poivre non può abolire la schiavitù e deve perciò limitarsi ad una condanna di carattere platonico, con la quale mette però a nudo, prima di iniziare qualsiasi cura delle disfunzioni dell’isola, l’assurdo morale, politico ed economico (contre la nature des choses) rappresentato da una colonia nata sulla sfruttamento di una parte degli uomini che la popolano. L’impostazione del discorso teorico, oltre a rivelare in molte sue parti l’influenza della scuola fisiocratica, denuncia una netta discendenza da Montesquieu. Parlando di Stati moralmente sani egli sostiene infatti che: « De telles mœurs ne se trouvent jamais que là ou sont la liberté et le travail. Rien ne leur est si opposé que la servitude; elle dégrade l’homme, et après avoir avili l’esclave, elle tend à énerver le maître, à le corrompre, à l’enchaîner sous le joug honteux de l’orgueil, de la dureté, et de tous les vices » (Ib., p. 160). Quali che siano le ragioni che hanno dato vita a questa aberrazione, ormai il male è fatto ed il modo migliore per porvi rimedio (da funzionario e filosofo non poteva esprimersi meglio) è quello di seguire « l’esprit de la loi » che regola l’uso degli schiavi. Esso vuole che siano trattati con umanità ed istruiti nella religione cattolica, affinché, nonostante gli orrori della schiavitù, possano essere « heureux, en conservant cette liberté précieuse de l’âme que le vice seul peut enlever » (p. 162). Il richiamo alla conversione, come ricompensa dei mali inflitti agli schiavi e giustificazione della schiavitù, è vecchio e scontato, ma nel discorso di Poivre si arricchisce di un duplice significato, umano e strumentale, che ne cambia i connotati. La conversione dei pagani è infatti vista, nello spirito della legge, come funzionale alla non spersonalizzazione dello schiavo, alla sicurezza delle colonie e quindi, in ultima analisi, si inserisce in una prospettiva laica avente come meta finale l’interesse della metropoli, che coincide però, a ben guardare e data la situazione particolare, con quello delle colonie e dei loro abitanti: padroni e schiavi. Dall’adesione dei coloni allo spirito, e non soltanto alla lettera della legge, che vuole il bene di tutte le componenti coloniali, nascerà la situazione ottimale che la colonia potrà raggiungere, compatibilmente con l’errore iniziale su cui ha posto le basi. Ed è proprio a questo punto che Poivre sconfina nell’utopia, abbandonandosi a sogni idilliaci di tipo rousseauiano (il Rousseau paternalista di Clarens) (15), anche se è molto probabile che, in un pubblico discorso, Poivre usi abilmente l’utopia come miraggio per coloni refrattari a discorsi di tono umanitario. Il quadro della futura Ile- 212 de-France tracciato da Poivre è così avvincente che non possiamo esimerci dal trascriverlo senza tagli: « Quelle situation plus délicieuse que celle d’un maître bienfaisant, qui vit sur sa terre au milieu de ses esclaves, comme au milieu de ses enfans! qui les voit autour de lui, deviner ses volontés et prévenir sa parole, pour les exécuter avec ardeur; qui voit des pères et des mères sains et robustes lui apporter annuellement le premier sourire du fruit de leur amour, comme des prémices dus au père commun de tous ses serviteurs. Ils craignent son absence, autant que d’autres malheureux craignent la présence d’un maître impitoyable; lorsqu’il reparoît au milieu d’eux, il est comme l’astre bienfaisant qui rejouit toute la nature de ses regards. Il trouve tout dans le plus grand ordre, et ne voit autour de lui que des hommes empressés, gais et contents » (Ib., pp. 164-65). È probabile, tenuto conto della definizione che l’autore ha dato della schiavitù e degli effetti negativi su cui ha tanto insistito, che questa bella scena abbia essenzialmente un valore strumentale e cerchi di far leva sull’amor proprio dei coloni, i quali potrebbero essere tentati a provare il gioco del « buon padre » o quello ancor più lusinghiero dell’ «astre bienfaisant». Ma c’è dietro, sfrondati gli abbellimenti d’obbligo in un pubblico discorso, un’idea di fondo assai diffusa in quegli anni, grazie soprattutto al lavoro dei Fisiocratici, secondo la quale interesse ed umanità procedono su percorsi coincidenti e non solo non sono antitetici, ma non sono neppure separabili, senza danno reciproco. Per cui, al di là delle soddisfazioni morali che possono derivare ad un colono dal fatto di sentirsi al centro di un piccolo impero ben organizzato, ne consegue un utile reale per tutti (il maggior utile compatibile con l’anomalia della situazione): « Vous voyez donc, messieurs, que la nature, la raison, la religion, votre intérêt et celui de la colonie, votre propre bonheur, tout vous parle plus fortement que la loi elle-même, en faveur de ces infortunés » (Ib., p. 166). Ma l’immagine utopica e le blandizie non sono i soli strumenti verbali di cui si serva Poivre nel suo discorso; passando da una visione generale dei problemi alla situazione contingente della colonia che è stato chiamato ad amministrare, egli non disdegna l’allusione alla minaccia della legge o gli attacchi diretti al profitto 213 individuale: « Si nous examinons les causes morales, nous voyons que depuis l’établissement de cette colonie, toujours languissante, il en est sorti une multitude prodigieuse de fortunes énormes; si ces fortunes avoient été le produit des cultures, ces cultures existeroient encore, et l’isle ne seroit pas dans l’état de foiblesse où nous la trouvons. D’où donc sont sorties tant de fortunes subites, dans une isle qui semble ne produire encore que des bois et des pierres? » (Ib., pp. 169-70). Visto che poco prima aveva fatto cenno alle somme immense spese dallo Stato per far crescere la colonia, senza aver ottenuto alcun risultato apprezzabile, è chiara l’insinuazione contenuta nella domanda. La posizione assunta da Poivre è, con ogni probabilità, il risultato di una serie di calcoli che si sono cominciati a fare al Bureau des Colonies, dai quali risultano molto più affollate le colonne delle perdite che quelle degli utili pubblici, a tutto vantaggio di pochi privati che si arricchiscono alle spalle della comunità e sulle sofferenze degli schiavi. Dai discorsi del funzionario-filosofo Pierre Poivre emergono alcuni elementi che ci possono essere utili per definire il complesso di atteggiamenti che si vanno affermando, attorno agli anni Sessanta, nei confronti delle colonie e della schiavitù: l’elemento dominante ci sembra una revisione critica in tutti i settori ed a tutti i livelli. Il modello coloniale a cui l’Europa si è ancorata per più di un secolo mostra pericolose fragilità, non soltanto dal punto di vista della sicurezza, ma anche da quello degli utili ed infine da quello della crescita civile. In quegli anni anche Bernardin de Saint-Pierre viene inviato come funzionario all’Ile-de-France e le sue reazioni di fronte alla miseria dei negri schiavi sono assai più appassionate e veementi di quelle di Poivre. Tutti conoscono sommariamente le sue posizioni nei confronti della schiavitù negra, almeno attraverso il notissimo Paul et Virginie (1787), scritto parecchi anni più tardi, quando le impressioni violente dell’impatto con la realtà coloniale si sono un po’ mitigate. Meno comunemente letto è invece il suo Voyage à l’Ile-de-France, dove queste reazioni hanno ancora tutta la loro spontaneità e la loro forza (16). Il viaggio è raccontato in forma epistolare: la dodicesima lettera è dedicata ai negri schiavi dell’isola. Dopo averci informati che vengono quasi tutti dalla vicina isola di Madagascar, Bernardin de Saint-Pierre traccia un quadro sommario, ma piuttosto lusinghiero, delle loro caratteristiche fisiche e morali: sono meno neri ed hanno il naso meno schiacciato degli abitanti della costa occidentale dell’Africa, sono 214 « adroits, intelligents, sensibles à l’honneur et à la reconnaissance », amano la musica e sono molto ospitali (l7). Giunti all’Ile-de-France vengono brutalmente separati dai loro congiunti e costretti ad un lavoro massacrante, sotto il pungolo di punizioni che, senza alcun rispetto delle limitazioni imposte dal Code noir, raggiungono anche le duecento frustate per una mancanza di poco conto. Prima di addormentarsi, ci dice ironicamente Bernardin de Saint-Pierre, hanno, tuttavia, la consolazione di pregare Dio per la prosperità dei padroni! Se gli Europei che sbarcano per la prima volta nell’isola si commuovono di fronte a questa situazione, i coloni snocciolano per loro il rosario dei difetti dei negri ed in questo modo pareggiano i conti. Si sentono anche autorizzati ad organizzare partite di caccia per ricondurli all’ovile, semmai avessero deciso che la vita nei boschi è, comunque, preferibile a quella delle piantagioni. Come si può vedere, il trattamento degli schiavi all’Ile-de-France è lo stesso che viene loro imposto nelle colonie d’America, ed è un chiaro esempio di come la colonizzazione africana non sia nata sotto migliori auspici di quella americana. Di fronte ad una realtà così drammatica, resa ancor più sconvolgente dalla brutalità dei coloni e dalla loro totale assuefazione alla sofferenza altrui, Bernardin de Saint-Pierre sembra ritrarsi con orrore e rimpiangere la sorte di chi può vivere senza avere sotto gli occhi uno spettacolo tanto penoso: « Ma plume se lasse d’écrire ces horreurs! mes yeux sont fatigués de les voir, et mes oreilles de les entendre. Que vous êtes heureux! (...). Ici je vois de pauvres négresses courbées sur leurs bêches avec leurs enfants nus collés sur le dos, des noirs qui passent en tremblant devant moi; quelquefois j’entends au loin le son de leur tambour, mais plus souvent celui des fouets (...) et des cris qui vont au cœur... » (18). La lettera dodicesima porta la data del 25 aprile 1769, ma il Voyage fu pubblicato nel 1773. Seguendo una moda che va a poco a poco consolidandosi, la lettera si completa di un post-scriptum, in cui Bernardin de Saint-Pierre esprime brevemente le sue opinioni sulla schiavitù, allineandosi alle posizioni dei Fisiocratici, laddove si tratta di valutarla dal punto di vista economico: « Un habitant serait à son aise avec vingt fermiers, il est pauvre avec vingt esclaves. On en compte ici vingt mille, qu’on est obligé de renouveler tous les ans d’un dix-huitième. Ainsi la colonie, abandonnée à elle-même, se détruirait au bout de dix-huit ans; tant il est vrai qu’il n’y a point de population sans 215 liberté et sans propriété, et que l’injustice est une mauvaise ménagère » (Ib., p. 161). Condanna il fatto che si trattino degli esseri umani come degli animali, perché altri possano vivere come uomini, ma gli ripugna soprattutto che gli Europei, non contenti di sfruttare questi popoli, abbiano tentato di giustificare il tutto con vergognosi sofismi, aiutati in ciò dalla complicità dei loro politici e dei loro teologi, e dalla superficialità o indifferenza dei loro filosofi. Termina infine smascherando la leggerezza e la profonda indifferenza che si nasconde dietro la tanto decantata sensibilità della sua epoca: « Femmes sensibles, vous pleurez aux tragédies, et ce qui sert à vos plaisirs est mouillé des pleurs et teint du sang des hommes! » (Ib., p. 163) (19). Condita con il tocco di una contenuta commozione, la posizione assunta da Bernardin de Saint-Pierre, senza essere nuova, è molto incisiva, anche perché, come si è già rilevato a proposito di Poivre, è uscita dalla penna di un inviato del governo che ha visto le cose con i propri occhi, e sa dirle nel modo giusto. Ad esempio, l’aneddoto della schiava che, per essersi addormentata sfiancata dalla stanchezza e dalla mancanza di riposo, è costretta dalla padrona a mangiare delle « ordures », suscita maggior repulsione ed indignazione nel lettore, del più infuocato discorso in favore della causa negra. La povera vittima scatena la pietà del lettore e lo rende disponibile ad ascoltare un discorso in favore suo e della sua gente. In questo sta proprio l’apporto specifico alla causa abolizionista da parte della letteratura, anche della più mediocre, della più condizionata dalle mode e dal desiderio di successo: attraverso storie commoventi ed esemplari, sa conquistare la simpatia dei lettori alle vittime della schiavitù. Aiuta, personalizzando i protagonisti delle sue storie, a neutralizzare la massificazione e la reificazione imposta al negro, comprato, venduto ed usato come strumento od animale da lavoro. Pur non essendo completamente immune da pregiudizi razziali (20) – ma sono rarissimi i pensatori del raffinato Settecento ad esserne immuni – Bernardin de SaintPierre ha sempre usato la sua penna in difesa dei negri schiavi, anche se a volte ha assunto atteggiamenti che possono lasciare perplessi. Per esempio, quando nel 1788 gli abolizionisti francesi decidono di creare una « Société des Amis des Noirs » con il compito di coordinare la lotta, Bernardin de Saint-Pierre, pur approvando la 216 decisione, si rifiuta di farne parte (21). Però, proprio in quegli anni, nelle Études de la nature, la cui pubblicazione si inizia a partire dal 1784, egli prende ancora, a più riprese, posizione contro la schiavitù negra, formulando le sue critiche, le sue riserve ed i suoi dubbi, a partire da ottiche diverse che trovano il loro punto di confluenza nella conclusione di sostanziale negatività della schiavitù a cui tutte conducono. Per quanto concerne l’Europa, ad esempio, ed in particolare la Francia, gli sembra che tutta l’operazione coloniale, portata avanti con l’impiego di schiavi, sia fallimentare dal momento che non favorisce né la crescita interna, né quella esterna, non migliora le condizioni di vita nella madrepatria e non soddisfa la sua aspirazione ad accrescere i possedimenti americani: « Par quelle fatale contradiction, avons-nous rendu la plus grande partie des terres de France roturières, tandis que nous avons ennobli celles du nouveau monde? (...). Ce genre d’ennoblissement n’a pas été moins funeste à ces terres étrangères, où il a introduit l’esclavage, qu’aux terres de la patrie, aux laboureurs desquelles il a enlevé une multitude de ressources » (22). Ricordiamo che anche Poivre aveva fatto allusione alle enormi somme sperperate dallo Stato per lo sviluppo di una colonia alla quale la schiavitù, utile soltanto ai privati, impediva di crescere. Ma la condanna più decisa e più organicamente formulata, anche perché è inserita nell’ambito di una rivendicazione che concerne tutta la classe subalterna, è quella contenuta nei Vœux d’un solitaire, indirizzati all’Assemblea nazionale. Si tratta di una serie di richieste che l’autore fa formulare ai diversi stati (nobiltà, clero, popolo) nella speranza che l’Assemblea voglia ascoltarli. La richiesta di abolizione della schiavitù è una voce obbligatoria dei vœux pour le peuple, che sarebbero incompleti se non si facessero interpreti anche di coloro che vivono al di sotto del terzo stato, in possedimenti lontani: « Comme il n’est pas juste que le Français qui veut être libre en France, soit tyran dans les autres parties du monde, il est nécessaire d’abolir l’esclavage des noirs dans nos colonies d’Afrique et d’Amérique: il y va non seulement de l’intérêt de la nation, mais de celui du genre humain » (23). Per quanto riguarda gli interessi della nazione, egli ribadisce posizioni già emerse nel Voyage à l’Ile-de-France, insistendo però particolarmente su alcuni aspetti 217 lasciati precedentement in ombra. È, per esempio, convinto che se non si fossero condotti schiavi negri nelle colonie americane, esse avrebbero potuto offrire lavoro ad una quantità di contadini ed operai francesi, privi di risorse in patria, con vantaggio dei coloni e della madrepatria, che avrebbero potuto contare su di un lavoro intelligente, sulla sicurezza all’interno delle colonie e su di un appoggio contro eventuali attacchi dall’esterno. Ma l’aspetto più negativo della schiavitù non è costituito da eventuali perdite economiche, bensì dalla corrosione che essa esercita sulle strutture dello Stato e sulle coscienze individuali, portando insensibilmente la Francia su posizioni retrograde e tagliando così il cammino ad ogni forma di progresso civile: « Ces opinions tyranniques, déjà si répandues en France, prennent naissance dans l’esclavage de nos îles d’Amérique, comme un foyer toujours subsistant de servitude, et se propagent en Europe par la voie de leur commerce, ainsi que la peste se transporte de l’Egypte avec ses productions. Or, comme on n’a point établi jusqu’ici sur les côtes de France de quarantaine pour les hommes d’au-delà des mers, infectés par naissance, par habitude et par intérêt du dogme de l’esclavage, et que la dépravation des esprits est encore plus contagieuse que celle des corps, il est de toute nécessité que l’esclavage du peuple noir soit aboli dans nos colonies... » (Ib., p. 133). Il grande potere di corruzione della schiavitù è reso in maniera incisiva attraverso la comparazione con la peste ed i ripetuti richiami al contagio che riescono a presentarcela immersa in un’atmosfera malsana, putrida di miasmi capaci di agire sul fisico e sul morale degli uomini e degli Stati, senza che nessuna misura preventiva sia prevista per difenderli. È un atto di accusa di grande potere suggestivo, mutuato agli anatemi contro il peccato che si lanciavano dai pulpiti delle chiese, dopo averne evocato la demoniaca capacità di presa sugli uomini, un atto d’accusa che vuole però agire, pur servendosi di metodi persuasivi collaudati in altra sede, sulle forze laiche che hanno appena preso il potere e si accingono ad operare secondo giustizia. E giustizia devono a tre popoli, di cui una malintesa politica coloniale ha stravolto i destini e fatto l’infelicità: « Un crime produit toujours un autre crime. Il en est résulté trois peuplades malheureuses, d’Indiens asservis, de noirs esclaves, de Blancs tyrans. Les Blancs sont sans doute les plus misérables (...). Ils vivent d’abord au milieu de leurs frères, cuivrés et noirs dans une crainte perpétuelle (...). Ils sont gouvernés 218 par des moines qui sont avides (...). L’or et l’argent arrosés des pleurs des hommes, ne sortent de leurs mains que pour enrichir des monastères » (Ib., pp. 239-240) (24). L’allusione, nel passo citato, all’avidità dei monaci ed alla destinazione finale delle ricchezze coloniali, lascia supporre un giudizio negativo sul ruolo svolto dalla Chiesa in tutta la vicenda, mentre in altra sede ne aveva difeso l’operato: « Quoi qu’on ait dit de l’ambition de l’église romaine, elle est venue souvent au secours des peuples malheureux » (25). L’infelicità dei bianchi « carnefici » è retoricamente esagerata, nel testo, rispetto a quella delle loro vittime e si può aver l’impressione che Bernardin de Saint-Pierre abbia operato delle semplificazioni pericolose e catartiche per l’Europeo, dal momento che sulla china dell’infelicità, prodotta da un’operazione iniziale sbagliata, sarebbe colui che ha fatto lo scivolone più lungo. Ma il senso di questa misurazione delle rispettive sofferenze, secondo noi volutamente parziale, ci sembra in realtà ben altro. Sull’infelicità degli Indiani decimati e dei negri schiavi, dopo lo scoppio della Rivoluzione, sono ormai soltanto i coloni, parte in causa, ad avanzare dei dubbi, mentre l’idea che con la stessa operazione si sia fatta anche l’infelicità dei bianchi è assai meno diffusa ed accettata. È dunque su questo terreno che si deve condurre la lotta più dura, per smantellare le fondamenta, ancora troppo solide, che offre alla schiavitù la convinzione di possibili interessi per la Francia. L’Assemblea nazionale deve essere informata sulla situazione reale delle colonie, perché non accada che lasci immutato un settore così gonfio di pericoli per il futuro (26). Dunque l’abolizione della schiavitù deve far parte dei programmi dell’Assemblea, che avrà cura, naturalmente, di operare in maniera graduale, per non fare « le malheur des maîtres et des esclaves ». Bisognerà dapprima abolire la tratta, per giungere in seguito all’abolizione della schiavitù, passando attraverso lo stadio della servitù della gleba, fino alla coltivazione con negri e bianchi liberi. L’esperienza di funzionario delle colonie, che gli ha fatto toccare con mano non solo gli orrori della schiavitù negra, ma anche la sua negatività, a tutti i livelli, per la metropoli, lo ha spinto a porre fra i problemi urgenti che l’Assemblea nazionale deve affrontare, per sanare i mali del popolo francese, anche quello della schiavitù coloniale. Sulle posizioni degli abolizionisti alla vigilia della Rivoluzione e nel periodo 219 rivoluzionario ritorneremo in seguito. Quello che ci preme far notare qui è come le esperienze fatte all’interno dell’amministrazione coloniale abbiano portato alla nascita, alla maturazione o, semplicemente, al rafforzamento di una coscienza antischiavista, non soltanto, come è avvenuto per alcuni, a causa dell’orrore suscitato dallo spettacolo di uomini trattati come animali, ma anche in seguito ad un ponderato calcolo, su dati concreti di varia natura, delle perdite e dei pericoli immensi derivanti dalla schiavitù. Mirabeau, Pierre Poivre, Bernardin de Saint-Pierre non sono che le punte avanzate di un apparato governativo che va lentamente trasformandosi, attraverso una revisione capillare dei suoi ingranaggi coloniali. I funzionari diventano philosophes ed i philosophes funzionari: ideologia e tattica operativa sono ormai così strettamente connesse l’una all’altra che i ruoli si scambiano. Diventa perciò un procedimento abbastanza diffuso da parte dei funzionari far precedere le indicazioni od i suggerimenti operativi, da considerazioni generali di ordine socio-economico, morale o filosofico e, da parte dei philosophes, consolidare le argomentazioni di ordine superiore con il computo dei vantaggi concreti derivanti dal processo di umanizzazione e di progressiva abolizione della schiavitù. Certo, gli archivi coloniali hanno ancora bisogno di spogli lunghi e minuziosi, ma quanto ci ha già rivelato la Duchet, sulla base di una campionatura probante, dimostra come, a partire dagli anni Sessanta, si vada maturando la convinzione che la situazione coloniale sia colma di tensione ed oltremodo pericolosa, senza neppure essere delle più redditizie. Anche sul piano della prassi giuridica accadono, in questi anni, fatti che denunciano senza ombra di dubbio un mutamento di orientamenti. Le leggi che regolavano il soggiorno in Francia di schiavi venuti dalle colonie al seguito dei loro padroni erano abbastanza severe e prevedevano tutta una serie di formalità da esplicare ed un periodo di permanenza limitato (27). Qualora le condizioni previste non fossero state rispettate, lo schiavo avrebbe dovuto ottenere la libertà. In realtà la legge non era mai stata applicata e gli schiavi negri vivevano in Francia, al servizio dei loro padroni o di amici dei padroni, anche per molti anni. La difesa, da parte dell’avvocato Henrion de Pansey, del negro Roc, ingiustamente fatto schiavo, che reclama la sua libertà è un’occasione per ricordare che la legge è ancora in vigore e deve perciò essere rispettata e fatta rispettare (28). Ma è soprattutto un’occasione per condannare, in una pubblica arringa, la tratta, la schiavitù ed i pregiudizi razziali su cui sono nate e cresciute: « S’il étoit quelqu’un assez ignorant ou assez prévenu pour croire que les Nègres 220 sont d’une espèce inférieure à la nôtre, qu’il apprenne que ces hommes, l’objet de notre mépris, sont la plupart dignes de commander à leurs tyrans, et d’être les modèles de leurs maîtres. Ils ont le germe de toutes les vertus, ils en ont porté plusieurs à un degré d’énergie auquel nos ames affaissées par la mollesse, n’atteindront jamais » (29). Nel corso dell’arringa Henrion de Pansey ricorda anche con orgoglio che « Nul n’est esclave en France », ma il suo discorso va, come si è visto, ben oltre i confini della Francia, per perorare la causa della libertà di tutti gli uomini. A partire dagli anni Sessanta, l’Europa dell’economia e della politica comincia a prendere coscienza che i tanto decantati utili coloniali sono da rimettere in discussione, anche perché in ogni caso vanno a vantaggio di pochi, l’Europa del diritto a rendersi conto che la tolleranza della schiavitù è un affronto fatto alla giustizia, l’Europa dei lumi denuncia le vittime che il progresso materiale calpesta e fagocita per alimentare la sua crescita. Anche l’Europa religiosa comincia ad interrogarsi sui metodi della sua missione ed a chiedersi se la schiavitù sia realmente la strada migliore, o la sola, che porta gli infedeli a Dio. Il momento è maturo per una campagna abolizionista suscettibile di buoni risultati: l’abolizione della schiavitù diventa sempre più, negli anni che precedono la Rivoluzione, una questione di modi e di tempi, piuttosto che una questione di principio. Note (1) Mirabeau, L’Ami des hommes, ou traité de la population, Amburgo, 1760, 6 voll. (5 ed.), III, cap. IV, Des colonies, pp. 283-284. (2) Anthropologie et histoire..., cit., pp. 161-162. (3) Ibidem, p. 161. (4) Cfr. A. Stern, La vie de Mirabeau, 2 voll., tr. fr., Parigi, 1895-96, I – Avant la Révolution; II – Pendant la Révolution, II, p. 11. (5) Il passo è citato in Stern, I, p. 12. (6) Esprit des lois, XVIII, 3. Per un’analisi dell’affermazione di Montesquieu in rapporto al determinismo « climatico » cfr. C. Rosso, Montesquieu moraliste, cit., p. 153. (7) L’argomentazione continuerà ad essere valida anche alla vigilia della Rivoluzione ed in periodo rivoluzionario, fino all’abolizione della schiavitù. Leggiamo ad esempio nelle Réflexions sur le sort des Noirs dans nos colonies (1789) di Daniel Lescallier (EDHIS, I, 5): « La première de ces vérités est que l’habitation dont la régie est la plus raisonnée, la moins arbitraire, où les Nègres son catéchisés, où on cherche à leur donner des mœurs, où ils ont a 221 quelques propriétés, et une espèce d’existence sociale, est aussi celle qui rapporte des revenus plus constans à son propriétaire, et que moins les Nègres sont malheureux plus leur Maître s’enrichit. Les partisans de l’esclavage en convinrent eux-mêmes » (p. 13). Ma gli esempi potrebbero essere numerosissimi. (8) Cfr. Dell’origine e dei progressi di una scienza nuova, inserita nel I volume della Biblioteca dell’Economista, dedicato appunto ai Fisiocratici, pubblicata da Pomba, Torino, 1850, pp. 408-432. Per una bibliografia essenziale aggiornata sulla scuola fisiocratica rinviamo a P. Capitani, Evidenza e legge naturale in François Quesnay, in La politica della ragione, a cura di P. Casini, cit., pp. 107-134. (9) Abbiamo letto il testo nel volume dedicato ai Fisiocratici, cit. Su Turgot cfr. C. Signorile, Il progresso e la storia in A. J. R. Turgot (1746-1761), Venezia-Padova, 1974. Sulle posizioni di Turgot e Necker cfr. C. L. Lokke, France and the colonial question. A study of contemporary French opinion (1763-1801), New York, 1968, pp. 70-78 (1a ed. 1932). (10) Sulle posizioni dei funzionari e dell’amministrazione coloniale, è fondamentale il testo della Duchet (Anthropologie et histoire...). Cfr. in particolare, pp. 125-136; 151-160 e passim. (11) « Éphémérides du citoyen », 1771, VI, pp. 218-219. (12) « Le premier Souverain qui prendra le parti de montrer aux negres à faire du syrop, et de leur en acheter au lieu d’esclaves, forcera bientôt les autres Nations de l’imiter. Il sera le bienfaiteur de l’Europe et de l’Afrique, le réformateur des noirs et des blancs; il sera agréable à Dieu et aux hommes; son nom ne sera prononcé qu’avec amour et bénédiction; ses vertus et ses lumieres attireront les récompenses du Ciel, les dons de la nature sur ses États et sur ceux de ses voisins » (Ib., p. 244). È un’alternativa alla coltivazione delle colonie americane con schiavi, suggerita in seguito da quasi tutti gli abolizionisti anche alle soglie della Rivoluzione ed in epoca rivoluzionaria. Cfr., ad esempio, M. Lamiral, réfuté par lui-même, ou Réponse aux opinions de cet auteur, sur l’abolition de la Traite des Noirs, suivie de quelques idées sur les établissemens libres que la France ne doit point différer au Sénégal. Par un ami des blancs et des noirs, (Parigi 1790) di François-Xavier Lanthenas (ma pubblicata anonima). In quegli anni Lanthenas stava conducendo una lotta anche in favore di una concezione medica meno arida e più socialmente utile (cfr. S. Moravia, La scienza dell’uomo nel Settecento, Bari, 1970, p. 59). Echi di questa nuova sperimentazione suggerita dagli abolizionisti si ritrovano anche in una novella di Mme de Staël, Mirza, ou lettre d’un voyageur, composta, come dice l’autrice stessa nella prefazione, prima della Rivoluzione, quando non aveva ancora vent’anni. Il protagonista della vicenda si chiama, ad imitazione dell’eroe di SaintLambert, Ximéo. (Abbiamo consultato il testo in Œuvres complètes, Parigi, 1838, 3 voll., I, pp. 72-78). Quella che ci narra Mme de Staël è una storia d’amore (e di morte) abbastanza banale: il protagonista porta dentro di sé la tragedia della morte della giovane Mirza che ha tradito, dopo averle promesso amore eterno. Il rimorso è aumentato anche dal fatto che, prima di scegliere la morte, la giovane, ormai incapace di vivere, aveva offerto ai mercanti negrieri la sua vita al posto di quella di Ximéo. La storia, seguendo un cliché ben collaudato, si fa veicolo della condanna della schiavitù coloniale (« J’avais horreur de l’esclavage... », p. 73). Come Lanthenas e molti altri abolizionisti nell’ultimo Settecento, Mme de Staël propone di impiantare in Africa la coltivazione dei prodotti che si ricavano dalle colonie americane e di far lavorare la terra da uomini liberi « ... elle (la piantagione) rendait au moins autant qu’un pareil espace de terrein cultivé à Saint-Dominque par un même nombre d’hommes, et les 222 nègres heureux n’étaient point accablés de travail » (p. 73). Il protagonista ha accettato, nonostante la sua disperazione, questo esperimento proposto dai bianchi, perché possa servire da esempio e da stimolo ai suoi infelici fratelli, affinché « Puisse un commerce libre s’établir entre les deux parties du monde! » (Ib.). Per un analogo auspicio di cessazione del commercio vergognoso degli Europei sulle coste africane in Sylvain Maréchal, cfr. F. Aubert, Sylvain Maréchal. Passion et faillite d’un égalitaire, Pisa, 1975, p. 37. (13) Delacroix sostiene ad esempio che è quasi impossibile riuscire a mutare la mentalità nelle colonie : « On est tellement persuadé à Saint-Domingue de la nécessité de la servitude, et ces maximes si révoltantes de châtiment sont si cruellement adoptées, qu’il seroit impossible d’examiner 1°. s’il ne seroit pas possible d’employer des mains libres à la culture de la terre; 2°. s’il est vrai qu’un traitement indigne soit le seul moyen d’inviter au travail l’esclave paresseux; il est certain que l’Européen souffriroit avec peine cette chaleur brûlante que le Nègre endure. Mais parce que l’Africain robuste est nécessaire à un peuple mou et orgueilleux, faut-il qu’il soit condamné à un éternel esclavage; que sa condition soit plus affreuse que celle de l’animal qui laboure nos campagne? » (op. cit., p. 136). (14) Citiamo dall’edizione di Parigi del 1794, p. 4. (15) Fra i testi più recenti sull’utopia nel ‘700 ricordiamo Iluminismo e utopia. Temi e progetti utopici nella cultura francese (1676-1788), curato da S. Bartolommei per il Saggiatore, Milano, 1978, e, soprattutto, B. Baczko, Lumières de l’utopie, Parigi, 1978. (16) Bernardin de Saint-Pierre è molto letto ed apprezzato dagli scrittori abolizionisti alla vigilia della Rivoluzione ed anche oltre. Condorcet fa gli elogi del Voyage à l’Ile-de-France: « C’est un des Ouvrages où la manière dont les Nègres sont traités, est exposée avec le plus de vérité» (op. cit., p. 28, nota). Edmond Favières farà rappresentare nel 1791 una commedia in tre atti, in prosa, « mêlée d’ariettes », dal titolo Paul et Virginie, tratta dal romanzo di Bernardin de Saint-Pierre (Bruxelles et se trouve à Paris, 1792). (17) Voyage à l’Ile-de-France, cit., p. 153. Sul commercio degli schiavi destinati all’Ilede-France ed all’Ile Bourbon cfr. J. M. Filliot, La traite des esclaves vers les Mascareignes au XVIIIe siècle, Parigi, 1974. (18) Ibidem, pp. 159-160. Uno stato d’animo analogo lo troviamo in una lettera scritta dall’Ile-de-Bourbon, nel gennaio 1775, dal poeta Parny a Bertin: « Non je ne saurais me plaire dans un pays où mes regards ne peuvent tomber que sur le spectacle de la servitude, où le bruit des fouets et des chaînes étourdit mon oreille et retentit dans mon cœur. Je ne vois que des tyrans et des esclaves et je ne vois pas mon semblable. On troque tous les jours un homme contre un cheval: il est impossible que je m’accoutume à une bizarrerie si révoltante » (Œuvres, Parigi, 1808, 3 voll., I, p. 230). Nella stessa lettera sostiene che il commercio europeo ha guastato la vita dell’isola: i negri hanno contratto tutti i vizi dei bianchi e vendono i loro figli per un fucile o qualche bottiglia di acquavite. (19) Anche nei Vœux d’un solitaire, rivolti all’Assemblea nazionale, che fanno parte delle Études de la nature, ritorna sullo stesso concetto, di piaceri che si gustano con indifferenza in Europa, senza preoccuparsi delle sofferenze che li hanno procurati: “Quant aux choses qui sont à mon usage habituel, je dois certainement mon tabac, mon sucre et mon café, aux pauvres nègres d’Afrique, qui les cultivent en Amérique sous les fouets des Européens” (vol. V, p. 23). Del resto, l’immagine dello zucchero e del caffè grondanti del sangue di vittime innocenti diventa un luogo comune della letteratura abolizionista. (20) Leggiamo, ad esempio, nelle Études de la nature: « Cependant, il faut l’avouer, si quelques peuplades d’Afrique nous surpassent en qualités morales, en général les Nègres sont 223 très inférieurs aux autres nations par celles de l’esprit » (citiamo dall’edizione di Parigi, 1804, in 5 voll., vol. I, p. 459, nota). (21) Egli scrive nei Vœux d’un solitaire (pubblicati, come risulta dal preambolo, nel settembre 1799): « Il s’est formé à Paris comme à Londres une société amie et patronne des pauvres noirs esclaves, au moins aussi digne de l’estime publique que celle de la Merci. C’est à cette Société respectable à porter les doléances de ces infortunés à l’Assemblée nationale » (Études, vol. V, p. 134). (22) Application des lois de la Nature aux maux de la Société, in Études, vol. III, p. 283. (23) Études, vol. V, p. 129. (24) Il concetto che la tratta e la schiavitù abbiano fatto il male di tanti popoli è più volte ribadito: « Voilà sans doute bien des larmes et du sang répandus par l’Afrique. Mais la balance des maux sera au moins égale pour l’Europe, si l’on met de son côté la navigation même de l’Afrique, dont le mauvais air emporte les équipages de nos vaisseaux tout entiers, ainsi que les garnisons de nos comptoirs en Afrique, par les dyssenteries, le scorbut, les fièvres putrides, et surtout par celles de Guinée qui tuent en trois jours l’homme le plus robuste. Ajoutez à ces maux physiques les maladies morales de l’esclavage, qui détruisent dans nos colonies de l’Amérique les premiers sentiments de l’humanité, parce que là où il y a des esclaves, il se forme des tyrans, et l’influence de cette dépravation morale sur l’Europe... » e la serie dei mati continua (Explication des figures, in Études, I, p. 72, nota). (25) Études, vol. II, p. 1. Sulle difficoltà incontrate nelle colonie da quei missionari che avrebbero voluto adottare, nella conduzione della loro missione, atteggiamenti in contrasto con gli interessi dei coloni, cfr. L’esclavage aux Antilles françaises (XVIIe-XVIIIe siècle). Contribution au problème de l’esclavage, del padre Antoine Gisler, Friburgo, 1965, pp. 7778. (26) Un settore che è, tra l’altro, ben lontano dal dare i frutti che sono stati e continuano ad essere tanto decantati dai sostenitori della schiavitù « Quant à la balance des biens, elle se réduit de part et d’autre à fort peu de chose. On ne peut pas, en conscience, compter dans les biens que les habitants de l’Afrique tirent de la vente de leurs compatriotes, nos sabres, et nos eaux-de-vie, qui leur font perdre la raison et la santé: tout se réduit donc, à peu-près, pour eux à des miroirs et à des sonettes. Quant aux biens qui en reviennent à l’Europe, il y a le sucre, le café et le coton, que l’Amérique nous donne par le travail dés esclaves nègres, mais ces produits bruts et informes ne peuvent entrer en comparaison avec les fabriques perfectionnées et les récoltes en tout genre que tireroient de ces mêmes campagnes de cultivateurs européens libres, heureux et intelligens » (Études, I, pp. 73-74, nota). (27) Cfr. L. Vignols, Les esclaves coloniaux en France..., cit. (28) Il fenomeno della presenza di schiavi negri in Francia non deve essere né cessato né diminuito negli anni seguenti se leggiamo in un anonimo romanzo negrofobo del primo Ottocento (Les amours de Zémédare et Carina, et description de l’île de la Martinique, Parigi, 1806, 2 voll.) : « Le transport des nègres en France, où cette espèce devient chaque jours plus nombreuse, est également contraire au progrès de la culture, et à la sûreté des colonies. On enlève ainsi, par un luxe ridicule, une infinité de bras aux ateliers; et les esclaves, assimilés dans le royaume à tous les citoyens, rapportent en Amérique un esprit d’indépendance et de libertinage, dont les suites peuvent devenir très dangereuses» (II, 257). (29) Henrion de Pansey, op. cit., p. 13. 224 SCHIAVISMO LENTO A MORIRE Per avere un quadro completo dello stato del problema in questi anni di progressiva e rapida affermazione di un orientamento antischiavista, bisogna anche tenere presente che sono nate in questo stesso periodo (ma il fenomeno continua fino alla Rivoluzione ed oltre) anche le più solide difese della schiavitù, come le Lettres russiennes di Strube (1760) e la Théorie des lois civiles di Linguet (1767) o la Dissertation sur la traite et le commerce des nègres (1764) di Bellon de Saint-Quentin, senza contare numerosi altri scritti ripetitivi di vecchie posizioni, o ambigui negli orientamenti, o grossolani e denigratori nell’elaborazione di un’approssimativa tipologia negra. Senza contare, inoltre, gli ostacoli non voluti, ma non per questo meno reali che venivano da fonti del tutto inattese e di grande peso nel dibattito, come è il caso di Voltaire, di cui già si è parlato. Nel 1765 appare in Francia il decimo volume dei Mélanges intéressants et curieux di Rousselot de Surgy (1), in cui l’autore, partendo da una delle tipologie della razza nera più negative che siano mai state formulate, ne giustifica pienamente la schiavitù, anche nelle forme più dure: « On verra mieux encore, d’après l’examen du caractère moral des Nègres, si réellement ces peuples sont faits pour une condition supérieure à celle où ils sont réduits » (2). Allo stesso modo giustifica la tratta, sulla base ormai scontata di presunti vantaggi pratici e morali di tutti coloro che vi sono coinvolti, negri compresi: « Sans alléguer encore ici différentes autres raisons dont on s’est servi pour vouloir condamner ce trafic, bornons-nous à rapporter ce qui l’occasionne, les services qu’il rend à l’humanité et les avantages qu’en retirent ceux même qui en sont l’objet. Toute personne sensée se verra par-là en état de prononcer sur la question de sçavoir s’il mérite d’être anéanti ou encouragé » (Ib., p. 161) (3). 225 A partire dal 1765 inizia la pubblicazione del Voyageur François, ou connoissance de l’Ancien et du Nouveau monde dell’abate Joseph Delaporte (4), i cui primi volumi hanno già raggiunto nel 1772 la quarta edizione, che è quella da noi consultata. Uno degli scopi dell’opera è, come indica l’autore nell’Avertissement, quello di servire da supplemento all’Histoire générale des voyages di Prévost, rimasta incompiuta al momento di trattare dell’« ancien monde, où se sont passé les événements les plus mémorables ». Ma il vero scopo è quello di mutare l’impostazione del lavoro, il modo di accostarsi ai paesi ed ai popoli « En portant, dans ses voyages, le flambeau de la philosophie et de l’observation », per suscitare l’interesse di un « lecteur philosophe ». In realtà, le parti dell’opera che abbiamo consultate ci sono sembrate ben modeste e, soprattutto, prive di quei « lumi » che l’autore aveva annunciati nell’Avertissement. Certo, a prima vista, si ha l’impressione di una descrizione più raccolta e quindi di una sintesi delle relazioni di viaggio più abile di quella di Prévost, ma ci si accorge ben presto che l’omogeneità è dovuta all’eliminazione della pluralità delle fonti: per esempio, tutte le lettere scritte da San Domingo e dedicate alla descrizione della colonia (l’opera è in forma epistolare) sono, non molto diversamente da quanto aveva fatto anche Prévost, un rimpasto, e a volte una trascrizione quasi letterale, del Nouveau voyage aux Iles de l’Amérique di Labat, di cui si è parlato agli inizi di questo lavoro. È allora abbastanza facile farsi un’idea di quale « filosofia » ci si possa aspettare da un autore che si accontenta di ripetere, su di un problema divenuto così scottante in quegli anni, le opinioni di un missionario che era vissuto nelle Antille alla fine del secolo precedente e aveva pubblicato la sua opera una cinquantina di anni prima. Tutto ciò che poteva esservi di positivo, all’epoca in cui scriveva Labat, per gli schiavi negri, risulta ora pericolosamente datato, tanto più che non vengono neppure riprodotti gli aneddoti che rappresentavano, nel testo del missionario, i passi più decisamente favorevoli all’elaborazione di una tipologia positiva del negro. Vi si parla di orrore di fronte al trattamento disumano degli schiavi, di condizione « affreuse », ma non vi è alcuna presa di coscienza reale di fronte al problema, per cui si parla anche delle « douceurs » che i negri troverebbero in America, di « changement en bien », ecc. Ciò non toglie che un passo di tipo apparentemente descrittivo come quello che segue, per la vastità della sofferenza che evoca nella sua puntigliosa enumerazione, possa risultare di un’efficacia straordinaria nella condanna della schiavitù: « De Saint-Domingue à Portorico, de Portorico à la Guadeloupe, de la 226 Guadeloupe à la Martinique, de la Martinique à Sainte-Lucie, Saint-Vincent, la Barbade, Tabaco, la Grenade et Surinam (...). J’ai passé successivement chez les Espagnols, les François, les Anglois, les Hollandois, les Danois; j’ai vu des contrées nombreuses, couvertes de troupeaux d’esclaves, et les trois quarts des habitants changés en bêtes, pour le service de l’autre quart » (5). L’atmosfera generale nei confronti della schiavitù sta ormai decisamente mutando, come dimostrano anche testi di compilazione tipo questo dell’abate Delaporte che, accanto alla trascrizione di opere non dico schiaviste, ma scritte in un’ottica non antischiavista, inseriscono una condanna della schiavitù. Opere ambigue, se si vuole, in cui coesistono orientamenti apparentemente inconciliabili, ma quanto mai significative per leggere il profondo travaglio di quegli anni, verso la conquista di una coscienza decisamente antischiavista. Nel 1766 e nel 1769 si pubblicano due romanzi ambientati in Africa, che hanno come protagoniste due donne, due regine: La reine de Benni, nouvelle historique di Jean-Pierre-Louis Luchet (6) e Zingha, reine d’Angola di Jean-Louis Castilhon (7). Nel primo l’ambientazione africana, il regno di Benin, è soltanto un pretesto per criticare i governi d’Europa ed in particolare quello francese. La scelta di una donna come protagonista non è casuale, perché è proprio in quanto donna che Trémissa sceglie di governare in modo del tutto nuovo, essendo per lei inaccettabili gli esempi che ha dinnanzi agli occhi: « Quand je parcours des yeux les Royaumes de l’Univers, je n’y vois que des despotes, ou des esclaves; des peuples se croyant libres et sans cesse opprimés (...); des loix qui n’ont d’autre appui que de honteux supplices; des Religions destructives de l’humanité; des préjugés vainqueurs de la nature même » (8). Quando, in seguito a guerre, peripezie, intrighi, Trémissa deciderà di eliminare gli uomini dai posti chiave dello Stato e di sostituirli con donne, si realizzerà a Benin il governo più saggio ed illuminato che mai si sia visto sulla terra: « Cela prouveroit cependant que cette différence dans les sexes n’est pas aussi démontrée qu’on l’a cru jusqu’ici; et que l’âme des femmes est peut-être semblable à celle des hommes » (Ib., p. 94). Tanta cautela nell’esprimere l’idea dell’uguaglianza intellettuale fra i sessi 227 meriterebbe davvero un’analisi approfondita nell’ambito di una ricerca sul problema della donna nel Settecento. La pace e la tranquillità che regnano a Benin, come capita spesso, generano la noia. Per combatterla Trémissa invita artisti stranieri, mentre qualcuna delle sue collaboratrici le consiglia di farsi un serraglio di ben cinquecento uomini di età variabile dai quindici ai venticinque anni. Anche alle altre donne di governo che si distinguono nella loro carica vengono regalati due o tre « maschi » perché possano divertirsi. Ma, sul modello della regina, anch’esse vogliono un piccolo serraglio; ottengono così la concessione di un numero di mariti che cresce in rapporto con l’età, partendo da uno tra i diciotto ed i venticinque anni, per giungere a dodici tra i quaranta ed i cinquantadue (9). Risulta chiaro che l’ambientazione in Africa e le più o meno piccanti storie di serraglio « alla rovescia », sono soltanto espedienti narrativi, già ben collaudati nelle Lettres persanes di Montesquieu. A tal fine si incontrano anche altre pennellate di colore locale: gli schiavi che seguono il padrone nella tomba per accompagnarlo nel suo viaggio, la allusione ai vizi portati in Africa dagli Europei, ecc. Lo scopo reale dell’opera è, come si è detto, fare una critica dei governi cosiddetti civili. Quello che può invece essere interessante rilevare qui, è il fatto che sia una regina africana, sia pure poco credibile come tale, a realizzare un governo di saggezza. Grazie a questa sua straordinaria impresa, essa entra nella galleria delle grandi personalità nere che, per il solo fatto di esistere, servono da contrappeso alla mercificazione della tratta ed alla massificazione della schiavitù (10) Più generalmente l’opera, nonostante la sua mediocrità, presenta, sia pure in forma non chiaramente cosciente, lo straordinario abbinamento di due esigenze di riscatto: quella dei popoli negri e quella delle donne. L’accostamento non è casuale: agli inizi dell’Ottocento molti romanzi lacrimevoli, scritti per difendere la causa negra, sono opera di donne (11). Zingha di Castilhon è invece un romanzo storico: la protagonista è realmente vissuta tra il 1582 ed il 1663 e la sua storia è narrata dal padre Cavazzi (12). Ricordiamo che la Istorica descrizione di Cavazzi è liberamente tradotta in francese da Labat, nel 1732 (la parte concernente la storia di Zingha è in traduzione quasi letterale), con il titolo Relation historique de l’Ethiopie, quindi la storia era ben conosciuta in Francia. Persino Sade vi farà allusione nelle Prospérités du vice, a proposito di un intervento della regina per limitare le nascite: « Singha, reine d’Angola, avait fait une loi qui établissait la vulgivaguibilité des femmes. Cette même loi leur enjoignait de se garantir des grossesses, sous peine 228 d’être pilées dans un mortier... » (13). L’allusione di Sade indica già molto bene di fronte a che tipo di personaggio ci troviamo: siamo ben lontani dal governo saggio di Trémissa, anche se non sarà impossibile riscontrare analogie fra le due protagoniste. Non sappiamo se Sade abbia conosciuto Zingha e la sua storia attraverso l’opera di Cavazzi-Labat o di Castilhon, ma è certo che nella versione di quest’ultimo il personaggio ha tutte le caratteristiche per piacere al Divin Marchese: « C’étoit dans ces momens réitérés d’effervescence, que n’osant se livrer à la fougue de ses sens, aux plaisirs de l’amour, de la débauche, et à l’épuisement de la satiété, elle cherchoit à éteindre dans le sang des malheureux qu’elle sacrifioit, et dans l’ivresse de ses festins antropophages, la dévorante ardeur dont elle se sentoit consumée... » (l4). Niente di più sadiano della voluttà insoddisfatta che cerca sfogo nel sangue. E Zingha non è la sola ad avere tali mortiferi ardori. Un’altra delle protagoniste afferma infatti: « ... les cris des malheureux qui tombent sous mes coups, sont pour moi les sons les plus doux... » (p. 134). Il personaggio era già piuttosto truculento anche nella presentazione di Cavazzi; amava la guerra e le situazioni forti, era violento e disposto a tutto pur di giungere al potere e mantenerlo, ma aveva una sua grandezza ed una dignità regale che si ritrova solo raramente nel romanzo settecentesco. La risposta che Zingha dà ai Portoghesi, all’inizio della sua carriera, quando ancora era ambasciatrice del fratello, è uno dei migliori esempi che si sia conservato nel testo di Castilhon: « A l’égard de la protection du Roi de Portugal, votre maître, quelques événemens qui puissent arriver, je ne puis ni ne dois accepter. Les souverains d’Angola se protegent eux-mêmes; ils n’ont et ne veulent avoir que des alliés: des protecteurs, quelque puissants qu’ils fussent, aviliroient la majesté de leur couronne » (Ib., pp. 44-45). Questa richiesta di rapporti paritari tra il suo popolo e gli Europei, che si vogliono invece offrire come protettori, è uno dei tratti dominanti del personaggio storico, come ci è presentato da Cavazzi, anche se quest’ultimo è più propenso a criticare il comportamento come frutto di uno stolto orgoglio, che a coglierlo in quella che ci sembra oggi la sua giusta luce. Cavazzi preferisce soffermarsi più a 229 lungo sulla seconda parte della vita di Zingha, quella che la vede, tra ascese e cadute, giungere infine alla conversione. Castilhon privilegia invece le situazioni forti e scabrose e fa della sua protagonista un mostro assetato di sangue, che sparge ovunque intorno a sé lutti e rovine, in cui sono coinvolti uomini, animali e persino le piante, cioè ogni forma vivente (15). La sua fama di crudeltà è tale che i Giagga, il popolo più crudele di tutta l’Africa, la sceglieranno come regina (16). E, come c’era da aspettarselo, il programma di governo di Zingha non è certo di quelli che deludono gli elettori: « ... je jure d’étendre les horreurs de la désolation dans toutes les contrées habitées par nos ennemis et les infracteurs de tes loix; de ne jamais permettre qu’aucun de nos captifs échappe au sacrifice; d’être perpétuellement en guerre avec les nations voisines, afin que nos autels soient toujours inondés du sang des victimes, et nos boucheries publiques toujours abondamment remplies » (Ib., pp. 158-159). Tutta la prima parte dell’opera è veramente un’orgia di sangue di cui sono vittime gli stessi figli di Zingha e del fratello, mentre la seconda parte anche in Castilhon è dedicata alla conversione della regina ed alla provvisoria trasformazione dei mostruosi costumi dei Giagga. Va da sé che il personaggio, nonostante il suo carattere straordinario, non è di quelli che possono portare appoggio alla causa abolizionista: Zingha, abbastanza scialba come convertita, è grande nel male, nella crudeltà, nella ferocia. È uno dei tanti « mostri » di cui si parla nelle relazioni di viaggio sull’Africa, per la distruzione dei quali si è giustificato qualsiasi tipo di intervento europeo. Va anche aggiunto, però, che Castilhon questo intervento è ben lungi dal sentirlo come risanatore in tutti i suoi aspetti: se l’opera di conversione di Zingha è presentata come positiva, il commercio degli schiavi è invece annoverato tra le cause di corruzione dei costumi africani: « Quoique noirs les habitans du royaume d’Angola sont en général fort adroits, d’une vigueur peu commune dans nos climats, et très ingénieux: en un mot, pour être des hommes, il ne leur manque qu’une sage législation, un souverain qui les chérisse, et l’espoir de la liberté: mais abattus comme ils le sont sous les chaînes du plus dur esclavage, assujettis au despotisme le plus cruel, forcés de respecter les caprices d’un tyran, maître suprême de la vie et des biens de ses sujets, qu’il égorge ou qu’il vend aux avares Européens, qui vont lui acheter des hommes, comme on achette ailleurs des troupeaux et des bêtes de somme, les malheureux 230 habitans d’Angola ne possédant rien, et n’ayant que des jouissances précaires, sont lâches, paresseux; ils sont même perfides, par l’habitude que leur fait contracter la nécessité où ils sont de dissimuler les injures et les outrages qu’ils reçoivent de leur prince, de ses favoris, ou de ses avides ministres » (Ib., pp. 2021). Come si può vedere, Castilhon oscilla fra vecchi modelli descrittivi, tendenti a relegare i negri ai margini dell’umanità, ed i nuovi orientamenti che, pur riconoscendo lo stadio di arretratezza del negro, non ne traggono la conclusione della sua inferiorità, ma cercano piuttosto di individuare le cause e gli eventuali responsabili. Ed il responsabile maggiore risulta sempre essere la schiavitù, sia essa esercitata dai principi africani o dai coloni europei in America. La posizione di Castilhon resta però ambigua e, tutto sommato, forse indifferente nei confronti della schiavitù; tuttavia, in un’altra sua opera, pubblicata nello stesso 1769, con il titolo significativo di Considérations sur les causes physiques et morales de la diversité du génie, des mœurs et du gouvernement des Nations (17), trattando della diversità tra gli uomini del Nord e quelli del Sud, pur senza fare alcuna allusione precisa ai popoli neri, egli afferma che « Les uns sont faits pour commander et conquérir, et les autres pour obéir » (p. 35). Sulla scia di Montesquieu, e senza condividerne le esitazioni, egli sembrerebbe ammettere l’esistenza di una schiavitù irrimediabilmente legata alla situazione geografica di un popolo, mettendosi così su posizioni favorevoli al mantenimento della schiavitù coloniale. Strettamente collegato ai due romanzi che abbiamo esaminato, anche se di orientamento più decisamente antischiavista e di periodo posteriore, è una specie di romanzo anonimo, dal titolo La négresse couronnée, ou les mœurs des peuples mises en action. Histoire remplie d’événemens singuliers, amusans et curieux (18). E gli avvenimenti di tutti i tipi non mancano davvero in questa storia che ha per protagonista Byty, una negra di modeste origini che, dopo una serie ininterrotta di avventure in quasi tutti i paesi del mondo, diventa regina di Tombut. La parte più interessante dell’opera è certamente l’Epître dédicatoire aux Noirs, che vuol essere un atto di giustizia nei confronti di uomini verso i quali l’Europa ha tanti debiti: « On est las de ne voir que des noms pompeux à la tête des Ouvrages; eh! pourquoi des hommes qui, par leurs sueurs, font éclore le sucre et l’indigo, n’auroient-ils point de part à notre reconnoissance! 231 En fait de mérite, la couleur n’y fait rien » (Ib., I). Il tono dell’opera è spesso ironico e, come nel caso della Reine de Benni di Luchet, sous le couvert di costumi o di modi di vita africani, si criticano in realtà costumi e modi di vita europei. Questa descrizione di cortigiani che vivono attorno al trono di Byty non lascia dubbi: « On ne s’imagineroit pas qu’il y a des Nègres Petits-Maîtres, et cependant il en parut en essaim lorsque Byty eut pris les rênes du Gouvernement. C’étoit un plaisir de les voir se ratisser la peau, se parfumer avec les herbes les plus odoriférantes, s’épiler les sourcils, dans l’idée que cela donnoit un air distingué, et chercher les mouchoirs les plus fins et les plus colorés pour se faire des espèces de turbans. La Reine en rit; cela lui servit de comédie... » (Ib., II, pp. 209-210). La conclusione del passo ci illumina già, in parte, sul carattere di Byty, una regina saggia, convinta che « les Royaumes gouvernés par des femmes, n’éprouvoient point la tyrannie et la cruauté » (II, p. 181). Sotto di lei fioriscono l’agricoltura, il commercio e le arti. Nell’elaborare un codice di leggi, quasi fosse un’allieva di Montesquieu, ha cura non di imitare quello che hanno fatto altri Stati, ma di tener conto dei costumi e del carattere del suo popolo. Non ci stupisce quindi che alla sua morte si meriti un elogio funebre di questo tenore: « Comment-a-t-elle pu mourir, elle qui avoit les charmes divins des immortels? Toutes les ames présentes et passées, ne valoient pas la sienne. Son cœur étoit le Trône du Tout-Puissant; c’est là qu’il faisoit briller ses attributs, et qu’il répandoit la miséricorde à pleines mains » (Ib., II, p. 276). Anche qui il tono è un poco ironico, come lo era del resto, con ogni probabilità, anche quello dell’Epître dédicatoire; non si tratta però di un’ironia che voglia prendersi gioco della razza nera, ma piuttosto del disprezzo di cui è stata vittima. Il personaggio della regina Byty è positivo e la bellezza completa un ritratto già fin troppo lusinghiero: « Elle joignoit au langage le plus insinuant, la physionomie la plus spirituelle et la plus noble; jamais on n’avoit vu une Négresse aussi belle et aussi accomplie: on l’eût prise pour une Françoise, sans la couleur » (Ib., I, p. 5). 232 Anche qui, ma in maniera molto più chiara che nel testo di Luchet, rivendicazione femminile e rivendicazione razziale sono strettamente unite: Byty rivendica alla donna capacità di governo che l’uomo si sforza di negarle, i negri diventano i destinatari di un romanzo che li vede protagonisti. Pur inserendosi sulla scia di Luchet e di Castilhon, l’anonimo autore della Négresse couronnée, che scrive quasi dieci anni più tardi, riflette bene la maturazione di fronte al problema nero avvenuta in quegli anni. Il periodo che va dalla fine degli anni ‘50 agli inizi degli anni ‘70, ma anche ben oltre, si presenta dunque particolarmente ricco di contributi di vario orientamento al dibattito attorno alla schiavitù ed ai popoli africani che ne sono l’« oggetto ». Pur con comprensibili sbandamenti, prodotti anche da non trascurabili riscosse da parte degli schiavisti, la causa abolizionista consolida le sue basi e trova difensori sempre più agguerriti e decisi. Note (1) Parigi, 1763-1765, 10 voll. (2) Ibidem, X, p. 164. (3) Un’analoga, calorosa difesa della tratta, la ritroviamo spesso agli inizi dell’Ottocento, dopo che Napoleone ha ripristinato nelle colonie francesi la schiavitù che la Convenzione aveva abolita nel 1794. Nei già citati Amours di Zémédare et Carina (II, pp. 165-166) si legge: « Comparez leur sort avec ceux des esclaves, et prononcez franchement auquel vous donnerez la préférence! Les Sauvages et les Africains vendent, font périr et quelquefois ils mangent leurs prisonniers, l’Européen qui fait la traite avec les peuples d’Afrique en achetant des hommes vaincus, les arrache à une mort certaine; et par cet acte de générosité ou d’intérêt, comme il vous plaira de le considérer, il passe avec eux, tacitement soit, un vrai contrat synallagmatique ». (4) Parigi, 1765-1795, 42 voll. (5) Lettera CXXVIII, dedicata alle Antille, ed. 1772, vol. XI, p. 204. (6) L’opera apparve anonima, Amsterdam, 1766. (7) Bouillon (et se trouve à Paris), 1769. (8) La reine de Benni, pp. 21-22. Su analoghe capacità di governo ricononosciute alla donna da Montesquieu cfr. J. Geffriaud Rosso, Montesquieu et la féminité, Pisa, 1977. (9) Sugli appetiti sessuali dei negri e delle negre c’è tutta una letteratura nel Settecento (e non solo nel Settecento). Nelle Aventures de Maturin Bonice, premier habitant de l’île de l’Esclavage, ancien ministre du Roi de Zanfara, tirées de ses Mémoires, par un Académicien des Arcades (Parigi, 1782-1783), di Joly, fra i vari affronti che deve subire il protagonista, Maturin Bonice, un bianco fatto schiavo dai Mori, ci sono anche i reiterati assalti di una 233 schiava negra. Forte della sua personale esperienza, Bonice può affermare che « Les Négresses ont un tempérament tout de feu: et n’ayant aucum motif de religion qui les contienne, on n’a pas lieu d’espérer d’elles une exacte continence » (parte I, pp. 84-85). L’opera di Joly, pur non essendo sorretta da una chiara impostazione ideologica, è degna di una certa attenzione perché lo schiavo è qui un bianco ed il lettore europeo anche non impegnato, è certamente sensibile alle sue vicende, ed è costretto a porsi in termini diversi e meno distaccati il problema dell’acquisto e della vendita di un uomo. Va però detto subito che JoIy insiste maggiormente sull’aspetto avventuroso di tutta la vicenda che sulle sue implicazioni ideologiche. (10) Sul deterioramento prodotto dalla massificazione e dalla mercificazione dell’uomo, indipendentmente dalla razza o dal colore, leggiamo ancora in Joly, a proposito di un magazzino di schiavi bianchi : « Il trouva dans son magasin d’Esclaves une compagnie plus nombreuse qu’agréable. La mauvaise nourriture, l’infection de l’air, le chagrin, avoient altéré la santé de plusieurs. Les Maures venoient là comme dans un marché aux bœufs et aux moutons, où l’on choisit ce qu’on veut achetter » (op. cit., I, p. 52). È fuor di dubbio che Joly vuol colpire il commercio negriero. Su questo deterioramento prodotto dalla schiavitù cfr. J.C. Charles, Le corps de l’esclave. Saint-Domingue 1764. Le travail idéologique de l’information, « Les temps modernes », giugno 1978, pp. 1983-2020. Diamo i titoli di alcuni paragrafi: « L’esclave corps marqué », « L’esclave corps massifié », « L’esclave corps sans parole », ed alcune definizioni: corps-maladie, corps-suicide, corps sans âme, corps sans mémoire, corps déréglé, ecc. (11) Cfr. L. F. Hoffmann, Le nègre romantique, personnage littéraire et obsession collective, Parigi, 1973. Ma già nel 1789, in periodo rivoluzionario, Olympe de Gouges faceva rappresentare alla Comédie-Française un dramma dal titolo L’esclavage des noirs, ou l’heureux naufrage, Parigi, 1792. L’opera è preceduta da una prefazione altisonante: « Les Savans peuvent s’appésantir et se perdre sur ces observations métaphysique. Pour moi, qui n’ai étudié que les bons principes de la Nature, je ne définis plus l’homme, et mes connoissances sauvages ne m’ont appris à juger des choses que d’après mon ame. Aussi mes productions n’ont-elles que la couleur de l’humanité ». (12) Istorica descrizione de’ trè regni Congo, Matamba, et Angola situati nell’Etiopia inferiore occidentale e delle Missioni apostoliche esercitateui da Religiosi Capuccini, Bologna, 1687. (13) Citiamo dall’edizione 10/18, Parigi, 1969, p. 47. Oggi, Zingha sembra sia divenuta un simbolo per le donne africane che cercano faticosamente il loro duplice, difficilissimo, riscatto dal mondo maschile e dai residui del colonialismo bianco. Awa Thiam che ha dato con La parole aux négresses (Parigi, 1978), voce alle rivendicazioni delle donne africane, premette al suo lavoro una lunga dedica, di cui diamo qui uno stralcio: « ...A mes sœurs et frères qui - de par le monde - luttent pour l’abolition du sexisme, du patriarcat et de toute forme de domination de l’homme par l’homme. Aux amazones d’Afrique, d’Amérique, de Bohême. Aux guerrières antisexistes de tout temps. A Zingha. 234 (...) ». Nelle pagine introduttive che seguono si precisano le ragioni della dedica: « Jadis, des Négro-Africaines ont eu leur mot à dire quand il fallait prendre des décisions de grande importance. Que l’on se souvienne de Zingha, amazone et guerrière, première résistante à la colonisation portugaise de l’Angola au XVIIe siècle (...) ». In nota si rinvia all’opera di Kake (Ibrahima Baba), Anne Zingha, Parigi, 1975 (p, 17). (14) Castilhon, Zingha..., cit., p. 175. (15) Castilhon non fa alcun riferimento né a Cavazzi né a Labat. (16) Sulla crudeltà dei Giagga cfr. anche Sade, Histoire de Sainville et de Léonore, Parigi, 1963, a cura di G. Lely, pp. 45-46 e passim. Il romanzo è una parte di Aline et Valcour, per il quale Lely propone la data del 1785-1788. Per alcune notizie riguardanti questo popolo cfr. E. Sik, Storia dell’Africa nera (1970), tr. it., Milano 1978, 4 voll., I, p. 132. L’opera di Sik si apre con una discussione sui termini indigeno e negro, prodotti di un’etnologia eurocentrica e discriminante. Sull’ultimo termine il discorso è però più complesso e gli stessi letterati di colore lo usano (o lo hanno usato) come una sorta di vessillo di lotta. (17) Bouillon, 1769. (18) Il luogo di edizione è così indicato : A Tombut et à Paris, I vol. 1777, II vol. 1776 (sic). 235 L’« HISTOIRE PHILOSOPHIQUE » E IL MITO « SPARTAKISTA » Abbiamo definito il Commerce de l’Amérique par Marseille di Chambon una summa di fatti e problemi coloniali, intorno alla metà degli anni Sessanta. Il decennio successivo è tutto occupato da un tentativo di sintesi ben altrimenti ambizioso, come indica lo stesso titolo: Histoire philosophique et politique des établissements des Européens dans les deux Indes, coordinata dall’abate Raynal e rielaborata a più riprese a partire dalla prima edizione del 1770 (ma diffusa soltanto nel 1772), fino all’edizione del 1780 (1). La storia della nascita dell’opera e della sua crescita progressiva attraverso le varie edizioni, grazie al contributo di molti collaboratori, non ancora del tutto identificati (l’apporto più rilevante è certamente quello di Diderot), è una delle più complesse, anche perché solleva il problema dei rapporti tra Raynal e l’Amministrazione coloniale, e quindi, indirettamente, il problema dei rapporti tra i funzionari coloniali ed il mondo della cultura. Come già si è detto, su questo settore dei rapporti fra philosophes e funzionari, sulla reciproca influenza e sulla convergenza di orientamenti tutt’altro che casuale, il contributo della Duchet è fondamentale. Per quanto riguarda in particolare l’Histoire philosophique, le ricerche fatte dalla stessa Duchet negli archivi coloniali rivelano strette analogie fra interi passi dell’opera di Raynal e relazioni inviate dalle colonie, analogie che testimoniano senza ombra di dubbio le ampie possibilità offerte all’abate di accedere a quei testi. Inoltre, una pensione governativa di cui Raynal ha beneficiato quasi ininterrottamente per lunghissimi anni e la relativa sicurezza di cui ha goduto l’opera, nonostante gli ardimenti innegabili, soprattutto in materia di religione (lo stesso Diderot era stupito di quello che poteva permettersi di scrivere dietro il paravento di Raynal, il cui nome compare però soltanto nell’edizione del 1780, ma l’anonimato non era tale per nessuno), hanno fatto pensare ad un testo scritto su ordinazione o, quanto meno, vivamente caldeggiato dall’alto. Per la presenza attiva, e sempre più consistente di edizione in edizione di 236 Diderot, per la larghissima diffusione dell’opera nelle sue molteplici edizioni e contraffazioni, per i probabili legami di Raynal con il Bureau des colonies e, più generalmente con gli ambienti governativi, l’Histoire philosophique rappresenta una tappa fondamentale nella storia del pensiero abolizionista ed un testo privilegiato per un’indagine sugli eventuali rapporti tra potere e mondo della cultura, e sulle analogie di orientamenti che vanno profilandosi in quegli anni, soprattutto in materia di sfruttamento del suolo coloniale. Un’ulteriore conferma dell’importanza dell’opera, in materia di riflessione coloniale, nel decennio 1770-80, è data dal fatto che con l’Histoire philosophique si giunge ad una sintesi di tutto il dibattito precedente, che aveva avuto spesso l’Esprit des lois come punto di riferimento, e si inizia una fase nuova in cui è l’opera di Raynal a fare da perno attorno al quale si articola e cresce il movimento abolizionista. Non ci sono nell’opera grandissime novità di rilievo in materia di lotta antischiavista: la tesi di fondo, pur arricchita e ampiamente articolata, resta quella imposta dai Fisiocratici e fa quindi dell’interesse il punto nodale di tutta l’argomentazione contro la schiavitù, ma la ricchezza di documentazione, la molteplicità degli argomenti, dei fatti, degli aneddoti portati sul tappeto, i brividi apocalittici di rivolta che si fanno sempre più scorticanti di edizione in edizione, danno alla tesi stessa una portata assai più ampia di quanto non avesse nei controllati interventi dei Fisiocratici. L’Histoire philosophique dunque, non priva, come avremo modo di vedere, di ambiguità e contraddizioni, può definirsi, in materia di schiavitù coloniale, il testo chiave degli anni Settanta. Essa costituisce perciò il fulcro d’indagine di un periodo fondamentale non soltanto per la maturazione in Francia di una coscienza antischiavista, ma anche per il coinvolgimento di settori di pubblico fino a questo momento estraneo o scarsamente interessato a tali problemi. Dopo due secoli di modesto interessamento, oggi la critica sta riscoprendo l’Histoire philosophique ed è propensa ad attribuirle un peso ben più rilevante nella cultura del tempo, di quello che non le sia stato comunemente riconosciuto. Il numero elevato raggiunto dalle diverse edizioni, rivedute e accresciute nel decennio 17701780 (si parla di settanta edizioni e contraffazioni, ma forse il computo non è completo), e l’ormai accertata collaborazione di Diderot, che sembra aver dedicato una parte cospicua del suo tempo a rivedere il testo di Raynal ed a scriverne o riscriverne interi capitoli, in particolare per l’ultima edizione del 1780, fanno oggi guardare con occhio diverso a quest’opera di « compilazione » a più mani, tanto che la Duchet ha potuto definirla « un prolongement des méthodes et de l’esprit encyclopédistes » (2). Sui problemi generali della composizione, non ancora del tutto chiariti, ed in 237 particolare sulla collaborazione di Diderot all’opera e sulle trasformazioni che questa ha subito nelle edizioni successive a quella del 1770, rinviamo ai lavori già esistenti, ed in particalore al recente Diderot et l’Histoire des deux Indes ou l’écriture fragmentaire di Michèle Duchet (3), limitandoci qui ad analizzare l’opera in rapporto ai problemi della colonizzazione americana e della schiavitù. Per quanto concerne la colonizzazione, la posizione che emerge dall’Histoire philosophique non è delle più coerenti e si potrebbero estrapolare dal testo citazioni sufficienti per suffragare l’affermazione che Raynal ne ha fatto l’apologia, ma anche per sostenere la tesi opposta. Fra i due momenti ci sembra che esista tuttavia una differenza di rilievo poiché, mentre nell’analisi storica delle imprese europee nel mondo può capitare di trovare toni elogiativi che fanno pensare ad un’apologia, tutta la parte ideologica dell’opera tende invece a mitigare, se non a cancellare questa impressione, ponendo in risalto l’assenza di princìpi su cui la colonizzazione è cresciuta, o peggio, il dispregio di tutti quei princìpi che regolavano in Europa il rapporto tra i popoli, al punto che in più occasioni i conquistatori europei sono presentati come ladri e assassini. Sulla base di quei princìpi trascurati, Diderot (4) elabora una sintetica « carta » della colonizzazione che, fissando tre varianti essenziali all’incontro di un popolo con una nuova terra, espone diritti e doveri inerenti a ciascuna delle situazioni previste. Questa « carta » non è però collocata, come ci si potrebbe aspettare, all’inizio dell’opera che si apre appunto sul problema della colonizzazione, bensì all’inizio del libro VIII, mentre l’incipit dell’Histoire presenta in termini piuttosto trionfalistici la scoperta dell’America e quanto ne è conseguito per l’Europa. Si formulano però fin dall’inizio dell’opera una serie di interrogativi, anche molto angosciosi, sul senso delle grandi trasformazioni che mutano rapidamente e totalmente i destini dell’umanità: « Tout est changé et doit changer encore. Mais les révolutions passées et celles qui doivent suivre, ont-elles été, seront-elles utiles à la nature humaine? L’homme leur devra-t-il un jour plus de tranquillité, de bonheur et de plaisir? Son état sera-t-il meilleur, ou ne fera-t-il que changer? »(5). In seguito gli interrogativi si fanno più circostanziati attorno al problema della colonizzazione e sembrano aprire un processo che, dopo la raccolta dei dati, viene appunto celebrato nel libro VIII e si conclude nel libro XIX, l’ultimo, con la condanna, sia pure con attenuanti, dell’Europa. All’inizio dell’opera, tuttavia, le risposte sono ancora tutte possibili: dopo aver 238 sollevato interrogativi tanto inquietanti ed aver pronunciato una professione di obiettività storica, nella ricerca di una risposta attraverso gli eventi che hanno fatto seguito alla scoperta dell’America, si introduce subito un caloroso elogio del commercio, incentivato dalle scoperte e dalla colonizzazione, che è anche, non dimentichiamolo, commercio di schiavi. Raynal (usiamo il suo nome per ragioni di comodo, per indicare l’opera) afferma di volersi innalzare al di sopra della mischia per guardare, imparzialmente, il globo sotto di sé, ed è da queste altezze che sgorga cristallino l’inno al commercio, forza motrice della civiltà: « C’est-là enfin que, voyant à mes pieds ces belles contrées où fleurissent les sciences et les arts, et que les ténèbres de la barbarie avoient si long-tems occupées, je me suis demandé: qui est-ce qui a creusé ces canaux? qui est-ce qui a desséché ces plaines? qui est-ce qui a rassemblé, vêtu, civilisé ces peuples? et qu’alors toutes les voix des hommes éclairés qui sont parmi elles m’ont répondu: c’est le commerce, c’est le commerce » (l. I, vol. I, p. 5). Nel corso dell’opera, tuttavia, pur restando intatta la fiducia nel potere di trasformazione dei paesi e dei popoli che è prerogativa del commercio, si profila in più occasioni la convinzione che i popoli non europei, ed in particolare i negri e gli indigeni americani, siano stati unicamente le vittime di questo processo di trasformazione, di cui ha beneficiato il solo Europeo. Quest’ultimo infatti ha portato avanti una colonizzazione selvaggia, alla quale non ha mai fissato princìpi e limiti, anche a causa di un’autorizzazione alla conquista indiscriminata che gli è venuta dalla Chiesa: « Et c’est le chef de la plus sainte des religions qui donne à autrui ce qui ne lui appartient pas? (...). Pontife abominable; et si ces contrées dont tu disposes ont un légitime propriétaire, ton avis est donc qu’on l’en dépouille? si elles ont un légitime souverain, ton avis est donc que les sujets lui soient infidèles? si elles ont des dieux, ton avis est donc qu’elles soient impies? » (1. 7, vol. IV, p. 6) (6). È appunto per essersi sentiti autorizzati ad avanzare dei diritti di proprietà su tutte le terre che non appartenessero già ad una nazione europea, che i colonizzatori d’Europa hanno calpestato tutti i diritti dei popoli primitivi, senza preoccuparsi minimamente di sapere se era legittimo appropriarsi indiscriminatamente di una terra 239 deserta come di una terra già abitata. Il fondatore di una colonia (sia esso individuo o gruppo) non può invece prescindere dallo stabilire se il luogo prescelto è interamente abitato, parzialmente abitato o disabitato, perché i comportamenti da adottare nei tre casi sono completamente diversi. Nel primo caso non può che pretendere all’ospitalità ed accettare, se decide di fermarsi, le regole di vita del popolo che lo accoglie. Ogni altro tipo di comportamento sarebbe un atto di violenza fatto all’ospite. Nel secondo caso ha diritto di fissarsi sulle terre incolte e di vivere su queste terre nella maniera che crede, senza tuttavia dare l’impressione di rappresentare una minaccia per i popoli vicini, coi quali deve invece mantenere sempre dei rapporti pacifici. Nel terzo caso, ovviamente, non esiste al suo potere alcuna limitazione: « Une contrée déserte et inhabitée, est la seule qu’on puisse s’approprier. La première découverte bien constatée fut une prise de possession légitime » (1. 8, vol. IV, p. 249). Dopo aver enunciato queste semplici regole di una colonizzazione secondo ragione e giustizia, Diderot invita le nazioni europee a giudicare il loro comportamento e a darsi « le nom qu’elles méritent ». Tanto più che la violazione di questi princìpi ha prodotto in America il più mostruoso dei genocidi ed ha fatto dei popoli africani una mandria di animali da lavoro, destinati anch’essi alle più spaventose decimazioni. Si potrebbero trovare ovunque nell’opera numerosi altri passi a sostegno della colonizzazione e della conquista, a dimostrazione appunto della possibilità che essa offre di un tipo di lettura favorevole alle imprese europee nel mondo, anche se queste hanno comportato lo sfruttamento di altri popoli. Citiamo un esempio fra i tanti, di cui sono protagoniste le isole Antille, quelle isole cioè che sono la culla della schiavitù coloniale, fustigata altrove come il più tremendo dei mali prodotti dall’incontro dei due mondi: « Non seulement la population s’est accrue dans les états propriétaires des isles, mais elle y est devenue plus heureuse. Le bonheur est en général le résultat des commodités; et il doit être plus grand, à mesure qu’on peut les varier et les étendre. Les isles ont procuré cet avantage à leurs possesseurs (...). De cette manière, les empires que le hasard, le bonheur des circonstances, ou des vues bien combinées, avoient mis en possession des isles, sont devenus le séjour des 240 arts et de tous les agrémens, qui sont une suite naturelle et nécessaire d’une grande abondance » (1. 11, vol. VI, pp. 280-281). Tra l’altro, questa presentazione delle Antille come cornucopia dei paesi europei che le possiedono è in contrasto con una delle argomentazioni di maggior peso che vengono portate in campo contro la schiavitù, anche nella stessa Histoire philosophique, vale a dire la scarsità di utili che si possono ricavare da colonie lavorate da schiavi. Senza contare che l’immagine dell’Europa che gode spensierata dei prodotti coloniali è, altrove, assai meno splendida e l’idea del bonheur è offuscata dalle sofferenze e dal sangue di coloro cui si strappa, giorno per giorno, la vita al fine di procurarselo: L’Europe retentit depuis un siècle des plus saines, des plus sublimes maximes de la morale. La fraternité de tous les hommes est établie de la manière la plus touchante dans d’immortels écrits. On s’indigne des cruautés civiles et religieuses de nos féroces ancêtres et l’on détourne les regards de ces siècles d’horreur et de sang (...). Des malheurs même imaginaires nous arrachent des larmes dans le silence du cabinet et surtout au théâtre. Il n’y a que la fatale destinée des malheureux nègres qui ne nous intéresse pas. On les tyrannise, on les mutile, on les brûle, on les poignarde, et nous l’entendons dire froidement et sans émotion » (1. 11, vol. VI, pp. 167-168). Altre contraddizioni di egual peso concernono anche la caratterizzazione dei popoli negri, che è ovviamente molto importante perché non si tratta soltanto di orientare in un senso piuttosto che in un altro una ricerca antropologica, ma anche, inevitabilmente, di appoggiare o di opporsi ad una valutazione antropologica che è stata usata a sostegno della schiavitù. Per questo è molto importante combattere la massificazione, la reificazione o qualsiasi altra manipolazione antropologica che leghi la tipologia del negro alla schiavitù. Ora, l’Histoire philosophique rifiuta con nettezza la discriminazione razziale, basti pensare alla veemenza con cui si respinge la teoria che fa discendere i negri da Caino come razza maledetta, e condanna la tratta senza eufemismi: « ... une terre que trois siècles ont à jamais souillée d’un infâme trafic, de crime et de malheur, d’hommes échangés pour des armes, d’enfans vendus par leurs pères. On n’a pas assez de larmes pour déplorer de pareilles horreurs; et ces larmes sont inutiles » (l. 11, vol. VI, p. 150). 241 Ma nell’Histoire philosophique si sono anche, a più riprese, valutati i popoli africani prendendo come punto di riferimento costante lo schiavo americano, quindi un uomo avulso dal suo ambiente e già sottoposto a trattamenti spersonalizzanti. La tipologia così tracciata suona piuttosto come una valutazione di tipo commerciale, del tutto stridente con la stroncatura di quel commercio che abbiamo or ora citata e che è ovunque presente nell’opera: « On observera que les esclaves qui partent du Bénin, du Calbari et du Gabon sont très inférieurs à ceux qu’on achète ailleurs » (l. 11, vol. VI, pp. 127-128). « [A Molembo] Les esclaves y sont en plus grand nombre et de meilleure qualité que sur le reste de la côte » (Ib., pp. 129-130). Quest’indagine sulle migliori « zone di caccia » e sui pregi e difetti degli « animali » cacciati, in funzione della cucina coloniale, è assente dalla prima edizione dell’Histoire philosophique del 1770 che, in tutta la parte riguardante la tipologia dei popoli africani, si rivela meno condizionata dal commercio europeo di quanto non lo sia l’ultima edizione del 1780. Per contro, nella ricerca delle cause del colore nero, la prima edizione dell’Histoire philosophique, sulla scia dell’Essai sur les mœurs e della Philosophie de la nature di Voltaire, dopo aver rifiutato la spiegazione climatica del colore, fa propria la concezione poligenetica sulle origini delle razze, assorbendo dai testi volterriani anche la carica « razzista » che li caratterizza: « Leur peau est toujours plus échauffée, et leur pouls plus vif. Aussi la crainte et l’amour sont-ils excessifs chez ce peuple; et c’est ce qui le rend plus efféminé, plus paresseux, plus foible, et malheureusement plus propre à l’esclavage. D’ailleurs les facultés intellectuelles étant presque épuisées par les prodigalités de l’amour physique, il n’a ni mémoire ni intelligence, pour suppléer par la ruse à la force qui lui manque » (7). Tutto cambia nell’edizione del 1780, dove si sostiene invece l’unità della specie umana, l’influenza del clima sull’origine del colore e dove, soprattutto, scompare ogni giudizio di merito sulle razze. Nell’una e nell’altra edizione si trova invece, immutata (ad eccezione di pochi interventi di stile), la condanna di un uso improprio dei testi sacri a danno di certi 242 gruppi etnici. Nel condannare la strumentalizzazione della religione a svantaggio dei popoli non europei, l’Histoire philosophique non mostra esitazioni, è anzi caratterizzata da una perfetta coerenza attraverso le varie edizioni. Citiamo dall’edizione del 1780, dove il testo è più conciso ed incisivo: « ... la théologie, après avoir fait une race d’hommes coupables et malheureux par la faute d’Adam, fait une race d’hommes noirs, pour punir le fratricide de son fils. C’est de Caïn que sont descendus les nègres. Si leur père étoit assassin, il faut convenir que son crime est cruellement expié par ses enfans (...). Grand Dieu quelles extravagances atroces t’imputent des êtres qui ne parlent et n’agissent que par un bienfait continuel de ta puissance, et qui te font parler et agir selon les ridicules caprices de leur ignorance présomptueuse! » (1. 11, vol. VI, pp. 64-65). Ci sono inoltre, come correttivo delle caratterizzazioni negative di cui si è parlato, soprattutto nell’edizione del 1780, numerose situazioni e numerosi aneddoti che mettono in risalto belle figure di negri, in cui la bontà, la generosità, il senso di giustizia, il coraggio raggiungono momenti sublimi, senza cadere nell’oleografia. Certuni di questi aneddoti diventeranno famosi (ed oleografici) negli anni successivi. Ad esempio, la storia dello schiavo che acquistò con grandi fatiche una libertà da tanto tempo promessa e mai concessa e che, più tardi, fornì abbondanti mezzi di sussistenza all’ex-padrone divenuto povero, inviando regolarmente una pensione in Francia, fu ripresa da Charles-Jacob Guillemain nel suo Nègre aubergiste, un vaudeville strappalacrime pubblicato nel 1794. Altri momenti contradditori si possono rilevare nell’Histoire philosophique anche nella maniera di trattare lo stesso problema della schiavitù, poiché la si condanna ma si propongono anche dei suggerimenti sul miglior modo di impiegare gli schiavi, per ricavarne il maggiore utile possibile, applicando così al governo degli schiavi quelle massime impiegate dai Fisiocratici, ed in altre parti dell’opera dallo stesso Raynal, contro la schiavitù: « Ils connoîtront qu’ils perdent plus qu’ils ne gagnent à outrager perpétuellement l’humanité; et s’ils ne deviennent pas les bienfaiteurs de leurs esclaves, du moins cesseront-ils d’en être les bourreaux » (l. 11, vol. VI, p. 181). Ma la contraddizione è, in questo caso, più apparente che reale, poiché non si tratta di posizioni diverse, ma di momenti operativi diversi, che richiedono interventi programmati sia sulla situazione del momento che in prospettiva: 243 « Si tout ce que nous avons dit, n’a paru tendre qu’à diminuer le poids de la servitude; c’est qu’il falloit soulager d’abord des malheureux qu’on ne pouvoit délivrer; c’est qu’il s’agissoit de convaincre leurs oppresseurs même, qu’ils étoient cruels au préjudice de leurs intérêts. Mais en attendant que de grandes révolutions fassent sentir l’évidence de cette vérité, il convient de s’élever plus haut » (1. 11, vol. VI, p. 186). Dunque l’attardarsi sulle migliorie da apportare al trattamento degli schiavi non corrisponde ad una tattica dilatoria, ma all’esigenza di ottenere subito un minimo di risultati in attesa della soluzione definitiva del problema, che tutti gli abolizionisti vedono lontana nel tempo. Certo, migliorare una situazione in attesa della sua eliminazione comporta sempre il rischio di prolungarne l’esistenza ma, date le condizioni terribili in cui vivono gli schiavi nelle colonie, gli abolizionisti non possono non contemplare interventi parziali da mettere in funzione subito, pur nella consapevolezza di un possibile rinvio della soluzione finale. Se abbiamo insistito tanto sulle ambiguità e contraddizioni dell’opera, anche a proposito di punti fondamentali della trattazione, è stato per mostrarne subito la complessità, la disparità di letture possibili facendo leva su certi aspetti piuttosto che su altri, l’incerto magma su cui è riuscito a crescere rigoglioso, nonostante tutto, un articolato e caloroso processo contro la tratta e la schiavitù. Perché tale è in effetti, nonostante i limiti di cui si è parlato, l’Histoire philosophique des deux Indes. Un processo in cui si esaminano tutti i punti importanti e meno importanti del dibattito, dalla storia della schiavitù antica e moderna alla storia delle scoperte europee e delle origini della tratta, cui fa seguito un elenco dettagliato delle ragioni portate in campo dagli schiavisti, introdotte da una lunga serie di Mais e confutate ad una ad una in formule stringate e durissime: « Vous n’avez rien négligé pour dégrader ces malheureux et vous leur reprochez ensuite d’être vils » (Ib., p. 207). «Sans vous, y auroit-il eu des combats? Les dissensions de ces peuples ne sont-elles pas votre ouvrage?» (Ib., p. 209). «Etesvous donc les bourreaux des peuples d’Afrique? » (Ib., p. 210). Al più spregevole dei sofismi schiavisti, quello con cui si vuol dare ad intendere che con la tratta si è anche fatta la felicità dei popoli africani, Diderot risponde con una bordata di domande ancora più martellanti delle precedenti, in cui chiede conto di 244 tutta una serie di fatti reali, e non di mistificazioni della realtà, che stridono drammaticamente con le affermazioni dei coloni: « Pourquoi donc ces esclaves soupirent-ils sans cesse après leur patrie? Pourquoi reprennent-ils leur liberté dès qu’ils le peuvent? Pourquoi préfèrent-ils des déserts et la société des bêtes féroces à un état qui vous paroît si doux? Pourquoi le désespoir les porte-t-il à se défaire ou à vous empoisonner? Pourquoi leurs femmes se font-elles si souvent avorter? (...) » (Ib., p. 211). L’uso della religione, con il quale si cerca di convincere i credenti che la schiavitù è il solo mezzo per condurre i negri alla beatitudine eterna, provoca in Diderot un moto di ribellione, di fronte a chi ha osato servirsi di un dio d’amore come di uno strumento di oppressione e di tortura: « O débonnaire Jésus, eussiez-vous prévu qu’on feroit servir vos douces maximes à la justification de tant d’horreur! » (Ib., p. 213) (8). In realtà l’assenza di libertà, togliendo all’uomo la responsabilità delle sue azioni, lo sottrae contemporaneamente ai suoi simili, allo Stato e a Dio, per cui nessuna salvezza è possibile attraverso la schiavitù, che è solo uno scivoloso cammino verso lo scempio fisico e spirituale: « Sans la liberté ou la propriété de son corps et la jouissance de son esprit, on n’est ni époux, ni père, ni parent, ni ami. On n’a ni patrie, ni concitoyen, ni dieu. Dans la main du méchant, instrument de scélératesse, l’esclave est au-dessous du chien que l’Espagnol lâchoit contre l’Américain: car la conscience qui manque au chien reste à l’homme (...) » (Ib., pp. 201-202). Per questo si invitano la Chiesa ed i sovrani a ritirare il loro appoggio alla tratta ed alla schiavitù, e ad operare invece affinché, grazie al loro determinante intervento, la condizione dei negri schiavi possa essere trasformata, in armonia con le massime della religione cristiana e con quelle degli stati civili. Raynal, come la maggior parte degli abolizionisti, chiede che si faccia immediatamente cessare la tratta e si comincino a fissare le tappe di una progressiva abolizione della schiavitù. Ma la fiducia nella Chiesa e nella buona volontà dei sovrani è molto esile; le dimostrazioni che la schiavitù è antieconomica, oltre che ingiusta, non lasciano insensibili gli amministratori coloniali, ma agiscono a rilento, soltanto la paura della rivolta negra 245 può dare una salutare scossa ad una situazione stagnante, sotto cui bolle realmente un vulcano in piena attività che lancia di tanto in tanto infuocati lapilli. La minaccia della rivolta, come già abbiamo visto in numerosi capitoli precedenti, non è nuova; è anzi nata con le colonie americane e fin dai tempi più lontani le opere letterarie se ne sono fatte eco: è documentata nelle relazioni dei missionari, è un momento importante dell’Oroonoko di Aphra Behn ed è il tema centrale della Harangue d’un chef nègre di Prévost. Più recentemente se ne sono serviti Saint-Lambert in Ziméo e Butini nelle Lettres africaines, con lo scopo esplicito di completare, con scene d’orrore e di sangue, il quadro negativo che essi hanno tracciato della schiavitù. Ed il fremito della rivolta percorre come un filone sotterraneo l’Histoire philosophique fin dalla prima edizione (i passi più arditi vi sono attribuiti a Pechméja), come testimonia questa veemente replica in cui il negro oppone la sua multiforme violenza alla legge di violenza a cui si richiama il bianco per opprimerlo: « Que si tu te crois autorisé à m’opprimer, parce que tu es plus fort et plus adroit que moi, ne te plains pas quand mon bras vigoureux ouvrira ton sein pour y chercher ton cœur; ne te plains pas, lorsque, dans tes entrailles déchirées, tu sentiras la mort que j’y aurai fait passer avec tes alimens. Je suis plus fort et plus adroit que toi; sois, à ton tour victime, expie maintenant le crime d’avoir été oppresseur » (Ib., pp. 203-204). Ma per la collocazione che gli viene data (dopo l’invito alla Chiesa ed ai sovrani), per le dimensioni che assume e per il modo in cui viene usato, il tema della rivolta si carica, nell’edizione del 1780, grazie all’intervento di Diderot, di una maggior forza di suggestione e di un significato socio-politico ben più preciso di quello che si esprimeva attraverso le ribellioni nascoste (uso del veleno) o velleitarie delle edizioni precedenti. Abbiamo detto grazie all’intervento di Diderot, e avremmo forse potuto dire meglio grazie all’intervento di Mercier, rilanciato da Diderot. È infatti ormai noto come quest’ultimo non abbia fatto altro che « riscrivere », per l’edizione del 1780, con modifiche di poco conto (accentuate però dalle diversità del contesto) un passo de l’An 2440 (1770) di Mercier, che dà alla rivolta negra un ruolo di primo piano nella storia dei popoli. Mercier, che ha « dormito » per settecento anni e si sveglia nella Parigi del 2440, passa di sorpresa in sorpresa, quasi tutte piacevoli però. Fra queste, vi è la scoperta, in una piazza parigina, di un gruppo marmoreo che rappresenta le nazioni europee in atto di implorare il perdono dell’Umanità, per le sofferenze inflitte a tanti popoli. 246 Poco oltre scorge anche un altro « singulier monument »: la statua di un negro dall’aria fiera ed imponente, su di un piedistallo che si innalza sui resti di venti scettri, portante questa dedica: Au vengeur du nouveau monde. Alla vista di questo riconoscimento che la Francia, un tempo schiavista, ha tributato ad un negro, Mercier lancia un grido di gioiosa sorpresa. Il parigino del 2440 gli spiega allora le ragioni per cui l’Europa ha sentito il bisogno ed il dovere di rendere omaggio ad un tale eroe. Servendosi di questa finzione futurista, Mercier scrive la più bella riabilitazione di una razza sfruttata ed umiliata che sia uscita dalla penna di uno scrittore del ‘700: « ... la nature a enfin créé cet homme étonnant, cet homme immortel, qui devait délivrer un monde de la tyrannie la plus atroce, la plus longue, la plus insultante. Son génie, son audace, sa patience, sa fermeté, sa vertueuse vengeance ont été récompensés: il a brisé les fers de ses compatriotes. Tant d’esclaves opprimés sous le plus odieux esclavage semblaient n’attendre que son signal pour former autant de héros (...). Dans le même instant ils ont versé le sang de leurs tyrans: Français, Espagnols, Anglais, Hollandais, Portugais, tout a été la proie du fer, du poison, de la flamme. La terre d’Amérique a bu ce sang qu’elle attendait depuis longtemps, et les ossements de leurs ancêtres lâchement égorgés ont paru s’élever alors et tressaillir de joie (...). Cet héroïque vengeur a rendu libre un monde dont il est le dieu, et l’autre lui a décerné des hommages et des couronnes » (9). La vendetta è stata atroce, ma indispensabile e quindi vertueuse. Dio stesso l’ha guidata facendo dell’eroe negro l’angelo sterminatore che brandisce la spada della giustizia: « Il est venu comme l’orage qui s’étend sur une ville criminelle que les foudres vont écraser. Il a été l’ange exterminateur à qui le Dieu de justice avait remis son glaive: il a donné l’exemple que tôt ou tard la cruauté sera punie, et que la Providence tient en réserve de ces âmes fortes qu’elle déchaîne sur la terre pour rétablir l’équilibre que l’iniquité de la féroce ambition a su détruire » (Ib., p. 206). Egli ha ristabilito sulla terra un equilibrio che era stato spezzato ed ha riabilitato così non soltanto l’uomo nero, ma tutta l’umanità. Mercier sembra dirci che la violenza brutale ed irresponsabile si neutralizza soltanto con una violenza eguale di segno contrario: dopo che si sarà ristabilito un 247 equilibrio nella sofferenza e nell’umiliazione ci sarà infatti il regno della pace e dell’uguaglianza. I popoli oppressori prenderanno coscienza che il male da essi subito è la giusta espiazione del male fatto, la liquidazione di un passato vergognoso e, riconoscenti per essere stati aiutati ad uscire dall’errore, innalzeranno all’eroe negro un monumento degno della grandezza e degli esiti delle sue imprese. La posizione di Mercier è chiara: per lui la soluzione al problema della schiavitù non può venire da coloro che se ne sono resi responsabili, ma unicamente dalle vittime, perché soltanto attraverso una nemesi riparatrice si potranno mutare le storture mentali che ne sono all’origine. Con lui si assiste al rovesciamento delle posizioni abituali sia degli schiavisti che degli abolizionisti: l’impotenza non sta più dalla parte del negro, ma del bianco, al quale sfugge di mano il processo storico verso il mondo del futuro, che dovrà essere un mondo di giustizia. Potrà reinserirvisi e diventarne parte attiva nel momento in cui sarà maturato in lui un altro processo, cioè quando egli avrà acquistato la consapevolezza delle ingiustizie commesse e quindi della scorrettezza dei princìpi su cui aveva regolato la propria vita a svantaggio di quella degli altri popoli (10). La funzione assegnata al negro da Mercier nel processo storico è quindi fondamentale. Proprio per questo dobbiamo a lui una delle più belle pagine di vera solidarietà con le vittime della schiavitù e di totale rispetto dell’uomo negro: una pagina dettata da un sincero sentimento egualitario. Mercier che amava definirsi profeta ed era orgoglioso di aver previsto, nel suo An 2440, la presa della Bastiglia e l’avvento della repubblica in Francia, avrebbe potuto in un certo senso vantarsi, come ha fatto rilevare Raymond Trousson, di aver azzeccato un’altra profezia: lo scoppio della rivolta negra di San Domingo ed il ruolo di grande protagonista svolto in essa da Toussaint Louverture. Il brano di Mercier, come si diceva, è stato « riscritto » (11) da Diderot per l’edizione del 1780 dell’Histoire philosophique, quasi senza varianti, se si eccettuano alcuni tagli. Nella trascrizione di Diderot, poiché il testo è inserito in un’opera storicofilosofica e non in un’utopia futurista, l’avvenimento è presentato, ovviamente, non come un fatto già accaduto in un lontano passato, ma come un possibile ed auspicabile (sia pure soltanto a fini strumentali) avvenimento di un prossimo futuro. Il testo, che la maggior concisione ha già reso più crudo di quello di Mercier, assume così la carica erompente e distruttiva di un vero e proprio invito alla rivolta, con le inevitabili componenti di violenza che essa comporta. Componenti che non erano certamente assenti dal testo di Mercier, ma che perdevano in parte la loro connotazione negativa per il fatto di essere collocate, rispetto all’ambientazione 248 dell’opera, in un passato lontano, i cui echi sanguinosi si erano ormai spenti per lasciare il posto alla pace fra tutti i popoli. Proprio la diversa collocazione temporale dell’avvenimento rispetto al testo di Mercier, rende meno plausibile il tripudio del Vecchio Mondo di fronte alla rivolta degli schiavi, ritrascritto quasi testualmente, in quanto l’evento, che costerà molto sangue agli Europei, è un pericolo che incombe sul futuro e non un lontano fatto del passato. La partecipazione gioiosa del Vecchio Mondo risulta perciò assai meno credibile: « L’ancien monde joindra ses applaudissemens au nouveau. Partout on bénira le nom du héros qui aura rétabli les droits de l’espèce humaine, par-tout on érigera des trophées à sa gloire » (12). La credibilità del testo è ulteriormente compromessa dal fatto che il discorso continua, nell’Histoire philosophique, ventilando la minaccia di un Code blanc che potrebbe sostituirsi al Code noir, insistendo così su di un semplice rovesciamento della sopraffazione quale frutto immediato della rivolta, e non su quell’armonia, realizzabile ovviamente a più lunga scadenza, su cui aveva invece posto l’accento Mercier. L’azione dell’eroe nero viene così ridimensionata da Diderot (anche se nella sua « riscrittura » si continuerà a parlare di un ristabilimento di valori per l’intera specie umana) ad un atto di giustizia che riscatta unicamente la razza negra e concerne l’intera umanità soltanto nella misura in cui ogni atto di giustizia la concerne. L’azione dell’eroe perde dunque, nel testo di Diderot, quella portata universalistica e quel carattere di evento liberatore assoluto senza alternativa possibile, che gli aveva attribuito Mercier. Il passo dell’An 2440 non lascia dubbi sul significato che Mercier attribuisce alla rivolta, come solo strumento di liberazione del popolo negro e dell’intera umanità dalla piaga della schiavitù e della sopraffazione. Se ha anche funzionato come spauracchio per accelerare la ricerca di altre possibili soluzioni, meno radicali, ciò è accaduto indipendentemente dal suo vero significato. Il testo di Diderot diventa invece meno chiaramente leggibile. Si è detto che fin dalla prima edizione serpeggia nell’Histoire philosophique la minaccia della rivolta, ma si è anche detto che vi sono altrettante pagine capaci di neutralizzarla o, quanto meno, di smorzarne le veementi note. Il contesto generale condiziona dunque inevitabilmente anche il testo di Mercier venuto a far parte di questo nuovo corpo. E non solo il contesto generale, ma anche quello specifico. Il passo viene infatti inserito 249 dopo l’invito alla Chiesa a ritornare sulle sue posizioni ed a rifiutare la connivenza con la schiavitù e dopo l’invocazione ai sovrani affinché sanino questo male di cui sono responsabili. Proprio questa invocazione è formulata in termini che non sembrerebbero ammettere alternativa possibile alla soluzione del problema: « Pour renverser l’édifice de l’esclavage, étayé par des passions si universelles, par des loix si authentiques, par la rivalité de nations si puissantes, par des préjugés plus puissans encore, à quel tribunal porterons-nous la cause de l’humanité, que tant d’hommes trahissent de concert? Rois de la terre, vous seuls pouvez faire cette révolution » (Ib., p. 219). Abbiamo l’impressione che questa sia la vera soluzione a cui tende e nella quale crede l’équipe dell’Histoire philosophique. Con questo non si vuol dire che il resto sia vuota retorica, ma piuttosto uno dei tanti strumenti dialettici impiegati per agire sulle coscienze in Francia e nelle colonie. Tuttavia (ed ecco perché si diceva che il brano non è chiaramente leggibile), liquidare il passo mutuato da Mercier con l’etichetta di « oggetto strumentale » impiegato a fini diversi, non però opposti, da quelli in esso prospettati, non è del tutto corretto. Se è vero infatti che il contesto condiziona il brano nel senso or ora indicato, è pur vero anche che Diderot, sulla scia di Mercier, si è abbandonato ad uno slancio di entusiastica solidarietà con coloro che si ribellano al giogo, per cui se per un verso la minaccia della rivolta è certamente usata come spauracchio in funzione di altre soluzioni, per altro verso è certo che Diderot quell’eroe che spezza le sue catene lo ama e non può far a meno di sentire la sua venuta come il momento tanto atteso della rinascita di un popolo. Con quest’immagine si concludono i paragrafi del libro undicesimo dedicato alla tratta e alla schiavitù. Quali che siano i modi privilegiati per la sua abolizione, è certo che sulla necessità di porre fine a questa piaga, che corrompe le colonie e la madrepatria, non vi sono dubbi ed esitazioni. Anzi, l’opera si conclude con una condanna di dimensioni ben più ampie, che coinvolge non soltanto la schiavitù negra, ma l’intera colonizzazione europea in quanto violazione dei diritti di tanti popoli: « On a parcouru et l’on continue de parcourir tous les climats vers l’un ou vers l’autre pôle, pour y trouver quelques continens à envahir, quelques isles à ravager, quelques peuples à dépouiller, à subjuguer, à massacrer. Celui qui éteindroit cette fureur ne mériteroit-il pas d’être compté parmi les bienfaiteurs du 250 genre humain? » ( l. 19, vol. X, pp. 465-466). Il processo, apertosi fin dalle prime pagine dell’opera si è concluso: attraverso incertezze, ambiguità, ardimentose requisitorie e timide giustificazioni, si è giunti, pur con attenuanti, non solo alla condanna della tratta e della schiavitù, ma dell’intera colonizzazione europea in quanto violazione di quell’eguaglianza di diritti fra tutti gli uomini, di cui si ribadisce il valore assoluto a conclusione della lunga e tortuosa ricerca della verità: « La voix de mon cœur s’est élevée en faveur de tous les hommes, sans distinction de secte ni de contrée. Ils ont été tous égaux à mes yeux, par le rapport des mêmes besoins et des mêmes misères, comme ils le sont aux yeux de l’Etre suprême par le rapport de leur foiblesse à sa puissance » (Ib., pp. 477-78). Questa lunga ricerca attraverso tante vicende, tanti avvenimenti di secoli, ma anche tanta sofferenza si conclude con unn invito alla fratellanza, che è negazione di ogni forma di sfruttamento reciproco. Se la posizione dell’Histoire philosophique è, al di là dei suoi aspetti ambivalenti dovuti certamente in gran parte anche al concorso di più mani, e fin dalla prima edizione del 1770, tanto chiaramente antischiavista, non possiamo non chiederci, conoscendo i legami di Raynal con l’amministrazione coloniale, come mai un’opera voluta o caldeggiata dal governo abbia potuto, non dico ospitare attacchi alla schiavitù, ma essere una « macchina da guerra » contro la schiavitù. Si potrebbe supporre che fin dagli inizi l’opera sia sfuggita di mano ai committenti ed allo stesso Raynal, ma sappiamo che Raynal ha continuato a godere della sua pensione per anni, che l’ascesa dell’opera non è stata troppo ostacolata e che Diderot si stupiva delle audacie che poteva permettersi scrivendo per l’Histoire philosophique, audacie che Raynal non frenava, ma sollecitava, o perlomeno accettava. Dobbiamo dunque concludere, sempre in attesa di una migliore conoscenza della politica coloniale di quegli anni, che le posizioni ed i toni audaci dell’Histoire philosophique, come si è detto a proposito di Poivre, convenivano agli amministratori coloniali, proprio in vista di spezzare il conservatorismo dei coloni che si opponevano ad ogni mutamento nella conduzione dei lavori coloniali, anche se questo fosse andato a loro vantaggio. Incapaci di vedere al di là del loro interesse immediato, pur sentendo il pericolo di possibili rivolte dei negri, i coloni credevano di poterle 251 scongiurare raddoppiando la vigilanza e la severità, senza rendersi conto che proprio questi provvedimenti erano degli inneschi pericolosi per la rivolta. Le maniere forti potevano, come già si è detto, aiutarli a smuoversi dalle loro posizioni. Questo può forse spiegare l’appoggio dato ad un’opera come l’Histoire philosophique. In quest’epoca dunque gli abolizionisti si sarebbero trovati a fare il gioco del potere che non traeva più il suo tornaconto da colonie lavorate da schiavi, sulla cui importazione doveva pagare un « prix » anche abbastanza elevato, di cui beneficiavano unicamente i grossi commercianti e gli armatori, talvolta anche stranieri, che facevano il commercio di negri dietro il paravento di prestanome francesi. L’influenza dell’Histoire philosophique sul pensiero abolizionista nel decennio che vede le sue numerose edizioni (1770, 1774, 1780) rivedute ed aumentate ed anche in quello successivo, fino alla Rivoluzione ed all’abolizione della schiavitù, è notevole. L’autore che denuncia questa influenza in maniera più esplicita, a parole, ma anche attraverso il tipo di argomentazione che adotta nella sua opera, è Doigny de Ponceau, di cui già si è parlato nel capitolo dedicato ai critici di Montesquieu. Nell’introduzione al suo Discours d’un nègre à un européen, presentato per il Prix de l’Académie française del 1775, egli dichiara a gran voce la sua ammirazione per Raynal ed il debito che ha nei suoi confronti: « ... j’ai vingt fois arrosé de mes larmes le Plaidoyer attendrissant, où l’HistorienPhilosophe venge l’humanité avec tant de courage; qu’il me pardonne de m’être enrichi de ses idées: ses sentimens étoient dans mon cœur » (13). Nella stessa introduzione, Doigny esprime un’eguale ammirazione per la sua epoca, in cui l’uomo, « grâce aux lumières », ha lasciato dietro di sé quei tempi infelici in cui la « science des dévoirs de l’homme » era relegata nelle scuole, ed insiste sulla necessità che il ruolo della poesia muti per aderire maggiormente alla realtà: « Elle a parlé jusqu’à présent le langage des Dieux; il est temps qu’elle parle le langage des Hommes » (Ib., p. V). Fedele a questa premessa, si può dire che il Discours sia una trasposizione poetica dei passi più ispirati dell’Histoire philosophique (all’epoca del concorso accademico era già uscita la seconda edizione del 1774 e sarebbe interessante anche ricercare in che misura l’opera di Raynal può aver contribuito alla scelta 252 dell’argomento per il concorso stesso). Il lungo poema di Doigny non è però un prodotto dozzinale, e non stupisce che l’Accademia ne abbia fatto, come leggiamo nella prefazione, « une mention honorable ». È animato da un’indignazione così sincera di fronte al comportamento dell’Europeo, che riesce immediatamente a trovare il tono contagioso capace di trasmettere intatta questa sua indignazione. Certo, non è un capolavoro poetico in assoluto, ma nell’ambito limitato della poesia ideologica ed in particolare di quella che si occupa della schiavitù, è certamente una delle cose migliori che siano state scritte. Il messaggio è trasmesso con forza, la ricostruzione degli avvenimenti, pur se enfatizzata (è la storia vista dalla parte del negro), è attendibile. È insomma un buon lavoro di divulgazione, con in più una carica emotiva che lo riscatta dalla piatta rielaborazione di idee altrui. Dopo aver proclamato non soltanto il suo diritto alla libertà, ma anche l’impossibilità da parte del padrone di sottrargliela (« dans tes fers, de moi seul tu me verras dépendre », p. 7), il negro di Doigny condanna la ferocia del bianco assetato di sangue e le leggi mistificatorie con cui ha cercato di giustificare e mascherare questa sua violenza. Dopo aver condannato le leggi del bianco, che sanzionano la violazione dei diritti fondamentali dell’uomo, egli si scaglia contro la religione che ha permesso questo sopruso: « Si ce Dieu, quel qu’il soit, qui voit ton brigandage, Reçoit à ses autels tes vœux et ton hommage, Je ne le connois point à ces horribles traits. Ton Dieu!... c’est ton complice, il permet tes forfaits » (p. 9). Alla descrizione della brutalità che ha caratterizzato il rapporto dell’Europeo con gli altri popoli (come era già accaduto in Ziméo, più volte il bianco viene accusato di essere un tigre, e che ha trovato connivenza a tutti i livelli, espressa con l’approvazione esplicita o con l’acquiescenza silenziosa, il negro fa seguire la sua sfida. La minaccia di una reazione che si fondi sugli stessi princìpi disumani adottati dal bianco nei suoi confronti è virulenta e travolgente: « J’ai droit de tout oser et de tout entreprendre, Je veux jusqu’en ton cœur chercher la liberté, Dans ton sang répandu tarir ma cruauté. Je le veux; j’armerai contre la tyrannie 253 La sourde trahison, l’infame perfidie. Oui je m’affranchirai, malgré tous tes efforts, De ce joug que je traîne et du frein que je mords » (p. 10). Ma anche in questo caso, la soluzione prospettata non è quella da cui si crede debba veramente giungere la fine della schiavitù coloniale. Si mettono in bocca al negro parole di ribellione, ancora a parole si mettono a ferro e fuoco le colonie, si distrugge, si avvelena, si evocano scene da fine del mondo, per concludere: « Faut-il donc n’exhaler que les vœux de la haine? C’est à l’humanité de briser notre chaîne » (p. 14) (14). E per giustificare la percorribilità della via umanitaria all’abolizione della schiavitù si porta l’esempio dei Quaccheri, che già l’hanno percorsa con successo, non sopportando di sentirsi liberi, vedendosi circondati da schiavi. Dunque, coerente con le posizioni dell’Histoire philosophique, anche Doigny, pur riconoscendo la giustizia di una rivolta negra, è convinto che la soluzione non possa essere che nelle mani del bianco, ed usa perciò la rivolta come strumento retorico di persuasione. Doigny, anche in questo legato a una moda del suo tempo, si serve del suo negro, uomo della natura che viveva nella sua terra d’Africa una vita innocente ed heureuse, per criticare la vita civile, percorsa da miasmi impuri con i quali l’Europeo contamina tutto ciò con cui entra in contatto: « Ah! ne vantez plus vos orgueilleuses villes, De la corruption contagieux asiles, Prisons, où pour ramper on cherche à s’enfermer (...) » (p. 13). Per questo anche per Doigny, come già per Mercier, l’avvenire non è dei popoli bianchi ma dei negri, con la sola differenza che, mentre Mercier prospettava un futuro di armonia a cui avrebbero dato vita i popoli oppressi, insieme agli oppressori, Doigny parla di un puro e semplice rovesciamento di posizioni, senza alcun mutamento qualitativo: « Et par la liberté l’Afrique couronnée, A vous assujettir à son tour destinée (...) » (p. 14). Ma tutto ciò ha un sapore mitico, l’unica cosa concreta – relativamente concreta – su cui si possa far leva per il momento, con abili operazioni dialettiche a cui il brivido 254 della distruzione dà mordente, è il senso umanitario dei bianchi che detengono il potere e possono convincersi ad usarlo in maniera diversa, per il bene dell’umanità e per il loro personale tornaconto. L’immagine della distruzione delle situazioni aberranti create dai bianchi fuori dei confini d’Europa, sia essa il risultato delle rivolte degli oppressi o un giusto castigo inviato dal cielo per cancellare dalla terra una piaga immonda, ritorna sempre più di frequente negli scritti di questi anni. Nei Mois di Roucher, su indubbia imitazione delle Saisons di Saint-Lambert, che hanno introdotto in Francia la moda di interventi antischiavisti nella poesia didascalica, leggiamo: « Eh bien! qu’un Dieu vengeur des enfans de l’Afrique, Et du sang, dont le glaive inonda l’Amérique; Qu’un Dieu dans ces climats vous poursuive; et sur vous, Des vents, des feux, des eaux déchaîne le courroux; Que sous vos pas, la terre ébranlée, entrouverte S’abyme dans la mer de vos débris couverte; Et que votre supplice épouvante à jamais L’avare imitateur de vos lâches forfaits! » (15). Questa rivoluzione cosmica, assai più improbabile di una rivolta degli schiavi, assolve però come quella, e forse più di quella, una funzione insostituibile per la trasformazione delle coscienze. L’immagine della distruzione, soprattutto attraverso fenomeni naturalistici anomali di proporzioni straordinarie, è da sempre stata legata nella coscienza cristiana all’idea di colpe così orribili o di proporzioni così vaste da non lasciare più alcuno spazio_ ad una catarsi che non nasca appunto dalla distruzione totale. L’idea di un cataclisma riparatore rende dunque bene ad un tempo la gravità delle colpe europee ed il prezzo che si deve pagare per il loro riscatto. E questa idea si farà sempre più frequente negli scritti degli anni che precedono e in qualche modo preannunciano la Rivoluzione. Il testo di Roucher è accompagnato da lunghe, minuziose e documentatissime note di Garat (16), in cui si fa una sintesi di fatti e problemi concernenti la schiavitù coloniale e in cui si affianca all’idea della distruzione voluta da Dio, di cui parla Roucher, quella di una scossa che viene dal basso, per cui si ha l’impressione che nell’opera il colono bianco si trovi ormai fra l’incudine ed il martello: « Eh bien! Que l’Esclave soulève sa chaîne, qu’il en frappe son Maître; et le meurtre qu’il a commis lui rend à l’instant tous ses droits. Le droit passe, avec la force, du Maître à l’Esclave. Celui-ci devient homme en devenant assassin (...) il 255 faut prendre des poignards et faire taire les loix » (Ib., p. 130). Il linguaggio e i toni della lotta abolizionista stanno davvero cambiando: i dibattiti di carattere giuridico sulla schiavitù, se non sono completamente abbandonati, hanno però ormai già fatto il loro tempo ed è chiaro per tutti, in ogni caso, che essi hanno ben poco a che vedere con la schiavitù dei popoli africani, comprati con il denaro dei ricchi commercianti europei, violentati, deturpati, animalizzati, reificati, in dispregio di qualsiasi legge possa aver regolato, nel corso dei tempi, un istituto di per sé già spregevole come la schiavitù. Nello stesso anno 1779 anche Lemierre nel canto XIII dei suoi Fastes, anch’esso corredato di note (non così importanti come quelle di Garat), affronta il tema d’obbligo del genocidio degli Americani e della schiavitù negra. Dopo aver condannato la violenza perpetrata dagli Europei su uomini pacifici, la connivenza della Chiesa che ha permesso un commercio così aberrante e la menzogna che si nasconde dietro gli scritti dei « saggi » d’Europa che pretendono di aspirare al bene dell’umanità, Lemierre gioca anche lui la carta della rivolta, che ha presa a prestito da Doigny o, come Doigny e forse lo stesso Garat, dall’Histoire philosophique: « Poursuivez, mais craignez que peut-être bientôt L’homme dans l’Africain ne s’éveille en sursaut; Du nombre à tout moment l’avantage lui reste, A tout moment sur vous pend ce glaive funeste; Tremblez qu’il ne s’éleve un nouveau Spartacus, La nature et l’instinct ne sont jamais vaincus » (17). Anche qui però, come nel testo di Doigny de Ponceau, segue il riferimento d’obbligo all’esempio dei Quaccheri, per indicare l’unica via realmente percorribile in vista della liberazione degli schiavi: « Puisse l’Européen briser par-tout les fers Qu’il donne à son semblable en un autre univers » (Ib., p. 238). Nelle scarne note che seguono, Lemierre insiste in particolare sulle pessime condizioni di vita degli schiavi nella colonia di San Domingo. Il riferimento a Spartaco nei versi sopra citati indica la filiazione dall’Histoire philosophique, dove, nelle edizioni precedenti a quella del 1780, si faceva riferimento al famoso schiavo romano che aveva capeggiato una rivolta servile nel ‘73 avanti Cristo. Ed è proprio allo Spartaco dell’Histoire philosophique che si richiamerà, di lì a qualche anno, 256 l’eroe della rivolta negra di San Domingo, Toussaint Louverture (18). Nel 1781, un altro poema didascalico, la Navigation, dovuto alla penna di un non meglio identificato Grée (almeno questo è il nome con cui è firmata una dedica agli ufficiali della Marina), riprende l’argomento in maniera abbastanza pedissequa, soprattutto sulla scia di Lemierre. Anche in questo caso, seguendo un cliché divenuto ormai fisso, il testo è accompagnato da note in cui l’autore enumera le colpe degli Europei nei confronti dei popoli africani, ai quali non hanno portato la civiltà ma « une liqueur perfide » che ha stravolto la loro vita, spingendoli persino al commercio vergognoso dei loro simili e di se stessi, commercio di cui « tout l’opprobre retombe sur l’acheteur ». Contesta Grozio e Pufendorf con l’appoggio di Montesquieu, inorridisce di fronte a tanti crimini dei coloni bianchi rimasti impuniti e allude anch’egli alla rivolta, ma nei termini di un pericolo da evitare: « N’est-il pas à craindre que ces esclaves ne secouent un jour leurs chaînes, dont le poids seul suffiroit pour écraser les corps efféminés de leurs tyrans? » (19). Questo per quanto concerne le note. Nel poema l’autore finge che Colombo, come in un brutto sogno, venga reso edotto dal dio Oceano delle conseguenze funeste del suo viaggio, fra cui la strage degli indigeni americani, la tratta e la schiavitù negra. La condanna della tratta e della schiavitù è tradotta in formule poetiche che ricordano molto da vicino il testo di Lemierre, per questo forse il richiamo alla rivolta, diversamente dalle note che accompagnano il testo e ne danno la giusta chiave interpretativa, è presentato nei termini ormai abituali di un giusto evento liberatore, di cui si sottolinea però ancora una volta la pericolosità per i bianchi: « Mais enfin, je le vois ce jour où la Nature, De ses fils opprimés viendra venger l’injure; La raison en leur cœur, après un long sommeil, Fera parler ses droits... qu’on craigne son réveil » (Ib., p. 48) (20). Quali che siano i termini usati e gli intenti perseguiti dagli scrittori abolizionisti parlando di rivolta (e forse dal Governo lasciandone abbondantemente parlare), vi è il dato di fatto incontrovertibile che se ne parla davvero molto. E del resto se ne parla molto anche nelle colonie, dove ogni tanto, ed a distanze sempre più ravvicinate nel tempo, se ne vedono anche dei rudimentali saggi pratici messi in atto dagli schiavi. Il processo all’Europa va assumendo toni violenti e minacciosi; pur facendo la debita parte alla retorica ed all’enfasi che caratterizzano in particolare le opere 257 poetiche minori, ma anche tutti gli altri scritti letterari a contenuto ideologicoumanitario, non si può non cogliere un’ondata di indignazione che coinvolge settori di pubblico fino a questo momento assolutamente estranei al dibattito. Gli epiteti di cui vengono gratificati gli Europei a proposito del loro comportamento nei confronti degli indigeni americani e dei popoli africani sono ormai quelli usati contro gli imputati in un processo: sono definiti tiranni, ma più comunemente assassini, ladri, carnefici, corruttori. La critica ha ormai imboccato una strada senza ritorno. Note (1) Sui problemi concernenti le varie edizioni dell’opera, non ancora del tutto elucidati, cfr. A. Feugère, Un précurseur de la Révolution. L’abbé Raynal (1713-1796). Documents inédits, Parigi, 1922; L’abbé Raynal. Bibliographie critique, Angoulême, 1922 (ristampa Slatkine 1970); H. Wolpe, Raynal et sa machine de guerre. L’Histoire des Deux Indes et ses perfectionnements, Parigi, 1956. (2) M. Duchet, Diderot et l’Histoire des Deux Indes ou l’écriture fragmentaire, Parigi, 1978, p. 10. Sulla fortuna di Raynal in Svezia cfr. C. Rosso, La Francia nel Nord: le «lumières» in Svezia al tempo della libertà (1718-1772), in Illuminismo, felicità, dolore, cit., pp. 151-200, p. 151 e passim. (3) Oltre ai testi su Raynal già citati, in particolare per quanto concerne i collaboratori, possiamo ricordare : H. Dieckmann, Les contributions de Diderot à la « Correspondance littéraire » , et à l’Histoire des deux Indes, « Revue d’histoire littéraire de la France » (« R.H.L.F. »), ott. - dic. 1951, pp. 417-440; M. Duchet, Diderot collaborateur de Raynal: à propos des « Fragments imprimés » du Fonds Vandeul, « R.H.L.F. », 1960, pp. 531-556; Le supplément au voyage de Bougainville et la collaboration de Diderot à l’« Histoire des Deux Indes », « Cahiers de l’Association internationale d’études françaises », 1961, pp. 173-187; Bougainville, Raynal, Diderot et les sauvages du Canada, « R.H. L.F. », aprile-giugno 1963, pp. 228-236. C. P. Courteney, A. L. de Jussieu collaborateur de l’abbé Raynal. Documents inédits, « R.H.L.F. », aprile-giugno 1963, pp. 417-440; D. Brahimi, Un informateur de l’abbé Raynal. L’abbé Poiret, auteur du « Voyage en Barbarie », « Dix-huitième siècle », 1972, n. 4, pp. 237-253. Sul contributo di Diderot all’opera di Raynal cfr. ora anche l’edizione dei Mélanges et morceaux divers, II. Contributions à l’Histoire des deux Indes, a cura di G. Goggi, Siena, 1977 (Collana di studi sull’Illuminismo diretta da E. de Angelis). (4) Quando parliamo di Diderot significa che il passo è già stato riconosciuto come suo dagli studiosi sopra citati. Importante per la collaborazione di Diderot all’Histoire philosophique, nell’ottica che ci concerne, è il lavoro di Y. Benot, Diderot, de l’athéisme à l’anticolonialisme, Parigi, 1970. Sul problema della colonizzazione americana cfr. C. Borghero, Raynal, Paine e la rivoluzione americana, in La politica della ragione, a cura di P. Casini, cit., pp. 349-381 (corredato di bibliografia aggiornata). (5) Citiamo l’opera dall’edizione del 1780 di Ginevra in 10 volumi, più atlante, I, p. 2. Quando la citazione è tratta da edizioni precedenti lo specificheremo in nota. 258 (6) Anche Marmontel condanna in quegli anni, con parole ancor più violente, il diritto che si sono arrogati i papi di spartire il mondo come se questo appartenesse loro: « Un pontife a partagé l’Inde! Mais l’Inde est-elle a lui? mais avoit-il lui-même le droit qu’on s’arroge en son nom? Il a pu confier ce monde à qui prendroit soin de l’instruire, mais non pas le livrer en proie à qui voudroit le ravager» (Les Incas, cit., I, p. 45). Anche nella prefazione Marmontel attacca la bolla con cui, nel 1493, Alessandro VI aveva diviso il mondo fra Spagnoli e Portoghesi. (7) Histoire philosophique, ed. di Amsterdam, 1770, 6 voll., IV, p. 120. E del resto le prevenzioni nei confronti della razza negra restano forti anche ben oltre questa data, e presso uomini che non sono implicati nello sfruttamento coloniale. Ad esempio, il marchese di Chastellux, nella relazione di un viaggio fatto nell’America settentrionale, pur essendo sensibile alla sofferenza degli schiavi e contrario alla schiavitù, li considera senza ombra di dubbio di una razza inferiore; parla di «insensibilité naturelle» e dice esplicitamente: « ... plus on observe les nègres, plus on se persuade que la différence qui les distingue de nous, ne consiste pas seulement dans la couleur » (Voyages de M. le Marquis de Chastellux dans l’Amérique septentrionale. Dans les années 1780, 1781 et 1782, Parigi, 1786, 2 voll., II, p. 146). (8) Sull’argomento egli torna più di una volta e con uguale veemenza: « Vous frémissez... Eh! s’il existoit une religion qui tolérât, qui autorisât, ne fût-ce que par son silence de pareilles horreurs; si occupée de questions oiseuses ou séditieuses, elle ne tonnoit pas sans cesse contre les auteurs ou les instrumens de cette tyrannie; si elle faisoit un crime à l’esclave de briser ses fers, si elle souffroit dans son sein le juge qui condamne le fugitif à la mort: si cette religion existoit, n’en faudroit-il pas étouffer les ministres sous les débris de leurs autels? » (1. XI, vol. VI, p. 203). (9) L’An deux mille quatre cent quarante. Rêve s’il en fut jamais, ed. a cura di R. Trousson, Bordeaux, 1971, pp. 205-206. Il testo di Mercier non è soltanto stato «riscritto» da Diderot per l’Histoire philosophique: ne ritroviamo echi anche in altre opere. Naturalmente è difficile dire per le opere posteriori se la fonte sia Mercier o Raynal. In ogni caso, in un romanzetto anonimo del 1792, Aza, ou le nègre, leggiamo: « ... ils dorment dans la poussière des tombeaux, en attendant le jour de la vengeance; mais aux accens de ta voix, ils se réveilleront, et leurs ossemens desséchés tressailleront encore sous la terre brûlante qui les couvre » (p. 11). (10) Su di una catarsi possibile soltanto attraverso la sperimentazione della sofferenza che si è imposta agli altri cfr. il nostro saggio, già citato, sull’Ile des esclaves di Marivaux. (11) La definizione è di Benot, op. cit., p. 214 (1781 : Diderot « rewrite » Mercier). (12) Histoire philosophique, l. 11, vol. VI, p. 221. (13) Parigi, 1775, p. V. Anche Pigault-Lebrun apre la prefazione del suo dramma, Le blanc et le noir (« Représenté et tombé sur le Théâtre de la Cité le 14 Brumaire de l’an IV» e stampato a Parigi lo stesso anno), con l’affermazione« J’ai lu Raynal, et j’ai fait cet ouvrage ». Inoltre il dramma porta in esergo la seguente frase, tratta dall’Histoire philosophique: « Quiconque s’efforce de justifier le système de l’esclavage, mérite du philosophe un profond mépris, et du nègre un coup de poignard ». (L’esergo porta l’indicazione « tome IV, page 225 »). (14) Anche in un altro poema presentato al concorso accademico, L’esclavage des Américains et des Nègres di Claude-Louis-Michel de Sacy (Parigi, 1775, EDHIS, 1, 2), si fa balenare la minaccia della rivolta, per poi concludere: 259 « O toi! jeune LOUIS, dont la paisible aurore Promet des jours sereins au François qui t’adore, Tu dois un grand exemple à cent Peuples divers. Fais respecter nos lois dans un autre Univers Leur sublime équité n’admet point l’esclavage. Brise, brise les fers du Nègre et du Sauvage; Que ces infortunés soient libres à jamais, Et retiens-les Captifs à force de bienfaits» (pp. 11-12). (15) Roucher, Les mois, Parigi, 1779, canto II, p. 91. (16) Garat continua la battaglia per la causa negra anche in periodo rivoluzionario, cfr. Anna J. Cooper, L’attitude de la France à l’égard de l’esclavage pendant la Révolution, Thèse pour le Doctorat d’Université, Parigi, 1925, p. 37 e passim. (17) Lemierre, Les fastes, Parigi, 1779, canto XIII, pp. 237-238. (18) Sul mito ‘spartakista’ in questi anni cfr. R. Mortier, Diderot anticolonialiste, «Revue belge de Philologie et d’Histoire», t. XLIX, 1971, n. 3, 892-901 (Il saggio è una recensione, o meglio, molto di più di una recensione, del libro di Benot). Mortier ha giustamente rilevato l’esistenzaa di questo mito, liquidandolo forse un po’ duramente, per il suo carattere di vuoto verbalismo: «Il semble qu’il y ait eu, entre 1770 et 1780, une sorte de mythe ‘spartakiste’ dans la gauche intellectuelle française (...). Mais en 1793-1794, ce sera l’abbé Grégoire qui se dépensera pour obtenir la suppression de la traite et l’abolition de l’esclavage. On mesure là l’écart entre la parole et l’action» (p. 898). (19) La navigation, poëme en quatre chants, Parigi, 1781, II, note, p. 71. (20) Ben diverso sarà il quadro della rivolta negra tracciato da Delille nella Pitié, quando questa rivolta non era più un mito letterario, ma un episodio storico: « O champs de Saint-Domingue! o scènes exécrables! Ah! fuyez, sauvez-vous, familles déplorables; Les tigres sont lancés; du soleil africain Tous les feux à-la-fois bouillonnent dans leur sein. Pour vous leur art cruel raffina les souffrances; Robespierre lui-même envîroit leurs vengeances. Là, des enfans portés sur la pointe des dards De leurs noirs bataillons forment les étendards; Ici, tombe le fils égorgé sur son père, Le frère sur la sœur la fille sur la mère ». (La Pitié, Parigi, 1803, seconda edizione, pp. 21-22). Le note, se ce ne fosse bisogno, ci danno la giusta chiave di lettura del poema di questo tenero cantore di jardins: « Ces nègres, inutiles dans leur pays, devinrent un fond de richesse inestimable dans les colonies (...). Il suffira de donner ici quelques notions sur le commerce des nègres en Afrique, pour faire voir que ces hommes, dont on a tant déploré le sort, sont beaucoup plus heureux dans les colonies que dans leur propre patrie» (note, p. 10). Su Delille cfr. Delille est-il mort? ouvrage collectif, Clermont-Ferrand, 1970; E. Guitton, Jacques Delille (1738-1813) et le poème de la nature en France de 1750 à 1820, Parigi, 1974. 260 ALLA VIGILIA DELLA RIVOLUZIONE Negli anni che seguono, fino alla Rivoluzione, alla rivolta negra di San Domingo (1791) ed all’abolizione della schiavitù, proclamata nel febbraio 1794, il contenuto ed il tono degli scritti abolizionisti non subiscono più trasformazioni sensibili. Certe note si fanno a volte più aspre, ma sono sempre corrette da un’estrema moderazione nel suggerire gli interventi pratici. Cambiano invece le dimensioni del fenomeno, fino a farsi coro, ed il metodo di lotta: soprattutto dopo la creazione della Société des Amis des Noirs, si cominciano a programmare le ricerche ed i settori di intervento. Più che sui commenti teorici, si comincia a far leva sulla materia incandescente di una documentazione minuziosa degli orrori su cui la schiavitù negra è nata e si regge. Spaventosi « oggetti di tratta » che corredano le navi negriere e che servono, con tutti i mezzi, a domare la nera « bestia indomita », vengono minuziosamente descritti e riprodotti, costringendo il lettore europeo a guardare quell’arsenale sadico, di fronte al quale ha sempre chiuso gli occhi o di cui, in buona fede, ignorava l’esistenza. Spaccati di navi negriere, dove poveri esseri strappati alla loro terra vivono incatenati, avvoltolati nei loro escrementi, in un’atmosfera ammorbata ed in uno spazio impossibile, vengono sottoposti al giudizio imparziale di uomini che si dicono civili (1). Si pubblicano anche i risultati di indagini condotte direttamente nelle colonie, dalle quali occhi non immunizzati dall’interesse e dalla consuetudine con spettacoli così tremendi, riportano immagini orride, capaci di sconvolgere la buona coscienza ed il quieto vivere degli Europei, che non possono più far finta di non sapere o di non essere parte in causa. Ad un certo punto, a forza di accumulare uno sull’altro i capi d’accusa contro l’Europa, i termini del processo sono chiari: se la sentenza si fa attendere è soltanto perché i giudici sono anche parte in causa e, soprattutto, perché tutti sono ormai convinti che non basti più condannare, ma che bisogni anche, nello stesso momento, suggerire precisi rimedi. Due testi ci sembrano particolarmente importanti fra quelli pubblicati in Francia alla vigilia della Rivoluzione: le Réflexions sur l’esclavage des nègres, pubblicate una 261 prima volta da Condorcet nel 1781 e ristampate, riviste e corrette, nel 1788 (in entrambi i casi sotto lo pseudonimo di Schwartz, pasteur du Saint Evangile à Bienne) e le Réflexions sur la traite et l’esclavage des nègres di Ottobah Cugoano, tradotte dall’inglese nel 1788. L’importanza di queste ultime viene dal fatto che sono scritte da un ex-schiavo, che vive libero a Londra al momento della composizione dell’opera. La loro traduzione porta perciò per la prima volta in Francia (2) la voce di coloro a cui era stata per lunghi anni tolta la parola, in seguito all’espropriazione di ogni forma di linguaggio (3). L’opera di Condorcet è il primo importante, specifico, articolato saggio scritto in Francia contro la schiavitù negra. Ad un linguaggio molto tagliente nei confronti dei coloni e di tutti coloro che sono coinvolti nei traffici che portano alla schiavitù dei negri (un’indagine statistica rivelerebbe forse che i termini più frequentemente ricorrenti nel testo sono: crime, vol, brigands, voleurs, ecc.), fa da contrappeso uno sforzo di obiettività nell’indagine della situazione coloniale ed una grande cautela nel prevedere gli interventi dello Stato. Cautela, come dice l’autore stesso, dettata non tanto dall’esigenza di salvaguardare i coloni, anche se questo aspetto del problema non è da sottovalutare, ma dalla necessità che la trasformazione possa avvenire senza traumi e senza rendere ancor più drammatica la situazione degli schiavi che, in assenza di strutture alternative, correrebbero il rischio di restare senza tetto e senza sussistenza. Tutta la prima parte del saggio, dedicata, sulla scia di Montesquieu, a dibattere i problemi legali concernenti la schiavitù in genere, e quella negra in particolare, è molto dura nei confronti degli Europei che hanno provocato in America ed in Africa guasti irreparabili: il genocidio di un popolo e lo stravolgimento dei sistemi di vita di un altro. Senza contare la corruzione dei costumi, sia dei coloni che degli schiavi, resi inadatti al pieno uso delle loro facoltà di uomini: « … si, par leur éducation, par l’abrutissement contracté dans l’esclavage, par la corruption des mœurs, suite nécessaire des vices et de l’exemple de leurs maîtres, les esclaves des colonies Européennes sont devenus incapables de remplir les fonctions d’hommes libres; on peut (du moins jusqu’au temps où l’usage de la liberté leur aura rendu ce que l’esclavage leur a fait perdre) les traiter comme ces hommes que le malheur ou la maladie- a privés d’une partie de leurs facultés... » (4). Il passo è importante non soltanto perché denuncia senza ombra di dubbio il carattere corruttore della schiavitù, ma anche perché ci aiuta a capire il lungo lasso di 262 tempo (settant’anni) previsto da Condorcet per la sua scomparsa definitiva nelle colonie francesi: una delle ragioni importanti che suggeriscono la cautela, è la necessità di rimettere gli schiavi negri in grado di « remplir leurs fonctions d’hommes », cosa che non può essere fatta se non in tempi sufficientemente lunghi (5). L’atteggiamento di Condorcet potrebbe risultare urtante per la lentezza dei tempi di riforma previsti e per la sfiducia che sembra mostrare nei confronti del popolo nero, ma a ben leggere il testo ci si rende conto che sarebbe un giudizio ingiusto. Innanzitutto non c’è da parte sua alcuna sfiducia nei confronti della razza nera, anzi, in più occasioni si scaglia contro ogni tipo di discriminazione: la sfiducia concerne tutti coloro che sono stati manipolati dalla distruttiva macchina della schiavitù, indipendentemente dalla loro origine o dal colore della loro pelle. Se il nero delle colonie è attualmente un « mezzo uomo », le responsabilità non sono da ricercarsi nelle sue origini africane, ma nella schiavitù e nei trattamenti inflitti dai coloni bianchi. Per quanto concerne la cautela nell’elaborazione delle fasi che devono condurre alla riparazione di quello che definisce un « crime » legalizzato, egli è il primo a dolersi di essere costretto dalla situazione ad agire con tanta lentezza: « Mais si nous les proposons, c’est en gémissant sur cette espèce de consentement forcé que nous donnons pour un temps à l’injustice, et en protestant que c’est la crainte seule de voir traiter l’affranchissement général comme un projet chimérique, par la plupart des politiques, qui nous fait consentir à proposer ces moyens » (Ib., p. 33). Condorcet si è dunque sforzato di essere obiettivo e controllato nel proporre la sua via all’abolizione, anche per evitare le accuse di astrattismo, comunemente rivolte agli abolizionisti, e per poter quindi agire sia sul terreno ideologico che su quello della realtà concreta, presentando un piano che, come ogni progetto, può essere discutibile, ma che non corre il rischia di essere definito irrealizzabile. La prima tappa del cammino verso l’abolizione della schiavitù è la proscrizione della tratta che rappresenta anche la fase più disumana di tutta l’operazione coloniale: quando i coloni si troveranno nell’impossibilità di approvigionarsi di nuovi schiavi sulle coste d’Africa, saranno costretti a migliorare le condizioni di quelli che posseggono, divenuti nel frattempo merce rara e quindi molto preziosa. Il Governo dovrà poi prevedere, nel tempo, tutta una serie di trasformazioni affinché il negro, divenuto libero, possa trovare intorno a sé strutture che gli permettano di iniziare la nuova fase della sua vita in maniera più vantaggiosa ed 263 umana di quella precedente, senza che la libertà si trasformi in un assillo per la sopravvivenza. Segue l’indicazione delle fasi e dei tempi di emancipazione, che sono assai lunghi. Quello che più stupisce è il tempo previsto per l’emancipazione dei bambini che non hanno ancora compiuto i quindici anni al momento della promulgazione della legge: devono infatti aspettare fino al trentacinquesimo anno di età per essere resi liberi, il che, considerata la lunghezza media della vita degli schiavi nelle colonie, significa per loro ottenere la libertà al momento in cui sono da « buttare ». Condorcet giustifica questa proposta, apparentemente così svantaggiosa per gli schiavi, con la necessità di evitare reazioni incontrollate da parte dei padroni che, incapaci di guardare ai loro interessi in prospettiva, potrebbero trasformare questo momento di riscatto in una nera ecatombe. Senza un cospicuo tornaconto farebbero infatti di tutto per sfiancare le madri, affinché non nascessero più bambini destinati ad essere da loro nutriti in pura perdita e, per la stessa ragione, cercherebbero di farli morire appena nati o comunque li sottoporrebbero ad angherie peggiori di quelle attuali, perché, nonostante gli eventuali controlli a cui venissero sottoposte periodicamente le piantagioni (e Condorcet ne prevede infatti uno ogni due mesi), è pura chimera il credere di riuscire ad intervenire nei rapporti tra padrone e schiavo (6). Anche perché la maggior parte dei funzionari si lascerebbero corrompere, come capita soprattutto nelle colonie dove operano, generalmente, persone che hanno già perduto ogni credibilità in Francia o sono spinte dalla sete di facili guadagni, per realizzare i quali sono pronti a tutti i compromessi. Si potrebbe ovviare, in parte, a questo inconveniente affidando il controllo a dei medici, che gli sembrano meno corrotti e meno corruttibili degli altri funzionari, ma resta pur sempre la difficoltà insormontabile di riuscire davvero a superare la barriera di quel piccolo universo concentrazionario che è la piantagione. Per questo Condorcet ritiene indispensabile che il controllo si innesti su di una serie di provvedimenti, i quali, prevedendo l’utile del padrone portato fino ai limiti di una generazione, ne arrestino la mano omicida e ne cambino a poco a poco la mentalità, familiarizzandolo con l’idea della fine di un’epoca che, forse, era stata soltanto apparentemente a suo reale vantaggio dal punto di vista degli utili (almeno negli ultimi tempi). Per quanto concerne il calcolo degli utili, Condorcet si richiama a quello fatto dai Fisiocratici sulle « Ephémérides ». In nome di quell’obiettività che caratterizza la sua posizione, egli mostra tuttavia una certa perplessità di fronte ai calcoli dei Fisiocratici: è infatti propenso a credere che il lavoro servile non sia più redditizio di quello fatto da uomini liberi, ma non è del tutto convinto che il lavoro libero venga a 264 costare la metà di quello servile, come aveva sostenuto Dupont de Nemours (7). In ogni caso, anche a parità di resa, o in nome di un lieve vantaggio economico, è criminale ed assurdo mantenere in piedi un istituto che è un’organizzazione legalizzata della violenza e del sopruso. Non crede all’umanità di cui i coloni fanno sfoggio nei loro scritti, cercando di contrabbandare come merce nobile il loro esclusivo tornaconto, anzi, inorridito, cerca di smontare il mostruoso e mistificatorio confronto che essi stabiliscono con i cavalli per dare garanzie del buon trattamento che riservano ai loro schiavi: « Tel est l’exemple qu’on propose sérieusement, pour montrer qu’un esclave sera bien traité, d’après ce principe, que l’intérêt de son maître est de le conserver! comme si l’intérêt du maître pour l’esclave, ainsi que pour le cheval, n’étoit pas d’en tirer le plus grand parti possibile, et qu’il n’y eût pas une balance à établir entre l’intérêt de conserver plus long-temps l’esclave et le cheval, et l’intérêt d’en tirer, pendant qu’ils dureront, un plus grand profit! D’ailleurs un homme n’est pas un cheval, et un homme mis au régime de captivité du cheval le plus humainement traité, seroit encore très-malheureux » (Ib., p. 68). Il solo atto di umanità credibile da parte dei coloni, anche in vista della soluzione finale, dovrebbe consistere nel fare in modo che i loro schiavi si « trasformassero in uomini », per permettere appunto di ristabilire sulle colonie, al posto degli anomali rapporti attuali, dei rapporti interumani. È il solo momento in cui, alla cruda analisi della vita coloniale, alla veemenza delle critiche ed alla cautela delle proposte, si sostituisce un’immagine luminosa anche se, di stampo paternalistico, come quelle che abbiamo già incontrate nelle opere di Pierre Poivre o di Bernardin de Saint-Pierre. Anche gli scrittori che, come Condorcet, hanno affrontato il problema della schiavitù in maniera quanto mai realistica, non resistono, nella loro generosità e nel loro desiderio di giustizia, al fascino di un sogno di rapporti armoniosi e sereni nelle colonie: « Au bruit des fouets, aux hurlemens des Nègres, succéderoient les sons doux et tendres de la flûte des bords du Niger. Au-lieu de cette crainte servile, de ce respect plus humiliant pour celui qui le reçoit, que révoltant pour ceux qui sont contraints à le rendre; au-lieu de ce spectacle de servitude, de férocité, de prostitution et de misère, que sa présence a fait disparoître, il verroit naître autour 265 de lui la simplicité grossière, mais ingénue, de la vie patriarchale; partout des familles heureuses de travailler et de se reposer ensemble, viendroient frapper ses regards attendris (...) et au-lieu d’être riche du malheur de ses esclaves, il seroit heureux de leur bonheur » (Ib., pp. 74-75). Certo, su queste basi, se davvero si potesse far conto sull’umanità dei coloni, sarebbe facile giungere al traguardo senza scosse violente, ma la cosa più sicura, anzi l’unica possibile resta sempre quella di « ménager » i loro interessi, compatibilmente però con una decisa volontà di eliminare la schiavitù e di non rinviare l’impatto con il problema. In un post-scriptum dell’edizione del 1788, attribuito all’editore, egli riporta l’eco delle posizioni assunte dagli Stati Uniti (o almeno da alcuni di essi) nei confronti della schiavitù: è infatti importante per i pensatori europei conoscere le reazioni di popoli che si sono conquistati la libertà con grandi lotte, di fronte al problema della libertà degli schiavi, cioè di quei « cittadini » americani che hanno soltanto il colore della pelle diverso dagli altri. Vi è anche l’elogio della Società filantropica che si è costituita a Londra per la proscrizione della tratta e la liberazione dei negri schiavi e della consorella Société des Amis des Noirs, fondata in Francia proprio nel 1788, dietro l’esempio e la spinta di quella inglese. Condorcet ne fu uno dei primi, influenti membri, molti dei quali erano esponenti della nobiltà, avvocati, medici e funzionari. Il post-scriptum termina con un elogio del Governo che sembra essersi fatto sensibile alle esigenze degli uomini oppressi: « ... jamais le Gouvernement n’a montré un esprit d’humanité plus éclairé, plus suivi, ni plus de respect pour les droits des classes inférieures de la société » (Ib., p. 86). Al momento in cui si riuniscono in Francia i corpi elettorali con il compito di scegliere i rapresentanti per gli Stati generali e di formulare i « cahiers de doléance », Condorcet chiede, a nome della Société des Amis des Noirs, che sia formata una commissione per elaborare e presentare le rivendicazioni degli schiavi negri, altrimenti diventa impossibile per i Francesi « oser, sans rougir, réclamer ces déclarations des droits, ces remparts inviolables de la liberté, de la sûreté des citoyens... » (8). 266 Come nel Post-scriptum egli si richiama all’esempio degli Stati Uniti, per convincere i suoi concittadini che l’acquisizione di diritti per sé, comporta anche dei doveri: « A l’instant même où l’Amérique achevait de briser ses fers, les amis généreux de la liberté sentirent qu’ils aviliraient leur cause, s’ils autorisaient, par des lois, la servitude des noirs » (Ib., p. 149). Continua enumerando le ragioni di giustizia che rendono improrogabile l’attenzione al problema da parte dei legislatori, ma anche quelle di una sana politica e di un interesse ben inteso che non si trovano in contrasto con la giustizia. In ogni caso, la prosperità dei Francesi non si può ottenere con la schiavitù e la sofferenza di quattrocentomila Africani. Come nel testo precedentemente esaminato, anche qui, alla fermezza della condanna ed all’asprezza dei giudizi espressi su chi si acquista una felicità lorda di lacrime e di sangue, fa da contrappeso un’estrema circospezione nelle richieste di intervento: « ... nous ne vous demandons point de voter la destruction actuelle de ces maux. Nous vous conjurons seulement aujourd’hui de tourner vos regards sur les souffrances de quatre cent mille hommes, livrés à l’esclavage par la trahison ou la violence, condamnés, avec leur famille, à des travaux sans espérance comme sans relâche, exposés à la rigueur arbitraire de leurs maîtres, privés de tous les droits de la nature et de la société, et réduits à la condition des animaux domestiques, puisqu’ils n’ont, comme eux, que l’intérêt pour garant de leur vie et de leur bonheur » (Ib., pp. 151-152). Condorcet conclude la sua richiesta affermando che anche molti coloni hanno dato il loro appoggio ai lavori della Société e ne hanno approvato gli scopi (9). Al momento in cui i deputati dei piantatori di San Domingo chiedono di essere ammessi all’Assemblea nazionale, Condorcet, molto duramente, pone sotto gli occhi dei suoi concittadini un brutale confronto tra la professione di fede di un deputato di una nazione libera e quella di un deputato dei coloni. Sono sei articoli sibillini messi a confronto. Citiamo il primo a titolo di esempio: 267 I II La liberté est un droit que tout homme tient de la nature, et dont la société ne peut légitimement priver à perpétuité aucun individu, s’il n’est convaincu d’un crime contre lequel cette peine ait été prononcée. La liberté n’est pas un droit que les hommes tiennent de la nature; et la société peut légitimement réduire des hommes à l’esclavage, pourvu qu’il en revienne du profit à quelques-uns de ses membres (10). Seguono parole molto dure nei confronti di coloro che si dicono i deputati di San Domingo, i quali, pur essendo stati eletti da una minoranza bianca, pretendono di rappresentare anche i mulatti ed i negri dell’isola. Pretesa scandalosa ed assurda, anche perché chiedono che il loro numero sia fissato in rapporto a tutta la popolazione di San Domingo: bianchi, mulatti, negri liberi e schiavi, mirando ad ottenere una percentuale che permetterebbe loro di schiacciare ogni iniziativa in favore degli schiavi (11). Condorcet conclude il suo intervento ricordando tutti i diritti che calpestano, proprio nel momento in cui pretendono di far valere i loro diritti: « Nous les prions, enfin, de se souvenir que la propriété d’une terre est le droit d’en recueillir les fruits, mais non celui de les multiplier à force de crimes (...); qu’ils peuvent, sans doute, parler de leurs intérêts, mais que dans leur bouche le mot sacré de droits est un outrage à la nature, et un blasphème contre la raison » (Ib., pp. 165-166). Anche nell’Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain (1793), portato a termine in un momento quanto mai difficile della sua vita, quando gli uomini della Rivoluzione lo avevano profondamente deluso, Condorcet ribadisce la necessità e la speranza che l’Europa rinunci al suo atteggiamento aggressivo nei confronti degli altri popoli, perché soltanto a queste condizioni i benefici delle scoperte, e del conseguente progresso del commercio e delle arti, andranno a vantaggio di tutta l’umanità: « ... telles ont été les conséquences heureuses de ces découvertes qui ne pourront expier ce qu’elles ont coûté à l’humanité, qu’au moment où l’Europe (...) se souviendra que les hommes de tous les climats, égaux et frères par le vœu de la nature, n’ont point été formés par l’orgueil et l’avarice de quelques nations 268 privilégiées; qu’au moment où mieux éclairée de ses véritables intérêts, elle appellera tous les peuples au partage de son indépendance, de sa liberté, de ses lumières » (12). Progresso significa dunque per Condorcet anche, e soprattutto, incontro egualitario e fraterno fra i popoli: è il senso della lotta che ha sempre combattuto con i suoi scritti ed il suo impegno personale. Tra la prima e la seconda edizione delle Réflexions sur l’esclavage des Nègres di Condorcet, appare in Francia, nel 1785, anonimo e senza luogo di edizione, lo scritto Du commerce des colonies, ses principes et ses lois (13): un testo subdolo e piuttosto repellente che, proprio a causa della sua natura e del tipo di argomentazioni esclusivamente di ordine commerciale portate in campo, ha giocato a favore della causa abolizionista un ruolo che forse l’autore non avrebbe gradito. Siccome i negri portati nelle colonie dai commercianti francesi vengono a costare più cari di quelli portati dai mercanti inglesi, egli elabora tutta una serie di argomentazioni per dimostrare che la Francia avrebbe tutto l’interesse a lasciar perdere questa branca del suo commercio. Non vuole dunque che si proscriva la tratta, ma semplicemente che i Francesi vi rinuncino. Inevitabilmente però queste argomentazioni si trasformano in un atto di accusa contro la tratta che ha, oltretutto, il merito di venire da fonte non sospetta. Estrapolati dal contesto, molti passi non sfigurerebbero nel più acceso scritto abolizionista, tanto è vero che a volte l’interesse fa trovare gli accenti appassionati degni delle migliori cause. Il passo che segue, a condanna della tratta ed in difesa della schiavitù, ci sembra abilmente congegnato per dimostrare che chi si limitasse ad avere schiavi nelle colonie, senza andarli a cercare sulle coste africane, farebbe opera assai meritoria: « Mais quand on considère de quelles iniquités les Noirs ont été les victimes avant de passer à cet état de travail, d’insouciance et de tranquillité, l’esprit se révolte et le cœur se resserre; un mouvement d’horreur s’empare de toutes les facultés de l’homme à qui l’avarice n’a pas fait perdre tout sentiment de compassion » (14). L’autore fa seguire a questa affermazione una lunga nota in cui enumera con un’acribia sconcertante in un uomo che ha visto nella condizione di schiavo soltanto «insouciance » e « tranquillité », i terribili mali della tratta, di cui è molto meglio lasciare la responsabilità ad altri: 269 « On arrache la fille des bras de sa mère, qui avale sa langue et s’étrangle de désespoir; les fils ne peuvent plus secourir la vieillesse de leur père; celle qui se croyoit au jour de son mariage, est séparée de son amant (...). Le métier de brigands a-t-il rien de plus affreux et peut-il jamais finir d’une manière plus sinistre? Et voilà la mesure des crimes que nous voulons disputer à des marchands étrangers! Ah! plutôt rejetons sur eux cet odieux Commerce, et n’achetons des esclaves que pour adoucir leur malheur » (pp. 53-54). È uno scritto veramente odioso: specula sulla sofferenza dei negri per condurre in porto un progetto commerciale che gli sembra il più conveniente per i coloni. A questo fine disgiunge nettamente la schiavitù dalla tratta, come se quest’ultima non fosse una conseguenza della prima e come se le responsabilità di tutti i mali che descrive, con tanta enfasi e così ricca tavolozza, non fossero da ricollegare alla schiavitù, e quindi ai coloni, che fanno nel suo testo la figura di dolci santi protettori. Ma il dato importante di questo testo anonimo, probabilmente fabbricato o fatto fabbricare da un colono, è che la tratta vi è presentata a tinte rivoltanti e, quale che sia il fine verso cui tende questo quadro in negativo, tutte le letture sono possibili, anzi, visto che sta soffiando vento di contestazione di certi aspetti delle imprese coloniali, una lettura in chiave antischiavista è fra le più probabili (15). Negli anni che precedono la Rivoluzione, la maggior parte degli scritti concorrono ormai ad aggravare la posizione dei coloni, mercanti di schiavi e schiavisti in genere. Persino un sostenitore della necessità di mantenere la schiavitù negra nelle colonie come Malouet, che pubblica il suo Mémoire sur l’esclavage des Nègres (1788) appunto per fronteggiare l’avanzata di quelli che egli chiama i « nouveaux Missionaires », si trova nella necessità, e non solo retorica, di iniziare il suo saggio con un riconoscimento della negatività morale della schiavitù (16). Il testo di Malouet ha fra l’altro il merito, venendo da un sostenitore della schiavitù, di offrire una testimonianza non sospetta sui progressi della lotta abolizionista in Francia. La data posta in calce all’opera è quella del 2 novembre 1788: a quella data anche la Société des Amis des Noirs aveva già avuto modo di mostrare il suo attivismo e la sua grinta. Malouet ha capito molto bene che quando la contestazione contro un’istituzione si fa coro, questa deve cambiare od è destinata a scomparire. Ed è proprio per difendere la schiavitù che egli si sforza di convincere, soprattutto i coloni, ad accettare di renderla meno dura, anche con l’aiuto di un controllo governativo. È la stessa proposta, da realizzare immediatamente, che avanzano anche gli « 270 Amis des Noirs », convinti però che nessun reale controllo sia possibile all’interno delle piantagioni, finché il negro sarà proprietà di un padrone, e che il miglioramento della condizione degli schiavi sarà possibile, sia pure in minima parte, soltanto se si proscriverà immediatamente la tratta e si prepareranno i programmi di un’abolizione da attuarsi nel giro di un certo numero di anni. Le ragioni che hanno portato alla nascita della Società sono chiaramente indicate nel preambolo che precede i Réglemens de la Société des Amis des Noirs (17): « Pour connoître les motifs de l’établissement de la Société des Amis des Noirs, il suffira de fixer un moment ses regards sur la traite des Nègres, de la suivre depuis son origine jusqu’au moment où ces malheureux gémissent dans l’esclavage » (18). Lo scopo che essa si prefigge è quello di coordinare tante forze sparse che hanno lottato e lottano contro la schiavitù coloniale, perché questo è il solo sistema che offra la possibilità: « … soit de présenter aux Gouvernemens des projets assez détaillés, assez appuyés de faits et de calculs pour mériter leur attention, soit d’éclairer les Colons sur leurs intérêts... » (Ib., p. 13). I regolamenti sono abbastanza dettagliati; si compongono di otto capitoli a loro volta suddivisi in un numero variabile di articoli: per divenire membri della società bisogna essere presentati da qualcuno che già sia membro e che farà da padrino. La lettera di presentazione deve portare anche la firma di altri quattro membri: la quota annuale di iscrizione è di due luigi per i residenti a Parigi e di ventiquattro livres per coloro che vivono in provincia o all’estero. Si tratta dunque di una società seria, cui sta a cuore non tanto il numero dei membri, quanto piuttosto la loro « qualità » e le garanzie di appoggio e di lavoro effettivo che offrono. In capo alla lista degli iscritti per l’anno 1789, stilata rispettando l’ordine di adesione alla società, c’è il nome di Brissot de Warville, che ne è uno dei fondatori e dei membri più attivi (19). Fin dal 1787 era, assieme a Clavière (il secondo della lista), membro onorario e corrispondente per la Francia della Società contro la tratta che si era formata a Londra, sul cui modello è sorta la Società francese. Nel febbraio del 1790, in qualità di presidente della Société des Amis des Noirs, egli firma uno struggente invito all’Assemblea nazionale, affinché abolisca immediatamente il commercio degli schiavi (20). Nel 1790 la lista delle opere pubblicate o tradotte a cura della Società è 271 imponente: si tratta di ben venticinque lavori, alcuni dei quali sono pamphlets, o adresses di poche pagine, ma altri sono scritti consistenti sia per le dimensioni che per il lavoro di ricerca e di documentazione che li ha preceduti (21). Quattordici di questi scritti sono stati inviati all’Assemblea nazionale per sollecitare il suo interessamento ed una presa di posizione, prima di tutto ideologica ed in seguito operativa. La stessa lista si completa di un lungo elenco di opere inglesi contro la tratta e la schiavitù, tradotte a cura della Società, molte delle quali sono state inviate, come le precedenti, all’Assemblea nazionale. Il lavoro svolto dalla Société des Amis des Noirs, sia per quanto concerne la ricerca e l’elaborazione di dati che per quanto concerne la diffusione dell’informazione, la conquista di adepti alla causa negra, le pressioni sul Governo e sulle Assemblee rivoluzionarie, è certamente uno dei più cospicui e fruttuosi del Settecento. Tra l’altro si tirano le somme di tutto quanto è già stato fatto in precedenza in favore della causa negra, non soltanto in Francia ma anche in Inghilterra, coordinando gli interventi, focalizzandoli di volta in volta sui migliori bersagli, pur senza sguarnire alcun settore di un assedio sempre più massiccio alla roccaforte schiavista. E, tuttavia, come già si è detto in più occasioni, se gli schiavi negri non avessero preso in mano la loro situazione, gli sforzi degli Amis des Noirs e la buona volontà, un po’ distratta, degli uomini politici della Rivoluzione, ben difficilmente sarebbero approdati all’abolizione della schiavitù. Tanto più che i coloni erano subito passati al contrattacco anche in Francia: a Parigi si era infatti costituito, nel 1789, il Club Massiac con lo scopo di difendere appunto le posizioni dei coloni e di contrastare l’operato degli Amis des Noirs (22). A questo fine, i membri del Club non disdegnano neppure di servirsi della calunnia o quanto meno di spargere il sospetto che la Società faccia il gioco dell’Inghilterra, la quale mirerebbe non soltanto a distruggere il commercio coloniale della Francia, ma anche ad impadronirsi delle sue colonie delle Antille. Che l’Inghilterra avesse queste mire è fuor di dubbio: soltanto Toussaint ed il suo esercito di ex-schiavi riusciranno ad impedirle di impadronirsi di San Domingo, ma che gli Amis des Noirs fossero al suo servizio è completamente falso. Basterebbe a dimostrarlo la relativa cautela, nonostante facciano tanto polverone, con cui chiedono modifiche allo stato delle persone nelle colonie ed i tempi lunghi che prevedono per giungere all’abolizione totale. Vorrebbero che questo atto di giustizia, per il trionfo del quale lottano con tanta passione, si realizzasse nel modo migliore, con il minor spreco di vite umane ed anche con il minor danno per la Francia. Fra le numerose opere tradotte dall’inglese a cura della Société des Amis des 272 Noirs, ce n’è una particolarmente degna di attenzione, in quanto, essendo opera di un ex-schiavo, porta a conoscenza dei Francesi i sentimenti di una vittima dell’oppressione europea. Si tratta delle già menzionate Réflexions sur la traite et l’esclavage des nègres di Ottobah Cugoano (23). Il traduttore, Antoine Diannyère, premette all’opera una breve prefazione informativa sulla vita dell’autore che, ottenuta in Inghilterra la libertà, ha dedicato il suo tempo ad istruirsi, soprattutto in materia religiosa. Conosce perciò assai bene i testi sacri da cui trae citazioni a piene mani per la sua opera che è, del resto, tutta di intonazione biblica: lo sdegno per l’offesa arrecata a Dio, attraverso le sofferenze inflitte ai suoi figli neri, e la convinzione dell’imminente punizione divina costituiscono il filo conduttore di tutto il discorso. Lo sdegno che corre come un filone sotterraneo trova, di tanto in tanto, sbocchi violenti per riversarsi in rivoli infuocati su tutto e su tutti, mantenendo l’opera al livello di tensione di un appassionato pamphlet. Può anche paragonarsi al sermone di un predicatore irritato, che getta dal pulpito parole di fuoco sui peccatori impenitenti che lo ascoltano, richiamando a più riprese, con un’insistenza ossessiva, l’immagine della vengeance divina che non si farà attendere, se non ci sarà pentimento e riparazione delle colpe commesse. È un atto d’accusa in nome della giustizia umana e divina nei confronti dell’Inghilterra in particolare e dell’Europa in generale, per gli orribili delitti di cui si sono macchiate, andando a comperare o a rubare i negri sulle coste africane per farne degli animali da lavoro nelle loro colonie d’America. Le citazioni bibliche si sprecano per dimostrare che Dio condanna chi ruba o traffica esseri umani e che non potrà perciò tollerare più a lungo un tale scempio. La punizione da parte del Tout Puissant è il motivo conduttore dell’opera e ritorna così spesso sotto la penna di Cugoano che se ne potrebbero riempire intere pagine. Sono passi veementi ed ispirati, spesso di straordinaria efficacia: « La méchanceté des colons est odieuse, et leur trafic est honteux; et votre tolérance abominable. Vos injustices contre les Afriquains évoquent le courroux du Tout-Puissant. Comment vous pardonnerat-il? » (pp. 162-163). « ... la colère du Tout-Puissant les punira d’une manière terrible. Car des attrocités (sic) réfléchies et multipliées appellent la vengeance, à grands cris » (p. 128). Così, dopo aver dimostrato agli Inglesi che la cosa migliore da fare, per la loro pace interiore, per la salvezza delle loro anime ed infine per ottenere maggiori utili, è 273 la proscrizione della tratta e l’abolizione della schiavitù, egli arriva alla sua conclusione prediletta che è meglio aspettarsi tutto da Dio e niente dagli uomini: « ... aussi nous devons croire que ce sera lui qui nous délivrera; nous devons avoir plus de confiance en lui qu’en la nation anglaise, ou qu’en aucune autre nation... » (pp. 160-161). Poiché tutto parte da Dio e dipende da lui, si arriva a volte, nel testo di Cugoano, all’assurdo che quanto viene scritto contro la tratta e la schiavitù, possa anche trasformarsi in un ordigno che scoppia fra le mani di chi lo usa. Per esempio, egli vede nella perdita delle colonie americane da parte degli Inglesi uno dei segni della punizione divina, ed in ciò è perfettamente coerente con tutto il suo discorso precedente e con la sua concezione della giustizia divina, ma le conclusioni che ne trae sono sconcertanti e non vanno certo a vantaggio della sua gente: « Examinez les peuples accablés par les malheurs, vous verrez qu’ils le méritent » (p. 119). Lasciando da parte questi casi limite, a cui il contesto dà la giusta chiave interpretativa, Cugoano non risparmia nessun mezzo per mettere gli Europei di fronte alle loro responsabilità: li chiama senza eufemismi con i nomi che si sono meritati in seguito alle operazioni compiute in America ed in Africa. Sono appellativi tutt’altro che lusinghieri, ripetuti insistentemente, di pagina in pagina, in questo lungo pamphlet, senza tagli, senza suddivisioni e perciò senza soste, in un crescendo da incubo: « vicieux », « voleurs », « criminels », « assassins », « brigands », « scélérats », ecc. Il termine che li riassume tutti, il più sferzante, il più crudo, è « monstres »: « Pour penser que la traite et la servitude des nègres soient permises, il faut avoir étouffé en soi toute espèce de sensibilité. Mais choisir ce moyen de s’enrichir, se complaire dans la méchanceté, et mettre des innocens dans les fers, c’est être un monstre » (p. 77). E non credano coloro che non sono direttamente coinvolti nel commercio negriero o non hanno interessi nelle imprese coloniali di avere, per questo, le mani pulite e di non essere conniventi con il male. Chi approva o tace è infatti, secondo Cugoano, non meno colpevole di colui che opera, anzi, chi tace è per di più ipocrita e vile. In questo modo tutte le nazioni europee si trovano coinvolte nella condanna: 274 « … les peuples qui tolèrent ou encouragent les atrocités, sont non-seulement les complices de ceux qui les commettent, mais ils sont encore la honte de l’humanité » (p. 103). Gli Europei, più barbari del più barbaro dei selvaggi, hanno calpestato ovunque il diritto dei popoli ed hanno lasciato rovine e lutti sul loro passaggio, al punto che è difficile individuare un male che non sia ancora da essi stato inflitto ai popoli che hanno avuto la sventura di non respingerli non appena li hanno avvistati sulle loro sponde. Cugoano esprime il suo rimpianto con parole assai belle, di chiaro stampo biblico, ma che ricordano da vicino quelle che Diderot fa pronunciare al vecchio tahitiano del Supplément au voyage de Bougainville (24): « O mes compatriotes! pourquoi avez-vous reçu parmi vous des mortels aigus comme des ronces ? Pourquoi avez-vous laissé établir parmi vous des mortels adroits et fourbes comme des renards ? » (p. 101). Nelle Chansons madécasses (1787), anche il poeta creolo Evariste Parny esprime un concetto analogo, invitando gli abitanti dell’isola di Madagascar a diffidare dei bianchi. Tutta la quinta canzone, scandita sull’avvertimento: « Méfiez-vous des blancs », racconta la storia ormai nota dell’incontro fra gli Europei ed un popolo africano: i primi, accolti fraternamente, innalzano subito delle fortezze ed impongono la loro legge di sopraffazione. I risultati sono stati tremendi, anche dal punto di vista dello sconvolgimento dei sistemi di vita di un popolo, tanto che nella nona canzone, Parny è costretto a cantare una storia orribile: « Une mère traînoit sur le rivage sa fille unique, pour la vendre aux blancs », mentre questa la scongiura di rinunciare alla sua follia (25). Le ragioni di recriminazione nei confronti degli Europei sono sempre le stesse e si ritrovano, più o meno ampiamente trattate, in tutti gli autori. L’unica differenza sta nell’efficacia con cui vengono presentate e nel contesto che può minimizzarle od esaltarle. Anche Cugoano, come molti altri scrittori abolizionisti insiste sulla corruzione che si è sempre accompagnata alle distruzioni, ai furti ed agli assassinii, là dove il bianco è passato: « Leurs intrigues ont infecté les Nègres » (p. 106), e naturalmente conclude che Dio lo punirà anche per questa colpa irrimediabile, come punirà i suoi ministri che sono scesi a patti con i mercanti di carne umana e con gli oppressori dei loro simili. Ci sono anche pagine meno esaltate nel testo di Cugoano, in cui l’autore propone 275 un programma di abolizione in tempi molto brevi, ma il senso pratico non è il suo forte ed il programma, in concreto, è quasi inesistente. Più lucido è invece l’esame del fallimento dell’esperimento fatto dall’Inghilterra con la colonia libera della Sierra Leone, fallimento che deve ricondursi essenzialmente a due cause: la mancanza di solide basi su cui lo si è impiantato e la profonda sfiducia dei negri nei confronti dei bianchi. Una volta che gli schiavi hanno ottenuto la libertà nelle colonie americane, affrontano difficilmente i rischi che comporta il ritorno in Africa, tanto più che temono si tratti di una nuova trappola dei bianchi per strappar loro quella libertà che alcuni di loro hanno ottenuto con tanta fatica e tante sofferenze. Il motivo che ritorna con più frequenza sotto la penna di Cugoano è, come si è detto, quello della disobbedienza ai comandamenti di Dio e quindi della punizione che egli farà ricadere sui trasgressori, ma non manca, proprio nelle parole che concludono l’opera, il richiamo ad una punizione tutta terrena: « Rien ne pourra les arrêter; les mers, les montagnes, les rochers, les déserts, les forêts ne les empêcheront pas de venir jusqu’à vous; la bonhommie des Noirs deviendra une fureur indomptable qui renversera tout; les cœurs les plus intrépides frémiront; et une aveugle confiance en votre bravoure, sera le dernier piège que vous tendra votre entêtement » (pp. 193-194). Questa voce negra che si fa sentire per la prima volta in Francia, se non conosce alla perfezione l’arte di ordinare e suddividere la materia per evitare confusioni e ripetizioni, ha però il tono giusto per distaccarsi dalla massa, spesso indistinta, degli scritti abolizionisti e bombardare il lettore con una pioggia ininterrotta di recriminazioni, di richiami ad una sana visione dei rapporti umani, in un’atmosfera da giudizio universale che finisce per colpevolizzare anche chi non ha proprio mai avuto nulla a che vedere con il commercio negriero e con le colonie americane. È l’effetto voluto: una specie di « terrorismo pio ». Credenti e non credenti non possono restare insensibili alle immagini di sofferenza senza limiti che Cugoano ha saputo evocare ed al richiamo alla necessità di pagare che le accompagna. Siamo alla vigilia di una catarsi violenta: il tono, paradossalmente, annuncia la Rivoluzione. L’abbé Grégoire, strenuo difensore della causa negra e mulatta, presentando elogiativamente l’opera di Cugoano in quel tempio consacrato alla grandezza e alle capacità negre che è, appunto, De la littérature des nègres, dirà di lui e della sua opera: 276 « La plupart des auteurs, qui avoient censuré le commerce de l’espèce humaine, avoient employé les seules armes de la raison; une voix s’éleva pour faire retentir le cri de la religion, pour prouver par la Bible, que le vol, la vente, l’achat des hommes, leur détention dans l’esclavage, sont des forfaits dignes de mort... » (26). Quella condanna in nome di Dio, che spettava ad un uomo di Chiesa, Cugoano, negro convertito, l’ha assunta su di sé e l’ha resa infuocata con l’esperienza delle sofferenze sue e di tutta la sua razza. Ma a partire dal 1789 sono molti gli uomini di Chiesa che cominciano ad occuparsi della questione della schiavitù, a disgiungere, ed a chiedere che si disgiungano, le responsabilità della Chiesa da quelle dei coloni: alludiamo all’abbé Sibire, all’abbé Cournand e, soprattutto, all’abbé Grégoire che al riconoscimento dei diritti dei negri e mulatti liberi ha dedicato un’intera vita di lotte (27). Altri ecclesiastici figurano fra gli iscritti alla Société des Amis des Noirs, anzi fra questi vi è anche il vescovo di Chartres (28). I loro scritti spezzano connivenze secolari e chiedono che il nome di Dio venga, per l’avvenire, associato soltanto ad atti di amore e di giustizia per l’umanità non, in maniera blasfema, ad atti infami e crudeli. Nei mesi che precedono la convocazione degli Stati generali e dopo lo scoppio della Rivoluzione, gli scritti in favore della causa negra diventano sempre più numerosi, anche grazie all’attività della Société des Amis des Noirs, che cerca di far proseliti, di stimolare indagini e di pubblicare e diffondere quanto è stato scritto in Francia ed in Inghilterra a favore della causa abolizionista. Si insiste, in particolare sul fatto che è vergognoso, soprattutto dopo la Dichiarazione dei diritti dell’uomo, lasciare in vita la schiavitù nelle colonie, anche se le richieste concrete restano sempre molto caute: non si chiede, infatti l’affrancamento totale ed immediato degli schiavi, ma soltanto di proscrivere la tratta e di preparare un piano di abolizione: « L’HUMANITÉ, la justice et la magnanimité qui vous ont dirigés dans la réforme des abus les plus profondément enracinés, font espérer à la Société des Amis des Noirs, que vous acueillerez avec bienveillance sa réclamation en faveur de cette nombreuse portion du genre humain, si cruellement opprimée depuis deux siècles » (29). La veemenza nella condanna e la cautela nelle modifiche richieste ed introdotte nel sistema coloniale concerne anche le diverse assemblee rivoluzionarie(30) che, a dire il vero, erano già impegnate a fondo per fronteggiare la situazione in Francia. Per di più, i deputati coloniali lottano strenuamente affinché nulla venga mutato 277 nelle colonie per quanto riguarda lo « stato delle persone », senza una previa decisione delle assemblee locali. Qualora non riescano ad evitare l’emanazione di un decreto, si sforzano di farlo restare il più generico possibile, e quindi ambiguo, affinché sia permesso ai coloni di usarlo a loro vantaggio. La battaglia fra abolizionistii e schiavisti è strenua in seno alle assemblee rivoluzionarie e fuori: si conduce con testimonianze, saggi, adresses, pamphlets, ma anche con reciproche accuse di malafede, di incompetenza, di menzogna, di tradimento della causa rivoluzionaria e della nazione francese: gli « amici dei negri » sono infatti accusati a più riprese, come già si è accennato, di fare il gioco dell’Inghilterra, la quale, dopo aver perduto le sue colonie americane, si sarebbe messa a plaider la causa dell’umanità, per privare anche la Francia dei proventi delle sue. Frattanto gli schiavi di San Domingo, anche a causa del disaccordo esistente nella colonia fra bianchi e mulatti possessori di schiavi, che li hanno armati di volta in volta gli uni contro gli altri, cominciano ad essere in fermento ed infine, nell’estate del 1791, scoppia quella rivolta che trova, poco dopo, il suo capo carismatico in Toussaint Louverture (31). Questi costringe, nel 1793, quando l’Inghilterra minaccia l’isola dall’esterno, il commissario Sonthonax a dichiarare abolita la schiavitù ed a chiedere a Parigi la ratifica del decreto di abolizione. L’ottusa chiusura dei coloni e la cautela dei deputati rivoluzionari non sono servite che a precipitare una situazione che sfugge ormai ad ogni controllo e, nonostante gli sforzi di Toussaint per riuscire ad ottenere la liberazione dei suoi fratelli schiavi senza trucidare i bianchi e senza cacciarli dall’isola, si giunge ad una vera e propria ecatombe che finisce soltanto, in epoca napoleonica, con la definitiva sconfitta e cacciata dei coloni bianchi da San Domingo. Questo anche perché Napoleone ha fatto catturare, con l’inganno, e morire in una prigione del Giura (1803), Toussaint Louverture, il solo fra gli schiavi in rivolta capace di vedere la situazione in prospettiva, da politico oltre che da combattente, e quindi il solo che difendesse la necessità di un accordo fra gli ex-padroni bianchi, detentori delle conoscenze e delle competenze, e gli ex-schiavi divenuti liberi, ma ancora impreparati a gestire nella maniera più fruttuosa una colonia che restasse soltanto nelle loro mani. Sotto la spinta degli eventi coloniali, senza alcuna seria discussione preliminare, il 4 febbraio 1794, la Convenzione dichiarava abolita la schiavitù: « LA CONVENTION NATIONALE déclare que l’esclavage des Nègres dans toutes les Colonies est aboli; en conséquence elle décrète que tous les hommes, sans 278 distinction de couleur, domiciliés dans les colonies, sont citoyens Français, et jouiront de tous les droits assurés par la constitution » (32). Questa dichiarazione legherà Toussaint alla Francia, di cui si professerà sempre suddito fedele, a patto, però, che non si minacci quella libertà che i negri hanno conquistata con tanta fatica. Toussaint lo lascia chiaramente intendere in una lettera indirizzata al Direttorio (di cui non capisce bene gli orientamenti), per confutare l’accusa di mirare all’indipendenza di San Domingo: « Tout ce que les ennemis des principes qu’elle a décrétés pour Saint-Domingue pourront vous dire pour affaiblir à vos yeux l’attachement inviolable à la France et à sa Constitution, des généraux noirs et de couleur, ne leur fera jamais enfreindre le serment qu’ils ont fait de vivre libres et Français; ils préféreront toujours s’ensevelir sous les ruines de leur pays, plutôt que d’y voir revivre l’esclavage... » (33). Toussaint e il suo successore Dessalines hanno mantenuto la promessa, respingendo le truppe del generale Leclerc, inviato da Napoleone, che portava segretamente con sé anche il decreto di ripristino della schiavitù. I Francesi non riconquisteranno più la « perla delle Antille », che si dichiarerà indipendente nel 1804, sotto Dessalines, con l’antico nome di Haiti. Gli ex-schiavi si sono così trovati ad affrontare problemi spaventosi in condizioni precarie e dopo lunghi anni di guerre e di distruzioni che avevano sconvolto l’isola. Hanno sofferto molto, e soffrono ancora oggi, non soltanto delle conseguenze del lontano servaggio, come tutte le Antille, ma anche della politica prevaricatrice di Napoleone che li ha costretti all’isolamento, dopo aver bloccato la ristrutturazione dell’isola, cominciata con Toussaint, ed aver bruciato le loro ultime energie in una guerra fratricida, dal momento che si fronteggiano uomini che la Repubblica aveva chiamati, senza distinzione di colore, cittadini francesi. Oggi Toussaint ha un posto di primo piano fra gli eroi della liberazione negra ed è assurto al significato di un simbolo. Il poeta haitiano René Depestre lo definisce, nei Sept piliers de l’Innocence: « l’aïeul de tout ce qui sur cette terre marche vers le printemps » e fa crescere sul suo vecchio tronco, abbattuto con l’inganno, l’albero giovane e rigoglioso della libertà: « En me renversant, on n’a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l’arbre de la 279 liberté des Noirs; il repoussera par les racines parce qu’elles sont nombreuses et profondes » (34). La lotta per la liberazione negra e la proclamata abolizione della schiavitù fanno nascere in Francia, accanto agli scritti di carattere saggistico, una rigogliosa produzione letteraria, quasi sempre stucchevolmente sdolcinata ed indigesta, con eroi negri buoni, generosi, sfruttati ed infelici, con padroni cattivi puniti e padroni buoni amati, rispettati e difesi, in caso di rivolta, dai loro stessi schiavi. Una letteratura manichea che non conosce esitazioni nello spartire il bene dal male, il buono dal cattivo ecc. Adonis, ou le bon nègre (1798) e Zoflora, ou la bonne négresse (1800) di JeanBaptiste Picquenard danno fin dal titolo un’idea di come si sia passati, in perfetta buona fede, da una mistificazione ad un’altra, trasformando il negro-animale, il negro-cosa, in un negro-melenso, stakanovista della bontà e della dedizione, vittima designata di tutti i successivi soprusi. Bisognerà aspettare Eugène Sue per scoprire, dietro la maschera ossequiente di Atar-Gull (1831), il negro ribelle che non ha dimenticato le offese ricevute e che si traveste di mansuetudine soltanto per portare a termine il suo paziente e terribile piano di vendetta. Un piano così abilmente programmato che, a conclusione di tutta la vicenda, riceve persino un premio di bontà per il suo comportamento esemplare (36). Ma il Settecento, nonostante le stragi inevitabili della rivolta coloniale, si chiude su di un’immagine di bontà zuccherosa, galleggiante sulle acque tempestose dei tempi e destinata a toccare gli animi sensibili, come si legge nella conclusione di Adonis: « … j’ai fait tout ce que j’ai pu pour rendre intéressant mon bon nègre: c’est aux bons cœurs, c’est aux ames sensibles à faire le reste » (37). Ed il resto arriva: nel 1802 (38) Napoleone ripristina la schiavitù e bisognerà aspettare il 1848, cioè l’avvento di una nuova repubblica, perché, dopo un altro mezzo secolo di lotte, si decreti la definitiva abolizione della schiavitù in tutti i possedimenti della Francia e finisca il più vergognoso dei soprusi coloniali. Note (1) La planche della nave negriera Brooks, oggi abbondantemente riprodotta, che accompagna la Description d’un navire négrier, s.l. (Parigi), s.d., (1789), in EDHIS, VI, 5, e 280 più eloquente di un lungo saggio contro la tratta. La stessa raccolta di EDHIS, tomi VI-IX, pur riunendo soltanto una parte del lavoro svolto dalla Société des Amis des Noirs, riesce a dare un’idea convincente degli sforzi compiuti per il trionfo della causa che aveva abbracciata. (2) La requisitoria del negro di Prévost è, come abbiamo visto, da collocarsi con ogni probabilità fra i « romans ». (3) Oggi, dopo il successo, anche televisivo, di Radici di Alex Haley (tr. it. Rizzoli 1978), tutti sanno che agli schiavi era proibito imparare a leggere ed a scrivere e che incorrevano in severe punizioni se venivano scoperti. Ancor più impressionante è la testimonianza di uno schiavo, Frederick Douglass, che pubblica nel 1892 Life and Times, ora tradotta da Serenella Pelaggi per la collezione « II pane e le rose » dell’editore Savelli, con il titolo Autobiografia di uno schiavo (1978). È lo stesso titolo che l’editore Einaudi aveva dato nel 1968 alla traduzione della Biografia de un cimarrón del cubano Miguel Barnet. (4) Condorcet, op. cit., in EDHIS, VI, 2, p. 13. La convinzione che la schiavitù releghi l’uomo ad una condizione inferiore è ribadita anche in altre parti dell’opera : « On ne peut dissimuler que les nègres n’aient en général une grande stupidité: ce n’est pas à eux que nous en faisons le reproche; c’est à leurs maîtres » (p. 31). (5) Condorcet chiede tempi lunghi per preparare il terreno all’abolizione meno dolorosa possibile, ed in ciò, come si è detto, si trova d’accordo con la maggior parte degli abolizionisti. A preoccupazioni analoghe risponde anche il « piano » del marchese di Chastellux, che presenta però l’originale intento di giungere allo scopo, attraverso l’« abolizione del colore nero »: « Il paroît donc qu’on ne peut abolir l’esclavage qu’en se débarassant des nègres, et cette mesure ne peut-être prise que graduellement. Le meilleur moyen seroit d’exporter un grand nombre de mâles, et de favoriser le mariage des blancs avec les négresses. Pour cela il faudroit abroger la loi qui veut que l’esclavage se transmette par les mères, ou du moins ordonner que toute esclave deviendroit libre en épousant un homme libre ». Si arriverebbe così, nel giro di un certo numero di generazioni, ad annullare la diversità di colore (Voyages de M. le Marquis de Chastellux dans l’Amérique septentrionale. Dans les années 1780, 1781 et 1782, Parigi, 1786, 2 voll., II, p. 148). (6) Su questo punto anche l’autore della Réponse à l’écrit de M. Malouet sur l’esclavage des nègres, s.l. (Parigi), 1789, in EDHIS, VI, 6 (un membro della Société des Amis des Noirs non meglio identificato), è categorico. Egli cerca di dimostrare che, a ben leggerlo, è lo stesso testo di Malouet a denunciare la chimera di poter migliorare la condizione dello schiavo, in quanto nessun intervento è possibile tra il padrone e un « oggetto » di sua proprietà. (7) In M. Lamiral, réfuté par lui-même, ou Réponse aux opinions de cet auteur (...). Par un ami des Blancs et des Noirs (Parigi, 1790, EDHIS, 4), opera di Xavier-François Lanthenas, ma pubblicato anonimo a cura della Société des Amis des Noirs, l’autore sostiene, confutando un’opinione espressa da Necker, che il lavoro con operai è meno oneroso di quello fatto da schiavi (p. 52). Necker aveva espresso la convinzione che il lavoro coloniale fatto da schiavi fosse il più redditizio in De l’administration des finances de la France (1784), non per difendere la schiavitù, ma per rammaricarsi che il fatto costituisse un serio ostacolo ad ogni tentativo di abolizione. (8) Au corps électoral contre l’esclavage des noirs, riprodotto in EDHIS, VI, 7, da Œuvres complètes, Brunswick e Parigi, 1804, tomo XVI, pp. 147-154. Assai più pressante nelle richieste e drastico nella condanna dei coloni e dei mercanti di schiavi si dimostra l’abbé Cournand, in un’opera scritta in difesa dell’abbé Grégoire : « Le moment est venu de 281 ne plus garder de ménagemens avec ces hommes affreux qui se jouent de l’humanité souffrante, et osent afficher hautement le mépris qu’ils ont pour elle. Que nous serviroit d’être libres, si nous craignions de sentir et de communiquer aux autres l’indignation de la vertu? » [Réponse aux observations d’un habitant des colonies, sur le Mémoire en faveur des gens de couleur ou sang-mêlés de Saint-Domingue, et des autres Isles françaises de l’Amérique, par M. Grégoire, Curé d’Emberménil, Député de Lorraine, s.l. (Parigi), s.d. (1789), in EDHIS, I, 7, p. 10]. Cournand si scaglia nella sua opera in particolare contro il pregiudizio del colore e della superiorità bianca. (9) Daniel Lescallier, ad esempio, autore di Réflexions sur le sort des Noirs dans nos colonies, s.l. (Parigi), 1789 (EDHIS, I, 5), è od è certamente stato, un colono, come risulta da più di un riferimento nel testo (cfr. anche infra, nota 16). Ma, anche per il bene dei coloni e della Francia, è convinto che si debbano conciliare, nelle colonie più che altrove, umanità ed interesse. A tal fine conclude l’opera con un Envoi à MM. les Députés de la Nation, che è un vero pezzo da antologia: « O! vous, l’élite de la plus belle Nation et de la plus généreuse, assemblés en présence de l’univers pour réparer les maux de l’humanité souffrante, pour soutenir le foible contre l’oppression du fort, pour faire jouir le pauvre du sacrifice des riches! daignez vous occuper un instant de 500 mille Cultivateurs qui font parties des sujets de ce vaste empire (...). Croyez que nul objet n’est plus digne de vos glorieux travaux que la suppression de la Traite des Noirs, et la résolution prise dès-à-présent de préparer les voies à celle de l’esclavage par tous les moyens graduels indiqués ici rapidement, ou tels autres, que la propre disposition des propriétaires fera éclore successivement, encouragée par l’autorité souveraine » (pp. 69-71). L’intento di fare contemporaneamente il bene degli schiavi, della Francia e delle colonie ispira anche uno dei testi più completi e più solidi che siano stati pubblicati in quello stesso anno contro la tratta e la schiavitù: La cause des esclaves nègres et des habitants de la Guinée portée au Tribunal de la justice, de la Religion, de la Politique, ou histoire de la Traite et de l’Esclavage des Nègres (...), Lione, 1789, 2 voll. (ristampa Slatkine 1978). L’autore è Benjamin-Sigismond Frossard. (10) Sur l’admission des députés des planteurs de Saint-Domingue, dans l’Assemblée Nationale, in EDHIS, VI, 8, tratto da Œuvres complètes, cit., tomo XVI, pp. 155-166, p. 155. Sul terreno dell’ammissione dei deputati coloniali all’Assemblea si scontrarono violentemente abolizionisti e coloni. I primi chiedevano che si considerasse anche il caso dei mulatti e negri liberi che, in attesa di risolvere il problema degli schiavi, avevano tutti i diritti di avere dei rappresentanti propri all’Assemblea Nazionale, i secondi pretendevano invece di rappresentare gli interessi di tutti gli abitanti delle colonie. Al centro della lotta c’è l’abbé Grégoire, curato di Emberménil e deputato della Lorena, che ha messo la sua penna al servizio della causa dei mulatti e dei negri: Mémoire en faveur des gens de couleur ou sangmêlés de Saint-Domingue et des autres isles françoises de l’Amérique, adressé à l’Assemblée Nationale, Parigi, 1789 (EDHIS I, 6); Lettre aux philanthropes, sur les malheurs, les droits et les réclamations des gens de couleur de Saint-Domingue et des autres îles françoises de l’Amérique, Parigi, 1790 (EDHIS, IV, 9); Lettre aux citoyens de couleur et nègres libres de Saint-Domingue, et des autres Isles Françoises de l’Amérique, Parigi, s.d. (1791) (EDHIS, IV, 14). Tutti i quattordici testi contenuti nel volume IV di EDHIS sono interessanti al riguardo. (11) Sulle reazioni di Mirabeau di fronte alla pretesa dei deputati bianchi di San Domingo di rappresentare anche gli interessi dei mulatti e dei negri liberi, nonché degli schiavi cfr. A. J. Cooper, op. cit., p. 37. Del resto per avere un’idea di quanto fossero giustificate le reazioni 282 degli abolizionisti nei confronti delle pretese di questi deputati, basta leggere la Correspondance secrette des Colons députés à l’Assemblée Constituante, servant à faire connaître l’esprit des colons en général, sur la Révolution, Parigi, s.d. (1793), in EDHIS, VIII, 10. Citiamo un piccolo échantillon di questa corrispondenza: « Prenez les mesures que votre sagesse vous dictera: observez bien les personnes et les choses; Qu’ON ARRÊTE LES GENS SUSPECTS, QU’ON SAISISSE LES ÉCRITS OÙ LE MOT MÊME DE LIBERTÉ EST PRONONCÉ; redoublez la garde sur vos habitations, dans les villes, dans les bourgs; par-tout attachons les gens de couleur libres, MÉFIEZ-VOUS DE CEUX QUI VONT VOUS ARRIVER D’EUROPE» (EDHIS, VIII, 10, p. 11). E’ una lettera spedita da Versailles il 29 agosto 1789, dai deputati di San Domingo ai loro «elettori», che ben dimostra in quale modo si occupino degli interessi dei negri e dei mulatti. (12) Citiamo dall’edizione curata da Monique e François Hincker per le Éditions sociales, Parigi, 1966, p. 183. (13) EDHIS, I, 3. L’opera porta un sottotitolo abbastanza indicativo di cosa stia a cuore all’autore: La paix est le temps de régler et d’agrandir le commerce. (14) Ibidem, p. 51. (15) Lo dimostra anche la decisione, da parte di coloro che hanno curato per conto delle Editions d’histoire sociale (EDHIS), la raccolta La Révolution française et l’abolition de l’esclavage. Textes et documents (1968), di comprenderlo nella scelta, pur avendo dichiarato nella prefazione: « La collection (...) ne reproduit que des textes antiesclavagistes et favorables à l’égalité des hommes, quelle que soit leur origine ». (16) Mémoire sur l’esclavage des nègres, Neuchâtel, 1788, p. 15. Porta la stessa data una lettera di Malouet, scritta da Caienna ad un destinatario residente a San Domingo, pubblicata a cura di Gabriel Debien e Johanna Felhoen Kraal, su «De West-Indisches Gids », nel 1955, sotto il titolo Esclaves et plantations de Surinam vus par Malouet, 1777 (pp. 53-60). In realtà Debien dimostra come la data del 2 dicembre 1788 sia falsa per una svista del copista o « pour une transposition volontaire et très précisément dirigée», poiché Malouet era a Caienna nell’autunno del 1777. La giustificazione della post-datazione potrebbe essere la seguente, secondo Debien: « En cette fin de 1788 certains milieux parisiens sont en pleines discussions sur l’abolition de la traite et de l’esclavage. La société des Amis des Noirs vient d’être fondée à Paris. Elle est en rapport avec celle de Londres. Malouet vient de publier ou de laisser publier à Neufchâtel le Mémoire sur l’esclavage des nègres dont il est question dans cette lettre, et son petit livre a fait beaucoup de bruit. Lescallier, qui arrive de la Guyane, va faire imprimer ses Réflexions sur le sort des Noirs dans nos colonies. Cette lettre est une arme entre les mains de ceux qui veulent abolir la traite et améliorer le sort des esclaves. Elle démontre le danger permanent qu’est pour la prospérité et même pour la vie coloniale la dureté des planteurs» (p. 55). (17) EDHIS, VI, 3. Léon Cahen afferma che i regolamenti della Società sono opera di Condorcet: li ha trovati fra le sue carte, scritti da lui e corretti a più riprese (La Société des Amis des Noirs et Condorcet, in « La Révolution française », 1906, n. I, pp. 481-511). Alcuni anni più tardi la Società modificò, in parte, il nome ed i regolamenti come risulta dalle Additions aux règlemens de la Société des Amis des Noirs et des Colonies, s.l. (Parigi), s.d. (anno II), dovute alla penna dello svedese Charles-Bernard Wadstrom (EDHIS, VIII, 12). (18) Réglemens, cit., p. 2. (19) Per alcune notizie sulla sua vita cfr. Jean François Primo, La jeunesse de Brissot, 283 Parigi, 1932. (20) Il regolamento della Società prevedeva che il presidente restasse in carica soltanto tre mesi. Il testo porta il titolo di Adresse à l’Assemblée nationale, pour l’abolition de la traite des noirs. Par la Société des Amis des Noirs de Paris, Parigi, febbraio 1790 (EDHIS, VII, 7). Sul frontespizio, al centro della pagina, è riprodotto l’emblema della Società: una sorta di medaglione con un negro inginocchiato in catene, che porta attorno la scritta : Ne suis-je pas ton frère? L’emblema è stato probabilmente imitato da quello della Società inglese : un medaglione analogo che portava appunto la scritta : Am I not a man and a brother? Il medaglione inglese, opera di Josiah Wedgwood, è riprodotto in D. P. Mannix e M. Cowley, Carico nero, cit. (21) Cfr. EDHIS, VIII, 2. (22) Cfr. A. J. Cooper, op. cit., p. 27. Sulle posizioni difese dai coloni e sulle accuse che muovevano agli Amis des Noirs, ci informa anche la prefazione del già citato Aza, ou le nègre (anonimo, Parigi, 1792): « On croira difficilement peut-être en d’autres tems, qu’il se soit trouvé dans celui-ci des déclamateurs assez hardis pour soutenir que les Noirs, peuples pasteurs et agricoles dans leurs contrées, y sont plus malheureux qu’en Amérique sous le fouet des colons. C’est cependant ce que nous avons vu dans plusieurs écrits récens, et entendu avec bien plus grand scandale dans la tribune même de l’assemblée constituante. On n’a pas craint d’imprimer aussi et de débiter par-tout, que les écrits de quelques membres de la société avoient causé les soulèvemens arrivés dans nos colonies... » (p. III). (23) Parigi, 1788, in EDHIS, X. Nella prefazione, il traduttore pubblica, in traduzione francese, la lettera che gli ha inviato un certo Piatoli, autore di un Saggio intorno al luogo del seppellire, stampato a Modena e tradotto nel 1778 in francese, sempre stando alle notizie di Dyannière, dietro richiesta di d’Alembert e dell’abate Contrit. Piatoli afferma di aver conosciuto bene, a Londra, Cugoano e ne traccia un ritratto molto lusinghiero. Anche l’abbé Grégoire riporta la notizia in De la littérature des nègres, Parigi, 1808, p. 215. (24) Cfr. supra il capitolo dedicato alla Critica dei « conquistadores ». (25) Chansons madécasses, traduites en François, suivies de Poésies fugitives, par M. le Chevalier de P..., Parigi, 1787. (26) p. 218. (27) Oltre alle opere citate, bisogna almeno ricordare De la noblesse de la peau, ou du préjugé des Blancs contre la couleur des Africains et celle de leurs descendans noirs ou sang-mêlés (Parigi, 1826) che dimostra come, giunto ormai alla fine della sua vita, non avesse rinunciato alla lotta contro la schiavitù e la discriminazione razziale. Di lì a poco apparirà sulla scena francese un altro strenuo e grande difensore della causa negra : Victor Schœelcher. Su di lui vedi la premessa di Ch. Julien e l’introduzione di A. Césaire alla scelta di testi curata da E. Tersen: Esclavage et colonisation, Parigi, 1948. (28) Cfr. Tableau des membres de la Société des Amis des Noirs. Année 1789, in EDHIS, VI, 4. (29) Adresse à l’Assemblée générale, cit. (per non creare confusione ricordiamo che è quella firmata da Brissot), p. l. (30) Per seguire le fasi del dibattito rivoluzionario attorno al problema delle colonie e della schiavitù, rinviamo all’opera della Cooper. È anche molto istruttivo leggere i vari decreti, riprodotti in EDHIS, vol. XII. (31) Su Toussaint Louverture la bibliografia è piuttosto vasta. Ci limitiamo perciò a citare il Toussaint-Louverture dello scrittore martinicano Aimé Césaire (Parigi, 1960), ed il 284 Toussaint Louverture ou la vocation de la liberté di Roger Dorsinville (Parigi, 1965). Ricordiamo che Toussaint è anche il protagonista di una pièce (a cui dà il titolo) di Édouard Glissant, pubblicata da Seuil nel 1961. A chiarire le circostanze piuttosto oscure della sua morte contribuiscono le pagine di Léonard Sainville, La captivité et la mort de ToussaintLouverture, « Présence africaine », 1970, n. 76, pp. 238-251. (32) Décret de la Convention Nationale. Du 16 jour de Pluviôse, an second de la République Française, une et indivisible. Qui abolit l’Esclavage des Nègres dans les Colonies, in EDHIS, XII, 8. (33) Réfutation de quelques Assertions d’un Discours prononcé au Corps législatif le 10 Prairial, an cinq, par Vienot Vaublanc. Toussaint Louverture, Général en chef de l’Armée de S. Domingue, au Directoire exécutif, s.l. (Le Cap), s.d. (7 brumaio anno VI), in EDHIS, XI, 14, p. 32. (34) « Présence africaine », 1966, n. 57, p. 207. I Sept piliers de l’Innocence fanno parte della raccolta Un arc-en-ciel pour l’Occident chrétien, Parigi, 1967. (35) Sulla ricca letteratura negrofila dell’ultimo decennio del Settecento cfr. S. Etienne, Les sources de « Bug-Jargal », Bruxelles, 1923; E. D. Seeber, Anti-Slavery Opinion..., cit.; R. Mercier, L’Afrique noire dans la littérature française. Les premières images (XVIIe-XVIIIe siècles), Dakar, 1962; L.- F. Hoffmann, op. cit. (tutta la prima parte è dedicata agli ancêtres ed al Settecento); L. Sebbar-Pignon, Le mythe du bon nègre ou l’idéologie coloniale dans la production romanesque du XVIIIe siècle, « Les temps modernes », 1974, n. 336, pp. 23492375 e nn. 337-338, pp. 2589-2613. (36) Per colmo di ironia, l’anno seguente l’Académie Française assegnava il primo Prix de Vertu a Eustache Belin, « Le Bon Noir », cfr. Portraits et histoire des hommes utiles, hommes et femmes de tous pays et de toutes conditions (...). Publiés et propagés pour et par la Société Montyon et Franklin, 1833-1834, Parigi, 1834. L’elogio è preceduto da un delizioso ritratto del buon Eustache. La sua storia è raccontata (con corredo di belle illustrazioni) anche da Maxime Du Camp in La vertu en France, Parigi, 1888, pp. 95-125. (37) Adonis ou le bon nègre. Anecdote coloniale, Parigi, 1798, p. 278. L’autore ci tiene molto a sottolineare che non si tratta di un romanzo, ma di un episodio di vita vissuta. Il modello letterario al quale Picquenard si ispira è Bernardin de Saint-Pierre: « Immortel auteur de Paul et Virginie! ô Bernardin de SaintPierre! les vertus d’Adonis étaient dignes de ta plume (...) C’est cependant sous tes auspices favorables que j’ose introduire aujourd’hui mon pauvre Nègre dans le monde » (pp. VIII-IX). Egli spera che la sua opera serva a « ramener les hommes à l’amour de l’ordre, de la justice et de l’humanité, par des exemples touchants et vrais ... » (p. XI). Di Adonis esiste una riduzione teatrale di Beraud e Rosny, un melodramma fatto rappresentare all’Ambigu Comique e pubblicato nello stesso 1798. (38) Cfr. C.L.R. James, op. cit., p. 291. James riproduce anche stralci di lettere del generale Leclerc a Napoleone, in cui si rimprovera a quest’ultimo non il fatto di aver ripristinato la schiavitù, ma di non aver aspettato il momento giusto per farlo: « Io vi pregai, Cittadino Console, di non far nulla che potesse renderli ansiosi circa la loro libertà finché io non fossi pronto (...). Improvvisamente è giunta qui la legge che autorizza il traffico degli schiavi nelle colonie (...). Adesso che, Cittadino Console, son perfettamente noti i vostri piani per le colonie, se voi volete conservare Santo Domingo, inviate un nuovo esercito (...) se voi ci abbandonate a noi stessi, come avete fatto fino ad oggi, questa colonia è perduta... » (pp. 293-294). 285 286 Bibliografia∗ Abanime E. P., Voltaire et les Noirs, University of Illinois at Urbana Champaign, 1976 (Doctoral dissertation). Abanime E. P., Voltaire as an anthropologist: the case of the albino, « Studies on Voltaire and the eighteenth century », 1976, CXLIII, pp. 85-104. Abénon L. R., Blancs et libres de couleur dans deux paroisses de la Guadeloupe (Capesterre et Trois-Rivières). 1699-1799, « Revue française d’histoire d’OutreMer », 1973, n. 220, pp. 297-329. Adotevi S., Négritude et négrologues, Parigi, 1972. Aguet I., La traite des nègres, Ginevra, 1971. Airian J., L’opposition aux physiocrates à la fin de l’Ancien Régime, Parigi, 1965. Alatri P., Agli albori dell’anticolonialismo, «Ulisse», 1958, n. 28-29, pp. 1682-1687. Annan G. L., Wroth L. C., Acts of the French royal administration concerning Canada, Guiana, the West Indies and Louisiana prior to 1791, New York, 1930. Ardouin B., Etudes sur l’histoire d’Haïti, Parigi, 1853, 6 voll. Atkinson G., Les relations de voyages du XVIIe siècle et l’évolution des idées. Contribution à l’étude de l’esprit du XVIIIe siècle, Parigi, 1927. Augeard E., Etudes sur la traite des noirs avant 1790 au point de vue du commerce nantais, Nantes, 1901. Aulard A., Malouet in Les orateurs de la Révolution. Assemblée constituante, Parigi, 1905, pp. 329-340. Austen R. A., Smith D., Images of Africa and British slave-trade abolition: the transition to an imperialist ideology, 1787-1807, « Africans historical studies », 1969, n. 1, pp. 69-83. Balandier G., La vie quotidienne au royaume de Kongo du XVIe au XVIIIe siècle, Parigi, 1965. Balmas E., La scoperta dell’America e le lettere francesi del Cinquecento. Buon selvaggio e terzo mondo, Milano, 1971. Banbuck C. A., Histoire politique, économique et sociale de la Martinique sous l’Ancien Régime (1635-1789), Parigi, 1935. Barnet M., Autobiografia di uno schiavo (1966), tr. it., Milano, 1968. ∗ Il cospicuo numero di scritti settecenteschi concernenti specificamente o marginalmente l’argomento da noi trattato, nonché la vasta bibliografia critica oggi in rapidissimo aumento, richiederebbero ormai un lavoro specifico che facesse il punto della situazione e riordinasse un materiale ricchissimo, ma caotico. Noi ci limitiamo qui ad indicare, senza alcuna suddivisione interna (eccezion fatta per le opere sui conflitti razziali e le antologie), un buon numero di lavori critici provenienti dai più diversi settori di ricerca, che ci sembra possano costituire un’utile piattaforma di partenza per ricerche ulteriori. 287 Barquisseau R., Les poètes créoles du XVIIIe siècle, Parigi, 1949. Barrey P., Les origines de la colonisation française aux Antilles, Le Havre, 1918. Bastide R., Les Amériques noires: les civilisations africaines dans le Nouveau Monde, Parigi, 1967, tr. it., Firenze, 1970. Bastide R., Le prochain et le lointain, Parigi, 1970. Bataillon M., Montaigne et les conquérants de l’or, « Studi Francesi », dic. 1959, pp. 353-367. Batie R. C., Why sugar? Economic cycles and the changing of staples in the English and French Antilles. 1624-1654, « Journal of caribbean history », 1976, n. 8-9, pp. 1-41. Baude P., L’affranchissement des esclaves aux Antilles françaises, principalement à la Martinique, du début de la colonisation à 1848, Fort-de -France, 1948. Baudet H., Paradise on earth. Some thoughts on European images on non-european man (tr. dall’olandese), New Haven - Londra, 1965. Bégouen-Demeaux M., Stanislas Foüche, négociant à Saint-Domingue, 1737-1806, Parigi, 1951. Bellegarde D., Histoire du peuple haïtien, Port-au-Prince, 1954. Bénard J.-Cl., L’armement honfleurais et le commerce des esclaves, «Annales de Normandie », ott. 1960, pp. 249-264. Bennett N. R., Christian and negro slavery in eighteenth century north Africa, « The journal of african history », 1960, n. 1, pp. 65-82. Benot Y., Diderot, Pechmeja, Raynal et l’anticolonialisme, « Europe », genn.-febb. 1963, pp. 137-153. Benot Y., « Capitalisme et esclavage » d’Éric Williams ou la philanthropie dévoilée, « La Pensée », 1969, n. 147, pp. 109-116. Benot Y., Diderot de l’athéisme à l’anticolonialisme, Parigi, 1970. Berbain S., Le comptoir français de Juda (Ouidah) au XVIIIe siècle. Études sur la traite des Noirs au golfe de Guinée, Parigi, 1942. Berlioux E. F., André Brue ou l’origine de la colonie française du Sénégal, avec une carte de la Sénégambie, Parigi, 1874. Besson M., La police des Noirs en France sous Louis XVI, « Revue d’histoire des colonies françaises », ott. 1928, pp. 433-446. Biondi C., La Rivoluzione francese e la schiavitù: buio a mezzogiorno o alba di liberazione?, «Spicilegio moderno», 1972, n. 1, pp. 139-146. Biondi C., Il «Drame raisonnable» di Delisle de Sales: gli ultimi saranno i primi? in Studi sull’uguaglianza. Contributi alla storia e alla tipologia critica di un’idea nell’areaa francese, a cura di C. Rosso, vol. I, Pisa, 1973, pp. 54-64. Biondi C., Mon frère, tu es mon esclave! Teorie schiaviste e dibattiti antropologicorazziali nel Settecento francese. Prefazione di C. Rosso, Pisa, 1973. Biondi C., Metamorfosi e palingenesi dello schiavo in un testo del «Pour et contre » di Prévost, « Spicilegio moderno », 1974, n. 3, pp. 13-24. Biondi C., « L’île des esclaves » di Marivaux come psicodramma sociale in Studi sull’uguaglianza a cura di C. Rosso, vol. II, Pisa, 1975, pp. 85-106. 288 Biondi C., Montesquieu, Strube et l’esclavage, postface a Strube de Piermont, Lettres russiennes a cura di C. Rosso, Pisa, 1978, pp. 191-209. Biou J., Lumières et anthropophagie, « Revue des sciences humaines », aprile-giugno 1972, pp. 224-233. Bissainthe M., Dictionnaire de bibliographie haïtienne, Washington, 1951. Bitter M., Haiti, Parigi, 1970. Blet H., Histoire de la colonisation française, Grenoble, 1946-1950, 3 voll. Bodard L., Le massacre des Indiens, Parigi, 1969. Bodiguel M., Corsaires et négriers, Parigi, 1970. Boerner P., The images of America in eighteenth century Europe, « Studies on Voltaire and the eighteenth century », 1976, CLI, pp. 323-332. Boissonade P., Saint-Domingue à la veille de la Révolution et la question de la représentation coloniale aux Etats-généraux, Parigi, 1906. Boiteau P., Contribution à l’histoire de la nation malgache, Parigi, 1958. Bolloc’h A. Y., Ménier M.-A., Dépôt des papiers publics des colonies: Saint-Domingue, notariat, « Revue d’histoire des colonies », XXXVIII, 1951, pp. 339-358. Borghero C., Raynal, Paine e la rivoluzione americana in La politica della ragione a cura di P. Casini, Bologna, 1978, pp. 349-381. Boscher J. F., French finances, 1770-1795: from business to bureaucracy, LondraNew York, 1970. Boss I. R., Linguet: the reformer as anti-«philosophe», «Studies on Voltaire and the eighteenth century », 1976, CLI, pp. 333-352. Bouis R., A propos de Grégoire, «Annales historiques de la Révolution», 1957, pp. 161-166. Bourde De La Rogerie H., Les Bretons aux îles de France et de Bourbon au XVIIe et au XVIIIe siècle, Rennes, 1934. Brathwaite E., The development of creole society in Jamaica, 1770-1820, Londra, 1971. Brette A., Les gens de couleur libres et leurs députés en 1789, «La Révolution française», XXIX, 1895, pp. 326-345; 385-407. Broc N., La géographie des philosophes. Géographes et voyageurs au XVIIIe siècle, Parigi, 1975. Brown G. W., The origins of abolition in Santo-Domingo, «The journal of negro history», VII, 1922, pp. 365-376. Brunschwig H., L’avènement de l’Afrique noire du XIXe siècle à nos jours, Parigi, 1963. Brunschwig H., Afrique noire, «Revue historique», gen.-mar. 1972, pp. 133-184 (rassegna bibliografica). Bryan E., A historical survey of the french colony of Santo Domingo (1801), Londra, 1976. Burmeister B., Les paradoxes de Linguet, « Dix-huitième siècle », 1975, n. 7, pp. 147-155. Butel P., Le trafic colonial de Bordeaux de la guerre d’Amérique à la Révolution, 289 « Annales du Midi », 1967, pp. 287-306. Cabon A., Histoire d’Haïti, Port-au-Prince, 1930-1938, 4 voll. Cahen L., La Société des Amis des Noirs et Condorcet, «La Révolution française», L, 1906, pp. 481-511. Calvet L. J., Linguistique et colonialisme. Petit traité de glottophagie, Parigi, 1974, tr. it. (ridotta), con saggio introduttivo di D. Canciani, Milano, 1977. Carpentier A., Il regno di questa terra, tr. it. Milano, 1959. Carpentier A., Le siècle des lumières, tr. fr. Parigi, 1962 ( prefazione di J. Blanzat). Carrière Ch., Négociants marseillais au XVIIIe siècle. Contribution à l’étude des économies maritimes, Marsiglia, 1973, 2 voll. Casini P., Introduzione all’Illuminismo. Da Newton a Rousseau, Bari, 1973. Castoldi A., Il fascino del colibrì. Aspetti della letteratura di viaggio esotica nel Settecento francese, Firenze, 1972. Cavignac J., Commerce colonial et commerce local dans le midi de la France (17181755), « Annales du Midi », gennaio 1965, pp. 47-57. Cento A., Condorcet e l’idea di progresso, Firenze, 1956. Césaire A., Discours sur le colonialisme, Parigi, 1955 (1970 7a ed.). Césaire A., Toussaint Louverture: la Révolution française et le problème colonial, prefazione di Ch. Julien, Parigi, 1961. Césaire A., La tragédie du roi Christophe, Parigi, 1964, tr. it. Torino, 1968. Chailley-Bert J., Les compagnies de colonisation sous l’Ancien Régime, Parigi, 1898. Chauleau L., La société à la Martinique au XVIII` siècle (1635-1713), Caen, 1966. Charles J.-Cl., Le corps de l’esclave. Saint-Domingue 1764. Le travail idéologique de l’information, « Les temps modernes », giugno 1978, pp. 1983-2020. Charpentier G., Les relations économiques entre Bordeaux et les Antilles au XVIIIe siècle, Bordeaux, 1937. Chaunu P., Las Casas et la première crise structurelle de la colonisation espagnole (1515-1523), « Revue historique », gen.-mar. 1963, pp. 59-102. Chaunu P., L’Amérique et les Amériques de la préhistoire à nos jours, Parigi, 1964. Chemin-Dupontes P., Les compagnies de colonisation en Afrique occidentale sous Colbert, Parigi, 1903. Chevalier A., Michel Adanson, voyageur, naturaliste et philosophe, Parigi, 1934. Chiche M.-Cl., Hygiène et santé à bord des navires négriers au XVIIIe siècle, Parigi, 1957. Chinard G., L’Amérique et le rêve exotique dans la littérature française au XVIIe et au XVIIIe siècles, Parigi, 1913 (rist. 1934). Chrétien J.-P., Esclavage et civilisation, « Esprit », genn. 1972, pp. 113-122. Cicognani D., La questione della schiavitù coloniale dal congresso di Vienna a oggi, Firenze, 1935. Clarke J. H., Slave revolts in the Caribbean islands, « Présence africaine », 1972, n. 84, pp. 117-130. Clavier J.-L. (a cura di), Toussaint-Louverture, d’après le «Mémoire abrégé des événements de Saint-Domingue depuis l’année 1789 jusqu’à celle de 1807, 290 « Revue d’histoire d’Outre-Mer », 1975, n. 3, pp. 462-504. Cocchiara G., Il mito del buon selvaggio, Messina, 1948. Cochin A., L’abolition de l’esclavage, Parigi, 1861, 2 voll. Confer V., French colonial ideas before 1789, « French historical studies », primavera 1964, pp. 338-359. Conti Oderisio G., S. N. H. Linguet. Dall’Ancien Régime alla Rivoluzione, Milano, 1976. Cook M., Jean-Jacques Rousseau and the negro, « Journal of negro history », luglio 1936, pp. 294-303. Cooper A. J., L’attitude de la France à l’égard de l’esclavage pendant la Révolution, Parigi, 1925. Coupland R., The British anti-slavery movement, Londra, 1964 (1a ed. 1933). Cornevin R., Histoire des peuples de l’Afrique noire, Parigi, 1960. Cornevin R., Histoire de l’Afrique, II: L’Afrique précoloniale, du tournant du XVIe siècle au tournant du XXe siècle, Parigi, 1966. Courlander H., The drum and the hoe: life and lore of the haitian people, Berkeley, 1960. Courteney C. P., Antonie-Laurent de Jussieu collaborateur de Raynal. Documents inédits, « Revue d’histoire littéraire de la France », aprile-giugno 1963, pp. 217227. Courteney C. P., Montesquieu and Burke, Oxford, 1963. Cox E. G., A referente guide to the literature of travel, Seattle, 1935-1949, 3 voll. Crocker L. G., An age of crisis: I, Man and world in eighteenth century thought, Baltimora, 1959; II, Nature and culture. Ethical thought in french enlightement, Baltimora, 1963. Crouse N. M., The french struggle for the West Indies (1665-1713), New York, 1943. Cruppi J.. Un avocat journaliste au XVIIIe siècle. Linguet, Parigi, 1885. Cultru P., Les origines de l’Afrique occidentale. Histoire du Sénégal du XVe siècle à 1870, Parigi, 1910. Curtin Ph. D., The image of Africa. British ideas and action, 1780-1850, Madison, 1964. Curtin Ph. D., Africa remembered. Narratives by west Africans from the era of the slave trade, Madison, 1967. Curtin Ph. D., The atlantic slave trade. A census, Madison-Londra, 1969. Daget S., La France et l’abolition de la traite des Noirs de 1814 à 1831. Introduction à l’étude de la repression française de la traite, Thèse de 3e cycle, Parigi, Centre d’études africaines, 1969. (Una sintesi della tesi è pubblicata in « Cahiers d’études africaines », 1971, n. 41, pp. 14-58). Daget S., Les mots esclave, nègre, noir et les jugements de valeur sur la traite négrière dans la littérature abolitionniste française de 1770 à 1845, « Revue française d’histoire d’Outre-Mer », 1973, n. 221, pp. 511-548. Dampierre J. de, Essai sur les sources de l’histoire des Antilles françaises, 1492-1664, Parigi 1904. 291 Dardel P., Le trafic maritime de Rouen aux XVIIe et XVIIIe siècles. Essai statistique, Rouen, 1946. Dardel P., Navires et marchandises dans les ports de Rouen et du Havre au XVIIIe siècle, Parigi, 1963. Dardel P., Commerce, industrie et navigation à Rouen et au Havre au XVIIIe siècle, Rouen, 1966. Daubigny E., Choiseul et la France d’Outre-Mer après le traité de Paris. Etude sur la politique coloniale au XVIIIe siècle, Parigi, 1892. Davidson B., The lost cities of Africa, Boston, 1959. Davidson B., La riscoperta dell’Africa (1959), tr. it., Milano 1963. Davidson B., Madre nera. L’Africa nera e il commercio degli schiavi (1961), tr. it.; Torino, 1966. Davidson B., La civiltà africana (1969), tr. it., Torino, 1972. Davies K. G., The Royal African company, Londra, 1957, New York, 1970. Davies O., West Africa before the Europeans, Londra, 1967. Davis A., Alcune note sul ruolo della donna nera nella comunità di schiavi in Donne bianche e nere nell’America dell’uomo bianco, tr. it., Milano, 1975, pp. 143-180. Davis B. D., Il problema della schiavitù nella cultura occidentale (1966), tr. it., Torino, 1971. Debbasch Y., Poésie et traite: l’opinion française sur le commerce négrier au début du XIXe siècle, «Revue française d’histoire d’Outre-Mer», 1961, n. 172-173, pp. 311-352. Debbasch Y., Le marronnage, essai sur la désertion de l’esclave antillais, « L’année sociologique », 1961, pp. 1-112; 1962, pp. 311-352. Debbasch Y., Le crime d’empoisonnement aux îles pendant la période esclavagiste, « Revue française d’histoire d’Outre-Mer », 2° trim., 1963, pp. 137-188. Debbasch Y., Couleur et liberté, le jeu du critère ethnique dans un ordre juridique esclavagiste, I : L’affranchi dans les possessions françaises de la Caraïbe, 16351833, Parigi, 1967. Debien G., Une plantation de Saint-Domingue, la sucrerie Galbaud du Fort (1690-1802), Il Cairo, 1941. Debien G., Le commerce nantais et la perte de Saint-Domingue d’après une correspondance de la maison Lebourg (1784-1800), « Revue de la Société d’histoire et de géographie d’Haïti », gennaio 1944, pp. 1-69. Debien G., Comptes, profits, esclaves et travaux de deux sucreries de Saint-Domingue (1774-1798), « Revue de la Société d’histoire et de géographie d’Haïti », ottobre 1944, pp. 1-60 e gennaio 1945, pp. 1-60. Debien G., Gouverneurs, magistrats et colons: l’opposition parlementaire et coloniale à Saint-Domingue, 1763-1769, « Revue de la Société d’histoire et de géographie d’Haïti », ottobre 1946, pp. 1-50. Debien G., Gens de couleur libres et colons de Saint-Domingue devant la Constituante, « Revue d’histoire de l’Amérique française », sett. 1950, pp. 211-232; dic. 1950, pp. 398-426; marzo 1951, pp. 530-549. 292 Debien G., Un roman colonial de V. Hugo, « Bug-Jargal », « Revue d’histoire littéraire de la France », gen.-marzo 1952, pp. 298-313. Debien G., La société coloniale aux XVIIe et XVIIIe siècles. I: Les engagés pour les Antilles (1634-1715), Parigi, 1952. Debien G., La société coloniale aux XVIIe et XVIIIe siècles. II: Les colons de SaintDominque et la Révolution. Essai sur le Club Massiac, août 1789-août 1792, Parigi, 1953. Debien G., Esprit colon et esprit d’autonomie à Saint-Domingue au XVIIIe siècle, Parigi, 1954 (2a ed). Debien G., Le Club des colons de la Rochelle (septembre 1789-octobre 1790), « Revue française d’histoire des colonies », XLIII, 1956, pp. 338-368. Debien G., Les colons des Antilles et leur main-d’œuvre à la fin du XVIIIe siècle, « Annales historiques de la Révolution française », 1955, pp. 259-283. Debien G., Etudes antillaises. XVIIIe siècle, Parigi, 1956. Debien G., Un colon sur sa plantation, Dakar, 1959. Debien G., Nouvelles de Saint-Domingue (1790-1791), « Annales historiques de la Révolution française », 1960, pp. 183-198. Debien G., Destinées d’esclaves à la Martinique (1746-1788), « Bulletin de l’Institut français d’Afrique Noire », gen.- apr. 1960, pp. 1-91. Debien G., Le Rd. P. Adolphe Cabon historien de Saint-Domingue et de la vie catholique en Haïti (1873-1961), « Revue française d’histoire d’Outre-Mer », 2° trim. 1961, pp. 458-461. Debien G., Les travaux d’histoire sur les Antilles françaises, chronique bibliographique (1959 et 1960), « Revue française d’histoire d’Outre-Mer », 2° trim. 1961, pp. 267-308. Debien G., Plantatations et esclaves à Saint-Domingue, Dakar, 1962. Debien G., Les Antilles françaises, « Revue française d’histoire d’Outre-Mer », 2° trim. 1963, pp. 227-267. Debien G., La nourriture des esclaves sur les plantations des Antilles françaises aux XVIIe et XVIIIe siècles, « Caribbean studies », 1964, n. 2, pp. 3-27. Debien G., Lettres de colons, Laval, 1965. Debien G., La christianisation des esclaves des Antilles françaises au XVIIe et au XVIIIe siècles, « Revue d’histoire de l’Amérique française », marzo 1967, pp. 525555; giugno 1967, pp. 99-111. Debien G., Petits cimetières de quartier et de plantation à Saint-Domingue au XVIIIe siècle, « Revue française d’histoire d’Outre-Mer », 1974, n. 225, pp. 522-541. Debien G., Les esclaves aux Antilles françaises (XVIIe-XVIIIe siècles), Basse-Terre Fort-de-France, 1974. Debien G. - Delafosse M., Marchands et colons des îles. Quelques lettres du XVIIe siècle, « Revue française d’histoire d’Outre-Mer », 1° trim. 1961, pp. 96-134. Debien G., Dermigny L., La Révolution aux Antilles. Marins et colons marchands et petits-blancs. Août 1790-août 1792, « Revue d’histoire de l’Amérique française », 293 1955, n. 4, pp. 496-517. Debien G., Felhoen-Kraal J., Esclaves et plantations de Surinam vus par Malouet,1777, « De West-Indisches Gids », gennaio 1955, pp. 53-60. Delacroix Mgr. S. (a cura di), Histoire universelle des missions catholiques, ParigiMonaco, 1956-1959, 4 voll. Delafosse M., La Rochelle et les îles au XVIIIe siècle, « Revue d’histoire des colonies », 1949, pp. 238-281. Delafosse M., Planteurs de Saint-Domingue et négociants rochelais au temps de Law, « Revue d’histoire des colonies », 1954, XLI, pp. 14-21. Delavignette R., Petite histoire des colonies françaises, Parigi, 1941. Delavignette R., Christianisme et colonialisme, Parigi, 1960. Delcourt A., La « Réponse à Malouet », « Annales historiques de la Révolution », 1939, pp. 444-450. Delcourt A., La finance parisienne et le commerce négrier au milieu du XVIIIe siècle, « Bulletin de la société d’études historiques et géographiques de la région parisienne », gen.- luglio 1948, pp. 21 ss. Delcourt A., La France et les établissements français au Sénégal entre 1713 et 1763, Dakar, 1952. Delesalle S. - Valensi L., Le mot « nègre » dans les dictionnaires d’Ancien Régime: histoire et lexicographie, « Langue française », sett. 1972, pp. 79-104. Delon M., Corps sauvages, corps étranges, « Dix-huitième siècle », 1977, n. 9, pp. 27-38. Delumeau J., Le trafic du port de Saint-Malo, Rennes, 1962. Dermigny L., Saint-Domingue et le Languedoc au XVIII` siècle, « Revue d’histoire des colonies » XLI, 1954, pp. 47-70. Derre J. R. (a cura di), L’habitation de Saint-Domingue ou l’insurrection (1824), di Ch. de Rémusat, Parigi, 1977. Deschamps H., Les méthodes et les doctrines coloniales de la France du XVI, siècle à nos jours, Parigi, 1953. Deschamps H., Histoire de Madagascar, Parigi, 1972. Deschamps H., L’Afrique tropicale aux XVIIe et XVIIIe siècles, Parigi, 1964. Deschamps H., L’Afrique noire précoloniale, Parigi, 1969, 2a ed. Deschamps H. (a cura di), Histoire générale de l’Afrique noire, de Madagascar et des archipels. I: Des origines à 1800, Parigi, 1970. Deschamps H., Histoire de la traite des noirs de l’antiquité à nos jours, Parigi, 1971, tr. it., Milano, 1974. Deschamps H., Les Européens hors d’Europe de 1434 à 1815, Parigi 1972. Deschamps L., Histoire de la question coloniale en France, Parigi, 1891. Deschamps L., Les colonies pendant la Révolution. La constituante et la réforme coloniale, Parigi, 1898. Devèze M., Histoire de la colonisation française en Amérique et aux Indes au XVIIIe siècle, Parigi, 1953. 294 Devèze M., L’Europe et le monde à la fin du XVIIIe siècle, Parigi, 1970. Diaz F., Filosofia e politica nel Settecento francese, Torino, 1973, 2a ed. Dieckmann H., Les contributions de Diderot à la « Correspondance littéraire » et à l’« Histoire des Deux Indes », « Revue d’histoire littéraire de la France », ott.-dic. 1951, pp. 417-440. Dieckmann H., Inventaire du fonds Vandeul et inédits de Diderot, Ginevra, 1951. Dodds M.. Les récits de voyages sources de l’« Esprit des lois » de Montesquieu, Parigi, 1929. Donnan E. (a cura di), Documents illustrative of the history of the slave trade to America, Washington, 1930-1935, 4 voll. Dorsainvil J. - Cl., Manue ld’histoire d’Haïti, Port-au-Prince, 1949. Dorsinville R., Toussaint Louverture ou la vocation de la liberté, Parigi, 1965. Doubout J.-J., Problèmes d’une période de transition. De Saint-Domingue à Haïti (1793-1806), « La Pensée », 1974, n. 174, pp. 67-80. Douglass F., Autobiografia di uno schiavo (1892), tr. it., Roma, 1978. (Introduzione di C. Beebe Tarantelli, nota bibliografica di A. Portelli). Douyon E. (a cura di), Culture et développement en Haïti, Montréal, 1972. Dubois (Col.), Le Robespierre des Colonies... Victor Hughes (1762-1826), «Revue historique de l’armée», 1963, n. 1, pp. 91-100. Ducasse A., Les négriers ou le trafic des esclaves, Parigi, 1948. Duchêne A., La politique coloniale de la France. Le ministère des colonies depuis Richelieu, Parigi, 1928. Duchêne A., Histoire des finances coloniales de la France, Parigi, 1938. Duchet M., Diderot collaborateur de Raynal, à propos des Fragments imprimés du fonds Vandeul, « Revue d’histoire littéraire de la France », ott.-dic. 1960, pp. 531556. Duchet M., Le « Supplément au voyage de Bougainville n et la collaboration de Diderot à l’« Histoire des Deux Indes », «Cahiers de l’Association internationale d’études françaises», 1961, pp. 173-187. Duchet M., Bougainville, Raynal, Diderot et les sauvages du Canada, « Revue d’histoire littéraire de la France », apr.-giu. 1963, pp. 228-36. Duchet M., Le primitivisme de Diderot, « Europe », 1963 (numero speciale su Diderot), pp. 126-37. Duchet M., « L’histoire des voyages »: originalité et influence in L’abbé Prévost, Atti del colloquio di Aix-en-Provence, 20-21 dic. 1963, Aix, 1965, pp. 145-154. Duchet M., Esclavage et humanisme en 1787: un mémoire inédit de Saint-Lambert sur les gens de couleur, « Annales historiques de la Révolution française », 1965, n. 3, riprodotto in Annexe al cap. III di Anthropologie et histoire au siècle des lumières (cfr. infra). Duchet M., Un ami de Diderot en Guyane: Vallet de Fayolle. A propos d’une lettre inédite, « Diderot studies », VIII, 1966, pp. 15-21. Duchet M., Monde civilisé et monde sauvage au siècle des lumières. Les fondements de l’anthropologie des philosophes, in Au siècle des Lumières, Parigi-Mosca, 295 1970, pp. 7-28. Duchet M., ed. di De l’homme di Buffon, Parigi, 1971. Duchet M., Anthropologie et histoire au siècle des lumières, Parigi, 1971 (nuova ed. con soppressione di note ed indici, 1977), tr. it., Bari, 1976-1977, 4 voll. Duchet M., Discours ethnologique et discours historique: le texte de Lafitau, « Studies on Voltaire and the eighteenth century », 1976, CLII, pp. 607-624. Duchet M., Diderot et l’histoire des Deux Indes ou l’écriture fragmentaire, Parigi, 1978. Ducrot O., Montesquieu et l’esclavage (I e II) in La preuve et le dire (in coll. con M. C. Barbault e J. Depresle), Parigi, 1973, pp. 185-208. Dufrénoy M.-L., L’orient romanesque en France (1704-1789), Montréal, 1946-1947, 2 voll. Dumond D. L., A bibliography of antislavery in America, Ann Arbor, 1961. Dupuy A., Spanish colonialism and the origin of underdevelopment in Haiti, « Latin american perspectives », 1976, n. 2, pp. 5-29. Ehrard J., L’idée de nature en France dans la première moitié du XVIIIe siècle, Parigi, 1963, 2 voll. Ehrard J., Jean-François Marmontel (1723-1799), Clermont-Ferrand, 1970. Elicone A.- L., Un colonial sous la Révolution en France et en Amérique. Moreau de Saint-Méry, Parigi, 1934. Elkins S., Slavery. A problem in American institutional and intellectual lite, Chicago, 1959. Ellery E., Brissot de Warville, a study in the history of the French revolution, Boston, 1915. Estancelin L., Recherches sur les voyages et découvertes des navigateurs normands en Afrique, dans les Indes Orientales et en Amérique, suivies d’observations sur la marine, le commerce et les établissements coloniaux des Français, Parigi, 1832. Etienne S.. Les sources de « Bug-Jargal ». Avec en appendice quelques sources de «Han d’Islande», Bruxelles, 1923. Everaert J., Les fluctuations du trafic négrier nantais (1763-1792), «Les cahiers de Tunisie», 1963, n. 43, pp. 37-62. Fanon F., Peau noire, masques blancs, Parigi, 1952, tr. it. con il titolo Il negro e l’altro, Milano, 1971 (2a ed.). Fanon F., Les damnés de la terre, Parigi, 1961, tr. it., Torino, 1971. Fanoudh-Siefer L., Le mythe du nègre et de l’Afrique noire dans la littérature française de 1800 à la 2e guerre mondiale, Parigi, 1968. Fernandez de Castro J. A., Tema negro en las letras de Cuba (1608-1935), L’Avana, 1943. Feugère A., Raynal, Diderot et quelques autres « historiens des deux Indes », « Revue d’histoire littéraire de la France », 1913, pp. 343-379. Feugère A., La doctrine révolutionnaire de Raynal et de Diderot d’après l’« Histoire des Indes », « Mercure de France », 1913, pp. 498-517. Feugère A., Un précurseur de la Révolution. L’abbé Raynal (1713-1796). Documents 296 inédits, Parigi, 1922. Feugère A., Bibliographie critique de l’abbé Raynal, Angoulême, 1922, rist. Ginevra, 1970. Filliot J. M., La traite des esclaves vers les Mascareignes au XVI1Ie siècle, Parigi, 1974. Forster H. J., Partners or captives in commerce? The role of Africans in slave trade, « Journal of black studies », 1976, n. 4, 421-434. Foubert B., Colons et esclaves du Sud de Saint-Domingue au début de la Révolution, «Revue française d’histoire d’Outre-Mer », 1974, n. 233, pp. 199-217. Fouchard J., Les marrons du syllabaire, Port-au-Prince, 1953. Fouchard J., Les joies de la lecture à Saint-Domingue au XVIIIe siècle, « Revue d’histoire des colonies », XLI, 1954, pp. 103-111. Fouchard J., Plaisirs de Saint-Domingue, Port-au-Prince, 1955. Fouchard J., Minette et Lise ... deux actrices de couleur sur les scènes de Saint Domingue, « Revue d’histoire des colonies», XLII, 1955, pp. 186-219. Fouchard J., Les marrons de la liberté, Parigi, 1972. Foury B., Maudave et la colonisation de Madagascar, Parigi, 1956. François-Primo J., La jeunesse de Brissot, Parigi, 1932. Frazier Th. R., Afro-american history: primary sources, New York, 1970. Freyre G., Padroni e schiavi. La formazione della famiglia brasiliana in regime di economia patriarcale (1958), tr. it., Torino, 1965. Frostin Ch., Histoire de l’autonomisme colon de la partie française de l’île de SaintDomingue aux XVIIe et XVIIIe siècles, Thèse d’état, Lille, 1973. Gaston-Martin, Nantes au XVIIIe siècle. L’ère des négriers (1714-1774), d’après des documents inédits, Parigi, 1931. Gaston-Martin, Histoire de l’esclavage dans les colonies françaises, Parigi, 1948. Gaston-Martin, L’abolition de l’esclavage (27 avril 1848), Parigi, 1948. Gay J., Bibliographie des ouvrages relatifs à l’Afrique et à l’Arabie (1875), Amsterdam, 1961. Gemery H. A., Hogendorn J. S., The uncommon market: the economies of the transatlantic slave trade, New YorK, 1979. Genovese E. D., L’economia politica della schiavitù (1961), tr. it., Troino, 1972. Genovese E. D., In red and black. Marxist explorations in southern and afroamerican history, New York, 1971. Genovese E. D., Neri d’America, tr, it., Roma, 1977. Gerbi A., La disputa del nuovo mondo. Storia di una polemica (1750-1900), MilanoNapoli, 1955. Gerbi A., La natura delle Indie Nove da Colombo a Gonzalo de Oviedo, Milano-Napoli, 1975. Gidney L. M., L’influence des Etats-Unis sur Brissot, Condorcet et Mme Roland, Parigi, 1930. Gilman M., Othello in France, Parigi, 1925. Girod F., La vie quotidienne de la société créole (Saint-Domingue au 18e siècle), 297 Parigi, 1972. Gisler A., L’esclavage aux Antilles françaises (XVIIe-XIXe siècle). Contribution au problème de l’esclavage, Friburgo, 1965. Gliozzi G., Adamo e il nuovo mondo. La nascita dell’antropologia come ideologia coloniale: dalle genealogie bibliche alle teorie razziali, Firenze, 1977. Godechot J., L’Europe et l’Amérique à l’époque napoléonienne, Parigi, 1967. Goggi G., (a cura di), Diderot Mélanges et morceaux divers II: Contribution à l’Histoire des deux Indes, Siena, 1977. Goyau G., Missions et missionnaires, Parigi, 1931. Goyau G., La France missionnaire dans les cinq parties du monde, Parigi, 1948. Gragnon-Lacoste Th. P., Toussaint L’Ouverture, Parigi, 1877. Grant D. The fortunate slave: an illustration of African slavery in the early eighteenth century, Londra, 1968. Gray R., Birmingham D. (a cura di), Precolonial african trade. Essays on trade in central and eastern Africa before 1900, Londra, 1970. Grimoüard H. de, L’amiral de Grimoüard au Port-au-Prince (mars 1791- juillet 1792), Parigi, 1937. Grotsky R. P., Le père J.-B. Labat (1663-1738): un voyageur «philosophe», City University of New York, 1976 (Doctoral dissertation). Groves C. P., The planting of christianity in Africa, Londra, 1948-1958, 4 voll. Grunebaum-Ballin P. F., Henri Grégoire, l’ami des hommes de toutes les couleurs. La lutte pour la suppression de la traite et l’abolition de l’esclavage, 1789-1831, Parigi, 1948. Guiducci R., La disuguaglianza fra gli uomini, Milano, 1977. Halgouet H. du, Nantes. Ses relations commerciales avec les îles d’Amérique au XVIIIe siècle. Ses armateurs, Rennes, 1939. Halgouet H. du, Au temps de Saint-Domingue et de la Martinique, d’après la correspondance des trafiquants maritimes, Rennes, 1941. Hanke L., Colonisation et conscience chrétienne au XVIe siècle, tr. fr., Parigi, 1957. Hanotaux G., Martineau A. (a cura di), Histoire des colonies françaises et de l’expansion de la France dans le monde, Parigi, 1929-1933, 6 voll. Hanstley R., Hargreaves J., Rise C., The transatlantic slave trade from West Africa, Edimburgo, 1965. Hardy Ch. O., The negro question in the French Revolution, Menasha, 1919. Hardy G., Géographie et colonisation, Parigi, 1933. Hardy G., Histoire de la colonisation française, Parigi, 1947 (5a ed). Hardy G., Histoire sociale de la colonisation française, Parigi, 1953. Hayot E., Les gens de couleur libres du Fort-Royal, 1679-1823, Parigi, 1971. Heawood E., A history of geographical discovery in the seventeenth and eighteenth centuries, Cambridge, 1912. Herskovits M. J., Il mito del passato negro, tr. it., Firenze, 1976. Hoffmann L.-F., Balzac et les noirs, « Année balzacienne », 1966, pp. 297-308. Hoffmann L.-F., Le nègre romantique. Personnage littéraire et obsession collective, 298 Parigi, 1973. Hoffmann L.-F., En marge d’un article du «Pour et contre»: Prévost et l’esclavage colonial in Essays on the age of enlightenment in honor of Ira O. Wade, GinevraParigi, 1977, pp. 155-168. Hunting Cl., The « philosophes » and black slavery: 1748-1765, « Journal of the history of Ideas », luglio-sett. 1978, pp. 405-418. Hurault J., Les noirs réfugiés Boni de la Guyane française, Dakar, 1961. Hurbon L., Dieu dans le Vaudou haïtien, Parigi, 1972. Idinson L. A., The negro as metaphor. A study of esthetic and ethical negativism in English, Spanish and French literatures, Tesi dell’Università del Michigan, 1969. Irvine K., The rise of the colored races, Londra, 1972 (la ed. americana 1970). James C. L. R., I Giacobini neri. La prima rivolta contro l’uomo bianco (1963), tr. it., Milano, 1968. James C. L. R., Il commercio atlantico degli schiavi e la schiavitù. Alcune interpretazioni della loro importanza nello sviluppo degli Stati Uniti e del mondo occidentale in Da schiavo a proletario, Torino, 1973. James C. L. R., De Toussaint L’Ouverture à Fidel Castro, «Casa de las Americas», 1975, n. 91, pp. 64-69. Jameson R. P., Montesquieu et l’esclavage. Étude sur les origines de l’opinion antiesclavagiste en France au XVIIIe siècle, Parigi, 1911. Janin J., Le clergé colonial de 1815 à 1850, Parigi, 1936. Janin J., La religion aux colonies françaises sous l’Ancien Régime, Parigi, 1942. Jaray G.-L., L’empire français d’Amérique (1534-1803), Parigi, 1938. Jaulin R., La paix blanche. Introduction à l’ethnocide, Parigi, 1970 (rist. 1974, 2 voll.), tr. it., Bari, 1972. Jaulin R., (a cura di) Le livre blanc de l’ethnocide en Amérique, Parigi, 1972. Jervey Th. D., The slave trade: slavery and color, Columbia (South Carolina), 1926. Joachim B., L’indemnité coloniale de Saint Domingue et la question des rapatriés, « Revue historique », ott.-dic., 1971, pp. 359-76. Joachim B., La reconnaissance d’Haïti par la France (1825): naissance de rapports internationaux de type néo-colonial, « Bulletin de la société d’histoire moderne », 1974, n. 7, pp. 21-28. Jore L., Les établissements français sur la côte occidentale d’Afrique de 1758 à 1809, Parigi, 1965. Julien Ch. A., Les voyages de découverte et les premiers établissements (XVe-XVIe siècle), Parigi, 1948. Julien Ch. A., Les Français en Amérique (1713-1784), Parigi, 1953. Kain R. M., The problem of civilisation in english abolition literature, 1772-1808, « Philological Quarterly », apr. 1936, pp. 103-125. Kerboull J., Le Vaudou, magie ou religion?, Parigi, 1973. Klein H. S., Slavery in the Americas. A comparative study of Virginia and Cuba, Chicago, 1967. Klingberg F. J., The anti-slavery movement in England, New Haven, 1926. 299 Labriolle M. R., Les sources du « Pour et contre » (1733-1734), « Revue de littérature comparée », aprile-giugno 1959, pp. 239-57. Labriolle M. R., Les sources anglaises du «Pour et contre» in L’abbé Prévost, Atti del colloquio di Aix-en-Provence, 20-21 dic. 1963, Aix, 1965, pp. 93-100. Labriolle M. R., Le «Pour et contre » et son temps, « Studies on Voltaire and the eighteenth century », 1965, voll. XXIV e XXV. Lacombe R., Histoire monétaire de Saint-Domingue et de la république d’Haïti jusqu’à 1874, Parigi, 1958. Lacour A., Histoire de la Guadeloupe, Basse-Terre, 1855-1860, 4 voll., rist., Parigi, 1960. Lacroix F.-J. P. de, Mémoires pour servir à l’histoire de la Révolution à Saint Domingue, Parigi, 1819, 2 voll. Lafaye J., Les conquistadores, Parigi, 1964. Lafontant J. J., Montesquieu et le problème de l’esclavage, State University of New York at Binghamton, 1976 (Doctoral dissertation). La Gravière E., Grégoire et l’esclavage, « Europe », apr.-sett., 1956, pp. 26-46. Lainé J., Les négriers (romanzo), Parigi, 1970. Landucci S., I filosofi e i selvaggi: 1580-1780, Bari, 1972. La Roncière Ch., Nègre set négriers, Parigi, 1933. Lasserre G., La Guadeloupe, Bordeaux, 1961, 2 voll. Lebeau A., De la condition des gens de couleur libres sous l’Ancien Régime, d’après des documents des archives coloniales, Parigi, 1903. Lebel R., L’Afrique occidentale dans la littérature française depuis 1870, Parigi, 1925. Lebel R., Etudes de littérature coloniale, Parigi, 1928. Lebel R., Histoire de la littérature coloniale en France, Parigi, 1931. Lebel R., Les établissements français d’Outre-Mer et leur reflet dans la littérature, Parigi, 1952. Le Blant R., Les études historiques sur la Martinique pour la période française jusqu’en 1789, « Revue d’histoire des colonies », 1948, XXXV, pp. 270-83. Leclerc G., Anthropologie et colonialisme. Essai sur l’histoire de l’africanisme, Parigi, 1972, tr. it., Milano, 1973. Leiris M., L’ethnographie devant le colonialisme, «Temps modernes», 1950, n. 58, pp. 357-374, rist. in Cinq études d’ethnologie, Parigi, 1969, pp. 83-112. Lémery H., La Révolution française à la Martinique, Parigi, 1936. Lengellé M., L’esclavage, Parigi, 1967. Léon P., Structures du commerce extérieur et évolution industrielle de la France à la fin du XVIIIe siècle in Conjoncture économique. Structures sociales. Hommage à Ernest Labrousse, Parigi - L’Aia, 1974, pp. 407-432. Le Ruzic I., Documents sur la mission des Frères-Prêcheurs à Saint-Domingue, Lorient, 1912. Lévi-Strauss Cl., La pensée sauvage, Parigi, 1962. Levy D. G., Simon Linguet‘s sociological system: an exhortation to patience and 300 invitation to revolution, « Studies on Voltaire and the eighteenth century », 1970, LXX, pp. 219-293. Lichtenberger A., Le socialisme utopique. Études sur quelques précurseurs du socialisme, Parigi, 1898, rist. Ginevra, 1970. Lokke C. L., France and the colonial question of contemporary French opinion (1763-1801), New York, 1932, rist. 1968. Lokke C. L., Le plaidoyer de Malouet en faveur de l’esclavage en 1789, «Annales historiques de la Révolution », 1938, pp. 193-204. Lokke C. L., Malouet and the Saint-Domingue mulatto question in 1793, « Journal of negro history”, XXIV, 1939, pp. 381-389. Lougnon A., Documents concernant les îles Bourbon et de France, pendant la régie de la Compagnie des Indes. Répertoire des pièces conservées dans les divers dépôts d’archives de Paris, Nérac, 1953. Lougnon A., L’île Bourbon pendant la Régence, Parigi, 1957. Lucas E., La littérature anti-esclavagiste au XIXe siècle. H. B. Stowe et son influence en France, Parigi, 1930. Ly A., La Compagnie du Sénégal, Parigi, 1958. Machat J., Documents sur les établissements français de l’Afrique occidentale au XVIIIe siècle, Parigi, 1906. Mackenzie-Grieve A., The last years of the English slave trade. Liverpool, 17501807, Londra, 1941, rist. 1968. Madiou T., Histoire d’Haïti, Parigi, 1923 Malenfant (col.), Des colonies et particulièrement de Saint-Domingue, Parigi, 1814. Malueg S. E., America in the «Encyclopédie», « Studies on Voltaire and the eighteenth century », 1976, CLIII, pp. 1381-1387. Mannix D., Cowley M., Carico nero. Una storia del commercio degli schiavi in Atlantico (1518-1865), (1962), tr. it., Milano, 1964. Mannoni O., Prospero et Caliban: psychologie de la colonisation, Parigi, 1950. Marcelin Ph. e P., Contes et légendes d’Haïti, Parigi, 1967. Marchand-Thébault M. L., L’esclavage en Guyane française sous l’Ancien Régime, « Revue française d’histoire d’Outre-Mer », XLVII, n. 166, 1960, pp. 5-75. Marienstras E., Les mythes fondateurs de la nation américaine, Parigi, 1976. Martin E., The British west African settlements (1750-1821), Londra, 1927. Martin-Allanic J.-E., Bougainville navigateur et les découvertes de son temps, Parigi, 1964, 2 voll. Martineau A., May L. Ph., Trois siècles d’histoire antillaise, Martinique et Guadeloupe de 1635 à nos jours, Parigi, 1935. Masse F., The negro race in French literature, « Journal of negro history », XVIII, 1933, pp. 225-245. Maurel B., Cahiers de doléances de la colonie de Saint-Domingue pour les Etats généraux de 1789, Parigi, 1933. Maurel B., Saint-Domingue et la Révolution française. Les représentants des colons en France de 1789 à 1795, Parigi, 1943. 301 Maurel B., Le vent du large ou le destin tourmenté de Jean-Baptiste Gérard, colon de Saint-Domingue, Parigi, 1952. Maurel B., Une société de pensée à Saint-Domingue: le «Cercle des Philadelphes» au Cap Français, « Revue française d’histoire d’Outre-Mer » 2° trim. 1961, pp. 234-266. Maurel B., Taillemite E. (a cura di), Description de la partie française de l’île de Saint-Domingue (1797) di Moreau de Saint-Méry, Parigi, 1958, 3 voll. Mauro F., L’expansion européenne (1600-1870), Parigi, 1967. May L. Ph., Histoire économique de la Martinique (1635-1736), Parigi, 1930. May L. Ph., Le Mercier de la Rivière intendant des îles-du-Vent, 1759-1764, « Revue d’histoire économique », 1932, XX, pp. 44-74. Mc Cloy Sh. T., Negroes and mulattoes in eighteenth-century France, « Journal of negro history », 1945, pp. 276-292. Mc Cloy Sh. T., The negro in France, Lexington, 1961. Mc Cloy Sh. T., The negro in English literature, Ilfracombe, 1962. Mc Cloy Sh. T., The negro in French west Indien, Lexington, 1966. Mc Intosh M. E., Weber B. C. (a cura di), Une correspondance familiale au temps des troubles de Saint-Domingue (1791-1796). Lettres du marquis et de la marquise de Rouvray à leur fille, Parigi, 1959. Meillassoux C. (a cura di), L’esclavage en Afrique précoloniale, Parigi, 1975. Mellafe R., Negro slavery in Latin America, tr. ingl., Berkley-Los Angeles-Londra, 1975. Memmi A., Portrait du colonisé, Montréal, 1964, rist. preceduto da Portrait du colonisateur, pref. di J.-P. Sartre, Parigi, 1966. Memmi A., L’homme dominé, Parigi, 1968. Mercier R., La réhabilitation de la nature humaine (1700-1750), Villemomble, 1960. Mercier R., Les débuts de l’exotisme africain en France, « Revue de Littérature comparée », 1962, n. 36, pp. 191-209. Mercier R., L’Afrique noire dans la littérature française. Les premières images (XVIIe et XVIIIe siècles), Dakar, 1962. Mercier R., Image de l’autre et image de soi-même dans le discours ethnologique au XVIIIe siècle, « Studies on Voltaire and the eighteenth century », 1976, CLIV, pp. 1417-1436. Merrien J., Histoire mondiale des pirates, flibustiers et négriers, Parigi, 1959. Métral A., Histoire de l’expédition des Français à Saint-Domingue sous le consulat de. Napoléon Bonaparte, Parigi, 1825. Métraux A., Le Vaudou haïtien, Parigi, 1958, tr. it., Torino, 1971. Meyer J., Le commerce négrier nantais (1774-1792), «Annales», febb.- marzo 1960, pp. 120-129. Meyer J., La noblesse bretonne au XVIIIe siècle, Parigi, 1966. Meyer J., L’armement nantais dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, Parigi, 1969. Michel A., La mission du général Hédouville à Saint-Domingue, Port-Au-Prince, 1929. 302 Mirabeau (Les) et leur temps, Actes du colloque d’Aix-en-Provence, 17-18 dic. 1966, Parigi, 1968. Montague L. L., Haiti and the United States, 1774-1938, Durham, 1940. Moral P., L’économie haïtienne, Port-au-Prince, 1959. Moran Ch., Black triumvirate: a study of L’Ouverture, Dessalines, Christophe. The men who made Haiti, New York, 1957. Moravia S., Il tramonto dell’Illuminismo. Filosofia e politica nella società francese (1770-1810), Bari, 1968. Moravia S., La scienza dell’uomo nel Settecento, Bari, 1970. Moravia S., Il pensiero degli «idéologues». Scienza e filosofia in Francia (1780-1815), Firenze 1974. Morénas J.-E., Précis historique de la traite des noirs et de l’esclavage colonial, Parigi, 1828. Mortier R., Diderot anticolonialiste, « Revue belge de philologie et d’histoire », 1971, n. 3, pp. 892-901. Moya Pons F., Notas sobre la primera abolición de la esclavitud en Santo Domingo, « Eme-Eme », 1974, n. 13, pp. 3-26. Nemours A., Histoire militaire de la guerre d’indépendance de Saint-Domingue. I: La campagne de Leclerc contre Toussaint-Louverture. II: Les glorieux combats des divisions du Nord, Parigi, 1925-1928, 2 voll. Nemours A., Histoire de la captivité et de la mort de Toussaint-Louverture. Notre pèlerinage au Fort de Joux, Parigi, 1929. Nemours A., Haïti et la guerre d’indépendance américaine, Port-au-Prince, 1952. Noël K., La condition matérielle des esclaves à l’île de France, période française (1715-1810), « Revue d’histoire des colonies », 1954, XLI, pp. 303-313. Olsen O., La conquête de la terre: histoire des découvertes et des explorations depuis les origines jusqu’à nos jours, Parigi, 1933-1936. Pageard R., Un mystérieux voyage au pays de Bambouc (1789), « Notes africaines » , gennaio 1961, pp. 27-37. Palmer R., The age of the democratic revolution: a political history of Europe and America, 1760-1800, Princeton, 1959-1964, 2 voll. Patient S., Le nègre du gouverneur (Chronique coloniale), Parigi, 1972. Patterson O., The sociology of slavery: an analysis of the origins, development and structure of negro slave in Jamaica, Rutherford, 1969. Pernoud R., L’Amérique du Sud au XVIIIe siècle, Mantes, 1942. Petit E., Droit public ou gouvernement des colonies françaises d’aprèss les lois faites pour ces pays (1771), introduzione di A. Girault, Parigi, 1911. Peyronnet P., L’exotisme américain sur la scène française au XVIIIe siècle, « Studies on Voltaire and the eighteenth century », 1976, CLIV, pp. 1617-1628. Peytraud L., L’esclavage aux Antilles françaises avant 1789, Parigi, 1897. Piras G.. Studi recenti sul problema della schiavitù, « Storia contemporanea », giugno 1973, pp. 345-359. Pire G., J.-J. Rousseau et les relations de voyage, « Revue d’histoire littéraire de la 303 France », luglio-sett. 1956, pp. 355-378. Placido B., Le due schiavitù. Per un’analisi dell’immaginazione americana, Torino 1975. Pluchon P., Haïti, république caraïbe, Parigi, 1974. Poliakov L., Les idées anthropologiques des philosophes du siècle des Lumières, « Revue française d’histoire d’Outre-Mer », 1971, n. 212, pp. 255-278. Pons E., Le « voyage », genre littéraire au XVIIIe siècle, « Bulletin de la Faculté des Lettres de Strasbourg », 1925-1926, t. IV, pp. 97-101; 144-149; 201-207. Pope-Hennessy J., Sins of the fathers. A study of the Atlantic slave traders (14411807), Londra, 1967. Pouget De Saint-André H., La colonisation de Madagascar sous Louis XV, d’après la correspondance inédite du comte de Maudave, Parigi, 1886. Poyen H. de, La guerre des Antilles de 1793 à 1815, Parigi, 1896. Poyen H. de, Histoire militaire de la révolution de Saint-Domingue, Parigi, 1899. Price-Mars J., Silhouettes de nègres et négrophiles, Parigi, 1959. Proust J., A propos d’un fragment de lettre de Diderot (1769), « Studi Francesi », 1959, n. 7, pp. 88-91. Proust J., Diderot et l’Encyclopédie, Parigì, 1962. Queneuil H., De la traite des Noirs et de l’esclavage (La conférence de Bruxelles et ses résultats), Bruxelles, 1907. Ralaimihoatra E., Histoire de Madagascar des origines à la fin du XIXe siècle, Tananarive, 1965. Rambert G. (a cura di), Histoire du commerce de Marseille, Parigi, 1951-1967, 7 voll. Rawick G. P., Lo schiavo americano dal, tramonto all’alba. La formazione delle comunità nere durante la schiavità negli Stati Uniti (1972), tr. it., Milano, 1973. Redsons V., Genèse des rapports sociaux en Haïti (1492-1970), Parigi, 1971. Reimers D., White protestantism and the negro, New York, 1965. Renault F.-P., Le « pacte de famille » et l’Amérique. La politique coloniale francoespagnole de 1760 à 1792, Parigi, 1922. Rennard J., Essai bibliographique sur l’histoire religieuse des Antilles françaises, Parigi, 1932. Rennard J., Arrivée des femmes aux Antilles, « Revue d’histoire des colonies », 1935, XXVIII, pp. 135-48. Rennard J., Documents inédits publiés à l’occasion du troisième centenaire des Antilles, Guadeloupe, 1635-1935, Basse-Terre, 1935. Rennard J., Histoire religieuse des Antilles françaises des origines à 1914, Parigi, 1954. Retamar R. F., Caliban cannibale, Parigi, 1973. Richard R., Les minutes des notaires de Saint-Domingue aux archives du ministère de la France d’Outre-Mer, « Revue d’histoire des colonies », 1951, XXXVIII, pp. 281-338. 304 Riddell W. R., Le Code noir, «Journal of negro history», luglio 1925, pp. 321-329. Rinchon D., La traite et l’esclavage des Congolais par les Européens, Bruxelles, 1929. Rinchon D., La campagne négrière du Pompée (1768-1770), « Etudes franciscaines », 1935, XLVII, pp. 473-499, 523-547; 1936, XLVIII, pp. 67-93. Rinchon D., Le trafic négrier, d’après les livres de commerce du capitaine gantois Pierre-Ignace-Liévin Van Alstein, Parigi, 1938. Rinchon D., Les armements négriers au XVIIIe siècle, d’après la correspondance et la comptabilité des armateurs et des capitaines nantais, Bruxelles, 1956. Rinchon D., Pierre-Ignace-Liévin Van Alstein capitaine négrier. Gand 1733-Nantes 1793, Dakar, 1964. Roberts A. W., Les Français aux Indes occidentales, tr. fr., Montréal, 1946. Rodney W., West Africa and the Atlantic slave trade, Nairobi, 1969. Rodney W., A history of the upper Guinea coast (1545-1800), Oxford, 1970. Roelens M., L’expérience de l’espace américain dans les récits de voyage entre La Hontan et Charlevoix, « Studies on Voltaire and the eighteenth century », 1976, CLV, pp. 1861-1896. Roger J., Les sciences de la vie dans la pensée française du XVIIIe siècle, Parigi, 1963. Romano R., Les mécanisme de la conquête: les conquistadores, Parigi, 1972, tr. it.. Milano, 1974. Rosso C., Montesquieu et Dupin (un éreintement avorté), in appendice a Montesquieu moraliste. Des lois au bonheur, Bordeaux, 1971 (la edizione it. Pisa, 1965). Rosso C., Montesquieu, Voltaire et la cueillette des fruits au Canada ou l’inégalité par le dénigrement in Studi sull’uguaglianza, saggi a cura di C. Rosso, Pisa, 1973, I, pp. 32-53, rist. in Inventari e postille. Letture francesi e divagazioni europee, Pisa, 1974, pp. 295-319. Rosso C., Montesquieu présent: études et travaux depuis 1960, « Dix-huitième siècle », 1976, n. 8, pp. 373-404. Rosso C., Uguaglianza, pluralismo, elitismo nel pensiero del Settecento francese, «Spicilegio moderno », 1977, n. 8, pp. 106-114. Rosso C., La schiavitù è un destino? (recensione all’opera di Guiducci, La disuguaglianza fra gli uomini, v. supra), « Uomini e libri », marzo-apr. 1978, pp. 2426. Roussier P., L’ancien clergé colonial français, « Revue d’histoire des missions », dic. 1928- marzo 1930. Roussier P., L’application des lois de la Révolution aux colonies françaises (17891802), «Cahiers de la Révolution française », 1935, t. III, pp. 45-71. Roussier P. (a cura di), Lettres du général Leclerc, Parigi, 1937. Rouvellat de Cussac J.-B., Situation des esclaves dans les colonies françaises, Parigi, 1845. Roux Ph. de, Le marquis Casaux, un planteur des Antilles inspirateur de Mirabeau, Parigi, 1951. 305 Ryder A. F. C., Benin and the Europeans, 1485-1897, Londra, 1969. Sabin J. (cont. da Eames W. e terminato da Vail R. W. G.), A dictionary of books relating to America from its discovery to the present time, New York, 1868-1936, 29 voll. in 15 tomi, rist., Amsterdam, 1961. Sachs L., L’image du Noir dans l’art européen, «Annales», luglio-agosto 1969, pp. 883-892. Saintoyant J.-F., La colonisation française sous l’Ancien Régime, Parigi, 1929, 2 voll. Saintoyant J.-F., Les colonies françaises pendant la Révolution (1789-1799). I: Les assemblées révolutionnaires et les colonies. II: Les événements coloniaux, Parigi, 1930, 2 voll. Saintoyant J.-F., La colonisation française pendant la période napoléonienne (17991815), Parigi, 1931. Sainville L., La captivité et la mort de Toussaint-Louverture, « Présence africaine », 1970, n. 78, pp. 238-251. Sannon P., Histoire de Toussaint-L’Ouverture, Port-au-Prince, 1920-1933, 3 voll. Sarrien M., La traite des nègres et le droit de visite au cours du XIXe siècle dans les rapports de la France et de l’Angleterre, Parigi, 1910. Satineau M., Histoire de la Guadeloupe sous l’Ancien Régime, 1635-1789, Parigi, 1928. Satineau M., Schœlcher, héros de l’abolition de l’esclavage dans les possessions françaises, Parigi, 1948. Savine A., Saint-Domingue à la veille de la Révolution (Souvenirs du baron de Wimpffen), Parigi, 1911. Scaglione A., A note on Montaigne‘s « Des cannibales » and the humanist tradition, in First images of America. The impact of the new world on the old, a cura di F. Chiappelli, Berkeley - Los Angeles - Londra, 1976, pp. 63-70. Scharon F., Toussaint Louverture et la révolution de Saint-Domingue, Port-au-Prince, 1957. Schéfer Ch., La France moderne et le problème colonial (1815-1830), Parigi, 1907. Schéfer Ch., (a cura di), Instructions générales données de 1763 à 1870 aux gouverneurs et ordonnateurs des établissements français en Afrique occidentale, Parigi, 1921-1927, 2 voll. Schérer E., Les mémoires de Malouet in Etudes sur la littérature au XVIIIe siècle, Parigi, 1891, pp. 293-326. Schnakenbourg Ch., Introduction aux archives anciennes de la Guadeloupe (17541848), «Revue historique », 1969, n. 242, pp. 105-120. Schœlcher V., Les colonies françaises: abolition immédiate de l’esclavage, Parigi, 1842. Schœlcher V., Vie de Toussaint-Louverture, Parigi, 1889. Schœlcher V., Esclavage et colonisation, premessa di Ch. A. Julien, intr. di A. Césaire, testi scelti e annotati da E. Tersen, Parigi, 1948. Sebbar-Pignon L., Le mythe du bon nègre ou l’idéologie coloniale dans la production romanesque du XVIIIe siècle, « Les temps modernes », 1974, n. 336, pp. 2349- 306 2375 e numeri 337-38, pp. 2589-2631. Sée H., Le commerce de Saint-Malo dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, «Revue internationale du commerce, de l’industrie et de la banque», sett. 1924, pp. 44-109. Sée H., Les économistes et la question coloniale au XVIIIe siècle, « Revue d’histoire des colonies », 1929, XXII, pp. 381-92. Seeber E. D., Parny as un opponent of slavery, « Modern language notes », 1934, XLIX, pp. 360-366. Seeber E. D., Anti-slavery opinion in the poems of some early French followers of James Thomson, « Modern language notes », 1935, L, pp. 427-434. Seeber E. D., Oroonoko in France in the XVIIIth century, « Publications of modern language association», dic. 1936, pp. 935-959. Seeber E. D., Anti-slavery opinion in France during the second hall of the eighteenth century, Baltimora, 1937, rist. New York, 1969. Sgard J., Prévost, de l’ombre aux lumières (1736-1746), « Studies on Voltaire and the eighteenth century », 1963, XXVII, pp. 1479-1487. Sgard J., Prévost romancier, Parigi, 1968. Sgard J., Le « Pour et contre » de Prévost, Parigi, 1969. Shyllon F. O., Black slavery in Britain, Londra-New York-Ibadan, 1974. Sik E., Storia dell’Africa nera (1970), tr. it., Milano, 1977, 4 voll. Simon K., L’esclavage, Parigi, 1930. Slave insurrections: selected documents, Westport, 1970. Smith R. W., Edmund Burke negro code: slavery and the slave trade, « History today », 1976, pp. 715-723. Stern A., La vie de Mirabeau, tr. fr., Parigi, 1895-1896, 2 voll. Stoddard T. L., The french Revolution in San Domingo, Boston-New York, 1914. Street B. V., The savage in literature, Londra, 1975. Strickland D. A., Kingship and slavery in African thought: a conceptual analysis, « Comparative studies in society and history », 1976, n. 3, pp. 371-394. Sypher W., Guinea’s captive kings: british anti-slavery literature of the eighteenth century, Chapel Hill, 1942. Taillemite E., Moreau de Saint-Méry et les Angevins de Saint-Domingue avant la Révolution, «Bulletin de l’Académie d’Angers» , 1958, pp. 45-46. Tardon R., Le combat de Schœlcher, Parigi, 1948. Tarrade J., L’administration coloniale en France à la fin de l’Ancien Régime, «Revue historique», gen.-marzo 1963, pp. 103-122. Tersen E., Histoire de la colonisation française, Parigi, 1950. Thérou (abbé), Le christianisme et l’esclavage, suivi d’un traité historique de Mœlher sur le même suiet, Parigi, 1841. Tild J., L’abbé Grégoire d’après ses mémoires, recueillis par Hippolyte Carnot, Parigi, 1946. Tinland F., L’homme sauvage, pref. di G. Gusdorf, Parigi, 1968. Toussaint A., L’administration française de l’île Maurice et ses archives (1721-1821), Port-Louis, 1965. 307 Toussaint A., Histoire de l’île Maurice, Parigi, 1971. Toussaint A., Histoire des îles Mascareignes, Parigi, 1972. Toussaint A., L’océan Indien au XVIII’ siècle, Parigi, 1974. Toussaint A., Les Lyonnais à l’Ile-de-France (Ile Maurice), 1721-1810, «Cahiers d’histoire», 1975, n. 1, pp. 39-58. Toussaint A., Le mirage des îles. Le négoce français aux Mascareignes au XVIIIe siècle, Aix-en-Provence, 1977. Tramond J., Saint-Domingue en 1756 et 1757, d’après la correspondance de l’ordonnateur Lambert, Parigi. 1928. Tramond J., Les études historiques françaises sur les Antilles depuis 1900, «Revue d’histoire des colonies», 1931, XXIV, pp. 409-418. Tramond J. (a cura di), Les colonies et la vie française pendant huit siècles, Parigi, 1933. Trayer P., Étude historique de la condition légale des esclaves dans les colonies françaises, Parigi, 1887. Treudley M., The United States and Santo Domingo, 1789-1866, «Journal of race development» 1916-1917, VII, pp. 83-145; 220-274. Trouillot H., La condition des nègres domestiques à Saint-Domingue, Port-au-Prince, 1955. Trouillot H., La guerre de l’indépendance d’Haïti: les grands prêtres du vodou contre l’armée française, « Revista de historia de América », 1971, n. 72, pp. 259-327. Trouillot H., La guerre de l’indépendance d’Haïti, « Revista de historia de América », 1972, n. 73-74, pp. 75-130. Ulvioni P., Un aspetto dell’ideologia prerivoluzionaria. L’«Histoire des deux Indes» e Raynal, «Critica storica », sett. 1972, pp. 357-396. Vaissière P. de, Saint-Domingue, 1629-1789. La société et la vie créoles sous l’Ancien Régime, Parigi, 1909. Vandercook J. W., Black majesty: the life of Christophe, king of Haiti, New York, 1928. Vaulx B. de, Histoire des missions catholiques françaises, Parigi, 1951. Venturi F., Un enciclopedista: Alexandre Deleyre, « Rivista storica italiana », 1965, IV, pp. 791-824. Venturi F., Utopia e riforma nell’Illuminismo, Torino, 1973. Verger P., Flux et reflux de la traite des nègres entre le golfe de Bénin et Bahia de Todos os Santos, du dix-septième au dix-neuvième siècle, Parigi-L’Aia, 1968. Verguin J., La politique de la Compagnie des Indes dans la traite des noirs à l’île Bourbon (1662-1672), «Revue historique», ott.-dic. 1956, pp. 45-48. Vidalenc J., La traite des nègres en France au début de la Révolution, «Annales historiques de la Révolution française», apr.-giugno 1957, pp. 56-69. Vignes J., Sguardo sull’Africa, tr. it., Milano, 1968. Vignols L., Les esclaves coloniaux en France, aux XVIIe et XVIIIe siècles, Rennes, 308 1927. Vignols L., Les sources de « Tamango » de Mérimée et la littérature négrière à l’époque romantique, « Mercure de France », dic. 1927, pp. 542-557. Vignols L., Etudes négrières de 1774 à 1928. Pourquoi la date de 1774, « Revue d’histoire économique et sociale », 1928, pp. 5-11. Vignols L., Le dictionnaire universel de Savary de Bruslons. L’opinion des négociants nantais, «Annales de Bretagne», 1929, pp. 742-751. Vignols L., Etudes négrières de 1774 à 1928, Parigi, 1929. Vignols L., Une question mal posée: le travail manuel des Blancs et des esclaves aux Antilles (XVIIe-XVIIIe siècles), « Revue historique », marzo-apr. 1935, pp. 308315. Vinogradov A., The black consul, tr. ingl., Londra, 1935. Wallon H., Histoire de l’esclavage dans l’antiquité, Parigi, 1847. Waxman P., The black Napoleon, New York, 1931. Weber H., La Compagnie française des Indes (1604-1875), Parigi, 1904. Wellard J., The merchandise was human, « Horizon », 1965, n. 1, pp. 110-117. Wiedener D. L., L’Afrique noire avant la colonisation, Parigi, 1971. Williams E., The negro in the Caribbean, Washington, 1942. Williams E., Capitalismo e schiavitù (1944), tr. it., Bari, 1971, pref. di L. Villari. Williams E., From Colombus to Castro. The history of the Caribbean, 1492-1969, Londra, 1970, New York, 1971. Williams E., The blackest thing in slavery was not the black man, «Revista interamericana », 1973, I, pp. 1-23. Wirkus F., Le roi blanc de la Gonave. Le culte vaudou en Haïti, Parigi, 1932. Wolpe H., Raynal et sa machine de guerre: l’«Histoire philosophique des deux Indes» et ses perfectionnements, Parigi, 1957. Work M. N., A bibliography of the negro in Africa and America, New York, 1928. Yacono X., Histoire de la colonisation française, Parigi, 1969. Zadoc K., L’esclavage selon la Bible et le Talmud, Parigi, 1867. Zavala S. A., America en el espíritu francés del siglo XVIII, Città del Messico, 1949. Zavala S. A., La défense des droits de l’homme en Amérique latine (XVIe-XVIIIe siècles), pubbl. dell’UNESCO, 1964. Zendegui G. de, The great Haitian epic, « Americas », 1970, n. 6, pp. 2-11. Ziégler J., Le pouvoir africain. Eléments d’une sociologie politique de l’Afrique noire et de sa diaspora aux Amériques, Parigi, 1971. Conflitti razziali (lavori specifici recenti) Baker J. R., Race, Londra-New York-Toronto, 1974. Banton M., Sociologie des relations raciales, tr. fr., Parigi, 1971. 309 Barzun J., Race, a study in superstition (1937), ed riv., New York, 1965. Bernard J., Ruffié J., Hématologie géographique, Parigi, 1966, 2 voll. Boissel J., Victor Courtet (1813-1867), premier théoricien de la hiérarchie des races, Parigi, 1972. Boyd W. C., Génétique et races humaines, tr. fr., Parigi, 1952. Comas J., Racial myths, pubbl. UNESCO, 1951. Comarmond P. de, Duchet Cl., (a cura di), Racisme et société, Parigi, 1969 Dobzhansky Th., Diversità genetica e uguaglianza umana. Razzismo e ricerca scientifica (1973), tr. it., Torino, 1975. Du Bois W. E. B., The negro (1915) rist., Londra-Oxford-New York. 1972. Duchet M., Esclavage et préjugé de couleur in Comarmond P. de, Duchet Cl., (a cura di), Racisme et société, Parigi, 1969, pp. 131-132. Fontette F. de, Le racisme, Parigi, 1975. Frederickson G. M., The black image in the white mind. The debate on Afro-american character and destiny, 1817-1914, New York, 1971. Guillaumin C., L’idéologie raciste, Parigi-L’Aia, 1972. Hanke L., Gimenez F., Aristotle and the American Indians. A study in race prejudice in the modern world, Santiago del Cile, 1958. Hankins F., La race dans la civilisation, Parigi, 1935. Haris M., Patterns of race in the Americas, New York, 1964. Hersch J., Sur la notion de race, « Diogène n, 1967, n. 59, pp. 114-33. Hoetinik H., The two variants in Caribbean race relations. A contribution to the sociology of segmented societies, Londra-New York-Toronto, 1967. Jordan W. P., Il fardello dell’uomo bianco. Origine del razzismo negli U.S.A., tr. it., Firenze, 1976. Katz I., Gurin P. (a cura di), Race and the social sciences, New York, 1969. Kovel J., Psicostoria del razzismo bianco (1970), tr. it., Milano, 1971. Ladner J. A., Racism and tradition: black womanhood in historical perspective in Carroll B. A., Liberating women’s history, Chicago, 1976, pp. 179-193. Lévi-Strauss Cl., Race et histoire, Parigi, 1952, rist. 1970. Lewis B., Razza e colore nell’Islam (1970), tr. it., Milano, 1975. Mason Ph., Race relations, Londra- New York, 1970. Maucorps P. H., Memmi A., Held J. F., Les Français et le racisme, Parigi, 1965. Montagu A., La razza. Analisi di un mito, tr. it., Torino, 1966. Montagu A., Statement on race, New York, 1972, 3a ed. Pagliaro H. E. (a cura di), Racism in eighteenth century, Cleveland, 1973. Pittard E., Les races et l’histoire, Parigi, 1924. Poliakov L.. Histoire de l’antisémitisme, Parigi, 1955-1968, 4 voll. Poliakov L., Il mito ariano. Storia di un’antropologia negativa (1973), tr. it., Milano, 1976. Poliakov L., Le racisme, Parigi, 1976. Racisme (Le) devant la science, pubbl. UNESCO, 1960, rist. 1973. Rogers J. A., Nature knows no color-line, New York, 1952. 310 Rose P. I., The subject is race. Traditional ideologies and the teaching of race relations, New York, 1968. Rousseau G. S., Le Cat and the physiology of negroes in Pagliaro H. E. (a cura di), Racism in eighteenth century, Cleveland, 1973, pp. 369-386. Segal R., The race war. The world-wide conflict of race, Londra, 1966. Simar Th., Etude critique sur la formation de la doctrine des races au XVIIIe siècle et son expansion au XIXe siècle, Bruxelles, 1922. Sloan P. R., The idea of racial degeneracy in Buffon’s «Histoire naturelle» in Pagliaro H. E. (a cura di), Racism in eighteenth century, Cleveland, 1973, pp. 293321. Van Den Berghe P. L., Race and racism. A comparative perspective, New York, 1967. Varet G., Racisme et philosophie. Essai sur une limite de la pensée, Parigi, 1973. Wright R., Le « noir » est une création du blanc, «Preuves», maggio 1958, pp. 40-41. Wright R., Razza umana, tr. it., Milano, 1959. Zubaida S. (a cura di), Race and racialism, Londra, 1970. Antologie L’anticolonialisme au XVIIIe siècle, a cura di G. Esquer, Parigi, 1951. Journal de la traite des nègres, a cura di J. Mousnier, Parigi, 1957. La découverte de l’Afrique, a cura di C. Coquery, Parigi, 1965. Cayenne. Déportés et bagnards, a cura di M. Devèze, Parigi, 1965. France and west Africa. An anthology of historical documents, a cura di J. D. Hargreaves, Londra, 1969. L’anticolonialisme européen de Las Casas à Marx, a cura di M. Merle, Parigi, 1969. Esclaves et planteurs dans le Sud américain au XIXe siècle, a cura di M. Fabre, Parigi, 1970. La scoperta della costa occidentale dell’Africa nelle relazioni di Gomes Eanes de Zurara, Diogo Gomes, Eustache de la Fosse, Valentim Fernandes e Duarte Pacheco, a cura di R. Rainiero, Milano, 1970. Las Casas et la défense des Indiens, a cura di M. Bataillon e A. Saint-Lu, Parigi,1971. La scoperta del nuovo mondo, a cura di J. Cassou (1966), tr. it., Novara, 1971. La scoperta dei selvaggi. Antropologia e colonialismo da Colombo a Diderot, a cura di G. Gliozzi, Milano, 1971. L’Amérique et les poètes français de la Renaissance, a cura di R. Le Moine, Ottawa, 1972. Montesquieu e l’origine della scienza sociale, a cura di S. Landucci, Firenze, 1973. Il problema negro, a cura di R. Salomoni, Messina-Firenze, 1973. La polemica sul lusso nel Settecento francese, a cura di C. Borghero, Torino, 1974. Il rovescio della conquista. Testimonianze azteche, maya e inca, a cura di M. LéonPortilla (1964), tr. it., Milano, 1974. 311 La condizione dello schiavo. Autobiografie degli schiavi neri negli Stati Uniti, a cura di B. Armellin, Torino, 1975. Négritude. Texte zur Geschichte des französischen Kolonialismus und seiner Überwindung, a cura di J. Von Stackelberg, Francoforte-Berlino-Monaco, 1976. Illuminismo e utopia. Temi e progetti utopici nella cultura francese (1676-1788), a cura di S. Bartolommei, Milano, 1978. 312 Indice dei nomi Adotevi; 68; 287 Aguesseau (cancelliere d’); 84 Aimé-Martin; 177 Alembert d’; 177; 285 Ambroise; 26 Angioletti Marciano; 25 Antonini; 112 Aristotele; 128; 130; 157 Aubert; 223 Baczko; 223 Balmas; 44; 287 Barbot; 74 Barnet; 281; 287 Barni; 137; 156 Bartolommei; 223; 312 Bastide; 55; 90; 288 Bataillon; 40; 288; 311 Baudeau; 172; 178; 204 Bayle; 43; 120 Bazalgues; 113 Beecher Stowe; 111 Behn; 6; 47; 56; 92; 93; 95; 97; 99; 100; 101; 102; 104-112; 193; 246 Belin; 286 Bellon de SaintQuentin; 225 Bénac; 177 Benot; 258; 259; 260; 288 Bertin; 170; 177; 223 Bertolini; 178 Billy; 42 Biondi; 5; 6; 7; 25; 26; 27; 38; 43; 89; 91; 135; 148; 156; 157; 158; 177; 200; 201; 288; 289 Blanzat; 57; 290 Bluet; 80; 81 Bodin; 57; 119-121; 122; 136 Bonnemain; 56 Borghero; 202; 258; 289; 311 Brahimi; 258 Brissot de Warville; 272; 296 Buffon; 44; 89; 183; 200; 296 Butini; 192; 198-200; 203; 210; 246 Cahen; 284; 290 Caillois; 42; 136 Cameron; 202 Cantelli; 43 Capitani; 222 Carpentier; 57; 290 Carrilho; 68 Casini; 159; 222; 258; 289; 290 Cassou; 40; 311 Castilhon; 227; 228-231; 233; 235 Cavazzi; 23-24; 27; 228; 229; 235 Césaire; 285; 290; 306 Chambon; 167-169; 186-188; 236 Charles; 120; 234; 243; 284; 290 Charlevoix; 26; 84; 86; 305 Chastellux; 259; 282 Chiappelli; 41; 306 Chinard; 25; 26; 27; 290 Clarkson; 56 Clavière; 272 Clemente; 145 Cohen; 41 Colombo; 31; 40; 44; 52; 257; 297; 311 Condorcet; 151; 153; 158; 176; 201; 223; 262-267; 269; 281; 282; 284; 290; 297 Contarini; 89 Conti Odorisio; 157 Contrit; 285 Cooper; 260; 283; 284; 285; 291 Cotta; 136 Cournand; 278; 282 Courteney; 258; 291 Cowley; 25; 55; 284; 301 Cugoano; 175; 262; 273-277; 285 Curtin; 55; 291 Dalmazzo Vasco; 154; 158-159 Dam Joulin; 45; 46 D’Auberteuil; 151 Davis; 25; 155; 156; 158; 292 De Mas; 159 Debbasch; 50; 55; 57; 292 Debien; 284; 292; 293; 294 313 Debonnaire; 138; 156; 161-163; 172; 177 Decroix; 201 Defoe; 101 Delacroix; 201; 223; 294 Delaporte; 226-227 Delille; 260 Delisle de Sales; 44; 288 Démeunier; 170; 171 Depestre; 280 Depresle; 134; 296 Deschamps; 55; 56; 57; 294 Dessalines; 280; 303 Destutt de Tracy; 158 Diannyère; 273 Diderot; 36; 42; 44; 236; 237; 238; 240; 244-246; 248-251; 258-260; 275; 288; 295; 296; 298; 303; 304; 311 Dodds; 135; 136; 295 Doigny de Ponceau; 172; 178; 252-254; 256 Dorsinville; 285; 295 Douglass; 281; 295 Du Camp; 286 Du Tertre; 5; 11-17; 19; 24; 26; 108 Duchet; 44; 55; 67; 68; 70; 72; 88; 89; 90; 140; 156; 197; 201; 202; 205; 211; 220; 222; 236; 237; 238; 258; 295; 296; 310 Ducrot; 134; 296 Dulaurens; 170 Dupin; 142; 157; 305 Dupont de Nemours; 200; 204; 207; 208; 209; 210; 264 Dupont de Némours; 172 Errera; 136 Etienne; 285; 296 Fabre; 56; 311 Favières; 223 Feijóo y Montenegro; 157 Felhoen Kraal; 284 Feugère; 258; 296; 297 Filliot; 223; 297 Fiquet Du Bocage; 92 Formey; 165 Fouchard; 55; 297 Fournol; 136 François-Primo; 297 Franklin; 286 Freer; 202 Fromageau; 18 Frossard; 283 Garat; 172-173; 176; 178; 255-256; 260 Genovesi; 154; 159 Gerbi; 40; 42; 297 Gisler; 224; 298 Gliozzi; 42; 44; 298; 311 Goggi; 258; 298 Gouges; 234 Graffigny; 41 Grant; 90; 298 Grée; 172; 178; 256 Grégoire; 6; 43; 260; 277; 278; 282; 283; 285; 289; 298; 300; 307 Griffin; 137 Grimm; 42 Grosley; 134; 141 Grozio; 118; 119; 122; 135; 144; 147; 167; 257 Guillemain; 243 Guillemin; 177 Guiral; 136 Guitton; 260 Haley; 281 Hanke; 40; 298; 310 Hearn; 27 Helvétius; 41; 182-185; 187; 200 Henderson; 112 Henrion de Pansey; 4; 171; 174; 220; 221; 224 Henry; 57 Hilliard; 150 Hobbes; 118; 156 Hoffmann; 67; 68; 234; 286; 298; 299 Hume; 158; 174 Irvine; 57; 299 James; 57; 80; 286; 299 Jameson; 68; 115; 123; 135; 138; 139; 151; 157; 299 Jaucourt; 164-165; 168; 172; 202 Joly; 233; 234 Jussieu; 258; 291 Kake; 235 Kasteloot; 68 314 Knust; 155 La Harpe; 88; 91 La Place; 92; 110 Labat; 5; 6; 11; 16- 27; 28; 78; 84; 85; 86; 125; 226; 228; 229; 235; 298 Lafontant; 135; 300 Landucci; 44; 300; 311 Lanthenas; 3; 222; 282 Laplace; 56; 110; 113 Las Casas; 29; 37; 38; 40; 41; 43; 290; 311 Le Blanc; 92; 111; 112; 113 Le Moine; 41; 311 Le Vaillant; 89 Leclerc; 280; 286; 300; 303; 305 Lecointe-Marcillac; 173; 178 Lely; 235 Lemierre; 256-257; 260 Léon-Portilla; 40; 311 Lescallier; 221; 282; 284 Lichtenberger; 108; 112; 301 Linguet; 116; 117; 143; 147-149; 157; 163; 225; 289; 291; 300 Locke; 118; 121; 122; 136 Long; 89 Lopez de Gómara; 124 Luchet; 227; 232; 233 Luigi XIII; 125 Macandal; 49-50; 53; 57 Mahn-Lot; 40 Mailhol; 188-191 Malouet; 43; 117; 149-150; 158; 163; 271; 282; 284; 287; 294; 301; 306 Mannix; 25; 55; 112; 284; 301 Maréchal; 223 Marienstras; 55; 301 Marivaux; 137; 201; 259; 288 Marmontel; 36; 37; 38; 42; 43; 258; 259; 296 Martin; 47; 57; 103; 297; 301 Matteo; 43 Maurel; 57; 301; 302 Melon; 139; 156; 167; 187 Mercier; 208; 246-250; 254; 259; 286; 302 Mercier de la Rivière; 208; 302 Mérimée; 47; 309 Métraux; 90; 302 Meusnier de Querlon; 88 Meyer; 57; 302 Milscent; 174; 175 Mirabeau (marchese di); 48; 204-207; 220; 221; 283; 303; 305; 307 Montague (duca di); 80; 303 Montaigne; 5; 30; 31; 40; 41; 288; 306 Montesquieu; 5; 6; 34; 35; 41; 42; 68; 115-178; 181; 184; 199; 207; 212; 221; 228; 231-233; 252; 257; 262; 289; 291; 295; 296; 299; 300; 305; 311 Montyon; 286 Moore; 81 Moravia; 222; 303 Moreau de Saint-Méry; 54; 57; 58; 296; 302; 307 Morelly; 180-181; 196; 200 Mornet; 111 Mortier; 260; 303 Mouralis; 55 Mousnier; 55; 311 Napoleone; 5; 233; 279; 280; 281; 286 Necker; 48; 222; 282 Neumann; 159 Newton; 25; 290 Nugent; 155; 159 Oglethorpe; 80 Orfei; 159 Pareyson; 135 Parny; 223; 276; 307 Pascal; 176 Pechméja; 246 Pernoud; 56; 303 Picquenard; 280; 286 Pincherle; 41 Pinière; 152; 158 Piscitelli; 200 Poiret; 258 Poivre; 6; 210-217; 220; 251; 265 Pomeau; 41; 201 Pontano; 57 Prévost; 6; 58-92; 108; 156; 226; 246; 281; 288; 295; 299; 300; 307 Prichard; 155 315 Pufendorf; 118; 119; 147; 257 Quesnay; 207; 222 Raulin; 55 Raynal; 42; 43; 56; 57; 108; 169; 171; 172; 175; 176; 177; 236-239; 243; 245; 251; 252; 258; 259; 288-291; 295; 296; 297; 308; 309 Rennefort; 90 Richer d’Aube; 122 Rinchon; 57; 305 Romano; 40; Ronsard; 30; 31; 36; 41 Rosny; 286 Rosso, C.; 1; 7; 41; 43; 44; 137; 157; 159; 201; 221; 258; 288; 289; 305 Rosso, G.; 233 Rota Gribaudi; 158 Rotta; 159 Roucher; 172; 176; 178; 255; 260 Rousseau; 101; 112; 149; 167; 212; 290291; 303; 311 Rousselot de Surgy; 88; 225 Ruggiero; 159 Sacy; 259 Sade; 228; 229; 235 Saint-Lambert (de); 172; 176; 192-198; 201; 202; 210; 246; 255; 295 Saint-Lu; 40; 311 Saint-Pierre; 172; 175; 176; 177; 214; 215; 216; 219; 220; 223; 265; 286 Sainville; 235; 285; 306 Scaglione; 41; 306 Schoelcher; 306 Sebbar-Pignon; 286; 306 Seeber; 42; 113; 177; 202; 286; 307 Sepúlveda; 29 Sgard; 67; 72; 89; 307 Shakespeare; 68 Sibire; 173; 174; 278 Signorile; 222 Sik; 235; 307 Sloane; 53; 55; 58; 67 Smith; 174; 307 Sonthonax; 279 Southerne; 92; 111; 113 Spartaco; 132; 256 Staël; 222 Stedman; 51; 57; 68 Stern; 221; 307 Strube de Piermont; 143; 157; 289 Sue; 281 Swinburne; 113 Taillemite; 57; 302; 307 Tarello; 159 Tarrade; 152; 158; 307 Terenzio; 188 Tersen; 285; 306; 307 Thiam; 234 Thomson; 202; 307 Tommaso; 135 Toussaint Louverture; 248; 256; 279; 285; 290; 295; 306 Trousson; 248; 259 Turgot; 207; 222 Turnbull; 158 Usbek; 131 Valdarnini; 136 Vega; 171 Vernière; 41; 136; 137 Viénot de Vaublanc; 285 Vignols; 178; 224; 308; 309 Voltaire; 23; 31; 33; 34; 41; 43; 48; 89; 135; 156; 166-167; 169; 170; 172; 177; 184-186; 188; 192; 201; 225; 242; 287; 289; 296; 300-303; 305; 307 Wadstrom; 284 Wedgwood; 284 Whitefield; 174 Wolpe; 258; 309 316 INDICE GENERALE Prefazione ............................................................................................................................................... 5 PREMESSE PER UN DISCORSO ABOLIZIONISTA ......................................................................... 8 I primi missionari delle Antille francesi di fronte alla schiavitù ......................................................... 9 Critica dei «conquistadores » ............................................................................................................ 29 Le rivolte degli schiavi ..................................................................................................................... 45 L’INFLUENZA INGLESE ................................................................................................................... 59 Rivolta e « marronnage » in un testo del « Pour et contre » di Prévost ........................................... 60 L’« Histoire générale des voyages » ................................................................................................. 69 Oroonoko, lo schiavo regale ............................................................................................................. 92 MONTESQUIEU: CRITICI ED EPIGONI ........................................................................................ 114 Montesquieu e il problema della schiavitù...................................................................................... 115 Reazioni degli schiavisti, usi impropri e fraintendimenti dell’« Esprit des lois » ........................... 138 « L’esprit des lois » nel Settecento antischiavista ........................................................................... 161 LA LOTTA PER L’ABOLIZIONE .................................................................................................... 179 Gli audaci anni sessanta .................................................................................................................. 180 Fisiocratici, amministratori, funzionari-filosofi .............................................................................. 204 Schiavismo lento a morire .............................................................................................................. 225 L’« Histoire philosophique » e il mito « spartakista » .................................................................... 236 Alla vigilia della rivoluzione .......................................................................................................... 261 Bibliografia ......................................................................................................................................... 287 Indice dei nomi ................................................................................................................................... 313 317
Scarica