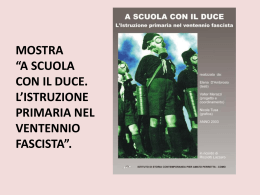6 I SENTIERI DELLA RICERCA rivista di storia contemporanea Bologna Galli Fabei Corsi Magnani Gerbi Galimi Sbacchi Milanese Letterio D’Addea Romandini Vecchia Fontana Del Boca dicembre 2007 EDIZIONI CENTRO STUDI “PIERO GINOCCHI” CRODO I SENTIERI DELLA RICERCA rivista di storia contemporanea EDIZIONI CENTRO STUDI “PIERO GINOCCHI” CRODO I Sentieri della Ricerca è una pubblicazione del Centro Studi Piero Ginocchi, Crodo. Direttore Angelo Del Boca Condirettori Giorgio Rochat, Nicola Labanca Redattrice Severina Fontana Comitato scientifico Marina Addis Saba, Aldo Agosti, Mauro Begozzi, Shiferaw Bekele, Gian Mario Bravo, Marco Buttino, Giampaolo Calchi Novati, Vanni Clodomiro, Basil Davidson, Jacques Delarue, Mirco Dondi, Angelo d’Orsi, Nuruddin Farah, Edgardo Ferrari, Mimmo Franzinelli, Sandro Gerbi, Francesco Germinario, Mario Giovana, Claudio Gorlier, Mario Isnenghi, Lutz Klinkhammer, Nicola Labanca, Vittorio Lanternari, Marco Lenci, Aram Mattioli, Gilbert Meynier, Pierre Milza, Renato Monteleone, Marco Mozzati, Richard Pankhurst, Giorgio Rochat, Massimo Romandini, Alain Rouaud, Gerhard Schreiber, Francesco Surdich, Nicola Tranfaglia, Jean Luc Vellut, Bahru Zewde La rivista esce in fascicoli semestrali Direttore Angelo Del Boca Editrice: Centro Studi Piero Ginocchi Via Pellanda, 15 - 28862 Crodo (VB) Stampa: Tipolitografia Saccardo Carlo & Figli Via Jenghi, 10 - 28877 Ornavasso (VB) e-mail: [email protected] N. 6 - 2° Sem. 2007 Numero di registrazione presso il Tribunale di Verbania: 8, in data 9 giugno 2005 Poste italiane spa Sped. in a.p. D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n. 46) Art. 1 Prezzo di copertina � 12,00 Abbonamento annuale � 20,00 Abbonamento sostenitore � 100,00 C.C.P. n. 14099287 intestato al Centro Studi Piero Ginocchi via Pellanda, 15 - 28862 Crodo (VB) causale abbonamento: ISDR La pubblicazione di questa rivista è stata possibile grazie al contributo di: Provincia del Verbano Cusio Ossola Comune di Crodo Sommario gli anni della Resistenza 7 Cronaca di una fuga di Paolo Bologna 21 400 nomi. L’archivio sulla deportazione novarese: un progetto in corso di Giovanni Galli storia nazionale 63 «Pagine libere»: la voce del sindacalismo rivoluzionario interventista (1914-1915) di Stefano Fabei 91 Armi e propaganda. «Il regime fascista» di Farinacci e la guerra civile spagnola di Francesco Corsi 123 RamÓn Franco e gli antifascisti italiani (1930-1932) di Alberto Magnani 135 Mio padre di Sandro Gerbi 147 «Un ente che la scienza sposa alla propaganda». L’Istituto per gli studi di politica internazionale negli anni trenta di Valeria Galimi Africa e dintorni 165 Italia e Etiopia: la rilettura del periodo coloniale e la valutazione delle sue conseguenze sul paese africano di Alberto Sbacchi 2 01 L’intrapresa di Luigi di Savoia in Somalia, ovvero storia di una bonifica ‘integrale’ coloniale di Ernesto Milanese 2 31 La Francia, le colonie, la Storia. Riflessioni a partire dalla legge del 23 febbraio 2005 di Domenico Letterio storia e mass media 245 Le fonti cinematografiche nello studio del Novecento. Analisi della filmografia sul Vietnam di Ottavio D’Addea rassegna bibliografica 267 Schede di Severina Fontana, Massimo Romandini, Matteo Vecchia 283 286 notizie sugli autori di questo numero In memoriam gli anni della Resistenza Cronaca di una fuga di Paolo Bologna Un cielo sempre più luminoso annuncia la primavera ossolana del 1944, disvelando ancora una volta un grandioso panorama alpino, immutato e immutabile. Madre Natura non bada se l’Umanità è in pace o in guerra, ogni anno si rinnova e si riveste di colori. Ma sull’Ossola grava la cappa di piombo dell’occupazione tedesca e della capillare, vessatoria e rabbiosa presenza delle milizie fasciste che in quei mesi faticano a contenere il movimento partigiano sempre più esteso per dimensioni e vivacità. Non servirà a molto, anzi sarà in larga parte controproducente, il bando di Salò che dava tempo sino al 25 maggio per abbandonare la macchia e presentarsi ai distretti. Qui come altrove i guerrieri calati dal Brennero con la svastica sull’elmetto e il Gott mit Uns, Dio è con noi, la bestemmia nazista sulla fibbia del cinturone, non hanno perso tempo ad arrivare dopo l’8 settembre del 1943. Quando Badoglio ha annunciato il suo frettoloso armistizio e Hitler ha dato il via all’occupazione dell’Italia, piani, truppe, ordini di marcia, tutto era pronto da tempo. I primi arrivano a metà settembre, quando ormai non c’è più ombra di esercito italiano. I militari della Gaf, la Guardia alla Frontiera che presidia la zona e le vecchie opere difensive del tunnel del Sempione che risalgono al primo Novecento, e le più recenti a fine anni trenta, segmento ossolano del cosiddetto «valico alpino» (il «corridoio vallesano» della neutrale Svizzera ha sempre preoccupato il nostro Stato Maggiore), si sono squagliati subito. L’orgoglioso motto di quel corpo, dipinto a grossi caratteri sulle loro caserme abbandonate, «Dei sacri confini guardia sicura», diventa improvvisamente una battuta di deprimente involontario umorismo nero. Qualcuno di quei militari, che portano il cappello alpino ma senza la penna, è stato per qualche tempo alla macchia, poi ha preso la via della Svizzera o di casa. Spariti i soldati, la gente svaligia le caserme. Ovviamente, si arraffa con mi7 Paolo Bologna gliori risultati nelle due di Domodossola, la Chiossi del Calvario e la Urli in città, depredando arredi di casermaggio, masserizie, muli e finimenti, tutto. Solo pochi pensano a prendere qualche moschetto, munizioni1. A saccheggio ormai concluso, ecco apparire a Domodossola gli uomini di un battaglione della 1a Panzer-Division Waffen SS-Leibstandarte Adolf Hitler. In quel dolce settembre italiano, sulle romantiche rive del lago Maggiore, altri loro camerati si dedicano con la consueta fredda professionalità a sterminare gli ebrei là rifugiatisi2. Questi arrivati in Ossola occupano militarmente la città, ovviamente senza incontrare resistenza. Ne percorrono le vie principali – pochi curiosi sui marciapiedi - a passo di strada su due file; in mezzo, a intervalli, le camionette con il capo-equipaggio in piedi che scruta a destra e a sinistra. Quasi tutti in calzoncini corti, Maschinenpistole alla mano, ai piedi le scarpe della naja italiana nuove di zecca trovate nei magazzini abbandonati e mai distribuite ai nostri soldati lasciati con le scarpe rotte. Si fermano in piazza Cavour, quattro o cinque giovani figlie di fascisti si fanno vicino, qualcuna sale sulle camionette, i giovani biondi sorridenti distribuiscono tavolette di cioccolato. Poi raggiungono i confini, prendono contatto coi posti di frontiera degli svizzeri (Paglino-Gondo tra Ossola e Vallese, la Ribellasca verso il Ticino; altri reparti puntano al valico di Cannobio-Piaggio Valmara sulla litoranea del lago Maggiore), che ad ogni buon conto davanti alle normali sbarre, buone per il traffico spicciolo dei giorni di pace, hanno steso i cavalli di Frisia. Dietro ai reticolati, un paio di ufficiali in divisa da campagna, elmetto in testa. Di poco distanziati come vuole il regolamento due o tre soldati e più indietro ancora ben mimetizzati nel terreno, si sa che ci sono ma non si vedono, i mitraglieri. Nel giro di qualche giorno i tedeschi lasciano l’Ossola3. Ma prima, lì in piazza Cavour a Domodossola, all’hotel Corona insediano il comando militare (che poi si trasferirà a villa Ceretti di Masera), contrassegnato da un’enorme bandiera con la svastica, pendente dal balcone. Dovrebbe essere questa prima Kommandantur cittadina che manda, il 29 settembre, un picchetto all’ospedale per prelevare il ventiquattrenne sergente dell’aviazione americana Bunn Marslace Frank. A inizio mese, il giorno 2, il giovane si era gettato con gli altri dell’equipaggio dall’apparecchio che stava precipitando alla periferia di Villadossola. Un salvataggio in extremis prima dello schianto al suolo. La Fortezza Volante era reduce da un bombardamento su Bologna; in avarìa aveva tentato di raggiungere la 8 Cronaca di una fuga Svizzera ma probabilmente il pilota non era riuscito a innalzarla sopra le Alpi. Gli aviatori erano stati rastrellati dai carabinieri, il sergente spedalizzato per le fratture riportate4. Già dai primi giorni dopo l’8 settembre - tutto era stato pianificato in anticipo - col decreto WFS/111/43 della Orts Kommandantur West (OKW), il comando per l’Italia occidentale che si è insediato a Monza, era stato chiuso il confine con la Svizzera. Per sorvegliarlo, arrivano ben presto in zona, subito coadiuvati con migliori risultati dagli zelanti militi della Confinaria, i tedesconi della Zollgrenzschutz, corpo militare doganale-confinario dislocato nelle principali località del territorio, che si sovrappone e in buona misura sostituisce la poco entusiasta Guardia di Finanza. I tedeschi snobbano le vecchie caserme italiane puzzolenti e per niente confortevoli. Alloggiano in alberghi o requisiscono ville e case di buona fattura dove, questa Italia demilitarizzata wo die Zitronen blühen induce a lieti incontri pur nel turbinìo della guerra, talvolta si organizzano festini. Alla tedesca, col buon vino italiano requisito, musica e balli scollacciati. Ragazze compiacenti non mancano mai quando arriva lo straniero. E se poi ci scappa il morto, questa è la guerra, Kamerad!5 I militi della Zoll sono vestiti come quelli dell’esercito, almeno così pare a occhi italiani, si riconoscono per la fascia verde che contorna il berretto a visiera. Hanno disciplina militare, ma i loro ufficiali si chiamano ispettori. Insediano a Biella il quartier generale, Befehlstelle; i comandi dipendenti sono Bezirkszollkommissariat, commissariati di circolo doganale, da cui dipendono altri Gast (che ci azzarderemmo tradurre con la terminologia dei nostri carabinieri in «posto fisso», cellula minore delle tradizionali «stazioni» dell’Arma), nelle località strategiche del territorio di competenza: Macugnaga, Antrona, Bognanco, Varzo etc. Il circolo di Domodossola fa la parte del leone, deve badare alla fascia confinaria da Alagna val Sesia a Iselle; mentre per la restante fascia di frontiera con Vallese e Ticino da Goglio a Cannobio, con esclusione della litoranea da Intra al confine di Piaggio Valmara che dipende da Varese, è competente il circolo di Santa Maria Maggiore. A Domodossola ha anche sede un BZKom Grenz, posto di controllo che deve badare al più importante e strategico valico del Sempione, strada e ferrovia6. In quella lontana primavera di guerra un milite della Zoll, di quelli che tengono sott’occhio la val Vigezzo, certo Johann Streng, Hilfszollassistent del Gast di Malesco, assistente doganale ausiliario del posto di Malesco, il 9 Paolo Bologna 2 maggio del 1944 col collega Grûner, già di buon’ora è salito sul trenino che percorre la valle per compiere il breve tragitto von Ponte Ribellasca nach Re, dal confine della Ribellasca sino a Re. I due sono di corvée, portano al lavandaio Umtausch der Bettwäsche, la biancheria da letto del distaccamento. Sono da poco passate le 6 quando lo Streng, insospettito da un paio di brevi fermate fuori programma e dal fatto che poco prima dal finestrino ha visto già in territorio svizzero una persona con due valigie, capisce che c’è qualcosa che non quadra. Fa irruzione nella cabina di guida proprio mentre tre individui si distribuiscono del denaro. Sospetta quasi subito che si tratti del compenso per avere organizzato un espatrio clandestino. Guardati a vista dai due doganieri, alla stazione di Santa Maria Maggiore i tre debbono lasciare il treno e vengono scortati al comando tedesco. Sono due anziani ferrovieri, il macchinista Francesco Furnari di 47 anni, il conduttore Giuseppe Gatti di 53, e un contrabbandiere valligiano, Carlo Besana di Malesco, 29 anni. Nel suo ufficio di S. Maria il Bezirkskommissar Doerk, tra il pomeriggio di quel 2 maggio quando i suoi subalterni gli portano i tre, già in stato di arresto, e il 4 successivo sente tutti i protagonisti della vicenda: lo Streng, poi il Besana e gli altri due, che, come risulta dai verbali di interrogatorio, vengono così identificati: - Besana Carlo, nato il 31 dicembre 1915 a Malesco, di Bartolomeo e di Ferrari Giuditta, istruzione elementare, professione di fede romano cattolico, celibe, senza occupazione (arbeitet nicht, non lavora), abitante a Malesco via del Sotto 1. Arrestato il 2 maggio 19 maggio 1944 ore 6,15 alla galleria tra Olgia e Ponte Ribellasca. Posizione politica sconosciuta; causa dell’arresto contrabbando di persona (ebrea) in Svizzera contro compenso, e delitto contro i decreti sulla totale chiusura di frontiera. In tasca gli trovano 7.100 lire. Più in là nel tempo, quando per lui e per gli altri si chiamerà un regolare processo alla pretura di Domodossola7, dal tribunale di Verbania arriverà il certificato penale da cui risulta che l’uomo ha qualche precedente, ma gli è sempre andata bene. Nel novembre del 1935 è stato assolto per insufficienza di prove per contrabbando in unione, altra assoluzione tre anni dopo «per non avere commesso il fatto» per espatrio clandestino apolitico, e se pur nell’aprile del 1940 il tribunale militare di Torino gli ha affibbiato un anno di carcere per furto in danno dell’amministrazione militare, la pena è stata interamente condonata, e per altra analoga imputazione «non doversi procedere» per sopravvenuta amnistia. - Furnari Francesco, nato a Novara di Sicilia (ma su altro documento 10 Cronaca di una fuga il luogo di nascita sarà più correttamente indicato in Francavilla di Sicilia) il 12 luglio1897, coniugato, «occupato presso la società ferroviaria Domodossola-Locarno, residente a Malesco in via Eria 1», arrestato insieme al Besana, cattolico, posizione politica sconosciuta. Gli vengono sequestrate 13.000 lire. - Gatti Giuseppe nato il 28 ottobre 1891 a Vicchio (Firenze), anche lui romano cattolico e occupato come il Furnari, abita a Re nell’edificio della stazione. Come «posizione politica» risulta iscritto al Pnf fino al 1943. Il diligente Kommissar sente tutti, mette su carta quello che gli dicono i tre italiani e il suo Streng; quando ha notato qualche discrepanza tra le dichiarazioni degli interrogati li ha risentiti a confronto. Il quadro che esce da quelle carte in tedesco e tradotte in italiano, che ispessiscono il fascicolo processuale, è ora sufficientemente chiaro. Tutta la vicenda si può ricostruire dall’interrogatorio cui il Doerk sottopone il Besana, poi gli altri due, e dal rapporto dello Streng che gli ha portato davanti quei tre italiani. Dichiara il Besana che la sera di sabato 29 aprile ha incontrato per caso a Domodossola un suo vecchio compagno d’armi, tale Fradelizio di Trontano. (Colpito da improvvisa amnesia, questo smemorato Besana ha pur fatto il soldato insieme al Fradelizio, ma il nome non lo sa, non ricorda, e manco ne conosce l’indirizzo preciso). L’amico gli propone di accompagnare due persone oltre confine e, se ci sta, quanto chiede. «Poiché la cosa è di grande rischio e punita con la fucilazione, io chiesi 25.000 lire. Fradelizio disse che la somma era troppo alta, ma che avrebbe pagato L.20.000». In ogni modo Besana accetta e la domenica sera col trenino arrivano a Malesco le due persone, una signora, che tanto lui quanto il Furnari descriveranno al Doerk come «alta e magra, nata a Torino e ci ha detto di non essere ebrea e di dovere andare a Lugano a trovare una figlia che sta là» e il figlio, un giovane tra i 15 e 17 anni, che hanno sentito chiamarsi Walter, con due valigie. Il piano originario del Besana è evidentemente diverso e più semplice di quello che poi metterà in azione tre giorni dopo. Infatti già attorno alle dieci di sera di quella stessa domenica tenta di avvicinarsi alla Svizzera con i due fuggiaschi e i loro ingombranti bagagli mettendosi in cammino verso Re, circa tre chilometri e mezzo, evitando la carrozzabile e tenendosi sotto bosco. È probabile che pensasse di pernottare a Re, quella celebre Madonna potrà ben miracolarli portandoli tutti a salvamento, e il mattino dopo fare l’ultimo tratto fino al confine. Ma la signora non regge a quella marcia notturna. Si rientra a Malesco, i due dormono a casa del 11 Paolo Bologna TrasmissionedelladenunciadapartedeimilititedeschidellaZollallagiustiziaitaliana.Ildocumento proviene dall’archivio della Pretura di Domodossola. Besana che deve cambiare programma e pensa al treno. Allora gli serve la complicità di un ferroviere, e lo trova il giorno dopo quando contatta il Furnari, che per l’anagrafe è Francesco, ma tutti chiamano Primo perché è stato il primo manovratore del trenino quando nel novembre 1923 è stata attivata la linea. Gli dice che ci saranno 20.000 lire da dividersi. Il macchinista vuole saperne di più, nel pomeriggio va a casa del Besana dove conosce quei due. La cosa si può fare, il Primo ci sta, il piano si concretizza. I due monte12 Cronaca di una fuga ranno in treno a Re, alla galleria di Olgia una breve fermata per farli scendere, lì la Svizzera è a due passi, al ritorno altra sosta per riprendere a bordo il Besana. Ma per quelle fermate fuori programma in prossimità della frontiera il macchinista obietta che a questo punto occorre coinvolgere anche il conduttore; così le 20.000 lire diventeranno ventuno per comodità di divisione, settemila a testa. Lunedì sera il Besana e i due fuggitivi prendono l’ultimo treno fino a Re, dove pernottano alla men peggio in stazione, il giorno dopo l’appuntamento è al primo treno del mattino. Che arriva col Primo alla guida, ma il collega, l’Antonio Melini anche lui di Malesco, non c’è, non vuole rischiare e per non restare invischiato non si è nemmeno presentato al turno della mattina, si è dato ammalato. Lo rimpiazza il Gatti, per lui la cosa va bene, avrà la sua parte. Secondo il piano, il treno si ferma alla galleria di Olgia. In quel punto il confine è sghembo, c’è una breve lingua di territorio svizzero che si incunea nel nostro, il torrente Melezzo orientale divide per un breve tratto i due Stati, di qua una stretta striscia è Italia, sull’altra riva è Svizzera. Il Besana sa dove il piccolo corso d’acqua si può guadare facilmente, è lì che il trenino fa una breve sosta, giusto il tempo di fare scendere i due torinesi. Il Besana è giù con un salto, prima di mettere i piedi in acqua per trasbordare anche le valigie riceve il danaro del passaggio. Walter e la mamma ce l’hanno fatta, sono in Svizzera e si affrettano verso il primo posto delle guardie di confine per chiedere asilo. E lo Streng li vede dal finestrino del treno!8 Il Primo riprende la corsa, pochi minuti e si arriva alla frontiera della Ribellasca (da lì in avanti sino a Locarno la linea è in mano ai ferrovieri svizzeri). Poi il convoglio torna indietro, rallenta per riprendere il Besana. Ma il tedesco ha fatto due più due e piomba nella cabina della motrice mentre i due ferrovieri e il Besana, con i calzoni ancora fradici, si dividono il compenso. Dai verbali degli interrogatori condotti dal commissario Doerk (particolarmente corposo quello del Furnari), conservati nel fascicolo nella versione originale tedesca e con traduzione italiana, non emergono circostanze tali da modificare il quadro sin qui tracciato.Vi è però una postilla al Meldung, il rapporto-denuncia che lo Streng rende al suo superiore già nel pomeriggio del 2 maggio: «io portai l’arrestato Besana Carlo al comando distrettuale di S. Maria. Io faccio questa denuncia contro Besana per sospetto di contrabbando, in più contro il conducente del treno, che arresterò, per assistenza al contrabbando di persona e merce». 13 Paolo Bologna Non molla dunque la sua preda questo Streng. Sembra proprio un duro e non smentisce il suo nome. «Streng», guarda caso, il vocabolario lo traduce appunto in rigido, rigoroso. Chissà dove è andato a finire il suo rigore quando, da lì a tre mesi, tutto il Gast di Maleso, dove lui presta servizio, pressato dai partigiani chiede e ottiene di riparare in Svizzera. Ma oltre alle armi anche le buone scarpe e le divise servono a quei «ribelli», e tutti sconfineranno in mutande, come annota nel suo rapporto il colonnello Schira delle Guardie Federali svizzere di confine il 5 agosto di quell’anno: «Si presentano 15 doganieri germanici spogliati e respinti dai partigiani verso i nostri confini»9. Nei loro interrogatori i tre italiani, ai quali vengono sequestrati oltre ai danari del passaggio, le solite piccole povere cose degli operai: portafogli vecchi e unti, tesserini personali della ferrovia vigezzina, una carta annonaria, si difendono e giustificano. Il Besana: «Dichiaro secondo verità che è la prima volta che ho portato persone al di là della frontiera, clandestinamente. Dopo il mio rilascio da militare ho fatto due viaggi in Svizzera. Le 21.000 lire mi furono date prima del passaggio del fiume [...] prima portai al di là le due valigie, quindi il giovanotto e la signora […] al momento in cui davo L.14.000 a Primo, venne un soldato tedesco e mi arrestò [...] non so se le due persone fossero ebree». Il Furnari: «Giuro sulla tomba di mia madre che questa era la prima volta che facevo simile cosa. Io non ho neanche mai osservato o sentito che i miei colleghi abbiano rischiato simile cosa [...] del Besana so che era la prima volta che portava persone clandestinamente oltre confine […] il Besana che prima caricava legna in servizio della ferrovia e guadagnava 70-80 lire al giorno, ha lasciato questo lavoro da circa un mese e si è occupato di contrabbando di merce, perché egli con ciò poteva guadagnare di più. Io ho solamente approfittato di questa occasione per potere vestire la mia famiglia. Col mio piccolo stipendio di L.1.700 al mese non sono in grado di mantenere la mia famiglia che oltre a mia moglie consta di tre bambini e la mia vecchia suocera, di comprare scarpe e vestiti, perché i prezzi sono troppo alti, io sono già da sei / sette mesi in arretrato con l’affitto. Io so che ho fatto una grande stupidaggine, prego per una clemente punizione. Non sono mai stato condannato in vita mia». Il Gatti: «Il 2 maggio un po’ dopo le 5 del mattino venne il macchinista Furnari nella mia casa e mi svegliò. Egli mi disse che dovevo fare servizio perchè il Melini era malato. Nel treno non ho visto alcuna persona e non ho visto scendere alcuno. Io credo però di avere sentito delle voci quando il 14 Cronaca di una fuga Furnari fermò il treno. Però non me ne sono occupato. Se il Furnari sostiene che egli mi ha detto che vi erano due persone sul treno che volevano passare la frontiera e che noi avremmo potuto guadagnare qualcosa in questo affare, mente. Io ho saputo di ciò solo dopo, quando tutti i ferrovieri raccontavano di questo arresto. Dichiaro ancora un volta che questa è la verità». Il Doerk vuole arrivare a capo di quelle deposizioni contrastanti, qualcuno non gliela conta giusta, e l’8 maggio mette a confronto Furnari e Gatti. I due si rimbeccano ancora, ma alla fine il Gatti ammette che «il Furnari ha detto la verità [...] per prima mi sono rifiutato causa il pericolo in questo affare, dopo però ero d’accordo». Per il Kommissar interrogante, per il suo scrivano Fels, per l’interprete Renzo Travaini, poi sostituito da certa professoressa Margherita Taroffio, l’istruttoria è chiusa. Il Doerk denuncia i due ferrovieri per Verschleppung von Juden. I tedeschi si sono messi in testa, e probabilmente hanno ragione, che i due fuggitivi siano ebrei (Juden), come aveva sospettato e suggerito nel suo Meldung lo Streng indicando la persona che aveva visto dal treno con le Koffern in mano, le valigie: …wahrscheinlich Jude, probabilmente ebreo10. Il Doerk rimette a piedi libero i due ferrovieri «perché non vi è sospetto di fuga o di occultamento» trattenendo il povero Besana «consegnato al capo delle SS e comandante della polizia Italia, comandante di polizia di sicurezza di Cernobbio allo scopo di una assegnazione in un campo di concentramento, perché egli è da considerarsi contrabbandiere abituale». Ora inizia la seconda fase. L’11 maggio l’ispettore manda tutto alla giustizia italiana con una denuncia riassuntiva, specificando, come già sappiamo, che i due ferrovieri sono a piede libero, il contrabbandiere è stato consegnato a Cernobbio. Probabilmente il Doerk non è tanto sprovveduto da pensare che l’uomo sia ancora là, ma la procedura va rispettata. Informa anche che a carico del Fradelizio Luigi ha emesso ordine di ricerca e cattura. Nella denuncia compaiono due errori, uno del Doerk che manda l’incartamento «al Tribunale di Pallanza», mentre è competente la pretura di Domodossola alla quale verrà poi dirottato il plico. L’altro è della Taroffio che sbaglia nel tradurre l’intestazione del mittente, che nel dattiloscritto del Doerk è Bezirkszollkommissar Italien – G – Santa Maria Maggiore e significa che questa è la Zoll dislocata in Italia (ce n’è un’altra nella Francia occupata ed è Zoll Frankreich). Mentre la Taroffio traduce «Dogana italiana di S.Maria Maggiore», che non esiste. E siamo agli ultimi atti. Si 15 Paolo Bologna muove il pretore di Domodossola, Mario Peagno, e il 15 giugno, «visti gli atti processuali contro due ignoti» (i due presunti o veri ebrei scampati oltreconfine), Besana «detenuto presso il comando germanico di Santa Maria Maggiore» (e non è vero, il Doerk gli ha pur detto per iscritto di averlo già consegnato alle SS) e i ferrovieri, fissa l’udienza del processo a carico di tutti da lì a un mese. Nomina a difensori d’ufficio due avvocati locali, Vittorio Fossati per il Besana e Romeo Ghisoli per gli altri. Ma in aula non si presenta nessuno, tutti risultano irreperibili, al pretore Peagno (funge da PM l’avvocato Luigi Benini) non resta che rinviare il processo a nuovo ruolo. Il Furnari e il Gatti hanno pensato bene di rendersi uccel di bosco e passare il confine. Il Furnari sarebbe addirittura stato consigliato di prendere il largo, hanno ricordato la vedova e il genero in una testimonianza di qualche anno fa, già all’indomani dell’interrogatorio del Doerk, da uno di quei doganieri della Zoll! Come sappiamo, il Besana è andato in mano alle SS di Cernobbio. Verrà spedito in Germania dove si spegnerà il 28 gennaio 1945, così è annotato accanto al suo nome al municipio di Malesco; ma per lo storico Pappalettera, ex deportato, la morte sarebbe avvenuta dieci giorni prima11. Oltre al Besana, questa storia deve registrare un’altra vittima, Luigi Fradelizio. L’uomo probabilmente faceva parte di una di quelle prime reti che si occupavano di fare passare il confine a ebrei, antifascisti, ex prigionieri alleati. Per la sua collocazione geografica, l’Ossola era importante nodo di un «corridoio» che partendo da Milano, in alcuni casi da Vercelli, aveva come terminal il posto di confine ticinese di Cimalmotto in valle Maggia. Tappe fondamentali, Domodossola e altre finitime località pedemontane tra cui Masera e Trontano, «vivai» tradizionali di contrabbandieri, insostituibili per la conoscenza del territorio, e gli alpeggi antigoriani di Aleccio e Cravairola a breve distanza da Cimalmotto. Tra gli organizzatori, a Masera si ricorda certo Camillo Rondolini, a Trontano l’avvocato Paul Ferraris, ben presto arrestato e deportato in Germania da cui non fece più ritorno, alla Cravairola i fratelli Claudio e Onorina Castelli. La rete, in contatto con l’organizzazione Bacciagaluppi, collegava anche le missioni alleate di Lugano col CLN e per quel corridoio giunsero in Ossola addirittura alcuni fucili-mitragliatori Hispano-Suiza dell’esercito svizzero! 12 Il 30 giugno 1944, scendendo da Aleccio verso Premia con altri compagni, il Fradelizio cadde sotto i colpi di un distaccamento tedesco del nu16 Cronaca di una fuga trito presidio di Baceno. Lui e altri sei sventurati partigiani, che in tempi successivi persero la vita sotto fuoco tedesco o della Milizia tra Premia e Crodo (tra essi un ebreo genovese, Davide Pugliesi, e il giovane Oreste Capitani di Montecrestese, sul cui cadavere i militi infierirono strappandogli il cuore e gli occhi) sono ricordati da una lapide nel piazzale antistante la chiesa parrocchiale di Crodo13. Luigi Fradelizio lasciava la giovane sposa Desolina di 24 anni, una figlia che non aveva ancora compiuto i due anni e un figlio di quattro mesi. Il fascicolo della pretura per qualche tempo è muto, ed è privo della sentenza di condanna emessa il 24 luglio 1944, quando il processo è stato chiamato a nuovo ruolo, per i reati di cui agli artt.110 C.P. (concorso nel reato) e 158 del Testo Unico delle leggi di P.S. (espatrio clandestino). Per continuare e avviare a conclusione la storia bisogna correre al 20 febbraio 1945, quando tale tenente Castellani della Confinaria di S.Maria Maggiore (che non dipende più dalla 2a Legione Monte Rosa, adesso è 5a Legione Monte Bianco) dà ricevuta alla pretura di Domodossola dell’ordine di cattura per Gatti Giuseppe e per Furnari Francesco. Il mese seguente, con sua prot. 346/SI/2 del 12 marzo, altro ufficiale dello stesso reparto, un sottotenente con firma illeggibile, si rivolge «Alla Pretura repubblicana» e ai suoi comandi superiori della Gnr per fare sapere che «l’anno millenovecentoquarantacinque addì otto del mese di Marzo» eccetera eccetera «inviava una pattuglia con regolare ordine di carcerazione» nelle abitazioni del Gatti e del Furnari «che però risultavano latitanti» e dalle informazioni assunte dai confinari incaricati della bisogna, che tornati a mani vuote sottoscrivono il «verbale di vane ricerche» (vicebrigadiere Martinato Angelo, militi Covini Ferruccio e Marinari Carlo) «si veniva a sapere che i suddetti individui sono riparati in Svizzera sin dall’ottobre 1944, in seguito ai fatti ben noti dell’Ossolano». Sappiamo da altre fonti che certamente il Furnari era rimpatriato nel settembre 1944 nei giorni della «repubblica» partigiana, per poi tornarsene al sicuro un mese dopo all’avvicinarsi delle colonne nazifasciste (probabilmente il Gatti avrà avuto analogo percorso) mentre il fascicolo del processo ci offre l’atto finale della vicenda: il 17 marzo 1949 il pretore di Domodossola, che non è più il piemontese Peagno dell’epoca fascista, ma un dinamico meridionale, Bruno Cinelli, dichiara «Estinto il reato per intervenuta amnistia, decreto n.32 del 9 febbraio 1948» a carico dell’ormai defunto Besana e dei due ferrovieri vigezzini. 17 Paolo Bologna Note al testo 1 Sulle fortificazioni della linea del Sempione, cfr. Pier Antonio Ragozza, Sentinelle di pietra. Le difese del confine italo-svizzero in Ossola e Verbano, in «Le Rive», 5, 2006, pp 25-30. L’unica patetica reazione da parte dei militari dell’esercito di stanza nell’Ossola, risulterebbe quella avvenuta al caposaldo della Gaf di Iselle al comando del capitano Camera. All’annuncio dell’armistizio e al dissolvimento del presidio alcuni ufficiali pensarono «perfino di far saltare la galleria del Sempione […] ma alla fine ci si raccolse per la mesta cerimonia dell’ammainabandiera. Erano circa le cinque del pomeriggio dell’11 settembre 1943. Ceccherini, il più giovane degli ufficiali, uno dei nuovi tenenti del caposaldo, raccolse fra le sue braccia il tricolore con al centro lo stemma sabaudo. Tutti erano profondamente abbattuti dopo tanti mesi di guerra[…] quella fine così ingloriosa riempiva tutti di umiliazione». L’episodio è raccontato da Franca Cucchi, All’ombra del Calvario. Le vicende di una giovane ossolana nel periodo della seconda guerra mondiale (diario inedito, 2002) presente alla «mesta cerimonia» avendo raggiunto da Domodossola, in quei giorni di incertezza, il fidanzato ten. Giuseppe Picone Chiodo in servizio in quella località di confine. I due si sposeranno poi nel municipio di Berna il 26 febbraio dell’anno successivo; ambedue alla caduta della «repubblica» partigiana dell’Ossola si erano rifugiati in Svizzera al seguito della Giunta di governo, espatriata dal Passo di San Giacomo il 22 ottobre 1944. Il Picone era uno degli ufficiali della «Guardia Nazionale» istituita dalla Giunta; nei successivi anni settanta, coinvolto in un movimento eversivo di destra, sfuggì a un mandato di cattura riparando in Germania con la famiglia. Il Ceccherini, dopo un primo periodo di sbandamento nei dintorni di Domodossola, entrò in Svizzera uscendone alla liberazione del settembre 1944 e partecipando da allora in avanti alla lotta partigiana col nome di copertura di «tenente Pascoli». Il giovane perse la vita in uno scontro a fuoco nei pressi dell’Alpe Archia sulla montagna verbanese. Venne ricordato in un breve necrologio tratto «da una lettera di un suo soldato» col titolo Arnaldo Ceccherini e fotografia del caduto, in Ossola Insorta. A ricordo dei giorni della liberazione. Un governo modello nel nome della democrazia, Milano 1945. Se la conclusione della disastrosa guerra dell’Italia fascista fece registrare, al caposaldo di Iselle, quel simbolico rito dell’ammainabandiera, anche l’inizio del giugno 1940 aveva suggerito altro singolare gesto agli ufficiali in servizio a quella data (cinque sottotenenti e un capitano) che, radunati in sala-mensa, su proposta del ten. Pomi brindarono alla Francia! (Franca Cucchi, All’ombra del Calvario cit. e breve cenno in Marco Picone Chiodo, In nome della resa, l’Italia nella seconda guerra mondiale, Varese 1990). 2 Nel giro di una diecina di giorni, dal 13 al 24 settembre, un reparto di quella divisione SS rastrellò e uccise almeno 55 ebrei che si erano rifugiati nel Verbano, da Arona a Intra a Mergozzo. Su questo raccapricciante eccidio, per numero di vittime ebree in territorio italiano superato solo da quello delle Fosse Ardeatine vedasi Marco Dozza, Hotel Meina. La prima strage di ebrei in Italia, Verona 1993 e La strage dimenticata. Meina settembre 1943, il primo eccidio di ebrei in Italia, a cura di Mauro Begozzi, Novara 2003. 3 L’allora parroco di Domodossola don Luigi Pellanda (L’Ossola nella tempesta. Dal settembre 1939 alla Liberazione, 1a ed. Novara 1954, 5a Ornavasso 2002) colloca al 20 settembre l’arrivo in città della colonna SS e nota anch’egli, come notai io stesso, i soldati «vestiti a nuovo con magnifiche scarpe italiane» e il ritrovo finale «davanti alla Farmacia Bogani» (ancor oggi in piazza Cavour). Il reparto SS venne però preceduto, qualche giorno prima, da un paio di esploratori motociclisti. La circostanza è ricordata tanto dal Pellanda quanto dalla Cucchi e io stesso vidi due militari in breve sosta davanti alla stazione ferroviaria. Secondo il Dozza anche nelle località rivierasche del Verbano prima dell’arrivo delle SS che dettero la caccia agli ebrei transitarono staffette che proseguirono poi nell’Ossola sino a toccare il confine di Stato. Anticipano di un giorno, alla domenica 19, l’arrivo della colonna tedesca Onorina Castelli di Masera (test. maggio 1989), attiva nei primissimi comitati spontanei di resistenza, e anche Dante 18 Cronaca di una fuga Morando, insegnante del liceo Rosmini, che dalla sua abitazione in via Roma vide sfilare il reparto, nel suo Dal diario di un domese, in «Nostre Vette», n. unico della DC di Domodossola, Domodossola aprile 1945. 4 P. Bologna, Chi ha volato nel cielo dell’Ossola. In «Novara», rivista della CCIA novarese, VII, 1982. 5 Almeno una di quelle «festicciole» si concluse con un’uccisione, di cui è rimasta memoria tra la popolazione di Varzo, la cui via principale è intitolata al «Martire Giuseppe Pieri». Costui, giovanissimo partigiano, nel novembre 1944 rientrò in paese perché ammalato ma ben presto, per una delazione, venne catturato dai tedeschi e rinchiuso nella cantina della loro caserma a Villa Castelli. Ne venne fatto uscire a metà dicembre, in quanto noto come abile fisarmonicista, per accompagnare a suon di musica una allegra serata: «Fu una grande baldoria alla quale il ragazzo, per forza, dovette assistere, suonando per tutto il tempo. Terminato il divertimento, poiché il giovane conosceva le donne che si erano divertite con loro, i tedeschi temendo che questo involontario spettatore divulgasse in futuro gli episodi dei [sic] quali era stato costretto ad assistere, pensarono di risolvere il caso portandolo a fare una passeggiata con loro verso il comune di Trasquera. Era la mattina del 18 dicembre 1944». Inutile trascrivere il seguito del testo, facile a intuirsi: il giovane fu abbattuto da una scarica di mitra, il suo cadavere venne ritrovato da due giovani compaesani, e recuperato da alcuni boscaioli. Cfr. Piero Piretti, Squarci di vita, Ornavasso 1999, pp 28-29). 6 I tedeschi si acquartierarono preferibilmente in alberghi, fabbricati padronali e di pregio. Un primo reparto delle SS, giunto a Stresa per la nota operazione contro gli ebrei, si installò nella storica e prestigiosa villa Ducale dei padri rosminiani, altra prestigiosa residenza, la «villa del Pascià», venne occupata a Ghiffa. A Domodossola vennero requisite casa Capponi in centro città (sgomberata nel giro di 48 ore, compreso l’appartamento dell’ex podestà di Domodossola Ghisoli, che con moglie e tre figli piccoli dovette adattarsi alla men peggio in un edificio comunale), villa Castoldi in via Bognanco, la bella villa del direttore della Montecatini in via Mattarella dirimpetto al collegio femminile «Rosmini», un intero piano di casa Ceretti in corso Ferraris (sopra al caffé Regina) per l’ufficio di polizia del Betriebsuberwachum. A Crevoladossola-capoluogo villa Valdo, a Oira di Crevola villa Ferraris, a Villadossola l’albergo Italia (dove le pareti restarono a lungo imbrattate dal sangue dei numerosi prigionieri violentemente percossi – e ben otto di loro vennero poi passati per le armi, altri deportati – catturati dopo la nota insurrezione dell’8 novembre 1943) e villa Lena di proprietà Ceretti, a Varzo villa Castelli, a Baceno l’albergo Italia, a Macugnaga la villa del conte Sterzi, ancora a Masera una seconda villa di altro fratello Ceretti, e così via. Uffici e alloggi erano disseminati un po’ ovunque, se almeno sino al febbraio 1944 il Bezirk del capoluogo era sistemato nell’albergo Milano & Schweizerhof dei f.lli Catena, dirimpetto all’hotel Corona, come risulta dai mandati di pagamento del municipio (in Archivio del Comune di Domodossola, d’ora innanzi ACDo, e sono grato per la segnalazione di questo documento al riordinatore dell’archivio, G. Vittorio Moro) per le stanze occupate da quel Circolo nel trimestre dicembre 1943-febbraio 1944 in 9.788 lire. I primi contingenti della Zoll entrarono in Italia dalla Francia «attraverso il Monginevro a partire dalla terza settimana di settembre». Il valico alpino sarebbe stato affrontato a piedi, in autocarro solo il trasferimento successivo sino a Torino e da qui in ferrovia per le varie destinazioni assegnate; la forza del Corpo era di 600 uomini dislocati su una linea di confine di 250 chilometri. Per tutte le notizie relative alla Zollgrenzschutz sono debitore al ricercatore svizzero Raphael Rues, autore di un corposo saggio tuttora inedito, redatto su letteratura specifica, testimonianze, e sulla consultazione degli archivi federali svizzeri e tedeschi, che ricostruisce le vicende dal settembre 1943 all’aprile 1945 in provincia di Novara, allora comprendente l’attuale provincia del VCO. Una traccia documentale del Bezirkszollkommissar di Masera è in ACDo: il 30 ottobre 1943 il commissario, o chi per esso (sigla I.V., ma firma illeggibile) 19 Paolo Bologna si rivolge Herrn Bürgerrmeister der Stadt in Domodossola, al podestà di Domodossola, con una comunicazione molto spiccia per ricordare che il comando tedesco aveva collocato, nei pressi del garage Fiat all’ingresso della città, due cartelli indicatori «Zollgrenzschutz» che ora risultano asportati o strappati da ignoti. Il tedesco ne farà approntare altri due a spese del Comune ed esige la vigilanza mediante appostamenti da parte di guardie di città! Il podestà Bianchetti, con prot. 10528 del 4 novembre, gira la segnalazione al «Capo delle Guardie Urbane» con «l’incarico di fare accertamenti in merito e riferire dell’esito». Pronta, e scontata, la risposta del capoguardia Giovanni Trischetti: «da indagini praticate non fu possibile avere il minimo indizio di chi possa avere asportato le frecce […] detti vandalismi sono certamente stati fatti di notte durante l’oscuramento come purtroppo tutte le mattine vengono cancellate numerose iscrizioni sui muri fatte da ignoti».Gli «ignoti» erano piccole bande spontanee di giovanissimi, attive sino all’inizio del 1944. 7 Ove non altrimenti indicato, tutte le informazioni concernenti l’episodio del 2 maggio 1944 e conseguenze relative, sono tratte dal fascicolo del processo a carico di «due ignoti» (Walter e la madre), dei due ferrovieri e del Besana, consultato a metà degli anni ottanta, nell’archivio della Pretura di Domodossola. 8 Ancora nel maggio 1944 il flusso di fuggiaschi verso la Svizzera, seppur diminuito rispetto ai primi mesi dell’occupazione, non era cessato. Antonio Bolzani, all’epoca comandante delle Guardie di frontiera del Canton Ticino, nel suo libro Oltre la rete. Storia delle migliaia di italiani, perseguitati, ebrei, braccati dai nazifascisti, Milano 1946, pubblica la statistica dei «civili» accolti nel Cantone di sua competenza provenienti quindi non solo dalla provincia di Novara ma anche da quelle confinanti lombarde di Varese e Como. In quel mese di maggio del 1944 entrarono 339 persone; erano state 329 in gennaio, 229 in febbraio, 323 in marzo, 275 in aprile, per scendere poi a 148 in giugno. Queste le entrate del secondo semestre: 183 in luglio, 286 in agosto, 316 in settembre, 3.528 in ottobre (il picco riflette eloquentemente l’esodo degli ossolani alla caduta della «repubblica» partigiana), 297 in novembre, 258 in dicembre. 9 In Archivio privato Augusto Rima, Losone-Locarno. 10 Anche se appare verosimile che Walter e sua mamma fossero ebrei, una nostra ricerca risalente ormai ad almeno venti anni fa presso la Comunità ebraica di Torino che diffuse ai propri membri le sommarie indicazioni emerse dal processo, tra cui data, località, nome del ragazzo, non ha sortito alcun esito. 11 Vincenzo Pappalettera, Tu passerai per il camino, Torino 1965, a p 235 pubblica l’elenco delle vittime italiane del lager di Melk, un Kommando dipendente da Mauthausen, anticipando la morte del Besana al 17 dello stesso mese. 12 Test. dei partigiani Carlo Tessitori di Domodossola, Vico Rosaspina di Milano e, tutti di Masera, Onorina Castelli, Franco Sgrena e Gustavo Betlamini. Quest’ultimo ricorda che vennero condotti oltre confine anche ex prigionieri alleati provenienti da Vercelli. Ne abbiamo precisa conferma da Giuseppe Bacciagaluppi, Rapporto sull’attività in favore di ex prigionieri alleati, in «Agorà», fascicolo monografico sul Novecento e la Resistenza, Liceo scientifico G. Ferraris, Varese 1999, pp.249-63. 13 Test. di F. Sgrena. 20 400 nomi. L’archivio sulla deportazione novarese: un progetto in corso di Giovanni Galli Premesse storiche Per un istituto storico della Resistenza e della società contemporanea l’attenzione verso il fenomeno della deportazione risulta scontata, parte integrante della propria attività istituzionale sul territorio, anche se inizialmente - l’istituto di Novara è attivo dalla seconda metà degli anni sessanta - la ricerca è stata in buona parte assorbita dalle tematiche relative alla guerra partigiana. La società nel suo insieme del resto aveva accolto nell’immediato dopoguerra i deportati e i loro racconti con lentezza e forse qualche iniziale diffidenza: «La cosa più importante da rilevare è che, non diciamo dal ’45, ma da qualche anno dopo, per un arco di tempo di molti anni, nelle scuole, negli istituti l’unica presenza accettata è stata soltanto quella di Primo Levi, […] per l’enorme successo ottenuto con i suoi libri, […] per cui era richiesta la sua presenza anche ad altissimo livello culturale, tutte porte che per i deportati politici erano chiuse, sistematicamente chiuse. […] Per venti anni, diciamo ’58 – ’78, solo lui ha fatto la parte per tutti noi»1. Lo stesso atteggiamento si poteva riscontrare anche a livello della realtà locale. Il Novarese, e con questo si intende l’area interessata dalle attuali province di Novara e del Verbano, Cusio, Ossola, è stata una zona di forte radicamento partigiano e come ricordavano alcuni anni fa Gisa Magenes e Filippo Colombara a proposito della loro ricerca sui deportati di Villadossola: «nella comunità forte permane il dibattito sull’epopea resistenziale. […] L’effettiva realtà dei campi di sterminio è conosciuta da pochi, la confusione tra internati militari e deportati è tuttora presente»2. Posizione che emerge lucidamente dalle parole di Rino Zanelli3: «Nei primi anni non si sapeva niente dei campi di concentramento, noi si parlava perché per forza qualche volta si doveva parlare, però non eravamo neanche capiti perché sembrava impossibile; la maggioranza erano internati militari, sentivano la maggioranza, i primi anni pochi conoscevano la nostra condizione […] 21 Giovanni Galli il problema della deportazione è stato capito molti anni dopo perché han cominciato a vedere attraverso film, racconti, documentari, noi non si raccontava perché tanti non credevano “ma è impossibile che siete stati male così”, eppure…»4. Nonostante ciò l’Istituto storico di Novara, come gli altri istituti del resto, aveva già iniziato dagli anni settanta a lavorare attorno alle tematiche della deportazione sulla base della prima memorialistica e soprattutto dei contatti e colloqui con i partigiani deportati. La situazione riguardo alle ricerche sulla deportazione, come è noto, è ulteriormente migliorata negli anni ottanta, per varie ragioni, non ultima l’attenzione che le amministrazioni pubbliche hanno dedicato al problema. Si sono intensificate le ricerche, i convegni e le pubblicazioni sull’argomento e questo clima più favorevole e meno reticente ha fatto sì che molti ex deportati, che ancora non l’avevano fatto, accettassero interviste e testimoniassero la propria esperienza spesso anche con scritti di memorie, indispensabili per una più attenta ricostruzione degli eventi. In questo contesto si collocano le interviste a Enrico Piccaluga, a Otello Vecchio e a Francesco Albertini5, ma anche il recupero di importante materiale fotografico che ora costituisce il Fondo deportazione dell’Archivio fotografico dell’Istituto novarese: si tratta di oltre cento foto su pannelli per una mostra organizzata dall’Aned negli anni sessanta, di foto private donate da Otello Vecchio e delle copie di materiale appartenente ad Albe Steiner. Il lavoro svolto dall’Istituto su questo fondo è stato successivamente evidenziato nel seminario di studi Progetto di un archivio delle immagini dello sterminio, svoltosi a Novara nell’aprile del 1999. Grazie a questi materiali e a partire da queste prime attività, iniziano le ricerche sistematiche condotte sul nostro territorio da Gisa Magenes, insegnante e storica locale, purtroppo scomparsa, e da suo marito Filippo Colombara, anch’egli ricercatore. Loro fanno parte del gruppo di lavoro (promosso a livello regionale dall’Aned in collaborazione con l’Università di Torino e gli istituti storici provinciali) che ha intervistato gli ex deportati della Regione ancora in vita. La ricerca iniziata nel 1982 porta alla pubblicazione nel 1985 del libro La deportazione nei campi di sterminio nazisti (a cura di Federico Cereja e Brunello Mantelli) e nel 1986 alla raccolta di testimonianze e interviste La vita offesa (a cura di Anna Bravo e Davide Jalla). Tra i novaresi6 gli autori della ricerca si erano concentrati sul gruppo di Villadossola, di cui poi meglio riparleremo, perché particolarmente 22 400 nomi. L’archivio sulla deportazione novarese: un progetto in corso interessante in relazione ai rapporti tra i ricordi degli ex deportati e la comunità locale d’origine. Il lavoro di raccolta dei nominativi e delle testimonianze è poi proseguito negli anni successivi fino ad arrivare al 1994 quando, sulle riviste locali «Fogli sensibili» prima e «Resistenza Unita» poi, sempre Gisa Magenes, con il contributo dell’Istituto Ernesto De Martino, pubblica un elenco di 99 persone che costituirà il primo punto fermo per la conoscenza della deportazione sul territorio. Vengono segnalati i novaresi di nascita o di residenza, ma anche i non novaresi arrestati nella provincia e poi deportati. Da questo elenco sono escluse alcune categorie, gli Imi e i «lavoratori liberi»7, ma sono segnalati quelli che, mandati in Germania come internati militari, finiscono poi nei campi di concentramento. Inoltre non ci sono distinzioni tra politici e deportati per motivi di razza (sono inclusi i due Levi catturati a Orta nel settembre del 1943) e in molti casi non compare il campo di destinazione, ma solo una generica indicazione di deportazione in Germania. Dove la destinazione, o le destinazioni sono indicate, si evidenzia l’alto numero (circa il 38 per cento) di persone mandate nel campo di Mauthausen e anche l’alto numero complessivo dei decessi (circa il 55 per cento). In seguito e spesso a margine di altri lavori di ricerca nuovi episodi di deportazione emergevano, anche di una certa entità come è il caso delle decine di civili catturati a Verbania durante il rastrellamento della val Grande nel giugno del 1944 e poi mandati per lo più nei campi di lavoro in Germania. A volte erano persone di cui si conoscevano almeno alcuni dati biografici e di cui occorreva ricostruire per intero la vicenda, altre volte erano soltanto dei numeri ancora senza nome e senza storia (gli ottantasei di Verbania, appunto). E intanto, tra gli ultimi anni novanta e i primi anni duemila, si arricchiva ulteriormente di documenti l’Archivio dell’Istituto relativo alla deportazione8 e proseguivano le interviste e le pubblicazioni sul tema9. A partire da questa situazione il nostro lavoro è andato avanti con l’obiettivo di completare la schedatura dei nominativi con quelli che si erano aggiunti nel frattempo, per ottenere un quadro completo della deportazione locale. Si trattava di mettere assieme e ordinare tutte le informazioni a disposizione per recuperare la memoria di quegli eventi e dare voce a tutti quanti avevano vissuto tale esperienza, ma anche per rispondere alle esigenze di chi si rivolgeva all’Istituto per motivi di ricerca o personali, per avere informazioni su parenti in vario modo coinvolti con le vicende della 23 Giovanni Galli seconda guerra mondiale. Realizzare una banca dati sui deportati sarebbe stato uno strumento comodissimo per fornire le prime informazioni essenziali e da qui si è ripartiti cercando di conciliare il rigore della ricerca con le esigenze pratiche di funzionalità del servizio. Considerazioni metodologiche Per questo quanto alla definizione di deportazione i criteri adottati sono stati forse più ampi sia rispetto alla ricerca nazionale coordinata da Nicola Tranfaglia e Brunello Mantelli, sia rispetto all’originario elenco di Gisa Magenes: lo scopo iniziale era raccogliere tutti i nominativi possibili che abbiano avuto relazione con le diverse tipologie di deportazione nell’accezione più ampia del termine, includendo i VL, i KL, i campi di transito e i campi di lavoro (lavoro coatto – «lavoratori liberi»), anche se per ora non abbiamo considerato gli internati militari10, se non quelli che poi sono finiti anch’essi nei campi di concentramento. Inoltre sono stati incluse, per l’importanza storica non solo locale dell’evento, anche le cinquantasei persone ebree catturate tra settembre e ottobre 1943 nella nostra zona, la cosiddetta strage del lago Maggiore. A prescindere quindi dalla loro effettiva sorte individuale, è praticamente certo che tutte vennero uccise nel Novarese appena dopo la cattura, si è preferito ricordarle accomunandole nella categoria dei deportati della Provincia. Un’altra inclusione parzialmente forzata per eccesso riguarda le persone che seguono la sorte di Clotilde Giannini, operaia nativa di Tornaco (provincia di Novara), ma residente a Gravellona Lomellina (provincia di Pavia). In seguito agli scioperi del marzo 1944 viene arrestata e poi deportata (muore a Bergen Belsen) con Camilla Campana, Luigina Cerini e Giovanni Maccaferri. Loro tre sono pavesi ma ci è sembrato opportuno includerli anche nella banca dati di Novara perché la loro vicenda si intreccia strettamente con quella di una novarese11. Sempre dal punto di vista metodologico occorre precisare che nel nostro database abbiamo segnalato le fonti in cui si trovano notizie del deportato, evidenziandone le eventuali discrepanze, ma di fatto (salvo qualche eccezione) le abbiamo considerate tutte sullo stesso piano. La ricerca inizialmente è stata di natura bibliografica, nel senso che le informazioni e i nomi erano già presenti in libri, opuscoli e articoli editi, ma in ordine sparso. Abbiamo quindi semplicemente censito, sistemato e ordinato con 24 400 nomi. L’archivio sulla deportazione novarese: un progetto in corso criteri funzionali alle esigenze dell’istituto, tutto quanto siamo riusciti a reperire. In seguito, e allo scopo di verificare e approfondire alcuni dati, abbiamo iniziato un lavoro di consultazione archivistica che sta ancora procedendo su alcuni fondi presenti in istituto12 e nell’archivio di Stato di Novara. Ed è a questo livello di consultazione che sono comparsi molti nomi nuovi, in particolare per quanto riguarda i lavoratori coatti, che non risultano per il momento in nessuna fonte già edita. Quindi abbiamo preferito per il momento registrare e formalizzare su una scheda ogni nominativo, riservando ad un secondo livello di analisi e di sviluppo del database le scremature sulla base di più attenti controlli incrociati e delle fonti gerarchicamente più autorevoli. Riflessioni generali sulla struttura della banca dati I dati raccolti inizialmente erano tutti in formato cartaceo con i nomi dei deportati ordinati alfabeticamente. Successivamente si è passati al supporto informatico, anche se ancora in modo incompleto e imperfetto. Esiste comunque un database con le informazioni principali riguardanti le persone. Innanzitutto i dati anagrafici con l’indicazione del titolo di studio e della professione, perché ci sembrava importante capire l’estrazione sociale dei deportati anche in relazione alle diverse tipologie di deportazione, ma i dati sono spesso mancanti e in certi casi non del tutto attendibili: all’ingresso in lager dichiarare una professione anziché un’altra, anche se falsa, poteva essere estremamente utile. In seguito la scheda riporta una sintesi delle circostanze che hanno condotto all’arresto e alla successiva deportazione. Nel caso dei politici è presente anche la descrizione dell’attività partigiana con l’indicazione della formazione di appartenenza. Il contesto in cui le persone vengono arrestate è significativo per verificare se la cattura è avvenuta per rappresaglia in seguito ad azioni militari partigiane, per rispondere a precise direttive tedesche riguardanti il reclutamento di mano d’opera nei territori occupati, oppure ancora come atto dimostrativo per terrorizzare la popolazione civile. È utile anche per capire chi è l’autore dell’intervento e in particolare se si tratta o meno di reparti italiani o se comunque si possano ravvisare responsabilità locali e nazionali. Infine permette di capire le caratteristiche del deportato: abbiamo indicato alcune tipologie ricorrenti (militari, lavoratori coatti, politici, ebrei), ma all’interno di queste altre differenziazioni e 25 Giovanni Galli diverse classificazioni sono possibili a seconda delle esigenze di ricerca. Vi è però ancora un buon numero di persone che non siamo riusciti ad inserire in nessuna di queste categorie per insufficienza di informazioni. A questi dati si aggiungono quelli strettamente riguardanti l’esperienza del lager con l’indicazione del campo o dei campi di permanenza: come già precisato abbiamo considerato anche i deportati rimasti nel solo campo di transito di Bolzano. Seguono l’indicazione della tipologia di deportazione, se nota, e alcune note tecniche: numero del trasporto, numeri di matricola, date di partenza, date e luogo di eventuale decesso, di liberazione e di rientro in Italia. Sempre in questo settore della scheda abbiamo inserito eventuali testimonianze legate ai ricordi nei campi. Per lo più si rinvia alla bibliografia delle fonti, ma in certi casi possono comparire segnalazioni di compagni deportati di cui non risulta per il momento altra fonte13 oppure utili testimonianze riguardanti persone decedute di cui non si aveva altra notizia14. La parte conclusiva riguarda brevi cenni biografici sulla persona prima della guerra ed eventualmente dopo. Anche in questo caso abitualmente si rinvia alle fonti segnalando solo le circostanze più significative e interessanti per cogliere quanto l’antifascismo sia in relazione con deportazione e per approfondire meglio i rapporti tra il deportato e la sua comunità al rientro15. La scheda termina con l’elenco delle fonti e alcune brevi note per spiegare o semplicemente evidenziare discordanze e contraddizioni tra fonti. Dovrebbe essere dunque uno strumento funzionale non solo per una veloce ricerca nominativa, ma anche per fornire un minimo di indicazioni sulla storia del deportato e quindi indirizzare il lavoro di chi si avvicina a questo materiale per motivi di studio. Da qui poi è possibile passare alla schede cartacee di ogni deportato, che già in molti casi contengono fotocopie di documenti che li riguardano, e poi naturalmente alle fonti dirette citate nelle schede. Le tipologie dei deportati Ogni classificazione sconta il limite della genericità e ovviamente dell’arbitrarietà, ma è utile per descrivere sinteticamente le caratteristiche della deportazione nel Novarese e per confrontarle con altre aree geografiche. Va comunque tenuto presente che una parte delle persone schedate, circa il 25 per cento, non risulta ancora identificabile con certezza, ma le 26 400 nomi. L’archivio sulla deportazione novarese: un progetto in corso possibilità che buona parte di loro siano «politici» è alta. Per deportazione si intende sostanzialmente quella dei politici che finiscono nei campi di concentramento nazista (KL/KZ - Konzentrationslager) e quella degli ebrei deportati nei campi di sterminio (VL - Vernichtungslager). Nel nostro archivio abbiamo schedato anche gli IMI che poi finiscono nei KL e soprattutto i lavoratori coatti, considerando che, in particolare per la deportazione italiana avvenuta tra l’autunno del 1943 e l’inizio del 1945, le distinzioni tra deportati politici nei KL, internati militari, lavoratori coatti e in parte, dall’estate del 1943, anche ebrei, ovviamente quelli «selezionati per il lavoro», finiscono per sfumare quanto alle loro condizioni e soprattutto al loro utilizzo, in particolare nell’ultimo anno di guerra16. Politici È sicuramente la categoria più rappresentata con circa la metà dei nominativi tuttora segnalati, e questo per molti aspetti è un dato abbastanza scontato e atteso per una zona ricca di formazioni partigiane ripetutamente coinvolte in scontri e sottoposte a rastrellamenti. E proprio in relazione al grande rastrellamento del giugno 1944 sui monti della val Grande, a nord di Verbania (l’operazione Köln-Freiburg), vengono deportati molti partigiani appartenenti alla formazione Valdossola di Dionigi Superti e Mario Muneghina, che in quel periodo subisce un alto numero di perdite durante gli scontri o dopo la resa, per rappresaglia o per terrorizzare la popolazione (come è il caso dei diciassette fucilati a Baveno o dei quarantatre a Fondotoce). Purtroppo le schede per il riconoscimento della qualifica di partigiano compilate nell’immediato dopoguerra dal CLN dell’Alta Italia contengono solitamente l’indicazione «deportato in Germania» e solo in alcuni casi si specifica il campo di destinazione. Tra i politici sono presenti anche partigiani della prima ora come quelli coinvolti nell’insurrezione di Villadossola del novembre 1943 e tra questi Luigi Boghi di Domodossola, arrestato e condannato a morte dopo il processo a Novara. La pena viene successivamente commutata in dieci anni di reclusione in Germania che sconta in alcuni campi nei pressi di Monaco («a Bernau si lavorava la torba, o si piantavano patate o rabarbaro»17), di Baden Baden («si lavorava 12 ore al giorno alla fabbrica della BMW, sorvegliati da capiturno civili, tutti nazisti fanatici»18) e infine a Rosenheim («il 27 Giovanni Galli nostro compito era quello di andare a rimuovere macerie e cadaveri dopo ogni bombardamento; si era talmente cattivi che si guardava se spuntavano dalle macerie le strisce gialle o rosse delle divise degli internati e si tiravano fuori solo quelli, i civili tedeschi si lasciavano sotto appena si poteva»19). Vi sono poi casi individuali, storie curiose e percorsi a volte anche molto diversi tra loro. Tra i superstiti troviamo giovani come l’operaio ossolano Rosano Brustia, partigiano della divisione Valtoce durante la liberazione di Domodossola nell’autunno del 1944. Viene preso nel gennaio dell’anno successivo mentre tenta di catturare alcuni fascisti per uno scambio di prigionieri: dopo aver scampato l’immediata fucilazione, è mandato a Bolzano dove per due volte viene caricato sui convogli, prima diretto a Mauthausen e poi a Buchenwald, ma i treni non possono partire a causa dei bombardamenti alleati. Alla fine lo lasceranno in un piccolo campo di lavoro nei pressi di Vipiteno dove verrà liberato a fine guerra. Tra i deportati di questo gruppo ci sono anche vecchi e noti antifascisti novaresi come Francesco Albertini, Carletto Leonardi o Montano Lampugnani20, ma anche altri meno noti. È il caso di Ugo Suardi di Novara, operaio all’Abital di Rho, in provincia di Milano, dove viene arrestato nella primavera del 1944. Dopo alcuni mesi passati a S. Vittore viene mandato nel campo di Flossenbürg e lì muore nel settembre del 1944. Oppure Antonio Paglino di Trecate, antifascista dagli anni venti e per questo incarcerato e poi confinato a Ventotene fino al 1943. L’anno successivo viene nuovamente arrestato per attività partigiana e deportato a Mauthausen. Lavoratori coatti Le prime fasi di sviluppo dei campi di concentramento, che coincidono con i primi anni del regime hitleriano, sono caratterizzate dall’utilizzo dei detenuti per attività anche lavorative ma a scopo «rieducativo» non certo produttivo. La situazione cambia dopo il 1936, anno in cui il sistema concentrazionario viene posto sotto il controllo della polizia di sicurezza (SIPO) e del servizio di sicurezza delle SS (SD), entrambi comandati da Reinhard Heydrich e quindi dal suo superiore Heinrich Himmler. A questo punto il lavoro dei deportati incomincia ad essere finalizzato ad obiettivi economici: «la creazione delle prime imprese economiche delle SS anticipava il primo sistematico impiego dei prigionieri per il lavoro a profitto dell’apparato alle dipendenza di Himmler»21. 28 400 nomi. L’archivio sulla deportazione novarese: un progetto in corso Con l’inizio della guerra e in seguito l’espansione verso l’Urss si intensifica sempre più lo sfruttamento economico dei deportati a cui si aggiungono i lavoratori prelevati a forza dai territori orientali e portati nelle aziende tedesche. In questo contesto l’anno di svolta più significativo è il 1942 quando già dai primi mesi vengono prese importanti decisioni, a partire dall’ordinanza di Hitler per la pianificazione della produzione bellica (10 gennaio). Il 1° febbraio del 1942 viene poi costituito l’Ufficio centrale per le questioni economiche e amministrative (WVHA) che raccoglie le varie strutture delle SS deputate a quegli scopi. Il capo di questa istituzione, Oswald Pohl, emana il 30 aprile dello stesso anno un ordine «sulla responsabilità dei comandanti dei campi di concentramento per l’impiego come mano d’opera dei prigionieri. […] Questo impiego deve essere produttivo nel vero senso della parola, al fine di ottenere il massimo rendimento»22. Intanto a marzo Himmler aveva fatto confluire nel WVHA l’Ispettorato di controllo dei KL e nello stesso mese era stato creato l’ufficio del Plenipotenziario generale per l’impiego della manodopera (GBA - Generalbevollmächtiger für der Arbeitseinsatz) con a capo Fritz Sauckel. In questi mesi si assiste alla «proliferazione dei cosiddetti sottocampi o campi esterni (Aussenlager) che fece sì che intorno ai campi base o campi principali si ramificassero una serie di filiali, talvolta a notevole distanza dallo Stammlager, che diventava così a sua volta l’epicentro di un sistema policentrico»23. Sistema nel quale si inseriscono sempre di più le imprese private, e in particolare quelle legate alla produzione bellica, che intensificano e formalizzano i loro rapporti economici con gli apparti delle SS24. Ma a partire dal 1943 la Germania è sempre più in difficoltà per la presenza nel Mediterraneo degli Usa e la controffensiva russa. Per questo l’armistizio italiano dell’8 settembre 1943 può almeno servire per risolvere in parte la situazione di ormai cronica mancanza di manodopera in un momento in cui la Germania deve aumentare considerevolmente il proprio sforzo bellico25: i deportati italiani (e i militari e i lavoratori coatti) arrivano quindi quando la macchina tedesca dello sfruttamento economico è necessariamente in piena attività. A questo punto non solo Sauckel, ma anche la Wehrmacht26 cercheranno in tutti i modi di recuperare persone da utilizzare come lavoratori coatti. I piani grandiosi di Sauckel, che prevedeva il trasferimento di un milione e mezzo di italiani in Germania, resteranno ampiamente disat29 Giovanni Galli tesi anche per i contrasti con il ministero delle Armi e Munizioni diretto da Albert Speer (più propenso a trattenere nei paesi d’origine i lavoratori occupati in aziende a produzione bellica utili per la Germania) e con le autorità politiche e militari presenti in Italia. Il rappresentante di Himmler e quindi delle SS Karl Wollf e soprattutto il plenipotenziario del Reich, l’ambasciatore Rudolph Rahn sono favorevoli a una linea più moderata e che comporti il coinvolgimento delle autorità italiane della Rsi nell’invio dei propri cittadini in Germania27, al fine di ridurre fenomeni di resistenza contro i tedeschi e fughe nei gruppi partigiani. La collaborazione delle autorità italiane, pur con molti limiti dovuti a carenze organizzative, ci sarà in effetti sin dall’inizio28, ma i risultati dei bandi d’arruolamento sono molto deludenti29. Gli obiettivi non vengono raggiunti e per questo iniziano meticolosi rastrellamenti prima cercando di ottenere «volontariamente» operai disposti a trasferirsi in Germania e poi passando a vere e proprie operazioni di razzia: «in pieno giorno, nei grandi centri, pattuglie motorizzate tedesche chiudevano, con improvvisati posti di blocco volanti, un incrocio, un bivio, una strada o una piazza e i passanti sprovvisti di documenti oppure che non erano in grado di dimostrare di avere un’occupazione venivano deportati come lavoratori coatti»30. Questo accadrà non solo nelle città ma anche nei piccoli paesi di montagna come Trontano, nei pressi di Domodossola, dove il 12 giugno del 1944 i tedeschi fermano a un posto di blocco tre ragazzi di diciassette e diciotto anni mentre si stanno recando al lavoro, Giovanni Pelganta, Augusto Conti e Luigi Jossi31. Dopo una breve permanenza nelle carceri ossolane, vengono destinati assieme ad altri al campo di Zwickau, destinazione finale anche per il gruppo più numeroso dei ragazzi arrestati a Verbania e per gli altri civili catturati a Baveno. Questi arresti avvengono a margine di una grossa operazione antipartigiana, il rastrellamento in val Grande, ma la manovalanza a bassissimo costo viene reperita anche prelevando scioperanti nelle fabbriche o tifosi di calcio all’uscita dagli stadi32. Le misure adottate dalle autorità tedesche tendono quindi ad oscillare tra l’arruolamento volontario e le razzie generalizzate33, e come detto il numero degli italiani portati in Germania come lavoratori coatti è decisamente inferiore rispetto alle intenzioni di Sauckel e dei suoi uomini, ma in ogni caso raggiunge la ragguardevole cifra di circa 100.000 persone durante il periodo di occupazione tedesca. Si tratta di civili che rientrano nei bandi d’arruolamento (quelli che si presentano volontariamente e quelli 30 400 nomi. L’archivio sulla deportazione novarese: un progetto in corso che vengono catturati come renitenti); di lavoratori direttamente prelevati nelle aziende e in accordo con le autorità italiane; di lavoratori, studenti o altro, presi «a margine» di rastrellamenti34 o semplicemente presi e portati in Germania a lavorare. Queste persone si aggiungono alla quantità più o meno simile di lavoratori italiani emigrati in Germania a partire dal 193835 e trattenuti a forza dal settembre 1943. In condizioni di lavoro coatto finiscono poi gran parte dei deportati nei KL (ca. 40.000) e circa 400/450.000 soldati italiani catturati e considerati internati militari. Naturalmente la condizione di vita e di lavoro cambia abissalmente a seconda che ci si trovi a Mauthausen o a Zwickau36, e la destinazione è determinata dalle motivazioni che portano all’arresto, ma tenuto conto degli spostamenti e dei mutamenti anche notevoli di condizione degli stessi deportati e del comune utilizzo di queste persone, cioè del loro sfruttamento a fini economici, ci sembrava importante segnalare anche i lavoratori coatti e inserire i loro nomi nel database. Ebrei La deportazione razziale, che in provincia di Novara ha coinvolto esclusivamente ebrei, consiste in modo particolare nella «strage del lago Maggiore», la prima uccisione sistematica per odio antisemita avvenuta sul territorio italiano ad opera dei tedeschi. Si tratta di cinquantasei persone in parte residenti nel Novarese, in parte di passaggio verso la Svizzera, che vengono uccise e spariscono nell’autunno del 1943, durante le primissime settimane di occupazione. In alcuni casi la popolazione locale, come vedremo, contribuisce alla cattura degli ebrei, ma in molte altre situazioni risulta determinante per la loro salvezza e grazie alle informazioni tempestive sull’arrivo dei tedeschi permette loro di sottrarsi alla deportazione37. La presenza ebraica sul territorio non riguarda però soltanto i fatti avvenuti sui laghi all’arrivo delle truppe di occupazione tedesca. Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 la provincia di Novara diventa luogo di transito per molti che cercano salvezza in Svizzera. Una parte di loro è costituita da ebrei (complessivamente passeranno il confine italo-svizzero circa in 6.000) che attraversano le zone del Verbano, sfruttando i sentieri sulle alture a ridosso del lago Maggiore e la val Cannobina, e dell’Ossola, con le sue molteplici valli, come la val Vigezzo o la val Formazza, che mettono in 31 Giovanni Galli comunicazione Domodossola con la Svizzera38. Gli ebrei presenti in queste zone vengono aiutati ad espatriare dagli abitanti dei paesi di montagna, dagli «spalloni», i contrabbandieri (anche se a volte dietro compenso), e dai partigiani come quelli appartenenti alla formazione Cesare Battisti che nel Verbano organizzano la fuga in Svizzera di molte persone. Ma non sempre la fuga riesce: sono documentati gli arresti ad opera della Gnr (Guardia Nazionale Repubblicana) confinaria a Craveggia, in val Vigezzo, che portano alla cattura delle famiglia di Abner Hasson e Ester Ass, lui greco e lei lituana, dei turchi residenti a Trieste Emanuele Staineri e Basilia Salambrassi, della famiglia ferrarese di Gino Ravenna e Letizia Rossi. È molto probabile che anche in questi casi ci siano state delazioni che hanno permesso ai fascisti di rintracciare e fermare queste famiglie in giorni diversi nel dicembre 1943. La sorte che seguiranno è comunque piuttosto simile: dal carcere di Domodossola a quello di Novara, per poi finire a S. Vittore e successivamente deportata dalle SS ad Auschwitz la famiglia Hasson; direttamente da Domodossola a Milano e poi ad Auschwitz gli Staineri; da Domodossola a Ferrara e poi a Fossoli prima di arrivare ad Auschwitz, i Ravenna39. Militari I militari italiani disarmati e catturati dopo l’8 settembre dai tedeschi in Italia e all’estero (in particolare nei Balcani) superano il milione. Vengono subito (dal settembre 1943) considerati internati militari (IMI) per ordine di Hitler e questo li pone in condizione di essere utilizzati come lavoratori per le aziende belliche tedesche40. Solo una parte degli IMI accetta di riprendere il servizio militare con le autorità tedesche o italiane della Rsi, per cui considerando tutti i morti e quelli che riescono a scappare o comunque a tornare in libertà, e tenuto conto che l’esenzione al lavoro per gli ufficiali termina di fatto nell’estate del 1944 quando, sulla base di un accordo tra Hitler e Mussolini, tutti gli IMI vengono trasformati in «lavoratori civili», la cifra complessiva dei militari italiani usati come manodopera schiavile supera abbondantemente le 400.000 persone41. I nomi segnalati nel nostro archivio sono di pochi deportati, sette per la precisione, tutti tornati dal lager e alcuni di loro intervistati da Gisa Magenes (le registrazioni sono conservate in istituto e in parte pubblicate42). 32 400 nomi. L’archivio sulla deportazione novarese: un progetto in corso Questo piccolo campione di persone può facilmente essere diviso in due gruppi: soldati catturati in Italia o all’estero dopo l’8 settembre dai tedeschi, oppure soldati che sono già nelle carceri militari per una condanna avuta dalle autorità italiane. Rientrano nel primo caso Aldo Scendrati, arrestato a Lubiana, Renato Colombo e Cornelio De Taddeo43: la loro sorte segue quella degli Internati militari italiani, e a dire finiscono nei campi di concentramento controllati dalla Wehrmacht e sono divisi tra ufficiali e resto della truppa. In seguito vengono spostati, come molti altri militari italiani, nel campo di Dora Mittelbau, istituito per espresso volere di Hitler come sottocampo di Buchenwald e adibito alla costruzione delle armi segrete (V1 e V2). È situato in una zona mineraria ricca di gallerie e quindi ideale per realizzare la produzione bellica al riparo dai continui bombardamenti alleati a cui erano sottoposti gli impianti tedeschi. Diventerà poi un KL autonomo dall’ottobre del 194444. Diversa la situazione di Francesco Luigi Lamagni, Gaudenzio Peroni e Marco Abruzzese: sono militari già detenuti nel carcere di Peschiera nel settembre del 1943 quando arrivano i tedeschi che li prelevano mandandoli immediatamente (trasporto n. 2 del 20 settembre 1943) a Dachau45. Una vicenda diversa dalle precedenti riguarda invece il lombardo Carlo Fontanella46 che, militare da un mese nell’aeronautica a Casale Monferrato, il 23 febbraio 1944 diserta per non giurare fedeltà alla Rsi rifugiandosi nel Novarese, a Cravegna in val Formazza. Ad aprile viene scoperto da reparti tedeschi e dopo un periodo di permanenza a S. Vittore viene mandato al lager di Bolzano e poi il 7 settembre arriva a Flossenbürg. Merita infine di essere segnalato anche un altro interessante gruppo, trasversale a gran parte dei precedenti, quello costituito dalle donne. Molte di loro sono ebree e sono coinvolte nella strage del lago Maggiore. Vi sono però anche alcune rappresentanti di quell’universo di persone che pur non indossando divise o usando armi ha collaborato molto attivamente con il movimento partigiano armato, come Antonietta Babbini, Renata Grossi, Domenica Diverio47, oppure le operaie del gruppo di Clotilde Giannini, a cui si è già fatto cenno. Clotilde lavorava al calzificio Giudice di Cilavegna (sempre in provincia di Pavia) e a marzo dopo uno sciopero viene arrestata e poi deportata con i compagni di lavoro Camilla Campana, Luigina Cerini e Giovanni Maccaferri48. Il percorso della deportazione delle tre donne è per altro interessante e complesso: tutte e tre finiscono prima a Mauthausen e poi ad Auschwitz; ad Auschwitz resterà fino alla liberazione 33 Giovanni Galli la Cirini, mentre la Giannini viene mandata a Bergen Belsen dove muore e la Campana passando per Rawensbrück e Buchenwald finisce a Lipsia dove viene liberata. Qualche esemplificazione sulle tipologie della deportazione nel Novarese La deportazione razziale. La strage del lago Maggiore «La notte dell’11 settembre qualcuno bussò alla porta della casa cantoniera di Meina, in località Pontecchio. Pioveva forte. Il cantoniere, Ernesto Giuliani, andò ad aprire. Erano tre soldati tedeschi, tutti bagnati. Viaggiavano su una moto con sidecar. Entrarono e si fermarono qualche ora per asciugarsi e riposare. Il cantoniere sapeva qualche parola di tedesco e facendo un po’ di conversazione apprese da dove venivano. Erano le prime SS della divisione corazzata Leibstandarte Adolf Hitler che arrivavano sul lago Maggiore. Il grosso sarebbe arrivato il giorno dopo»49. Sono militari del primo battaglione, secondo Reggimento, prima Divisione meccanizzata (Panzergrenadier Division) Waffen SS Leibstandarte Adolf Hitler, in Italia dall’agosto 1943 dopo essere stati a combattere sul fronte orientale. Fa parte, con la 24a Divisione corazzata, del secondo corpo d’armata Waffen SS di stanza a Reggio Emilia. Assieme ad altri reparti, “per una forza che può essere stimata attorno ai 120.000 uomini”50, costituisce il gruppo di eserciti B (Heeresgruppe B) al cui comando è stato posto Erwin Rommel e il cui obiettivo consiste, in base alle disposizioni di Hitler, nel controllare la pianura padana dopo la destituzione e l’arresto di Mussolini. In seguito all’armistizio la Leibstandarte riceve l’ordine di presentarsi nelle caserme italiane per chiedere la resa e la consegna delle armi. Ordine prontamente eseguito dalle prime ore del 9 settembre quando i suoi reparti si muovono dall’Emilia verso la Lombardia (includendo la zona di Verona) e il Piemonte dove il terzo battaglione comandato dal maggiore Joachim Peiper si dirige verso Cuneo rendendosi responsabile oltre che dell’eccidio di Boves, anche della cattura di oltre duecento ebrei provenienti dalla Francia. Questi sono concentrati a Borgo San Dalmazzo e dopo qualche giorno vengono consegnati alla polizia di sicurezza delle SS (SIPO/SD) incaricata dell’applicazione delle misure antiebraiche51. È invece il primo battaglione (comandante Hans Becker) che arriva a Novara e 34 400 nomi. L’archivio sulla deportazione novarese: un progetto in corso da lì, sotto la guida del vicecomandante il capitano Hans Röhwer occupa la zona dei laghi per controllare l’accesso alla Svizzera52. Il comando di battaglione con due compagnie guidate dai capitani Friedrich Bremer e Karl Schnelle si stabilisce a Baveno, mentre le altre tre compagnie comandate dai capitani Max Sterl, Gottfried Meir e Hans Krüger alloggiano rispettivamente a Pallanza, Intra e Stresa53. In quel periodo non sono pochi gli ebrei presenti nei paesi del lago: oltre ai cittadini italiani residenti o villeggianti abituali vi sono anche parecchi stranieri sfollati a causa dei bombardamenti sulle grandi città. Nonostante le discriminazioni razziali gli ebrei italiani si sentivano relativamente al sicuro in Italia e pensavano che la loro cittadinanza li avrebbe comunque protetti dai tedeschi54. Questi riescono ad individuare dove si trovano gli ebrei con l’aiuto di delazioni, ma anche degli elenchi creati dallo stato italiano in seguito alle leggi razziali del 1938 che permettono loro di arrivare alle abitazioni dei residenti. Sono informazioni depositate presso i comuni, le questure, i comandi dei carabinieri, e non sono state distrutte dopo la caduta del governo Mussolini il 25 luglio del 1943, pur essendo prevedibile la sorte degli ebrei presenti in Italia nel caso di un’occupazione tedesca del territorio55. Da lunedì 13 settembre le Waffen SS iniziano i rastrellamenti e i saccheggi e dal 15 le uccisioni e le sparizioni che coinvolgono anche il lago d’Orta e la stessa città di Novara. Non si tratta soltanto di una caccia alle persone ma anche ai loro beni: le abitazioni dei residenti vengono letteralmente depredate. «Era in casa nostra il comando delle SS. Erano in casa, li portavano lì. Li han portati di notte, di giorno. I Serman e quell’altro che aveva la villa lì con due figlie… ah sì ne han portati tanti e poi li portavano via di notte. Questo al 14 settembre del ’43. Sono venuti, hanno requisito una camera e il salone»56. Così racconta Gaetana Cardini, figlia dei proprietari dell’hotel La Ripa di Baveno, sul lago Maggiore, dove si stabilisce per un paio di settimane la quinta compagnia del capitano Karl Schnelle. A Baveno nei giorni successivi vengono uccisi quattordici ebrei e i loro corpi vengono dispersi nel lago e forse in parte sepolti nei boschi sulla riva57: Emil Serman con la moglie Maria Müller, la cognata Stefania Müller e la suocera Giulia Werner; Carla Caroglio; Fanny Jette Engel; Sofia Czolosinska; il rabbino di origine russa Joseph Wofsi con la moglie Emma Baron; Mario Luzzatto con la moglie Bice Genesi, le figlie Silvia e Maria Grazia e la cognata Olga 35 Giovanni Galli Genesi. Per tacitare la popolazione che incominciava a preoccuparsi per la sorte di alcuni suoi concittadini58 i tedeschi costringono il podestà di Baveno, Pietro Columella, a leggere in piazza alcune false lettere di commiato rivolte dalle famiglie Serman, Luzzato e Wofsi alla cittadinanza di Baveno, con le quali spiegavano i motivi del loro allontanamento dal paese ed esprimevano parole di apprezzamento per i tedeschi: «siamo stati arrestati perché ebrei. Ci trattano bene e ci porteranno in un campo di concentramento. In segno di riconoscenza per gli abitanti del paese che ci ha ospitato, lasciamo del denaro affinché venga distribuito ai poveri»59. Intanto iniziano i rastrellamenti anche ad Arona, Meina, Mergozzo e Orta. Ad Arona vengono arrestate nove persone che sono portate prima nella caserma dei carabinieri e poi probabilmente nel carcere di Novara: di loro non si è saputo più nulla60. Sono Irma Finzi con il figlio Vittorio Angelo Cantoni Mamiani Della Rovere; Clara Kleinberger con il figlio Tiberio Alexander Rakosi; Giacomo Elia Modiano con la moglie Mary Bardavid, il fratello Carlo e la sorella Grazia; Margherita Coen. «Il 15 settembre vennero nel mio negozio otto o dieci uomini tedeschi armati. L’interprete tradusse indicando mia moglie: “Lei è in arresto”. Mia moglie è quasi svenuta. Un soldato l’ha presa per un braccio. È partita, è salita su una camionetta, ciau. Sulla camionetta c’era già il conte Cantoni. Nessuno li ha più rivisti»61. Alcune di queste persone non risultano neppure ebree dal punto di vista religioso, ma secondo i criteri del razzismo biologico non è ovviamente quello che conta: è il caso ad esempio di Vittorio Cantoni e di sua madre (ma una situazione analoga si ripete anche ad Orta), «difatti mio marito era cattolico dalla nascita, era battezzato, e mia suocera era battezzata dal 1906. Gli ho fatto vedere [alle SS che sono entrate nella loro villa]: avevamo piene le pareti di papi, di autografi, di quadri religiosi»62. A Meina sono catturati i sedici ebrei presenti nell’hotel Meina, gestito da Alberto Behar, ebreo con cittadinanza turca (circostanza che gli permette di salvarsi assieme alla propria famiglia perché la Turchia in quel momento è un paese neutrale). «Due tedeschi entrarono nella camera, chiedendo a mio padre se era il proprietario dell’albergo. […] Alla riposta affermativa di mio padre dissero «sappiate che da questo momento niente più vi appartiene, avete dato ospitalità nel vostro albergo a degli ebrei, avete quindi aiutato i nemici della Germania!». Dette queste poche parole in tono secco e con un’espressione di durezza nel viso uscirono dalla camera proibendoci di muoverci fino 36 400 nomi. L’archivio sulla deportazione novarese: un progetto in corso a nuovi ordini. […] Da un mese si trovavano in albergo alcune famiglie di ebrei emigrati dalla Grecia e mio padre, senza fare nessuna eccezione per loro, li trattava come gli altri clienti. […] Il console turco, amico di mio padre, si trovava nella nostra villa, essendo stata bombardata la sua casa a Milano. Avvertito quindi dell’arresto di mio padre, si era recato immediatamente al comando dicendo che per nessuna ragione i tedeschi avevano il diritto di arrestare un cittadino turco innocente: aveva quindi chiesto la liberazione di mio padre e di tutti noi, altrimenti avrebbe fatto sorgere una questione diplomatica, essendo la Turchia una nazione neutrale. E così fummo liberati»63. Gli altri ebrei presenti vengono invece trattenuti per alcuni giorni nelle stanze dell’albergo e poi uccisi tra il 22 e il 23 settembre e buttati nel lago legati a pesanti massi. Il luogo degli omicidi è nei pressi della casa cantoniera, all’ingresso del paese, poche centinaia di metri prima dell’hotel dove erano rinchiusi e dove un cippo, ora quasi del tutto illeggibile, ricorda quegli avvenimenti. Alcuni corpi riaffioreranno dalle acque del lago ma le SS faranno di tutto per ributtarli sotto e solo alcuni resti verranno recuperati nei mesi e negli anni successivi. Sono uccisi Dino Fernandez Diaz con il figlio Pierre, la nuora Liliana Scialom e i nipoti Jean, Robert e Blanchette; Raoul Torres con la moglie Valerie Nahoum; Marco Mosseri con la moglie Ester Botton, il figlio Giacomo Renato e la nuora Odette Uziel; Daniele Modiano; Lotte Froehlich; Vitale Cori; Vittorio Haim Pompas. A Mergozzo «alle 15 e un quarto sono venuti quattro soldati tedeschi, un carabiniere disarmato e un interprete. Tutto questo apparato per verificare se erano in casa gli ebrei che avevano in nota: Mario Covo, Alberto e Mati Arditi. C’erano e va bene. Un sommario interrogatorio, un’altrettanta perquisizione della casa, poi tutti se ne sono andati lasciando due soldati armati di tutto punto, con tanto di elmetto, coll’ingiunzione ai tre disgraziati colpevoli… solo di essere nati ebrei, di non muoversi. […] Alle 22 è ritornato il capo di questa piccola spedizione e tutti quanti se ne sono andati. Abbiamo sperato il loro pronto ritorno, dato che si trattava di un interrogatorio. Povero caro il mio uomo e pure i suoi nipoti, così come erano alzati dal letto, senza niente del più elementare fabbisogno per la loro persona… Cosa sarà di loro? Come staranno? Come li tratteranno? Sono le domande angosciose che ogni momento mi faccio»64. In questo modo Mario Abramo Covo e i coniugi Alberto Abramo Arditi e Matilde David spariscono il giorno 15 settembre e di loro non si sa più nulla anche se è 37 Giovanni Galli molto probabile seguano la stessa sorte degli altri ebrei catturati in quei giorni: «Quello che è sicuro, siccome non ci sono tracce, è che quando li hanno portati via, sono passati dietro Mergozzo, verso Gravellona Toce e, lì dove c’è il Toce, li hanno fatti fuori. Così si presume, anche se non è stato trovato niente. Mio padre aveva coscienza della sua fine, aveva lasciato il testamento in bella vista»65. A Orta vengono prelevati Mario e Roberto Levi, rispettivamente zio e cugino di Primo Levi. Roberto ha sposato da pochi mesi con rito cattolico Elena Bachi66 e con i suoi genitori si è rifugiato sul lago nella casa dove i Levi erano soliti passare le vacanze. Con l’arrivo dei tedeschi decidono di fuggire in Svizzera proprio il 15 settembre, ma per un contrattempo che risulterà fatale l’espatrio viene rinviato di un giorno67. «Il giorno 15 settembre del ’43, tra le sedici e le diciassette, mi trovavo al caffè sulla piazza di Orta, insieme a mio marito Roberto Levi, allorché arrivarono due camionette di SS. Il nostro istinto di giovani fu quello di correre a casa, pensando così di sfuggire a un possibile rastrellamento. Poco dopo, mentre eravamo nella nostra camera, sentimmo aprirsi il portone ed udimmo dei passi su per le scale. Di colpo capimmo che si trattava di militari che venivano a cercarci. Non sapendo dove nasconderci, né pensando al peggio, dato che non avevamo, fino ad allora, avuto notizie di ricerche di ebrei da parte dei tedeschi, appena ci fu detto che eravamo chiamati al piano inferiore, ci presentammo»68. La storia poi procede in modo rocambolesco e strano: i tedeschi attendono l’arrivo in casa di Mario Levi e di sua moglie Emma Coen, li interrogano in modo gentile e poi prelevano, per proseguire altrove l’interrogatorio, solo i due uomini. Elena Bachi e la suocera in preda alla disperazione iniziano dal giorno successivo la ricerca dei loro mariti nelle cittadine sul lago Maggiore dove si diceva stessero portando gli ebrei arrestati e a Stresa vanno direttamente al comando SS a chiedere informazioni, ma non sono arrestate. Vengono però raggiunte da un padre rosminiano che le esorta a fuggire raccontando loro quello che sta succedendo. A questo punto il destino delle due donne si divide. Elena tornerà a Orta e aiutata ancora dal podestà verrà affidata alle cure del parroco di Omegna, don Giuseppe Annichini, che prima tenta di farla espatriare e poi di fronte al rifiuto delle guardie di frontiera (la Svizzera in quel momento non accetta profughi), la nasconde assieme ai suoi genitori nel frattempo giunti da Torino in una casa a Loreglia, in val Strona, sotto falsa identità69. Invece Emma lascia la provincia di Novara e riesce a tornare a Torino, sopravvi38 400 nomi. L’archivio sulla deportazione novarese: un progetto in corso vendo durante la guerra nascosta in una casa di riposo70. Il giorno 16 settembre sono arrestati a Stresa Tullio Massarani con la sorella Olga Massarani e Giuseppe Ottolenghi con la figlia Lina: restano nella caserma dei carabinieri fino al giorno 22 quando vengono uccisi71. Il 17 settembre a Pian Nava, nei pressi di Premeno sui monti sopra Verbania, sono arrestati e uccisi i coniugi Humbert Scialom e Berthe Bensussan. Rientra nel clima di quei giorni e quindi è da considerare pienamente inserito nella strage del lago Maggiore anche l’episodio di Novara. Il 19 settembre «il Sonderkommando Schlott dopo essersi sistemato nei locali della scuola Ugo Ferrandi richiese alla Questura di Novara l’elenco degli ebrei residenti. La maggior parte degli stessi, avvertiti tempestivamente da qualcuno della Questura, riuscì a mettersi in salvo. Solo il signor Giacomo Diena non volle mettersi al sicuro, sostenendo che, in quanto ufficiale e invalido della guerra 1914-1918, non gli avrebbero fatto niente»72. Giacomo Diena viene invece arrestato e portato via dalle SS assieme al suo anziano zio Amadio Iona73. Infine gli ultimi ebrei che vengono catturati ed uccisi in quel periodo, almeno per quanto ci è dato di sapere, sono i componenti della famiglia Ovazza, Ettore, la moglie Nella Sacerdote e i figli Elena e Riccardo, torinesi sfollati da settembre a Gressoney con l’obiettivo di espatriare il più presto possibile. Il primo a tentare di superare il confine svizzero è Riccardo che però viene arrestato l’8 ottobre a Domodossola e successivamente portato nella sede della seconda compagnia SS di stanza a Intra presso l’allora sede delle scuole elementari femminili74. I tedeschi estorcono al ragazzo informazioni utili per rintracciar gli altri componenti della famiglia che vengono immediatamente portati anch’essi a Intra dove tra il 9 e l’11 ottobre sono tutti uccisi e i loro corpi bruciati nella caldaia della scuola. La strage arriva per la prima volta nelle aule di un tribunale nel 1954 quando in Austria, a Graz, viene processato il tenente Gottfried Meier, accusato di essere il comandante della compagnia SS presente a Intra e responsabile dell’uccisione della famiglia Ovazza: viene assolto per insufficienza di prove e la responsabilità dei fatti attribuita a due suoi militari nel frattempo deceduti. L’anno successivo il Tribunale Militare di Torino riapre il caso e condanna Meier all’ergastolo, pena che però non sarà eseguita perché l’Austria non concede l’estradizione. Ci sarà da aspettare il 1963 quando un giudice tedesco, che indagava sulle operazioni in Italia del capitano della polizia di sicurezza delle SS (SI39 Giovanni Galli PO) Theodor Saewecke, comandante a Milano della Gestapo, si imbatte nelle vicende relative al lago Maggiore e dopo aver recuperato sufficienti testimonianze in Italia grazie alla magistratura italiana e al Centro di Documentazione Ebraica di Milano, può avviare il processo che si svolge a Osnabrück, tra il 1968 e il 1969, nei confronti dei militari superstiti e rintracciati. Gli imputati sono gli ufficiali Hans Röhwer del primo battaglione della Divisione meccanizzata Waffen SS Leibstandarte Adolf Hitler, che in quel momento aveva il comando del Battaglione, Hans Krüger, comandante della terza compagnia che si trovava a Stresa, Karl Schnelle, comandante della quinta compagnia a Baveno, e i sottufficiali Ludwig Leithe e Oscar Schultz che appartenevano alla quarta compagnia, sempre alloggiata a Baveno e responsabile dei fatti di Meina. Il tribunale condanna all’ergastolo Röhwer, Krüger e Schnelle, mentre gli altri due vengono condannati a pene minori, sostenendo la tesi che l’iniziativa della strage sia da attribuire agli ufficiali presenti nel Novarese e non a ordini superiori75. Nel processo d’appello, il 17 aprile del 1970, la Corte di Berlino annulla però la sentenza precedente e assolve gli imputati perché i reati sono caduti in prescrizione76. La sentenza di condanna parlava espressamente di responsabilità dei graduati presenti sul lago che agirono spinti da odio razziale e dal desiderio di impossessarsi delle ricchezze appartenenti alle persone assassinate. Per questo la strage viene considerata anomala77 rispetto alle direttive tedesche sul trattamento degli ebrei in Italia (preparate dalla caduta di Mussolini e impartite da Himmler il 12 settembre all’ambasciatore Rahn) che ne prevedevano la cattura e il trasporto nei lager del nord Europa, come in effetti avviene negli stessi giorni per gli ebrei di Borgo San Dalmazzo. Non emersero nel processo, né finora sono emerse, prove contrarie, tuttavia proprio la scarsa documentazione tedesca (scarsa perché i documenti relativi anche ad inchieste fatte dalle stesse autorità militari tedesche sono spariti78), impedisce di sapere con certezza se i comandanti superiori (Paul Hausser del secondo corpo d’armata delle Waffen SS presenti nel nord Italia, o Erwin Rommel comandante dell’Heeresgruppe B, o qualcun altro ancora più in alto nella scala gerarchica) fossero informati di quanto stava succedendo. Per questo Marco Nozza, che era un giornalista e non uno storico di professione, ma è anche l’autore del libro per ora più significativo sulla vicenda, ha ipotizzato responsabilità a livello non semplicemente locale79. «Nozza cercherà, con argomenti molto convincenti, di 40 400 nomi. L’archivio sulla deportazione novarese: un progetto in corso dimostrare che l’eccidio non fu compiuto da sottograduati annoiati, che male avevano interpretato gli ordini e ai quali era scappata un po’ la mano. La loro efferatezza non era ascrivibile alla semplice avidità. Per Nozza la strage fu compiuta in seguito a precisi ordini dei comandanti superiori, di tutti i comandi superiori che ne portano per intero la responsabilità. E lo dimostra il fatto che la strage non si risolse in poche ore, in un giorno, ma durò per più di un mese e si sviluppò su un territorio molto ampio […] e pure a Novara. Qui operava un altro battaglione, altri comandanti, ma il comportamento e i risultati furono gli stessi. Anche qui la prima cosa da fare era farsi consegnare le famigerate liste, poi depredare (in questo caso farsi aprire le cassette di sicurezza della Banca Popolare di Novara) e infine dare la caccia all’ebreo e farlo sparire»80. La deportazione politica. L’insurrezione di Villadossola Sono tanti i deportati politici «novaresi» e la scelta di raccontare la storia del gruppo di Villadossola dipende innanzitutto dal fatto che in questo paese c’è stata la prima insurrezione partigiana della provincia e sicuramente una delle prime ribellioni nell’intero nord Italia. E poi perché questo gruppo di deportati risulta omogeneo quanto alla provenienza (sono tutti ossolani) e, almeno durante i primi mesi, rispetto al percorso di prigionia in Germania le esperienze sono identiche e riguardano più tipologie di deportazione: si passa da situazioni di pura e semplice carcerazione, al lager «tradizionale», a condizioni di lavoro coatto. Immediatamente dopo l’8 settembre 1943 si formano i primi nuclei partigiani nell’alto Novarese e la zona dell’Ossola diventa uno dei principali luoghi di incontro e organizzazione per vecchi e nuovi antifascisti che già durante l’estate avevano cominciato a ricostruire i partiti. Proprio a Domodossola nascono i primi gruppi come la Banda della Libertà che comprende Luigi Boghi, Silvestro Curotti e altri, mentre a Premosello, più a sud lungo il Toce e a ridosso della val Grande si forma un altro nucleo partigiano attorno a Dionigi Superti che dirigeva un’azienda boschiva. Intanto a nord, a Pontemaglio di Crevoladossola, Mario Muneghina (che successivamente con Superti darà vita alla divisione Valdossola) giunto da Milano raggruppa altri giovani, mentre a Villadossola si raduna un folto gruppo di ragazzi ex militari e antifascisti attorno ai fratelli Ugo e Ottavio Scrittori, a Dante e Giovanni Zaretti, a Redimisto Fabbri. La loro princi41 Giovanni Galli pale attività durante le prime settimane di occupazione tedesca consiste nel reperimento di armi e nel controllo delle centrali idroelettriche della zona (c’è la convinzione che la guerra stia per finire e che i tedeschi tentino azioni di sabotaggio), ma soprattutto nell’aiuto fornito per raggiungere la Svizzera a fuggiaschi di ogni tipo, militari, renitenti alla leva, prigionieri di guerra alleati che erano riusciti a scappare, ebrei, antifascisti. A ottobre con l’arrivo di altre persone appartenenti ai Gap milanesi il gruppo di Villadossola si rafforza e alla fine di ottobre, per ragioni di sicurezza81, i partigiani si spostano sulle baite della Pianasca, poco sopra il paese, che diventano il loro luogo di rifugio e il loro deposito d’armi. Tra queste persone matura la convinzione che la guerra sia prossima alla fine e che occorra un grande gesto dimostrativo per coinvolgere l’intera popolazione e dar inizio all’insurrezione generale. Così, pur non essendoci ancora nessuna struttura organizzativa di coordinamento, all’alba dell’8 novembre 1943 poche decine di partigiani scendono a Villadossola per occuparla. «Gli obiettivi sono: reperimento di fondi per l’autofinanziamento del gruppo; arresto delle attività produttive; isolamento delle comunicazioni; occupazione delle caserme dei Carabinieri e della Finanza; azione punitiva contro i responsabili locali del fascio»82. In poco tempo vengono recuperate armi sia dai Carabinieri, sia dalla Guardia di Finanza, si bloccano le strutture economiche e amministrative del paese annunciando l’insurrezione generale e «c’è la convinzione che ci possano essere, a breve termine, aiuti anche da parte degli alleati»83. In realtà la situazione locale e internazionale è ben diversa e Villadossola viene subito attaccata a partire dal pomeriggio, ma gran parte della popolazione si unisce ai partigiani e gli insorti riescono a respingere l’attacco congiunto di tedeschi e italiani della neonata Rsi. Nel frattempo si muovono anche gli altri gruppi partigiani della zona: a Domodossola la Banda della Libertà recupera armi e alcuni partigiani scendono dai monti per aiutare gli insorti di Villadossola, mentre il gruppo di Muneghina si scontra con i tedeschi sulla strada per Crodo e Superti attacca il presidio di Premosello. Vista la situazione, nazisti e fascisti decidono per un’azione militare in grande stile: la mattina del 9 novembre arrivano tre aerei tedeschi Junker 88 e iniziano a bombardare il paese e in particolare Villa Lena dove si era rifugiato il comando partigiano. I bombardamenti provocano molti feriti e la morte di quattro civili, Mario Bosio, Annibale Dell’Orto, Ines e Olga Zanotti. Intanto procedendo lungo la statale da Domodossola e da Pallan42 400 nomi. L’archivio sulla deportazione novarese: un progetto in corso zeno, piccolo paese a sud di Villadossola, e con altri rinforzi provenienti da Novara su di un treno blindato, alcuni reparti fascisti e nazisti attaccano il paese che viene occupato prima di mezzogiorno: la gente fugge, i partigiani cercano rifugio e si ritirano in valle Antrona. In quello stesso giorno anche un’altra formazione partigiana locale, quella di Filippo Maria Beltrami, inizia la sua attività bellica scontrandosi con i fascisti a Gravellona Toce84. I tedeschi, ripreso il controllo della situazione, instaurano un clima di terrore e si mettono alla ricerca dei responsabili dell’insurrezione interrogando la popolazione e riuscendo a mettere le mani su alcune persone coinvolte nei fatti, ma arrestando anche altre del tutto estranee. «Dopo i primi arresti gli inquisitori trovano il muro di silenzio: moltissimi sanno ed hanno visto, ma pochi parlano o si limitano a segnalare i nomi già noti dei capi locali (Zaretti, Benini, Fabbri)»85. Tutti vengono interrogati nell’allora albergo Italia di Villadossola dove si trova il comando tedesco, compreso Redimisto Fabbri, ricoverato in ospedale per una ferita ricevuta durante gli scontri del primo giorno. Dopo un sommario processo sei partigiani (Andrea Comina, Italo Finotto, Giuseppe Preioni, Luigi Rossi, Albino Valdré e Redimisto Fabbri) sono condannati a morte e la sentenza viene eseguita a Pallanzeno l’11 novembre, su un prato vicino alla statale. La situazione non si normalizza nei giorni successivi anche se i tedeschi sembrano convincersi che i veri sobillatori siano stati elementi provenienti dall’esterno (i milanesi) e che quindi la popolazione locale abbia responsabilità limitate, «finché non entra in azione Gian Franco Balzani, un giovane cresciuto a Villa, ma residente con la famiglia in Domo, sorpreso a rubare al presidio tedesco di Masera. Per salvarsi dice di essere in grado di segnalare i nomi degli insorti di Villa»86. Così i tedeschi ottengono i nomi di altri ragazzi di Villadossola, di Domodossola e di Crodo che, dopo l’arresto e i primi interrogatori, sono portati nelle carceri di Novara87. Il processo si svolge l’8 dicembre e si conclude con alcune condanne a morte, per le persone riconosciute da testimoni come direttamente coinvolte nell’insurrezione, e con altre condanne alla deportazione in Germania per i sospettati. A partire dalla fine di dicembre vengono uccisi Novello Bianchi, Gian Franco Balzani (il delatore che non è riuscito a salvarsi), Ernesto Conti, Guido Falcaro, Osvaldo Giovannone, Giuseppe Giudici, Erminio Marini, Bruno Matli, Paolo Steffanino, Guido Vivarelli, Giuseppe Bianchetti88. Il 4 gennaio partono invece per Verona e poi per la Germania Luigi Arioli, Pilade Bartolozzi, Battista Bertaccini, Luigi Boghi, Idilio Brandini, 43 Giovanni Galli Remo Busca, Romualdo Casadei, Enea Rinaldi, Rino Zanelli. Nei giorni successivi verranno deportati anche Mario Martinelli, Francesco Scaciga Della Silva, Angelo e Pasquale Perotti. Il primo gruppo resta unito durante i primi mesi di deportazione: inizialmente vengono mandati tre mesi in una cella di rigore a Monaco, nel penitenziario di Stadelheim89, e poi dal 13 aprile 1944 a Bernau, un campo di lavoro vicino a Monaco «assieme ai prigionieri comuni e delinquenti tedeschi, che gli davano da mangiare bene per fargli reggere lo sforzo, e noi dovevamo seguire la loro capacità di lavoro. Quelli che non reggevano a ritmo di quei tedeschi, li mandavano a Dachau per “rimettersi”, e li guardavamo partire con invidia. Non pensavamo che fosse vero, non si sapeva allora che invece eliminavano quelli che non ce la facevano più a lavorare»90. Dopo alcuni mesi il gruppo viene diviso in vari sottocampi di Dachau e i deportati ossolani non sono più impiegati in attività agricole, ma utilizzati per la produzione industriale direttamente all’interno di aziende tedesche. Vengono tutti liberati all’arrivo degli statunitensi nel maggio del 1945 e nel corso dell’estate riescono a tornare in Italia. Il loro rientro nelle comunità di origine non è stato facile, come documentano molto bene Gisa Magenes e Filippo Colombara nel loro già citato saggio, ma per alcuni l’esperienza della deportazione ha avuto anche lunghi e grotteschi risvolti, da attribuirsi principalmente a problemi burocratici e a disguidi nell’invio della documentazione, perché non è stato immediatamente riconosciuto loro lo status di deportato e quindi non hanno avuto gli indennizzi per «cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste» previste dalla legislazione a partire dagli anni sessanta91. «Protagonisti del “caso” sono i domesi Luigi Boghi, 82 anni, e Remo Busca, deceduto circa tre anni fa. […] Alcuni giorni fa un plico proveniente dal Servizio Internazionale Ricerche di Arolsen (Germania) è arrivato in Comune. Nella busta c’era copia della richiesta di Boghi e il certificato intestato a Remo Busca. “Prima o poi – commenta Boghi ironicamente – arriverà anche il mio certificato”»92. La richiesta per il riconoscimento dello status di deportati era stato regolarmente inoltrato alla Croce rossa internazionale dal Comune di Domodossola il 24 aprile del 1964. La deportazione «civile». Gli 86 di Verbania «Tutti i giornali comparsi dopo la Liberazione hanno lodevolmente 44 400 nomi. L’archivio sulla deportazione novarese: un progetto in corso messo giustamente in luce opere, sacrifici e disagi sofferti dai partigiani. Nessuno ha mai accennato ai fatti che si svolsero a Intra il 15 giugno 1944, fatti che si conclusero con la deportazione in Germania di 86 Verbanesi. Non riuscirò mai a cancellare dalla mente il ricordo di quel mattino del 17 giugno, quando carichi di carne da macello, cinque camions tedeschi si muovevano dal piazzale delle scuole femminili, verso destinazione a tutti ignota»93. Le considerazioni amare dell’autore di queste frasi sono pienamente giustificate non solo in relazione all’immediato dopoguerra, ma soprattutto pensando al velo di oblio calato negli anni successivi sulla vicenda di questi ragazzi che arrivati alle Casermette di Borgo S. Paolo a Torino vengono subito etichettati come «gli 86 di Verbania». Solo in tempi più recenti, a partire dagli anni novanta, a volte casualmente, sono riaffiorati quei fatti durante alcune interviste e infine grazie alla stesura di due memorie (in un caso si tratta parzialmente di un inedito, un’edizione privata, o meglio autogestita, come scrive l’autore) scritte dai protagonisti di quegli eventi94. Probabilmente questa storia ne nasconde altre analoghe di cui forse si è persa totalmente memoria e si intreccia con altre deportazioni che avvengono negli stessi giorni sul lago Maggiore e che avranno gli stessi sviluppi95. Sono già state illustrate precedentemente le ragioni che spingono la Germania, in particolare durante la guerra, a intensificare l’uso di lavoro coatto per sostenere la propria economia e soprattutto lo sforzo bellico. Dall’autunno del 1943 gli italiani sono uno dei principali serbatoi di manodopera schiavile e le differenze riguardo ai motivi che hanno condotto alla detenzione forzata in Germania, in molti casi e in molte situazioni e in molti campi, finiscono per ridursi e appiattirsi nel lavoro forzato per l’economia tedesca. Per questo ai politici, ai militari, agli ebrei, abbiamo affiancato nell’archivio dati anche i nomi, e in certi casi le storie, dei cosiddetti «lavoratori civili» (intendendo persone che in quel momento non stavano attaccando o mettendo in discussione il potere tedesco o italiano della Rsi, come potevano fare i militari renitenti alla leva o i partigiani o anche gli operai che scioperavano per motivi politici) che vengono catturati in occasione di rastrellamenti operati per ritorsione contro la popolazione o apparentemente senza alcuna plausibile ragione militare, come nel caso dei verbanesi. Il 14 giugno 1944 è appena iniziato il rastrellamento in val Grande quando a Verbania appare un bando che impone il coprifuoco e ordina a 45 Giovanni Galli «tutti gli appartenenti alle classi dal 1914 al 1927» di presentarsi alle scuole elementari femminili, sede del comando tedesco, muniti di documenti. Due giorni dopo un altro bando avverte che dal giorno successivo tutti quelli appartenenti alle classi citate sprovvisti del «timbro del Comando Germanico vengono dichiarati come banditi e sono sottoposti alla pena di morte». Gianluigi Molinari, diciassette anni non ancora compiuti, frequenta il liceo classico dai padri Marianisti di Pallanza e il 15 giugno, avvertito dalla madre di un suo amico, anziché recarsi a scuola si dirige verso Intra: «alle 8 di quel mattino, al comando tedesco eravamo tre-quattrocento uomini ad attendere il famoso timbro lasciapassare; un interprete, dopo un po’, ci dice che i nati tra il 1914 ed il 1927, essendo in età di impegni di lavoro, erano attesi al primo piano per finire prima l’operazione della timbratura. Ci precipitiamo sulle scale. Appena la fiumana è finita, vengono messe le sentinelle e non possiamo più scendere»96. Anche Alberto Ziviani non ha ancora compiuto i diciassette anni nel giugno del 1944 e pure lui frequenta lo stesso liceo classico, ma è già entrato in contatto con i gruppi partigiani dislocati in val Grande, tra Rovegro e Ponte Casletto (si tratta degli uomini del Valdossola, la formazione di Dionigi Superti e Mario Muneghina), e per loro svolge alcuni compiti come staffetta. Ma qualche frase troppo dichiaratamente antifascista che si lascia sfuggire a scuola - un compagno di classe è figlio del console della milizia di Pallanza - provoca il suo arresto proprio il 15 giugno: «scuole elementari, trasformate dai tedeschi in campo di concentramento del quale le varie aule costituiscono le celle. Sono rinchiuso con altri giovani in una di esse»97. La situazione per Ziviani è chiaramente più difficile: accusato di essere un partigiano, è condannato a morte. Come gli altri ragazzi catturati viene mandato a Torino, ma quando è già di fronte al plotone di esecuzione arriva l’ordine di sospendere la pena: grazie agli interventi del padre e alla sua giovane età viene condannato alla deportazione e a questo punto la sua storia si intreccia di nuovo con quella degli altri di Verbania. Non tutti però. Molti dei ragazzi chiusi nelle scuole femminili riescono a fuggire98 e alla fine dopo due giorni di attesa vengono portati via «solo» 86 ragazzi. In camion percorrono tutto il lago fino a Novara e da lì arrivano a Torino, alle Casermette di Borgo San Paolo. Durante il breve periodo di detenzione a Torino, entrando in contatto con altri prigionieri soprattutto politici, alcuni di loro cominciano a maturare convincimenti antitedeschi e antifascisti99. Il 25 giugno assieme a molti altri giovani catturati in modo 46 400 nomi. L’archivio sulla deportazione novarese: un progetto in corso analogo, sono circa in quattrocento, partono dalla stazione di Torino, dove ad attenderli ci sono alcuni parenti fortunosamente avvertiti100, e si dirigono verso il Brennero. Dopo quattro giorni arrivano al lager di Chemnitz, a qualche chilometro da Dresda, e lì restano alcune settimane prima di essere nuovamente trasferiti, ai primi di luglio, in un altro lager più a sud, un sottocampo di Flossenbürg, Zwickau, definito Betriebslager Polbitz101. Il campo è formato da circa dieci baracche che contengono dalle cinque alle otto camerate. Una baracca isolata è per i prigionieri russi. Molinari e Ziviani finiscono nella camerata n. 5 in cui sono rinchiusi tutti ragazzi di sedici e diciassette anni: «Sveglia alle 5; una guardia entra, suona un fischietto e urla: “Aufstehen”, (alzarsi); si va al lavatoio e si ritira una caraffa di caffè. La razione del pane viene distribuita a fettine, giornalmente (circa 3,5 chilogrammi a settimana). Alle 5,30 ci incolonnano e, con la scorta armata, si va in fabbrica attraversando una zona della città»102. Lavorano in un’azienda automobilistica, la Werk Audi che appartiene al gruppo Auto Union, e tutti quanti loro studenti vengono mandati sulle catene di montaggio nei diversi reparti adibiti alla produzione di camionette militari. Sono controllati da personale civile tedesco e lavorano anche con altri tedeschi. Sono lavoratori coatti e quindi godono di molte più libertà rispetto ad esempio ai deportati politici e alle condizioni di vita presenti in altri campi103; durante l’inverno ricevono i pacchi della Croce rossa internazionale e possono scrivere a casa per ottenere cibo e vestiti: si trovano in una condizione per molti aspetti simile a quella degli internati militari. Molinari racconta anche della possibilità di andare a Messa nella chiesa del paese (alcune domeniche non lavoravano in fabbrica) e di un incontro domenicale in barca con una compagna tedesca di reparto. Ma resta come elemento comune in tutti i racconti la grande fame sofferta e il desiderio, realizzato in modi diversi e con attenzione, di opporsi a quella condizione di reclusi. Da Zwickau alcuni di loro non torneranno più, altri lo faranno quando il campo verrà liberato, Molinari e Ziviani, assieme a Franco Mondolfo104, organizzano invece una fuga preparandola scrupolosamente già dall’autunno del 1944. «Ore 20 di giovedì primo marzo 1945. baracca del lager fiocamente rischiarata e vagamente fumosa: intercalare concitato di 20 esseri debilitati, sfiduciati, sconfitti nel fisico e nella volontà. “Fra mezz’ora fuggiremo dal lager!”, hanno appena confidato ai componenti della camerata i tre più giovani e subito è generale fermento»105. La fuga inizialmente riesce 47 Giovanni Galli ma arrivati a Innsbruck dopo pochi giorni e viaggiando per lo più in treno non riescono assolutamente a passare il confine a causa dei rigidissimi controlli. A Innsbruck incontrano militari italiani prigionieri, ormai nella condizione di «liberi lavoratori»106, che li aiutano a trovare una sistemazione e un lavoro in Tirolo per gli ultimi due mesi di guerra. Sono utilizzati come muratori in un campo a Zell am Ziller107 dove trovano altri italiani catturati come loro e portati nei territori tedeschi come lavoratori coatti108. Lì resteranno fino all’arrivo degli statunitensi che li aiuteranno a tornare in Italia. Sono tutti e tre di nuovo a Verbania il 7 maggio 1945. Riflessioni conclusive e provvisorie. Qualche dato statistico Il titolo dato a questo scritto («una ricerca in corso») impone necessariamente di considerare come assolutamente provvisorie le analisi fatte sul complesso dei dati emersi riguardo alla deportazione nel Novarese. È necessario un serio confronto con i risultati della ricerca nazionale, è necessario terminare il lavoro di spoglio dei nominativi ancora in corso presso l’archivio di Stato di Novara e, almeno per un maggior chiarezza sulle diverse tipologie di deportazione presenti sul territorio, è necessario ridurre sensibilmente il numero di coloro che ancora non siamo riusciti ad identificare come civili, politici o altro, per insufficienza di informazioni. In ogni caso considerando il centinaio di nomi accertati una decina di anni fa, ora sicuramente possiamo dire che il fenomeno ebbe un’ampiezza ben maggiore di quanto forse si pensasse (o si temesse). Inoltre ci sono tanti nuovi nominativi che dovrebbero aggiungersi e che riguardano per lo più lavoratori civili/coatti. Risultano nei documenti inviati dai carabinieri dei paesi della Provincia in risposta alle richieste che la Prefettura fece nell’immediato dopoguerra per avere notizie su deportati o lavoratori volontari rientrati in patria. Nella maggior parte dei casi sono informazioni molto scarne e da valutare con attenzione anche perché i termini usati per definire queste persone variano molto a seconda di chi redige il documento e scontano l’approssimativa conoscenza che in quei momenti si aveva del fenomeno concentrazionario: a volte si parla di prigionieri internati in Germania per riferirsi ai civili rastrellati come anche ai politici; quasi mai è indicato il campo di detenzione, ma solo la Germania come generica destinazione, e spesso manca la data di arresto. Tuttavia da un’analisi ancora superficiale sono dati che confermerebbero più che altro l’estensione del 48 400 nomi. L’archivio sulla deportazione novarese: un progetto in corso fenomeno relativo alla deportazione di lavoratori coatti. Per cui pur non includendo nell’elenco dei deportati gli oltre cinquanta ebrei della strage del lago Maggiore (perché uccisi sul posto) e pochi altri effettivamente «fuori provincia» anche se in qualche modo collegati ai deportati novaresi, considerando questi possibili nuovi nominativi non dovremmo in ogni caso discostarci molto dalla cifra attuale di 384 persone, che al contrario è probabilmente destinata più ad aumentare che a ridimensionarsi. Come già è stato detto risulta abbastanza scontata, sulla base dei dati attuali, la forte presenza (circa il cinquanta per cento) di deportati nei KL per motivi politici. All’interno di questa categoria ci sono altri elementi da considerare nella norma, infatti oltre il 42 per cento dei politici è costituito da ragazzi (la percentuale delle donne che è possibile classificare in questo ambito è veramente molto bassa, nemmeno il 2 per cento) nati tra il 1921 e il 1925, vale a dire che nel 1944, anno in cui principalmente si manifesta il fenomeno della deportazione, questi avevano tra i diciannove e i ventitre anni. Sono quelli maggiormente coinvolti dai bandi di reclutamento militare della Rsi109 (la chiamata alle armi serve moltissimo per ingrossare le formazioni partigiane), ma sono anche la gioventù che incomincia a riflettere sulla propria condizione e a prendere coscienza della situazione politica italiana e internazionale. Un po’ meno scontata forse la relativamente bassa presenza di giovanissimi, quelli nati dopo il 1926, che risultano in numero inferiore sia rispetto ai nati tra il 1911 e il 1920, sia rispetto ai nati nei primi dieci anni del Novecento. I politici novaresi sembrano poi destinati soprattutto al lager di Mauthausen, anche se la stragrande maggioranza delle segnalazioni sui documenti consultati riporta la generica indicazione di «deportato in Germania». Naturalmente va precisato che non per tutti i deportati siamo in possesso di indicazioni precise ed esplicite, per cui le considerazioni e i dati percentuali settoriali e specifici si basano solo sulle schede dalle quali è possibile individuare con esattezza la tipologia di deportazione, la data di nascita e il luogo della deportazione (in questo caso è stato considerato il primo campo di arrivo). Non ci sono novità, solo conferme di elementi già noti, nei dati riguardanti i settanta ebrei schedati (in cui, ricordiamo ancora, sono compresi i cinquantasei della strage del lago Maggiore). Però vale sempre la pena soffermarsi a riflettere sulle caratteristiche particolari e anomale, rispetto 49 Giovanni Galli alle altre tipologie di deportazione, che ha avuto quella per motivi razziali: il cinquanta per cento è costituito da donne e poco più del cinquanta per cento degli ebrei deportati è nato prima del Novecento. Non basta, solo all’interno di questo gruppo troviamo gli unici deportati nati dopo il 1930: adolescenti, adulti, nonni e nonne, famiglie intere insomma. È questo il dato che fa più riflettere e che caratterizza la deportazione ebraica: solo in questo caso troviamo bambini e un così grande numero di donne. Loro sul totale dei deportati novaresi sono solo l’11 per cento, un numero tutto sommato esiguo, ma di queste ben l’81 per cento è costituito da ebree. Considerando le altre categorie di deportati è tra i civili che troviamo più donne, dato abbastanza prevedibile, ma in questo caso non costituiscono più del 16 per cento del totale complessivo. Anche analizzando i dati generali, a prescindere dalle diverse tipologie di deportazione, non ci sono grosse sorprese. I due campi di concentramento (KL) verso cui maggiormente vengono mandati i deportati novaresi sono Mauthausen e Dachau (con i loro vari sottocampi) e prendendo in considerazione le fasce d’età, ancora risultano in maggior numero i nati tra il 1921 e il 1925. Sempre ragionando sui dati complessivi il numero dei decessi, pur restando alto, è inferiore a quello ottenuto sul primo campione dei cento deportati (cfr. le ricerche di Gisa Magenes già citate) che però non prendeva in considerazione la categoria dei lavoratori coatti. Le persone che non tornano dai campi risultano ora circa il 45 per cento del totale (nel quale sono inclusi anche gli ebrei della strage) e in particolare se si considera la categoria dei politici, al momento accertati, i morti sono attorno al 30 per cento contro un 70 per cento di prigionieri che invece riesce a tornare. Naturalmente se una parte delle persone non ancora identificate fosse da includere nella deportazione politica è probabile che il rapporto cambierebbe e aumenterebbero i decessi. Al di là delle cifre l’importante di ricerche come questa è comunque far riemergere nomi e ricostruire storie che altrimenti a distanza omai di troppo tempo rischierebbero di scomparire per sempre. Ma forse è ancor più importante ridar voce alle parole di queste persone e riprendere magari qualche loro sogno che si è perso con gli anni: «perché in campo il pensiero fisso era che chi riusciva a sopravvivere vedeva la libertà, che le guerre erano finite. Ecco noi si vedeva un mondo più giusto… si diceva sempre: “noi abbiamo sofferto, ma chi resta non avrà più l’assillo delle guerre”; questo era proprio il pensiero fisso»110. 50 400 nomi. L’archivio sulla deportazione novarese: un progetto in corso Note al testo 1 Intervista di Federico Cereja a Ferruccio Maruffi in Primo Levi. Il presente del passato, Franco Angeli, Milano 1991. 2 La deportazione nei campi di sterminio nazisti, a cura di Federico Cereja e Brunello Mantelli, Franco Angeli, Milano 1985. 3 Rino Zanelli nasce a Villadossola nel 1920 e durante la guerra è militare di leva. L’8 settembre 1943 si trova a Livorno e da lì torna a casa mettendosi in contatto con i primi gruppi partigiani locali. Partecipa all’insurrezione di Villadossola nel novembre dello stesso anno e in seguito a questo fatto viene arrestato e processato a Novara. Inizialmente condannato a morte, la sua pena viene poi trasformata nella deportazione in alcuni sottocampi di Dachau, dove resta fino alla fine della guerra. 4 La deportazione nei campi di sterminio nazisti, a cura di Federico Cereja e Brunello Mantelli, cit. 5 Le interviste sono ora conservate nell’Archivio sonoro dell’Istituto P. Fornara di Novara (a cura di Piero Beldì) e precisamente: Cd 121-1 e 122-1 intervista di Mauro Begozzi e Adolfo Mignemi a Otello Vecchio; Cd 123-1 intervista di Mauro Begozzi a Enrico Piccaluga; Cd 124-1 e 125-1 intervista di Mauro Begozzi, Gisa Magenes e Filippo Colombara a Otello Vecchio; Cd 126-1 intervista di Gisa Magenes e Filippo Colombara a Francesco Albertini. La rivista dell’Istituto «Ieri Novara Oggi» ha poi pubblicato sul n. 5 del 1981, con un’introduzione di Mauro Begozzi, lo scritto di Enrico Piccaluga e Otello Vecchio, IT 113447, IT 113586: diario da un lager. Otello Vecchio è un operaio novarese membro del comando generale del CVL a Milano, dove viene arrestato nel settembre del 1944 e deportato a Dachau. Enrico Piccaluga, milanese, entra in contatto con le formazioni partigiane in Valcuvia dove la famiglia è sfollata. Viene arrestato a Milano dai tedeschi nel luglio del 1944 e deportato a Dachau. Francesco Albertini aderisce al partito comunista dal 1929 e per la sua attività politica viene più volte arrestato negli anni successivi. Dopo l’8 settembre 1943 organizza nuclei partigiani e per questo è di nuovo arrestato nel dicembre e deportato a Mauthausen e poi a Gusen. Nel dopoguerra svolge attività politica nelle file del Psi diventando parlamentare per più legislature. 6 «I nominativi delle persone deportate nei KZ ed individuate per la ricerca sono desunti dalla Gazzetta ufficiale del 22 maggio 1968 avente come oggetto Elenchi nominativi delle domande accolte per gli indennizzi a cittadini italiani colpite da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui alla legge 6 febbraio 1963 n. 404. Non sono presenti ovviamente i nomi di coloro che morirono nei campi di sterminio, i cui parenti non inoltrarono domanda, e dei sopravvissuti che, per disinformazione o per scelta, si astennero dal produrre la documentazione necessaria per il riconoscimento» (Gisa Magenes, in «Resistenza Unita», Novara, dicembre 1985). 7 «I nominativi presenti si riferiscono solo ai deportati nei campi di sterminio nazisti (KZ), ne sono esclusi gli internati militari nei lager di prigionia e i cosiddetti «liberi lavoratori». Tale scelta non implica nessun giudizio di valore e non vuole neppure stabilire delle gerarchie di valore, l’obiettivo è quello di delineare nelle loro diversità i percorsi e i confini di questa peculiare esperienza» (Gisa Magenes, in «Fogli sensibili», Verbania, n. 3, ottobre/dicembre 1994). 8 L’Archivio sulla deportazione, oltre alle schede generali riguardanti i deportati della Provincia di cui si parla in questo scritto, contiene il Fondo Ferruccio Maruffi, con le schede nominative e altro materiale originale o in fotocopia (da lui utilizzato per la pubblicazione del libro Fermo posta Paradiso, Stamperia Ramolfo ed., 2002) e il Fondo Francesco Albertini – Aldo Toscano, che contiene i documenti di Albertini sulla deportazione politica e i materiali utilizzati da Toscano per la sua ricerca sulla strage degli ebrei sul lago Maggiore (vedi oltre). 9 In seguito alla morte di Albertini nel 1996, Ferruccio Maruffi e Mauro Begozzi decidono di 51 Giovanni Galli curare e pubblicare il suo memoriale del lager: Francesco Albertini, Un resistente nel lager. Mauthausen matr. N. 53347, Euredit, Torino, 1998.In occasione del Giorno della Memoria del 2002 l’Istituto pubblica il video Ricordo Primo Levi (a cura di Mauro Begozzi, Marco Fontana e Giovanni Galli), interviste ad Alberto Cavaglion, Ferruccio Maruffi, Silvio Ortona, Giovanni Tesio e Bruno Vasari. 10 L’Istituto si è naturalmente occupato in più occasioni degli internati militari, sulle pagine dei suoi giornali, con pubblicazioni, all’interno di convegni. Molti articoli sono apparsi su «Resistenza Unita» (si ricorda in particolare lo scritto di Piero Fornara dedicato al medico suo collaboratore Felice Bonfantini, militare in Grecia, catturato dai tedeschi dopo l’8 settembre 1943 e morto nel 1944 nello Stammlager di Dortmund). Mentre su «Ieri Novara Ogg»i, n. 2 del 1994, l’allora direttore dell’Istituto Rosario Muratore raccontava le sue esperienze di internato (Resistenza e sopravvivenza: letture in un campo di concentramento in Germania). Si segnala anche il contributo dato alla tesi di laurea di Marino Adorno, Prigionieri reduci della seconda guerra mondiale attraverso un giornale partigiano: La Stella Alpina, Università degli studi di Milano, Facoltà di scienze politiche, a.s 1988/89 (una copia è depositata in Istituto). Tra le pubblicazioni più recenti ci sono gli scritti dell’internato bresciano Natale Carè (Natale Carè, Diario 8 settembre 1943 – 8 settembre 1945, a cura di Anna Borrini, 1999) e il lavoro svolto da alcuni allievi del locale Liceo classico sulle lettere di un militare novarese (La divisa del tenente Volpe. I ricordi di Giuseppe Volpe dalla Somalia a Corfù ai campi di internamento tedeschi, a cura di Francesca Ferri, Laura Lampugnani, Giovanni Galli, Interlinea, Novara 2004). 11 Sulla vicenda legata agli scioperi del marzo 1944 e alla deportazione di operai attivi sindacalmente, si veda in particolare: I deportati pavesi nei lager nazisti, Pavia, 1981; Guido Guderzo, L’altra guerra, Il Mulino, Bologna 2002; Marco Savino, Maria Antonietta Arrigoni, Dizionario biografico della deportazione pavese, Unicopli, Milano 2005. 12 In particolare la sez. 24, bb. I-V, Fondo Valdossola che raccoglie i documenti dei partigiani della formazione di Dionigi Superti e Mario Muneghina, molti dei quali in seguito al rastrellamento in val Grande nel giugno 1944 vengono catturati e risultano deportati in Germania. 13 È il caso di Secondo Jorda di Cravegna, un paese a nord di Domodossola, in valle Antigorio, ora provincia del Vco. Militare congedato nel 1943, torna al paese e aiuta chi ne ha bisogno ad espatriare in Svizzera. Nell’aprile del 1944 gli capita di guidare alcune persone tra cui Mike Bongiorno, ma per una delazione viene arrestato assieme a quelli che tentavano di espatriare e portato nel carcere di S. Vittore. Mike Bongiorno verrà poi scambiato con altri prigionieri ed espatriato negli Usa, mentre Jorda finisce a Bolzano dove lavora alla costruzione delle baracche del campo dove resta fino ad aprile del 1945. Nei suoi ricordi (cfr. Paolo Bologna, Il prezzo di una capra marcia, ed Libreria Giovannacci, 1969) segnala la presenza a Bolzano di Ettore Leonardi di Montecrestese, altro paese nei pressi di Domodossola, che aiuta a fuggire alla fine di dicembre del 1944 e Giovanni Sbanchi, appartenente al suo stesso gruppo di carpentieri, mandato a Mauthausen perché volutamente non si applicava a dovere nel suo lavoro. 14 Giovanni Pelganta di Trontano (Domodossola), viene arrestato dai tedeschi a un posto di blocco il 12 giugno del 1944 mentre sta andando al lavoro assieme ad Augusto Conti e a Luigi Jossi. I tre finiranno nel campo di lavoro di Zwickau a lavorare per la Auto Union. Durante un bombardamento alleato nell’ottobre dello stesso anno, Conti e Jossi vengono uccisi e solo il racconto del supersite Pelganta ha permesso di avere informazioni sui due. 15 Tema questo già sviluppato da Filippo Colombara, Alberto Lovatto e Gisa Magenes per quanto riguarda i paesi di Netro (ora in provincia di Biella) e di Villadossola (ora in provincia di Verbania). Molti elementi comuni emergono dalla loro ricerca: il deportato che non viene creduto per l’assurdità dei suoi racconti, che non viene capito perché ai concittadini sono molto più familiari i racconti dei prigionieri di guerra o degli stessi internati militari, che alla fine preferisce 52 400 nomi. L’archivio sulla deportazione novarese: un progetto in corso dimenticare e non parlarne più. (cfr. il loro saggio Memoria dei deportati e comunità. I casi di Netro e Villadossola, contenuto nel già citato La deportazione nei campi di sterminio nazisti) 16 «I campi di concentramento che non avrebbero dovuto accogliere prigionieri di guerra, che avrebbero dovuto essere destinati ai campi di prigionia sotto sorveglianza della Wehrmacht, nel collasso delle strutture accolsero anche prigionieri di guerra; ebrei sopravvissuti ai campi di sterminio, dopo l’ordine impartito da Himmler di cessare la loro uccisione di massa, finirono nei campi di concentramento tradizionali, a Mauthausen piuttosto che a Dachau o altrove; ma già in precedenza le esigenze dello sfruttamento della manodopera catturata aveva fatto saltare ogni barriera formale inviando i prigionieri, al di là di ogni distinzione di categoria, dove fosse necessario il fabbisogno di forza-lavoro» (Enzo Collotti, Il sistema concentrazionario nella Germania nazista, in I campi di sterminio nazisti, a cura di Giovanna D’Amico e Brunello Mantelli, Franco Angeli, Milano 2003) 17 Cfr. Li mandavano a Dachau per rimettersi intervista a Luigi Boghi, in Paolo Bologna, Il prezzo di una capra marcia cit. 18 Ibidem. 19 Ibidem 20 Carletto Leonardi prima socialista e poi dal 1921 comunista diventa dirigente della federazione novarese. Nel settembre del 1943 ad Arona organizza il Cln provinciale e collabora attivamente alla formazione dei primi gruppi partigiani della zona. Viene arrestato ad aprile del 1944 e deportato a Fossoli, poi a Mauthausen e a Gusen II. Muore nel lager il 19 gennaio 1945. Montano Lampugnani del Cln di Novara, ispettore delle organizzazioni partigiane della provincia viene arrestato da un agente dell’OVRA il 13 febbraio 1944. Processato dal Tribunale Speciale resta in carcere fino a giugno, per poi finire a Fossoli e a Mauthausen. 21 Enzo Collotti, Il sistema concentrazionario nella Germania nazista cit. Ma cfr. anche: «L’apparato SS pensò allora di servirsi dei deportati come lavoratori coatti, per motivi economici ma anche per rafforzare la propria posizione di potere all’interno del Terzo Reich; pertanto vennero fondate aziende che facevano capo direttamente alla milizia nera, e dal 1937 si cercò di fare in modo che nelle vicinanze dei KL aperti di volta in volta ci fossero cave di pietra o fornaci in cui impiegare i detenuti» (Brunello Mantelli, Il lavoro forzato nel sistema concentrazionario nazionalsocialista, in I campi di sterminio nazisti cit.) 22 Cfr. La circolare Pohl, Consiglio regionale del Piemonte, Aned, F. Angeli, Milano 1991. 23 Enzo Collotti, Il sistema concentrazionario nella Germania nazista cit. 24 «L’apparato SS stipulò veri e propri contratti con il Ministero delle Armi e Munizioni, e con imprese pubbliche e private per l’affitto di manodopera coatta. Inoltre il WVHA ordinò la costruzione di numerosi sottocampi nei pressi dei distretti industriali interessati. Una volta definite con precisione le reciproche sfere di potere e competenza, come è noto l’industria privata non perse tempo a servirsi della nuova opportunità di disporre di manodopera» (Brunello Mantelli, Il lavoro forzato nel sistema concentrazionario nazionalsocialista cit.). 25 «L’uscita dell’Italia dalla guerra ebbe certamente almeno un aspetto positivo agli occhi della dirigenza nazista: la possibilità di attingere ad un notevole serbatoio di manodopera, rappresentato in primo luogo dai militari italiani e in secondo luogo dai civili residenti in Italia, proprio in un momento in cui la Germania aveva un notevole bisogno di braccia» (Luigi Cajani, Gli internati militari italiani nell’economia di guerra nazista, in Fra sterminio e sfruttamento, a cura di Nicola Labanca, Casa editrice Le lettere, Firenze 1992). 26 «Il capo del comando supremo della Wehrmacht (OKW), Keitel, diede già dal 17 settembre 1943 l’ordine con cui i comandanti supremi tedeschi in Italia, Kesserling e Rommel, veniva- 53 Giovanni Galli no rigorosamente esortati alla caccia di manodopera. Per la realizzazione di tali disposizioni Keitel “lasciava libertà di usare tutti i provvedimenti opportuni”» (Lutz Klinkhammer, Reclutamento forzato di lavoratori e deportazione di ebrei dall’Italia in Germania 1943-1945, in L’emigrazione tra Italia e Germania, a cura di Jens Petersen, Piero Lacaita Editore, ManduriaRoma-Bari 1993) 27 Cfr. Lutz Klinkhammer, Reclutamento forzato di lavoratori e deportazione di ebrei dall’Italia in Germania 1943-1945 cit. 28 «Il 12 dicembre 1943 Mussolini istituisce un Commissariato nazionale del lavoro, sottoposto alle sue dirette dipendenze, le cui competenze sono ricalcate, grosso modo, su quelle attribuite in Germania al GBA. A capo del Commissariato è posto Ernesto Marchiandi che, il 23 dicembre successivo, emana un bando che rende obbligatorio il servizio del lavoro. Il 9 marzo 1944 Marchiandi dispone, con un’importante circolare, il prolungamento dell’orario di lavoro nelle aziende che lavoravano meno di 45 ore settimanali e contestualmente ordina l’invio in Germania della manodopera maschile resa in tal modo eccedente» (Brunello Mantelli, L’arruolamento di civili italiani come manodopera per il Terzo Reich dopo l’8 settembre 1943, in Fra sterminio e sfruttamento cit.). 29 «I diversi uffici tedeschi si accordarono, a fine marzo del 1944, di richiamare le classi di leva dal 1900 al 1920 e di “mandarle in licenza” all’Arbeitsdienst nel Reich, i renitenti venivano minacciati con la pena di morte. […] Kretzschmann [rappresentante di Sauckel in Italia] calcolò che sarebbe dovuto essere trasportato il 42 per cento dei complessivi 3 milioni e seicentomila richiamati (ognuna delle 20 classi di leva comprendeva circa 180.000 uomini), per raggiungere la prefissata quota di 1 milione e cinquecentomila. Questo calcolo non fu realizzabile a causa della resistenza della popolazione, dell’ostruzionismo o della mancanza di autorità delle istituzioni italiane e per l’opposizione dei restanti uffici tedeschi» (Lutz Klinkhammer, Reclutamento forzato di lavoratori e deportazione di ebrei dall’Italia in Germania 1943-1945 cit.). 30 Giuseppe Mayda, Storia della deportazione dall’Italia 1943-1945, Bollati-Boringhieri, Torino 2002. 31 Cfr. Paolo Bologna, Pagine trontanesi della Resistenza, in «Eco-Risveglio Ossolano», n. 45 del 29 novembre 1984. 32 Nel libro di Giuseppe Mayda, Storia della deportazione dall’Italia 1943-1945 cit., sono ricordati i 1.448 deportati di Genova dopo gli scioperi del giugno 1944 nelle fabbriche: pare che in questo caso ci fossero esplicite richieste di un’azienda tedesca bisognosa di operai e delle aziende gestite dalla SS a Mauthausen altrettanto carenti di manodopera. Nello stesso periodo e con gli stessi obiettivi vengono rastrellati in val di Susa un migliaio di maschi abili al lavoro tra i 15 e i 60 anni (villeggianti compresi) e il 2 luglio 1944 a S. Siro, al termine della partita Milan-Juventus, le SS e i soldati italiani alle loro dipendenze lasciano uscire solo donne e bambini. A tutti i maschi controllano i documenti e trattengono trecento persone tra i 18 e i 28 anni che vengono caricate su autocarri e spariscono. Sull’episodio di Genova cfr. anche Brunello Mantelli, L’arruolamento di civili italiani come manodopera per il Terzo Reich dopo l’8 settembre 1943 cit. 33 «Il capo dello stato maggiore della OKW, il generale Warlimont, propose [durante un incontro tenuto l’11 luglio1944 e voluto da Sauckel per decidere i mezzi da usare nel reperire manodopera dall’Italia] di far catturare dalla Wehrmacht, in modo rigoroso, la popolazione per l’impiego in Germania: non solo nei luoghi dove si trovavano i partigiani, ma anche nelle grandi città, che dovevano essere evacuate per la mancanza di viveri, e anche nelle regioni del fronte, in cui si trovava un notevole numero di rifugiati, che dovevano essere, in particolar modo, catturati. […] Il Ministro dell’economia Funk e il suo segretario di stato Landfried, capo dell’amministrazione militare in Italia, così come il ministro per gli armamenti Speer si dimostrarono però 54 400 nomi. L’archivio sulla deportazione novarese: un progetto in corso contrari alle razzie che avrebbero portato «a notevoli disturbi nella produzione» e fatto scappare in massa la popolazione sulle montagne. Il risultato dell’incontro fu la rinuncia di Sauckel all’arruolamento forzato. Sauckel accettò di tornare ad usare il sistema del volontariato che si dimostrò, però, come prima infruttuoso» (Lutz Klinkhammer, Reclutamento forzato di lavoratori e deportazione di ebrei dall’Italia in Germania 1943-1945 cit.). 34 «Nella misura in cui il reclutamento di manodopera italiana per la Germania tende a far un uso sempre maggiore di tecniche coattive, si sfumano le distinzioni fra azioni repressive condotte dalle forze armate del Reich per svuotare potenziali bacini di alimentazione delle formazioni partigiane e rastrellamenti tesi a recuperare giovani sottrattisi alla precettazione per il lavoro obbligatorio» (Brunello Mantelli, L’arruolamento di civili italiani come manodopera per il Terzo Reich dopo l’8 settembre 1943, cit.). 35 Nella primavera del 1937 i tedeschi contattano l’ambasciata italiana a Berlino chiedendo lavoratori italiani per il settore agricolo. La carenza di manodopera in Germania e le decine di migliaia di disoccupati in Italia favoriscono gli accordi per avviare l’emigrazione controllata e programmata di lavoratori italiani verso la Germania che inizia nel 1938: ai contadini seguono già dal 1939 anche i lavoratori dell’industria. Gli eventi bellici accrescono la richiesta tedesca soprattutto nei settori industriali e l’Italia, in cambio di rifornimenti bellici ed energetici, garantisce quote di lavoratori prelevandoli anche tra gli operai occupati nelle aziende. Le richieste di rimpatrio dei lavoratori italiani, avviate nel 1943 in seguito allo squilibrio tra le rimesse degli emigranti trattenute in Germania e le forniture di carbone per l’Italia, sono inizialmente accettate da Hitler, ma a luglio la caduta di Mussolini blocca ogni accordo e l’armistizio di settembre non solo permette alla Germina di trattenere a forza i circa 100.000 italiani ancora presenti, ma di accrescere di parecchio la manodopera di origine italiana inizialmente con i militari catturati e poi con i deportati politici e i lavoratori coatti. Cfr. Luca Cajani e Brunello Mantelli, Lavorare in Germania: gli italiani dall’“Asse” al Mercato Comune Europeo, in L’emigrazione tra Italia e Germania cit.; Brunello Mantelli, «Camerati del lavoro». I lavoratori italiani emigrati nel Terzo Reich nel periodo dell’Asse 1938-1943, La Nuova Italia, Firenze 1992. 36 «I soldi erano quei pochi che la fabbrica ci dava mensilmente e che servivano a dimostrare ai tedeschi al governo italiano e alla Croce Rossa Internazionale che noi eravamo comuni lavoratori. […] Senza bollini annonari si acquistava solo birra e crauti, che venduti alla mensa in fabbrica, erano immangiabili anche per noi affamati; amari ed acidi, macerati dall’aceto. […] La birra invece era buona ma non si vendeva in mensa. Potevamo andarla a bere nella birreria in Moseler Strasse di fronte al cancello del lager» (Gianluigi Molinari, Da Intra a Zwickau, andata e ritorno, Guardamagna editori in Varzi, 2001) 37 Si ricordano ad Arona le famiglie Benelli, Veneziani, Jarach, Sabatino Lopez, tra quelle che riescono a sfuggire alla cattura, ma probabilmente anche altri si salvarono. A Novara riesce a scappare anche la professoressa Benvenuta Treves insegnante di materie letterarie all’Istituto tecnico Mossotti di Novara, già allontanata dall’insegnamento per motivi razziali nel 1938 assieme ad altri tre colleghi. Quando il 17 settembre 1943 il reparto rimasto in città, appartenente alla prima divisione meccanizzata Waffen SS Leibstandarte Adolf Hitler, che sui laghi stava facendo razzie di ebrei, inizia il rastrellamento in città, Benvenuta Treves assieme ad altre persone prontamente avvertite riesce a sottrarsi alla cattura. 38 Cfr. Gianni Clemente, Rosa Gallucci, Maddalena Gatto, Maria Rosa La Casella, Tiziana Minazzi, Roberta Picchetti, Ebrei verso la Svizzera, in «Ieri Novara Oggi» n. 4/5, Istituto storico Piero Fornara, 1996; Renata Broggini, La frontiera della speranza. Gli ebrei dall’Italia verso la Svizzera 1943-1945, Mondadori, Milano 1998. 39 Liliana Picciotto segnala come deceduti in luogo e data ignoti Abner Hasson, Ester Hass, Emanuele Staineri, Basilia Salambrassi, Letizia e Milena Rossi e Marcello Ravenna; sono morti 55 Giovanni Galli sicuramente ad Auschwitz Edith e Jean Pierre Hasson, Gino Ravenna, Amelia e Novella Melli (parenti dei Ravenna); risulta invece sopravvissuto e liberato Gilberto Hasson (cfr. Liliana Picciotto, Il libro della memoria, Mursia, Milano 2002). 40 «Questi italiani, definiti inizialmente prigionieri di guerra, vennero trasformati già il 26 settembre in internati militari italiani (IMI). Con questa forzatura giuridica le autorità tedesche ottenevano un doppio risultato: da un lato venivano incontro ad un desiderio delle autorità repubblichine, che volevano affermare – in primo luogo di fronte al governo rivale del Regno d’Italia – la loro sovranità su questi italiani, e pertanto ritenevano lo status di prigionieri di guerra incompatibile con il rapporto di alleanza ristabilito con la Germania; ma al tempo stesso realizzavano un importante vantaggio per se stesse proprio sul piano dell’impiego lavorativo, in quanto gli internati militari non facevano parte delle categorie protette dalla Convenzione di Ginevra del 1929, e quindi, essendo sottratti al controllo del Comité international de la Croix-Rouge, potevano essere impiegati liberamente nelle attività proibite dalla Convenzione, in particolare – appunto – nell’industria bellica» (Luigi Cajani, Gli internati militari italiani nell’economia di guerra nazista cit.). 41 Cfr. Gerhard Schreiber, I militari internati nei campi di concentramento del III Reich, Ufficio storico SME, Roma 1992; cfr. anche i lavori di Gerhard Schreiber, Gli internati militari italiani e tedeschi, Giorgio Rochat, La società dei lager, Brunello Mantelli, L’arruolamento di civili italiani come manodopera per il Terzo Reich dopo l’8 settembre 1943, tutti compresi nel volume Fra sterminio e sfruttamento, a cura di Nicola Labanca, cit. 42 Cfr. La vita offesa, a cura di Anna Bravo e Daniele Jalla, Franco Angeli, Milano 1986. 43 È significativa la storia di Cornelio De Taddeo, di Trobaso nel Verbano, che si trova a Torino come alpino di leva all’arrivo dei tedeschi. Tenta di fuggire, ma viene catturato e internato a Lückenwalde a metà settembre 1943. Un mese dopo viene spostato a Dora Mittelbau, dove vive e lavora nelle gallerie perché non ci sono ancora le baracche. Finirà poi a Bergen Belsen e verrà liberato il 15 aprile 1945. 44 «Il periodo che va dall’agosto al dicembre ’43 fu dedicato alla costruzione materiale del campo, cioè all’adattamento delle preesistenti gallerie, al loro ampliamento, all’installazione dei binari ferroviari necessari al movimento. […] Esso fu uno dei primi KZ ad accogliere italiani e nei suoi Arbeitskommandos scomparve ogni differenza fra deportati ed IMI» (Brunello Mantelli, «Untermenschen» e industria di guerra. Il lavoro nelle fabbriche dei lager, in La deportazione nei campi di sterminio nazisti, a cura di Federico Cereja e Brunello Mantelli, Franco Angeli, Milano 1985) 45 Marco Abruzzese si ferisce volontariamente a una mano per smettere di combattere (è militare di leva in Albania) e nel giugno del 1941 viene condannato a vent’anni di carcere a Gaeta. Dopo lo sbarco alleato è trasferito a Peschiera. Sorte simile anche per Gaudenzio Peroni che si trova in Istria quando viene arrestato per insubordinazione e diserzione. Nell’autunno del 1942 è nel carcere di Gaeta da dove poi verrà spostato nell’agosto del 1943 finendo a Peschiera. 46 Cfr. Marco Savino, Maria Antonietta Arrigoni, Dizionario biografico della deportazione pavese, Unicopli, Milano 2005. 47 Antonietta Babbini di Domodossola collabora con il Cln locale e aiuta militari e civili che vogliono espatriare. Viene arrestata nell’aprile del 1944 e dopo una breve permanenza nelle carceri torinesi, finisce a Bolzano. Domenica Diverio di Stresa viene mandata a Rawensbrück, dove muore nel dicembre del 1944. Renata Grossi di Mergozzo, vicina ai partigiani della divisione Valtoce finisce invece a Mauthausen. 48 Cfr. Marco Savino, Maria Antonietta Arrigoni, Dizionario biografico della deportazione pavese cit. 56 400 nomi. L’archivio sulla deportazione novarese: un progetto in corso 49 Marco Nozza, Hotel Meina, Mondadori, Milano 1995. 50 Brunello Mantelli, 8 settembre 1943: il disarmo delle truppe italiane nell’Italia nordoccidentale, in Mezzosecolo n. 8, Franco Angeli, Milano 1989. 51 Carlo Gentile, Settembre 1943. Documenti sull’attività della divisione «Leibstandarte-SSAdolf-Hitler» in Piemonte, in «Il presente e la storia», n. 47, rivista dell’Istituto storico della resistenza in Cuneo e provincia, giugno 1995. 52 «Il I./2 Panz. Gren. Rgt. messo in marcia il 13-9, ore 15,00, dopo l’avvicendamento a Verona, per raggiungere l’area del nuovo acquartieramento ad ovest del lago Maggiore ed eseguire un nuovo incarico (blocco del confine svizzero a nord e ad ovest del lago Maggiore)» (Stralcio della comunicazione giornaliera del 13 settembre 1943 inviata dalla Leibstandarte al comando del secondo corpo d’armata). «I./2 Panz. Gren. Rgt. ha iniziato il disarmo e la raccolta della preda bellica [nell’area] della sponda occidentale del lago Maggiore fino al confine svizzero» (Stralcio della comunicazione giornaliera del 15 settembre 1943 inviata dalla Leibstandarte al comando del secondo corpo d’armata). Entrambi i documenti sono riportati in Carlo Gentile, Settembre 1943. Documenti sull’attività della divisione «Leibstandarte-SS-Adolf-Hitler» in Piemonte cit. 53 Cfr. Aldo Toscano, L’olocausto del Lago Maggiore (settembre - ottobre 1943), Alberti, Verbania 1993. 54 «Alcuni degli ebrei italiani del Verbano, avvisati che i tedeschi stavano per giungere alle loro residenze, non fuggirono ma li attesero, fiduciosi nel loro passaporto italiano. Altri, informati che i tedeschi li aspettavano a casa, vi andarono per chiarire che loro erano italiani» (Roberto Morozzo della Rocca, Introduzione a La strage dimenticata. Meina, settembre 1943. Il primo eccidio di ebrei in Italia, Interlinea, Novara 2003). 55 «Le SS sapevano bene dove, a Stresa, a Baveno, ad Arona, a Meina, sul lungolago, sulle colline, abitassero gli ebrei. Non è detto che le liste fossero date loro dal gruppo di funzionari incaricati da Himmler della caccia agli ebrei italiani che l’8 settembre ricevettero luce verde per l’azione diretta. Potevano anche essersele procurate localmente in poche ore, con o senza l’aiuto di collaborazionisti locali. Potevano averle prese negli uffici comunali o nei commissariati» (Roberto Morozzo della Rocca, Introduzione cit.). 56 Dall’intervista a Gaetana Cardini, in Giovanni Galli, Memorie ritrovate, i diciassette ragazzi fucilati a Baveno nel giugno del 1944, Borgomanero 2004. 57 Secondo la testimonianza resa al processo di Osnabrück nel 1968 dal sergente maggiore Karl Heinrich Eberhard della quinta compagnia presente a Baveno, gli ebrei vengono uccisi con chiavi inglesi e poi gettati nel lago dentro sacchi postali. Cfr. Aldo Toscano, L’olocausto del Lago Maggiore (settembre - ottobre 1943) cit. 58 Sempre Gaetana Cardini (intervista citata) ricorda: «quando son venuti han detto alla mamma che avevano bisogno di un salone e di una camera per il loro ufficiale “perché andiamo a prendere gli ebrei”. La mamma dice “ma non ci sono ebrei a Baveno”.“Eh no, ci sono, sappiamo noi tutti gli ebrei che ci sono a Baveno”. Non si pensava neanche che il Luzzatto e gli altri fossero ebrei, non si faceva attenzione, non si faceva caso». Le famiglie Serman, Luzzato e Wofsi erano perfettamente integrate nel tessuto sociale della comunità di Baveno al punto che ci si sorprende nello scoprirli ebrei. 59 Aldo Toscano, L’olocausto del Lago Maggiore (settembre - ottobre 1943) cit. 60 Liliana Picciotto li considera uccisi in Italia il 16 settembre 1943 (cfr. Il libro della memoria cit.) 61 Dalla deposizione al processo di Osnabrück di Adolfo Penco, marito di Margherita Cohen, in 57 Giovanni Galli Aldo Toscano, L’olocausto del Lago Maggiore (settembre - ottobre 1943) cit. 62 Dalla testimonianza orale di Teresa Gattico, moglie di Vittorio Cantoni, Arona, 15 settembre 1943. A Villa Cantoni, in «Bollettino storico per la Provincia di Novara», n. 1 – 1993. 63 Il diario di Becky Behar, in La strage dimenticata cit. 64 Dal diario di Maddalena Stramba Covo, in Salvare la memoria (a cura di Alessandro Ceresatto e Marco Fossati), Anabasi, 1995. Mario Covo di nazionalità spagnola sposa Maddalena Stramba di Mergozzo, cattolica e per questo non arrestata dai tedeschi. I due sono rientrati in Italia dal Canada all’inizio della guerra, nonostante corressero seri pericoli, per stare vicini alla figlia, Matilde Maria (Lica) e al genero Albe Steiner, che dopo l’8 settembre rivestiranno un importante ruolo nella resistenza novarese. Albe Steiner in particolare sarà commissario politico dell’85a brigata Garibaldi. I due coniugi Covo al momento dell’arresto stanno ospitando i nipoti francesi, i coniugi Arditi, scappati dalla Francia e dalle persecuzioni naziste. 65 Dall’intervista a Lica Steiner, in La strage dimenticata cit. Nel luogo in cui si presume sia avvenuta l’uccisione, è stato da poco posto un cippo a memoria delle tre persone. 66 La famiglia di Elena si è convertita al cattolicesimo dal 1939 per evitare gran parte delle restrizioni imposte agli ebrei dalle leggi razziali ma in realtà diventarono poi tutti e tre cattolici convinti. Pare solo determinata dalle leggi razziali invece la conversione della famiglia di Roberto (Cfr. Carole Angier, Il doppio legame. Vita di Primo Levi, Mondadori, Milano 2004). 67 «Il podestà di Orta era l’avvocato Galli, che ci avrebbe gentilmente accompagnati ad Omegna, da dove avremmo potuto espatriare in Svizzera. Ma la partenza fu rinviata al giorno seguente, poiché in quella cittadina ci sarebbe stato il mercato locale e quindi la possibilità per lui d’incontrare dei clienti senza dare troppo nell’occhio in nostra compagnia. Quello che avvenne dopo ci capitò come un fulmine a ciel sereno. Qualcuno che ci conosceva bene ci denunciò, e le SS arrivarono lì, proprio per noi» (Simonetta Bachi, Vengo domani, zia, Genesi editrice, Torino 2001). 68 Dalla testimonianza scritta rilasciata da Elena Bachi ai giudici del processo di Osnabrück nel maggio 1968, in Simonetta Bachi, Vengo domani, zia, cit. 69 «Così su un semplice foglio di carta protocollo, firmato dal podestà di Omegna, io divenni Elena Annichini, figlia di Enrico e Paratore Rita, cugini di Don Giuseppe, sfollati dalla Sicilia, loro terra di origine, dove non si potevano fare accertamenti sui documenti di identità, essendo già stata liberta dagli alleati. Don Giuseppe credeva di averci sistemati in un posto tranquillo; invece ci ritrovammo nel bel mezzo dei covi dei partigiani. Ma senza averne mai alcun problema particolare. Anzi, ci salvammo la vita». (Simonetta Bachi, Vengo domani, zia, cit.). 70 Cfr. Carole Angier, Il doppio legame. Vita di Primo Levi cit. 71 «Li portarono nella caserma dei carabinieri. Ci rimasero per sei giorni, ogni giorno andammo a trovarli liberamente. […] Quel giorno [il 22 i prigionieri vengono trasferiti nell’ex villa ducale dove alloggiavano le SS] cercammo di andarli a trovare. Entrammo nel giardino, li intravedemmo in una saletta del pianterreno con l’avvocato Massarani e la sorella. Ma non potemmo parlar loro perché le SS ci cacciarono. Da quel momento non ne sapemmo più nulla. O meglio, qualcosa disse uno dei padri rosminiani, che erano rimasti nella villa: “li ho visti portar via la sera del 22 con una camionetta”. E dopo? Una domanda che ci angosciò a lungo. Nemmeno i corpi vennero trovati» (Dalla testimonianza di Ada Montaldo, figlia di primo letto di Enrichetta Repetto, moglie «ariana» di Giuseppe Ottolenghi, in Aldo Toscano, L’olocausto del Lago Maggiore cit.). 72 Cfr. la testimonianza di Mario Campiglio, Ancora una testimonianza, in «Bollettino storico per la Provincia di Novara», n. 1, 1993, cit. 58 400 nomi. L’archivio sulla deportazione novarese: un progetto in corso 73 «Anche di loro non si è saputo più nulla: unica labile traccia, l’elenco di un trasporto di ebrei da Torino ove compare un nome simile. Si può presumere quindi che fossero stati deportati, anche se di loro non è stata trovata traccia in nessun campo» (Mauro Begozzi, La strage dimenticata: un bilancio degli studi, in La strage dimenticata cit.). I due novaresi sono considerati uccisi lo stesso 19 settembre da Liliana Picciotto (cfr. Il libro della memoria, cit.). 74 Per le vicende legate all’arresto, cfr. Aldo Toscano, L’olocausto del Lago Maggiore (settembre ottobre 1943) cit. 75 «Fu un’azione “spontanea” delle SS? Oppure un’iniziativa ordinata ad alto livello dai comandanti della Leibstandarte o della Gestapo già attiva a Milano all’indomani dell’8 settembre? Le SS riportavano istintivamente nella inconsapevole provincia italiana la loro ferocia di Polonia e di Russia? Oppure erano guidate passo dopo passo dai loro vertici in Italia? All’interrogativo si è cercata risposta attraverso un processo celebrato con teutonica meticolosità, ad Osnabrück nel 1968. Due ufficiali e un sottufficiale che comandavano i reparti di stanza sul lago furono condannati all’ergastolo (due anni dopo una corte berlinese li avrebbe rimessi in libertà per prescrizione di reato) ma non furono provate responsabilità più in alto, sia per la scomparsa in guerra o successivamente, di personaggi chiave, sia per mancanza di documentazione. Nell’aprile del 1945 erano stati preventivamente distrutti i dossier della Leibstandarte relativi ai fatti del Verbano» (Roberto Morozzo della Rocca, Introduzione cit.) 76 «Seicentotrenta giorni dopo la sentenza di Osnabrück, precisamente il 2 aprile del 1970, la Corte d’Appello di Berlino la annullò completamente con questa semplice motivazione: “i reati devono considerarsi prescritti”. I tre ergastolani uscirono immediatamente dal carcere» (Marco Nozza, Hotel Meina cit.). Cfr. anche Aldo Toscano, L’olocausto del Lago Maggiore (settembre - ottobre 1943) cit. 77 Cfr. Liliana Picciotto, Il libro della memoria cit. 78 «Documenti sulla strage del lago Maggiore, non ne sono rimasti. Tutti distrutti dai tedeschi, incendiati, fatti sparire. Che esistessero, lo hanno confermato numerosi testimoni del processo di Osnabrück, testimoni di livello, ex autorità della Leibstandarte e della Gestapo, che hanno parlato di vere e proprie inchieste da loro avviate e poi insabbiate» (Marco Nozza, Hotel Meina cit.). 79 «Il processo di Osnabrück ebbe comunque il grande merito di far emergere con chiarezza la responsabilità di alcuni reparti della divisione SS Leibstandarte Adolf Hitler. Ma in modo altrettanto evidente sono emersi, durante quel dibattimento, i tentativi attuati dai comandanti superstiti della stessa Leibstandarte di coprire complicità a livello più elevato» (Marco Nozza, Hotel Meina cit.). 80 Mauro Begozzi, La strage dimenticata: un bilancio degli studi, in La strage dimenticata cit. 81 Dante Zaretti strappa una bandiera fascista dalla piazza di Villadossola, viene arrestato ma riesce a fuggire rifugiandosi alla Pianasca dove ben presto è raggiunto da altri partigiani. 82 Carlo Squizzi, 8.11.43. I primi partigiani ossolani e l’insurrezione di Villadossola, ed. La Pagina, Villadossola 1989 83 Ibidem 84 «Cominciavano le cose serie. Avvenne a Gravellona, subito dopo, il primo scontro armato. Una sciocchezza, ma avrebbe potuto essere grossa. Si trattava di attaccare una colonna di fascisti di ritorno da una spedizione punitiva in Val d’Ossola; non passarono di lì e non ci fu che una vittoriosa scaramuccia di un piccolo distaccamento dei nostri coi repubblichini che presidiavano Gravellona: due fascisti morti, un po’ d’armi e un prigioniero» (Giuliana Gadola Beltrami, Il Capitano, Lampi di stampa, Milano 2003) 59 Giovanni Galli 85 Carlo Squizzi, 8.11.43. I primi partigiani ossolani e l’insurrezione di Villadossola cit. 86 Ibidem. 87 «Intanto arriva il 17 novembre: io sono a Domo quando Aldo Gallacci mi avvisa che mi han cercato i tedeschi, milizia e carabinieri a casa mia, e mi consiglia di presentarmi perché se no portano via i miei genitori. Io sono stato ingenuo. […] Nella mattinata mi sono presentato alla caserma dei Carabinieri; quando sono stato là, mi han detto subito:«sai com’è il nostro albergo, togliti la cinta e i lacci delle scarpe», mi han messo in cella di sicurezza, ed è cominciata la via Crucis» (Dall’intervista a Luigi Boghi, in Paolo Bologna, Il prezzo di una capra marcia cit.). 88 Le ultime lettere dal carcere di quasi tutti questi fucilati sono raccolte in Mauro Begozzi, Non preoccuparti… che muoio innocente, Interlinea, Novara 1995/2005. 89 «Io ricordo solamente quando eravamo a München, a Monaco, andavamo lì, ci davano un’ora e mezza d’aria la settimana, ma sempre nel recinto, un muro che era alto nove o dieci metri, eravamo dentro lì, allora noi con questi zoccoli, queste pezze ai piedi, allora camminavamo, io vedevo Enea [Rinaldi] lì davanti, dietro a me, usciva un po’ lì per mettere a posto la pezza da piedi tanto vedevo lui vicino a me, “allora come va?”, parlavamo un po’, ma erano più le botte che prendevamo che le parole che dicevamo» (Dall’intervista a Duilio Bertaccini in La deportazione nei campi di sterminio nazisti cit.). 90 Dall’intervista a Luigi Boghi, in Paolo Bologna, Il prezzo di una capra marcia cit. 91 «Un ultimo elemento, che è secondario all’interno della valutazione generale dell’esperienza concentrazionaria, ma si presenta ben vivo negli ex deportati, riguarda un aspetto burocratico proprio dello Stato italiano, e cioè l’applicazione del Dpr 6 ottobre 1963, n. 2043 (convertito con modifiche nella L. 14 marzo 1968, n. 211) avente per oggetto: Norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania, in base all’Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste. A Netro i sopravvissuti sono stati riconosciuti tutti a livello istituzionale come ex deportati, a Villa no, ad alcuni è stata negata la qualifica ufficiale di deportato» (Filippo Colombara in La deportazione nei campi di sterminio nazisti cit.). 92 «La Stampa», 12 gennaio 2006 (Cronache di Novara e del Vco). 93 L’articolo a firma «bieffe (uno degli 86)» compare il 15 dicembre 1945 su un foglio partigiano locale, un giornale che prosegue la pubblicazione ancora per qualche anno dopo la fine della guerra, il «Monte Marona». 94 Si tratta di Gianluigi Molinari, Da Intra a Zwickau, andata e ritorno, Guardamagna editori in Varzi, 2001 e dei racconti di Alberto Ziviani, 1944: Preludio di un dramma (scritto tra il 1997 e il 2001) e 1945: Primavera della Libertà (scritto tra il 2001 e il 2002 in parte sulla base di appunti risalenti al 1945). 95 Il 20 giugno 1944 un’azione partigiana a Baveno per catturare tedeschi da scambiare con altri prigionieri (è lo stesso giorno in cui avviene la fucilazione dei partigiani a Fondotoce) porta all’uccisione di un capitano tedesco e di un maggiore della Gnr. Il capitano Stamm, comandante del III battaglione SS-Polizei, Reggimento 20, reparto coinvolto in quei giorni nel rastrellamento in Val Grande, dal suo quartier generale a Baveno ordina la cattura di un buon numero di abitanti del luogo. L’operazione avviene il giorno successivo, «prendevano a caso, ma solo uomini, perché io lavoravo lì allo stabilimento e son venuti dentro, non so se erano tedeschi o fascisti, son venuti dentro e prendevano uomini. Qualcuno è riuscito a scappare, qualcuno l’han preso, le donne no» (Dall’intervista a Maria Rigoli, in Giovanni Galli, Memorie ritrovate, i diciassette ragazzi fucilati a Baveno nel giugno del 1944 cit.). Queste persone inizialmente destinate alla fucilazione vengono poi in gran parte deportate seguendo lo stesso tragitto fatto 60 400 nomi. L’archivio sulla deportazione novarese: un progetto in corso dai verbanesi qualche giorno prima: Torino, Casermette S. Paolo, e poi i campi di lavoro tedeschi. A Baveno il 21 giugno vengono comunque fucilati per ritorsione 17 partigiani catturati durante il rastrellamento della val Grande. 96 Gianluigi Molinari, Da Intra a Zwickau, andata e ritorno cit. 97 Alberto Ziviani, 1944: Preludio di un dramma cit. 98 Una fuga riuscita viene raccontata dal partigiano verbanese Arialdo Catenazzi, classe 1924. «Entrai nei bagni della scuola e […] con una lametta che avevo in tasca tagliai i cordoni delle tende che coprivano le finestre e ne feci una corda per calarmi nel cortile. Attesi che i tedeschi abbandonassero il cortile per scendere nella mensa […] e poi mi calai di sotto. […] Seppi poi che con la mia corda ne scapparono altri 13. Il quattordicesimo si trovò un mitra spianato mentre scendeva» (Dall’intervista rilasciata ad Antonella Braga e Mauro Begozzi, in «Resistenza Unita», giugno 1994). 99 «Con l’amico Emanuele Levati avevo pensato sul finire del 1943 di scappare di casa per andare a combattere contro i nemici, gli inglesi, perché, pensavamo, non si può perdere una guerra: ora vedo che il nemico è dall’altra parte» (Gianluigi Molinari, Da Intra a Zwickau, andata e ritorno cit.). «Così sul marciapiede del primo binario incontro mia mamma con la mamma di Alberto Ziviani. Mia mamma è impietrita dal dolore, la mamma di Alberto piange come una fontana» (ibidem). 100 Il «campo della fabbrica» si trova in Moseler Strasse al numero 5, nel paese di Zwickau (ibidem). 101 102 Ibidem «La sera si tornava al lager non incolonnati e senza guardie perché il lavoro non finiva mai alla stessa ora, per tutti. Spesso eravamo insieme Buccella [Antonio Buccella di Feriolo è un altro degli 86 ragazzi catturati a Verbania] ed io, perché provenienti dalla stessa squadra. Una sera vediamo una donna con una bimba scaricare un camion carico di ceste di carbone e portarle in cantina; ci siamo intesi con Antonio, senza parlare, ed io mi sono avvicinato alla signora e le ho detto che noi avremmo volentieri aiutato per avere poi un po’ di cibo. La donna era ben lieta per l’aiuto ma, dice, «non ho nulla fuorché un po’ di pane». Un nostro ampio sorriso le risponde ed in mezz’ora il camion è scaricato. Mi dà un bollino della tessera annonaria per un kg. di pane. Lì vicino c’è un panettiere, compriamo una forma di pane nero da 1 kg. e me lo metto sotto la tuta, sul petto. All’ingresso del lager le guardie vedono il mio gonfiore, mi fermano, mi interrogano e mi sequestrano la pagnotta. La sera successiva passo da quella donna, le racconto l’accaduto e la prego i fare qualcosa; due giorni dopo al cancello c’è un avviso: Molinari si presenti alla polizia, ci vado, mi ridanno la pagnotta e, a scanso di altri guai, con Buccella ce la mangiamo subito!» (ibidem). 103 «Ci accordiamo per coinvolgere Franco che ha ricevuto quattro pacchi da casa tramite la Croce Rossa […] Il contenuto dei pacchi di Franco (maglioni, riso, sigarette) era necessario per barattarlo con razioni di pane che avremmo raccolto in qualche sacchetto ed anche per mettere insieme un po’ di marchi, sempre utili per le situazioni impreviste» (Gianluigi Molinari, Da Intra a Zwickau, andata e ritorno cit.). 104 105 Alberto Ziviani, 1945: Primavera della Libertà cit. «Renato ci dice di essere il fiduciario del campo di prigionia degli allievi della Accademia Navale di Livorno, catturati dai tedeschi. […] Il nostro marinaio ci porta al campo dove veniamo accolti dagli allievi con molta simpatia e rifocillati con un po’ di cibo. Essi erano internati militari e considerati loro stessi responsabili del loro campo, non avevano cioè uno stretto controllo 106 61 Giovanni Galli della polizia militare tedesca» (Gianluigi Molinari, Da Intra a Zwickau, andata e ritorno cit.). «Ci raccontano che, cadetti dell’accademia navale di Livorno, erano stati presi dai tedeschi subito dopo l’8 settembre, deportati ad Innsbruck e costretti ai più svariati lavori» (Alberto Ziviani, 1945: Primavera della Libertà cit.). «Siamo stati assunti da un piccolo imprenditore edile, il vecchio Mühlbacher. Egli ha in appalto i lavori per la ristrutturazione del civico ospedale gestito dalle suore e noi lavoriamo lì come muratori. Col poco che guadagniamo ci paghiamo vitto e alloggio: il primo fornitoci dalle suore dell’ospedale, il secondo dalla compagnia costruttrice della centrale elettrica che ci ha assegnato tre castelletti nelle baracche dove dormono i suoi dipendenti, tutti italiani» (ibidem). 107 «Nella stessa baracca troviamo altri italiani fra cui padre e figlio della borgata Dalmassi, frazione di Giaveno. […] I due Dalmasso (il loro cognome) erano stati portati via dalla loro cascina solo perché nella zona di Giaveno verso i monti, si erano organizzati alcuni gruppi partigiani» (Gianluigi Molinari, Da Intra a Zwickau, andata e ritorno cit.). 108 Nel novembre del 1943 sono chiamati alle armi i ragazzi del 1925 e il secondo e terzo quadrimestre del 1924. A febbraio dell’anno successivo vengono coinvolti quelli del 1922, del 1923 e del primo quadrimestre del 1924. A maggio e ad aprile sono richiamati i giovani dal 1916 al 1919 e infine a giugno del 1944 la chiamata alle armi riguarda i nati nel 1920, 1921 e nel primo quadrimestre del 1926. 109 Sono le parole di Marco Abruzzese, uno dei militari prelevati dal carcere di Peschiera dopo l’8 settembre e deportato a Dachau. La testimonianza si trova in La vita offesa, a cura di Anna Bravo e Daniele Jalla, cit. 110 62 storia nazionale «Pagine libere»: la voce del sindacalismo rivoluzionario interventista (1914-1915) di Stefano Fabei Nel periodo compreso tra l’autunno 1914 ed il maggio 1915, nonostante le posizioni neutraliste di gran parte delle forze rappresentate in parlamento, dal Partito socialista ai liberali giolittiani alla componente cattolica, diversi gruppi politici, molto attivi sul piano della propaganda per quanto minoritari nel Paese, spinti da convinzioni ideologiche e obiettivi diversi, vennero a trovarsi uniti sulle piazze per chiedere la partecipazione dell’Italia al conflitto. Due tendenze fondamentali confluivano nel movimento favorevole all’ingresso dell’Italia in guerra: quella nazionalista, per cui lo sforzo bellico sarebbe stato un «grande lavacro purificatore» che avrebbe generato nazionalità rinnovate, «ordinate sulla base di un criterio di potenza e libere dalla cancrena della democrazia e dalla peste del parlamentarismo», e quella di matrice repubblicana, democratica, radicale e garibaldina per cui la guerra costituiva l’ultima fase del Risorgimento, la necessaria campagna contro l’impero austro-ungarico per la liberazione di Trento e Trieste. Se i primi inviti ad intervenire militarmente al fianco dell’Intesa vennero dai democratici di sinistra, dai riformisti e dai massoni, ad essi si aggiunsero ben presto i sindacalisti rivoluzionari, anche se inizialmente non mancò tra loro qualche esitazione. All’inizio infatti essi avevano affermato, pur con toni che andavano oltre un generico pacifismo umanitario la necessità per l’Italia di non partecipare al conflitto. Sul manifesto dell’Unione sindacale italiana1 del 1° agosto 1914 si leggeva: «Noi non vi predichiamo un pacifismo imbelle ed inutilmente piagnone. Noi vi diciamo invece di tenervi pronti a trasformare l’odiosa guerra tra le nazioni nella liberatrice guerra civile servendovi delle armi che vi daranno in mano pel fratricidio ai fini della vostra redenzione di classe»2. Lo stesso giorno sul periodico sindacalista della Camera del lavoro di Parma, «L’Internazionale», in un articolo intitolato Mentre tuona il cannone, si aggiungeva che «se non sarà la 63 Stefano Fabei pace per volontà dei governi e dei re, sarà pure la guerra per volontà nostra e del socialismo: sarà la rivoluzione»3. La sinistra si spacca di fronte alla guerra Il 5 agosto si erano riuniti a Milano la direzione del Partito socialista, gli esponenti della CGdL e Tullio Masotti e Alceste De Ambris in rappresentanza dell’Usi. Tutti si erano espressi a favore della neutralità italiana concordando sulla necessità di proclamare uno sciopero generale rivoluzionario qualora si fosse avuta da parte del governo una presa di posizione a favore dell’Austria-Ungheria e della Germania. I due esponenti sindacalisti avevano tuttavia dissentito dalla CGdL che aveva proposto di affidare l’incarico di dirigere l’azione solo alla direzione del Partito socialista. Dopo un breve fronte unitario con la CGdL e i socialisti, in nome del rifiuto della guerra, si era però determinata la frattura prodotta anche da eventi sconvolgenti per la sinistra: il fallimento della II Internazionale, l’invasione del Belgio, l’inattesa adesione alla guerra di molti socialisti e anarchici francesi, fra cui Hervé4. L’8 agosto il comitato esecutivo dell’Usi ribadiva la condanna della guerra, contraria agli interessi del proletariato, mentre su «L’Internazionale» Masotti metteva in discussione il significato stesso della neutralità assoluta. Dieci giorni dopo in un intervento tenuto presso la sede milanese dell’Usi, si dichiarava senza mezzi termini a favore della guerra rivoluzionaria. Al consiglio generale dell’Usi, riunitosi il 13 e il 14 settembre 1914, Alceste De Ambris5 presentò un ordine del giorno in cui era espressa aperta simpatia nei confronti delle potenze occidentali, con le quali auspicava l’alleanza dell’Italia.6 Solo le camere del lavoro di Milano, Parma e Castrocaro si espressero a favore, mentre le altre votarono l’ordine del giorno di Armando Borghi in cui si affermava l’irriducibile opposizione alla guerra frutto della politica imperialistica nemica del proletariato che in tutti i Paesi belligeranti doveva ritrovare in sé «lo spirito di solidarietà di classe e le energie rivoluzionarie per profittare dell’inevitabile indebolimento delle forze statali e della crisi generale derivanti dalla guerra stessa per un’azione comune intesa a travolgere gli stati borghesi e monarchici che della guerra furono per un cinquantennio i coscienti e cinici preparatori»7. Il voto causò le dimissioni del comitato centrale, la nomina di uno nuovo e l’elezione di Borghi a segretario. I sindacalisti interventisti ricrea64 «Pagine libere»: la voce del sindacalismo rivoluzionario interventista (1914-1915) rono il vecchio Comitato sindacalista milanese cui facevano capo anche le organizzazioni sindacali di dichiarata tendenza repubblicana: prima fra tutte entrò a farne parte l’Unione sindacale milanese guidata da Filippo Corridoni8. Sempre a Milano nelle giornate del 15 e 16 settembre si tennero le prime manifestazioni di piazza contro l’Austria e a favore dell’intervento, organizzate dai futuristi guidati da Marinetti e da Boccioni. Contemporaneamente, sotto gli auspici di Corridoni, i gruppi rivoluzionari di sinistra che si erano pronunciati per la guerra andarono organizzandosi e si prepararono a reclamare l’intervento italiano. La spaccatura dell’Usi era più grave di quanto Borghi avesse creduto: non si trattava soltanto di un cambio della guardia al vertice ma della perdita della più forte camera del lavoro, quella di Parma. Da quel momento i sindacalisti interventisti iniziarono a propagandare con forza crescente la necessità di entrare nel conflitto per battere i reazionari imperi centrali, difendere le libertà politiche conquistate e rafforzare il proletariato, che avrebbe potuto rivendicare i suoi diritti una volta conseguita la vittoria. Olivetti e la terza serie della rivista «Pagine libere» A dare l’avvio ad una decisa campagna di stampa in difesa delle posizioni interventiste fu Angelo Oliviero Olivetti, direttore della rivista «Pagine libere», che dal 10 ottobre 1914 riprese la pubblicazione, dopo una sospensione di alcuni anni9. Attorno a questo periodico si raccolsero sindacalisti rivoluzionari e anarchici come Michele Bianchi, Filippo Corridoni, Amilcare De Ambris, Attilio Deffenu, Cesare Rossi, Massimo Rocca, che insieme a Decio Bacchi, Ugo Clerici, Aurelio Galassi, Decio Papa, Sincero Rugarli e Sergio Rossi, costituirono il Comitato promotore del Fascio rivoluzionario di azione internazionalista. Si trattava, come si legge nella breve premessa al primo appello rivolto il 5 ottobre 1914 ai lavoratori italiani, di «un gruppo di amici, tutti appartenenti a frazioni diverse della parte rivoluzionaria, […] iniziatore di un movimento […] di revisione delle dottrine nostre di fronte alla nuova realtà storica che deve essere ammonimento di fatti e sprone all’azione»10. Attraverso la rivista diretta da Olivetti si produsse la chiarificazione ideologica dell’interventismo che fu da un lato un’opera di riattraversamento 65 Stefano Fabei critico della tradizione politica e teorica maturata nel corso di un ventennio dal sindacalismo rivoluzionario, dall’altro l’individuazione del nucleo essenziale configurante quest’ultimo come fenomeno originale, autonomo e indipendente rispetto alle altre dottrine politiche, sia precedenti sia successive, nucleo rappresentato dall’imperativo di coordinare la rivoluzione sociale col fatto nazionale. Preso atto della rottura radicale operata dai sindacalisti interventisti nei confronti della tradizione socialpacifista, cercheremo di individuare la vera portata innovativa, l’elemento caratterizzante che permette di configurare il sindacalismo rivoluzionario come una delle più significative componenti di quella tendenza «nazional-rivoluzionaria» che, sebbene emarginata dalla successiva affermazione delle «ortodossie» fascista e comunista, può essere riconosciuta come dotata di una sua legittima autonomia e di una sua caratteristica identità. Come abbiamo detto, il 5 ottobre 1914 il Fascio rivoluzionario di azione internazionalista lanciava il proprio appello ai lavoratori italiani: Nell’ora tragica che passa, mentre la guerra immane celebra in Europa i suoi fasti sanguinosi, mentre appaiono le ragioni stesse della civiltà travolte sotto la marea della rimontante barbarie, noi militanti in frazioni diverse della parte rivoluzionaria, sentiamo il dovere di dirvi una parola chiara e sincera, perché non sia il nostro silenzio interpretato acquiescenza o viltà in un momento in cui è supremo interesse e preciso dovere d’ogni rivoluzionario esprimere il suo pensiero e chiarire il proprio atteggiamento di fronte all’incalzare degli avvenimenti. Non ricerchiamo – ché sarebbe vano e ozioso – la genesi della grande tragedia. Se come rivoluzionari non potremmo che considerare la borghesia internazionale responsabile in solido del flagello dei popoli, sarebbe d’altra parte insincero e disonesto non riconoscere quel tanto di responsabilità che spetta a noi rivoluzionari, alla classe operaia dei diversi paesi, agli elementi d’avanguardia, in una parola, che hanno nel loro programma l’avversione alla guerra e la lotta contro il militarismo, per opera insufficiente e inefficace svolta al fine di impedire che i disegni imperialistici dei governi borghesi e delle caste militaristiche d’Europa avessero attuazione attraverso la guerra. L’Internazionale operaia si è dimostrata alla prova dei fatti, più che impotente a fronteggiare gli avvenimenti e impedire l’evento guerresco. Mentre infatti i compagni di Francia, Belgio e Inghilterra seppero compiere sino alla fine il proprio dovere di socialisti, pronti a iniziare con lo sciopero generale internazionale il movimento di rivolta contro le mene guerresche delle borghesie, quelli di Germania e di Austria, cioè degli stati che sono apparsi al mondo intero come gli artefici della fosca congiura ordita dalle rinate forze del medioevo europeo contro ogni luce di civiltà e ogni elemento di progresso, in luogo di opporre la forza delle loro potenti organizzazioni economiche e 66 «Pagine libere»: la voce del sindacalismo rivoluzionario interventista (1914-1915) politiche alle scatenatesi furie aggressive dei loro governi, hanno ceduto alla corrente dell’imperialismo più brutale e selvaggio, dimentichi del loro dovere di socialisti, traditori dei sacri doveri della solidarietà operaia internazionale. Non una vana parola, forse, sarebbe stato il nostro sogno d’affratellamento dei popoli al di là di ogni frontiera, se i socialisti tedeschi e austroungarici fossero insorti contro l’ignobile ultimatum del governo austriaco al piccolo popolo serbo, se si fossero commossi al grido angoscioso del Lussemburgo e del Belgio vilipesi e offesi nel loro sacrosanto diritto alla libertà e alla indipendenza, se, in una parola, avessero affermate le ragioni dell’interesse proletario e della civiltà socialista contro i loro governi vessilliferi di tirannide militare e di imperialismo. Così la guerra è oggi una tragica realtà della quale non possiamo essere spettatori indifferenti senza tradire la causa stessa della rivoluzione, senza rinnegare i nostri principi socialisti che parlano ai popoli in nome della civiltà e della libertà. E allora giova domandarsi se gli interessi più vitali della classe lavoratrice dei diversi paesi, se la causa della rivoluzione sociale, siano meglio tutelati dall’atteggiamento di rigorosa neutralità voluto per l’Italia dal Partito Socialista ufficiale, in pieno accordo con gli elementi clericali, e a tutto vantaggio delle armi tedesche, o non piuttosto l’intervento a favore degli stati che rappresentano in Europa la causa della libertà e della pace: a favore della Francia culla di cento rivoluzioni, dell’Inghilterra presidio di ogni libertà politica, del Belgio generoso ed eroico. La risposta non può essere dubbia per noi rivoluzionari che, fedeli all’insegnamento dei nostri grandi, opiniamo non potersi superare i limiti delle rivoluzioni nazionali senza prima averli raggiunti, onde la lotta di classe è una formula vana, non una forza attuosa e feconda ove ogni popolo non siasi integrato nei propri confini naturali di lingua e di razza, e, definitivamente risoluta la questione delle nazionalità, non siasi formato il clima storico necessario allo sviluppo normale del movimento di classe, al progresso e al trionfo delle stesse idee dell’internazionalismo operaio. Il trionfo del blocco austrotedesco sarebbe in Europa il rinnovato trionfo della Santa Alleanza, il rafforzamento della reazione e del militarismo contro quello della rivoluzione [...] I grandi contrasti storici non si risolvono col negarli ideologicamente, sibbene col superarne praticamente i termini: la guerra non si combatte col ruminare delle formule o coll’opporre a essa delle sterili negazioni verbali, sibbene con l’eliminarne le cause generatrici, col ridurne i fattori di forza e di successo.I neutralisti a oltranza appaiono oggi i veri amici della guerra. Noi, combattendo a lato dei rivoluzionari di Francia, di Russia, del Belgio e dell’Inghilterra per la causa della libertà e della civiltà contro quella dell’autoritarismo e del militarismo teutonico, per la ragione contro la forza, per la rivoluzione europea contro il sogno folle e delittuoso di instaurazione di un impero universale – visione di medioevo che deve essere ricacciata nel medioevo – crediamo di compiere l’opera più utile che si possa oggi a favore della pace europea, per la causa della rivoluzione sociale, per la ricostruzione dell’internazionale operaia sulle nuove basi dell’avversione sistematica perseguita con ogni mezzo a ogni guerra che non sia guerra d’oppressi contro oppressori, di sfruttati contro sfruttatori. Lavoratori, gli avvenimenti incalzano. L’Italia, a fianco delle potenze che combattono per la libertà e l’indipendenza dei popoli, renderebbe più sollecito e decisivo l’esito 67 Stefano Fabei della guerra, attenuandone gli immani disastri. La neutralità armata non risparmia le gravi conseguenze che dalla guerra derivano al nostro paese e al tempo stesso non ci immunizza dal pericolo bellico: essa piuttosto dà al governo, con la mobilitazione dell’esercito la possibilità di coglierei alla sprovvista domani con qualunque guerra che gli piacerà dichiarare, anche contro le ragioni della civiltà e i nostri stessi interessi, e inoltre – il che sarebbe anche peggio – il mezzo di coprirci di vergogna, con un turpe ricatto mettendo a prezzo il nostro non intervento. L’imporre oggi la guerra contro il blocco austrotedesco è il mezzo migliore per impedire che l’Italia possa domani subdolamente rimettersi al suo servigio. Noi rivoluzionari non abbiamo nessun interesse da conservare, non abbiamo alcun motivo per ingannare il popolo. Parlino pure di neutralità i partiti che hanno da conservare onori, stipendi, posizioni politiche, ciechi o interessati assertori di una grande viltà nazionale e di una grande infamia storica, alleati alla politica dinastica e clericale e complici degli scannatori e dei saccheggiatori. Noi rivoluzionari vogliamo che si riprenda la tradizione dei grandi intelletti e dei grandi cuori che seppero le voci dell’avvenire umano e previdero i destini dei popoli. Non cooperare alla vittoria del migliore significa recare aiuto al peggiore. I rivoluzionari non devono avere dubbi di scelta. La nostra causa è quella di Amilcare Cipriani, di Kropotkin, di James Guillaume, di Vaillant, quella della rivoluzione europea contro la barbarie, l’autoritarismo, il militarismo, il feudalesimo germanico e la perfidia catto lica dell’Austria. Ognuno compia fino all’ultimo e in tutti i modi il suo dovere. Tutte le forze vive del mondo, tutti coloro che augurano all’umanità lavoratrice un avvenire migliore e combattono per il trionfo della causa operaia e della rivoluzione sociale, per l’affratellamento dei popoli e la fine di tutte le guerre, debbono scendere in campo risolutamente. Noi dobbiamo imporre al governo di cessare di disonorarci o di sparire, e fin d’ora separare le responsabilità e prepararci all’azione11. I firmatari del manifesto erano i sopra citati sindacalisti rivoluzionari, i quali avevano preparato l’uscita del primo fascicolo della nuova serie di «Pagine Libere» che, in un certo senso, sarebbe stata l’organo del Fascio rivoluzionario di azione internazionalista. Nel redigere il programma della rivista, che poi coincise in buona sostanza con quello del sindacalismo rivoluzionario, riveduto e corretto sia alla luce delle nuove condizioni storiche che di una revisione critica dell’esperienza precedente, Olivetti poneva le basi per una nuova sintesi politica: Io credo sia venuta l’ora di porsi, con piena libertà di spirito e senza preconcetti conservativi e iconoclastici, a rivedere tutte le nostre dottrine, a farci una relatività di coscienza politica nuova, attraverso l’esperienza vissuta di un quarto di secolo... Il socialismo e il sindacalismo devono uscire purificati dal crogiolo della storia, soprattutto attraverso il fuoco dei grandiosi avvenimenti dei quali siamo spettatori. Essi debbono liberarsi 68 «Pagine libere»: la voce del sindacalismo rivoluzionario interventista (1914-1915) di tutte le impurità di tutte le scorie, rifarsi un’anima tersa, lucida, piena, combattiva come ebbero alloro nascimento. In questa ora di storia sanguinante si tratta per loro di rinnovarsi o di perire. Ogni dottrina è destinata per forza di cose a logorarsi con l’uso, col perpetuo strofinio con la vita [...] Noi non possiamo essere conservatori del vecchio sovversivismo [...] Via le dottrine mummificate, le formule rancide e ipocrite, le intransigenze formali che rappresentano solo il terrore della realtà, le filosofie oltre passate che vengono ancora imperturbabilmente ammannite al proletariato come una camelotte intellettuale, via le idee a buon mercato, l’edonismo piatto e il materialismo opportunistico! Con uno sforzo assiduo, con una revisione onesta di tutto il passato, potremo salvare la quintessenza della nostra idea ed elevarla purificandola, darle valore e verginità nuova, contro tutti i conservatori, quelli di fuori e quelli di dentro che sono certo i più pericolosi. Questa rivista vuole essere la libera palestra di un simile movimento di revisione che è nell’animo di molti e che non poté avere finora alcuna espressione in causa del sistematico boicottaggio dei partiti, i quali sono per eccellenza gli strumenti della conservazione sociale [...]. Oggi chi non è folle o tolstoiano o imbecille del tutto si arrende alla realtà che ci mostra la bancarotta fraudolenta del vecchio internazionalismo e la persistenza dei motivi di nazionalità superante e travolgente ogni altro sentimento degli uomini. Coordinare la rivoluzione sociale col fatto nazionale è il più grave problema per i veri e sinceri rivoluzionari dell’ ora presente. […] Il socialismo credé di risolvere la questione sociale convergendo gli sforzi dell’operaio come individuo politico alla formazione di un partito che rappresentasse la classe e la conducesse al trionfo con l’esercizio della lotta di classe. Il sindacalismo pose al primo piano della visuale storica l’uomo non più come individuo politico, ma come produttore, e perciò riconobbe nel sindacato l’arnese appropriato della lotta di classe, anziché nel partito [...]. Il nuovo sovversivismo trarrà dal socialismo il concetto fondamentale della lotta di classe, dal sindacalismo la strumentalità sindacale, ma dovrà integrare l’uno e l’altro con tutta un’opera educativa intellettuale e morale per darci il rivoluzionario compiuto, l’uomo nuovo, il vincitore, il superatore, che non solo perverrà alla conquista del pane, ma vi arriverà con un animo siffatto, sì temprato e foggiato agli ardimenti e alle conquiste, da poter signoreggiare la materia per prendere il volo a più alte ascensioni.[…]. Dobbiamo perciò superare il concetto di un rivoluzionarismo empiricamente politico e quello di un rivoluzionarismo grettamente economico [...]. Io non voglio essere solo un socialista o solo un sindacalista, ma soprattutto un uomo [...]. Nessuna umanità deve essermi aliena [...]12. Contro il feudalesimo e il socialismo austro-tedesco responsabili della guerra Quelle che dovevano essere le nuove premesse ideologiche venivano ulteriormente sviluppate in un altro articolo in cui Olivetti, deplorando la barbarie tedesca ampiamente manifestatasi in Belgio con stragi e saccheggi, osservava come la civiltà meccanica non comportasse un miglioramento 69 Stefano Fabei morale se uno dei popoli ritenuti più civili poteva macchiarsi di tanto scempio13. Originale la tesi per cui la guerra in corso costituiva una sorta di reazione austro-tedesca alla rivoluzione francese: «Sono precisamente le due nazioni che non hanno subito la rivoluzione francese in modo diretto e che non hanno avuto completo sfogo delle rivoluzioni borghesi dell’ultimo secolo, quelle che hanno mosso la presente guerra. Sono le nazioni in cui esistono ancora le sopravvivenze feudali, dove il contadino è pressoché ancora servo della gleba come nella Prussia Orientale, in Pomerania, in Galizia. Il soffocamento delle rivoluzioni democratiche nel 1948 a Berlino, nella Germania meridionale, a Vienna, orientò in senso feudale militaresco il blocco austrotedesco che rappresenta veramente in Europa l’ultimo baluardo dell’antico regime. Guglielmo II ripete la spedizione di Brunswick, ed è ancora la Francia della rivoluzione che salva il mondo dall’imbarbarimento e dalla reazione»14. Naturalmente non può mancare la condanna del socialismo tedesco nei confronti del quale, peraltro, Olivetti aveva messo in guardia da tempo: «Noi abbiamo il diritto di fare il processo del socialismo tedesco e di metterlo al bando dell’internazionale operaia [...] Da dieci anni io vado dicendo che il socialismo tedesco è prima tedesco che socialismo e non c’è che da sfogliare la raccolta delle “Pagine Libere” per constatare che questa non è una tardiva vanteria, fatta del senno di poi, ma l’accertamento di fatto di chi, per i casi della vita, ebbe per quattordici anni l’occasione di seguire da vicino e di studiare sul luogo le gesta del socialismo teutonico. Esso approvò sempre tutti gli atti di violenza dei governi tedeschi [...] Non solo il socialismo austrogermanico ha tradito la solidarietà dell’internazionale operaia, ma deve anzi essere considerato come il principale responsabile della grande guerra d’Europa. Esso non è propriamente che un’altra forma del tentativo tedesco di dominare il mondo [...] Esso è tedesco come il Kaiser».15 Secondo Olivetti, per i sindacalisti rivoluzionari, la lotta è fra due termini: il principio di libertà contro il principio di autorità. Il secondo è rappresentato dagli imperi centrali e «il socialismo tedesco tiene bordone all’impresa della quale dividerà gli utili»16. Tra il 10 ottobre 1914 e il 15 gennaio 1915, l’iniziativa più importante di «Pagine Libere» è senz’altro la promozione di una Inchiesta sulla guerra europea, con la quale è possibile ricostruire, attraverso numerosi interventi dagli accenti anche diversi, la pluralità delle motivazioni dell’atteggiamen70 «Pagine libere»: la voce del sindacalismo rivoluzionario interventista (1914-1915) to dei sindacalisti rivoluzionari nei confronti della guerra. È proprio Olivetti, direttore della rivista, a lanciare l’idea di una sorta di referendum su interventismo e neutralismo e il fatto di essere lui stesso decisamente a favore dell’intervento non gli impedisce di ospitare sulla propria rivista le tesi di quanti sono in disaccordo con lui. Intervenendo nel dibattito, Edmondo Rossoni17, «redattore del Proletariato di Nuova York», rivendica l’utilità delle guerre in quanto «sono sempre state foriere di grandi avvenimenti d’altro carattere» e, nel caso presente, il vantaggio consiste nel fatto che con la sconfitta degli imperi centrali «sarebbe abbattuto un ciclopico ostacolo sul cammino della marcia libertaria». Rossoni auspica altresì che quando saranno chiuse le vicende della guerra fra popoli e popoli, e i rovesci militari e finanziari – che non mancheranno per nessuna nazione, vincitrice o vinta – avranno rincrudite le sorti delle classi lavoratrici, prima di deporre le armi i proletari che non seppero opporsi alla guerra con lo sciopero generale, facciano i conti con i loro rispettivi governi perché il sangue versato disseti almeno i superstiti18. Fra gli altri interventi, molti dei quali incentrati s ulla barbarie germanica e sull’aggressività degli Imperi centrali, significativi quelli del segretario del Sindacato ferrovieri, Livio Ciardi, per il quale la guerra in atto è uno scontro di civiltà che vede la latinità opporsi all’imperialismo feudale teutonico, e di Maria Rygier19. Questa sostiene che la conflagrazione europea «chiuderà il ciclo di guerre di indipendenza nazionale» con ciò liberando la lotta di classe del suo maggior ostacolo sentimentale: la necessità per il proletariato di collaborare con la borghesia per la difesa o la rivendicazione della indipendenza minacciata o manomessa20. Massimo Rocca21 è invece l’unico interventista ad addurre motivazioni di prestigio nazionale, volendo evitare che siano altri popoli a rinnovare il mondo negando all’Italia ogni protagonismo, e sostenendo che se il movimento operaio suppone la risoluzione completa di ogni problema nazionale, questo deve essere risolto combattendo quegli imperi centrali negatori del diritto nazionale e responsabili dello scoppio della guerra. Molte sono le ragioni che rendono quest’ultima necessaria per l’Europa e tanto gli italiani quanto i sovversivi hanno interesse a che l’Italia vi partecipi. Per i primi, se la vittoria degli imperi centrali ribadirebbe la subordinazione del Paese nei loro confronti, con il continuo ricatto militare di un Trentino incuneato come minaccia armata nella Val Padana e di un Adriatico controllato dall’Austria, dall’altra parte un trionfo completo, 71 Stefano Fabei senza gli italiani, della Serbia – con la Russia tendente anch’essa all’Adriatico – e delle flotte franco-britanniche nel Mediterraneo, cancellerebbe ogni nostra influenza in quest’area da Rocca definita «il nostro cortile di casa». Egli ritiene che una tale prospettiva, oltre a costringere l’Italia ad armarsi – fatto che la renderebbe sospetta ad un’Europa sprezzante e diffidente – spezzerebbe tutte le linee di espansione pacifica del nostro commercio e delle nostre industrie verso Oriente e Occidente, con grave danno per il capitalismo e il proletariato italici. Sarebbe inoltre una prova di ignoranza e malafede suggerire il nostro intervento all’ultimo momento per imporre la volontà dell’Italia «quasi che la sua potenza fosse capace di opporsi ad una Triplice Intesa vittoriosa, mentre la stessa Inghilterra, che pure ha la cintura invincibile del mare, ha dovuto prendere parte al conflitto per evitare la conquista del Belgio». Occorre evitare la trasformazione del Mediterraneo in un lago francese e il miglior modo per conseguire questo obiettivo consiste nel mettersi in grado di poter sfruttare domani la rivalità che prima o poi risorgerà tra la Francia e l’Inghilterra. Ciò è possibile solo se gli italiani riusciranno a vantare presso Parigi un aiuto corrispondente a quello offertogli da Londra, pena – in caso contrario – di rimanere soli contro la vicina repubblica, o di vedersele entrambe contro. Quanto al pericolo slavo, paventato da molti, Rocca lo ritiene ancora lontano e a contrastarlo in un prossimo futuro ci sarà un’Asia sempre più forte di fronte alla quale la Russia costituirà una muraglia protettrice. Comunque, tale minaccia non sarebbe attenuata dalla permanenza di Trieste e della Dalmazia sotto l’Austria, «tanto che forse bisognerebbe dolorosamente rinunciare all’italianità di entrambe: senza contare che uno slavismo posto a servizio dell’imperialismo tedesco mediante l’Austria è infinitamente più forte e pericoloso che una Slavia autonoma». Nel caso in cui il pericolo slavo avesse quell’urgenza cui Rocca comunque non crede, il miglior modo per salvaguardarsene sarebbe avere un forte esercito in Austria al momento della pace per imporne la trasformazione federalistica, ottenendo che la sponda orientale dell’Adriatico sia divisa tra l’Austria e la Serbia, stabilendo così un equilibrio a tre che renderebbe l’Italia padrona della situazione. Un’Austria ridotta alle province ceche, tedesche, ungheresi e croate e riordinata in modo che tutte le popolazioni possano avere la propria autonomia sarebbe un prezioso elemento di equilibrio contro gli slavi del sud e i tedeschi che altrimenti eserciterebbero una forte pressione sul Tirolo, tendendo a Venezia e a Trieste. 72 «Pagine libere»: la voce del sindacalismo rivoluzionario interventista (1914-1915) Oltre a queste ragioni per cui gli italiani devono entrare in guerra, ce ne sono delle altre per cui i sovversivi devono partecipare a quello che è un grande conflitto di razza, «paragonabile soltanto alla conquista romana e all’invasione barbarica», e siccome il principale ostacolo alla fratellanza tra le razze «civili» è proprio il predominio di una sull’altra, «è dovere della razza latina difendersi contro l’aggressione dei teutoni che già serbano il predominio, e non lasciarsi difendere dalla razza slava, col pericolo di sostituire l’una all’altra egemonia»22. Schiacciare il militarismo prussiano è fare il bene della razza tedesca, con la quale bisogna coltivare per il domani un’amicizia fraterna ed averla al fianco contro un eventuale militarismo russo. Rocca ritiene inoltre «scandaloso che un popolo, il quale ha ricevuto la libertà nel 1796 dagli straccioni di Napoleone I, l’unità del 1859 dagli zuavi di Napoleone III, la Venezia dai prussiani e la pace in Libia dal grazioso intervento degli staterelli balcanici, debba ricevere anche oggi il Trentino con un ignobile mercato uso 1866, ad eccezione che vogliamo rassegnarci a rimanere anche domani servi della Germania, accampata formidabilmente a 25 chilometri da Verona»23. Il posto dell’Italia è contro gli Imperi centrali che sono la negazione vivente del diritto delle nazioni e al fianco della Francia e del Belgio con cui è ipocrita simpatizzare se ci si rifiuta di muovere un dito per salvarli, «sebbene la Francia sia la patria morale di tutto il proletariato rivoluzionario, come Atene lo fu della libertà greca contro Sparta». Inoltre in un’Europa, sostiene Rocca, come quella attuale in cui le guerre non si fanno e non si faranno più senza il consenso dell’opinione pubblica, porsi nel momento critico al fianco della Francia significherebbe riprendere le tradizioni dell’«egoismo illuminato di Cavour» culminanti nell’intervento in Crimea. Insomma, i sovversivi italiani devono spingere il loro governo ad intervenire perché la neutralità condurrà il Paese al disonore e alla vergogna del nostro proletariato di fronte a quelli delle altre nazioni. Una guerra imposta dalla volontà popolare susciterebbe rispetto anche presso lo straniero, tanto più che «noi sovversivi non abbiamo nessuno dovere di riguardi verso quell’Austria che mai ne ebbe e non ne avrebbe per noi, né verso quella Germania che ci impose l’entrata nella triplice attraverso un ricatto ignobile sulla questione romana, che si dichiarò pronta a favorire il ritorno dei Borboni in caso di repubblica, e che fu l’ispiratrice della politica reazionaria di Umberto I». I sovversivi, «negatori di una civiltà capitalistica che riduce l’individuo ad un automa armato o ad uno strozzino pacifista», devono «ricordarsi che il sov73 Stefano Fabei versivismo si suicida quando vuol andare contro il sentimento proletario in nome dei dogmi che la realtà ha sconfitto, e ricordare al proletariato che i popoli risorgono spesso dalle sconfitte più terribili, ma non dagli abissi dell’indipendenza, della viltà e del disonore»24. Armando Pietroni del Sindacato ferrovieri ritiene che «il trionfo della Germania e dell’Austria significherebbe il ritorno al passato, cioè all’imperialismo e al militarismo, e perciò intralcio di ogni movimento operaio. Se non ve ne fossero altri, basterebbero questi motivi perché l’Italia intervenisse nel conflitto»25. Contro il socialismo pacifista, reazionario e conservatore, per la guerra rivoluzionaria del sindacalismo volontaristico e imperialista Di seguito all’inchiesta, sulla rivista appare un altro articolo degno di attenzione, Salutatemi i pacifisti, in cui si fa notare polemicamente come il manifesto del partito comunista fosse un vero inno di guerra, un appello allo scontro civile anche attraverso i conflitti nazionali, e come Marx e Bakunin, i rappresentanti delle due maniere originali del nuovo socialismo fossero antipacifisti. «Il solo originale assertore di un socialismo nazionale in Italia, comunalista e libertario, conforme alla nostra indole e alla nostra storia, Carlo Pisacane, fu uomo di guerra ed ebbe una concezione quasi bakouninistica del movimento sociale. Il più grande aderente sentimentale dell’Internazionale, Garibaldi, non rifiutò mai la spada alle battaglie dei popoli»26. L’autore dell’articolo muove un duro attacco ai pacifisti, «codesti pericolosi utopisti, che avrebbero meritato l’internamento nel manicomio», considerati tra i principali artefici della guerra: «essi ci hanno stomacato di retorica, hanno rimbecillito i popoli con la vuota predicazione verbosa della impossibilità della guerra, ed hanno creato uno stato d’animo artificioso che ha impedito le sole risoluzioni violente che ci potevano salvare dalla guerra […]. Ricordate? Ci sentivamo ripetere ogni giorno che la guerra era ormai impossibile, che tutti i governi tremavano innanzi alla tragica responsabilità di provocarla, che l’Europa si avviava alla Federazione, che i conflitti internazionali si sarebbero composti negli arbitramenti […]. E quando la guerra venne, i pacifisti corsero a rifugiarsi in cantina, e se avessero un briciolo di dignità umana dovrebbero andare a nascondersi in un buco, sì che nessun uomo più avesse a vedere la loro faccia. Propongo un domicilio coatto perpetuo per i pacifisti e per i professori di diritto internazionale. Per gli uni e per gli altri non c’è più posto nell’Europa del 1914 […]. Il pacifismo è 74 «Pagine libere»: la voce del sindacalismo rivoluzionario interventista (1914-1915) la più grande menzogna con al quale siano stati turlupinati i popoli […] è la dottrina del chi ha avuto ha avuto, sta in contrasto alle rivendicazioni nazionali che sono la necessaria tappa di passaggio innanzi alle rivendicazioni sociali. Il pacifismo è inoltre per eccellenza una dottrina reazionaria e conservatrice perché da una parte pretende mantenere le oppressioni nazionali etniche e linguistiche, dall’altra per il ritardo delle logiche e necessarie soluzioni di codesti problemi imminenti, automaticamente tende a ritardare le soluzioni rivoluzionarie dei conflitti sociali. Il pacifismo sta ai problemi internazionali presso a poco come le teorie delle armonie sociali stanno alla questione sociale. È un’utopia pericolosa in ritardo di tre quarti di secolo. Ben altro era lo spirito del movimento della pace quando lo agitavano uomini di spada e di sommossa come Mazzini, Bakounin e Garibaldi. La pace era concepita non come fine a se stessa, non come lo statu quo dell’ingiustizia e della tirannide, ma come radiosa meta dopo il trionfo della giustizia etnica [sic] e della giustizia sociale […]. Noi siamo stanchi del tapis roulant del partito socialista e lo mandiamo a dormire insieme coi pacifisti, con la democrazia, con tutte le altre marionette della vecchia commedia politica. Aria, aria, vogliamo; anche tra il fumo acre della polvere e degli esplosivi ad alto potenziale che non ci tolgono il senso e la vista della realtà. Solo il sindacalismo volontaristico ed imperialistico, in altri termini il sindacalismo che se ne infischia, potrà non uscire sconfitto dalla grande guerra europea27. Il 20 ottobre 1914, intanto, la direzione del Partito socialista pubblicava il secondo manifesto in favore della neutralità assoluta e proprio con un violento attacco a questo manifesto, e al Partito socialista in generale, si apre il secondo numero di «Pagine Libere». Olivetti definisce tale documento «la predica di un prete pederasta» e accusa i socialisti di negare il fatto nazionale nel momento stesso in cui esso travolge i partiti socialisti di tutto il mondo: «ma per i nostri Papiniani tutti sono ammattiti. Solo il Partito socialista italiano conserva la testa a posto, fuori dal sospensorio. Esso è il depositario della vera internazionale, la casta vestale che salva il fuoco sacro, tra lo scrosciar della tempesta». Il direttore della rivista sfida «tutti gli asini laureati in marxismo [...] che non hanno mai letto Marx [...] a indicare i principi in nome dei quali si fanno traditori della patria. […]. Invocano il marxismo e non sanno, i quadruplici analfabeti, che Marx disse il contrario di loro, giustificò tutte le guerre di rivendicazione nazionale e nella “Questione d’Oriente” profetò il grande e definitivo assestamento delle nazionalità»28. I socialisti italiani identificano la loro dottrina col pacifismo «mentre il socialismo sorse come Cristo a portare agli uomini non la pace, ma la guerra, guerra feconda di bene e di libertà, non una pace tesoriera di tirannide. Privi di senso storico, per ignoranza e per fanatismo 75 Stefano Fabei beota, da frasi zoccolanti, sono incapaci non pure di comprendere la storia ma di vederla in azione sotto i loro occhi. Anzi chiudono gli occhi per rifiutarsi di vedere, per il timore che la vita sia diversa dallo schema convenzionale che è l’allucinazione rabbiosa della loro ottusità mentale. Parlano come i preti, scomunicano come i preti, sentono come i preti»29. Secondo Olivetti i socialisti si contraddicono grossolanamente perché da un lato – ritenendo che esistano solo il proletariato e la borghesia – negano il fatto nazionale, «l’individuo nazione», dall’altro dicono di provare simpatia per alcuni dei belligeranti. Ritiene inoltre artificiosi il voler distinguere tra guerra difensiva e guerra offensiva («in una guerra difensiva non persiste forse più l’antagonismo di interessi tra borghesia e proletariato?») e il continuare a ritenere, arbitrariamente e contro ogni evidenza, che borghesia e proletariato siano sempre e comunque contrapposti, soprattutto in un momento in cui ogni singola borghesia, in perfetto accordo con il rispettivo proletariato nazionale, si scaglia contro le altre borghesie e gli altri proletariati. E se la nazione non esiste, si chiede Olivetti, che senso ha la difesa del territorio nazionale? «La nazione insomma, o c’è o non c’è. O c’è, ed allora ha tutti i diritti di difesa e di offesa che la sua esistenza comporta. O non c’è, ed allora perché opporsi, putacaso ad una nuova dominazione austriaca in Italia?»30. Insomma, perché lottare contro un padrone che viene a sostituirne un altro? Il Partito socialista, «perduto ogni contatto con l’istinto della stirpe, in un furore iconoclastico senza grandezza, perché pavido di arrivare alle ultime conseguenze [...] chiude gli occhi davanti alla realtà». La conclusione cui perviene il direttore della rivista è che il capitalismo non è ancora uniformemente diffuso nel mondo, che vi sono squilibri di sviluppo che gli impediscono di essere un tutto compatto e che qualcosa di extraeconomico esiste ancora, la lingua, il costume, la cultura, che danno forma e contenuto alla nazione, che ci sono ancora oppressioni da nazione a nazione e che la lotta per la integrale libertà umana non è solo la lotta per la redenzione del salariato. La lotta per l’emancipazione operaia potrà avere inizio solo dopo il raggiungimento del «naturale assetto» delle nazioni: «Chi irride e nega il valore etico ed il valore sociale di tali lotte legittime e sante, o vive nelle nuvole o è schiavo di un dogma più gretto di quello delle religioni rivelate, o mente in mala fede sotto la spinta di un ben altro interesse di capeggiamento politico». Questa realtà secondo Olivetti è rappresentata dall’effettività del concetto di nazione, infatti la verità è che il capitalismo non è ancora uniformemente diffuso nel mondo, che vi 76 «Pagine libere»: la voce del sindacalismo rivoluzionario interventista (1914-1915) sono squilibri di sviluppo che gli impediscono di essere un tutto compatto e che qualcosa di extraeconomico esiste ancora, la lingua, il costume, la cultura, che danno forma e contenuto alla nazione, che ci sono ancora oppressioni da nazione a nazione e che la lotta per la integrale libertà umana non è solo la lotta per la redenzione del proletariato. Tutto questo hanno sentito i singoli proletari e ognuno lotta per la conquista delle libertà elementari. E solo dopo aver raggiunto il naturale assetto delle nazioni potrà incominciare la vera lotta per l’emancipazione operaia31. I sindacalisti rivoluzionari pervengono quindi al convincimento che la nazione è una realtà da cui non è possibile prescindere in nome di astratte teorie anche perché la stessa determinazione di identità del proletariato non si definisce solamente sulla base dell’appartenenza di classe, ma anche sulla base di un’appartenenza territoriale, nella quale il concetto di terri torio rimanda a una pluralità di fattori non solo geografici, ma etnici, culturali e determinati dai costumi e dalle tradizioni. Da un certo punto di vista si potrebbe dire che l’affacciarsi di queste problematiche comporta il diluirsi degli elementi distintivi fra sindacalismo e nazionalismo, tuttavia resta, fra questi, la differenza fondamentale rispetto al fine ultimo da raggiungere, a guerra finita, nel senso che per i sindacalisti l’affermazione piena del concetto di nazionalità e quindi di compiuta indipendenza nazionale è solo una tappa della più generale lotta per l’emanci pazione operaia. A fianco di Mussolini Nei confronti del direttore dell’«Avanti!» i sindacalisti rivoluzionari non hanno, per lo meno inizialmente, una grande simpatia, nonostante i rapporti cordiali esistenti fra lui e alcuni di loro, soprattutto Corridoni. D’altra parte «Pagine Libere» non potrebbe certo consentire alle posizioni di Mussolini anche quando quest’ultimo passa dalla posizione della neutralità assoluta a quella della neutralità attiva ed operante; tuttavia Olivetti e altri sindacalisti mettono in atto, nei confronti del leader socialista, una strategia avvolgente, in qualche maniera intuendone i possibili ampi margini di evoluzione politica. In questo senso su «Pagine Libere» viene scritto che Mussolini è «uomo che pensa onestamente e generosamente» ma ha ancora paura di farsene accorgere e intanto autorizza, sotto il suo nome, la campagna di «tutti i gaglioffi, di tutti gli imbelli, di tutti gli austriacanti del 77 Stefano Fabei cosiddetto proletariato [ma] sarebbe ancora in tempo a compiere un gesto virile da romagnolo autentico, sprezzante di ogni opportunismo, con un atto di coraggio e di fede»32. Nello stesso numero della rivista un corsivo annuncia che Mussolini ha dato le dimissioni da direttore dell’«Avanti!», con le motivazioni che egli «non si sentiva più di far opposizione alla guerra. Con questo gesto il Mus solini ha riscattato le sue colpe, ha lasciato trionfare la metà migliore di se stesso. Ma non si è liberato dalle gravissime responsabilità che ha incontrato nel periodo precedente le dimissioni». Mussolini è quindi invitato a esprimere una dichiarazione pubblica chiarificatrice del proprio pensiero. Intanto, passato in un breve lasso di tempo dalla neutralità assoluta a quella vigilata, il leader socialista inizia il 15 novembre a pubblicare «Il Popolo d’Italia», destinato a diventare un acceso manifesto interventista. Ben presto si stringono pertanto intorno a lui non solo i socialisti usciti dal Partito perché favorevoli all’intervento, ma anche alcuni riformisti, anarchici, repubblicani, «vociani» e sindacalisti rivoluzionari. Di questi ultimi Ottavio Dinale entra nella redazione del quotidiano, mentre ne divengono collaboratori e corrispondenti, insieme a Giuseppe Prezzolini, Sergio Panunzio33 e Agostino Lanzillo che nel suo libro, La disfatta del socialismo, racconta in modo efficace il processo mentale che portò i sindacalisti a essere sostenitori di una guerra intesa come un anticipo della rivoluzione34. Secondo Lanzillo35 nella società si accumula con costante periodicità una quantità di energie che necessariamente scoppiano determinando una rivoluzione o una guerra. Dal momento che sul piano sociale, a causa del tradimento riformista e borghese, non ha avuto luogo lo scontro tra la borghesia e il proletariato, la tensione accumulata scoppia a livello internazionale con il conflitto tra le nazioni. Lanzillo ritiene quella in corso una guerra anticapitalisica che trasformerà il mondo in maniera radicale, profonda e imprevedibile, da cui nascerà un nuovo tipo di società, diversa da quella precedente nella sua organizzazione, nelle sue finalità, nella sua struttura economica, morale e politica. Tra la componente mussoliniana e quella anarco-sindacalista nel campo dell’interventismo rivoluzionario italiano va progressivamente rafforzandosi la comunanza di idee e di obiettivi. I sindacalisti […] come i mussoliniani vedevano nella guerra un fatto rivoluzionario, accentuavano tale carattere e si proponevano di far leva sugli effetti che una prova di 78 «Pagine libere»: la voce del sindacalismo rivoluzionario interventista (1914-1915) tal genere non avrebbe potuto non esercitate sugli italiani. I primi soprattutto, che miravano a promuovere, non solo in linea teorica, il massimo sviluppo della potenzialità economica del capitalismo, perché tale maturazione doveva generare la nuova società proletaria, considerarono l’imminente lotta militare un utile strumento di addestramento del proletariato – non intorpidito da un relativo benessere e dalla pace esterna ed interna – alla prova suprema che lo attendeva. In pratica, non solo veniva stabilito un nesso costante tra la prosperità di un paese e la sua capacità militare, ma l’esercizio e lo spiegamento di questa capacità nella guerra internazionale miravano per essi, ad un tempo, a difendere quella prosperità e a preparare l’avvento del nuovo regime di classe. Tutto questo spiega la saldatura operata, per la guerra, fra capitalismo borghese e «imperialismo operaio»; spiega inoltre l’atteggiamento di forti gruppi operai, sfuggiti di mano all’organizzazione del socialismo pacifista, e la loro alleanza con la borghesia del capitalismo industriale e del nazionalismo irredentista36. Sul secondo numero della rivista di Olivetti compaiono altre risposte alla Inchiesta sulla guerra da parte di Decio Papa, Alfredo Pondrelli, Mario Alonge Park. Pur essendo fra i firmatari del manifesto del Fascio rivoluzionario, Decio Papa si rivela abbastanza cauto proclamando un in terventismo che possiamo definire soprattutto di «difesa preventiva», temendo che un’eventuale vittoria militare degli imperi centrali potrebbe costituire la condizione per una loro futura aggressione nei nostri confronti. Pondrelli più che altro esprime condanna nei confronti della diplomazia italiana, mentre Alonge Park, con prosa enfatica, si unisce ai pochi che nel campo sindacalista fanno proprie le istanze irredentistiche: «vogliamo che su tutta la costa triestina sventoli il tricolore, su Trento, in Istria [...]. Ricordiamo ciò che fece patire Cecco Beppe ai nostri padri...!»37. Ai temi dell’irredentismo apre anche Olivetti, affermando che tutta l’Italia anela di compiere i fati della Nazione, e scendere in campo per la causa della civiltà contro quella della barbarie. Non vogliamo conquiste territoriali, ma compiere l’opera fatale dell’unificazione della nazione e della stirpe. E se non sarà ora non lo sarà mai più. La storia non si ripete […] Per compiere l’opera dei nostri padri occorre che Germania ed Austria insieme siano domate al suolo, e questo può avvenire ora, se no non avverrà più mai […]. Una soluzione del problema adriatico senza il nostro intervento vorrebbe dire gli slavi padroni del nostro mare, in eterno, la soffocazione definitiva verso l’Oriente: quello sarebbe davvero il pericolo slavo […]. Il dovere dell’Italia nell’ora presente è di attaccare, il più presto possibile, il nemico ereditario. Altrimenti il nemico attaccherà noi e ci troveremo allora a doverci difendere nelle più tristi condizioni.[…]38. Con Olivetti si schierano Umberto Bianchini e Edoardo Malusardi, 79 Stefano Fabei intervenendo nel terzo numero della rivista. Per il primo l’Italia, in quanto «culla della latinità» deve scendere in campo per difendere i vincoli di fratellanza che ci legano alla Francia sulla base della comune appartenenza alla medesima civiltà. Malusardi, anarchico milanese, si dichiara favorevole all’intervento per varie ragioni: dal punto di vista antireligioso poiché il trionfo delle armi tedesche sarebbe anche il trionfo del clericalismo e del papato; per un senso di umanità, perché l’intervento dell’Italia provocherebbe il rapido termine del conflitto; dal punto di vista internazionalista perché l’internazionalismo è da concepire come unione solidale di tutti i popoli contro gli aggressori e in questa contingenza è ovvio che siano i tedeschi gli oppressori; perché una vittoria dei popoli alleati, se avvenuta per volontà fattiva del proletariato, significherebbe la debilitazione del militarismo, risolverebbe l’assillante problema delle nazionalità che inceppa il diffondersi delle idee di lotta di classe [...] e sarebbe il fallimento della politica savoiarda eternante un vassallaggio obbrobrioso verso gli imperi della reazione39. Infine, nel dibattito provocato dall’inchiesta promossa da Olivetti, interviene Filippo Corridoni che esordisce con argomentazioni – che suonano anche come autocritiche – tese ad evidenziare l’assenza pressoché assoluta di intuito politico da parte di quasi tutti i sovversivi: Era diventato un dogma credere che le guerre di conquista in Europa fossero diventate impossibili perché nessun governo le meditava e nessun popolo le avrebbe tollerate. Invece vi erano governi che si preparavano da lunghi anni a guerre della più sfacciata rapina e popoli, anzi proletariati, che alla loro volta erano pronti a subirle e forse a secondarle. I proletari della Germania hanno dichiarato di essere prima tedeschi e poi socialisti. Ecco uno stato d’animo che noi dovevamo conoscere e almeno intuire e che invece abbiamo ignorato o trascurato. Ed è stato in base a questa ignoranza o leggerezza che noi rivoluzionari abbiamo accolto come parte integrante della nostra dottrina e della nostra azione l’herveismo che, se dapprima fu semplice tesi dialettica alle esagerazioni di patriottismo scemo, divenne poi in noi la convinzione assoluta e, più ancora, pietra di paragone delle convinzioni altrui. Vi è stato un tempo in cui l’herveismo era il lasciapassare indispensabile a ogni sovversivo che volesse entrare in gruppi rivoluzionari. Ora, con la guerra, quell’herveismo è caduto per non più risorgere. Resta ancora un herveismo, più serio e più ragionato, ed è quello che servirà da base alla nuova Internazionale dei Lavoratori. Lo sciopero generale insurrezionale in caso di guerra – herveismo – che dovrebbe essere l’alfa e l’omega di ogni associazione internazionale dei lavoratori, deve essere accettato da tutte le organizzazioni aderenti, con il patto supplettivo che se una d’esse mancasse fede e s’associasse al suo governo per una 80 «Pagine libere»: la voce del sindacalismo rivoluzionario interventista (1914-1915) guerra di aggressione, il proletariato di tutte le altre nazioni dovrebbe costringere il suo governo a schierarsi contro la nazione assalitrice. Ché se l’herveismo dovesse essere fatto solo da me, se solo io dovessi disarmare mentre il mio vicino di casa affila le armi per spezzarmi, io sarei un pazzo e un balordo. In altre parole, l’herveismo applicato solo parzialmente darebbe la nazione più sovversiva in balia di quella più reazionaria40. Circa le responsabilità dello scatenamento della guerra Corridoni non ha dubbi: «La guerra attuale è stata voluta dall’Austria per una ragione di esistenza, dalla Germania per una ragione di conservazione, dalla Russia per una ragione di orgoglio. In ogni modo il pomo della discordia è l’Austria. È essa che da un secolo scatena guerre in Europa. Finché l’Austria non sparirà fomenterà altri motivi di guerra. Essa è l’amalgama di nove popoli […]. Il problema austriaco, che è poi quello delle nazionalità, deve essere risolto se davvero si ama che l’Europa non sia flagellata da altre guerre. Ebbene, quale occasione migliore di questa per imporre la soluzione? E ciò anche nel nostro interesse di appartenenti alla classe proletaria»41. Quanto all’Italia, dice Corridoni, deve intervenire nel conflitto: Parlo della nostra Italia, ché quella borghese sta dando un tale disgustoso spettacolo di vigliaccheria da non trovare l’esempio nella storia. Ma già: L’Italia si è fatta pitoccando e approfittando delle disgrazie altrui. E Casa Savoia era quella che ci voleva per una Italia siffatta. La Lombardia gliela hanno conquistata i Francesi; il Meridion[al]e Garibaldi; il Veneto lo ebbero dopo Sadowa, in compassione delle botte prese a Custoza ed a Lissa; a Roma ci andarono a pedate nel sedere, ma dopo Sédan; Trento e Trieste, anch’esse, le avranno dai… Russi. Ma meglio così, per la resa dei conti. Noi, però, abbiamo delle ragioni nostre: oggi si giuoca sui campi d’Europa la libertà dei popoli. E come faremmo una rivoluzione per avere un governo liberale al posto di uno reazionario, così dobbiamo propugnare la guerra per avere un’Europa democratica invece che... tedesca42. Per la guerra delle nazionalità, contro l’internazionale del sacro romano impero sotto la dominazione teutonica Nell’editoriale dal titolo Parole chiare Olivetti sottolineava l’importanza del compito che il momento richiedeva, quello di unire l’idea di nazionalità, «emersa spaventosamente tenace e ricca di creazione, dalla guerra» con l’internazionalismo apparentemente sconfitto ma prossimo a risorgere forse ancor prima della fine del conflitto. L’internazionale, che è miseramente fallita, aveva di mira l’homo oeconomicus non occupandosi minimamente 81 Stefano Fabei del fatto nazionale. Questo, però, era tutt’altro che morto, come la guerra stava tragicamente a dimostrare. Il distacco dell’operaio non era avvenuto che in maniera del tutto teorica e i partiti socialisti, pur negando la nazione, erano sorti su base strettamente nazionale: «Essi mirarono all’homo politicus. L’internazionale ebbe in sospetto il partito. Ma il partito vinse e ci condusse alla situazione presente»43. Olivetti attacca il partito per la sua intransigenza pacifista sostenendo che Marx, come ogni vero rivoluzionario deve essere, non fu mai intransigente; è il fine quello che conta non il mezzo con cui lo si ottiene. Intransigente è solo il dottrinario politico e «l’intransigenza fu polvere negli occhi per i gonzi, entro i confini dello Stato: è l’atteggiamento di un partito, non la disciplina di una classe. La costituzione dei partiti socialisti segnò la nazionalizzazione della classe operaia. Pretendere con ciò di far rivivere l’Internazionale era un assurdo, una petizione di principio. Fu costituita una nuova Internazionale di cartapesta, che naturalmente doveva sfasciarsi al primo urto coi fatti»44. La classe operaia dei Paesi più evoluti, di fronte all’immane sfascio di tutto un mondo, ha saputo scegliere la sua via: «Poiché l’internazionale non c’è più, ed un interesse universale della classe operaia non c’è ancora, ognuno riprenda il suo posto nello Stato singolo cui appartiene. Così pensarono ed operarono i rivoluzionari di Francia, del Belgio, d’Inghilterra, di Russia. E si gettarono a corpo morto nella terribile guerra. La quale potrà essere di liberazione se riuscirà ad infrangere la forza dello Stato tedesco e quella del partito socialista tedesco, il quale voleva, sì, ricondurci ad una internazionale, ma all’internazionale del sacro romano impero sotto la dominazione teutonica. Noi speriamo che la guerra, se avrà il suo logico svolgimento, riesca a risolvere definitivamente le questioni nazionali. E ad affermare sia il principio di nazionalità, sia la volontà internazionalistica del proletariato, noi vorremmo che ancor sotto il rombo del cannone fosse fondata la nuova internazionale»45. Questa, secondo Olivetti, dovrà essere l’unione dei sindacati operai di tutto il mondo combattenti sotto un’unica bandiera, quella della lotta di classe, con l’esclusione, in un primo momento, degli austriaci e dei tedeschi, i quali vi potranno essere ammessi solo dopo aver fatto onorevole ammenda. La nuova internazionale «riaffermando il principio di nazionalità, compirà opera di piena consapevolezza ed eviterà lo scoglio che fece infrangere la seconda internazionale e negando ogni e qualunque valore di rappresentanza di classe ai partiti socialisti politici chiuderà la triste parentesi che fu aperta con la scomparsa della prima gloriosa 82 «Pagine libere»: la voce del sindacalismo rivoluzionario interventista (1914-1915) internazionale. Il periodo dal 1871 al 1914 deve essere cancellato dalla storia del proletariato mondiale. Il sindacalismo riprenderà e farà trionfare la bandiera che il socialismo ha abbandonato nel fango e nel sangue»46. Intanto il governo italiano, che in agosto aveva ricordato a quello austriaco l’articolo del trattato della Triplice che obbligava ad accordarsi con l’alleato per le occupazioni permanenti o temporanee dei Balcani, ottenuta dalla Camera dei deputati l’approvazione per la linea seguita, poneva, ai primi di dicembre, le sue richieste di compensi territoriali all’Austria. Fare tali appelli ed entrare nei relativi negoziati significava togliere alla neutralità il carattere di scelta assoluta e definitiva. Verso la neutralità certamente non inclinava il ministro degli Esteri Sonnino che, da circa un mese, aveva preso il posto del defunto marchese di San Giuliano, bestia nera dei sindacalisti interventisti, e che non aveva fatto mistero, al momento della dichiarazione di neutralità, della sua propensione ad accogliere il partito della fedeltà alla Triplice alleanza e dell’obbligo a unirsi ad Austria e Germania. La febbre interventista continuò a salire, come risulta dall’ultimo numero del 1914 e dal primo del 1915 di «Pagine libere», dove Olivetti portava avanti la sua battaglia sottolineando «la necessità di rivedere tutti i nostri valori innanzi alla realtà grandiosa della guerra»47, e tutte le false convinzioni a cominciare da quella per cui la borghesia sarebbe sempre e comunque guerrafondaia, e desiderosa di battersi, mentre il proletariato sarebbe pacifista. Questa tesi, diffusa dal socialismo ufficiale, da pochi sindacalisti e da certi «anarchici dell’età della pietra» secondo Olivetti, è una grande bugia e chi la diffonde è un conservatore, come alcuni socialisti del Partito socialista. In Italia le classi dirigenti più alte sono contro la guerra, come tutti i conservatori sono contro la guerra, la Corte, i preti, i grassi borghesi che fanno gli affari lauti con la neutralità e ne auspicano il proseguimento. Perfino l’esercito è contro la guerra, checché ne dicano i bevitori di frasi. In Italia non c’è casta militare; gli ufficiali sono dei buoni borghesi, amanti del quieto vivere, burocratici, più che militari, malati di eccessivi affetti domestici […]. Tutto quello che vien detto in contrario è un voler far passare il proprio antagonista per un leone […]. Ed oggi vediamo da una parte tutti i conservatori, dal re all’anarchico, fatti tutti della stessa pasta, prodotti ejusdem farinae. Dall’altra coloro che anelano al nuovo, che tendono a superare, a far atto di forza, di volontà e di giustizia. E siamo noi guerrafondai, come ci chiamano gli spermatozoi del neutralismo dediti al rispetto della venere solitaria che li ha prodotti48. 83 Stefano Fabei Olivetti invoca la fine della «sconcia» commedia che fa passare per rivoluzionarismo quello che lui ritiene essere il più gretto, avaro e pigro spirito di conservazione. Costoro cianciano di internazionalismo che non c’è (in Italia si è internazionalisti non perché sia stato superato il concetto di nazione, ma perché non ci si è ancora arrivati e ci si trastulla ancora nel più arretrato campanilismo) di socialismo che non si sa più che bestia sia, di anarchia che ha perduto i denti, di una quantità di principi ai quali nessuno più crede, e negano la vita perché vogliono conservare il silenzio e la quiete, favorevoli alle pacifiche digestioni. Un po’ di guerra, ma fatta sul serio, ci libererà […] da tutte le maschere del teatro nazionale dei burattini, neri o tricolori, o rossi scarlatto, ma tutti fatti di cartapesta e tutti mettenti capo ad un filo, col quale una mano misteriosa li agita per i suoi fini, imperscrutabili come quelli della divina provvidenza. Noi attendiamo dalla guerra la fine della politica e l’inizio della purificazione nazionale. Per questo noi, ai quali piace l’aria libera e l’acqua corrente, contro tutti i conservatori invochiamo la guerra che sarà insieme nazionale e rivoluzionaria49. All’interno del fronte politico antineutralista, in rapida crescita, si mostrava particolarmente impaziente anche Arturo Labriola, uno dei maggiori teorici del sindacalismo rivoluzionario, le cui posizioni riassumono e rappresentano, al massimo livello di lucidità e realismo politico, la complessità degli elementi del dibattito e dell’agitazione del sindacalismo interventista50. Per Labriola si tratta di compiere l’ultima impresa nazionale che porterebbe a compimento il Risorgimento sottraendo l’Italia all’egemonia dell’Austria. Se Labriola vuole il rovesciamento delle alleanze e l’appoggio delle potenze dell’Intesa, è altrettanto chiaro nell’enunciare il motivo che lo spinge ad avvicinarsi alla Francia e all’Inghilterra: il rifiuto della politica imperialistica della Germania, mentre si dimostra più realista di molti suoi compagni a proposito del giudizio sulle nazioni alleate. Così, infatti, argomenta in un discorso pronunciato il 4 dicembre alla Camera dei deputati: Io non ho nessuna voglia di figurarmi l’Inghilterra padrona dei mari e delle più ricche colonie del mondo, in veste di angelo sterminatore della nequizie umana. lo non mi immagino punto la Francia come il messaggero della libertà e della democrazia nel mondo. Ammetto volentieri che questi stati facciano la politica dei loro interessi e non siano affatto disposti a fare una rinuncia per amore della giustizia internazionale. Ma io mi pongo sul terreno dei fatti e contrastando la grande moderazione con la quale l’Inghilterra ha sempre esercitato il suo imperio e la limitata potenza di sviluppo della 84 «Pagine libere»: la voce del sindacalismo rivoluzionario interventista (1914-1915) Francia, io non ho nessuna ragione di temere di esse. La Germania no. I teorici della superiorità della razza germanica sulle altre razze non sono come i futuristi nostri, degli allegri compari che stampano tutto quello che frulla loro nel cervello; ma sono la legittima e diretta espressione della coscienza germanica. Treitscke e Lagarde, Wilser e Houston Chamberlain, Mommsen e Schliemann rappresentano il fiore dell’intelligenza e della cultura germanica. Ora, quando uomini come questi proclamano la superiorità del germanico su tutti gli altri uomini, io che sono un mediterraneo mi ribello finché posso e pensando che dietro i pensieri ci sono gli obici da 420 mi preparo alla resistenza51. Per Labriola il socialismo doveva essere considerato pacifista soltanto nel caso in cui si fosse realizzato come società universale; il pacifismo era un punto non di partenza bensì di arrivo. Corridoni, che sarebbe morto sul Carso nell’ottobre del 1915, ai compagni che lo accusavano di incoerenza e di essersi allontanato dalla giusta via ribatteva: «Queste nostre idee cozzano con i nostri principi? Niente affatto. Siamo più che mai nella più pura ortodossia. E poi il sindacalismo non ha sempre rivendicato il diritto ad essere eretici?»52. Note al testo 1 L’Usi era nata per iniziativa dei sindacalisti rivoluzionari e degli anarchici usciti dalla CGdL, che accusavano di essere intrisa di «confessionalismo politico», di «centralismo autoritario» e di «involuzione burocratica». La scissione avvenne nel congresso di Modena del 23-25 novembre 1912, soprattutto per volontà di Tullio Masotti e Amilcare De Ambris che invitarono i rivoluzionari del partito ad abbandonare il «bagaglio riformistico». Secondo loro occorreva sottoporre a revisione il ruolo del socialismo nella fase che stava attraversando lo scontro sociale e sostenere il sindacato rivoluzionario. La mozione di De Ambris raccolse oltre 42.000 voti, mentre quella presentata da Ines Bitelli, contraria all’uscita dalla CGdL, ne ricevette quasi 29.000. Dopo l’approvazione dello statuto e l’elezione del comitato centrale della neonata Unione sindacale italiana, i delegati approvarono anche una mozione di Filippo Corridoni in cui veniva ribadito che solo con la più assoluta e rigorosa lotta di classe, portata avanti dal sindacato di mestiere, il proletariato avrebbe potuto conquistare la libertà dal capitale. Quali transitori strumenti di lotta sindacale erano riconosciuti lo sciopero di categoria, il boicottaggio e il sabotaggio, mentre lo sciopero generale era ritenuto l’unico mezzo efficace e idoneo per la definitiva espropriazione della classe borghese. 2 G. B. Furiozzi, Il sindacalismo rivoluzionario italiano, Milano 1977, p. 58. 3 Fondato nel 1907, «L’Internazionale», diretto da Alceste De Ambris, aveva oltre all’edizione parmense quelle per Bologna, Milano e Modena. 4 Gustave Hervé (Brest 1871- Parigi 1944). Politico francese inizialmente su posizioni antimili- 85 Stefano Fabei tariste e antiborghesi, nel 1905 entrò nel Partito socialista unificato (SFIO) schierandosi con l’estrema sinistra. Per molti aspetti vicino a Sorel e ai sindacalisti rivoluzionari, fu tra i fondatori del periodico «La guerre sociale» che diresse fino alla prima guerra mondiale quando si convertì al «socialpatriottismo», fondò il giornale «La Victoire» e divenne sostenitore della guerra a oltranza. 5 Alceste De Ambris (Licciana di Pontremoli 1874 – Brive, Francia 1934). Proveniente da un’agiata famiglia, fu dirigente sindacale e militante socialista fin dalla fondazione del Partito socialista. Nel 1903 divenne un attivo esponente del sindacalismo rivoluzionario. Direttore di «Gioventù socialista» e de «L’Internazionale». Organizzatore di scioperi, tra il 1903 e il 1908 fu segretario delle camere del lavoro di Savona e di Parma. Nel 1908, dopo uno sciopero nel Parmense, emigrò per la seconda volta in Sud America e quindi in Svizzera. Contrario alla guerra di Libia nel 1911, fu tra i fondatori dell’Usi. Deputato nel 1913, l’anno successivo si dichiarò a favore dell’intervento e fu volontario. Nel 1919 si avvicinò ai fasci di combattimento; capo di gabinetto di D’Annunzio a Fiume, nel 1920 redasse la Carta del Quarnaro. Dal 1920 si allontanò sempre più da Mussolini e dal fascismo e dopo la marcia su Roma emigrò in Francia dove operò fino alla morte come giornalista e propagandista. Fratello di Amilcare De Ambris, durante il fascismo esponente della Confederazione dei lavoratori dell’industria. 6 Vedi a proposito S. Fabei, Guerra e proletariato, 1914: il Sindacalismo Rivoluzionario dalla neutralità all’interventismo, Milano 1996, pp. 109-120. 7 G. B. Furiozzi, Il sindacalismo rivoluzionario italiano cit. 8 Filippo Corridoni (Pausala, Macerata 1888 – Carso 1915). Politico e sindacalista rivoluzionario seguace delle idee di George Sorel, entrò presto in contrasto coi dirigenti della CGdL entrando nell’Unione sindacale italiana (1913). Nel giugno 1914 partecipò alle agitazioni della «settimana rossa». Fautore dell’interventismo rivoluzionario si accostò a Mussolini. Volontario, morì sul fronte del Carso. 9 Angelo Oliviero Olivetti (Ravenna 1874 – Spoleto 1931). Di famiglia borghese, laureato in giurisprudenza, ancora studente si iscrisse al Partito Socialista Italiano e iniziò una intensa attività di pubblicista e organizzatore nelle file del sindacalismo rivoluzionario in Italia e in Svizzera. Fu favorevole alla guerra di Libia e interventista nel primo conflitto mondiale. Nel primo dopoguerra fu vicino alla UIL e dopo il delitto Matteotti si avvicinò a Mussolini e al fascismo diventando collaboratore de «Il Popolo d’Italia» nel 1924. Studioso delle problematiche sindacali, membro delle Commissioni dei Quindici (1924) e dei Diciotto (1925), sostenne la tesi del sindacalismo integrale, si dichiarò quindi favorevole alle corporazioni prendendo parte alla loro elaborazione. Accolse in modo positivo la pubblicazione della «Carta del Lavoro» ritenendola tuttavia soltanto un primo passo. Nominato nel 1931 ordinario a Scienze politiche presso l’Università degli studi di Perugia, morì poco tempo dopo. 10 Premessa a Ai lavoratori d’Italia, in «Pagine libere» (Rivista di critica, di politica e di cultura), VI, serie III, n. 1, 10 ottobre 1914, p. 36. 11 Ivi, pp. 36-39. 12 A.O. Olivetti., Ricominciando, ivi, pp. 1-4. 13 A.O.Olivetti, Europa 1914, ivi, pp. 5-6. 14 Ivi, p. 6. 15 Ivi, pp. 10-11. 16 Ivi, p. 12. 17 Edmondo Rossoni (Tresingallo 1884 – Roma 1965). Iscritto al Partito socialista, partecipa agli 86 «Pagine libere»: la voce del sindacalismo rivoluzionario interventista (1914-1915) scioperi agrari del 1903-1904. Si trasferisce a Milano dove si avvicina al sindacalismo rivoluzionario, s’impegna in battaglie antimilitariste e diventa corrispondente della «Gioventù socialista». Nel 1907, in linea con gli indirizzi del sindacalismo rivoluzionario, abbandona la Federazione per impegnarsi nelle organizzazioni della Camera del lavoro. In seguito a discorsi pubblici rivoluzionari nel 1908 viene condannato a quattro anni di reclusione e a due di sorveglianza speciale. Per sfuggire alla pena si trasferisce prima a Nizza e poi in Brasile. Nel 1910, a New York, aderisce alla Federazione Socialista Italiana. Tornato in Italia, allo scoppio della Prima guerra mondiale si schiera con l’ala interventista. Prende parte ad alcuni momenti bellici e nel 1918 fonda «L’Italia Nostra». In seguito partecipa alla costituzione della UIL di cui è segretario fino al marzo del 1919 quando lascia l’incarico per prendere la direzione della Camera del Lavoro di Roma. Nel 1922 è nominato segretario generale della Confederazione nazionale delle corporazioni sindacali, i nuovi sindacati fascisti costituitisi con il convegno di Bologna nel gennaio precedente. Si scontra con la Commissione dei Diciotto, istituita dal regime per studiare le problematiche politiche e sociali. Nel 1930, ritornato nelle grazie del regime, è nominato membro del Gran Consiglio del Fascismo e due anni dopo riveste la carica di sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Nel marzo del 1935 è nominato ministro dell’Agricoltura, carica che mantiene fino al 1939. Il 25 luglio del 1943 vota a favore dell’ordine del giorno Grandi, atto che gli costa la condanna a morte decretata dal Tribunale di Verona. Rifugiatosi dapprima in Vaticano, dopo la condanna all’ergastolo inflittagli nel maggio 1945, ripara in Canada dove rimane un solo anno. Amnistiato, fa ritorno in Italia per ritirarsi a vita privata. 18 Risposte all’inchiesta su la guerra europea, in «Pagine libere», VI, serie III, n. 1, pp. 13-16. 19 Maria Rygier, nata a Firenze nel 1884, sindacalista rivoluzionaria, nel 1907 crea insieme a Filippo Corridoni il giornale antimilitarista «Rompete le righe!». Nel 1909 passa al movimento anarchico. Il 13 agosto 1914 firma per «Il Libertario» di La Spezia La bancarotta della politica monarchica in Italia, articolo in cui, richiamandosi al Risorgimento e alla tradizione garibaldina, plaude alla fine della Triplice Alleanza, auspicando la guerra liberatrice contro gli Asburgo, i carnefici di Oberdan. Vedi a riguardo A. Luparini, Anarchici di Mussolini, Montespertoli 2001. 20 Ivi, pp. 16-20. 21 Massimo Rocca (Libero Tancredi). Figura molto controversa e poco definita della storia italiana del secolo scorso. Esponente di spicco anarchico-sindacalista, collaboratore nel 1914 dell’«Avanti!», in cui il 4 agosto pubblicò un articolo, A rimorchio dei ciechi, amputato da Mussolini del periodo conclusivo da cui emergeva un atteggiamento positivo verso l’interventismo. Dopo uno scambio di lettere con Mussolini interruppe la sua collaborazione col quotidiano socialista e con Il dovere della guerra, pubblicato sull’«Iniziativa», il 20 agosto, prese nettamente posizione a favore del conflitto e contro «l’irresponsabilità eretta a sistema» dei socialisti: «Una sconfitta tedesca significa spezzare il militarismo germanico che obbligò il mondo a tarpare le ali del suo spirito rivoluzionario per difendere la propria esistenza […] il suo crollo vuol dire un gigantesco passo sulla via della libertà e della possibilità di risolvere per lungo tempo le questioni nazionali e di razza; vuol dire creare il terreno sul quale l’emancipazione operaia potrà svilupparsi e vincere». L’assunzione di una posizione del genere da parte di Rocca non meravigliò più di tanto la sinistra in quanto già il l7 aprile del 1906 aveva pubblicato un articolo, Pacifismo, sul «Novatore Anarchico» in cui giudicava l’eventualità di una guerra «più funesta alla borghesia che al proletariato», dal momento che rappresentava «un’occasione favorevole alla rivoluzione». Nel 1911 si era espresso a favore della guerra libica. Nel dopoguerra fu un dirigente fascista fino al 1924, quando ruppe con Mussolini al quale si riavvicinò nel periodo della Repubblica sociale italiana. Sul suo percorso dall’anarco-sindacalismo al fascismo vedi A. Luparini, Anarchici di Mussolini cit. 87 Stefano Fabei 22 Risposte all’inchiesta su la guerra europea, in «Pagine libere», VI, serie III, n. 1, p. 22. 23 Ivi, pp. 22-23. 24 Ivi, p. 24. 25 Ibidem. 26 Salutatemi i pacifisti, ivi, p. 29. 27 Ivi, pp. 28-29. 28 A.O. Olivetti, Il vaso di pandora, in «Pagine libere», VI, serie III, n. 2, 30 ottobre 1914, p. 1. 29 Ivi, p. 2. 30 Ivi, p. 3. 31 Ibidem. 32 Mussolini in moratoria, ivi, p. 17. 33 Sergio Panunzio (Molfetta 1886 – Roma 1944). Socialista, sindacalista seguace di Sorel, fu redattore dell’«Avanti!» e dell’«Azione». Laureato in giurisprudenza e filosofia, è favorevole alla guerra di Libia e poi interventista. Fonda con Italo Balbo il Fascio nazionale interventista; teorizzatore della guerra rivoluzionaria collabora a «Il Popolo d’Italia». Membro della direzione nazionale del PNF dal 1924, diviene segretario generale della corporazione nazionale della scuola e membro del consiglio corporativo nazionale. Libero docente tra il 1925 e il 1927 all’università di Perugia ne è anche rettore negli anni 1926-1927. Passerà poi all’università di Roma. Deputato dal 1924 al 1939, consigliere nazionale dal 1939 al 1943, tra il 1924 e il 1926 ricopre la carica di sottosegretario alle Comunicazioni. Nel 1932 al convegno di studi corporativi di Ferrara sostiene le tesi di Ugo Spirito sulla corporazione proprietaria. Dopo il 25 luglio 1943 non aderisce alla RSI. 34 A. Lanzillo, La disfatta del socialismo, Firenze,1922. 35 Agostino Lanzillo (Reggio Calabria 1886 – Milano 1952). Conseguita la laurea in giurisprudenza a Roma si avvicina al sindacalismo rivoluzionario e dal 1908 collabora al «Divenire sociale». Ammiratore di Sorel, interventista e volontario, collabora a «Il Popolo d’Italia» e a «Utopia». Nel dopoguerra si trasferisce a Milano, aderisce al fascismo e insegna alla Bocconi. Personalità di spicco del fascismo, è deputato tra il 1924 e il 1929, anno in cui viene escluso dalle liste elettorali a causa delle sue critiche sulle nuove leggi riguardanti il sindacato. Da allora in poi si dedica agli studi e all’insegnamento universitario. Ordinario di Economia politica a Cagliari tra il 1923 e il 1934, insegna poi a Venezia dove tra il 1935 e il 1938 è anche rettore. 36 G. B. Furiozzi, Il sindacalismo rivoluzionario italiano cit., p. 63. 37 Risposte all’inchiesta sulla guerra, in «Pagine libere», VI, serie III, n. 2, 30 ottobre 1914, p. 38. 38 Ivi, pp. 37-38. 39 Risposte all’inchiesta sulla guerra europea, in «Pagine libere», VI, serie III, n. 3, 15 novembre 1914, p. 27. 40 Risposte all’inchiesta sulla guerra europea, in «Pagine libere», VI, serie III, n. 4, 30 novembre 1914, pp. 27-28. 41 Ivi, pp. 28-29. 42 Ivi, pp. 29-30. 43 A.O.Olivetti, Parole chiare, in «Pagine libere», VI, serie III, n. 4, 30 novembre 1914, p. 3. 88 «Pagine libere»: la voce del sindacalismo rivoluzionario interventista (1914-1915) 44 Ivi, pp. 3-4. 45 Ivi, pp. 4-5. 46 47 Ivi, p. 5. A.O. Olivetti, Le Armi al Popolo!, in «Pagine libere», VI, serie III, n. 5, 15 dicembre 1914, p. 1. 48 A.O. Olivetti, Menzogne, in «Pagine libere», VI, serie III, n. 6, 10 gennaio 1915, p. 4. 49 Ivi, p. 5. 50 Arturo Labriola (Napoli 1873 – ivi 1959). Intellettuale in origine repubblicano, iscritto dal 1895 al Partito socialista. Costretto tre anni dopo all’esilio in Svizzera e in Francia, subì fortemente l’influenza di G. Sorel. Tornato in Italia, dal 1900 divenne un esponente di spicco dei sindacalisti rivoluzionari e direttore di «Avanguardia socialista» (1902-1906). Uscito nel 1907 dal partito, nel 1911 si schierò a favore dell’impresa libica e nel 1913 fu eletto deputato come socialista indipendente. Interventista nel 1915, cinque anni dopo divenne ministro del Lavoro nell’ultimo gabinetto Giolitti. Espatriato nel 1926 in Francia e in Belgio, poté far ritorno in Italia nel 1935 essendosi favorevolmente espresso sulla impresa etiopica. Dopo la guerra fece parte dell’Assemblea costituente e fu senatore di diritto. 51 D. Marucco, Arturo Labriola e il sindacalismo rivoluzionario in Italia, Torino 1970, pp. 222223. 52 G. B. Furiozzi, Il sindacalismo rivoluzionario italiano cit., p. 64. 89 Armi e propaganda. «Il regime fascista» di Farinacci e la guerra civile spagnola di Francesco Corsi La guerra civile spagnola fu principalmente una guerra ideologica e come tale fu combattuta, oltre che con le armi convenzionali, anche con quelle più sperimentali della propaganda e del controllo dell’informazione. La guerra fu banco di prova per l’impiego di armamenti e tattiche militari, ma rappresentò anche un passo decisamente significativo sulla strada del controllo dell’informazione e della propaganda. Le pagine che seguono1 intendono documentare come uno dei principali organi del regime mussoliniano, il giornale «Il regime fascista», presentò ai suoi lettori quel conflitto. Si tratta di un capitolo particolare ma significativo della propaganda italiana. Una guerra, un giornale L’inizio del conflitto cadde in un periodo ricco di sconvolgimenti e rivoluzioni nel campo dei media, segnatamente per quanto riguardava il loro utilizzo e la loro disposizione verso l’opinione pubblica. Durante la prima guerra mondiale le nuove tecniche di controllo dei flussi informativi avevano avuto il loro battesimo del fuoco, svolgendo un ruolo di primissimo piano (anche se non ancora completamente definito) all’interno della politica e della strategia bellica. Gli stati, i governi e gli eserciti capirono che l’informazione andava veicolata e tenuta sotto stretto controllo non solo nei confronti dell’esterno (ciò che, in tempo di guerra, riguardava soprattutto i rapporti col nemico), ma anche verso il cosiddetto fronte interno. A questo processo concorsero tutti i mezzi di comunicazione, indistintamente: i più recenti, come il cinema sonoro o la radio, vennero sfruttati immediatamente in tutte le loro potenzialità; quelli vecchi, in primo luogo la stampa, furono potenziati e strutturati secondo un’ottica più unitaria e pianificata. La lezione servì a democrazie e totalitarismi: que91 Francesco Corsi sti ultimi in particolare fecero della propaganda e del controllo dell’informazione una delle principali armi per la creazione del consenso. In guerra come in pace, la nazione doveva parlare sempre con una voce sola. Lo scoppio della guerra civile prestò l’occasione per impiegare, in maniera maggiormente organizzata e più consapevole, tutti gli strumenti che erano stati sperimentati negli anni addietro. Questo fu possibile anche perché, obbiettivamente, sin dal suo inizio la guerra di Spagna trascese di molto i confini nazionali. Democrazia, comunismo, socialismo e anarchismo da una parte, franchismo e fascismo dall’altra rappresentarono gli attori in scena della tragedia spagnola. Il conflitto fu percepito in tutto il mondo come un immane scontro tra due idee inconciliabili di società, scenario che indubbiamente sarebbe stato confermato dalla seconda guerra mondiale. Nei giorni immediatamente successivi alla ribellione degli ufficiali nazionalisti, i media di tutto il mondo volsero lo sguardo verso la Spagna, ricercando notizie sul golpe e schierandosi per l’una o per l’altra parte. Lo sforzo di copertura delle notizie fu generalmente molto elevato, anche se non si mantenne, lungo i quasi tre anni di guerra, sempre agli stessi livelli. In ogni caso, per quanto riguardava le nazioni più direttamente coinvolte, l’attenzione per le vicende spagnole assunse un impegno praticamente continuo, anche materiale, in uomini e mezzi. L’Italia stessa sperimentò questa strada e la guerra civile fu sentita dall’intera società a causa dell’intensa campagna propagandistica effettuata dal governo di Mussolini, attraverso tutti i tipi di media a disposizione. Se la radio, essendo nel periodo del suo maggiore sviluppo, ricoprì una parte fondamentale nell’informazione più diretta e rivolta specialmente alle zone di guerra, l’impegno del regime si misurò soprattutto sull’universo della carta stampata. Di conseguenza, quotidiani e periodici dimostrarono subito un vivo interesse per i fatti di Spagna: alcuni giornali si avvalsero prevalentemente dei comunicati ufficiali dell’agenzia governativa Stefani, altri – specialmente i più importanti – inviarono sul fronte spagnolo i loro migliori corrispondenti. Per tutti la guerra di Spagna rappresentò uno dei principali argomenti riguardo a notiziabilità e copertura delle notizie, durante praticamente l’intero corso del suo svolgimento. Caso esemplare (e inspiegabilmente trascurato) di questo paradigma fu la condotta del quotidiano cremonese «Il Regime Fascista». 92 Armi e propaganda. «Il regime fascista» di Farinacci e la guerra civile spagnola Del vasto e complesso panorama della stampa italiana dell’epoca il giornale di Farinacci rappresentava la punta di diamante del giornalismo ideologico: un quotidiano violentemente polemico, aggressivo, orgoglioso di rappresentare fedelmente la natura originaria del fascismo squadrista. In questo si differenziava distintamente da giornali più affermati (come «Il Corriere della Sera» o «La Stampa») che, pur essendo da tempo fascistizzati, ancora conservavano alcune velleità di giornalismo obiettivo. «Il Regime Fascista» seguì con grande dispiego di mezzi tutta la vicenda spagnola, utilizzando – cosa piuttosto originale per un giornale delle sue dimensioni – un cospicuo numero di corrispondenti e di inviati speciali, tra cui spiccavano eccezionalmente alcune delle firme più in vista del giornalismo italiano dell’epoca, come quella del celebre reporter Sandro Sandri. La causa di un impegno tanto consistente – che superava, in proporzione, quello dei giornali italiani più conosciuti – è facilmente comprensibile: il giornalismo ideologico di Farinacci trovò nella guerra ideologica della Spagna il suo contesto naturale. In questo senso, un giornale come «Il Regime Fascista» era il miglior interprete delle esigenze propagandistiche del governo di Mussolini: lo scontro che si delineava in Spagna, e soprattutto la ricostruzione che ne doveva venir data, incontrava decisamente i favori dell’impostazione politica e giornalistica di Farinacci. La Spagna fu in qualche modo il coronamento della sua polemica contro l’antifascismo internazionale, ancora più evidente perché condotta (quasi fin da subito) su posizioni di forza e secondo le tematiche più consuete dell’immaginario fascista. Se la propaganda, la censura, ed il controllo dell’informazione raggiunsero indistintamente tutti i giornali italiani, «Il Regime Fascista» non le subì passivamente, ma ne fu semmai la voce amplificata. In altre parole, il giornale di Farinacci fu il megafono più intransigente e fedele della propaganda di regime e poté svolgere questo compito proprio in virtù della propria natura militante. Fatta eccezione per un primo e piuttosto breve periodo di assestamento giornalistico e ideologico dovuto ad una molteplice schiera di fattori (incertezza delle notizie, scarsa verificabilità della fonte, prudenza di Roma verso la comunità internazionale) il ras di Cremona cercò di spostare la barra dello scontro sul campo puramente ideologico: eliminò drasticamente le corrispondenze dalle zone repubblicane e dette spazio a quelle scritte da giornalisti che affiancavano l’avanzata delle truppe marocchine di 93 Francesco Corsi Franco; inventò rubriche a sfondo storico e sociale riguardanti le vicende del passato della giovane repubblica di Spagna; infine espose chiaramente ai lettori la propria ricostruzione di quello che ancora, negli occhielli delle corrispondenze, veniva definito «caos spagnolo»: una guerra civile provocata dall’antifascismo europeo e fomentata di lontano dall’Unione Sovietica. Un buon pretesto per schierarsi attivamente dalla parte degli insorti: La Francia, che da qualche tempo vive in uno stato di sfrenata demagogia, e si riscalda al sole di Mosca, deve aver ritenuto che sul terreno spagnolo si possa combattere una grande battaglia contro il fascismo internazionale […]. La cosa non ci dispiace, anche perché il domani è per noi pieno di seduzione e pieno di speranze […]. Più volte abbiamo detto che due forze avrebbero preso il sopravvento sulle decrepite demagogie: il Fascismo e il comunismo. Se la lotta dovesse svilupparsi su questo terreno e in questa direzione sarebbe come invitarci a nozze2. C’erano cose di cui non si poteva assolutamente parlare, l’appoggio di Berlino e di Roma al pronunciamento franchista, la presenza militare italiana al fianco dei nazionali spagnoli, e tutto ciò che poteva mettere in pericolo il tenue equilibrio di sottintesi e diplomazia tra le potenze. Il più delle volte Farinacci tacque sui fatti (e in questo rispettò la consegna al silenzio), ma dando sempre prova di un compiacimento tanto ambiguo da far presupporre chiaramente la presenza di un impegno italiano in terra spagnola; ciò che fu ampiamente confermato dalla stampa antifascista in occasione della prima grande offensiva nazionale, cui gli italiani parteciparono direttamente. Cronache di guerra, cronache di regime: l’arrivo di Sandro Sandri e la vittoria fascista di Malaga Infatti, il 17 gennaio 1937 Queipo de Llano, comandante dell’armata del sud, diede inizio ad un’offensiva nel settore circostante la zona di Malaga. La linea del fronte partiva qualche decina di chilometri sulla costa a nord di Gibilterra e si estendeva fino al centro di Motril. Questa striscia di terreno, che comprendeva Estepona, Marbella, Torremolinos e Malaga, era ancora sotto il regime repubblicano, anche se circondata per tre quarti dal territorio in mano ai nazionalisti. L’unica strada per il nord, presso Motril, era sbarrata da un’inondazione. Di fatto, quindi, la striscia di Malaga era 94 Armi e propaganda. «Il regime fascista» di Farinacci e la guerra civile spagnola un’isola repubblicana nel mare nazionale. Nei primi tre giorni dell’offensiva Queipo de Llano si preoccupò di tagliar fuori la parte più occidentale del territorio repubblicano, spingendosi fino a Marbella. In seguito, l’offensiva volse contro la zona a nord di Malaga. Questi primi due attacchi preparatori della battaglia di Malaga, «furono condotti a termine senza quasi incontrare resistenza»3. Occupato più che altro in diatribe di carattere ideologico, «Il Regime Fascista» non sembrò dare molto peso a questa prima parte dell’offensiva: liquidò la faccenda con alcuni pezzi abbastanza brevi e sempre confinati in ultima pagina4. Allo stesso modo non fece nemmeno un accenno (per ragioni più che comprensibili) alla presenza di soldati italiani al seguito delle truppe franchiste in quella zona. A nord di Malaga si erano infatti raccolti nove battaglioni motorizzati di camicie nere italiane, agli ordini del generale Roatta, «uno dei più fidati sostenitori di Mussolini nell’esercito e già capo dei servizi segreti italiani»5. Inquadrati in un corpo autonomo e non più tra le file della legione straniera spagnola, questi dovevano condurre l’attacco su Malaga, impadronirsene e volgere poi verso il nord. Nell’opinione di Ciano le truppe italiane «sarebbero risalite lungo la costa sino a Valenza» per poi «partecipare ad un attacco a Madrid» che sarebbe stato l’epilogo glorioso delle «ultime decisive offensive della guerra»6. Ora, al di là dei piani magniloquenti che avevano stregato Ciano, l’offensiva su Malaga rientrava perfettamente anche nei disegni di Franco che anzi si avvalse molto volentieri dell’aiuto italiano. In altre parole, Malaga fu la prima vera battaglia cui parteciparono, con grande dispiegamento di mezzi, le truppe italiane. La tattica adottata fu quella della «guerra celere» che consisteva nell’uso offensivo di colonne motorizzate precedute da carri veloci (e non carri armati pesanti come avveniva nella blitzkrieg tedesca). La notte del 4 febbraio iniziò l’avanzata delle camicie nere italiane e il 6 erano già alle porte di Malaga, presso l’altura che dominava la pianura circostante. La sera del 7 febbraio le truppe italiane entrarono nella periferia di Malaga. Nei giorni dell’offensiva, la disorganizzazione delle forze repubblicane ed il timore delle repressioni, uniti ad un forte scoraggiamento, determinarono una fortissima ondata di panico: «il comando supremo repubblicano, i capi dei partiti e dei sindacati e tutti coloro che avevano ragione di temere l’occupazione nazionalista si affrettarono a fuggire lungo la costa. I fortunati fuggivano a bordo delle poche auto disponibili, gli 95 Francesco Corsi altri a piedi»7. Con la presa di Malaga anche «Il Regime Fascista» riportò la guerra in prima pagina, affidando l’onore della corrispondenza a Sandro Sandri, uomo di punta del giornalismo fascista e collaboratore dei maggiori quotidiani italiani. Sandri, già comparso sulle colonne del giornale per sparute corrispondenze, delineò un sicuro salto di qualità nelle intenzioni di Farinacci. Con l’Italia impegnata sempre di più nel conflitto spagnolo, anche le cronache dei fatti dovevano adeguarsi ad un livello più alto: una firma come la sua, in questo senso, era un marchio di qualità e credibilità, almeno in ambiente fascista. Il piglio da reporter puro di Sandri non passa inosservato, fin dalle prime righe della corrispondenza: annunciava di trovarsi a Malaga, nei locali di una compagnia telefonica italiana, miracolosamente risparmiata dalla furia della battaglia. Prima ancora che il racconto inizi, i crismi dell’avventura e del pericolo ci sono già tutti. La città, raccontava, era ormai libera: La popolazione ha accolto le truppe liberatrici con manifestazioni di entusiasmo delirante […]. Il popolo sembra impazzito dalla gioia e corre incontro alle truppe piangendo e abbracciando i soldati. La cronaca dell’occupazione di Malaga ha aspetti che nell’ora febbrile che viviamo sfuggono al nostro controllo8. La popolazione di Malaga avrebbe dunque gioito immensamente, al vedere sfilare le truppe dei nazionali. La cronaca ricalcava nei toni e nelle sfumature il tema classico ma sempre coinvolgente ed emotivo della liberazione dal terrore rosso: il popolo, nella sua accezione più interclassista tanto cara a Franco e al fascismo, accoglieva i conquistatori con animo ricolmo di gratitudine e sospiri di sollievo, poiché il giogo sovversivo (che fosse repubblicano, liberale o bolscevico poco importava) era finalmente spezzato. «Il popolo, l’autentico popolo della città, – scriveva Sandri – è uscito da un incubo». La folla è nelle strade dalle 10 di stamane e nessuno pensa di mangiare oppure di riposarsi. Le truppe che non meno affluiscono in lunghe colonne dai monti dove hanno battuto il nemico sono accolte dalla moltitudine frenetica con ininterrotto getto di fiori. Nelle strade si balla e si incendiano bandiere rosse, si urlano «Viva Spagna! Viva Franco». Si improvvisano cortei preceduti da bandiere nazionali e grammofoni muniti di altoparlanti diffondono le note di dischi con gli inni della falange e della legione9 96 Armi e propaganda. «Il regime fascista» di Farinacci e la guerra civile spagnola Il ritratto di Malaga liberata è ricco di tratti accesi di vivo entusiasmo popolare. Gli altoparlanti attaccati ai grammofoni, la musica dei nazionali che invade le strade e la gente comune che accoglie col lancio di fiori le truppe di Franco sono immagini che appartengono al patrimonio antico dei trionfi. L’immagine rievocava lo stile delle parate dell’antica Roma, con le colonne di soldati accolte dalla folla e si mischiava a richiami quasi catartici e liberatori: il popolo che bruciava le bandiere rosse attuava, oltre ad un gesto di violenza al simbolo ed all’idea socialista, anche una manifestazione di tipo rigeneratore. Con Franco, Malaga ritorna spagnola, immune cioè all’influenza straniera e sovversiva. Del resto i segni dell’incubo erano ancora ben presenti nelle strade della città, sotto forma di distruzione, morte, sparizioni. Carestia e fame erano le piaghe più diffuse, senza contare appunto la violenza generalizzata di cui i repubblicani rendevano vittime persone e cose. Oltre la gioia dell’accoglienza, i soldati dovevano tenere conto anche dello spettacolo di desolazione che gli si parava di fronte. Purtroppo molti non trovano più nessuno! Comunisti e anarchici hanno fucilato migliaia di persone, uomini e donne, devastato, violato, incendiato, ovunque; i migliori alberghi sono stati distrutti, ville signorili saccheggiate, il patrimonio artistico della città messo a sacco. Da diciotto giorni la città era senza pane e limitate le altre qualità di viveri 10. Distruzione fisica cui corrispondeva naturalmente un grave imbarbarimento morale, visto che «il disordine, la distruzione, l’arbitrio e le immoralità costituivano il clima nel quale la città [aveva vissuto] sotto il dominio dei comunisti e degli anarchici»11. Le descrizioni ad opera di Sandro Sandri erano estremamente cariche di pathos: il fattore emotivo sembrava innestarsi sulla struttura semplice della narrazione della cronaca fino a prevalere e ad essere il vero protagonista della corrispondenza. La ricostruzione era tanto più forte quanto era in grado di coinvolgere emotivamente: a maggior ragione questo valeva per i casi individuali, che diventavano esempi universali della sofferenza provocata dai rossi. L’emozione, in questi casi, era elevata all’estremo, ricercata attraverso i dettagli e la rievocazione dell’ambiente familiare. Sandri se ne faceva portavoce, riferendo uno dei tanti casi della tragedia: Scrivo queste note in un piccolo albergo dove delle donne in lutto mi narrano che il 97 Francesco Corsi loro padre la scorsa settimana, mentre era seduto sul limitare dell’uscio fu invitato da alcuni miliziani in un comando per un chiarimento. Fatto salire su una automobile, prima che la macchina si mettesse in moto, fu freddato a rivoltellate sparate a bruciapelo, e il suo corpo ancora caldo e sanguinante fu gettato sul selciato, ai piedi delle donne atterrite12 Non c’è miglior modo che questo per evidenziare la violenza della furia repubblicana: l’assassinio a sangue freddo di un vecchio e lo strazio del suo cadavere. Non si trattava più di enumerare una lista di crimini commessi dai rossi, o di richiamare in causa le responsabilità bolsceviche nella tragedia spagnola. Un singolo caso, descritto in questa maniera, valeva molto più di mille teorie o ricostruzioni, per materializzare nell’immaginario del lettore (e quindi, in generale, dell’opinione pubblica) tutto il dramma della guerra civile nella sua interezza. Dov’erano rossi c’era il terrore; viceversa, la Spagna tradizionale, liberata e riportata in vita dalle truppe di Franco, aveva le fattezze tranquille e quasi ingenue di un vecchio sulla porta di casa, vittima di un odio di cui era impossibile darsi spiegazioni. L’unico dato certo era che il massacro era continuato ininterrottamente dall’inizio della sollevazione dei generali e che più di cinquemila abitanti erano stati trucidati. E non c’era quindi da stupirsi dei festeggiamenti quasi estatici della popolazione. A città ormai completamente conquistata e con i nazionali che montavano di guardia sulla sicurezza della gente, anche la notte pareva fatta apposta per chiudere il capitolo della violenza sovversiva. La città era divenuta, in positivo, una gigantesca caserma: soldati e civili fraternizzavano, brindavano alla Spagna ed alla libertà ritrovata. «Nella notte ancora risuonano – scriveva il corrispondente – e da ore ed ore echeggiano i canti dei legionari e del popolo liberato dal più truce e spaventoso esperimento sociale che i cervelli malati e criminali possano avere concepito»13 Come di consueto, il quadro della corrispondenza era fortemente falsato e la realtà delle cose stava in tutt’altra maniera: a partire dal giorno della presa di Malaga si scatenò una caccia all’uomo tra le più feroci che la Spagna avesse fino ad allora conosciuto: «delle migliaia di repubblicani che non erano fuggiti, moltissimi furono fucilati immediatamente, altri furono fucilati in carcere. Secondo un testimone oculare, 4.000 persone furono uccise nella prima settimana di occupazione»14. Sandri non parlò mai di questa carneficina, anche perché, nella sua ricostruzione, la popolazione non riservava alcuna simpatia per i repubbli98 Armi e propaganda. «Il regime fascista» di Farinacci e la guerra civile spagnola cani. Anzi, una volta liberati apparivano ben contenti di trovarsi sotto la tutela della operazioni di polizia affidate «a reparti della falange spagnola partiti in autocarro verso i villaggi della montagna, donde contadini terrorizzati giungevano in città riferendo racconti raccapriccianti»15. I rossi erano spietati anche nella ritirata: abbassati al rango di bestie, una volta scopertisi sconfitti, non poterono fare altro che fuggire in preda alla vergogna e seminando il terrore. Era ancora il sentimento popolare a farla da padrone nelle corrispondenze: La gente che oggi ci guarda mentre passiamo per le strade, pare che stenti a persuadersi che tutto è finito e ci sentiamo chiedere: «Non torneranno?». No, non torneranno! Rimangono tuttavia i lutti nelle famiglie di cinquemila fucilati, rimangono le distruzioni di centinaia di case, rimane la miseria di quelli ai quali tutto fu tolto, rimane, incancellabile, il terrore di ogni giorno, rimane l’odio profondo contro quelli che non hanno potuto essere raggiunti dalla giustizia umana dopo tanti crimini16. Lo schema era semplice e non lasciava spazio ad equivoci o fraintendimenti: ordine e civiltà contro violenza e barbarie. I soldati di Franco non massacravano, tutt’al più facevano «pulizia». E la facevano per rendere completamente sicuro il territorio nazionale. Non per niente fu proprio il termine limpieza a diventare tristemente famoso negli anni della guerra civile e dopo, visto che con il pretesto delle operazioni di pulizia si perpetrarono i peggiori massacri di oppositori al regime. «Franco – assicurava Sandri – andrà fino in fondo, combattendo fino al giorno in cui l’ultimo comunista avrà abbandonato il territorio spagnolo. L’operazione chirurgica è dolorosa, ma sarà salutare»17. Malaga, in questo senso, fu una delle prime tragiche prove di massacro in grande stile e le truppe di Mussolini ne divisero la responsabilità con il resto dell’esercito nazionalista. Neppure un accenno il cronista del «Regime Fascista» dedicava alla presenza dei propri connazionali: le divisioni franchiste erano tutte indistintamente parte dello stesso esercito: al massimo, si distingueva tra regolari e legionari, ma, al di là dell’ambiguità di fondo (nella legione erano ammessi anche elementi stranieri), niente lasciava trapelare la presenza di corpi militari italiani, per di più inquadrati ed impiegati autonomamente. Oltre a coprirne i misfatti, «Il Regime Fascista» ne negava dunque la presenza. La presa della città era celebrata – genericamente – come vittoria 99 Francesco Corsi fascista, e tanto bastava. Se l’opinione pubblica non era tenuta a saperlo, chi stava più vicino agli ambienti governativi e diplomatici doveva tuttavia essere ben consapevole del doppio significato di quella espressione: fuor di metafora, prima di tutto vittoria fascista significava vittoria italiana. Nel complesso, comunque, le corrispondenze di Sandro Sandri dovevano apparire molto credibili, soprattutto se giudicate in base all’accuratezza dei particolari e all’enfasi mai troppo pedestre che poneva nella descrizione degli eventi: a centinaia di chilometri di distanza, senz’altra fonte che non fosse quella dei media di regime, la prosa di Sandri non raccontava certo cose improbabili. Erano cronache ben scritte, verosimili e completamente allineate allo spirito fascista. Ed in definitiva erano l’arma migliore (sicuramente la più efficace, almeno a livello di pubblico generico) che il controllo fascista poteva esprimere, proprio perché la migliore propaganda era quella che non passava per tale. Malaga ricoprì un ruolo di notevole importanza, anche se non decisivo, nei piani dell’offensiva nazionalista. Ma fu il fattore ideologico ad essere molto più significativo di quello strategico. Particolare, questo, che non sfuggì a Farinacci che, in occasione della conclusione della battaglia di Malaga, colse l’occasione per uscire con un significativo editoriale, dal sapore di un bilancio entusiasta. «Le notizie che ci giungono dalla Spagna – diceva il direttore – ci riempiono l’anima di immensa infinita gioia»18. Poi, dopo un prologo più che consueto in cui si rammentava la fratellanza di spirito tra Franco ed il fascismo italiano e in cui si dava spazio al solito repertorio sulle trame di Mosca e dell’antifascismo internazionale, l’editoriale affrontava un argomento fino ad allora inconsueto: la partecipazione italiana alla «crociata antibolscevica». La nostra gioventù chiamata in causa, altro non attendeva se non che le cose si complicassero per accorrere là in legioni compatte, a debellare il nemico della civiltà ed a colpire a morte la ciurmaglia internazionale che sperava di trovare in Caballero il suo vindice redentore19. Di fronte al clamore internazionale suscitato dalle voci che davano per certa la presenza dei soldati italiani in Spagna, Farinacci si difendeva a modo suo, vale a dire con una spiazzante impennata d’orgoglio. Se le nazioni antifasciste credevano di indebolire la reputazione dell’Italia di Mussolini avevano sbagliato bersaglio: quella che loro ritenevano un’accusa infamante risultava essere per Farinacci motivo di vanto. 100 Armi e propaganda. «Il regime fascista» di Farinacci e la guerra civile spagnola Però i giornali stranieri affermano che la vittoria di Malaga è vittoria italiana. Si dice che in questi ultimi tempi, eludendo la sorveglianza del Governo, da ogni città d’Italia siano partiti i più animosi per offrire la loro fede, il loro entusiasmo e l’indomito coraggio al generale Franco. Noi non abbiamo modo di controllare queste notizie. Ma se sono vere, non possiamo che dichiararci soddisfatti ed orgogliosi. Non solo, ma siamo sicuri che soltanto per effetto di questa offerta l’ora del redde rationem è prossima20. Il senso fasullo di queste parole stava tutto nel fatto che Farinacci negasse assolutamente qualsiasi coinvolgimento del governo fascista. I soldati italiani sarebbero stati solo dei volontari, non organizzati e sfuggiti al controllo della sorveglianza, inquadratisi per proprio conto nell’esercito spagnolo. Paradossalmente, la descrizione corrisponderebbe a verità se Farinacci avesse inteso parlare dei volontari antifascisti e non, al contrario, dei fascisti italiani. Resta il fatto che, ancora una volta, le parole del «Regime Fascista» sembravano mal sopportare le direttive prudenziali imposte da Mussolini ai giornali sul caso spagnolo. La vittoria fascista di Malaga segnò in questo senso un’accelerazione: col passare dei giorni sarebbe stato sempre più difficile mascherare l’intervento italiano al fianco di Franco. Le pressioni delle diplomazie, unitariamente a quelle della stampa internazionale, rendevano l’impegno di Roma (come del resto quello di Berlino) sempre meno occultabile. Allo stesso modo, anche la storiella costruita ad arte dei volontari sfuggiti alla sorveglianza di regime si doveva rivelare come una costruzione dalla vita e dalla credibilità effimere. Già molta strada era stata fatta dalla finta neutralità all’impegno ideologico. Il passo tra partecipazione nascosta e intervento palese appariva di sicuro molto più breve. La vittoria di Malaga esaltò le prospettive di italiane per una soluzione immediata del conflitto spagnolo, anche perché aveva dimostrato che i reparti delle truppe del Corpo Volontari, se impiegati autonomamente come voleva Mussolini, potevano conseguire grandi successi con relativa facilità. Come afferma Coverdale, «il pronostico che le truppe italiane sarebbero passate attraverso la resistenza spagnola come se fosse stata di burro sembrò pienamente confermato»21. La battaglia di Gudalajara L’attacco presso Guadalajara fu sferrato nel momento di massimo svi101 Francesco Corsi luppo delle forze repubblicane. Dopo Malaga i nazionali avevano subito uno scacco presso il Jarama, ciò che aveva contribuito a risollevare di molto il morale della Repubblica. Per di più, l’esercito repubblicano, riorganizzato sul modello delle brigate internazionali, aveva dimostrato di poter tenere testa ai nazionalisti in campo aperto ed i caccia sovietici detenevano, almeno per il momento, il dominio dei cieli. La riorganizzazione del fronte repubblicano spinse Mussolini a sostenere ancor più la propria idea di guerra celere contro i rossi, e la battaglia di Guadalajara doveva appunto rappresentarne la prima significativa tappa. L’attacco fu intrapreso da 20.000 uomini dell’esercito nazionalista, agli ordini di Moscardò, il difensore dell’Alcazár di Toledo e da circa 30.000 italiani comandati da Roatta, ripartiti in quattro divisioni: le Camicie nere del generale Rossi, le Fiamme nere del generale Coppi, le Frecce nere del generale Nuvolari, e la divisione Littorio del generale Bergonzoli; erano appoggiati da 250 carri armati e da 180 pezzi d’artiglieria mobile di vario tipo, nonché da una compagnia equipaggiata per la guerra chimica e da un compagnia dotata di lanciafiamme. Inoltre disponevano di 70 camion per battaglione, di 50 caccia e di 12 aerei da ricognizione22. Tutto questo dispiegamento di forze, senza precedenti nella storia della guerra civile, doveva essere impiegato contemporaneamente e in maniera autonoma, cosicché la vittoria risultasse il più possibile significativa per la reputazione del governo italiano. L’avanzata verso Guadalajara iniziò al mattino dell’8 marzo e il primo assalto delle divisioni di Coppi fu coronato da successo così come quello sferrato da Moscardò. Sandro Sandri, che si trovava al seguito delle truppe italiane, e seguì per «Il Regime Fascista» tutte le fasi della battaglia, vedeva già Madrid a portata di mano. Il dramma di Madrid sta per entrare in una fase che si può veramente ritenere decisiva dopo oltre quattro mesi di lotta. Il panorama che oggi presenta la situazione della città nella quale oltre quattrocentomila persone innocenti soffrono gli orrori della guerra è quello di una fortezza che sta per essere accerchiata e isolata dal resto della Spagna che reclama risolto il problema della sua capitale, nella quale si è concentrata tutta la canaglia internazionale i cui fasti e nefasti sono noti a tutto il mondo23. Ma il maltempo ed una violenta nevicata impedirono all’aviazione na102 Armi e propaganda. «Il regime fascista» di Farinacci e la guerra civile spagnola zionalista di decollare e quindi l’attacco si rivelò incompiuto. Solo il giorno dopo gli italiani poterono riprendere l’avanzata, ma viste le ancora pessime condizioni del tempo, progredirono di pochi passi. In compenso Madrid aveva messo insieme un nuovo corpo d’armata, formato dai «migliori reggimenti repubblicani»24: vi figuravano i comandanti più in vista dell’esercito rosso, come il comunista Lister e l’anarchico Cipriano Mera. Agli ordini di quest’ultimo era una divisione che comprendeva la XII brigata internazionale, con in testa il battaglione Garibaldi. A fronte della situazione ancora incerta e sostanzialmente invariata «Il Regime Fascista» decise di rimanere sulla difensiva, e il giorno successivo si limitò a pubblicare un articolo in cui il fronte di Guadalajara era appena accennato25. Poi, a riempire la mancanza di notizie ci pensò ancora Sandro Sandri, che narrò, in un flashback carico di accenti lirici, il suo viaggio verso Guadalajara. Ho attraversato – scriveva Sandri – nelle scorse settimane l’Andalusia, la Estremadura e quindi la vecchia Castiglia – seguendo le truppe in marcia – dalle rive del mare, dove gli aranceti e gli oliveti stupendi si alternano alle piantagioni di canna da zucchero all’Andalusia, dove le piante del mandorlo sono fiorite e le greggi fluiscono lente sulle colline verdi popolate di querceti26. È il racconto di un viaggio dai toni quasi bucolici e Sandri non risparmia nessuno dei luoghi comuni riguardanti la terra spagnola: ci sono i paesaggi incontaminati, la bellezza disarmante degli scenari naturali ed il segno dell’uomo (le greggi) che pare non turbare, essendo discreto e solo accennato, questo immortale spettacolo. È un modo diverso, e forse originale per «Il Regime Fascista», di descrivere la Spagna nazionale, ma che resta invariata nei suoi tratti di fondo: il regno della pace e della tranquillità. Il passaggio dalla Spagna pacificata del generale Franco alla zona di guerra del fronte di Madrid non era stato certo indolore ed anche il clima più rigido e inclemente pareva marcare la differenza tra le due opposte fazioni in lotta. In ogni caso, neanche il brutto tempo sembrava scoraggiare le truppe nazionali, o scalfire la sicurezza nella vittoria finale dei soldati e delle popolazioni liberate. Scriveva Sandri: Pioggia violenta e nevicate furiose hanno abbassato la temperatura, ma non hanno raffreddato l’entusiasmo dei legionari e della popolazioni che, schierate come per una 103 Francesco Corsi parata, non si sono stancate, notte e giorno, di applaudire le truppe sfilanti in autocarro. […] Il grido «Suerte!» cioè «Fortuna» echeggia nella notte sotto una pioggia scrosciante, tra un agitare convulso di braccia tese27. Dopo Malaga, la scena della folla in delirio si ripeteva e, se possibile, anche con maggior forza. Qui il contrasto tra il clima livido ed il calore del popolo liberato è stridente: la gente comune era schierata militarmente («in parata» dice Sandri) ed accoglieva le truppe col saluto romano. La pioggia, il maltempo, la notte sembravano ormai retaggio del passato, mentre il presente era rappresentato dagli autocarri (italiani, ma il cronista si guarda bene dal dirlo) che sfrecciavano velocemente per le strade dei paesini. L’augurio era implicito: presto anche quelle terre avrebbero goduto di climi migliori. Poco più in là, era asserragliato l’esercito repubblicano impegnato nel profondere gli ultimi sforzi di resistenza contro l’inarrestabile impeto franchista. Per una volta, pur con tutte le riserve del caso, anche ai «rossi» veniva riconosciuta tenacia nel combattimento, ammettendo che, seppure «trincerati in comodi ripari costruiti in pietra, i comunisti dei battaglioni “Alicante Rossa” e “Dimitroff ” valutati in circa millecinquecento uomini, opposero ben dura resistenza all’assalto dei legionari che manovrarono sotto la pioggia dirotta con un impeto straordinario»28. Inoltre, ricordava Sandri, le truppe repubblicane erano ammassate sul fronte in grande quantità e la loro consistenza non era certo da sottovalutare. Circa 4.000 comunisti appartenenti alla Brigata internazionale sono di fronte ai fanti legionari. Sono truppe trasportate frettolosamente in autocarro da Madrid durante la notte e ammassate a contatto con la colonna legionaria per tentare di arrestarne l’impeto 29. Il cronista doveva avere ben presente che la campagna di Guadalajara ricopriva tra i repubblicani un ruolo di primo piano, ma, allo stesso tempo, aveva piena fiducia nella vittoria dei franchisti. Ed anche porre in evidenza la consistenza delle forze della Repubblica rientrava in una prospettiva di celebrazione dei successi nazionali. Quanto più forte fosse stato il nemico, tanto più grande sarebbe stata la vittoria. Nel mezzo ai due eserciti si trovava la città di Brihuega: questa, «dopo una quiete ormai bisecolare»30 (era stata infatti luogo di una famosa battaglia napoleonica), fu presa d’assalto dalle divisioni delle Fiamme nere e delle Frecce nere italiane e cadde nelle loro mani all’alba del 10 marzo. Il 104 Armi e propaganda. «Il regime fascista» di Farinacci e la guerra civile spagnola fulmineo successo italiano creò l’occasione, per «Il Regime Fascista», di tornare a raccontare da vicino la battaglia e lo fece in toni quasi scanzonati, lasciando più spazio all’invettiva ed alla derisione del nemico. La notizia cui veniva dato maggiore rilievo, e che compariva anche nel titolo, faceva riferimento alla cattura del comandante della guarnigione repubblicana: Per quanto riguarda la conquista di Brihuega è […] la sorpresa del nemico è stata completa. Il comandante rosso riteneva che la resistenza dei suoi uomini trattenesse fino all’alba le truppe legionarie e dormiva tranquillamente, quando con audace colpo di mano le truppe circondarono il borgo e penetrarono nell’anello dell’abitato. Il comandante rosso fu catturato nel suo letto31. Lo stesso giorno, ma questa notizia non apparve sulle colonne del giornale di Farinacci, a pochi chilometri da Brihuega i carri armati del generale Coppi furono attaccati dalle mitragliatrici dei garibaldini e due pattuglie di Fiamme nere mandate all’attacco si arresero ai loro connazionali antifascisti. Altri scontri si verificarono, per tutto il giorno, nei pressi di Palazzo Ibarra, dove gli italiani furono impegnati in «una guerra civile per proprio conto»32: nel frattempo, Longo, Vidali e Nenni (tutti impegnati con funzioni effettive di comando nelle brigate internazionali) predisposero un’intensa campagna propagandistica rivolta ai legionari italiani, invitandoli alla diserzione attraverso proclami agli altoparlanti e lancio di volantini dagli aerei repubblicani. L’11 marzo fu giorno di nuovo attacco: le Frecce nere sfondarono le linee protette dalla divisione di Lister, presero Trijueque e puntarono con le loro autoblindo verso Torija, ma non la raggiunsero perché furono respinti, a costo di gravi perdite, dalle divisioni repubblicane. Anche la strada che collegava Brihuega e Trijueque rimase sotto il controllo del battaglione Garibaldi. Ciononostante «Il Regime Fascista» esaltò l’avanzata nazionale con i toni di una schiacciante vittoria. Riccardo Forte, impiegato di ripiego sul fronte di Madrid, precisò che nei villaggi liberati dai nazionali i comunisti avevano trascinato con sé nella loro fuga tutti gli uomini validi dai 18 ai 45 anni, costringendoli a seguirli con la forza. «Questo gregge umano in marcia con le baionette alle reni – scriveva – procede verso la capitale sotto la pioggia dirotta»33. Sandri, dal canto suo, affermava trionfante che «la resistenza rossa sulla fronte da Bruhuega [sic] a Miralrio [aveva] ceduto, travolta dall’impetuoso assalto legionario» e rivelava, affidandosi a toni 105 Francesco Corsi vagamente macabri, che «il bosco di querce, dove la resistenza rossa fu più tenace, [era] popolato di cadaveri, altri [giacevano] sulla strada e nelle trincee»34. Infine, il dito ribatteva sul solito tasto premuto da Forte; la pietà per i morti non durava che qualche riga e lasciava spazio alla consueta denigrazione: Col miraggio di forti paghe e di facili lavori in Spagna è attirata questa gente, che venne per lo più inquadrata nei famosi battaglioni antifascisti e cacciata avanti con un fucile in pugno e con la solita minaccia a tergo delle mitragliatrici, in nome del trionfo della libertà e suoi derivati. Non uno di questi esseri umani dimostra di possedere la dignità del soldato35. Di fronte ad un nemico così disumanizzato e spinto in battaglia contro il proprio volere, la compattezza e l’efficacia dei legionari rilucevano in tutto il loro splendore. Di villaggio in villaggio l’avanzata verso Madrid pareva fosse ormai un fatto scontato, ed in effetti così pensavano i gerarchi di Roma, i militari ed i giornalisti italiani in Spagna. «Questa notte ha di nuovo nevicato – concludeva fiducioso Sandri – l’azione sta per ricominciare»36. Invece non ricominciò proprio nulla. Il 12 marzo una tempesta di neve bloccò sulle piste l’aviazione nazionalista, mentre quella repubblicana poté muoversi liberamente e disperse, senza alcuna difficoltà, le colonne motorizzate italiane. Poi, seguì il contrattacco: prima le divisioni di Lister avanzarono verso Trijueque, che fu conquistata piuttosto facilmente. Da lì, Cipriano Mera, con un imponente gruppo di carri armati sovietici, si spinse alle porte di Siguenza. Nemmeno ventiquattro ore dopo, il governo repubblicano telegrafò alla Società delle Nazioni per comunicare che era in possesso di prove e documenti (tra cui molte lettere di soldati) che testimoniavano senza ombra di dubbio «la presenza di unità dell’esercito regolare italiano in Spagna»37. Dal 15 al 17 marzo la battaglia sul fronte di Guadalajara subì una sosta, principalmente per colpa delle cattive condizioni metereologiche. Il 18, finalmente, i repubblicani decisero di iniziare la controffensiva. L’aviazione bombardò i dintorni di Brihuega e a ciò fece seguito un violento fuoco d’artiglieria. Subito dopo, Lister e Cipriano Mera, sempre coadiuvati dai carri sovietici di Pavlov, attaccarono la città da due lati opposti, accerchiandola completamente. Ad operazione quasi ultimata, i legionari italiani ricevettero l’ordine di ritirarsi: «lo eseguirono con tanta fretta che la ritirata 106 Armi e propaganda. «Il regime fascista» di Farinacci e la guerra civile spagnola fu una vera e propria rotta, giù per la sola strada ancora aperta. L’inseguimento continuò per vari chilometri»38. Da parte del «Regime Fascista», un buio praticamente assoluto. Dopo aver celebrato l’offensiva iniziale, la lotta sul fronte di Madrid sparì quasi del tutto dalle colonne del giornale. La guerra di Spagna restò relegata nello spazio angusto delle ultime notizie, privilegiando argomenti assolutamente di secondo piano o di scarsa importanza, come le consuete minacce della «Pasionaria»39, alcuni successi franchisti lontani dal fronte principale40, o ancora i tentennamenti del comitato di «non intervento»41. Talvolta, nascosto tra notizie di vario tipo, cadeva qualche accenno su Guadalajara, dato in maniera estremamente stringata, tanto da apparire quasi casuale. In seguito ai primi bombardamenti e la riconquista di Brihuega, Riccardo Forte, in un articolo che parlava di tutt’altro, riusciva solo ad annunciare: «dopo le furibonde giornate passate, la battaglia di Guadalajara subisce una sosta»42. Il silenzio di Sandri era stato invece assoluto: in una situazione tanto negativa per le speranze di Mussolini e Farinacci, «Il Regime Fascista» preferiva rifugiarsi nella sicurezza dei bollettini ufficiali, piuttosto che affidarsi alle corrispondenze dei propri reporter. In compenso, la battaglia di Guadalajara aveva già suscitato una vastissima eco nella stampa e nell’opinione pubblica internazionali. Militarmente la battaglia aveva visto la sconfitta in campo aperto delle forze fasciste nella loro rappresentazione più genuina, cioè i soldati di Mussolini. Guadalajara stava a significare che anche il fascismo poteva essere vinto. La sconfitta, poi, fu tanto più cocente in quanto subita ad opera delle brigate internazionali, vale a dire da quegli stessi uomini che il fascismo aveva perseguitato e costretto all’esilio. E questo fatto era chiaramente ancor più vero e significativo per quanto riguardava gli antifascisti italiani del Battaglione Garibaldi. In altre parole, come afferma Coverdale, l’importanze di Guadalajara non deve essere valutata in termini esclusivamente numerici. Non diversamente dall’offensiva del Tet, essa ebbe un’importanza di gran lunga superiore dal punto di vista psicologico e morale che non da quello strategico e tattico. Il regime fascista sfruttava abbondantemente il mito dell’infallibilità e dell’invincibilità del duce […]. Guadalajara fornì la materia per la creazione di un mito opposto: il fascismo aveva ammassato le sue forze contro la repubblica ed era stato costretto a fare marcia indietro43. 107 Francesco Corsi Gli antifascisti di tutto il mondo e segnatamente i simpatizzanti europei ed americani della Repubblica spagnola si dettero molto da fare per esaltare la vittoria sul fronte di Guadalajara, con toni trionfali anche maggiori di quelli della difesa di Madrid. Hemingway scrisse che, dopo aver studiato per giorni la battaglia, poteva «affermare recisamente che, nella storia militare, a Brihuega è riservato un posto accanto alle altre decisive battaglie mondiali»44. Analogamente la pensavano tutti i maggiori organi di stampa internazionali, e non solo quelli più palesemente vicini al governo di Madrid. Il silenzio del «Regime Fascista» durò fino al 24 marzo. In questa data Sandro Sandri riprese voce ed uscì con un articolo dal titolo definitivo, La battaglia di Guadalajara. Il pezzo era ancora parzialmente nascosto, visto che figurava, poco prima delle notizie locali, in quinta pagina. All’unisono con il resto della stampa italiana, e ad una settimana dall’offensiva, il giornale di Farinacci tentò, un po’ alla chetichella, di limitare i danni, affidando l’onere dell’iniziativa alla sua penna migliore. Sandri esordì come aveva fatto alla vigilia dell’offensiva italiana, tirando in ballo ambiente, pathos ed emozione, ma dipinse un quadro che era all’opposto di quello iniziale. Malinconica terra questa terra di Castiglia, specie in questa stagione che la pioggia, il gelo, il vento, la rendono ancor più desolata e squallida. Tutto ha il colore delle nubi che si rincorrono senza pausa nel cielo e quando un raggio di sole viene a rallegrare lo squallore del paesaggio questo appare ocre, come nei tragici quadri del Greco45. Il paesaggio idilliaco e primaverile della prima corrispondenza (dai mandorli fioriti agli aranceti) era scomparso, per lasciare spazio ad uno scenario lugubre e negativo. Si aveva il ritratto di una terra desolata e inospitale, ostile all’uomo anche nell’aspetto: precisamente l’opposto, cioè, della natura inviolata ed accogliente che avevano ammirato i legionari al loro passaggio. Il panorama riflette, in questo caso, l’animo di chi scrive: con l’entusiasmo delle prime ore erano sparite anche le figure gloriose dei soldati acclamati dalla folla. L’ambiente ostile della Castiglia sembra voler inghiottire anche loro. I soldati affondano nel fango. Il fango domina, rossigno, appiccicoso, carsico. L’orizzonte è senza confine: da una piana che si trasforma lentamente in una collina appena appena rilevabile a un’altra piana a onde di mare come nei deserti del sud. Radure 108 Armi e propaganda. «Il regime fascista» di Farinacci e la guerra civile spagnola nude, rocce che emergono d’improvviso come gli avanzi di una naufragio sul giallo della terra46. In tutta questa ricostruzione non c’era un solo particolare che rimandasse ad un effetto o ad una sensazione positivi. La terra è trasformata in un mare di fango, sempre uguale a se stesso, appena interrotto da speroni di roccia che (ancora un’immagine drammatica) evocano il disastro di un naufragio. In uno scenario simile era praticamente impossibile riposizionare i contadini operosi ed esultanti che accoglievano i legionari col saluto romano. Anche di questi non era rimasto nulla, se non un paesaggio già in rovina. Villaggi poveri, miserabili, le cui case appiccicate le une alle altre hanno il colore del fango e gli abitanti vi scomparivano come in cunicoli sotterranei, povera gente spaurita dal cannone e dalla fucileria, che passa facendosi il segno della croce quasi di nascosto, poiché i comunisti hanno distrutto la loro chiesa e i nuovi arrivati non si sa come la pensino47. Per la prima ed ultima volta era evocata un’immagine originale, e fuori dagli schemi consueti in cui veniva inquadrata la guerra civile: la «povera gente» descritta da Sandri appariva qui come la vera vittima dello scontro tra le due fazioni. Erano persone travolte dagli eventi, la cui miseria era stata ancor più sconvolta dal dramma della guerra e delle opposte ideologie che si contendevano la Spagna. Sui nuovi arrivati, i nazionali, per una volta appare qualche dubbio (anche se solo di maniera, ai fini di enfatizzare la narrazione) concretizzato nella diffidenza dei contadini; i «rossi» invece erano solo evocati, tramite le tracce che avevano lasciato dietro di sé: segni di distruzione e barbarie, forse, implicitamente, la causa recondita di tutta quella miseria descritta. Nella loro furia distruttiva non avevano risparmiato neanche la chiesa del paese, come il corrispondente aveva già ricordato: Paglia fradicia in un canto, avanzi di una cucina da campo sull’altare maggiore. Immondizia dappertutto. Il comunismo non ha saputo fare altro. La miseria dei villaggi è rimasta miseria, l’ignoranza della povera gente è rimasta tale. Mi fecero vedere in un prato il tumulo sotto il quale riposa il prete del villaggio fucilato un mese fa perché era prete. La cavalleria di Moscardó sfila lentamente48. La ricostruzione è composta da elementi già letti molte volte, la violen109 Francesco Corsi za comunista, la rovina, le tracce di inciviltà; tuttavia i toni sono amplificati e rendono un ritratto ancora più lugubre del passato. Il comunismo (con tutto quello che Sandri vi includeva: anarchia, democrazia, socialismo, ecc.) aveva saputo solo aggravare lo stato già insostenibile di miseria e ignoranza che affliggeva i contadini del villaggio. Di suo, in più, aveva aggiunto il consueto carico di violenza arbitraria e cieca, di cui l’omicidio del parroco era l’episodio più esemplare. Più in là, quasi del tutto al di fuori del contesto, la cavalleria nazionalista stava ripiegando lentamente. È un’immagine che rimanda, per come è costruita, più al mondo cinematografico che a quello giornalistico. Come in un montaggio alternato, le due sequenze, la visita alla chiesa violata e le truppe in marcia, esasperano i tratti cupi di una corrispondenza fondata esclusivamente sul fattore emotivo. A prova di questo era il fatto che, a metà dell’articolo, ancora Sandri non aveva accennato affatto alla battaglia di Guadalajara. Compito che si decideva a svolgere poco più avanti, senza minimamente abbandonare i toni apocalittici della lunga introduzione. L’intera battaglia era condensata nell’episodio dell’assalto a Trijueque, descritta sommariamente come «una folla di case raggruppate dominate da un campanile rettangolare come una torre. È tra quelle – riferiva Sandri – che si è combattuto con ferocia inaudita». Le ondate di uomini scagliati all’assalto tre volte arrivarono al villaggio e tre volte furono ricacciate dai legionari. Le brigate internazionali composte da tutta la schiuma del mondo, di tutti i rifiuti umani raccolti nei bassifondi delle grandi città europee vennero a dissanguarsi sulle linee di Trijeque seminando di cadaveri la strada dell’assalto. Alle venti arrivò l’ultimo assalto comunista al villaggio. La notte era nera e tempestosa. Le vampate del cannone lampeggiavano come in un temporale che venisse dalla terra49. I soldati repubblicani erano descritti come carne da cannone, spedita al macello dai propri comandanti: era una delle tante facce della violenza cieca cui il comunismo asserviva gli uomini. Se possibile, anzi, il tasto del disprezzo e della disumanizzazione assumeva anche toni più concreti, venati da un odio di matrice quasi classista. Gli appartenenti alle brigate erano i reietti del mondo, la «schiuma», cioè il residuo e la spazzatura buttata fuori dalle «grandi città europee» della democrazia e del liberalismo. Per questo non si parlava di uomini, ma di «rifiuti umani». Sono parole di Sandri, ma sembrerebbe che a parlare fosse Farinacci in persona. Ancora una volta, poi, nessun accenno sostanziale alle fasi della battaglia, se si eccettua la descrizione del turbinio provocato dall’attacco dei 110 Armi e propaganda. «Il regime fascista» di Farinacci e la guerra civile spagnola rossi e dalla reazione nazionalista. Alla fine del pezzo, ancora l’esito della battaglia non era riportato. I toni cupi certo rimandavano ad uno scenario negativo, ma non c’era nessun dato che lasciasse supporre un successo dei repubblicani contro i nazionalisti. Gli attacchi delle brigate internazionali parevano senza esito, dovute solo alla foga cieca e distruttrice dei soldati repubblicani. Sandri parlò di un «ultimo assalto», ma si guardò bene dal concluderne la ricostruzione. Questo perché, come scrive Thomas, «Trijeque fu riconquistata con un assalto alla baionetta, dalla brigata Thalmann e da quella di El Campesino. Molti italiani si arresero»50. Sandri, questo, evitò accuratamente di raccontarlo: parlò del paesaggio inospitale, dei villaggi miseri e semidistrutti, della furia dei comunisti, ma in pratica non descrisse mai la battaglia di Guadalajara, in un articolo che portava quello stesso titolo. Non rinunciò, anzi, ad un ultimo impeto d’orgoglio legionario, quasi la prospettiva indistinta e vaga di una prossima rivincita: «I legionari che combattevano da quattro giorni – concludeva Sandri – hanno il cambio. Eccoli che tornano. Uno mi dice: Ora che i rossi scappano ci danno il cambio»51. Il giorno dopo fu la volta di Farinacci, che ricomparve sulle colonne del proprio giornale dopo il lungo silenzio dovuto alla missione in Spagna. Come di consueto l’editoriale non era firmato, ma il tono e lo stile erano inconfondibili. Prima di tutto se la prendeva con la stampa estera, colpevole, secondo lui, di aver dato il via ad una campagna diffamatrice senza precedenti. La stampa antifascista straniera continua a pubblicare le più grosse e volgari menzogne sulla battaglia di Guadalajara. Si è spinta a parlare addirittura di una disfatta italiana, soltanto perché su quel fronte si trovavano dei reparti di nostri volontari52. Il «ras» di Cremona puntava il dito contro la propaganda antifascista cercando di evidenziare come questa fosse finalizzata in verità a nascondere gli insuccessi repubblicani e la crisi del governo di Madrid. Si parlava di «disfatta italiana», cercando ancora una volta di strumentalizzare il ruolo dei volontari italiani solo per compromettere l’immagine del fascismo e rialzare il morale alle truppe repubblicane. In realtà, diceva Farinacci, questa è la solita manovra, che serve a nascondere le gravi perdite subite dai rossi. Le brigate internazionali, compreso il battaglione garibaldino, che inquadra tutta la ciurmaglia dell’antifascismo, sono state decimate. La demoralizzazione nel campo avversario è enorme (e lo dice la stessa stampa straniera che non è al soldo di Mosca), e 111 Francesco Corsi molti volontari inglesi e francesi hanno chiesto alle loro rappresentanze diplomatiche di Madrid di rimpatriare53. Il grido di Farinacci era volto a contrastare l’eco gigantesca che la battaglia aveva avuto in tutto il mondo. Era, a livello generale, una lotta impari, ma che poteva essere vinta nell’Italia di Mussolini con una certa facilità: del resto il pubblico di lettori del «Regime Fascista» non aveva fonti alternative che potessero confutare quello che diceva. Così la sconfitta italiana diveniva una disfatta rossa ed alla fuga dei legionari si sostituiva la decimazione degli internazionali. Per di più, le brigate internazionali parevano sul punto di implodere. In un contesto simile solo la malafede della stampa estera poteva far cantare vittoria agli antifascisti. Ribatté sullo stesso tasto appena qualche giorno dopo: In questi ultimi giorni non riuscivamo a comprendere perché la stampa francese, inglese e russa avesse veduto tanto scalpore sul fatto che i volontari italiani, impegnati sul fronte di Guadalajara, hanno dovuto retrocedere per qualche chilometro dinanzi al numero stragrande dei rossi […]. Parlare di disfatta e di sconfitta è semplicemente cretino e ridicolo»54. Dalle colonne del «Regime Fascista» spirava come di consueto l’aria del complotto internazionale. E se anche per la prima volta veniva accennata la ritirata italiana (certo non con i toni di una fuga) questa era minimizzata e ridimensionata al rango di un semplice ripiegamento strategico. Infine il «ras» avvertiva, minaccioso, che i fascisti erano abituati a fare i conti «in ultimo»55: se gli antifascisti avessero continuato ad esaltare piccoli movimenti di eserciti come se fossero battaglie decisive, molto presto si sarebbero ritrovati di fronte alla pura verità dei fatti: il fascismo era infallibile e la crociata anticomunista aveva un esito scontato, nonostante la propaganda avversaria. «Qualche prigioniero italiano sotto minaccia di morte è stato costretto a fare dichiarazioni addomesticate – rivelava Farinacci – per far colpo nelle file dei combattenti di Franco, che però non si lasciano minimamente impressionare ed hanno dimostrato una sola volontà: annientare il comunismo. E lo annienteranno!»56. Nonostante però lo strepitio della stampa fascista, di cui Farinacci era come di consueto punta di diamante, gli ambienti dell’antifascismo europeo continuarono ad alimentare il mito di Guadalajara. Ciò che sembrò essere intollerabile per «Il Regime Fascista» che era anzi ansioso di mettere 112 Armi e propaganda. «Il regime fascista» di Farinacci e la guerra civile spagnola la parola «fine» sull’intera vicenda. Al solito modo, e facendo finta di non essere smentito da quasi tutti i circuiti dei media fuori dalla Germania e dall’Italia, Farinacci proseguì ancora per lungo tempo ad imporre la propria verità. Il 9 aprile, quando gli occhi del mondo si erano ormai spostati su altri fronti, imperterrito e incurante di una sconfitta ormai riconosciuta, addirittura si provò a cantare vittoria: Come vedesi, la carnevalata cartacea è durata poco. I nostri buffissimi avversari si sono smascherati da soli. Essi già prevedono che pagheranno a duro prezzo gli insulti e le menzogne lanciati contro le nostre Camicie Nere, che sono accorse volontariamente in Ispagna a combattere il multicolore antifascismo. Mettono le mani avanti per coprire il grugno spudorato57. Da parte sua Franco decise di abbandonare l’impegno attivo sul fronte di Madrid: cominciò a fortificare la linea di Guadalajara, acquistò all’estero nuovi aeroplani e cannoni e volse lo sguardo alla zona settentrionale della Spagna, affidando al generale Mola (il cui esercito fu riorganizzato e riequipaggiato) il compito di sferrare un’offensiva contro i baschi. Un simile spostamento del teatro delle operazioni «si dovette al fatto che i generali nazionalisti erano arrivati all’amarissima conclusione che non era possibile prendere Madrid e che la guerra sarebbe durata a lungo»58. L’offensiva di Mola ebbe inizio il 31 marzo, condotta impiegando diverse brigate della Navarra, prevalentemente monarchiche. Alle ali di queste divisioni furono affiancati due reparti italiani e tutte queste forze erano appoggiate dall’aviazione nazionale. Lo schieramento repubblicano era molto peggio armato e coordinato con poca efficienza dal governo di Madrid che non riteneva eccessivamente importante il fronte del nord. Mola cercò di approfittare di questa situazione, inviando sin da subito ultimatum minacciosi in cui si intimava alla resa. Al resto pensarono gli aerei tedeschi che presero a bombardare senza tregua i territori baschi mietendo numerose vittime tra la popolazione civile. Per conto loro i baschi resistevano molto tenacemente e si avvalevano delle asperità del terreno per rendere impossibile l’avanzata dei nazionali. Eppure, anche se ciò impedì che «l’offensiva [fosse] coronata, come avrebbe voluto Mola, da una rapida vittoria»59 l’esercito nazionalista fu solo rallentato nel proprio percorso: prima della fine di aprile le brigate di Navarra avevano già oltrepassato la linea di Durango e si preparavano a vincere le fortificatissime difese della capitale basca. Bilbao era a pochi chilometri. 113 Francesco Corsi Le menzogne di Guernica Per tutta la fase iniziale dell’operazione sul fronte basco «Il Regime Fascista» trattò gli eventi spagnoli mantenendo un profilo piuttosto basso. L’offensiva venne presentata come una tranquilla avanzata verso la capitale, ma lo spazio che le fu riservato non fu largo come in passato. Le corrispondenze, inaugurate eccezionalmente (e quasi in tempo reale) da Riccardo Forte60, furono per il momento affidate al solito Sandro Sandri, i cui pezzi raramente comparirono fuori dall’ultima pagina: visto che il ruolo dei soldati italiani era stato ridimensionato, vennero ridimensionate anche le cronache della guerra di Spagna. Il 25 aprile 1937 Mola emanò da Salamanca l’ennesimo comunicato via radio: «Franco sta per assestare un colpo mortale contro il quale ogni resistenza è vana. Baschi! Arrendetevi ora e avrete salva la vita!»61. L’offensiva procedette vittoriosa ed il 28 caddero in mano ai nazionali sia Durango che Guernica. Sandri, entrando nella cittadina al seguito degli italiani, riferì ai lettori: «uno spettacolo terribile si presentò ai nostri occhi, non appena fummo nell’abitato». La città era completamente distrutta. «I “dinamiteros» asturiani” – scrisse Sandri – nella giornata di martedì hanno fatto saltare l’abitato della città pezzo per pezzo, appiccandovi poi il fuoco che ne completò la distruzione […]. Detti focolai furono collegati con fili per l’accensione elettrica [poi] sulle rovine fu lanciata della benzina e un rogo pauroso che ne seguì completò il disastro»62. Secondo la ricostruzione di Sandri Guernica era stata vittima della furia distruttrice dei suoi stessi difensori. Era un’ipotesi che ben si adattava all’idea che dei repubblicani voleva far passare «Il Regime Fascista»: quando i rossi non avevano più niente da perdere rivolgevano la violenza contro le proprie cose; al disprezzo per la vita umana si aggiungeva quello per la proprietà. Per far quadrare ancor di più il conto Sandri rovesciò la responsabilità sui minatori delle Asturie, considerate la culla dell’estremismo comunista fin dai tempi della rivolta. Il governo di Burgos, naturalmente, mise in giro una versione molto simile: in entrambi i casi si trattava di pura propaganda, senza un fondamento di verità. Infatti, nemmeno ventiquattro ore dopo il proclama del generale Mola la legione Condor era passata all’azione e aveva bombardato a tappeto la città di Guernica. Siccome era giorno di mercato, le strade erano affollatissime: sotto il tiro dei bombardieri tedeschi il centro fu completamente 114 Armi e propaganda. «Il regime fascista» di Farinacci e la guerra civile spagnola devastato e cadde in preda alle fiamme. A sera, la cittadina era rasa al suolo: «la popolazione [aveva cercato] di fuggire verso la campagna, ma venne spietatamente mitragliata»63. Quasi 1.700 persone morirono sotto le bombe ed i colpi di mitragliatrice, i feriti furono circa 900. Guernica, che fino ad allora aveva rappresentato uno dei maggiori simboli della tradizione basca, sarebbe stata ricordata come il luogo del massacro più atroce di tutta la guerra civile. I particolari della tragedia furono confermati dai superstiti e dai partiti di tutto l’arco del fronte repubblicano basco, dagli anarchici ai repubblicani, fino agli autonomisti; i maggiori quotidiani europei e mondiali riferirono la stessa versione. [I fatti] furono narrati dai corrispondenti del «Times», del «Daily Telegraph», della «Reuter», di «Star», di «Ce Soir», e del «Daily Express», che visitarono i luoghi quella sera stessa e raccolsero frammenti di bombe di fabbricazione tedesca. Venti sacerdoti baschi, nove dei quali testimoni oculari, e il vicario generale della diocesi, scrissero al papa fornendogli la stessa versione64. La mobilitazione che già era avvenuta per Guadalajara si stava ripetendo per Guernica. Solo che adesso non si trattava di enfatizzare una vittoria più o meno importante, quanto di dare la giusta copertura ad un massacro di immani dimensioni. Di fronte alle rimostranze di tutta la stampa internazionale, della maggior parte dei circoli d’opinione e anche di parti importanti della Chiesa, il fronte nazionalista non seppe fare di meglio che contestare l’evidenza a forza di bollettini ufficiali. Come di consueto al «Regime Fascista» alzarono il tiro ed infarcirono la polemica tra loro ed il resto del mondo con i soliti toni risentiti e aggressivi. Del resto lo stesso Sandro Sandri aveva parlato chiaro nel primo articolo sul bombardamento: La stupida panzana del bombardamento di Guernica proparata (sic) dai microfoni delle radio di Bilbao e raccolta dalla stampa antifascista francese, che in questi giorni diffonde le più fantastiche notizie su di esso, è falsa65. Le «fantastiche notizie» di cui parlava Sandri altro non erano che le precise corrispondenze di quasi tutti i giornalisti presenti. Ben prima infatti che «Il Regime Fascista» si prendesse la briga di narrare enfaticamente l’entrata delle truppe a Guernica il resto del mondo era già venuto a sapere, 115 Francesco Corsi tramite testimonianze come quella – attendibilissima – di George Steer, corrispondente del «Times». Guernica – scrisse Steer il 28 aprile – è stata rasa al suolo dalle incursioni aeree degli insorti. Il bombardamento di questa città aperta , distante dalla linea del fronte, è durato esattamente tre ore e un quarto. Durante tutto questo tempo un possente squadrone aereo […] ha continuato a sganciare sulla città bombe da mille libbre in giù e, si calcola, oltre tremila proiettili incendiari di alluminio del peso di due libbre. Contemporaneamente i bombardieri si tuffavano sul centro della città, mitragliando i civili che vi si erano rifugiati66. Un fronte tanto ampio e così ben documentato riuscì probabilmente a spiazzare Farinacci che, almeno sulle prime, rispose in maniera piuttosto timida alle pesanti accuse mosse contro i nazionali e lo fece con un piccolo commento a fondo pagina, di fatto non discostandosi dalla strada già intrapresa dal corrispondente. La polemica muoveva principalmente contro l’agenzia Reuters, «che durante l’impresa etiopica prendeva i talleri dal Negus per diramare al mondo le sconfitte degli italiani» e che aveva continuato allora «con gli stessi metodi e condizioni a seguire la causa dei rossi spagnoli»67. In pratica, diceva Farinacci, tutto l’affare di Guernica era stata una gigantesca montatura ad opera del fronte antifascista; per fortuna, concludeva, ancora i testimoni oculari ed i corrispondenti più seri potevano rivelare il giusto quadro degli avvenimenti. Per esempio, un corrispondente dell’United Press aveva comunicato che Guernica era stata completamente distrutta dai comunisti per mezzo di mine fatte brillare prima della ritirata. «Staremo a vedere – concludeva Farinacci – dopo questo ristabilimento della verità, se i Governi di Parigi e di Londra […] sapranno protestare presso il governo di Valenza. Noi però non c’illudiamo. È tutta una lega!»68 Questo tenue atto d’accusa contro la Reuters fu la prima tappa. Pochi giorni dopo Farinacci alzò il tiro e colse l’occasione per riportare la guerra sul binario che a lui pareva più appropriato, cioè quello della crociata contro i comunisti e le democrazie borghesi decadenti. Paradossalmente i fatti di Guernica gli offrivano una buona sponda per le proprie invettive ideologiche. «Il Regime Fascista» uscì con un lungo editoriale non firmato, ma inconfondibilmente partorito dalla penna del direttore. Il titolo era tutto un programma, Inchiodati alla gogna; ed il testo non deludeva le aspettative. 116 Armi e propaganda. «Il regime fascista» di Farinacci e la guerra civile spagnola Prendendo spunto dal comunicato con cui il generale Franco aveva smentito il bombardamento nazionalista, Farinacci se la prendeva con «i metodi ignobili» di cui si serviva la stampa estera e più precisamente quella di fantasiosa derivazione «anglo-ebraica»69. Ancora una volta la memoria tornava alla campagna d’Etiopia ed alle faziosi mobilitazioni a mezzo stampa per sminuire i successi italiani: Il sistema di «mentire sapendo di mentire» è infatti patrimonio morale del popolo inglese [cui] si aggiunge l’acuta perfidia tipica della mentalità ebraica. Il tutto si chiama «propaganda» ed è fatta più per uso interno dell’Impero inglese più che per uso esterno. Si sa benissimo a Londra che all’estero certe panzane attaccano poco: gli stessi giornali guidati dagli ebrei del fronte popolare francese non giungono spesso a tanta enormità perché rammentano che in Francia vi è ancora qualche francese che potrebbe ucciderli col ridicolo70. La polemica anti-inglese di Farinacci prendeva così pieghe del tutto irreali: l’Impero britannico era accusato di produrre false informazioni al solo scopo di tenere sotto controllo i propri sudditi. Era precisamente ciò che il fascismo stava facendo in Italia da diversi anni: non per niente «mentire sapendo di mentire» era una formula che aderiva perfettamente alla linea editoriale del «Regime Fascista». Del resto, in una situazione ben poco difendibile come quella dei fatti di Guernica, l’unica maniera per scrollarsi di dosso le accuse era quella di rovesciarle automaticamente contro gli altri. Ed anche se, come in questo caso, l’invettiva poteva apparire assai difficilmente credibile, Farinacci continuava per la propria strada, non essendocene altre da percorrere, ripetendo infinite volte la verità delle fonti fasciste. Guernica, città distrutta dalle orde petrolifere rosse, è fatta passare come rasa al suolo dall’aviazione «tedesca» e per una settimana non si parla in Inghilterra e nel solito consorzio di giornali francesi e belgi che delle «atrocità» contro quella inerme popolazione. Ciò fino a che l’evidenza si impone a tutti i visitatori delle rovine. Gli scopi della propaganda qui erano molteplici: screditare i fascisti, mantenere possibilmente in vista la repubblica basca sotto la protezione inglese, ed infine battere cassa per gli armamenti, così impopolari in Inghilterra71. Nuovamente Farinacci batteva il tasto sulla teoria del complotto internazionale antifascista: i tratti della cospirazione, seppure leggermente diversi dal passato (si parla solo dell’Inghilterra, la più «vicina» agli interessi baschi) non erano caratterizzati da fattori ideologici, ma da puri calcoli 117 Francesco Corsi opportunistici e di potere. Comunisti, ebrei o inglesi ancora una volta si confondevano nel medesimo contenitore, a formare la cupola dell’antifascismo internazionale. Da questa constatazione il direttore del «Regime Fascista» prendeva spunto per far quadrare i conti del recente (e inglorioso) passato: Già alla metà di marzo, a proposito dei combattimenti dati attorno a Guadalajara, a cui avevano partecipato dei volontari italiani, dovevamo sopportare, da parte degli stessi giornali (unitamente a quelli collegati del Fronte Popolare francese, della massoneria belga, ecc) una oscena sarabanda. Mentre si era osservato un silenzio funereo attorno alla presa di Malaga, a cui presero parte volontari italiani, il non riuscito attacco di Guadalajara diventò una catastrofe senza nome, né si mancò di parlare di «seconda Caporetto»72. Una linea continua di menzogne e manipolazione – che passava da Guadalajara e Guernica ed ignorava Malaga – aveva segnato la ricostruzione della guerra civile sulle pagine dei giornali. Il fatto che il popolo inglese avesse ancora intenzione di credere alla propria propaganda non stupiva molto Farinacci, anzi lo rallegrava anche perché, come diceva concludendo il lungo commento, «queste auto-illusioni, queste menzogne cartacee si rivelano catastrofiche per gli autori quando vengono a contatto con la dura realtà. Avviene allora di dover incassare e portare a casa dei ceffoni in pieno volto»73. E con questa conclusione in puro stile squadrista il «ras» di Cremona chiuse la polemica sul caso di Guernica, assicurando la veridicità della propria versione, nonostante tutto il mondo stesse ancora affermando il contrario. In fin dei conti, era solo l’ennesimo tassello di una revisione completa della realtà del caso spagnolo, opera che «Il Regime Fascista» aveva svolto con estrema costanza praticamente sin dall’inizio del conflitto. Questo periodo coincise con il momento di maggiore sforzo di copertura giornalistica della guerra civile: le parti in lotta erano state compiutamente descritte ed i lettori del «Regime Fascista» avevano ormai un’immagine senza equivoci della situazione spagnola; l’impiego dei corrispondenti raggiunse il suo punto massimo e la propaganda si riservò di mantenere alti i toni della crociata franchista contro l’antifascismo internazionale. L’impegno massiccio degli italiani sul fronte spagnolo contribuì ad amplificare questa tendenza: nella buona e nella cattiva sorte la propaganda svolse il proprio compito, ora esaltando le vittorie (come quella di Malaga, anche 118 Armi e propaganda. «Il regime fascista» di Farinacci e la guerra civile spagnola se ancora non ufficialmente «italiana»), ora occultando del tutto le sconfitte come Guadalajara o gli eccessi di parte nazionale (Guernica il caso più eclatante).Così «Il Regime Fascista» operò una continua revisione – in tempo reale – della realtà del conflitto, piegandola alle proprie esigenze ideologiche e disegnando uno scenario organico (e più coerente possibile) degli avvenimenti spagnoli. Per far questo si servì appunto degli schemi consueti della propaganda di guerra: disprezzo e disumanizzazione del nemico, esaltazione della propria forza e diffusione di notizie false, in special modo riguardanti le atrocità commesse dall’avversario. Il controllo delle notizie fece sì che la guerra di Spagna si delineasse presto come una cronaca ininterrotta di successi nazionalisti, tale da far apparire la vittoria di Franco e del fascismo come una sicura predestinazione. Ovvero, l’unico finale possibile per una crociata. I piccoli insuccessi venivano talvolta minimizzati in ultima pagina, più spesso non comparivano affatto (quindi non esistevano). Nei casi più importanti e negativi per l’immagine del fascismo (la sconfitta di Guadalajara o il bombardamento di Guernica) i fatti vennero semplicemente stravolti: non per niente «Il Regime Fascista» si trovò spesso, con toni ancor più violenti del normale, a dover confutare le ricostruzioni più attendibili del resto della stampa mondiale. Missione, occorre ricordare, che Farinacci portava avanti con estrema disinvoltura. I corrispondenti ricoprirono, in questo disegno, un ruolo di importanza vitale: lungi dall’essere voci svincolate dai circuiti di potere, essi rappresentarono la punta migliore delle lance della manipolazione: le loro corrispondenze davano colore e vita ai grigi bollettini ufficiali: li rendevano credibili proprio perché ne infarcivano la struttura con storie dirette ed emotive. In pratica, vestivano la propaganda pura di una certa verosimiglianza. Propaganda e censura, ancora una volta strettamente collegate, risultarono quindi essere i migliori strumenti di mistificazione della realtà. Il ritratto che Farinacci ed i suoi collaboratori fornivano della Spagna ne usciva così completamente falsato e fondato su di un immaginario che ricalcava pedissequamente quello fascista. In questo, Farinacci fu alquanto zelante: l’odio per il comunismo o le dottrine liberali e la foga antisemita furono le sue principali argomentazioni contro la Repubblica in tutto l’arco di tempo della guerra. La Spagna di Farinacci era una nazione in preda al terrore rosso, alla violenza ed alla barbarie, all’assassinio generalizzato. Era il regno della morte e dell’irrazionalità. Dall’altra parte, in compenso, precisamente 119 Francesco Corsi ciò che il fascismo ambiva ad essere: sicurezza, tranquillità, ma anche coraggio, lealtà e forza. Da una parte stava il Male, dall’altra il Bene. Dopo quasi tre anni di guerra, e uomini e mezzi profusi senza precedenti nell’impegno di copertura giornalistica, questo fu il messaggio di sintesi che si volle far passare. Un perfetto e basilare risultato di propaganda. E, tutto sommato, non dissimile da molti esempi più recenti. Note al testo 1 Il saggio prende le mosse da una tesi di laurea discussa presso l’Università di Siena nel 2005, relatore Nicola Labanca. 2 Messa a punto, «Il Regime Fascista», 8 agosto 1936, p. 1. 3 Hugh Thomas, Storia della guerra civile spagnola, Einaudi, Torino 1963, p. 392. 4 L’offensiva contro Malaga si svolge metodicamente. Gravi disordini a Barcellona, «Il Regime Fascista», 5 febbraio 1937, p. 6. 5 Hugh Thomas, Storia della guerra civile spagnola cit., p. 393. 6 John Coverdale, I fascisti italiani alla guerra di Spagna, Laterza, Bari 1977, p. 196. 7 Hugh Thomas, Storia della guerra civile spagnola cit., pp. 394-5. 8 Malaga occupata dai nazionali – delirio del popolo liberato, «Il Regime Fascista», 9 febbraio 1937, p. 1. 9 Ibidem. 10 Ibidem. 11 Ibidem. 12 Ibidem. 13 Ibidem. 14 Hugh Thomas, Storia della guerra civile spagnola cit., p. 395. 15 L’avanzata franchista prosegue di cento chilometri oltre Malaga, «Il Regime Fascista», 12 febbraio 1937, p. 1. 16 Come avvenne la liberazione della provincia di Malaga, «Il Regime Fascista», 14 febbraio 1937, p. 2. 17 Ibidem. 18 Redde Rationem, «Il Regime Fascista», 12 febbraio 1937, p. 1. 19 Ibidem. 120 Armi e propaganda. «Il regime fascista» di Farinacci e la guerra civile spagnola 20 Ibidem. 21 John Coverdale, I fascisti italiani alla guerra di Spagna cit., p. 201. 22 Hugh Thomas, Storia della guerra civile spagnola cit., p. 406. 23 Sandro Sandri, Decisa offensiva contro Madrid iniziata dalle truppe nazionali, «Il Regime Fascista», 9 marzo 1937, p. 8. 24 Hugh Thomas, Storia della guerra civile spagnola cit., p. 408. 25 L’avanzata franchista verso Guadalajara ultimo baluardo della capitale, «Il Regime Fascista», 10 marzo 1937, p. 1. 26 Sandro Sandri, Il magnifico slancio dei legionari nell’assalto delle posizioni di Guadalajara, «Il Regime Fascista», 11 marzo 1937, p. 1. 27 Ibidem. 28 Ibidem. 29 Sandro Sandri, Brihuega conquistata di sorpresa con una fulminea manovra dei nazionali. Il comandante rosso catturato nel sonno, «Il Regime Fascista», 12 marzo 1937, p. 1. 30 Hugh Thomas, Storia della guerra civile spagnola cit., p. 408. 31 Sandro Sandri, Brihuega conquistata di sorpresa con una fulminea manovra dei nazionali. Il comandante rosso catturato nel sonno, «Il Regime Fascista», 12 marzo 1937, p. 1. 32 Hugh Thomas, Storia della guerra civile spagnola cit., p. 409. 33 Riccardo Forte, I rossi snidati dalle fortificazioni dell’altura di palazzo de Ibarra, «Il Regime Fascista», 13 marzo 1937, p. 6. 34 Sandro Sandri, La lotta per Guadalajara tra raffiche di neve, «Il Regime Fascista», 14 marzo 1936, p. 5. 35 Ibidem. 36 Ibidem. 37 Hugh Thomas, Storia della guerra civile spagnola cit., p. 410. 38 Ibidem. 39 La «Pasionaria» propone l’incendio di Madrid prima che la occupino i nazionali, «Il Regime Fascista», 19 marzo 1937, p. 8. 40 I nazionali dominano la strada di Valencia, «Il Regime Fascista», 21 marzo 1937, p. 5. 41 I piani del comitato londinese dormono nei cassetti del Foreign Office. Un energico monito di Grandi, «Il Regime Fascista», 17 marzo 1937, p. 6. 42 Riccardo Forte, Una battaglia aerea a Madrid. Undici «caccia» rossi abbattuti, «Il Regime Fascista», 16 marzo 1937, p. 6. 43 John Coverdale, I fascisti italiani alla guerra di Spagna cit., p. 229. 44 Citato in John Coverdale, I fascisti italiani alla guerra di Spagna cit., p. 230. 45 Sandro Sandri, La battaglia di Guadalajara, «Il Regime Fascista», 24 marzo 1937, p. 5. 46 Ibidem. 47 Ibidem. 48 Ibidem. 121 Francesco Corsi 49 Ibidem. 50 Hugh Thomas, Storia della guerra civile spagnola cit., p. 409. 51 Sandro Sandri, La battaglia di Guadalajara, «Il Regime Fascista», 24 marzo 1937, p. 5. 52 Solita manovra, «Il Regime Fascista», 25 marzo 1937, p. 1. 53 Ibidem. 54 Chi riderà l’ultimo?, «l Regime Fascista», 28 marzo 1937, p. 1. 55 Ibidem. 56 Solita manovra, «Il Regime Fascista», 25 marzo 1937, p. 1. 57 A macchina indietro, «Il Regime Fascista», 9 aprile 1937, p. 1. 58 Hugh Thomas, Storia della guerra civile spagnola cit., p. 423. 59 Paul Preston, La guerra civile spagnola, Mondadori, Milano 2002, p. 203. 60 Riccardo Forte, L’offensiva dei nazionali su Bilbao, «Il Regime Fascista», 1 aprile 1937, p. 3. 61 Cit. in Paul Preston, La guerra civile spagnola cit., p. 204. 62 Sandro Sandri, La popolazione di Guernica acclama le truppe liberatrici del gen. Mola, «Il Regime Fascista», 30 aprile 1937, p. 6. 63 Hugh Thomas, Storia della guerra civile spagnola cit., p. 442. 64 Ivi, p. 443. 65 Sandro Sandri, La popolazione di Guernica acclama le truppe liberatrici del gen. Mola, «Il Regime Fascista», 30 aprile 1937, p. 6. 66 Cit. in Paul Preston, La guerra civile spagnola cit., p. 204. 67 Tutti in lega, «Il Regime Fascista», 4 maggio 1937, p. 1. 68 Ibidem. 69 Inchiodati alla gogna, «Il Regime Fascista», 7 maggio 1937, p. 1. 70 Ibidem. 71 Ibidem. 72 Ibidem. 73 Ibidem. 122 Ramón Franco e gli antifascisti italiani (1930-1932) di Alberto Magnani Il fratello dimenticato di Franco è il titolo di una recente biografia di Ramón Franco y Bahamonde, fratello minore del dittatore spagnolo1. Effettivamente, la memoria storica ha preferito rimuovere questo personaggio, così come risultano ignorati o scarsamente considerati i rapporti che egli coltivò con gli ambienti antifascisti italiani. Ma, all’inizio degli anni trenta del Novecento, quando progettava audaci imprese insieme a Carlo Rosselli o a Giovanni Bassanesi, Ramón Franco era una celebrità internazionale. In primo luogo per le sue doti di aviatore, che gli avevano permesso di compiere la prima trasvolata dell’Atlantico meridionale, guadagnandosi «un caldo e meritatissimo elogio quale pilota insuperabile da parte della stampa mondiale»2; e inoltre per la sua movimentata attività politica, che lo aveva reso «un personaggio attorniato da un alone romantico, popolare tra i progressisti e odiato a morte dalla reazione»3. L’aereo di Giordano Viezzoli Ramón, nato nel 1896, era il penultimo dei cinque fratelli Franco4. Il suo temperamento, per certi aspetti, può essere ricondotto a una tipologia che, in Italia, definiremmo da esteta dannunziano, amante, cioè, delle gesta eroiche e spettacolari; era privo, peraltro, di interessi artistici o culturali. Nel 1920 entrò in Aviazione e, nel 1926, portò a termine, con una pattuglia di idrovolanti, la trasvolata dalla Spagna al Sudamerica, diventando un autentico eroe nazionale. In quel periodo godeva della stima e della protezione di Alfonso XIII e del dittatore Primo de Rivera, anche se finì per frequentare ambienti dell’opposizione repubblicana. Nel 1929 tentò una nuova trasvolata, ma precipitò in mare al largo delle Azzorre. Fu creduto morto. Invece, inaspettatamente, venne ripescato, con tutto il suo equipaggio, da una nave inglese. Il ritorno in Spagna fu trionfale, 123 Alberto Magnani quasi avesse realizzato l’impresa. Nelle settimane successive, però, emersero irregolarità nella preparazione della trasvolata, cui si aggiunsero accuse di corruzione5. Espulso dall’Aviazione, Ramón Franco si atteggiò a perseguitato politico, radicalizzò le proprie posizioni e aderì alla Massoneria. Il suo attivismo crebbe nella seconda metà degli anni trenta, fase in cui si collocano i suoi primi rapporti con i fuorusciti italiani in Francia. L’11 luglio 1930 avvenne il raid di Giovanni Bassanesi, che, decollato dalla Svizzera, sorvolò Milano con un aereo da turismo e vi lasciò cadere una pioggia di volantini antifascisti. Ramón dovette rimanere molto suggestionato dall’impresa: nei due anni successivi, infatti, tenterà in tutti i modi di emularla. Nell’autunno dello stesso anno, era già in contatto con ambienti dell’antifascismo repubblicano, intenzionati a promuovere un’organizzazione alternativa a Giustizia e Libertà, la Giovane Italia6. Gli approcci di Ramón Franco si collocano nel quadro di una collaborazione tradizionale fra oppositori politici italiani e spagnoli7; potrebbero inoltre essere stati agevolati dalla comune appartenenza alla Massoneria di Franco e di elementi quali Cipriano Facchinetti, uomo di punta della Giovane Italia, con cui l’aviatore spagnolo si trovò subito in sintonia8. Franco seppe dai suoi interlocutori italiani che era in preparazione un nuovo volo. Giordano Viezzoli, sergente pilota di stanza a Elmas, in Sardegna, si accingeva a disertare e riparare in Corsica con un idrovolante S.629. Si trattava di un’occasione d’oro: l’aereo poteva essere utlilizzato per effettuare un nuovo raid di propaganda, su Genova o, addirittura, su Roma. Presumibilmente, una notizia tanto riservata venne confidata a Franco in quanto da un aviatore esperto come lui ci si poteva attendere qualche prezioso consiglio. A quanto pare, Ramón volle subito entrare nella faccenda. Secondo quanto comunicò a Roma un informatore fascista, «si sarebbe servito del noto apparecchio per fare un’incursione su Barcellona e gettarvi dei manifesti di propaganda del movimento repubblicano catalano»10. Il piano, soprattutto per quanto riguardava la partecipazione di Franco, rimase a un livello puramente teorico. Nelle settimane successive, infatti, le delazioni del noto doppiogiochista Carlo Del Re scompaginarono le file degli antifascisti che gravitavano attorno a Giustizia e Libertà. Anche Viezzoli venne arrestato. E lo stesso Ramón, in Spagna, pagava con il carcere un attivismo cospirativo ormai troppo palese. Mentre si trovava dietro le sbarre, ricevette una visita: quella di suo fratello, il generale Francisco Franco. 124 Ramón Franco e gli antifascisti italiani (1930-1932) I due Franco «Non ero il solo», ha scritto Giovanni Bassanesi di Ramón Franco, «a pensare che egli doveva essere in rapporti migliori di quanto non apparisse con suo fratello, il generale»11. Sospetto fondato. Apertamente, Ramón ostentava disprezzo nei confronti di Francisco Franco, all’epoca celebrato in patria come eroe della guerra coloniale in Marocco. I due fratelli erano di temperamento diverso – estroverso e scapestrato Ramón, cupo, taciturno e formale Francisco – e non erano mai andati d’accordo. Le scelte politiche di Ramón non avevano che peggiorato la situazione, tanto che i loro rapporti personali si erano ufficialmente interrotti. In realtà, come evidenziato da Paul Preston, biografo del futuro caudillo, anche dopo il 1929 i fratelli si erano comunque scambiati alcune lettere. Scorrendo tale corrispondenza, notiamo che Francisco indossa le vesti del buon fratello maggiore e, con tono paternalista, cerca di ricondurre Ramón sulla retta via12. Risulta inoltre che si sforzasse di proteggerlo dalle conseguenze delle sue azioni13. Non sappiamo se lo facesse per senso della famiglia o per calcolo. Le sregolatezze del fratello, tanto nella vita privata quanto in politica, non giovavano alla carriera dello stesso Francisco, che, peraltro, dimostrò sempre grande pazienza, dote di cui non era privo: la sua tattica era quella di cercare, nei limiti del possibile, di contenere Ramón, sperando che, prima o poi, sarebbe tornato all’ovile. E se coltivava tale speranza, dipendeva forse anche dal fatto che lo conosceva bene. Ramón non era privo di intuito politico: coglieva, per esempio, l’importanza che avrebbero assunto gli autonomismi nella società spagnola. Ma gli mancavano una strategia chiara e solide basi ideologiche. Nella sostanza, era un populista piuttosto che un democratico, incline ad adattarsi alle circostanze con abilità camaleontica, e l’esito verso cui tendeva non sembra molto diverso da un regime autoritario, vicino al modello di Mussolini più che al franchismo di suo fratello, ma comunque. Durante l’incontro avvenuto in carcere, Francisco promise a Ramón di intervenire in suo aiuto, a patto che egli troncasse ogni rapporto con l’opposizione repubblicana14. Ramón rifiutò. Il suo istinto gli suggeriva che la monarchia era in crisi e che avrebbe potuto trarre vantaggio da eventi ormai maturi. Pochi giorni dopo, clamorosamente, riusciva a evadere, aggiungendo un’ulteriore pennellata al suo ritratto di eroe avventuroso. Re125 Alberto Magnani stò alla macchia qualche settimana e ricomparve in dicembre, in tempo per partecipare alla sollevazione di Jaca e Cuatro Vientos. «Pareva un brigante della Sierra Morena», ricorda Hidalgo de Cisneros15. La sollevazione fallì e Ramón Franco dovette riparare a Parigi. Francisco gli scrisse una mesta lettera, auspicando che, un giorno, abbandonasse una volta per tutte le sue idee; e gli inviò una somma di denaro. Ramón rispose che non intendeva rinunciare ai propri ideali. E ringraziò per il denaro16. Volantini o bombe? Nel breve periodo trascorso a Parigi, Ramón Franco, ricorda sempre Hidalgo de Cisneros, era una sorta di vedette tra gli esuli spagnoli17. Tra la fine del 1930 e l’inizio del 1931, incontrò i vertici della Concentrazione Antifascista italiana e cercò di contattare Giovanni Bassanesi18. Ben presto prese forma l’organizzazione di un nuovo raid aereo. Franco proponeva un salto di qualità: non limitarsi a gettare volantini, ma sganciare bombe; e parlava di colpire Villa Torlonia, la residenza di Mussolini, a Roma. Garantiva inoltre sostegno finanziario per procurare gli apparecchi necessari. Pare che Carlo Rosselli fosse suggestionato dall’idea19. Bassanesi sarebbe stato uno dei piloti. Un altro pilota fu individuato in Lucio Labriola, figlio di Arturo, il noto esponente socialista, poi ministro nell’ultimo governo Giolitti. Vennero coinvolti anche Luca Menerini e Leo Franchetti, che si presentò a Bassanesi vantando i propri trascorsi di aviatore in Libia. Franchetti era un personaggio assai singolare: ventiquattrenne, di famiglia ebrea, dopo una crisi religiosa, seguita a un fallito tentativo di suicidio, si era convertito al cattolicesimo e si definiva «clericale monarchico antifascista». In realtà, era un confidente dell’Ovra: i suoi rapporti ci permettono di tentare una ricostruzione dell’avventurosa impresa20. I preparativi vennero interrotti dal precipitare della situazione politica in Spagna. Franco rientrò in patria, ove, il 14 aprile 1931, venne proclamata la Repubblica. Al suo arrivo, fu accolto come un eroe. Ben presto ottenne il comando dell’Aviazione militare. Intanto, nello stesso mese di aprile, Carlo Rosselli, Alberto Tarchiani e Giovanni Bassanesi raggiunsero, in automobile, Madrid per rimettere in moto il progetto21. Ramòn Franco si rimangiò le promesse di finanziare l’impresa. Millantava di potersi impadronire di qualche aereo, ma i suoi piani apparvero 126 Ramón Franco e gli antifascisti italiani (1930-1932) Ramón Franco, fratello del Caudillo, in una foto del secondo dopoguerra quando aveva del tutto abbandonato la fede antifascista. 127 Alberto Magnani alquanto fumosi22. Bassanesi, inoltre, si dichiarò contrario a un raid il cui scopo fosse un bombardamento. «Con il suo spirito di contraddizione», scrive Aldo Garosci, «cominciò con Ramòn Franco una lunga querela, in nome dell’umanità e delle vittime innocenti che una simile impresa poteva fare». Bassanesi chiese tempo per riflettere e si trattenne a Madrid, ove ebbe almeno altri due incontri con Franco. Infine i tre italiani avrebbero concordato di respingere le offerte dell’aviatore spagnolo e glielo avrebbero comunicato durante una cena ad Alcalà De Henares23, avvenuta in maggio, in occasione di un secondo viaggio in Spagna di Rosselli e Tarchiani24. Non pare peraltro che la collaborazione con Franco cessasse. Lo spagnolo garantiva comunque appoggio logistico e, verosimilmente, Rosselli mise per il momento da parte la questione se sganciare bombe o lanciare volantini. Bassanesi fu invitato a rimanere ancora in Spagna: sino al mese di luglio, infatti, rimase nella base aerea di Getafe, insieme ad altri piloti civili che seguivano corsi di volo alla scuola del comandante (grado equivalente a maggiore) Ortiz, amico di Franco25. Era questi Juan Ortiz Muñoz, un brillante pilota militare26. Intanto, scartata l’ipotesi di un volo su Roma, gli antifascisti si orientarono per ripetere un raid su Milano, partendo ancora da Lodrino, come aveva fatto Bassanesi l’anno precedente. Gli apparecchi sarebbero stati due, acquistati in Inghilterra, con denaro procurato da un industriale argentino conosciuto da Filippo Turati27. Franco metteva a disposizione piloti spagnoli per trasferire gli aerei in Austria, ove Bassanesi poteva contare su solide amicizie. Da qui sarebbero poi giunti a Lodrino. Il raid, inizialmente previsto per la data del 10 giugno 1931 (anniversario del delitto Matteotti), fu posticipato al 28 ottobre (anniversario della Marcia su Roma). Franco offriva anche un carico di bombe. Durante la permanenza di Bassanesi a Getafe, aveva in tutti i modi fatto pressioni per convincerlo ad accettare l’idea del bombardamento, ma senza successo. Bassanesi, da parte sua, aveva ricavato un’impressione sempre più negativa dell’aviatore spagnolo, avvertendo che le sue idee erano prive di basi etiche. Inoltre, con grande lucidità, comprendeva che utilizzare l’aereo come arma per un’azione terroristica sarebbe stato un errore politico. «Io ero ben favorevole all’insurrezione armata contro il fascismo, e glielo dissi. Bombardare sì, in guerra aperta, per appoggiare le truppe, o per appoggiare dei cittadini in rivolta; e bombardare comunque soltanto i centri del nemico. Ma bombardare anche una sola casa, in una città, così all’improvviso, con la quasi 128 Ramón Franco e gli antifascisti italiani (1930-1932) assoluta certezza di colpire degli innocenti, per suscitare agitazione, per fare del terrorismo: questo no»28. Tra Franco e Bassanesi si giunse infine a una brusca rottura. L’antifascista italiano, dopo aver assistito ai tentativi di Franco di provocare un’insurrezione in Andalusia, decise di lasciare la Spagna. Si diresse in Germania, dove la rete di Giustizia e Libertà riprese il progetto di un volo, esclusivamente propagandistico, con nuovi interlocutori29. Pare che Rosselli rimanesse irritato dalla partenza di Bassanesi dalla Spagna. Forse contava di poter comunque trovare una forma di collaborazione con Franco e riteneva che Bassanesi avrebbe dovuto comportarsi in modo più diplomatico ed evitare uno scontro frontale con l’aviatore. Ma la spiegazione potrebbe essere un’altra: secondo la testimonianza di Garosci30, Rosselli aveva raggiunto un’intesa con Manuel Azaña, Ministro della Guerra nel governo repubblicano. Azaña avrebbe chiuso un occhio sui preparativi per un raid aereo in partenza dalla Spagna, quindi si poteva fare a meno della collaborazione di Ramón, la cui affidabilità doveva apparire ormai scarsa. Con la partenza di Bassanesi veniva a mancare il pilota più esperto. Sarebbe allora stato addestrato al volo Fernando De Rosa, il mancato attentatore del principe Umberto a Bruxelles. De Rosa si allenava ancora all’inizio del 1932, ma finì per distruggere l’aereo in un incidente. L’ultimo tentativo Il progetto di raid con lancio di bombe era fallito, «ma Ramón Franco era di tutt’altro avviso», ricorda Bassanesi. «Per realizzare la sua idea, egli cercò subito (e lo trovò) un anarchico, che egli fece addestrare in un posto che conoscevo». L’anarchico era, con ogni probabilità, Gino Bibbi31. Franco, in quel periodo, si era avvicinato agli ambienti anarchici, con i quali stava complottando per suscitare un moto rivoluzionario in Andalusia. Nello stesso tempo, riprese i contatti con quegli ambienti dell’antifascismo italiano orientati ad azioni più decise, ossia con Facchinetti e gli elementi che gravitavano attorno alla «Giovane Italia», particolarmente irrequieti nel 1931. Oltre a Bibbi, seguirono corsi di pilotaggio, sicuramente a Getafe e sempre agli ordini di Juan Ortiz, Assunto Zamboni e Baldassare Londero32. Zamboni era fratello di Anteo, il giovane trucidato dagli squadristi, che lo accusavano di un presunto attentato contro Mussolini. L’intera famiglia 129 Alberto Magnani era stata colpita da una dura persecuzione e Assunto, dopo esser riuscito a riparare all’estero, soffriva di crisi depressive. La sua fidanzata, Graziella Roda, era una confidente dell’Ovra. Quanto a Londero, era un avventuriero, facile al doppiogioco, che finirà assassinato nel 1936 in circostanze poco chiare. A questa già singolare compagnia si aggiunse Giobbe Giopp, «un antifascista strano non solo di nome», come è stato definito33, uomo di punta della Giovane Italia, nel cui passato si collocano rapporti poco chiari, e mai del tutto chiariti, con gli inquirenti fascisti. Ma è ormai giunto il momento di chiedersi per quale motivo Ramón Franco inseguisse con tanta ostinazione il sogno di un attentato dal cielo. Una possibile spiegazione si può trovare facendo riferimento alle trame politiche dell’aviatore. In quei mesi Franco cercava di mantenere alta la temperatura rivoluzionaria della Spagna repubblicana, allo scopo di spostare su posizioni più radicali gli indirizzi del governo e crearsi così una base di potere personale. Considerando l’impressione provocata dal volo di Bassanesi dell’anno precedente, un nuovo volo, questa volta con lancio di bombe, avrebbe avuto una risonanza enorme (oggi diremmo: un impatto mediatico) in tutta Europa; e avrebbe alimentato gli entusiasmi ribellistici in Spagna34. Alla fine del 1931, pertanto, si venne a creare una bizzarra situazione: Rosselli cercava l’appoggio di Manuel Azaña, che Franco combatteva da posizioni estremiste; e Franco cercava di collaborare con i settori del fuoruscitismo che contestavano Giustizia e Libertà da posizioni ugualmente estremiste. Franco avrebbe addirittura tentato di cooptare Fernando De Rosa nel suo progetto e, pare, con qualche successo35. I maneggi di Franco stavano peraltro arrivando a un punto morto. I suoi equilibrismi tra radicali, anarchici, catalanisti, autonomisti andalusi avevano finito per provocare una diffidenza generale nei suoi confronti. Ormai si vociferava che ricevesse persino denaro da Mosca36. Il suo coinvolgimento nella fallita insurrezione di Siviglia rischiò di procurargli un arresto, da cui lo salvò solo l’immunità parlamentare: nel giugno del 1931, infatti, era stato eletto deputato alle Cortes sia a Siviglia, sia a Barcellona. Franco optò per Siviglia. Risultato: i catalani si sentirono traditi, mentre gli andalusi lo accusavano di fare segretamente il gioco dei catalani. Mentre il suo isolamento cresceva, Assunto Zamboni, trasferitosi in Svizzera dopo il corso di pilotaggio, fu indotto dalla fidanzata a consegnarsi alle autorità fasciste e a mettersi a loro disposizione, in cambio di cle130 Ramón Franco e gli antifascisti italiani (1930-1932) menza per la sua famiglia37. Londero, che si dedicava a esperimenti chimici per creare nuovi esplosivi, venne arrestato a Madrid. Le ultime speranze di realizzare un volo di propaganda con l’aiuto spagnolo si schiantarono con l’aereo di De Rosa. Il ritorno del fratel prodigo A partire dal 1932 Ramón Franco si defilò dalla politica. Rifluì nel privato: divorziò e si risposò. Nel 1934 si allineò al nuovo governo repubblicano di destra, uscito dalle elezioni del dicembre precedente. Era, comunque, un personaggio scomodo. Lo spedirono in America, come addetto militare nell’ambasciata spagnola di Washington. Il 18 luglio 1936, quando giunsero le prime notizie dell’alzamiento, Ramón rimase per breve tempo indeciso se rimanere leale alla Repubblica o meno. Alla fine, decise di passare dalla parte dei golpisti, tra i quali si sarebbe ben presto imposto suo fratello Francisco, che vide così premiata la lunga pazienza: Ramón era tornato all’ovile. Intanto, molti dei personaggi che abbiamo incontrato si schieravano con la Repubblica, a cominciare da Rosselli. Juan Ortiz, diventato nel frattempo tenente colonnello, mantenne la base di Los Alcazares sotto controllo repubblicano. Fernando De Rosa cadde in combattimento, alla testa del Battaglione Octubre, il 16 settembre 1936. Giordano Viezzoli, arruolatosi nella Squadriglia internazionale di André Malraux, cadde a sua volta il 30 settembre. Gino Bibbi si unì alle milizie anarchiche e Giobbe Giopp si mise a progettare mine per la Marina. Bassanesi non si arruolò, ma soggiornò a lungo in territorio repubblicano, cercando di svolgervi attività politica. Ramón Franco non era comunque stato accolto a braccia aperte. Molti non gli perdonavano il passato repubblicano, a cominciare da Alfredo Kindelàn, il comandante dell’aviazione franchista, lo stesso uomo che gli si era opposto nel 1929. Francisco gli affidò il comando della base aerea di Pollensa, nelle Baleari: le isole rivestivano una certa importanza dal punto di vista strategico e, nello stesso tempo, permettevano di mantenere Ramón ai margini del teatro di guerra continentale. La maggioranza delle forze aeree ivi dislocate, peraltro, erano italiane e Ramón pretese che passassero sotto il suo comando, provocando l’irritazione di Roma. Francisco, sempre per tenerlo il più possibile a prudente distanza, utilizzò il fratello anche per missioni diplomatiche all’estero. Quando Ramón si recò a Roma, Bassane131 Alberto Magnani si, indignato, pubblicò il suo libello in cui raccontava gli antichi progetti di bombardare la città. Infine Ramón si adattò al suo incarico di comandante della base di Pollensa, confermando le sue doti migliori: quelle di pilota. Doti che non lo salvarono dalla morte. La contraerea repubblicana abbatté il suo aereo, un Cant Z. 506, il 26 ottobre 1938, al largo di Minorca. I cadaveri dell’equipaggio, tra cui quello di Ramón Franco, vennero recuperati in mare nei giorni successivi. Il 31 ottobre si svolsero solenni funerali. Francisco Franco non vi assistette: si fece rappresentare da Nicolàs, il primogenito dei fratelli, e inviò un telegramma. Intorno alle circostanze della morte di Ramón fiorirono le voci più disparate38. Ma, alla fine, si preferì dimenticarlo. Note al testo 1 Joaquin Leguina, Ramón Franco: el hermano olvidado del dictador, Suma de Letras, Madrid 2002. Una precedente biografia, risalente all’immediato post-franchismo, lo presentava invece come «fratello maledetto» (Ramón Garriga, Ramón Franco, el hermano maldito, Planeta, Barcelona 1978). Di Ramón aveva inoltre parlato la vedova del dittatore, Carmen Polo Diaz, Mi vida con Ramón Franco contada a José Antonio Silva, Planeta, Barcelona 1981. 2 Rafael Fernandez De Castro Y Pedrera, El raid aéreo a Buenos Aires, «Aeroplano», 2001/19, p. 4. L’articolo in questione, riproposto nel settantacinquesimo anniversario della trasvolata, era stato scritto nel 1942: è curioso notare che la rivista «Aeroplano», pubblicata dal Ministero della Difesa spagnolo, abbia preferito rispolverare un vecchio articolo piuttosto che confrontarsi con l’imbarazzante figura di Ramón. 3 Ignacio Hidalgo De Cisneros, Cielo rosso di Spagna, Editori Riuniti, Roma 1966, p. 122. Hidalgo de Cisneros, comandante dell’aviazione repubblicana durante la guerra civile, aveva conosciuto da vicino Ramón e ne ha lasciato una vivace testimonianza in queste sue memorie (il cui titolo originale, ben diverso da quello della versione italiana, era Cambio de rumbo). 4 I cinque fratelli erano Nicolàs, nato nel 1891, Francisco, il futuro dittatore (1892), Pilar (1895), Ramón (1896) e Paz (1898), morta ancora bambina. 5 Ramón avrebbe sostituito l’idrovolante con cui doveva compiere la trasvolata, un Dornier Wal, con un altro apparecchio dello stesso modello, falsificando i numeri di matricola. Inoltre pare che ricevesse una tangente dalla Dornier perché utilizzasse un velivolo prodotto da quell’industria aeronautica. 6 Tali ambienti facevano capo a Cipriano Facchinetti e a Raffaele Rossetti, cui si aggiunse Giobbe Giopp. Il gruppo intendeva svolgere un’attività di propaganda antifascista più incisiva di quella svolta in precedenza. Cfr. Lorenzo Verdolini, La trama segreta. Il caso Sandri fra terrorismo e polizia politica fascista, Einaudi, Torino 2003, pp. 63-67. 132 Ramón Franco e gli antifascisti italiani (1930-1932) 7 Una sintesi di tali rapporti in: Marco Puppini, Il movimento operaio in Italia e in Spagna dalla Prima Internazionale alla Guerra Civile, in La Spagna nel nostro cuore. 1936-1939, AICVAS, Milano 1996, pp. 18-28. 8 Paolo Palma, Una bomba per il Duce. La centrale antifascista di Pacciardi a Lugano (19271933), Rubbettino, Soveria Mannelli 2003, p. 225. 9 A Giordano Viezzoli, che morirà combattendo con i repubblicani nel 1936, e alle sue vicende ha dedicato un ampio e appassionato studio Franco Fucci, Ali contro Mussolini. I raid aerei degli antifascisti negli anni trenta, Mursia, Milano 1978, pp. 89-136. In esso si parla anche di suo padre Giuliano, amico di Facchinetti, che fece da tramite tra il figlio e i fuorusciti. Su Giordano Viezzoli vedasi anche la documentata scheda in Angelo Emiliani, Italiani nell’aviazione repubblicana spagnola, Edizioni Aeronautiche Italiane, Firenze 1981, pp. 88-94. 10 Archivio Centrale dello Stato (d’ora in avanti ACS), Ministero degli Interni, Divisione Affari Generali e Riservati, Attività criminose nel Regno a mezzo aeroplani, rapporto di Santorre Vezzari in data 5 novembre 1930. Il riferimento ai volantini catalanisti trova riscontro nell’alleanza che si stabilì allora tra Ramón Franco e Francesc Macià, leader degli autonomisti catalani. 11 Nel 1937 Bassanesi pubblicò in Francia un opuscolo intitolato Quand Ramón Franco voulait tuer Mussolini, nel quale svelava alcuni retroscena dei rapporti fra l’aviatore spagnolo e gli antifascisti italiani. Il testo, tradotto dal francese, è integralmente riportato in appendice a FUCCI, Ali contro Mussolini cit., pp. 201-219, con il titolo Quando Ramón Franco voleva uccidere Mussolini. La frase in questione è a p. 213. 12 Paul Preston, Francisco Franco. La lunga vita del caudillo, Mondadori, Milano 1997, p. 71. 13 A quanto pare, Francisco Franco aveva sempre avuto l’abitudine di coprire le malefatte del fratello, tanto che quando, nel 1926, nacque l’unica figlia del futuro dittatore, si diffuse il pettegolezzo secondo cui la bambina era in realtà frutto di una relazione adulterina di Ramón e che Francisco l’aveva fatta passare come propria per coprire lo scandalo. Paul Preston, Palomas de guerra, Plaza y Janès, Barcelona 2001, p. 364. 14 Paul Preston, Francisco Franco cit., p. 72. 15 Hidalgo De Cisneros, Cielo rosso di Spagna cit., p. 125. 16 Paul Preston, Francisco Franco cit., p. 74. 17 Hidalgo De Cisneros, Cielo rosso di Spagna cit., p. 141. 18 Secondo Franco Fucci, Ali contro Mussolini cit., p. 56, Franco incontrò Bassanesi a Bruxelles. Nel suo scritto del 1937, però, Bassanesi afferma che Franco mancò al previsto incontro e lascia intendere di averlo conosciuto personalmente solo a Madrid (ibidem, p. 210). 19 Paolo Palma, Una bomba per il duce cit., p. 224. 20 ACS, Attività criminose nel Regno a mezzo aeroplani cit., rapporti di Franchetti in data 14 e 26 giugno 1931. Su questa base, Paolo Palma, Una bomba per il duce cit., tenta una propria ricostruzione (pp. 278-284), che però, a mio parere, prende troppo alla lettera i discorsi di Franchetti. Questi, come molti delatori, tendeva a ingigantire i fatti per aumentare il valore della «merce» che offriva all’Ovra. Propongo una ricostruzione in parte differente, utilizzando anche altre fonti. 21 Aldo Garosci, Vita di Carlo Rosselli, Edizioni U, Roma-Firenze-Milano 1945, vol. I, p. 234. 22 Quando Ramón Franco voleva uccidere Mussolini cit., p. 217. 23 Quando Ramón Franco voleva uccidere Mussolini cit., p. 218. 133 Alberto Magnani 24 Aldo Garosci, Vita di Carlo Rosselli cit., p. 236. 25 Nel suo scritto, Quando Ramón Franco voleva uccidere Mussolini, Bassanesi si riferisce spesso alla sua esperienza a Getafe. 26 Juan Ortiz, in seguito promosso tenente colonnello, assumerà il comando della base di Los Alcazares, che manterrà leale alla Repubblica allo scoppio della guerra civile. Sopravviverà alle ostilità, ma morirà in estrema miseria. Informazioni fornitemi da Carlos Lázaro, presidente dell’ADAR. 27 Paolo Palma, Una bomba per il duce cit., p. 280n, ipotizza che l’industriale fosse Torquato Di Tella, industriale italo-argentino di ferme convinzioni antifasciste. 28 Quando Ramón Franco voleva uccidere Mussolini cit., pp. 217-218. 29 Jens Petersen, Gli antifascisti italiani in Germania e il volo di Bassanesi del novembre 1931, «Il movimento di Liberazione in Italia», ottobre-dicembre 1968. 30 Aldo Garosci, Vita di Carlo Rosselli cit., p. 237. 31 Ivi, p. 238. 32 Ministero degli Interni, Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, Divisione di Polizia Politica, fascicolo Londero Baldassarre. Ivi è incluso un rapporto fiduciario, in data 11 dicembre 1931, ove si riferisce del nuovo tentativo in preparazione. Ulteriori rapporti sono datati 21 marzo, 10 aprile e 7 giugno 1932. Su Londero, cfr. Mimmo Franzinelli, I tentacoli dell’Ovra. Agenti, collaboratori e vittime della polizia politica fascista, Einaudi, Torino 1999, p. 255. 33 Romano Canosa, I servizi segreti del Duce. I persecutori e le vittime, Mondadori, Milano 2000, p. 199. 34 Nel 1948, anarchici spagnoli, capeggiati da Antonio Ortiz, cercheranno di compiere un attentato contro Franco (Francisco, naturalmente) con un aereo da turismo, secondo modalità identiche a quelle vagheggiate da Ramón diciassette anni prima, segno che il ricordo e la suggestione di quel metodo di lotta era ancora vivo presso di loro. José Manuel Marquez Rodriguez – Juan José Gallardo Romero, Ortiz. General sin Dios ni amo, Editorial Hacer, Barcelona 1999, pp. 325-331. 35 Aldo Garosci, Vita di Carlo Rosselli cit., p. 237. 36 Franco Fucci, Ali contro Mussolini cit., p. 73. Cfr. Hidalgo De Cisneros, Cielo rosso di Spagna cit., p. 165. 37 Su Graziella Roda e i suoi rapporti con Zamboni: Paolo Palma, Una bomba per il duce cit., pp. 321 ss. 38 Le voci furono alimentate dal fatto che Ramòn era decollato senza precisare gli scopi del suo volo. Una rassegna di tali voci in: Carlos Coelho, La muerte de Ramón Franco, in La Guerra Civil espanola, tomo XXX, Biblioteca El Mundo, Madrid 2005, pp. 166-167. Tra l’altro, si disse che l’aereo di Franco era stato sabotato da nazionalisti che non gli perdonavano il passato o da massoni che non gli perdonavano di aver tradito la causa repubblicana. Quest’ultima insinuazione fu, indirettamente, avvalorata da Francisco: il caudillo, infatti, scrisse la sceneggiatura di un film di propaganda, Raza, basato sulle vicende di una famiglia, nella quale era trasposta (e idealizzata) la famiglia Franco; il personaggio che rappresenta Ramòn si ravvede dalle proprie idee rivoluzionarie, ma viene ucciso dagli ex compagni. Qualcuno, di recente, ha ipotizzato che Ramón volesse fuggire in Francia. L’unica voce con qualche possibilità di fondamento è che egli volesse compiere un raid su Barcellona, ove, il 28 ottobre, era prevista la sfilata delle brigate internazionali. 134 Mio padre di Sandro Gerbi Antonello Gerbi (1904-1976) è una figura eterodossa nel panorama della cultura italiana novecentesca. Come molti altri intellettuali (Sergio Solmi, Leo Valiani, Ugo La Malfa, ecc.), ha lavorato per anni al fianco di Raffaele Mattioli presso la Banca Commerciale Italiana, ma allo stesso tempo è riuscito a coltivare i propri interessi, che poco avevano a che fare con l’attività dell’azienda di credito. Oggi è forse più noto come americanista (soprattutto grazie alle numerose traduzioni delle sue opere all’estero) che non come ex capo dell’Ufficio Studi della Comit. Nato a Firenze nel 1904, in una famiglia della buona borghesia ebraica (il padre era agente di cambio), ha vissuto prevalentemente a Milano, laureandosi però all’Università di Roma in filosofia del diritto. Nel frattempo intraprendeva un’intensa attività pubblicistica, soprattutto sulle colonne della «Giustizia», il quotidiano diretto da suo zio, il leader socialista Claudio Treves. Nel 1928 pubblicava da Laterza, auspice Benedetto Croce, il suo primo volume: La politica del Settecento, un ampio affresco delle correnti politico-filosofiche contro cui si batterono i proto-romantici tedeschi. Tra il 1929 e il 1931 fu all’estero, soprattutto a Berlino e Londra, con una doppia borsa di studio Rockefeller, propiziatagli da Luigi Einaudi e da Croce. Frutto di questi soggiorni furono due volumi, La politica del Romanticismo (Laterza), con al centro le figure di Möser, Hamann, Herder e Kant, e Il peccato di Adamo ed Eva (Ed. «La Cultura»), storia della ‘scandalosa’ ipotesi di un libertino olandese del Seicento, Adriaan Beverland, secondo cui il peccato originale non era stato altro che la cognizione carnale di Eva da parte di Adamo. Nel frattempo Gerbi aveva conosciuto Raffaele Mattioli e, seguendo i suoi consigli, a Londra aveva anche fatto pratica finanziaria presso la Midland Bank. Nel 1932 entrava dunque alla Comit, come capo dell’Ufficio Studi, e partecipava alla profonda ristrutturazione dell’azienda di credito, entrata nell’orbita dell’IRI dopo la «grande crisi». Ma nel 1938 Gerbi fu costretto dalle leggi razziali ad abbandonare l’Italia e la banca (sostituito dal suo vice, Ugo 135 Sandro Gerbi La Malfa). Mattioli lo ‘sistemò’ presso una consociata della Comit a Lima, in Perù, dove rimase fino al 1948. Fu in questo decennio che i suoi studi conobbero la svolta ‘americanistica’, con alcuni lavori sulla situazione economica del Perù e con le prime versioni in spagnolo di quello che sarebbe divenuto il suo libro più importante, La disputa del Nuovo Mondo (due edizioni Ricciardi, 1955 e 1983; ristampa Adelphi, 2000). Si tratta di un ampio panorama delle denigrazioni europee dell’America, soprattutto da un punto di vista fisico, fra il 1750 e il 1900: tipica storia delle idee, che piacque molto al ‘capostipite’ di questo orientamento, Arthur O. Lovejoy. Rientrato in Italia nel 1948, Gerbi riprese il suo posto di capo dell’Ufficio Studi fino al momento della pensione, nel 1970. Un anno prima della morte (sopravvenuta nel 1976) fece in tempo a pubblicare, sempre presso la Ricciardi, l’antefatto della ricordata polemica sette-ottocentesca, La natura della Indie Nove, saggio dedicato ai primi viaggiatori europei in America, da Cristoforo Colombo al poco noto Oviedo. Per approfondire la figura di Gerbi, si possono proficuamente leggere: la «voce» a lui dedicata nel 1999 dal Dizionario Biografico degli Italiani (di Roberto Pertici), un volume di Sandro Gerbi (Raffaele Mattioli e il filosofo domato, Einaudi, Torino 2002) e la recente guida alle sue carte, depositate a Milano, presso l’Archivio Storico di Banca Intesa (Francesca Pino e Guido Montanari, Un filosofo in banca, Ed. di Storia e Letteratura, Roma 2007). Il testo di Sandro Gerbi, che qui proponiamo, è stato letto a conclusione del convegno di studi su Antonello Gerbi tra vecchio e Nuovo Mondo, tenutosi a Milano il 27 febbraio 2007, sotto il patrocinio di Banca Intesa (oggi IntesaSanpaolo) e dell’Università degli Studi di Milano. Per definire il carattere di mio padre, non credo di commettere una forzatura se adopererò le parole pronunciate nel 1952 da Raffaele Mattioli - il suo amico più stretto - per commemorare Benedetto Croce, caro ad entrambi. Quali erano state, secondo Mattioli, le grandi «lezioni di vita» del filosofo napoletano? «la semplicità, la serena indifferenza ai titoli e agli onori, l’aborrimento d’ogni retorica, lo scrupolo assiduo del lavoro ben fatto che importa la costante disposizione a rimetterlo sul telaio, l’impavida ricerca e soprattutto l’impavida accettazione del vero»1. Sono tratti che chiunque abbia conosciuto mio padre sentirà di riconoscergli, accompagnati da una salda ma non superba coscienza dei propri meriti. Il suo mot136 Mio padre to ricorrente era infatti: «poco se mi considero, ma molto se mi comparo», il che implicava scarsissima considerazione della categoria dei soi-disants intellettuali, ma un giusto e severo senso autocritico. Non si pensi comunque ad un personaggio eccessivamente serioso: la bonaria ironia era un tratto distintivo del suo temperamento, e traspariva in modo evidente dalla sua conversazione, così come dai suoi scritti. Celebre, in famiglia, la battuta conclusiva di una sua corrispondenza dalla Germania, apparsa sul «Lavoro» (Film di spavento, 2 novembre 1929) e dedicata all’ultima produzione cinematografica tedesca. Dopo aver visto a Berlino, il film Gas asfissianti, in cui i protagonisti sono «in perpetua tensione epilettica» e alla fine cadono come mosche assieme a operai, donne, bambini, in un macabro trionfo della morte, Gerbi chiudeva catarticamente: «E ora torno a vedere Charlot che sa commuoverci senza mobilitare i cimiteri»2. Insieme, un epilogo spiritoso e un manifesto di estetica. Coerente con questo atteggiamento ‘antieroico’, il suo stile di vita: pochissima mondanità (sempre gradite però le cene casalinghe con gli amici o con i visitatori di passaggio); molta musica (concerti alla Società del Quartetto e abbonamento alla Scala); gite fuori porta o brevi viaggi all’estero con la famiglia (spesso in luoghi visitati prima della guerra); ovviamente vaste letture (rigorosamente in lingua originale); domeniche pomeriggio passate a sentir dischi con una pattuglia di fedelissimi, patiti come lui; apprezzamento di cibi e vini, nonostante la spada di Damocle di un fastidioso diabete giovanile. Ciò detto, mi soffermerò ora - in veloce sintesi - su alcuni aspetti che mi sembrano caratterizzare la vicenda umana e professionale di mio padre: l’apparente contraddizione tra la sua vita di studi e quella pratica, alla Banca Commerciale; il Perù come suo Eldorado provvidenziale, ma allo stesso tempo ovviamente come esilio indesiderato; la sua visione scettica della politica. 1. Ho alluso allo sdoppiamento (in mio padre) tra vita pratica e vita intellettuale nel titolo del libro da me dedicato alla sua amicizia con Raffaele Mattioli. Al momento dell’assunzione in banca, Gerbi fu definito da Mattioli con affettuoso sarcasmo un ‘filosofo domato’, cioè una persona che si rassegnava ad abbandonare il prediletto campo degli studi per porre le proprie doti al servizio della Comit3. Premesso che in ogni caso a mio padre non interessava l’insegnamento né lo attraeva la professione forense, e che 137 Sandro Gerbi Mattioli amava avere con sé in banca persone di vasta cultura (massimo esempio, il letterato e poeta Sergio Solmi, capo del servizio legale), c’era del vero nel paradosso mattioliano. La Comit degli anni trenta era oggetto di una radicale trasformazione e assorbiva le migliori energie di ciascun dipendente. Sicché dal 1932 al 1938, a parte nel 1933 il saggio sul Peccato di Adamo ed Eva - preparato in precedenza - mio padre non produsse nulla di scientifico e nemmeno articoli, se non una recensione per la rivista «La Cultura» (governata da Mattioli) e la cronaca di un viaggio ad Amalfi per «L’Illustrazione Italiana», entrambi nel 1934. Tenne - è vero - due corsi all’Università di Milano, fra il 1936 e il 1938, ma lo fece per ‘stabilizzare’ la sua libera docenza. Solo nel forzato soggiorno peruviano avrebbe ritrovato il tempo, il gusto e gli stimoli per rimettersi alle amate ricerche, pur cambiandone radicalmente l’orientamento. Così, dall’«europeista» - e solo grazie all’«europeista» - nacque l’«americanista». Rimaneva però nel fondo del suo animo un senso di disagio, una difficoltà intrinseca ad identificarsi con l’azienda, cosa che in apparenza riusciva invece più facilmente al suo dottissimo corrispondente e amico, Giovanni Malagodi, all’epoca direttore generale a Buenos Aires della Banque Française et Italienne pour l’Amérique du Sud (Sudameris). Così scriveva mio padre a Malagodi il 24 aprile 1944: Fortunate puer, tu, che puoi identificarti con il tuo lavoro, e dar così coerenza lineare alla tua vita! Io non mi son mai trovato in quella felice condizione. Non parliamo del banco Gerbi [attività familiare], né dello studio Dello Strologo [in cui aveva fatto pratica legale], né di altre «istituzioni» cui diedi l’opera mia [la Comit, fra il 1932 e il 1938]. Ma nemmeno identifico con la concretezza etica gli «istituti» cui sto ancora dandola [Banco de Crédito del Perú]. Milano era un gruppo di amici. Lima, un provvidenziale [c.vo mio] «intermezzo». Ma dal retrobottega di Montaigne io mi vedo nei miei uffici come un altro. È mio desiderio che quell’altro faccia il suo dovere come meglio può. E mi sforzo perché questo avvenga. Peraltro, anziché esaurirmi in quell’ufficio, custodisco gelosamente il resto dell’anima, o, empiricamente, del tempo, per studii disinteressati. E qui, in questa parola, è forse il nocciolo della questione. Il tuo interesse è tutto in un tuo lavoro; il mio in due almeno. La dispersione è quindi mia, e non tua, di te che, anche per effetto di quella concentrazione, hai ottenuto, per te, e soprattutto per l’azienda, così importanti successi. Se difendo quella «dispersione», è perché mi pare legge di vita alternare il sacro col profano, il dovere con la inclinazione e con le velleità, e, tra i doveri, il dovere professionale col dovere verso uno «spirito» che, dualisticamente, non riesco, non posso vedere (nel mio caso, ripeto) nell’analisi tecnica di dati e cifre dubbiosi, o nella redazione 138 Mio padre Antonello Gerbi nel 1946, con i figli Sandro e Daniele, nella loro casa peruviana a Lima, in Avenida Orrantia 581. convenzionale di note semi-sincere. Qui sembra che Gerbi interrompa nella lunga lettera quel che gli sta più a cuore, non se ne dimentica invece e subito riprende il tema attenuandone lo schematismo apparente: Mi rileggo, - e non vorrei dar l’impressione che stabilisco una gerarchia di qualità tra un lavoro e l’altro, che antepongo lo «studio» all’«impiego» e quindi soffro una forma volgarissima della infelicità delle zwei Seelen4. Le due attività mi sono entrambe essenziali. Non vorrei davvero essere un «puro studioso»; e mi dispiacerebbe essere un «mero impiegato». Se ho, o avrò, una qualsiasi personalità, nasce dalla somma di queste due attività basiche (e di varie altre, of course). Confido che l’esercizio dell’una giovi all’esercizio dell’altra; ed anche che, su un piano squallidamente eudemonistico, una attività consoli, distrugga, compensi per i fiaschi dell’altra. Per nulli che risultino i miei conati teorici, posso sempre sperare d’essere stato un buon impiegato5. Non ne avrebbe mai fatto un problema esistenziale, specie dopo il suo ritorno a Milano nel 1948. Fu allora che poté ritrovare l’amico di una vi139 Sandro Gerbi ta, Raffaele Mattioli - il suo ‘salvatore’, non si dimentichi -, e da lui essere costantemente stimolato e agevolato nella sua attività di studioso, oltre che di collaboratore delle edizioni Ricciardi. Ne serberà perenne gratitudine. Valgano le parole scritte a un anno dalla morte di Mattioli, nel 1974: Non c’è formula che possa racchiudere una personalità così proteiforme, così propulsiva, così schietta. Nessuno che l’abbia trovato sulla sua strada ha proseguito il cammino con lo stesso passo. Non è stato più lo stesso dopo averlo conosciuto. A nessuno, che non abbia goduto di quell’autentico «privilege», si potrà mai spiegare il come e il perché di quella sua elementarissima, semplicissima e pur trasfigurata umanità6. E valgano, un anno dopo, i due magici versi dal Vecchio marinaio di Coleridge, che mio padre volle come epigrafe accanto alla postuma dedica a Mattioli del suo ultimo libro, La natura delle Indie Nove (1975): «We were the first that ever burst / Into that silent sea», che nella traduzione di Fenoglio suonano «Noi fummo i primi che mettemmo la prua / In quel tacito mare». Noi due, insieme nei più ardui confronti, a caccia della mitica Balena Bianca, navigando «per oceani e biblioteche», uniti da una salvifica amicizia. 2. Passo ora all’esperienza peruviana. L’irridente motto di mio padre «Non perire in Perù!» mi fu riferito da Max Ascoli, altro suo vecchio amico, politologo, rifugiato da tempo negli Stati Uniti. Risale alla metà degli anni quaranta, quando la guerra era finita e mio padre anelava a rientrare in Italia. E rivela un senso di sazietà per quell’esperienza ormai troppo lunga. Solo sul finire del 1944 Gerbi comincia a intravedere uno spiraglio di luce. È ben conscio di aver goduto di una sorte privilegiata, ma la nostalgia per l’Italia è più forte che mai. Ne scrive con abbandono allo zio Alessandro Levi, rifugiatosi a Ginevra dopo l’8 settembre, con un fortunoso viaggio attraverso le Alpi: Il cataclisma, per restar nella metafora biblica del Diluvio, pare veramente stia per finire. E come superstiti dobbiamo prepararci a intonare il canto di grazie all’Eterno. Veramente, quando penso ai martiri, agli esuli, alle innumerevoli vittime, - anche solo tra le mie conoscenze, - e mi «vedo» qui nella mia biblioteca più numerosa che mai, alla fine di una domenica passata facendo una gita in macchina colla moglie, i ragazzi e la balia, intramezzata (la gita, non la balia!) da una succulenta colazione nella villa di certi amici; e ascolto venire dalla stanza da bagno le risate e le esclamazioni di Dannie, e immagino che Sandro già dorme placido nel suo lettino, e tra poco saliranno dal pian 140 Mio padre terreno le note di Bach o di Haydn, che Herma si esercita a suonare prima di cena (e anche dopo, se non c’è alla radio Toscanini, o altro consimile «rivale» di musica); e penso che domattina tornerò nel mio ufficio a fare più o meno il medesimo lavoro che da dodici anni […] e forse passerò alla Bibl.[ioteca] Universitaria o alla Nazionale, dove, come ospite d’onore, ho libero accesso a tutti gli scaffali e ottengo in prestito i volumi più rari; e tornando a casa, presso i vasi di fiori di cui ci è prodigo il giardino, troverò probabilmente, come tutti i lunedì, una cara lettera [dei fratelli Giuliano e Claudio] […], - veramente, vien quasi voglia di vergognarsi. Non mancan certo le ombre al quadro: la madre di Herma deportata e scomparsa, la sorte tristissima del nostro Paese, l’incertezza circa il futuro nostro e ora, soprattutto dei figli (dove educarli? che lingua insegnar loro?), e la rodente impazienza di riabbracciare parenti ed amici, di riveder volti e cieli e tombe, e di fermare finalmente il piede in una terra che non sia di «transito», per quanto provvidenziale7. Rivolgendosi a Mattioli il 20 maggio del 1946, la sua determinazione si farà ancora più ferma: È mia intenzione lasciare questo paese: non dico domani, né domani l’altro, ma lasciarlo sì; non perché mi ci sia trovato, o mi ci trovi male, ché anzi sotto moltissimi aspetti considero questo mio soggiorno peruviano provvidenziale [è la terza volta che lo scrive], ma perché guardando ai prossimi cinque, dieci o quindici anni, guardando a me e ai miei, trovo che il nostro posto non è qui. Restar qui altri cinque o dieci anni sarebbe un’anomalia, un assurdo, un principio di «sradicamento» non tanto per me (che ormai mi son fatto il mio vaso di coccio nel quale posso esser portato di qua e di là), quanto per i miei figli, che non hanno ancora radici, e in qualche posto dovranno pur metterle. Il nostro posto è in Italia8. Non tornerà mai in Perù. Ma sempre conserverà un senso di gratitudine nei confronti di quella patria provvisoria, ovvero «provvidenziale», come si è visto. Una gratitudine che traspare anche dall’unico cenno autobiografico presente nella Disputa del Nuovo Mondo, già nell’edizione del 1955, laddove mio padre si immedesima con Alexander von Humboldt e riconosce che la «lieve euforia» del grande naturalista-esploratore è la stessa che ancor oggi prova uno qualunque di noi quando dalle strettoie e dalle innumerevoli voci ancestrali della nostra civiltà giunga per la prima volta ai muti e abbaglianti orizzonti dell’America tropicale, agli arsi deserti costieri e ai turgidi margini intatti della gran selva continentale. Si sente rinascere. E se nella piccola, lontanissima Europa infuria proprio allora una guerra, napoleonica o hitleriana, è facile che il felicissimo profugo scopra una grossolana razionalità, una perfezione ingenua, una passabile imitazione dell’antico Eden in quel paesaggio di piatte e folte boscaglie solcate da vaste 141 Sandro Gerbi fiumane e di candide altissime vette a picco sulle arene del mare9. 3. Infine, un cenno al suo atteggiamento nei confronti della politica. A parte la scelta rivelatrice dello pseudonimo - «Don Ferrante» -, mio padre amava autodefinirsi «anarchico costituzionale», sorridendo al gioco dell’ossimoro e dei doppi sensi. E «anarchico» fu sempre, non solo nella sua attività di studioso non accademico o nelle simpatie umane, bensì anche nelle scelte politiche: antifascista, ovviamente, anche se costretto ad iscriversi al Pnf nel 1933 per poter lavorare in banca; ma troppo individualista e scettico per militare davvero in alcun partito. Nel dopoguerra votò alternativamente per i liberali di Malagodi o per i repubblicani di La Malfa, ma per pura amicizia, non per convinzione. Così scriveva infatti al cugino Piero Treves, il 19 aprile del 1968: Qui siamo in clima di vigilia elettorale, ma non c’è nessun excitement [...]. Il pericolo più grave sembra quello di un’affermazione di coloro che voteranno scheda bianca! Confesso che anch’io ho avuto tale tentazione, ma non credo vi soggiacerò, pur non sapendo ancora a quale insignificante partitucolo darò il conforto del mio voto. Il resto della famiglia socialisteggia10. Lo stesso scetticismo e lo stesso gusto per la battuta sarcastica gli fecero commettere in gioventù una clamorosa gaffe con il cugino Carlo Levi, gaffe di cui serberà l’imbarazzato ricordo per cinquant’anni: una volta almeno feci una stecca clamorosa, di cui ancora mi vergogno. Carlo mi aveva descritto con sobrio orrore le ultime efferatezze notturne dei fascisti a Torino, e io gli risposi da estetizzante (e il peggio è che non lo ero) invitandolo a godere la bellezza del verso oraziano (ahimè allora attualissimo): ut iugulent hominem surgunt de nocte latrones11. A parte questi piccoli incidenti, nulla del costume littorio - dalla rozza retorica al gallismo insolente - poteva andargli a genio. Né gli mancavano certo le credenziali antifasciste. Prescindendo dal rischioso rapporto con Benedetto Croce, documentato anche da varie carte della polizia politica, le frequentazioni socialiste erano per lui naturali, attraverso gli zii Alessandro Levi e soprattutto Claudio Treves. Fu quest’ultimo che lo presentò a Filippo Turati e ad Anna Kuliscioff. Andò talvolta a trovarla nel celebre salotto di Portici Galleria 23 a Milano e fu picchiato dagli squadristi al suo funerale, il 31 dicembre del 1925. Un anno e mezzo prima aveva parteci142 Mio padre pato alla ricerca del corpo straziato di Giacomo Matteotti nella campagna romana. Nel 1926 scriveva sul «Quarto Stato» di Nenni e Rosselli, e piangerà «con vero dolore» la morte di Gobetti12. Per non parlare delle assidue collaborazioni alla «Giustizia» e, dall’inizio di quello stesso 1926, al «Lavoro» di Genova, diretto dal socialista Giuseppe Canepa. Era ormai passato un anno dalle leggi ‘liberticide’ del gennaio del 1925, e i giornali erano sottoposti ad una severa censura. Ma il giornale di Canepa - caporedattore l’«antifascista riluttante» Giovanni Ansaldo - godeva ancora di un minimo di libertà, grazie al vecchio rapporto d’amicizia fra il direttore e Mussolini. Questa relativa autonomia toccava in particolare la ‘terza pagina’, che più facilmente sfuggiva al becero controllo dei censori. Circostanza che mio padre non mancò di sfruttare. Mi piace segnalare in questa sede - a dimostrazione di quanto sia interessante cominciare a studiare la sua produzione giornalistica giovanile - un articolo dal titolo L’origine di un’Accademia, apparso sul «Lavoro» del 5 febbraio 1926. È un capolavoro di perfidia politico-intellettuale, scritto (si pensi) a soli ventun’anni. Un mese prima, era stata istituita dal regime l’Accademia d’Italia, allo scopo «di promuovere e coordinare il movimento intellettuale italiano nel campo delle scienze, delle lettere e delle arti, di conservare puro il carattere nazionale, secondo il genio e le tradizioni della stirpe e di favorirne l’espansione e l’influsso oltre i confini dello Stato». Poco dopo il 25 luglio del 1943, Benedetto Croce avrebbe senza mezzi termini affermato che l’Accademia era stata «notoriamente creata come mezzo di allettamento e di asservimento verso gli uomini di arte e di scienza italiani, e che purtroppo» aveva «largamente esercitato il suo ufficio corruttore». «Don Ferrante» si permette di dire le stesse cose nel 1926. Però lo fa indirettamente, prendendo di mira il massimo modello storico, l’Académie Française, nel terzo centenario della sua fondazione. Ne racconta le origini, il ruolo del cardinale Richelieu nel voler asservire la letteratura allo Stato, i criteri di selezione dei primi quaranta «immortali» («l’amicizia, la parentela, la fedeltà al regime»), la loro sostanziale mediocrità, le grettezze, le beghe, la bocciatura di un vero ‘grande’ come Corneille, perché il Cid non piaceva al suddetto cardinale. Ma lo sfottò va ben oltre. A parte la preparazione di un modesto Dictionnaire, l’Académie - scrive «Don Ferrante» - ha avuto varie importanti funzioni: in primo luogo, quella nobilissima di consolare gli imbecilli, gli imbecilli ammessi, con 143 Sandro Gerbi il crisma dell’immortalità, gli imbecilli esclusi permettendo loro di unirsi alla compagnia di Descartes, di Larochefoucauld, di Pascal, di Molière, di Bourdaloue, di SaintSimon, di Diderot, di Rousseau, di Balzac, di Stendhal, di Baudelaire, di Flaubert (ecc. ecc.) che non furono degli immortali e in verità non avevano nessun bisogno di diventarlo; in secondo luogo, con le elezioni, di fornire ai salotti parigini un inesauribile argomento di chiacchiere, di pettegolezzi e d’intrighi; in terzo, far fruire 40 illustri personaggi dei vantaggi che dà la qualifica d’académiciens anche oggi che nessun Luigi XIV offre loro dei fastosi banchetti della durata di sei ore (storico!); e poi, servir di bersaglio alle arguzie e alle irrisioni [sottinteso, dei veri intellettuali, esclusi]. Il finale è feroce: Cosa voglio concludere? Per oggi niente. Se nonostante le loro malefatte e gli scherni altrui, le Accademie durano, e ne nascon anzi di nuove, una ragione ci dev’essere. E c’è, e molto semplice: poeti si nasce, accademici si diventa. Ma questo è un altro discorso. Oggi commemoro il terzo centenario dell’Académie Française13. A quanto pare, la suocera - nella sua stupidità, non nella sua indulgenza - non intese. Mi avvio ora alla conclusione. Ho iniziato ad occuparmi degli scritti di mio padre poco dopo la sua morte, avvenuta nel luglio del ’76. Dapprima ho curato per la Ricciardi la nuova edizione della Disputa del Nuovo Mondo, lasciata in una versione quasi pronta per la stampa. Ma quel «quasi» ha significato un editing durato quattro anni, in biblioteche italiane, francesi e in particolare americane, sotto l’attenta e affettuosa supervisione di Gianni Antonini e con una rilettura delle bozze fatta da quell’altro prodigio di cultura ed erudizione che fu Piero Treves. Il libro uscì nel 1983. Poi, auspice Marino Berengo, ho pubblicato vari scritti peruviani, quasi tutti inediti, per Franco Angeli: Il mito del Perù, nel 1988, e Il Perù, una storia sociale, nel 1994. Tra l’uno e l’altro, nel 1993, uscì - di nuovo da Ricciardi - Germania e dintorni, raccolta di brillanti corrispondenze giornalistiche degli anni 1929-1933, soprattutto da Berlino e da Londra. Adelphi propose nel 2000 una ristampa anastatica della Disputa e ha ora in cantiere una nuova edizione, da me curata, del Peccato di Adamo ed Eva, apparso originariamente nel 1933. Nel frattempo, sono riuscito a promuovere nuove traduzioni della Disputa (in spagnolo e in portoghese) e della Natura delle Indie Nove (in inglese e in spagnolo). Ne è valsa la pena? 144 Mio padre Una simile domanda poneva con un amaro sorriso mio padre, dedicando in limine mortis al suo cardiologo un esemplare fresco di stampa della Natura delle Indie Nove: «Al dr. Tosetti, perché giudichi se valeva la pena di lasciar in vita l’autore di questo libro»14. Se oggi qualcuno mi chiedesse se è valsa la pena di chinarmi per tanto tempo sui testi di mio padre, non avrei dubbi nel rispondere: sì, ne è valsa la pena, sia per la loro qualità intrinseca, sia per cercare di apprendere - ripercorrendo le sue opere - il rigore di un metodo di lavoro, sia per avvicinarmi alla sua personalità restia alle smancerie e avvezza (come accade in molti timidi) a celare i propri umori sotto la lieve coltre d’un sorriso. Negli ultimi tempi mio padre affermava che avrebbe avuto bisogno di altri vent’anni per finire i lavori iniziati e per riscrivere quelli giovanili. Io ho dedicato circa trent’anni alla ‘cura’ delle sue opere, nei limiti delle mie forze e delle mie competenze. E, con il passare del tempo, ho avuto la piacevole e corroborante sensazione di essere quasi riuscito a superare il naturale stacco generazionale. Il convegno odierno e il definitivo riordino delle sue carte mi affrancano ora da questo lungo labor amoris e simbolicamente suggellano il passaggio del testimone in mani diverse e più esperte: come del resto, prima o poi, sarebbe divenuto inevitabile. Grazie a voi tutti e…ad maiora. Note al testo 1 R. Mattioli, Fedeltà a Croce, all’insegna del pesce d’oro, Milano 1966, p. 12. 2 A. Gerbi, Film di spavento, «Il Lavoro», 22 novembre 1929 (riprodotto in Id., Germania e dintorni, 1929-1933, R. Ricciardi, Milano-Napoli, p. 31). 3 Cfr. S. Gerbi, Raffaele Mattioli e il filosofo domato, Einaudi, Torino 2002, pp. V-VI. 4 Allude al Faust di Goethe: «Due anime alberga il petto mio, / l’una si vuole dall’altra staccare». 5 A. Gerbi a Malagodi, Lima, 24 aprile 1944 (tutte le lettere citate si trovano nel fondo Antonello Gerbi, depositato presso l’Archivio Storico di Banca Intesa). 6 A. Gerbi, Ricordo di Raffaele Mattioli.Una sedia vuota a Milano, «Il Mondo», 18 luglio 1974 (riprodotto in S. Gerbi, Raffaele Mattioli e il filosofo domato cit., p. 214). 7 A. Gerbi ad A. Levi, Lima, 15 ottobre 1944 (sottolineatura mia). 8 A. Gerbi a R. Mattioli, Lima, 20 maggio 1946. 9 A. Gerbi, La disputa del Nuovo Mondo. Storia di una polemica (1750-1900), R. Ricciardi, Milano-Napoli 1983, pp. 568-69). 10 A. Gerbi a Piero Treves, Milano, 19 aprile 1968. 145 Sandro Gerbi 11 A Gerbi, Amico piacevole, «L’Osservatore Politico Letterario», febbraio 1975, p. 67. 12 A. Gerbi a C. Levi, Milano, 17 febbraio 1926 (ACS, Carte della Fondazione Carlo Levi). 13 Don Ferrante [A. Gerbi], L’origine di un’Accademia, 5 febbraio 1926. 14 Cfr. Piero Treves, Profilo di Antonello Gerbi, in A. Gerbi, La disputa del Nuovo Mondo cit., p. LXXI. 146 «Un ente che la scienza sposa alla propaganda». L’Istituto per gli studi di politica internazionale negli anni trenta* di Valeria Galimi Un’istituzione culturale fascista fra ambiguità e continuità La storiografia sul fascismo italiano ha da tempo confutato la nota asserzione di Norberto Bobbio, secondo la quale il fascismo non ha prodotto cultura propria1. Ne è testimonianza una ricca produzione che, da alcuni decenni, è volta a ricostruire, fra l’altro, la politica culturale del fascismo, la natura delle sue istituzioni, le liturgie e i riti collettivi messi in opera dal regime2; si tratta di temi fra i più analizzati dalla storiografia «fin da quando, alla caduta del regime, la maggior parte degli intellettuali si è impegnata in un’opera di autoassoluzione individuale e collettiva sottolineando quella che, anche in buona fede, riteneva una originaria e organica incomunicabilità tra cultura e fascismo»3. A fronte dell’interesse focalizzato principalmente sulle istituzioni e sulle personalità dell’ambiente letterario, storico e filosofico4, risultano meno indagate le istituzioni culturali legate alla tradizione delle scienze politiche e sociali. Fra queste, l’Istituto per gli studi di politica internazionale di Milano rivestì un ruolo di rilievo e costituisce un’esemplificazione del carattere di profonda ambiguità comune a molti centri culturali del fascismo italiano; l’ISPI, infatti, si mosse fra un intento propagandistico e una reale necessità di operare per il rinnovamento e la modernizzazione di apparati e organismi di politica estera, alfine di contribuire alle mire espansionistiche del regime5. A questo carattere di forte ambiguità dell’attività durante il fascismo, nel dopoguerra ha corrisposto un’immagine dell’ISPI - che nel 2004 ha festeggiato i 70 anni di esistenza - come un luogo in cui è stata preservata l’autonomia degli intellettuali che ruotavano intorno ad esso. Specchio di questa interpretazione che è stata prevalente nel secondo dopoguerra è il giudizio espresso da Ruggero Zangrandi, nel suo Il lungo viaggio attraverso il fascismo, ove egli narra il suo passato di giornalista fascista e 147 Valeria Galimi di organizzatore di cultura e traccia il proprio percorso biografico segnato dal passaggio all’antifascismo. Zangrandi, infatti, annovera la principale rivista dell’ISPI fra la «la stampa di ‘tendenza’ e di fronda». Una funzione affatto particolare svolse infine la Rassegna di politica internazionale pubblicata a Milano dall’Istituto di studi di politica internazionale e diretta da P.F. Gaslini. Va notato che l’Ispi era ispirato al noto industriale, ministro fascista, Alberto Pirelli, di cui tuttavia erano noti i legami con gli ambienti economici di Inghilterra e Francia. Sta di fatto che la Rassegna, per la larghezza e la libertà con cui ospitò documenti stranieri di politica internazionale, divenne una fonte insostituibile e preziosa per chiunque volesse avere informazioni che la stampa quotidiana ignorava o travisava6. Di contro, Ernesto Ragionieri, nella sua analisi dell’«imperialismo debole ma pericoloso» del fascismo, ha indicato come esempio dell’ampio coinvolgimento di intellettuali nelle strutture di regime proprio l’ISPI, definito il «più tipico frutto culturale della politica imperiale del fascismo»7. L’Istituto, che si proponeva di essere un luogo di aggregazione per specialisti di questioni internazionali, accettò la collaborazione di intellettuali meno legati al regime e, in alcuni casi accolse anche degli oppositori, che erano rimasti privi di altri luoghi di espressione. Fra i collaboratori delle riviste si ritrovano nomi di intellettuali notoriamente antifascisti (La Malfa, Mira, Salvatorelli), oppure di esperti scelti per le loro competenze e non per la loro posizione politica. La loro presenza, nondimeno, non modifica le posizioni di fondo dell’ISPI. Infatti, la lettura dominante dell’attività dell’Istituto come un luogo autonomo nei confronti del regime non consente di cogliere le ambiguità sottese agli scopi preposti: essere uno strumento di formazione del consenso intorno agli obiettivi di politica estera del regime e, al contempo, un valido ausilio per la formazione dei funzionari del ministero degli Esteri, attraverso l’attività di informazione e di documentazione sulla politica internazionale8. In questo breve saggio ci proponiamo di tracciare un rapido ritratto dell’Istituto e delle sue attività negli anni trenta. Sono molti gli aspetti che meriterebbero di essere analizzati in modo puntuale per indagare la natura e i caratteri di questa istituzione nel mondo culturale fascista: i rapporti di avvicinamento con la Germania nazista, le posizioni sulla guerra di Spagna, l’interesse mostrato per le esperienze che si richiamavano al fascismo internazionale, l’osservazione delle conseguenze della rivoluzione russa. In queste pagine, in particolare, ci soffermeremo sulla partecipazione 148 «Un ente che la scienza sposa alla propaganda» dell’ISPI alla propaganda in occasione dell’aggressione all’Etiopia da parte dell’Italia fascista. In questa occasione, il governo di Mussolini mobilitò stampa e istituzioni culturali per legittimare le azioni militari. «Il tentativo di contrapporre alla diplomazia una sorta di plebiscito popolare di consenso alla formazione dell’impero fu certo un aspetto della nuova strumentazione che il regime voleva utilizzare anche nella politica estera e, in linea più generale, del processo di ideologizzazione che coinvolgeva le grandi masse anche intorno a scelte di politica internazionale spesso indissociabili da scelte di regime», scrive al riguardo Enzo Collotti9. Attraverso gli articoli di riviste e le pubblicazioni, l’organizzazione di conferenze e di incontri di studio, questa istituzione porta il suo specifico contributo alla creazione di consenso intorno alla guerra d’aggressione fascista, secondo modalità e competenze proprie. «Informare per orientare»: l’attività dell’ ISPI L’ISPI avviò ufficialmente le proprie attività a Milano il 27 marzo 1934, per iniziativa di un gruppo di giovani studiosi dell’Università di Milano e di Pavia. Il gruppo dei giovani promotori, riuniti intorno alla figura di Pierfranco Gaslini10, avevano come obiettivo di creare un centro di studio sulla politica estera, sul modello del Royal Institut of International Affairs di Londra e della Foreign Policy Association di New York. L’Istituto – come si leggeva nell’articolo 1 dello statuto - «avente lo scopo di studiare e divulgare i problemi di politica internazionale» si proponeva di predisporre le seguenti attività: la formazione di raccolte di documenti e di una biblioteca specializzata; la pubblicazione di studi e di ricerche sul tema; l’istituzione di corsi di conferenze su determinati problemi di politica internazionale; l’organizzazione di manifestazioni pubbliche di promozione delle attività11. Il primo nucleo dei collaboratori dell’ISPI aveva condiviso un medesimo percorso di studio, che li aveva portati a conseguire la laurea in Giurisprudenza all’Università di Milano, e in Scienze politiche presso l’Università di Pavia. Si trattava di una generazione di venticinquenni (il direttore Gaslini era il più anziano), che non aveva vissuto direttamente l’esperienza della Grande Guerra e si era formata in una università in via di completa fascistizzazione. Quasi tutti militavano nei Guf (Gruppi universitari fascisti) milanesi, e molti di essi erano attivi anche presso la Scuola di mistica 149 Valeria Galimi fascista «Arnaldo Mussolini». Ruotavano intorno a questo gruppo fondatore altri studiosi legati al mondo accademico o giornalisti esperti di questioni di politica estera - Rodolfo Mosca, Renzo Sertoli Salis, Mario Toscano – che collaboravano in modo continuativo al periodico più importante dell’Istituto, la «Rassegna di politica internazionale», edita dal gennaio 1934 e trasformata nel 1939 in «Storia e politica internazionale»12. Il gruppo dei promotori illustrava nell’editoriale del primo numero della rivista i caratteri della pubblicazione alla base dell’attività dell’Istituto stesso, quelli di ‘obiettività e serenità’: La Rassegna che con questo numero inizia la sua vita vuol essere, mensilmente, veramente la «Rassegna» fedele di tutti gli avvenimenti e di tutti i problemi, che in questo determinato momento storico, agitano la vita dei popoli. L’obiettività assoluta è difficile da raggiungere perché ognun di noi, nella singola interiore elaborazione critica di un problema porta quelli che sono gli elementi della propria personalità, derivanti da tendenze e da posizioni ideologiche, alle quali difficile è rinunciare: purtuttavia gli articoli di differenti personalità e studiosi, che la Rassegna verrà di numero in numero pubblicando, saranno improntati per quanto umanamente possibile a quei caratteri di obiettività e serenità, in questi tempi forza prima dei popoli che aspirano a grandi mete13. Era un’obiettività che si intendeva perseguire in primo luogo attraverso la varietà dei collaboratori e delle opinioni. Peculiare della rivista era la seconda sezione, dedicata alla pubblicazione di documenti, perché, si spiegava, «uno studio serio della politica estera non può farsi che dopo una sicura conoscenza di quelli che sono i prodotti fondamentali della politica estera stessa: precisamente i documenti, intesi nel loro più lato senso»14. L’Istituto inscriveva chiaramente la propria attività nel quadro della politica culturale del fascismo: «L’interessamento sempre maggiore degli Italiani per i problemi di politica internazionale», si legge nella presentazione - «è dovuto esclusivamente al Fascismo ed a Mussolini che ha saputo elevare, a poco a poco, ma incessantemente, la posizione dell’Italia tra le potenze mondiali, sì da porla, in questo crepuscolo di principi e di metodi, nella posizione di poter prospettare idee e indicare soluzioni realistiche, e perciò benefiche»15. Di rimando, Arrigo Solmi, docente di storia del diritto a Pavia e maestro di Gaslini e di altri collaboratori dell’Istituto, all’epoca sottosegretario al ministero dell’Educazione nazionale, nonché rappresentante del governo all’inaugurazione dell’Istituto, in un articolo dal titolo Il fascismo e gli studi di politica internazionale ribadiva la duplice funzione dell’ISPI: 150 «Un ente che la scienza sposa alla propaganda» Non mai forse come nell’ora attuale fu per l’Italia presente e viva l’esigenza di uno studio approfondito e scientifico dei problemi della politica estera, nell’ora attuale, dico, allorché il Fascismo ha portato veramente e definitivamente l’Italia al grado di grande Potenza ad interessi mondiali e allorché la mirabile genialità del Duce, con lo studio profondo e con l’intuizione sicura e felice, ha saputo dare e dà a tutti quei problemi, via via che si sono presentati e si presentano, la giusta soluzione. È necessario che l’opinione pubblica sia esattamente orientata; è necessario che gli elementi atti al giudizio siano raccolti diligentemente e compresi nel loro giusto significato; è necessario che, dall’esame storico e giuridico di questi elementi di fatto, sia dato agli studiosi e ai dirigenti della politica estera la possibilità di ricercare e di trovare la giusta via di condotta16. «Informare per orientare», chiosò il direttore Gaslini e così si esprimeva nell’inaugurazione dell’anno culturale il 12 novembre 1934, in uno dei primi numeri della rivista, ribadendo che l’«Istituto agisce nell’ambito delle direttive segnate dal ministero degli Affari esteri»: Desideriamo riaffermare subito il carattere dell’Istituto: quello cioè di un ente che la scienza sposa alla propaganda. Il che significa volgarizzare, fare conoscere nel modo più diffuso, con i mezzi più opportuni, i problemi che assillano i popoli, la potenza dello Stato fascista nel mondo, le possibilità di sviluppo da dodici anni incessantemente e lentamente costruite cui le giovani generazioni, e non solo le giovani generazioni dovranno allacciarsi se vorranno che la politica di un Uomo sia nel futuro perpetuata. […] Ma […] diciamo subito perché si sappia, qui e fuori di qui, che l’Istituto agisce nell’ambito delle direttive segnate dal Ministero degli Affari esteri, i frequenti contatti col Gabinetto […], l’informazione sincera di qualsiasi nostra iniziativa; l’esame di alcune pubblicazioni più importanti da parte del Ministero, ci consentono di procedere tranquilli, sicuri di fare opera proficua nell’informazione di una cerchia sempre più larga di pubblico: informare per orientare, può essere il motto di questo istituto17. L’ISPI mirava quindi a contribuire alla volontà espansionistica del fascismo italiano, attraverso una rigorosa documentazione dell’analisi dei rapporti di forza sul piano internazionale. «Di qui il frequente oscillare tra propaganda e documentazione integrale», conclude Angelo Montenegro a proposito della contraddizione sottesa alla duplice funzione di orientamento e di informazione già richiamata e messa in opera. Dal 1935 la rivista era composta da una prima sezione intitolata Orientamenti, nella quale venivano espresse le linee guida della politica estera del regime, e da una sezione di Documenti nella quale documentazione di politica internazionale, sovente riprodotta integralmente e in lingua originale. In tal modo, la contraddizione fra obiettivi di ‘scienza’ e quelli di propaganda sembrava 151 Valeria Galimi ricomporsi, poiché si supponeva che i lettori cui erano rivolti rispettivamente i due orientamenti prestassero attenzione ad una sola sezione: infatti, il lavoro di documentazione, destinato ai funzionari del ministero degli Esteri, sarebbe apparso di scarso interesse per gli studenti e gli insegnanti delle scuole medie, lettori abituali della rivista, cui era indirizzata la prima sezione di Orientamenti, redatta con un linguaggio semplice e senza tecnicismi. Insieme alla «Rassegna di politica internazionale», l’ISPI promosse un’ampia attività editoriale, comprendente la rivista «Relazioni internazionali», divenuta un settimanale dal 1936 con una tiratura fra le 30.000 e le 75.000 copie, molte alte testate periodiche e varie collane di volumi e collane di politica internazionali; venne infine creato un Ufficio Studi e aperta una biblioteca specializzata18. Una svolta nella storia dell’Istituto fu segnata dall’incontro, nel corso del 1935, con Alberto Pirelli, industriale lombardo, diplomatico e uomo politico, che ne divenne il presidente; la sua presenza rappresentò un salto di qualità nei progetti dell’ISPI, innanzitutto per le risorse economiche che Pirelli riuscì a muovere e per il cambiamento di sede a Palazzo Clerici19. Pirelli poteva vantare una larga esperienza e competenza di questioni di politica internazionale: dopo la guerra aveva partecipato come membro della delegazione italiana alla Conferenza per la pace di Versailles; successivamente ricoprì il ruolo di negoziatore per l’Italia dei problemi inerenti alle riparazioni tedesche e ai debiti interalleati, sia a livello internazionale, sia nei rapporti diretti tra l’Italia e i paesi creditori. In queste occasioni, l’industriale milanese aveva intrattenuto rapporti con quasi tutti i maggiori politici e diplomatici europei e americani del tempo; rapporti che si dimostrarono utili anche nel decennio successivo, creando un forte legame fra l’ISPI e l’ambiente della grande industria. Dal 1935, difatti, il consiglio di amministrazione comprese alcuni importanti industriali italiani20. All’atto del suo insediamento alla presidenza, Pirelli aveva presentato in modo contraddittorio («essere indipendente, ma seguire le direttive del regime») la linea perseguita dall’istituto: «Io penso che l’ISPI per corrispondere bene al suo scopo, debba mantenere un carattere interamente indipendente dalle sfere ufficiali, ma di fatto seguirne strettamente le direttive», così egli aveva affermato21. Con la presidenza Pirelli, dunque, l’ISPI divenne un interlocutore privilegiato di alcuni settori del ministero degli Esteri. In qualità di presidente dell’Istituto Pirelli tenne nella seconda metà degli anni trenta numerose conferenze su temi di politica estera, scrivendo 152 «Un ente che la scienza sposa alla propaganda» spesso sulle riviste, e firmando prefazioni di volumi delle collane. Il presidente, nell’intervento pronunciato in occasione dell’inaugurazione del primo convegno di studi di politica estera, svoltosi nel 1936, alla presenza del ministro degli Esteri Galeazzo Ciano, illustrava la missione dell’ISPI in vista del nuovo ruolo assunto dall’Italia nello scacchiere internazionale: In questa atmosfera oscurata da incertezze e da minacce, il Duce con una politica che non conosce debolezze né esitazioni, quando sono in giuoco la dignità e gli interessi vitali del Paese, e che contemporaneamente è tutta pervasa da un’alta coscienza delle accresciute responsabilità dell’Italia come fattore di equilibrio e di pace in Europa – e il parallelismo di queste due direttive durante la guerra etiopica resterà memorabile nella storia politica e diplomatica – ha dato al nostro Paese un prestigio nel campo internazionale che è uno dei maggiori indici della sua nuova potenza. Per essere degno della posizione conquistata nella gerarchia delle Nazioni e della missione internazionale che il Duce gli addita, il popolo italiano deve e vuole allargare sempre più e rapidamente la propria separazione culturale nel campo degli studi di politica estera così da assicurare al Capo la partecipazione cosciente e fattiva di tutti gli elementi vitali e consapevoli del divenire della Nazione22. Pirelli fu consultato dallo stesso Mussolini in alcuni momenti di maggiore difficoltà dell’Italia nei rapporti internazionali; successivamente all’aggressione all’Etiopia, si recò per conto del governo italiano in Inghilterra per sondare ufficiosamente le intenzioni di Churchill e per verificare le possibilità di mediazione fra le posizioni inglesi e l’Italia23. Allo stesso tempo, il ministero degli Esteri prestò molta attenzione all’attività dell’istituto milanese24; il ministro dell’Educazione Nazionale Giuseppe Bottai allacciò stretti rapporti dal novembre 1936, affidando all’ISPI numerosi corsi di aggiornamento su questioni di politica internazionale destinati a insegnanti di scuole medie. Dal 1939 si aprì una nuova fase della storia di questo istituto, che in questa sede è possibile solo accennare. Apparvero in questo periodo nuove riviste, come «Popoli», edita dal 1941 e diretta da Carlo Morandi e Federico Chabod, in occasione del varo del nuovo programma scolastico di storia e geografia e «Geopolitica», patrocinata anch’essa dal ministro Bottai, a testimonianza dello stretto legame fra l’interesse per la geografia e la politica estera25. Sono gli anni in cui prese vita un ampio progetto di pubblicazione di una storia della politica estera italiana (Storia della politica estera italiana dal 1861 al 1914) da realizzarsi sotto la direzione di Gioacchino Volpe, 153 Valeria Galimi Walter Maturi, Federico Chabod, Carlo Morandi e Augusto Torre, con un progetto approvato da Mussolini nel 1936. Da questo momento l’attività di promozione degli studi storici dell’ISPI si mescolò a quella dell’Istituto e della Scuola per la storia moderna e contemporanea attraverso l’operato di Volpe26. Dopo la caduta del fascismo, l’Ufficio Studi dell’ISPI e i giovani collaboratori, grazie all’iniziativa di Ferruccio Parri, si costituì in Ufficio Studi del Partito d’Azione, allo scopo di studiare la pace futura, e impegnandosi in azioni di soccorso a prigionieri e internati nei campi di concentramento italiani27. Diritto alla guerra: l’aggressione militare all’Etiopia L’attacco contro l’Etiopia, il 3 ottobre 1935, è presentato come un atto di legittima difesa nei confronti di un governo accusato di fomentare i disordini alla frontiera con la Somalia. Nel corso del 1934, Mussolini aveva già manifestato l’intenzione di concentrare i propri sforzi in politica estera sulle le colonie africane. Nel dicembre 1934, Mussolini in un rapporto al maresciallo Badoglio affermò che «il tempo lavora contro di noi […]. Bisogna risolvere il problema [etiopico] il più presto possibile, l’obiettivo non può essere che la distruzione totale delle forze armate abissine e la conquista totale dell’Etiopia. L’impero non si fa altrimenti»28. La costruzione dell’Impero era dunque un obiettivo fondamentale della politica di potenza che il regime fascista mirava a mettere in atto negli anni trenta. Dopo l’attacco, l’Etiopia fece ricorso alla Società delle Nazioni, in nome dell’articolo 12 dello statuto, che prevedeva la rinuncia alla guerra come mezzo per risolvere contenziosi fra gli Stati membri. A questa presa di posizione, la diplomazia fascista rispose tempestivamente, invocando da una parte il diritto dell’Italia a trovare una soluzione autonoma, e dall’altra richiamando il carattere strettamente ‘coloniale’ del conflitto, nonché l’approvazione plebiscitaria del popolo italiano di questa azione militare. Il 7 ottobre 1935 la Società delle Nazioni riconobbe l’Italia come Stato aggressore e stabilì che fosse sottoposta a sanzioni29. A partire da questo momento, stampa e organi di regime si mossero per orchestrare una campagna di propaganda contro le «inique sanzioni»30. L’Istituto per lo studio della politica internazionale partecipò attivamente a questa campagna, per dimostrare che si trattava di una guerra coloniale e non nazionale, mettendo alla prova l’apparato di studio e di 154 «Un ente che la scienza sposa alla propaganda» divulgazione di cui si era dotato nei mesi precedenti. Nella «Rassegna di politica internazionale» ampio spazio, dagli ultimi mesi del 1934, è dedicato al conflitto italo-etiopico sia nella sezione Orientamenti, con la pubblicazione di saggi di approfondimento sia nella sezione documentaria31. Nel numero del gennaio 1935, la rivista offre una tribuna ai difensori del conflitto, che ribaltano l’accusa di non rispettare gli accordi da parte del governo etiopico, imputando allo stesso tempo alla Società delle Nazioni di non essere in grado di trovare delle soluzioni: «Si tratta in ogni modo di un tentativo, in verità poco abile, del Governo etiopico di sottrarsi alla responsabilità delle azioni dei capi che malamente si sottomettono agli ordini del Governo centrale, rovesciando la situazione di fatto: le spiegazioni fornite volontariamente dal Governo italiano alla Società delle Nazioni sono più che sufficienti per ristabilire la verità dei fatti»32, concludeva al riguardo un commentatore. Nel numero del giugno 1935, si ribadiva che l’Italia aveva contribuito a aggravare una crisi già in atto nella Società delle Nazioni: «In ogni modo, grazie alla fermezza, ma anche alla buona volontà dell’Italia, è stata evitata alla Società delle Nazioni una crisi grave, come probabilmente sarebbe avvenuto, analogamente ad altre occasioni, se la Società avesse voluto, essa stessa, entrare nel merito della questione italo-etiopica»33. Successivamente all’applicazione delle sanzioni all’Italia, si moltiplicano le proteste contro quello che viene definito un «illegale provvedimento», e si aggiunge: D’altronde, anche rimanendo su un terreno strettamente giuridico, si presenta insuperabile la considerazione che male si può parlare di violazione di integrità territoriale di uno stato quando dalla ricordata sottocommissione della Società delle Nazioni e dell’Assemblea del 1923 era stato ammesso che sui territori, rispetto ai quali l’Italia avrebbe commessa questa violazione, il governo del paese preteso aggredito non esercitava la propria autorità ed il propro dominio politico34. Nelle analisi pubblicate nella rivista dell’ISPI sono ricorrenti due argomentazioni, sovente presentate congiuntamente: la prima è si appoggia su spiegazioni giuridiche, che sottolinea che quella in atto non è una «violazione di integrità nazionale» poiché l’Etiopia di fatto non esercita il controllo del proprio territorio; l’altra motivazione, squisitamente politica, rimanda al diritto alla guerra dell’Italia fascista. Questa linea è ribadita nella rivista dall’ISPI in varie occasioni. Nel discorso tenuto il 27 febbraio all’American Club di Parigi, lo stesso presidente Pirelli asseriva: «Vorrei 155 Valeria Galimi premettere alcune considerazioni sul bisogno di espansione dell’Italia, perché seppur tale bisogno è ormai genericamente ammesso da molti, pochi, credo, si rendono conto del grado d’urgenza e dell’importanza vitale del problema»35. La posizione della Società delle Nazioni viene di fatto interpretata come strumentale per attaccare e ospporsi alla volontà di espansione di un paese «con più di 43 milioni di abitanti, con 8 milioni di soldati formidabilmente armati». La politica sanzionista tendeva infatti all’isolamento dell’Italia con l’assurdo proposito di escluderla gradatamente dal circuito delle forze internazionali. Il calcolo era piuttosto ingenuo: in una situazione come quella europea, in equilibrio perennemente instabile, nella quale il più lieve spostamento delle forze basta a determinare una oscillazione della bilancia politica, il peso di una nazione con più di 43 milioni di abitanti, con 8 milioni di soldati formidabilmente armati, non si elimina con una semplice deliberazione ginevrina36. Nello stesso numero, un contributo dello storico medievista Pietro Silva dal titolo L’Italia moderna nel Mediterraneo presentava, con accenti più contenuti, il nuovo quadro che si era andato formando nel Mediterraneo. «Le vicende del conflitto italo-etiopico hanno costituito un nuovo elemento di complicazione e di aggravamento in una situazione mediterranea che l’Inghilterra non considerava più con tranquillità già dall’epoca degli sviluppi delle forze navali e aeree italiane e dell’avvicinamento italo-francese; e hanno offerto alla politica britannica motivi e mezzi per tentare di modificare a proprio vantaggio tale situazione»37, commentava Silva, aggiungendo: «Che tutto ciò miri a premere sull’Italia e a paralizzarne l’efficacia mediterranea, è innegabile. L’Italia però si trova ormai in condizioni da poter opporre efficace resistenza, e anche reazione, alle possibili pressioni e minacce»38. L’Italia era dunque in condizione di difendersi dalle minacce che l’Inghilterra muoveva attraverso la Società delle Nazioni, al solo scopo di difendere la propria posizione di forza nell’area mediterranea. Silva pertanto concludeva che era opportuno giungere a un accordo fra i contendenti; tuttavia «il suo presupposto è che innanzi tutto si costituisca in Mediterraneo fra le grandi Potenze una situazione di forze basate sull’equilibrio e non sulla minaccia, dopo che sia stato riconosciuto il buon diritto italiano nell’Africa Orientale»39. Tutt’altri accenti mostrava l’editoriale del numero del maggio 1936, in cui si annunciava la proclamazione dell’impero; in tal modo l’Italia «entra nel gioco delle relazioni internazionali, col 156 «Un ente che la scienza sposa alla propaganda» suo peso e col suo prestigio di Potenza imperiale, vincitrice, colle sue forze, della volontà coalizzata di 52 stati civili»40. L’evento atteso si è verificato: l’Impero è dal 9 maggio realizzato. Il sogno di generazioni per il quale molti combatterono e caddero è compiuto. Esso non trova impreparati gli Italiani che da quattordici anni il Duce ha abituati a lavorare e a pensare per questa meta suprema che genio di Capo, valore di Condottieri e volontà concorde di popolo hanno in sì breve tempo realizzato. Per chi è abituato ad osservare ed a capire nel loro più logico e intimo significato lo svolgimento dei fatti internazionali, la soluzione era chiara, precisa dopo il trionfo delle armi: quella soluzione di fatto e di diritto che il Duce ha annunciato a suggello della questione etiopica. Nessuna preoccupazione d’ordine internazionale poteva influire sulle decisioni prese: la costruzione di pace, di lavoro, di civiltà di un Capo e di un popolo, non poteva essere arrestata, né interrotta senza danno altrui, specie quando avveniva in una parte dell’Africa già spiritualmente vicina al popolo italiano da cinquant’anni tanto essa fu percorsa, esplorata, bagnata dal sudore, consacrata dal sangue dei pionieri italiani41. Nell’articolo con tono trionfalistico si presenta come una via obbligata il percorso raggiunto e che ha portato il paese alla realizzazione del «sogno di generazioni» di italiani, grazie alla guida del loro Capo. Viene richiamato il passato glorioso di Roma, si considera il nuovo evento come il compimento «di una volontà nuova per una più alta giustizia tra i popoli». Il popolo italiano sa che dal nove maggio egli è soggetto della nuova storia d’Europa. Sui colli fatali di Roma è riapparso l’Impero: esso significa inevitabilmente sul continente europeo una volontà nuova per una più alta giustizia tra i popoli, un impulso potente verso una più aperta collaborazione tra gli stati per il progresso della civiltà42. In un altro articolo, Carlo Cereti, professore all’Università di Genova, ribadisce la legittimità dell’annessione dei territori e delle genti d’Etiopia, in nome della volontà del popolo italiano a costruire l’impero, una volontà che diventa fonte di «legittimità giuridica». Un passaggio del testo è particolarmente significativo: si oppone alla «legalità grettamente formale» una «giustizia vitale e sostanziale». Il voto di tutti gli italiani ha trovato nella volontà manifestata dagli organi costituzionali e legislativi il suo pieno esaudimento e la sua legittimazione giuridica. I territori e le genti che appartenevano all’Impero di Etiopia si trovano ora sotto la sovranità piena ed intera del Regno d’Italia. Per l’ordinamento giuridico italiano il nuovo stato di dirit- 157 Valeria Galimi to è perfetto e definitivo. […] Il magnifico sforzo civile e militare del popolo italiano, il suo incontestabile trionfo politico, è lo sfasciamento di quello che solo fittiziamente poteva essere considerato uno Stato, dovrebbero rimanere senza effetto per una pretesa illegittimità di quanto è irrevocabilmente avvenuto. Non rammenteremo che al di sopra della legalità grettamente formale vi è una giustizia vitale e sostanziale della quale il diritto positivo, che si vorrebbe invocare contro di noi, non sarebbe che una fredda e pallida ombra, quando addirittura non sia la negazione43. Una «giustizia» che non è priva di venature razziste, poiché si ribadisce che «conviene anzitutto rammentare che la inferiorità dello status internazionale del continente africano in genere e dell’Etiopia in ispecie, sancito a chiare note da una serie di trattati internazionali, non venne cancellata dall’ammissione dell’Etiopia alla società delle nazioni». Dopo la fuga di Hailè Selassiè sotto il regno del Negus – si concludeva - «quando l’Italia nella pienezza della sua sovranità segnò irrevocabilmente la sorte futura dei territori e delle genti d’Etiopia non violò alcuna norma internazionale, ma, sicura di sé e della capacità dei propri figli, seguì la via più diritta e più leale per il compimento della sua opera di civiltà»44. All’inizio del 1937, la rivista ritornava sulla nuova situazione creata dalla conquista dell’Etiopia. «L’Italia, infatti, attendeva da secoli la “riapparizione dell’Impero sui colli fatali di Roma”. La coscienza politica italiana, formatasi sotto la influenza della tradizione romana, è una coscienza imperiale», vi si afferma. «L’Italia inizia una politica imperiale, cioè autonoma. Le condizioni di questa autonomia sono nella forza dei suoi armamenti, che fanno dell’Italia una delle prime Potenze militari del mondo […] ma soprattutto nella volontà incrollabile di non piegarsi ad alcuna minaccia: volontà di cui ha dato prova al mondo in un’impresa che resterà ineguagliata nella storia»45. La propaganda a favore del regime si fa sempre più esplicita, come nel passaggio che segue, in cui si sostiene che era inevitabile che ripercussione del fascismo siano mondiali; la sua irradiazione non è dovuta alla propaganda, ma all’«evidenza dei fatti». Per l’Italia il Fascismo non è un’ideologia, ma la tipica espressione dei suoi ideali, la forma definitiva dell’organizzazione morale, sociale e politica rispondente alla sua natura e alle sue esigenze. Il Fascismo è un sistema prettamente italiano, nato dal genio italiano, ispirato dalla tradizione italiana, riflesso della realtà italiana. Era inevitabile tuttavia che, come tutte le grandi esperienze, le ripercussioni del Fascismo fossero mondiali. La forza rinnovatrice che si è sprigionata dalle sue formule ha spinto altri 158 «Un ente che la scienza sposa alla propaganda» popoli a mettersi sulla sua medesima via. Ciò che nondimeno distingue il Fascismo da tutti gli altri movimenti è che la sua potenza d’irradiazione non è affidata alla propaganda, sempre deformatrice e pericolosa, ma all’evidenza dei fatti46. Numerosi articoli celebrarono il primo anniversario della proclamazione dell’impero, e pure nell’anno successivo l’ISPI confermò la sua attenzione nei confronti delle questioni coloniali con numerosi interventi sulla «Rassegna» e con pubblicazioni specifiche47. «Continuerà sulla quarta sponda la mirabile rinascita della madre-patria: ne sarà un incomparabile elemento di prestigio e di forza, e proietterà fin nel centro dell’Africa il raggio della civiltà di Roma», scriveva al riguardo Nello Quilici48. Di rimando, nella prolusione tenuta dal presidente dell’Istituto Alberto Pirelli in occasione dei Corsi di aggiornamento sui problemi politici internazionali per gli insegnanti delle scuole medie superiori, organizzati dall’ISPI per incarico del ministero dell’Educazione Nazionale, ricordava che in particolare Francia e Inghilterra si erano mostrate «sospettose ed ostili verso le nazioni giovani, espansive e dinamiche, che la legge inesorabile del loro divenire spingeva a cercare fuori dei troppo angusti confini presenti la via della grandezza avvenire»49. Fra queste, si trova l’Italia. Potenze antiche e Potenze nuove debbono sentire profondamente, insieme con l’alta coscienza della propria peculiare missione, anche la legge superiore della disciplina, della reciproca comprensione, del grande impegno che incombe a tutte. Quanto a noi, ci conforta la serena certezza che l’Italia fascista vi si accinge con la fermissima volontà che muove ogni suo passo e con la intrepida fede nel suo grande Capo50. Si potrebbero moltiplicare gli esempi di espressioni meramente propagandistiche come quelle appena citate. Il modo di trattare altri temi di politica estera – la guerra di Spagna, l’alleanza con la Germania nazista, l’Unione Sovietica – potrebbe essere preso come esempio del carattere dell’attività di questo istituto, che si muove fra un intento di fornire una documentazione originale e il proposito di orientare l’opinione dei lettori. L’ISPI, «un ente che la scienza sposa alla propaganda», come il direttore Gaslini l’ha definito, mostra talvolta di avere messo la scienza al servizio della propaganda, come emerge nel caso del conflitto italo-etiopico, rivelando le ambiguità sottese alla sua autonomia dichiarata, ma di difficile realizzazione durante il fascismo. 159 Valeria Galimi Note al testo * Questo saggio è una rielaborazione di un contributo dal titolo Guerre du droit et culture fasciste: L’Istituto per gli studi di politica internazionale dans les années Trente, pubblicato nel numero speciale curato da Éric Thiers La guerre du droit 1914-1918 nella rivista «Mil Neuf Cent. Revue d’histoire intellectuelle», n. 23, 2005, pp. 167-182. 1 N. Bobbio, La cultura e il fascismo, in Guido Quazza, Fascismo e società italiana, Einaudi, Torino 1973 ora in Id., Il dubbio e la scelta. Intellettuali e potere nella società contemporanea, Carocci, Roma 2001, pp. 75-100. Per il dibattito su fascismo e cultura rinviamo a una rassegna ancora assai preziosa: Gabriele Turi, Fascismo e cultura ieri e oggi, in Il regime fascista. Storia e storiografia, a cura di Angelo Del Boca, Massimo Legnani, Mario G. Rossi, Laterza, Bari-Roma 1995, pp. 529-550. 2 Tra l’ampia bibliografia, di cui non possiamo dare conto in questa sede, segnaliamo i fondamentali lavori di Gabriele Turi, Il fascismo e il consenso degli intellettuali, il Mulino, Bologna 1980; Id., Il mecenate, il filosofo e il gesuita. «L’enciclopedia italiana» specchio della nazione, il Mulino, Bologna 2002; Luisa Mangoni, L’interventismo della cultura: intellettuali e riviste del fascismo, Laterza, Bari 1974; Mario Isnenghi, Intellettuali militanti e intellettuali funzionari. Appunti sulla cultura fascista, Einaudi, Torino 1979; Emilio Gentile, Il culto del littorio. La sacralizzazione della politica nell’Italia fascista, Laterza, Roma-Bari 1993. Fra la produzione recente sono state oggetto di discussione i contributi di Ruth Ben Ghiat, Fascist Modernities: 1922-1945, University of California press, Berkeley 2001 (tr. italiana il Mulino, Bologna 2000) e Angelo d’Orsi, La cultura a Torino fra le due guerre, Einaudi, Torino 2000. Si vedano, da ultimo, le numerose voci e lemmi sulle istituzioni culturali del regime fascista in Dizionario del fascismo, a cura di Victoria De Grazia e Sergio Luzzatto, Einaudi, Torino 2002, 2 voll. 3 Gabriele Turi, Lo Stato educatore. Politica e intellettuali nell’Italia fascista, Bari-Roma, Laterza, 2002, p. VII. 4 In merito rinvio ai numerosi lavori recensiti in Bibliografia orientativa del fascismo, a cura di Renzo De Felice, Bonacci, Roma 1991. Si veda anche il recente volume di Massimo Baioni, Risorgimento in camicia nera. Studi, istituzioni, musei nell’Italia fascista, Carocci, Roma 2006. 5 Per il quadro d’insieme della politica estera del regime fascista si rinvia a Enzo Collotti (con la collaborazione di Nicola Labanca e Teodoro Sala), Fascismo e politica di potenza. Politica estera 1922-1939, La Nuova Italia, Milano 2000 e all’ampia nota storiografico-bibliografica (ivi, pp. 467-483). Per il periodo della seconda guerra mondiale, cfr. Davide Rodogno, Il nuovo ordine mediterraneo. Le politiche di occupazione dell’Italia fascista in Europa (1940-1943), prefazione di Philippe Burrin, Bollati Boringhieri, Torino 2003. 6 Renato Zangrandi, Il lungo viaggio attraverso il fascismo. Contributo alla storia di una generazione, Mursia, Milano 1988 (1 ed. 1976), p. 486. 7 Ernesto Ragionieri, La storia politica e culturale, in Storia d’Italia, vol. IV, t. III, Einaudi, Torino, p. 2262. 8 Per la ricostruzione dell’attività dell’ISPI cfr. Angelo Montenegro, Politica estera e organizzazione del consenso. Note sull’Istituto per gli studi di politica internazionale 1933-1943, «Studi storici», aprile 1978, pp. 777-817; Enrico Decleva, Politica estera, storia, propaganda: l’ISPI di Milano e la Francia (1934-1943), in Italia e Francia 1939-1945, a cura di Jean Baptiste Duroselle, Enrico Serra, Angeli, Milano 1984, II vol., pp. 294-356 (già pubblicato in «Storia contemporanea», a. 13, nn. 4-5, ottobre 1982, pp. 697-757); si veda anche la voce di Massimo Baioni in Dizionario del fascismo cit., I v., p. 698. 9 Enzo Collotti, Fascismo e politica di potenza. Politica estera 1922-1939 cit., p. 263. 160 «Un ente che la scienza sposa alla propaganda» 10 Il primo comitato direttivo dell’Istituto risultava così composto: Gerolamo Bassani, Adriano Orlandi, Annibale Carena, Alberto De Capitani D’Arzago, Giampaolo Riboldi e Cesare Rizzini, e in qualità di segretario Pierfranco Gaslini. Questi, nato nel 1906, dopo essersi laureato in Scienze politiche a Pavia con una tesi sull’articolo 19 del trattato di Versailles, aveva svolto per qualche tempo attività di assistente presso la stessa facoltà. Aveva poi svolto un’esperienza internazionale a Ginevra presso l’Istituto di alti studi internazionali con una borsa di studio annuale della Società delle Nazioni. 11 Editoriale, «Rassegna di politica internazionale», I, marzo 1934, p. 7. 12 Cfr. Angelo Montenegro, Politica estera e organizzazione del consenso cit., pp. 783-786. Sui Gruppi Universitari Fascisti si veda il recente volume di Luca La Rovere, Storia dei Guf. Organizzazione, politica e miti della gioventù universitaria fascista (1919-1943), Bollati Boringhieri, Torino 2003. 13 Editoriale, «Rassegna di politica internazionale», I, marzo 1934, p. 3. 14 Ibidem. 15 Presentazione, «Rassegna di politica internazionale», I, marzo 1934, pp. 5-6. 16 Arrigo Solmi, Il fascismo e gli studi di politica internazionale, in «Rassegna di politica internazionale», I, 1934, pp. 11-12. 17 Vita dell’Istituto. Inaugurazione dell’anno culturale, «Rassegna di politica internazionale», I, novembre 1934, p. 613 (corsivo mio). Si veda anche Il sottosegretario della Stampa e della Propaganda, in «Rassegna di politica internazionale», I, agosto-settembre 1934, p. 378. 18 Per un elenco del gran numero dei quotidiani e riviste straniere - allora di difficile reperimento in Italia - presenti nella biblioteca dell’ISPI, cfr. Vita dell’istituto, in «Rassegna di politica internazionale», II, gennaio 1935, n. 1, pp. 62-64. 19 Cfr. la voce di Nicola Trafaglia in Dizionario del fascismo cit., pp. 383-384 e Angelo Montenegro, Diplomazia ed economia. Alberto Pirelli e la politica estera italiana, 1918-1932, in «Passato e presente», n. 22, IX (1990), pp. 55-90. Si veda anche il diario di Alberto Pirelli, Dopoguerra 1919-1932. Note ed esperienze, Tip. Ghezzi, Milano 1961. 20 Presieduto da Alberto Pirelli, dal 1935 venne istituito un Consiglio di amministrazione che comprendeva Giuseppe Bevione, Raffaele Mattioli, Gino Olivetti, Giovanni Stringher, Francesco Salata, Giuseppe Volpi di Misurata. 21 Appunti sull’ISPI. Rapporto per il consiglio direttivo, senza data ma fine 1935, in Archivio privato Pirelli, citato in A. Montenegro, Politica estera e organizzazione del consenso cit., p. 792. 22 Alberto Pirelli, Relazione inaugurale al I convegno di studi di politica estera, in Vita dell’Istituto, «Rassegna di politica internazionale», III, dicembre 1936, pp. 847-848. Per il programma del convegno Vita dell’Istituto, «Rassegna di politica internazionale», III, novembre 1936, p. 771. 23 Angelo Montenegro, Diplomazia ed economia. Alberto Pirelli e la politica estera italiana cit., p. 90. 24 Si veda a titolo d’esempio Vita dell’Istituto. Direttive del Duce al nostro istituto, «Rassegna di politica internazionale», IV, aprile 1937, pp. 351-352. 25 Angelo Montenegro, «Popoli»: un’esperienza di divulgazione storico-geografica negli anni della guerra fascista, «Italia contemporanea», n. 145, 1981, pp. 3-37; cfr. Costantino Caldo, Il territorio come dominio: la geografia italiana durante il fascismo, Napoli, Loffredo, 1982. 26 Su questo aspetto rinvio a A. Montenegro, Politica estera e organizzazione del consenso cit., 161 Valeria Galimi pp. 802 ss. 27 Cfr. in merito l’interessante testimonianza di Enrico Serra, Ferruccio Parri e l’Istituto di studi di politica internazionale negli anni quaranta, «Studi piacentini. Rivista dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea», n. 36, 2004, pp. 105-139. 28 Promemoria di Mussolini a Badoglio, 30 dicembre 1934, pubblicato in Giorgio Rochat, Militari e politici nella preparazione della campagna d’Etiopia. Studio e documenti 1932-1936, Angeli, Milano 1971, pp. 376-379 (sottolineato nel testo). 29 Sulla guerra d’Etiopia esiste oggi una vasta bibliografia; rinviamo all’ottimo volume di N. Labanca, Oltremare. Storia dell’espansione coloniale italiana, il Mulino, Bologna 2002 e alla bibliografia citata; si veda anche Giorgio Rochat, Militari e politici nella preparazione della campagna d’Etiopia. Studio e documenti cit.; Le guerre coloniali del fascismo cit.; Angelo del Boca, I gas di Mussolini. Il fascismo e la guerra d’Etiopia, Editori Riuniti, Roma 1996; e sulla propaganda Immagine coordinata per un impero: Etiopia 1935-1936, a cura di Adolfo Mignemi, Forma, Torino 1984. 30 Cfr. Mario Isnenghi, Il radioso maggio africano del «Corriere della Sera», in Id., Intellettuali militanti e, intellettuali funzionari cit., pp. 92-151; Enrica Bricchetto, La verità della propaganda. Il Corriere della Sera alla guerra d’Etiopia (1935-1936), Unicopli, Milano 2004; Marco Mozzati, Gli intellettuali e la propaganda coloniale del regime, in Le guerre coloniali del fascismo cit., pp. 99-111 (sull’Enciclopedia Italiana Treccani); N. Labanca, Riabilitare, o vendicare Adua? Storici militari nella preparazione della campagna d’Etiopia, ivi, pp. 132-169. 31 Renzo Sertoli Salis, I rapporti fra Italia e Etiopia, I, novembre 1934, pp. 594-597. 32 Orientamenti. Il conflitto italo-etiopico, «Rassegna di politica internazionale», a. II, gennaio 1935, p. 9. In merito si veda anche la sezione Documenti. La controversa italo-etiopica, «Rassegna di politica internazionale», II, aprile 1935, pp. 66-68; Documenti. Il conflitto italo-etiopico, ivi, pp. 54-57. 33 Orientamenti. La vertenza italo-etiopica ed il consiglio della società delle nazioni, «Rassegna di politica internazionale», II, giugno 1935, p. 54. 34 Cfr. Il patto e la procedura della SdN nel conflitto italo-etiopico, «Rassegna di politica internazionale», III, febbraio 1936, p. 112. 35 Alberto Pirelli, Considerazioni sul conflitto italo-etiopico, «Rassegna di politica internazionale», III, marzo 1936, p. 141. 36 Orientamenti. Il conflitto italo-etiopico e la SdN. Commento sulla politica sanzionista, «Rassegna di politica internazionale», III, aprile 1936, p. 239. 37 Pietro Silva, L’Italia moderna nel Mediterraneo, «Rassegna di politica internazionale», III, aprile 1936, p. 307. 38 Ivi, p. 310. 39 Ibidem. 40 Editoriale, «Rassegna di politica internazionale», a. III, maggio 1936, p. 325. 41 Ivi, p. 327. 42 Ivi, p. 326. 43 Carlo Cereti, La legittimità dell’annessione dei territori e delle genti dell’Etiopia, «Rassegna di politica internazionale», III, giugno, p. 460. 44 Ibidem. 162 «Un ente che la scienza sposa alla propaganda» 45 S.a, L’Italia e la situazione internazionale nel 1936, in «Rassegna di politica internazionale», IV, marzo 1937, pp. 172-180. 46 Ivi, p. 179. 47 Cfr. Pietro Silva, Il mediterraneo dall’Unità di Roma all’Impero italiano, Ispi, Milano 1938. 48 Nello Quilici, Nuova politica imperiale in Libia, «Rassegna di politica internazionale», V, febbraio 1938, pp. 66-78. 49 Alberto Pirelli, La politica delle potenze europee dopo la guerra, «Rassegna di politica internazionale», V, maggio 1938, p. 238. 50 Ivi, p. 258. 163 Africa e dintorni Italia e Etiopia: la rilettura del periodo coloniale e la valutazione delle sue conseguenze sul paese africano* di Alberto Sbacchi Introduzione Gli studiosi concordano nel ritenere che il tema della colonizzazione italiana non abbia ricevuto sufficiente attenzione e che l’Etiopia sotto la dominazione italiana sia stata a lungo trascurata come argomento di discussione. Anche per meglio comprendere gli eventi contemporanei, è necessario inoltre ritornare al coinvolgimento italiano nel Corno d’Africa. La cosa è stata resa più facile dalla visita del Presidente Oscar Luigi Scalfaro in Etiopia e dalle sue formali scuse alla popolazione etiopica per l’invasione fascista. È stata questa la prima volta che un capo di Stato italiano ha visitato un’ex-colonia e che ha accettato di riconoscere la responsabilità italiana per il massacro di 400.000 etiopici. La condanna del colonialismo italiano, nella visita di Scalfaro ad Addis Abeba il 25 novembre 1997, era un obbligo morale ed etico non solo nei confronti degli etiopici ma anche delle popolazioni della Libia e della Somalia che hanno anch’esse sofferto nel periodo del terrore fascista. È vero, come ha rilevato Angelo Del Boca che ha consigliato Scalfaro prima della partenza per l’Africa, che l’Italia vi ha apportato alcuni benefici, ma si deve anche rammentare che l’Italia ha utilizzato 350 tonnellate di gas velenosi contro gli etiopici. Altro atto ignobile nelle pagine della storia è il massacro di 6.000 etiopici a seguito dell’attentato alla vita di Graziani nel 1937. L’attentato fu seguito da un’esecuzione di massa che avvenne al monastero di Debrà Libanòs. Infine, Del Boca ha rammentato al presidente italiano lo sfruttamento dei contadini etiopici durante i cinque anni di presenza italiana in Africa. Scalfaro aveva raccolto svariate testimonianze dell’infamia delle azioni italiane. Anche l’Italia - come ha fatto il Giappone domandando il perdono ai cinesi per i 165 Alberto Sbacchi crimini commessi in Manciuria, il sudafricano Botha riconoscendo la vergogna dell’apartheid, ed il presidente francese Chirac ammettendo le azioni criminali di Vichy nei confronti del popolo ebraico - doveva ammettere il suo buio passato e chiedere alla popolazione etiopica perdono per i passati errori1. Queste scuse pubbliche sono state accettate dal presidente etiopico, Negasso Gidala. Quest’ultimo ha considerato la presenza di Scalfaro come una «storica visita» anche in ragione della restituzione promessa in quell’occasione dell’obelisco di Axum, monumento trasportato in Italia durante l’occupazione italiana. L’Italia, ha aggiunto allora Scalfaro, non doveva essere ringraziata perché questo atto era un gesto che arrivava comunque con sessant’anni di ritardo. Al suo arrivo nella capitale dell’Etiopia, Scalfaro ha spiegato di essere giunto in visita in Etiopia anche per consolidare una proficua amicizia che è stata capace di superare periodi in cui fu sostituita dagli spargimenti di sangue. Il presidente italiano ha promesso un incremento della cooperazione allo sviluppo al fine di mantenere l’Etiopia nell’attuale posizione di primo partner italiano in Africa2. Una successiva visita di Scalfaro è seguita il 27 novembre, quando egli è giunto ad Asmara dove ha pronunciato un altro discorso storico ringraziando Dio che il colonialismo fosse finito e che l’Italia volesse chiudere tutti i conti col passato e guardare alla futura collaborazione con l’Eritrea, paese col quale l’Italia aveva pure mantenuto forti legami. A confortare Scalfaro, la sua controparte, il Presidente Isaias Afwerki, ha replicato che il colonialismo è stata una cosa orribile ma che in alcuni momenti esso è stato anche una benedizione perché ha permesso al popolo eritreo di conoscere meglio gli italiani, di vivere e lavorare insieme ad essi. In risposta Scalfaro ha promesso la totale collaborazione tra Italia e Eritrea in campo culturale, economico e politico. Il Presidente italiano ha aggiunto inoltre di augurarsi l’aumento di questa collaborazione, ritenendo che il popolo e il governo eritrei abbiano contribuito alla pace nel Corno d’Africa3. La visita e l’ammissione dei passati errori dovrebbe intensificare non solo i legami culturali ed economico-politici, ma dovrebbe anche aprire la via per rivalutare la presenza italiana in Etiopia. Tradizionalmente il colonialismo italiano è stato descritto in termini negativi. Anche oggi rimane un argomento che si presta ad interpretazioni emozionali, ma dopo sessant’anni dal momento in cui è finita la seconda guerra mondiale, c’è stato abbastanza tempo per riconsiderarae l’argomento in maniera oggettiva e 166 ItaliaeEtiopia:lariletturadelperiodocolonialeelavalutazionedellesueconseguenzesulpaeseafricano non passionale da parte degli studiosi. Ciò che segue in questo studio è un tentativo di sottolineare gli aspetti positivi della presenza italiana in Etiopia., obiettivo non facile da perseguire perché a volte è difficile ottenere prove manifeste e quando esse sono disponibili risultano distorte. Genenew Assafa sottolinea che la distorsione dei fatti e delle cifre è oggi largamente diffusa, ed ha una origine remota. Nel suo libro sulla guerra italoetiopica, il compianto Paolos Gnogno riporta di aver evitato l’utilizzo di fonti etiopiche, a causa del fatto che molte di esse non coincidevano con i fatti reali. I testi etiopici in materia sono pieni di esagerazioni e il loro valore per la comprensione storica è limitato4. Allo stesso modo Gebru Taneke osserva con disappunto che vi è una maggiore conoscenza degli ecclesiastici e dei signori della guerra. Gli studi etiopici si interessano di storia sacra, ma un maggiore lavoro di ricerca deve essere compiuto riguardo ad altri temi della storia etiopica5. Anche Harold Marcus riflette sulla storiografia contemporanea rilevando le vistose mancanze rispetto alle quali gli storici possono giocare un proprio ruolo rimanendo fuori dagli affari politici e dalle polemiche, sforzandosi di raccogliere informazioni e offrire valide sintesi che possano rendere possibile l’attività di scrittura della storia6 . Un altro storico, Bahru Zewde, rileva che la storia può essere scritta solo dalla prospettiva del presente. L’Etiopia è infatti uno di quei paesi in cui la depoliticizzazione della storia è più che mai necessaria7. Nel caso della valutazione della colonizzazione italiana le osservazioni più positive sono state fatte a riguardo dell’occupazione e del dominio italiano sulle isole del Dodecaneso. Sebbene il caso non sia simile a quello delle colonie africane, ci sono importanti analogie. Le popolazioni delle isole ricordano l’amministrazione italiana con nostalgia e hanno buoni ricordi delle qualità umane italiane. Gli abitanti descrivono l’occupazione come un periodo di progresso, sviluppo, miglioramento culturale e sociale. Un aspetto negativo della dominazione italiana fu la presenza dei detestati fascisti, un fenomeno osservato anche in Etiopia dove la popolazione fu capace di differenziare tra l’italiano medio ed il fascista fanatico e razzista. Inoltre gli italiani nelle isole del Dodecaneso si sposarono liberamente con le donne del luogo che hanno definito i loro corteggiatori italiani dei «matti romantici» 8. 167 Alberto Sbacchi Lo studio del colonialismo italiano In Italia lo studio della colonizzazione italiana è stato rallentato da diversi fattori. Nel 1967 gli studiosi italiani ammettevano i limitati contributi allo studio del colonialismo. Dieci anni dopo Rainero dichiarava che in Italia l’esame critico del colonialismo italiano non aveva avuto luogo. «Questa negligenza dell’Italia post-coloniale costituiva un’evidente lacuna nella disciplina […] la storia coloniale in Italia appariva [...] un periodo chiuso riguardo al quale ciò che doveva essere detto era già stato detto»9. Tra le ragioni inerenti la mancanza di studi sul colonialismo c’è l’insoddisfacente situazione della ricerca storica in Italia e, come Rainero sottolineò al Congresso di studi africani a Roma nel 1985, ci sono sempre meno università che offrono corsi di specializzazione sull’Africa e vi è un corrispondente declino nel numero degli storici interessati a fare ricerche sulla storia coloniale italiana. Ciò influenza negativamente la storiografia italiana10. Il contesto politicizzato degli studi storici italiani e le polemiche che circondano le guerre italo-etiopiche ostacolano ulteriormente una valutazione obiettiva del colonialismo italiano. L’occupazione dell’Etiopia e la formazione dell’Impero africano da parte dell’Italia sono stati studiati in termini di politica italiana e di politica estera mussoliniana, ma pochi studiosi hanno preso in esame il periodo successivo alla conquista dell’Etiopia11. Un’altra causa del ritardo nel dibattito sul colonialismo italiano è la sconfitta dell’Italia nella seconda guerra mondiale e la conseguente perdita delle sue colonie. Da ciò ne deriva che l’Africa non sia un tema in voga tra gli storici italiani e rimane un argomento da dover dimenticare. Ma, a parte le cause psicologiche, Angelo Del Boca suggerisce che ci siano istituzioni politico-militari interessate a perpetuare il mito dei meriti del colonialismo italiano. Di conseguenza le tematiche che il regime fascista ha portato a giustificazione del colonialismo restano vive nella cultura italiana. I testi di scuola superiore in Italia perpetuano la distorsione storica, così come lo fanno i testi universitari nei quali gli studenti sono sommersi da letteratura di epoca fascista che glorifica le conquiste coloniali12. Molto rimane da fare sulla strada di una oggettiva e scientifica valutazione del colonialismo italiano. Altro ostacolo è il difficile accesso agli archivi che sono gelosamente controllati da coloro che li amministrano13. Il tema del colonialismo italiano non è stato invece dimenticato dagli studiosi stranieri, i quali hanno prodotto validi studi sull’Impero ita168 ItaliaeEtiopia:lariletturadelperiodocolonialeelavalutazionedellesueconseguenzesulpaeseafricano liano14. Donald Crummey dice che alla fine degli anni ottanta del Novecento la storiografia etiopica era più interessata al marxismo, alla struttura sociale e al conflitto, all’economia, alle relazioni di classe, ai gruppi etnici e all’antropologia sociale. «La guerra italo-etiopica è stata relegata ai margini» mentre la carestia e la storia agraria hanno carpito l’attenzione degli studiosi15. Sebbene questo mutamento di interessi sia comprensibile in virtù dei recenti avvenimenti etiopici, Bahru Zewde osserva correttamente che per comprendere gli eventi passati c’è bisogno di una prospettiva storica e che una giusta valutazione del significato storico dell’occupazione italiana è ancora di là da venire. In ogni caso è evidente che il lascito italiano non può identificarsi semplicemente, come d’abitudine, con la costruzione di strade e la prostituzione16. Zewde, che ha scritto la prima storia generale dell’Etiopia dopo quella di Jones e Monroe del 193517, dedica nel suo libro un modesto numero di pagine all’argomento dell’occupazione italiana nel 1936-41. La sua cauta e distaccata ricostruzione della dominazione italiana segna tuttavia un allontanamento dal tradizionale atteggiamento anti-italiano. Dalla sua oggettiva valutazione della presenza italiana in Etiopia è evidente che il fenomeno può ora essere valutato anche per i propri meriti. Lo studioso conclude che «la dominazione italiana non è passata senza lasciare tracce. La rete di strade, seppure in un paese minato dalla miseria, si può dire abbia facilitato l’integrazione nazionale anche se la politica italiana del dividere e governare e il ridefinizione dei confini amministrativi rimarcando le divisioni etniche e linguistiche, ha incoraggiato le tendenze centrifughe […] l’urbanizzazione ne ha guadagnato in slancio. Il trasporto motorizzato ha facilitato anch’esso la circolazione di beni e idee [...] l’indebolimento della nobiltà etiopica, incominciato con l’imperatore Hailè Selassiè, è proseguito [con gli italiani]», così che quando l’imperatore ritornò al potere poteva governare su uno stato unificato18. Allo stesso modo la colonizzazione italiana scosse drammaticamente le istituzioni feudali e il tradizionale stile di vita. Traendo profitto dal tentativo italiano di imporre un’autorità centrale di governo dappertutto in Etiopia, Hailè Selassiè, reinsediatosi sul trono, poté lanciare con solerzia la sua campagna per portare tutta la nazione sotto il proprio dominio19. 169 Alberto Sbacchi Fonti per lo studio del colonialismo italiano L’intensificarsi degli studi sull’argomento è un fattore incoraggiante così come lo è l’apertura di nuovi archivi. L’Archivio centrale di Stato è stato il primo a rendere accessibili i documenti ai ricercatori che si occupano della storia delle colonie africane dell’Italia. Le principali collezioni di interesse per gli storici sono i documenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli archivi fascisti, le carte private, l’Archivio del ministero dell’Interno, della Marina, dell’Aeronautica Militare, del Tesoro, dell’Africa Italiana e dell’Opera nazionale combattenti20. L’altra, se non la più importante fonte di informazione sul colonialismo italiano, è il ministero degli Affari Esteri con la sua documentazione sulla politica estera italiana e l’archivio di quello che fu il ministero per l’Africa Italiana. Vincenzo Pellegrini, l’archivista, ha pubblicato numerosi lavori che illustrano l’immenso valore storico di queste collezioni in alcuni casi ancora inesplorate. Pellegrini fornisce una storia della formazione del ministero delle Colonie che nel 1937 diventò ministero dell’Africa Italiana, e descrive le principali categorie documentarie nelle quali si articola. L’ostacolo nel fare ricerca agli archivi del ministero degli Affari Esteri sta nel fatto che la sala di lettura è aperta solo mezza giornata. Si tratta dell’unico grande archivio in Europa ad avere questa fastidiosa limitazione21. Gli storici hanno ora accesso anche ai documenti economici e finanziari ufficiali sulle colonie italiane che sono stati depositati al ministero delle Finanze. A causa del loro contenuto essi non erano accessibili agli studiosi fino al 1993, anno nel quale furono trasferiti all’Archivio centrali di Stato a Roma. Il loro contenuto divso in 3.000 scatole renderà possibile accertare i costi dell’Impero e delle opere realizzate dagli italiani in Africa22. Altro importante recente evento archivistico è la maggiore libertà di accesso agli archivi militari, in special modo a quelli del ministero della Difesa, dell’Aeronautica Militare e dell’Ufficio storico dello Stato Maggiore dell’Esercito. Tutti insieme, questi archivi, conservano circa 1.500 fascicoli di documenti concernenti l’attività militare italiana in Africa23. Infine, la disponibilità dei documenti dell’Archivio storico della Camera dei Deputati per il periodo che va dal 1848 al 1943 ha creato interesse fra gli studiosi24. In merito all’azione della chiesa cattolica in Etiopia, anche gli archivi della Missione della Consolata sono una miniera di informazioni, ma l’accesso deve essere di volta in volta negoziato25. Per ciò che concer170 ItaliaeEtiopia:lariletturadelperiodocolonialeelavalutazionedellesueconseguenzesulpaeseafricano ne gli archivi personali, ci sono quelli del ministro Brusasca che negoziò la riattivazione delle relazioni diplomatiche tra Italia e Etiopia. I suoi documenti sono depositati all’Archivio storico comunale di Casale Monferrato. I documenti di Brusasca integrano quelli del ministero degli Affari Esteri e dell’Istituto agronomico d’Oltremare di Firenze26. L’interesse degli studiosi nelle colonie ha reso possibile, seppur con grande ritardo, la pubblicazione dei documenti diplomatici italiani e l’inclusione di quelli che si occupano dell’azione italiana in Africa. Il progetto di pubblicazione cominciò negli anni cinquanta del Novecento per il periodo che va dall’unificazione italiana al 1943. Si tratta di documenti indispensabili disposti in ordine cronologico e sono una guida per i ricercatori che devono poi continuare il proprio lavoro negli archivi pubblici27. Questa rassegna di fonti per una valutazione del colonialismo italiano non sarebbe completa se non si menzionassero i vari congressi e conferenze che hanno trattato della presenza italiana in Africa. Giampaolo Calchi Novati fa proprio questo per il periodo che va dal 1905 ad oggi, aggiungendovi anche un’ampia analisi di ciascun evento28. Maria Rait, Vladimir Vigand29 e Rita Pankhurst30 hanno fornito un panorama dei principali argomenti discussi alla Conferenza internazionale di studi etiopici mentre Bahru Zewde31 ed altri hanno riassunto l’esito degli studi etiopici degli ultimi dieci anni. Quanto ai libri, Pietro Pastorelli offre una valutazione critica delle opere sul colonialismo italiano pubblicate negli ultimi trent’anni32. La letteratura sul colonialismo italiano non attrae l’attenzione di lettori, scrittori e case editrici; il pubblico italiano è invece più interessato agli studi sulla popolazione del Sud Africa durante il regime di apartheid, allo scrittore nigeriano Chinua Achebe, e alla lettura del libro di Kenyatta Facing Mount Kenya. Anche il senegalese David Diop è nella lista dei migliori autori stranieri. Una ragione della mancanza di attenzione da parte degli italiani per la letteratura coloniale può essere il fatto che l’Italia non è riuscita a influenzare la cultura africana e che a livello nazionale non c’era coscienza diffusa della sbandierata «missione civilizzatrice» in Africa. L’ossessiva propaganda coloniale fascista si è rapidamente dissipata dopo la seconda guerra mondiale33. Al contrario la letteratura etiopica sembra essere interessata alla presenza italiana in Etiopia e Richard Pankhurst rivela che dagli anni quaranta del Novecento ad oggi essa è importante perché rivela come siano percepite l’invasione italiana e l’occupazione, e come questi eventi continuino a condizionare la vita del popolo dell’Etiopia34. 171 Alberto Sbacchi Condizioni dell’Etiopia prima dell’invasione italiana Il colonialismo italiano non è l’unico fattore responsabile delle attuali condizioni dell’Etiopia. Come sottolinea Charles McClellan l’aspetto più importante degli sforzi etiopici di sconfiggere i propri nemici esterni è stata la lotta che ha avuto luogo all’interno dell’Etiopia stessa. Le guerre italo-etiopiche divisero profondamente gli etiopici l’uno dall’altro. Le fazioni che emersero durante la guerra erano già presenti in precedenza, ma la guerra le rafforzò e le ampliò, e queste fazioni dominarono la politica etiopica nel periodo post-bellico. Gli italiani certamente aiutarono, promossero e rafforzarono la divisione in fazioni, anche se le rivalità e il malcontento sui quali costruirono i loro sforzi erano preesistenti. Prima dell’invasione italiana, Hailè Selassiè non si sentiva sicuro dell’appoggio della nobiltà tradizionale ed in particolare delle case regnanti del Goggiam e del Tigrè, da sempre aspiranti al trono imperiale che era stato preso dal sovrano del regno di Shoa nel 1889. L’imperatore perciò tese a ridurre il loro potere e a portarle sotto la propria autorità. Nelle regioni del sud l’ostilità è stata presente fin dagli anni novanta dell’Ottocento quando queste aree furono incorporate a forza nello Stato etiopico. Lo scontento aumentò negli anni trenta del Novecento quando il sistema neftegna-gabbar significò per i contadini del sud la perdita di tutti i diritti sulle terre loro assegnate per tradizione. Quando arrivarono gli italiani molti etiopici erano insoddisfatti e c’era una flebile lealtà verso lo Stato laddove c’era un’eredità di sfruttamento ed espropriazione. Le guerre italo-etiopiche resero evidente questa debolezza nazionale. Hailè Selassiè si preoccupò della lealtà degli oromo e di altri gruppi etnici cosi come dei tradizionali rivali feudali nel Goggiam e nel Tigrè. La guerra costrinse gli etiopici a fare scelte che furono attuate in modo trasversale alle fratture etniche, di classe e religione per essere in grado di sopravvivere durante la guerra. In molti fecero scelte dettate da opportunismo prestando il proprio sostegno alle forze italiane e in altre occasioni ai resistenti etiopici. La grande maggioranza degli etiopi, in prevalenza contadini, ebbe sentimenti vari riguardo alla guerra. Alcuni membri della nobiltà, come i fratelli Kassa, negoziarono la resa agli italiani invece di combattere; gli italiani li giustiziarono ed essi diventarono eroi dall’oggi al domani. Una parte piuttosto grande della nobiltà abbandonando le ostilità o astenendosi dalla resistenza rivelava la grande insoddisfazione che numerose élite locali nutrivano nei 172 ItaliaeEtiopia:lariletturadelperiodocolonialeelavalutazionedellesueconseguenzesulpaeseafricano confronti della corona. Hailè Selassiè stesso scelse di abbandonare la nazione dopo essere stato sconfitto, primo imperatore ad arrivare a fare addirittura questo contro i consigli dei suoi più stretti consiglieri35. Come rileva Bahru Zewde, gli etiopici avrebbero preferito vedere Hailè Selassiè morire combattendo. Essi non erano particolarmente impressionati dalla sua performance alla Società delle Nazioni quando egli fece il suo discorso nel 193636. Durante il suo esilio, egli arrivò ad accarezzare l’idea di sottomettersi agli italiani. Per convenienza Hailè Selassiè, come ha rilevato Marcus, ha più tardi censurato questo fatto e ha omesso di includerlo nella sua autobiografia37. Durante il disastroso periodo 1938-1939 uno dei grandi leader della rivolta contro gli italiani, ras Abebe Aragai, negoziò la sua possibile resa con gli italiani. Gli storici interpretano questo episodio come un mero diversivo per prendere tempo a favore delle sue truppe esauste38. Per ciò che riguarda i patrioti, alcuni combatterono l’occupante per un certo periodo e poi si sottomisero quietamente ai nuovi dominatori divenendo parte dell’armata coloniale. Altri abbandonarono la famiglia e la fattoria per raggiungere la resistenza quando la tendenza della guerra mutò a favore dell’Etiopia. Per essi, sebbene combattessero gli italiani, la nozione di madrepatria era ancora vaga. Se si fosse chiesto loro per chi combattevano, essi avrebbero risposto «per la croce portata al collo, per la religione cristiana». Il loro senso di nazione si riferiva ai luoghi ad essi circostanti39. Il loro sostegno della nazione lasciava molto a desiderare; il patriottismo non era la loro massima priorità, lo era invece la sopravvivenza. Sebbene la maggior parte degli etiopici propendessero a favore dei patrioti c’erano altri che parteggiavano per gli italiani. Queste azioni non erano necessariamente opportunistiche ma riflettevano una lunga tradizionale rivalità e tensione tra il governo centrale e il popolo40. Konovaloff riporta nel suo testo Una storia d’Etiopia che i contadini del nord erano apatici, essendo principalmente interessati a preservare le loro terre, a vivere in pace ed erano soddisfatti di vendere i loro prodotti a buoni prezzi e di guadagnare qualcosa lavorando nel loro tempo libero. Gli italiani tentarono di soddisfarli per la loro stessa tranquillità e agio41. Sidney Barton, ministro inglese ad Addis Abeba, fece rapporto al Foreign Office scrivendo che le classi meno agiate etiopiche parteggiavano per l’imperatore ma consideravano i governatori dell’imperatore come degli oppressori e ritenevano di non potersi trovare in condizioni peggiori 173 Alberto Sbacchi sotto la dominazione italiana. Altri storici riportano che i contadini nella regione di Debra Tabor non erano scontenti di vedere gli italiani, almeno fino al momento in cui non ne compresero le reali intenzioni42. Patrioti e collaboratori Ciò non significa che l’umiliazione, la discriminazione e il razzismo potessero essere facilmente cancellati dalle menti delle popolazioni del Corno d’Africa e nonostante ciò al cimitero di Keren ci sono allineati allo stesso modo ascari e italiani che caddero nel 1940-41 combattendo contro le truppe inglesi. La logica coloniale non è sempre del tutto chiara, ma dal 1896 al 1935 e nel 1941 gli eritrei combatterono per lo più con convinzione per l’Italia e molti sacrificarono le proprie vite. Essi riconoscevano il loro debito con gli italiani anche se dovevano pagare un prezzo estremamente altro per essere liberi43. Bahru Zewdeafferma con chiarezza che non vi è discussione sul fatto che nella società etiopica vi siano stati collaboratori, così come vi furono ardenti patrioti fra gli intellettuali. I disertori erano persone come Takla Markos Walda Gabriel, il segretario privato di Hailè Selassiè. Un’altra eminente persona che si schierò con gli italiani fu Walde-Mariam, ministro dell’Etiopia a Parigi e capo della delegazione etiopica alla Società delle Nazioni. Un altro fu Berhame Markos, incaricato d’affari etiopico ad Ankara e Ayala Gabre, ex presidente della Corte Speciale; un altro ancora Balachew Jamanah, direttore generale delle Poste e Telecomunicazioni. Alcuni intellettuali che posero la proprie capacità letterarie al servizio dei fascisti furono Walda-Giorgis, Walda-Yohannes, e Afewok Gebre-Iyyasus, l’ultimo dei quali era anche ministro etiopico a Roma44. Ma forse il caso più controverso fu quello di Takele Wolde Hawariat, l’ex direttore della Municipalità di Addis Abeba, persona che fu anche autore nel 1931 della costituzione etiopica. Takele e gli altri esiliati che avevano ricevuto una educazione francese guardavano alla repubblica francese come modello di democrazia. Egli scrisse lettere ai leader etiopici e visitò il Goggiam e Begemder per discutere una petizione alla Società delle Nazioni, firmata da 900 patrioti, concernente il tipo di governo che essi volevano avere. Allo stesso tempo, egli esplorò la possibilità di organizzare un governo federale con l’aiuto degli italiani. Il governo coloniale italiano fu d’accordo nel dare denaro e armi al 174 ItaliaeEtiopia:lariletturadelperiodocolonialeelavalutazionedellesueconseguenzesulpaeseafricano Il degiac Nasibù Zamanuel in una foto scattata ad Harar nel dicembre del 1935 all’inizio dell’aggressione fascista all’Etiopia. Nasibù comandava il Fronte Sud dell’impero abissino ed aveva come avversario il generale Rodolfo Graziani. 175 Alberto Sbacchi Reparti dell’esercito regolare etiopico mentre si preparano a raggiungere le regioni minacciate dall’invasione italiana. Elio Barontini, il secondo da sinistra, in compagnia di alcuni capi della resistenza etiopica. Il compito di questo antifascista, che già si era segnalato nella guerra di Spagna, più che di istruire le bande abissine, fu quello di cercare di unire le varie formazioni partigiane. 176 ItaliaeEtiopia:lariletturadelperiodocolonialeelavalutazionedellesueconseguenzesulpaeseafricano Joseph e Benjamin Martin, animatori della resistenza etiopica, poco prima di essere fucilati. Il collaborazionista Taclù Mescescià, al centro con il largo cappello, partecipò alla cattura e all’impiccagione di ras Destà Damteu, genero dell’imperatore Hailè Selassiè e comandante di una delle formazioni dell’esercito regolare etiopico che continuò a combattere anche dopo la caduta di Addis Abeba. Raccolta Alberto Imperiali. 177 Alberto Sbacchi gruppo capeggiato da Tekele, ma rifiutò recisamente la loro richiesta di federazione. Lo scopo reale di Tekele, comunque, non era la collaborazione con gli italiani, ma avere l’approvazione in linea di principio al suo piano; è difficile capire come egli si aspettasse che i fascisti avrebbero accettato il suo programma. Tra le altre cose, egli contemplava l’unità di tutti i patrioti, e il fatto che essi dovessero liberare l’Etiopia con le proprie forze senza aiuto esterno. Radicale era la sua richiesta di un governo eletto a livello popolare dopo la liberazione, al posto della restaurazione di Hailè Selassiè. Alla fine non a torto sosteneva una forma federale di governo per accomodare le diversità etniche dell’Etiopia45. In conclusione Bahru Zewde sostiene che gli intellettuali ebbero una percezione realistica delle minacce all’indipendenza dell’Etiopia. Il livello di istruzione elevato non corrispondeva automaticamente ad una scelta di campo a favore della resistenza al dominio italiano, ma i patrioti sorpassavano per numero i collaborazionisti fra le persone di più alta cultura. La consapevolezza dello stato di arretratezza del paese portò alcuni a considerare la soluzione coloniale come una via che poteva accelerare i tempi dello sviluppo. Gebre-Haywot a supporto di tale convinzione nei suoi scritti comparava la situazione in cuisi trovava l’Etiopia, indipendente, con quella del Sudan governato dagli inglesi e dell’Eritrea governata dagli italiani. Ma ci furono pochi intellettuali disposti a giocarsi l’indipendenza per la causa del progresso46. Gli oromo e le altre minoranze etiopiche durante l’occupazione italiana Sulla reazione dei vari gruppi etnici alla presenza italiana non c’è un’interpretazione univoca.. Il più largo gruppo di popolazione dell’Etiopia era quello degli oromo; per ragioni politiche il governo etiopico ha deciso di ignorare la storia degli oromo47. Marcus afferma nella sua Storia dell’Etiopia che le popolazioni periferiche dello Stato non avevano riconoscimenti e apparentemente non avevano storia fino al momento in cui furono conquistati dagli etiopici alla fine del XIX secolo. Secondo McClellan, il recensore del libro di Marcus, ciò riflette una concezione imperialistica della storia48. Alcuni giovani studiosi, comunque, come Hassan Mohammed e Ahmad Abdusamal, spiegano che i wollo oromo accettarono l’islam e lo utilizzarono come ideologia di resistenza al cristianesimo e al colonialismo etiopico. Asafa Jalata insieme a Richard Greenfield, Hassa e Marcus fanno 178 ItaliaeEtiopia:lariletturadelperiodocolonialeelavalutazionedellesueconseguenzesulpaeseafricano ricorso alla storia per dimostrare che gli oromo combatterono strenuamente contro gli etiopici e li costrinsero alla difensiva tra i secoli XVI e XIX, fino a che le potenze europee non si associarono agli etiopici e mutarono l’equilibrio delle forze. Gli oromo ebbero successo durante i tre suddetti secoli perché erano fermamente decisi ad avere la meglio o morire. Successivamente, dal momento in cui i territori degli oromo furono divisi e ripartiti in regioni amministrative coloniali, gli studiosi hanno asserito che il nazionalismo oromo non esistesse in precedenza. E che invece si fosse sviluppato in risposta al potere coloniale. Jalata menziona il libro di Gada Melbaa Oromia, un’introduzione, che dimostra come il colonialismo etiopico portò alla distruzione del sistema gada in alcune società oromo e alla disintegrazione della società egualitaria della regione del Gibe. Hassan analizza il commercio, l’agricoltura e lo stabilirsi di cinque Stati oromo nel Gibe49. Malgrado il comune linguaggio, la cultura, la religione, le relazioni commerciali e un simile sistema agricolo e amministrativo, i cinque Stati del Gibe non si unirono mai in una entità politica e la loro incapacità di unire i cinque eserciti fu un fattore determinante della loro definitiva resa alle forze di Menelik50. Herbert Lewis ne La monarchia Galla, spiega la potente organizzazione della monarchia Jimma basata sul controllo dell’economia e della milizia. Jalata sostiene nel suo Oromia e Etiopia che durante la conquista gli etiopi saccheggiarono e prelevarono le risorse oromo avendo così successo nello stabilire un colonialismo di conquista che praticava il sistema neftenya-gabbar e lo schiavismo51. Parimenti, altri popoli dell’impero furono sottomessi alla forte mano del governo centrale. Il popolo gedeo negli anni venti del Novecento fu colpito da una espropriazione52 su larga scala della terra e subì l’imposizione del neftenya-gabbar. Essi coltivavano caffè, il prodotto di esportazione più importante dell’Etiopia, e oltre ad essere privati delle proprie terre, dovevano pagare le tasse ai colonizzatori del nord e al governo. In aggiunta, erano scontenti del lento avanzamento del loro status sociale e economico. L’arrivo degli italiani nel 1935-1936 fu una fortuna per il popolo gedeo53. Gli italiani erano generalmente salutati come liberatori; questi ultimi giocando su tali sentimenti riconobbero i diritti alla terra antecedenti la conquista e tolsero ogni tassa. L’occupazione italiana aiutò anche a indebolire il sistema neftenya-gabbar54. La percezione che gli italiani fossero degli oppressori era marginale, il dominio italiano parera un intermezzo abba179 Alberto Sbacchi stanza felice e la posizione economica dei gedei migliorò55. Sidney Barton, alla vigilia dell’occupazione italiana, telegrafò al Foreign Office che non era probabile che i popoli dei wolaita, arussi, oromo e kambata insorgessero contro gli amhara, ma che una volta che gli italiani avessero occupato questi territori i nativi avrebbero continuato le loro normali attività, non avrebbero interferito con i nuovi dominatori e non avrebbero fatto nulla per preservare il dominio etiopico. Egli disse che i gurage erano disposti ad associarsi alla parte che avesse promesso di più56. Complessivamente, nel sud, le popolazioni erano abbastanza tranquille sotto la dominazione italiana, e ciò era indice del fatto che tali popoli non erano meno felici sotto il dominio italiano di quanto lo fossero sotto l’amministrazione etiopica. Molti erano considerevolmente più felici e ci furono alcuni sentori di rivolta in queste aree dopo la restaurazione del controllo etiopico57. Intanto gli oromo dell’Etiopia occidentale, con il collasso del governo etiopico nel 1936, fecero appello al governo inglese affinché stabilisse un protettorato sulla regione58. Nonostante nutrissero sospetti sulle intenzioni italiane in Etiopia, gli oromo diedero un grande contributo alla conquista dell’Etiopia da parte dell’Italia fascista per ragioni di avidità, deferenza e sopravvivenza. Gli oromo araya, gli yejju e gli azebu collaborarono con le armate d’invasione italiane perché il governo etiopico rasentava la discriminazione contro di loro e perché erano fortemente tassati. I wollo oromo furono spinti dagli italiani ad allearsi con loro, ma la loro irritazione contro le politiche centralizzatrici di Hailè Selassiè fu la causa principale del loro malcontento. Quando l’imperatore fu sconfitto a Mai Chew scrisse alla propria moglie che gli oromo lo avevano aiutato solo con le urla e non con il loro forte braccio destro. Asfaw Wassen di poco scampò a un tentativo di assassinio a Dessie, e Hailè Selassiè nella sua ritirata dal fronte nord ad Addis Abeba dovette difendersi dagli attacchi degli oromo59. Questi ultimi erano generalmente trattati dagli italiani meglio degli amhara; per i loro fini politici gli italiani utilizzarono gli oromo per controbilanciare la potenza del popolo amhara. Gli oromo furono riportati nelle loro terre d’origine e i conquistatori eliminarono il sistema gabbar nel tentativo di attirarsi la lealtà degli oromo. L’oppressione degli oromo durante il dominio amhara diventò il tema centrale della propaganda italiana. Gli italiani permisero lo studio della lingua oromomyna nelle scuole oromo. A dispetto della politica pro-oromo il viceré Duca di Aosta segnalò che la popolazione oromo era disorientata e perplessa di fronte alla velocità con cui 180 ItaliaeEtiopia:lariletturadelperiodocolonialeelavalutazionedellesueconseguenzesulpaeseafricano avveniva l’occupazione italiana. Gli oromo collaborarono con gli italiani, ma rimasero diffidenti. Come gli altri popoli in Etiopia, essi diedero impressione di deferenza, ma questa durò finché l’Italia fu forte, ed è quindi da intendere come una questione di sopravvivenza60! La politica italiana del «divide et impera» aveva i propri limiti, la presenza italiana lasciava comunque un’eredità evidente che pure Hailè Selassiè doveva ammettere che aveva cambiato il suo paese. Hailè Selassiè e gli italiani Bahru Zewde fa osservare che gli anni della quarantena storica sono ora superati e gli storici possono dedicarsi a una ragionevole e spassionata valutazione del regno di Hailè Selassiè61. Una delle prime cose che il re fece mettendo piede nel proprio paese il 18 gennaio 1941 con l’aiuto della Gideon Force britannica fu quella di lanciare un appello a tutte le forze dell’Etiopia per raccogliere tutti gli italiani che si fossero arresi invitando gli etiopi a non compiere atrocità contro di essi e a dimostrare così di essere soldati con senso dell’onore e con un cuore umano62. Allo stesso modo il 5 maggio, entrando ad Addis Abeba invitò prima di tutto ad agire con pietà nei confronti dell’ex nemico: Non ricompensare il male con lo stesso male. Non commettere atti di crudeltà come quelli che i nemici hanno commesso contro di noi fino ad oggi. Non lasciare al nemico occasioni per macchiare il buon nome dell’Etiopia63. È difficile valutare le ragioni delle dichiarazioni di Hailè Selassiè in favore degli italiani. Oggi sappiamo dall’imperatore stesso che le rappresaglie non furono mai prese in considerazione. A parte le ragioni umanitarie, Hailè Selassiè può aver deciso di perdonare i suoi nemici per ragioni di praticità politica, salvando numerosi etiopi dalle mani italiane. Egli era senza dubbio preoccupato del destino di sua figlia, Tanagna Warq, tre propri nipoti in linea diretta ed un altro nipote ancora. Essi si trovavano in Italia presso la Missione della Consolata di Torino. E pure il cugino di Hailè Selassiè, ras Imru, era ancora prigioniero in Italia. In più, l’atto di clemenza sopra descritto gli diede un favorevole riconoscimento internazionale come persona attenta agli aspetti umanitari e l’apprezzamento del papa e del presidente Roosevelt, i quali avevano espresso al governo inglese la loro 181 Alberto Sbacchi preoccupazione per le vite delle popolazioni bianche64. Allo stesso modo l’imperatore era convinto di non poter condannare tutti gli italiani per il fatto che nella loro storia essi fossero stati trascinati in avventure disastrose da un uomo come Mussolini. Hailè Selassiè sosteneva che non tutti gli italiani erano criminali, e combatté contro le autorità militari inglesi che occupavano l’Etiopia, al fine di trattenere il maggior numero di italiani possibile; egli autorizzò il suo popolo a dare nascondiglio agli italiani nelle case etiopiche e nel palazzo imperiale65. Ma anche il popolo etiopico aveva imparato ad apprezzare gli italiani dopo cinque anni di coabitazione. Oltre a ciò, in molti erano diventati stanchi di uccidere e desideravano solo stabilità per le loro vite66. Così, l’appello alla compassione dell’imperatore colse la popolazione ben disposta nei confronti dell’ex-nemico. Gli italiani che vivevano ad Addis Abeba credevano che fosse la presenza di Abebe Aragai nella capitale più che i proclami di Hailè Selassiè ad averli salvati. Il leader patriottico si impegnò affinché gli italiani e le loro proprietà fossero rispettate. Egli posizionò guardie in ogni quartiere e sentinelle di fronte alle case degli italiani più in vista. Come risultato di ciò, alla fine del 1942 la Croce rossa internazionale riferì di 56 omicidi commessi contro gli italiani, di 96 italiani feriti e di 103 rapine armate, su una popolazione ad Addis Abeba di 30.000 italiani. Nel Lekept, il leader patriottico fitaurari Kumsa protesse anch’esso gli italiani e questo atteggiamento volto a dimenticare il passato si ripeté per tutta l’Etiopia67. Senza considerare chi fu l’artefice della relativamente pacifica transizione, la presenza degli italiani in Etiopia portò benefici personali ad Hailè Selassiè e anche all’Etiopia perché gli italiani assicurarono la manutenzione e l’operatività delle infrastrutture indispensabili; allo stesso tempo l’imperatore utilizzò gli italiani per controbilanciare l’influenza britannica. Hailè Selassiè imparò anche ad apprezzare gli italiani per la loro ingegnosità, creatività e operosità68. Infatti l’Italia parzialmente industrializzò l’economia dell’Etiopia e l’agricoltura fu meccanizzata. Senza gli italiani, l’Etiopia sarebbe rimasta priva di mezzi di comunicazione e produzione industriale. Un etiope che aveva combattuto contro l’occupazione italiana del suo paese ha confessato a Nasi che il popolo etiopico ricorderà per i prossimi mille anni i benefici introdotti dagli italiani. Greenfield ha scritto che, contrariamente alle comuni asserzioni, c’era una certa diffidenza nei confronti degli italiani in Etiopia, ma che, una volta dimenticato il fascismo, gli italiani non mantennero un atteggiamento razzista e negli anni del dopoguer182 ItaliaeEtiopia:lariletturadelperiodocolonialeelavalutazionedellesueconseguenzesulpaeseafricano ra furono accettati, ed addirittura apprezzati69. In queste circostanze Abebeb Aragai, Lorenzo Taezaz, il ministro degli Affari Esteri, e l’imperatore avviarono un programma per trattenere inizialmente 15.000 italiani e solo per le pressioni dei britannici il loro numero venne ridimensionato. Alla fine, con l’aiuto dell’imperatore, diverse migliaia gli italiani che poterono rimanere in Etiopia. Eugenio Pisano, amico e medico personale di Hailè Selassiè, che diede il proprio aiuto nei negoziati con gli inglesi per decidere il destino degli italiani, riferisce che gli stessi inglesi erano convinti che gli italiani e gli etiopi fossero lontani dall’odiarsi a vicenda70. Con l’aiuto degli italiani, Hailè Selassiè fu capace di combattere le mire inglesi di dichiarare l’Etiopia un protettorato temporaneo britannico. Hailè Selassiè confidò ad un suo amico italiano, l’ex ministro ad Addis Abeba Renato Piacentini e all’ingegner Ettone Bayon che gli inglesi lo consideravano un vassallo. Ironicamente gli Inglesi che avevano liberato l’Etiopia nel 1941, consideravano l’Etiopia un territorio nemico e il loro inequivoco atteggiamento razzista era calcolato per sottolineare la loro superiore posizione nello Stato. Il loro obiettivo era quello di riportare l’Etiopia ai livelli del 1935, privandola dei pochi benefici apportati dalla dominazione italiana71. Queste frizioni rinviarono la conclusione e la firma dell’accordo anglo-etiopico del 1942; Hailè Selassiè richiese il parere di Giuseppe Fabbri sulle questioni militari e legali. Per ricevere notizie di guerra indipendenti il colonnello Livi procurò a Hailè Selassiè radiotrasmettitori e due operatori, il sergente Alessandro Sala e Rolando Franciosi72. L’imperatore aveva dunque buone ragioni per rimanere in buoni rapporti con gli italiani, e ciò era particolarmente vero dopo che l’Asse ebbe attaccato l’Egitto e pare l’idea di una marcia verso l’Etiopia. Per quanto incredibile possa sembrare, prevedendo una vittoria dell’Asse, Hailè Selassiè cercò un possibile accordo con l’Italia. Con l’aiuto degli italiani in Etiopia un certo numero di confuse iniziative diplomatiche fu avviato per contattare Roma e per negoziare i termini di una possibile alleanza. Segretamente l’imperatore, Taezaz e personalità italiane furono incaricate della preparazione di una bozza di compromesso italo-etiopico. Pisano riportò a Mussolini che, nel momento in cui le truppe italiane raggiungevano El Alamein nel luglio 1942, gli inglesi erano seriamente preoccupati e gli sbigottiti etiopici aspettavano l’invasione del loro Stato da un momento all’altro. Con il permesso di Hailè Selassiè e la cooperazione di 183 Alberto Sbacchi Pisano, venne fatto filtrare che Taezaz aveva previsto di presentarsi di persona al comandante italiano in Egitto dopo l’occupazione, per essere portato a Roma e negoziare con Mussolini la sottomissione di Hailè Selassiè. Il piano di Taezaz prevedeva l’amnistia da parte dell’Italia per tutti gli etiopici, l’impiego degli etiopici istruiti nell’amministrazione italiana in Etiopia, e la partecipazione di Hailè Selassiè nel governo dell’Etiopia. Il ministro Piacentini, in un incontro con Mussolini, sostenne l’idea di dare a Hailè Selassiè una elevata posizione nell’Etiopia sotto la sovranità italiana. Mussolini ordinò a Piacentini di contattare l’imperatore e di recarsi in Etiopia attraverso il Sudan non appena le truppe italiane avessero raggiunto il Nilo. Gli etiopici erano interessati a mantenere i negoziati con l’Italia aperti e a fare piani per il futuro dell’Etiopia prima che Mussolini diventasse meno conciliante. In più, fu deciso che anche prima che le truppe italiane avessero raggiunto l’Egitto, Taezaz avrebbe incontrato in Savizzera Galeazzo Ciano, il ministro degli Esteri, per discutere tematiche di mutuo interesse italiano ed etiopico73. Le sorti della guerra non volsero a favore dell’Asse e così Hailè Selassiè tagliò ogni ulteriore contatto con gli italiani, ma ebbe successo nell’ottenere la lealtà degli italiani in Etiopia. Molti anni dopo, nel 1970, egli confidò all’ambasciatore Pascucci-Righi, in un tono di sentita emozione, che egli doveva tutto alla Gran Bretagna, per il fatto di avergli dato ospitalità durante il proprio esilio e per averlo restaurato sul trono. Comunque, egli disse che era cosa strana che gli etiopici non amassero i britannici. Due Stati erano amici dell’Etiopia e comprendevano lo Stato africano: la Francia e l’Italia. Egli sperava che i suoi successori avessero proseguito nelmantenere buoni rapporti con questi due paesi74. Hailè Selassiè: autocrate e reazionario Sebbene fosse popolare con gli italiani in Etiopia, Hailè Selassiè ebbe difficoltà a convincere il proprio popolo che egli era il legittimo governatore. Al momento del suo ritorno egli continuò la lotta, già iniziata prima del 1935, per limitare il potere della nobiltà e creare uno Stato centralizzato. Egli non comprese che gli etiopici non volevano tornare alle condizioni esistenti prima dell’occupazione italiana e che questa politica di consolidamento del proprio potere non portava allo sviluppo socio-economico75. L’imperatore immaginava di aver condotto la sua nazione sulla via di una presunta rinascita ma la maggior parte delle volte le sue idee riflette184 ItaliaeEtiopia:lariletturadelperiodocolonialeelavalutazionedellesueconseguenzesulpaeseafricano vano la volontà di tornare al passato. La creazione di un parlamento democratico fallì perché egli era maggiormente preoccupato di mantenere il suo potere personale. La sua visione dello Stato era più una visione che rispecchiava la vecchia Abissinia più che le realtà della nuova Etiopia. Le divisioni verificatesi in Etiopia durante l’occupazione italiana non furono mai completamente affrontate76. Sebbene il popolo etiopico si rivolgesse ad Hailè Selassiè con rispetto, è altrettanto vero che le nuove generazioni lo guardavano con un certo grado di ostlità. La bramosia delpotere e la volontà di conservarlo sono elementi centrali per capire Hailè Selassiè. La sua era una preoccupazione ossessiva che giungeva ai confini della megalomania. E ciò lo rendeva insensibile al potere locale. La centralizzazione politica negava l’aspirazione delle singole regioni all’autonomia interna. Da un lato l’autocrazia seguiva i principi di una politica assolutista, dall’altro l’opposizione politica mirava all’eliminazione dell’autocrazia e degli abusi di potere77. Le rivolte negli anni quaranta, cinquanta e sessanta del Novecento erano in parte il risultato di una politica discriminatoria e delle espropriazioni di terre cominciate durante il regno di Menelik78. Ulteriori cause di questa insurrezione furono identificate nei tentativi di ridurre l’autonomia nel Tigrè nel 1943-1944. La rivolta di Bale nel 1963-1970 era motivata dalla discriminazione etnica e religiosa79. Nel 1951 la prima rivoluzione guidata da Bitweded Negash mirava a stabilire una repubblica; la rivoluzione del 1960 si prefiggeva di introdurre una monarchia costituzionale80. Fronteggiando lo scontento regionale e nazionale a intervalli regolari dopo il proprio ritorno dall’esilio, Hailè Selassiè nel 1955 raggiunse l’apice del proprio potere e avrebbe potuto usare la revisione costituzionale attuata nel 1955 per avviare la transizione dall’autocrazia alla democrazia ed alla giustizia economica e sociale. Invece egli non colse i segnali e continuò a governare troppo a lungo come un reazionario81. Finché non fu troppo tardi! Gli investimenti italiani in Etiopia Quando Hailè Selassiè tornò in Etiopia dopo cinque anni di esilio trovò la sua patria trasformata dall’occupazione italiana. Egli fu piacevolmente sorpreso di ciò che vide; difficilmente poteva riconoscervi la vecchia Etiopia. Durante la sua visita a Jimma nel marzo 1944 promise alla popolazione che il suo governo avrebbe aiutato a mantenere le iniziative di svi185 Alberto Sbacchi luppo che l’amministrazione italiana ricca di fondi aveva intrapreso82. Un professionista del Corno d’Africa, riflettendo sui contributi della presenza italiana in Etiopia, ha riconosciuto oggi gli aspetti positivi e avrebbe voluto che gli italiani fossero rimasti più tempo in Etiopia83. Un altro ha ammesso che tutte le infrastrutture dell’ex Impero italiano erano state costruite dall’Italia senza alcun costo per le popolazioni locali84. Il britannico lord Hailey ha lodato il lavoro e gli investimenti italiani in Etiopia: «l’Italia ha mostrato una così vasta energia e liberalità nell’approvvigionamento finanziario che non vi è analogia nella storia dell’Africa» 85. I francesi hanno rilevato la liberalità italiana nelle colonie e hanno concluso che l’Italia ha speso più denaro nelle colonie di quanto non ne abbia ricavato. L’Italia ha speso dieci volte più denaro di quanto non ne abbia ottenuto indietro86. La storiografia contemporanea supporta queste affermazioni. L’Italia spese un grosso ammontare di denaro per il suo impero, era in ciò all’avanguardia in Europa, e investì con munificenza in Etiopia per la costruzione di strutture civili e amministrative e per lavori pubblici87. Calchi-Novati conclude che a fronte del fatto che sul colonialismo italiano pesava un giudizio negativo, l’Etiopia ricevette dalla presenza italiana alcuni vantaggi che hanno in parte riparato le ingiustizie subite88. John Spencer, al suo ritorno in Etiopia nel 1941 fu sorpreso di vedere che ad Addis Abeba c’era acqua corrente nei bagni, elettricità, telefoni che funzionavano e muri intonacati89. Hailè Selassiè apprezzò il know-how italiano e lo utilizzò per il mantenimento delle strade e delle industrie, e nella costruzione di lavori pubblici. Ebbe quale dipendente Cesare Branca all’acquedotto, Federico Bazzi alla centrale elettrica e Mario Buschi al dipartimento dei lavori pubblici. Affidò all’architetto Arturo Mezzedini il compito di progettare e costruire 72 edifici scolastici. Subito dopo, a Mezzedini fu affidato il compito di progettare il Municipio, gli edifici della Banca Commerciale, le sedi del Finfin e del Consiglio nazionale. Infine l’impresario edile Mario Buschi restaurò il palazzo di Menelik e più tardi costruì il Parlamento90. Hailè Selassiè era conscio che senza i duemila camion Lancia e Fiat, in mani italiane, ogni commercio e comunicazione si sarebbe arrestato91. È difficile quantificare l’esatto ammontare di quanto l’Italia investì in Etiopia. Giglio rileva che tra 1936-1941 il budget ordinario e straordinario era di cinque miliardi di lire. A questa cifra devono essere aggiunte le spese delle istituzioni riconosciute dallo Stato operanti in Etiopia che ricevevano 186 ItaliaeEtiopia:lariletturadelperiodocolonialeelavalutazionedellesueconseguenzesulpaeseafricano sussidi governativi, e le entità private. Queste spese erano aumentate dal budget militare che solitamente assorbiva una grande quantità di denaro92. I dati archivistici portano alla conclusione che la spesa per l’occupazione militare tra 1934 e 1937 è stata di 39 miliardi di lire e che i successivi budget per l’Africa Orientale Italiana erano di cinque milioni l’anno93. Nel complesso, Del Boca conclude che l’Italia abbia lasciato in Etiopia un patrimonio di strade, ponti, scuole, ospedali, impianti elettrici, industrie del valore di 300.000.000 di dollari dell’epoca94. Anche gli etiopici sono consci del patrimonio di sviluppo che gli italiani hanno lasciato. Bekure W. Semai osserva che gli italiani devono essere ricordati non tanto per l’industrializzazione quanto per la costruzione di strade95. Stando a quanto riportato da Ferdinando Quaranta l’Italia ha dotato l’Etiopia di 2.770 miglia di strade e 8.354 ponti stradali con un costo stimato in 3 miliardi di lire96. Haile Larebo afferma anche che gli italiani hanno introdotto moderne tecniche di coltivazione e offerto pareri tecnici per stimolare la produzione indigena. Considerando il breve lasso di tempo, quanto realizzato e la trasformazione dell’economica agricola non sono stati insignificanti. Qualsiasi ragione avessero gli italiani, essi progettarono infrastrutture per lo sviluppo e diedero avvio a politiche agricole che spinsero fortemente l’Etiopia ad una maggiore partecipazione al sistema capitalistico mondiale. Gli italiani smantellarono le strutture tradizionali etiopiche e le sostituirono con moderne istituzioni che miravano a sfruttare il ricco potenziale agricolo dello Stato. Molte migliaia di miglia di strade praticabili in tutte le stagioni furono costruite per collegare le principali regioni incoraggiando lo sfruttamento dei terreni agricoli e il mercato della produzione. La monetarizzazione dell’economia venne stimolata incoraggiando la raccolta di cash crops. Emerse così una embrionale società del consumo. Si introdussero riforme sociali, frenando così il potere delle élite tradizionali che si erano opposte al cambiamento. Gli italiani fecero un notevole lavoro pionieristico, introducendo per prima cosa elementi di pianificazione per lo sviluppo. Oggi in Etiopia è difficile menzionare un qualche importante progetto di cui non si siano poste le basi durante il periodo dell’occupazione. L’industria del commercio creata dagli italiani ha un vastissima influenza nell’Etiopia post-liberazione. Le industrie più importanti hanno antecedenti italiani, come ad esempio quella del cotone, dello zucchero, dello sfruttamento delle foreste e delle piantagioni di prodotti oleosi. 187 Alberto Sbacchi Dopo il 1941 gli italiani svolsero un ruolo dominante nelle concessioni a lungo termine, mentre gli specialisti italiani furono impiegati nelle principali compagnie parastatali97. Imparando dagli italiani, l’Etiopia ha sponsorizzato una serie di organizzazioni parastatali che hanno controllato il commercio estero della nazione: si tratta di istituzioni come il Consiglio nazionale etiopico, la Società etiopica per il commercio e il trasporto, il Consiglio nazionale del caffè e il Consiglio del grano, enti destinati a controllare le più importanti esportazioni etiopiche. Nel campo industriale, l’Etiopia post-liberazione basa le sue attività manifatturiere sulle attività fondate dagli italiani. Nel Dire Dawa ci sono industrie tessili e del cemento, frantoi, mulini per la produzione di farina, e segherie lungo tutta la nazione. Ad Addis Abeba ci sono mulini per la produzione di farina e fibre, e una centrale idroelettrica. La fabbrica di birra Saint George è divenuta molto remunerativa. Lo zuccherificio Wangji ha origini italiane. Dal momento che l’Etiopia fu il primo Stato liberato dal fascismo era nella posizione unica di rifornire il Medio Oriente lacerato dalla guerra di beni e prodotti per un ammontare di 3.714.076 sterline. Oltre all’agricoltura, all’industria, alle strade e ai pubblici lavori gli italiani crearono situazioni favorevoli per l’ascesa e lo sviluppo di una borghesia che comprendeva anche la upper class che si era dedicata al commercio. Si racconta che la famiglia reale avesse interessi in quasi tutte le attività commerciali98. Il processo di sviluppo avviato dagli italiani durò dal 1941 al 1975, facendo di Addis Abeba il centro della produzione industriale99. Sebbene dopo l’indipendenza l’Etiopia fosse ancora uno degli Stati più poveri dell’Africa, essa ha beneficiato della generosità di molti Stati donatori. La cooperazione allo sviluppo italiana è basata sui vecchi legami storici e sociali, e l’Etiopia beneficia del fatto di essere stata la prima nazione a ricevere l’aiuto italiano. Negli anni settanta del Novecento l’Italia ha offerto prestiti e sussidi dei quali 100 milioni di lire sono stati destinati alla sanità, alle infrastrutture e alla pianificazione urbana. Nel 1981 l’Italia ha disposto un credito di 20 milioni di dollari per migliorare l’acquedotto di Addis Abeba e ha sponsorizzato progetti nel settore tessile, dell’energia e in quello agro-industriale. Nel 1978 l’Italia ha dato all’Etiopia un totale di 2,5 milioni di dollari, mentre nel 1987 ha reso disponibili 129 milioni di dollari, con una dodecuplicazione nel giro di dieci anni. Queste somme erano divise in 31 milioni di dollari di prestiti e 98 milioni di sussidi. L’Ita188 ItaliaeEtiopia:lariletturadelperiodocolonialeelavalutazionedellesueconseguenzesulpaeseafricano lia è impegnata a far sì che gli etiopici diventino autosufficienti in quanto a cibo, che si curino dei bisogni di base dei bambini; è impegnata inoltre a convogliare l’aiuto nelle regioni centro-meridionali con gli obiettivi speciali dello sviluppo, del controllo dei prezzi dei prodotti e della distribuzione dei prodotti. Un altro obiettivo degli aiuti italiani è lo sviluppo delle infrastrutture industriali, dei trasporti, delle comunicazioni e nel rendere l’Etiopia autosufficiente in quanto a energia elettrica. L’enfasi posta sull’aiuto industriale ha le sue radici nell’esperienza coloniale italiana, momento nel quale furono avviate le prime infrastrutture. L’educazione è un altro aspetto privilegiato della politica di aiuti seguita dall’Italia. Nel 1983-1984 ha offerto 1.875 borse di studio a studenti etiopici. L’Italia ha anche curato lo sviluppo dell’assistenza medica sotto forma di costruzione di ospedali, di programmi comunitari di sanità e di addestramento del personale medico. Il progetto di assistenza sanitaria primaria Arussi è uno degli esempi migliori. Rispetto ad altri stati donatori, l’Italia ha fornito il più grande ammontare di aiuti all’Etiopia100. Relazioni diplomatiche italo-etiopiche A dispetto della collaborazione e dell’aiuto finanziario le relazioni italoetiopiche dopo la guerra tardarono a normalizzarsi. Il compianto Robert H. Less osservò che una grande diffidenza persisteva in Etiopia nei confronti degli italiani anche se in genere erano ben accolti. L’Italia mantiene nel paese una grande influenza culturale poiché gli italiani avevano stretti contatti con gli etiopici già da molto tempo prima che Mussolini decidesse di invadere l’Etiopia101. Anche dopo la firma del trattato di pace con l’Italia nel 1947, la ripresa dei contatti diplomatici fu un processo penosamente lento: ciò avvenne in parte in ragione del fatto che l’Italia non voleva abbandonare l’Eritrea e insisteva nel mantenimento della propria presenza in Somalia, cosa che Addis Abeba temeva avrebbe favorito la restaurazione dell’influenza dell’Italia nel Corno d’Africa. Di qui, per ragioni psicologiche e pragmatiche la riconciliazione fu rinviata a dispetto del fatto che l’Etiopia riconoscesse il ruolo dell’Italia come valido partner nelle imprese economiche e commerciali e quello della diplomazia italiana nell’aiutare l’Etiopia a evitare i tentativi di fare del Paese un mandato britannico durante la guerra102. Entrambe le parti erano interessate a una soluzione duratura, e nel 1951 gli etiopici informarono Roma che il governo etiopico 189 Alberto Sbacchi sarebbe stato onorato che un rappresentante plenipotenziario fosse inviato ad Addis Abeba per discutere lo stabilimento di relazioni diplomatiche. Il sottosegretario del ministero degli Affari Esteri, Giuseppe Brusasca partì per l’Etiopia il 4 settembre 1951. Prima di avviare la sua missione diplomatica Brusasca dichiarò alla stampa italiana che il colonialismo aveva vissuto i suoi ultimi giorni e che gli italiani a titolo del loro senso di umanità, del loro spirito fraterno e della loro laboriosità erano stati invitati dalle popolazioni locali a rimanere e tornare nelle terre africane. Il principale obiettivo della sua visita era quello di stabilire relazioni diplomatiche sebbene il problema eritreo fosse un difficile scoglio da superare. L’Italia considerava il concetto di federazione come una copertura per l’annessione. Allo stesso tempo il destino degli italiani in Africa Orientale era una questione determinante se essi volevano essere parte del tessuto sociale dell’Etiopia del dopoguerra103. Parimenti il governo statunitense, che aveva comprato l’utilizzo di Radio Marina ad Asmara, era desideroso che l’Italia contribuisse alla pace in Africa orientale e nel Medio Oriente riaprendo le relazioni diplomatiche con l’Etiopia e riconoscendo la federazione dell’Eritrea con l’Etiopia. Quindi il ristabilimento delle relazioni diplomatiche con l’Etiopia tramite l’aiuto degli Stati Uniti si basava su un «quid pro quo». Lo scambio di ambasciatori ebbe luogo nel 1952. Il successivo importante punto di discussione era il pagamento delle riparazioni di guerra e la restituzione degli oggetti artistici confiscati durante l’occupazione. Gli oggetti del Museo coloniale furono restituiti ma la statua del leone di Judah, che non si riusciva a localizzare, fu restituita nel 1969. La statua commemorava la vittoria etiopica ad Adua nel 1896 ed era stata rimossa per ordine di Mussolini. L’Italia democratica concesse il ritorno ai legittimi proprietari la propria buona fede104. I danni delle guerre etiopiche vennero stimati da Addis Abeba in 185 milioni di sterline, ma il trattato limitò l’indennità a 25 milioni. Ci furono controversie su come interpretare l’articolo 74 del trattato di pace e le discussioni si trascinarono fino al 1957 quando l’Italia accettò di pagare 16,3 milioni di dollari sotto forma di equipaggiamenti industriali e infrastrutture, della costruzione di una diga, di numerose barche, di una industria di cotone a Bahar Dar e di vari lavori pubblici. Ciò significò una forte presenza italiana in Etiopia, posizionando così l’Italia al primo posto rispetto alle altre nazioni concorrenti. Questo fu l’inizio della cooperazione italiana allo 190 ItaliaeEtiopia:lariletturadelperiodocolonialeelavalutazionedellesueconseguenzesulpaeseafricano sviluppo. Da allora il commercio tra i due Stati si espanse enormemente e lo stesso lo fece l’influenza economica italiana105. Ora che le relazioni diplomatiche ed economiche erano state restaurate, Hailè Selassiè dichiarò a Del Boca in un’intervista tenutasi il 18 luglio 1960 che si sentiva pronto ad andare a Roma, ma che i leader italiani non lo avevano invitato. Non c’era da parte sua obiezione ad intensificare la collaborazione italo-etiopica. Gli italiani residenti in Etiopia e gli etiopici stessi volevano rafforzare le relazioni tra i due Stati. Per tutto il periodo in cui rimase Hailè Selassiè la presenza degli italiani in Etiopia e le loro attività diedero all’Etiopia le massime soddisfazioni. All’apertura del Palazzo d’Africa in 22 maggio 1963 Hailè Selassiè facendo un velato riferimento ai passati abusi fascisti, volle rassicurare gli italiani dell’inutilità della vendetta e del bisogno di sbarazzarsi dell’inimicizia poiché essa avvelena anima e corpo. Questa affermazione incoraggiò l’Italia, la quale nel 1963 inviò in Etiopia il ministro del Commercio, Luigi Preti, per firmare un trattato di cooperazione economica e la concessione di un prestito di 14 milioni di dollari, il più ampio mai ricevuto dall’Etiopia. Ad apprezzamento degli atti dell’Italia, l’imperatore propose la concessione di un vasto appezzamento di terreno in Addis Abeba per la costruzione di una scuola italiana. Sfortunatamente il prestito non fu accettato dal governo etiopico perché era troppo oneroso. Negli anni seguenti Hailè Selassiè dichiarò alla stampa che desiderava visitare l’Italia, ma che con la sua visita a Roma non intendeva chiedere il saldo dei conti perché questi erano già chiusi. Alla fine, nel novembre 1970 egli visitò l’Italia e fu ricevuto con spontanee manifestazioni di benvenuto e di gradimento da parte del popolo italiano. Dopo una settimana coronata dal successo, alla partenza egli inviò un messaggio al Presidente italiano, Saragat, esprimendo il suo apprezzamento per la calda e generosa ospitalità e riconfermando che negli incontri con i leader italiani si era dimostrato che i due stati condividevano gli stessi obiettivi di cooperazione, e che c’era un sentimento di amicizia tra gli italiani e gli etiopici. Soddisfatto, l’imperatore tornò a casa con un prestito di 50 milioni di dollari e l’estensione di un accordo di assistenza tecnica106. Alla fine, trent’anni dopo la fine della guerra c’era stata un’autentica riconciliazione tra Addis Abeba e Roma. 191 Alberto Sbacchi Il ritorno dell’obelisco di Axum In questo spirito sarebbe stato più facile trovare una soluzione per qualsiasi problema irrisolto. L’obelisco di Axum è stato una fonte di tensione perché l’Italia ha trovato mille scuse per non adempiere al ritorno di questo tesoro artistico vecchio migliaia d’anni, obbligo prescritto dall’articolo 37 del trattato di pace del 1947. Il valore psicologico del monumento era ben conosciuto alle autorità italiane, ma ogni sforzo fu messo in opera per non porre riparo all’errore compiuto. La stampa italiana fece intendere che l’obelisco servisse per unire l’Italia e l’Etiopia. Carlo Stamm, ex direttore dell’Ufficio politico del ministero dell’Africa, rivelò che i sacerdoti di Axum avevano donato la stele all’Italia come segno di gratitudine per aver liberato la chiesa etiopica dal Patriarcato di Alessandria d’Egitto107. Però, si deve aggiungere che nel rendere autonoma la chiesa etiopica gli italiani avevano riconosciuto solo quelle autorità religiose che erano favorevoli al regime fascista. Indi, è concepibile l’affermazione che la motivazione a donare l’obelisco sia stata suggerita dagli italiani al clero locale, il quale accettò per ingraziarsi il governo coloniale italiano. Poiché negli anni settanta del Novecento i fascicoli del Ministero dell’Africa Italiana su Axum erano in prestito al Ministro degli Affari Esteri non si poteva trarne molte informazioni ma è chiaro che Lessona propose a Mussolini di portare la stele a Roma come bottino di guerra. Mario Buschi fu incaricato di rimuovere e trasportare l’obelisco in Italia con l’aiuto della compagnia di trasporti Gondrand. Per il trasporto e l’installazione del monumento a Roma la spesa è stata stimata in 1,5 milioni di lire108. Un promemoria del gennaio 1937 rivela che l’unico modo di trasportare la stele alta 24 metri era di posarla sul suolo e tagliarla in cinque pezzi. Il primo pezzo di 7.5 metri aveva un peso di 54 tonnellate, un altro di 8 metri pesava 57 tonnellate, due pezzi di 3,5 metri avevano un peso ciascuno 25 tonnellate, e l’ultimo di 1,5 metri ne pesava 11. Nel complesso gli ingegneri italiani dovettero confrontarsi con 172 tonnellate di granito, ma poiché l’obelisco fu rotto in cinque pezzi ciò alla fine facilitò il suo trasporto a Massaua e poi in Italia109 con la nave Caffaro nel marzo 1937. Lessona ha riportato che il duce dispose che l’obelisco fosse inaugurato il 9 maggio 1937 per commemorare la fondazione dell’Impero110. Poiché l’obelisco fu posizionato vicino all’arco di Costantino ed al grande complesso archeologico di piazzale di Porta Capena, si scurì a causa dei gas di scarico del192 ItaliaeEtiopia:lariletturadelperiodocolonialeelavalutazionedellesueconseguenzesulpaeseafricano le vetture e dell’inquinamento dell’aria. Nel 1968 il parlamento etiopico dichiarò che dal momento che non era desiderabile ritardare e men che meno trascurare il ritorno dell’obelisco, era necessario che ogni passo fosse intrapreso per assicurare l’immediato ritorno dell’obelisco, minacciando di sospendere i rapporti commerciali e di rompere le relazioni diplomatiche con l’Italia111. Sebbene l’imperatore stesso assumesse una posizione più distaccata, non poteva non badare ai sentimenti popolari e alle reazioni emozionali della patria, e pospose così il suo tanto lungamente atteso viaggio in Italia fino a che non si fosse trovata una soluzione112. Nel 1970 Haile visitò l’Italia a dispetto del mancato ritorno dell’obelisco e si rumoreggiò al ministero degli Esteri che Hailè Selassiè non desse così tanta importanza al ritorno del monumento. Il compianto Mario Gazzini, archivista specializzato nella documentazione africana al Ministero degli Affari Esteri affermò che egli ebbe a che fare con la richiesta etiopica di restituzione di tutti gli oggetti artistici trasportati in Italia e dichiarò che Hailè Selassiè utilizzò la crisi dell’obelisco per esercitare pressione e ottenere un prestito di 50 milioni di dollari113. Dopo la caduta della monarchia, il governo Mengistu non tornò a chiedere la restituzione della stele, ma Richard Pankhurst mantenne vivo l’interesse in Europa pubblicando articoli sul tema. Tra il 1991 e il 1996 Parnkhurst intensificò questa campagna con articoli a stampa, interviste, apparizioni in tv e mail per sensibilizzare gli italiani e l’opinione pubblica internazionale. Nel 1996 Seyoum Mesfin, ministro degli Affari Esteri ricordò alla sua controparte italiana che l’obelisco aveva un grande valore storico e spirituale per gli etiopici. Il presidente Meles Zenawi sollecitò una soluzione razionale. Quando il primo ministro etiopico visitò l’Italia nel 1997, il ministro degli Affari Esteri Lamberto Dini diede il via libera per trovare la migliore soluzione per trasferire il monumento in Etiopia114. Il passo successivo fu la dichiarazione pubblica fatta dal Presidente italiano durante la visita ad Addis Abeba nel novembre 1997 che l’obelisco sarebbe tornato a casa nel 1998. Il ministro Dini riaffermò l’intenzione di restituire l’obelisco. Una promessa è una promessa, disse, l’obelisco ritornerà115. Sette anni dopo questa promessa, l’obelisco era ancora a Roma. Alla fine del 2004 era stato liberato dalle impalcature, diviso in tre pezzi, ed era ancora parcheggiato in un grande magazzino alla periferia di Roma, in attesa che un aereo lo riportasse finalmente ad Axum. Trad. dall’inglese di Matteo Vecchia 193 Alberto Sbacchi Note al testo 1* Una versione ridotta di questo saggio è stata presentata dall’Autore, scomparso di recente, all’African Studies Association Conference, Philadelphia, 12 novembre 1999. Angelo Del Boca dagli anni sessanta ha promosso lo studio e la riflessione sul colonialismo fascista. Egli è autore di migliaia di articoli e saggi, e 34 libri. Diciannove monografie sono sull’Africa, incluso il lavoro enciclopedico in 4 volumi su Gli italiani in Africa, Laterza, Roma – Bari 1976-1984; Gli italiani in Libia, 2 volumi, Laterza, Roma – Bari 1986-1988. Dal 1985 è stato direttore della rivista «Studi Piacentini». «Corriere della Sera», 22 novembre 1997; «La Repubblica», 25 novembre 1997. 2 «La Repubblica», 25 novembre 1997. 3 «Il Tempo», 28 novembre 1997. 4 Genenew Assafa, Thinking out luod of fact and fiction, nostalgia and empiricism, «Horn of Africa», 16 (1998), p. 174. 5 Recensione da parte di H. Marcus su Gebru Taneke, Ethiopia: power and protest, Cambridge University press, Cambridge 1991, in «Journal of Africa history», 34 (1993), pp. 333-334. 6 Recensione da parte di C. Mc Clellan su H. Marcus, A history of Ethiopia, University of California Press, Berkeley 1994, in «Northeast African Studies», 3 (1996), p. 125. 7 Bahru Zewde, Hailè Selassiè I, from progressive to reactionary, «Ethiopian Review», (nov-dec 1998) 35. 8 Recensione da parte di Alberto Sbacchi a N. Doumanis, Mith and memory in the Mediterranea: remembering fascism’s empire, in «American Historical Review», 104 (1999), p.667. 9 A. Triulzi, Italian colonialism and Ethiopia, «Journal of African History», 23 (1982), p. 23; R. Rainero, Presentazione ad A. Sbacchi, Il colonialismo italiano in Etiopia, Mursia, Milano1980), p. VI. 10 Il torpore delle Istituzioni, «Passato e presente», 5 (1984), pp. 13-25; ivi, 6 (1984), pp. 11-28; R. Rainero, Gli studi sul colonialismo italiano. Atti del convegno: gli studi africanistici in Italia,Roma 1986, p. 97. 11 A. Triulzi, Italian colonialism cit., pp. 238-239; R. Rainero, Gli studi sul colonialismo cit., pp. 107-108. 12 A. Del Boca, Le guerre africane di Mussolini e il mancato dibattito sul colonialismo italiano, «Studi Piacentini», 5 (1989), p.118. 13 A. Del Boca, Le guerre coloniali del fascismo, Laterza, Roma - Bari 1991, pp. V-VIII. 14 R. Rainero, Gli studi sul colonialismo cit., pp. 110, 111-114; P. Pastorelli, Gli studi sulla politica coloniale italiana, «Clio», 29 (1993), pp. 742-745. 15 D. Crummey, Society, state and nationality in recent historiography of Ethiopia, «Journal of African History», 31 (1990), p. 105. 16 Bahru Zewde, Some aspects of post liberation Ethiopia 1941-50 in Proceedings of the 8th Conference of Ethiopian Studies,Addis Abeba 1984, I, p. 227. 17 A. H. M. Jones, E. Monroe, A history of Ethiopia, Oxford University Press, Oxford 1935; Bahru Zewde, A history of modern Ethiopia,London 1991. 18 Ivi, p. 230. 19 A. Sbacchi, Ethiopia under Mussolini, Zed books, London 1985, p. 241. 194 ItaliaeEtiopia:lariletturadelperiodocolonialeelavalutazionedellesueconseguenzesulpaeseafricano 20 M. Serio, L’Archivio Centrale di Stato e le fonti peer la storia del colonialismo, in Atti, fonti e problemi della politica coloniale italiana, Taormina-Messina, 23-29 Ottobre 1989 (Roma: Ministero per i Beni Culturali, 1996), pp. 46-51: E. Ladolini, Le fonti sulla politica coloniale negli Archivi di Stato italiani, ivi, pp. 57-76. 21 V. Pellegrini, Le fonti del Ministero dell’Africa Italiana, ivi, pp. 294-333; recensione da parte di M. Cacioli su V. Pellegrini e A. Bertinelli, Per la storia dell’amministrazione coloniale italiana, Giuffré, Milano 1994 in «Rassegna degli Archivi di Stato», 55 (1995), pp. 493-495. 22 P. Ferrara, Recenti acquisizioni dell’ACS in materia di fonti per la storia dell’Africa italiana, in Atti, fonti e problemi della politica coloniale italiana, Taormina-Messina, 23-29 ottobre 1989, Ministero per i beni culturali, Roma 1996, pp.76-86; L. Sagrù, N. Santarelli, E. Raspondi, Ministero del Tesoro, Direzione Generale in Per la storiografia italiana del XXI secolo, Seminario sul progetto di censimento degli archivi di deposito del ministero realizzato dall’Archivio Centrale di Stato, Roma 20 aprile 1995, Ministero per i Beni Culturali, , Roma 1998, pp. 205-208. 23 G. Rochat, L’impiego di gas nella guerra d’Etiopia, «Storia contemporanea», 1 (1988), p. 74; R. H. Rainero, La Commission italienne d’armistice avec la France, Service historique de l’Armée de terre, Paris 1995; Italy: documents and notes, «Italian Military Historiography: the Army Historical Office», 25 (1076), pp. 461-474. 24 Il nuovo regolamento dell’Archivio Storico della Camera dei Deputati, «Rassegna degli Archivi di Stato», 54 (1994), pp. 689-697. 25 A. Sbacchi, The archives of Consolata Mission: towards a better understanding of italian colonialism in Africa in Atti, fonti e problemi della politica coloniale italiana, Taormina-Messina, 23-29 ottobre 1989, Ministero per i Beni Culturali, Roma 1996, pp. 87-112. 26 V. Mosca, D. Siccardi, Due situazioni archivistiche opposte, gli archivi di C. Donat-Cattin e Giuseppe Brusasca, in Gli archivi dei partiti politici, atti dei seminari di Roma (30 giugno 1994) e di Perugia (20-26 ottobre 1994), Ministero per i Beni Culturali, Roma 1996, pp. 384-38; A. Del Boca, Gli italiani in Africa: la caduta dell’Impero, Laterza, , Roma 1982. 27 P.Pastorelli, I criteri di pubblicazione dei documenti diplomatici in Fonti diplomatiche in età moderna e contemporanea, Atti del convegno internazionale di Lucca, 20-25 gennaio 1989, Ministero per i Beni Culturali, Roma 1995, pp. 123-127. 28 G. Calchi-Novati, Studi e politica dei convegni coloniali del primo dopoguerra, in Atti, fonti e problemi della politica coloniale italiana, Taormina-Messina, 23-29 Ottobre 1989, Ministero per i Beni Culturali, Roma 1996, pp. 166-195. 29 Maria Rait e V. Vigand, Genesis of Ethiopian studies and its future trends, in 12th International Conference on Ethiopian studies, Kyoto, December 1997, Shokado Book Sellers, Kyoto 1997, pp. 242-243. 30 R. Pankhurst, International conference of Ethiopian studies, 7th International Conference on Ethiopian studies, Lund, April 1982, Scandinavian Institute of African Studies, Uppsala 1984, pp. 681-706. 31 Bahru Zewde et al., From Lund to Addis Abeba, a Decade of Ethiopian Studies, «Journal of Ethiopian Studies», 27 (1994); W. Shack, Social Science Research in Ethiopia. 7th International Conference, Lund 1984, p. 441. 32 P. Pastorelli, Gli studi sulla politica coloniale italiana in Atti, fonti e problemi della politica coloniale italiana, Taormina-Messina, 23-29 ottobre 1989, Ministero per i Beni Culturali, Roma 1996, pp.31-44. 33 C. Ghezzi, La letteratura africana in Italia, un caso a parte, «Africa», 47 (1992), pp. 275-286; 195 Alberto Sbacchi G. Tomasello, La letteratura coloniale italiana dalle avanguardie al fascismo, Sellerio, Palermo1984. 34 R. Pankhurst, L’occupazione fascista nella letteratura etiopica, «Studi Piacentini», 13 (1993), pp.135-148. 35 C. McClellan, Observations on the Ethiopian nation, its nationalism and the Italo-Ethiopian War, «Northeast African Studies», 3 (1996), pp. 57-62; Gebru Taneke, Ethiopia, power and protest, Cambridge University Press, 1991, p. 48. 36 Bahru Zewde, Hailè Selassiè I, from progressive to reactionary, «Ethiopian Review», novembredicembre 1998, p. 35. 37 A. Sbacchi, Secret talks for the submission of Hailè Selassiè and Prince Asfaw Wossen, 1935-1939, «The international journal of African historical studies», 7 (1974), pp.668-680; A. Sbacchi, Legacy of bitterness, Red Sea Press, Lawrenceville 1997) 297; H. Marcus, To be or not to be emperor: Hailè Selassiè and Italy, in Atti, fonti e problemi della politica coloniale italiana, TaorminaMessina, 23-29 ottobre 1989, Ministero per i Beni Culturali, Roma 1996, pp. 728-734. 38 C. Mc Clellan, Observations on the Ethiopian nation cit., p. 62; A. Sbacchi, Legacy of bitterness cit., pp.185-189. 39 Solomon Haddis, The career of Ras Amaron Wubuah Tasama, in Five years of patriotic struggle, Senior History Paper, Department of History, Addis Abeba University, 1985, pp. 26-27 citato in C. McClellan, Observation on the Ethiopian Nation cit., p. 74. 40 C. Mc Clellan, Observations on the Ethiopian nation cit., p. 63. 41 Theodor Konovaloff, A history of Ethiopia, testo trovato all’Istituto di studi etiopici di Addis Abeba, citato da Mc Clellan in Observations on the Ethiopian nation cit., p. 64. 42 Ivi, p. 82. 43 J. C. Guilleband, R. Depardon, La porte des larmes: retour vers l’Abyssinie, Seuil, Paris 1996, p. 208. 44 Bahru Zewde, The Ethiopian Intelligentsia and the Italo-Ethiopian War, 1935-1941, «International Journal of African Histori cal Studies», 26 (1993), pp. 276-285. 45 A. Sbacchi, Legacy of Bitterness cit., p.189 46 Bahru Zewde, The Ethiopian Intelligentsia cit., pp. 293-294; si veda anche Alain Rouaud, Afa-Warf: un Intellectuel Ethiopien témoin de Son Temps, Editions du CNR, Paris 1991. 47 Asafa Jalata, The struggle for knowledge: the case of emergent Oromo studies, «African Studies Review», 39 (1996), pp. 95-96. 48 Recensione da parte di C. McClellan su H. Marcus, A history of Ethiopia, University of California Press, Berkeley 1994) in «Northeast African studies», 3 (1996), p. 124. 49 Asafa Jalata, The struggle for knowledge cit., pp. 108-109. 50 Recensione da parte di J. Quirin su Mohammed Hassen, The Oromo of Ethiopia: a history 1570-1860, in «Africa studies review», 35 (1992), p. 124. 51 Asafa Jalata, The struggle for knowledge cit., pp.108-109. 52 C. McClellan, State transformation and national integration: Gedeo and the Ethiopian empire 1895-1935, Michigan State University, East Lansing 1988. p. 97. 53 Ivi, p. 144. 54 Ivi, p. 96. 196 ItaliaeEtiopia:lariletturadelperiodocolonialeelavalutazionedellesueconseguenzesulpaeseafricano 55 Ivi, p. 144. 56 C. McClellan, Observations on the Ethiopian nation cit., p. 82. 57 Ivi, p.65. 58 A. Sbacchi, Ethiopia under Mussolini cit., pp.181, 204. 59 Ivi, pp. 35-36. 60 Ivi, pp. 160-161. 61 Bahru Zewde, Hailè Selassiè I, from progressive to reactionary cit., p.35. 62 Governo imperiale etiopico: Dipartimento della stampa e dell’informazione, La civilisation de l’Italie fasciste, vol.1,Berhanena Selam Press, Addis Abeba 1945, p. 9. 63 J. Spencer, Ethiopia at bay: a personal account of Hailè Selassiè years, Reference Publications, Algonac 1984, p. 93 ; A. Del Boca, Il Negus. Vita e morte dell’ultimo re dei re, Laterza, RomaBari 1995, pp. 210, 302. 64 A. Sbacchi Hailè Selassiè and the Italians, «African studies review», 22 (1979), p. 29. 65 A. Del Boca, Il Negus cit., p. 221. 66 C. McClellan, Observations on the Ethiopian nation cit., p. 65. 67 A. Sbacchi, Hailè Selassiè and the italians cit., pp. 33, 35. 68 A. Del Boca, Il Negus cit., pp.208, 220, 217. 69 A. Sbacchi, Il colonialismo italiano in Etiopia, Mursia, Milano 1980, p. 346 ; R. Greenfield, Ethiopia: a new political history, Pall Mall, London 1965, p.271. 70 A. Sbacchi, Hailè Selassiè and the italians cit., p. 30; A. Del Boca, Il Negus cit., p. 208. Come se non fosse abbastanza, ras Imru propose a Fuzzi, il presidente dell’Ente Romagna, che la colonizzazione demografica italiana continuasse il proprio programma in Etiopia. A. Sbacchi, Il colonialismo italiano in Etiopia cit., p.346. 71 A. Sbacchi, Legacy of bitterness cit., p.330 ; A. Sbacchi, Hailè Selassiè and the italians cit., pp. 32-33. 72 Ivi, pp. 33, 35. 73 Ivi, p. 36 ; J. Spencer, Ethiopia at bay cit., p. 112. 74 A. Del Boca, Il Negus cit., p.305. 75 A. Sbacchi, Legacy of bitterness cit., p.331. 76 C. McClellan, Observations on the Ethiopian nation cit., p. 67. 77 Bahru Zewde, Hailè Selassiè I, from progressive to reactionary cit., pp. 35, 38, 39, 40, 42, 43, 44. 78 Recensione da parte di D. Crummey su Teshale Tibebu, The making of modern Ethiopia, Red Sea Press, Lawrenceville 1995 in «Journal of African history», 38 (1997), p. 328. 79 Recensione da parte di T. Fernyhough su Teshale Tibebu, The making of modern Ethiopia, Red Sea Press, Lawrenceville 1995 e su Gebru Tareke, Ethiopia, power and protest, Red Sea Press, Lawrenceville 1996 in «The historian», 60 (1998), pp. 598-603. 80 Bahru Zewde, Hailè Selassiè I, from progressive to reactionary cit, p. 42. 81 Ivi, pp. 43-44. 197 Alberto Sbacchi 82 H. Marcus, Hailè Selassiè’s leadership, Papers of the 12th international conference of Ethiopian Studies, Michigan State University, 5-10 Settembre 1994, Red Sea Press, Lawrenceville 1994, p. 884. 83 Dichiarazioni di H. T. all’autore, 1990. 84 Dichiarazioni di S. S. all’autore, 12 ottobre 1999. 85 F. Quaranta, Ethiopia, an empire in the making, King, London 1939) p.VI; C. Schaefer, Serendipitous resistance in fascist-occupied Ethiopia, «Northeast African studies», 1 (1996) pp.87-115. 86 P. Guillen, L’historiographie française et la politique coloniale italienne, in Atti, fonti e problemi della politica coloniale italiana, Taormina-Messina, 23-29 ottobre 1989, Ministero per i Beni Culturali, Roma 1996, pp. 200-210. 87 A. Sbacchi, Ethiopia under Mussolini cit., p.242. 88 G. Calchi-Novati, Il Corno dell’Africa nella storia e nella politica, SEI, Torino 1994, p.75. 89 J. Spencer, Ethiopia at bay cit., p. 110. 90 A. Del Boca, Il Negus cit., pp.220, 242, 277. 91 Ivi, p.220 ; J. Spencer, Ethiopia at bay cit., p. 110; Bahru Zewde, Some aspects of post-liberation Ethiopia in 8th International conference of Ethiopian studies, University of Addis Abeba, 1984, Institute of Ethiopian studies, Addis Abeba 1989, p.283. 92 C. Giglio, Colonizzazione e decolonizzazione, Editrice Padus, Cremona 1971, pp. 352-353 ; Memorandum sulla situazione economica e finanziaria dei territori italiani, Tipografia dello Stato, Roma 1946); Investimenti dei capitali italiani in Etiopia, ivi. 93 A. Sbacchi, Il colonialismo cit., pp. 88, 91. Gli Italiani tentarono di tassare gli etiopici e per il periodo 1937-38 avevano previsto la raccolta di 12 milioni di lire. Nel 1938-39 anticiparono 50 milioni di lire; nel 1939-40 si sperava di ricevere 70 milioni di lire. Si trattava comunque di statistiche ipotetiche. 94 A. Del Boca, Il Negus cit., p.220. 95 Bedure W. Semait, Industrial labor force in Addis Abeba region, in Proceedings of the 7th international conference of Ethiopian studies, University of Lund, 26-29 aprile 1982, Scandinavian Institute of African Studies, Uppsala 1984, p. 604. 96 Quaranta, Ethiopia cit., pp. 77-79; Lapiso G. Dilebo, Land tenure, the underlying cause of the Ethiopian revolution in Proceedings of the 5th international conference of Ethiopian studies, University of Illinois at Chicago, 13-16 aprile 1978, University of Illinois Press, Chicago 1979, p. 720. 97 Haile Larebo, The building of an empire, Oxford University Press, Clarendon 1994, pp. 291-295. 98 Bahru Zewde, A history of modern Ethiopia cit., pp.195-198 ; Id., Some aspects of post-liberation Ethiopia cit., pp. 281, 282. 99 Bekure Semiat, Industrial labor force cit., p. 604. Ingrid Sbacchi, Development assistance: contributions to development in Ethiopia from Italy and Sweden, 1978-1987, International Graduate School, University of Stockholm, 1989, pp. 52, 53, 57, 59, 60, 61, 65; si veda anche AID, Economic data book for Africa, The national technical information service for the U.S. Department of Commerce, 28 dicembre 1973. 100 101 Robert L. Hess, Ethiopia: the modernisation of authocracy, Cornell University Press, Ithaca 198 ItaliaeEtiopia:lariletturadelperiodocolonialeelavalutazionedellesueconseguenzesulpaeseafricano 1970), p. 205. G. Calchi-Novati, Re-establishing Italo-Ethiopian relations after the war: old prejudices and new policies, «Northeast Africa studies», 3 (1966), p. 27; si veda anche Le guerre coloniali del fascismo, acura di Angelo Del Boca, Laterza, Roma – Bari 1991, pp. 517-548; sul destino delle colonie italiane si consulti G. L. Rossi, L’Africa verso l’indipendenza, Giuffré, Varese 1980; per le difficoltà del riavvicinamento italo-etiopico, A. Del Boca, Gli Italiani in Africa: nostalgia delle colonie, Laterza, Roma - Bari 1984, pp. 94-110; J. Spencer, Ethiopia at bay cit.; C. Sforza, Cinque anni a Palazzo Chigi, Roma 1952, pp. 159-160; G. Cora, La ripresa delle relazioni diplomatiche tra Italia e Etiopia, «Rivista di studi politici internazionali», gennaio-giugno 1952, p. 33; «Corriere della Sera», 6 gennaio 1951. 102 103 G. Calchi-Novati, Re-establishing Italo-Ethiopian relations cit., pp. 33, 34, 35, 37. 104 Robert L. Hess, Ethiopia cit., pp. 205-206. G. Calchi-Novati, Re-establishing Italo-Ethiopian relations cit., pp. 39-40; Robert L. Hess, Ethiopia cit., p. 206; A. Del Boca, Il Negus cit., pp. 223, 226. 105 A. Del Boca, Il Negus cit., pp.240, 279, 284-285, 306, 375; si veda anche «La Stampa», 9 marzo 1965 ; «Corriere della Sera», 10 giugno 1966 e 6 novembre 1970. 106 G. Calchi-Novati, Re-establishing Italo-Ethiopian relations cit., p.41; «Epoca», 1053 (1970), p. 3. 107 Archivio Storico del Ministero dell’Africa Italiana (d’ora in poi ASMAI) 181/60/F302 Lessona al Duce 21 ottobre 1936; Lessona al Governo Generale, 13 dicembre 1936; Graziani al ministro delle Colonie 25 dicembre 1936; A. Del Boca, Il Negus cit., p.277. 108 ASMAI 181/60/F302 [R. Micacchi?] Promemoria per il Ministro delle Colonie [gennaio 1937]. 109 110 Ivi, Lessona a Colonna, 9 febbraio 1937. R. Pankhurst, A history of the Axum obelisk return struggle, «Horn of Africa», 16 (1998), p. 127. 111 112 G. Calchi-Novati, Re-establishing Italo-Ethiopian relations cit., p. 41. Mario Marsala, Ho il cuore scavato di date... Una conversazione con Mario Gazzini, «Italiani d’Africa» 29 (1997), p. 13; comunicazione di Mario Gazzini all’autore, 1973. 113 A. Del Boca, Gli obblighi dell’Italia nei confronti dell’Etiopia e della Libia, «Studi Piacentini», 22 (1997), pp. 153-156; R. Pankhurst, A history of the Axum obelisk cit., pp. 128-143 . 114 «Ethiopian review», gennaio-marzo 1999. 115 199 L’intrapresa di Luigi di Savoia in Somalia, ovvero storia di una bonifica 'integrale' coloniale di Ernesto Milanese «Tantae molis erat»: così ebbe a esprimersi Federico Negrotto1 nel rammentare la decisione presa diciotto anni prima da Luigi Amedeo di Savoia, di impiantare in Somalia una grande azienda agricola e zootecnica. La citazione suona oggi un poco retorica (con buona pace di Virgilio), ma appare giustificata quando si consideri l’epoca e la natura della pubblicazione. Una certa esagerazione dunque, e niente di più. Ma era davvero un’esagerazione? Abituati alle tante strombazzature che hanno spesso accompagnato la vita pubblica italiana durante il «regime» (e anche dopo, a dire il vero) si è portati ad accogliere con fastidio, e magari con sospetto, qualunque dichiarazione di questo tipo, e così a non vagliare adeguatamente il grano per separarlo dal loglio. Ci sono imprese – fare da soli il giro del mondo, arrivare al Polo tirandosi appresso la slitta o collezionare cime da 8.000 – che appaiono veramente straordinarie, non appena si guardino con attenzione, e con quel pizzico di empatia senza la quale è difficile avere comprensione di qualsiasi cosa. Questi eventi sono però di durata limitata, di facile identificazione, e si manifestano con evidenza alla nostra attenzione. Quando l’impresa è lunga e complessa, l’aspetto eccezionale tende invece a sfrangiarsi, a diluirsi nel tempo, a non essere più riconosciuto. In certo qual modo, proprio Luigi di Savoia offre un chiaro esempio di ciò. Egli divenne noto come scalatore nell’allora piuttosto ristretto circolo degli appassionati di montagna, e poi in tutto il mondo nell’estate del 1897 per la spedizione al Sant’Elia2; e famoso come esploratore ed alpinista per la spedizione polare del 1899-1900, e quelle al Ruwenzori (1906) e al Caracoram (1909), ove sempre stabilì dei primati. A fronte di ciò, il periodo somalo è apparso a molti quasi come il ritiro in campagna di un gentiluomo deluso nei sentimenti e amareggiato della carriera in Marina3. Lo stesso Angelo Del Boca, qualche anno addietro4, rilevava come il 201 Ernesto Milanese «Duca esploratore» avesse consegnato ai posteri pagine ben più fulgide di quelle del «Duca colono», sintetizzando un’opinione in quel momento largamente condivisa dagli storici5, pur essendo spesso presentata come un dato di fatto, senza adeguato supporto di prove o di argomentazioni. Oppure facendo riferimento a generiche osservazioni sul trattamento della manodopera (contratti giugulatori, impiego forzoso); ma anche queste riportate di seconda mano, senza concreti richiami all’ambiente, all’epoca, o alla particolare situazione del momento. A questi rilievi si accompagnavano spesso giudizi negativi, ove la SAIS era via via imputata di «schiavismo bianco» o paternalismo, secondo i punti di vista6. Sull’argomento occorre però osservare che il lavoro agricolo è stato sempre uno dei ’grandi’ problemi del paese7, nell’agenda, si può dire, di tutti i governatori della Colonia – e poi, dopo il 1960, dei governi somali8. Si può dunque facilmente capire perché esso abbia costituito una costante preoccupazione per la direzione della Società, specialmente agli inizi, quando ci furono momenti di tensione per l’accavallarsi dei lavori di impianto e di conduzione, e si dovette ricorrere al reclutamento forzoso (che in Somalia era adottato da gran tempo per sopperire alla cronica carenza di manodopera, anche se saltuariamente e con modestissimi risultati). Ad ogni modo, lontani dalle polemiche e dagli interessi del passato, sembra possibile tentare oggi una più equilibrata analisi della vita della Società; ossia, in sostanza, dell’opera in Somalia del Duca degli Abruzzi, giacché solo grazie al suo impegno la SAIS poté sopravvivere e svilupparsi, mentre la maggior parte delle altre intraprese metropolitane languiva o finiva col morire di stenti9. Cercheremo dunque di riconsiderare il significato dell’iniziativa somala di Luigi di Savoia, e di ravvivarne al contempo la memoria dopo molti anni di oblio10; pur riconoscendo che quella della SAIS fu un’esperienza particolare, sotto alcuni aspetti forse un poco idealistica, legata fortemente alla sua persona e difficilmente ripetibile. Trattandosi però di luoghi così lontani, e di vicende oramai quasi dimenticate, può risultare opportuno rammentare per brevi capi quali fossero le condizioni ambientali e umane della Somalia di allora, anche per meglio comprendere meglio le cause degli insuccessi di molti degli agricoltori metropolitani e, all’opposto, del successo della SAIS11. 202 L’intrapresa di Luigi di Savoia in Somalia Gli antefatti e i presupposti della bonifica voluta da Luigi di Savoia Quando nel settembre del 1918 Luigi di Savoia lasciò l’Italia diretto all’East Africa per un viaggio «di diporto» durante il quale soggiornò in Somalia più a lungo che altrove12, l’opinione corrente circa la potenzialità agricola di quel paese era che, ovunque fossero disponibili acqua, lavoro e capitali, là si sarebbero potute ottenere tutte le usuali colture tropicali. Anche gli agronomi che l’avevano visitata, o condotto prove di coltivazione, si erano espressi in modo simile, ma dal punto di vista tecnico, perché ben differenti furono le loro conclusioni una volta considerate le esperienze, negative, dei pochi pionieri che, a partire dal 1906, vi avevano tentato la sorte: si palesavano allora con indubbia chiarezza i tanti ostacoli, legati all’ambiente naturale e alla situazione complessiva della Colonia, che si opponevano alle rosee visioni sulla sua potenzialità agricola, troppo spesso riportate negli scritti divulgativi del tempo, e pure in qualcuno di quelli… ufficiali. Per non ripetere fatti noti, ricorderò solo che lo stesso Negrotto, nel confrontare la Somalia del 1919 con altre colonie africane, osservava che invece di genti docili, di terre fertili, regime delle piogge adatto a redditizie colture, approdi marittimi naturalmente protetti e accessibili, si trovava piuttosto la seguente situazione: a) un regime delle piogge poco conosciuto, sapendosi solo che era assai irregolare13; b) sconosciuti quasi il regime e le portate dello Uebi Scebeli14; c) popolazione scarsa, formata per la maggior parte di pastori seminomadi, da poco tempo pacificati15, e da relativamente piccoli gruppi di liberti agricoltori «ancora incompresi della libertà acquistata per opera altrui ed ancora travagliati dalla crisi morale ed economica di transizione fra due stati sociali antitetici»16; d) Mogadiscio, che di fatto era l’unico approdo disponibile, nient’altro che una rada aperta, senza buoni collegamenti con l’interno. Ora, se è vero che «l’erba del vicino è sempre più verde» anche in Africa, e che il confronto è un poco semplificato, nel complesso il giudizio appare fondato; e concorda in sostanza colle conclusioni di Romolo Onor17, che purtroppo erano rimaste quasi sconosciute, o poco considerate, in Italia. Ciononostante – aggiunge Negrotto – Luigi di Savoia, percorsi i luoghi e conosciute le genti durante il suo viaggio del 1918-19, ritenne che 203 Ernesto Milanese un organismo produttivo con attività differenziate per diminuire i rischi agronomici ed economici, abbastanza grande per ridurre l’incidenza dei forti costi generali, ma abbastanza piccolo per rimanere sotto il controllo di una unica direzione, potesse avere successo. Convintosi18 dunque «che quella colonia [avesse] un avvenire»19, dopo aver visitato anche l’Eritrea, al rientro in Italia subito approntò una spedizione, o ‘missione’, agricola, e ripartì nell’autunno, per approfittare della buona stagione, alla ricerca di un sito idoneo alla formazione di una grande azienda agricola e zootecnica nelle zone coltivate lungo lo Uebi Scebeli20. Il luogo fu infine trovato in regione Scidle (appartenente allora al distretto di Mahaddei Uen) in una zona fittamente popolata21, e da genti che avevano il possesso delle terre che coltivavano. Questi, sempre secondo Negrotto, furono i concreti elementi alla base del convincimento di Luigi di Savoia: che l’irrigazione avrebbe sopperito alla mancanza o all’irregolarità delle precipitazioni; che, mediante la perforazione di pozzi, si sarebbe trovata acqua in zone prossime all’azienda ma abbastanza lontane dal fiume per essere immuni dalla tze-tze, e così sarebbe stato possibile disporre di bestiame da opera per i lavori agricoli, affiancandolo alle macchine, e moltiplicare il rendimento del lavoro colonico mentre si alleviava la fatica; infine, e soprattutto, «niente monocoltura [mirando invece] ad una ampia serie di produzioni agricole, senza trascurare la zootecnia ed [affiancando] il tutto con una adeguata organizzazione industriale», per ottenere in loco il massimo grado possibile di finitura dei prodotti. Tali direttive, sempre seguite anche negli anni successivi con gli opportuni adattamenti, furono tra i motivi del successo della bonifica, e poi della sopravvivenza della SAIS durante e dopo la guerra mondiale. Essendo però basate su osservazioni limitate nel tempo e nello spazio, in un ambiente nuovo per gli agronomi italiani, dovettero spesso essere riviste e corrette… verso il basso, nonostante fossero state impostate dal Duca con la cautela e l’accortezza che gli erano abituali: Luigi di Savoia era infatti tenace e coraggioso, ma di sicuro non avventato, anzi forse a volte perfino troppo meticoloso22. La nascita della SAIS e le difficoltà incontrate in Somalia Può risultare utile, prima di procedere, chiarire un altro punto, in ge204 L’intrapresa di Luigi di Savoia in Somalia nere solo sfiorato dai biografi e che potrebbe destare, se non perplessità, almeno curiosità: come mai un principe ‘montanaro’ e ammiraglio abbia pensato di diventare agricoltore, e per di più in Somalia. Per concorde testimonianza di Negrotto e di Vittorio Sella sappiamo però che già al momento della partenza, nell’autunno del 1918, Luigi di Savoia era assillato dal «desiderio di nuove imprese per la maggior grandezza dell’Italia»23 e pensava a «un vasto piano di bonifica agraria, che la sua mente organizzatrice aveva carezzato già da tempo»24. Poiché, d’altra parte, la vita del farmer in Africa era allora diffusa tra le upper classes europee, quindi socialmente e politicamente accettabile per un membro della famiglia reale, bisogna forse riconoscere che poche vere alternative gli si offrivano. Sappiamo anche che Luigi di Savoia provava un forte interesse per l’agricoltura25, e i suoi viaggi gli avevano fatto conoscere molti ambienti tropicali: così, ricorda G. Dainelli nel 1906, la «Spedizione al Ruvenzori gli aveva dato modo di osservare come pochi anni di un Governo ordinato e guidato dalle conoscenze insegnate dalla moderna Scienza fossero state sufficienti per iniziare la trasformazione economica, quindi anche sociale, di un intero territorio»26. Ciò premesso, possiamo ritornare al 1920 e alla ‘spedizione agricola’. Una volta impostato il progetto, Luigi di Savoia formulò delle precise proposte al governo locale e poi al ministro in Italia, ottenendo, nel luglio, l’approvazione di massima. Poté allora formalizzare l’iniziativa, e raccogliere i capitali necessari mediante contatti personali e pubbliche conferenze a Torino, Genova, Milano e Roma; al contempo, con alcuni dei compagni della ‘missione’ visitava i parchi dei residuati bellici. Le sue non comuni doti organizzative, la notorietà e il prestigio di cui godeva in Italia e fuori, unite alla concretezza del progetto, condussero presto a un felice esito, con la costituzione della Società agricola italo-somala (SAIS), avvenuta mercoledì 10 novembre in Milano27. L’attività ‘somala’ della Società ebbe inizio nel dicembre 1920, quando giunsero a Mogadiscio parte del personale e il primo carico di attrezzature e materiali. Nel luogo prescelto, a circa 105 chilometri da Moga, presso Giohar28, i lavori di impianto cominciarono il 22 gennaio del 1921, all’arrivo di Luigi di Savoia, e procedettero rapidamente29, assieme a quelli di messa a coltura delle terre via via bonificate, tantoché nell’autunno del 1922 si ebbe il primo, e più che soddisfacente, raccolto della principale coltura industriale, il cotone. Tuttavia, le spese sostenute, pur con le agevolazioni ottenute dal 205 Ernesto Milanese governo per la cessione di residuati di guerra e di altro materiale in esubero, risultarono maggiori delle pur prudenziali stime30, e tali da far temere per le sorti stesse dell’impresa31. Superata questa crisi finanziaria, non finirono però le difficoltà: nella vita della società sono stati anzi riconosciuti tre distinti periodi di crisi acuta, il primo nel 1923, il secondo nel 1926, l’ultimo nel 193032. La prima crisi ‘tecnica’ sopravvenne nel 1923, mentre era ancora in pieno svolgimento la fase organizzativa, per una somma di eventi sfavorevoli: a) un’inondazione accompagnata da piogge torrenziali (92 mm in 2 h), che danneggiò le difese idrauliche e pure una parte dei terreni; b) un’epidemia di peste bubbonica, con conseguente riduzione della manodopera33; c) la bassa resa del cotone, dopo il buon successo del primo raccolto34, tale da far dubitare persino del futuro della coltura in Somalia. La seconda crisi si ebbe nel 1926, quando di nuovo una piena eccezionale per intensità e durata, provocando estesi allagamenti ai coltivi e la virulenza di svariate malattie (malaria compresa), costrinse a trascurare le colture in atto. La terza nel 1930, ancora una volta a causa della piena, che non allagò i campi coltivati, ma danneggiò gravemente le arginature e minacciò la linea ferroviaria, portando alla mobilitazione delle maestranze della SAIS a scapito dei lavori aziendali. A tutto ciò si deve aggiungere una forte epidemia di amebiasi, già serpeggiante dal 1929, che colpì in modo massiccio (70 per cento) anche il personale europeo e che solo nell’anno seguente venne debellata. In effetti, dal 1922 fino al 1931 ed oltre, gli straripamenti crearono gravi difficoltà in maniera ricorrente, costringendo ad opere di difesa ed arginature sempre più impegnative35, che furono poi riconosciute di pubblica utilità e riscattate dal Governo con legge apposita. Non mancarono, ovviamente, altre difficoltà: ma, presentandosi isolatamente o in periodi più favorevoli, furono meglio superate; così fu per la ricorrente carenza di manodopera agricola, sia nei primi anni (fino all’adozione del contratto di colonìa) sia durante e dopo la campagna d’Etiopia, che, per concorde testimonianza, sconvolse e turbò gravemente tutta l’economia somala36. Similmente avvenne per le avversità agronomiche e naturali (carestie, epidemie ed epizoozie) o di mercato (crisi del cotone37); tanto che la SAIS divenne in breve tempo, per così dire, uno dei fiori all’occhiello del Governo della Somalia e di quello nazionale, meta di quasi tutti i visitatori illustri, e collocata tra le attrattive turistiche della Colonia 38. 206 L’intrapresa di Luigi di Savoia in Somalia Le fasi dello sviluppo e l’azione di Luigi di Savoia All’inizio, le aziende erano basate sul cotone come coltura industriale, più i cereali alimentari e il foraggio per gli animali. Dopo il 1925, perdurando la tendenza al ribasso del prezzo della fibra, ed essendosi nel frattempo mostrato conveniente l’impianto di uno zuccherificio per effetto del mutato indirizzo di politica economica in Italia39, e insieme per ridurre i rischi tecnici della monocoltura, venne potenziata la coltivazione della canna. Altra notevole causa di mutamento nell’ordinamento produttivo fu poi il graduale abbandono del lavoro animale a vantaggio di quello meccanico, con liberazione di gran parte della superficie destinata ai foraggi. Questa fase di assestamento intorno al binomio canna/cotone, più alcune oleaginose (oltre, naturalmente, i cereali per la sussistenza) fu poi interrotta dalla guerra d’Etiopia, che non solo squassò la fragile economia del paese, ma ne modificò fortemente attese e prospettive, nel quadro della nuova Africa Orientale Italiana; fino a quando la guerra mondiale e l’occupazione inglese la riportarono alla mera sopravvivenza nell’isolamento. La storia della Società fino alla seconda guerra mondiale può dunque essere suddivisa in tre periodi: la bonifica e l’avviamento (1922-26); il passaggio dal cotone alla canna, con una crescente meccanizzazione; la stabilizzazione dopo il 1936. Quando Luigi di Savoia morì, nel marzo del 1933, la Società aveva ormai raggiunto l’equilibrio economico e finanziario, e, per personale iniziativa del Duca, a fianco delle usuali colture era stato introdotto il banano per l’esportazione40. Invero non solo durante i lavori iniziali, ma in numerose occasioni della vita aziendale Luigi di Savoia seppe appianare le difficoltà o superarle con l’esempio e la forza morale, individuando nuove possibilità produttive o alternative colturali. Non è il caso di elencare qui le tante iniziative, già riferite da molti41, mentre può apparire utile aggiungere qualche considerazione circa le convinzioni, le ‘idee-guida’, che guidarono Luigi di Savoia nello sviluppo della bonifica. Si è visto sopra su quali concetti Luigi di Savoia, secondo la fondata testimonianza di Negrotto, avesse basato la sua intrapresa; conosciamo poi il suo pensiero, almeno come manifestato nelle conferenze di presentazione della Società tenute in varie città nell’autunno del 1920 42; abbiamo infine la testimonianza di persone che lo conobbero e che ebbero con lui specifici rapporti di lavoro43. Maugini, ad esempio, che conosceva la Somalia e la 207 Ernesto Milanese SAIS, ed ebbe occasione di conversare con Luigi di Savoia, così riferisce le convinzioni del Duca al momento della nascita della SAIS44: 1) che il precario livello di vita non andava tanto attribuito alla povertà dell’ambiente biologico o ad altri ostacoli insormontabili, quanto a fattori geografici, storici e politici insieme combinati, al secolare isolamento, alla struttura sociale; e quindi almeno in parte suscettibili di graduali cambiamenti; 2) che migliorando l’organizzazione civile, offrendo occasioni di lavoro, si sarebbe potuto liberare gli uomini dal rassegnato fatalismo che li paralizzava, e aprire i cuori alla fiducia e alla speranza. Aggiunge che tali convinzioni si tradussero nelle «cure più assidue e continuative [per gli] aspetti sociali ed umani del programma», volendosi non soltanto giorno per giorno realizzare una azienda agricola come tante altre, ma «uno strumento di progresso, una vera scuola, volutamente innovatrice, ricca di contenuti umani, di sapore quasi rivoluzionario per le masse che si avvicinano per la prima volta alla disciplina, ai doveri e ai diritti di un lavoro organizzato». In tal modo si offriva ai lavoratori la possibilità di conoscere meglio sé stessi, di evolversi, di elevare la loro personalità, e si cercava di favorire i meglio dotati e volenterosi. Ritroviamo qui – mi sembra – i legami (tecnici e ideali) con le esperienze nazionali di bonificamento in ambienti particolari (Sardegna) cui si accennava avanti; anzi, circa una tale ‘concezione’ della bonifica, segnalo uno spunto suggerito dall’agronomo Renato Sassaroli, di un certo ‘filo rosso’ con il pensiero e le iniziative repubblicane e garibaldine di fine Ottocento, di redenzione sociale e patriottiche insieme. D’altronde, non mancarono all’epoca paragoni in tal senso: «Sulla terra fecondata dal Suo lavoro [Luigi di Savoia] ha voluto chiudere la Sua giornata mortale: dopo aver percorso tutti i mari, dopo aver segnato in tutte le terre le tappe del Suo ardire e della Sua fede, Egli ha chiesto, per il suo riposo, ospitalità alla terra d’Italia, a quella stessa terra che aveva già fatto fiorire col suo lavoro nobilissimo. Così morirono i più grandi pionieri ed esploratori, così morì l’ultimo cavaliere dell’umanità, Giuseppe Garibaldi»45. In effetti nelle due esperienze di bonificamento agrario – la SAIS in Somalia, la Sella & Mosca in Sardegna – appaiono simili le ‘idee guida’ dei costitutori, nel senso che si riconosceva che il buon esito economico di simili imprese non poteva essere raggiunto senza cambiamenti del contesto ‘sociale’, ossia che non bastavano gli investimenti e una ‘buona tecnica agricola’ per raggiungere il successo. 208 L’intrapresa di Luigi di Savoia in Somalia È questo un concetto che può sembrare ovvio, ma che pure incontrò molte resistenze, fino a Serpieri. Il quale, ancora nell’immediato dopoguerra, a San Donà di Piave, ricordando il Congresso di venticinque anni prima, ripeté che «La bonifica, come oggi va intesa […] estesa quindi ad ogni terra nella quale il regime fondiario, qualunque ne sia la ragione, ancora giace in condizioni primitive - è insomma adattamento di detto regime ad un più alto livello di produzione e ad una più civile vita rurale [corsivo mio]; sottolineando poi che nella bonifica «Non v’è solo […] l’aspetto, dirò, specificamente economico: v’è altro, non meno importante aspetto, che dirò sociale»46. Un altro aspetto da considerare è la preparazione tecnica e scientifica di Luigi di Savoia. Osserva Negrotto47 che «il giornaliero sforzo per guidare l’impresa non distolse il Principe Pioniere dallo studio dei complessi problemi scientifici», enumerando tra le «cose volute» da lui: il servizio meteo, il controllo idrometrico e chimico-fisico delle acque dello Scebeli, il prodromo di entomologia agraria. Rileva poi che la spedizione del 1928-29 alle sorgenti dello Scebeli lo lasciò affaticato, ma che, non appena assestate le cose in azienda dopo l’improvvisa morte di Scassellati, Luigi di Savoia rientrò in Italia per presentare al governo la sua relazione, il 21 febbraio 1929. Questa specifica preparazione, e l’apertura mentale acquisita negli anni di studio e nei viaggi, aiutarono forse anche l’ideazione di altre sue iniziative48, quasi tutte tendenti alla realizzazione di uno dei punti chiave enumerati sopra, la trasformazione in loco dei prodotti primi aziendali, quando possibile e conveniente. Ad ogni modo, per mantenere un qualche ordine all’esposizione, cercherò di condurre un’analisi degli eventi a partire dagli elementi considerati da Onor, il lavoro, l’acqua, i capitali. Il lavoro Si è già accennato ai problemi incontrati dalla SAIS per il reclutamento e l’impiego dei lavoratori somali. All’inizio, durante le prime trattative con i capi locali, alcuni aspetti erano forse stati sottovalutati, ritenendo che gli accordi presi bastassero ad assicurare l’afflusso di manodopera, attratta dalla sicurezza delle colture irrigue e quindi dalla stabilità di vita. Anche durante i lavori di impianto (disboscamento, dissodamento, costruzioni) la facilità di adattamento alle nuove incombenze e l’afflusso di lavoratori facevano bene sperare; ma si è visto che questa fortunata situa209 Ernesto Milanese zione fu favorita dalla eccezionale magra del fiume e dalla perdita dei raccolti nelle zone circostanti. Negli anni successivi, col ritorno dei contadini alle zone di origine, e una peggiore situazione sanitaria dovuta al maltempo, nacquero delle difficoltà sia per il reperimento degli operai nei cantieri sia per la mano d’opera addetta alle prime colture, simili a quelle da sempre riscontrate in Somalia coi lavoratori, i quali, non appena raggranellato un gruzzoletto, o per ritornare al villaggio di origine o semplicemente per il desiderio di cambiamento tanto forte in quelle popolazioni, semplicemente se ne andavano; magari proprio quando il momento era più critico (la semina o il raccolto). Il più delle volte, l’ascendente personale del Duca sulle popolazioni bastò a risolvere le difficoltà49; in altri casi50, come si è detto sopra, si chiese il sostegno del Governo per il reclutamento forzoso. Ma si dovette al contempo studiare qualche forma nuova di collaborazione, meglio definita, anche perché occorreva far convivere senza speciali differenziazioni le genti ‘del patto’, ossia i locali51, con i nuovi venuti, fissi o stagionali. Il contratto colonico applicato dal 1924 e rivisto marginalmente qualche anno dopo, superate le incertezze e la diffidenza dei primi anni, riuscì a costruire nuovi equilibri e ad assicurare per molti anni la forza lavoro52, anche grazie alla crescente meccanizzazione, e con essa le basi per lo sviluppo agricolo ed industriale. Proprio questo contratto è stato oggetto di grandi critiche, come si è detto, e accusato al contempo di essere ‘schiavistico’ o ‘paternalistico’. Meno frequenti, forse, sono state analisi puntuali e studi di ricostruzione storica, o ricerche sul campo, interpellando gli anziani quando ancora sarebbe stato possibile. Ad ogni modo, non deve stupire che l’argomento sia di quelli poco pacifici: si pensi alle discussioni, alle polemiche, agli scontri ideologici che nel dopoguerra la questione ha sollevato qui in Italia, fino agli anni sessanta, quando i contratti di colonia furono vietati per legge, e quelli di affitto regolamentati arbitrariamente, con conseguenze che ancora penalizzano la nostra economia. In agricoltura, infatti, la regolamentazione normativa è una delle soluzioni più stupide che si possano prendere per favorire i cambiamenti53, giacché, come è noto, i rapporti lavoro/capitale sono tutt’altro che arbitrari, e seguono anzi una ‘tendenza naturale’ in funzione dello sviluppo economico generale, delle istituzioni civili esistenti, della pressione sociale, passando in genere dalla compartecipazione, all’affitto, alla proprietà conduttrice (con o senza salariati). Ognuna di queste soluzioni, con tutti gli adattamenti possibili e storicamente 210 L’intrapresa di Luigi di Savoia in Somalia noti, ha un suo ambito di applicazione, dove assicura l’efficienza economica, ossia il migliore impiego delle scarse (o scarsissime) risorse54. Nelle economie arretrate (diciamo così per comodità e giusto per intendersi) la conduzione famigliare, diffusissima, ha in genere poche possibilità di accumulo (per limiti naturali o indotti dalla pressione sociale), e non potendo neppure valorizzare le economie di scala ha poi pochissima capacità di miglioramento e sviluppo; anzi, il più delle volte è già da considerarsi soddisfacente quando assicura la sopravvivenza. La conduzione a salariati presuppone almeno una certa standardizzazione delle tecniche di produzione (per motivi di efficienza e di mercato) e la disponibilità di capitali liquidi; nella tipiche situazioni dell’agricoltura tradizionale (Somalia compresa) comporterebbe poi una voce di costo che risulterebbe insopportabile, la necessità di sorvegliare l’esecuzione del lavoro per tutto il ciclo colturale. Altro aspetto rilevante è che il rischio rimane tutto a carico del conduttore. L’impiego di persone in condizione di schiavitù ‘pura’ potrebbe essere assimilato a questo caso, rimanendo però il problema dei costi di sorveglianza e di controllo della qualità del lavoro; per questo, e per altri comprensibili motivi, è quindi poco diffuso. Circa l’affitto, esso trova applicazione quando sussistono da un lato dei detentori di terra non interessati personalmente alla sua gestione, dall’altro una classe o un gruppo di persone tecnicamente preparate, con una certa disponibilità di capitali, e fiduciose di sé: infatti il rischio grava tutto, o essenzialmente, sull’affittuario. Dunque è proprio per ripartire il rischio, oltre che per minimizzare i costi di sorveglianza e controllo, che le forme di partecipazione sono così diffuse nei paesi e nelle situazioni più differenti. La stessa ‘schiavitù’ agricola praticata un tempo in Somalia nelle zone irrigabili, o sufficientemente piovose, aveva molto della conduzione in partecipazione: infatti, escludendo i casi estremi55, il lavoro era in genere assegnato ‘a squadra’ (un esempio conosciuto è quello dei soddom ‘trenta’) e i lavoratori avevano due giorni liberi (oppure uno, con compensi in natura) per dedicarsi agli appezzamenti loro assegnati per uso personale. Ora, 2 su 5 è come dire il 40 per cento; e se supponiamo, con sufficiente verosimiglianza, che il rendimento delle colture proprie superasse quello dei campi del padrone, non siamo lontani dal famoso 50 per cento che, poco più poco meno, è la misura standard dell’incidenza del lavoro manuale sul valore della produzione, salvo particolarissime condizioni. Ciò considerato, si comprende perché la compartecipazione fosse la for211 Ernesto Milanese ma di conduzione prescelta al momento dell’ideazione dell’impresa, anche sulla base delle esperienze dei ‘pionieri’ italiani nel Giuba e nel basso Scebeli e di Romolo Onor. Nessuno, ovviamente, pensava allora che essa, da sola, avrebbe risolto tutti i problemi; ma certo rimaneva il convincimento che ad essa, in quella situazione, non ci fossero alternative. Si dovette però adattare il contratto al modo di pensare locale, e farlo evolvere secondo le tecniche colturali e le nuove esigenze collegate al rapido cambiamento economico indotto nella regione dallo sviluppo della SAIS stessa, badando sostanzialmente al livello del complessivo reddito famigliare. In poco tempo infatti (4-5 anni) si passò da un’economia di sussistenza che generava occasionali eccedenze – oggetto di incetta da parte dei padroni somali o dei mercanti arabi – a una estesa remunerazione mista in natura e in denaro, con la possibile formazione di risparmio liquido. Occorreva dunque, da un lato, come si è visto, evitare… la fuga dei lavoratori non appena raggiunta una certa disponibilità liquida56, dall’altro individuare condizioni contrattuali ed altri incentivi che portassero alla formazione di una nuova mentalità e di nuove abitudini nei lavoratori, man mano che per lo sviluppo delle colture industriali e le migliori rese dei cereali aumentavano la sicurezza alimentare e i redditi monetari (assistenza sanitaria e provvedimenti igienici, apertura di botteghe, credito agevolato, scuola elementare, possibilità di istruirsi, ecc.). Essendo alta la partecipazione femminile ai lavori, soprattutto per la raccolta del cotone, la direzione della Società volle valorizzare il lavoro delle donne con premi specifici e altre disposizioni, irrise da qualche studioso, ben contento forse del piacere provato quando ha avuto lui l'occasione di essere premiato. Anche i compensi in denaro sono stati oggetto di critica, e tacciati di essere irrisori, però senza un qualsiasi confronto con valori ritenuti congrui, né distinguere tra premi di produzione e paghe57. Pare quindi opportuno richiamare brevemente i punti essenziali del contratto, inizialmente adottato nella primavera del 1924 con un gruppo di 430 famiglie Scidle, e ritoccato nel 1927. Ogni capo famiglia riceveva 1 ettaro (rectius due dareb58) canalizzato, livellato, dissodato, pronto per i lavori preparatori di semina; una metà era coltivata a mais o dura o sesamo (con fagioli o altra pianta consociata), l’altra metà a cotone o altra coltura industriale secondo turni prestabiliti (articoli 1 e 2). Mais, dura e sesamo rimanevano al colono, mentre il prodotto delle colture industriali era consegnato al centro aziendale; erano 212 L’intrapresa di Luigi di Savoia in Somalia previsti (art. 3) dei compensi speciali: per il cotone (intero), di 20 lire per quintale, 15 o 10 secondo la qualità; per le cime di granturco in massa, 8 lire o 12 (per consegna su strada o centro aziendale). Circa le modalità di lavoro, un articolo (6 bis) aggiunto nel 1926 o 1927 stabiliva che «ove speciali circostanze lo richiedano» [in particolare – si può ritenere – durante i turni irrigui o la raccolta per squadre] e per disposizione del capo azienda, i coloni dello stesso villaggio potessero essere riuniti in gruppi opportunamente sorvegliati e diretti. Secondo l’art. 7, i canali irrigui, le prese d’acqua e le strade di pertinenza del podere erano dati in consegna al colono, che ne doveva curare la manutenzione, badando a utilizzare l’acqua con parsimonia. I grandi attrezzi (aratri, erpici, assolcatori, coltivatori) erano dati in consegna gratuita, purché fossero assicurati il buon uso e le piccole manutenzioni; gli arnesi (zappette, accette, roncole, badili, gravine, cababe, cordami, sacchi, ecc.) erano addebitati, con rimborso in prodotti (art. 9). La tariffa addebitata per le giogature era di 35 lire per dareb, quella per la lavorazione meccanica di 70, rimborsabile con prestazioni orarie (art. 11). Per l’art. 12, ogni adulto libero dai lavori nel podere era tenuto a prestazioni nell’azienda, con mercede giornaliera di lire 3 per gli uomini, di lire 2 per le donne e i ragazzi. Che cosa dire dunque di questi compensi colonici: era tanto? era poco? Per rispondere occorrerebbe conoscere meglio di quanto sia ora possibile, dopo più di settant’anni, l’economia famigliare e le condizioni di vita del tempo; ma può essere indicativo un semplice riferimento al potere d’acquisto secondo il prodotto alimentare di base, il mais (in gergo locale detto ‘grano’), il cui prezzo corrente era di 40 lire il quintale: 2 lire equivalevano dunque a 5 chilogrammi di mais. Rapetti, in un rapporto del 193459, rilevava che le paghe offerte per la raccolta del cotone, di 3 lire per gli uomini, 2,50 per le donne e 2 per i ragazzi (quasi uguali alle coloniche) risultavano appetibili, perché attiravano anche avventizi volontari60. L’acqua (ossia piogge ed irrigazione) La Somalia, come è noto, deve essere considerata, nel complesso, un paese arido: solo un terzo circa della superficie riceve 300-500 mm (l’Oltregiuba e la regione mesopotamica), mentre gli altri due terzi restano sotto i 200 mm (zona centrale), o anche i 100 mm (Nogal e Migiurtinia); inol213 Ernesto Milanese tre, l’evapo-traspirazione è assai alta. Oltre ad essere scarse, le piogge somale sono irregolari, cosicché si possono manifestare lunghi periodi siccitosi, perduranti in alcune località anche qualche anno di seguito, senza regola di sorta61. In particolare, il comprensorio di bonifica della SAIS, identificato in genere col nome Villaggio Duca degli Abruzzi (o ‘Villabruzzi’), apparteneva alla zona mesopotamica detta, e rientrava nella fascia climatica costiera, caratterizzata dall’essere i due periodi piovosi principali di gu e di der congiunti da una serie di piovaschi di breve durata e limitata estensione, per un totale di 350-600 mm, ma con minimi fino a un terzo o massimi fino a tre volte tanto (Tab. 1). Tabella 1. Le piogge nella zona del villaggio Duca degli Abruzzi 214 anno piogge (mm) prime piogge (gu) arrivo della piena 1921 256 scarsissime 20 maggio 1922 357 7 aprile primi marzo 1923 1.088 5 aprile 7 marzo 1924 552 fine marzo 22 feb 1925 504 1° aprile 8 maggio 1926 1.892 gennaio primi aprile 1927 632 aprile niente secca 1928 561,5 16 aprile 10 maggio 1929 482,7 18 aprile 25 aprile 1930 407,0 14 aprile niente secca – forte piena a fine aprile 1931 332,6 5 maggio piena a metà aprile 1932 369,0 19 aprile niente secca – piena a fine aprile 1933 390,7 26 aprile in secca da marzo alla fine di aprile – piena 7 maggio L’intrapresa di Luigi di Savoia in Somalia Tabella 2. Precipitazioni mensili al Villaggio GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC mm 4,4 1,4 21,2 95,1 88,7 25,0 23,7 16,5 12,1 106,3 86,1 21,9 502,4 % 0,9 0,3 4,2 18,9 17,5 5,0 4,7 3,3 2,4 21,2 17,2 4,4 100,0 Fonte: A. Fantoli, le precipitazioni atmosferiche in Somalia in «Rivista di agricoltura subtropicale e tropicale», 1960. I dati presentati nella Tab.2 bene evidenziano il fenomeno: infatti, i tre quarti circa delle piogge sono concentrate in quattro mesi (aprile-maggio, ottobre-novembre), un altro 15 per cento va da giugno a settembre, mentre nei quattro restanti mesi (periodo di gilal) le precipitazioni restano sotto il 10 per cento. Questi sono però dati medi, riferiti a circa quaranta anni di osservazioni, mentre in agricoltura è il rischio legato all’andamento stagionale che interessa. Per non tediare il lettore con considerazioni statistiche, basti osservare quale fu l’andamento delle piogge di Gu nei primi anni della bonifica, segnalato dal giorno di inizio delle ‘grandi piogge’ (Tab.1): in soli tredici anni si va da gennaio al 26 di aprile! Si comprende dunque facilmente perché in Somalia le sole imprese agricole coloniali con speranza di successo fossero quelle irrigue, da impiantare sul Giuba o sullo Scebeli. Ma anche la portata dei fiumi, lungo l’anno e di anno in anno, presenta una notevole irregolarità (lo Scebeli più del Giuba), cosicché la progettazione irrigua di una bonifica era tutt’altro 215 Ernesto Milanese che semplice e facile, specie nel 1920, quando, come si è visto, scarse e imprecise erano le notizie sul clima e sul regime fluviale. Va dunque ad onore del progettista, l’ingegnere Pier Gastone Agostinelli, non avere troppo errato nella stima delle grandezze fondamentali. Come per l’analisi delle piogge, riterrei fuori luogo presentare dati tecnici specifici, quali le portate di magra e di piena o le altezze idrometriche; anche perché la diga e le opere di presa erano per l’appunto state progettate in modo che l’acqua del fiume, quando c’era, potesse coprire il fabbisogno62. Sono le date di arrivo della piena al Villaggio Duca degli Abruzzi che possono aiutarci a capire i problemi di conduzione delle aziende: si va infatti da anni (il 1927, il 1930, il 1932) nei quali l’acqua non mancò mai, al 1921, anno di grande secca, quando la piena giunse solo il 20 di maggio, mentre essa era attesa in genere verso metà marzo. Un altro aspetto che non poté all’inizio essere considerato con conoscenza di causa fu la salinità. Essa divenne presto un problema, che sostanzialmente rimase tale nonostante gli studi chimici e agronomici via via compiuti, tanto che Negrotto (1939) cita esplicitamente, tra le tante difficoltà incontrate, «l’irrigazione per acque leggermente salse in terreno alcalino». In sede di progettazione, presumibilmente basandosi sulle osservazioni di Onor, era stato previsto un esteso sistema drenante, destinato per l’appunto ad allontanare rapidamente l’acqua irrigua in eccesso63, e, ancor più – anche se all’inizio ciò non fu forse interamente compreso – per consentire alle piogge di ‘lavare’ gli strati superficiali maggiormente impregnati dei sali apportati dall’acqua del fiume. Ma sempre vi furono difficoltà, soprattutto con l’estendersi della canna, e solo con l’affinamento delle tecniche irrigue e il riposo annuo (su circa 1/3 delle terre) si poté mantenere un sufficiente grado di fertilità64; mentre, in tempi più recenti, dopo la nazionalizzazione, quando si volle per motivi politici forzare la produzione di zucchero e quindi la monocoltura – sempre pericolosa in ambiente tropicale – ben presto essa venne meno. Non si può dunque ritenere che la vita del farmer italiano in Somalia fosse una sinecura, che, avendo il caldo e il sole dell’Africa65, bastasse far scorrere l’acqua, e pensare poi alla caccia e alle gonnelle (o per mantenere la metonimia, ai guntiinooyin delle ragazze): la riprova che, al contrario, i problemi tecnici fossero grandi viene proprio dalla bonifica di Genale, dove molti concessionari, raccogliticci, non possedevano le conoscenze necessarie né, alcuni, la voglia di imparare66. 216 L’intrapresa di Luigi di Savoia in Somalia I capitali Come si è accennato, nelle conferenze al pubblico dell’autunno 1920 il fabbisogno per l’avviamento dei lavori di impianto (capitale fondiario e industriale fisso) era stato preventivato in quindici milioni di lire; ad esso andavano aggiunte le spese d’esercizio dei primi tre anni, per 6 milioni, nella previsione che solo dal quarto anno, con 5 aziende sistemate, i redditi avrebbero superato i costi. Si arrivava così a un totale di 21 milioni; ma ritenendo possibile un concorso governativo, Luigi di Savoia aveva in un primo tempo considerato di costituire la Società non appena raggiunti i 20 milioni di capitale sottoscritto. Venuta meno una tale opportunità, la somma fu portata a 24 milioni di lire, che oggi potrebbero equivalere a poco più di 16 milioni di euro, una dotazione tutt’altro che misera. Eppure, come si è visto, già alla fine del primo esercizio le casse della Società erano semivuote, e Luigi di Savoia dovette pensare a come realizzare un aumento di capitale in un momento politicamente incerto e ancora più sfavorevole per l’economia italiana dell’anno prima. La situazione è dipinta con poche parole in una lettera all’amico Sella del 22 novembre 1921: Fondi. I 10 decimi saranno esauriti in Giugno. Penso perciò sin d’ora ad un aumento di capitale - fra sottoscrittori Americani Inglesi Egiziani ed ad ottenere un mutuo di favore dal Governo - senza che i vecchi azionisti abbiano nulla da versare in più o possano farlo quelli che vogliono67. Il ritmo di spesa, giudicato dall’esterno, dovette apparire folle: 24 milioni in 18-20 mesi, ossia quasi 1,2 milioni al mese; un bello spendere in effetti, che sicuramente avrà impensierito non poco gli amministratori e i soci!68 Il programma accennato nella lettera fu attuato con una certa gradualità, ma con determinazione: dopo aver subito richiamato i 5/10 dell’aumento di otto milioni deliberato dall’assemblea nel maggio del 1923, nel gennaio del 1924 furono richiesti gli altri 5/10, portando il capitale versato da 24 a 32 milioni; l’anno successivo, in giugno, furono incassati dai soci altri tre milioni, dietro delibera presa nel maggio69. Nel frattempo le necessità di cassa furono coperte utilizzando il credito bancario; alcune operazioni (presso la Banca d’Italia a Genova) dietro garanzia su titoli personali del presidente. Circa i sottoscrittori «Americani Inglesi Egiziani» della lettera, cui rivol217 Ernesto Milanese gersi per ridurre l’impegno dei soci italiani, di quelli inglesi ed egiziani non ho trovato tracce, mentre dei fondi americani si sa, secondo quanto pubblicato nella biografia Tenderini-Shandrick70, che provenivano da miss Elkins. Quanto al mutuo, che nel 1920 era stato negato per mancanza di una norma specifica, le pressioni di Luigi di Savoia sul governo (e presumibilmente sul re) porteranno alla legge 24 luglio 1922 n. 1046, che applicava alle colonie le medesime provvidenze stabilite per l’Agro romano, già estese anni prima alla Sardegna; e all’erogazione di due successivi prestiti, di 30 e 3 milioni, quarantennali al tasso del 2.5 per cento. Un altro rilevante recupero di denaro si ebbe col riscatto di molte delle opere idrauliche compiute sullo Scebeli, classificate di pubblica utilità, in ispecie le arginature, e in un secondo tempo, delle opere assistenziali, come la scuola. Tutto ciò, oltre il sicuro commercio locale dello zucchero e degli oli, consentì di sanare la posizione finanziaria a partire dal 1926, quando la posizione debitoria si stabilizzò, e la Società poté assumere partecipazioni sostanziose in altre società ‘sorelle’, dalla Società saccarifera somala (SSS) alla Società agricola industriale d’Etiopia (SAIDE). Conclusioni Tratteggiando le vicende della SAIS abbiamo mostrato la sostanziale identificazione della Società con la persona di Luigi di Savoia, la cui iniziativa agricola e industriale determinò di fatto la vita economica dell’intera Somalia per circa un trentennio. A questo punto ci si potrebbe chiedere però quanto gli intendimenti dei costitutori e la concezione iniziale del progetto abbiano corrisposto alle condizioni del tempo e alle possibilità di un futuro sviluppo del paese. Si tratta forse di un esercizio un poco scolastico, che ci verrà perdonato, speriamo, almeno per la sua brevità. Se consideriamo, secondo una ormai classica opinione71, quelle che sono ritenute le cause dirette dello sviluppo economico: a) lo sforzo ad agire economicamente, b) l’accumulazione della conoscenza, c) l’accumulazione di capitale; constatiamo, confrontandole con i contenuti delle relazioni della ‘missione’ e con le idee più volte espresse dal Duca e dai suoi collaboratori, che questi ‘motori’ del successo furono tutti ben considerati nei progetti, e messi poi in atto dai dirigenti della SAIS. 218 L’intrapresa di Luigi di Savoia in Somalia In particolare, tenendo presente l’osservazione che la ‘conoscenza’ deve essere intesa nel duplice aspetto tecnologico e sociale72, si vede che anche da questo punto di vista colse nel segno, coll’immediato trasferimento di nuove competenze ai lavoratori locali (trattoristi, autisti, fuochisti, ecc.) e la successiva selezione del personale specializzato per l’oleificio, lo zuccherificio, e gli altri servizi. Anche riguardando i più generali legami con l’economia del Paese, l’azione della SAIS risulta essere stata conforme alla ‘buona condotta’ per avviare lo sviluppo: si intuì infatti che l’elevazione economica e sociale delle popolazioni agricole del comprensorio avrebbe portato non solo all’aumento dei consumi, ma, nel tempo – diremmo oggi per il crescere del costo opportunità della risorsa lavoro – a una maggiore produttività media dello stesso settore agricolo. Occorre aggiungere che così operando, poiché nei paesi a basso livello di reddito e a forte incidenza dell’agricoltura la produttività del settore agricolo è molto correlata al livello di sviluppo economico generale, la strategia migliore, accanto agli interventi generali, dovrebbe includere politiche settoriali volte ad ammodernare il settore agricolo73. Un tale approccio viene proprio a coincidere con uno dei primi convincimenti del Duca, di volere cioè che la Società operasse per l’istruzione e il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni locali74. La stessa presenza di attività industriali di trasformazione – anche questa voluta dal Duca75 – all'inizio oli e pannelli, poi lo zuccherificio, se generò qualche tensione nella disponibilità di manodopera, favorì però la valorizzazione del lavoro già all’interno del comprensorio, costituendo in più uno stimolo all’affermazione personale dei giovani e un polo di irradiazione del progresso tecnico all’esterno76. Questa ‘scuola pratica’ e la tradizione di lavoro ebbe una tale impronta che ancora negli anni settanta-ottanta, quando qualcuno si presentava come artigiano o per chiedere lavoro in qualche impresa statale, la referenza SAIS, più precisamente SNAI, era accettata dappertutto senza riserve. Un altro aspetto poi merita attenzione, ossia che la SAIS, pur ammesso che fosse stata concepita come azienda coloniale «per incominciare a fare fruttare la Colonia» come si legge in un appunto che circolava al momento della sua costituzione, oltre che assicurare i generi essenziali ai dipendenti, divenne ben presto fornitrice del mercato interno, dapprima con i sottoprodotti, poi con colture specifiche, e soprattutto con la raffinazione dello zucchero e la distillazione dell’alcool. 219 Ernesto Milanese Circa l’opera di colonizzazione, oggi certo non è possibile conoscere l’opinione degli interessati; né ho avuto la ventura di rintracciare in letteratura o ascoltare i ricordi di qualche discendente. Effettivamente gli inizi furono difficili, e portarono a incomprensioni e momenti di crisi, come si è detto; ma da quanto esposto, in parte suffragato dalle unanimi opinioni di colleghi somali, sembra di capire che dopo il 1930 le cose funzionassero meglio, avendo la popolazione sperimentato la convenienza della nuova situazione durante le carestie. Inoltre, in parallelo con la rapida crescita della produzione ‘industriale’ della SAIS destinata ai consumi interni della Somalia dopo lo spostamento dal cotone alla canna, grazie al passaggio dalla coltura colonica tradizionale a quella irrigua ‘migliorata’ aumentò di molto pure la disponibilità di derrate per i consumi dei contadini, che infatti poterono passare dalle iniziali 2.400 unità77 alle circa 7.000 del 193378. Anche questo modo di procedere, e gli effetti constatati, risultano in piena sintonia con le concezioni economiche attuali79, e soprattutto, direi, spiega, a contrariis, le varie negative esperienze di intervento internazionale, quando siano così affrettate e massicce da sconvolgere l’assetto economico locale senza crearne di nuovi abbastanza duraturi, e portando in molti casi a una diminuzione delle risorse primarie; infatti, per poter mettere in atto gli elementi ritenuti necessari per lo sviluppo rurale occorre tempo e pazienza80, ossia una ben controllata gradualità di intervento sulla popolazione locale. Questo aspetto, in effetti, fu considerato dai più attenti colonizzatori di allora, in Africa dai tedeschi, in particolare per l’istruzione tecnica agricola e forestale: mentre sembra essere sparito dalle menti dei più indottrinati e ‘rapido viaggianti’ nipoti. Correlato al precedente troviamo un altro punto fondamentale dell’azione della SAIS: il mantenimento dell’unità di villaggio all’interno della nuova struttura aziendale. Pure questa soluzione, collegata d’altronde direttamente alla questione della mano d’opera, richiese grande attenzione e dovette trovare aggiustamenti successivi, ma parve non solo opportuna quanto inevitabile, per essere appunto il villaggio «la base della vita rurale»81, l’unità spaziale, economica e sociale nella quale si svolge l’intera attività della popolazione rurale. Quante volte invece in tempi recenti, pur se giustificati da eventi naturali o straordinari (guerre, carestie), si sono creati insediamenti recidendo ogni precedente legame di origine, spesso per opportunità politica ovvero per affrettare la radiosa nascita di qualche nuova ideologia; salvo poi am220 L’intrapresa di Luigi di Savoia in Somalia mettere, dopo qualche tempo o mutate le circostanze, il fallimento dei progetti, ma quasi con un residuo senso di meraviglia per… lo scarso spirito di adattamento delle persone coinvolte. Un ultimo punto: progetti come questo avrebbero un senso anche oggi? Purtroppo, proprio ciò che è avvenuto in Somalia dimostra che in regime liberistico (o capitalistico, come si diceva un tempo) iniziative di così alta intensità fondiaria in un tale ambiente agronomico e sociale (ossia con tali costi fissi) sarebbero indubbiamente destinate all’insuccesso. D’altra parte, l’impossibilità attuale di investimenti di lunga durata è proprio uno dei principali fattori di freno al miglioramento delle condizioni dell’agricoltura in tutti quegli ambienti ove, come in Somalia, poca è la tranquillità di vita e insicuri sono i rapporti sociali: l’agricoltura non può progredire senza stabilità e speranza. Note al testo 1 In una intervista pubblicata nell’ottobre 1938 su «L’Autarchia Alimentare» (v. 1, n. 5, pp. 1835) col titolo Inizi, sviluppi e affermazioni della Società agricola italo-somala ideata e fondata da S.A.R. il Duca degli Abruzzi. Negrotto, in quel periodo, della società era il presidente. 2 La quale, dopo due tentativi falliti, fece grande impressione in America; impressione che durò a lungo, anche perché nessuno raggiunse nuovamente quella cima fino al 1948. Cfr. Peter Bridges, A prince of climbers, «The Virginian Quarterly J.» 2005: «It would be another halfcentury before the next group of climbers, from the Harvard Mountaineering Club, reached the top of Mount St. Elias»; il quale Bridges, per inciso, ambasciatore degli USA a Mogadiscio nel 1984-86, e che conosce i monti d’Abruzzo per aver vissuto a Roma, nota come il titolo creato nel 1890 da Umberto per il nipote non potesse riuscire più adatto. 3 Il riferimento è all’abbandono del servizio attivo, avvenuto nel febbraio del 1917, e alla nota vicenda del legame con Katherine Elkins, di qualche anno prima. Questa relazione aveva vivamente interessato l’opinione pubblica, opposizione politica compresa: ne La Luce repubblicana del 25 settembre 1910, ad es., sotto il titolo Finalmente! si poteva leggere (a p. 4): «Dunque, finalmente, l’Agenzia Stefani s’è fatta uscire il rospo di corpo: miss Elkins non vuole più saperne del duca degli Abruzzi. / Ce ne rallegriamo vivamente con la davvero bellissima signorina americana, perché … ci dispiace che un’onesta e intelligente giovane come lei non avesse già risposto con un sonorissimo schiaffo a quel cortigiano mammalucco che ... nelle ultime trattative le aveva offerto un matrimonio morganatico, uso quello della famigerata contessa Mirafiori col Padre della Patria». 4 Gli Italiani in Africa Orientale: dall’Unità alla marcia su Roma, p. 872 dell’ed. 1985. 221 Ernesto Milanese 5 Che sembra ora oggetto di parziale revisione: in un più recente lavoro si può leggere: «La fama del Duca degli Abruzzi è però strettamente legata alla creazione della più grande azienda agricola in Somalia» (K. Raguzzoni, Colonialismo e politica agraria in Somalia, in L’Africa e il XX secolo: riflessioni sulle culture e le società contemporanee, Torino 1997, p. 96). All’epoca, ovviamente, e ancor più dopo la morte del Duca e in concomitanza col crescente impegno coloniale dell’Italia, era proprio l’opera di colonizzatore in Somalia ad essere considerata la sua maggiore benemerenza. 6 Estesa e documentata l’analisi di Marco Guadagni in Xeerka beeraha…, Milano 1981, pp. 173-184), soprattutto per gli aspetti giuridici del titolo di possesso della terra, mentre quelli economici non sono considerati. Sulla questione del lavoro l’A. riporta un unico giudizio negativo, di parte inglese, scritto nel 1948 (quando l’amministrazione militare era chiamata a rispondere della sua azione durante l’occupazione, in particolare proprio per i provvedimenti presi a tamburo battente con i quali si vietava la compartecipazione; bisogna inoltre tenere presente che il volume è basato sulla tesi di dottorato, sostenuta nel 1979 alla University of London). Anche nell’articolo di Bridges sopra citato si può leggere: «With the help of local clan leaders, many Somalis were forced against their will to become SAIS laborers. The duke’s use of forced labor in Somalia was perhaps the most negative aspect of his life». Ricordando però le impressioni di una «famiglia americana» in visita all’azienda nel 1985 (quando era ambasciatore in Somalia), nota che «The plantations were again using forced - prison - labor» e manifesta poi quasi un certa meraviglia per avere trovato, dopo tante vicende storiche e politiche, ancora funzionante l’azienda creata dal Duca, anche se malamente condotta sotto la gestione statale e con crescenti problemi di salinità del suolo. Ad ogni modo, pur se si volesse escludere i tanti giudizi nel complesso favorevoli, dell’epoca e del dopoguerra, ritenendoli tutti viziati da preconcetti storici o politici, si potrebbe almeno considerare qualcuno di quelli… neutrali. Il riferimento è ai vari siti ‘somali’ presenti in Internet, ove è quasi sempre presente una sezione di storia ‘coloniale’, con commenti e giudizi sulla Somalia italiana e inglese. 7 È noto che dopo la metà del XIX secolo, in presenza di condizioni commerciali favorevoli, la manodopera necessaria per la valorizzazione dei terreni irrigabili fu acquisita mediante l’importazione di schiavi dai paesi contermini (cfr. Peter Conze - Thomas Labahn, Somalia: agriculture in the winds of change, Saarbrucken-Schafbrucke, 1986, pp.129-30; ove si riprendono, confermandoli, elementi accertati da Cassanelli nelle sue indagini degli anni settanta). 8 Così si esprimeva nell’aprile del 1960 Salad Abdi Mohamed, allora ministro dell’agricoltura (corsivo mio): «Il miglioramento della nostra agricoltura implica grandi sforzi ed enormi investimenti ... sta a noi indirizzare questo sforzo internazionale [ossia la cooperazione tecnica e finanziaria] nelle direzioni di maggiore suscettibilità, tenendo conto dei limiti impostici dall’ambiente fisico che è tra i più difficili dell’Africa e dalla mentalità degli uomini che richiede una paziente educazione per evolversi» (in Linee di politica agraria somala, «Rivista di agricoltura subtropicale e tropicale» LIV, 1960, p. 164). 9 L’importanza dell’opera di Luigi di Savoia per la Somalia è un fatto da molti sostenuto: per tutti, fuori dell’ambito specialistico, si veda, di Clelia Maino, La Somalia e l’opera del Duca degli Abruzzi, Roma 1959. All’epoca, fu riconosciuto apertis verbis da personalità di primo piano e in occasioni ‘ufficialissime’: per i diretti legami con la Somalia citerò De Vecchi, che così ebbe a esprimersi nella commemorazione di Luigi di Savoia (in «Nuova Antologia», aprile 1933, n. 1465, p. 323), senza che sia possibile oggi sapere se questo fosse il suo vero pensiero: «Ogni prosperità della quale oggi tutti i colonizzatori già godono nella colonia benedetta è frutto della Sua fatica. Il suo fiorire di domani sarà [...] figlio del seme lanciato dal Principe Augusto con tanta liberalità […] Tutto in quel campo discende da Lui: la visione della feracità della terra, la irrigazione, la scelta dei prodotti, la impostazione delle aziende [...] la valorizzazione della colonia incomincia senza dubbio da Lui». All’estremo opposto, per così dire, ossia in scritti riserva- 222 L’intrapresa di Luigi di Savoia in Somalia ti, sta ciò che riferì da Mogadiscio, in un rapporto nel novembre 1934, un ispettore della Banca d’Italia, Rocco Quattrone: parlando del settore agricolo egli ribadiva che «all’avanguardia della bonifica integrale della Somalia lungo lo Scebeli [sta la SAIS], sorta per la volontà tenace e per la instancabile attività [di Luigi di Savoia ] al quale la Colonia deve certamente il suo sviluppo agricolo oltre che il vanto di possedere il più grande centro [...] delle colonie italiane, ove tutto è sapientemente e razionalmente organizzato» (ASBI, IspGen 385, 6, Mogadiscio 1934/52). 10 Anche Bridges così conclude il suo scritto già citato su Luigi di Savoia: «His death in an African village was world news; and then the modern world began to forget about him». 11 Per più precisi riferimenti e altre notizie mi permetto di rimandare ai seguenti lavori: L’indebitamento della Società Agricola Italo-Somala (SAIS) dal 1921 al 1939, Riv. Agric. Subtropic. e Tropic. (giugno 1991), v. 85, n. 2: 333-9; Tra Sardegna e Somalia: storia di due bonifiche nella corrispondenza fra il Duca degli Abruzzi e Vittorio Sella, Lettura tenuta all’Accademia dei Georgofili - 8 giugno 1995, in: ‘I Georgofili’, Atti dell’Accademia dei Georgofili, (serie 7ª) XLII (1995), pp. 209-31; Storia di una bonifica coloniale: la nascita della Società Agricola Italo-Somala (SAIS), «Rivista di Storia dell’Agricoltura» (dicembre 1995), XXXV, n. 2, pp. 67-122; La Società Agricola Italo-Somala e l’opera del Duca degli Abruzzi in Somalia tra il 1920 e il 1933, in Miscellanea di storia delle esplorazioni, v. 24°, 1999, pp. 233-58. 12 Non potendo ripercorrere qui le vicende dell’origine della Società, ricorderò solamente che Luigi di Savoia, dopo aver lasciato il 4 febbraio 1917 il servizio attivo in Marina, e non essendogli consentito di partecipare in altro modo alla guerra, decise infine «per troncare una situazione che diventava difficile» di compiere un viaggio in Africa Orientale per «[vedere] a che punto si trova la nostra colonia del Benadir» (Biglietto a Vittorio Sella del 16 settembre 1918); e che di qui nacque l’idea e poi il progetto della bonifica. Per la corrispondenza tra Luigi di Savoia e Vittorio Sella, si veda in Storia di una bonifica coloniale cit., l’appendice I, alle pp. 100-114. 13 Nella Somalia centrale, come è noto, vi sono due stagioni principali di piogge, gu (nella nostra primavera) e der (autunno). Più precisamente, le quattro stagioni della Somalia centromeridionale possono essere così caratterizzate: gilàl (‘Jiilaal’), da metà dicembre a metà marzo, monsone invernale di N.E., molto caldo e secco, fiumi in magra; gu (‘Gu’), da metà marzo a fine maggio, piogge principali (44 d, 200-300 mm), caldo e piovoso, fiumi in piena; hagai (‘Xagaa’), dai primi di giugno a fine settembre, monsone estivo di S.W., fresco con piovaschi, fiumi in mezza magra; der (‘Dayr’), dai primi di ottobre a metà dicembre, piogge secondarie (36 d, 150-200 mm), mediamente caldo e piovoso, fiumi in piena. 14 Le note di Onor sull’argomento, preparate intorno al 1915, non erano state pubblicate; e lo saranno solo nel 1921, tre anni dopo la morte, a cura di Mazzocchi Alemanni (Romolo Onor, Il problema idraulico del Benadir [I] in «Agricoltura Coloniale», luglio 1921, pp. 354-72). Gli unici dati disponibili, ritengo, erano le osservazioni idrometriche compiute ad Afgoi tra l’ottobre del 1908 e il marzo del 1910 (dall’Ufficio incaricato della progettazione della ferrovia e dal Residente), oltre le poche osservazioni e informazioni raccolte da viaggiatori e funzionari. Cfr.: Osservazioni idrometriche del fiume Uebi Scebeli presso Afgoi compiute dall’Ufficio per lo studio della Linea Mogadiscio-Afgoi negli anni 1908-909, «Boll. Soc. Africana d’Italia», febbraio 1911, v. XXX, pp. 20-3 (con le osservazioni giornaliere dal 19 ottobre 1908 all’8 settembre 1909); Roberto Fano, Del regime delle acque nelle nostre colonie: Somalia Italiana, in Atti del 2° Congresso Italiani all’Estero, Ist. Coloniale It., Roma 1911: v. 1°, parte III, pp.1639-1646 (accenna alle misure fatte dal Residente di Afgoi dall’aprile 1909 al marzo 1910, riporta una misura di portata fatta nel dicembre 1910, di 17,31 mc, e stima in 270 mc la portata di piena). Effettivamente, nel periodo 1918-33 la portata media al Villaggio Duca degli Abruzzi fu di circa 50,8 mc/s, pari a un deflusso annuo di 1.600 milioni di metri cubi; da notare che, nei tratti più stretti, portate maggiori di 120-130 metri cubi davano luogo ad esondazioni. 223 Ernesto Milanese 15 Indicativamente, per il solo Benadir e secondo le zone, da 7-10 anni. 16 Sui lavoratori locali c’era alternanza di opinioni e di giudizi, fin dalle prime osservazioni fatte nella zona del Giuba; in particolare, pur avendosi vari esempi contrari, si considerava che solo genti non somale fossero disponibili per la coltivazione delle terre. Interessanti le osservazioni di Nallo Mazzocchi Alemanni relative al periodo della sua visita in zona, nel 1911-12 (L’agricoltura nella politica coloniale, «Agricoltura Coloniale», giugno 1919, pp.130-46). Per uno sguardo ’prospettico’, pur nei limiti delle conoscenze del tempo, si vedano anche: Il problema agricolo e la manodopera del Benadir, «Rivista Coloniale», novembre 1918, v. 13: 503-506; Guido Mangano, Della mano d’opera nelle nostre colonie: Somalia Italiana, in Congresso (secondo) degli Italiani all’Estero. Atti, Ist. Coloniale It., Roma 1911; v. 1°, pp. 1669-1696. 17 Egli, fin dal 1911, invitava a non fare affidamento sugli «ipotetici coefficienti di ricchezza» che pure infioravano gli scritti riguardanti la Somalia, ma ammetteva che «una operosa e ordinata attività, sorretta da un prudente e oculato, ma non esiguo, concorso di capitali [potesse] condurre a risultati proficu», sempre che terra e lavoro fossero reperibili in quantità adeguata. 18 Luigi di Savoia era certamente persona che non decideva senza avere studiato e meditato; ma vorrei qui ricordare, chiedendo venia per la divagazione, un passo di Leopardi, che, con l’abituale capacità sintetica e rappresentativa, scrive «poiché un’intima persuasione originata dal caso ha spesse volte più forza sul nostro animo che qualunque prova ricercata e studiata » (Discorso sopra la batracomiomachia in Poesie e prose, a cura di M.A. Rigoni, Milano 1998; v. 1, p. 412). 19 Lettera a Vittorio Sella del 2 marzo 1919: «Ho trovato il Benadir molto interessante e credo ora dopo d’averlo percorso in lungo ed in largo di conoscerlo abbastanza. Lungo i fiumi vi sono dei terreni fertilissimi. Purtroppo l’abolizione della schiavitù ha tolto le braccia -- il Somalo non lavorando ma facendo lavorare gli schiavi. Ma lascio il Benadir convinto che quella colonia ha un avvenire». 20 La cronistoria dei lavori e le relazioni per la parte agricola (Scassellati Sforzolini) ed idraulica (Agostinelli), esposte nella Relazione al Governo della Colonia, furono poi stampate nel volume della SAIS dedicato ai lavori compiuti: Lavori di bonifica compiuti dalla S.A.I.S. nella regione «Scidle» della Somalia Italiana, Tip. G. Bonavia, Genova 1929. 21 Col metro somalo, s’intende. Su una superficie di circa 1.000 chilometri quadrati furono trovati 23.000 abitanti in 49 villaggi prossimi al fiume e 25 lontani, con una densità risultante di circa 23 abitanti per chilometro quadrato, contro una media, per la Somalia del tempo di circa 2,5. 22 Tanto che l’amico Vittorio Sella ebbe a scrivergli (lettera del 17 giugno 1920): «V.A. mira sempre a una certa grandezza e perfezione in tutto quello che intraprende e perciò ritengo che, a malgrado di ogni contrarietà sempre possibile, avrà voluto insistere nelle esperienze [di coltivazione] al fine di sapere dove convenga operare con maggior garanzia di successo. Però nella vita, e credo che V.A. sarà dello stesso mio parere, per essere non dico felici ma abbastanza divertiti è necessario acquistare un poco d’indifferenza verso noi stessi, e lasciarsi portare dalla volontà della fortuna». D’altra parte, il suo motto (secondo l’Ufficio Storico della Marina) era «meditare ed osare»; e nella corrispondenza da Napoli spesso figura uno stemma col motto «ardisci e spera». Lo stesso Vittorio Sella così aveva scritto alla moglie durante la spedizione al Sant’Elia (nella prefazione al libro di A. A. Michieli, Il Duca degli Abruzzi e le sue imprese, 2ª ed., Milano, 1943, p. IX): «Ammiro sempre più nel Principe la rara perspicacia e una mente chiara e previdente. La Spedizione, grazie alla sua energia, sarà organizzata in modo esemplare. A tutto Egli pensa ed è veramente, come vuol essere, il capo dell’impresa. Ha letto tutte le Relazioni degli esploratori precedenti e discute, con ragionamenti sani e osservazioni sensate, sulle difficoltà della nostra prossima esplorazione, sui difetti e vantaggi di organizzare i trasporti 224 L’intrapresa di Luigi di Savoia in Somalia in un modo piuttosto che in un altro, cosa veramente ammirevole per un giovane della sua età [24 anni]» (lettera dell’8 giugno 1897 da S. Francisco). 23 Federico Negrotto, L’opera feconda di Luigi di Savoia, nel supplemento al n. 7 di «Africa It.» del 9 maggio 1939 intitolato Gli Italiani in Africa e pubblicato in occasione della Giornata coloniale. 24 Vittorio Sella, a p. XIII della prefazione al libro di Michieli citato sopra. 25 Lo stesso Sella rammenta (ivi, p. XII) che: «A S.A.R. era ben noto che fin dal 1903 io ero divenuto un appassionato agricoltore in Sardegna, [e] aveva preso particolare interesse per tale tipo di bonifica. Molte volte mi si era presentata l’occasione di parlargliene anche nel corso delle spedizioni al Ruwenzori e al Karakorum e di illustrargli quei nostri lavori che molto lo interessavano, poiché […] mi confessava di avere una profonda passione per l’agricoltura». 26 Il Duca degli Abruzzi: le imprese dell’ultimo grande esploratore italiano, Torino 1967; p. 296. Mi permetto poi di rammentare che Luigi di Savoia aveva già visitato i nostri approdi in Somalia nel 1893 e che notizie e impressioni sulle genti e sui luoghi erano comuni in famiglia: Elena di Francia compì due viaggi in Africa nel 1908 e nel 1910; il conte di Torino si recò in Somalia con Frankestein nel 1908 (devo questa informazione alla cortesia del sig. G. Rinaldelli, già dipendente SAIS). 27 La sede sociale era in Mogadiscio; il capitale sottoscritto, di 24 milioni di lire, era suddiviso in 48.000 azioni da lire 500. Partecipavano, oltre il Duca e suoi familiari, istituti bancari nazionali e locali, gli ambienti cotonieri e zuccherieri, singoli industriali e privati cittadini di Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Queste le maggiori partecipazioni: Banca Italiana di Sconto (3.000 azioni), Banca Commerciale Italiana, Banco di Roma e Credito Italiano (2.000), Martini Basagni De Vecchi & C. (1.800), Duca degli Abruzzi e familiari (1.700); tra i privati, con 1.000 azioni troviamo: G. Agnelli, L. Baldeschi Cennini, A. Mylius, G. Treccani. 28 Giohar (ma pure Gioar) è la grafia tradizionale; la trascrizione ufficiale è Jawhar, ma anche Jowhar è in uso, e mi permetto di ricordare che la forma ‘dotta’ era Jôwhar. 29 Favoriti dall’eccezionale secca di quell’anno, che per vari mesi consentì liberamente i trasporti tra le due sponde, e dal cattivo andamento dei raccolti, che spinse molti contadini a cercare lavoro nei cantieri per sopravvivere e sostenere la famiglia: nel giugno risultavano presenti nei cantieri 1200 Somali, guidati da capi squadra eritrei e arabi. Di questi si poté presto fare a meno, giacché sin dai primi momenti si cercò in tutti i modi, per semplicità organizzativa e anche per ridurre i costi, di formare sul posto la manodopera qualificata per la guida dei trattori, la distribuzione delle acque, ecc., e perfino per la navigazione fluviale, individuando e preparando le persone naturalmente dotate e più disposte all’adattamento, i giovani soprattutto, come sempre avviene nei periodi di grande cambiamento. 30 Quindici milioni, secondo il preventivo di massima presentato nelle conferenze al pubblico dell’autunno 1920 (cfr. BiSS 13, p. 14). [Con BiSS si indica la Bibliografia della Società Agricola Italo-Somala (1920-1942), Firenze 1998 «Biblioteca agraria tropicale»; il numero è quello d’ordine delle opere elencate]. 31 E ciò non solo per la grande complessità delle opere e gli ostacoli ambientali: a pesare erano anche la lontananza dall’Italia, la lentezza dei trasporti marittimi, la precarietà di quelli terrestri, le carenze organizzative della Colonia. Grazie però alla determinazione degli amministratori, al sostegno dei soci, alla capacità e all’impegno dei collaboratori, e all’esempio e alla volontà del presidente, che si era stabilito sul luogo, e che di persona intervenne ai più alti livelli governativi e in Somalia e in Italia, la crisi venne superata. 225 Ernesto Milanese 32 F. Negrotto, Inizi, sviluppi e affermazioni cit., pp. 24-30; C. Maino, La Somalia e l’opera del Duca degli Abruzzi cit., pp. 99-101. Le difficoltà del 1921, forse perché di natura finanziaria, non sono state considerate da questi Autori; né, ovviamente, furono evidenziate in modo esplicito dai dirigenti. Esse erano certamente note al momento, e commenti più o meno espliciti comparvero sulla stampa, specie in occasione degli aumenti di capitale. 33 A quali apprensioni dessero luogo in Italia questi eventi appare, ad esempio, da una lettera a Luigi di Savoia di Toeplitz (vicepresidente della SAIS), il quale così scriveva il 7 febbraio 1924: «Ho seguito con grande interesse e trepidazione l’opera da V.A.R. svolta costì a vantaggio della nostra intrapresa, e la lotta sostenuta contro le difficoltà [...]: le pioggie torrenziali, e poi l’epidemia che ha infierito su codeste plaghe […]. Ora, io mi rendo perfettamente conto di questo desiderio [ossia di prolungare il soggiorno sino al subentrare della massima piena] e comprendo [...] le ragioni che lo ispirano; tuttavia, nell’interesse stesso dell’impresa […] vorrei permettermi di farLe giungere la mia sommessa protesta [per una decisione che potrebbe] mettere a repentaglio la salute di V.A.R.». 34 Da 3,6 a 2,8 quintali di fibra per ettaro, che era pur sempre una buona produzione: la resa massima si ebbe nel 1931-32 con 4,35, la minima nel 1926-27 con 1,09. Dopo la campagna d’Etiopia non si riuscì più a superare i 2 quintali per ettaro, mancando la mano d’opera, ma anche per il diminuito interesse della coltura rispetto alla canna. 35 L’opera della Società Agricola Italo-Somala in Somalia, Milano, 1978, p. 54. Al momento della definizione dei piani per l’AOI, la gravosità delle opere di arginatura fu una delle principali critiche all’impianto di grandi aziende irrigue per la produzione del cotone. Così, G. Lavelli De Capitani, al Congresso di Studi Coloniali (Firenze, 1937) nell’esporre l’impostazione essenziale della produzione cotoniera, dopo aver rammentato le iniziative di Luigi di Savoia in Somalia e di Gasparini sul Gasc [Eritrea], avverte che «questi programmi con sistemazioni e bonifiche preliminari, non sono, né potranno essere mai finanziariamente redditizie per l’eccessivo capitale investito in confronto agli ettari coltivati e della produzione ottenuta» (Coltivazione del cotone in A.O.I., in Atti del III Congresso Studi Coloniali, Firenze 1937; vol. VIII, pp. 403-404). 36 Il direttore della Filiale di Mogadiscio della Banca d’Italia, Secondino De Ambrosis, nel rapporto annuale del 1935 (ASBI, IspGen 51, 6, Mogadiscio), dopo le espressioni di rito per la campagna d’Etiopia, riferisce sull’intensa attività dell’esercizio legata all’afflusso di disponibilità e ai buoni guadagni, «che hanno sistemato molte posizioni»; e rileva la tendenza ad abbandonare le abituali occupazioni per seguire «allettanti e facili fonti di guadagno», prontamente frenata – aggiunge – anche dalla Filiale, vigilando sulla natura delle operazioni (domande fasulle di credito agrario, effetti di comodo, ecc.). Nota poi come dalle campagne si sia avuto la corsa in città per l'impiego nei servizi domestici, nell'edilizia e nei cantieri stradali, e per l'arruolamento. 37 I prezzi realizzati dalla SAIS scesero dalle 1.800-2.000 lire dei primi anni alle 505 del 1933 (quando le quotazioni dell’Upland furono meno di un terzo di quelle del 1918-19) per risalire a circa 600 negli anni successivi (L’indebitamento cit., p. 336). 38 In particolare, v. il volume XVII (e ultimo della I ed.) della Guida d’Italia del Touring Club Italiana, Possedimenti e colonie del 1929, alle pp. 734-9, e quello Africa Orientale Italiana del 1938 (XXIV della Guida), alle pp. 602-6. Circa le visite di personalità straniere, solo per la primavera del 1930 possiamo rammentare: un gruppo di 4 persone, tra cui sir John Ramsdon, già governatore. del Chenia; sir F.C. Gowers, governatore della colonia inglese dell’Uganda. 39 Giacché in molte zone l’aumento della superficie a cereali voluto dal governo contrastava con quello della barbabietola da zucchero. 40 Per convenienza organizzativa e per la vicinanza al porto d’imbarco di Merca i bananeti saran- 226 L’intrapresa di Luigi di Savoia in Somalia no poi concentrati in un «lotto bananiero» a Genale. 41 Basti l’enumerazione fattane da Negrotto, che tra le altre sue iniziative pone: la coltura industriale delle banane; le regole per la coltivazione del cotone; la raffinazione degli olii commestibili; la fabbricazione del sapone, pur dietro il parere negativo degli specialisti. 42 Per una sintesi del contenuto v. BiSS 9-11, 13-14, 15 bis. Le naturali doti di semplicità, chiarezza e brevità, esercitate dal lungo periodo di comando in Marina, e anche la lunga pratica di conferenze in occasione delle esplorazioni, rendevano efficaci e gradite al pubblico le sue parole. Per riportare un esempio… insospettabile, nell’«Avanti» di venerdì 18 febbraio 1910 (anno XIV, n. 49, p. 2) si può leggere, con riferimento a una conferenza tenuta il giorno prima a Torino sulla spedizione al Caracoram: «La conferenza, con bellissime proiezioni e cinematografie, è risultata molto interessante. Il Duca ha parlato senza artificio letterario, senza punte sciovinistiche, stringente, spoglio di rettorica esaltazione. Applaudite furono anche le conclusioni scientifiche». 43 Un qualche aiuto viene pure dalla corrispondenza tenuta con l’amico Vittorio Sella. 44 Prefazione a L’Opera della Società Agricola Italo-Somala cit., p. VI. 45 Angelo Piccioli, in una nota aggiunta tra la stesura e la stampa (31 ago 1933) di La Nuova Italia d’Oltremare, Milano, pp. 845-6. 46 Arrigo Serpieri, venticinque anni dal Congresso di San Donà di Piave, in Scritti di economia agraria, 1946 - 1953, Firenze 1957 (già negli Atti del Congresso regionale delle bonifiche venete, 5-7 giugno 1947). 47 L’opera feconda di Luigi di Savoia, in Gli Italiani in Africa, Soc. ed. di «Novissima», Roma 9 maggio 1939 (suppl. al n. 7 di Africa It.), p. 14. 48 Vedi nota 42. 49 Vedi lettera Luigi di Savoia del 23 novembre 1923 a Vittorio Sella: «Le preoccupazioni per la mano d’opera si sono dileguate al mio arrivo. Tutto procede per ora secondo il programma stabilito». 50 Ciò avvenne nel periodo iniziale e in situazioni particolari (epidemie, alluvioni), senza dar luogo, si può ritenere, ad abusi come altrove (leggasi Genale). Le maggiori difficoltà si ebbero, in presenza di un’epidemia di peste, dal maggio 1923 alla primavera del 1924, quando fu introdotto il contratto di colonia. Di ciò si trova traccia nella stesse Relazioni del Consiglio d'Amministrazione: così, in quella sul bilancio 1923 presentata all’assemblea del 17 luglio 1924 (opuscolo a stampa) si riferisce che tra gli animali le piogge hanno favorito vari casi di peste equina e di tripanosi dei bovini; e che l'abbondanza delle piogge e la comparsa della peste bubbonica hanno aggravato il problema della manodopera, per cercare di risolvere il quale «il nostro Presidente, con forte virtù di esempio, ha creduto appunto di prolungare il Suo soggiorno in Colonia [e che, sempre allo stesso fine] è stata fatta una grande e importante trasformazione nel sistema di conduzione, passando, per una estensione di oltre 500 Ettari, da quello in economia a quello a mezzadria, trasferendo 430 famiglie Scidle dai loro Villaggi a quelli nuovi [...] Per tale trasformazione, nell'anno in corso, 265 Ettari saranno coltivati a cotone .. da mezzadri, ai quali in compenso saranno assegnati altrettanti Ettari per colture cerealicole ad essi riservate. […] Se i risultati [...] saranno [...] favorevoli, la mano d'opera, per quanto riguarda la coltivazione dei terreni, darà minori preoccupazioni, restando peraltro [...] da provvedere a quella eccezionale per gli impianti e la preparazione delle nuove Aziende, in gran parte formata da volontari di regioni extra Scidle». 51 Il ‘patto’ con i capi dei villaggi era stato siglato il 19 marzo 1921. Che certamente si prestava a interpretazioni discordanti, ed era forse frutto di un eccesso di ottimismo da parte di Luigi 227 Ernesto Milanese di Savoia. 52 Riporto alcune considerazioni di Scassellati, riferite al 1925, quando il ‘nuovo’ contratto di colonìa era al 2° anno di applicazione generalizzata: «Questo sistema – egli scriveva – specialmente all’inizio ha incontrato nella sua pratica attuazione molte difficoltà ed ha talora sollevato dubbi ed incertezza sulla possibilità d’essere esteso con successo su di un così notevole numero di individui tanto primitivi ed indocili. Sta però il fatto concreto ed inconfutabile che detto sistema .. si è mostrato ottimo sotto ogni riguardo ed ha permesso il regolare esercizio delle nostre colture, anche durante periodi di gravi crisi e deficienza di mano d’opera avventizia » (La SAIS in Somalia, «Agricoltura Coloniale.», XX, n. 4-5, p. 157). Pur essendo parte… in causa, l’affermazione è da ritenere valida; tanto più che questo tipo di conduzione fu poi ripreso a Genale (con risultati meno buoni, però) e anche in Libia e in Eritrea. 53 Cfr. B.F. Johnston, Criteria for the design of agricultural development strategies e H.P. Binswanger & M.R. Rosenzweig, Contractual arrangements, employment and wages in rural labor markets in G.M. Meier e J.E. Rauch, Leading issues in economic development, 7ª ed., 2000, OUP, pp. 344 e 357. Proprio nel caso italiano, ad esempio, fu certamente un errore il voler inserire nel codice civile del 1942 la clausola di divisione a metà per la mezzadria invece di lasciarla alla contrattazione delle parti, per potersi adattare alle circostanze e decidere secondo opportunità. 54 Nel mondo perfetto della teoria economica, con un perfetto mercato di libera concorrenza, senza asimmetrie e la conoscenza perfetta di ciò che avviene, la possibilità di trasferire i rischi e di… comperare il tempo (prestiti e altri contratti finanziari), i diversi modi di gestione sarebbero equivalenti: ma non nel mondo vero. Per questi argomenti, e una visione un po’ meno… semplificata, rimando al classico e diffusissimo testo di G.M. Meier e J.E. Rauch, Leading issues cit., in particolare al cap. VII e alle pp. 356-360. 55 Che si presentano quasi con un certo aspetto di «leggenda metropolitana» dell’epoca, come quella che il padrone (e questo gli altri Somali lo dicevano dei Bimal) ponesse al mattino una manciata di creta umida sulle spalle del lavoratore per controllare che «non si raddrizzasse mai» dal lavoro (di zappatura/sarchiatura) durante il giorno. 56 O lasciando debiti nel conto corrente colonico: nei primi anni infatti le posizioni negative continuarono a crescere, superando il mezzo milione di lire, di fatto inesigibili. Solo aumentando le rese dei cereali colonici e prelevando l’eccedenza al raccolto si poté riportare la situazione a un livello fisiologico. 57 Per il contenuto del contratto colonico, v. A. Maugini, Contratti per la mano d’opera indigena nella Somalia Italiana (Actes du V Congres International d’Agriculture Tropicale, Anversa 1930, pp. 43-54; ampiamente riassunto in BiSS 119); e poi di G. Rapetti, Il contratto di colonia adottato dalla Società Agricola Italo-Somala, comunicazione presentata al II Congresso di studi coloniali (Napoli 1934) pubblicata anche in «Rassegna Economica delle Colonie», v. 23, 1-4 (aprile 1935, pp. 97-108) e in «Agricoltura Coloniale», v. 29, 1 (gennaio 1935): 3-14; ristampato poi nella collana di Relazioni e Monografie Agrarie Coloniali, n. 36. Il testo completo del «Contratto e regolamento colonico» sta nell’appendice V di Lavori di bonifica (1929). Circa l’attenzione personale di Luigi di Savoia per i lavoratori, si veda, come esempio, la fotografia a p. 65 dell’«Italia Coloniale», marzo 1933 (vol. 10), che ha per didascalia «S.A.R. paga personalmente i coloni» (ove, in effetti, la persona ripresa è una colona). 58 Dareb è la forma italianizzata standard; in somalo anche darab (pl. darabyo). Misura di superficie variabilissima da zona a zona: intorno a Genale, secondo Onor, era di 2.600-3.750 metri quadrati, mentre in vari villaggi della regione Scidle variava da 2.300 a 12.700 metri quadrati. Un decreto governativo del 1912 l’aveva fissato a 8.000 metri quadrati, ma dalla SAIS fu convenzionalmente considerato di mezzo ettaro; per il ministero dell’Agricoltura somalo è (uffi- 228 L’intrapresa di Luigi di Savoia in Somalia ciosamente) pari a un quarto di ettaro. 59 L’ingegnere Giulio Rapetti era allora il direttore della SAIS. Il documento (dattiloscritto di 8 pagine) ha per titolo: Promemoria: condizioni [della] mano d’opera colonica in Somalia (fascicolo 1882 del Centro di documentazione dell’Istituto Agronomico per l’Oltremare, Firenze). 60 Nel medesimo rapporto si dice che un terrazziere Scidle chiedeva 4 lire il giorno, e i ‘frontalieri’ Sciaveli per disboscamento e altri lavori faticosi, da 3,50 a 4,50 per famiglia. Un altro confronto veniva fatto col libero coltivatore proprietario, mostrando che, tenuto conto degli incentivi e delle giornate a opera, il ricavo annuo per famiglia era di 1.379 lire contro 864, a parità di giornate lavorate. Per i coloni, naturalmente, bisognerebbe tenere conto che la decisione di fare ore aggiuntive era legata alla produttività marginale del loro lavoro nel podere o nella sciamba. 61 A Fantoli, Le precipitazioni atmosferiche in Somalia in «Rivista di agricoltura subtropicale e tropicale», 1960, dal quale abbiamo ripreso anche la zonizzazione climatica. 62 La SAIS aveva ottenuto una dotazione continua di 6 metri cubi al secondo, ossia più di 8 litri al giorno per metro quadro irrigabile. 63 L’acqua reflua era ricondotta allo Scebeli o immessa nei vecchi canali dei villaggi, a sostegno dell’agricoltura indigena. 64 Che la fertilità agronomica fosse una costante preoccupazione per Luigi di Savoia, lo mostra anche una lettera del 12 novembre 1930 a Vittorio Sella, poco dopo una visita dell’amico, quando era ancora convalescente (Fondazione Sella, Fondo Vittorio Sella, s/particolare, Luigi di Savoia a Vittorio Sella, fasc. 1930-31): «Mi ero dimenticato di domandarLe ieri l’altro, ogni quanti anni devono arare profondamente in Sardegna, dopo il 1° lavoro di scasso. Da noi ogni tre anni bisogna arare profondamente». 65 Ma anche l’umidità: durante hagai non erano infrequenti ammuffimenti, tanto che a Genale, dove il fenomeno era più grave, anche per incuria, si pensava di installare degli essiccatori. 66 Lo stesso De Vecchi, che bene li conosceva, così si era espresso su di loro: «Date le origini eterogenee e la levatura, nella media assai modesta, ho rinunciato da vari anni alla speranza che il tempo e le parole del Governo li possano migliorare. Sono quelli che sono, e finché resteranno, bisognerà prenderli per il loro verso. In fondo c’è della brava gente, degli aspri lavoratori, degli appassionati rurali: i migliori sono i più umili» (Da un rapporto ‘segretissimo’ di Caroselli, Documentazione inedita dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, fasc. 1861). 67 Fondazione Sella, Fondo Vittorio Sella, s/particolare, Luigi di Savoia a Vittorio Sella, fasc. 1920-23. 68 A lavori quasi ultimati, intorno al 1927, l’investimento per ettaro bonificato ammontava a ca. 10.600 lire, secondo il bilancio del 7° esercizio (Archivio storico della Banca Commerciale, ST, 56/3); dai dati del medesimo bilancio si può determinare l’incidenza delle spese di trasporto sui costi di produzione: 31 lire per q. dall’Italia a Moga; 34 da Moga al Villaggio. 69 Ciò consentì di integrare di un pari importo il mutuo governativo di favore ottenuto nel frattempo dal Ministero (vedi avanti, nel testo). Nel 1934, superata la crisi finanziaria e assestata la gestione, si ebbe un rimborso di capitale di 5 milioni, mediante annullamento di azioni proprie (acquistate a un prezzo inferiore al nominale). 70 M Tenderini e M. Shandrick, Il duca degli Abruzzi: principe delle montagne, Novara 1997, p. 113. 71 William Arthur Lewis, Teoria dello sviluppo economico, Milano 1963, p. 171. 72 «Lo sviluppo infatti dipende tanto da elementi quali la capacità di amministrare organizzazioni di larga scala o creare istituzioni che favoriscano lo sforzo in senso economico, quanto 229 Ernesto Milanese dal diffondere nuove sementi o imparare a costruire dighe più massicce». (W. A. Lewis, Teoria dello sviluppo cit.) 73 È questo un aspetto ancora richiamato di recente in ambito internazionale; cfr. la relazione di Nikos Alexandratos alla XXI Conferenza Internaz.le degli Economisti Agrari (Tokyo, 1991) come riportata da S. Tarditi nella «Rivista di Economia Agraria», XLVI (1991), 4, p. 635. 74 Spedizione agricola di SAR il Duca degli Abruzzi nella Somalia Italiana / Relazione al Governo Coloniale della Somalia Italiana / (ottobre 1919 - maggio 1920). In Relazione sulla Somalia, [Mogadiscio] 1920. (Parte 1ª) - cc. 25. 75 Cfr la testimonianza di Negrotto riportata in precedenza. 76 Per molti anni la SAIS costituì di fatto per i nativi un vero centro di formazione di manodopera specializzata (trattoristi, meccanici, ecc.). 77 «Nel comprensorio di pertinenza della S.A.I.S. [esisteva] nel 1920 […] una popolazione stabile complessiva di circa 2.374 abitanti (843 uomini)», G. Scassellati Sforzolini, La S.A.I.S. in Somalia in «Agricoltura Coloniale», 1926, p. 145, n.l. 78 Cfr. per il numero delle famiglie presenti A. Piccioli, La valorizzazione agraria della Somalia italiana in Emilio De Bono, La nuova Italia d'Oltremare, Milano 1933, p. 178, e G. Rapetti, Il contratto di colonia adottato dalla Società Agricola Italo-Somala in «Rassegna Economica delle Colonie», aprile 1935, p. 107, per la composizione media delle medesime. 79 Per un confronto tra le condizioni dello sviluppo nel XIX secolo e oggi cfr. D. Salvatore, Trade and trade policies of developing countries, «MEDIT», V (1994), 4, pp. 4-11. Di particolare interesse, per la nostra analisi, il possibile parallelo tra i principi della politica coloniale del tempo e gli effetti del commercio internazionale elencati dall’A. per quanto riguarda: a) la trasmissione di nuove idee, di nuove tecnologie e di capacità amministrativa, b) l’afflusso di capitali per investimenti diretti da parte di imprese estere (p. 5). 80 Parikh, dell’Ist. Indira Gandhi di Bombay, scrive: «Lo sviluppo rurale, attraverso ricerca, assistenza tecnica, ed investimenti specifici in opere irrigue e progresso tecnologico, fornisce risultati più consistenti e duraturi degli aiuti alimentari, anche perché favorisce il processo di sviluppo economico locale» («Rivista di economia agraria» loc. cit., p. 637). 81 Così un titolo in uno scritto di Jacques Chonchol, L’agriculture dans les pays en développement in Enciclopedia Universalis, suppl. II (1984), pp. 986-96. 230 La Francia, le colonie, la Storia. Riflessioni a partire dalla legge del 23 febbraio 2005 di Domenico Letterio 1. Nelle ultime settimane del 2005, le prime pagine della stampa quotidiana francese furono animate da una rovente polemica intorno a quella che divenne presto nota come la «legge del 23 febbraio»1. Essa fu innescata da una singola proposizione della legge 158 promulgata dal Presidente della Repubblica francese Jacques Chirac il 23 febbraio 2005. Una legge che recitava, al secondo comma dell’articolo 4: Les programmes scolaires reconnaissent […] le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l’histoire et aux sacrifices des combattants de l’armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit2. Pietra dello scandalo era quel «ruolo positivo della presenza francese oltremare» che nella trascrizione mediatica della vicenda si era trasformato, senza fare granché torto alle intenzioni del legislatore, nel «ruolo positivo della colonizzazione». Tale fu il livello dello scontro politico su tale dicitura che nel breve volgere di qualche mese il governo, per calmare le acque, fu costretto ad impegnarsi per l’abrogazione. La «legge del 23 febbraio» – che, epurata del comma incriminato, è tuttora vigente – è un provvedimento legislativo portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés. Con il termine rapatriés essa allude ai cittadini francesi delle colonie che, in seguito alle indipendenze, scelsero di emigrare nella Francia metropolitana. Rapatriés, in particolare, sono i «francesi d’Algeria» che abbandonarono il loro paese in seguito alla guerra di liberazione. Ad essi ci si riferisce spesso col termine di pieds-noirs, a indicare gli emigranti o i discendenti di emigranti europei (i «bianchi», vale a dire i «coloni» in senso proprio), o con quello di harki, in riferimento ai nord-africani che si misero al servizio della Francia 231 Domenico Letterio prima e durante la guerra d’Algeria. Divisi su tutto, dal momento che si poteva trattare di migranti di prima, di seconda o di altra generazione, di semplici operai o di ricchi proprietari, a volte di origini francesi, altre volte provenienti da altri paesi del Mediterraneo o dall’Europa centrale, i pieds-noirs si trovarono ad essere accomunati dal semplice fatto di occupare una medesima posizione in rapporto alla «linea del colore»3. Si trattava di una popolazione eterogenea, ma per buona parte integrata in una società urbana fatta di funzionari, piccoli commercianti, artigiani, impiegati e operai4. Essi avrebbero avuto una difficoltà soltanto relativa nel «reinserimento» nella società francese: donne e uomini di pelle bianca, il più delle volte con nome e cognome francesi, già a partire dalla seconda metà degli anni sessanta, complici la plasticità dell’economia e la crescita di quel periodo, avevano cessato di costituire un problema specifico per quanto riguardava la loro integrazione5. Ben diversa era la situazione degli harki, la cui posizione era quella che risultava maggiormente scavata dalle contraddizioni della società coloniale. Con il resto della popolazione algerina essi condividevano il limbo determinato dagli estremi della cittadinanza francese e da tratti somatici che li inchiodavano alle categorie squisitamente coloniali di «indigeni», «musulmani», «arabi» o «berberi»: un proliferare di appellativi che traduceva certamente la complessità della situazione coloniale, ma anche una realtà in cui alcuni erano «più francesi» di altri. Dopo aver lealmente servito la Francia in numerosi fronti della seconda guerra mondiale, gli harki si trovarono di fronte ad un drammatico dilemma quando, nel 1955-6, compresero che quella che stava attraversando l’Algeria non era affatto una rivolta locale, ma un movimento che alludeva ad una prossima indipendenza6. Essi furono letteralmente usati dall’amministrazione coloniale per mantenere il controllo dell’Algeria, ma si videro costantemente negato quel diritto ad una piena integrazione nella società francese cui la loro fedeltà alla «patria» li aveva fatti sentire legittimati ad aspirare. Disprezzati dalla Francia, essi si trovarono inoltre a subire le crescenti minacce del Fronte di Liberazione Nazionale, che li condannava in quanto «algerini» che avevano tradito la causa nazionale. La finzione di una piena appartenenza degli harki alla società francese crollò nelle settimane immediatamente successive all’indipendenza. Il generale de Gaulle fece infatti introdurre misure restrittive che limitavano l’immigrazione di quella che egli, senza troppe sottigliezze, definiva «gente 232 La Francia, le colonie, la Storia con il turbante»7. Come ha osservato Benjamin Stora, nei mesi successivi alla perdita dell’Algeria «è il tema dell’invasione nord-africana che si diffonde, l’intrusione dei colonizzati, sub-cittadini, nella nazione francese, al cuore stesso delle città e di Parigi»8. Ciò che i tumultuosi eventi di quegli anni misero in luce era il fatto che sullo spazio coloniale insisteva un doppio registro epistemologico: alla retorica repubblicana e assimilazionista corrispondeva infatti un immaginario strutturato dall’irriducibile differenza degli «arabi», inclusi in via subordinata nello spazio francese. Se fino a pochi mesi prima il motto preferito dai sostenitori dell’Algeria francese era: «l’Algérie, c’est la France», il tentativo di limitare l’emigrazione degli harki verso la metropoli mostrava come nel breve volgere di qualche settimana essi fossero già ridivenuti algerini. Pieds-noirs e harki condividevano quindi la sorte di persone in fuga da un paese nel quale si sentivano sempre più «indesiderati». I primi, la cui pelle bianca era nella nuova Algeria un immediato richiamo al recente passato di domino e sopraffazione, temevano che la violenza contro di loro potesse perpetuarsi ben oltre la formale cessazione delle ostilità. Oppure non vedevano per quale motivo restare in Algeria dopo aver perso i privilegi e le risorse di cui avevano per lungo tempo goduto. Gli harki invece, tanto nel caso dei militari quanto in quello dei dipendenti dell’amministrazione coloniale, fuggivano in quanto perseguibili come traditori al servizio del dominio francese. Con le indipendenze divenne sempre più evidente che l’outre-mer francese non corrispondeva in alcun modo all’immagine ancor oggi prevalente di un progetto di dominio che faceva dei «bianchi» i dominatori e degli «altri» i dominati. Un immaginario, questo, prodotto per attrazione dallo stesso apparato categoriale coloniale, ma che si discosta dalla realtà dei dispositivi che hanno materialmente operato in Algeria e altrove. Il «progetto coloniale»9 non ha mai aperto una frattura lineare, ma ha messo in opera dispositivi di governo e di messa a valore che si avvalevano della «linea del colore» senza mai coincidere con essa. Il suo segreto stava proprio nel fatto che le categorie dei dominanti e dei dominati non sono mai state coestensive a quelle dei francesi de souche européenne (gli «europei») e dei francesi de souche nord-africaine (gli «arabi»). Il potere coloniale non avrebbe mai potuto conservare la propria presa senza convincere almeno una minima parte dei suoi sujets di poter ottenere una sorta di vantaggio competitivo dalla situazione. La «razza» diveniva in tal modo un fattore di differimen233 Domenico Letterio to della conflittualità più che un elemento produttivo della conflittualità stessa. Il progetto coloniale si dipanava in uno spazio che era già da sempre articolato in conflitti: li disarticolava e li ricomponeva, non li produceva ex novo. 2. Al loro arrivo in Francia, harki e pieds-noirs si distribuirono in maniera non omogenea sul territorio nazionale. In parte come effetto di reti amicali e familiari preesistenti, in parte seguendo specifiche disposizioni governative, essi scelsero principalmente Parigi, il nordest, l’asse che unisce Lione a Grenoble e soprattutto la costa mediterranea10. È proprio grazie alla loro concentrazione geografica che harki e pieds-noirs sono spesso riusciti ad imporre al dibattito politico alcuni temi loro cari: le loro richieste sono infatti un qualcosa di non aggirabile per coloro che si candidano nelle circoscrizioni con una larga presenza di rapatriés. Un esempio eclatante di tale dinamica è proprio l’iter parlamentare della legge del 23 febbraio: essa costituisce infatti il precipitato di anni di pressioni e lavorio politico da parte delle associazioni harki e pieds-noirs. Il relatore del progetto di legge originale, discusso dall’Assemblea Nazionale l’11 giugno 2004, era il deputato dell’UMP Christian Kert, eletto in una circoscrizione, Bouches-du-Rhone, che conosce un’alta concentrazione di rapatriés. Modifiche importanti, tra le quali l’introduzione della frase dello scandalo, furono proposte da un sotto-emendamento del deputato Christian Vanneste, suo collega di partito. Il testo definitivo fu adottato il 10 febbraio 2005 e promulgato due settimane dopo dal Presidente della Repubblica. A seguito del crescendo di critiche dei mesi successivi, il governo si venne a trovare in una posizione di notevole imbarazzo. Fatta eccezione per alcuni membri dell’estrema destra nostalgica, il comma che proclamava gli «effetti positivi della colonizzazione» era infatti impresentabile per la quasi totalità delle forze politiche. È per questo motivo che nelle prime settimane del 2006 Jacques Chirac si dichiarò favorevole alla sua abrogazione. Il primo ministro Dominique de Villepin, il 25 gennaio 2006, chiese al Conseil constitutionnel di constatare il carattere réglementaire del secondo comma dell’articolo 4, in modo tale da consentirne la soppressione per decreto ed evitare un dibattito in Parlamento. La risposta affermativa del Consiglio costituzionale arrivò il 31 gennaio, determinando in tal modo la definitiva archiviazione della vicenda. Soffermarsi oggi, a due anni di distanza, su un frammento di legge ri234 La Francia, le colonie, la Storia masto in vigore il breve spazio di qualche mese e oramai definitivamente accantonato significa illuminare un tratto peculiare della vita politica nella Francia postcoloniale. Centrale, in questa vicenda, è il fatto che gli estensori della legge abbiano tentato di entrare a gamba tesa in un dibattito estremamente complesso, giocando le memorie harki e pieds-noirs – come tutte le memorie, inevitabilmente parziali – contro la «Storia ufficiale» della Francia. È evidente a chiunque che i rapatriés non possono in alcun modo riconoscersi in una narrazione, quella della «Storia ufficiale», che rimuove e stigmatizza come «male assoluto» quel passato coloniale che è esattamente ciò in cui essi sono stati spinti per decenni a credere, e ciò per cui hanno tenacemente combattuto. Da un lato, la legge del 23 febbraio si pone su una linea di continuità con una serie di analoghe proposte legislative approvate negli ultimi anni. Ne costituisce un chiaro esempio la legge 488 dell’11 giugno 1994, che risponde alle domande di risarcimento avanzate da chi, fuggendo dall’Algeria, è stato costretto ad abbandonare vita e averi in Africa. Dall’altro lato, tuttavia, v’è in tale legge un elemento in più: con la proclamazione degli «effetti positivi della presenza francese oltremare», infatti, essa va decisamente al di là del mero riconoscimento delle perdite materiali. Essa accorda infatti un riconoscimento che è anche e soprattutto simbolico. Ciò che traspariva dal comma abrogato era la richiesta, da parte dei rapatriés, di una proclamazione ufficiale del loro statuto di vittime della decolonizzazione. È evidente che le memorie harki e pieds-noirs sono oggettivamente incompatibili con quella di una Francia che cerca di ripudiare il proprio passato coloniale. Ed è esattamente questo l’insegnamento della vicenda della legge del 23 febbraio: il carattere irriducibile delle memorie coinvolte, la radicale impossibilità di una sintesi tra le parti. 3. È proprio il dibattito sul rapporto tra «memoria» e «memorie» ad aver ricevuto in questa vicenda il maggiore impulso. Numerosi storici si sono pubblicamente esposti al fine di manifestare tutta la loro preoccupazione per quella che si è preso a definire come una «guerra di memorie coloniali»11. Essi hanno adoperato i loro attrezzi concettuali nell’analisi di una supposta deriva «comunitaria», mettendo in luce i rischi di una situazione in cui ad ogni gruppo sia concesso il diritto di riscrivere la propria storia. Ma ancor più grave, ai loro occhi, era il fatto che il Parlamento si fosse arrogato il diritto di intervenire, per via legislativa, nella riscrittura di una delle pagine più importanti della storia politica francese. Non è casua235 Domenico Letterio le l’insistenza pressoché esclusiva, da parte loro, su due soli articoli della legge: il terzo, che prevede la creazione di una «fondazione per la memoria della guerra d’Algeria» demandata al Consiglio di Stato, e il quarto, che oltre a proclamare «gli effetti positivi della presenza francese oltremare», interviene, con una disposizione contenuta nel primo comma, nella determinazione dei programmi di ricerca universitaria. In maniera analoga, essi hanno inoltre associato la loi du 23 février ad alcune altre leggi promulgate negli ultimi anni, come la Gayssot, del 1990, che mira a réprimer tout propos raciste, antisémite ou xénophobe, la Taubira, del 2001, che definisce la «tratta negriera» crimine contro l’umanità, e infine la legge che ha riconosciuto il genocidio armeno. La scelta di unire con un filo rosso tutte queste leggi origina dal desiderio di opporsi con forza eguale a qualunque tentativo del Parlamento di mettere bocca su questioni che, a parer loro, sarebbero di stretta competenza degli «storici di professione». Il loro interesse si è quindi progressivamente focalizzato su questioni che riguardano le condizioni di esercizio della loro professione, spesso prescindendo dal contenuto specifico della legge del 23 febbraio12. Per quanto le analisi di coloro che si sono espressi su tale punto siano varie e non di rado eterogenee, alcuni temi di fondo tornano con una certa regolarità. Per la semplicità dell’esposizione e la nettezza della proposta, vale la pena soffermarsi su un’intervista a Pierre Nora comparsa – a vicenda conclusa – su «Le Monde 2», settimanale allegato al più diffuso quotidiano francese. Ciò che egli ritiene di aver individuato nella legge del 23 febbraio è un progressivo slittamento da una memoria che egli definisce «normale» a una «patologica»13. Per Nora la memoria «normale» è quella che riconosce la priorità della sintesi stato-nazionale, quella capace di ridurre la complessità e riassorbire l’attuale proliferare di narrazioni. Osserva Nora: «Voi potevate essere il discendente di un aristocratico ghigliottinato, di un comunardo fucilato, di emigranti polacchi, di ebrei alsaziani rifugiati, di bretoni ligi alle consuetudini bretoni, con tutte le tradizioni familiari e memoriali che ciò comportava. Ma, a scuola, voi non eravate altro che un piccolo francese che recitava: i nostri antenati, i Galli»14. Attraverso un riferimento alla funzione disciplinante delle istituzioni scolastiche, Nora ripercorre quel processo di reductio ad unum che, nella celebre formulazione di Koselleck, ha fatto di storie plurali il singolare della Storia15. Ciò che sembra guidare la riflessione di Nora è una sorta di malinconia per i bei tempi andati della nazione, per l’epoca in cui rassicuranti narrazioni nazio236 La Francia, le colonie, la Storia nali sembravano capaci – e in parte senz’altro lo erano – di disciplinare e ridurre la complessità. La lezione di Koselleck, tuttavia, va decisamente al di là dei pochi elementi ripresi da Nora. Non è elemento accessorio nella riflessione del teorico tedesco l’idea che l’emergere della storia come singolare collettivo abbia coinciso con una concentrazione del potere nelle mani di alcuni specifici attori, e quindi con una specifica forma delle relazioni sociali. La Storia è emersa come esito del processo di neutralizzazione delle forze centrifughe che resistevano o tentavano di opporsi alla monopolizzazione del potere da parte di una singola istanza centrale, quella dello Stato nazionale. Un processo all’interno del quale si è altresì data la creazione del «popolo». Lungi dal costituire un’entità «naturale», il «popolo» è infatti prodotto per attrazione dalla stessa singolarità del potere statale. Detto in altri termini, esso non è altro che un artificio necessario alla messa in forma di un’unità che sia quanto più possibile immunizzata dalla conflittualità sociale, una conflittualità che, tuttavia, non è mai totalmente riducibile. È infatti evidente che l’idea di un «popolo» unito da una storia è molto più vicina al costituire una proiezione sul passato di un desiderio attuale che non qualcosa che si sia storicamente dato. È anzi proprio l’odierno proliferare di storie a mettere in luce come l’artificio sia quello della sintesi stato-nazionale, la cui verità coincide con uno specifico ordine: quello dello Stato nazionale moderno. Alla domanda dell’intervistatore su quale atteggiamento gli storici siano oggi chiamati a tenere, la risposta di Nora è inequivocabile: «resistere». Una metafora esprime ancor più chiaramente il suo pensiero: «al punto in cui ci troviamo, vale a dire minacciati da una riscrittura completa della storia dal punto di vista delle vittime, non è forse inutile riaffermare dei principi semplici. E restarci incollati come una cozza ad uno scoglio»16. C’è da essere sconfortati al solo pensiero che un «addetto ai lavori» possa ritenere che il compito degli storici debba essere quello di ergersi a estremi baluardi di un ordine ampiamente superato dal tumultuoso incedere dell’epoca in cui stiamo vivendo. È quantomeno curioso che Nora, dopo aver sostenuto per un’intera intervista che la storia è la disciplina anti-dogmatica per definizione, non riesca a fare altro che rendere le armi al dogma principale della disciplina storica così come la conosciamo: cioè al fatto che si tratti, in particolare nella sua trascrizione scolastica, di una storia nazionale. Per come lui e numerosi altri storici hanno impostato la polemica contro la legge del 23 febbraio, essi sembrano aver innalzato a principale obiettivo 237 Domenico Letterio del loro agire pubblico la mera difesa del canone nazionale. E la cosa è ancora più paradossale se se si tiene conto che, come è stato messo in luce da Abdelmalek Sayad, la mediazione stato-nazionale ha trovato proprio nelle ex-colonie una sua riproduzione «fuori tempo massimo». Ne costituisce un esempio palese il discorso politico del FLN, che ha riprodotto un nazionalismo uguale e contrario a quello della Francia colonizzatrice, riproducendone nell’Algeria indipendente i limiti e il portato di violenza17. La piega che alcuni storici hanno impresso al dibattito ha quindi prodotto un differimento del piano del discorso: se in un primo momento l’obiettivo polemico era stato da tutti individuato nella scelta di assegnare alla colonizzazione degli «effetti positivi», in seguito alla loro presa di parola questo elemento è slittato sullo sfondo, e l’obiettivo è divenuto quello di negare alle storie «non ufficiali» il diritto a essere narrate. È così sfumata l’iniziale compatta indignazione nei confronti di un revisionismo che non a caso si trova in sinergia con le forze politiche più retrive, spesso mobilitate dall’estrema destra, nostalgiche dell’Algeria francese e dell’Organizzazione Armata Segreta. Al suo posto si è coagulata un’aperta ostilità nei confronti di qualunque tentativo di mettere in discussione la storia «ufficiale». Nora e i suoi colleghi si sono compattati attorno all’imperativo della difesa di un canone, negando alla radice l’evidenza del fatto che la storia è un processo aperto, un complesso di narrazioni in perpetua trasformazione, i cui contorni sono continuamente ridefiniti dagli attori che si muovono sulla ribalta dello spazio pubblico. Parafrasando Nora, non è forse inutile riaffermare altri principi semplici. Come è stato messo in luce ancora una volta da Koselleck, gli storici inevitabilmente traducono il loro «residuo» soggettivo all’interno del proprio lavoro18. Il punto di vista dello storico precede necessariamente l’analisi storiografica ed è ineliminabile. È quindi necessario per lo storico assumere in prima battuta la necessaria parzialità del proprio punto di vista, una parzialità che si manifesta anche nella scelta dei temi da affrontare. È allora un peccato che nel chiacchiericcio generalizzato attorno alla legge del 23 febbraio tale parzialità non sia stata utilizzata, come era sembrato essere in un primo tempo, per proporre all’opinione pubblica un dibattito sui lasciti e l’attualità della storia coloniale francese. 4. Non è casuale che dopo alcuni mesi in cui il dibattito era stato semplicemente abbozzato la legge del 23 febbraio abbia acquisito centralità 238 La Francia, le colonie, la Storia solo nelle ultime settimane del 2005. È stata infatti la rivolta nelle banlieues – a cavallo tra ottobre e novembre – a imprimere una spinta decisiva alla discussione, che ha in tal modo guadagnato la ribalta del circo mediatico ed è infine approdata in vetta all’agenda di governo. La guerriglia di cui migliaia di giovani banlieusards si erano resi protagonisti sembrò dare evidenza empirica a quella categoria di «frattura coloniale» che un importante volume aveva da poco proposto ai dibattiti politici francesi e che era stata aspramente criticata da alcuni degli storici firmatari delle petizioni contro la legge del 23 febbraio19. Questi si mostrarono infatti convinti che tale categoria potesse veicolare un’ulteriore proliferazione delle cristallizzazioni identitarie alla base di quella «deriva comunitaria» che tanta isteria suscita in buona parte dell’intellighenzia d’Oltralpe20. Il loro, tuttavia, non era semplicemente il rifiuto di una categoria. Nora e molti dei suoi colleghi non sono stati infatti capaci di tematizzare il nesso tra il passato coloniale e ciò che è successo nelle banlieues, presi com’erano nel tentativo di riassorbire quella complessità in dibattiti «alti» sul rapporto tra legge, colonizzazione e Storia. Nella scelta di rifiutare la categoria di «frattura coloniale» v’era infatti anche il rifiuto di confrontarsi con la più drammatica epifania della violenta conflittualità che innerva il tessuto politico e sociale francese21. In tal modo essi hanno prodotto uno scollamento del dibattito politico da alcune delle forze che stanno aprendo le principali contraddizioni nello spazio pubblico francese. Nora e i suoi colleghi paiono non vedere che con la fine degli imperi coloniali si sono trascinati nella metropoli non solo i corpi di numerosi degli ex sujets, ma anche una buona parte dei dispositivi di dominio in cui essi erano impigliati già al di là del Mediterraneo. Essi tendono a leggere la storia francese in termini squisitamente dialettici: se la colonizzazione costituisce il momento puntuale che ha frantumato l’ideale originario dell’unità repubblicana, ora che quella pagina buia della nostra storia è alle spalle è venuta l’ora di una sua riaffermazione positiva. All’interno di un tale schema, categorie come quella di «frattura coloniale», alludendo a una presunta persistenza di elementi tipici dell’epoca coloniale nell’attualità politica francese, non fanno che ostacolare tale movimento di ricomposizione. Tuttavia il concetto di frattura coloniale, a prescindere dalla qualità del libro cui dà il titolo, ci costringe a decentrare lo sguardo dal piano meramente discorsivo della «guerra di memorie» per volgerlo in direzione della 239 Domenico Letterio violenza oggi subita in Francia da buona parte di coloro che provengono dai territori delle ex colonie. Ciò ovviamente non significa che il discorso sulla «memoria» appartenga a un registro separato, «sovrastrutturale»: ciò che le dispute degli ultimi mesi hanno dimostrato è semmai il fatto che la parzialità di ciascuna memoria può essere mobilitata a sostegno delle battaglie che i singoli ingaggiano sulle proprie condizioni materiali di vita. Spesso la «memoria» è ciò attraverso cui soggetti «subalterni» provano ad articolare le proprie rivendicazioni. È l’anelito a un’uguaglianza che deve necessariamente passare per il riconoscimento – e non la sottrazione – della differenza. Se in molti oggi decidono di articolare le proprie richieste in termini di memoria e valori è perché essi si trovano costretti ad inseguire i propri obiettivi sul piano in cui opera la forma principale dell’ideologia contemporanea. Essa parla di «memorie» e di «valori» per evitare che ci si esprima su una conflittualità che si dipana su ben altri piani, come quelli dell’allocazione di risorse o diritti, dell’accesso a servizi e opportunità e via discorrendo22. 5. V’è un ultimo punto su cui vale la pena soffermarsi. Ad uno sguardo più approfondito, la singolarità della storia nazionale su cui insiste Nora non costituisce altro che lo sfondo epistemologico del discorso che divide coloro che risiedono in Francia tra autoctoni e allogeni. È esattamente da tale luogo immaginario – ma profondamente reale – che origina l’ingiunzione paradossale con cui lo Stato francese si rivolge ad alcuni suoi giovani cittadini, nati e sempre vissuti in Francia, chiedendo loro di partecipare ad uno sforzo collettivo volto a perseguire l’obiettivo della loro integrazione. È esattamente questa la piega assunta dai dibattiti che hanno fatto seguito all’esplosione delle banlieues, nutriti dalla convinzione che la qualità di «francese» sia un qualcosa di essenzialmente estraneo a coloro che hanno un qualche legame di sangue con le periferie dell’ex impero coloniale. È con queste modalità che l’armamentario razzista dell’epoca coloniale continua a strutturare lo spazio urbano e gli immaginari abitati dalle popolazioni post-coloniali. Se quindi oggi non è possibile sostenere gli «effetti positivi della presenza francese oltremare», non è tanto perché si rischierebbe in tal modo di dare libero corso a una «deriva comunitaria». Ma piuttosto perché ciò significherebbe prendere parte contro coloro che oggi sostengono la necessità di continuare una lotta alla persistenza di un razzismo assai spesso istituzionalizzato. 240 La Francia, le colonie, la Storia La vicenda di harki e pieds-noirs mette compiutamente in evidenza che le colonie hanno tracciato solchi che continuano a insistere sul presente del paese. Ma, nonostante il linguaggio da loro utilizzato, non sono certo i promotori della legge del 23 febbraio le vere «vittime» della vicenda. Sarebbe bene impedirsi di romanzare in maniera eccessiva la storia di harki e pieds-noirs, ricordando che, nello scacchiere algerino, essi stavano senza resti dalla parte sbagliata23. Sono quindi da prendere con cautela le rivendicazioni da loro avanzate. Sono altre le linee tracciate dal progetto coloniale che oggi differenziano l’inclusione nella cittadinanza repubblicana. Più che sulle «memorie» occorrerebbe allora soffermarsi sul doppio registro che formalmente include i giovani banlieusards nella comunità politica francese, ma di fatto li esclude dall’accesso a pressoché ogni opportunità. Si tratta di continuare ad abbattere le linee di confine tracciate dal progetto coloniale, linee che si servono del linguaggio del diritto come strumento per includere in maniera differenziale chi vive nello spazio europeo. Oggi migliaia di ex sujets incontrano barriere costruite alle frontiere di un’Europa che si dice universale ma non prevede per loro alcuno spazio. Oppure consente loro un accesso sotto condizione – se promettono di lavorare senza lamentarsi, se saranno bravi cittadini, se faranno uno sforzo di «integrazione – continuando in tal modo ad approfondire la frattura che corre, attraversandolo da parte a parte, nello spazio della cittadinanza24. A tali continui tentativi di costruire nuove frontiere, si oppone fortunatamente la mobilitazione dei diretti interessati. Nelle rivendicazioni degli esclusi/inclusi, come può essere in Francia nel caso dei sans-papiers, riconosciamo oggi il principale tentativo di tenere aperto il discorso sulla cittadinanza. Essi danno un nuovo senso ad universali altrimenti vuoti come quelli di libertà e uguaglianza, rivendicando il loro diritto di vivere dove hanno scelto di farlo. Perché l’intervento da parte degli «storici di professione» su una questione come quella delle colonie non rischi – come ha fatto negli ultimi due anni – di essere interpretato nei termini di una difesa corporativa è allora necessario fare uno sforzo di attualizzare il dibattito, provando a leggere nella filigrana del presente quelli che sono i lasciti della vicenda coloniale, gli elementi che ancora insistono sul presente e quelli che sono i tentativi di lasciarseli definitivamente alle spalle. Occorre abbandonare l’idea che per pensare il rapporto con il nostro passato sia necessario ridursi, per dirla con Nora, a fare le «cozze». L’odierno proliferare di memorie non è 241 Domenico Letterio un fenomeno da stigmatizzare: esso merita anzi di essere analizzato con la massima attenzione. Se la storia singolare è in crisi, non bisogna pensare di essere di fronte ad una sciagura: occorre piuttosto disporsi ad analizzare le nuove configurazioni di potere di cui essa è espressione. Note al testo 1 Ma a dire il vero le origini della polemica sono di molto precedenti: cfr. ad es. Claude Liauzu, Une loi contre l’histoire, in «Le Monde Diplomatique», aprile 2005 e Gilbert Meynier, Le piège de mémoires antagonistes, in «Le Monde», 12 maggio 2005. 2 «I programmi scolastici riconoscano […] il ruolo positivo della presenza francese oltremare, segnatamente in Africa del Nord, e accordino alla storia e ai sacrifici dei combattenti dell’esercito francese originari di questi territori la posizione eminente alla quale essi hanno diritto». 3 Per una prima analisi di tale categoria, originariamente proposta da W.E.B. Du Bois, si faccia riferimento ad Alessandro Portelli, La linea del colore. Saggi sulla cultura afroamericana, Manifestolibri, Roma 1994. 4 Daniel Lefeuvre, Les pieds-noirs, in Mohammed Harbi e Benjamin Stora, La guerre d’Algérie, Robert Laffont, Paris 2004, p. 390. 5 Ivi, p. 408. 6 Cfr. Mohand Hamoumou e Abderahmen Moumen, L’histoire des harkis et Français musulmans: la fin d’un tabou?, in Mohammed Harbi e Benjamin Stora, La guerre d’Algérie cit., p. 459. 7 Ivi, p. 477. 8 Benjamin Stora, La gangrène et l’oubli. La mémoire de la guerre d’Algérie, La Découverte, Paris 1998, p. 22. 9 Tale categoria, oramai classica, è stata per la prima volta proposta da Edward W. Said, Cultura e imperialismo. Letteratura e consenso nel progetto coloniale dell’Occidente, Gamberetti, Roma 1998. 10 Mohand Hamoumou e Abderahmen Moumen, L’histoire des harkis et Français musulmans cit., p. 484. 11 In questo senso, cfr. ad es. Claude Liauzu, Les historiens saisis par les guerres de mémoires coloniales, in «Revue d’histoire moderne et contemporaine», 52(4)bis, 2005. Su tale questione, un particolare rilievo hanno assunto due appelli: cfr. in particolare Des historiens contre la loi du 23 février 2005 sur «le role positif de la présence française outre-mer», che vede tra i suoi primi firmatari Claude Liauzu, Gilbert Meynier, Gérard Noiriel, Frédéric Régent, Trinh Van Thao e Lucette Valensi e l’appello degli storici guidati da Pierre Nora e riuniti nell’associazione Liberté pour l’histoire!, pubblicato su «Libération» del 13 dicembre 2005. 242 La Francia, le colonie, la Storia 12 Un timido tentativo di correggere tale posizione si trova in Henri Leclerc, Quatre lois de nature très différente, in Claude Liauzu e Gilles Manceron, La colonisation, la loi et l’histoire, Editions Syllepse, Paris 2006. 13 Pierre Nora, La France est malade de sa mémoire, intervista a cura di Jacques Buob e Alain Frachon, «Le Monde 2», n. 105, 18 febbraio 2006, p. 26. 14 Pierre Nora, La France est malade de sa mémoire cit., p. 25. 15 Cfr. Reinhart Koselleck, Futuro passato. Per una semantica dei tempi storici, Marietti, Genova 1986. 16 Pierre Nora, La France est malade de sa mémoire cit., p. 27. 17 Cfr. Abdelmalek Sayad, Algeria: nazionalismo senza nazione, Mesogea, Messina 2003. 18 Cfr. Reinhart Koselleck, Futuro passato cit. 19 La fracture colonial. La société française au prisme de l’héritage colonial, a cura di Pascal Blanchard, Nicolas Bancel e Sandrine Lemaire, La Découverte, Paris 2005. Altri volumi recenti hanno cercato di installare al centro dei dibattiti politici e culturali francesi la tematica coloniale, sia pur non parlando esplicitamente di una «frattura». Si faccia ad es. riferimento a L’esclavage, la colonisation, et après…, a cura di Patrick Weil e Stéphane Dufoix, Presses Universitaires de France, Paris 2005 e Olivier Le Cour Grandmaison, Coloniser exterminer. Sur la guerre et l’Etat colonial, Fayard, Paris 2005. 20 La pertinenza di tale concetto è messa criticamente in dubbio, ad es., nell’appello di Daniel Hémery, Claude Liauzu, Gilbert Meynier e Pierre Vidal-Naquet, Où va la République?, in «Libération», 16 novembre 2005. 21 Cfr. in questo senso Yann Moulier Boutang, La Révolte des banlieues ou les habits nus de la République, Éditions Amsterdam, Paris 2005 e Id., Les vieux habits neufs de la République. En défense d’émeutiers prétendument «insignifiants», in «Multitudes», 23(2006). 22 È in questo senso che va la riflessione di Slavoj Žižek sul «multiculturalismo». Cfr. ad es. Slavoj Žižek, Il soggetto scabroso. Trattato di ontologia politica, Cortina, Milano 2003, in part. pp. 271-9. 23 Come ha ricordato giustamente Gilbert Meynier. Cfr. Gilbert Meynier, «Les harkîs n’ont été ni plus ni moins que des mercenaires», intervista di Nadjia Bouzeghrane,«El Watan», 10 marzo 2005. 24 Per una introduzione alla tematica dell’immigrazione in Francia si veda Patrick Weil, La République et sa diversité. Immigration, intégration, discriminations, Seuil, Paris 2005. Si tratta di un lavoro che, nonostante le intenzioni spesso diametralmente opposte, tende a riprodurre una fede repubblicana non dissimile da quella che si è vista in Pierre Nora. 243 storia e mass media Le fonti cinematografiche nello studio del Novecento. Analisi della filmografia sul Vietnam di Ottavio D’Addea Introduzione Lo studio storico si è contraddistinto sin dall’antichità come studio di un fatto o di un evento in conseguenza di un riscontro autoptico, fare oggi storia significa invece analizzare dei documenti che testimoniano dell’epoca studiata: la ricerca storica è descrivere il passato attraverso le fonti. Non esiste una sola storiografia, semmai si potrebbe parlare di storiografie: esistono vari modi e approcci per accostarsi a temi e problemi. Dopo la lezione delle «Annales» tutto è fonte storica, tutte le manifestazioni culturali e materiali dell’uomo divengono fonte di studio storico. L’uso dei film nell’insegnamento della storia Anche ciò che si trova nei manuali è frutto della più avanzata discussione accademica su un problema, la scuola però non accoglie al meglio ciò che viene suggerito dalla manualistica più aggiornata perchè i docenti spesso non accolgono alcune suggestioni della «nuova storia». Bisogna invece riflettere sui nuovi mezzi e sul loro agire nella cultura aprendosi alla tecnologia e al Novecento. Gli ultimi venti anni hanno visto aprirsi un gap fra bambini multimedializzati e adulti. Rivolgendosi ad essi sarebbe opportuno mettere in rapporto macchina, contenuto e stile di apprendimento. Il paradigma enciclopedico non può godere della stessa autorevolezza che lo ha caratterizzato per tre secoli passati; oggi non si può prescindere dalla cultura multimediale che predilige l’incontro, la mediazione, l’integrazione e la contaminazione; questi ultimi termini ci portano al concetto di didattica trasversale1. Una nuova cultura è il frutto di una nuova società, didatticamente parlando oggi si può parlare di studenti come utenti dei media; tra utente e 245 Ottavio D’Addea macchina si inserisce il luogo dell’interfaccia, cioè la scuola come luogo di mediazione, saranno necessarie delle competenze tecniche per far funzionare questa macchina che necessita non solo di competenze enciclopediche ma anche esperienziali2. Se l’utente3 viene considerato alla stregua di una macchina si pone il problema del rapporto tra utente-macchina e sapere, questo rapporto può essere mono-dimensionale, il che produce una ricettività indifferenziata, può essere bidimensionale, un rapporto cioè tra l’utente e il mezzo o ancora tridimensionale; il criterio di interattività tridimensionale ci riconduce a Topolsky e al suo rapporto tridimensionale con le fonti4. L’adozione del supporto filmico quale strumento didattico comporta comunque alcune ripercussioni sul piano della fruizione. L’uso dei film e della propria videoteca trasforma il film (da mass media in personal media o ancora in group media), questo significa che viene snaturato lo statuto in base il quale il cinema è un prodotto pubblico che va consumato in un luogo pubblico. A differenza dei romanzi che possono essere fruiti nel privato, il film, per essere analizzato, necessita un paziente lavoro alla moviola ed è per questo destinato a una fruizione singola o della classe. Dopo la visione del film sarà necessario redigere una scheda di lettura del film per avere delle coordinate essenziali. L’insegnamento attraverso i media e più in particolare sul cinema potrà essere articolato in vari modi5: -insegnamento con i media -insegnamento sui media6 -insegnamento dentro i media Nella prima scelta pedagogica i film costituiscono dei sussidi utilizzabili in vario modo, il secondo approccio vede al centro del lavoro didattico il film in quanto oggetto di studio, ma finora è stato poco usato nella scuola italiana anche per un certo grado di incompetenza del corpo docente che non ha né una preparazione adeguata, cinematogaficamene parlando, né sa analizzare i prodotti della settima arte. È auspicabile che la scuola si occupi sempre più di insegnare a decifrare e a leggere dal punto di vista denotativo i film, questa abilità potrebbe divenire trasversale e utilizzabile in più discipline vista l’estrema ricchezza del cinema e il suo tendere ad abbracciare più campi. Il terzo approccio è quello più proficuo didatticamente par246 Le fonti cinematografiche nello studio del Novecento. lando, è basato su una modulazione della didattica all’interno dei media e vede il loro uso quali supporti di esercizio. Questo uso è particolarmente proficuo per insegnare l’analisi dei documenti ma può essere usato anche in altri ambiti. Le parole e le immagini e la ricerca storica I registi usano supporti comuni agli storici: gli spettatori si aspettano di vedere rappresentazioni di fatti raccontati in maniera veridica, per questo i registi devono dare garanzie di serietà.. Il cinema ha storicamente rappresentato le masse7, ha generato la comparsa che raffigura il paesaggio umano nel quale si svolge l’azione, la sua nascita è coincisa con una nuova idea di promozione del prodotto artistico. L’audiovisivo ha completato l’immagine storiografica della mentalità dando un’immagine storica degli eventi8, la sua presenza, a differenza degli anni settanta è costante nelle case facendo sì che Tv e cinema agiscano potentemente nella nostra visione del passato e del presente.. Il documento non deve essere più portato al pubblico, deve essere «trattato storicamente». Il film serve allo storico a comprendere e spiegare come gli individui e i gruppi comprendono la loro epoca. Si capovolge lo statuto dello storico: non si scoprono più fonti sconosciute ai più, si usa ciò che è già noto alla massa. Lo storico produce testi scritti a partire da immagini tenendo presente che tutto quello che si vede è frutto di una scelta soggettiva. La tradizione storica può essere vista come la difesa di un gruppo che opera con lo scopo di difendere qualche aspetto del presente, la storiografia in questo caso funge da strumento principe per accostarsi ai problemi delle società: descrivendo un oggetto dall’esterno comprendiamo come una società ha descritto se stessa9. Il successo di un film non è un indice assoluto10 per caratterizzare la descrizione, esso è indice di quanto sia stato pubblicizzato e di quanto abbia influito la post-produzione. Si possono distinguere quattro criteri nell’analisi preventiva del film: originalità, il suo rapporto con eventi correnti, il fatto di essere stato accolto favorevolmente dal pubblico e di essere stato prodotto in un periodo di crisi. Il film è un fatto espresso, per questa ragione coinvolge la psicologia della percezione, dell’intellezione, comprendendo anche i campi dell’este247 Ottavio D’Addea tica e della sociologia. Il cinema è un fatto antropologico, il fatto filmico non è qualcosa di scontato, merita uno studio delle strutture portanti. Quando lo spettatore vede un film ha un’impressione di realtà, ha l’impressione di assistere a uno spettacolo quasi reale, perché quello che vede ha un tono assertivo, il movimento ha con sé un indizio di realtà e di corporeità11, ci dà l’impressione della realtà. Il film storico Il film per essere storico deve avere al suo interno dei dati del patrimonio storico di una comunità: date, eventi ecc., sia per i cineasta che per il pubblico esiste qualcosa di ben sicuro e di inattaccabile storicamente. Il film storico è una dissertazione della storia che non interroga il suo soggetto, differendo in ciò dal lavoro dello storico, esso stabilisce dei rapporti con i fatti e ne offre una visione: la comprensione dei meccanismi storici è un campo di indagine. Tutti i film storici sono film di fiction dove interagiscono storia e storia personale. Il modo in cui un film viene tagliato per gli usi nazionali può sembrare irrilevante ma l’assenza di qualcosa è loquace come il silenzio. Il testo filmico deve essere analizzato per vedere il trattamento delle tematiche storiche, la presenza di scene storiche e come sono montate, come sono rapportate (il loro grado di esattezza storica)12. L’ultimo aspetto è l’analisi del tempo del film secondo delle scale prestabilite. Queste scale sono costruite mettendo in relazione tempo storico e tempo narrativo: bisogna operare una distinzione tra tempo della cosa raccontata e il tempo del racconto, perché il racconto «fonde un tempo in un altro tempo», a differenza della descrizione che fonde uno spazio in un tempo, e dell’immagine che fonde «uno spazio in un altro spazio»13: 1. tempo reale 2. tempo abbreviato 3. durata indeterminata 4. frattura 5. tempo di montaggio La guerra può costituire un ottimo spunto di ricerca per analizzare il nostro rapporto rispetto alla fonte cinematografica. La rappresentazione 248 Le fonti cinematografiche nello studio del Novecento. cinematografica della guerra ha consentito una partecipazione delle masse alla stessa, il mezzo audiovisivo ha introdotto un’emotivizzazione dei fatti14. L’attualità nella quale ci troviamo è differente da quella di chi ha fruito del cinema come luogo di produzione di mentalità: il cinema è mutato con la sua trasposizione nello schermo. Il nuovo punto critico non è costituito più dall’indipendenza del regista ma dal problema del controllo dell’audiovisivo, il cinema diviene uno strumento di potere. Un’analisi del fenomeno cinematografico sul Vietnam Greetings TheGreenBerets Big Wednesday Coming Home The Deer Hunter ApocalypseNow Ciao America BrianDePalma 1968 United Artists EagleFilmCorporation RayKellogg,John 1968 Berretti verdi / TriStar / Vision P.D.G. Wayne A-Team Productions / Un mercoledì da John Milius 1978 Warner Brothers leoni Columbia Pictures / Tornando a casa Hal Ashby 1978 Tri-Star Ixtlan Corporation / Il cacciatore MichaelCimino 1978 Universal Francis Ford 1979 Columbia Pictures Apocalipsenowredux Coppola RamboFirstBlood Rambo I Ted Kotcheff 1982 United Artists Streamers RobertAltman 1983 HBO / Taurus Films Streamers UncommonValor Fratelli nella notte Ted Kotcheff 1983 AmblinEntertainment/ Warner Brothers Birdy Birdy le ali della libertà Alan Parker Fandango Fandango KevinReynolds 1985 Warner Brothers 1984 Paramount HeartbreakRidge Gunny Buena Vista / Rollins, Morra,BreznerProductions ClintEastwood 1986 /SilverScreenPartnersIII/ Touchstone Pictures Platoon Oliver Stone 1986 SigmaIII/WestEndFilms Platoon Paramount / RKO Radio Pictures JayWestonProductions/ DearAmerica:Letters DearAmerica:Letters Bill Couturie 1987 Malpaso/WarnerBrothers HomefromVietnam HomefromVietnam Rambo:TheRescue Rambo II 1986 Full Metal Jacket Full Metal Jacket StanleyKubrick 1987 Hemdale / Orion 249 Ottavio D’Addea Good Morning, Vietnam Good Morning, Vietnam Hamburger Hill Hamburger Hill Bat 21 Bat 21 BornontheFourth Nato il 4 luglio of July BarryLevinson 1987 International Family Home Entertainment EMI Film Productions / Peter Markle 1988 Universal Batjac Productions / Oliver Stone 1989 Seven Arts / Warner Brothers John Irvin 1987 Haft Entertainment / CasualtiesofWar Vittime di guerra BrianDePalma 1989 NewRegencyPictures/ Regency Enterprises HeavenandEarth Tra cielo e terra Oliver Stone 1993 Forrest Gump Forrest Gump RobertZemeckis 1994 Paramount Tigerland Tigerland JoelSchumacher 2000 WeWereSoldiers We were soldiers RandallWallace 2002 Icon Productions / The Wheelhouse La tabella spiega visivamente l’evolversi della reazione di Hollywood nei confronti della guerra del Vietnam15. La guerra inizia già negli anni sessanta, i primi film appaiono nel 1968 e sono testimoni di due modi di intendere l’America: un modo satirico e un modo eroico, questi sono gli approcci di De Palma e di John Wayne. Hollywood sembra restia a prendere una posizione chiara sulla guerra in corso16. Questo non impedisce ai cineasti di accostarsi tramite il genere Western in maniera obliqua rispetto al Vietnam. In questi anni usciranno film come Piccolo grande uomo (1970) di Arthur Penn e Soldato blu di Ralph Nelson. Si inizia a prendere coscienza del problema dei reduci, vengono prodotti i primi B-movies, film di registi indipendenti girati a bassi costi. Questi film precedono la produzione degli anni settanta e poi accompagneranno questo genere coniugando temi nuovi e luoghi conosciuti, soprattutto per le serie televisive, portando ad allargamenti successivi come ad esempio il tema della self-justice17, dei veterani che tornano in città con la loro esperienza pronti per combattere nella jungla d’asfalto18. Nei B-movies troviamo le prime citazioni del Vietnam. Questa produzione assieme ai film sul movimento pacifista ha colmato il vuoto causato dalla mancata presa di posizione di Hollywood19. Gli anni settanta hanno rappresentato una data simbolica per l’entrata in scena sul tema del Vietnam di due grandi registi come Cimino e Cop250 Le fonti cinematografiche nello studio del Novecento. pola assieme a Milius e Asby. Ogni regista ambienta il suo film in modo diverso, i lavori di Cimino e Coppola sono fondamentali, oltre che per il loro accostamento a opere letterarie (in particolare Coppola che ambienta il suo film rifacendosi a Cuore di tenebra di Conrad) e per i loro progetti: sulla scorta del successo de Il padrino Coppola riesce a realizzare un film senza l’appoggio dell’esercito americano, primo caso dalla seconda guerra mondiale20. Gli anni settanta vedono due grandi film entrambi ambientati sul tema dei reduci: Tornando a casa e Un mercoledì da Leoni. La produzione degli anni settanta contiene già tutti gli elementi tipici del Vietnam Movie e, anche se risente del clima culturale di quegli anni, denuncia i problemi del Vietnam e descrive le coordinate esistenziali della guerra. Sono già presenti i temi della guerra americana e della guerriglia21 vietnamita (cioè due modi di accostarsi alla guerra), della pazzia generale e degli aspetti della nuova società americana che si ripercuotono in Vietnam. Nei primi anni settanta è già delineato il problema dei reduci, dei loro problemi di reinserimento e dei loro problemi psichici22. Gli anni ottanta segnano cinematograficamente un’epoca matura per il Vietmovie, Hollywood si rende conto che dopo la scottatura del maccartismo sulle questioni politiche è possibile prendere una posizione in merito. Tutta la produzione è in polemica con la guerra, nessun film risulta essere banale anche se ripropone storie di guerre rivissute. La produzione raggiunge livelli altissimi di polemica come nel caso Streamer. Ma anche film come Rambo I vogliono essere di denuncia. Una parte della produzione di questi anni costituisce un tentativo di una rimozione della guerra del Vietnam, specie per quello che riguarda il problema dell’essere reduci. Tutti i film, da Forrest Gump a Rambo, esprimono in maniere differenti il disagio cui andarono incontri i reduci23. Al loro ritorno in patria i reduci possono avere difficoltà di accettazione sociale per il fatto di essere storpi - questo motivo è ben presente nella produzione di Stone - oppure non avere lavoro e non essere assunti perché reduci (Rambo e Forrest Gump). Non vi sono due posizioni sulla guerra, vi sono semmai due posizioni nei confronti dei militari, alcune serie televisive come A-team rispecchiano questa posizione. I militari coinvolti nella guerra manifestano esteriormente un disagio interiore per il fatto di essere andati a combattere, disagio che si acuisce perché essendo stati plagiati non vengono accolti dall’America che ora è in rivolta. Gli anni novanta e il nuovo secolo vedono pochi film che sono però 251 Ottavio D’Addea di spessore. Oliver Stone completa la sua trilogia girando Tra terra e cielo, documento avvincente, unico caso di film sul Vietnam che ha per protagonista una donna24, Forrest Gump è una descrizione diacronica della vita americana dal dopoguerra fino agli anni ottanta. Tigerland è un film che esprime il dissenso interno al mondo militare, Gardens of Stone è un film incentrato sul tema della morte. Per concludere citiamo We Were Soldiers, film non filo-militare ma militarista, carico di sentimenti e di alcune importanti citazioni riguardanti gli inizi della guerra del Vietnam, anche se non eccellente dal punto di vista artistico. Il Vietmovie La guerra del Vietnam non è stata una guerra normale, si è trasformata in una guerra civile interna all’America, è stata quindi una guerra a lento spegnimento, le sue ferite sono visibili ancora oggi. Il film di guerra ha come oggetto la guerra, l’America e il suo background, per background possiamo osservare la truppa, il territorio e la nazione, questi luoghi tendono a dare una rappresentazione dell’America. Relativamente alla struttura dei film si può effettuare una tripartizione: addestramento, guerra e ritorno in patria. Ognuno di questi momenti può ricoprire una parte preponderante all’interno del film o ancora può costituire tutto il film, si potrà parlare di film tripartiti, monopartiti e bipartiti. Il classico Vietmovie è un film narrativamente tripartito, questa organizzazione serve normalmente a dar ragione dell’evoluzione del pensiero del protagonista per arrivare a delle conclusioni negative sulla guerra. I film sul Vietnam non partono generalmente da una scrittura originale, sono la trasposizione cinematografica di memorie scritte da veterani, queste memorie sono normalmente tripartite. Il protagonista parte da un ambito culturale e sociale che normalmente accetta la guerra, comprende in combattimento cosa sia la guerra, tornando a casa cerca di spiegare agli altri il suo vissuto. Essere dei veterani non è mai un’esperienza neutra: il reduce è colui che tornando scopre il gap che lo separa dall’America. Questo gap può essere spiegato con molte ragioni. La più usuale è sicuramente l’evoluzione sociale americana e la fissità di chi è stato in guerra, o viceversa. I registi tendono a rappresentare un’America che, osservando i propri figli in combattimento, avendo dei forti dissidi interni e vedendo delle bare o degli storpi che tornano a casa, si rende conto dell’errore che 252 Le fonti cinematografiche nello studio del Novecento. ha rappresentato questa guerra. Un fattore fondamentale per classificare la struttura di un film è il luogo i cui si svolge, si possono fare più suddivisioni, ma se non si resta ancorati al fattore spaziale si rischia di perdere aderenza rispetto al testo da analizzare. L’unica sotto-classificazione possibile può essere quella psicologico-mentale: lo spazio può essere rappresentato a livello mentale durante stati allucinatori nel richiamare alla memoria un fatto o un sogno. Full Metal Jacket Kubrick rintraccia la fonte su cui costruire il suo film da un diario di guerra scritto da Gustav Hashford che si intitola The Short-Timers contraddistinto per la forte presenza onirica25, opera una trasposizione metaforica nell’ambientazione del suo film: la guerra del Vietnam si è distinta per essersi svolta nella jungla, Kubrick sceglie di trasformarla in guerriglia urbana. In tutto il film vi sono solo due scene nelle quali è presente l’elemento arboreo, l’una nel campo di addestramento, l’altra in un trasferimento in elicottero. Kubrick sceglie un genere che già è classico, pienamente accettato dal pubblico ma sceglie di eliminare l’elemento che di solito lo caratterizza, la jungla che diviene jungla di palazzi. L’arte di Kubrick è stata da sempre contraddistinta per una ricerca parossistica di perfezione tecnica, Kubrick si è sempre tenuto aggiornato tramite contatti continui con i colleghi sulle novità tecniche, sugli effetti speciali, sulla fotografia dei film e sugli attori. Se da un lato vuole fare un film con il progetto deliberato di smontare e ritrasformare la struttura narrativa del Vietnam war movie, dall’altro è preoccupato per la scelta degli attori e per non incorrere in questo problema sceglie attori di secondo piano al tempo: Matthew Modine e Vincent D’Onofrio. Kubrick sceglie di organizzare strutturalmente il film in due parti: l’addestramento e il fronte. Ogni parte può essere suddivisa a sua volta internamente, ciò che caratterizza fortemente ogni parte è l’incipit e l’explicit. Tutta la sua produzione può essere letta alla luce di due figure: la scacchiera e il labirinto che qui contraddistinguono la prima e la seconda parte. Il titolo Full Metal Jacket. Di primo acchito questo titolo potrebbe sembrare 253 Ottavio D’Addea straniante, questa scelta è tutt’altro che ingenua. Kubrick sta presentando un film sul Vietnam che parla della vita dei militari, dare questo titolo significa identificare il mondo militare con delle caratteristiche che gli sono proprie. Come la pallottola blindata è caratteristica degli usi militari, ha degli effetti deleteri per la sua incamiciatura, così l’azione di un marine o del corpo dei marines è blindata (apparentemente) e può avere degli effetti devastanti. Kubrick parla di un mondo chiuso come chiusa è la pallottola, un mondo che indaga con la sua telecamera, un mondo fatto di uomini dalla «volontà pura» che non temono di uccidere. Questo titolo risulta chiaro allo spettatore solo alla fine del film così come risulta chiaro l’intento dissacratorio del titolo all’interno film. In senso stretto il titolo è una citazione desunta dal film, il soldato Palla di lardo parla delle cartucce «blindatissime» che ha portato nei bagni per adempiere al suo piano. Tutto il discorso di Palla di lardo è un discorso conchiuso, blindato, è la ripetizione di cadenze e moduli che sono iscritti nella sua mente, questa liturgia militare però lo porta a uccidere il suo istruttore e poi se stesso. La figura protagonista della prima parte: il sergente Hartmann La prima scena è ambientata nel locale dove lavora il barbiere militare, Kubrick sceglie sicuramente di iniziare il suo film così per dare un valore simbolico al servizio di leva e per descrivere cosa comporti la chiamata coatta alle armi. Le diciassette teste che vengono rasate, sicuramente non solo per motivi igienico sanitari, vengono rasate tutte alla stessa altezza, questo ci parla di omologazione. La rasatura rappresenta un rito di passaggio da leggere antropologicamente. A riprova della lettura simbolica di questo atto di passaggio sta il fatto che la macchina da presa inquadra l’esito del lavoro del barbiere: un insieme raccapricciante di ciocche di capelli Evidenti sono i forti richiami storici al passato europeo. La costruzione tecnica di questa scena è molto eloquente. Il film inizia con la proiezione del logo della casa produttrice, contemporaneamente inizia una musica off: il suono straniante di una chitarra country, inizia la canzone e compare la scritta col nome del regista: chiaramente quello che l’artista ci vuole comunicare è la sua lettura del Vietnam. Inizia il processo di rasatura, comprendiamo che il Vietnam qui non è una scelta volontaria perchè nessuno parla col barbiere, tutti i militari, chi più chi meno, ma tutti in maniera diversa guardano smarriti nel nulla. Già 254 Le fonti cinematografiche nello studio del Novecento. La rasatura del marine. nello sguardo di alcuni di loro sarebbe possibile trovare gli elementi di una caratterizzazione del personaggio. Kubrick pone particolare enfasi nei volti dei militari, questa attenzione è una caratteristica della sua arte. In tutto il film e nelle sequenze che analizzeremo i volti rappresentano una risorsa descrittiva. Il volto di Hartmann viene analizzato costantemente con primissimi piani (e in particolare negli occhi), anche i volti degli altri militari sono oggetto di attenzione da parte del regista. In questo film Kubrick analizza l’alienazione, la pazzia proiettando una luce forte sui volti. Lo si vede dai riflessi sulla pelle, come aveva fatto in Arancia meccanica, la pazzia viene caratterizzata tramite continui campi/controcampi. Mentre i militari sono rasati due voci off cantano la canzone Hello Vietnam: Kiss me goodbye and write me while I’m gone. Goodbye my sweetheart... hello Vietnam. America has heard the bugle call and you know it involves us one and all. I don’t suppose that war will ever end 255 Ottavio D’Addea there’s fighting that will break us up again. Goodbye my darling... hello Vietnam. I’m here to take a battle to be won. Kiss me goodbye and write me while I’m gone. Goodbye my sweetheart... hello Vietnam. A ship is waiting for us at the dock. America has trouble to be stopped. We must stop communism in that land or freedom will start slipping through our hand. (spoken) I hope and pray someday the world will learn that fires we don’t put out will bigger burn. We must save freedom now at any cost or someday our own freedom will be lost. Kiss me goodbye and write me while I’m gone. Goodbye my sweetheart... hello Vietnam26. Rituali apotropaici nel corpo dei marine. 256 Le fonti cinematografiche nello studio del Novecento. L’inserzione di questa canzone, le cui parole e la cui musica sono state scritte da Tom T. Hall nel 1965, è interessante da due punti di vista differenti: primo, il regista sceglie di ambientare il film non molto tempo prima dell’offensiva del Tet (1968) ma inserisce una canzone che profeticamente parla dell’arrivederci triste, quindi di un addio che l’America fa ai suoi boys, secondo, la canzone testimonia alcuni aspetti tipici dell’indottrinamento anticomunista che proviene dal non lontano maccartismo e delle difficoltà dell’America già nel 1965. Tra la fine della prima sequenza e l’inizio della seconda, non vi sono effetti di passaggio, potremmo dare una lettura al montaggio simbolico e vederlo come la spersonalizzazione che continua una volta che si è sotto le armi. Il resto della sequenza si svolge nella camerata ed ha per protagonista il sergente Hartmann che spiega le regole da seguire e inizia a conoscere la truppa. Riportiamo il testo integrale italiano del suo discorso: Io sono il sergente maggiore Hartmann, vostro capo istruttore. Da questo momento potrete parlare soltanto quando vi sarà richiesto e la prima e l’ultima parola che dovrà uscire dalle vostre fogne sarà «signore». Tutto chiaro, luridissimi vermi? Macchè, cazzo, non vi sento rispondete come se lo aveste davvero. Se voi signorine finirete questo corso e se sopravviverete all’addestramento: sarete un’arma, sarete dispensatori di morte e pregherete per uccidere. Ma fino a quel giorno, siete uno sputo, la più bassa forma di vita che ci sia nel globo. Non siete neanche fottuti esseri umani: sarete solo pezzi informi di materia inorganica anfibia comunemente detta merda. Dato che sono un duro non mi aspetto di piacervi: ma più mi odierete più imparerete, io sono un duro pero sono giusto qui non si fanno distinzioni razziali: qui si rispetta gentaglia come: negri, ebrei, italiani o messicani. Qui vige l’eguaglianza e non conta un cazzo nessuno. I miei ordini sono quelli di scremare tutti quelli che non hanno le palle per servire nel mio beneamato corpo. Capito bene, luridissimi vermi? ma che cazzo, non vi ho sentito. come ti chiami, faccia di merda? […] Palle d’ora in poi tu sei il soldato Biancaneve, ti piace questo nome? 257 Ottavio D’Addea Beh c’è una cosa che non ti piacerà qui non si serve il piatto negro nazionale, né pollo fritto, né cocomero alla mia mensa […] Chi ha parlato, chi cazzo ha parlato? chi è quel lurido, stronzo comunista, brutta checca, pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte?… ah, non è nessuno, […] Vi ammazzo a forza di ginnastica, vi faccio venire i muscoli al buco del culo, che ci potrete succhiare il latte senza cannuccia […] Soldato Joker, perché sei qui nel mio beneamato corpo? allora tu sei un Killer, fammi una faccia da guerra […] Questa scena ci parla dell’America o delle Americhe degli anni sessanta. Analizziamo il discorso di Hartmann. Linguisticamente parlando viene scandito frase per frase. Kubrick coniuga la parola con il passeggiare di Hartmann. Aldilà dell’egotismo del sergente maggiore, non dimentichiamo che il Vietnam è la guerra dei plotoni guidati da tenenti inesperti ma sorretti da sergenti. Hartmann si pone come colui che può accogliere quelle che lui non considera neanche forme di vita. Il centro del tutto non è la guerra - che è solo un fattore temporaneo - il centro è far parte del corpo dei marines. I marines sono secondo le sue parole dei «dispensatori di morte», più tardi Hartmann arriverà ad essere blasfemo ma a dire che «Dio fa il suo mestiere e loro per ringraziarlo gli mandano sempre un numero fresco di anime in cielo». L’America che Hartmann fotografa nel suo discorso è un America divisa per razze da discriminare: negri, ebrei, italiani e messicani. Nel suo corpo non vi sono distinzioni, tutti sono uguali e nessuno conta niente. Difatti la sua prima vittima è un nero cui cambia il nome, il primo elemento di identità, e di cui critica la cultura culinaria. Il cibo dopo l’identificazione e accanto alla sessualità è l’elemento che mantiene la vita e identifica una cultura. La seconda persona verso cui si dirige è comunque un texano. Il campo di addestramento si trova del resto a Parris Island, come dice Joker, nella Carolina del Sud, stato storicamente razzista. Questi sono gli anni che vedono la partecipazione in massa dei neri al conflitto del Vietnam, anche se quella del Vietnam è la guerra dei bianchi secondo le parole di un film di Oliver Stone27. In Full metal jacket tutti i problemi e i conflitti sono tra bianchi e vengono risolti fra bianchi. Palla di lardo è bianco così come Cowboy e Joker. Anche Animal Mother è bianco, egli rappresenta la quintessenza del razzismo americano nei confronti delle persone di colore. 258 Le fonti cinematografiche nello studio del Novecento. L’entrata nel corpo dei marines comporta anche la rottura di uno statuto antropologico fondamentale per l’America: il matriarcato. Andare in guerra significa distaccarsi dalle proprie madri, accettare che queste vengano costantemente insultate, comporta l’entrare nella cultura patriarcale. Nella quinta sequenza troviamo un curioso accostamento tra fucile e genitali. Hartmann guida i soldati in una marcia attorno alle colonne della camerata facendogli intonare una cadenza: «con lui ammazziam e con questo chiaviam». Già in una delle prime notti i soldati vengono obbligati a dormire con i fucili in branda, Hartmann gli comunica che non vedranno più donne ma l’unico «buco» che vedranno è quello del fucile. Prima di andare a letto i soldati recitano una preghiera nella quale si autoconvincono che il fucile non è nulla senza loro come loro non son nulla senza quello. Tutto il discorso di Hartmann nella camerata è infarcito di espressioni non semplicemente oscene, Hartmann sta preparando i suoi militari alla cultura dell’uccidere, alla cultura della morte. Il contrario della morte è la vita, quindi la sessualità deve essere vilipesa. Nella sua prolusione Hartmann comunica che l’ordine che ha ricevuto è di scremare tutti quelli che non hanno le caratteristiche per appartenere al suo «beneamato corpo». Poco dopo entrano sulla scena il soldato Joker e il soldato Palla di lardo. Il primo cita John Wayne facendo un richiamo al western (ma anche al film Berretti verdi), il secondo, forse per problemi fisici e di labilità mentale, ha uno sguardo epiforico. Siamo negli anni sessanta, in piena guerra fredda, due sono i nemici: i comunisti e coloro che non possono o non vogliono combatterli, come Joker e Palla di lardo. Quando Hartmann sente la voce di Joker che interrompe ironicamente la circolarità del suo passeggiare, apostrofa il nemico o il disturbatore col nome di comunista, poi inserisce con delle ripetizioni anaforiche degli altri appellativi. Kubrick caratterizza tutta questa sequenza secondo l’ordine della scacchiera. Il luogo è osservato dalla cinepresa come un luogo innaturale, lo si può notare dalla forte luce che si riflette nei volti dei militari. Hartmann dà sicuramente l’impressione di essere una figura alienata, per il registro linguistico e per i suoi atteggiamenti singolari. La sequenza si svolge circolarmente con Hartmann che passeggia, mentre cammina tiene le gambe innaturalmente flesse ed è rigido nei movimenti, un’altra spia della sua alienazione è il movimento continuo delle dita della mano sinistra, movimento che scandisce la sua prolusione. In tutta la prima parte del film vi è una impostazione lenta del tempo 259 Ottavio D’Addea che doppia quello dei dialoghi. Il tempo del racconto corrisponde a quello della storia. In pochi casi, segnatamente agli interventi della voce off di Joker, vi sono delle ellissi28. L’ambiente viene descritto dalla cinepresa come spoglio e funzionale. Nell’addestramento a Parris Island ci sono due momenti che riguardano Hartmann che meritano una riflessione. Il primo è nell’undicesima sequenza29 quando Hartmann tiene una lezione sugli omicidi politici. Hartman sottolinea l’importanza che può avere la volontà pura di uccidere, egli non parla di addestramento parla dell’essere marine quindi una macchina fatta per uccidere. In una delle ultime cadenze ritornano l’idea del dovere e la figura della madre. I militari cantano: una smarpina non la voglio perché solo il fucile porterò con me, e se in battaglia poi creperò dentro una bara io tornerò, alla mia mamma fatelo saper che io ho fatto sempre il mio dover. La prima parte di questo film costituisce una preparazione alla morte. La filmografia sul Vietnam può essere analizzata alla luce del tema dell’ostensione o della preparazione all’ostensione della morte. Kubrick rappresenta la visione religiosa americana del tempo raccontando la domenica nella quale si parteciperà al «varietà religioso» dove il reverendo del campo spiegherà come Dio si servirà di un pugno di marines per liberare il mondo dai comunisti. La religione viene asservita alla causa delle guerra ripetendo un rituale tristemente noto. Tutti devono credere alla vergine Maria anche quando puliscono le latrine, chi non lo fa è un comunista e ateo, a meno che non sia riabilitato dal suo coraggio ( cosa che contraddistingue i marines). Come abbiamo anticipato, riveste una funzione fondamentale per capire storicamente un film l’analisi dell’explicit. In questo caso si può osservare come la tattica di Hartmann di umiliare le persone sortisca l’effetto opposto così come ha sortito e sortisce effetti opposti l’umiliare un popolo con la guerra. Kubrick ci dà una rappresentazione del mondo militare fatta da un anti-militare. Egli rappresenta una confraternita che perpetua la memoria di ogni suo appartenente, per entrarvi è necessario annullare se stessi e la propria personalità. La confraternita però fallisce nel momento in cui le sue regole le si ritorcono contro. La visione di Kubrick è sicura260 Le fonti cinematografiche nello studio del Novecento. mente viziata dalle sue posizioni, nella seconda parte del film arriverà a far abbandonare un compagno a un plotone dei marines, cosa inconcepibile secondo le regole del corpo. La morte, il Vietnam e Topolino La seconda parte del film vede Joker impegnato in Vietnam. Anche qui analizziamo l’incipit. La prima immagine che vediamo è urbana. Kubrick ci offre uno spaccato di americanizzazione del Vietnam. Sappiamo che il Vietnam era stato colonia francese. Ora la presenza americana ha modificato il tessuto urbano. Nelle immagini che osserviamo nella ventottesima sequenza abbiamo dei militari che sono parte del paesaggio urbano. Nella città si ha uno sconvolgimento culturale. Il Vietnam è un immenso campo di guerra dove campeggiano già cartelloni americani che pubblicizzano birra30 e dove accanto a un bar è possibile trovare icone pseudo-cristiane. La sequenza, la diciassettesima, è un esempio di come l’informazione dal fronte all’America giocasse un ruolo fondamentale. L’ufficiale responsabile dello Star and Stripes istruisce i militari su come trasformare l’informazione per rendere popolare una guerra che non lo è. Dalle sue parole apprendiamo come sia possibile trasformare la realtà chiamando diversamente le cose. Le operazioni militari americane non si chiameranno più «snidare e distruggere», ma «cercare e ripulire». Il modo di trattare il Tet, il considerarlo solo una festività denota la disattenzione alla cultura vietnamita fatta di paziente lavoro: i vietnamiti si riorganizzarono e diedero un ultimo colpo agli americani: l’offensiva del Tet costituisce infatti il punto di non ritorno di questa guerra. Durante il loro spostameto in elicottero per recarsi a Dubay Joker e Rafterman hanno l’occasione di parlare con un militare addetto alla copertura balistica dell’elicottero. Questo si vanta dei vietnamiti e dei buoi abbattuti. Abbiamo qui l’espressione della pazzia causata dal rapporto con la morte. Ci si vanta di poter uccidere tutto, anche donne e bambini. Nella medesima sequenza osserviamo un’altra ostensione della morte: le fosse comuni. Stavolta sono i vietkong che fanno delle rappresaglie verso i connazionali che li tradiscono. Joker viene apostrofato da un colonnello che lo sgrida perché indossa un distintivo da pacifista e sull’elmetto ha scritto: Born to kill. Alla minaccia di esser spedito alla disciplinare, Joker imbastisce una discussione di psicanalisi e fa confondere l’ufficiale, che risponde: 261 Ottavio D’Addea Marines e fosse comuni di vietnamiti. L’esorcizzazione della morte. 262 Le fonti cinematografiche nello studio del Novecento. Tu da che parte stai, giovanotto? tieni per la tua patria? e allora uniformati al programma e in riga con gli altri e… avanti per la grande vittoria. Figliuolo, ai miei marines io non ho mai chiesto altro che ubbidire a me come alla [parola di Dio. Noi siamo qui per aiutare i vietnamiti perché dentro a ogni muso giallo c’è uno che sogna di diventare americano. È un mondo spietato figliuolo, bisogna tener duro fino a quando non passerà questa mania della pace. I toni di questo colonnello sono sicuramente paterni. Usa la parola «figliuolo». Questo ufficiale rappresenta bene l’indottrinamento che sicuramente ha caratterizzato anche gli alti ufficiali. I militari devono far fronte compatto contro la minaccia interna della pace. Poco dopo Joker ritrova il suo amico Cowboy e, schivata la rissa, lui e Raftermann sono chiamati dal gruppo perché c’è una festa. Un militare scopre la testa di un vietnamita e dice che è dedicata a lui che oggi fa il compleanno. La morte viene ritualizzata ed esorcizzata, i militari ascoltano musica mentre un corpo morto giace seduto e insepolto da vari giorni di fronte a loro. Nella ventiquattresima sequenza un gruppo di soldati davanti a due cadaveri discute della guerra e della morte. Animal Brother esprime un giudizio illuminante: Raftermann: «Almeno sono morti per la buona causa della libertà». Animal: «Tira la catena e sciacquati il cervello, tu credi che li ammazziamo per la libertà? questa è strage. Se devo rischiare la pelle per una parola, allora l’unica che mi va bene è: scopare». Gli altri militari danno interpretazioni differenti della morte dei compagni. Ogni interpretazione appartiene a un’America differente. Nelle ultime sequenze si ha la ricerca di un cecchino che ha decimato la squadra e ucciso Cowboy. Dopo la morte del cecchino per mano di Joker e Raftermann, anche questa volta vengono inquadrati circolarmente vari soldati: un ispano americano, il biondo e americano Rafterman e Animal Mother. Ognuno dà un’interpretazione della fine del cecchino quindi del Vietnam. Joker non può accettare di lasciarlo mentre questi lo prega di sparargli. Come durante il linciaggio a Palla di lardo o prima della morte di Hatmann inizia in sottofondo una musica che preannunzia un evento 263 Ottavio D’Addea tragico scandita dal ritmo del Blockwood. Joker è dilaniato dal dilemma che ha spiegato al colonnello: non sa se uccidere sia giusto. Come sempre Kubrick analizza le emozioni inquadrando in primo piano i protagonisti, la luce stavolta proviene dalle fiamme di oggetti che bruciano nel palazzo. Con un grande sforzo e un deformarsi del volto Joker spara e viene accettato dai compagni perché ora è «un duro come loro». Hartmann ha compiuto la sua missione, il killer è emerso. L’ultima sequenza è ambientata al di fuori dei palazzi, i militari si allontanano illuminati dai fuochi fuori dal palazzo. Mentre viene inquadrato Joker che marcia, sentiamo la sua voce off che dice: per oggi abbiamo scolpito abbastanza i nostri nomi nelle pagine della storia, ci mettiamo in marcia verso il fiume dei profumi per passarci la notte […] certo vivo in un mondo di merda, ma sono vivo e non ho più paura. Mentre si allontanano i soldati cantano l’inno del club di Topolino, Kubrick rappresenta così sarcasticamente l’adunanza della confraternita che si allontana nella notte. Conclusioni Kubrick rappresenta un’America separata, per nulla blindata, i figli di quest’America vivono il labirinto dentro se stessi, vivono un labirinto di razze e razzismi. Ognuno interpreta la guerra secondo il proprio grado e i propri valori, ma il Vietnam è pieno di due tipi di pazzi: i pazzi furiosi e i pazzi razionali, entrambi hanno un elemento in comune: l’essere americani. L’America degli anni sessanta è un paese nel quale non regna più il consenso interno ma vi è una lacerazione profonda a livello culturale, sociale, razziale e di genere. L’America ha due visioni del Vietnam: la visione televisiva e la visione delle bare. Già durante il conflitto che ha avuto una durata considerevole gli americani iniziano a vedere delle bare ambulanti: i veterani. Il funerale è già stato celebrato nei cortei di piazza, non viene accettato che dei morti continuino a camminare in giro. I veterani portano in America anche l’esperienza della droga che si coniuga col movimento di liberalizzazione degli anni sessanta, questo li renderà invisi alla parte conservatrice che li aveva voluti in guerra. Vi sono in America quindi più Americhe. Kubrick ha scelto di rappre264 Le fonti cinematografiche nello studio del Novecento. sentare dal di dentro il mondo militare dandone un’immagine contraddittoria. Full Metal Jacket si distingue per l’essere l’unico film che dà la rappresentazione degli effetti del Vietnam su alcuni giovani prima ancora che questi vi si recassero: Palla di lardo si uccide prima di partire. Note al testo 1 Roberto Maragliano, Manuale di didattica muiltimediale, Laterza, Bari 1994, pp. 71-75. 2 Ivi, pp. 81-85. 3 Ivi, p. 201. 4 La costruzione teorica di Topolsky tende a creare tanti metodi di studio delle fonti quante sono le fonti, questo modo di accedere alle fonti è perciò definito dinamico perché porta a una trasformazione del passato come coscienza umana. L’innovazione principale di questo approccio riguarda quindi la struttura informativa e il nuovo rapporto tra storico e fonti. Viene superata la distinzione tradizionale tra storico e fonti, il rapporto diviene tridimensionale: storico, fonti, rapporto reciproco fra loro. 5 R. Maragliano, Manuale di didattica muiltimediale cit., p. 180. 6 Il linguaggio cinematografico. L’educazione audiovisiva e cinematografica nella scuola, Casa et Plan, Firenze 2002. 7 Pierre Sorlin, L’immagine e l’evento. L’uso storico delle fonti audiovisive, Torino, Paravia, 1999, p. 24. 8 Ivi, p. 25. 9 Pierre Sorlin, The film in History. Restaging the Past, Basil Blackwell, Oxford 1980. Trad it, La storia nei film. Interpretazioni del passato, La Nuova Italia, Firenze 1980, p. 17. 10 G. De Luna, L’occhio e l’orecchio dello storico Le fonti audiovisive nella ricerca e nella didattica della storia, La Nuova Italia, Firenze 1993, p. 34. 11 Christian Metz, Semiologia del cinema. Saggi sulla significazione nel cinema, Garzanti, Milano 1972, pp 31-36. 12 P. Sorlin, The film in History cit. 13 C. Metz, Semiologia del cinema cit., pp. 48-49. 14 P. Sorlin, L’immagine e l’evento cit., p. 9. 15 Cristina Balzano, Cento anni di cinema civile.Dizionario cronologico tematico, Editori Riuniti, Roma 2002, pp.274-276. 16 Andrea Alone, Roy Menarini, Massimo Moretti, Il cinema di guerra americano, Le Mani, Genova 1999, p. 14. 17 Vietnam e ritorno. La »guerra sporca» nel cinema, nella letteratura e nel teatro, a cura di Stefano Ghislotti e Stefano RossoMarcos Y Marcos, , Milano 1996, pp. 73-85. 18 Le serie televisive poliziesche sono caratterizzate dalla presenza di ex combattenti, ufficiali e non; a titolo di esempio citiamo Hunter e TJ Hooker. 265 Ottavio D’Addea 19 A. Alone, R. Menarini, M. Moretti, Il cinema di guerra americano cit., p. 15. 20 Jean- Michel Valantin, Hollywood, le Pentagone et Washington. Le trois acteurs d’une strategie globale, Editions Autrement. Trad. ital. Hollywood il Pentagono e Washington. Il cinema e la sicurezza nazionale dalla seconda guerra mondiale ai nostri giorni, Fazi, Roma 2005, p. 36. 21 Ezio Cecchini, Storia della guerriglia. Dall’antichità all’era nucleare, Mursia, Milano 1990, pp. 297-305. 22 Il cinema con la sua sensibilità diagnostica un male prima delle istituzioni ufficiali. 23 Federico Romero, Gianpaolo Valdevit, Elisabetta Vezzosi, Gli Stati Uniti dal 1945 a oggi, Laterza, Bari, p.266. Questo film getta nuova luce sul conflitto del Vietnam vedendolo come guerra necessaria per tenere alte le commissioni governative sugli armamenti. Stone fa rientrare la guerra del Vietnam all’interno della ricerca di benessere del popolo americano, ricerca mascherata dalla missione di democratizzazione. Si conclude un cerchio di citazioni che parte dal discorso di Johnson in Greetings di De Palma per arrivare alle confessioni di un consigliere militare in Stone. 24 25 Roy Menarini - Claudio Bisoni, Stanley Kubrick. Full Metal Jacket, Lindau, Torino 2002, p 12. 26 http://www.archiviokubrick.it/film/fmj/audio/lyrics/hello-vietnam.html, 25 aprile 2006. 27 Platoon. 28 Maurizio Ambrosiani, Lucia Cardone, Lorenzo Cuccu, Introduzione al linguaggio del film, Carocci, Roma 2003, p 117. 29 R. Menarini – C. Bisoni, Stanley Kubrick cit., p. 26. 30 Nella sedicesima sequenza. 266 rassegna bibliografica Le schede Gilbert Meynier, L’Algérie des origines. De la préhistoire à l’avènement de l’islam, Editions «La découverte», Paris, 2007 Il libro di Gilbert Meynier pubblicato nel corso di quest’anno colma un vuoto lasciato dalla pubblicistica sulla storia dell’Africa del Nord. Ciò che lo storico francese pone al centro dell’attenzione è che gli abitanti dell’odierna Algeria sono gli eredi di una ricca storia millenaria che affondano sì le radici nel substrato libico-berbero, ma non si esauriscono in esso. Rifiutando «i semplicismi della storiografia coloniale ufficiale e gli eccessi eroicooscurantisti di quella algerina», nel volume viene dato spazio ad una documentata narrazione che non si vuole aggregare a nessun centro di potere o ideologia. Come più volte ribadito nel corso di interviste, l’obiettivo del professore emerito dell’Università Nancy II è infatti quello di riconsegnare gli algerini, ma anche i francesi, alla propria identità. Il testo segue sostanzialmente una linea cronologica, ma molti sono gli spunti che esulano dalla semplice esposizione del dato storico. Grande interesse Meynier riserva infatti a tutte le manifestazioni dell’arte, della letteratura e della cultura algerina, sia a livello privato che pubblico. Secondo lo studioso, la scoperta della eredità preislamica che ha caratterizzato la storia degli Stati che poi si sono costituiti sul territorio dell’attuale Algeria è stata finora troppo trascurata. E ciò, per lui, non significa, come abbiamo accennato sopra, disconoscere il forte tributo che gli algerini d’oggi devono alle loro origini berbere, ma allargare l’orizzonte e il campo di indagine.Dopo avere ricordato che gli scavi archeologici condotti hanno portato alla luce reperti che mostrano chiaramente la presenza di insediamenti dalle origini dell’umanità, Meynier procede nel suo studio abbracciando un campo di indagine molto diverso da quello a lui consueto, la storia contempo267 Le schede ranea, con una trattazione che va appunto dalla preistoria all’avvento dell’islam. Dopo i capitoli su preistoria e protostoria, il saggio mostra quanto la presenza cartaginese e poi romana siano state fondamentali per dare l’avvio ad una organizzazione politica ed economica delle terre nordafricane. Lo storico illustra infatti con chiarezza come i colonizzatori fenici ed in seguito i romani - che allora si avviavano a diventare i dominatori incontrastati del «mare nostrum» – abbiano favorito la nascita e l’estendersi di relazioni economiche, ma anche culturali, con il Medioriente prima ancora della venuta degli arabi. Dell’epoca classica della dominazione romana caratteri peculiari furono l’inquadramento militare e la forte attenzione riservata alla difesa del territorio. A ciò si associarono, dice lo studioso, anche le «normative proprie di una società che non esclude forti ingiustizie nella suddivisione della ricchezza». Della civiltà romano-africana viene anche sottolineata, nella seconda parte del libro, la grande importanza assunta dalla città con i suoi «luoghi di culto, i cimiteri, i mercati, i teatri, i giochi del circo e il senso dello scorrere della vita». Ma è la religione il punto focale dell’attenzione dello storico: una religione che Meynier dice essere l’unione di 268 elementi nazionali, culti popolari romani e ufficialità sacrale. La parte finale del libro parla infine delle origini e delle ragioni dell’espansione del cristianesimo nel Nord Africa ed esamina in particolare il fenomeno del diffondersi di alcune eresie, prima fra tutte quella donatista. Su questa si incentra l’attenzione dello storico francese in quanto proprio in essa alcuni studiosi hanno visto la manifestazione di un particolarismo africano, altri l’apice di violenti lotte interne alla società africana. In conclusione l’autore cerca di capire se nel passaggio dal cristianesimo all’islam ci sia stata frattura o slittamento: evidenziando che la conquista araba del Maghreb non fu affatto facile, fa notare però che paradossalmente, mentre in Siria e in Egitto restano tracce non trascurabili della religione cristiana, la vittoria dell’Islam nell’Africa del Nord sembra totale. E ciò, come ha rilevato lo studioso stesso in una propria esposizione editoriale, è forse dovuto al fatto che «l’arte di arrangiarsi ha insegnato spesso agli uomini a riverire chi poteva assicurare loro benessere». L’Algérie des origines. De la préhistoire à l’avènement de l’islam quindi, pur avendo una impostazione che si avvicina a quella manualistica, va bene al di là delle caratteristi- Le schede che di un manuale. Si rivela infatti un saggio che coniuga la fluidità espositiva e la grande fruibilità anche da parte di un pubblico di non addetti ai lavori, alla specificità di un’indagine storica condotta con lo scopo di ricostruire le trame non certo di «una fantomatica memoria comune» di algerini e francesi, ma di «una storia suscettibile di parlare agli uni e agli altri non disprezzando né valorizzando né gli uni né gli altri» (Matteo Vecchia). Silvia Chicchi e Roberto Macellari, Il Barone Viaggiante. Raimondo Franchetti e le esplorazioni nel Corno d’Africa, Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia e Musei Civici, 2007, pp. 139 («Documenti per la storia delle arti, dell’archeologia e delle scienze a Reggio Emilia», n. 9). sul viaggiatore/esploratore da parte di Domenico Quirico (Miti e luoghi comuni su esploratori e colonialisti italiani), Claudio Cerreti (La Società geografica italiana e l’esperienza coloniale in Africa), Christel Taillibert (La Spedizione Franchetti in Dancalia e la produzione cinematografica sull’Africa dai F.lli Lumière in poi), Francesco Surdich (La Dancalia esplorata da Ludovico Maria Nesbitt). Altre relazioni di Silvia Chicchi, Roberto Macellari, Gino Badini, Luciana Serra, hanno riguardato piuttosto la storia della famiglia Franchetti e delle sue relazioni con Reggio Emilia, nonché la vicenda delle raccolte etnografiche presenti nei Musei Civici. Raimondo Franchetti, il Barone viaggiante è poi il titolo del ben centrato contributo di Valeria Isacchini, peraltro già autrice de Il 10° parallelo. Vita di Raimondo Franchetti da Salgari alla guerra d’Africa (Aliberti, 2005), che ha anche presentato il documentario La Spedizione Franchetti in Dancalia di Ettore della Giovanna Gi esploratori del passato non devono essere (comunque) dimenticati: è questo l’invito, neanche troppo velato, che i curatori del volume rivolgono ai lettori: un volume in bella veste editoriale che nasce nell’ambito della giornata di studi promossa dal Comune di Reggio Emilia, assessorato alla Cultura e Musei Civici, in collaborazione con «Insieme per il teatro»; intitolata appunto Il Barone Viaggiante. Raimondo Franchetti e le esplorazioni nel Corno d’Africa e tenutasi nella sala del Capitano del popolo a Reggio Emilia il 16 aprile 2005. In quella occasione sono state presentate alcune interessanti relazioni 269 Le schede (RAI, 1963). Come si può vedere, una giornata di studi di tutto rilievo sulle orme, per così dire, di un esploratore del suo tempo, con tanti difetti e qualche pregio, ma pienamente inserito nella speciale e spesso (a ragione) condannata categoria degli uomini, anche senza scrupoli e dediti al solo profitto economico e/o politico, che calcarono le terre africane alla ricerca di sensazioni «romantiche» ancora in un’epoca (si legge proprio nella relazione di Quirico) in cui, a imperi coloniali da tempo consolidati, di romantico era rimasto ben poco da conseguire. Più che mai contraddittoria, in questo contesto storico su cui negli ultimi decenni gli studiosi hanno fatto molta chiarezza, la vicenda africanistica dell’Italia, avviatasi tardi e male verso orizzonti che né economicamente né culturalmente le competevano. Raimondo Franchetti potrebbe essere accostato a De Monfreid, uomo certamente più colto, «più scrittore» del barone che aveva bisogno di qualcuno che desse uno sguardo alle sue relazioni di viaggio, ma in ogni caso (sempre secondo Quirico) Franchetti e il francese De Monfreid restano, ad ogni effetto, due personaggi «in ritardo», a loro modo fuori epoca, discendenti da una schiera di esploratori/viaggiatori che aveva annoverato 270 uomini molto «diversi» come Gessi e Piaggia, ma che fondamentalmente denotano un colonialismo italiano deviante nelle sue manifestazioni e, per usare una definizione di Cerreti nel suo contributo, caratterizzato da chiari segni di specificità, perché «l’Italia non aveva nessuna ragione di metter su colonie». Non reggono, infatti, né la motivazione espansionistica imputabile ad un’emigrazione pressante né il mito dell’industrializzazione/espansione commerciale e dell’applicazione del capitale in esubero. Motivazioni, queste, che potrebbero avere valore per ben altre Potenze del tempo, non per l’Italia. Chi fu veramente il barone Franchetti, trevigiano per nascita ma emiliano di adozione, ce lo dice il citato contributo di Valeria Isacchini in cui è tracciata la storia della famiglia e dell’esploratore (altri dati possono desumersi anche dal contributo di Gino Badini). Fu un uomo decisamente fortunato per disponibilità finanziarie, libertà di movimento, segnato da un carattere «impetuoso, volitivo e impulsivo», ma anche da «scarso equilibrio politico» (se ascoltiamo la testimonianza dell’ambasciatore italiano in Etiopia, Guariglia). Si rese noto già giovanissimo per la sua smania di vivere e per alcuni viaggi interessanti in diverse parti del Le schede mondo, ma non fu (nonostante il tempo e le apparenze) un appassionato sostenitore del fascismo a cui comunque si avvicinò, quando cominciarono a collimare i reciproci interessi per l’Africa e il possibile sogno di un impero unico dall’Eritrea alla Somalia, non più intervallato dall’acrocoro. La «missione» di Franchetti in un’Africa che fosse più italiana, dopo altre esperienze significative nei territori britannici (compreso il Sudan), si rivolse alla Dancalia centrale, in direzione prima est-ovest, poi ovest-est. Il barone fece suo il progetto e lo realizzò a sue spese nel 1929, quindi subito dopo de Regny e Nesbitt, superando la difficoltà di uomini e di mezzi, oltre che di un ambiente difficilissimo di cui è testimonianza, oltre che nella pellicola di Craveri, nel suo ben documentato volume Nella Dancalia etiopica edito da Mondatori nel 1930. A monte dell’impresa resta, comunque, una storia complessa e non del tutto chiara, se prima e dopo la spedizione dancala il barone continuò ad aggirarsi nei ministeri e a godere delle simpatie di Mussolini per una politica di forte penetrazione in Etiopia alla quale solo Franchetti avrebbe potuto dare un contributo notevole e gravante sul ricco patrimonio di famiglia. L’esploratore trevigiano avrebbe potuto spendere la sua influenza sul posto per il governo italiano e dirigere una missione in Etiopia. Ma ecco che accade l’irreparabile con tanto di epilogo misterioso. Il 7 agosto 1935 il barone perde la vita nei pressi del Cairo, allorché è diretto all’Asmara per prendere contatti con capi etiopici e dancali favorevoli alle mire espansionistiche di Roma e svolgere azioni mirate di propaganda politica. Era appena passato anche il progetto del barone di un Ufficio Speciale Etiopia, e intanto l’attacco italiano all’allora Abissinia poteva dirsi imminente. Finisce qui la storia di Franchetti che fu sepolto, come da lui voluto, ad Assab e che oggi riposa nel cimitero militare italiano di Otumlo, a circa 7 chilometri da Massawa, dopo l’eliminazione dello stesso cimitero di Assab nei primi anni settanta. Ci resta tuttora la figura dell’esploratore/viaggiatore, non priva di un certo controverso fascino. E Franchetti è figura a suo modo singolare, in parte costruita da lui stesso. La spedizione nella Dancalia etiopica, come ricorda nel suo contributo Taillibert, fu oggetto di un’attenta documentazione fotografica con tutti i pregi e i difetti del tempo. La realizzò un giovanissimo Mario Craveri per conto dell’Istituto Nazionale Luce: un film documentario in un tempo che si avvia271 Le schede va ormai al sonoro, girato in condizioni assai precarie, con al seguito della troupe materiale abbastanza limitato, ma tendente a fornire allo spettatore ampia documentazione e spunti di immaginazione. Un film inevitabilmente propagandistico, con immagini ufficiali tipiche di ogni spedizione che si rispetti e altre della vita quotidiana di uomini alla conquista dell’ignoto. Franchetti non fu certo il primo esploratore ad avventurarsi nella Dancalia inesplorata. Surdich ne fa ampio cenno nel suo contributo dedicato a Ludovico Maria Nesbitt, ingegnere minerario italo-inglese di quelle terre desertiche che cominciarono a essere percorse, seppure con itinerari diversi, dall’inglese Cornwalis Harris nel 1843 e dal lazzarista italiano Sapeto nel 1850. Esplorazioni spesso finite in tragedia, soprattutto se viziate da intrusioni politiche: si pensi al massacro dello svizzero Munzinger ucciso nel 1875, dopo un primo viaggio del 1867, nei pressi del lago Assal, o alla distru- zione, nel 1881 nei pressi di Egreré, della colonna guidata da Giulietti, i cui resti furono identificati proprio dagli uomini di Franchetti. La spedizione Nesbitt si era svolta nel marzo-giugno 1928 in condizioni drammatiche, in un territorio ancora in parte sconosciuto e negato ad ogni forma di attività economica, come si rileva nelle pagine di questo esploratore a conferma di quello che probabilmente lo stesso Franchetti sapeva da tempo: la Dancalia valeva quasi niente e il porto di Assab, desolato e poco accessibile da ogni parte, non avrebbe potuto mai rivaleggiare con quello di Massawa, economicamente più valido e sfruttabile. L’ultimo contributo è dei due curatori del bel volume e riguarda La donazione Franchetti nei Musei civici di Reggio Emilia, la città a cui tanto si collega il nome del Barone viaggiante, esploratore e anche, in fondo (come si è potuto capire), agente politico (Massimo Romandini). Stefano Fabei, Carmelo Borg Pisani (1915-1942). Eroe o traditore?, Bologna, Editrice Lo Scarabeo, 2007, pp. 153 (Collana «Documenti per la Storia») In quell’«eroe o traditore?», posto a fine titolo in modo così drammatico, consiste l’essenza di questo nuovo volume di Stefano Fabei, attento studioso e valido ricercatore perugino ormai noto per le sue interessanti pubblicazioni dedicate 272 Le schede alla storia del mondo arabo e balcanico (cito, tra le più recenti, le due dedicate rispettivamente a Mussolini e la resistenza palestinese, Mursia 2005 e I Cetnici nella seconda guerra mondiale, Libreria Editrice Goriziana 2006). Questa volta le ricerche di Fabei si sono rivolte a un personaggio praticamente sconosciuto, ma meritevole di essere riesumato dal forzato oblio imposto dalla Storia. Chi fu veramente Carmelo Borg Pisani, il giovane di Senglea (quartiere di La Valletta) che sognava la liberazione di Malta dal dominio britannico e guardava con innegabile simpatia all’Italia fascista, ma finì impiccato alle prime luci del 28 novembre 1942 nel carcere maltese di Corradino? È meno difficile dirlo oggi, dopo le pagine storicamente valide di Fabei su questa emblematica figura di artista-soldato, che si arruolò nell’esercito italiano in quel tremendo periodo del secondo conflitto mondiale. A leggere il volume ben documentato e altrettanto ben illustrato si ha l’impressione che la figura di Borg Pisani sia destinata a restare avvolta da un velo di leggenda, in quanto il personaggio stesso, ad un tempo apprezzato e condannato dagli opposti versanti della Storia, è di quelli che «crea(no) qualche difficoltà», come ricorda nella Presentazione Guido De Marco, Presidente emerito di Malta. Eroe, appunto, per chi lo affianca a un Cesare Battisti, un Fabio Filzi, un Nazario Sauro per il sogno di una Malta unita all’Italia e libera dal dominio inglese che da tempo snazionalizzava l’isola in senso antitaliano; traditore, però, per chi ricorda la sua adesione alla politica italo-tedesca che produsse bombardamenti indiscriminati sulla sua amata Malta, distruzioni e povere vittime civili. Proprio in questo – ricorda De Marco – consiste «l’enigma dell’uomo. In verità qui sta il semplicismo di chi vuol ridurre la tragedia di un giovane, serio e idealista, in un’apoteosi non del tutto meritata, o in un disprezzo non del tutto dovuto». Certo, Borg Pisani visse in un periodo di forti contraddizioni e il suo nazionalismo che vedeva nell’Italia un sicuro punto di riferimento era diverso da quello di altri maltesi che, pur aspirando all’indipendenza dalla Gran Bretagna (realizzatasi solo il 21 settembre 1964), non erano «irredenti» e miravano piuttosto ad una più generica conservazione della civiltà latina di Malta che la Gran Bretagna, da parte sua, cercava con ogni forza di mettere al bando insieme alla lingua italiana soprattutto dopo l’abolizione del self government concesso nel 1921 e l’instaurazione di un governo for273 Le schede te, quasi dittatoriale, che però, in quell’epoca di affermati fascismi e nazismi, aveva il merito di credere nei principi della democrazia. Per dirla ancora con De Marco, questo è il «vortice» nel quale si trovò a vivere Borg Pisani e che lo travolse fino al sacrificio estremo. Il personaggio si presenta, nelle pagine di Fabei, stranamente lineare e complesso. Ce ne rendiamo conto non solo dalla narrazione delle vicende della sua breve vita (di questo il merito è, appunto, da attribuire all’autore), ma anche dalle parole che a lui dedica Franco Cardini nell’Introduzione. Borg Pisani (due cognomi come nella tradizione maltese, non bastando spesso il solo cognome paterno, Borg in questo caso, peraltro piuttosto comune a Malta, a identificare adeguatamente le persone) potrebbe ancora restare avvolto nella duplice veste dell’eroe e del traditore a seconda delle diverse visuali, tanto più che fattore determinante di giudizio «è il lato dal quale inclina la bilancia della Storia», perché «sono i vincitori a decidere chi sia eroe, chi sia traditore». Né l’Italia si è sottratta a questo destino, l’Italia che ha avuto la sua bella schiera di «irredentisti (che) sono sempre dei rinnegati e dei traditori per quella che – premesse alcuni condizioni storiche e giuridiche – è 274 formalmente, istituzionalmente la loro patria». Si pensi agli irredentisti anteriori al 1918 a cui non è mancata la gloria seppure postuma e a tutti quelli che, invece, hanno lottato tra le due guerre mondiali: catalogati dalla storiografia postbellica come «buoni» (quindi patrioti) quelli che combatterono contro il proprio esercito e il proprio Paese e come «assolvibili» gli altri che non ebbero il coraggio di compiere una simile scelta e condannabili all’oblio, al contrario, perché traditori quanti, vivendo all’estero, tentarono ogni via per ricongiungersi all’Italia anche se sottoposta alla dittatura fascista. Il caso di Borg Pisani rientra tra questi ultimi, per quanto si differenzi per qualche particolarità. Cresciuto in una Malta in cui la politica assimilazionista inglese non aveva toccato i livelli francesi in Corsica (come ricorda sempre Cardini), Borg Pisani sostenne sempre l’italianità dell’isola, partecipò alle vicende politiche italiane del tempo, sostenne il fascismo con convinta partecipazione, sperò in un ritorno «storico» di Malta all’Italia. Studiò all’Accademia di Belle Arti dopo aver studiato nelle scuole italiane di Malta che poi il governo inglese aveva chiuso. Entrata l’Italia nel conflitto mondiale, Borg Pisani non volle rientrare a Malta, si iscris- Le schede se al Partito Nazionale Fascista, fu presente come camicia nera alla campagna di Grecia, conseguì il grado di sottotenente della MVSN dopo un corso a Messina. L’inizio della sua fine fu la richiesta di essere assegnato alla squadriglia Mas di Augusta. Per il giovane maltese sembrò, invece, essere l’inizio del sogno di liberare Malta e il Mediterraneo dagli Inglesi, visto che le alte gerarchie militari italiane miravano a un imponente sbarco sull’isola poi non più realizzato. Una missione investigativa avrebbe dovuto raccogliere notizie importanti sulla situazione difensiva maltese e Borg Pisani finì, a richiesta, col farne parte. Andò tutto male, restò isolato in un punto dell’isola da cui non avrebbe potuto fare ritorno e fu catturato dagli Inglesi. Era la metà di maggio 1942. Il giovane fu condannato all’impiccagione (e non alla fucilazione, come a lungo si pensò in Italia anche in occasione delle prime commemorazioni del suo sacrificio), dopo un veloce processo, durato solo una settimana, nel mese di novembre, da parte della Criminal Court. Il governo fascista gli concesse la Medaglia d’oro al valor militare. Così finì questo artista-soldato di origini siciliane, cittadino di un’isola che oggi guarda all’Europa con rinnovato interesse, ma che sessant’anni fa, in pieno conflitto mondiale, non poteva accettare pur sotto il duro dominio britannico l’idealismo romantico di Borg Pisani e il suo sogno di restituire Malta «libera alla Patria»(Massimo Romandini). Mimmo Franzinelli, Il delitto Rosselli 9 giugno 1937 Anatomia di un omicidio politico, Mondadori, Milano 2007 spiegazioni uno dei grandi delitti politici del regime, l’assassinio dei fratelli Carlo e Nello Rosselli, avvenuto il pomeriggio del 9 giugno 1937 in Normandia. Quello che è di grande interesse nell’opera, oltre che la ricostruzione della rete di rapporti fra gli ambienti politici e militari italiani e la destra francese, l’attenzione prestata a quanto è accaduto dopo il delitto, i depistaggi organizzati dalla stampa e le trame del ministro Galeazzo Non nuovo ai temi del fascismo e della sua polizia politica, Mimmo Franzinelli in questo volume ha messo mani nel vasto materiale che negli ultimi anni, con l’accesso alle fonti processuali, si è reso disponibile per riconsiderare gli eventi nei quali si colloca e trova le proprie 275 Le schede Ciano. Ricerca dentro la ricerca, le pagine dedicate alla storia della Cagoule, un’organizzazione filofascista d’Oltralpe alla quale appartenevano i sicari dei due antifascisti italiani, e dei loro rapporti con i burattinai italiani. Tra questi ultimi basti un nome, quello di Mario Roatta che, da poco reduce dalla Spagna dove aveva comandato con il grado di generale d’armata la missione fascista, al tempo dell’assassinio dirigeva il Sim, costituendo tra l’altro una sezione speciale di servizi speciali per atti di sabotaggio e attentati all’estero. Noto anche per i crimini commessi negli anni della seconda guerra mondiale in Croazia, dove al comando della II armata conduceva una spietata repressione contro i civili, e poi per la sua fuga, l’8 settembre 1943, quando con il re riparava dietro le linee alleate, nel 1945 veniva condannato al termine di un processo durante il quale aveva ammesso di aver dato l’incarico per l’uccisione dei Rosselli al capitano Roberto Navale, ma tre anni dopo veniva assolto per non aver commesso il fatto. Rientrato successivamente dalla Spagna, dove si era nascosto, moriva indisturbato nella propria casa romana nel 1968. 276 Non meno interessante la vicenda biografica di Navale, il regista dei contatti con i cagoulards francesi, che nel 1938, a qualche mese dal delitto, era stato promosso da Galeazzo Ciano «per meriti eccezionali» e, dopo aver concluso ingloriosamente la sua carriera militare con il collocamento nella riserva a seguito di un’inchiesta aperta sul Sim che aveva accertato nel 1940 l’apertura di una casa di tolleranza con i denari del controspionaggio, era stato assunto da Valletta alla Fiat, dove lui stesso aveva già collocato alcuni dei nizzardi coinvolti nella morte dei Rosselli. Come Roatta anche Navale, dopo una prima condanna all’ergastolo del 1945, qualche anno dopo veniva assolto per insufficienza di prove. Per il delitto Rosselli non doveva esistere verità giudiziaria. Anche in Francia l’istruttoria e il processo trascuravano i legami fra gli assassini e i mandanti italiani. Non si voleva spingere in questa direzione. Dovevano passare settant’anni dalla morte del maggiore esponente del movimento italiano di Giustizia e libertà e del fratello, storico del Risorgimento nazionale, perché la storia accertasse la verità di quanto allora accaduto (Severina Fontana). Le schede Francesco Prestopino, I bimbi libici (Storia e storie dei ragazzi della Quarta Sponda), prefazione di Romain H. Rainero, Milano, Edizioni La Vita Felice, 2007, pp. 99 (Collana «Silphium», 5) Autore già di interessanti lavori sulla presenza italiana in Libia tra Ottocento e Novecento, Prestopino tocca questa volta un argomento davvero poco noto che la sua sensibilità di attento ricercatore presenta in modo che potremmo definire discreto, nello stesso tempo in cui invita ad una saggia riflessione. Preceduto da una prefazione di Romain H. Rainero, il libro propone alla nostra attenzione la storia, molto triste, di alcune migliaia di bambini italiani che il regime fascista sottrasse alle famiglie residenti in Libia alla vigilia del secondo conflitto mondiale: bambini che in parte ebbero un destino benevolo, in parte poterono ritornare dopo alterne e comunque sempre drammatiche vicende nella patria libica dai genitori colonizzatori all’indomani del conflitto e della perdita delle colonie da parte dell’Italia, e in parte ancora, purtroppo, si persero nella tragiche vicende belliche di un’Italia ormai allo sbando dopo la caduta del fascismo e quel che ne seguì in termini di distruzioni materiali e morali. Quella riportata alla luce da Prestopino è una pagina della nostra storia conosciuta da pochi e solo, finora, grazie ad una trasmissione televisiva di alcuni anni fa e a qualche preziosa testimonianza scritta. Ma non si tratta, a dire il vero, della sola pagina del colonialismo italiano su cui gli storici hanno volutamente sorvolato. Rainero, nella prefazione, ricorda ad alta voce che altre pagine o sono state scritte frettolosamente e con paura o risultano volutamente ignorate. Ricorda poi, con altrettanto coraggio, la storia dei «non-personaggi» che manca al racconto della vicenda coloniale italiana, a bella posta costruita solo sui grandi avvenimenti, sugli intrighi diplomatici, sulle battaglie cruente vinte o perdute, sui personaggi di rango, dimenticando colpevolmente quanti alla grande storia dettero il loro apporto di uomini comuni in un contesto coloniale (quello italiano) di secondo rango, se non misero addirittura. In questa storia di chiaroscuri tipica di molte vicende umane, ricorda sempre Rainero, è venuta meno soprattutto la storia degli umili protagonisti, «vittime sacrificali di situazioni che ne frantumarono senza pietà speranze, fatiche, risparmi e avvenire». A questi «non-personaggi» dimenticati dalla storia ufficiale hanno dedicato, in questi anni (e coraggio277 Le schede samente), molte pagine Del Boca, Susigan e qualche altro storico, ma è ancora poco se si pensa che tante testimonianze non potranno essere più raccolte e gli archivi, spesso dispersi nelle vicende belliche, sono al riguardo tristemente muti. In questa stessa intricata e spesso tragica storia di esseri umani, occupano un posto importante tutti gli italiani che vissero nelle colonie d’Africa, dall’Etiopia all’Eritrea e dalla Somalia alla Libia. In questi ultimi anni alla storia dei dimenticati della Libia dalla storiografia togata ha dato un contributo importante, non solo con questo volume, proprio Prestopino. L’attenzione dello studioso si è rivolta ai tredicimila giovani, in gran parte figli dei contadini venuti in Libia con l’ondata dei Ventimila voluta da Balbo nell’ottobre del 1938: ragazzi dai quattro ai quattordici anni (soprattutto veneti, ma anche siciliani e pugliesi), mandati in Italia ai primi di giugno 1940, data (come si è già accennato) l’imminenza della guerra, nelle colonie marine e montane della GIL. La guerra isolò irrimediabilmente questi poveri ragazzi che persero i contatti con le rispettive famiglie in Africa e si ritrovarono allo sbando dopo il 25 luglio 1943, che vide la fine del fascismo. Un vero calvario - come lo definisce Rainero - per i poveri ragazzi della «Quarta spon278 da» dimenticati da tutti nel mezzo di vicende gravissime. Prestopino ha compiuto un lavoro importante, oltre che interessante, e meritevole di lode (sia detto senza la retorica che accompagna a volte la segnalazione di questi libri a cui non può mancare la tristezza del ricordo): un atto d’amore verso una terra che continua ad amare nonostante tanti dolori trascorsi e la constatazione amara che il vecchio contenzioso italo-libico, per un groviglio di colpe reciproche, forse non si risolverà mai. Il volume è ben articolato. Un significato particolare assume, per forza di cose, il capitolo intitolato La vita nelle colonie (pp. 39-59) in cui, grazie a diverse testimonianze, è possibile ricostruire la vita quotidiana di molti bambini che lasciarono la Libia per le colonie della GIL. Sono pagine interessanti e commoventi con notizie di prima mano, «certamente più attendibili (sottolinea a ragione Prestopino) delle notizie ricavabili dalle fonti coeve, più o meno ufficiali e quindi inevitabilmente soggette alla propaganda del regime». Ma altrettanto interessante è il capitolo seguente intitolato «Quel che si ricava dalle testimonianze dei ’bimbi libici’» (pp. 61-68) in cui l’autore trae alcune conclusioni che confermano le sofferenze dei bambini costretti Le schede a spostarsi continuamente da una colonia all’altra (fino a quattordici volte uno di loro!), costretti a partecipare a sfilate, a essere inquadrati a volte militarmente, a subire i duri colpi della guerra (alcuni persero la vita sotto i bombardamenti). Ne deriva la rappresentazione, fra testimonianze dei protagonisti e conclusioni dell’autore, di un’umanità sofferente e allo sbando, anche se all’inizio il ricorso alla colonia sembrò poter essere la giusta soluzione al dramma della guerra appena scoppiata. Semplicemente commovente poi l’elenco di «bimbi libici» alle pp. 83-93 del testo: un elenco ovviamente incompleto, ma che si commenta da solo. Molto belle, poi, le foto d’epoca che Prestopino ha inserito qua e là nella narrazione degli avvenimenti (Massimo Romandini). Antonella Braga, Un federalista giacobino. Ernesto Rossi pioniere degli Stati Uniti d’Europa, il Mulino, Bologna 2007-10-31 formazione politica, la studiosa ha avuto modo di ricostruire come i suoi convincimenti in senso federalista risalgano a quegli anni lontani, ben precedenti l’incontro con Spinelli a Ventotene, e affondino le proprie origini in ideali di solidarietà internazionale di matrice democratica risorgimentale, come siano stati influenzati poi dall’incontro con Gaetano Salvemini a Firenze nel primo dopoguerra e da quellli con Riccardo Bauer e Luigi Einaudi negli ambienti dell’Umanitaria milanese e della Bocconi degli anni venti, quando Rossi insegnava in un istituto tecnico bergamasco e frequentava gli ambienti di Giustizia e Libertà, e siano da ultimo maturati negli anni della prigionia, fra il 1930 e il 1939. Ernesto Rossi era stato arrestato nel capoluogo lombardo nel 1930, il Partendo dalla documentazione conservata a Firenze negli Archivi storici dell’Unione Europea e in altri archivi italiani e svizzeri Antonella Braga in questo volume ripercorre l’evoluzione del pensiero di Ernesto Rossi, il cui ruolo nell’affermazione del federalismo europeo è finora rimasto in ombra rispetto a quello riconosciuto ad Altiero Spinelli. A quest’ultimo si è infatti generalmente ascritta la paternità del progetto espresso dal Manifesto di Ventotene nonché l’azione politica che ne è seguita. Disegnando la biografia intellettuale di Rossi e risalendo agli anni della giovinezza e della sua prima 279 Le schede 30 di ottobre, lo stesso giorno nel quale avevano subito la medesima sorte Riccardo Bauer, Ferrruccio Parri e Umberto Ceva. Con il primo si ritrovò nel IV braccio di Regina Coeli dal 1933 al 1939. Con loro era anche Manlio Rossi Doria, che Rossi aveva conosciuto nel carcere di Piacenza in cui era rimasto due anni dal 1931 al 1933. Bauer con altri compagni studiava filosofia. Rossi, insofferente all’idealismo crociano degli amici, preferiva i testi di economia. Alla vigilia della scarcerazione confidava alla moglie di aver letto in nove anni di detenzione tanta roba quanta non ne avrebbe potuta leggere in cent’anni se fosse stato fuori. Al centro della sua riflessione politica la delusione per le promesse non mantenute della democrazia: le folle acclamanti il duce nelle piazze italiane o la votazione plebiscitaria della Saar in favore di Hitler nel 1935 avevano provocato in Rossi il rigetto di quelle formule troppo semplicistiche, tolte da Rousseau, che attribuivano al popolo tutte le virtù, insieme alla capacità di intendere quale fosse bil suo «vero bene». Anche lo studio dei regimi di più lunga tradizione liberaldemocratica che avevano resistito alla tentazione totalitaria - come la Gran Bretagna e gli Stati Uniti - l’avevano convinto di quanto illusoria fosse la con280 vinzione che il popolo, chiamato a scegliere i suoi rappresentanti al governo, sapesse e volesse sempre scegliere i migliori. L’avvento delle masse sulla scena della storia aveva fornito un esercito di manovra a moderni demagoghi. Nonostante ciò, per sfiducia nei confronti di minoranze illuminate restava democratico, portando la propria attenzione, piuttosto che sull’esercizio della sovranità popolare, sui meccanismi dì controllo con i quali doveva essere limitato il potere dei governanti. Secondo Rossi le teorie democratiche dovevano quindi essere continuamente rivedute e le istituzioni adattate alle mutevoli condizioni storiche. Dalle medesime riflessioni prendeva le mosse nel considerare l’ipotesi federalista, non solo nella sua dimensione sovranazionale ma anche in quella infranazionale, come strumento di riforma dello Stato nazionale accentrato e nella direzione del rafforzamento dei corpi intermedi fra Stato e cittadino perché il singolo potesse trovarvi appoggio al di fuori e - quando occorresse - anche contro lo Stato. Puntuale e rigorosa, la ricostruzione della Braga restituisce la ricchezza di un percorso che negli anni del secondo dopoguerra si misura sul piano dell’azione e che, nell’immediato sconfitto dal corso degli Le schede eventi, presenta ancor oggi evidenti motivi di interesse e contenuti di indubitabile attualità (Severina Fontana). Arduino Paniccia, La quarta era. Un futuro senza terrore, Mazzanti Editori, Venezia 2006, pp. 136. innescando una escalation che potrebbe portere alla reciproca distruzione dei contendenti. Secondo il docente di Strategia ed economia presso l’ateneo giuliano, il presupposto della Mad che ha retto per tutta la guerra fredda è ora traballante e potrebbe cadere da un momento all’altro in caso di reazione ad un attacco atomico di uno Stato terzo connivente con il terrorismo. La percezione di tale rischio non è così chiara per l’opinione pubblica internazionale: «dopo l’11 settembre – dice Paniccia nell’introduzione al libro – abbiamo cominciato a convivere con un nuovo incubo: quello del terrorismo e della insicurezza internazionale. Mentre ci abituiamo a questa idea di emergenza permanente come già ci abituammo ad altre, tendiamo comunque a pensare che ci siamo già passati. Ma non è vero: viviamo una minaccia nuova ed imprevedibile: il possibile ritorno di uno scontro nucleare e della guerra totale». Muovendosi tra i fatti storici e le parole dei grandi maestri della strategia come Sun Tzu, Karl von Clausewitz, Henry Jomini, Helmut Karl von Molte, i brigadieri generali cinesi Xiao Liang e Wong Xiang, Dopo un intermezzo durato circa un lustro, dedicato all’attività di docente universitario e opinionista presso le principali reti televisive italiane, Arduino Paniccia torna a parlare di strategia con un pregevole libro che analizza l’attualità delle relazioni internazionali segnate dal fenomeno terroristico e dalle incertezze per gli scenari a venire. In questa interessante disamina della realtà contemporanea, Paniccia non è accompagnato da Edward Luttwak, politologo ed ex consulente dell’US National Security Council, come invece era stato per I nuovi condottieri. Vincere nel XXI secolo (Marsilio, 2000), ma da un think tank creatosi presso l’Università di Trieste e poi estesosi con proprie ramificazioni nelle principali organizzazioni internazionali. In estrema sintesi, il volume di Paniccia rivendica l’attualità del rischio della MAD (Mutual Assured Destruction), ovvero la possibilità che ad un attacco atomico si risponda con una uguale azione, 281 Le schede l’autore del libro definisce nelle prime pagine della sua opera il progressivo evolversi delle tipologie di conflitto nelle relazioni internazionali, preparando così il campo alla disamina di un eventuale scontro di quarta generazione, che potrebbe nascere dall’unione di conflitto asimmetrico e terrore. La presentazione da parte di Arduino Paniccia degli scenari da lui preconizzati per il post 11 settembre (ciò che egli definisce «il punto di svolta») inizia in qualche modo con le interessanti pagine dedicate alla storia del terrorismo in età contemporanea. Esse servono a fornire al lettore gli strumenti di base per capire quali siano le radici storiche del fenomeno e come esso si sia evoluto nell’età contemporanea. Prosegue avvertendo che «nel futuro dell’umanità altre bombe, oltre a quella nucleare e del terrorismo, possono esplodere 282 se non verrà rapidamente ammodernato il sistema di regole internazionali. Sessanta anni sono passati dal grande accordo di Bretton Woods, che fu siglato proprio nel corso di una guerra. È un esempio da imitare». Ancora più chiaro è nelle ultime righe del saggio, dove fornisce le linee guida da seguire per scongiurare l’incombente pericolo: «gli obiettivi da raggiungere nella Quarta Era devono essere: l’accantonamento delle soluzioni unilaterali (da qualsiasi nazione siano esse generate), la «pace difesa» da nuove norme internazionali e l’adozione di valori e direttive che indirizzino i comportamenti dei singoli e ispirino le azioni di governi e società transnazionali. In caso contrario, l’odierna parentesi di pace guerreggiata rischia di svanire nell’abbagliante esplosione del fungo nucleare» (Matteo Vecchia). notizie sugli autori di questo numero Paolo Bologna – Collaboratore dell’Istituto storico della Resistenza in provincia di Novara e studioso delle vicende legate alla storia della resistenza piemontese. Francesco Corsi – Giovane studioso che si è laureato nel 2005 all’Università di Siena con una tesi, seguita da Nicola Labanca, sul giornale cremonese di Farinacci «Il regime fascista». Ottavio D’Addea – Giovane insegnante, conduce studi su temi metodologici connessi allo studio e all’insegnamento della storia contemporanea Angelo Del Boca - Da quarant’anni si occupa di storia del colonialismo e dei problemi dell’Africa d’oggi. Fra i suoi libri recenti: Gheddafi. Una sfida dal deserto, Laterza, 1998; Un testimone scomodo, Grossi, 2000; La disfatta di Gasr bu Hàdi, Mondadori, 2004; Italiani, brava gente?, Neri Pozza, 2005. Da poco è uscito, per i tipi della Baldini Castoldi Dalai A un passo dalla forca, con il quale ricostruisce la vicenda di uno dei protagonisti della resistenza libica all’occupazione italiana, Mohamed Fekini. Stefano Fabei – Insegnante dell’istituto tecnico per le attività sociali di Perugia. tra i suoi libri citiamo Il fascio, la svastica e la mezzaluna, Mursia, Milano 2002, Una vita per la Palestina, storia del Gran Mufti di Gerusalemme, Mursia, Milano 2003 e Mussolini e la resistenza palestinese, Mursia, Milano 2005, oltre all’ultimo lavoro su Carmelo Borg Pisani (1915-1942). Eroe o traditore?, Bologna, Editrice Lo Scarabeo, 2007. Severina Fontana- Insegnante di storia e filosofia al Liceo classico Melchiorre Gioia di Piacenza, si è occupata di storia delle borghesie nell’Ottocento italiano, di associazionismo economico fra Otto e Novecento e ha toccato tematiche di storia di genere. Ha scritto su riviste italiane e straniere come «Quaderni storici» e «Histoire économie et Société». Tra le altre pubblicazioni ha curato La Federconsorzi fra Stato liberale e fascismo, Laterza, Roma-Bari 1995 e Donne luoghi lavoro, Mazzotta, Milano 2003. Valeria Galimi – Dopo aver conseguito il dottorato di ricerca presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, con un lavoro sull’antisemitismo francese degli anni trenta, ha avuto incarichi di insegnamento e ricerca oltre che al Sant’Anna, pres- so le università di Roma. Modena e Siena ed è chercheur associé all’Institut d’histoire du temps présent. Fa parte anche del comitato di redazione della rivista francese «Histoire & Sociétés. Revue européenne d’histoire sociale». Tra i suoi lavori a stampa citiamo la curatela, con P. Finelli e G.L.Fruci, del numero monografico di «Quaderni storici» del dicembre 2004 sul tema Discorsi agli elettori e il volume L’antisemitismo in azione. Pratiche antiebraiche nella Francia degli anni Trenta, Unicopli edizioni, Milano 2006. Giovanni Galli - Insegna storia e filosofia al Liceo scientifico Antonelli di Novara. Per tre anni è stato distaccato presso l’Istituto storico P. Fornara dove ha svolto studi e ricerche anche di carattere didattico. Ha pubblicato Memorie ritrovate. I diciassette ragazzi fucilati a Baveno nel giugno del 1944, Istituto e Comune di Baveno, 2004; Primo Levi tra storia e memorialistica, in Novecento. Letteratura e non solo, a cura di Maria Motta, Lampi di stampa, Milano 2004; La divisa del Tenente Volpe. I ricordi di Giuseppe Volpe dalla Somalia a Corfù ai campi di internamento tedeschi, con Francesca Ferri e Laura Lampugnani, Interlinea, Novara 2004 e il VHS, Ricordo Primo Levi, Novara 2002. Sandro Gerbi - Giornalista, ha lavorato per «La Stampa», «Il Mondo» e «Il Giorno». Con Einaudi ha pubblicato nel 1999 In tempi di malafede. Una storia italiana fra fascismo e dopoguerra. Guido Piovene ed Eugenio Colorni, nel 2002 Raffaele Mattioli e il filosofo domato e nel 2006, insieme al giovane allievo Raffaele Liucci, Lo stregone. La prima vita di Indro Montanelli. Domenico Letterio - Giovane studioso, si occupa di storia del pensiero politico e in particolare degli scritti di Alexis de Tocqueville su Algeria, India e Antille francesi. Alberto Magnani - Ha svolto attività di ricerca presso il Dipartimento storicogeografico dell’Università di Pavia e presso altri enti e istituti storici. Ha pubblicato con La Nuova Italia nel 1990 un volume su Luigi Montemartini nella storia del riformismo italiano. Ernesto Milanese - Titolare di Estimo rurale nella Facoltà di Agraria dell’Università di Firenze, ove insegna nel corso di Agricoltura tropicale, è stato docente nell’Università nazionale somala (Afgoi). Ha svolto missioni per conto della Cooperazione Italiana (MAE) in Etiopia per studiare lo stato delle cooperative in Arsi e Bale e per attuare un programma di formazione per cooperatori. Massimo Romandini - Dirigente scolastico, dal 1969 al 1975 ha insegnato in Etiopia alle dipendenze del ministero degli Esteri. Si occupa di storia del colonialismo italiano in Africa Orientale. Alberto Sbacchi. Nato a Palermo nel 1937, ha studiato in Francia e Inghilterra prima di conseguire il Ph. D. nel 1974 all’Università dell’Illinois, studiando sotto la supervisione del prof. Robert L. Hess. Specializzato nella storia dei paesi europei e del colonialismo italiano ha fatto ricerche nei maggiori archivi dell’Europa occidentale, degli Stati Uniti e del Kenya, Sudan ed Etiopia. Membro di varie società professionali, nazionali e straniere, ha ricevuto il prestigioso Fulbright-Hays per i suoi studi sul Corno d’Africa. Autore di libri e numerosi articoli pubblicati in riviste locali – statunitensi - ed estere, dal 1963 al 1968 ha insegnato in Etiopia e dal 1974 al 2003 è stato professore di storia all’Atlantic Union College del S. Lancaster, nel Massachusetts. Matteo Vecchia - Laureato in Scienze Internazionali e Diplomatiche presso l’Università di Trieste, è dottorando di ricerca in Storia Contemporanea presso l’Istituto Italiano di Scienze Umane (Firenze-Napoli). Sta conducendo studi sul terrorismo arabo e islamico, e scrive articoli di politica internazionale su quotidiani e riviste italiane. In Memoriam Tre fra i più prestigiosi collaboratori della nostra rivista e membri del Comitato Scientifico, Alberto Sbacchi, Christopher Seton-Watson ed Enrico Serra, sono scomparsi in questi ultimi mesi, lasciando un vuoto difficilmente colmabile. Tutti e tre questi illustri studiosi e docenti erano con noi fin dagli anni ottanta del secolo scorso quando fondammo «Studi Piacentini». L’italo.americano Alberto Sbacchi era professore di storia all’Atlantic Union College di South Lancaster, nel Massachusetts. Era considerato uno dei più importanti studiosi dell’avventura fascista in Etiopia. Uno dei suoi ultimi libri si intitola: Legacy of bitterness. Ethiopia and fascist Italy: 1935-1941. In questo numero della rivista pubblichiamo l’ultimo saggio che ci ha inviato, sui rapporti tra il nostro paese e l’Etiopia, con una acuta rilettura del periodo coloniale e del suo impatto sulla società etiopica. Christopher Seton-Watson è stato per quarant’anni uno dei più illustri docenti del New College di Oxford. Raccontò per primo, al mondo anglosassone, l’ascesa e la caduta dell’Italia liberale. Celebre la sua opera, Italy from Liberalism to Fascism, del 1967, ormai considerata un classico. Tra i molti libri che ha scritto, alcuni con il fratello Hugh, va segnalato Dunkirk, Alamein, Bologna. Letters and diaries of an artilleryman, 1939-1945, nel quale racconta la sua straordinaria esperienza di artigliere su tutti i fronti della seconda guerra mondiale. Nel 1982 Seton-Watson ha fondato l’Associaton for the Study of Modern Italy. Due anni dopo, per i suoi eccezionali meriti di studioso della storia del nostro paese, è stato insignito dal presidente Sandro Pertini della commenda della Repubblica. Enrico Serra ha lavorato a lungo all’ISPI, prima e dopo il secondo conflitto mondiale. In seguito è stato corrispondente dell’ANSA a Londra e a Parigi. Dal 1961 ha insegnato Relazioni internazionali all’Università di Bologna. Ha infine diretto, per diciannove anni, il Servizio storico e documentazione del Ministero degli Affari Esteri. Ha pubblicato molti volumi di storia della politica estera e della diplomazia, tra i quali: Alberto Pisani Dossi diplomatico, L’Italia e le grandi alleanze al tempo dell’imperialismo, La diplomazia in Italia. Ma il suo libro più significativo è Tempi duri, apparso nel 1996, nel quale racconta la sua esperienza di ufficiale carrista in Libia e la sua partecipazione alla lotta armata antifascista. Uno dei grandi meriti di Enrico Serra è di aver realizzato gli Inventari degli archivi della Farnesina, fornendo così agli storici - che gli saranno perennemente grati - i più validi strumenti per poter utilizzare i ricchissimi fondi del Ministero degli Esteri (a.d.b.). Finito di stampare nel mese di dicembre 2007 presso la Tipolitografia Saccardo Carlo & Figli snc - Ornavasso (VB) e-mail: [email protected] ISSN 1826-7920 6 I SENTIERI DELLA RICERCA � 12,00 6 I SENTIERI DELLA RICERCA rivista di storia contemporanea Bologna Galli Fabei Corsi Magnani Gerbi Galimi Sbacchi Milanese Letterio D’Addea Romandini Vecchia Fontana Del Boca dicembre 2007 EDIZIONI CENTRO STUDI “PIERO GINOCCHI” CRODO
Scaricare