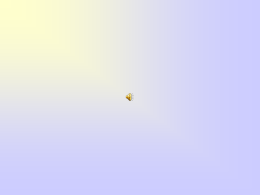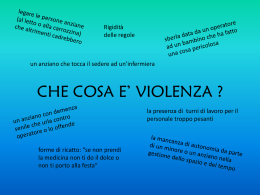la solitudine di Sherazade speciale donne/1 www.osservatorioitaq.it | INDICE INTRODUZIONE5 Turchia BUONE LE PREMESSE, MODESTI I RISULTATI Cambiare si può: incontro con Pervin Chakar Libano di Luca Bellusci 6 di Luca Bellusci10 SE LE DONNE SONO CITTADINE A METÀ di Elisa Piccioni Migliorare la condizione della donna, “liberando” l’uomo 12 di Elisa Piccioni16 Palestina Speciale Donne/1 L’INTIFADA DELLE DONNE, TRA OCCUPAZIONE E PATRIARCATO di Cecilia Dalla Negra 20 Le donne di Gaza continuano a lottare di Cecilia Dalla Negra26 la solitudine di Sherazade Giordania MORIRE D’ONORE di Marta Ghezzi30 Iraq SHERAZADE NON ABITA PIÙ QUI di Francesca Manfroni36 Golfo ESCLUSIONE E DISCRIMINAZIONE, PER LE DONNE IL LAVORO È ANCORA UN MIRAGGIO di Anna Toro 40 Donne migranti, una tragedia tutta ‘domestica’ di Stefano Nanni44 Iran STORIE DAL BRACCIO 209 di Cecilia Dalla Negra50 Non rinnegano la rivoluzione, è la rivoluzione a rinnegare loro di Marta Ghezzi 54 Afghanistan TRA PAURA, VIOLENZE E LEGGI “INVISIBILI” Quando la prostituzione comincia in famiglia di Anna Toro58 di Anna Toro62 www.osservatorioitaq.it | 5 INTRODUZIONE Poveri o ricchi, rivoluzionari o conservatori, la storia è quasi la stessa. Anche il 2012 si chiude senza progressi significativi in termini di miglioramento delle condizioni delle donne e dei loro diritti, anzi. Secondo la classifica stilata dal Global Gender Gap, che si parli di paesi post-primavere o dei potenti Stati del Golfo Persico, la storia non cambia. È così che il Libano – a cui tanti guardano per le libertà accordate alla popolazione femminile - segue invece in negativo il Bahrein, collocandosi ben 11 punti al di sotto. O il “progressista” Marocco, come amano chiamarlo le cancellerie occidentali, che con il suo 129esimo posto nel 2010 ha visto 41.098 ragazze sotto i 18 anni diventare mogli. Chiudono la classifica Arabia Saudita, Siria e Yemen, che si aggiudica lo scettro di paese peggiore in termini di rispetto dei diritti di genere, soprattutto in virtù di un 55% di analfabete e di un 79% di donne che non hanno accesso al mondo del lavoro. Yemen tristemente noto anche per le proporzioni del fenomeno delle spose bambine, che appena dodicenni muoiono per problemi legati al parto. Ma la povertà non c’entra, come dimostra la regina delle sabbie, l’Arabia Saudita, dove le donne possono solo spendere le enormi fortune legate ai proventi della vendita del petrolio. O dove nel 2002 sono arse vive 15 ragazze in un incendio scoppiato in una scuola della Mecca: allora fu proprio la «polizia morale» ad impedirgli di salvarsi, perché è meglio morire che non indossare il velo. Così come non c’entra il grado di apertura di una società, se si pensa che l’Egitto ha reso illegale la pratica delle mutilazioni genitali femminili solo nel 2008, e con l’opposizione di diversi esponenti dei Fratelli Musulmani (attualmente al potere). Quello stesso Egitto in cui, ancora nel 2008, oltre l’80% della popolazione femminile dichiarava di aver subito molestie e più del 60% degli uomini ammetteva di aver provato ad abusare di una donna. Con o senza primavere, è sul corpo delle donne che si combatte la vera battaglia di libertà di questi paesi. E sebbene ad innescare le rivolte sia stato un uomo - il venditore ambulante Mohamed Bouazizi - la vera rivoluzione sarà sicuramente al femminile. 6 www.osservatorioitaq.it | 7 | speciale donne La Turchia è un laboratorio politico e sociale molto interessante. Negli ultimi dieci anni, il paese ha avuto una crescita economica senza precedenti e ha adottato importanti riforme strutturali, sia sul piano legislativo che giudiziario. La questione di genere, nonostante gli sforzi fatti fin qui dalle istituzioni turche, rimane però un tema ancora poco discusso perché avvenga un reale cambiamento nella società. di Luca Bellusci Quella turca è una società prettamente patriarcale, dove il ruolo dell’uomo è predominante e quello della donna è legato a una concezione che va aldilà del discorso religioso e affonda le proprie radici in tradizioni, usanze e culture molto antiche. La figura della donna e le ambiguità sulla Turchia TURCHIA: BUONE LE PREMESSE, MODESTI I RISULTATI Negli anni società, Islam e politica hanno avuto modo di integrarsi, fondendosi nel tessuto sociale turco, grazie soprattutto alla forte impronta kemalista (laica) che le istituzioni hanno saputo conservare nel tempo. Oggi la condizione della donna è lo specchio di un paese che ha enormi potenziali di crescita, un’economia consolidata e un ruolo internazionale di primo piano, ma che al tempo stesso subisce duri contraccolpi sul piano delle politiche sociali e del rispetto dei diritti civili. Secondo le valutazioni internazionali, nella lotta alla discriminazione e alla violazione dei diritti delle donne la Turchia si colloca al 124esimo posto su 135 (Global Gender Gap Report). Nell’ultimo rapporto (2012) della Commissione Europea sui progressi per raggiungere la piena adesione nell’Unione, la parte dedicata ai diritti delle donne è molto chiara e parla di “violenza sessuale, violenza domestica, discriminazioni sul lavoro, delitti d’onore e matrimoni forzati”, tutti elementi ancora molto presenti all’interno della società turca. Dei 35 capitoli inerenti le riforme strutturali che Ankara dovrebbe attuare per una completa adesione all’UE, mancano quelli più importanti, come la riforma del sistema giuridico e il rispetto delle libertà personali e dei diritti civili, secondo gli standard dettati da Bruxelles. La legislazione e i reati connessi Il riconoscimento dell’uguaglianza tra generi è sancito dall’art.10 della Costituzione turca, che vieta ogni forma di discriminazione in base al sesso, mentre il n.41, rivisto di recente, sancisce che la famiglia è fondata sull’uguaglianza dei due coniugi. Esistono perciò quelle premesse giuridiche su cui lavorare per armonizzare la legislazione nazionale con i principi riconosciuti dalla comunità internazionale a protezione della donna. Inoltre, nel marzo di quest’anno è stata ratificata da Ankara la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e lotta alla violenza domestica e sulle donne (Stop Violence Against Women). Le organizzazioni a protezione della donna Pur essendoci grandi disparità di genere, la Turchia si contraddistingue per la vivacità della sua società civile, in grado talvolta di essere foto di Simona Ghizzoni 8 | speciale donne precursore di importanti cambiamenti sociali. Tra le varie associazioni che lavorano da anni per il rispetto dei diritti della donna, ci sono la KA.DER e la CATOM, due organizzazioni nate nella seconda metà degli anni ’90. KA.DER mira ad aumentare il numero delle donne in politica e nelle posizioni decisionali, in modo da realizzare una pari rappresentanza di donne e uomini. L’associazione ritiene che le diverse esperienze e le capacità delle donne dovrebbero riflettersi anche nelle questioni sociali e politiche. Per quanto riguarda invece la rete dei centri CATOM, essi costituiscono una parte centrale degli sforzi dello Stato turco per la promozione di istruzione, equità sociale e di genere, e la partecipazione delle popolazioni locali. Questi centri sono perlopiù presenti nel sud est turco, notoriamente meno sviluppato del resto del paese, e hanno un importante ruolo nel cercare di rompere quelle antiche usanze, ancora presenti soprattutto nelle regioni curde, che vogliono il ruolo della donna relegato esclusivamente al mantenimento della famiglia. www.osservatorioitaq.it | 9 www.osservatorioitaq.it | 11 10 | speciale donne TURCHIA Cambiare si può: incontro con Pervin Chakar ragazze che hanno difficoltà a realizzare i propri sogni e troppo spesso scelgono professioni che rientrano nei piani dei propri genitori. Come vengono trattate le donne che studiano? Intervista a Pervin Chakar, giovane soprano di origine curda che del suo lavoro ne ha fatto una missione: “Vorrei essere la voce del mio popolo per la pace – dice – e unire i popoli con la mia musica”. Pervin vive e lavora in Italia, ma non dimentica gli sforzi compiuti per affermare i propri diritti, sia come curda che come donna. di Luca Bellusci Mia madre è stata costretta a lasciare gli studi. Mio nonno non voleva mandarla a scuola. Il suo compito era quello di sposarsi e fare figli. È solo dopo aver incontrato mio padre che ha potuto diplomarsi alla scuola serale. Sono tante le ragazze che vengono private di un’educazione, molte dopo aver frequentato la scuola elementare abbandonano gli studi. Le famiglie sono numerose e alcuni uomini hanno anche due o tre mogli, e considerano i figli una grande ricchezza. Avresti fatto carriera anche in Turchia? Le donne hanno le stesse possibilità degli uomini? In Turchia ci sono soltanto sei teatri d’opera. Per un anno mi sono esibita ad Ankara, dato che vengo dalla parte curda del paese, dove ci sono solo teatri di prosa. Poi mi sono trasferita in Italia. La lirica non appartiene propriamente alla nostra cultura, ma quando l’ho scoperta ho deciso che sarei diventata una cantante. In Turchia i tempi stanno cambiando, anche se nei villaggi nulla sembra mutare. Qui la pressione delle famiglie e dei padri è ancora molto forte. Sono diverse le associazioni che si stanno adoperando per la difesa dei diritti delle donne, come dimostra il progetto Kardelen, che ha lo scopo di sensibilizzare le famiglie sull’istruzione delle proprie figlie. Alla fine i miei genitori hanno accettato che io intraprendessi questa strada, anche se convincerli non è stato semplice. Tutto è iniziato quando ho vinto un concorso letterario nel mio liceo e sono andata a ritirarlo proprio ad Ankara. Il presidente del concorso che era a conoscenza dei miei studi di musica mi chiese di cantare un pezzo a mia scelta. Senza averne una conoscenza approfondita scelsi di eseguire il ‘Ich liebe dich’ di Beethoven. Finita l’interpretazione, il preside mi chiese se conoscevo il soprano Maria Callas, e non sapendo chi fosse decise di regalarmi un suo cd. Fu così che decisi di diventare una cantante lirica. Quante sono le difficoltà per chi vuole denunciare la violenza domestica? Purtroppo quando le donne hanno paura non denunciano la violenza subita. Questo accade soprattutto quando una donna non è economicamente indipendente dal marito. Bisogna essere molto forti e lottare contro le ingiustizie. Vorrei essere la voce del mio popolo per la pace e unire i popoli con la mia musica. Quale è il ruolo della famiglia rispetto ai diritti della donna? L’uomo è una figura centrale nella famiglia turca. È infatti lui a mantenere moglie e figli, mentre la donna è costretta a rimanere a casa per accudire la prole. I tempi stanno cambiando e i giovani studiano. Grazie all’istruzione, le donne possono riscattarsi e avere il diritto di esprimere le proprie opinioni. Mio padre è un insegnante, mia madre una casalinga. Io ho avuto la possibilità di esprimermi anche se con fatica. Purtroppo sono molte le voci dal campo voci dal campo 12 | speciale donne www.osservatorioitaq.it | 13 Nonostante la fama di paese pionieristico per i diritti dello donne, oggi non ci sono che quattro seggi rosa nel Parlamento libanese mentre il sessismo continua ad essere istituzionalizzato a livello normativo. Secondo la legge, le donne non possono trasmettere la propria cittadinanza ai figli e la violenza di un marito non si chiama stupro. LIBANO: SE LE DONNE SONO CITTADINE A METÀ di Elisa Piccioni Nel panorama mediorientale, il Libano è stato a lungo considerato un’ isola felice di libertà ed emancipazione per le donne. Benché pionieristico nel concedere loro diritti economici, civili e politici (come il diritto di voto nel 1953, quello ad essere elette nei consigli locali nel 1963 e a praticare il commercio senza il permesso dell’uomo nel 1994), il paese dei cedri mantiene un sistema normativo retrogrado per quanto riguarda i diritti delle donne. Se paragonate alle sorelle dei paesi vicini, molte libanesi godono di una maggiore libertà sessuale, hanno un ampio accesso al mercato del lavoro e si intrattengono nei locali della città fino a tarda ora. Ma sotto il trucco e la chirurgia estetica permangono le catene di una cultura feudale e patriarcale sostenuta dalla maggioranza dei leader religiosi. Così, nonostante a livello costituzionale sia sancita l’uguaglianza tra i due sessi, la donna gode di limitati diritti di cittadinanza e non ha diritto ad essere protetta dalla violenza domestica. La discriminazione più eclatante è rappresentata dall’impossibilità di trasmettere la propria nazionalità al marito o ai figli. Se una libanese sposa uno straniero, i loro figli non saranno considerati libanesi e, di conseguenza, sarà per loro molto difficile accedere a servizi fondamentali come l’istruzione e l’assistenza sanitaria. La legge sulla nazionalità, che contraddice molte convenzioni internazionali firmate dal Libano, è un retaggio del periodo mandatario, durante il quale il vecchio codice napoleonico francese andò a sostituirsi alla legge ottomana, che invece riconosceva alle donne pieni diritti di cittadinanza. Da anni le associazioni per i diritti delle donne si battono per modificare questa disposizione. Nel marzo 2012 per la prima volta il progetto di legge è entrato nell›agenda di governo, ma il comitato competente non si è ancora espresso ed è difficile credere che lo farà a breve. Tra le ragioni del perdurare di questa legge, vi è la paura che permettendo alle donne di trasmettere la propria nazionalità al coniuge, centinaia di migliaia di rifugiati (soprattutto palestinesi, ma oggi anche siriani) verrebbero naturalizzati, sconvolgendo così i precari equilibri confessionali sui quali si regge il paese. L’umiliazione per la donna non finisce qui. Dentro le quattro mura la situazione non migliora. Il parlamento ha infatti rifiutato più volte di foto di Simona Ghizzoni 14 | speciale donne eliminare la riserva sull’articolo 16 della Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro la donna (CEDAW), che sancisce l’eguaglianza tra i due sessi all’interno della dimensione familiare. Qui ad essere messi in discussione sono anche i più basilari diritti di una donna sul proprio corpo: se infatti il matrimonio è sempre ‘sacro’ (le unioni civili in Libano non sono permesse), non per forza è sicuro per la sua salute e incolumità fisica. “In Libano non c’è una legge contro la violenza domestica. Mi ricordo che da piccola sentivo il mio vicino di casa picchiare sua moglie e i suoi bambini, ma mia madre mi diceva che non potevamo fare niente, che erano affari di famiglia”, racconta l’attivista Farah Kobaissy, che insiste: “Avrebbe potuto ucciderla, ma non erano affari nostri. Questo tabù non è più accettabile.” Nell’aprile del 2010 il Consiglio dei ministri ha approvato un progetto di legge contro la violenza domestica proposto da alcune organizzazioni, tra cui l’Ong Kafa (“basta” in arabo). Il progetto di legge è stato però emendato più volte dalla commissione parlamentare che lo ha svuotato della sua essenza originale, fino all’ultima uscita dei suoi membri che, incapaci di mettersi d’accordo, hanno convenuto su una cosa: non esiste stupro all’interno di una coppia sposata. La commissione ha quindi deciso lo scorso dicembre di rimuovere la clausola che puniva il reato di violenza sessuale tra i coniugi. “Non esiste qualcosa chiamato ‘stupro tra marito e moglie”, ha spiegato Imad Hout in quell’occasione al Daily Star – “Si tratta di costringere qualcuno con la forza ad avere rapporti”. Queste dichiarazioni suonano come se le conseguenze della violenza carnale sulla donna, in termini di trauma psicologico e fisico, non fossero le stesse se commesse all’interno del vincolo matrimoniale. Secondo le stime dell’associazione Kafa, almeno tre quarti delle donne libanesi avrebbe subito, almeno una volta, violenza domestica. Tra queste, circa l’80% sarebbero vittime di stupro coniugale. L’accertamento degli episodi di violenza domestica è inoltre disciplinato dal discusso articolo 26, aggiunto alla legge dalla Commissione. In caso di denuncia, i tribunali religiosi hanno il compito di valutare in via preliminare se vi sia stata o meno violenza. E solo dopo il giudizio finale viene deferito al tribunale civile. www.osservatorioitaq.it | 15 La legge sullo Statuto personale dipende infatti dall’affiliazione religiosa. Ed è così che esistono almeno quattro differenti codici per i musulmani, sei per i cattolici e tre per i cristiani greco-ortodossi. Come denunciato dalla Freedom House, ognuno di questi contiene disposizioni discriminatorie contro la donna. “Ancora una volta si sta dando ai tribunali religiosi il privilegio di definire quando si tratti di violenza. Questo è un nuovo attacco allo stato civile in Libano. Tenere le donne sotto le leggi comunitarie, vuol dire tenere tutta la famiglia e dunque tutta la società sotto questo sistema”, spiega Farah, membro del collettivo femminista Nasawiya. Per difendere il diritto di scelta sul proprio corpo, lo scorso settembre il collettivo ha lanciato una battaglia per la legalizzazione dell’aborto, che è ammesso da una legge del codice penale francese del 1943 solo se può salvare la vita della donna. Chi trasgredisce rischia fino a 3 anni di carcere. Questa proibizione, sostenuta ancora una volta dai leader religiosi (in particolare quelli cristiani) non ha fatto altro che alimentare l›aborto clandestino che, nonostante la mancanza di adeguate misure di sicurezza, può arrivare a costare fino a 3000 dollari. In occasione della Giornata internazionale per i diritti della donna, quattro importanti leader religiosi, sia musulmani che cattolici, hanno prestato il proprio volto a una campagna organizzata dalla Ong ABAAD per promuovere i diritti delle donne in Libano. La loro faccia è così apparsa in spot televisivi, sui principali quotidiani e su cartelloni pubblicitari diffusi nelle strade di tutto il Libano con la scritta “nu’aman” (“noi crediamo”) seguita da dichiarazioni contro la violenza sulle donne. 16 | speciale donne www.osservatorioitaq.it | 17 LIBANO Migliorare la condizione della donna, “liberando” l’uomo Per combattere la violenza sulle donne l’associazione ‘Abaad’ apre il primo Cento per uomini in Libano. Lo scopo è di offrire assistenza psicologica a chi ha comportamenti violenti, di coinvolgere l’uomo nella difesa dei diritti delle donne e, infine, di ricordare che sconfiggere il sistema patriarcale vuol dire anche sfidare i pregiudizi sulla mascolinità. di Elisa Piccioni Risultato di una cultura fortemente feudale e patriarcale, il sessismo in Libano è istituzionalizzato nella società a livello normativo. La donna libanese è portatrice di limitati diritti di cittadinanza e la violenza domestica non è presa seriamente in considerazione dal sistema giuridico che, al contrario, riconosce il corpo della donna come proprietà esclusiva del marito. Le associazioni per i diritti delle donne si battono da anni per tentare di migliorare il sistema legislativo, ma le campagne hanno avuto finora un successo limitato (l’ultima a fallire quella per il riconoscimento dello stupro maritale). Se le norme giuridiche sono lo specchio di quelle sociali, vuol dire che c›è ancora molto da lavorare a livello culturale ed educativo. L’associazione ‘Abaad’, in collaborazione con l’International medical corps e l’Arab foundation for freedoms and equality, sta provando a cambiare strategia lanciando una campagna innovativa volta a coinvolgere attivamente l›uomo nella promozione dei diritti della donna. Ed è così che ha aperto il primo ‘Men Center’ del Libano. Intervista ad Antony Keedi, responsabile del progetto Engaging men & boys in gender equality per ‘Abaad’. Come nasce l’idea di coinvolgere gli uomini nella lotta contro la violenza sulle donne? Un errore frequente è quello di concentrasi esclusivamente sull’emancipazione della donna e di non coinvolgere l’uomo nel voci dal campo processo. I movimenti femministi, soprattutto in Medio Oriente, non sempre hanno saputo indirizzarsi agli uomini e farli partecipi delle loro battaglie. Raggiungerli è fondamentale per capire, ad esempio, da dove viene la violenza. L’uomo non va pensato solo come colui che la perpetua, il suo ruolo è molto più ampio ed è su questa convinzione che si concentra il lavoro di ‘Abaad’. Quale è quindi il ruolo del l’uomo nella promozione dell’uguaglianza di genere? Il nemico dei diritti delle donne non è l’uomo. Il nemico dei diritti delle donne è il sistema patriarcale, e anche gli uomini sono parte di questo sistema. È questo che dobbiamo avere in mente se vogliamo pensare alle questioni di genere in senso olistico. Il “genere” non è soltanto femminile, ma anche maschile. Gli uomini sono cresciuti nel sistema patriarcale così come le donne ed entrambi i sessi vengono educati in un modo volto a mantenere questo sistema intatto. I movimenti per le donne hanno fatto un lavoro eccezionale nel combattere questo sistema per le donne. Ora dobbiamo trovare il modo di combatterlo anche per gli uomini e dalla prospettiva maschile. Come è possibile combattere questo sistema? Pensiamo ad esempio ai giochi preferiti dalle bambine. Fin dall’inizio sono educate in un determinato modo: viene insegnato loro che la società si aspetta che siano belle, non necessariamente ambiziose ma sostenute dall’uomo, e che vogliano una famiglia. Lo stesso vale per gli uomini: i loro giochi da piccoli sono spesso violenti e competitivi. L’uomo, soprattutto in questa regione, non può piangere perché deve essere emotivamente freddo, forte e dominante. Deve lavorare e portare i soldi a casa. Se c’è una guerra poi, deve trasformarsi anche in un guerriero. Quello che i movimenti femministi hanno fatto è stato di dire alle donne che questa educazione è sbagliata. Tu puoi essere bella o non bella, puoi avere ambizioni o no, volere una famiglia o no, ma deve essere sempre una tua decisione. Così come le tue aspirazioni non devono essere imposte dalla società. E gli uomini? Il pregiudizio sui caratteri della mascolinità non è stato rotto. Così da un lato abbiamo una società in cui le donne cominciano ad essere voci dal campo 18 | speciale donne educate ad avere ambizioni, a rompere questo sistema. E dall’altro lato uomini che non sanno più quale sia la loro identità, il loro ruolo nella società. In questo processo c’è una mancanza di comunicazione. Se stai studiando o lavorando, allora chi guarda i bambini o pulisce casa se gli uomini sono ancora attaccati al loro ruolo tradizionale? www.osservatorioitaq.it | 19 in cui educhiamo al femminismo e alle pari opportunità. Il progetto più innovativo è stato però l’apertura di un Centro per uomini in cui offriamo terapie psicologiche individuali gratuitamente e un numero verde attivo 24 ore. Inoltre, abbiamo progetti specifici con i rifugiati, che qui in Libano sono molti e affrontano situazioni di stress molto difficili, che a volte si traducono in violenza domestica. Come rompere i pregiudizi sulla mascolinità obbligatoria? Come affrontate il tema della violenza con i pazienti e come reagiscono? Lavorare sul dialogo e sulla comunicazione è fondamentale. Molti studi nella regione hanno confermato che davvero l’uomo crede che non sia suo compito quello di esprimere i sentimenti e parlare dei suoi problemi. Ma questo non è sano. In Libano molto spesso capita di vedere uomini litigare per motivi stupidi, come il traffico. Questo comportamento è sciocco, ma quando accumuli un’alta quantità di stress senza avere modo di sfogarti, magari parlandone, queste reazioni diventano comprensibili. L’uomo è stato educato ad essere dominate, quindi quando si scontra con un altro sente la sua mascolinità minacciata e diventa violento. Bisogna discutere e riflettere sul modo in cui siamo cresciuti. È illogico dire ad un essere umano che non deve avere una carriera, ma stare a casa. È però altrettanto illogico dirgli che se porta a casa i soldi allora vale, altrimenti no. Ecco, questo fa parte di quella concezione dell’essere uomo che dobbiamo rompere, così come abbiamo fatto per le donne. In generale è molto difficile per un uomo ammettere di essere violento. La maggior parte non è neanche in grado di riconoscerlo. Quello che noi facciamo è discutere sulle situazioni di stress che generalmente si affrontano nella vita quotidiana in famiglia, a lavoro e nella società e su come queste situazioni possano portare a comportarsi in modo sbagliato, magari sfogandosi su chi è vicino. Se l’uomo si comporta violentemente e abusa, deve prendersi le sue responsabilità e cambiare perché sta violando i diritti di un’altra persona. Ma per aiutare davvero, è necessario capire davvero. Dobbiamo comprendere che anche l’uomo è parte dell’ordine patriarcale e può esserne vittima allo stesso modo. Per migliorare il sistema dobbiamo coinvolgerlo in questo processo di cambiamento. In Libano la molestia sessuale in strada, spesso verbale e a volte anche fisica, è molto diffusa. Perché? Sicuramente abbiamo bisogno di leggi che proteggano le donne e una maggiore risposta da parte dell’autorità giudiziaria. Ma le leggi in ogni società rappresentato le norme sociali vigenti. Per cui la risposta è nel sistema patriarcale e nella mancanza di rispetto per la donna a livello sociale, per cui la molestia sessuale non è vista come un problema. Dobbiamo cambiare il modo in cui gli uomini percepiscono sé stessi e le donne se vogliamo davvero vedere le cose cambiare. Noi crediamo che non bisogna combattere l’individuo, ma il sistema. Cosa è il Men Center? In generale organizziamo workshop con uomini e ragazzi sulla gestione della violenza e dello stress e abbiamo sessioni di discussioni voci dal campo voci dal campo www.osservatorioitaq.it | 21 20 | speciale donne Quella delle donne palestinesi è una storia fatta di partecipazione politica, attivismo, coraggio. Ma anche della doppia sfida contro occupazione e patriarcato. Un excursus nella storia degli ultimi anni, conversando con Luisa Morgantini. PALESTINA: L’INTIFADA DELLE DONNE, TRA OCCUPAZIONE E PATRIARCATO di Cecilia Dalla Negra “Sin dalla fine degli anni Ottanta, quando noi internazionali andavamo in Palestina, ricordo che le donne ci mostravano con orgoglio vecchie foto di altre palestinesi che lottavano per proteggere la propria terra prima ancora dei moti del 1929. La loro è una storia segnata dalla lotta contro molte oppressioni: il sionismo, il furto della terra e l’occupazione militare, da una parte; una società nel complesso conservatrice e patriarcale, dall’altra. E dalla fine degli anni Ottanta, anche contro le campagne moralizzatrici di Hamas”. Luisa Morgantini è un nome storico dell’attivismo femminista e pacifista. Potrebbe essere sintetizzata così, nelle sue parole, la storia delle donne palestinesi, del loro movimento per la liberazione di genere, sempre affiancato – e talvolta oscurato – da quella più impellente, urgente e immediata per la liberazione nazionale. Un doppio binario sempre costante, due facce di una stessa lotta per i diritti e la libertà. La storia del movimento femminile palestinese è diversa da quelle che attraversano i paesi del Maghreb, del Mashrek, del Sud del mondo e dell’Europa: perché si scontra con le chiusure della società, con il patriarcato della tradizione, e con il ricatto dell’Occupazione militare. Una storia diversa, che affonda le sue radici lontano nel tempo. Alle origini del movimento femminile È il 1921 quando nasce la Palestine Women Union (Pwu): il primo tentativo di unire al lavoro sociale femminile una vocazione più politica, strettamente legata ai temi del nascente movimento nazionalista. Pochi anni dopo, nel ‘29, a Gerusalemme si svolge il primo Congresso delle Donne Arabe di Palestina: l’obiettivo è sostenere il movimento per l’indipendenza nazionale, opporsi alla dichiarazione Balfour e dare vita ad una rete di associazioni femminili. Che la lotta nazionale e quella per l’affermazione di genere andassero di pari passo lo aveva intuito quello shaykh Izz al-Din al-Qassam di cui i movimenti islamisti recenti hanno conservato il nome. “E solo quello, ignorando l’essenziale del suo metodo, fondato sull’inquadramento di tutta la popolazione, uomini e donne”. Siamo nel 1936, la rivolta contro l’immigrazione sionista in Palestina cresce, e al-Qassam tenta di mobilitare gli strati sociali più colpiti dal mandato britannico. Consapevole dell’importanza di avere le donne dalla sua parte, lo shaykh si rivolse alle giovani con corsi di politica, religione e formazione militare, organizzando l’alfabetizzazione femminile e creando gruppi d’azione, “le compagne di Qassam”. L’idea “era quella di mobilitare ogni 22 | speciale donne componente della società per resistere” (1). Ed è proprio la situazione ‘emergenziale’ che va a crearsi nel ’36 ad imporre una prima sfida, tutta femminile, all’ordine sociale vigente. Da una parte la partecipazione attiva delle donne alla lotta armata, nelle campagne; dall’altra il lavoro di assistenza sociale delle componenti dell’alta borghesia nel contesto urbano. Il precipitare degli eventi verso la al-nakba, la ‘catastrofe’ palestinese, condurrà anche il movimento femminile alla gestione della contingenza: una storia che in questi anni sarà fatta di espropri, esilio, campi profughi in cui tentare di tenere insieme nuclei familiari sradicati e devastati dalla violenza dell’aggressione sionista. Il 1965 è l’anno che vede la formazione della Unione Generale delle Donne Palestinesi (GUWP), che ha come obiettivo il coinvolgimento femminile nella lotta per la liberazione nazionale sotto il cappello di una OLP appena nata. Il 1967 porta con sé la Guerra dei Sei Giorni e una nuova ondata di violenze, con l’Occupazione israeliana che penetra nelle case e nelle vite dei palestinesi, provocando mutamenti sociali importanti. Sono tutti i membri delle famiglie ad essere politicizzati: donne e bambini inclusi. La crisi economica e la mancanza di impiego portano le donne ad affacciarsi sul mondo del lavoro. Se fino a questo momento gran parte dell’impegno femminile è ancora molto più sociale che politico, è nel corso degli anni ’70 che si assiste ad una svolta, con la nascita degli Women’s Committees, su iniziativa di un’avanguardia di giovani attiviste, laiche e progressiste, che si pongono come obiettivo politico, oltre alla liberazione nazionale, la parità di genere. La partecipazione politica delle donne è già cambiata. www.osservatorioitaq.it | 23 diversi fra loro, accomunando città e campagna, nomadi e sedentari, uomini e donne; enfatizzando nuclei di consapevolezza preesistenti il movimento nazionalista per l’indipendenza si è in effetti – e quasi sempre – intrecciato con i movimenti femministi” (2). Accade così anche nella Palestina aggredita, dove le donne si impongono non solo nella partecipazione attiva alla resistenza, ma anche nella gestione diretta della vita sociale, economica, familiare. Ma sono questi anche gli anni in cui si sviluppa una retorica nazionalista che assimila la donna alla terra perduta, che la vorrebbe ancora moglie e madre prima che attivista. Capace di proteggere gli ‘eroi’ della resistenza, assicurandone la continuità attraverso i figli. È la politicizzazione della maternità, e del corpo della donna: “Si diffondeva questo concetto che la donna dovesse fare figli per il bene del paese, per aumentare le fila della resistenza: anche sul loro corpo si giocava la lotta nazionale: è un aspetto che ricordo come molto presente durante tutta la prima Intifada”, racconta Morgantini. “Anche per questo il dilemma che ha sempre attraversato il movimento femminista era se dovesse venire prima la lotta nazionale o liberazione di genere. In entrambi i campi comunque, in quegli anni, le donne hanno avuto un ruolo determinante. La prima Intifada è stata un’esperienza straordinaria: perché si lottava tutti insieme, non c’erano differenze di sesso. Purtroppo però la lotta di liberazione femminile è passata in secondo piano rispetto alle esigenze nazionali. E intanto nuovi fenomeni andavano affermandosi, come l’ascesa di Hamas”. L’emergere di Hamas. Un richiamo alla tradizione? Il 1988 e la prima Intifada Con l’esplodere della prima Intifada, nel 1988, il protagonismo femminile nella resistenza si fa centrale e dirompente. L’Occupazione e la militarizzazione della vita quotidiana abbattono il confine tra sfera pubblica e privata: la violenza entra nei villaggi, invade le case, tocca quei focolai domestici in cui le donne erano state relegate. È la vita pubblica e sociale nel suo insieme ad essere sconquassata; è l’ordine gerarchico che si ribalta, rompendo gli schemi. Le donne irrompono sulla scena pubblica: scendono in strada, manifestano, organizzano proteste. Si confrontano faccia a faccia con i soldati, entrando a tutti gli effetti nella lotta di liberazione nazionale. Già in passato nel mondo arabo, e non solo “la lotta contro la colonizzazione ha unificato strati e ambienti sociali profondamente Il 1988 è infatti anche l’anno in cui si afferma il movimento islamico di resistenza, Hamas. Di fronte alla distruzione di una società scossa alle basi, all’espropriazione della terra, alla negazione dell’ identità collettiva, cresce il bisogno di cercare radici comuni, proteggere la comunità dalle minacce esterne, attraverso il richiamo all’ordine e alla ‘tradizione’. Una spinta che assume la forma dell’islamismo di Hamas. “Sono molti gli elementi che entrano in gioco nella diffusione della sua ideologia”, spiega Morgantini. “La necessità di rivendicare la propria identità di fronte al nemico invasore, unita alla capacità del movimento di penetrare nel tessuto sociale attraverso una rete di aiuto diretto alla popolazione stremata, e al quadro generale dell’epoca. Non è un caso che la sua ascesa avvenga in un contesto di rinato vigore religioso in tutta la regione mediorientale, da quando ha iniziato a farsi spazio la retorica dello ‘scontro di civiltà’. Nella tradizione palestinese l’identità 24 | speciale donne nazionale veniva prima di quella religiosa: il velo delle donne era quello bianco, delle contadine. Oggi portarlo è anche una forma di ribellione, l’affermazione di un’identità negata”. Nel 1988 Hamas lancia la campagna per l’imposizione forzata dell’hijab e del soprabito per le donne. “Una forma di controllo politico e una prova di forza nei confronti della leadership nazionalista che sta guidando l’Intifada”, secondo Morgantini. Attraverso il tentativo di ricostruire una ‘tradizione perduta’, che perduta non è perché mai è esistita. Un percorso avviato già nei primi anni ’70 a Gaza, con la creazione del Congresso Islamico (Mujama) dello sheykh Yassin, per legare la partecipazione politica all’appartenenza religiosa. “La questione non verte sul vestito delle donne, ma su quale movimento stia per assumere la guida della lotta nazionale”, scrive l’antropologa palestinese Rema Hammami. “Lasciar passare questa spinta identitaria e sottovalutarne la portata è stato un errore: all’epoca molte donne hanno preferito poggiare un velo sui capelli perché era più semplice, pensando che non fosse importante. Invece ha prodotto un mutamento nella mentalità”, sostiene Morgantini. Il passaggio-Oslo e il ‘copione’ algerino Con il protrarsi della crisi e la necessità di sedersi al tavolo delle trattative la resistenza subisce un arresto: il confronto da popolare si fa diplomatico, e lascia fuori le donne. A Oslo arriveranno solo in tre: Suad Amiry, Hanan Ashrawi e Zaira Khamal, leader del Fronte Democratico e storica militante femminista. Come ricorda Morgantini “era lei che ci raccontava il doppio fronte della lotta palestinese. Che ci parlava del timore di replicare lo schema algerino: ‘non vogliamo tornare a casa finita la battaglia’, spiegava”. Il lavoro di questi anni è dunque tutto concentrato a costruire una società in cui lo spazio delle donne non sia ridotto. “Oslo ha avuto effetti anche positivi. Penso ai tentativi di modificare le leggi, alla costruzione di un ‘parlamento ombra’ delle donne cui si è lavorato per anni, come all’impegno nella ricerca accademica: le donne, pur con molte critiche verso Oslo, puntavano su un percorso di crescita e sulla costruzione di un’agenda politica finalmente libera dall’Occupazione e dal patriarcato”. Il dopo-Oslo, però, imprime una svolta negativa. Non è il ‘modello algerino’ ad andare in scena, secondo Morgantini. Piuttosto “l’Occupazione è diventata meno visibile ma molto più forte: subentrano i check point, la libertà di movimento è ridotta in modo sempre più penetrante. La www.osservatorioitaq.it | 25 frammentazione non è stata solo territoriale, ma anche umana: i rapporti tra gruppi di donne nelle diverse città si sono interrotti. L’Occupazione, lentamente, ha forgiato la vita delle persone”. L’Intifada al-Aqsa, che scoppia nel 2000, è completamente differente rispetto alla prima. “E’ stata la sua militarizzazione a tagliare fuori le donne, a rendere impossibile la loro partecipazione”. La feroce repressione che ne è scaturita ha lasciato ferite ancora aperte, macerie ancora da raccogliere. La società si è chiusa su se stessa, la popolazione, dopo anni di violenze, è rimasta stremata. Le rivendicazioni di genere sono scivolate lentamente in un angolo. “Hamas ha preso il sopravvento, così come il sentimento religioso: quando la disperazione si diffonde non resta molto, oltre a Dio. Quando hai centinaia di uccisi, feriti, imprigionati e menomati dalla guerra c’è poco spazio per rivendicare i tuoi diritti di donna”. L’attualità Oggi l’Occupazione non è cessata, ma di recente dalle donne sono arrivati segnali importanti. Alle ultime elezioni amministrative sono state tante le liste femminili a presentarsi. Vera Baboun, a Betlemme, è diventato il primo sindaco donna. I centri anti-violenza si sono moltiplicati, così come le associazioni che si occupano di assistenza ed empowerment femminile. Un attivismo “nuovo”, secondo Morgantini, “non più legato alle vecchie formule dei partiti: è un movimento senza appartenenze, molto radicale. Gruppi piccoli e ancora giovani che cercano di rivendicare spazi e diritti. Trovando una collaborazione non ancora sufficiente, ma comunque importante, da parte del governo dell’Anp. E molto meno a Gaza”, dove l’attivismo femminile rappresenta spesso il solo argine alla carneficina sociale causata dall’assedio israeliano. È ancora sui loro corpi che oggi si combatte la battaglia. Nel tentativo di emergere, di conquistare spazio e rivendicare diritti presso la propria società; e in quello di resistere alla disumanità dell’Occupazione. Sono ancora loro le vittime di una doppia oppressione; loro a caricarsi il peso di ciò che resta quando tacciono le armi. In un panorama di devastazione, la sfida delle donne palestinesi è ancora in campo: “Battersi per i loro diritti, non tornare indietro”, commenta la nostra interlocutrice, che ci ha accompagnati in questo excursus storico. (1) Jad Islah, “Le donne palestinesi e i movimenti islamisti”, Birzeit University, Palestina (2) da Ada Lonni, “Femminismo e lotte di liberazione nei paesi araboislamici”, l’Harmattan, 2002. www.osservatorioitaq.it | 27 26 | speciale donne PALESTINA Le donne di Gaza continuano a lottare Sovraffollamento, isolamento, disoccupazione sull’orlo dell’80%, povertà diffusa. Una situazione sociale al collasso, in declino costante dal 2007. Se la Striscia di Gaza sembra vivere in assenza di prospettiva, conosce però innumerevoli forme di resistenza civile. Il racconto di due attiviste impegnate nei centri di sostegno alle donne nati in seguito alla prima Intifada. di Cecilia Dalla Negra Nella Striscia di Gaza assediata dal cielo, dalla terra e dal mare, vive una popolazione capace di non arrendersi. Di organizzarsi, per aggirare controlli e Occupazione, ricostruire dalle macerie, fornire dal basso quelle forme di assistenza e cooperazione che l’assedio israeliano vorrebbe negare. È in questa Gaza – un milione e mezzo di persone concentrare in 360 km quadrati, una tra le aree più densamente popolate del mondo che le donne si sono auto-organizzate, dando vita a centri di sostegno capaci di rispondere ad alcune esigenze primarie, ma anche di lavorare sul livello di consapevolezza femminile all’interno di una società in cui rivendicare spazi non è scontato. Nati in seguito alla prima Intifada per fornire assistenza sanitaria, migliorare i livelli di salute femminile e lavorare contro una violenza di genere diffusa, i centri hanno rappresentato dopo l’operazione militare “Piombo Fuso” (2008-2009) e la stretta intorno ai confini della Striscia un argine al declino delle condizioni sociali della popolazione. Feryal Thabet e Mariam Shaqqura ne dirigono due, in alcune tra le aree più difficili della zona: il campo profughi di el Bureij e quello di Jabalia, pochi chilometri quadrati e migliaia di persone. “Rivendicare uguaglianza e parità quando non ci sono riconosciuti neanche i fondamentali diritti umani non è facile”, raccontano. È una storia di resistenza civile e quotidiana la loro, che lottano per fornire assistenza di base a una popolazione stremata dall’assedio, all’interno di una società patriarcale che non sempre comprende il loro lavoro. voci dal campo Che consiste, principalmente, nello sviluppare le condizioni di salute generali della popolazione “attraverso un approccio comprensivo, che includa sia l’assistenza medica, psicologica e sanitaria alle donne, che quella legale e sociale”. Perché se le donne rappresentano una delle categorie maggiormente colpite dagli effetti dell’occupazione, un’azione importante è anche quella “diretta contro la discriminazione all’interno della società”, spiegano queste due attiviste, che come molte altre hanno faticato a lungo “per coinvolgere i leader delle nostre comunità, perché accettassero e rispettassero il lavoro che svolgiamo. Non sempre è scontato”. Quando si domanda loro perché questo lavoro sul territorio è così importante, restituiscono tutta la complessità della situazione in cui si trovano a vivere: “C’è l’assedio imposto da Israele, che ha un impatto negativo su tutti gli aspetti della nostra vita. Ci sono problemi pratici come l’assenza di energia elettrica, di medicinali e di risorse per fornire l’assistenza medica e sociale basilare alla popolazione. Ma tutto questo ha anche un effetto devastante a livello psicologico. Quando una società è costretta a chiudersi su se stessa i fattori di deterioramento e rischio per le categorie più esposte aumentano, e le prime a farne le spese sono le donne”. Una condizione che, nel corso degli ultimi anni, è costantemente peggiorata. “Sia dal punto di vista sanitario – con un aumento delle patologie femminili, degli aborti e del livello di salute – sia da quello psicologico e sociale”, raccontano. “A causa del conflitto interno tra Hamas e Fatah non abbiamo indicatori ufficiali – spiegano Feryal e Mariam - ma il peggioramento è tangibile. Su tutto questo noi cerchiamo di intervenire”. Il permanere dell’assedio israeliano ha finito per entrare nella vita quotidiana della popolazione di Gaza, modificando gerarchie, assetti sociali, strutture. E anche il ruolo della donna all’interno della società. Le stime ufficiali parlano di un’occupazione femminile ferma all’11%, ma soprattutto di una mancanza di impiego maschile molto diffusa, così come le detenzioni di lungo periodo. “Fattori radicali, che hanno comportato mutamenti sociali importanti – spiegano. Sono le donne e i bambini a dover trovare fonti di sussistenza, accettando forme di lavoro subordinate. Le vecchie dinamiche di genere si sono spezzate, l’uomo ha perso la propria centralità familiare con un aumento della conflittualità interna e della violenza domestica. D’altra voci dal campo 28 | speciale donne www.osservatorioitaq.it | 29 parte le donne stanno acquisendo maggiore consapevolezza delle proprie capacità e dei propri diritti. Sono aumentati i divorzi, ma anche le iscrizioni femminili all’università: hanno capito che il loro posto non è necessariamente ai fornelli, che hanno la capacità di contribuire allo sviluppo del nucleo familiare”. Feryal e Mariam, come le loro colleghe impegnate nel lavoro politico e sociale, restano convinte che rivendicare diritti di genere in un paese che non è riconosciuto come tale sia ancora più complesso che altrove. “Ancor prima dei nostri diritti dobbiamo affrontare la questione della rivendicazione di un’identità collettiva. Abbiamo tre livelli di conflitto: quello con Israele, quello interno al nostro governo e quello con una società di stampo patriarcale che non riconosce parità e uguaglianza. Se il governo non controlla neanche i suoi confini nazionali e tutto il settore economico e sociale è in crisi, come si può lottare per l’indipendenza femminile?”, si domandano. Una contraddizione antica ma quotidiana la loro: “Usiamo Facebook, ma siamo costrette a cucinare con la bombola che usavano le nostre nonne”, ironizzano, ma la verità è “che non siamo libere di scegliere neanche cosa comprare al mercato, perché non sappiamo quali merci Israele farà entrare”. Ecco perché il lavoro dei loro centri, così come la determinazione di chi rincorre il sogno di una vita normale, a Gaza, rappresenta “una forma di resistenza quotidiana. Ognuna di noi tenta di migliorare la condizione dei diritti delle donne come esseri umani, che in quanto tali devono essere considerate al pari dell’uomo, avere una rappresentanza dignitosa negli organi decisionali e incidere con la propria visione sulla politica, sull’economia, sulla società”. Su un punto poi sono molto precise: “Sia chiaro – sottolineano – che rifiutiamo di essere considerate solo vittime: la cosa più bella del nostro popolo è la sua capacità di andare avanti nonostante le difficoltà, di trovare soluzioni laddove sembra che non ce ne siano. Le donne di Gaza hanno la capacità di lottare per i propri diritti contro tutte le ingiustizie sociali, nonostante l’Occupazione, l’assedio e le divisioni interne”. voci dal campo voci dal campo www.osservatorioitaq.it | 31 30 | speciale donne «Non riuscivo a capire perché tutte le mie cognate, quando nasceva una femmina in famiglia, non manifestavano nessuna gioia. Poi ho avuto due figlie anche io. E allora ho capito». Donne, spesso poco più che bambine, uccise da parenti, spesso poco più che bambini, per lavar via nel sangue l›onta del disonore. di Marta Ghezzi Le statistiche ufficiali parlano di almeno 20 vittime all’anno. Donne, spesso poco più che bambine, uccise da parenti, spesso poco più che bambini, per lavar via nel sangue l’onta del disonore. Un dato, quello sulle vittime, del tutto relativo, se si considera che prende in considerazione unicamente i casi che arrivano sul tavolo del giudice, e non con quelli che giacciono sul tavolo dell’obitorio. Non riuscivo a capire perché tutte le mie cognate, quando nasceva una femmina in famiglia, non manifestavano nessuna gioia. Poi ho avuto due figlie anche io. E allora ho capito. (M.) Tra i tanti binari paralleli su cui viaggia la Giordania, il più evidente è quello che divide la popolazione tra maschi e femmine. GIORDANIA: MORIRE D’ONORE Negli ultimi anni, mentre il divario di genere si faceva più evidente, alcune voci hanno iniziato a levarsi in protesta. Erano le voci delle tante associazioni per il riconoscimento dei diritti delle donne sorte un po’ in tutto il paese. Voci che diventano cori, e fanno rumore. L’ultimo di questi cori si è levato il 15 novembre scorso, sotto le finestre del palazzo del primo ministro Abdallah Ensour, per chiedere la ratifica della Convention on the elimination of all forms of discrimination against women, CEDAW, delle Nazioni Uniti. La manifestazione, organizzata dell’Arab Women Organization, chiedeva in particolare l’accoglimento degli articoli 9 e 16 sul passaggio di cittadinanza da madre a figlio e sul riconoscimento di pari diritti e doveri tra uomini e donne in materia di diritto di famiglia, eredità, libertà personali. A ritare il freno sulla CEDAW sono da sempre i Fratelli Musulmani dell’Islamic Action Front: in risposta alle dichiarazioni del premier che prometteva una revisione delle norme di accoglimento della convenzione nella legislazione nazionale, l’IAF si è affrettato a promulgare un comunicato in cui chiedeva pubbliche scuse ad Ensour e il rigetto totale della convenzione, contraria alle tradizioni e alla morale del paese. Le questioni di diritto civile segnano un profondo solco tra uomo e donna in Giordania: ad esempio, alle donne sotto i 35 anni non è permesso contrarre matrimonio senza l’assenso di un parente maschio, e ancora, all’uomo è data la possibilità di divorziare senza addurre alcuna giustificazione o senza alcun preavviso oppure di sposare fino a quattro mogli. vignetta di Omar Abdallat 32 | speciale donne www.osservatorioitaq.it | 33 In quest’ottica duale, l’inverno per le madri di famiglia giordane divorziate sarà un inverno ancora più freddo, questo. In questo caso l’assassino rischia da sei mesi ad un anno di carcere, massimo due. È notizia del 23 novembre che le donne divorziate non potranno accedere ai sussidi stanziati dal governo in compensazione all’aumento dei prezzi decretato a metà mese, in quanto non risultano ‘capifamiglia’: per legge i figli vengono registrati sullo stato di famiglia del padre, e lì restano anche in caso di separazione, indipendentemente dal fatto che vivano o meno con il genitore. Sempre che non intervenga prima, come nel 2011, un’amnistia reale per i reati cosiddetti minori. Come ad esempio i delitti d’onore. Sempre che non sia lui stesso un minore, nel qual caso rischia un periodo di detenzione presso un centro correzionale, con la possibilità che il delitto non figuri nemmeno sulla sua fedina penale. Le donne sono considerate una proprietà degli uomini, i quali sono autorizzati a sbarazzarsene quando e come vogliono. (Lubna Dawany Nimry) Ma è nel diritto penale che la Giordania segna l’abisso in cui lascia cadere le sue stesse figlie, vittime di un onore che pesa sempre e solo sulle loro spalle. Un onore che conta: 98, 99, 100, 340. L’articolo 98 del codice penale prevede una riduzione di pena per l’omicida condotto al delitto da uno stato di profonda ira o da una condotta pericolosa o illegale da parte della vittima. Gli articoli 99 e 100 contemplano la possibilità per il giudice di applicare fantomatiche attenuanti nel caso in cui la famiglia della vittima rinuci a far causa contro la famiglia del colpevole. Nella maggior parte dei casi, la famiglia che ha armato il colpevole è anche la famiglia che non ha difeso la vittima. L’articolo 340 prevede da una riduzione di pena fino all’annullamento totale della stessa in caso di adulterio commesso dalla moglie o da una parente appartenente al maharem (la cerchia stressa di parenti tra i quali è vietato il matrimonio per consanguineità). Il suo nome si sente ancora più forte, non venendo mai nominato: delitto d’onore. Aveva solo 16 anni e ha partorito un figlio, senza sapere chi fosse il padre, perchè fin dalla prima adolescenza veniva violentata dai cugini. Lo zio, padre degli stupratori, l’ha uccisa per salvare il nome della famiglia da quell’onta. Quella di un figlio al di fuori del matrimonio. In Giordania l’omicidio viene punito con la pena di morte. A meno che non sia commesso da un uomo contro una donna colpevole d’aver anche solo insinuato il sospetto di una condotta immorale. Si stima che circa un quarto dei delitti commessi in Giordania sia ricollegabile a questioni di ‘onore’. A commetterli, nel 68 per cento dei casi, sono i fratelli, nella maggioranza dei casi ancora minorenni. Per far valere le attenuanti è sufficiente il sospetto di condotta immorale. Rana Husseini, giornalista giordana e autrice del libro ‘Murder in the Name of Honour’, best sellers in lingua inglese che ha scoperchiato definitivamente il vaso di Pandora giordano, stila l’elenco delle ragioni addotte dagli assassini e accolte dalla corte: si va dal pettegolezzo, allo stupro, dall’incesto a motivi economici e di eredità, fino all’allontanamento da casa o alla frequentazione con un uomo non gradito alla famiglia. In ogni caso, durante il dibattimento, al convenuto non viene richiesto di produrre alcuna prova, considerando come sufficiente la sua parola, come non viene presa in considerazione alcuna la premeditazione del reato. A 15 anni è stata rapita e violentata per tre giorni e tre notti. Per evitare lo scandalo, suo padre ha acconsentito a darla in moglie al suo aguzzino. Per evitare la galera, il suo stupratore ha acconsentito a prenderla in moglie. La Giordania conta ancora sulla pelle delle sue donne: 308. La legge dello stupro. L’articolo 308 del codice penale giordano prevede che le accuse di violenza carnale decadano nel caso in cui il violentatore acconsenta a sposare la sua vittima. Non è permesso il divorzio durante i primi cinque anni dall’istituzione del vincolo matrimoniale. Lo stupro ai danni di un minore di 15 anni è punito con la pena di morte. Lo stupro poi convertito in matrimonio, non è niente. 34 | speciale donne La revisione della legge sul matrimonio del 2001 ha alzato l’età minima per le nozze ai 18 anni, che possono abbassarsi a 15 in caso di un interesse evidente del minorenne. Come ad esempio nascondere l’onta della violenza carnale. www.osservatorioitaq.it | 35 Noi non abbiamo un’etica. Noi non abbiamo una morale. Noi non abbiamo vergogna. Noi non abbiamo niente. Noi non siamo niente. (Roba Assi) Alcune donne giordane commettono un crimine, scontano la loro pena e poi camminano libere. Altre - alcune colpevoli solo agli occhi delle loro famiglie e della società - finiscono in prigione e non ne escono più. (Rana Husseini) La Giordania continua a dare i numeri: 7. La Legge di Prevenzione del Crimine datata 1954 prevede la possibilità di allontanamento dalla famiglia della donna in pericolo di vita perchè minacciata da un parente o dal marito. Lo Stato, nella figura del governatore e del giudice amministrativo locale, si fa carico della vittima, accogliendola in un luogo sicuro. Il carcere femminile di Jweideh, a sud di Amman. Sono tante ormai le storie di donne che, in cerca di protezione, si sono rivolte alle autorità e in cambio si ritrovano a dover scontare anni di reclusione senza aver commesso alcun crimine. Oppure storie di donne che una colpa ce l’hanno, ed è stata quella di volere un’altra vita. È ancora convita che la accoglieranno a braccia aperte e che la perdoneranno. Intanto è dal 1989 che vive chiusa in un’ala speciale di Jweideh. Aveva tentato di lasciare la Giordania con il ragazzo che amava, scappando da un matrimonio combinato. L’onore ferito della famiglia l’ha raggiunta a pochi passi dal confine, così come 4 dei 22 proiettili esplosi contro di lei dallo zio. All’inizio del 2010 erano una ventina le donne detenute a Jweideh a ‘tempo indeterminato’, senza alcun reato sulla coscenza se non il sospetto (altrui) di condotta immorale. Forse l’ira, o l’ignoranza. Per poter uscire dal carcere un garante di sesso maschile deve versare una cauzione di 5mila dinari (poco di più in euro) più l’assicurazione davanti al giudice di nuocere alla vittima. Promessa che molto spesso non viene mantenuta. Per saperne di più: - Lubna Dawany Nimry, Crimes of Honor in Jordan and the Arab World - Rana Husseini, A dual violation of civil rights - Rana Husseini, Women’s Rights in the Middle East and North Africa 2010 – Jordan per UNHCR - Campagna ‘La Sharaf fil-Jareemeh’ (Non c’è onore nel crimine) di sensibilizzazione sulla problematica dei crimini d’onore in Giordania *I corsivi dell’articolo, dove non specificato, arrivano da notizie di cronaca locale o da conversazioni personali dell’autrice. 36 | speciale donne www.osservatorioitaq.it | 37 Nell’82, l’Iraq ha vinto il Premio Unesco per aver sradicato l’analfabetismo: per le bambine il tasso era sceso dal 91% del 1957 al 12% del 1990. Poi venne l’embargo e i suoi ‘danni collaterali’: nell’97 era analfabeta il 30,9% della popolazione femminile. di Francesca Manfroni C’era una volta un paese dove le donne godevano dei più alti livelli di libertà del mondo arabo. Poi la guerra, la devastazione e l’embargo. L’invasione americana del 2003 ha lasciato sul terreno oltre 750 mila vedove, lasciate abbandonate nella cura dei propri figli. Moltissime anche le profughe che da dieci anni attendono invano di poter tornare a vivere, spesso separate dalle proprie famiglie e perciò prive di sostegno e protezione. Non c’è dubbio che nei vari conflitti giocati sulla pelle degli iracheni, sono le donne e i bambini ad aver pagato il prezzo più alto. Prima con la vita, ora con la solitudine e la disperazione di chi si vede negata un’esistenza dignitosa. Ed è questa la triste storia di coloro che continuano a subire abusi e violenze, lontane dalla loro terra, private dei loro diritti e abbandonate dalla comunità internazionale. IRAQ: SHERAZADE NON ABITA PIÙ QUI Un dramma che non guadagna spazio sui giornali, ma che coinvolge decine di migliaia di donne intrappolate in una condizione di schiavitù sessuale tra Iraq, Giordania e Siria. C’era un volta un paese in cui il 40% della popolazione femminile lavorava nella pubblica amministrazione, vestiva all’occidentale e soprattutto poteva contare sull’applicazione dell’articolo 2 della Costituzione, che sanciva l’uguaglianza dei sessi, il diritto all’eredità, all’educazione gratuita e al divorzio. Nell’82, l’Iraq ha vinto il Premio Unesco per aver sradicato l’analfabetismo: per le bambine il tasso era sceso dal 91% del 1957 al 12% del 1990. Poi venne l’embargo e i suoi ‘danni collaterali’: nell’97 era analfabeta il 30,9% della popolazione femminile. Sicuramente uno dei dati più simbolici che raccontano il ‘nuovo medioevo’ delle donne irachene è il tasso di analfabetismo, che ora è uno dei più alti al mondo. Negli anni dell’occupazione americana sono state costrette a rinunciare a un’educazione per via della povertà, dell’insicurezza, della detenzione ingiusta e illegale dei capifamiglia. Oggi le donne che non sanno né leggere né scrivere sono almeno un milione, 400 mila solo a Baghdad, con una percentuale che oscilla tra il 24% della città e il 50-70% (secondo alcune fonti) delle aree rurali. Tutte destinate a trasformarsi in spose bambine, costrette a partorire in condizioni estreme. foto di Simona Ghizzoni 38 | speciale donne L’arretramento della condizione delle donne inizia con la guerra del 1991 e la distruzione della maggior parte delle infrastrutture civili ivi comprese quelle educative, continua durante tutto l’arco dei 12 anni del durissimo embargo voluto dagli USA e subisce il colpo di grazia nel 2003, quando il paese precipita nel caos post-invasione americana. Ora Sherazade non abita più qui. Succede che le più giovani non possono più andare all’università se non completamente velate, e comunque accompagnate da padri o fratelli per evitare rapimenti, torture o violenze. Nell’inferno post-2003, il loro corpo si è trasformato nel campo di battaglia privilegiato degli scontri religiosi e politici, laddove lo stupro è diventato adulterio e l’adultera una prostituta. www.osservatorioitaq.it | 39 Nel lungo elenco dei pericoli che minano la vita delle donne non appena vengono al mondo in questo angolo del pianeta che fu la culla dell’umanità, anche le mutilazioni dei genitali, pratica sempre più diffusa in tutto il paese e in particolare nel Kurdistan, un posto dove le donne si danno fuoco pur di smettere di vedere il marito picchiarle di fronte ai figli. Non solo: diverse parti del paese sono state ‘contagiate’ dal cosiddetto “matrimonio a tempo” (il muta’a, un contratto con il quale la famiglia della ragazza riceve una dote per cederla a un uomo, istituto diffuso soprattutto nel vicino Iran), e che non ha niente a che vedere con la shari’a, quanto piuttosto con la prostituzione legalizzata. Nel ‘nuovo’ Iraq, le donne che non indossano l’hijab rischiano sempre di più, soprattutto se lavorano per il governo. Di questo inverno la notizia che il ministro degli ‘affari delle Donne’ ha imposto la separazione dei sessi in ufficio e un “codice di abbigliamento” che impone “indumenti adeguati”. Quindi niente gonne corte (non che se ne vedessero), via i pantaloni stretti e persino i colori vivaci. Vietati alcuni modelli di scarpe. Poi c’è il dramma della tratta, che inizia ad assumere proporzioni inquietanti, sia all’interno che verso l’esterno del paese. A cadere nella rete dello sfruttamento sono soprattutto vedove e minorenni, con alle spalle una vita di povertà e analfabetismo. Anche attraverso il sistema del matrimonio, con gli sfruttatori, che sposano più donne, per poi avviarle alla prostituzione. Secondo un recente studio delle Nazioni Unite, sarebbero almeno un milione le adolescenti destinate a essere comprate e vendute sul mercato del sesso. L’altissima percentuale di vedove di guerra induce le irachene a intercedere presso i loro mariti affinché tornino alla poligamia per salvarle dalla strada. Nonostante sia illegale, è il Corano a spiegare il perché di una scelta così dolorosa: “Se temete di essere ingiusti con gli orfani, sposate allora due o tre o quattro tra le donne che vi piacciono…” (Corano-An-Nisâ’, 3). Infine all’avviamento ‘professionale’ contribuisce anche la famiglia d’origine, che decide di vendere le proprie figlie, spesso vergini e dunque molto preziose. E anche restare tra le mura domestiche non è garanzia di salvezza, sebbene in questo caso sia più difficile stimare quanti siano realmente i casi di violenza. Sicuramente tanti, troppi. Note: Oggi in Iraq esistono tre importanti realtà al femminile che si battono per i diritti delle donne: Women and equality, Women for freedom e Women for peace. L’Iraq ha ratificato La Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW), il 13 agosto 1986 www.osservatorioitaq.it | 41 40 | speciale donne Una città su misura per donne lavoratrici: è l’idea che l’Arabia Saudita ha messo in campo per implementare il lavoro femminile, evitando di contravvenire alle rigide regole sociali e religiose del paese. Ma è davvero la soluzione migliore in un’area come quella del Golfo, caratterizzata da una così forte disuguaglianza di genere in tutti i settori lavorativi? di Anna Toro La fine dei lavori di questa cittadella, in costruzione nella zona orientale di Hafuf, è prevista per l’anno prossimo. In attesa di vedere se l’iniziativa avrà successo, le statistiche mostrano ancora dati poco incoraggianti sull’ingresso delle donne nel mondo del lavoro. Secondo un recente studio del Gallup institute e pubblicato sul quotidiano al-Riyadh, la bandiera nera va all'Arabia Saudita, all'Oman e al Qatar, i tre paesi del Golfo in cui la donna è meno integrata nel mercato del lavoro, con una media del 22% contro il 40% dell’area e il 43% del resto del mondo. GOLFO: ESCLUSIONE E DISCRIMINAZIONE, PER LE DONNE IL LAVORO È ANCORA UN MIRAGGIO Se negli Emirati Arabi Uniti la forza-lavoro nazionale donna non supera il 28%, in Qatar (paese che conta più donne laureate che uomini) la partecipazione femminile è di appena il 35%. Il motivo è sempre lo stesso: i valori religiosi e tradizionali, le rigide norme sociali e un'industria del lavoro totalmente dominata dagli uomini e dai pregiudizi conservatori. Il caso dell’Arabia Saudita Inutile dire che l’Arabia Saudita è uno dei paesi che maggiormente soffre questo genere di discriminazioni. Ma la situazione potrebbe cambiare, più che per l’eco delle rivolte arabe del 2011, per il fattore istruzione. “Le donne saudite sono culturalmente preparate, vogliono lavorare e sono stanche di aspettare”, afferma Khalid al-Khudairi, fondatore dell'agenzia di recruitment per donne Glowork.net: “La primavera araba può aver accelerato i tempi, ma ora le donne continuato a protestare, e sono anni che chiedono pari opportunità e accesso al mondo del lavoro”. Stando ai dati diffusi dall’Oxford Strategic Consulting, il 57% delle saudite ha un diploma di laurea. Ciononostante la maggior parte non lavora, compreso un 60% di PhD. Le statistiche ufficiali del Saudi Professional Classification Manual rilevano che il numero delle donne che lavorano è di appena 100 mila, tutte in professioni definite “primarie”. Tutti gli analisti concordano nel definire questa esclusione di forza lavoro potenzialmente preparata e qualificata un grosso spreco di foto di Simona Ghizzoni 42 | speciale donne denaro e opportunità per il paese, e perfino il governo se ne starebbe rendendo conto. Come dimostra il decreto emanato di recente dal ministero del Lavoro per assumere commesse nei negozi che vendono abiti, biancheria o accessori femminili. Un secondo decreto ha permesso finalmente alle donne di lavorare come cassiere nei supermercati, mentre un terzo darebbe loro la possibilità di lavorare nei parchi per famiglie. Un quarto provvedimento le autorizza a diventare cuoche nei ristoranti, a patto che si segua strettamente la legge secondo cui a una donna non è permesso stare da sola con un uomo che non sia un suo parente. E poi c’è la famosa cittadella di Hafuf, una sorta di “paradiso rosa in cui tutte le donne lavoratrici, dalle operaie alle manager, potranno sentirsi a proprio agio nel soddisfare le proprie ambizioni” (parola dell’authority saudita che ha presentato l’idea). Una soluzione che forse aiuterà le donne ad uscire di casa e ad avere il diritto a uno stipendio, dato che si prevede la creazione di circa 5mila posti di lavoro. Venti di cambiamento che attraversano il Golfo: Qatar, Kuwait e Bahrein Sebbene in Qatar vi siano più donne laureate che uomini, la partecipazione femminile al mondo del lavoro non supera il 3%. E s’incontra questa stessa modestissima percentuale se si guarda alle donne che occupano cariche dirigenziali. Secondo il report per la strategia di sviluppo nazionale, il governo di Doha starebbe mettendo a punto facilitazioni per le donne - maternità, asili nido, pensioni -, sebbene “consuetudini e tradizioni continuino a prevalere, a discapito delle nuove opportunità create dallo sviluppo economico del Qatar”. “La questione infatti non riguarda solo le pari opportunità nel mondo del lavoro”, come conferma Reem al-Darwish, studioso di economia, intervistato dal Financial Times. “Riguarda anche ciò che un padre ritiene opportuno e professionalmente accettabile per le proprie figlie. Sono molte le famiglie di ‘strette vedute’. Non vogliono che le loro figlie vadano a lavorare in posti frequentati anche da uomini”. www.osservatorioitaq.it | 43 E poi c’è il Kuwait, dove invece la percentuale della forza lavoro femminile è di circa l’88% (contro l’89% degli uomini), come a Singapore, Belgio, Finlandia, Danimarca, Estonia e Malta. E il Bahrein, che non si allontana di molto, con il suo 61% (contro l'80 dei maschi) di lavoratrici. In questa parte di Golfo sembra che il vento sia già cambiato. 44 | speciale donne www.osservatorioitaq.it | 45 GOLFO Donne migranti, una tragedia tutta ‘domestica’ Sono circa 100 milioni i lavoratori domestici migranti nel mondo, l’83% del quale è donna. Di queste un milione si trova nei paesi del Golfo, in condizioni che ricordano molto la schiavitù. Un sistema che i governanti cercano di risolvere con misure ‘originali’ che non intaccano minimamente il sistema della kafala. di Stefano Nanni L’ultima misura in ordine di tempo l’ha dettata l’Arabia Saudita. Per prevenire l’ingresso delle lavoratrici domestiche straniere, le autorità hanno deciso di rafforzare i controlli all’aeroporto tramite la “politica del dente del giudizio”, come scrive l’organizzazione per i diritti dei lavoratori migranti nel Golfo MigrantRights. Il 3 dicembre, Nassir al Otaibi atterra all’aeroporto di Dammam, di ritorno dal Nepal. Qui scopre che la donna che stava viaggiando con lui non avrebbe mai potuto diventare la sua domestica, com’era nei suoi piani. Viene infatti rimandata nel suo paese d’origine per via del “dente del giudizio”: “Quando ho chiesto spiegazioni le autorità non hanno saputo dirmi altro”, ha detto Nassir ai giornalisti del quotidiano saudita Kabar. Una misura che secondo fonti ufficiali servirebbe ad appurare la reale età delle aspiranti domestiche, dato che spesso i passaporti forniti sono falsi o semplicemente modificati. “Alle persone sospette viene effettuato questo controllo medico e vengono interrogate: la maggior parte di loro confessano di essere molto più giovani di quanto dichiarato”, rivela il portavoce dell’ufficio immigrazioni dell’aeroporto, il colonnello Imad Abdul Qadir. Risorse fondamentali I lavoratori migranti compongono il 66,9% del totale della forza lavoro degli Stati membri del Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC). Tra questi, le donne impiegate come domestiche, colf o badanti, voci dal campo rappresentano circa un milione della popolazione di Bahrain, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait e Oman, secondo i dati forniti dalla United Nations Entity for gender equality and the empowerment of women (UN WOMEN). Ma si tratta di cifre che andrebbero lette al rialzo visto che, oltre ai dati indisponibili di Yemen ed Emirati Arabi Uniti, l’immigrazione illegale è ampiamente diffusa. La forte domanda di manodopera estera è una conseguenza dell’elevato standard di vita vigente in questi Stati. La provenienza è per lo più asiatica: Nepal, India, Filippine, Sri Lanka, Bangladesh; ma anche africana, in particolare da Etiopia ed Eritrea. Paesi accomunati solo dall’indice di povertà. La stragrande maggioranza di queste persone decide di intraprendere la difficile scelta di emigrare con la speranza di poter inviare denaro ai propri cari. Risorse fondamentali se si considera, ad esempio, che le rimesse nepalesi equivalgono a ben il 22,9% del Pil nazionale, quasi un quarto di tutta la ricchezza del paese. Ma è una ricchezza che fa male, soprattutto tra le mura di casa. La tragedia della Kafala Perché parlare di lavoro domestico nei paesi del Golfo vuol dire parlare di una tragedia che si chiama kafala. Un codice, il più delle volte non scritto, di norme tradizionali che regola il rapporto tra impiegate e datori di lavoro locali. Funziona così: un kafeel, ovvero un datore di lavoro, contatta, direttamente o per mezzo di un’agenzia di reclutamento una potenziale domestica, agendo in questo modo da ‘sponsor’ per il suo ingresso nel paese. Kafala infatti si traduce con “sponsorship”, ma che in pratica si trasforma in un vero appropriamento della persona. Il kafeel, spesso un capo famiglia, garantisce per il visto e paga una quota all’agenzia, ma in cambio gli è garantita la totale dipendenza della lavoratrice: s’impossessa del suo passaporto, può trattenere gli stipendi – in media 100$ al mese senza contratto –, non le permette di uscire e può ‘riconsegnarla’ all’agenzia se non soddisfa le sue esigenze. E in quest’ultimo caso per la donna in questione ci sono tre possibilità: che un nuovo sponsor si faccia avanti; rivolgersi al proprio consolato oppure la tragedia. E dietro questa parola si celano prostituzione e maltrattamenti fisici e psicologi. Che conducono in certi casi alla morte, a volte per suicidio. voci dal campo 46 | speciale donne Basta guardare a ciò che è successo nel solo mese di novembre 2012, secondo quanto riporta l’organizzazione MigrantRights. In Arabia Saudita una domestica di nazionalità etiope è deceduta dopo essere stata bastonata per tutta la notte; stessa sorte è toccata alla moglie del kafeel e a un’altra colf, che però sono riuscite a salvarsi rinchiudendosi in bagno. Due i suicidi registrati in Kuwait: nel primo caso una filippina si è gettata dalla finestra dell’appartamento dove lavorava per impedire al suo datore di lavoro di ‘venderla’ a dei trafficanti di sesso; nel secondo una badante indiana si è suicidata impiccandosi nella sua stanza. In Bahrain, una colf bengalese è stata colpita a morte dal suo kafeel con un asse di legno. Ad Abu Dhabi un’altra domestica etiope è stata ripetutamente torturata dalla moglie del suo sponsor fino al decesso: la polizia ha trovato il corpo della donna in una vasca di acqua bollente avvolto da fili elettrici e con gli occhi ricoperti dal pepe. Il motivo di queste orrende atrocità sarebbe stata la presunta “pigrizia della lavoratrice”. L’ultimo caso in Oman, dove un datore di lavoro ha reagito violentemente alle continue richieste di pagamento della sua dipendente ferendola a morte con un oggetto tagliente nelle orecchie. Ma la tragedia non si ferma qui, perché storie di sfruttamento, stupri, razzismo, privazione di cibo e acqua vengono purtroppo frequentemente portate alla luce da organizzazioni come MigrantRights, che cercano di sensibilizzare l’opinione pubblica locale, spingendo i governanti ad agire. Politiche ‘inopportune’ Ma risolvere un problema così drammatico constatando o meno la presenza del dente del giudizio è definito “deleterio” anche da MigrantRights. Che chiede da tempo all’Arabia Saudita di prendere ben altri provvedimenti. Stupisce inoltre la celerità con cui questa è stata adottata. “In genere gli Stati del Golfo sono estremamente lenti nel legiferare in materia di protezione dei lavoratori migranti, ma stavolta l’Arabia Saudita si è rivelata molto rapida”, afferma l’organizzazione. Una misura del genere è inefficace perché si attua nel paese di destinazione, dopo che una persona ha già affrontato sforzi incredibili per la partenza voci dal campo www.osservatorioitaq.it | 47 nel suo paese di origine: non solo economici, che rappresentano sicuramente la parte più importante, ma anche sociali e familiari, dato che partire il più delle volte equivale a lasciare figli e famiglia. A spingere i sauditi ad adottare questa politica potrebbero essere state le dichiarazioni dell’ambasciatore nepalese presso Ryadh, Raj Pandey, secondo il quale il 2012 si sarebbe chiuso con il rientro in patria di 103 cadaveri, la maggior parte dei quali di lavoratrici domestiche. Una denuncia che fa seguito alla decisione del governo di vietare alle donne minori di trent’anni di andare a lavorare nei paesi del Golfo. E non è la prima volta che il Nepal impone restrizioni all’emigrazione femminile. In passato simili misure sono state prese anche da India e Sri Lanka, come riportato nel rapporto di UN women. Constatazione che fa pensare che neanche questo tipo di politiche sia servito ad arginare il problema né tantomeno a eliminarlo. Nel 2009 il Bahrain aveva annunciato di “prendere in considerazione” l’abolizione della kafala, ma ad oggi nessun passo concreto è stato fatto. “Per affrontare una condizione molto vicina alla schiavitù occorre ben altro”, secondo MigrantRights. Partendo innanzitutto dal conformarsi agli strumenti internazionali che regolano i diritti e i doveri dei lavoratori migranti: tutti i paesi del GCC, compreso lo Yemen, sono firmatari di diverse convenzioni internazionali, ma nessuno di loro le ha ratificate. Il 18 dicembre, invece, la Convenzione internazionale per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie compie 9 anni dalla sua entrata in vigore: i paesi del Golfo non l’hanno neanche firmata. E proprio una settimana prima l’Arabia Saudita aveva dichiarato non grata un’associazione filippina, Migrante-Middle East, che aveva denunciato casi di maltrattamenti. Per non parlare della Convenzione n.189 dell’Organizzazione internazionale del lavoro sulla condizione decente dei lavoratori domestici, nata soltanto lo scorso giugno e presentata come un successo della comunità internazionale, ma ratificata soltanto da Filippine e Mauritius. Queste convenzioni in fondo non dicono niente di straordinario: parlano di contratti, che siano pubblici e rispettati; affermano il diritto a un giorno di riposo e a un salario decente; chiedono che le agenzie di reclutamento siano iscritte presso lo stato di origine e vengano voci dal campo 48 | speciale donne www.osservatorioitaq.it | 49 regolamentate; domandano ai paesi da cui provengono i lavoratori di proteggere i propri cittadini all’estero. Invita gli Stati a considerare migranti e domestici dei lavoratori come gli altri. La cui condizione, al momento, somiglia sempre di più a quella di schiavi. voci dal campo voci dal campo www.osservatorioitaq.it | 51 50 | speciale donne Cinque storie di donne. Cinque storie di prigioniere di coscienza in Iran: Nasrin, Bahareh, Masha, Jila e Shiva. Detenute nel ‘braccio 209’ del carcere di Evin, a Teheran, per aver avuto il coraggio di raccontare le violazioni dei diritti umani nel loro paese. IRAN: STORIE DAL BRACCIO 209 di Cecilia Dalla Negra La chiamano “l’Università di Evin”, per il numero di insegnanti e intellettuali dissidenti che vi sono stati rinchiusi nel corso degli anni, per aver osato sfidare il regime in Iran. È il carcere di Evin, a nord di Teheran, costruito nel 1972 ai piedi dei monti Alborz sotto il regno dello shah Mohamed Reza Palahvi. Sulla carta doveva essere un centro di detenzione temporaneo per i prigionieri in attesa di giudizio, che sarebbero stati poi dislocati verso altre carceri. Ma sin dalla rivoluzione del 1979 ha visto passare migliaia di detenuti politici, oppositori e prigionieri di coscienza tra le sue mura. Diventando tristemente noto per la gestione blindata dell’intelligence iraniana: per le torture, le esecuzioni arbitrarie, i trattamenti inumani e gli abusi sessuali ai danni delle donne. Perché ci sono anche loro nel ‘wing 209’, il braccio riservato a quelli che in Iran sono chiamati i prigionieri di coscienza: persone arrestate per aver “attentato alla sicurezza nazionale”, spesso sulla base di accuse inconsistenti e attraverso processo sommari, condannate a scontare anni di detenzione per il loro attivismo nell’ambito dei diritti umani, della libertà di parola, di espressione. O per aver agito in difesa dei diritti delle donne: come Nasrin, Bahareh, Masha e le altre. Che passeranno anche questa giornata – dedicata all’eliminazione delle forme di violenza contro il genere femminile – in una cella d’isolamento, lontane dalle famiglie e in condizioni di salute precarie, pagando a carissimo prezzo il coraggio che hanno avuto nello sfidare il regime, o una legislazione che in quanto donne le discriminava. Il coraggio di denunciare abusi, violazioni, assenza di diritti, violenze. O quello di aver semplicemente fatto il proprio mestiere, ma nel paese sbagliato: è il caso delle tante giornaliste e blogger che, come Shiva e Jila, hanno scritto, raccontato, intervistato. Premiate in Europa e arrestate in patria, anche solo per aver pubblicato un articolo. Abbiamo scelto di raccontare cinque storie: di donne, coraggio e repressione. Bahareh Hedayat era una studentessa universitaria a Teheran quando è stata arrestata per aver denunciato le violazioni dei diritti degli studenti in seguito alle elezioni presidenziali iraniane del 2009. Agli impegni di studio aveva scelto di affiancare la militanza femminista, prendendo parte alla campagna “Un milione di firme”, lanciata dell’agosto del 2006 da diverse organizzazioni femminili per chiedere al parlamento iraniano la riforma della legge che in Iran discrimina e penalizza le donne. Bahareh, figlia della generazione nata dopo la rivoluzione foto di Simona Ghizzoni 52 | speciale donne del ’79, ha rivendicato per se stessa e per il suo paese una libertà di espressione e un’uguaglianza che non le sono state concesse: accusata di “attentato alla sicurezza nazionale” e arrestata molte volte, nel dicembre 2009 è stata condannata a 9 anni e mezzo di reclusione. La sua condanna è una delle più dure mai inflitte a un’attivista per i diritti umani in Iran. Oggi ha 31 anni. Jila Baniyaghoob è una giornalista. Negli ultimi anni è stata arrestata più volte per aver esercitato il diritto di stampa e di espressione attraverso il suo lavoro di freelance e redattrice-capo del giornale del Centro per i diritti delle Donne Kanoon Zanan Irani. L’ultimo arresto il 2 settembre del 2012, quando è stata condotta nel carcere di Evin per scontare una pena di un anno. Con lei è stato arrestato anche il marito Bahman Ahmadi Amoyee, anche lui giornalista. Nel 2009 l’International Women’s Media Foundation l’ha insignita del premio Courage in Journalism “per aver raccontato senza paura l’oppressione del governo nel suo paese, che l’ha particolarmente colpita in quanto donna”. Nel 2010 ha vinto il Freedom of Speech Award di Reporter senza frontiere. Una volta tornata in libertà, le sarà impedito esercitare la professione giornalistica per i prossimi 30 anni. Oggi ha 39 anni. Masha Amrabadi è una giornalista. Arrestata una prima volta nel 2009 per aver dato conto delle manifestazioni che animavano il paese all’indomani delle contestate elezioni presidenziali, è stata in seguito rilasciata. Nel maggio del 2012 è stata nuovamente condotta nel carcere di Evin e condannata a scontare un anno di reclusione per aver “diffuso propaganda contro il sistema attraverso le sue interviste e i suoi articoli”. E per aver cercato di difendere il marito Massoud Bastani, anche lui giornalista e prigioniero politico. Masha oggi ha 27 anni. Shiva Nazar Ahari, attivista per i diritti umani, blogger e giornalista. Membro del Comitato dei giornalisti per i diritti umani, è stata condannata a scontare una pena di 4 anni per “propaganda antiregime” e moharebeh, il reato di “guerra contro lo stato e contro dio”, tra i crimini più gravi secondo la legge islamica in vigore in Iran. Nel 2011 è stata insignitadel premio Theodor Haecher per aver “coraggiosamente coperto con le sue attività giornalistiche le violazioni dei diritti umani” nel suo paese. Shiva Nazar Ahari ha 28 anni. Nasrin Sotoudeh, attivista per i diritti umani, avvocatessa, insignita nel 2012 del premio Sakharov insieme a Jafar Panahi, un riconoscimento assegnato dal Parlamento Europeo a personalità che abbiano dedicato la loro vita alla difesa delle libertà individuali e dei diritti umani. Nel www.osservatorioitaq.it | 53 settembre di quest’anno è stata convocata nel carcere di Evin per “accertamenti”. Non ne è mai uscita. Condannata a scontare una pena di 6 anni per “propaganda anti-regime” e “attentato alla sicurezza nazionale”, oltre al divieto di esercitare la professione forense per i prossimi 10 anni. In seguito all’inasprimento delle condizioni di detenzione, e al divieto comminato alla figlia dodicenne di lasciare il paese, Nasrin Sotoudeh ha avviato uno sciopero della fame lungo 50 giorni, cui si sono unite altre nove detenute di Evin, tra cui Shiva Nazar Ahari e Bahareh Hedayat. 54 | speciale donne www.osservatorioitaq.it | 55 IRAN Non rinnegano la rivoluzione, è la rivoluzione a rinnegare loro La situazione delle donne in Iran è ben diversa dalla situazione delle donne nel resto del mondo islamico. A farcene un ritratto è la professoressa Anna Vanzan, iranista e islamologa, docente di Cultura araba presso l’Università di Milano e visiting lecturer al Master M.I.M. dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e al Master europeo on line EUMES. di Marta Ghezzi L’immagine che il mondo ha dell’Iran è quella di una donna nascosta sotto un chador nero, vittima di un regime religioso che la vuole chiusa in casa. Ma è davvero così? Se dopo 33 anni, lo Stato è ancora costretto a mettere negli uffici pubblici un quadretto con un disegnino per ricordare alle ‘sorelle’ come si devono velare, significa che davvero non è riuscito a piegare le donne d’Iran. È proprio nel tentativo di mettere le donne al loro supposto posto che il regime ha fallito. Si è buttato tutto il peso (e il significato) di una rivoluzione sulle spalle delle donne e soprattutto sulla loro condotta, e si è ingenerata paura. A pesare, e tanto, è l’embargo. Si sono create una società e un’economia parallele che stanno minando l’ordine e la normalità delle cose. A perdere il lavoro sono soprattutto le donne. Le élite se ne fregano delle sanzioni, anzi, c’è chi addirittura si è arricchito tra traffici illegali e della borsa nera. Chi soffre è la gente normale, che ora deve fare i conti anche con la crisi. Prima ha accennato al tasso di istruzione delle ragazze, ma leggevo di una nuova legge per limitare l’accesso a numerose facoltà proprio alle studentesse. La storia del divieto di accesso alle università per le ragazze è una storia vecchia almeno quanto la rivoluzione islamica. All’indomani della caduta dello Shah, l’idea che il nuovo governo voleva far passare era quella della segregazione totale tra i sessi anche nelle aule universitarie, ma in breve tempo si è rivelata un’opzione impraticabile: far funzionare un intero ateneo con classi femminili seguite da insegnanti femmine e classi maschili con insegnanti maschi richiede un enorme investimento in termini di spazio e di risorse umane. Oggi, la questione si ripropone alla luce di due nuove variabili, che all’inizio degli anni Ottanta non c’erano: la popolazione universitaria, presso tutte le facoltà, è per la stragrande maggioranza femminile, e visto l’alto tasso di disoccupazione intellettuale, c’è un surplus di insegnanti qualificati sia uomini sia donne. È una paura che arriva dalla famiglia prima di tutto, ma è indotta: arriva dall’imposizione di un codice di vestiario e dai controlli continui, dal timore di sbagliare e di perdersi dentro ad un sistema che non si comprende. L’iniziativa l’ha presa l’università della tradizionalissima città di Qum... diciamo anche che lì il terreno era anche più fertile, perchè attaccasse bene una proposta del genere: cedere ai gruppi di pressione e alle frange più estreme del parlamento e chiudere l’accesso alle facoltà scientifiche alle ragazze, introducendo delle quote azzurre. Ma le donne in Iran sono forti: si è detto loro che dovevano stare a casa, e loro di tutta risposta hanno alzato la media del tasso di istruzione. Si è andata rafforzando l’idea della donna istruita, laureata, e con il tempo questa donna istruita è diventata anche padrona del suo destino e dello spazio sociale. Non è una legge nazionale, o almeno non ancora, ma la questione è che il ministero dell’Istruzione non ha detto nulla in proposito, né a favore né contro l’iniziativa. Una presa di posizione verso la chiusura dell’Università di Teheran, considerata la più ‘aperta’ del paese, ecco, potrebbe sollevare un certo scalpore. E non è un concetto radicato solo nei grandi centri urbani: nelle campagne le famiglie sono disposte a grandi sacrifici pur di assicurare alla propria prole un banco all’università. Padri e madri che vogliono un futuro diverso per i propri figli. Il governo in pratica sta dando mano libera alle università private, la più famosa delle quali fa capo a Rafsanjani. Lì le politiche di genere sono diverse, l’insegnamento è più libero, il controllo sugli studenti è minore. voci dal campo voci dal campo 56 | speciale donne www.osservatorioitaq.it | 57 In generale l’ambiente universitario impone delle regole più strette rispetto alla normale quotidianità iraniana. È facile vedere in giro per gli atenei ragazze coperte dalla testa ai piedi, quando fuori indosserebbero al massimo un foulard. E proprio perchè le regole sono così strette e ben evidenti, che molti insegnanti riescono ad aggirarle. Certo, dopo il 2009 e l’Onda Verde, molti docenti sono stati costretti a lasciare il proprio posto di lavoro, perché accusati di connivenza con gli studenti in rivolta, oppure se ne sono andati perchè non sono stati più in grado di convivere con il sistema e le sue richieste, anche se molti continuano a lavorare stando attenti a dissimulare le loro opinioni personali, oppure portando avanti un discorso ‘parallelo’ con alcuni studenti fidati, magari all’esterno del recinto accademico. poligamia ‘estrema’? E’ per prima la società civile quella che si mobilita contro questa ipotesi. Con gli alti livelli di disoccupazione, soprattutto tra i giovani laureati e tra le donne, non è difficile sostituire personaggi scomodi con altri più condiscendenti e malleabili. Ma c’è ancora chi resiste e non abbandona la sua strada. Le donne in Iran sanno cosa vogliono e non mollano! Il codice di famiglia è restrittivo? Allora lottiamo per cambiarlo! È tutto un proliferare di movimenti per i diritti e associazioni. Il cammino è stato avviato. Bisogna solo continuare su questa strada. Le donne in Iran sono ben consapevoli delle conquiste ottenute finora e non sono disposte a tornare indietro per nulla al mondo. Durante i disordini post-elettorali del 2009, alla guida di molti cortei c’erano proprio studentesse, professioniste e madri. È una situazione che farebbe paura a qualunque governo, a maggior ragione a quello dell’Iran che ha perso apertamente la sua battaglia contro di loro. E le elezioni del prossimo anno? Cosa vede nel futuro del paese e delle sue donne? Le donne rivendicano uno spazio sociale che sia loro, libero, nuovo. Non rinnegano la rivoluzione islamica, ma sentono che in molti casi è stata la rivoluzione a rinnegare loro. Cosa che in ogni caso non le ferma. Negli anni Novanta, sotto la presidenza di Khatami, l’Iran ha vissuto un grande momento di riforme dal basso verso l’alto. Khatami ha sollevato il coperchio e iniziato un percorso. Gli iraniani, e soprattutto le iraniane, non sono disposti a tornare indietro. Una delle voci più agguerrite contro il sistema è la figlia di Rafsanjani: è stata parlamentare, ha un blog e parla senza tanti peli sulla lingua dei problemi del paese; è finita in galera per aver espresso le sue opinioni, ma non si è fermata. La linea che si è rafforzata in questi anni di presidenza di Ahmadinejad è tutta conservatrice e i giochi si faranno proprio tra le fila più tradizionaliste del potere iraniano. Ma l’opposizione c’è e l’Iran è un paese imprevedibile. Nessuno si aspettava quello che poi è successo nel 2009. Potrebbe esserci un nuovo 2009. Oppure no. D’altra parte gli iraniani si attribuiscono il merito di aver dato inizio alle primavere arabe...la protesta sociale andrà avanti perchè il movimento c’è. Dove poi porterà, questo ancora non si può sapere. Per fare un esempio: il Parlamento sta discutendo in questo periodo un disegno di legge che impedisca alle donne single al di sotto dei 40 anni di lasciare il paese senza il consenso di un uomo della famiglia. E chi si è schierato in prima fila contro questa proposta? Proprio le più tradizionaliste, che negli anni hanno preso coscienza del loro ruolo e che non sono più disposte ad essere messe nell’angolo in nome di una presunta superiorità, sociale o legale, degli uomini. Il giogo del codice di famiglia pesa ancora e sempre. Però la gente, e le donne stesse, oggi recepiscono le leggi in maniera diversa. La legge dà la possibilità alle bambine di 9 anni di sposarsi? Bene, le ragazze iraniane in media si sposano attorno ai 25. Si parla di reintrodurre la voci dal campo voci dal campo 58 | speciale donne www.osservatorioitaq.it | 59 Erano in due, su una moto, armati e col volto coperto. Le hanno sparato mentre si recava al suo ufficio, nel capoluogo della provincia est di Laghman. E’ morta così Najia Seddiqi, direttrice provinciale dell’Ufficio degli affari delle donne, lo scorso 10 dicembre. di Anna Toro Una morte quasi annunciata dato che, cinque mesi prima, anche il suo predecessore, Hanifa Safi, è stata uccisa a Kandahar, per mezzo di una bomba nascosta nella sua auto. Entrambe attiviste per i diritti delle donne, Seddiqi e Safi lavoravano senza scorta. Il figlio di Safi ha raccontato alla Reuters delle ripetute richieste di protezione puntualmente ignorate dalle autorità. Secondo lui, sarebbe l’ennesimo esempio di come il governo continui a prestare poca attenzione al lavoro delle donne, specie di quelle che lavorano in ruoli chiave e così esposti. AFGHANISTAN: TRA PAURA, VIOLENZE E LEGGI “INVISIBILI” Il presidente Karzai, naturalmente, ha sempre respinto le accuse. “Uccidere le donne è un atto codardo, contro i valori islamici e culturali dell’Afghanistan”, ha detto dopo l’assassinio di Seddiqi. Eppure, nonostante i comunicati ufficiali del governo sui miglioramenti della condizione femminile nel paese, le donne afghane continuano a essere le principali vittime di abusi e violenze, in particolare quelle che vivono nelle province più povere e remote. Certo, nel 2009 è stata emanata la legge sull’eliminazione della violenza di genere, che finalmente ha trasformato in reato il matrimonio forzato delle bambine, le percosse domestiche, la compravendita per questioni di debiti o dispute familiari, l’aggressione, lo stupro e un’altra dozzina di fattispecie. Legge che però è ancora lontana dall’essere applicata. A questo proposito, subito dopo l’uccisione di Seddiqi, le Nazioni Unite hanno reso pubblico uno studio realizzato in 22 delle 34 province afghane nel periodo tra settembre 2011 e settembre 2012. Secondo quanto si legge nel report, la maggior parte degli incidenti e delle violenze domestiche non vengono denunciati, come è successo a Storay, strangolata e uccisa dal marito perché ha dato alla luce una figlia femmina e non un maschio. O quello della bimba di 10 anni della provincia di Baghlan, che racconta come lo zio intendesse darla in sposa a suo figlio per ottenere la proprietà delle terre di famiglia. O, ancora, la sconvolgente testimonianza della quindicenne che, picchiata più volte dal marito e dal padre di lui, alla fine si è data fuoco ed è morta. foto di Simona Ghizzoni 60 | speciale donne Vittime in prigione: la legge ribaltata La Commissione indipendente afghana sui diritti umani riporta oltre 4 mila casi di violenza contro le donne commessi tra il 21 marzo e il 21 ottobre del 2012, quasi il doppio rispetto all’anno precedente. Ma le discriminazioni e la paura dello stigma sociale rendono molto difficile per le donne denunciare i crimini commessi nei loro confronti. Le Nazioni Unite sono riuscite a registrare appena 470 denunce alla polizia. I rinvii a giudizio sono stati 163, circa il 35%, e solo 72 erano basati su violazioni alla legge contro la violenza sulle donne. Nelle 16 province analizzate, solo il 21% dei casi sono finiti con una condanna. Secondo i dati riportati quest’anno da Simona Cataldi del Cisda (Coordinamento italiano sostegno donne afghane), più dei due terzi della popolazione femminile è in carcere proprio a causa di questi cosiddetti “crimini morali”. Partendo dal reato di zina, ovvero i rapporti sessuali pre o extra matrimoniali, e dalla fuga, che viene arbitrariamente associata all’intenzione di commettere adulterio e, quindi, di contravvenire a quanto prescritto dalla shari’a. “Le donne, al contrario, nella maggior parte dei casi scappano di casa per sfuggire a matrimoni forzati e ad altre forme di violenza”, afferma l’attivista e studiosa. “Nonostante la legge del 2009, e stando a quanto denunciato dalle principali agenzie dell’Onu, il 60% dei matrimoni sono forzati e di questi, il 57% riguarda ragazze che hanno meno di 16 anni. Ancora dalle statistiche, l’87% dichiara di aver subito una violenza, e la metà sono sessuali”. Certo, qualche piccolo miglioramento c’è stato, anche per quanto riguarda la presa di coscienza del problema. Ad esempio a Kabul, dove a luglio decine di donne, ma anche di uomini, sono scesi nelle strade per protestare contro l’esecuzione pubblica di una donna afghana accusata di adulterio. A scatenare la manifestazione, il video stesso della sua uccisione, avvenuta nella provincia di Parwan, a nord di Kabul, mentre la folla attorno applaudiva e rideva. Dopo la Nato... Sono in molte a chiedersi se la situazione delle donne non peggiorerà ulteriormente dopo il 2014, con l’annunciato ritiro delle truppe internazionali. Il mancato impegno da parte del governo afghano www.osservatorioitaq.it | 61 nel promuovere l’uguaglianza e nel perseguire il maltrattamento nei confronti delle donne fa crescere la paura di venir poste ancora più in fondo nell’agenda politica nazionale. Guhramaana Kakar, consulente per la parità di genere del presidente Hamid Karzai, ha sottolineato come “i negoziati tra il governo, i talebani e gli altri gruppi di insorti stiano ignorando in modo sistematico i diritti delle donne”. Secondo una recente ricerca dell’Ong ActionAid, l’86% delle donne afghane teme il ritorno della legge talebana, e una su cinque è preoccupata per l’educazione delle proprie figlie, anche se il 72% conferma che la sua vita è migliorata rispetto a 10 anni fa. “Le donne subiscono regolarmente molestie sul posto di lavoro”come afferma Kakar, sottolineando che sono spesso bersaglio degli insorti per il solo fatto che vanno a scuola o lavorano. Perfino a casa sono soggette a violenze e abusi, tacitamente tollerati dalle corti. “Tutti gli afghani, uomini e donne, vogliono un paese senza le truppe straniere, ma penso che la comunità internazionale dovrebbe mettere la questione donne in agenda e assicurarsi che sia garantita loro la sicurezza e le libertà fondamentali”. www.osservatorioitaq.it | 63 62 | speciale donne AFGHANISTAN Quando la prostituzione comincia in famiglia Non era la prima volta che la suocera della giovane Mah Gul, 20 anni, aveva cercato di farla prostituire. Al suo ennesimo rifiuto la donna ha preso la decisione: con l’aiuto di un complice, hanno aspettato che il figlio tornasse dal lavoro. In tre hanno bloccato la ragazza e, per punirla del suo rifiuto, le hanno tagliato la testa. di Anna Toro E’ successo appena il mese scorso, nella provincia afghana di Herat. Gli assassini sono stati tutti arrestati, ma questa è più un’eccezione che la regola, in un paese dove le donne da vittime si trasformano automaticamente in colpevoli, anche di fronte alla legge, mentre i loro aguzzini rimangono per lo più impuniti. La prostituzione stessa, pure quella forzata, fa parte infatti dei cosiddetti “crimini morali”. Con una particolarità: in Afghanistan, nella maggior parte dei casi conosciuti, tutto parte all’interno della famiglia (la propria o quella del proprio marito) ed è per questo che il fenomeno è ancora più difficile da individuare e controllare. Come nel caso di Soma, originaria di Mazar-e-Sharif. Era appena un’adolescente, racconta l’agenzia stampa Inter Press Service, quando suo nonno ha deciso di farla sposare con un uomo che nemmeno aveva mai visto. Una volta arrivata a Kabul per la cerimonia, la ragazzina scopre di essere stata data in sposa a un bambino di 8 anni. Non passa molto tempo che la famiglia di lui la costringe a prostituirsi, durante i festini organizzati dal suocero: per 200 dollari i visitatori mangiavano, bevevano e guardavano Soma e altre ragazzine della famiglia danzare, per poi spostarsi nelle camere da letto. Soma era costretta ad andare anche con 4 uomini per notte. voci dal campo Lei alla fine è stata più fortunata rispetto a Mah Gul, anche se fino a un certo punto: un cliente, impietosito dalla sua vicenda, l’ha aiutata a scappare e ad andare dalla polizia. Il caso è arrivato al ministero per gli Affari delle donne, ma intanto Soma è stata rimandata a casa di suo nonno a Mazar-e-Sharif e l’uomo che l’ha costretta a prostituirsi, è scampato all’arresto. “Sono per lo più le famiglie a vendere le loro figlie e nuore – conferma Nigina Mamadjonova dell’International Organisation of Migration – dopo di che le ragazze non hanno altra scelta che continuare questa strada”. “Non solo perchè le famiglie d’origine, per la vergogna, non le rivogliono in casa, ma anche perchè, se provano a scappare e a rivolgersi ad associazioni e ong in cerca di aiuto, rischiano di essere rintracciate e uccise”. Fenomeno in crescita La povertà cronica del Paese dopo decenni di guerra e occupazione straniera non ha fatto che accrescere il problema, rendendo queste donne, spesso giovanissime, sempre più vulnerabili (senza dimenticare che in Afghanistan il fenomeno della prostituzione forzata coinvolge pesantemente anche i bambini). Secondo un’inchiesta dell’Afghanistan Independent Human Rights Commission, il 60% del traffico di donne e bambini è interno. La prostituzione nel Paese è illegale ma, sebbene non si disponga ancora di dati ufficiali, per le Ong il fenomeno è in crescita. Il motivo per cui le ragazze finiscono col prostituirsi è innanzitutto la violenza domestica, e non solo nei casi sopra citati. Spesso il marito o il fratello, a causa della disoccupazione, diventa tossicodipendente o alcolizzato, e per la donna vendere il proprio corpo diventa l’unico modo di provvedere alla propria famiglia. La legge afghana spesso identifica questo crimine con l’adulterio, per il quale si rischiano anche 15 anni di prigione. Per le prostitute “di strada” condannate, però, la norma sono 6 mesi di prigione, mentre il cliente non viene arrestato, seppure anch’egli stia commettendo un reato. voci dal campo 64 | speciale donne www.osservatorioitaq.it | 65 In un Paese dove l’educazione sessuale è inesistente e dove le famiglie ancora puniscono le figlie o le mogli che li hanno disonorati, la prostituzione comporta dei rischi altissimi, soprattutto di attacchi da parte dei Talebani, ma anche, come capita dappertutto, di aggressioni e rapine da parte degli stessi clienti. “Il problema è che raramente queste leggi vengono applicate e la donna vittima finisce per diventare a sua volta imputata e condannata” denuncia Human Right watch, che quest’anno ha pubblicato un intero report sulle donne afghane colpevoli di “crimini morali”, ma soprattutto vittime di abusi e violenze, dal titolo significativo: “I had to run away”. Se il governo tace, le prostitute si auto-organizzano “Il presidente Karzai, gli Usa, tutti – termina l’ong – devono onorare le grandi promesse fatte 10 anni fa verso le donne afghane, innanzitutto mettendo fine alle carcerazioni per le donne vittime e poi concretizzando gli annunci e gli impegni presi a sostegno dei loro diritti”. E poi ci sono le malattie sessualmente trasmissibili, di cui sia le ragazze sia i clienti in genere sono poco o per nulla informati: basti pensare che, in un recente articolo del Wall Street Journal, un camionista afghano ha dichiarato di non sapere nemmeno cosa fosse un preservativo. Proprio per questo a Kabul, racconta ancora il Wsj, un gruppo di prostitute ha deciso di creare una rete interna per la diffusione di informazioni di tipo pratico e sanitario. Oltre alle liste nere dei clienti autori di aggressioni o rapine, il gruppo ha cominciato a distribuire preservativi e pamphlet illustrati sulle malattie infettive e sui pericoli del contagio (secondo l’Asian Human rights Commission più di 100mila afghani, tra uomini e donne, hanno contratto l’Hiv, malattia in crescita nel paese, mentre la malattia più diffusa nel Paese è l’epatite B, che è endemica). La rete stessa ha contato a Kabul circa 6mila prostitute donne, e 4mila maschi. Quando sono per strada le donne indossano il classico burqa azzurro e non si distinguono dalle altre, ma hanno i loro modi per contattare i clienti: tramite i commercianti, sui taxi, o anche per telefono. Le ragazze, se trovano un cliente facoltoso, riescono a guadagnare anche 1200 dollari a notte, mentre la media è 20 dollari a cliente. Un introito considerevole, se si pensa che lo stipendio medio per le donne nella capitale si aggira sui 150 dollari al mese. Nonostante questo, ben poche si ritengono felici di fare questo lavoro, e nessuna di loro l’ha scelto di propria spontanea volontà. E il governo afghano ha fatto pochissimi passi avanti sia nel contrastare questo fenomeno sia con le varie leggi a difesa delle donne. voci dal campo voci dal campo Speciale Donne/1 Quest’opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Unported. la solitudine di Sherazade progetto grafico: Marta Ghezzi
Scaricare