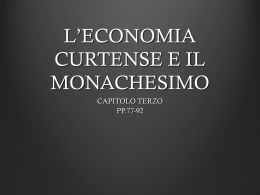Il film TIBHIRINE d es hommes et des dieux Quando l’occhio laico sa vedere il cuore di una Chiesa I l 22 ottobre, mentre andiamo in stampa, esce la versione italiana del film francese Des hommes et des dieux – Uomini di Dio, premio speciale della giuria di Cannes 2010.1 Lo recensisce in esclusiva per Il Regno mons. Henri Teissier, vescovo di Algeri al tempo dei fatti di cui il film tratta. Sulla vicenda, cf. anche Regno-att. 8,1996,216; 12,1996, 361; 16,1997,493; 10,2006,316; 14, 2009,462; Regno-doc. 13,1996,427; 7,1998,245; 22,1998,771 (Red.). Molti si meravigliano del successo che il film sui monaci di Tibhirine ha avuto in Francia, paese in cui il messaggio della Chiesa non raggiunge che una piccola parte della società. Anche se tutti sanno che il rapimento e poi l’uccisione dei monaci (27 marzo e 21 maggio 1996), assieme alla straordinaria qualità del testamento spirituale di p. Christian de Chergé, hanno suscitato allora una profonda emozione. Tuttavia, quasi non riesco a credere che il messaggio dei nostri fratelli di Tibhirine abbia già raggiunto 1.200.000 persone! E il suo percorso è lungi dall’essere terminato. Nei prossimi giorni il film sarà presentato anche al pubblico italiano, spagnolo, inglese. Fedeltà a un mess aggio Sono poi stato positivamente colpito dal fatto che sia un film tecnicamente valido e che, grazie ai consigli di Henri Quinson e alla testimonianza dell’abbazia di Tamié, gli elementi essenziali della vita cistercense trappista siano ben espressi: la preghiera, la lec- 592 IL REGNO - AT T UA L I T À 18/2010 tio divina, la vita fraterna comunitaria, l’accoglienza dei vicini nel rispetto della loro identità musulmana, il lavoro o il servizio nella diversità dei compiti: il dispensario, il giardino, il miele, l’assistenza reciproca, la cucina, le faccende quotidiane ecc. Ulteriore positiva meraviglia ha suscitato in me il fatto che questo film sia una scelta nata da dei professionisti del cinema, senza committenza da parte della Chiesa o di un’istituzione cristiana. In più è arrivato a Cannes per i normali canali della produzione cinematografica. Ha ottenuto il premio speciale della giuria e, sulla scia di questo, il premio del Ministero per l’istruzione, oltre al premio della giuria ecumenica. I riconoscimenti della critica e questa sua genesi laica hanno spinto molte persone, ben al di là dei cristiani praticanti, ad andare a vedere il film. E il silenzio attento con cui gli spettatori seguono ogni spettacolo prova che c’è un pubblico nella Francia d’oggi – e probabilmente anche in altri paesi – capace d’accogliere il messaggio di una comunità monastica quando essa si pone drammatiche domande di coscienza, come quella se accettare, per fedeltà alla propria vocazione umana e religiosa, di rischiare la propria vita. Ed è capace di cogliere l’innovativa relazione tra cristiani e musulmani, uno dei temi principali del film, vissuta dai monaci. La decisione dei monaci di rimanere è infatti una scelta che si fonda sui legami con i loro vicini musulmani e sulla loro volontà d’essere fedeli a una società musulmana lacerata da una crisi che coinvolgeva tutto e tutti. Tuttavia occorre riconoscere che c’è una distanza tra il film e la realtà. Noi che abbiamo conosciuto i monaci, che abbiamo frequentato tanto spesso quei luoghi e contemplato i paesaggi, dobbiamo innanzitutto abituarci a un diverso scenario. In effetti non è troppo difficile, soprattutto quando la recitazione degli attori ci permette di riconoscere le figure molto ben evocate di fratel Luc (Michael Lonsdale) o di fratel Amédée (Jacques Herlin) o di fratel Michel (Xavier Maly). È più difficile quando si tratta di ritrovare Christian de Chergé nella recitazione di Lambert Wilson o fratel Christophe (Olivier Rabourdin) nella parte del monaco tormentato dal rischio della morte, che gli è affidata dalla sceneggiatura. Immagini tratte da alcune scene del film. Vi sono poi due difficoltà più grandi che si presentano a noi che abbiamo vissuto con loro tutto quel periodo. Il film ha scelto di puntare la cinepresa sui monaci, e questo ha creato la maggior parte del successo presso il pubblico, che scopriva così un problema di coscienza e di fedeltà nei confronti di tutta la comunità. Ma possono in questo modo gli spettatori comprendere che il rischio che minacciava i monaci era lo stesso che gravava su tutta la popolazione? Ogni algerino – ogni cristiano – all’epoca della crisi dei gruppi armati era ugualmente, quotidianamente messo davanti alla propria morte, e non solo i monaci. Seconda difficoltà. I monaci non erano soli. Avevano il sostegno dell’ordine cistercense e della Chiesa d’Algeria. Ogni singola decisione, maturata attorno al tavolo del capitolo – cosa che il film mostra – era anche una decisione riflettuta con la diocesi, con l’Ordine cistercense e con l’Unione dei superiori di cui Christian era in quel momento il presidente. La nascita di Tibhirine I legami del monastero di Tibhirine con la Chiesa d’Algeria erano, infatti, particolarmente stretti. La presenza trappista risale al 1840, quando l’Ordine cistercense si stabilì in un villaggio situato a 30 km da Algeri e che doveva per questa ragione chiamarsi «La trappa». Padre Charles de Fou- cauld, allora trappista, ebbe a passare da questo monastero nel 1900, prima di prendere dimora come eremita a Beni Abbès. Tuttavia la separazione tra stato e Chiesa avviata in Francia nel 1905 e le misure conseguenti contro gli ordini religiosi spinsero i monaci a scegliere di partire dall’Algeria. Una nuova comunità cistercense ritornò negli anni Trenta e s’installò nella regione di Medea, prima a Ben Chicao e poi, nel 1937, a Tibhirine. A seguito dell’indipendenza dell’Algeria (1962), l’abate generale dei cistercensi decise la chiusura del monastero, affermando che l’ordine non poteva mantenere una propria presenza in un paese diventato quasi totalmente musulmano. Ma il card. Duval, allora arcivescovo di Algeri, ottenne l’annullamento di questa decisione. Da allora la comunità di Tibhirine prese progressivamente una forma di vita che ne ha fatto un vero e proprio simbolo della nostra vocazione cristiana in Algeria. Infatti, i monaci formavano una comunità cristiana e monastica attraverso il segno della preghiera cristiana, del servizio evangelico e dell’incontro senza pregiudizi con un vicinato quasi totalmente musulmano. Era la medesima vocazione della nostra Chiesa d’Algeria dopo la partenza per l’Europa della quasi totalità dei suoi fedeli. È per questo che la maggior parte dei cristiani praticanti delle quattro diocesi dell’Algeria cercava ogni occa- sione per passare di lì per un periodo di ritiro o per un week-end spirituale. Peraltro p. Christian de Chergé, divenuto abate del monastero – o priore – manteneva una corrispondenza di direzione spirituale molto ampia con numerosi preti, religiosi e laici. Aveva inoltre un ruolo molto importante nelle iniziative dell’Unione dei superiori maggiori d’Algeria, pur rimanendo strettamente legato alla piccola parrocchia vicina di Medea, il cui parroco, p. Gilles Nicholas, andava in visita ai monaci quasi ogni settimana. Più in generale il monastero era in stretto legame con le quattro diocesi d’Algeria. Un anno i padri Giovanni della croce e Christophe predicarono un ritiro spirituale ai vescovi dei quattro paesi del Maghreb. Un altro anno i preti della diocesi di Orano vennero al monastero per il loro ritiro spirituale annuale. Un altr’anno ancora fu p. Piroird, vescovo di Constantine, a predicare un ritiro ai monaci. Successivamente p. Sanson, gesuita di Algeri, fece altrettanto. Nel 1988 p. Claude Rault, oggi vescovo di Laghouat, fondò a Tibhirine il gruppo spirituale islamo-cristiano «Ribâta es-Salâm» («Legame della pace»). I rapporti col Maghreb si allargarono ancora dopo la fondazione della piccola comunità collegata di Fès (Marocco, oggi a Midelt). In breve: pochi monasteri possono vantare una relazione così stretta con la propria Chiesa locale. IL REGNO - AT T UA L I T À 18/2010 593 Chies a in una società musulmana Personalmente, in quanto sacerdote della diocesi d’Algeri avevo con i monaci i legami che avevano tutti, ma la mia relazione con il monastero si approfondì quando divenni loro vescovo. Infatti, dopo essere stato nominato vescovo di Orano dal 1973 al 1981, ritornai ad Algeri, prima come coadiutore del cardinale di Algeri e poi, dal 1988, come arcivescovo. Da allora, ogni due mesi, avevo il dovere d’andare al monastero. D’altra parte p. Christian de Chergé passava spesso da Algeri e faceva in modo, quasi ogni volta, d’incontrarmi. Quindici giorni prima del suo rapimento, l’8 marzo 1996, gli domandai di animare una giornata di ritiro spirituale per i laici della diocesi. Quando mi recavo al monastero, p. Christian aveva pronta una lista di quindici o venti punti di cui voleva parlarmi. Allora facevamo una panoramica delle domande che si ponevano a lui, al monastero, ma anche nella diocesi o anche su tutta l’Algeria. Questo scambio mi mostrava fino a quale punto p. Christian fosse attento a tutto quello che faceva parte della vita delle nostre comunità cristiane in Algeria e particolarmente preoccupato della vocazione propria di ciascuna persona. Ci metteva anche a parte dei suoi interventi durante le consultazioni con l’Ordine cistercense, nel corso delle 594 IL REGNO - AT T UA L I T À 18/2010 quali egli difendeva la vocazione della nostra Chiesa a una presenza evangelica in una società musulmana. Ma ciò che per noi era particolarmente commovente era la qualità dei legami umani e spirituali che i monaci avevano saputo stabilire con il loro vicinato musulmano. Avevano relazioni con la maggior parte degli abitanti del villaggio di Tibhirine, che poco a poco si erano abituati a riconoscere nei loro vicini trappisti dei fratelli in Dio, anche se loro erano musulmani e i monaci cristiani: relazioni di malati con fratel Luc, medico, il cui dispensario frequentavano, visite al fratello guardiano, Amedeo, o a un altro, per farsi compilare i moduli, lavoro in comune con fratel Christophe, incaricato del giardino, o con fratel Paul, le cui competenze di idraulico erano conosciute da tutti. Alcuni sapevano anche condividere con fratel Christian le loro preoccupazioni spirituali e comunque tutti riconoscevano il valore della preghiera dei monaci e contemporaneamente approfittavano della sala di preghiera che il monastero aveva preparato per loro aprendo una stanza del monastero che dava sulla strada. Quando la situazione è diventata più grave, a partire dal 1992, io mi recavo ovviamente al monastero dopo ogni nuovo avvenimento: per esempio dopo la prima visita di un gruppo armato il 24 dicembre 1993, o in occa- sione delle pressioni delle autorità perché i monaci lasciassero quei luoghi, o in occasione delle votazioni della comunità per decidere sul futuro della loro presenza. A due riprese il padre abate mi chiese di ricevere singolarmente ciascuno dei monaci per verificare la libertà delle decisioni che essi prendevano di rimanere, nonostante i pericoli che circondavano il monastero. Il loro rapimento nella notte tra il 6 e il 7 marzo fu una grande prova non solamente per la comunità cristiana, ma anche per tutta la società algerina. Tutti i nostri amici algerini ci hanno rassicurato fino alla fine, persuasi che i rapitori avrebbero rispettato la loro vita. Dopo l’annuncio della loro morte, il 21 maggio 1996, abbiamo ricevuto moltissime testimonianze di simpatia di persone molto diverse della società algerina. Ed è stato allora che il mistero della generosità monastica di cui essi vivevano, nascosti, in una regione isolata del Titteri si è rivelato al mondo, innanzitutto attraverso il testamento di Christian e poi grazie a diverse testimonianze come quelle della famiglia cistercense o anche come quella della nostra Chiesa d’Algeria. Tuttavia queste domande che mi pongo riguardo al film, proprio perché ho vissuto con loro tutto questo tempo, non m’impediscono d’esprimere la mia riconoscenza a tutti coloro che hanno realizzato questo capolavoro. La vocazione della nostra Chiesa a vivere un incontro umano e spirituale con i fratelli e le sorelle algerini e musulmani, attraverso la fedeltà al Vangelo, non è mai stata così apertamente manifestata e così ampiamente scoperta al di là della nostra piccola cerchia di cristiani d’Algeria. È un dono di Dio (e degli autori e degli attori) che capita opportunamente, proprio nel momento in cui alcuni vogliono far credere che non è possibile un futuro comune tra credenti di diverse religioni. Henri Teissier * * Arcivescovo emerito di Algeri. 1 Regia di Xavier Beauvois; la distribuzione in Italia è di Lucky Red. Esce in Italia "Uomini di Dio" I monaci di Tibhirine e il sondaggio dell'"Economist" di Lucetta Scaraffia L'ultimo numero dell'"Economist" presenta i risultati di un sondaggio fatto presso i lettori a proposito della religione. È stato loro chiesto, infatti, se ritenevano la religione forza "per il bene" oppure nociva. Le ragioni delle parti sono state difese sull'autorevole rivista britannica da due giornalisti, ma Mark Oppenheimer, che è intervenuto per la religione, non è stato molto convincente. Ha portato tre motivazioni a favore, di cui una decisamente originale e difficilmente sostenibile: "La religione diverte". Non c'è quindi da stupirsi se la netta maggioranza dei lettori - precisamente il 75 per cento - ha votato contro. Sono certa che se agli stessi lettori fosse stato mostrato il film di Xavier Beauvois Uomini di Dio - più bello è il titolo originale, Des hommes et des Dieux - avrebbero espresso un'opinione diversa. Questo film - che in Francia ha ottenuto un grande successo, fino a raggiungere i due milioni e mezzo di spettatori - racconta infatti in modo semplice e reale, senza risvolti agiografici, la vita e la morte dei monaci cistercensi di Tibhirine, sulle montagne del Maghreb. Una vita semplice, dedicata ai lavori manuali, che garantiscono la loro sopravvivenza, allo studio e, naturalmente, per gran parte della giornata riservata alla preghiera. I monaci non hanno la missione di evangelizzare, ma solo quella di portare una testimonianza d'amore e di preghiera. La loro vita quotidiana è quindi semplice: essi vogliono essere solamente "un segno sulla montagna" e non un'opposizione, un segno di fratellanza con un popolo in gran parte musulmano. Si scontrano però con lo scoppio dell'ostilità fra un Governo, che viene definito corrotto, e una ribellione fondamentalista. I monaci sanno a cosa andranno incontro, e umanamente hanno paura. Alcuni - i più giovani pensano di andarsene, come sollecita il Governo. Ma il superiore chiede loro un tempo di riflessione, e questo periodo servirà per arrivare, tutti, alla stessa decisione: restare e affrontare il martirio. Il percorso che li porta alla scelta è ben narrato, per tutti simile e per ognuno diverso, e mirabilmente rappresentato in un'ultima cena che li vede riuniti e durante la quale - sorseggiando un bicchiere di vino che già simboleggia il sacrificio - ciascuno di loro rifletterà nel volto la paura per ciò che lo aspetta e la serenità della decisione presa. La caratteristica più bella del film è che mostra i monaci come uomini comuni: con le debolezze e le paure degli uomini comuni, esseri umani come noi, fragili, che nel corso di giornate sempre più cupe attingono coraggio dalla preghiera. È infatti nel canto dei salmi e nelle orazioni che trovano la risposta che cercano: non possono lasciare la popolazione del villaggio con la quale hanno vissuto fino ad allora. Non nel momento del bisogno. Il loro messaggio sarà chiaro: per amore dei musulmani del Maghreb accettano di andare incontro al martirio, dimostrando così che il conflitto fra le religioni, come ogni conflitto, si può annullare con un atto di amore. In questo film abbiamo la religione cattiva - cioè la distorsione fondamentalista che ripugna agli stessi credenti musulmani - e quella buona messe a confronto, in una narrazione che sa farci vedere quanta luce può irradiare una scelta di amore totale. Anche i lettori dell'"Economist" avrebbero avuto molte difficoltà a ignorarlo. (©L'Osservatore Romano - 22 ottobre 2010) http://www.vatican.va/news_services/or/or_quo/text.html#9 Esce nelle sale italiane "Des hommes et des Dieux" di Xavier Beauvois Otto uomini Il film francese candidato agli Oscar di Emilio Ranzato Otto monaci francesi dell'ordine cistercense vivono in un monastero fra le montagne del Maghreb algerino. In perfetta armonia con la comunità musulmana locale, condividono le gioie e le difficoltà di chi li circonda. L'equilibrio spontaneo della regione si incrina quando un gruppo di fondamentalisti uccide alcuni lavoratori stranieri. Ci vuole poco perché l'attenzione dei terroristi si concentri sul monastero, malgrado chi lo abita svolga solo funzioni di preghiera e di meditazione, e non di proselitismo. Quando gli otto religiosi entrano in contatto con il gruppo armato, lo fanno con la stessa naturalezza che contraddistingue i loro rapporti quotidiani, prestando anche soccorso a un ferito. La loro vita sembra dunque proseguire come sempre, tanto che decidono di rifiutare la proposta di una scorta da parte dell'esercito. Se le semplici abitudini del monastero rimangono immutate, la tensione nella regione continua però a crescere e alcuni cittadini cominciano a scappare. A questo punto i monaci sono costretti a interrogarsi sull'opportunità di abbandonare il luogo. Il priore Christian - un sorprendente Lambert Wilson, conosciuto dal grande pubblico per aver partecipato in tutt'altre vesti alla saga di Matrix - propone di rimanere per proseguire la missione cui sono stati preposti, ma in un primo tempo il timore generale sembra avere la meglio. La decisione sarà graduale e sofferta, eppure alla fine quasi unanime. Otto monaci ma soprattutto otto uomini. Ognuno con le proprie caratteristiche, le proprie qualità e i propri limiti. Li vediamo assorbiti nella loro devozione, ma anche allegri o litigiosi. In tutta la loro umanità, insomma. Tanto che quando il pericolo si affaccerà alle porte del monastero, la prima cosa che ci si chiederà è come faranno a farvi fronte. Presi uno per uno, forse nemmeno loro saprebbero dare una risposta. Tutti insieme, però, la troveranno. Pur ispirandosi in modo esplicito alla tragedia di Tibhirine del 1996, quando dei monaci francesi furono vittime del Gia (il Gruppo Islamico Armato) in un'Algeria attraversata da profonde divisioni, quello firmato da Xavier Beauvois vuole essere solo in superficie un film di cronaca storica. Anzi, la bellezza di Uomini di Dio risiede soprattutto nel modo in cui si passa sottilmente e in modo impercettibile da uno sguardo naturalistico e quasi documentario - assecondato da una direzione degli attori tutt'altro che dispotica - a una dimensione sempre più metaforica. Gli stessi terroristi vengono mostrati in modo diretto solo in un paio di occasioni, e in atteggiamenti non dichiaratamente bellicosi, salvo poi essere relegati sempre più sullo sfondo, fino a diventare quasi la trasfigurazione del tormento interiore dei protagonisti. Per quest'idea di adombrare una violenza invisibile su un paesaggio tanto in armonia da farla apparire ancora più insensata e irreale, a tratti il film ricorda La sottile linea rossa di Terrence Malick. Così come per la volontà di conciliare le istanze ideologiche riconoscibili soprattutto nel sottolineare come un terreno comune fra fedeli di religioni diverse sia assolutamente possibile - con quelle simboliche: mentre ci viene raccontato che la tensione attorno a loro cresce in maniera esponenziale, vediamo gli otto monaci sempre più soli, alle prese con una indecisione che si porta dietro interrogativi pratici ma anche filosofici, e che attengono alla natura stessa del loro ruolo nel mondo: la libertà è di chi riesce a fuggire o di chi rimane saldamente ancorato alla propria missione? È giusto aderire al proprio ruolo fino alle estreme conseguenze? L'intero film è d'altronde disseminato di sottili corrispondenze che compensano un tessuto narrativo e drammaturgico volutamente ellittico e avaro di dettagli realistici, che alla lunga sarebbero risultati senz'altro invadenti. I paesaggi su cui la cinepresa indugia sempre un attimo in più di ciò che è consueto, lasciandoli respirare di vita propria anche quando i personaggi hanno lasciato la scena, è infatti strettamente legata alla vita dei monaci cistercensi, votata, fra l'altro, alla contemplazione della natura. Così come l'unanimità della loro decisione finale fa da pendant alle numerose scene in cui li vediamo impegnati nella preghiera corale. E proprio la scena cruciale e bellissima della presa di coscienza di ciò che è giusto fare ci viene raccontata senza una riga di dialogo, sulle note commoventi ma anche orgogliose del Lago dei cigni di Cajkovskij, come il silenzio e il canto liturgico accompagnano la vita dei monaci. E se alla fine qualcuno disattenderà la promessa fatta reciprocamente, ciò non farà che conferire ulteriore umanità al loro sacrificio, raccontato dal regista e dal suo sceneggiatore Etienne Comar senza cadere mai nella trappola del facile eroismo. "La mia vita non ha più valore di un'altra. Non ne ha neanche meno" si legge d'altronde nell'umanissimo e per questo ancora più toccante testamento spirituale del vero frère Christian. È forse per questo pudore che a tratti il film dà l'impressione di osare meno di quanto potrebbe, ma le ultime due o tre sequenze riescono a dare al risultato complessivo il colpo d'ala che ci si aspettava, con una soluzione enigmatica - ricordiamo che non è stata mai fatta pienamente luce sulla fine dei monaci di Tibhirine - ma anche poeticamente rasserenante. Dopo aver vinto il gran premio della giuria all'ultimo festival di Cannes, il film è stato selezionato come candidato per la Francia ai prossimi premi Oscar. (©L'Osservatore Romano - 22 ottobre 2010) http://www.vatican.va/news_services/or/or_quo/text.html#9 LA RECENSIONE DEL FILM “UOMINI DI DIO” DI XAVIER BEAUVOIS (Francia, 2010) A cura di Giona A. Nazzaro, apparsa su Micromega - ottobre 2010 Il cinema di Xavier Beauvois è un oggetto pressoché sconosciuto in Italia, nonostante l’elevata qualità dei risultati ottenuti dal regista nel corso degli anni. Dal lontano 1991, anno in cui Beauvois si fa notare con l’ottimo Nord, la sua progressione è costante al punto che si trova coinvolto in prima persona nel complesso processo del costante rinnovamento del cinema francese. Uomo di cinema in grado di passare con grande facilità davanti alla macchina da presa, Beauvois è anche un ottimo attore cosa evidenziata da una filmografia che comprende titoli del valore di Le ciel de Paris di Michel Bena, Ponette di Jacques Doillon, Le vent de la nuit di Philippe Garrel e Villa Amalia di Benoit Jacquot. Ed è in veste di regista e interprete che dirige quattro anni N’oublie pas que tu vas mourir, potente apologo intrecciato alla vita e alla morte che osa unire in un unico arco narrativo la guerra nei Balcani e il dramma di un uomo che scopre d’essere sieropositivo. Presentato a Cannes, il film suscita grande scalpore sia a causa della franchezza con cui Beauvois mette in scena la sessualità che per la visione particolarmente cruda, scevra di qualunque concessione al politicamente corretto, che fornisce della guerra nell’ex Jugoslavia. Anche i successivi Selon Mathieu (2000) e Le petit Lieutenant (2005) evidenziano la bontà e, soprattutto, l’irrequietezza dello sguardo di Beauvois, confermandone inoltre quale tratto dominante un’asperità che sembrerebbe avvicinarlo al magistero di Maurice Pialat. Ciò che dai detrattori del regista viene definita come “rozzezza” è in realtà la caratteristica distintiva di un approccio alla materia filmica potentemente ancorata ai corpi e agli ambienti naturali. Ed è esattamente questa caratteristica a fare la forza di Des hommes et des dieux, il nuovo film di Beauvois, presentato quest’anno in concorso a Cannes che la distribuzione italiana ha intitolato in maniera riduttiva Uomini di Dio. Il film rievoca la strage di sette monaci cistercensi di Tibihrine sullo sfondo della guerra civile in Algeria nel 1996. La Al-Jama’ah al-Islamiyah al-Musallaha, il gruppo armato che mira a rovesciare il governo, rivendicò la responsabilità dell’eccidio, ma fonti francesi hanno sempre ritenuto plausibile l’ipotesi che i religiosi siano stati trucidati da reparti dell’esercito algerino nel quadro o di una strategia della tensione o di un banale “errore”. Il progetto, nato per volontà del produttore cattolico Etienne Comar, è affidato a Beauvois che nel corso di un dettagliato lavoro di ricerca, durante il quale si confronta con teologi e religiosi, sceglie di trascorrere un periodo nel convento cistercense di NotreDame de Tamié fondato nel 1132 da Pietro di Tarentaise. Evidentemente una materia simile, in altre mani, sarebbe stata lo spunto privilegiato per una qualunque agiografica fiction religiosa prodotta da Mediaset o dalla Rai. Cosa in sé abbastanza curiosa, considerata che pur essendo un paese profondamente cattolico, e tranne qualche eccezione del valore di Giovanni Testori, l’Italia non è mai stata in grado di produrre un discorso sulla fede che non fosse inevitabilmente confessionale e normativo. In Francia, invece, esiste una tradizione di spiritualità potente e se si vuole anche violentemente conservatrice – si pensa per esempio a Leon Bloy, oppure, sull’altro estremo dello spettro politico, a Jean Genet – che nel cinema ha dato vita al magistero del cinema di Robert Bresson influenzando profondamente il pensiero stesso della nouvelle vague attraverso gli insegnamenti di André Bazin. Una corrente di pensiero che ha prodotto risultati altissimi come Sotto il sole di Satana di Maurice Pialat tratto dall’omonimo romanzo di Bernanos. Inevitabilmente il film di Xavier Beauvois s’innesta quindi in una tradizione di religiosità critica o comunque problematica in grado di dialogare anche con il versante laico della società. Infatti, pur essendo nato chiaramente per celebrare il sacrificio dei monaci, il film di Beauvois s’afferma prima di tutto come opera determinata da uno specifico cinematografico che se da un lato sviluppa e amplia il cinema precedente del regista, dall’altro si confronta con una serie di modelli estremamente impegnativi che vanno da John Ford (Missione in Manciuria) a Dreyer e Bresson. A Beauvois dunque riesce l’impresa di realizzare un film profondamente religioso, onorare la morte dei monaci e al tempo stesso di metterne in luce umanità e debolezze, anche ideologiche, senza per questo cadere nel tranello, tipicamente parrocchiale, dei difetti umani che inevitabilmente esaltano la forza della fede o del fedele. No. Beauvois coglie con grande fermezza degli uomini nell’agone della storia. Evidenzia i mezzi che questi hanno a disposizione per contrastare la violenza, il tentativo di porsi in comunicazione con i portatori di altre divinità per poi non potere fare altro che seguire le tracce del martirio. Beauvois però non esalta il martirio e non cede alla tentazione della mistica della morte bella. I monaci accettano la morte muovendo da convinzioni che per quanto nobili, sia sul piano individuale e collettivo, sono comunque il frutto di un pensiero che contempla la morte come parte integrante del proprio discorso. In questo senso vittime e carnefici si riconoscono potenzialmente simili nel loro essere per la morte. La politica, in parte accennata dalle aperture dello sguardo di padre Luc, non partecipa di questa dialettica. Il conflitto del film, squisitamente politico, è combattuto con le armi inadeguate della fede. Resta quindi solo una testimonianza di morte. E i sacrificati riconoscono le armi di coloro che uccidono. Un conflitto dell’identico. La straordinaria capacità di Beauvois di calarsi nella vicenda è data dalla commozione con la quale il regista filma ciò che il protagonista Lambert Wilson ha definito “l’elemento federativo del canto” e la forza di un territorio inospitale. Beauvois coglie il momento dell’angoscia dei suoi protagonisti e nel farlo riesce a dare una risposta cinematografica alla domanda di Gesù che chiedeva ai suoi discepoli se non fossero in grado di vegliare con lui neanche un’ora. Beauvois sta al fianco degli uomini che ha scelto di filmare. Lo fa con un cinema eticamente motivato e filmicamente evoca il magistero di Dreyer nell’ultima cena dei monaci regalandoci uno dei pochi attimi di cinema trascendentale degli ultimi anni. Non c’è bisogno d’essere credenti per apprezzare il film di Beauvois anche se è prevedibile la corsa all’appropriazione del martirio che purtroppo pare sia già iniziata con la scelta infelice del titolo italiano. Uomini di Dio significa infatti esattamente il contrario di Des hommes et des dieux. Non solo l’originale francese antepone gli uomini alle divinità, ma nella scelta del plurale accoglie anche il resto dell’umanità. Invece il subdolo Uomini di Dio ribadisce l’idea di un dio unico eliminando la dialettica di una possibile alterità. Ed è proprio quando gli uomini di Dio affrontano altri uomini di Dio che sorgono le guerre e gli uomini iniziano di nuovo a pensare di poter imporre ad altri uomini il presunto volere del loro Dio. La vicenda dei monaci di Tibhirine è raccontata nel libro Più forti dell’odio, di Frère Christian de Chergé (edito in Italia nel 2006 da Qjqajon, con una prefazione di Enzo Bianchi). Cultura 20 ottobre 2010 CINEMA E MARTIRI «Uomini di Dio»: il vero film dei magnifici 7 All’ultimo Festival di Cannes ha profondamente commosso il pubblico internazionale raccontando la vita quotidiana di un gruppo di monaci trappisti nell’Algeria degli anni Novanta. E non ha lasciato indifferente neppure la giuria presieduta da Tim Burton, che gli ha assegnato il prestigioso Grand Prix. Perché «Uomini di Dio» di Xavier Beauvois, fortemente voluto dal produttore cattolico Etienne Comar, nelle nostre sale dal 22 ottobre, è un perfetto esempio di come si possa fare grande cinema affidandosi, proprio come facevano Robert Bresson e Carl Dreyer, ai silenzi, agli sguardi, alla spiritualità e a temi che affrontano le grandi domande dell’uomo drammaticamente calato nell’arena della storia. Il film, opera profondamente religiosa, rievoca infatti la drammatica vicenda dei religiosi rapiti e assassinati a Tibhirine, sulle montagne dell’Atlante, nel marzo del 1996, ancora oggi al centro di una complessa indagine giudiziaria riaperta dopo il reportage del giornalista americano John Kiser. Se infatti la strage era stata inizialmente attribuita al Gia (Gruppo Islamico Armato), in una fase processuale successiva si è invece parlato di un «errore dell’esercito algerino». La verità è ancora da stabilire, ma il regista non si addentra nella controversia, evitando di fare del film un thriller politico su un intrigo internazionale; non mostra le teste ritrovate senza i corpi (anche per rispetto alle famiglie delle vittime l’atrocità della loro morte resta fuori campo e la storia si conclude con una scena ricca di emozione) e non fa dei protagonisti dei martiri da strumentalizzare. Non estraneo alle riflessioni sulla vita e la morte (N’oublie pas que tu vas mourir), Beauvois – che si è confrontato con religiosi e teologi trascorrendo un periodo nel convento cistercense di Notre-Dame de Tamié – si concentra piuttosto (come il bel documentario Il grande silenzio di Philip Gröning) sulla quotidiana vita monastica dei protagonisti, corpi immersi nella natura tra lavoro, preghiere, canti, pasti e impegno per il prossimo, secondo una ritualità capace di unire il cielo e la terra. Perfettamente integrati in terra musulmana, i monaci guidati dal priore Christian de Chergé sono «fratelli» degli islamici di cui si prendono cura e con i quali recitano anche passi del Corano («Amen» è sempre seguito da «inshallah»), testimoniando con la propria vita un amore per l’umanità che va oltre le barriere culturali e religiose. Una vocazione ben resa dal titolo originale del film, Des hommes et des dieux, e in parte tradita da quello italiano. Il 30 ottobre 1994 il Gia ordinò a tutti gli stranieri di abbandonare l’Algeria, ma quei monaci decisero di restare al fianco di chi aveva bisogno di loro, convinti di non poter tradire la loro fede e la fiducia in una comunità basata sulla tolleranza. «Non temo la morte, sono un uomo libero» dice Lambert Wilson nei panni di padre Christian. La forza, il rigore e il coraggio del film stanno proprio in questo, nella decisione di riflettere sulla difficoltà di una scelta non priva di dubbi, angosce e tensioni. E di offrire a un pubblico abituato a velocità ed effetti speciali, adrenalina e 3D un mondo fatto di lentezza, contemplazione e popolato di persone capaci di un amore e una compassione straordinari, pronti all’estremo sacrificio pur di dedicare la propria vita agli altri. Ritiratisi per alcuni giorni nella pace del monastero prima dell’inizio delle riprese, gli attori hanno più volte dichiarato di aver sentito su di loro la protezione e la fratellanza dei religiosi a cui stavano per ridare vita. E non c’è bisogno di essere credenti per sentire in quei personaggi una verità che viene da lontano. Alessandra De Luca
Scaricare