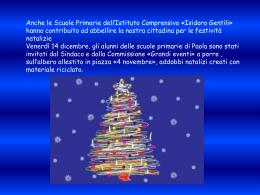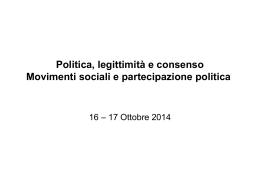Il "Che Guevara" controlacrisi.org di 8 ottobre 2012 - 08/10/2012 miogiornale.com Venezuela, Chavez rieletto Presidente! Partecipazione popolare record. 08/10/2012 di A. F. (controlacrisi.org) Hugo Chavez con il 54,42%, vale a dire 7.444.082 voti, è stato rieletto presidente del Venezuela. Ad annunciarlo, con la prima newsletter ufficiale, il presidente del Consiglio Nazionale Elettorale (CNE) del Venezuela, Tibisay Lucena. Il candidato sfidante Henrique Capriles ha ottenuto solo il 44,97%, vale a dire 5.446.151 voti. Chávez è stato rieletto per la terza volta, per un periodo di sei anni, dal 2013-2019. "Vogliamo sottolineare ancora una volta il comportamento civile e democratico del popolo di tutto il Venezuela. Abbiamo completato una pagina brillante nella democrazia venezuelana", ha detto Lucena, che ha aggiunto: "abbiamo avuto un processo pacifico elettorale, con la gioia delle persone che hanno deciso di uscire e votare in maniera massiccia" evidenziando che in queste elezioni si è registrata la più alta partecipazione degli ultimi decenni. I sostenitori del capo dello Stato uscente, che guida il Paese dal 1998, stanno festeggiando la vittoria per le strade del Paese. Hugo Chávez ha vinto nonostante le calunnie diffamatorie della stampa internazionale. Come aveva scritto bene pochi giorni fa Mélenchon, queste diffamazioni sempre più infami "testimoniano della disperazione degli avversari della rivoluzione bolivariana di fronte alla prospettiva di una nuova vittoria elettorale di Chávez. Un leader politico deve essere giudicato per le sue azioni, non per le voci messe in giro contro di lui. I candidati fanno promesse per essere eletti: pochi sono quelli che, una volta eletti, le mettono in pratica. Fin dall’inizio, la promessa elettorale di Chávez è stata molto chiara: lavorare a favore dei poveri, ossia – da quelle parti – la maggioranza dei venezuelani. E ha mantenuto la parola". Affacciato al balcone di palazzo Miraflores ( video ), Hugo Chavez ha celebrato la sua rielezione a presidente del Venezuela sottolineando che e' stato un "giorno memorabile" che lo ha condotto ad una vittoria "perfetta". Chavez, che ha ringraziato il suo popolo ha chiesto a Dio "vita e salute" e, senza citare direttamente il suo avversario Herique Capriles, si e' complimentato con l'opposizione "perche' ha riconosciuto la verita' della mia vittoria, la vittoria del popolo" e ha invitato i suoi avversari al dialogo. Leggi pure Perché Chavez? Ma che c'entrano le primarie con la democrazia diretta? 07/10/2012 di raul mordenti Credo che la questione delle primarie abbia assunto un tale rilievo politico e mediatico (paginate e paginate sui quotidiani!) da rendere necessaria una seria discussione fra compagni/e. Vorrei contibuire a favorire questa discussione dicendo la mia, sperando che altri/e, magari con posizioni diverse, vogliano intervenire. Dunque le primarie sono una istituzione americana che serve a designare un candidato Presidente all’interno dei due partiti democratico e repubblicano. Faccio notare che neppure la iper-presidenzialista Francia sceglie il candidato Presidente con le primarie, e meno che mai ricorrono a tale strumento altre democrazie europee, come la Germania o l’Inghilterra o la Spagna etc. Faccio notare ancora che negli Stati Uniti si eleggono con le primarie dei delegati (non è dunque affatto una votazione diretta o di primo grado!) e, specialmente in passato, è accaduto che le Convenzioni modificassero, o anche ribaltassero, i risultati delle primarie, da qui l’estrema importanza delle Convenzioni dei partiti che – queste sì! – nominano il candidato alla presidenza. L’oggetto delle primarie di cui si parla adesso da noi è la candidatura a Presidente del Consiglio (e mi permetterei di proporre – già che ci siamo – di chiamare questa carica con questo suo nome costituzionale, e non “premier” e meno che mai “Capo del Governo” come dicevano di sè Mussolini e poi Craxi: le parole in politica contano, perché corrispondono a concetti). E già qui sorge un rilevante problema, giacché la designazione di tale carica spetta, per la nostra Costituzione al Presidente della Repubblica (art. 92 della Costituzione: “Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri”). È il Presidente della Repubblica, non certo il popolo delle primarie e nemmeno l’elettorato, a scegliere il Presidente del Consiglio; fermo restando che il Presidente del Consiglio nominato deve avere la fiducia di entrambe le Camere, ed è una buona prassi, ormai consolidata, che prima di scegliere il Presidente del Consiglio il Presidente della Repubblica consulti i Gruppi parlamentari, che gli rappresentano gli orientamenti delle due Camere. Perché accade questo? Perché la nostra Repubblica è stata voluta dai padri costituenti come una Repubblica parlamentare, in cui cioè la sovranità popolare elegge un Parlamento e non una persona o un capo. 08/10/2012 1 di 8 Per noi comunisti (ma, direi, per tutti i sinceri democratici) è assolutamente evidente quanto sia stata giusta e lungimirante questa scelta dei Costituenti, che avevano conosciuto il fascismo e volevano impedire che si potessero riproporre forme di potere personale, sempre anticamera delle dittature (e pensiamo che cosa sarebbe successo se Berlusconi avesse potuto sostenere legittimamente una diretta investitura popolare sulla sua persona!). Da questo punto di vista, oso dire che anche la dizione “Per Tizio Presidente” che compare nel simbolo di alcuni (troppi!) partiti è al limite della costituzionalità, perché (ripeto, ripeto!) l’elettorato non è chiamato affatto a eleggere un Presidente del Consiglio bensì a eleggere un Parlamento, il quale Parlamento poi darà, oppure negherà, la sua fiducia a un Presidente del Consiglio scelto, anzi nominato!, dal Presidente della Repubblica. E infatti secondo la nostra Costituzione sarebbe del tutto legittimo che, dopo aver consultato i Gruppi parlamenari, un Presidente della Repubblica desse l’incarico di formare il Governo a una persona diversa dal leader del Partito che ha vinto le elezioni (naturalmente purché questa persona abbia la fiducia della maggioranza del Parlamento). Questo primo punto, che definirei di elementare cultura giuridica e costituzionale, mi sembra dunque già di per sé testimoniare contro il ricorso alle primarie, uno strumento improprio e, dunque, anche pericoloso, perché minaccia di turbare il delicato equilibrio costituzionale fra i poteri democratici dello Stato e di prefigurare (anzi di praticare già!) una Repubblica presidenziale, un “uomo solo al comando” legittimato personalmente dal voto popolare, che è l’esatto contrario di ciò che la Costituzione antifascista disegna. Ma veniamo al secondo punto: la primarie americane, che piacciono tanto ai nostri “americani a Roma”, sono interne ai due partiti; lì è del tutto ovvio che i candidati siano esponenti del partito alla cui investitura aspirano ed è anche del tutto ovvio che (per una consolidata tradizione) i votanti appartengano a quello stesso partito. Qui invece si parla di “primarie di coalizione”, in cui potrebbero votare tutti quelli che in qualche modo si riconoscono in quella coalizione. Se esaminiamo da vicino questa situazione ci rendiamo ben conto che ci troviamo di fronte al regno dell’assurdo. Intanto: di che coalizione si tratta? Quale è il suo programma? Quali i suoi confini? E, soprattutto, quali partiti ne fanno parte? Logica vorrebbe che prima ci fosse una coalizione e poi semmai questa, al suo interno, scegliesse il proprio candidato. Qui si propone, e si pratica, l’inverso: prima si sceglie il candidato Presidente e poi, se resta tempo, si definisce la coalizione e il suo programma. L’on. Tabacci, che è autorevole candidato alla primarie, fa parte oppure no della coalizione? E Vendola ne fa parte? In passato il PD rifiutò la candidatura di Marco Pannella con la (apparentemente ragionevole) obiezione che questi era esponente di un partito diverso. Questo argomento non vale più? Così come non vale più (e infatti si affretteranno a cambiarlo!) l’articolo dello Statuto del PD che afferma che il solo candidato di quel Partito alle primarie è il suo Segretario. Un’altra “stranezza”, degna di una comica finale e non certo di una democrazia seria: le primarie si dicono “di coalizione” ma le loro regole sono decise da un partito solo, il PD, che appunto ne sta discutendo in questi giorni (peraltro molto dopo l’inizio della campagna per le primarie!). Neppure l’esperienza insegna nulla: Forconi a Napoli vinse le primarie (lasciamo stare come) ma De Magistris, che non vi aveva partecipato, poi stravinse le elezioni vere. A Palermo la stessa situazione: Ferrandelli prevalse alle primarie ma poi (nonostante l’appoggio di Lombardo e di SEL) Orlando lo travolse alle elezioni vere; e altri analoghi esempi si potrebbero fare. D’altra parte l’esperienza romana di questi giorni parla chiaro: Zingaretti era un candidato credibile a fare il Sindaco: ma “qualcuno” – non certo le primarie – lo ha candidato invece “in mezz’ora” (come si è vantato l’on. Fioroni) a fare il Presidente della Regione Lazio, forse perché la carica di Sindaco deve essere scelta dal Vaticano. Le primarie allora si fanno solo se non servono a decidere davvero? Si dice ora che per votare alle primarie occorrerà prima sottoscrivere qualcosa e lasciare il proprio nome e indirizzo: a parte che questo contraddice un altro pilastro della Costituzione (ma costoro neppure l’hanno letta, e comunque se ne fottono), cioè l’art.48 (“Il voto è personale ed eguale, libero e segreto”), la domanda che sorge è: che senso ha tale sottoscrizione? Ci si impegna così a votare poi alle elezioni per quella coalizione, tuttora indeterminata e inesistente? E chi può impedire all’elettore di cambiare parere nel frattempo? Un fatto è tuttavia certo: le primarie impegnano in modo ferreo a sostenere quella “coalizione” almeno chi vi partecipa. Non è infatti possibile pensare, nemmeno nell’attuale degrado dell’etica politica, che uno si candidi come leader di una coalizione e poi, se sconfitto, non appoggi leamente il vincitore! Lo stesso vale, naturalmente, anche per i Partiti. E dunque: Vendola e SEL, appoggeranno il berlusconico Renzi o il democristiano Tabacci se uno di costoro vincerà le primarie? Oppure qualcuno pensa che potrebbe accadere l’inverso? Siamo seri, compagni di SEL, nessuno di voi può crederlo. Se un obiettivo ragionevole è possibile rintracciare nella partecipazione alle primarie, questo può consistere soltanto nell’intenzione di alzare un po’ il proprio prezzo, cioè di poter partecipare comunque a qualunque coalizione guidata dal PD (e dall’“agenda Monti”) trovando all’interno di questa un po’ di spazio in più per sistemare più comodamente il proprio sgabello. In conclusione: la democrazia diretta non c’entra proprio un bel nulla con questo incasinato balletto plebiscitario. Ormai è chiaro a tutti (almeno a chi voglia vedere onestamente le cose per quel che sono) che le primarie rappresentano solo un meccanismo che serve per umiliare ancora di più (come se ce ne fosse bisogno!) la democrazia costituzionale, la quale è fondata sul Parlamento e sui Partiti (sì, sui Partiti!), beninteso se, come il nostro, essi si sforzano di essere degni di questo onorato nome. Le primarie servono soprattutto per far pesare l’immenso potere mediatico e finanziario di alcuni “poteri forti” che (come dimostra il “caso” dello sciocco giovanotto democristian-berlusconico Matteo Renzi) sono perfettamente in grado, investendo soldi e consiglieri “di immagine” sufficienti, di creare dal nulla un candidato del nulla, e magari perfino di imporlo. 08/10/2012 2 di 8 Io credo che tutto ciò sia l’esatto contrario di quel complicato ma esaltante processo di partecipazione cosciente che noi chiamiamo democrazia diretta, e credo che da tutto ciò la sinistra debba tenersi ben lontana, anzi non stancandosi di denunciare l’ennesima truffa “tecnica” e “americana” ai danni delle masse popolari. Cercasi soggetto politico per ridare dignità al lavoro 07/10/2012 di Luce Manara (il manifesto) A pochi mesi dalle elezioni, la sinistra alternativa al «montismo» prova a ritrovarsi nelle urne Il ragazzo con la criniera bionda che parla a nome delle Officine Corsare – qui tra i trecento intervenuti al convegno l’età media è mediamente alta – strappa l’applauso quando dice che bisogna superare la dicotomia partito/movimento. Per uscire dal Novecento e tornare a farsi ascoltare. E perché non c’è più tempo da perdere – questo lo ripetono tutti – e la prossima primavera potrebbe essere maledetta. Il nodo da sciogliere, per semplificare la due giorni di studio ricca di interventi e suggestioni organizzati dall’ A.L.B.A. (Allenza per il lavoro, i beni comuni, l’ambiente), è questo. Ma essendo piuttosto ingarbugliato, ancora non si sa come uscirne vivi per costruire uno schieramento di sinistra plurale che non ci sta a rinchiudersi nel «montismo» dilagante. Si sa però da dove cominciare. Serve un contenitore, un movimento, forse anche «solo» un partito, capace di riportare al centro della politica il tema del lavoro, la vita calpestata di milioni di persone che stanno perdendo la dignità, la speranza e anche la bussola in vista delle prossime elezioni. La premessa di tutto questo ragionare (dopo i laboratori programmatici di ieri pomeriggio, oggi sono previste almeno cinque ore di discussione) è l’inadeguatezza di tutta questa sinistra che ormai ha smarrito la sua stella polare. La centralità del lavoro, appunto. Chi ci sta a ripartire? E come fa «il lavoro» a trovare il modo di essere rappresentato? Domande urgenti, anche perché forse non basta consolarsi sulla ritrovata unità per la campagna referendaria in difesa dell’articolo 18 (il 12 ottobre comincia la raccolta delle firme). L’ambizione, come spiega Marco Revelli nel suo intervento, dovrebbe essere quella di «immaginare un’alternativa di modello» sapendo che bisogna arrivare alla primavera con una idea condivisa per ridare speranza al lavoro, «una speranza che non esiste dentro il paradigma di questo governo sostenuto dal Pdl e dal Pd». Ma può l’A.L.B.A. candidarsi ad essere un riferimento elettorale? Forse non lo sanno neanche i militanti più convinti – vestiti di tutto punto con le nuove magliette dello «staff» – ma sicuramente qualcuno ci sta pensando di fronte alla desolante offerta dei partiti tradizionali. Il dibattito è aperto. C’è chi sostiene che da qualche parte bisognerà pur cominciare, anche tentando spericolate incursioni nelle urne, e chi invece teme la vocazione a rinchiudersi in gabbie autoriferite incomprensibili ai più. Unità modello Syriza o partitino? Questa, detta rozzamente, la discussione che oggi dalle 9,30 vedrà impegnati Landini, Gallino, Ginsborg, Rinaldini, Pepino, Gianni e altri ancora (al cinema Massimo di via Verdi 18). Ieri, invece, gli interventi hanno approfondito alcune tematiche condivise da tutti. I cosiddetti «punti fermi» (anche se nel chiuso di un convegno tra simili il rischio di parlarsi addosso è sempre in agguato). Mentre, dice qualcuno dello staff, la scommessa da vincere sarebbe farsi ascoltare là fuori, aggiornare i linguaggi, «fare società senza giocare solo in difesa». Giorgio Airaudo (Fiom, il sindacato ospite d’onore della due giorni torinese) parla chiaro. «Vogliamo risposte prima delle elezioni, i lavoratori devono utilizzare il loro voto per difendersi, bisogna unificare tutte le iniziative in difesa del lavoro ed è per questo che è sbagliato non indire lo sciopero generale perché servirebbe almeno a rompere la solitudine di tutte le vertenze sul territtorio. Il lavoro deve irrompere nella politica, in qualunque modo e in fretta, anche con azioni corsare». Altro applauso convinto. Roberta Carlini, invece, snocciola i dati di Sbilanciamoci per mettere in luce come le politiche di austerity colpiscano soprattutto le giovani donne. Piero Bevilacqua, in estrema sintesi, individua tre strade per uscire dalla crisi puntando sul lavoro: ripensamento dell’orario di lavoro (lavorare meno), reddito di cittadinanza e riconversione ecologica – tema cruciale per una sinistra moderna declinato anche da Carla Ravaioli, felice per una volta di non vedere «l’ambiente» relegato ai margini della discussione. Alberto Lucarelli punta sulla difesa dei beni comuni chiedendo che vengano inseriti in un patto elettorale per dare rappresentanza politica a una società civile che smarrita. Infine, verso sera – dopo i laboratori partecipati sulle imprese recuperate in Argentina e quelle abbandonate in Italia, sulla riconversione ecologica e sul reddito di cittadinanza – Giuliana Beltrame ha moderato una tavola rotonda sul tema «Lavoro di cura e cura del lavoro», perché l’uscita dal Novecento non può prescindere da una nuova riflessione sul femminile. Non siamo soli 06/10/2012 di Francesco Piccioni (il manifesto) Intervista a Francesca Re David (FIOM). A Roma con Fiom e Cgil perché «non c’è mai stato un governo così indifferente rispetto all’introduzione di elementi di politica industriale e di indirizzo» 08/10/2012 3 di 8 Come siete arrivati alla decisione di manifestare il 20 ottobre? La Cgil ha deciso di proclamare questa come giornata di mobilitazione e riunificazione delle lotte. Troviamo estremamente positivo che si ragioni sulla riunificazione delle vertenze, perché la situazione è drammatica da ogni punto di vista. Oltre alle singole situazioni, c’è un problema di totale assenza di politica industriale in questo paese. Il governo non sta svolgendo alcun ruolo in questo senso. Ogni volta sembra che cerchino soltanto un compratore, possibilmente straniero… Come si è visto dall’inizio della vicenda Fiat, si limita a dire che le imprese sono «libere di decidere che cosa fare» sulla base degli elementi di concorrenza, con un’assoluta indifferenza alla responsabilità sociale delle imprese, sia rispetto ai territori che all’aspetto produttivo. Credo non ci sia mai stato un governo così indifferente rispetto all’introduzione di elementi di politica industriale e di indirizzo. Da questa crisi non si può uscire senza investimenti importanti, da parte delle imprese e del governo. Voi avete il rapporto con i territori; come vive la gente questa indifferenza? Molto male. Vediamo sempre più spesso atti eclatanti. L’assenza di una politica porta a un’escalation di gesti per richiamare almeno per un po’ l’attenzione sulla propria condizione, individuale o collettiva. Accade in Sardegna, dall’Alcoa ai minatori. Ma ogni giorno c’è qualcuno arrampicato da qualche parte, come la Vinyls a S. Marco. Si cerca di «bucare» l’attenzione con l’evidenza della disperazione. La scadenza del 20 è dunque un richiamo per il governo alle sue responsabilità? Assolutamente sì. Del governo e delle imprese, tengo sempre a precisare. L’ho appena detto: non c’è nessuna politica industriale, ma le imprese mostrano indifferenza ad affrontare la concorrenza sulla base dell’innovazione dei prodotti. Tutta l’attenzione è puntata sull’abbattimento del costo del lavoro; una follia che ha portato a una riduzione dei diritti mai vista prima. E anche di reddito, quindi della domanda. Anche per questo vanno fatte politiche mirate. Squinzi e gli industriali, per esempio, si lamentano che la tassazione è troppo alta. Per noi la riduzione della tassazione va legata all’investimento in innovazione, oltre che alla stabilizzazione del lavoro attraverso la riduzione degli orari. Il governo qui potrebbe svolgere un ruolo. Gli incentivi sotto forma di detassazione andrebbero vincolati a cosa le imprese fanno. Nel decreto sulle start up, invece, viene incentivato un contratto «tipico» fatto di precarietà a tempo determinato e persino con la possibilità di pagare in «stock option»… È l’idea che il «sostegno» all’impresa va dato in forma di precarizzazione del lavoro, in abbassamento di salari e diritti. Pensiamo invece che debba essere collegato ai processi di innovazione, per un diverso modello di sviluppo. La giornata del 20 è importante come primo momento. Abbiamo l’assemblea dei 5.000 componenti dei direttivi Fiom, il 12 ottobre a Modena, perché nell’unificazione delle lotte vanno tenute insieme diverse questioni: il contratto nazionale che non c’è, la democrazia sotto attacco – per i metalmeccanici e in generale – e le crisi aziendali. Bisogna tener vivo un senso collettivo, altrimenti si passa solo ai gesti di disperazione individuale. Quando parliamo di contratto non possiamo non parlare di crisi, di occupazione, quindi di riduzione degli orari e di contratti di solidarietà; e di politiche industriali positive su un diverso modello di sviluppo. La defiscalizzazione andrebbe data su questi elementi, non a pioggia, come con i «contratti tipo» delle aziende start up. Basta una manifestazione, per questo? Pensiamo anche a uno sciopero generale della categoria. C’è un mandato del Comitato centrale che l’assemblea dei delegati potrebbe ratificare. Uno sciopero generale che intervenga sulla «trattativa separata» di Federmeccanica con Fim e Uilm, che peggiora ulteriormente le condizioni di lavoratrici e lavoratori, ignorando la democrazia e lasciando fuori il sindacato maggiormente rappresentativo. Oltre al problema «come si affrontano le crisi?» Siete riusciti a tenere il conto? Sulle 180.000 persone coinvolte nei tavoli di crisi aperti soltanto a Roma, al ministero, 110.000 sono metalmeccanici. Quanto vedete delle questioni poste dalla Fiom nel discorso pubblico dei partiti? Molto poco. Vediamo nella proposta di referendum su articolo 18 dello Statuto e art. 8 della «manovra d’agosto» una reazione alla legislazione che – con Berlusconi prima, con Monti poi – hanno varato sulle questioni del lavoro. Pensiamo che la discussione che si aprirà con la raccolta delle firme sia un modo per riportare i temi del lavoro dentro la discussione politica dei partiti, obbligandoli a una chiara presa di posizione. 08/10/2012 4 di 8 Allo stato attuale, però, tutto il loro dire rimane molto vincolato alle questioni del pareggio di bilancio… Sul clima sociale, in relazione al 20, che tipo di previsioni fate? Sui luoghi di lavoro, se le persone sono lasciate sole, il clima è di depressione. La scadenza deve diventare l’occasione per fare le assemblee, discutere con le persone, far uscire dalla solitudine e dall’immobilismo. Dev’essere una tappa in un percorso di rilancio della mobilitazione sul e per il lavoro; allora ha una possibilità di vero successo. Il 20 saranno soprattutto le aziende in crisi a essere presenti; è positivo che non siano più costrette a manifestare sole, una alla volta, sotto i palazzi del potere. FINESTRA INTERNAZIONALE. C'è un Portogallo che resiste 06/10/2012 di Alfredo Calderale In Portogallo, combattive e affollatissime manifestazioni organizzate, il 15 settembre scorso, dai sindacati e dall’opposizione, con in testa il Partito comunista, hanno indotto il premier Pedro Passos Coelho a ritirare l’ennesima misura economica, odiosa e recessiva, chiamata, nell’ottica liberista e conservatrice del governo di centro-destra, a contribuire al ‘’risanamento’’ finanziario del Paese, cioè l’aumento dall’11 al 18% dei contributi sociali a carico dei lavoratori e la simmetrica riduzione dal 23,7 al 18% di quelli a carico delle imprese. La giustificazione del provvedimento, ritenuta risibile anche da molti imprenditori, chiarissimi nel sottolineare l’insufficienza del beneficio loro concesso e la necessità di politiche di rilancio della domanda, era stata che avrebbe indotto le imprese ad assumere in un ambiente dove il tasso di disoccupazione, grazie anche alle misure di austerità finanziaria già in vigore, è del 15,2%, uno dei più alti dell’Eurozona. Immancabilmente, il 30 settembre Moody‘s ha strepitato che la retromarcia del governo mette in cattiva luce il Paese sui mercati finanziari internazionali perché «incoraggia l’opposizione a esigere mutamenti nel programma di risanamento». La potente agenzia di rating newyorkese non poteva illustrare meglio l’ attuale fase della lotta di classe in Portogallo. Essa è segnata da una vasta opposizione popolare ai provvedimenti varati per rispettare le condizioni che la troika Fmi-Ue-Bce ha imposto nel maggio 2011 per la concessione di un prestito di 78 miliardi di euro, somma da versarsi in tre anni al fraterno interesse del 5,1%, cioè per la modica cifra - euro più, euro meno - di 34 miliardi di euro, quasi la metà del valore del prestito. L’intervento della troika dal cuore d’oro era stato invocato dal primo ministro Socrates, del partito socialista, fresco di dimissioni dopo che la maggioranza parlamentare di centro destra gli aveva bocciato la quarta manovra di aggiustamento dei conti in un anno. Nell’immediato, la prima rata del prestito era servita a evitare la bancarotta dello stato, ormai a corto di fondi e pressoché impossibilitato a finanziarsi sui mercati a tassi schizzati fino dell’8% anche a causa della crisi politica. La lievitazione del debito pubblico, pari, alla fine del 2011, al 102% del Produto Interno Bruto (lordo) (Pib) è stata determinata da numerosi fattori. Il fattore scatenante, comune a molti altri Paesi del mondo, è stato l’intervento statale a sostegno del sistema bancario coinvolto nella crisi finanziaria internazionale esplosa dalla metà del 2007. Secondo il Tribunal de Contas , nel 2009 le misure a favore del sistema finanziario, ammontavano a 9.400 milioni di Euro, pari al 5,4% del Pib, somma ripartita tra garanzie, necessarie alla raccolta di fondi sui mercati, e operazioni di ricapitalizzazione o nazionalizzazione di banche alcune delle quali erano state gestite in maniera scandalosamente truffaldina. Le cause più profonde della crisi riguardano, però, lo stato dell’economia reale. La prima causa è la più iniqua distribuzione dei redditi di tutta l’Europa, favorita da un sistema fiscale definito « de ancien régime » perché implacabile con i lavoratori dipendenti e straordinariamente clemente con "la nobiltà" del denaro. Tale iniquo meccanismo ha contribuito non poco a deprimere la domanda interna di beni e servizi. L’altra ragione è la debolezza dell’apparato produttivo. Da tempo dipendente in buona parte dai capitali esteri, fiaccato dall’uso inefficiente dei fondi europei solo in parte utilizzati per promuoverne la necessaria ristrutturazione e modernizzazione, in tempi recenti è stato facilmente travolto dalla globalizzazione selvaggia con conseguente incremento del numero dei disoccupati. Alcuni dati confermano questa analisi. Nel 2011, le imposte indirette, che, come si sa, colpiscono assai più duramente i percettori dei redditi più bassi, hanno rappresentato circa il 58,3% delle entrate fiscali. Delle imposte dirette, L’Irs ( Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singualares ), che colpisce i redditi da lavoro e le pensioni, ha fornito il 29,7% delle entrate, mentre l’Irc ( Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas ), che riguarda i redditi da capitale, soltanto il 12,3%. Spiegano questo dato l’evasione fiscale contrastata in modo fiacco, l’elusione favorita dall’indecente paradiso fiscale dell’isola di Madeira, le insopportabili regole di favore relative alla tassazione delle rendite finanziarie. In tale scenario, è stato calcolato che la fortuna accumulata dai tre portoghesi più ricchi, pari a 6.500 milioni di euro, equivale al reddito annuale dei tre milioni di portoghesi che guadagnano fino a 7.500 euro l’anno. Forniscono questo gettito fiscale squilibrato le diverse classe sociali. Secondo studi del 2009 su una forza lavoro di circa 5.500.000 unità, 3,9 milioni sono lavoratori dipendenti. Essi appartengono nella misura del 61% nel settore dei servizi, del 29% nell’industria e dell’11% nell’agricoltura. I pensionati sono circa 1.300.000. Incaricati di gestire l’intervento pubblico nell’economia e il welfare, i pubblici dipendenti rappresentano circa il 10% della forza lavoro e, in generale, fino a un recentissimo passato hanno goduto di retribuzioni e condizioni di lavoro decorose, anche se fin dai tempi della proclamazione della repubblica, nel 1910, sono stati oggetto di periodiche denigrazioni, condotte in passato dalla classe dei possidenti e propalate oggi dai seguaci della 08/10/2012 5 di 8 troika . I salari più bassi vengono pagati nei settori alberghiero e turistico, quasi 323 euro al mese. I salari più alti sono corrisposti nel settore finanziario, in media 2.224 euro mensili e nei settori della elettricità, del gas e dell’acqua, 2.192 euro mensili. Il salario operaio medio è di circa 1.200 euro al mese. Imprenditori e liberi professionisti sono più o meno 1.600.000. Esistono circa 1.100.000 imprese registrate delle quali il 21% opera nel settore industriale e il 27% nel commercio. Si tratta in gran parte di piccolissime imprese: il 95,5 ha meno di 10 dipendenti, il 4% ne ha da 10 a 250, mentre le grandi imprese con più di 250 dipendenti rappresentano appena lo 0,3%. Nel 1986, con l’entrata nella Cee, il Portogallo ha vissuto una fase economica caratterizzata dagli investimenti del capitale straniero. Giovandosi della disponibilità di manodopera a basso costo e poco qualificata e della relativa abbondanza di risorse naturali, cospicui capitali francesi, inglesi e tedeschi rivitalizzarono i tradizionali comparti industriali a basso contenuto tecnologico: le industrie tessili che producevano per i mercati francesi tedeschi e olandesi; le industrie delle calzature, della carta e del legno. Ancora investimenti franco-tedeschi si diressero verso settori ad alto valore aggiunto, che impiegavano manodopera qualificata: quello dell’industria automobilistica e del relativo indotto (il primo grande investimento fu realizzato dalla Renault nel 1980. Poi ne seguirono altri del gruppo Volkswagen, della Continental per i pneumatici e della Bosch per la componentistica varia); quello dell’industria elettronica e dell’informazione per l’investimento ancora del gruppo Bosch (fabbricazioni di autoradio e di impianti di sicurezza), della Siemens (componenti elettronici), della Infineon poi Qimonda e della Epcos. Volkswagen, Siemens e Bosch hanno poi favorito la formazione di alcuni poli di ricerca e sviluppo (R&S). Allo stesso tempo, però, la dissennata politica comunitaria indeboliva l’agricoltura e la pesca nazionali costringendo il Paese a importare derrate alimentari. A partire dal 1999, questa spesa; la crisi del settore industriale innescata dalla decisione degli investitori di delocalizzare le produzioni nelle zone del mondo dove la manodopera risultava ancora meno costosa, come, per esempio, l’Europa dell’Est; la crescente competitività delle economie emergenti sia asiatiche, sia mediterranee anche nei comparti a bassa intensità di capitale; l’aumento del prezzo del petrolio hanno determinato un sensibile deterioramento dei conti con l’estero e la contrazione della domanda interna. Criticata vivacemente anche dal Partito comunista portoghese come incapace, da sola, di assicurare lo sviluppo armonico di economie fortemente differenziate, l’introduzione della moneta unica ha, sulle prime, avuto illusori effetti positivi. I più bassi tassi d’interesse, dovuti dall’apparente omogeneità delle zona Euro, hanno consentito ai portoghesi di indebitarsi per consumare eccitando la domanda di beni importati, mentre, dal 2003 al 2007, nel quadro del boom immobiliare mondiale, imprenditori nazionali e stranieri si sono lanciati in grandi progetti di turismo residenziale. Alla fine, un sistema complessivamente debole, nonostante alcune nicchie di eccellenza concentrate soprattutto nel settore dell’energia, e afflitto dal peso crescente del settore finanziario dedito, nonostante l’aiuto pubblico ricevuto, alla speculazione più che al sostegno dell’economia nazionale ha dovuto affrontare la crisi e, quel che è peggio, le misure imposte dalla troika per rientrare nei parametri finanziari dell’Eurozona. IL PERSONAGGIO. Eric Hobsbawm: lo sguardo storico del proletariato 06/10/2012 di Rino Malinconico Eric Hobsbawm si è spento a 95 anni. Ha vissuto due decenni oltre il suo “secolo breve”, affermando fino all'ultimo la possibilità storica di andare oltre la realtà del capitale. Un superamento con contenuti tutti da decifrare, ma che egli vedeva già parzialmente e contraddittoriamente all’opera nella tendenza del capitalismo a rivoluzionare continuamente se stesso. Il nostro tempo è sicuramente molto diverso dall’“età degli estremi”, vero titolo della sua notissima opera del 1995, che racchiudeva nella parabola dell’Urss, dalla prima guerra mondiale al 1991, un concentrato straordinario di vicende all’insegna della lotta di classe; nondimeno, le ragioni della critica al sistema di produzione capitalistico per lui restano intatte e Hobsbawm non ha avuto alcuna difficoltà a proclamare, proprio nel suo recentissimo How to change the world , la piena attualità di Marx e degli ideali comunisti. Lo aveva detto, da par suo, anche nella autobiografia, Interesting Times: a twentieth-Century life , con la sincerità ma anche la forza argomentativa del grande studioso. Del resto, al di là della notorietà presso il grande pubblico, arrivata, per l’appunto, con The age of extremes , egli aveva aperto, nel corso di oltre sessant’anni di pubblicazioni, significative prospettive di ricerca. Ha segnalato, per dirne una, il terreno della “invenzione della tradizione” come un campo ancora tutto da indagare per la comprensione medesima della contemporaneità; e ha ricondotto, per dirne un’altra, la “storia sociale” che veniva dalla tradizione francese de Les Annales ad una più complessiva “storia della società”, focalizzando l’attenzione sulla “gente comune”, ma proprio in quanto corpo vivo di una società. I suoi libri sull’Ottocento, a partire dall’ormai classica The Age of Revolution , equivalgono, per importanza storiografica, ai lavori di Marc Bloch sul Medioevo o di Fernand Braudel sulla seconda metà del Cinquecento. E’ stato davvero un innovatore degli studi storici. Persino quando ha coordinato l’impresa editoriale della Einaudi sulla Storia del marxismo , ha piegato il quadro nella direzione, molto più corretta, di una storia “dei marxismi”. Nel suo paese è considerato un riferimento culturale anche per chi ha idee politiche diverse; ma non era stata per nulla semplice l’attività storiografica di orientamento marxista nell’Inghilterra del XX secolo. Non solo ci si doveva scontrare con prestigiose narrazioni geopolitiche, tenacemente attestate sull’idea della funzione civilizzatrice del mondo anglosassone; ma proprio all'interno della stessa schiera degli storici marxisti si veniva chiamati immancabilmente a prendere posizione. Si trattava di scelte culturali prima ancora che politiche, relative alla visione di fondo sul procedere della storia. 08/10/2012 6 di 8 Il confronto interno a quel compatto milieu di intellettuali militanti (formatisi sui lavori degli anni ’30 e ‘40 di Maurice Dobb e Arthur Leslie Morton, e ritrovatisi poi, a partire dal 1952, attorno alla rivista Past & Present , che vide Hobsbawm tra i fondatori) era venuto progressivamente allo scoperto su una vicenda davvero cruciale della modernità: la rivoluzione puritana del 1648 e il ruolo dei levellers. Leslie Morton e Christopher Hill avevano sostenuto, in assonanza con taluni rapidi giudizi di Marx ed Engels, che la rivoluzione del 1648, essendo borghese, fosse tutta incentrata sullo scontro tra le sopravvivenze feudali e l’incipiente processo di accumulazione capitalista. La vittoria di Cromwell e del partito degli “indipendenti” garantiva, nel loro schema, la concreta affermazione della parte avanzata della società. Viceversa i repubblicani “di sinistra”, i livellatori appunto, proponendo non l’accumulazione capitalistica ma la piccola proprietà contadina e artigiana, si ritroverebbero “oggettivamente” dallo stesso lato delle sopravvivenze feudali. Avevano posto il tema della democrazia, e cioè era un fatto storicamente positivo; ma si portavano dietro la logica della società “per ceti”, e ciò li avrebbe inchiodati ad una visione anacronistica della realtà. La tesi era, in sostanza, che i livellatori avessero fatto bene a rivendicare, contro l’immaturità dei tempi, un maggior spazio per le classi popolari; ma era stato altrettanto un bene, per lo sviluppo generale delle cose, la loro sconfitta ad opera di Cromwell. A questa lettura si contrapposero seccamente altri autori, come Henry Holorenshaw e soprattutto Henry Noel Brailsford, i quali provarono a dire che la prospettiva dei livellatori fosse ugualmente realistica, e che, in ogni caso, una società fondata su un largo tessuto di piccoli proprietari avrebbe evitato il cumulo di sofferenze dell'accumulazione capitalistica per come l'abbiamo conosciuto prima con le enclosures e poi con la rivoluzione industriale. Un puro dibattito tra storici? O piuttosto la esemplificazione di un nervo scoperto all'interno della cultura marxista? A ben vedere quella discussione concerneva direttamente la dialettica tra forze produttive e articolazione della società. Un determinato stadio delle forze produttive si traduce in determinati rapporti sociali; e, viceversa, determinati rapporti sociali presuppongono un determinato stadio delle forze produttive. Ma l'andamento della storia ha come fulcro decisivo lo sviluppo delle forze produttive o la struttura dei rapporti sociali? Coloro che mettono l'accento sul primato delle forze produttive presuppongono un andamento per tappe obbligate delle vicende storiche; quelli che, al contrario, guardano ai rapporti sociali, e dunque alle contraddizioni tra le classi e alle dinamiche della lotta di classe, prospettano la possibilità di una società “dalla parte delle classi popolari” anche in assenza di un'economia propriamente avanzata. Eric Hobsbawm non partecipò direttamente alla discussione sui livellatori, già in corso quando pubblicò i suoi primi importanti lavori; e però, allorché propose nel 1959 il suo intramontabile Primitive Rebels , appariva fin troppo chiaro da che lato si andava collocando la sua visione delle cose. Egli sceglieva l’angolazione delle classi sociali e della loro soggettività. Anzi, lo faceva addirittura con qualche esagerazione, sicché, dopo aver distinto nel mondo rurale i banditi contadini dai banditi dei signori e dai banditi di Stato, arrivava a sostenere che nei due periodi 1799-1815 e 1860-1864 ci fosse stata in Italia la possibilità di una rivoluzione contadina “guidata da banditi sociali”. Ma al di là di questo giudizio poco meditato, ciò che davvero conta è l’attenzione di Hobsbawm per le dinamiche della lotta di classe. Ragionando della lotta di classe egli ha così incontrato, da storico, l’insieme delle classi subalterne dei secoli XIX e XX. Soprattutto l’ampia raccolta di saggi edita nel 1964 sulle classi lavoratrici nell’Inghilterra del XIX secolo ( Labouring Men. Studies in the history of labour ) testimonia del rigore dello studioso, ma anche della partecipazione addirittura emotiva del militante. In ogni caso, danno prova della coerente centralizzazione dell’indagine esattamente sull’elemento umano dei processi economici. Egli è stato, dunque, un marxista, ma non di quelli che, sotto l’ipoteca culturale del “materialismo dialettico” di matrice sovietica, pensavano che la storia umana coincidesse con lo sviluppo delle forze produttive. L’Urss, finanche l’Urss dello stalinismo, fu per lui certamente un riferimento politico, ma non influenzò più di tanto la sua scelta culturale per un marxismo anti-positivista. Del resto, è noto come tra i suoi principali riferimenti teorici figurasse Antonio Gramsci, segnatamente il Gramsci dei Quaderni del carcere , certamente molto lontano dalle rigidità del Dia-mat degli anni ’30. Insomma, Hobsbawm era di quelli che pensano che la storia sia propriamente “lotta di classe” e che non ci si debba per forza rassegnare a passaggi obbligati dentro l’inferno del capitalismo e delle sue diverse metamorfosi epocali. E’ una impostazione che accentua il carattere di ricerca della sua impresa intellettuale e della sua stessa biografia politica; e che lo porta, ad esempio, a richiamare ruvidamente i marxisti della nostra epoca al confronto reale con Marx, soprattutto col celebre frammento sulle macchine dei Grundrisse , il quale costituisce per Hobsbawm «il tentativo più sistematico di affrontare la questione dell'evoluzione storica mai realizzato da Marx; e si può affermare che qualsiasi discussione storica marxista che non tenga conto di questo testo deve essere riesaminata alla luce di esso». Non c’è che dire: un bell'esempio di longevità dell’intelligenza, oltre che di audacia militante. Arte. Vermeer a Roma, limiti e pregi di una mostra 06/10/2012 di roberto gramiccia La prima volta in Italia di una rassegna su Johannes Vermeer (dal 27 settembre 2012 al 20 gennaio 2013, presso le scuderie del Quirinale di Roma) appare un po’ come un’occasione mancata. Ad essere rappresentato adeguatamente è, infatti, più il secolo d’oro dell’arte olandese (sottotitolo della mostra) che una selezione significativa del corpus dell’opera del grande artista di Delft (1632-1675). A parziale scusante degli 08/10/2012 7 di 8 organizzatori della mostra e del suo curatore, Arthur K. Wheelock, c’è da dire che Vermeer nell’ arco della sua vita ha prodotto non più di cinquanta quadri e che oggi se ne conoscono solo 37. Vermeer lavorò solo su commissione e mai gli capitò di dipingere più di 2 o 3 opere l’anno. Lo stretto indispensabile per mantenere in vita la moglie e i suoi ben 11 figli. Una produzione scarsa, anzi scarsissima, che tuttavia lo ha consegnato alla storia dell’arte come uno dei più grandi pittori di tutti i tempi. Un artista formidabile che impressionò Marcel Proust e scrittrici come Tracy Chevalier, autrice del bestseller La ragazza con l’orecchino di perla di cui è molto nota la versione cinematografica. Delle opere di Johannes Vermeer riconosciute autentiche, nessuna appartiene ad una collezione italiana. Solo 26, sui 37 conosciuti, sono i suoi capolavori movimentabili. E negli ultimi 10 anni, soltanto 3 delle otto grandi mostre dedicate all’artista olandese hanno ottenuto in prestito più di 4 suoi capolavori. In questo senso, le 8 opere esposte alle Scuderie del Quirinale rappresentano un numero suo malgrado significativo. Anche se non possiamo nascondere, nonostante tutti questi distinguo, la delusione di essere andati per ammirare Vermeer e di essere ritornati a casa con gli occhi pieni di una pittura olandese di genere non esattamente entusiasmante. In questo senso, sarebbe stato più corretto intitolare la mostra “Il secolo d’oro dell’arte olandese” e basta, e cioè fare del sottotitolo il titolo della mostra, visto che la gran parte dei dipinti esposti non sono firmati dal caposcuola nato a Delft. Pur con queste riserve, ci sono almeno due dipinti che giustificano la fatica di mettersi in fila e il prezzo del biglietto, che sono “Donna che suona il liuto (1662-1663) e “Ragazza con il cappello rosso” (1665-1667 ca.). La qualità di questi due quadri descrive l’abisso che esiste fra Vermeer e i suoi giudiziosi e meticolosi contemporanei, tutti artisti adusi alla tradizione fiamminga, attenti ai particolari cronachistici ma scarsamente interessati alla pittura intesa come scavo del profondo, come strumento che avvicina alla verità. E’ invece questo che connota l’opera di Vermeer. Nei suoi quadri la “vita silenziosa” delle cose gareggia con la capacità di sopravvivere degli umani e spesso la supera. Lo notò Tano Festa, commentando i Coniugi Arnolfini di Jan Van Eyck, sicuramente uno dei maestri di Vermeer. E’ nella capacità del pittore olandese di fissare, attraverso il gioco della luce che attraversa finestre socchiuse, elementi di verità eterna estranei a una congiuntura puramente ottica, che si nasconde il segreto della sua arte. In questo tendere alla verità, oltre l’inganno degli effetti luministico-cromatici, oltre l’inganno dei sensi, per arrivare dal fenomeno al noumeno, dall’apparenza all’essenza della vita. L’indifferenza alla teatralità degli effetti cromatici e, piuttosto, l’uso di una gamma di colori che si accordano senza farsi la guerra, tonalisticamente, come in Piero della Francesca prima di lui e in Giorgio Morandi dopo di lui, fu la sua scelta. Una scelta destinata a fare scuola. La scuola che, tanto per fare un esempio, influenzò L’Ecole de Rome degli anni Trenta, nelle suo amore per la “misura” e nei suoi delicati equilibri cromatici, distinguendola dagli incendi sulfurei della scuola romana di Mario Mafai e di Scipione. Insomma, anche se per due, tre o quattro quadri di Vermeer e pochi altri fra gli artisti olandesi (Frans van Mieris su tutti), il gioco (la mostra) vale la candela. Ve la consigliamo, nonostante i limiti. 08/10/2012 8 di 8
Scarica