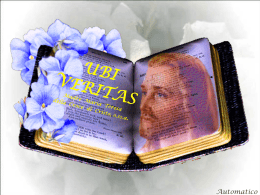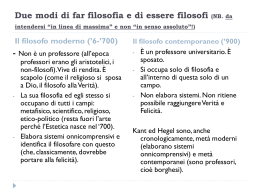Rocco Ronchi è nato a Forlì nel 1957. Laureatosi in filosofia a Bologna, ha poi conseguito il
dottorato di ricerca presso l'Università Statale di Milano. Critico e saggista, insegna attualmente
Scienze della comunicazione presso il CLEACC dell'Università Bocconi di Milano e Filosofia
teoretica presso l'Università dell'Aquila. Tra le sue opere: Bataille Levinas Blanchot. Un sapere
passionale (Spirali, Milano 1985); Bergson filosofo dell'interpretazione (Marletti, Genova 1990);
La scrittura della verità. Per una genealogia della teoria (Jaca Book, Milano 1996); Luogo
comune. Verso un'etica della scrittura (EGEA, Milano 1996); Il pensiero bastardo. Figurazione
dell'invisibile e comunicazione indiretta (Christian Marinotti Editore, Milano 2001); Teoria critica
della comunicazione, Bruno Mondadori, Milano 2003.
*****
1. Subject: [16/11/2002]- Sentieri nel bosco
La parola chiave: presupposto
Il fatto: A Firenze, come a Genova o a Porto Alegre, sono stati messi in questione i presupposti
dell'ordine neoliberista.
Dire è fare
La pragmatica non è solo quella parte della linguistica che si occupa del rapporto tra la parola
ed il contesto. La pragmatica è una straordinaria macchina teorica per criticare e smascherare
l'ideologia dominante. Essa infatti mette a nudo la potenza arcana della parola, la sua capacità
di dire sempre altro e di più di quello che dice. Un enunciato, per la pragmatica, non è solo
una proposizione che veicola un significato. Un enunciato, qualunque enunciato, è sempre
un'azione, una modificazione dell'ambiente. Chi parla e vuole essere compreso non parla
quindi mai nel vuoto. Non parla, come direbbe il barone de Curtis, "a prescindere". La sua
parola anzi, per essere veramente efficace, implica sempre un riferimento preliminare a qualche
presupposto condiviso. Chi prende la parola in realtà risponde ad enunciazioni anteriori, con
il suo detto le conferma oppure le contesta. La parola comunica certamente "qualcosa" ma
comunica sempre anche lo sfondo nel quale soltanto quella parola prende il suo rilievo e il suo
significato. Si tratta di un preriferimento tacito, non espresso, e perciò ancora più persuasivo.
Ascoltare un notiziario televisivo, seguire un dibattito televisivo o leggere il titolo del giornale di
domani è, a questo proposito, altamente istruttivo. Lo speaker non dà semplicemente notizie ma
ribadisce silenziosamente, attraverso la notizia, una serie di presupposti che fanno da invisibile
cornice alla notizia. E lo stesso fa chi sceglie per la prima pagina un titolo azzeccato. Se il tema,
ad esempio, è di cronaca nera, lo sfondo comunicato con esso sarà probabilmente il senso di
una diffusa insicurezza; se la notizia è la possibilità di una guerra, il preriferimento tacito sarà
l'esistenza di un nemico che bisogna combattere.
Sentieri nel bosco
La pragmatica insegna che ogni comunicazione è sempre un atto costitutivo, una
trasformazione del mondo ambiente, una presa di posizione politica. La parola umana, essendo
parola "in situazione", è sempre, come scrive Gilles Deleuze, "parola d'ordine". Chi ha il potere
della parola bisogna immaginarlo come qualcuno che apre una via in un bosco. Certo prima di
quell'atto di parola infinite altre vie erano possibili e ancora adesso, in un certo senso, lo sono.
Tuttavia per il fatto stesso che una parola è già stata pronunciata in merito a qualcosa un primo
sentiero è stato tracciato ed è ora assai più probabile che chi seguirà sarà incline, per ragioni
di economia cognitiva, a scegliere proprio quel primo abbozzo di via. Così nessuna parola ha
lo statuto inoffensivo di un puro suono della voce (flatus vocis). Nessuna parola è priva di effetti
pratici. La calunnia anche quando è radicalmente smentita dai fatti ha già fatto suo corso, il
sospetto per iniziare la sua opera corrosiva non ha bisogno del suffragio dell'esperienza. La
parola, infatti, non segue l'esperienza ma le fa da battistrada. Funge da mappa, da criterio di
orientamento e da discrimine tra l'essenziale e l'insignificante. E' la lanterna con cui gettiamo
luce. Nel suo chiarore le cose appaiono. Per questo il massimo potere sta nella parola. Chi
parla per primo controlla l'universo.
D'Alema in TV
Ad ogni latitudine la sinistra tradizionale non fa bella figura in televisione. Non buca lo
schermo. Nei dibattiti televisivi dà piuttosto l'impressione di inseguire trafelata l'avversario. Il
problema è di pertinenza della pragmatica del linguaggio. Già il semplice accettare l'agenda
dei problemi così come è proposta dall'avversario significa mostrare di accettare i suoi
presupposti. Indipendentemente da ciò che volta per volta raccontano, i media hanno infatti
già da sempre stabilito la cornice generale in cui quello che verrà detto troverà il suo senso.
E sarà un senso banale, effimero, sostanzialmente fascista. In quel contesto tentare di dire
qualcosa di radicalmente diverso equivale allora a cercare l'America sulle carte geografiche
tracciate dai predecessori di Colombo. Su quelle mappe l'America non c'è né mai potrà esserci.
Bisognerebbe invece provare a parlare una lingua diversa, una lingua capace di immaginare
quello che sulle carte in uso non è ancora disegnato. Oppure non parlare affatto, sottrarsi alla
comunicazione. I movimenti che contestano il pensiero unico sembrano averlo capito. In questa
capacità di cambiare i presupposti della parola quotidiana, e non in un presunto estremismo,
consiste la loro radicalità.
2. Subject: [15/02/2003]- I bugiardi non credono all'esistenza delle bugie
La parola chiave: falso
Il fatto: Per giustificare una guerra che comporterà centinaia di migliaia di morti l'intelligence
britannica ha pensato bene di presentare un dossier scopiazzato da una vecchia tesi di laurea.
I bugiardi non credono all'esistenza delle bugie
La storia della verità e la storia della menzogna sono intrecciate. Già il buon senso ci
insegna che l'una implica l'altra e che la loro apparente irriducibile opposizione è in realtà
una complementarità inevitabile. Si faccia un piccolissimo esperimento mentale e s'immagini
una umanità da sempre e per sempre incapace di mentire o, come dicevano gli antichi,
impossibilitata a "dire ciò che non è". Che ne sarebbe allora della verità? E lo stesso vale
nell'ipotesi di una umanità incondizionatamente menzognera. Che ne sarebbe del falso? Il vero
ha bisogno della possibilità del falso e viceversa. Altrimenti non si darebbe nessun giudizio,
nessuna possibilità di dire qualcosa intorno a ciò che è. Non stupisce allora che all'inizio della
filosofia, vale a dire di quella "scienza" che pretendeva di dire come stanno veramente le
cose, vi sia stata una gigantomachia che aveva per oggetto il contrario della filosofia e cioè la
possibilità del non vero, del falso e dell'errore. Il dialogo platonico intitolato "Il sofista" racconta
proprio questa battaglia. Il titolo evoca un sapere apparente e mendace. Ora l'impegno che si
assume il protagonista del dialogo, lo straniero di Elea, è proprio quello di fondare la possibilità
della menzogna. Solo così potrà stanare il suo avversario, il sofista, il quale, naturalmente, si
guarda bene dall'ammettere tale possibilità. Se lo facesse, riconoscerebbe infatti l'esistenza di
un criterio che permette di "giudicare" e cioè di discernere il grano di ciò "che è" dal loglio di ciò
che solo "sembra" essere ma "non è". E' strano, ma i più grandi osteggiatori della menzogna
sono sempre stati coloro che dalla menzogna generalizzata hanno tratto il loro pane.
Essi vivono!
Un piccolo film di fantascienza di John Carpenter dice meglio di molti dotti saggi sociologici
qual è lo stato delle cose nella società globalizzata. Il film si intitola They live, Essi vivono. Un
nerboruto disoccupato, comunque fiducioso nel sistema Occidente-libero mercato ecc., entra in
possesso di fiabeschi occhiali che, al pari della filosofia per Platone, permettono di vedere come
stanno veramente le cose. Il colore rutilante che si addice a quel grande supermercato che è la
vita quotidiana diventa improvvisamente un bianco e nero poveristico e le sfolgoranti insegne
pubblicitarie si rivelano sintetici messaggi che obbligano a obbedire, comprare, consumare
e a conformarsi... Naturalmente le peggiori visioni le riserva la televisione dove le siliconate
subrettine e i presentatori dei talk show si mostrano con le loro autentiche fattezze di mostri
venuti da un altro mondo. E così pure i rampanti frequentatori della city. A metà tra un ispettore
Callaghan e un black bloc, il nostro palestrato non esiterà a rovesciare piombo e distruzione su
tante orribili menzogne. Non so se Carpenter abbia mai letto il più radicale e sofisticato teorico
francese dei media, Guy Debord, ma il suo film, così felicemente privo di pretese intellettuali, è
il miglior commento ad una delle tesi capitali della "Società dello spettacolo": "il mondo vero è
divenuto falso".
F for fake
Grandi artisti come Orson Welles o Federico Fellini hanno eretto il loro domicilio nella
menzogna. L'intera arte, dopotutto, sposa felicemente la finzione. Ma di che menzogna si tratta
in questo caso? Non basta dire che è una menzogna saputa, voluta, dichiarata e, dunque,
a suo modo "vera" come menzogna. Non è semplicemente la consapevolezza a redimere
questo falso. A Platone, ad esempio, tutto questo non bastava e, nella "Repubblica", non esitò
infatti a cacciare via i fabbricanti di immagini dalla sua città ideale. Ma le immagini che Platone
detestava erano quelle prodotte a scopo illusionistico, per piacere al grande pubblico e per
conservarlo nel suo stato di perpetuo sonno. Le chiamava phantasmata. Noi oggi diremmo che
sono le immagini di cui è drogata la società di massa, una società che ormai immagina solo
ciò che altri hanno già immaginato per essa. Vi è però un altro tipo d'immagine, da Platone
battezzato eikon, icona. Non è fatta per piacere e per lusingare le attese del pubblico. Non crea
come la casa del grande fratello un'illusione di vita. E' un'immagine che disturba e che inquieta.
Un'immagine divergente ("critica", la chiamerà Walter Benjamin). Essa non "deforma" la realtà,
come si è soliti credere quando si parla di alcuni grandi artisti del 900 (le facce di Picasso!).
Come gli occhiali di Carpenter, mostra piuttosto una realtà deforme.
3. Subject: [03/05/2003]- Come le stelle, noi...
La parola chiave: amicizia
Il fatto: Il primo ministro difende a spada tratta l'amico prima inquisito e poi condannato.
Filosofi gesticolanti
Al centro della Scuola di Atene di Raffaello, Platone, canuto e quasi divino, ha l'indice della
mano destra puntato verso il cielo, Aristotele, giovane e vitale, quasi obiettando al maestro,
ha la mano destra rivolta decisamente verso il basso. E' perfino inutile ricordare come questa
contrapposizione posturale sia figlia del tempo. Platone è tanto poco idealista quanto poco
Aristotele è materialista. Tuttavia, anche un lettore superficiale, leggendo il filosofo di Stagira
avverte un certo cambiamento di clima. Aristotele è uno spirito certamente più prosaico, nel
senso che si lascia istruire dalla prosa del mondo. Non la disprezza come tanti suoi illustri
avi, disgustati dalla volgarità di piazze e tribunali, ma le porge orecchio convinto che in essa
si celi la sapienza. E' infatti ascoltando la gente parlare, ascoltandola discutere e non capirsi
mai pienamente oppure capirsi solo a metà, che Aristotele matura il principio chiave della sua
filosofia. Coniando una formula che resterà forse scolpita nella lapide della filosofia, egli scrive:
l'essere si dice in molti sensi. L'essere non è univoco ma polivoco e talvolta anche equivoco.
Non solo l'Essere con la maiuscola a capolettera, ma qualsiasi ente si dice sempre secondo
una pluralità di sensi. La parola "amicizia", ad esempio, può affiorare sulla bocca dei più diversi
uomini. Essa non denoterà allora la stessa cosa presso i corrotti e presso i buoni. Vi sarà
forse somiglianza fra queste espressioni, ma non identità. Compito del filosofo è allora quello
di portare ordine, di tracciare una mappa, di stabilire delle differenze, perché il senso primo
(essenziale) di quella parola non sia sfigurato e cancellato dai suoi sensi secondi e derivati
(accidentali)
Favori e benevolenze
Così nella "Etica nicomachea" Aristotele distingue la forma perfetta dell'amicizia dalle sue forme
imperfette. In primo luogo chiarisce quale sia la condizione dell'amicizia. Questa consiste in
una benevolenza reciproca e consapevole. Chi si dice amico deve sapersi tale e deve potere
contare, in caso di bisogno, sull'altro. Ma si tratta solo della condizione necessaria, non di
quella sufficiente. Perché ci sia amicizia in senso proprio bisogna che questa reciprocità non
sia fondata sull'utile o sul piacere. Sebbene anche tali relazioni siano dette amicali, esse, scrive
Aristotele, sono amicizia solo "per accidente". Venendo meno utilità e piacere, viene meno
anche l'amicizia: "infatti non erano amici l'uno dell'altro, ma dell'interesse". "Invece i buoni
saranno amici per se stessi, ossia in quanto buoni". La definizione della perfetta amicizia non
è affatto così semplice come può sembrare. Aristotele non sta dicendo soltanto che l'amicizia
non deve essere subordinata a interessi materiali o edonistici. Egli piuttosto afferma che la vera
amicizia ama nell'altro la bontà: il buono riconosce nel buono il tratto della bontà e questa bontà
è la ragione della sua benevolenza. E' evidente , dunque, che per un greco che ragionasse
aristotelicamente non si sarebbe allora potuta chiamare amicizia in senso proprio il favore
concesso ad un amico al di fuori del bene. Un tale atteggiamento di benevolenza ha solo la
forma dell'amicizia, non però la sostanza. Se i veri amici, come sostiene ancora Aristotele, non
hanno bisogno della giustizia o della legge ciò si deve allora al fatto che la giustizia e la legge
sono una necessità per una comunità politica che, a differenza della comunità di amici, non può
vivere naturalmente e quotidianamente nella luce del bene. Gli amici sono, insomma, sempre
già là dove la giustizia con le sue leggi vorrebbe guidare la città.
Come le stelle, noi...
L'interesse alla persona in quanto tale, nella sua particolarità, l'amore inteso come
attaccamento feticistico, non è essenziale per l'amicizia filosofica. Tant'è che una caratteristica
costitutiva dell'amicizia perfetta è per Nietzsche la possibilità sempre imminente del grande
congedo: "che ci dovessimo divenire estranei è la legge incombente su noi". Gli amici possono
diventare estranei perché nell'amicizia non è in gioco altro che la ricerca della verità. Può perciò
capitare che le strade divergano. Ma se il conflitto, perfino l'ostilità su questa terra, nascono
da questo comune amore per il vero e per il buono, allora la differenza è ricompresa in una più
ampia curva, come avviene alle stelle del cielo distanti migliaia di anni e, tuttavia, vicine per
l'occhio dell'astronomo. "E così, fa dire Nietzsche all'amico che si congeda, vogliamo credere
alla nostra amicizia stellare, anche se dovessimo essere terrestri nemici l'un l'altro".
4. Subject: [30/08/2003] - Pornografia invisibile
La parola chiave: calcio
Il fatto: Sciagurato provvedimento del governo salva-calcio.
Pornografia invisibile
E' stato recentemente tradotto un saggio del 1994 di Ivan Illich, come sempre bellissimo,
che ha come titolo "Proteggere lo sguardo nell'era dello show" (lo si può leggere in italiano
in "Biopolitica minore" della manifestolibri, purtroppo con parecchie trasandatezze traduttive). La
questione affrontata è un tema classico della filosofia: concerne infatti l'immagine. I riferimenti
testuali sono relativi alla grande letteratura antica e medievale sull'argomento, nonché ai più
raffinati studi di massmediologia. La domanda alla quale il filosofo recentemente scomparso
cerca di rispondere è però "per noi" di straordinaria attualità. Ivan chiede: "cosa posso fare per
sopravvivere nel mezzo dello spettacolo?" Traduciamola nella lingua patetica, sentimentale
e volgare della comunicazione mediatica: "come difendere i nostri figli dalla pornografia?".
Solo che la pornografia non è qui quella cosa inoffensiva che preoccupa le associazioni
cattoliche dei genitori, ma la quotidianità televisiva, e non solo televisiva, alla quale quegli
stessi genitori espongono tranquillamente i loro figli. L'immagine pornografica e violenta è nella
contemporaneità il regime normale dell'immagine, soprattutto quando questa non crede di
essere pornografica e violenta. Quando l'immagine, anzi, si presenta con i tratti dell'evasione
innocente, del divertimento collettivo o, addirittura, con quelli paludati dell'informazione e della
formazione, ecco allora che la sua carica pornografica si fa intollerabile. Purtroppo questa
violenza non è registrata sulla superficie della retina e non disturba le associazioni dei genitori.
Urla e cazzotti
Il calcio è uno sport bellissimo. Forse, come ogni gesto "bello", trascende perfino la dimensione
sportiva, e quella stessa del gioco, per toccare le corde più nascoste dell'esistenza. La scrittrice
americana Joyce Carroll Oates diceva qualcosa di simile a proposito della boxe. Dapprincipio
la disprezzava, come si conviene a qualsiasi aspirante intellettuale, poi improvvisamente ne
vide la sostanza metafisica ed eterna. La stessa visione la comunica la frenesia con cui i
ragazzini occupano i pochi spazi e il poco tempo che a loro è ancora concesso per inventarsi
improbabili partite a pallone (una volta, in un campetto di una scuola media inferiore, assistetti
ad una improvvisata e abbastanza cruenta partita: "nazisti"contro "comunisti"...). Ed anche
il tifo, spesso anche quello più esasperato degli ultras, tradisce un entusiasmo, che riattinge
al senso originario di questa parola, la quale, in greco, significa "sono ispirato, preso, invaso
dalla divinità". Né il sangue della noble art, né le ginocchia sbucciate dei ragazzi e le entrate
assassine dei difensori argentini, né le scazzottate tra i tifosi, sono violente e pornografiche.
Violenza e pornografia iniziano quando tutto questo entra in modo stabile e definitivo nel regime
dello spettacolo. C'è un momento critico in cui l'istituzione sequestra il fenomeno, lo codifica, ne
annulla ogni spontaneità e anarchia, lo normalizza e lo risputa fuori come prodotto plastificato
per il consumo domestico. Allora il calcio diventa nient'altro che la sua immagine. Una buona
immagine televisiva non deve però contenere nulla di imprevisto, niente che possa scuotere
lo spettatore dal suo sonno. In televisione non ci sono eventi, solo programmi. La Fiorentina,
insomma, non può restarsene in serie C. Prima ancora del becero calcolo politico è la logica del
palinsesto a non permetterlo.
La saggezza dei gesuiti
Come sopravvivere allora nel tempo dello show? Illich, che era un prete cristiano, riabilita
un'antica pratica risalente ai tempi della sua educazione cattolica. I gesuiti raccomandavano
al novizio una castità dello sguardo, un duro e difficile tirocinio con il quale arginare la "libido
spectandi" (il piacere quasi carnale della visione spettacolare), che da loro era considerata una
delle principali porte sfruttate dal diavolo per venire ad insidiare la nostra anima. Formule così
antiquate fanno sorridere solo coloro - in primis, proprio le associazioni cattoliche dei genitori
- che non credono in nessuna linea di fuga che porti fuori da questo mondo osceno. Per Illich,
invece, un'etica dello sguardo è, nella società dello spettacolo, un'etica rivoluzionaria, è una
pratica che, insegnandoci a chiudere gli occhi davanti falso-visibile, ce li apre al vero-invisibile.
Bisogna forse smettere di vedere questo calcio per poterlo amare ancora.
5. Subject: [20/09/2003] - Dire tutta la verità
La parola chiave: parresia
Il fatto: Sergio Zavoli chiede a Mario Moretti delle Brigate Rosse di dire finalmente tutta la verità
sul caso Moro.
Uccidere Arafat?
I giudizi "analitici" non ampliano la nostra conoscenza della cosa. Se di un triangolo dico
che ha tre lati non aggiungo nulla a quanto era già dato nel soggetto del giudizio. Si tratta
soltanto di una tautologia mascherata: A = A. E' come se ripetessi che un triangolo è un
triangolo. Tutt'al più nel predicato troviamo una chiarificazione di quanto era contenuto
implicitamente nel soggetto. Così ci insegna la logica. La conoscenza inizierebbe invece con
i giudizi cosiddetti "sintetici" che azzardano nel predicato qualcosa di nuovo, come quando,
ad esempio, si dice che quel determinato triangolo è isoscele invece che scaleno o retto... La
logica della logica è ineccepibile. Eppure anche le tautologie, talvolta, illuminano. Una delle
battute più caustiche del comico ebreo-americano Lenny Bruce non era nemmeno una battuta,
era un semplice "truismo", vale a dire una ovvietà talmente ovvia da risultare sconcertante.
Lenny, in piena guerra fredda, ricordava al suo pubblico che il comandamento "non uccidere"
voleva dire proprio "non uccidere". Grazie alla sola ripetizione nel predicato del soggetto, quel
comandamento appariva improvvisamente in tutta la sua trascendente dignità. Perdeva il suo
carattere scontato (chi infatti non sa che "non uccidere" significa "non uccidere"?) per risuonare
con la stessa potenza con la quale, forse, aveva risuonato la prima volta. Lenny dava voce
a quanto c'è di inaudito in quel comandamento, che da sempre l'umanità evade cercando
comunque ragioni e giustificazioni per continuare ad uccidere in buona coscienza (chi non sa
infatti che "non uccidere" non può significare proprio quello che dice, e cioè "non uccidere",
perché altrimenti la storia, di cui siamo parte, sarebbe solo un orrendo crimine?).
Dire tutta la verità
Michel Foucault, negli ultimi anni della sua purtroppo breve vita, aveva rivolto la propria
attenzione ai Lenny Bruce del periodo tardo antico (I e II sec. d.C.). Non erano i comici,
ma coloro che coltivavano la virtù della "parresia", quelli che dicono la verità, "tutta" la
verità, all'interno di contesti determinati assumendosene la responsabilità e testimoniando
per essa. L'esempio classico era il filosofo cinico che rispondeva sprezzante al grande
imperatore, rivelandogli in una battuta fulminante la vanità e la superbia del suo preteso
potere. La "parresia" inizia quando la pratica del dire la verità diventa da questione meramente
epistemologica una questione etica. Non è la semplice verità inopportuna, come credono
gli ingenui amanti della verità ad ogni costo. Una verità inutile, una verità che ferisce chi, ad
esempio, è in una condizione di debolezza e che dalla rivelazione di questa verità puo trarre
solo ulteriore nocumento, è infatti di per sé peggiore della peggiore bugia (Kant era una di
questi feticisti del vero ad ogni costo dal momento che per lui l'imperativo categorico del dire
della verità non poteva essere violato nemmeno per proteggere una vittima dal suo assassino,
casomai questi avesse chiesto dove quella si trovava...). "Parresia" significa invece osare dire
quella verità che in una situazione contingente è taciuta, misconosciuta, rimossa, per ragioni
di interesse e di potere. E' una verità più che mai "opportuna" ma quanto mai difficile. Vuol
dire prendere partito, qui e ora, per la creatura contro il suo violentatore. Ai francescani che,
durante il secondo conflitto mondiale, benedivano le baionette insanguinate degli ustascia croati
(il sangue era quello di serbi, di ebrei e di zingari) non sarebbe stato male ricordare per chi il
sangue di Cristo fosse stato versato.
Graticole
"Martirio" deriva da "martyr", una parola greca che significa "testimone". Il martire è un
testimone. In lui la verità ha perso quella dimensione esangue e astratta che ha sui libri per farsi
di carne. Che la "parresia", anche quella minima che possiamo praticare sul posto di lavoro,
abbia dei costi e si paghi con le piaghe della solitudine e dell'emarginazione è tesi che non ha
bisogno di essere dimostrata. Lenny Bruce morì infatti assai male. Tuttavia dire la verità dona
anche una particolare gioia. L'immagine di beatitudine del santo graticolato è decisamente
stucchevole, ma essa traduce in un desueto linguaggio popolare una intuizione che era
condivisa dai filosofi classici come dai padri della chiesa: la verità infine rende liberi, la verità per
qualche istante è anche più forte di quella paura della morte che ci asservisce.
6. Subject: [15/11/2003] - L'altare della Patria
La parola chiave: non violenza
Il fatto: Generale cordoglio per la morte dei soldati italiani in Iraq.
Avanti, Savoia!
Chi ha solennemente "festeggiato" il 4 Novembre avrebbe dovuto ricordare come il secolo
trascorso si sia aperto con il macello definitivo. Come polli d'allevamento i giovani europei
erano tirati giù dai treni che li portavano al fronte e gettati in pasto alle mitragliatrici nemiche. Se
esitavano erano passati immediatamente per le armi. La stessa cosa deve essere successa sul
confine tra Iran e Iraq ottant'anni dopo in occasione della guerra tra quei due paesi. Non uomini,
non guerrieri e tantomeno eroi, ma solo materiale che andava impiegato fino all'usura, secondo
una logica di tipo industriale. Ernst Junger vi vide il laboratorio di un nuovo tipo umano forgiato
nell'acciaio: l'operaio. L'"operaio" era diventato con la Grande Guerra il protagonista della storia
scalzando l'indolente borghese intento solo alla ricerca della sua felicità privata (inutile dire che
la silhouette del borghese egoista schizzata da Junger aveva evidenti tratti ebraici...). Ciò che
agli occhi del nobile prussiano rendeva grande l'operaio era esattamente l'opposto di quanto in
esso vagheggiava il socialista. Se questi nell'operaio consapevole e politicizzato vedeva l'uomo
possibile, l'uomo che torna ad essere fine e non mezzo, per Junger il tratto distintivo dell'operaio
era dato, al contrario, dalla sua fungibilità illimitata, dal suo sapersi e dal suo volersi come sola
appendice della macchina. Junger era stato al fronte e aveva visto i giovani del popolo morire
stupidamente come mosche, accettando questo destino con fatale rassegnazione. Questa
insensata devozione lo aveva inebriato. La grande fabbrica era riuscita nell'impresa di domare
definitivamente quanto nell'uomo sfugge alla geometrizzazione, riducendolo alla dimensione
di materiale plastico e disponibile. Ora - Junger pubblica "L'operaio" nel 1932 - bisognava solo
aspettare che sulla scena comparisse un artista della Storia, un Führer ad esempio, per dare
una grandiosa forma a questo nuovo "elemento".
L'altare della Patria
L'altare della patria con le sue retoriche architetture, le bandiere e le medaglie, con i preti
benedicenti e le autorità commosse, meglio dei campi disseminati di cadaveri spiega che cosa
sia la violenza (come strumento di azione politica) e, quindi, anche quella non-violenza che,
recentemente, in un appassionato intervento, Marco Revelli raccomandava al movimento di
opposizione come scelta strategica e non meramente tattica. La violenza politica implica il
sacro. E' interamente giocata dalla logica del sacrificio e da quella del mito. La Città, lo Stato,
la Nazione, la Patria o la Rivoluzione, tutto quanto insomma si scrive con la maiuscola e tutto
quanto chiede una idolatrica e fanatica devozione, può essere fondato soltanto nella violenza
e nel sangue. Senza una vittima da sacrificare non sarebbe legittimato. L'epoca s'incarica poi
di scegliere la sua vittima privilegiata in un variegato spettro di candidati che va da Luigi XVI
condotto al patibolo tra due ali festanti di folla fino al suo estremo opposto dal punto di vista
del prestigio sociale: il milite ignoto della Grande Guerra. L'importante è che il sangue scorra
perché solo così i popoli avranno la certezza di avere un piede nella Storia. A questo proposito
non bisogna coltivare nessuna illusione. La consapevolezza dell'innocenza della vittima non
distoglierà affatto dall'uso della violenza, semmai confermerà "tragicamente" la giustezza del
progetto (ecco il sillogismo: se i soldati italiani muoiono in Iraq per difendere interessi non
loro allora è "giusto", "decoroso", "patriottico" perseverare nella missione. Altrimenti come ci
giudicherà la "Storia"?)
Per farla finita con il giudizio di dio
L'obiezione alla pratica della non violenza è sempre la stessa. Non è forse la violenza
la "levatrice" della storia? Nessuno che abbia un minimo di discernimento potrebbe negare
questa tesi. Ma come chiedeva Antonin Artaud, nella sua straordinaria pièce censurata dalla
radio francese, non sarebbe ora di farla finita con il giudizio di dio, e cioè di quel dio che la
violenza sacrificale non cessa mai di onorare? Il Dio della Storia, appunto, quello che benedice
le baionette e infiamma gli animi nel giorno della commemorazione dei caduti. La portata
strategica dell'opzione della non violenza va allora ben oltre i limiti naturali di ogni strategia
(un termine, per altro, tutto militare...). Essa conduce evidentemente fuori dalla Storia e dalla
sua logica sacrificale. Il "realista" che in questa trasgressione scorge solo una generosa utopia
tradisce tutta la superstizione idolatrica di cui è imbevuto. Per lui infatti dio è solo un feticcio
insanguinato e l'uomo una mosca ronzante.
7. Subject: [22/11/2003]- La pena inevitabile
La parola chiave: eroe
Il fatto: Si rischia di affogare nella retorica patriottarda.
La pena inevitabile
Tommaso Campanella fu rinchiuso in carcere dal 1599 fino al 1629. Per evitare la morte aveva
dovuto fingersi pazzo e resistere fino allo stremo alla "verifica", tramite tortura, della fondatezza
della sua dichiarazione. La pena gli fu commutata in carcere a vita. La sua colpa era quella di
aver professato una metafisica di tipo naturalistico e di aver vagheggiato una riforma politico-
spirituale dell'Europa. Per un uomo così ingiustamente perseguitato non doveva essere facile
affermare che per assicurare il premio alla virtù e la colpa al castigo non occorre postulare una
vita ultramondana. Lo scandalo del giusto infelice e del prosperante cattivo non è ai suoi occhi
uno scandalo perché, a guardare le cose con occhiali speculativi, la punizione dell'ingiusto è
già data in questo secolo così come lo è il premio per il giusto. Il castigo dell'ingiustizia è infatti
la stessa ingiustizia e il premio del virtuoso è la stessa virtù. Tommaso (in realtà si chiamava
Giovanni, ma, per un'ironia del destino, entrando tredicenne nell'ordine domenicano, aveva
voluto prendere proprio il nome di quel sommo teologo, nel cui "nome" sarebbe poi stato tanto
vessato...) ragionava esattamente come un suo più antico compagno di sventura, Socrate, il
quale al giovane Teodoro, che lo interrogava sulla stessa questione, rispondeva pacatamente
che la pena dell'ingiusto è una pena alla quale questi non può mai sfuggire, vale a dire è la
stessa ingiustizia commessa. Essa sfigura infatti la sola felicità che all'uomo è data quaggiù, la
felicità che nasce dalla "omoiosis", dalla somiglianza con il dio perfettamente giusto. Gli ingiusti
pagano la loro pena essendo privati di questa somiglianza: essendo "brutti", diceva il greco,
essendo "tristi", diceva il calabrese.
Pomponazzi
Un altro brillante eretico, il medico e filosofo mantovano Pietro Pomponazzi (1462-1525), aveva
portato questa tesi alle sue conseguenze più paradossali. Vi sono, a suo giudizio, due modi del
premio e del castigo, quello accidentale e quello essenziale. Il premio che su questa terra quasi
sempre manca alla virtù è il premio accidentale (riconoscimento, felicità ecc.). E lo stesso vale
per la punizione che, quasi sempre, manca al vizio. Il premio essenziale, quello che consegue
dalla natura stessa dell'azione virtuosa, è però la vita virtuosa come il castigo essenziale del
vizio è la vita viziosa medesima. Fin qui niente di nuovo rispetto a quanto era già sostenuto
da Socrate. Il colpo di genio di Pomponazzi consiste nel negare che il premio (o il castigo)
accidentale ed estrinseco si sommi a quello essenziale. Una vita viziosa che sia insomma "qui e
ora" punita non sarebbe affatto "meglio" di una vita malvagia che prospera tranquillamente. Una
virtù ricompensata dagli uomini non è "meglio" di una virtù misconosciuta. La pena accidentale,
anzi, diminuisce la colpa nel malvagio e la ricompensa accidentale intorbidisce la pura acqua
della virtù. La sofferenza inflitta al tiranno (ad es., Mussolini a testa in giù a Piazzale Loreto)
rende in effetti la sua colpa meno grave e suscita una qualche simpatia umana. Le fanfare e
gli onori resi all'eroe riconosciuto inducono il sospetto che si tratti di retorica e di opportunismo
politico.
Agenti inquinanti
Non c'è bisogno di essere atei e materialisti per giungere a queste conclusioni. La mistica
cristiana Simone Weil, poco prima di spegnersi nel 1943, ebbe modo di sperimentare tutta
l'atrocità della guerra. Niente più della guerra è figlio del prosperare del vizio e della sventura
della virtù. La Weil non aveva però dubbi sul significato della parola "eroe". Ella individuava
nell'invisibilità la dimensione propria dell'azione massimamente virtuosa. Al limite l'eroe è
colui che sparisce, senza lasciare traccia di sé, senza nemmeno una memoria postuma. Al
contrario l'azione viziosa è quella che reclama visibilità, che pretende di essere apprezzata e
giudicata con i criteri del "mondo" e della "storia". Niente ai suoi occhi è più peccaminoso di
questa pretesa di riconoscimento. Bisogna infatti disperare profondamente della nostra celeste
radice per affidare a ricompense e punizioni "accidentali", come la galera o l'onore, il compito
di dare senso all'esistenza umana. Dal punto di vista di Simone anche il Paradiso e l'Inferno
dei cristiani, almeno nella loro accezione comune, sono allora solo degli agenti inquinanti che
contaminano tanto la purezza di una vita virtuosa quanto la colpevolezza di una vita malvagia.
8. Subject: [01/12/2003] - La guerra delle parole
La parola chiave: nome
Il fatto: A Gerusalemme dichiarazioni impegnative del segretario di Alleanza Nazionale.
Askesis
"Senza la virtù, infatti, Dio è un mero nome". La sentenza è tratta dalla seconda delle Enneadi
di Plotino e, più precisamente, da quel trattato "Contro gli gnostici" che, secondo l'autorevole
parere di Marco Vannini, "costituisce una delle più belle proteste contro il soggettivismo, il
sentimentalismo, l'irrazionalismo religioso". Un'involontaria parafrasi della saggezza plotiniana
la si ritrova in quel celebre passo del Vangelo nel quale dalla gloria della contemplazione
finale sono esclusi coloro che hanno sempre in bocca il nome del signore, ma che non fanno
la volontà del Padre. Il teologo neoplatonico parla la stessa lingua del cristiano. La filosofia,
infatti, come la mistica, non è una questione di sapere. Non la si fa con le prese di posizione sul
mondo, i sistemi e le catene di sillogismi. E' certamente anche questo, nella stessa misura in cui
anche la mistica si organizza in un discorso (che straordinario piacere è, ad esempio, misurarsi
con le asprezze speculative di un Meister Eckhart!), ma se si riduce a questo, se si esaurisce
nel discorso filosofico, nella dottrina, allora diventa non-filosofia, caricatura spettrale del sapere.
Senza la virtù, anche la verità è un mero nome e, in ultima analisi, nient'altro che menzogna.
Filosofia e mistica sono innanzi tutto esercizi, "forme di vita". La parola askesis (esercizio) è,
non a caso, la parola chiave comune ad entrambe queste esperienze spirituali (ma sono poi
veramente due?)
La guerra delle parole
Nella società dello spettacolo le parole sono usate irresponsabilmente come strumenti di
una guerra infinita. Nella guerra la logica dominante ed esclusiva è quella dell'amico-nemico.
Le parole non si misurano allora per il loro contenuto di verità, ma per l'effetto più o meno
distruttivo che suscitano nel campo avverso Quanto più fa male tanto più la parola è opportuna.
Come le armi rubate al nemico morto possono e devono essere riutilizzate contro il nemico
vivo così anche le parole, nella guerra mediatica, possono migrare da uno schieramento
all'altro secondo le circostanze. Non stupisce ritrovarle improvvisamente dove, secondo
il loro arcaico contenuto di verità, non avrebbero mai dovuto essere. La ragione di questo
slittamento non sta in un mutamente di prospettiva, in un cambiamento della "forma di vita"
che sostiene quella parola, ma nel fatto che quella parola, pronunciata in quel contesto, in quel
particolare momento della grande battaglia per il potere, "funziona", mette l'avversario con le
spalle al muro, buca lo schermo e persuade gli elettori. Siccome la guerra è spietata e, per
sua natura, non conosce limiti all'escalation militare, anche le parole più gravide di significato,
quelle che andrebbero pronunciate cautamente e pensosamente, non si sottraggono a questo
destino. "Antisemitismo", ad esempio, è una parola che nomina il peggiore dei sentimenti.
E' una parola che gronda sangue innocente. Però anch'essa ritorna, con irrisoria facilità,
nell'agone mediatico come arma per ridurre mal partito l'oppositore ("o incondizionatamente con
me oppure dalla parte degli antisemiti"). Non conta più il suo contenuto ma il disorientamento
che essa sa generare nel campo avverso.
Augh!
"Fate attenzione a come parlate!", gridava Nanni Moretti. Degradare le parole a semplici mezzi
della lotta per il potere è una forma di inquinamento spirituale. Senza la "virtù" anche la parola
più sublime è solo un nome. Il capo indiano sottolineava la serietà e la responsabilità della
parola pronunciata con il suo perentorio "Augh, ho detto!" posto al termine della frase. Chi parla
veramente assume, infatti, un impegno nei confronti del mondo. E' tenuto ad una condotta,
deve sostenere con l'askesis il proprio detto. La vera parola "non torna indietro". E' irreversibile.
Per queste le parole sono rare (e "rari" coloro che le pronunciano) ed è per questo che trattare
le parole come meri nomi ha il senso della perversione (il diavolo, secondo la teologia, è un
gran chiacchierone, un "comunicatore" instancabile e seducente).
9. Subject: [06/12/2003] - Sogni kantiani
La parola chiave: tregua
Il fatto: A Ginevra uomini di buona volontà hanno messo a punto un piano per provare ad uscire
dall'orrore della guerra infinita tra palestinesi e israeliani.
Sogni kantiani
Perché i progetti di pace falliscono sistematicamente? Consapevole della sua immensa
responsabilità la filosofia moderna non ha evaso il problema della pace. Prima Rousseau, poi
l'abate di Saint-Pierre, infine il grande Kant, hanno cercato una valida alternativa alla sola forma
di pace che la storia ha saputo immancabilmente realizzare. Intendo quella duratura pace di
cui parlava amaramente Tacito, la "pax romana", così simile alla "pax" armata cara all'attuale
amministrazione statunitense, quella pace, cioè, che consiste nel fare "preventivamente" un
deserto e nel chiamarlo poi pomposamente "pace". E le parole di Kant non sono affatto diverse
da quelle che oggi, soprattutto in Europa, si levano nel vano tentativo di arginare l'arroganza
militare dell'impero. "Il diritto internazionale deve fondarsi su una federazione di liberi stati",
scriveva Kant nel 1795. La pace perpetua ha insomma come sua imprescindibile condizione
una federazione di stati come mezzo di regolazione pacifica delle contese e di garanzia
delle libertà di ognuno. A torto si rimprovera all'illuminismo un arido razionalismo. Proprio
in questo progetto kantiano, che anticipa di 150 anni quanto si vorrà realizzare nel secondo
dopoguerra (senza riuscirci) con le Nazioni Unite, si può toccare con mano la generosa illusione
che caratterizza ogni illuminismo. Perché Kant sta chiedendo al potere di fare quello che il
potere, se vuole restare potere in atto, non può per principio fare: rinunciare a se stesso per
sottomettersi al diritto.
La pace dei disincantati
I "realisti" sanno invece che la pace può essere solo il risultato sempre precario di un equilibrio
di poteri. Già una singola nazione, per non scadere nell'orrore della guerra civile, abbisogna di
un delicato equilibrio di poteri e contropoteri, figuriamoci quella giungla costituita dai rapporti
internazionali tra stati! La pace può nascere solo dall'interesse, da un astuto egoismo e dalla
lucida considerazione delle forze dell'avversario che in realtà si vorrebbe uccidere. La pace del
realista differisce il momento dell'omicidio, nella speranza che esso arrivi il più tardi possibile.
Ciò che il realismo produce non è però vera "pace", ma solo "tregua", una sospensione
momentanea del conflitto (Primo Levi ebbe una lancinante consapevolezza della provvisorietà
di questa "tregua"...). Il disincanto del realista è fatto di un amaro sapere sull'uomo: la violenza
è lo "stato di natura" dell'umanità e quand'anche, dopo mille negoziazioni, la tregua fosse data,
comunque e in qualsiasi momento una breccia sarebbe sempre pronta ad aprirsi. La "pace
perpetua" di Kant o dell'abate di Saint Pierre è perciò l'impossibile per definizione e nessuno
meglio dello stesso Kant avrebbe dovuto saperlo. Proprio lui, infatti, aveva parlato, con toni
quasi agostiniani, di un "male radicale" nell'uomo e di una sua irriducibile "insocievolezza".
Il realismo di Gandhi
Con il sottile negoziatore di momentanee tregue il fautore illuminista della pace perpetua
condivide però un medesimo presupposto. Per entrambi la pace (o la tregua) è qualcosa
che va istituito. È il risultato - stabile o precario - di un fare, il termine di un'opera. In questo
si rivelano fratelli di sangue e tradiscono la loro comune radice "occidentale". Perché è
propria dell'occidente questa fiducia nell'azione, nella poiesis (l'agire produttivo), come solo
mezzo per fare essere qualcosa. La non-violenza gandiana, ad esempio, è pace in tutt'altro
senso. Non è "fare" la pace. E' "essere" già da sempre la pace. Non è agire in vista di, non
è progetto, ma inoperosità sovrana. E' uno "stare" che suscita sconcerto in chi crede che la
dinamica della vita sia, ad ogni latitudine, azione-reazione (il senso originario del sit-in...).
Il termine italiano "non violenza" inganna. La "non violenza" non nega sdegnosamente una
violenza già data. Piuttosto viene prima della distinzione tra la violenza e il suo rifiuto. Essa
manifesta una pace irraggiungibile da ogni violenza, una pace già così saldamente acquisita
e definitiva da permettere a Gandhi morente sotto i colpi del solito fanatico fondamentalista di
salutarlo, cadendo, con le mani giunte... Questa pace fuori dalla storia, questa pace (per noi
disincantati occidentali) così "astratta", può tutto proprio nella misura in cui non vuole più niente.
Il suo "vuoto" la rende, quando si manifesta, irresistibile.
10. Subject: [10/01/2004] - Dalla bellezza alla paura
La parola chiave: tremare
Il fatto: Da Natale ad oggi si sono susseguiti un numero imprecisato di allarmi a proposito di
possibili atti terroristici. Ovunque la popolazione è chiamata a prepararsi e a vigilare.
Dalla bellezza alla paura
Il più semplice ed il più efficace atto sovversivo consiste nello smettere di avere paura.
Ciò che molti, oggi, chiamano Impero, si nutre infatti della paura degli uomini. A dispetto
dell'impressionante apparato tecnologico e scientifico che la modernità ha saputo sviluppare
il tipo d'uomo che essa ha allevato è impulsivo e irrazionale. Tremare è il suo modo d'essere.
Lo "stato di natura" per l'uomo non è forse, secondo uno dei maestri della modernità in
filosofia, l'inglese Thomas Hobbes, proprio la paura? Platone, nel "Simposio", sosteneva che
la bellezza è l'elemento nel quale soltanto è possibile per l'uomo "generare". Bellezza era
l'apparizione sensibile del bene e del vero. Quanto non nasceva dalla bellezza era, per lui,
solo un simulacro di essere: aveva una pseudo-vita ma non era vera vita. Un sapere che non
fosse bello e buono non avrebbe quindi meritato il nome di sapere, nemmeno se fosse stato
il più efficace dei saperi. Per questo, forse, i greci avevano una tecnologia così arretrata,
nonostante l'impressionante mole di conoscenza che avevano, in ogni campo, promosso. Per
questo non eleggevano l'autoconservazione ad ogni costo dell'individuo a valore assoluto. I
moderni hanno invece fissato la loro dimora nella paura. Il loro sapere è stato ed è, in prima
battuta, una autodifesa. La natura, in un altro papà della modernità, Bacone, è un nemico che
si deve torturare al fine di estirparle verità utili alla sopravvivenza dell'uomo. E Blaise Pascal
darà perfino una dignità mistica al tremare convulso di questa piccola "canna" che è l'uomo
spaventato da un mondo che non capisce più.
Vive l'amour?
Il culto del sentimento è la religione specifica della modernità tremante. Lo inaugura un certo
romanticismo popolare. Sotto sotto, l'ideologia sentimentale dei moderni ha il senso di una
rivendicazione del diritto naturale dell'uomo a tremare. Tremare non solo non è disonorevole,
come pensavano gli antichi, ma adesso è "naturale". Tremare d'amore, soprattutto se è un
amore socialmente interdetto, diventa poi il paradigma della sensibilità moderna. E ciò che
è "immediato" per i moderni è automaticamente "buono". Il romanticismo, come è noto, rivolge
una critica serrata ad ogni forma di formalismo, da quello che caratterizza i rituali ingessati della
vita sociale a quello che, come organizzazione retorica del discorso, costringeva la poesia e
l'arte in genere in canoni prestabiliti. Si è sempre salutato in questo una liberazione della vita da
quanto la irreggimentava innaturalmente. Vive l'amour! Ma, a ben vedere, con l'acqua sporca
dell'ipocrisia si gettava anche il bambino, vale a dire quelle pratiche di autocontrollo, di saggia
dissimulazione e di "cura di sé", che, per secoli, erano ritenute indispensabili per la costruzione
di un uomo virtuoso, di un uomo "prudente" nel senso classico del termine: un uomo, cioè, che
non trema, e che, dunque, "per quanto è possibile", è libero dalla tirannia della paura.
"L'impero non è mai cessato" (P.K. Dick)
Sulla paura generalizzata e sul sentimento liberato da ogni controllo razionale si edificano gli
imperi. Non è un caso se la contemporaneità si rispecchia nei miti gnostici del I secolo d.C.
Da Minority Report fino al Truman Show, dal Grande Fratello televisivo e letterario fino ai
vari Matrix, passando attraverso l'opera più emblematica per comprendere il nostro tempo intendo la narrativa di P.K. Dick -, l'uomo contemporaneo si immagina, come l'antico gnostico,
rinchiuso in una gabbia di ferro, chiamata cosmo, generata da un dio decaduto irrazionale
e pazzo. L'Impero, secondo la gnosi, è stato generato dalla paura di un Dio minore che si
sente minacciato e che si alimenta della paura di uomini che non cessano mai di tremare.
Se cessassero di tremare l'Impero si scioglierebbe, in un sol giorno, come neve al sole. Per
evitare questa catastrofe occorre perciò che il Terrore sia costantemente evocato dall'Impero.
Non c'è nemmeno più bisogno di un terrore reale. E' sufficiente la minaccia periodica. All'uomo
deve infatti essere ricordata costantemente la sua natura pascaliana di esile canna. Così si
potranno all'infinito costruire muri e dispensare protezione. Che ne sarebbe invece dell'Impero
e di quel Dio minorato che lo regge se l'uomo, come insegnano i classici, si ricordasse della sua
somiglianza con il vero Dio e della sua partecipazione a quella natura divina?
11. Subject: [13/03/2004] - Lupi e cani
La parola chiave: contesa
Il fatto: Si annuncia una lunga campagna elettorale caratterizzata da falsificazioni,
manipolazione dell'informazione e rifiuto del pubblico confronto con l'opposizione.
Darsi la zappa sui piedi
"Bada a questo, però: non commettere ingiustizia nell'interrogare". Con queste parole, nel
dialogo platonico "Teeteto", Protagora ammonisce Socrate, responsabile di una critica troppo
disinvolta e astuta di quella tesi sulla relatività della conoscenza umana (l'uomo misura di
tutte le cose) che ha reso celebre in tutta la Grecia il filosofo di Abdera. In realtà a parlare
non è Protagora, da tempo deceduto, ma Socrate stesso che veste momentaneamente i
panni di Protagora per autoconfutarsi di fronte a quel pubblico che vorrebbe persuadere
proprio dell'infondatezza della tesi protagorea. Se Socrate si produce in un'apologia delle tesi
dell'avversario, in grado perfino di commuovere gli amici di Protagora presenti, è perché, in
omaggio al più autentico spirito socratico, non è in vista della vittoria che egli è sceso nell'agone
filosofico. La filosofia non è affare di potenza. Non è contesa tra uomini. Assomiglia alla guerra
e richiede probabilmente la stessa ferrea disciplina della guerra, ma il ferro non è quello delle
armi e l'obiettivo non è la distruzione a qualsiasi costo e con ogni mezzo dell'avversario.
Lupi e cani
In questo nobile disprezzo per la polemica consiste anzi la specificità del filosofo e la sua
differenza dal sofista. Come lupo e cane, anche filosofo e sofista, se visti da lontano, si
assomigliano, fino quasi a confondersi. Il vecchio Aristofane, nella commedia " Le nuvole" ,
li aveva, infatti, confusi. La loro differenza è però profondissima e concerne l'etica della
conversazione. Mentre il primo ha in orrore l'idea di " commettere ingiustizia nell'interrogare" ,
fino al punto di correre in soccorso del suo stesso avversario, quando si accorga di averlo
prevaricato, il secondo sfrutta sfrontatamente ogni risorsa linguistica per mettere il suo
stivale sulla testa del nemico. Per l'uno comunicare ha la sua radice nella comunione e nella
condivisione fraterna di un luogo comune. E' cooperazione su un piede di parità tra eguali
in vista di una verità che non è data, ma che deve essere raggiunta attraverso un percorso
comune ("dialettica"). Per l'altro la conversazione è soltanto contesa, guerra civile camuffata
("eristica"). Le parole sono usate come armi e sono piegate, a dispetto del loro significato, alle
esigenze strategiche dell'argomentante: " E si commette ingiustizia in questo modo - continua
Protagora-Socrate-Platone -, quando uno non distingua nettamente, facendo sue dispute, se
disputa con animo di contendente o con animo di dialettico: ché nel primo caso ama scherzare
e cerca quanto più può di cogliere in fallo l'avversario; mentre nell'altro ragiona con serietà (…)
non con malignità e bramosia, ma sinceramente, con tranquillità e remissione di animo".
La tentazione del dialettico
Il " nostro" problema è, dopotutto, sempre e soltanto questo. Che ne è di quanto Giacomo
Leopardi chiamava " l'onesto e retto conversare cittadino" nell'epoca in cui la comunicazione
è divenuta, appunto, arte eristica generalizzata? Platone, si sa, sognava una città governata
dai filosofi. In questa città la politica avrebbe coinciso con la dialettica. La politica sarebbe
stata "scienza" e non dittatura dell'opinione (maggioritaria). Questa città, evidentemente, non
era "democratica". La democrazia, per Platone, è solo il tempo dei "lupi". L'arrogante e sfrontato
Alcibiade, che si sottrae alla dialettica di Socrate per inseguire la sua sfrenata ambizione, n'è
l'indiscusso campione. Alcibiade sa che se avesse seguito Socrate avrebbe dovuto cambiare
vita, perché la dialettica, pur assomigliandovi, è proprio di tutt'altro genere rispetto all'eristica.
Proprio questa alterità la rende però politicamente impotente nella città democratica. Per guarire
la città dall'infezione eristica, il buon cane dialettico deve infatti presupporre quanto il lupo
sofista non potrà mai concedergli: un animo disinteressato e rivolto al bene. L'erista continuerà
a discutere da erista, tendendo trappole e seducendo le folle. Il dialettico potrà allora rivolgersi
solo alle " nature filosofiche" , conquistando chi potenzialmente è già dalla sua parte, ma tutti
gli altri? Ed è perché ignora la risposta a questa domanda che la filosofia è stata, a più riprese,
tentata dalle soluzioni autoritarie. Ma così facendo ha dovuto ancora una volta rinunciare a se
stessa, perché il suo scopo non è " vincere" . Almeno in questo mondo.
12. Subject: [20/03/2004] - Forma senza contenuto
La parola chiave: manifestazione
Il fatto: Manifestazioni governative contro il terrorismo e manifestazioni non governative per la
pace.
Forma senza contenuto
La fenomenologia ha liberato la descrizione dei vissuti religiosi da un radicato pregiudizio. In
omaggio ad uno schema di derivazione schiettamente platonica, il rito era infatti generalmente
pensato come ripetizione simbolica (così, ad esempio, ragionava il celebre storico delle
religioni Mircea Eliade). All'origine, come fondamento della serie, era posto il mito, di cui il rito
era considerato, appunto, una replica. Rito come memoria, mito come origine. La possibilità
per il rito di scadere a vuota ritualità priva di un autentico contenuto di verità era così già
inscritta nella sua stessa definizione. Ciò che nasce come copia non tarderà molto a diventare
pleonastico. Lavorando sul campo, gli antropologi si erano però imbattuti da tempo in un'altra
forma di ritualità ben poco platonica. Era un rito che si mostrava indifferente al principio di
autorità del mito, un rito impertinente che sfruttava semmai il mito per potere avere luogo.
Talvolta pareva perfino che il rito vivente un tale mito fondante se lo inventasse per giustificare
la sua esistenza come rito. I gesti, le codificate abitudini, le formule del rito, in molte circostanze
appaiono dunque sganciate dall'onnipotenza del mito. Il rito sembra essere ricercato per se
stesso. E' amato in quanto ripetizione, non per la cosa che sembra ripetere. E' amato per
l'esercizio di memoria a cui costringe, non per il testo che riproduce fedelmente. La forma è
insomma scambiata con il contenuto, ma questo scambio, apparentemente contro natura,
dona piacere. Ben lo sanno i bambini che si fanno raccontare mille volte sempre la medesima
storia, "ma proprio con le stesse parole, però…"
"Io c'ero"
L'autonomizzarsi del rito dal mito s'incrocia con quell'altro fenomeno, anch'esso paradossale,
che fenomenologi e antropologi hanno spesso evidenziato nell'esperienza religiosa e nelle
culture cosiddette " primitive" . Anche la comunicazione, in molte circostanze, è indifferente
a quanto viene comunicato. Secondo lo schema che abbiamo imparato sui banchi di scuola,
essa dovrebbe veicolare messaggi, dovrebbe fungere da nastro trasportatore di informazioni,
e invece quella che l'etnologo Bronislav Malinowski registra intorno al fuoco del villaggio
melanesiano è un chiacchiericcio insensato e divertito dove ciò che veramente conta non
è comunicare qualcosa, ma la forma vuota della comunicazione. Parlare per il gusto di
parlare. Parlare per il gusto di verificare il contatto con l'altro, la sua rassicurante presenza. Ai
fenomenologi della religione la stessa impressione lo doveva fare il largo spazio lasciato alla
glossolalia (il parlare a vuoto) in molte pratiche religiose, uno strano esercizio di vocalizzazione
non diverso, dopotutto, da quel ruminare meccanico che in tante anziane signore devote
accompagna il transito delle dita sulle palline del rosario. Malinowski coniò il termine "fàtico"
per indicare il complesso di queste pratiche che privilegiano il rito rispetto al mito e la
comunicazione (il contatto) rispetto all'informazione. Nella lingua del giovanilismo anni '70, si
potrebbe affermare che il rito e la comunicazione divengono dei fini in sé, quando quello che più
conta, anzi, forse la sola cosa che conta, è "esserci".
Avanti popolo…
Proprio per i suoi aspetti "rituali" e "fàtici" - e non nonostante questi! - una manifestazione
di popolo è la prefigurazione momentanea di una comunità finalmente libera. A fornirla di
questo straordinario valore non è il suo mito, vale a dire la "ragione" per la quale si scende in
piazza. Anzi è questa eccedenza del piacere di manifestare sulle motivazioni, per altro ben
fondate, del manifestare a differenziarla dalle manifestazioni "governative", sempre pilotate da
interessi "politici" che passano sopra le teste delle persone. Nelle seconde il popolo rappresenta
un mito imposto e si auto-rappresenta (gonfaloni, stendardi, autorità…), nelle prime "c'è".
Andare per l'ennesima volta in piazza vuol dire allora liberare per l'ennesima volta la piazza da
chi l'ha indebitamente occupata. Significa strapparla a chi, senza averne diritto, l'ha trasformata
in piazza di affari e di tribunali, per restituirla al suo legittimo proprietario, al popolo, il quale,
scendendo in piazza e recitando i propri preconfezionati slogan, snocciola il suo specifico - e
nient'affatto laico - rosario di libertà.
13. Subject: [19/07/2004] - Donne al bar
La parola chiave: apparizione
Il fatto: Morte di Marlon Brando
Donne al bar
In quel piccolo capolavoro della letteratura surrealista che è "L'Amour Fou" di André Breton,
l'apparizione è annunciata da un brivido condiviso. La bellissima dama che entra nel fumoso
bar parigino produce negli astanti e nel narratore una specie di piacevole disagio. Scombina
l'ordine abituale delle cose, segnalando a chi abbia antenne adeguate che là fuori c'è un altro
mondo dalle regole sconosciute e dai piaceri occulti. Da questo momento in poi per il narratore
non c'è più scampo. La dama diventa un destino e il tentativo di avvicinarla si trasforma nel
lavoro di decifrazione di una scrittura di cui non si possiede il codice. Breton non racconta
niente di nuovo. La bellezza "convulsa" che celebra non è nient'altro che la bellezza di cui
parlava Platone. Il compito "istituzionale" del bello è infatti, nel sistema platonico, quello di
stanare l'uomo dalla sua cuccia. Deve percepire tutta la sua attuale miseria e, al tempo stesso,
deve sognare un tesoro, per raggiungere il quale non esistono però mappe. Lungi dall'essere
rassicurante, il bello esercita una pedagogica violenza. Aiuta chi è gravido a generare e,
impietosamente, mette l'arido di fronte alla sua aridità. La bellezza è una prova, dalla quale si
può anche uscire con le ossa rotte e con il sentimento della propria inadeguatezza.
Star
Se la bellezza è un esercizio maieutico, se la sua apparizione è una provocazione ed una
sfida, chi sono allora i "belli", chi sono coloro che concretamente l'incarnano e che l'esibiscono
con sfrontatezza? Hollywood li ha battezzati stelle, cogliendo un aspetto significativo della
questione. La stella splende ed esaurisce la sua funzione nel rilucere. Il suo essere è il suo
stesso bruciare. Che le star poi si brucino effettivamente tra droghe e alcol non dipende soltanto
da tristi vicende personali. Una star è un sacrificato alla luce. Per alimentarla deve gettare nel
fuoco tutto quello che ha e, quando ha esaurito le risorse, deve bruciare se stesso. Il corpo
del grande attore è così un vero è proprio laboratorio vivente rispetto al quale gli esercizi di
automutilazione di un'artista all'Orlan sono solo giochetti buoni per stupire bambini.
Apparenza e apparizione
Nel bello, il dilemma metafisico tra essere e apparire è già da sempre risolto e superato in
favore dell'"apparizione". L'essere di un attore come Brando è infatti integralmente apparizione.
L'apocalittico Kurz che "appare" nella sequenza finale del mitico film n'è una potente metafora.
E proprio nella misura in cui l'essere del bello si risolve nella dimensione dell'apparire, il bello
può e, in un certo senso, "deve" sempre poter anche sparire (nello star-system hollywoodiano
l'archetipo di questa sparizione inerente all'apparizione è fornito dalla Garbo). Solo a tratti,
scrive il poeta tedesco Holderlin, l'uomo sopporta pienezza divina, "sogno di essi è, dopo,
la vita". Apparizione però non vuol dire apparenza. Qui si gioca tutta la differenza tra il bello
e la sua diabolica perversione, tra la verità che traluce improvvisamente e il mignottismo
televisivo da prima serata. L'apparenza è simulazione dell'apparizione. È l'inganno del mago da
strapazzo, è il lifting infinito del potere mediatico e delle siliconate di regime. Se apparizione e
sparizione misurano la verità del fenomeno, apparenza e inapparenza sono solo l'indice della
sua falsità. Aggrapparsi a qualche passaggio televisivo per continuare ad esistere significa
tristemente non essere mai stati (non essere mai "apparsi").
Demonlovers
Per indicare la natura di questa apparizione, la lingua greca aveva una parola
precisa: "daimon", il demone. Ma il demone non è niente di cattolicamente diabolico. E' un
messaggero, un intermediario, un metaxu (un "tra"). La sua funzione è quella di gettare ponti
tra le rive infinitamente lontane del divino e dell'umano. Nella filosofia di Platone ad Eros spetta
questa funzione demonica. La mania amorosa che la bellezza ispira persuade gli uomini ad
uscire dalla caverna dell'ignoranza. Bertolucci e Scorsese raccontano di come il corpo di
Brando - perfino quello vecchio e grasso - trasudasse una sensualità non arginabile in confini
di genere. Attraverso Brando facevano esperienza della bellezza demonica e dell'eros filosofico
che, mai disgiunto dall'eros fisico, essa sempre ispira.
Rocco Ronchi
IL FATTO
Braccato dalla polizia, l’uomo-lupo assassino è l’indiscusso protagonista dell’estate italiana
LA PAROLA CHIAVE: BESTIA
Stagione di caccia
Nel Conte di Kevenhuller il poeta Giorgio Caproni racconta, a modo suo, della spasmodica
caccia alla bestia, un lupo forse, degli spari a vuoto dei cacciatori e, soprattutto, delle
apparizioni fugaci dell’animale immondo e innominato. Apparizioni sorprendenti perché, in
quegli attimi di angoscia, il cacciatore si rispecchia per un attimo nel cacciato, il bracconiere
nel braccato. Si rispecchia senza però senza riconoscersi: nel volto del lupo c’è il suo volto,
ma è un volto che in quello specchio momentaneo gli ritorna con i tratti dell’anonimato,
confuso e inafferrabile come quello della bestia. Non solo l’apparizione della ‘cosa’ non
produce un sapere su di essa, ma addirittura scuote il sapere più certo, quello che concerne
la nostra identità, il nostro ‘chi siamo’. Davanti alla bestia, vera e propria potenza mitica,
imparentata senz’altro con la Gorgone, l’io depone così la sua certificata identità, diventa
un metafisico immigrato clandestino, e si scopre altro. Non ‘un’ altro ma assolutamente
altro. Più ancora del celebre detto rimbaudiano ‘Io è un altro’, vale forse qui il riferimento
al cacciatore Polifemo che dalla sua caccia ritorna accecato e privato del nome (‘io sono
nessuno’). Cosa trascina, allora, in questa folle danza della caccia? Nella desolata epica
caproniana sembra infatti non esserci scampo. La caccia non darà frutto e tuttavia nessuno
può sottrarsi ad essa. Da dove viene il fascino senza tempo della bestia che atterrisce?
Regali criminali
Max Stirner si faceva beffe di tutte le parole che possono essere scritte con la maiuscola
a capolettera: Dio, Patria, Uomo ecc. In ciascuna di esse avvertiva la minaccia che il
concetto ‘ e, dietro di lui, l’Istituzione ‘ porta all’esistenza. Questa, nella sua concretezza, è
singolarità e nient’altro che singolarità. L’esistenza è un costante ‘stato di eccezione’ rispetto
alla regola. Finché sono Uomo, Italiano, Cattolico, non sono veramente ancora ‘io’. In
queste definizioni sono classificato e perduto. Grazie a loro il gregge m’ingloba ed il pastore
esercita su di me un dominio incontrastato. Divengo invece libero, attraverso la negazione
esasperata e metodica di tutto quanto pretende di circoscrivere la mia singolarità. Violare la
legge, diventare ‘bandito’, essere cioè ‘al bando’ dalla comunità, è così la gloria che aureola
la singolarità. I filosofi della politica definiscono autenticamente ‘sovrana’ quell’istanza che
è in grado di decidere nello ‘stato di eccezione’, quando l’ordinamento giuridico, insomma,
non è più in grado di governare con i suoi impersonali automatismi. Nell’eccezione assoluta
a qualsiasi legge, valore, concetto, che voglia irreggimentare l’esistenza Stirner, poneva
allora la sovranità dell’uomo. Nella vita quotidiana, il bandito è perciò il vero sovrano. La
gloria regale del criminale sarà, non a caso, il tema dell’intera opera di Jean Genet. Va
infine osservato come il ‘mostro inumano’ celebrato dall’ateo Stirner abbia tratti fortemente
teologici. Alla domanda su chi poteva vivere fuori dei confini della città, nella solitudine dei
boschi, al bando dagli uomini e indifferente alle loro leggi gregarie, Aristotele rispondeva
che questo era concesso soltanto a due esseri: la ‘bestia immonda’ e il dio.
Singles
Dal suo letto di ospedale, il protagonista del film ‘L’inquilino del terzo piano’ (è lo stesso
regista Roman Polanski), chiede fin dove si possa procedere nelle amputazioni senza
compromettere l’identità di un corpo. Domanda abissale che chiede sostanzialmente dove
comincia l’io. Secondo Stirner, se si toglie tutto, se tutti i concetti, i principi ecc. sono
negati, resta il singolo. E’ lui che sopravvive a tutte le amputazioni. Ma guardato negli
occhi questo singolo si rivela uguale a nulla. La sua apparizione è l’apparizione di nessuno
in particolare. Definita da una serie illimitata di negazioni (né’né’né’), che dovrebbero
esaltarne la singolarità assoluta, la bestia immonda si rivela fungibile con qualsiasi altro
essere. Dopotutto, tutti siamo ‘single’. Dentro ogni uomo c’è sempre la medesima bestia. A
renderci diversi sono proprio le famigerate categorie (uomo/donna, cattolico/musulmano, ce
libe/coniugato ecc.). Hegel si sarebbe fatto matte risate della libertà proclamata da Stirner:
per lui quella è solo la libertà dell’astrazione, è la notte dell’indistinzione. E tuttavia in quel
buio in cui non c’è effettivamente niente da vedere c’è qualcosa che attrae irresistibilmente
il nostro occhio. Per questo, secondo Caproni, la caccia alla bestia immonda (la caccia a
Dio’) non si arresterà mai.
Rocco Ronchi
IL FATTO
Ostaggi italiani, francesi, russi, nepalesi, turchi… il mondo è in ostaggio
***
LA PAROLA CHIAVE: OSTAGGIO
Dopo tre giorni l’ospite puzza
La parola latina “hospes” (ospite) è una parola strana. Significa ospite ma è imparentata
con “hostis” che significa nemico. La stessa sacralità dell’ospite ha a che fare, secondo gli
antropologi della religione, con quella parte del sacro più oscura che concerne la presenza
nella comunità di un elemento estraneo al tempo stesso affascinante e tremendo. Tale
incrocio problematico non si deve a cause diverse, ma alla stessa causa. L’ospite appartiene
infatti, per definizione, ad un “fuori” rispetto al quale il “dentro” è venuto, faticosamente,
a costituirsi. E’ naturale che di questo “fuori” ci sia paura, curiosità e nostalgia. Esso
rappresenta infatti il pericolo ma anche l’eco di una provenienza, se non addirittura la
prefigurazione di una condizione che ci riguarderà. Il “fuori” infatti precede il “dentro”,
nella misura in cui questo per istituirsi ha dovuto circoscriversi. Bisogna in qualche modo
averlo frequentato per potere poi rinculare su se stessi e costruire la propria tana armata.
Ma il “fuori” che minaccia anche affascina. L’uomo di mezz’età, la cui vita scorre come su
binari d’acciaio, che altro vagheggia, nei suoi momenti di stanchezza, se non tutto quanto
poteva essere e invece non è stato? Cosa sogna se non quanto è rimasto “fuori” dalla sua
ordinata esistenza? Al fuori, poi tutto, deve inflessibilmente ritornare, nella misura in cui le
mura costruite con tanta cura intorno alla nostra esistenza individuale e associata dovranno
inevitabilmente crollare. Di questa duplicità è traccia l’ospite. Il fatto che, secondo il detto
popolare, questi, dopo un certo tempo, puzzi, soprattutto quando ostenta un’eccessiva
familiarità con le nostre cose, allude all’olezzo dei cadaveri. Il fuori da cui proviene e al
quale deve il suo esotico charme è nell’immediato sentire popolare anche il fuori assoluto
della morte al quale l’ospite in qualche modo appartiene e al quale deve ritornare.
***
Questa casa è un albergo!
Nel pittore francese Jean Fautrier (1898-1964) l'occupazione nazista della Francia lasciò una
traccia indelebile. All’indomani della guerra, dipinse una serie di strane macchie granulose,
al limite della pura astrazione, e le battezzò “ostaggi”. Sono forme embrionali e grumose,
dai tratti indecifrabili, che Malraux definiva " geroglifici del dolore”. Nessuna immagine
poteva dirsi più adeguata allo spirito tragico del tempo. L’ostaggio, insomma, come figura
dell’assolutamente contemporaneo. Un ostaggio è letteralmente un nemico-ospite. E’
tenuto nella casa come un ospite, contro la sua volontà, e, se non saranno accolte le
richieste dei suoi rapitori, su di esso si eserciterà a suo tempo la ritorsione. Con la sua serie
sugli ostaggi, Fautrier non sapeva di dare figura ad un antichissimo mito gnostico (I sec.
d.C.), secondo il quale l’uomo, conformemente al detto paolino, è “nel” mondo ma non
è “del” mondo. Nel mondo esso è letteralmente “gettato” e vi vive come un ostaggio in balia
delle potenze demoniache che reggono questo cosmo decaduto e malvagio. La sua vera
patria è però un altrove assoluto. A differenza delle mamme apprensive, la gnosi antica
pensava proprio che questa casa nella quale viviamo fosse solo un albergo, ma un albergo
stregato dal quale, come in Shining di Stanley Kubrik, non è dato all’albergato di uscire.
***
Le ragioni di Baldoni
Negli stessi anni in cui Fautrier dipingeva i suoi ostaggi un altro francese, il filosofo
Emmanuel Lévinas, scampato all’orrore nazista, provava a dare a questo sentimento un
altro significato. C’è, secondo lui, un buon modo di essere ostaggi. E’ quando ci sentiamo
chiamati ad una responsabilità che non possiamo declinare, quando il volto dell’Altro –
del povero, dell’infermo, del perseguitato – ci convoca prima di ogni nostra decisione ad
un’azione di soccorso alla quale non possiamo sottrarci. A differenza di quanto credeva la
gnosi, qui è il bene, e non il male, a prenderci in ostaggio. La nostra cattiva coscienza è la
ritorsione che, in quanto ostaggi, subiamo quando, nella situazione concreta, manchiamo
questo appuntamento con la possibilità del bene. Da quanto si è potuto leggere in merito
alle ragioni che portano alcuni coraggiosi nelle zone più devastate dal pianeta a rischiare e,
purtroppo, anche a morire, c’è da ritenere che a muoverli non sia una scelta ponderata, ma
proprio questo sentimento dell’inevitabile. Agli ostaggi non è data la scelta. Essi "devono",
costretti da una necessità invincibile. Ciò che allora rende una volontà “buona” è forse
questa sua resa anticipata ad un bene che, come un disumano rapitore, non accetta di
trattare.
Rocco Ronchi
IL FATTO
Dichiarazioni di immutato amore per l’Iraq e per il suo martoriato popolo da parte delle due
operatrici italiane rilasciate dai rapitori irakeni.
Notte dei tempi
In quello sterminato romanzo teologico e metafisico che è il “De divisione naturae”,
scritto nel IX secolo da un monaco irlandese, si trova una definizione dell’amore che
merita una qualche attenzione. “Si può – scrive quello straordinario filosofo ed erudito –
definire l’amore nella seguente maniera: l’amore è il termine finale e il riposo immobile
del movimento naturale che anima tutti gli esistenti che sono in movimento, termine
oltre il quale cessa ogni movimento della creatura”. In quell’epoca remota, dove i libri si
contavano sulla punta delle dita e si scriveva a fatica sulle pelli di pecore, Giovanni Scoto
Eriugena era tra i pochi che sapeva ancora leggere il greco. Questa sua commovente abilità
gli permetteva così di rendere testimonianza nel mondo latino di un immenso e, per i più,
ormai illeggibile patrimonio culturale. La sua definizione dell’amore ha il pregio di non essere
per niente originale. Ribadisce, anzi, una tradizione che nell’opera di Massimo il Confessore
(VII sec.), di Gregorio di Nazianzo (IV sec) e di Dionigi l’Areopagita (forse V sec.) ha i suoi
antecedenti prossimi, ma il cui luogo sorgivo è la Grecia di Platone e l’enigmatica voce della
sacerdotessa Diotima.
Monaci e maniaci
E’, quella di Eriugena, un’immagine dell’amore assolutamente inattuale. Fatichiamo a
riconoscervi le tempeste che hanno agitato il nostro cuore. Il monaco irlandese parla di
un termine finale del movimento naturale, quando a caratterizzare la più elementare
esperienza erotica è, al contrario, proprio il movimento, la tensione, l’aspirazione spesso
frustrata verso qualcosa che immancabilmente sfugge. Il nostro monaco non ignora affatto
questo “trasporto” amoroso. Di che altro tratta Platone, del resto, quando illustra i benefici
della “mania” erotica? Il “maniaco” è più simile ad un’indemoniata coribante che ad un
monaco raccolto in preghiera. Il riposo immobile, la quiete contemplativa (l’“esichia” del
monachesimo orientale), sembrano contrarie alla natura agitata dell’amore, ben descritta,
invece, da Ovidio quando nei suoi “Amores” mostra il tratto predatorio, avventuroso e
incosciente del desiderio. Ma quanto noi, romanticamente educati, intendiamo come la
sostanza del fenomeno, per Eriugena n’è solo la prefazione. L’amore, quello vero, inizia
quando il desiderio finisce, quando il movimento della creatura cessa. Il nostro monaco
vede insomma l’alba dell’amore dove i nostri solerti psicologi scorgerebbero solo l’inizio
della noia domestica. Per questi la cessazione del movimento è l’avvenuta entropia, il
letargo del sentimento, per lui l’immobilità, la stasi, è segno di una trasformazione che ha
avuto luogo, che è giunta finalmente al suo naturale compimento e che ha dato alla luce
un nuovo essere: un essere stabile, fermo, un essere che, nella lingua di questi giganti del
pensiero, si deve definire “apatico”. Tale è, infatti, la condizione di chi, giunto al termine
finale del movimento “naturale”, non “patisce” più mutamento alcuno. Allora non “ama”, ma
è nell’amore.
Jim Caviezel
Gli innamorati dell’amore amano dell’amore la dimensione “patologica”. Eternamente
adolescenti, cambiano per l’amore il leggero brivido che ogni forte emozione porta con sé.
Vogliono lo choc, il trasalimento, la furtiva lacrima. In un passo notissimo, Marcel Proust
ricorda però di aver incontrato l’amore più grande nella freddezza quasi disumana di chi,
costretto ad operare in una situazione d’emergenza, non ha tempo per le piacevolezze
del sentimento. Proust cita il chirurgo in tempo di guerra e i burberi modi delle infermiere
al fronte. Un buon volontario della pace, si sa, deve essere duro, quasi insensibile. Ma
questa apatia non è ovviamente indifferenza e non è nemmeno, come spesso si crede,
una maschera che copre chissà quale tormento interiore. E’ piuttosto la conseguenza
inevitabile di una trasformazione che ha già avuto luogo. Per una creatura giunta
al “termine” del “movimento naturale che anima tutti gli esistenti”, per una creatura in
quiete, cessa infatti ogni movimento, finisce ogni patire. Una raffigurazione indimenticabile
di questa “esichia” ce la regala il regista (e filosofo) americano Terence Malick nel film “La
sottile linea rossa”. E’ lo sguardo inspiegabilmente sereno del bellissimo protagonista
del film (Jim Caviezel), che, all’indomani della oscena battaglia e poco prima di morire
volontariamente, pare accarezzare, albero dopo albero, fiore dopo fiore, un paesaggio la cui
eterna bellezza è sentita comunque più forte delle devastazioni della guerra.
Rocco Ronchi
In questo numero di liberopensiero
la parola chiave è VALORE
Si parla di:
- no religion...
- Divina ignoranza
- Liberopensiero
IL FATTO
Secondo il “filosofo” Rocco Buttiglione i “valori” cattolici sarebbero discriminati
LA PAROLA CHIAVE: VALORE
no religion?
Chi canticchia Image spesso non lo sa, ma tra le condizioni che John Lennon poneva per
un mondo finalmente in pace c’era il venire meno di ogni religione. Da buon pannelliano
prima maniera, il mitico John vedeva nella religione l’oppio che giustifica ogni violenza.
Con maggiore realismo gli animi religiosi ribattono che la peggior violenza è stata in realtà
prodotta dalle religioni secolarizzate, vale a dire dai grandi sistemi ideologici, i quali,
soprattutto nel Novecento, hanno sostituito Dio con qualche umano succedaneo: la razza, la
classe, e, last but not least, la democrazia. L’obiezione non fa una piega, ma lascia inevasa
la domanda critica fondamentale. Perché se è indubitabile che è l’ideologia e non la religione
a produrre i peggiori guasti, è altrettanto vero che la dimensione religiosa con grande
facilità si converte in quella ideologica. I nostri tempi ne danno un’indiscutibile conferma. Da
Oriente ad Occidente, senza apparenti eccezioni, Dio è chiamato in causa da sedicenti devoti
per benedire baionette, attentati, apartheid, discriminazioni e tagli fiscali ai super ricchi.
C’è dunque una soglia varcata la quale ciò che nasce come religioso diventa ideologia. Alla
filosofia spetta il compito di identificarla e di nominarla, non curandosi dello scandalo che la
sua parola di verità potrà suscitare. Del resto, i filosofi non hanno molto da preoccuparsi,
giacché da tempo ormai, nonostante i festival modenesi, la loro udienza reale è ridotta
a poca cosa ed anche i fanatici islamici, dopo aver liquidato Averroè, sembrano non più
curarsene.
Divina ignoranza
Bisogna fare un passo indietro di dodici secoli e ritornare ad un tempo che si suole definire
buio ma che in realtà era solcato da vere e proprie comete di purissimo pensiero. Alla
domanda circa la somiglianza tra il Creatore e la sua Creatura umana, il filosofo e teologo
irlandese Giovanni Scoto Eriugena rispondeva in un modo che ancora oggi lascia il lettore
senza fiato. Dio è l’uomo sono in tutto e per tutto identici, tranne che per la loro origine:
ingenerato il primo, “fatto” il secondo. L’identità dell’immagine con il prototipo non è però
quella che si crederebbe. L’uomo non somiglia a Dio perché onnisciente o onnipotente.
L’uomo somiglia Dio nella misura in cui non sa e non potrà mai sapere. Anzi, se l’uomo
sapesse che cosa è, se cioè credesse di avere in mano il significato dell’esistenza (ad es. che
cosa è naturale e che cosa contronatura negli amori umani?), “l’uomo come immagine di
Dio” sono le parole del nostro filosofo “si allontanerebbe necessariamente dalla somiglianza
con il suo creatore”. Il non sapere, il dubbio, il rifiuto di ogni dogma, come cifra della
somiglianza! Perché, continua questo incredibile uomo del cosiddetto medioevo, Dio stesso,
a causa della sua infinità, non sa e non potrà mai sapere che cosa egli stesso è. Dio è
questa infinita ignoranza di sé “Dio è infinitamente più che sapere” e l’uomo si divinizza
nella misura in cui butta all’aria tutte le ideologie, tutte le definizioni, tutti i “valori”, che lo
sfigurano. Questi, infatti,lungi dall’essere qualcosa di positivo, sono soltanto i segni della
sua difformità dal prototipo, se non addirittura la prova del suo originario peccato in Adamo.
Per Eriugena non c’erano dubbi: la religione finisce quando si varca la soglia del sapere o,
come scrive un inconsapevole grande teologo del Novecento, lo psicanalista Jacques Lacan,
quando si accede al “supposto sapere”. La religione finisce insomma quando tramonta in
una comica enunciazione di “valori” che dovrebbero sovrintendere alla vita.
Liberopensiero
Esiste dunque una definizione possibile dello scadimento ideologico della dimensione
religiosa e vale la pena, in questi tristi tempi, di enunciarla chiaramente. Ogni volta che si
presuppone che il senso sia dato e ogni volta, dunque, che si fa coincidere la devozione con
l’applicazione pratica “al cospetto, naturalmente, di una casta di professionisti che vigilano
sul nostro lavoro” di questo senso (il “valore”), ebbene allora siamo di fronte all’ideologia,
quel genere di ideologia che la saggezza delle origini bollava come idolatria. Il senso non
è mai dato, il senso è sempre un’incognita all’interno di quella equazione che è la nostra
vita reale, il senso è sperimentale e congetturale ecco, invece, la parola d?ordine di uno
spirito libero. Non la parola di un ateo, ma, stando almeno a quanto scriveva un monaco
cristianissimo nel IX secolo, la parola di una fede non superstiziosa e non asservita al
mondo.
Rocco Ronchi
Scarica