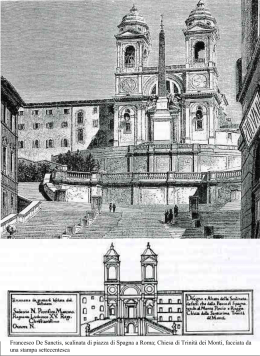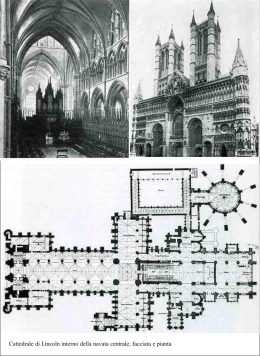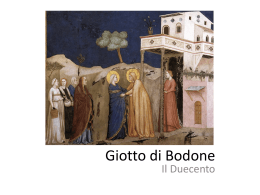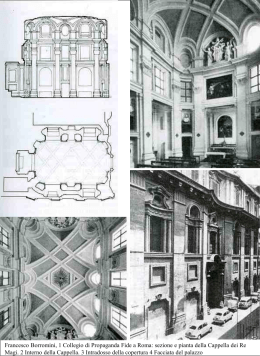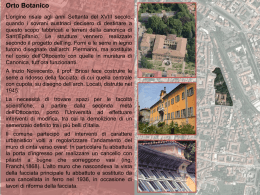MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL VENETO Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna Palazzo Ducale, 1 Venezia PERIZIA DI SPESA N. 23 del 2 luglio 2012 D.P.C.M. 10 Dicembre 2010 di ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale per l’anno 2010 RELAZIONE STORICA E RELAZIONE TECNICA CON CRONOPROGRAMMA VENEZIA – PIAZZA SAN MARCO LAVORI DI CONSERVAZIONE DELLA FACCIATA, DEL PORTICO E DELLE COPERTURE DELLE PROCURATIE NUOVE – Campate XI – XXXVI C.U.I. 13854 CUP F79G10000330001 Venezia, 2 LUGLIO 2012 IL PROGETTISTA Arch. Ilaria Cavaggioni Visto:IL SOPRINTENDENTE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Arch. Anna Chiarelli arch. Renata Codello Venezia - Procuratie Nuove o Palazzo Reale Intervento di conservazione della facciata principale e dalla falda di copertura (…) guardatevi dal voler comparire sopra le cose fatte: accomodatele, assicuratele, ma non aggiungete, non mutilate, e non fate il bravo. Giuseppe Valdier L’Architettura Pratica, III, p. 115 Relazione illustrativa con cenni sulla storia della fabbrica SOMMARIO 1. Introduzione 2. Cenni sulla storia della fabbrica 3. Caratteri stilistici 4. Caratteri costruttivi 5. La ricerca d’archivio 6. Stato di conservazione 7. Descrizione dell’intervento: linee guida e tecniche 8. Riferimenti bibliografici 1. Introduzione Molti degli aspetti descritti in questa relazione, relativi alla vicenda storica della fabbrica delle Procuratie Nuove, alle caratteristiche stilistiche e costruttive della facciata principale del palazzo, al suo stato di conservazione, ecc., si basano su ipotesi fondate sull’osservazione a distanza, ai piedi della fabbrica, sulla letteratura artistica consultata, su precedenti restauri documentati, su analogie con le Progetto definitivo 2 Venezia - Procuratie Nuove o Palazzo Reale Intervento di conservazione della facciata principale e dalla falda di copertura fabbriche coeve, sulle raccomandazioni dei manuali storici, ecc.. Tali ipotesi verranno verificate e documentate, ogniqualvolta possibile, a cantiere aperto. La fabbrica è una proprietà demaniale al 90,33% e presenta un interesse particolarmente importante dal punto di vista storico artistico, come riconosciuto da un decreto ministeriale di vincolo del 30 aprile 1993, ai sensi dell’articolo della Parte Seconda, Titolo I, Art. 10 Beni culturali del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Decreto Legislativo 42/2004). Inoltre la facciata è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte Terza dello stesso Codice. La fabbrica è occupata al piano terra da attività commerciali private nelle botteghe del sottoportico, nei due piani nobili, dal Museo Correr, comunale, e dal Museo Archeologico, statale, mentre nelle rimanenti parti è prevalentemente occupato da uffici pubblici e depositi. 2. Cenni sulla storia della fabbrica A. Scamozzi e il lascito culturale di Sansovino La fabbrica delle Procuratie Nuove era stata un elemento chiave della ristrutturazione rinascimentale di Piazza San Marco, concepita e avviata da Sansovino (1486-1570) dapprima con la realizzazione, nel 1532, del voltatesta di cinque campate delle Procuratie Vecchie (Lorenzetti 1974, 138) e poi, dal 1537, con la costruzione, a partire dall’angolo più vicino al campanile, della Libreria Marciana (Lotz 1977,58). Tale ristrutturazione aveva comportato: 1. l’isolamento del campanile e la connessa scelta di un nuovo allineamento, arretrato rispetto a quello preesistente, per la Libreria e per le adiacenti Procuratie Nuove; 2. un sistema a due ordini della nuova facciata della Libreria, impostata su un porticato, a continuazione ideale di quello a tre ordini delle Procuratie Vecchie, sul fronte opposto. L’arretramento delle facciate aveva conferito una maggiore regolarità al disegno della piazza1 e soprattutto l’aveva avvicinata alle dimensioni ideali suggerite da Vitruvio e da Alberti per il foro romano, che costituisce il vero modello ispiratore di questa ristrutturazione 2. Infatti, anche se già una cronaca del tardo Duecento ci informa che a quel tempo (Piazza San Marco) era cinta da logge (Lotz 1977, 57), il riferimento 1 In questa ristrutturazione (…) la basilica di San Marco viene posta al centro del lato orientale (…) le due facciate della Libreria formano un angolo retto (…) l’angolo sud-ovest della piazza, originariamente acuto, appare ora come ortogonale, sebbene in realtà misuri un po’ più di novanta gradi (Lodz 977, 58). Il Campanile (…) quasi un immenso gnomon vitruviano a determinare, sempre come insegna il De Architectura, gli allineamenti delle fabbriche e dei percorsi viari ruotanti attorno al “foro”. (…) non è un mistero che la larghezza dei fianchi, dei lati brevi (…) sia determinata dalla larghezza del Campanile (circa 35 piedi)(…) (e che) un analogo intervallo corra anche tra il lato meridionale del Campanile e la fronte della fabbrica marciana. Sviluppando ulteriormente questa considerazione c’è chi vede nel campanile il modulo della lunghezza del fronte delle Procuratie Nuove e della Libreria Marciana (Morolli 1994, 17). Progetto definitivo 3 Venezia - Procuratie Nuove o Palazzo Reale Intervento di conservazione della facciata principale e dalla falda di copertura culturale di Sansovino non fu tanto la preesistenza tardo quattrocentesca delle Procuratie Vecchie di Codussi 3, che a sua volta riprendeva i motivi della precedente costruzione in stile veneto-bizantino (Lorenzetti 1974, 138), ma piuttosto il modello classico del foro romano, come desumibile dalla descrizione contenuta ne I dieci libri de L’Architettura di Vitruvio, che a quel tempo era già stata divulgata dagli scritti di Alberti e di Filarete. Nel Rinascimento il legame ideale tra piazza e foro è molto stretto 4. Infatti, da un lato, il modello di foro divulgato da Leon Battista Alberti, e da questi desunto dal testo vitruviano, è quello di una piazza circondata da logge a due piani (Lodz 1974, 54); d’altro lato, quando, nel 1485, nella sua prima edizione dei Dieci Libri dell’Architettura, lo stesso Alberti descrive il progetto di una piazza, prendendo a prestito quasi parola per parola il testo di Vitruvio, (…) descrive l’agorà della città greca circondata da logge a due piani (Lodz 1977, 53). Si può quindi ragionevolmente ipotizzare che anche lo schema compositivo scelto da Sansovino per la facciata della Libreria alludesse a questo modello del foro con due piani loggiati, anche se il secondo ordine della facciata della Libreria non è costituito da una loggia aperta e continua ma piuttosto da una serie di logge (balconi), separate tra loro e schermate da finestre, che tuttavia riesce ad evocare l’immagine della loggia aperta e continua. Sviluppando ulteriormente questa ipotesi, potrebbe essere questa adozione del modello del foro con doppio loggiato continuo a spiegare perché Sansovino non avesse adottato per la Libreria lo schema a tre ordini delle Procuratie Vecchie - che egli stesso aveva adottato, appena cinque anni prima, nel realizzare le cinque campate del voltatesta di quest’ultima fabbrica sul lato corto di Piazza san Marco - e avesse inoltre scelto per il secondo ordine della Libreria Marciana un fregio ionico del tutto sproporzionato rispetto alle misure canoniche. Tale fregio infatti - oltre a mascherare le piccole finestre ovali del piano ammezzato e a costituire una bella citazione dell’analogo fregio a putti e ghirlande che orna la Farnesina di Peruzzi a Roma (Lodz 1977, 86) - gli permetteva, insieme alla balaustra dell’attico, di raggiungere la stessa 2 Il foro era il centro civico delle città romane e attorno ad esso gravitano le attività politiche, amministrative, mercantili e. almeno in parte, anche religiose. Vitruvio teorizzava che per il tipo monumentale del foro è preferibile una forma rettangolare con un rapporto 2:3 tra i lati. Inoltre la presenza di un portico colonnato è costantemente attestata per composizioni architettoniche complesse quali le agorà, anche se non è affatto dimostrata una derivazione del foro dall’agorà (cfr.EUA e Luigi Crema (1959), L’architettura romana, Torino, pp 35-36; 154-166; 358-367). Tipico del f. è inoltre l’esser definito, almeno parzialmente, da portici colonnati sia autonomi che corrispondenti a un edificio monumentale (…) Una precisa preferenza verso le prospettive assiali (…) si mostra frequentemente negli impianti più evoluti costruiti su pianta rettangolare, con un edificio templare (…) eretto su alto podio lungo uno dei lati minori (D.A.U. vol II, 368-369, sub voce “foro” redatta da Giovanni Scichilone). 3 L’erezione di questa fabbrica sembra dovuta all’architetto bergamasco Mauro Codussi che la condusse sino al primo piano entro l’anno 1500. Dopo un grande incendio (1512), i lavori furono continuati sotto la direzione del proto Bartolomeo Bon e di Guglielmo Grigi, completando il progetto codussiano (Lorenzetti 1974,138) 4 Lotz suggerisce a questo proposito che Sansovino può essere stato influenzato anche dalla frequentazione a Firenze di Baccio d’Agnolo nel periodo in cui questi progettava e costruiva con Sangallo la Loggia dell’Annunciata, che è copia intenzionale cinquecentesca della Loggia degli Innocenti e costruita espressamente allo scopo di creare una piazza circondata di portici che, pur essendo senza mercato, mantiene la forma del foro romano con loggiati (Lotz 1977, 57). Progetto definitivo 4 Venezia - Procuratie Nuove o Palazzo Reale Intervento di conservazione della facciata principale e dalla falda di copertura quota sommitale delle Procuratie Vecchie 5, per dare il segno che il suo sistema loggiato a due ordini avrebbe dovuto estendersi a tutte le facciate sulla Piazza e sulla Piazzetta6, tra l’altro inglobando anche le strade di accesso alla piazza 7. Le Procuratie Nuove, sorte sul sedime dell’antico Ospizio Orseolo e destinate ai nove appartamenti signorili e comodi dei nove Procuratori di San Marco (Selva 1815-20, 28r), vennero progettate da Vincenzo Scamozzi (1552-1616). Scamozzi era l’architetto che aveva portato a termine i lavori della Libreria Marciana interrotti dalla morte di Sansovino nel 1570. Nel 1582 i suoi disegni di cinque nuove campate, che si aggiungevano alle sedici già eseguite, avevano vinto il concorso per la prosecuzione della Libreria. Nel 1584 gli venne affidato anche l’incarico della progettazione delle Procuratie Nuove e nel 1586 ne iniziò la costruzione. Scamozzi, residente a Venezia dal 1572, era un architetto con studi teorici alle spalle e di formazione anche romana. Un suo contemporaneo, l’editore Francesco de Franceschi, nel dedicargli il libro VII della prima edizione completa di Tutte le opere di architettura di Sebastiano Serlio, di cui il padre di Scamozzi era stato amico, lo aveva significativamente battezzato il Vitruvio della nostra età (Wolters 1989, 81). Sul prospetto principale della nuova fabbrica delle Procuratie su Piazza San Marco, Scamozzi replicò fedelmente la campata tipo delle Libreria di Sansovino nel primo ordine dorico e nel secondo ordine ionico fino alla quota dei capitelli. A partire dall’architrave della trabeazione del secondo ordine, riprendendo una sua antica idea che prevedeva la sopraelevazione di un piano della stessa Libreria 8, abbandonò invece questo modello, riducendo l’altezza del fregio ionico del secondo ordine, che era, come si è già detto, di dimensioni non canoniche, eliminando la balaustra d’attico e sostituendola con un terzo ordine corinzio. Le dimensioni della fabbrica e il rispetto dei canoni classici ne fanno un bellissimo esempio di quel rinascimento romano che Ruskin, che non amava questo stile, aveva con felice sintesi descritto come caratterizzato da proporzioni tendenti al colossale e dalla supremazia della travata ritmica, da lui descritta come quell’elemento orizzontale – riconosciuto come architrave – sovrastante l’arco, che finalizza l’energia delle colonne al sostegno di questa trave, facendo dell’arco un elemento subordinato, se non del tutto superfluo (Ruskin 2000, 225). 5 Cfr. l’incisione di Vicenzo Maria Coronelli (1650-1718) raffigurante il fronte della chiesa di San Geminiano su Piazza San Marco (Franzoi 1994, 124) e il dipinto del Canaletto Venezia: Piazza S. Marco con S. Geminiano (Franzoi 1994, 134; anche in Pignatti 1996, fig. 25). 6 Francesco Sansovino scrive, quando il padre Jacopo è ancora vivo, che era nelle intenzioni di questi, e quindi ben prima di Scamozzi, che il voltatesta porticato della Libreria su piazza San Marco proseguisse fino alla Torre dell’Orologio, a parte l’interruzione costituita dalla chiesa di San Geminiano, di cui lo stesso Sansovino aveva progettato la facciata. Ma questa ipotesi, secondo Lotz, non è sufficientemente accreditata (Lotz 1977, 58). 7 (…) l’Alberti si era già premurato di raccomandare che le vie di accesso alla piazza fossero coperte a volta (Lotz 1977, 65, nota 9). 8 Al tempo del completamento della Libreria Marciana Scamozzi ne aveva proposto la sopraelevazione di un piano, garantendo che il fregio sommitale di Sansovino vi sarebbbe stato ricollocato. L’idea era stata scartata dai procuratori, per ragioni statiche (Favaro sd, 1). Progetto definitivo 5 Venezia - Procuratie Nuove o Palazzo Reale Intervento di conservazione della facciata principale e dalla falda di copertura B. La parti della fabbrica realizzate secondo il progetto originario di Scamozzi La costruzione delle prime dieci campate delle Procuratie Nuove fu eseguita sotto la direzione di Scamozzi. La sua direzione dei lavori cessò quando la undicesima campata della facciata principale non era stata ancora rivestita di pietra d’Istria e la facciata posteriore era appena arrivata alla seconda campata. Da questi brani autentici ancora visibili si può ricostruire l’immagine delle Procuratie secondo il progetto originario di Scamozzi, che venne pesantemente emendato dai continuatori della fabbrica ad eccezione della facciata principale che venne invece sostanzialmente proseguita nelle forme concepite da Scamozzi. L’edificio avrebbe dovuto presentare su piazza San Marco un fronte a tre ordini e 33 campate, che nel proseguo del cantiere divennero 36, per un totale di 384 piedi 9. Il fronte si presentava unico ma era in realtà articolato in tre edifici distinti che Scamozzi chiama “palazzi senatorii”, per richiamare l’atmosfera dell’antichità classica cui è improntato tutto il suo programma architettonico. Ogni “presa” (sinonimo di edificio o casa o lotto) doveva estendersi per undici campate ed essere costituita da due appartamenti (uno al primo ed uno al secondo piano) affacciati su due cortili separati dal setto murario contenente le scale a rampe incrociate 10 e due logge simmetriche a tre piani (sei “Case” cui avrebbero potuto seguirne altre due nella “risvolta” allineata con la fronte di San Geminiano) (Morolli 1994, 57). Nel progetto di Scamozzi la facciata posteriore sulla laguna e quelle interne dei cortili erano molto differenti dalla facciata principale su Piazza San Marco perché potevano mostrare, senza compromessi con le preesistenze sansoviniane, la netta preferenza dell’autore per la travata ritmica. Quello che sopravvive di questi prospetti mostra infatti una impaginazione basata su un sistema di lesene sovrapposte e di cornici orizzontali, di cui fanno parte anche le finestre degli ammezzati - qui presenti in tutti e tre i piani, mentre invece sul fronte principale, quando esistono, sono piuttosto mimetizzati 11 - e in cui sono scomparse, ad eccezione dei pochi portali di accesso, tutte le linee curve, quelle degli archivolti dei portici del primo ordine, dorico e della pseudo loggia, del secondo ordine ionico e quelle dei timpani curvilinei e dell’oculo del terzo ordine, corinzio. Il progetto di Scamozzi ebbe diversi ammiratori, tra cui Temanza e Quatremère de Quincy, ma anche diversi, importanti detrattori. Le critiche si appuntarono soprattutto sull’accostamento, troppo brusco, tra la facciata a due ordini della Marciana e quella a tre ordini delle Procuratie e sull’altezza, ritenuta eccessiva, delle Procuratie rispetto alla larghezza della piazza. Così, ad esempio, in rapporto alla prima di tali critiche, osservava Giannantonio Selva che (…) non potendo convenire allo Scamozzi l’altezza della trabeazione ionica del Sansovino, n’è provenuta la disgustosa irregolare unione, che si vede di faccia al campanile, delle porzioni superiori di esse due fabbriche; irregolarità che, quantunque non potesse nascere che dalla determinata volontà del suo autore, pure ha egli stesso (diciamolo pure) l’impudenza 9 Sulle misure delle Procuratie cfr. Morolli 1994, p. 57, nota 74. Questo tipo di scala a rampe incrociate, nota anche come leonardesca, era stata oggetto di studio da parte di Scamozzi e presentato nel suo trattato, come nel trattato di Palladio. 11 L’ammezzato del secondo piano è denunciato dall’oculo soprastante il timpano dell’edicola, l’ammezzato del piano terra dalla finestrella al centro dell’arcata appartenente all’ordine minore dorico della facciata di fondo nel sottoportico. 10 Progetto definitivo 6 Venezia - Procuratie Nuove o Palazzo Reale Intervento di conservazione della facciata principale e dalla falda di copertura di condannare, scrivendo (…) che ciò fu fatto senza il di lui consenso. Esistono però disegni di Scamozzi che mostrano l’inserimento tra Libreria e Procuratie Nuove di una campata atipica di mediazione tra le diverse altezze dei due corpi di fabbrica. Diverse versioni di questa campata vennero però scartate dalla committenza. La decisione a favore di una parete continua tra Libreria e Procuratie fu presa dopo parecchie discussioni (uno dei progetti era già stato approvato dal Senato) probabilmente in ricordo del vecchio progetto attribuito a Sansovino, secondo il quale tutta la piazza andava circondata di edifici uniformi (Huse, Wolters 1989, 66). Per quanto riguarda la seconda critica, quella secondo cui la presenza in facciata di un terzo ordine corinzio altererebbe le proporzioni dell’intera Piazza San Marco, tradendo in tal modo il programma di Sansovino per la sua ristrutturazione, così prosegue Selva: Allorchè Sansovino ideò il disegno del prospetto della Libreria, sapendo che questa fabbrica dovea continuare per tutta la linea della Piazza, ebbe in vista di pareggiarla in altezza a quella delle Procuratie vecchie che gli sono dirimpetto, il che avrebbe prodotto una conveniente e gradevole regolarità, ed una più proporzionata altezza colla media larghezza della Piazza; poiché le vecchie Procuratie sono alte il quarto, e le nuove il terzo di essa larghezza (Selva 1815-20, 28r). Quindi, mentre le Procuratie Vecchie e, di conseguenza, anche la Libreria sono alte un quarto della larghezza della fabbrica, con l’aggiunta del terzo ordine corinzio le Procuratie Nuove raggiungono una altezza pari a circa un terzo di questa larghezza. Se si concorda su questa valutazione di Selva - non deve essere dimenticato infatti che egli fa necessariamente riferimento ad una misura media, in quanto la larghezza della piazza non è costante ma variabile, dato che il lato costituito dalla Libreria e dalle Procuratie Nuove non è parallelo al lato delle Procuratie Vecchie ma si divarica da questa direzione mano a mano che ci si avvicina alla Basilica – ne emergerebbe che, più delle proporzioni con tanta cura ricercate da Sansovino, sarebbero proprio le criticate, nuove proporzioni volute da Scamozzi a ricondurre il disegno della piazza alle proporzioni ideali fissate da Vitruvio. Infatti, Daniele Barbaro12 nel suo commento a Vitruvio, inserito nella sua 12 Si riportano qui di seguito i passi pertinenti del commento di Barbaro, per una eventuale, futura verifica delle proporzioni della facciata. Così, nel Libro V, Cap I, Del Foro, p. 207-209: “ (…) i Romani e gli Italiani (…) il Foro (…) lo facevano più lungo, che largo, in modo che partita la lunghezza in tre parti, due ne davano alla larghezza, dove cadeva proporzione sesquialtera (= la metà di più). Erano gli spacij tra le colonne più larghi , e d’intorno i portichi, erano disposti i luoghi de banchieri, e di quelli che cambiano l’argento, se non volemo dire le botteghe degli orefici, e di sopra isportavano i poggiuoli, acciocche da quelli comodamente si potessero vedere gli spettacoli. (…) i poggioli, o pergolate coperte, che portano in fuori si chiamavano, meniana (…) Queste meniane erano commode all’uso, perche ivi si stava a vedere i giochi, e ivi si serbavano le cose, che si vendevano, e si compravano, come sono i punti in Anversa, le volte in realto in Vinetia.(Barbaro 1567, 208) E ancora, più avanti: Piace a Leon Battista, che la lunghezza sia di due quadri, e vi aggiugne anche una bella considerazione, che è questa, cioè che gli edificij, che saranno a torno la piazza, siano in modo proportionate, che non facciano parere la piazza stretta, essendo molto alti, o non la facciano parere troppo ampia, essendo molto bassi, e depressi. Però egli vuole , che gli edifici siano alti la terza parte delle larghezza del Foro. (…). Bello avvertimento è quello di Vitruvio nel presente luogo vuole vuole egli che se vorremo sopra le colonne del portico porre altre colonne, e levare la fabbrica con più ordini di tasselli, o solari, che si avvertisca di fare le colonne di sopra più sottili la quarta parte delle colonne di sotto (…). Ben dovemo avvertire, che ‘l primo ordine era Dorico, il secondo Ionico, e il terzo Corinthio, e che non seguita, che se le colonne di sotto sono la quarta parte più grosse delle colonne di sopra, che anche siano in altezza maggiori la quarta parte, perche se la colonna Dorica , è di piedi quattro di diametro essendo Dorica, sarà alta piedi ventiotto. la di sopra, che sarà ionica, se Progetto definitivo 7 Venezia - Procuratie Nuove o Palazzo Reale Intervento di conservazione della facciata principale e dalla falda di copertura traduzione a stampa del 1567 e che Scamozzi doveva ben conoscere, riporta così l’opinione di Leon Battista Alberti a proposito delle proporzioni del foro: Piace a Leon Battista, che la lunghezza sia di due quadri, e vi aggiugne anche una bella considerazione, che è questa, cioè che gli edificij, che saranno a torno la piazza, siano in modo proportionati, che non facciano parere la piazza stretta, essendo molto alti, o non la facciano parere troppo ampia, essendo molto bassi, e depressi. Però egli vuole, che gli edifici siano alti la terza parte delle larghezza del Foro (Barbaro 1567, 208). C. Le alterazioni della fabbrica rispetto al progetto originario Nel 1597, quando era quasi finita la costruzione della prima “presa” contenente le prime due abitazioni dei procuratori, il nome di Scamozzi scompare dai documenti di fabbrica. Estromesso il progettista, la direzione dei lavori venne proseguita dal proto Francesco Di Bernardin Smeraldi. Le conseguenze di questa drastica decisione della scelta di un nuovo proto, di certo meno equipaggiato dal punto di vista culturale, furono che prevalse la volontà funzionalistica e pauperistica della committenza, che precocemente rinnegò la severa magniloquenza classicistica dell’originale progetto scamozziano (Morolli 1994, 104). La facciata posteriore sulla laguna e quelle dei cortili vennero così drasticamente semplificate, eliminando ogni membratura architettonica lapidea ad eccezione di modeste cornici intorno alle aperture (Morolli 1994, 94). Venne così eliminato l’ordine architettonico a lesene architravate e la mostra a cimasa piana delle finestre, vennero eliminati i corpi scala a rampe incrociate. Tuttavia, la facciata principale su piazza San Marco venne invece semplificata soltanto in misura lieve. In particolare, la semplificazione operata consistette nella eliminazione dei festoni tra le colonne delle tre campate centrali di ogni “presa” di undici campate e della coppia di statue allegoriche sui timpani, alternativamente triangolari e curvilinei, delle finestre dell’ultimo ordine, corinzio. I critici d’arte segnalano però che in questa fase si manifestò anche una decadenza del lavoro degli scalpellini, dalla quale peraltro, secondo Temanza, non sarebbero state esenti neanche le sculture e gli intagli delle ultime campate eseguite sotto la direzione dello Scamozzi (Morolli 1994, 113). In seguito, Marco della Carità, fino al 1640, e Baldassarre Longhena (1598-1682), tra il 1645 e il1655, completarono le sequenza delle trentasei arcate della facciata e le successive sette arcate del voltatesta, fino alla Chiesa di San Gimignano. Venne replicato la schema della facciata di Scamozzi salvo che nelle ultime otto campate in cui invece scompare il terzo ordine corinzio e diventa immediato il riferimento alla Libreria di Sansovino, a due ordini, dorico e ionico, e balaustra di coronamento. bene sarà un quarto meno grossa della Dorica, cioè tre piedi, non sarà però un quarto minore, d’altezza della colonna di sotto, perche sarà di otto Diametri e mezzo, che sono piedi ventiquattro, e mezzo. e se bene anche fussero tutti gli ordini d’uno istesso genere; bisogneria, che la colonna di sotto non fusse più grossa dal piedi, di quello, che è la colonna di sotto nella cima, dove si fa la contrattura, acciocche la colonna di sopra si posasse sul vivo. Ben viene anche l’altezza della colonna minore, ma non la quarta parte (Barbaro 1567, 208-9). Progetto definitivo 8 Venezia - Procuratie Nuove o Palazzo Reale Intervento di conservazione della facciata principale e dalla falda di copertura Dopo la caduta della Repubblica di Venezia, a partire dal 1807, durante la dominazione francese, tutto il lato corto della Piazza San Marco fu rimaneggiato per fare posto ad una nuova ala delle Procuratie Nuove, trasformatesi in Palazzo Reale in quanto divenute sede della corte del vicerè Eugenio Beauharnais. Il Palazzo Reale mancava infatti di un ingresso monumentale e di un salone per le udienze e le feste. La fase progettuale fu alquanto laboriosa, si protrasse anche dopo la caduta di Napoleone, durante la dominazione asburgica, e vide il succedersi degli apporti di diversi architetti di rango, Antonio Diedo, Giannantonio Selva, Giannantonio Antolini, Giuseppe Maria Soli, Lorenzo Santi. Sotto la direzione di Soli vennero demolite la chiesa di San Geminiano e le cinque campate cinquecentesche e sansoviniane del voltatesta delle Procuratie Vecchie, mentre le sette campate della addizione secentesca di Longhena, contrariamente e quanto è stato a lungo erroneamente ritenuto, non furono anch’esse demolite ma sostanzialmente conservate e inserite nella nuova ala, detta Napoleonica. In seguito, su raccomandazione dell’Accademia delle Belle Arti e riprendendo alcuni elementi dei progetti di Antolini, il prospetto di Soli su Piazza San Marco venne significativamente modificato nella zona sommitale con l’arretramento dell’attico, l’inserimento di una terrazza chiusa da una balaustra - allineata con il poggiolo del terzo ordine scamozziano delle Procuratie Nuove e coronata da statue, secondo il modello sansoviniano della Libreria - l’abbassamento del tetto e il suo rivestimento con lastre in piombo. Si trattava di una soluzione non ardita di certo, ma alla quale è impossibile negare una qualche non spregevole volontà mimetica e di ambientazione nella fronte sulla piazza e qualità non trascurabili in quella sull’Ascensione (Bassi et Al 1978, 169-170). Nella facciata principale su Piazza San Marco, le nuove arcate neoclassiche sono ben distinguibili da quelle seicentesche di Longhena perché presentano una decorazione semplificata dei sottarchi, a ghirlande fiorite nel tratto precedentemente occupato dalla Chiesa di San Geminiano e con motivi tipicamente neoclassici nel tratto corrispondente al voltatesta demolito (Augusti 1994, 193, nota 23). Manutenzione e restauri Tra la fine del settecento e gli anni Venti del Novecento, il Palazzo delle Procuratie Nuove è stato, insieme alla adiacente Libreria Marciana, oggetto di una serie di interventi di manutenzione nella sua facciata principale. Data l’importanza dei manufatti, tali interventi - accurati, relativamente ben documentati da punto di vista archivistico 13 e quindi in teoria riconoscibili - consentono di aprire una finestra sulla cultura veneziana della manutenzione dei monumenti del periodo. Come vedremo nei paragrafi dedicati alla descrizione del progetto, proprio l’individuazione e il rispetto delle tracce superstiti di questi trattamenti, costituisce uno dei più importanti criteri guida del presente intervento di manutenzione. 13 Particolarmente importanti a questo proposito sono i documenti 1807-1922 provenienti dall’Archivio di Palazzo Reale in custodia della Soprintendenza di Venezia per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e i Beni Artistici, Storici e Demoetnoantropologici (Basso et Al. 2001, 35 e nota 2). Progetto definitivo 9 Venezia - Procuratie Nuove o Palazzo Reale Intervento di conservazione della facciata principale e dalla falda di copertura Ammodernamenti Se da una parte è raro che un edificio venga portato a termine così come viene disegnato in origine, come è appunto il caso delle Procuratie Nuove di Scamozzi, dall’altra, l’architettura si distingue dalle arti sorelle, scultura e pittura, per il fatto che nel tempo le sue opere subiscono radicali cambiamenti pur mantenendo la loro identità artistica. Il passare del tempo lascia sempre delle tracce in un edificio, non tanto a causa dell’effettivo deperimento, quanto nelle trasformazioni dovute ad un uso continuo, che possono consigliare di modificarlo o ricostruirlo per servire nuovi scopi o per soddisfare il mutamento dei gusti (Lodz 1977, 49). Nel caso del Palazzo Reale, accanto alle grandi trasformazioni, cui abbiamo già accennato e che hanno solo molto limitatamente interessato la sua facciata principale, occorre prendere in considerazione anche le trasformazioni “striscianti”, poco o per nulla documentate, in genere dettate dalle esigenze di ammodernamento tecnologico e di adattamento funzionale, come è stato il caso de: 1. il frazionamento di spazi interni per utilizzi non “di rappresentanza”, il che ha comportato l’introduzione di nuovi corpi scala incongrui con l’impianto distributivo originario, o la trasformazione in spazi commerciali di molti degli ingressi dal sottoportico ai cortili. Nella facciata nord, ad esempio, solo due ingressi su sei hanno mantenuto la loro funzione originaria; 2. l’inserimento dei termosifoni, che ha portato alla disattivazione, con eventuale occultamento o eliminazione, dei camini e delle relative canne fumarie, come mostra un semplice confronto dell’attuale skyline del palazzo con le molte vedute del Canaletto, in cui si nota anche come i comignoli superstiti hanno subito una significativa banalizzazione della loro sagoma (cfr Pignatti, 1996, figg. 93, 98, 100, 126, 134); 3. l’inserimento degli ascensori; 4.la trasformazione degli infissi della facciata rispetto alla loro forma originaria, testimoniata anche qui da dipinti del Canaletto e conservatasi invece nella facciata della Libreria Marciana. Gli scuri sono passati dall’interno all’esterno del foro finestra e si sono trasformati in più moderne “persiane”, in qualche caso interferendo con l’apparato decorativo (ad esempio con il bassorilievo all’intradosso dell’architrave dell’apertura dell’ordine minore corinzio). Gli elementi vetrati delle finestre hanno certamente cambiato dimensione, forma e forse anche colore, essendo dapprima lastre di piccole dimensioni, quadrate o esagonali o a rombo – forse in sostituzione del “vetro tondo” o “a rullo” ancora presente, come tipo ma non certamente come materia originale, nelle finestre della Marciana – per essere per ultimo sostituiti dalle moderne lastre rettangolari incolori, di più grandi dimensioni; 5.la modifica del tipo di luce e di corpi illuminanti, come di nuovo evidenziato dal confronto con una ben nota veduta del Canaletto dell’interno del sottoportico (cfr. Pignatti 1996, fig.130); Progetto definitivo 10 Venezia - Procuratie Nuove o Palazzo Reale Intervento di conservazione della facciata principale e dalla falda di copertura 6.Il cambiamento del, poco documentato, sistema originario di approvvigionamento e smaltimento delle acque: sono dismesse o scompaiono le cisterne nei cortili, viene abbandonato il primitivo impianto fognario, costituito da una rete di “gattoli” senza distinzione tra acque bianche, grigie e nere, vengono inserite moderne fosse settiche per la depurazione delle acque nere. La decadenza degli elementi di questo sistema, ormai praticamente in abbandono, non può non avere conseguenze, sul regime idrico del sottosuolo e quindi anche sulla stabilità del sedime della fabbrica; 7. Il cambiamento, ben documentato questo sì da immagini, relazioni e scavi archeologici, dei materiali della pavimentazione esterna e quindi del contesto cromatico al piede della facciata. L’aspetto della piazza è infatti profondamente mutato dal tempo in cui la facciata delle Procuratie venne ideata da Scamozzi. La pavimentazione del 1392, bicroma, a partiti quadrati di mattoni a spina di pesce circoscritti da “catene” in pietra bianca, probabilmente pietra d’Istria – che aveva sostituito la prima pavimentazione in cotto del 1267 – era stata a sua volta sostituita a partire dal 1723 da una decorazione geometrica in pietra d’Istria su sfondo di masegni di trachite euganea, su disegno di Andrea Tirali, a sua volta confermato nell’ultima ripavimentazione, che risale agli anni 1888-1890 ( Lorenzetti 1974, 137; Benedetti 1999, 14). 3. Caratteri stilistici Nei primi due ordini della facciata principale delle Procuratie Nuove, su Piazza San Marco, Scamozzi riprende e prosegue à l’idéntique il fronte della Libreria di Sansovino. Anche la vista dall’interno del portico mostra fin nel dettaglio del disegno delle pavimentazioni e degli stucchi della volta a botte questa chiara intenzione di riprodurre fedelmente i motivi architettonici sansoviniani. L’impianto architettonico, impostato su un crepidine (che allo stato attuale si mostra su tre gradini), è costituito da una combinazione di ordine maggiore trabeato e di ordine minore, costituito da arcate, nel primo ordine, dorico, da una combinazione di arco e colonne binate trabeate nel secondo ordine, ionico – dove si riconosce il motivo della serliana “contratta”, tipica del lessico di Sansovino e fonte di continua ispirazione per Scamozzi (Davis 2004, 41-42) - e da finestre con timpani alternativamente curvilinei e triangolari, nel terzo ordine, corinzio. Come abbiamo già visto, le preferenze di Scamozzi andavano alla soluzione del colonnato trabeato senza arcate che, fino al suo allontanamento dal cantiere, potè adottare nella facciata principale soltanto nel terzo ordine corinzio e che avrebbe invece dovuto dominare nelle altre facciate della fabbrica. Il motivo, anch’esso ampiamente presente in tutti e tre gli ordini della facciata principale, della colonna addossata al pilastro, che Scamozzi ha ereditato dalla Libreria di Sansovino, proviene probabilmente da Antonio da Sangallo, dal suo lavoro nel cortile di Palazzo Farnese, la cui fonte di ispirazione erano state le fabbriche romane antiche, come il teatro di Marcello (Lodz 1977, 83). Nelle colonne binate del loggiato delle Procuratie c’è, oltre che la citazione diretta delle lezioni stilistiche di Jacopo Sansovino, anche il ricordo di quelle di Giuliano da Sangallo e del Bramante di Palazzo Caprini Vidoni e della Casa Santa di Loreto (Lodz 1977, 80-81). Progetto definitivo 11 Venezia - Procuratie Nuove o Palazzo Reale Intervento di conservazione della facciata principale e dalla falda di copertura Per quanto riguarda invece le parti costruite sotto la direzione di Longhena, secondo la critica d’arte, la loro decorazione sarebbero caratterizzate da una maggiore vivacità plastica rispetto alla interpretazione più “piatta” che di tali ornati era stata data da parte dei Proti che nei primi decenni del Seicento erano succeduti allo Scamozzi nella direzione della fabbrica (Morolli 1994, 58). Nel 1797, in epoca napoleonica, nelle metope del fregio dorico del primo ordine, il ricorrente medaglione con il leone marciano in armi venne scalpellato, in quanto simbolo della Repubblica di Venezia, e sostituito da un più inoffensivo clipeo. E’ interessante notare che il simbolo venne però ripristinato nel 1883, in pieno regno sabaudo (Basso et Al 2001, 38), forse per dare il segno della continuità politica e artistico della nuova monarchia con il passato più glorioso. 4. Caratteri costruttivi La facciata della fabbrica è costituita da un muro in “pietra cotta” (mattoni) interamente rivestito da un paramento in “pietra viva” (pietra d’Istria) articolato in elementi portanti (archi, pilastri, lesene, semicolonne di ordine maggiore, colonne e semicolone di ordine minore), ed elementi portati (architravi, fregi e cornici delle trabeazioni, lastre di rivestimento delle specchiature). Sul muro si impostano la volta a botte del sottoportico, in mattoni e rivestita di stucchi, la travatura dei solai del primo e del secondo piano nobile, cui sono ancorate le centine in arelle e stucco dei controsoffitti voltati, e la travatura del piano ammezzato al secondo piano nobile, laddove presente, e quella copertura. Le grossezze da dare alli muri e la loro disposizione in un disegno del trattato di Valadier. Le dimensioni della fabbrica sono confrontabili con quelle delle Procuratie Nuove Valadier, nell’Articolo LIX della sua Architettura Pratica, intitolato Delle grossezze e proporzioni da dare alli muri nelle diverse circostanze, riporta proprio gli spessori suggeriti da Scamozzi per i muri d’ambito di un edifico di tre piani 14. Su questo tema aggiunge poi che Il Palladio vorrebbe saviamente che le riseghe fossero tutte nell’esterna parte (…) adducendo per ragione che in tal modo saranno meglio contrapposte le resistenze alle volte interne ed alli solari, giacchè il peso e l’attrito 14 (…) Scamozzi poi vorrebbe che in un edificio di tre piani alto ottanta piedi si dasse di grossezza alli muri esterni, cioè da terra sino al termine del primo piano di tre mattoni, da queste sino a tutto il secondo piano la grossezza di due mattoni e mezzo, da sopra a questo cioè tutto il terzo piano la grossezza di due mattoni. (…) sembra che debba interpretarsi che abbia voluto intendere di prendere la lunghezza del mattone (258) Progetto definitivo 12 Venezia - Procuratie Nuove o Palazzo Reale Intervento di conservazione della facciata principale e dalla falda di copertura sarà meglio contrastato (Valadier 1992, 257-268). E, in base ai rilievi disponibili, questa sembra essere stata la soluzione scelta da Scamozzi per le riseghe del muro di questa facciata. Sembra acquisito che durante il Rinascimento il rivestimento in pietra di una fabbrica veniva eseguito dopo l’assestamento dei muri in mattoni, riprendendo quindi in pieno la tradizione classica non soltanto dal punto di vista delle forme ma anche da quello dei procedimento costruttivi 15. Il collegamento tra gli elementi del rivestimento era realizzato con la malta, con i letti di piombo, con gli incastri 16 o con i legamenti metallici, vale a dire i chiodi (o doroni) e gli arpesi in rame degli antichi di cui parla Palladio nel Libro Primo del suo trattato, I Quattro Libri dell’Architettura, del 1570. Anche il collegamento tra rivestimento in pietra e retrostante muro in mattoni era principalmente affidato alla malta, agli incastri e ai legamenti metallici, in particolare gli incastri a coda di rondine e a coda di gazza raffigurati da Serlio nella famosa tavola XX, foglio 189, nel quarto de I sette libri dell’architettura17. 15 Durante il Rinascimento i costruttori seguono il sistema romano, eseguono cioè in un primo tempo la parte portante dell’edificio e procedono quindi alla posa in opera degli elementi decorativi che innestano a quella, servendosi delle smorze appositamente lasciate durante la prima fase dei lavori. (…). Il rivestimento è eseguito dopo un primo assestamento della massa muraria e in due tempi diversi: giacchè le cornici delle porte e finestre e i particolari decorativi in genere vengono posti in opera a rivestimento ultimato (Enciclopedia Italiana 1934, 62). 16 Il concatenamento della struttura in pietra da taglio non è solo affidato all’attrito o al sottilissimo strato di malta interposta tra i suoi componenti, ma si ottiene, soprattutto per i blocchi di grandi dimensioni fissati a secco, tramite incastri a tenone e mortasa ricavati dalle facce di contatto. Le sagome degli innesti sono molteplici. Le principali consistono in risalti verticali a dente rettilineo, a sezione semicircolare, quadrata o triangolare, corrispondente a incavi analoghi ricavati sui lati degli elementi contigui in modo da rimanere nascosti nel giunto (Menicali 1992, 40). 17 Havend’io trattato di tanti, e diversi ornamenti di pietra; è cosa conveniente, ch’io tratti ancora, come si debbian mettere in opera, e massimamente havendosi da accompagnare pietre vive con pietre cotte; le quai code vogliono gran diligenza e arte: percioche le pietre cotte sono la carne della fabbrica e le pietre vive sono le ossa che la trattengono. Lequal due cose, s’elle non saranno ben collegate insieme, in processo di tempo mancheranno: e però fatto il fondamento con quei debiti modi, che al sito si ricerca; bisogna che l’aveduto architetto habbia fatto preparare, e lavorare tutte le pietre vive, e anco le cotte, con l’altra materia, per il bisogno dela fabrica: e cosi ad un tempo venir murando e collegando le pietre vive con le cotte insieme. Le pietre vive fa dibisogno ch’entrino nel muro, che quantunque non ci fusse calcina che le tenesse insieme, si possa far giudicio, che da se stiano salde nel muro; il che facendo, le opere andranno a qualche perpetuità . L’esempo di questo si vede qui a canto nella figura A, dove si dimostra come si posson fare poggiuoli fuori delle finestre , senza menda alcuna, facendosi il primo ordine d’opera rustica: e de anco di opera dilicata si farà, si potrà tenere tal modo, pur che’l primo muro sia di tal grossezza, ch’ei faccia il piano a’ detti poggiuoli. Et se i basamenti, o piedistalli con le colonne sopra si haveranno da fare dove intervenghin’ pietre vive, e cotte come disopra dissi. Se le pietre vive non saran ben legate, e incastrate con le cotte, come si vede nella figura segnata B, le opere non dureran molto nel tempo. Et se le colonne saran di piu pezzi alcuni d’essi, cioè de’ minori, sarà ben che entrino piu nel muro, per sostenere piu sicuramente gli altri. Ma se le colonne sarà d’un pezzo solo vogliono esser per lo meno la terza parte del muro. Ma le base, e i capitelli sian fatti di maniera, che entrino assai piu nel muro; che la parte non lavorata sia di maggiore peso che la lavorata, accioche da se queste cose possin stare in opera senza altro sostegno. Ma se per carestia di pietre, o per la grande spesa de’ marmi, e d’altre pietre fine, si vorrà vestire alcuna facciata, o muro; sarà necessario, che’l prudente Architetto, prima che incominci a murare sopre terra, habbia fatto preparar tutte le pietre vive e lavorate, insieme con altre materie per tal bisogno, e cosi venir murando, e collegando le pietre vive con le cotte. Dico che alcuni pezzi sarà necessario che entrino tanto nel muro, che sostenghino altri pezzi sottili per virtù di alcuni incastri a coda di Rondine, o di Gazza, accioche per alcun tempo non possino uscire fuori de li altri: le quai cose bisogna venir ponendo in opera, mentre che si fa il muro di pietra cotta , per rispetto de gl’incastri sopradetti. Ma perche il muro di pietra cotta non venga calando, che calando egli si frangeriano le pietre vive oppresse dal peso disopra; bisognerà che di pietre cotte ben squadrate, e di buonissima Progetto definitivo 13 Venezia - Procuratie Nuove o Palazzo Reale Intervento di conservazione della facciata principale e dalla falda di copertura calcina ritratta sia fatto il muro, e fra le pietre sia poca calcina, e ben calcata l’una sopra l’altra, e sopra il tutto queste tali opere non vogliono esser fatte con violentia, né col giunger peso sopra peso cosi tosto: ma sian lasciati posare alquanto di corso in corso: perche se con la prestezza si vorrà fare, ponendovi peso sopra, certa cosa è, che’l muro calerà alquanto, e le pietre non potendo reggere il peso, si frangeranno. Ma se di tempo in tempo, tali opere si verrando fabricando, le cose resteran ne’ suoi termini: nondimeno io loderò sempre piu le opere collegate tutte ne’muri, che le investigioni, o incrostazioni che dir si le vogliamo, e massimamente nelle facciate di fuori, che a questo modo non si devrian far per mio aviso: percioche quei pochi edificij, che furon fatti da gli antichi, coperti di marmi, e d’altre pietre fine; si veggon hoggidì senza la scorza, dove è restato solo la massa delle pietre cotte, e anco consumate dagli anni. Ma quelli edificij, ove le pietre vive son legate con le pietre cotte, si veggono hoggidì ancora in essere: Nondimeno in diversi luoghi d’italia han fatte alcune fabbriche di muro semplice, lasciandovi i luoghi delle pietre vive, e da lì ad un tempo, poi ci han posto li suoi ornamenti: tuttavia per non esser tai cose ben legate ne’ muri: ma quasi attaccate con la colla; si vede in molti luoghi esser caduti de’ pezzi, e ogni giorno minacciar ruina. (Serlio 1584, Dell’ordine composito, commento alla tavola XX, foglio 189). Progetto definitivo 14 Venezia - Procuratie Nuove o Palazzo Reale Intervento di conservazione della facciata principale e dalla falda di copertura Valadier, a sua volta, ne descrive e disegna uno in dettaglio, nella tavola CCXVII del III libro della sua L’architettura pratica che illustra il succitato passo dedicato alla grossezza deimuri. Si tratta di una sbranca con grappa da un lato da impiombare (…) e l’altro da murare, avvertendo che il ferro della grappa (…) sia intaccato con lima e fatto a coda di rondina perché nel buco sotto squadro che sarà fatto nella pietra o marmo (…) non possa sortir fuori. La testa da murare sia rivoltata e spaccata, acciò nella muratura resti stretta e sicura (…)(Valadier 1992, 258). Tuttavia, è probabile che all’epoca di Scamozzi le preferenze andassero ancora ai legamenti in rame o meglio in bronzo, che è una lega di rame, sia perché meno dal tempo può essere consumato, essendo ch’egli non rugginisca (Palladio, ibidem, 9) sia perché l’uso del ferro per organi metallici di ancoraggio era ancora limitato per ragioni tecnologiche e quindi di costo 18. Si può quindi ipotizzare che il ferro non sia stato utilizzato nei legamenti metallici del cantiere scamozziano ma piuttosto, sempre di più, nei cantieri seicenteschi della fabbrica e nei successivi cantieri di restauro, in questo caso anche in analogia con quanto è stato osservato nelle tre campate della adiacente Libreria Marciana ricostruita dopo il crollo del campanile all’inizio del Novecento, dove sarebbe stato riscontrato l’inserimento di chiavi metalliche, con funzione di ancoraggio di lastre di rivestimento 19. In modo simile, intorno alla fine del secolo scorso, molte lastre pericolanti sono state assicurate con imperniature alla muratura in mattoni. Nel cantiere rinascimentale, ma anche nell’antichità, a partire dal cantiere egiziano, la finitura delle facceviste avveniva in opera. Come si deduce dallo stesso trattato di Palladio, ad eccezione dei piani di posa, che dovevano essere perfettamente spianati prima della messa in opera, le altre facce dei conci lapidei o delle lastre venivano collocate al rustico e poi fregate e lisciate in opera. La buona regola d’arte prescriveva dei giunti sottilissimi, appena visibili. La pietra d’Istria usata nella fabbrica, in particolare per rivestire interamente la facciata principale, proverrebbe dalla cava di Mondelago, come scrive lo stesso Scamozzi nel foglio 198 del secondo libro del suo L’idea della architettura universale: (…) Questa cava un terzo di miglio scosto dalla marina, & uno, e mezo da Rovigno guarda a Tramontana, e si ritrovano smisurate lunghezze, grossezze fino di tre piedi; tra le quali; perche ne sono forsi 20 corsi in più di 30 piedi d’altezza se ne ritrovano, che si chiaman le man bianche saldissime, e grosse circa un piede, e mezo, e queste sono delle migliori che venghino a Venetia, delle quali si servimo nelle fabriche publiche come degli Illustrissimi Signori Procuratori in Piazza San Marco di nostra inventione (…) (Scamozzi 1982, 198). La pietra d’Istria è una pietra sedimentaria, caratterizzata quindi da piani di sedimentazione pseudoparalleli che costituiscono anche le superfici di minore resistenza alla spaccatura. Tale proprietà dei piani di sedimentazione veniva sfruttata nel taglio in cava. Si distingue tra tipi di taglio in rapporto alla positione dei piani di sedimentazione. Se il taglio segue il piano di sedimentazione si tratta di un taglio nel 18 E’ soltanto a partire dal 1300 che, con lo sviluppo della tecnica della soffiatura, il ferro comincia ad avere un impiego più ampio in edilizia, non limitato agli impieghi indispensabili, cioè per la strumentazione destinata alla lavorazione del legno e della pietra (Becham 1984, 97). 19 Nella fabbrica adiacente, la Biblioteca Marciana, sarebbe stata riscontrata la presenza di tiranti, di ancoraggio di parti del rivestimento lapideo, che entrano nello spessore del muro di facciata fino ad m 1,50 di profondità. Progetto definitivo 15 Venezia - Procuratie Nuove o Palazzo Reale Intervento di conservazione della facciata principale e dalla falda di copertura verso della vena, se taglia i piani di sedimentazione si tratta invece di un taglio contro vena. Le pietre possono essere poste in opera come giacevano nelle loro cave, oppure voltando le loro giaciture all’infuori, secondo l’espressione usata dallo stesso Scamozzi (citata da Dalla Costa e Feiffer, 1981, 107, nota 2). In quest’ultimo caso le pietre col tempo sono guaste e logorate più facilmente. Il posizionamento corretto dei conci lapidei dipende quindi dalla giacitura dei piani di sedimentazione e dalla sollecitazione statica cui sono sottoposti, come mostrano le due illustrazioni, desunte dal testo di Ardito Desio, Geologia applicata all’ingegneria, Milano: Hoepli, 1973, p. 668 e p.671. Nonostante le dimensioni delle man bianche saldissime della cava di Mondelago di Rovigno avviene che anche nel cantiere delle Procuratie i fusti delle colonne, essendo monolitici, sono collocati controvena, o en délit, direbbe Choisy, e di conseguenza sono anche più soggetti a degrado, come è segnalato dai molti tasselli e mancanze visibili nel loro corpo. E’ ragionevole aspettarsi che, date le grandi dimensioni, i capitelli degli ordini maggiori costituiti da almeno due conci e che la finitura superficiale del rivestimento lapideo sia quella caratteristica del periodo di costruzione, a pelle fina, ottenuta con la martellina, almeno nelle parti non a rilievo di tipo scultoreo. Progetto definitivo 16 Venezia - Procuratie Nuove o Palazzo Reale Intervento di conservazione della facciata principale e dalla falda di copertura 5. La ricerca d’archivio Tra il 2007 e il 2009, nel corso dell’esecuzione dei primi due lotti di intervento relativi il restauro delle prime sette campate delle Procuratie Nuove, sono stati condotti approfondimenti della ricerca archivistica con la messa in luce di importanti documenti che hanno consentito di ricostruire la storia dei restauri e delle manutenzioni del Palazzo realizzati negli ultimi due secoli. L’intervento è stato occasione per riordinare almeno in parte l’importante archivio storico sugli interventi di manutenzione di Palazzo Reale - scoperto e messo in sicurezza da alcuni tecnici di questa Soprintendenza – che costituisce una insostituibile fonte di informazione sulla storia dei restauri della fabbrica e che ha guidato l’individuazione attendibile delle patine intenzionali. Di grande interesse è stato ritrovamento di un progetto di restauro realizzato alla metà del XIX secolo che ha interessato tutti gli edifici della Piazza e in particolare, tra il 1856 e il 1867, le Procuratie Nuove. Si tratta di un progetto tra il restauro e la manutenzione ampiamente illustrato attraverso elaborati grafici e voci descrittive dei lavori che prevede di intervenire sulla facciata sia per riparare i danni materiali sia per ristabilire la leggibilità architettonica del fronte. Il materiale lapideo risulta diffusamente degradato tanto da richiedere sistematici interventi di tassellatura con sostituzione di interi elementi anche architettonici e decorativi – colonne, capitelli, le statue dei fiumi dell’ordine dorico – così come l’intervento di sigillatura di tutti i giunti tra i conci di pietra che viene condotto in forma sistematica a protezione del punto di maggiore vulnerabilità per le infiltrazioni d’acqua. Ma allo stesso tempo il progetto prevede di intervenire sull’immagine del fronte alterata in parte da pregresse condizioni di degrado in parte dallo stesso intervento di restauro che aveva introdotto nuovi elementi lapidei creando forti discontinuità rispetto ad un contesto già di per sé patinato; il progetto ottocentesco prevede di intervenire dunque con una ‘tintura’, cromaticamente differenziata a seconda del contesto architettonico e decorativo, che doveva in parte patinare gli elementi bianchi di nuovo inserimento e in parte estendersi in modo più generale alle superfici per ricucire condizioni di discontinuità laddove si erano perdute o degradate patinature più antiche preesistenti. Il progetto in buona sostanza riconosce la presenza di patinature che l’intervento di restauro intende ribadire aggiornandole. 6. Stato di conservazione La facciata è orientata verso il nord /nord-ovest ed è quindi esposta all’azione del vento di tramontana. Il paramento, interamente costituito da pietra d’Istria, si presenta in mediocre stato di conservazione, anche se questa pietra, essendo un calcare bianco, compatto, a grana fine ed omogenea, è dotato di una forte capacità di resistenza all’aggressione dell’acqua, anche in un ambiente particolarmente sfavorevole, perché salmastro e inquinato, quale è quello della laguna di Venezia. L’esperienza già condotta in corrispondenza delle prime dieci arcate consente di individuare diverse forme di degrado del paramento lapideo che si possono ricondurre a due categorie identificabili in relazione ad un logica di causalità e agli effetti che ne derivano: 1) un degrado naturale, legato a cause di tipo ambientale, concepito come lenta e progressiva azione del tempo che agisce sulla materia determinando una trasformazione dell’immagine d’insieme, che ne modifica la leggibilità architettonica senza però creare turbamenti, senza alterazioni profonde, un Progetto definitivo 17 Venezia - Procuratie Nuove o Palazzo Reale Intervento di conservazione della facciata principale e dalla falda di copertura degrado che rientra in un processo naturale di invecchiamento dell’edificio a cui inevitabilmente le fabbriche sono sottoposte: a- il lento e progressivo dilavamento delle superfici con fenomeni diffusi di solfatazione e la formazione di forti differenziali cromatici tra le parti scure protette e le parti ‘bianche’ soggette a dilavamento; 2) Il degrado della materia inteso come perdita di funzionalità degli elementi costruttivi che richiede la messa in atto di presidi puntuali in grado ricostituire condizioni di integrità al fine di garantire la difesa rispetto all’innescarsi di processi degenerativi che hanno come causa principalmente l’acqua nelle sue diverse manifestazioni, un’azione manutentiva finalizzata a ristabilire la funzionalità dei sistemi costruttivi – il ripristino dei giunti di malta mediante la stuccatura, il fissaggio degli elementi rotti, la protezione dalle infiltrazioni degli elementi orizzontali, la ricostruzione degli elementi funzionali mancanti. Un degrado quindi che determina una perdita di funzionalità della fabbrica con due diverse conseguenze: lo scadimento generale della qualità della materia (degrado come aggiunta o come perdita o come alterazione della materia); i problemi più rilevati sono per gran parte legati alla presenza dell’acqua nelle sue diverse forme: a) la rottura e il distacco di porzioni di elementi lapidei di facciata con danno all’edificio e rischio per la pubblica incolumità; b) le infiltrazioni d’acqua attraverso microfessurazioni superficiali, in particolare in corrispondenza dello sporto piano dei cornicioni dell’ordine ionico e dorico, più insidiose, meno controllabili e forse più diffuse rispetto a quelle in corrispondenza dei giunti aperti, spesso non visibili né riconoscibili nei percorsi che molte volte seguono la via segnata da discontinuità del materiale all'interno del blocco lapideo, con il duplice effetto del dilavamento, nel caso di passaggi più copiosi di acqua, o di formazione di concrezioni calcaree tipo piccole 'stallattiti' che si formano nell'intradosso dei cornicioni per effetto della ricristallizzazione superficiale del carbonato di calcio disciolto dall'acqua di infiltrazione. c) la presenza di depositi dendritici (croste nere) in particolar modo nelle zone di sottosquadro dei cornicioni; d) la presenza di erbe infestanti e alghe; e) fenomeni localizzati di disgregazione superficiale e di scagliatura (cornicione ordine ionico e, in parte ordine dorico); f) fenomeni di erosione superficiale localizzati nelle aree soggette al processo di dilavamento; g) il guano dei colombi – danno estetico e danno chimico-fisico; h) mancanze e fratturazioni superficiali particolarmente localizzate in corrispondenza di elementi lapidei di sostituzione realizzati con pietra d’Istria di scadente qualità; Il degrado puntuale della materia con conseguenze sulla superficie si riflette sulla lettura dell’immagine architettonica: i dilavamenti, legati anche questi alla perdita di funzionalità dei giunti di malta e dei cornicioni, si configurano come criticità locali che influiscono drammaticamente sulla percezione visiva di insieme, sulla Progetto definitivo 18 Venezia - Procuratie Nuove o Palazzo Reale Intervento di conservazione della facciata principale e dalla falda di copertura leggibilità architettonica di un continuum, caratterizzato dalla serialità verticale degli elementi architettonici che si ripetono ritmicamente e dalla continuità delle linee orizzontali che segnano la partitura orizzontale degli ordini, determinando condizioni di discontinuità che interrompono lo sguardo. 7. Descrizione dell’intervento Le ragioni dell’intervento Questo intervento sulla facciata principale del Palazzo Reale è motivato da una assenza, nell’ultimo quarto del Novecento, di interventi di manutenzione a carattere non episodico ma sistematico, per cui nel corso degli ultimi anni si erano manifestate la necessità e l’urgenza di procedere ad una manutenzione straordinaria dell’intera facciata. L’intervento di restauro in questione costituisce la prosecuzione dei lavori di restauro avviati alla fine del 2006 e che hanno interessato le prime dieci campate del Palazzo verso Piazza San Marco. Il cantiere da poco concluso ha consentito di studiare in modo diretto le superfici della fabbrica e di comprendere il ruolo e significato delle patinature riconosciute in corrispondenza di alcune partiture architettoniche del fronte – in particolare il cornicione ed il fregio dell’ordine ionico con le figure alate, il cornicione e il fregio dell’ordine dorico con le sculture dei fiumi - in quanto trattamenti intenzionali. La lettura diretta delle stratificazioni unita alle analisi chimico-fisiche e alla ricerca archivistica ha consentito di individuare diversi trattamenti applicati sulle superfici architettoniche in pietra d’Istria e riconducibili in parte agli interventi manutentivi ottocenteschi e in parte ad interventi più antichi. Le scelte di progetto derivano da una lettura diretta e articolata della fabbrica e da un’attenta valutazione e sovrapposizione dei dati registrati dai diversi percorsi conoscitivi che hanno condotto a riconoscere nella facciata delle Procuratie Nuove una condizione assolutamente particolare legata alla specificità della fabbrica e ai suoi processi trasformativi nel tempo che, se può trovare delle analogie con gli altri edifici della piazza, ed in particolare con la Libreria, non deve necessariamente condurre a scelte reiterabili in modo indifferenziato. Le scelte nascono in relazione alla specificità dei singoli casi e, pur in una necessaria visione d’insieme, possono legittimamente differenziarsi. Le Procuratie Nuove rappresentano dunque un caso peculiare in cui la scelta di criteri conservativi, anche in relazione al tema del recupero della leggibilità del fronte architettonico, si fonda su una serie di considerazioni dalle quali non si può prescindere: a) Il fronte nord delle Procuratie Nuove presenta oggi una complessa articolazione di superfici in cui sono riconoscibili patinature in parte ottocentesche e in parte riferibili a cantieri più antichi alle quali nell’800 si erano rifatti con intento assolutamente mimetico. L’insieme di questo sistema stratificato è riferibile, sulla base dei dati desunti dai diversi percorsi analitici, a trattamenti con carattere di intenzionalità che fino ad oggi hanno caratterizzato la leggibilità del fronte architettonico. b) La presenza di tali patine contribuiscono ad una più articolata leggibilità dell’immagine architettonica e degli apparati decorativi con un'accentuazione degli effetti di chiaro-scuro che, in una zona d’ombra, scarsamente chiaroscurata per Progetto definitivo 19 Venezia - Procuratie Nuove o Palazzo Reale Intervento di conservazione della facciata principale e dalla falda di copertura l’assenza di un’illuminazione diretta e naturale in quanto esposta verso nord, mettono in risalto la plasticità in particolare degli elementi decorativi e scultorei. c) Ad una condizione di degradazione della pietra direttamente esposta all’azione degli agenti atmosferici, corrisponde al contrario il buono stato di conservazione del materiale lapideo al di sotto delle patinature, riscontrato dalle analisi chimiche, ed in particolare degli strati nero lucidi: le condizioni di conservazione sono tali da lasciare perfettamente integra la leggibilità dei segni di lavorazione della pietra (statue e metope dell’ordine dorico, fregio fitoforme dell’ordine ionico), cosa che risulta assolutamente perduta laddove la patina non esiste più. Dunque le patine non solo non rappresentano una causa di degrado del materiale lapideo, costituendo nell'insieme dei sistemi inerti rispetto al carbonato di calce, ma al contrario hanno svolto un’azione protettiva nel tempo. Reinserendosi nella logica della manutenzione ottocentesca il progetto mira a dare risposte diversificate in relazione alle diverse condizioni di degrado rilevato secondo i criteri di una moderna manutenzione. Indagini preliminari : a cantiere aperto, e a ponteggi montati, verrà condotta una attenta osservazione visiva ravvicinata del manufatto e una prima individuazione dei fenomeni di degrado e la loro mappatura, da eseguirsi usando la terminologia e i protocolli raccomandati dalla Commissiona Normal. L’elenco delle carte tematiche che potranno essere elaborate sulla scorta di queste informazioni è, in prima approssimazione, 1. Individuazione dei conci lapidei; 2. Individuazione dei tipi di lavorazione originaria dell’apparato lapideo, dei corrispondenti strumenti e di eventuali stuccature originarie; 3. Individuazione della giacitura dei singoli conci e giudizio sulla sua correttezza, in relazione ai piani di sedimentazione e al tipo di tensioni agenti; 4. individuazione degli precedenti interventi di restauro (ristuccature, in particolare cementizie, patine protettive, tassellature, sostituzioni, imperniature); 5. individuazione delle alterazioni - sulla base del lessico della Raccomandazione Normal 1/8020 e non invece le sue convenzioni grafiche, cadute in disuso con lo sviluppo della tecnologia informatica nel campo della rappresentazione grafica - 6. individuazione delle loro cause evidenti (infezione da biodeteriogeni, infiltrazione d’acqua, solfatazione da inquinamento dell’aria/acqua, ossidazione dei metalli, invecchiamento delle malte, sollecitazioni statiche, originarie o sopravvenute, agenti o non più agenti, ecc.). Come base grafica su cui riportare gli elementi di osservazione, verrà utilizzato il rilievo fotogrammetrico di tutto il fronte già eseguito nel corso dei precedenti lotti di intervento. - a cantiere aperto, e a ponteggi montati, sarà condotta in via preliminare una campagna di prelievi per le analisi chimico-fisiche che saranno localizzati nei punti stratigraficamente più significativi per completare la conoscenza dei trattamenti e delle loro stratificazioni sia in corrispondenza delle superfici 20 Il glossario Normal elenca e definisce i seguenti fenomeni: alterazione cromatica, alveolizzazione, concrezione, crosta, deformazione, degradazione differenziale, deposito superficiale, disgregazione, distacco, efflorescenza, erosione, esfoliazione, fratturazione o fessurazione, incrostazione, lacuna, macchia, mancanza, patina, patina biologica, pellicola, pitting, polverizzazione, presenza di vegetazione, rigonfiamento, scagliatura. Progetto definitivo 20 Venezia - Procuratie Nuove o Palazzo Reale Intervento di conservazione della facciata principale e dalla falda di copertura lapidee sia dei giunti di malta che presentano patinature superficilali e condizioni di stratificazione più complesse. Lavori previsti Considerato che l’intervento si estende ad un tratto consistente di facciata, si prevede di intervenire in tre fasi successive sia per limitare i disagi conseguenti l’allestimento di un cantiere con montaggio di ponteggi all’interno di un’area pubblica come Piazza San Marco, in cui è massima la concentrazione turistica con transito pedonale, sia per evitare di interferire per tempi troppo prolungati con le attività commerciali al piano terra del palazzo con accesso dal portico ed in particolare con i caffè con plateatico esterno sulla piazza. In particolare, quindi, si prevede di suddividere l’intervento in tre stralci funzionali di lavoro anche in funzione dei finanziamenti accreditati: I stralcio – campate 11 – 17 (7 campate) II stralcio – campate 18 – 26 (9 campate) III stralcio – campate 27 – 36 (10 campate) Il numero di campate per ogni stralcio sarà comunque verificato dalla DL insieme con il CSE e l’Appaltatore prima dell’inizio dei lavori in modo che la funzionalità degli stralci operativi sia anche compatibile con le attività commerciali ed in particolare con il plateatico del Caffè Florian. Sono previsti i seguenti interventi: 1. Allestimento di ponteggio, che sarà interamente metallico per ridurre il rischio di incendio. Il ponteggio sarà inoltre provvisto di un impianto di segnalazione incendi che sarà esteso anche alla zona di deposito di materiali infiammabili, prevista dal piano di sicurezza nel cortile retrostante – e di un impianto antifurto/antintrusione, data la presenza nelle Procuratie delle sedi di ben due musei, al primo piano, il Museo Archeologico, gestito dal Polo Museale Veneziano e, al secondo piano, il Museo Correr, gestito dal Comune. Entrambi gli impianti saranno collegati con i sistema di sorveglianza del Museo Correr in cui c’è una sorveglianza continua 24 ore su 24. Verranno inoltre adottati gli opportuni accorgimenti e misure per garantire, nei limiti del possibile: • la sicurezza degli addetti ai lavori e dei passanti il cui flusso nel sottoportico è piuttosto rilevante; • la prevenzione dei danni tipici da ponteggio, quali, in particolare, i danni da urti 21 dovuti alle manovre di montaggio del ponteggi, i danni da ancoraggi, che verranno, per quanto possibile, minimizzati/eliminati, innanzitutto dando la preferenza ad ancoraggi a contrasto non essendo possibile predisporre un 21 Per quanto riguarda i danni da urti durante il montaggio del ponteggio, il rischio può essere abbassato prevedendo tempi unitari di montaggio meno rapidi (Conti, Martines 1998, 55). Progetto definitivo 21 Venezia - Procuratie Nuove o Palazzo Reale Intervento di conservazione della facciata principale e dalla falda di copertura ponteggio a base larga per ragioni di ingombro e di costi 22, le macchie di ruggine23, i depositi di polvere, i sedimenti vari e la microflora sulle pavimentazioni (in masegni di trachite e in marmi, molto rari, del Cattaro) e sul paramento (in pietra d’Istria); • la minimizzazione dell’impatto del cantiere sulle attività commerciali gestite al piano terra, sia dal punto di vista visivo che logistico. Qualora ritenuto opportuno dalla direzione dei lavori, per proteggere la trachite e gli elementi in pietra d’Istria della pavimentazione e per ripartire il carico del ponteggio, si potrà eventualmente collocare sotto la base dei montanti una doppia orditura di tavole in legno, interponendo tra tavolato e pavimentazione fogli di polietilene o tessuto non tessuto o quant’altro indicato dalla D.L. per impedire la formazione di macchie. Revisione del manto di copertura della falda del tetto verso la Piazza, comprensiva della rimozione delle tegole in cotto, la rimozione della guaina impermeabilizzante, la verifica delle teste delle travi dell’ossatura lignea principale e secondaria, l’impermeabilizzazione della falda con manto sottocoppo che garantisce una maggiore traspirabilità della copertura, la ricollocazione dei coppi in cotto mediante l’impiego di ganci in rame e di rete parapasseri lungo il profilo di gronda. 2. Revisione della grondaia in pietra, con il controllo delle pendenze per il corretto deflusso delle acque, la stuccatura di lesioni e fessurazioni con malta di calce idraulica e polvere di pietra d’Istria o eventualmente altri tipi di inerti a scelta della direzione dei lavori 24, evitando di ricorrere al rivestimento in lastre di piombo. 3. 4. Manutenzione degli scuri in legno, con il loro smontaggio e la loro riparazione, inclusi la rimozione delle vecchie vernici, la sostituzione delle parti ammalorate con tasselli, la registrazione delle ante, dei cardini e dei sistemi di chiusura; 5. Restauro degli apparati lapidei, consistente in (eventuali) prestuccatura e preconsolidamento con fissaggio di scaglie o frammenti decoesi, disinfestazione 22 E’ bene premettere che, in genere, I danni più gravi sono causati dagli ancoraggi del ponteggio all’edificio da restaurare. (…) Nel rispetto della normativa vigente gli ancoraggi possono essere del tutto evitati predisponendo un progetto esecutivo specifico per il ponteggio del monumento da restaurare. In questo caso i ponteggi hanno una maggiore dimensione rispetto a un ponteggio ancorato allo stesso monumento, perché devono avere una rigidezza autonoma senza beneficiare dell’inerzia del monumento stesso. L’assenza di ancoraggi comporta maggiore area di ingombro del ponteggio a terra (…) I ponti privi di contrasto con gli edifici da restaurare oscillano per il vento , per il carico in movimento sui ponti e nel caso di un terremoto; le oscillazioni vanno calcolate preventivamente e in genere sono comprese entro la distanza massima consentita tra piano di lavoro e parete da restaurare (Conti, Martines 1998, 55) 23 Un ponteggio in lamiera zincata dovrebbe essere esente dal rischio della ruggine. La zincatura a caldo, effettuata direttamente dalle acciaierie mediante bagno è efficace e duratura; le canne sono ben protette dentro e fuori (…) Il costo del materiale zincato è mediamente il doppio (di quello) del materiale non zincato. (…) il periodo di ammortamento è breve perché il ponteggio non richiede spese aggiuntive per i lavori cautelativi – verniciatura, tappi (alle canne) secchi, teli – e successivamente il materiale non richiede manutenzioni dopo l’utilizzo. La zincatura ha un solo tallone d’Achille: gli urti e il punto di serraggio dei giunti (Conti, Martines 1998, 54). 24 Volendo rifarsi, come doveroso in un restauro, alle tecniche storiche, è stato di recente segnalato che Palladio ha utilizzato in una delle sue ville una malta contenente particelle di vetro allo scopo, sembrerebbe, di migliorare la resistenza dell’intonaco alle intemperie (dalla comunicazione del professore Adriano Ghivetti Giavarina all’incontro del 27 maggio 2004 a Bologna sul tema Storia dell’architettura come storia delle tecniche costruttive, sulle tecniche costruttive nel Rinascimento). Progetto definitivo 22 Venezia - Procuratie Nuove o Palazzo Reale Intervento di conservazione della facciata principale e dalla falda di copertura biologica, pulitura, consolidamento e la protezione (idrofobizzazione) del rivestimento lapideo in pietra d’Istria. E’ evidente che i primi tre lotti di lavori già completati hanno consentito di stabilire in modo piuttosto preciso i criteri metodologici che dovranno essere seguiti nelle linee generali per tutto il fronte individuando le tecniche e modalità di intervento – in particolare per quanto riguarda la pulitura ed il trattamento delle stuccature dei giunti in malta - nonché i materiali d’uso più opportuni. In ogni caso, considerato che, in particolare la pulitura è un’operazione particolarmente complessa e delicata per il margine di rischio che questa sempre comporta e per la sua irreversibilità, verranno comunque eseguite prove preliminari per testare sulle superfici le tecniche previste e le modalità di intervento in termini di efficacia e di conservazione. Per il preconsolidamento, ove necessario, si ricorrerà alla velatura con fogli di carta giapponese e resina acrilica, di relativamente facile rimozione con gli opportuni solventi; Per l’intervento di disinfezione, che, data l’esposizione della facciata, l’entità delle parti dilavate e la presenza visibile anche di vegetazione superiore, sarà relativamente esteso, si prevedono due applicazioni a spruzzo o a pennello di idoneo biocida, incolore e trasparente, in soluzione acquosa. Il prodotto non dovrà essere tossico e dovrà avere uno spettro di azione il più ampio possibile. Per la pulitura si prevede il ricorso, a seconda delle condizioni della superficie da pulire (in particolare stato di conservazione, giacitura, presenza di rilievo) e della consistenza e del grado di adesione del deposito da rimuovere, a quattro diverse tecniche: 1. Sulle parti soggette a dilavamento, dove la superficie della pietra si presenta di un bianco particolarmente intenso, causato in genere dalla presenza di un deposito di gesso e calcite (una “crosta bianca”) provenienti dalla solfatazione del carbonato di calcio e dalla ricristallizzazione del bicarbonato di calcio, lavaggio con acqua di rete e spazzole di saggina, a temperatura ambiente. Tale tecnica di pulitura si basa sull’azione solvente dell’acqua, eventualmente coadiuvata da un mezzo meccanico blando (spazzolone morbido in nylon o in saggina). Il lavaggio con acqua sarà comunque esteso a tutte le superfici per la rimozione dei depositi superficiali incoerenti; 2. Sulle parti sottosquadro, dove la superficie della pietra presenta in genere una “crosta nera”, più o meno spessa, coerente e aderente al supporto lapideo, applicazione di impacco biologico a base di urea. Tale tecnica di pulitura, già sperimentata con successo negli anni settanta e al momento oggetto di nuova attenzione, si basa su processi non ancora conosciuti ma che si sospetta siano di natura sia chimica che batterica. Questa tecnica va accuratamente controllata nelle sue modalità (tempo di contatto, asportazione, verifica della completa rimozione al termine). Va tassativamente esclusa a temperature ambiente inferiori a 18°C, perché diviene inefficace; all’impacco biologico potrà essere associato in alcune zone anche l’uso del vapore: Progetto definitivo 23 Venezia - Procuratie Nuove o Palazzo Reale Intervento di conservazione della facciata principale e dalla falda di copertura 3. Sulle altre parti, caratterizzate da un deposito meno spesso e/o meno coerente e meno aderente, esposizione al vapore acqueo, con acqua di rubinetto. Anche questa tecnica si basa sull’azione chimica, solvente, delle particelle di vapore acqueo che si condensano sulla superficie, eventualmente coadiuvata da un mezzo meccanico blando (spugna morbida). L’azione meccanica concomitante dovrà essere opportunamente calibrata variando la distanza tra la lancia dello spruzzo dalla superficie di trattamento. Con tale metodo l’impiego di acqua viene ridotto al minimo rispetto al lavaggio semplice o con acqua nebulizzata. Può quindi ridurre il ricorso alla stuccatura preliminare di fratture e giunti aperti, che sarebbe imposta invece nel caso di un impiego più rilevante di acqua di lavaggio, anche per impedire l’ingresso di eventuali altri agenti chimici di pulitura. L’uso del vapore acqueo consente una soddisfacente gradualità e controllabilità dell’intervento garantendo la rimozione dei depositi superficiali e dei Sali presenti in superficie e al tempo stesso la massima conservazione delle patine presenti sulle superfici. 4. In corrispondenza del fregio ionico, del fregio dorico e degli elementi scultorei dei primi due ordini, sarà utilizzata una pulitura ‘a secco’ mediante l’impiego di microtrapano con spazzolini morbidi in grado di rimuovere i depositi superficiali senza danneggiare le patinature sottostanti. Solo in specifiche situazioni di depositi particolarmente resistenti, è stata prevista la possibilità di ricorrere anche ad altre tecniche di pulitura, in particolare: 5. all’applicazione di impacchi di carbonato di ammonio, con acqua distillata, con uso di velina; 6. all’applicazione di resine a scambio ionico, nei casi in cui è più opportuno l’intervento a secco. Si tratta di composti polimerici di tipo anionico e cationico che agiscono selettivamente, mediante una azione di carattere chimico, nei confronti del solfato di calcio e del calcio. Entrambe queste tecniche, come è il caso dell’impacco di urea, vanno accuratamente controllate nelle modalità di applicazione (tempo di contatto, asportazione, verifica della completa rimozione dei prodotto al termine del trattamento). In casi limite potrà essere ammesso il ricorso a microsabbiatura di precisione. Le eventuali macchie di ruggine saranno rimosse impiegando idonee soluzioni acquose (fluoruro di ammonio a pH neutro; fosfato di ammonio portato a pH neutro con aggiunta di acido fosforico; EDTA; soluzioni acquose sature per SO 2) sapendo che questo tipo di macchie può essere solo attenuato e che l’applicazione di tutti i prodotti indicati deve essere seguita da un accurato lavaggio con acqua per impedire una loro interazione con il supporto lapideo. I depositi di guano sedimentato saranno asportati meccanicamente con bisturi. Per facilitare l'operazione la superficie interessata potrà essere bagnata e inumidita con compresse di cotone e soluzioni acquose di tensioattivo. Il consolidamento va inteso non in senso proprio, di impregnazione con un prodotto che migliori la coesione interna del materiale, ma nel senso di migliorare il legame tra conci lapidei o di ripristinare la continuità tra parti fratturate o anche solo lesionate di questi. Questo tipo di consolidamento consisterà quindi: Progetto definitivo 24 Venezia - Procuratie Nuove o Palazzo Reale Intervento di conservazione della facciata principale e dalla falda di copertura • nell’inserimento di perni in acciaio inox filettato, da fissare con resina epossidica. Le caratteristiche ottimali dei perni sono la buona stabilità chimica, come è il caso dei perni in acciaio speciale, e un coefficiente di dilatazione termica lineare il più possibile simile a quello della pietra, quale è appunto il caso dei perni in titanio o in una lega di titanio; • nelle iniezioni in profondità con resina epossidica fluida o semifluida; • negli incollaggi, sempre con resina epossidica, eventualmente caricata con inerti ventilati e coadiuvata dall’inserimento di perni in acciaio AISI 316; • nella rimozione di elementi metallici ossidati; • nella stuccatura di giunti e lesioni. Il cantiere da poco concluso ha messo in evidenza la presenza di una grande quantità di stuccature eseguite in epoche diverse, alcune anche di natura cementizia, e spesso stratificate ma che nell’insieme si presentano in discreto stato di conservazione. E’ stato riscontrato che la presenza di tutte queste stuccature rappresenta un’importante testimonianza materiale delle tecniche di intervento che si sono stratificate nel tempo consentendo anche di ricostruire la storia manutentiva del palazzo. In considerazione di ciò e visto che anche le stuccature cementizie non creano danneggiamento alla pietra, il progetto prevede, in continuità con quanto già eseguito nei lotti precedenti, di conservare tutte le stuccature esistenti intervenendo esclusivamente con la sostituzione di quelle degradate o completamente mancanti; le stuccature che saranno conservate potranno eventualmente essere oggetto di puntuali interventi di velatura per raccordarle cromaticamente con il contesto in cui si collocano. Per essere efficace e assolvere alle sue funzioni di consolidamento e di ostacolo alla infiltrazione d’acqua, l’impasto della stuccatura non dovrà rilasciare sostanze nocive al materiale lapideo (come è il caso dei sali solubili formati dagli ioni alcalini e dai solfati ceduti dal cemento), dovrà avere caratteristiche di porosità, capacità di assorbire acqua, resistenza meccanica, resistenza alla luce, dilatazione termica, abbastanza simili a quelle della pietra da stuccare e dovrà essere estesa anche alle fessure di piccole dimensioni. L’impasto sarà quindi costituito da un legante di calce aerea o idraulica (purché a basso tenore di alcali) e da un inerte costituito dalla stessa pietra d’Istria, a granulometria decrescente fino alla finitura esterna. La stuccatura potrà o dovrà, a scelta della DL, essere mantenuta leggermente sottolivello di qualche millimetro rispetto alla superficie lapidea. Sono previste inoltre indagini ultrasoniche per verificare la qualità degli elementi lapidei ed individuare eventuali soluzioni di continuità e difetti presenti nelle parti non visibili. A completamento del restauro dell’apparato lapideo verranno applicate a pennello, su tutta la superficie, e non limitatamente alle parti esposte, in continuità con quanto già eseguito nei primi due lotti di lavoro, resine idrofobiche silossaniche che hanno dimostrato di avere buoni requisiti prestazionali, in particolare relativamente all’assorbimento d’acqua e alla non alterazione del colore della pietra; 6. E’ stato inoltre previsto l’inserimento, nella fase conclusiva dei lavori, di un impianto antipiccione, per evitare che i cornicioni e gli altorilievi della facciata, una Progetto definitivo 25 Venezia - Procuratie Nuove o Palazzo Reale Intervento di conservazione della facciata principale e dalla falda di copertura volta puliti, vengano nuovamente invasi dal guano, che, come è noto, è, per la sua elevata acidità, altamente corrosivo e con il tempo costituisce un ambiente propizio alla infestazione da parte di piante superiori, in particolare nei giunti e nelle fessure della pietra. L’impianto previsto genera impulsi di sola tensione elettrostatica, di brevissima durata, circa 80 microsecondi, a intervalli di 2.5 secondi, senza consumo quindi di corrente elettrica, a parte quella minima (7 Watt) necessaria a eccitare il generatore di questi impulsi elettrostatici. Le linee elettrostatiche attive dell’impianto sono costituite da tondini in acciaio inossidabile AISI 316 L (resistenti agli ambienti acidi e salmastri). Tali linee sono supportate da isolatori in policarbonato antipolimerizzazione. Conduttori e isolatori devono resistere alle intemperie e ai raggi ultravioletti, sono fissati in parte con resine speciali reversibili, in parte attraverso l’esecuzione di micro fori, e possono essere ben mimetizzati su questo scegliendo opportunamente le tinte e i percorsi di minimo impatto. Principi guida alla conservazione a. La scelta puntuale dei trattamenti e dei materiali di restauro dovrà basarsi sulla valutazione della loro: • compatibilità con il tipo materiali oggetto di restauro e i loro comportamenti meccanici, fisici, chimici; • reversibilità; • controllabilità da parte dell’operatore; • ritrattabilità, vale a dire la possibilità di applicare nuovi trattamenti alle superfici già trattate; • efficacia e innocuità, grazie al confronto, con appositi test, delle condizioni delle superfici prima e dopo il trattamento; • durevolezza, tramite il controllo della loro efficacia anche nel lungo periodo. b. Verrà fatto ricorso, quanto più possibile, alle tecniche di indagine non invasiva o solo debolmente invasiva; A consuntivo dei lavori di restauro verrà redatta una relazione indirizzata alla programmazione dei cicli di manutenzione e ai controlli periodici di fenomeni patologici di degrado e/o di dissesto eventualmente venuti alla luce nel corso dei restauri, come richiesto dall’articolo 250 (Consuntivo scientifico) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; Per quanto riguarda il punto a), a proposito del principio della reversibilità dell’intervento, occorre chiarire che nel restauro, la reversibilità è uno stato limite piuttosto che uno stato concretamente raggiungibile. L’unico processo certo e irreversibile è invece quello del procedere inesorabile del degrado stesso. Può essere allora meno frustrante, che rincorrere interventi perfettamente reversibili, coltivare in massimo grado la discrezione, adoperandosi perché nessuno dei segni che sono visibili e riconoscibili prima dell’intervento di restauro sia perduto, nascosto Progetto definitivo 26 Venezia - Procuratie Nuove o Palazzo Reale Intervento di conservazione della facciata principale e dalla falda di copertura o confuso (specie se irreversibilmente) al termine dell’intervento stesso (Scoppola 1996, 185). Tra questi segni da conservare ci sono senz’altro le cosiddette patine “intenzionali”, vale a dire intenzionalmente applicate sulle superfici lapidee con vari interventi storici di manutenzione e la cui presenza è già stata riscontrata nelle prime campate del palazzo relative alla fabbrica scamozziana 25. - Per quanto riguarda il punto b), si ricorrerà come già detto, alla tecnica delle prove ultrasoniche. Per quanto riguarda il punto c), seguendo le indicazioni della Raccomandazione Normal 20/85, Interventi conservativi: Progettazione, esecuzione e valutazione preventiva, la relazione a consuntivo dovrà indicare dettagliatamente il fine specifico di ogni intervento eseguito; la sua esatta localizzazione; l’indicazione dei materiali di restauro effettivamente impiegati, delle modalità e dei tempi di applicazione con la descrizione delle eventuali apparecchiature utilizzate, la documentazione grafica e fotografica26 sullo stato del manufatto prima, durante e dopo l’intervento, corredati dalle schede tecniche27 e dal ricettario delle malte impiegate (tipo di legante; tipo di aggregato; rapporto legante/aggregato; in peso e volume; tipo di additivi) per stuccature di giunti, lesioni e mancanze, incollaggi, allettamento, iniezioni, ecc.. - Coperture: Fatta eccezione per l’edificio della ex Zecca caratterizzato da una copertura con rivestimento in lastre di piombo, l’intero sistema del complesso di Palazzo Reale è realizzato con manto di copertura in coppi. Tra il 1988 ed il 1992 è stato condotto da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici di Venezia un intervento sistematico di restauro delle strutture di copertura nel corso del quale si è provveduto anche alla protezione dell’impalcato di tavelle in cotto con la posa in 25 Esistono molti indizi, ricavati sia da documenti che da indagini sul campo, che confortano l’ipotesi che fosse pratica comune dei cantieri storici di manutenzione dei monumenti applicare patine sulle superfici lapidee esterne, anche se ancora l’individuazione dei componenti di tali patine resta questione ardua o irrisolta. Diverse, a seconda delle situazioni, sembrano essere stati i materiali componenti e gli obiettivi di tali patinature intenzionali. Una patina poteva essere stata applicata come “superficie di sacrificio” per proteggere la superficie lapidea originaria esposta agli agenti atmosferici, in analogia con i trattamenti riservati alla statuaria, questi ultimi meglio documentati e pienamente riconosciuti come tali, oppure applicata sin dall’inizio per fare concordare tra loro superfici lapidee già in partenza troppo disomogeneo dal punto di vista cromatico oppure applicata nel corso di un restauro per accordare dal punto di vista cromatico nuovi tasselli di restauro con un contesto fortemente annerito per inquinamento atmosferico. 26 (…( con indicate le condizioni di ripresa (illuminazione, tipo di pellicola, ecc.). per le riprese a colori va inclusa la scala cromatica di riferimento(ad esempio Kodak Color Control Patches). La riproducibilità della documentazione facilita infatti i confronti da ripetere in tempi successivi (Normal 20/85, p.4/22). 27 Le schede tecniche dovranno essere quelle conformi alle Norme UNI 8690 Parte III Edilizia – Informazione tecnica: articolazione e ordine espositivo dei contenuti e UNI 9038, Edilizia – Guida per la stesura di schede tecniche per prodotti e servizi (Cfr. AAVV (1994), Manuale di progettazione edilizia, vol. 3° Progetto tecnico e qualità, pp.166-171, Torino: Hoepli). Inoltre, come raccomandato da Normal 20/85, p/22: Le caratteristiche principali chimiche e chimico-fisiche degli eventuali prodotti impiegati vanno sempre dichiarate. Per esempio, nel caso di resine sintetiche: denominazione chimica esauriente, struttura di catena, peso molecolare medio, residuo secco, concentrazione di utlizzo, natura de/dei solventi, viscosità della soluzione, solubilità in eventuali altri solventi, possibilità di ulteriori polimerizzazioni, ecc.. Nel caso di soluzioni acquose: natura e concentrazione de/dei sali solubili, pH, ecc.. L’uso di prodotti individuati con il solo nome commerciale è tassativamente vietato. Dovranno essere indicati il nome della ditta produttrice e i nomi delle eventuali ditte trasformatrici e rivenditrici. Chi fornisce il prodotto dovrà corredarlo con un certificato che garantisca la costanza della qualità e la corrispondenza ai requisiti dichiarati. Quando devono essere impiegate particolari attrezzature, ne vanno descritte in modo dettagliato le caratteristiche e le condizioni operative. Progetto definitivo 27 Venezia - Procuratie Nuove o Palazzo Reale Intervento di conservazione della facciata principale e dalla falda di copertura opera di una guaina impermeabilizzante sopra la quale sono stati ricollocati i coppi in laterizio. Allo stato attuale le coperture presentano evidenti segni di degrado legato in parte allo scivolamento ed alla rottura dei coppi ma prevalentemente alle infiltrazioni d’acqua attraverso la cornice di gronda in pietra. Il problema si localizza in particolare in corrispondenza dei punti di discontinuità tra gli elementi lapidei della cornice di gronda dove la scarsa manutenzione dei giunti in malta degradati è causa di infiltrazione dell’acqua di scolo nelle murature innescando un processo cinematico di degrado che interessa le strutture murarie e le superfici di finitura se non, in alcuni casi, anche le strutture lignee di copertura. A ciò si aggiunge un’insufficienza dei pluviali di scarico, in parte incassati all’interno delle murature secondo l’impianto antico e in parte esterni in sostituzione degli originari danneggiati o non più affidabili, che risultano sicuramente sottodimensionati rispetto alla superficie complessiva di copertura non riuscendo a smaltire l’acqua di scolo e a consentire il completo deflusso delle gronde; il problema è aggravato inoltre dalla scarsa manutenzione delle bocche di innesto che, già di sezione ridotta, vengono il più delle volte otturate da fogliame o altro materiale di deposito. L’intervento prevede la ripassatura di tutto il manto in coppi con la rimozione della guaina di impermeabilizzazione e la messa in opera di lastre ondulate fibrobituminose in grado di proteggere il sottostante impalcato di tavelle da infiltrazioni d’acqua consentendo al tempo stesso la traspirazione del tetto ligneo; le gronde in pietra saranno interamente revisionate con la sigillatura dei giunti e la revisione delle pendenze e saranno adeguatamente protette con lastre in piombo. Si prevede inoltre di conservare i pluviali già esistenti in buone condizioni operando una revisione delle imboccature per garantirne la funzionalità. 7. Riferimenti bibliografici Augusti Adriana (1994), Dal Palazzo dei Procuratori al Palazzo del Re. Le vicende e la decorazione, sta in AAVV (1994), Le Procuratie Nuove in Piazza San Marco, Roma: Editalia Barbaro Daniele (1567), I Dieci Libri dell’Architettura di M. Vitruvio, (tradotti e commentati da Daniele Barbaro), ristampa anastatica delle Edizioni Librarie Siciliane e Bardi Editore Basso A., Quendolo A., Biscontin G., Zendri E.(1999), La libreria del Sansovino a Venezia: Studi sulle passate opere di manutenzione del paramento lapideo per l’attuale intervento di restauro, sta in Ripensare alla Manutenzione, Atti del Convegno di Studi di Bressanone, Bressanone 29 giugno- 2 luglio 1999), Venezia: Edizioni Arcadia Ricerche, pp. 251-279 Basso A., Quendolo A., Biscontin G., Zendri E., M. P. Birelli (2001), Indagini sul paramento lapideo della Libreria del Sansovino in Piazza San Marco a Venezia, sta in Tema n° 2, pp. 34-53 Progetto definitivo 28 Venezia - Procuratie Nuove o Palazzo Reale Intervento di conservazione della facciata principale e dalla falda di copertura Bassi Elena, Dorigato Attilia, Mariacher Giovanni, Pavanello Giuseppe, Romanelli Giandomenico (a cura di) (1978), 1780-1830 Venezia nell’età di Canova, Catalogo della Mostra Venezia Ottobre-Dicembre 1978, Venezia: Alfieri Becham Roland (1984), Le radici delle cattedrali, Casale Monferrato: Marietti Benedetti Andrea (1999), La pavimentazione di Piazza San Marco nella storia, sta in I I “masegni”, Quaderni: Documenti sulla manutenzione urbana di Venezia, numero 1, anno I, dicembre 1999, Venezia, Insula SpA, pp.14-16 Carbonara Giovanni (1996), Trattato di restauro architettonico, Torino: UTET, in quattro volumi Cicognara Leopoldo, Diedo Antonio, Selva Giovan Antonio (1815-1820), Le Fabbriche più cospicue di Venezia misurate, illustrate e intagliate dai membri della Reale Accademia di Belle Arti, Venezia Davi Charles (2004), Vincenzo Scamozzi architetto della luce, sta in CISA – Centro Internazionali di Studi di Architettura Andrea Palladio, Vincenzo Scamozzi 1548 – 1616, Marsilio 2004, pp. 32-45 Favaro Tiziana (s. d. ma non prima 1986), Relazione storico-artistica, pp. 1-8 sta in: Soprintendenza per i Beni Ambientali e architettonici di Venezia, Venezia - S. Marco Palazzo Reale: Intervento di restauro conservativo – Anno Finanziario 1986 Terzo Lotto Franzoi Umberto (1994), L’ala napoleonica, sta in AAVV (1994), Le Procuratie Nuove in Piazza San Marco, Roma: Editalia Huse Norbert, Wolters Wolfgang (1989), Venezia. L’arte del Rinascimento, Venezia: Arsenale Editrice Lorenzetti Giulio (1974), Venezia e il suo estuario: Guida Storico-artistica, Trieste: Lint, X ristampa novembre 1996 Lotz Wolfgang (1977), Studi sull’architettura italiana del Rinascimento, Milano: Electa Menicali Umberto (1992), I materiali dell’edilizia storica: Tenologia e impiego dei materiali tradizionali, Roma: La Nuova Italia Scientifica Morolli Gabriele (1994), Vincenzo Scamozzi e la fabbrica delle Procuratie nuove sta in AA.VV. Le Procuratie Nuove in Piazza San Marco, Roma: Editalia, 1994, pp. 11116 Pignatti Terisio (1996), Antonio Canal detto il Canaletto, Firenze: Giunti Ruskin John (2000), Le pietre di Venezia, Milano: Mondadori Scamozzi Vincenzo (1615), L’Idea della Architettura Universale, ristampa anastatica del 1982, Bologna: Arnaldo Forni Editore Progetto definitivo 29 Venezia - Procuratie Nuove o Palazzo Reale Intervento di conservazione della facciata principale e dalla falda di copertura Serlio Sebastiano (1584), I Sette Libri dell’Architettura, Libro IV, ristampa anastatica, Bologna: Arnaldo Forni Editore Scoppola F (1996), Il cantiere di restauro: Risvolti professionali, legali e amministrativi, sta in Carbonara Giovanni (1996), Trattato di restauro architettonico, Torino: UTET, vol. 4°, pp 169-223 Valadier Giuseppe (1992), L’architettura pratica, dettata nella Scuola e Cattedra dell’insigne Accademia di San Luca, 1828-1839, vol III, ristampa anastatica, Roma: Sapere 2000 Edizioni Multimediali ************************* Progetto definitivo 30 Venezia - Procuratie Nuove o Palazzo Reale Intervento di conservazione della facciata principale e dalla falda di copertura Appendici Cronologia delle vicende della fabbrica e dei suoi successivi restauri finora accertati: • 1527 Il Sacco di Roma dei Lanzicchenecchi costringe Sansovino a riparare a Venezia. Sansovino diviene Proto della Procuratia • 1532 Sansovino fa risvoltare l’edificio delle Procuratie Vecchie per cinque campate fino alla Chiesa di San Geminiano ancora gotica • 1536 Sansovino idea l’edificio della Libreria Marciana in parte anche a servizio dei Procuratori che utilizzeranno come uffici una parte delle botteghe del loggiato al piano terra (Lotz 1977, 59). • 1537 Comincia la costruzione nell’angolo più vicino al campanile, ad una distanza di circa 5 metri da esso. Il suo voltatesta di tre campate determinerà il futuro allineamento delle Procuratie Nuove, che sono arretrate rispetto a fronte del vecchio Ospizio Orseolo. • 1581 Il Maggior Consiglio decide la costruzione di nuove abitazioni per i Procuratori nell’area occupata dall’Ospizio Orseolo e altre abitazioni a ridosso del Campanile Marcantonio Barbano, fratello di Daniele, commentatore di Vitruvio, viene nominato Provveditore sopra le nuove fabbriche con la soprintendenza sui futuri lavori del proto Simone Sorella • 1582 10 aprile Vincenzo Scamozzo Visentin, battendo Simone Sorella e Francesco de Bernardin Smeraldi, vince il concorso per le Procuratie Nuove. In questo stadio, quasi certamente, l’edificio si limita a riproporre lo schema compositivo a due ordini delle tre campate del voltatesta su Piazza San Marco della Libreria Marciana • 1583 al 1593 Scamozzi dirige i lavori della libreria dalla XVII alla XXI campata. concludendoli nel 1585 (secondo Temanza) o nel 1588 (secondo Lorenzetti); Il lavori per le Procuratie saranno da lui diretti dal e presenta nel • 1596 Un modello in legno accompagnato da una scrittura circa la sistemazione di tutti gli edifici nelle due piazze S. Marco. Si desume che Scamozzi proponeva una soluzione diversa da quella adottata per il raccordo tra la Libreria di Sansovino e le Procuratie Nuove (da D.A.U. vol. V, pag 426, alla voce “Scamozzi” redatta da Renato Nicolini) • 1807 11 gennaio Per ordine di Napoleone le Procuratie Nuove diventano Palazzo Reale. Giannantonio Antolini, incaricato dal viceré Eugenio Beauharnais della Progetto definitivo 31 Venezia - Procuratie Nuove o Palazzo Reale Intervento di conservazione della facciata principale e dalla falda di copertura estensione del palazzo, fa demolire la chiesa di San Geminiano del Sansovino per costruire lo scalone di accesso a Palazzo Reale 1810-1814 Giovanni Maria Soli sostituisce Antolini • 1814 Ritornando Venezia in mano degli Austriaci, Giuseppe Borsato decora e arreda Palazzo Reale • 1822 nel Palazzo Reale si insediano il Museo Correr e il Museo Archeologico • 1856 - 1867 Intervento di restauro del fronte delle Procuratie • 1858 Ristrutturazione del caffè Florian • 1922 I Beni della Corona, tra cui il Palazzo Reale e la Libreria Marciana, che dall’epoca napoleonica ne è ormai parte integrante, sono donati al Demanio. Progetto definitivo 32 Venezia - Procuratie Nuove o Palazzo Reale Intervento di conservazione della facciata principale e dalla falda di copertura Cronoprogrammi della fase attuativa 1° Lotto funzionale - Campate XI – XVII CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI gg ponteggio montaggio smontaggio serramenti indagini preliminari analisi chimiche lapideo coperture antipiccione ponteggio smontaggio montaggio trabattello montaggio serramenti 30 60 90 XX X X X X XX XXX X X XXXX XXX X X XXXX 120 150 180 210 240 270 X XXX X XXX X XXX X XXX X XXX X XX XX XX XX X X XX XXX X X lapideo controfacciata smontaggio trabattello 2° Lotto funzionale - Campate XVIII – XXVI CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI gg 30 60 XX ponteggio montaggio X smontaggio serramenti X X indagini preliminari X analisi chimiche XX XXX lapideo X X XXX coperture X X antipiccione ponteggio smontaggio montaggio trabattello montaggio serramenti lapideo controfacciata smontaggio trabattello 90 120 150 180 210 240 270 300 X XXX X XXX X XXX X XXX X XXX X XXX X XXX X XXX X XX XX XX XX X X XX XXX X X Progetto definitivo 33 Venezia - Procuratie Nuove o Palazzo Reale Intervento di conservazione della facciata principale e dalla falda di copertura 3° Lotto funzionale - Campate XXVII – XXXVI CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI gg 30 60 XX ponteggio montaggio X smontaggio serramenti X X indagini preliminari X analisi chimiche XX XXX lapideo X X XXX coperture X X antipiccione ponteggio smontaggio montaggio trabattello montaggio serramenti lapideo controfacciata smontaggio trabattello 90 120 150 180 210 240 270 300 X XXX X XXX X XXX X XXX X XXX X XXX X XXX X XXX X XX XX XX XX X X XX XXX X X Progetto definitivo 34
Scarica