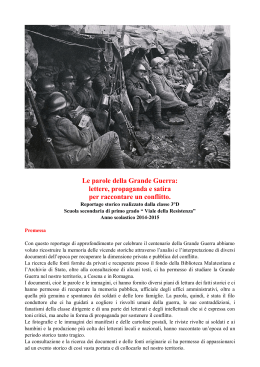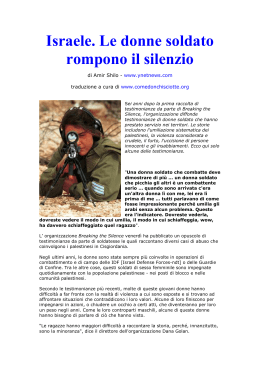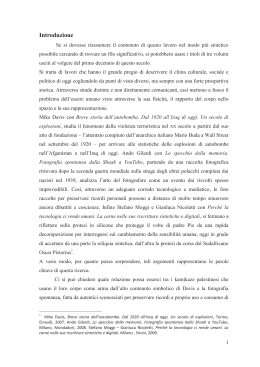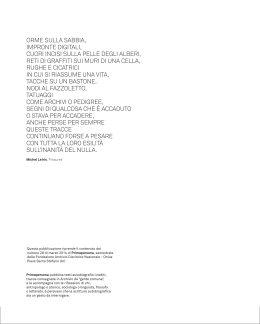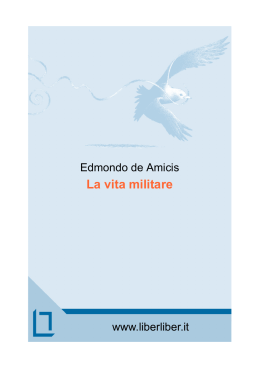Manifesto del Futurismo Le Figaro - 20 febbraio 1909 Noi vogliamo cantare l'amor del pericolo, l'abitudine all'energia e alla temerità. Il coraggio, l'audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della nostra poesia. Non v'è più bellezza se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo può essere un capolavoro. La poesia deve essere concepita come un violento assalto contro le forze ignote, per ridurle a prostrarsi davanti all'uomo. Noi vogliamo glorificare la guerra sola igiene del mondo – il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna. CONGEDO Poi che il soldato che non parte in guerra E' femmina che invecchia senz'amore: e c'é un binomio, che nel mesto cuore uno squillo ancor dà: Trento e Trieste: poi che la vita e' un male, e son moleste, dopo la prima giovinezza, l'ore: ma chi soldato fra i soldati muore, resta giovane sempre sulla terra: non so io se avverarsi ancor non possa quel sogno caro a me fin da bambino! ammiraglio non più, ma fantaccino, abbia, in ordine sparso, abbia a sparare, contro un bersaglio, che di carne e d'ossa, sappia un colpo ricevere, uno dare Non è l’amore della famiglia della giustizia della civiltà che ci spinge all’eccidio ed al massacro alla distruzione ma il nostro oscuro istinto di conquista e di rapina e di stupenda ribellione contro tutte le false leggi della società, stato, religione: menzogne, menzogne, maschere, maschere; perché solo la voracità l’insaziabilità sono le vere forze vive della creazione della vita. Saccheggia, stupra, ammazza, massacra, stupra, incendia, rovina, devasta, sconquassa, strazia! […] Puoi compiere tutte le vendette, soddisfare ogni tua cupidigia. Nessuno ti farà nessuna proibizione. Altri morirà per la Storia d'Italia volentieri e forse qualcuno per risolvere in qualche modo la vita. Ma io per far compagnia a questo popolo digiuno che non sa perché va a morire popolo che muore in guerra perché «mi vuol bene» «per me» nei suoi sessanta uomini comandati siccome è il giorno che tocca morire. Altri morirà per le medaglie e per le ovazioni ma io per questo popolo illetterato che non prepara guerre perché di miseria ha campato la miseria che non fa guerre, ma semmai rivoluzioni. Altri morirà per la sua vita ma io per questo popolo che fa i suoi figlioli perché sotto coperte non si conosce miseria popolo che accende il suo fuoco solo la mattina popolo che di osteria fa scuola popolo non guidato, sublime materia. Altri morirà solo, ma io sempre accompagnato: eccomi, come davo alla ruota la mia spalla facchina. Sotto, ragazzi, se non si muore si riposerà, allo spedale. Ma se si dovesse morire basterà un giorno di sole e tutta Italia ricomincia a cantare. In faccia a loro il Sabotin s’accende dietro i tuoi fanti, e in un orrendo schianto cade il Calvario, e sente il nostro canto Gorizia, che ci vede e si protende. Principe, in fondo, ancor trecento braccia Rammenti quando in sogno, nella valle sotto la terra, per non rimorire di crepacuore, il prossimo domani. del Tagliamento, udivi i tuoi furenti Ma il Sonno è ucciso: non potrai dormire, ùssari sciabolarci, come armenti che udrai tonfare sopra la tua faccia in fuga, innanzi alle bandiere gialle? le zampe dei cavalli maremmani. … Principe, è l’ora! déstati nel letto L’evento incalza: un ànsito prelude, di fango: alza la testa sulla fossa; fra cielo e terra, il canto dei cannoni: senti, le trombe suonan su l’Isonzo. fratelli in alto, in alto la bandiera. Giunge l’Italia: il popolo reietto viene, senza chitarre, a suon di bronzo; Nel testo il poeta si rivolge a Francesco principe, in piedi: è giunta la riscossa. Ferdinando d’Austria e gli fa presente, con Francesco Ferdinando, dalle spalle grosse e dal viso duro, ti rammenti quando sognavi i nostri monumenti crosciarti ai piedi, al rigno delle palle? Ma tu non senti, dentro le tremende tombe d’Asburgo, col tuo petto franto, sogni altre tombe sopra Monte Santo, che vedon bancheggiar le nostre tende. una serie di domande, come si era comportato il suo popolo nei confronti degli italiani. La seconda parte della poesia illustra le virtù degli italiani e il dovere di prendere le armi contro lo straniero. Ragazzi di diciannove anni, esortati da insegnanti e persino dalle famiglie, si arruolano, immaginando la guerra come una esaltante avventura. La trincea li metterà a contatto con una realtà molto diversa da quella creduta. Il punto di vista è tedesco, ma colpiscono le analogie con le testimonianze italiane. Kantorek era il nostro professore: un ometto severo, vestito di grigio, con un muso da topo. […] Nelle ore di ginnastica Kantorek ci tenne tanti e tanti discorsi; finché finimmo col recarci sotto la sua guida, tutta la classe indrappellata, al Comando di presidio, ad arruolarci come volontari. Lo vedo ancora davanti a me, quando ci fulminava attraverso i suoi occhiali e ci domandava con voce commossa: «Venite anche voi, nevvero, camerati?». […] Ce n'era uno, però, che esitava, non se la sentiva. Si chiamava Giuseppe Behm, un ragazzotto grasso e tranquillo. Si lasciò finalmente persuadere anche lui, perché altrimenti si sarebbe reso impossibile. Può darsi che parecchi altri la pensassero allo stesso modo; ma nessuno poté tirarsi fuori; a quell'epoca persino i genitori avevano la parola «vigliacco» a portata di mano. Gli è che la gente non aveva la più lontana idea di ciò che stava per accadere. In fondo i soli veramente ragionevoli erano i poveri, i semplici, che stimarono subito la guerra una disgrazia, mentre i benestanti non si tenevano dalla gioia, quantunque proprio essi avrebbero potuto rendersi conto delle conseguenze. […] Per uno strano caso, fu proprio Behm uno dei primi a cadere. Durante un assalto fu colpito agli occhi, e lo lasciammo per morto. Portarlo con noi non si poteva, perché dovemmo ritirarci di premura. Solo nel pomeriggio lo udimmo a un tratto gridare, e lo vedemmo fuori, che si trascinava carponi; aveva soltanto perduto coscienza. Poiché non ci vedeva, ed era pazzo dal dolore, non cercava affatto di coprirsi, sicché venne abbattuto a fucilate, prima che alcuno di noi potesse avvicinarsi a prenderlo. Naturalmente non si può far carico di questo a Kantorek: che sarebbe del mondo, se già questo si dovesse chiamare una colpa? Di Kantorek ve n'erano migliaia, convinti tutti di far per il meglio nel modo ad essi più comodo. Ma qui appunto sta il loro fallimento. Essi dovevano essere per noi diciottenni introduttori e guide all'età virile, condurci al mondo del lavoro, al dovere, alla cultura e al progresso; insomma all'avvenire. Noi li prendevamo in giro e talvolta facevamo loro dei piccoli scherzi, ma in fondo credevamo a ciò che ci dicevano. Al concetto dell'autorità di cui erano rivestiti, si univa nelle nostre menti un'idea di maggior prudenza, di più umano sapere. Ma il primo morto che vedemmo mandò in frantumi questa convinzione. Dovemmo riconoscere che la nostra età era più onesta della loro; essi ci sorpassavano soltanto nelle frasi e nell'astuzia. Il primo fuoco tambureggiante ci rivelò il nostro errore, e dietro ad esso crollò la concezione del mondo che ci avevano insegnata. Mentre essi continuavano a scrivere e a parlare, noi vedevamo gli ospedali e i moribondi; mentre essi esaltavano la grandezza del servire lo Stato, noi sapevamo già che il terrore della morte è più forte. Non per ciò diventammo ribelli, disertori, vigliacchi – espressioni tutte ch'essi maneggiavano con tanta facilità; – noi amavamo la patria quanto loro, e ad ogni attacco avanzavamo con coraggio; ma ormai sapevamo distinguere, avevamo ad un tratto imparato a guardare le cose in faccia. E vedevamo che del loro mondo non sopravviveva più nulla. Improvvisamente, spaventevolmente, ci sentimmo soli, e da soli dovevamo sbrigarcela. I rumori di fuori ci fasciano come un sogno: e tuttavia il ricordo non svanisce interamente. Nel dormiveglia vedo Kat alzare e abbassare il cucchiaio, e lo amo, lui, le sue spalle, la sua figura angolosa e china; ma al tempo stesso vedo dietro di lui una foresta, e le stelle, e una voce buona mormora parole che mi danno pace: pace a me, al povero soldato che coi suoi scarponi e con la sua cintura e col suo tascapane cammina sotto il vasto cielo, lungo la via che gli si stende dinanzi: pace al povero soldato che presto dimentica, e solo di rado ormai è triste, ma sempre cammina sotto il grande cielo notturno. Un piccolo soldato ed una voce buona: e se gli deste una carezza, forse non vi capirebbe più: ha gli scarponi ai piedi e il cuore pieno di terra; e marcia così, e ha tutto dimenticato fuori che il marciare. Non sono forse fiori all’orizzonte, e una campagna così quieta e serena, che gli viene voglia di piangere? Non sorgono là immagini di cose che egli non ha perdute, perché non le ha possedute mai: di cose che lo turbano, ma che per lui sono passate via: non sono là i suoi vent’anni? La notte è insopportabile: dormire non si può: ce ne stiamo accoccolati, guardando fissi dinanzi a noi e sonnecchiando ogni tanto. Tjaden lamenta che si siano sprecati quei pezzi di pane rosicchiati dai topi: dovevamo serbarli, ora ciascuno di noi li mangerebbe. Anche l'acqua, manca, ma sinora non abbiamo troppa sete. Verso il mattino, mentre è ancora scuro, ecco un'improvvisa commozione. Uno stormo di topi si precipita dall’ingresso e si slancia su per le pareti del ridotto. Le lampadine tascabili illuminano la scena. Tutti gridano e bestemmiano e picchiano. È l'ira e la disperazione di tutte queste ore che si scarica e si sfoga. Le facce sono stravolte, le braccia si agitano, le bestie guaiscono; e ci calmiamo a fatica; ancora un po', e ci saremmo assaliti l'un l'altro. Questo sfogo ci ha esauriti. Ci sediamo, e l'attesa riprende. È uno dei pochi ricoveri che ancora resistano. Il tempo Se il tempo diventa sereno il 10 faremo l’azione se il tempo diventa sereno… Ed i soldati scrutarono le stelle e il firmamento, pesarono respirando il fremito del vento. Ma il 9 si vide splendere un cerchio intorno alla luna la luna era velata d’un velo nuvoloso. I soldati e gli ufficiali che stavan da 30 giorni in attesa dell’azione si guardarono l’un l’altro si sarebbero baciati. All’alba del 10 pioveva. “La guerra non è altro che un lungo ozio, senza un minuto di riposo.” Viatico O ferito laggiù nel valloncello Tanto invocasti Se tre compagni interi Cadder per te che quasi più non eri, Tra melma e sangue Tronco senza gambe E il tuo lamento ancora, Pietà di noi rimasti, A rantolarci e non ha fine l’ora, Affretta l’agonia, Tu puoi finire, E conforto ti sia Nella demenza che non sa impazzire, Mentre sosta il momento, Il sonno sul cervello, Làsciaci in silenzio – Grazie, fratello Veglia Cima Quattro il 23 dicembre 1915 Un’intera nottata buttato vicino a un compagno massacrato con la sua bocca Digrignata volta al plenilunio con la congestione delle sue mani Penetrata nel mio silenzio ho scritto Lettere piene d’amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita San Martino del Carso Valloncello dell'Albero Isolato il 27 agosto 1916 Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro Di tanti che mi corrispondevano non è rimasto neppure tanto Ma nel cuore nessuna croce manca E' il mio cuore il paese più straziato Nasce non tanto come lavoro letterario, ma come viva testimonianza della terribile esperienza vissuta al fronte dal protagonista-narratore, il tenente Emilio Lussu della Brigata Sassari, quasi tutta composta da soldati sardi. Lussu racconta gli avvenimenti bellici succedutisi tra il giugno 1916 e il luglio 1917. lo stile narrativo è asciutto, incisivo, non concede nulla alla retorica, perché quello che preme all’autore è offrire una credibile testimonianza della sua esperienza e condannare l’orrore della guerra. – Ama lei la guerra? Io rimasi esitante. Dovevo o no rispondere alla domanda? Attorno v’erano ufficiali e soldati che sentivano. Mi decisi a rispondere. – Io ero per la guerra, signor generale, e alla mia Università, rappresentavo il gruppo degli interventisti. – Questo, – disse il generale con tono terribilmente calmo, – riguarda il passato. Io le chiedo del presente. – La guerra è una cosa seria, troppo seria ed è difficile dire se... è difficile... Comunque, io faccio il mio dovere –. E poiché mi fissava insoddisfatto, soggiunsi: – Tutto il mio dovere. – Io non le ho chiesto, – mi disse il generale, – se lei fa o non fa il suo dovere. In guerra, il dovere lo debbono fare tutti, perché, non facendolo, si corre il rischio di essere fucilati. Lei mi capisce. Io le ho chiesto se lei ama o non ama la guerra. – Amare la guerra! – esclamai io, un po’ scoraggiato. Il generale mi guardava fisso, inesorabile. Le pupille gli si erano fatte più grandi. Io ebbi l’impressione che gli girassero nell’orbita. – Non può rispondere? – incalzava il generale. – Ebbene, io ritengo... certo... mi pare di poter dire... di dover ritenere... Io cercavo una risposta possibile. – Che cosa ritiene lei, insomma? – Ritengo, personalmente, voglio dire io, per conto mio, in linea generale, non potrei affermare di prediligere, in modo particolare, la guerra. – Si metta sull’attenti! Io ero già sull’attenti. –Ah, lei è per la pace? Ora, nella voce del generale, v’erano sorpresa e sdegno. – Per la pace! Come una donnetta qualsiasi, consacrata alla casa, alla cucina, all’alcova, ai fiori, ai suoi fiori, ai suoi fiorellini! È così, signor tenente? –No, signor generale. – E quale pace desidera mai, lei? –Una pace... E l’ispirazione mi venne in aiuto. –Una pace vittoriosa. Il generale parve rassicurarsi. Mi rivolse ancora qualche domanda di servizio e mi pregò di “Addossati al cespuglio, il caporale ed io rimanemmo in agguato tutta la notte, senza riuscire a distinguere segni di vita nella trincea nemica. Ma l’alba ci compensò dell’attesa. Prima, fu un muoversi confuso di qualche ombra nei camminamenti, indi, in trincea, apparvero i soldati con delle marmitte. Era certo la corvee del caffè. I soldati passavano, per uno o per due, senza curvarsi, sicuri com’erano di non esser visti, chè le trincee e i traversoni laterali li proteggevano dall’osservazione e dai tiri d’infilata della nostra linea. Mai avevo visto uno spettacolo eguale. Ora erano là, gli austriaci: vicini, quasi a contatto, tranquilli, come i passanti su un marciapiede di città. Ne provai una sensazione strana. Stringevo forte il braccio del caporale che avevo alla mia destra, per comunicargli, senza voler parlare, la mia meraviglia. Anch’egli era attento e sorpreso, e io ne sentivo il tremito che gli dava il respiro lungamente trattenuto. Una vita sconosciuta si mostrava improvvisamente ai nostri occhi. Quelle trincee, che pure noi avevamo attaccato tante volte inutilmente, così viva ne era stata la resistenza, avevano poi finito per apparirci inanimate, lugubri, inabitate da viventi, rifugio di fantasmi misteriosi e terribili. Ora si mostravano a noi, nella loro vita vera. Il nemico, il nemico, gli austriaci, gli austriaci!… Ecco il nemico ed ecco gli austriaci. Uomini e soldati come noi, fatti come noi, in uniforme come noi, che ora si muovevano, parlavano e prendevano il caffè, proprio come stavano facendo, dietro di noi, in quell’ora stessa, i nostri stessi compagni. Strana cosa. Un’idea simile non mi era mai venuta in mente. Ora prendevano il caffè. Curioso! E perchè mai non avrebbero dovuto prendere il caffè? Perchè mai mi pareva straordinario che prendessero il caffè? Forse che il nemico può stare senza bere e senza mangiare? Certamente no. E allora, quale la ragione del mio stupore?” — Sai… così… un uomo solo… io non sparo. Tu, vuoi? Il caporale prese il calcio del fucile e mi rispose: — Neppure io. Rientrammo carponi in trincea. Il caffè era già distribuito e lo prendemmo anche noi. L’opera fu pubblicata in Italia solo nel 1948, a causa del suo tono antibellico che l’aveva fatta mettere al bando dal fascismo e mette in scena un esempio della cosiddetta “generazione perduta”, che ha perso la fiducia nei valori tradizionali (il patriottismo, la rispettabilità borghese, il lavoro, il moralismo vittoriano), ma non riesce a trovarne di nuovi. Ero sempre imbarazzato dalle parole sacro, glorioso e sacrificio e dall’espressione invano. Le avevamo udite a volte ritti nella pioggia quasi fuori dalla portata della voce, in modo che solo le parole urlate giungevano, e le avevamo lette su proclami che venivano spiaccicati su altri proclami, da un pezzo ormai, e non avevo visto niente di sacro, e le cose gloriose non avevano gloria e i sacrifici erano come i macelli a Chicago se con la carne non si faceva altro che seppellirla. C’erano molte parole che non si riusciva ad ascoltare e si finiva che soltanto i nomi dei luoghi avevano dignità. Anche certi numeri e certe date, e coi nomi dei luoghi erano l’unica cosa che si potesse dire che avesse un significato. Parole astratte come gloria, onore, coraggio o dedizione erano oscene accanto ai nomi concreti dei villaggi, ai numeri delle strade, ai nomi dei fiumi, ai numeri dei reggimenti e delle date. UOMO DEL MIO TEMPO. Sei ancora quello della pietra e della fionda, uomo del mio tempo. Eri nella carlinga, con le ali maligne, le meridiane di morte, t’ho visto – dentro il carro di fuoco, alle forche, alle ruote di tortura. T’ho visto: eri tu, con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio, senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora, come sempre, come uccisero i padri, come uccisero gli animali che ti videro per la prima volta. E questo sangue odora come nel giorno Quando il fratello disse all’altro fratello: «Andiamo ai campi». E quell’eco fredda, tenace, è giunta fino a te, dentro la tua giornata. Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue Salite dalla terra, dimenticate i padri: le loro tombe affondano nella cenere, gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore. Mio fratello aviatore Avevo un fratello aviatore. Un giorno, la cartolina. Fece i bagagli, e via, lungo la rotta del sud. Mio fratello è un conquistatore. Il popolo nostro ha bisogno di spazio; e prendersi terre su terre, da noi, è un sogno. E lo spazio che s'è conquistato è sui monti del Guadarrama. E' di lunghezza un metro e ottanta, uno e cinquanta di profondità. Sul muro c’era scritto Sul muro c'era scritto col gesso viva la guerra. Chi l'ha scritto è già caduto. La guerra che verrà La guerra che verrà non è la prima. Prima ci sono state altre guerre. Alla fine dell’ultima c’erano vincitori e vinti. Fra i vinti la povera gente faceva la fame. Fra i vincitori faceva la fame la povera gente egualmente. Dormi sepolto in un campo di grano E se gli sparo in fronte o nel cuore Non e' la rosa, non e' il tulipano Soltanto il tempo avrà per morire Che ti fan veglia dall'ombra dei fossi Ma il tempo a me resterà per vedere Ma sono mille papaveri rossi Vedere gli occhi di un uomo che muore Lungo le sponde del mio torrente E mentre gli usi questa premura Voglio che scendano i lucci argentati Quello si volta, ti vede e ha paura Non piu' i cadaveri dei soldati Ed imbracciata l'artiglieria Portati in braccio dalla corrente Non ti ricambia la cortesia Cosi' dicevi ed era inverno Cadesti a terra senza un lamento E come gli altri verso l'inferno E ti accorgesti in un solo momento Te ne vai triste come chi deve Che il tempo non ti sarebbe bastato Il vento ti sputa in faccia la neve A chieder perdono per ogni peccato Fermati Piero, fermati adesso Cadesti a terra senza un lamento Lascia che il vento ti passi un po' E ti accorgesti in un solo momento addosso Che la tua vita finiva quel giorno Dei morti in battaglia ti porti la voce E non ci sarebbe stato un ritorno Chi diede la vita ebbe in cambio una Ninetta mia crepare di maggio croce Ci vuole tanto troppo coraggio Ma tu non lo udisti e il tempo passava Ninetta bella dritto all'inferno Con le stagioni a passo di giava Avrai preferito andarci in inverno Ed arrivasti a passar la frontiera E mentre il grano ti stava a sentire In un bel giorno di primavera Dentro alle mani stringevi un fucile E mentre marciavi con l'anima in Dentro alla boca stringevi parole spalle Troppo gelate per sciogliersi al sole Vedesti un uomo in fondo alla valle Dormi sepolto in un campo di grano Che aveva il tuo stesso identico Non e la rosa, non e il tulipano umore Che ti fan veglia dall'ombra dei fossi Ma la divisa di un altro colore Ma sono mille papaveri rossi Sparagli Piero, sparagli ora E dopo un colpo sparagli ancora Fino a che tu non lo vedrai esangue Cadere in terra a coprire il suo sangue
Scaricare