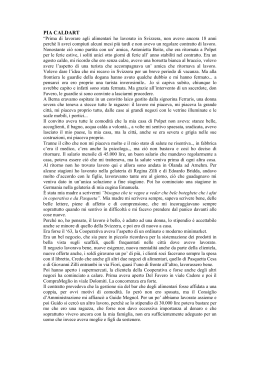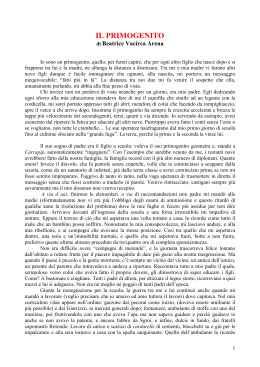1 Questo libro è dedicato alle persone che – oltre alla mia famiglia - nel corso di questi anni hanno creduto in me: alla mia editor, alla mia webmaster, alla curatrice della comunicazione per il progetto “MannaGGGiament”, alla regista degli spot youtube, alla mia supporter, alla mia coach, alla mia psycho-trainer ed ultima ma non ultima, alla mia compagna di vita. Che poi è sempre lei… Valeria. 2 Francesco Peluso MannàGGGiament! Odissea nello strazio 3 Dicette 'o pappece vicin' 'a noce: damme 'o tiemp' ca te spertoso. (Antico proverbio napoletano) Gutta cavat lapidem. (Antico proverbio latino) (Immagine presa dalla rete dalla paternità non identificata) 4 Introduzione Cos’è questo libro? Parafrasando le famose opere di Magritte, questo non è un libro. Questo libro – che non è un libro – non è un manuale di organizzazione aziendale, anche se ne parla. Questo non libro non è una noiosa e pomposa autobiografia del solito ignoto che si nutre del proprio ego. Anche se in alcuni tratti forse, c’è l’autobiografia di un ignoto (che poi sarei io…) Questo non libro (che non è un manuale né un’autobiografia pomposa) non è neanche un romanzo d’amore, anche se… beh, l’amore fa parte della nostra vita. Insomma, questo non libro, questo non…coso, è un rospo che volevo sputare da anni ed ora, finalmente, vede la luce! Le radici di questo breve scritto affondano nel passato: il 3 maggio 2006, ispirato dalla festa dei lavoratori appena trascorsa, nasce il mio blog: http://pre-cariato.splinder.com. L’incipit era questo: “Pre-cariato, ovvero: Quando il moLaRe è a Terra... Se la tua vita è diventata il ‘ponte’ tra un lavoro e l'altro e ti senti ‘giù di molare’, forse sei anche tu ‘pre-cariato’... Salviamoci prima di essere devitalizzati!” All’epoca ero un lavoratore a progetto in attesa di ottenere il rinnovo del permesso di sopravvivenza. La mia vita da blogger ha avuto andamenti altalenanti: momenti di ispirazione più o meno alta e persino qualche riconoscimento più o meno “gradito”. Vinsi il premio “Ibis” nel 2007, un piccolo concorso per blogger esordienti e ricevetti anche numerose “attenzioni” da parte delle Autorità di Controllo delle Telecomunicazioni. Tra i miei assidui lettori c’erano Ministeri, Autorità Garanti e Comandi Generali dell’Arma… Data l’aria un po’ pesante che si era creata intorno al blog con mia grande sorpresa e disappunto (in fin dei conti, non scrivevo nulla di “eversivo”) e poiché ero stanco di sentirmi “pre-cariato”, decisi di migrare verso altre sponde. Nacque così un altro blog nel maggio del 2009: mannaggiament.blogspot.com. Il termine “mannagggiament” mi venne in mente, per la prima volta nel 2002 quando, una volta ricevuto l’attestato per il conseguimento del Master in Management Bancario e Comunicazione Finanziaria, mi affrettai a farne una scansione ad alta qualità ed a sostituirne il titolo - rieditandolo con Photoshop – con un più appropriato: Master in Mannagggiament Bancario e Cornificazione Fidanzate 1. Ebbene, una volta rielaborato il nuovo attestato, mi affrettai a rispedirlo a tutti i miei colleghi partecipanti, scrivendo loro in una mail che: “Il Signor Sòla, organizzatore del Master, mi ha incaricato di spedirvi il VERO attestato poiché quello pervenuto per posta è, ahimè, errato. Dovete solo compilare il modulo in bianco con i vostri nomi ed i vostri dati”. Subito dopo l’invio della mail, fioccarono nella mia casella di posta irate richieste di spiegazioni sulle ragioni per cui ero stato io incaricato di tale delicato compito e non altri e sul perché avevano 1 Proseguendo nella lettura del libro capirete anche il perché di questo titolo. Soprattutto la parte riguardante le povere fidanzate. 5 scelto quella forma piuttosto che una nuova spedizione postale. In quel momento capii che come falsario, forse, avrei avuto buone chance e che molti dei miei colleghi avevano l’intelligenza di un uovo alla coque! Ripensandoci comunque, forse il termine mannagggiament risale ad ancora prima, a quando frequentavo la facoltà di Economia e Commercio insieme con il mio inseparabile amico Fausto. L’indirizzo che scegliemmo era - per l’appunto – quello in Management Aziendale. Sin dai banchi del liceo, che pure avevamo frequentato insieme, io e Fausto eravamo soliti storpiare le parole, enfatizzandone così i significati nascosti. Era stato il grande Nino Frassica, nei panni di Sani Gesualdi da Scasazza, ad averci influenzati insieme ai comici della scuola di “Drive-In” degli anni ’80. Fatto sta che il nostro passatempo preferito era sostituire i termini corretti con altri che ci suonavano meglio. Ancora oggi ho difficoltà – e mi devo concentrare per non sbagliare – nel dire che ero iscritto ‘all’albo dei promotori’ e non ‘all’album’, o che un tale personaggio è un po’ ‘sui geneRis’ e non ‘sui GeneSis’… Insomma, io e Fausto avevamo gettato la nostra bella lingua alle ‘ostriche’… (Pardon, ortiche) e fu così che trovatici di fronte alle mille difficoltà della carriera universitaria, esclamammo più e più volte Mannagggiament! Comunque sia andata, questo progetto mi è nato dentro ed ho sentito il bisogno di metterlo nero su bianco. Eccolo quindi, spero di non annoiarvi. Buona lettura! 6 Capitolo 1 Che cos’è il mannaggiament? Proviamo a dare una definizione dello strambo termine che dà il titolo alla mia opera. Dicesi mannaggiament quell’atteggiamento tutto italiano fatto di pressapochismo manageriale che pretende, simula e scimmiotta il vero sapere (o know-how) aziendale mediante il riflusso gastroesofageo di nozioni maldigerite. Il mannaggiament è dunque l’imitazione di comportamenti appresi da fonti non accademiche e non qualificate o ipoassimilato durante corsi di formazione iper intensivi, nei quali si sintetizzano in tre giorni concetti che richiederebbero anni di studi ed analisi sul campo per essere davvero appresi. Avete presente quei dirigenti che, per non dimostrare la propria assoluta, totale ignoranza, si trincerano dietro parole anglosassoni di cui non conoscono neanche bene il significato? (chiunque abbia partecipato ad una riunione aziendale nella propria vita, sa di cosa parlo) I dirigenti in questione sono affetti da una malattia che definisco milanesite, nel senso che colpisce prevalentemente quelli che, anche per un giorno nella propria vita, hanno avuto a che fare con dei formatori del Nord Italia e nella fattispecie, provenienti da quel di Milano. Perché ce l’ho proprio con i milanesi, vi chiederete? No, non ce l’ho affatto con loro, anzi! Milano è l’unica città italiana ad avere un respiro europeo e chiunque vi metta piede per più di un mese, ne rimane intriso. Puoi essere un montanaro della mitica Val Brembana o un terronaccio come il sottoscritto: se resti lì a lavorare, diventi uno di loro. Ma l’altro lato della medaglia è che chi vive lì, sente il peso del resto dell’Italia che va al rimorchio e sogna come reazione, di essere isolato in una piccola enclave, un ennesimo Stato degli USA distaccato per puro caso, nella nostra penisola. Ecco perché dunque, chi è “affetto” da milanesite, è portato all’uso ed abuso di termini anglosassoni che sono utilizzati a sproposito nel 99% dei casi. Il mannaggiament dunque, è un bolo di nozioni rimasticate e non digerite, mai apprese dalle fonti dirette, spesso anche superate da decenni nei paesi in cui hanno visto la luce. Questo modo di fare impresa è molto diffuso anche nel profondo Sud del nostro Paese. Anzi, noi del Sud – così pane e puparuoli [Naif, N.d.S]- diamo spesso libero sfogo al mannaggiament e chi vuol darsi arie da milanese (ovvero, apparire un manager competente e carismatico) infarcisce inevitabilmente l’italiano di parole inglesi, senza alcuna pietà. Faccio un esempio di un discorso di apertura per una riunione d’azienda tenuta da un mànnaggger: – “Signori, oggi abbiamo schedulato un meeting – e ringrazio i nostri colleghi della divisione X, FROM Ciainisello Balsamo che ci stanno followando in conference-call – per analizzare dei report di un’importanza really strategic ai fini della mission e dei target che ci siamo budgettati ad inizio anno. Il plus (pronunciato “plas” all’americana e non “plus” alla latina) della nostra enterprise ( ed è così che, mentre il mànnaggger parla e voi sbadigliate e sognate la pausa caffè, vi appare il Comandante Kirk di StarTrek che gioca a battaglia spaziale col Dr. Spock e gli colpisce ed affonda due corazzate Klingon) richiede una strategydi short-term che ci faccia essere sempre up-to-date anche se il trend di macro nella long-term, è nettamente down in questo ultimo rush di inizio decade…(pron. Dicaid)” E così discorrendo. Il mànnaggger in questione…cosa avrà voluto dire? Probabilmente, che lui non sa che pesci pigliare, che non sa 7 come il caso abbia potuto essere tanto stupido da fargli raggiungere la posizione che ricopre. Ma in fondo, non è colpa del mànnaggger se ha avuto genitori ricchi & potenti , genitori che gli hanno fatto fare le grandi scuole. Non è colpa del mànnaggger se lo zio Ministro-Imprenditore-Grande Avvocato-Luminare-Massone lo ha sistemato dove doveva quando doveva (non prima che che il giovane mànnaggger scavezzacollo abbia sparso il suo seme nel mondo per poi finalmente mettere la testa a posto… se no il buon-nome-della-famiglia che fine avrebbe fatto?) Voi, umili sottoposti di tale mànnaggger, potrete pure dipingergli un quadro in cui il sole sarà tanto splendente da farlo abbronzare… ma nulla sarà mai abbastanza per quest’uomo, che immancabilmente scaricherà la colpa di ogni suo eventuale fallimento su di voi (viceversa, in caso di successo, se ne assumerà ogni merito) Questo è un mànaggger italiano DOC! Il management sta al mannagggiament come la vera pizza Margherita, fatta da un pizzaiolo napoletano d.o.c. , cotta in un forno a legna, preparata con ingredienti freschi e di prima qualità come la mozzarella di bufala e del basilico profumato sta ad una sfoglia tonda di pastacolla ricoperta di ketchup, salami & pepperoni e “provolino” di simil plastica imbufalita, sfornata in un sobborgo di New-York da Maryo Fetuccinni (al secolo Ali Al Sakuri) anonimo muratore egiziano, emigrato dal Cairo negli anni ’70 e che, avendo casualmente condiviso per qualche tempo un posto letto con un amico che aveva lavorato per sei mesi nella cambusa di una nave da crociera italiana, millanta di essere un cuoco napoletano verace. Il termine mannaggiament però può avere anche un’altra accezione. Infatti, esso può essere inteso come quell’esclamazione che il povero studente (che ha studiato e si è fatto una gran… Cultura sui testi universitari) si lascerà sfuggire una volta trovatosi faccia a faccia con la rovina delle imprese vere: “Ma mannaggiament a me e a chi m’ha fatto perdere tanto tempo a studiare!!! Mi andavo a drogare come tutti gli altri diciottenni ! Ma no, io ho voluto iscrivermi ad Economia e Commercio!!!” Contro aziende mal gestite e i loro mànnaggger, il povero neolaureato, tanto preparato teoricamente quanto impreparato nel concreto, si troverà a combattere una guerra persa in partenza, con armi persino più spuntate e meno efficaci di quelle utilizzate da Don Chisciotte contro i mulini a vento. 8 Capitolo 2 Quando tutto è cominciato. 1970. È fine maggio. In una piccola clinica della periferia di Napoli nasco io, ultimo di quattro figli. Mio padre era un impiegato del Comune, mia madre una casalinga a tempo pieno. Entrambi erano stati degli ottimi e talentuosi sarti da ragazzi, entrambi però avevano poca inclinazione verso il mondo degli affari e così avevano abbandonato un’attività che si sarebbe potuta rivelare molto più redditizia di quanto non credessero. Mio padre, a dire il vero, con un “semplice” diploma da ragioniere e pur essendo stato assunto come semplice operaio, riuscì (un concorso alla volta) a scalare la piramide dell’organizzazione fino a pensionarsi al secondo gradino della struttura come “funzionario con mansioni direttive”. Oggi diremmo come un “manager”. Certo, lo stipendio era sempre da fame…ma almeno aveva fatto salvo l’orgoglio. Altri tempi! Questo però è solo l’inizio della (mia) storia. 1973: a causa della chiusura del Canale di Suez, il prezzo dei carburanti sale alle stelle. Al Telegiornale si inizia a parlare di austerity. In quegli anni la parola gossip era ancora un termine sconosciuto ai più. L’argomento “pettegolezzo” era trattato solo ed esclusivamente dai rotocalchi estivi , che si potevano sfogliare pudicamente sotto l’ombrellone oppure mentre ci si faceva fare i capelli dal barbiere (lui) o dal parrucchiere (lei). Ai giornalisti del Primo (ed unico)Canale televisivo quindi, toccava ancora raccontare i fatti così come accadevano realmente, magari rendendoli un pochino più presentabili ed edulcorati in modo un po’ deamicisiano, ma senza alterarne più di tanto la veridicità. L’informazione aveva poco a che fare con l’intrattenimento e mai nel Tele Giornale delle 20, ci si sarebbe sognati di parlare dei baci e dei tradimenti di una qualche campionessa olimpionica di tiro al piccione o dell’annosa questione delle coppie che litigano, prima di partire per le vacanze, per la difficile scelta tra mare e montagna. Figuriamoci poi un’alta carica dello Stato che si intratteneva con donne di facili costumi (negli anni ’70 c’era un solo tipo di escort e le produceva la Ford)… Sarebbe stata una cosa inimmaginabile, roba che Paolo VI avrebbe dovuto indire un concilio ecumenico straordinario e chiamare esorcisti e gesuiti per scacciare via il satanasso dal palazzo! Le auto che pian piano avevano invaso le nostre strade a partire dagli anni ’60 grazie all’acquisto anche da parte dei ceti più deboli come la piccola borghesia emergente e la classe operaia (che le ha pagate, spesso e volentieri, con chili e chili di cambiali) devono ora circolare a giorni alterni. Il governo (ve li ricordate quei “bei” democristiani, grigi e seriosi di una volta? Ah, che nostalgia)lo impone per cercare di frenare un’inflazione galoppante e a due cifre, spinta dal prezzo dei carburanti che si riversa su tutti i beni ed i servizi la cui domanda è cresciuta per il precedente periodo di boom economico. La fornitura di energia elettrica viene razionata forzatamente. Persino l’introduzione della Tv a colori viene rinviata di qualche anno, per evitare che la inevitabile corsa all’acquisto, scatenasse ancora di più l’inflazione. Il sogno italiano è precipitato nel buio e nell’incubo: è la prima più grave crisi dal dopoguerra. La messa in onda dell’ultima puntata dello sceneggiato televisivo (o fiction come diremmo oggi) “L’Odissea” salta a causa di un black-out programmato. Si veniva avvisati del black-out -cioè la sospensione totale di fornitura elettrica per un consistente numero di ore e su fasce di territorio molto vaste- allo scopo di ridurre i consumi energetici 9 nazionali ed il fabbisogno di petrolio con (non ricordo quanto) anticipo. La sera, ci si doveva armare di lumini e candele per non restare al buio. Poi dopo cena, di corsa a letto, visto che senza luce e d’inverno, si poteva fare poco altro, o almeno… questo era il destino dei bambini. All’epoca le famiglie erano ancora numerose visto che gli adulti avevano poche altre alternative di “intrattenimento” in quei frangenti e la contraccezione era ancora un tabù. I miei per fortuna si fermarono al quarto figlio, che già eravamo numerosi e rimasero per anni (fino alla prima replica del suddetto sceneggiato) con la curiosità di conoscere il destino del povero Ulisse! Ma per fortuna, già in quegli anni, la Rai era generosa con le repliche e fu solo questione di tempo. 1976: un giovanissimo Adriano Celentano, cantava questa canzone: Eh eh la benzina ogni giorno costa sempre di più e la lira cede e precipita giù svalutation (svalutescion) svalutation (svalutescion). Cambiano i governi niente cambia lassù c'è un buco nello Stato dove i soldi van giù svalutation (svalutescion) svalutation (svalutescion). … Con il salario di un mese compri solo un caffè gli stadi son gremiti ma la grana dov'è svalutation (svalutescion) svalutation (svalutescion). Ma siamo in crisi ma senza andare in là l'America è qua. … Ma quest'Italia qua se lo vuole sa che ce la farà e il sistema c'è quando pensi a te pensa... anche un po' per me. 2011: Son passati 35 anni dall’uscita di Svalutation. La Lira non c’è più, anche se ogni giorno le potenze europee che valgono, minacciano di restituircela forzatamente; le parole salario e ferie sono solo dei lontani ricordi; per il resto, vi rendete conto di quanto le parole di Celentano siano ancora tremendamente attuali? Persino l’invito ad essere meno individualisti e a ragionare come collettività, è un auspicio tanto inascoltato quanto attuale. Mentre sto scrivendo, la cronaca di queste ore ci spingerebbe al pessimismo più nero: le borse barcollano quando non crollano e gli Stati Nazionali faticano a sbarcare il lunario. Gli economisti temono il rischio default (fallimento) anche per quegli Stati che vengono tutt’ora considerati i giganti dell’economia. Siamo messi davvero male. Si paventa un fallimento generalizzato mentre le fasce sociali più deboli, ormai ridotte allo stremo delle forze e private di ogni speranza, oscillano tra inattività, timide reazioni, fino a veri e propri 10 scontri di piazza (come nelle piazze arabe) o si danno al vandalismo ed ai saccheggi (come accaduto a Londra) o infine si lagnano del tempo e dello sciopero dei calciatori (come qui in Italia). È ancora e sempre, tempo di crisi! Si esce da un tunnel ma solo per entrarne in uno più lungo e buio. Ma bisogna trovarlo un barlume di ottimismo no? Altrimenti, come lo proseguo questo bestseller? Partiamo quindi dall’analisi macro dei fattori economici, successivamente analizzeremo la micro esperienza individuale per poi ritornare a rielaborare il tutto in un’ ottica macro… ed è qui che si inserirà la mia storia. Sì lo ammetto, anche io sono un po’ affetto da milanesite, purtroppo! Mannagggia… ment! 11 Capitolo 2.1 La ricchezza di una nazione. Il Pil misura qualunque cosa, tranne ciò per cui vale la pena vivere. (Robert Kennedy) Per capire perché ci siamo impoveriti, materialmente e culturalmente, sarebbe utile riflettere sul concetto di ricchezza di una Nazione. Non c’è bisogno di studiare economia per sapere che il benessere di una Nazione ed il suo PIL ovvero il Prodotto Interno Lordo, uno dei tanti acronimi di cui sentiamo sempre parlare nei telegiornali e di cui leggiamo sulle pagine dei quotidiani, e che ci viene spacciato come una misura della NOSTRA ricchezza - non sempre coincidono. In Italia la ricchezza si sta sempre più concentrando nelle mani di pochi, la cosiddetta casta di cui ormai tutti parlano, composta da politici corrotti, imprenditori poco trasparenti, faccendieri, gente la cui fortuna non è facilmente identificabile e di origine spesso poco limpida ma anche (e residuamene) da quella che una volta era la grande borghesia industriale del nostro paese. La working class, la classe operaia di un tempo e soprattutto il ceto medio e piccolo borghese del terziario avanzato (nel senso proprio di avanzo, non consumato), vivono ormai della ricchezza e dei i risparmi accumulati in passato a livello familiare. Mezzi – mi fa fatica definirli come “ricchezze” che col passare degli anni, a causa delle varie recessioni, dell’inflazione strisciante e della diffusa disoccupazione giovanile, si assottigliano sempre più. Non c’è più un lavoro per tutti, anzi, il lavoro ormai è diventato quasi un privilegio per pochi eletti, una chimera. Quel po’ di lavoro che si trova è di bassissima qualità: precario, malpagato, per nulla gratificante, mobbizzato. La ricchezza della Nazione è in contrazione e con essa il benessere reale e percepito. La ricchezza si concentra nelle mani di pochi, lasciando la maggioranza del Paese nella condizione di veder sempre più peggiorare il proprio tenore di vita. Un tempo, il figlio superava il reddito del padre. Oggi - e come nel mio caso - pur con titoli di studio più elevati, un figlio non riesce né a superare né (nella maggior parte dei casi) neppure a raggiungere il tenore di vita del proprio genitore. I consumi si riducono per la recessione, i consumi ridotti generano altra recessione, la recessione porta alla riduzione della richiesta di forza lavoro; la mancanza di lavoro genera recessione. È un circolo vizioso che sembra inarrestabile, almeno fino ad ora. Almeno se gestito nel modo in cui lo è stato e cioè, abbandonato a sé stesso ed affidato solo al mercato. Il mercato, un deus ex machina sopravvalutato ed incompreso, mai realmente sviluppato secondo le teorie economiche e molto spesso drogato dal finto liberalismo. Ma chi dovrebbe produrre ricchezza? La risposta da manuale è: tutti noi. Noi che lavoriamo, noi che investiamo (ammesso di essere imprenditori o investitori finanziari), noi che paghiamo le tasse per redistribuire tale ricchezza anche verso i più deboli, assicurando – sempre in linea molto teorica – uguali servizi e prestazioni per tutti. Noi che compriamo, noi che consumiamo, noi che, alle volte, ricompriamo senza neanche consumare, noi che usufruiamo di beni e servizi, noi che quei beni e quei servizi contribuiamo a produrli. Ma anche il capitale intellettuale produce ricchezza, anche se capire che alle volte un investimento porta benefici solo sul lungo termine, non sembra essere una dote che appartiene a noi Italiani. 12 La realtà dei fatti però è ben diversa. Il capitale concentrato nelle mani di pochi, per produrre ricchezza utile alla nazione e quindi redistribuzione della stessa, dovrebbe essere reinvestito in attività produttive ed in maniera efficiente (cioè con una minimizzazione dei costi a fronte di una massimizzazione tendenziale dei ricavi) ed efficace (cioè conseguendo gli obiettivi che ci si pone). E dai casi concreti che vedremo in seguito, potremo ben comprendere come questo capiti molto di rado qui in Italia. 13 Capitolo 2.2 L’anomalia italiana. La domanda da porsi è: perché l’Italia, nonostante le sue risorse economiche (risorse che almeno fino ad oggi ci sono state), il suo ruolo di grande tra le Nazioni mondiali e soprattutto nonostante il suo ingente patrimonio storico-culturale, non riesce a prendere il volo ed uscire dal guado in cui, sempre più, si sta impantanando? Si parlava di crisi quasi quarant’anni fa, si è parlato di crisi per tutti questi quarant’anni ed ancora si parla di crisi. Di soluzioni al problema, non sembra se ne vedano da nessuna parte. Eppure dopo la seconda guerra mondiale, siamo stati capaci – certo, soprattutto grazie all’iniezione di capitali statunitensi – di quello che è stato definito il miracolo italiano (quello vero eh, non quello di cartapesta e cerone del 1994!). Una crescita economica a livelli tali che ora solo la Cina e l’India sembrano poter sostenere, è appartenuta anche noi, genti del mediterraneo, ora molto più inclini all’autocommiserazione che alla capacità di reagire. Nel mio piccolo, pur non disponendo dell’autorevolezza necessaria per formulare una vera e propria teoria economica, un’idea me la sono fatta. Quest’idea mi ha ispirato questo condensato di considerazioni tragicomiche semi-autobiografiche. Spero le possiate trovare anche interessanti! Ho messo in relazione alcune delle teorie economiche e di organizzazione aziendale apprese durante il corso dei miei studi e le ho confrontate con la realtà, dura e cruda, con la quale mi sono scontrato concretamente lungo il corso delle mie esperienze lavorative e professionali. Ecco dunque quello che mi è capitato. 14 Capitolo 3 Biografia del vero anti-mànnaggger. Iniziamo dall’ inizio, come direbbe uno studente poco capace che, una volta interrogato dal terribile docente, cerca di dipanare i propri ricordi un po’ confusi, sperando allo stesso modo di prendere tempo e farsi salvare dal suono espiatorio della campanella di fine lezioni. Sono nato con il Carosello, col fustone di Dash da scambiare con i due fustini di detersivo senza marchio, con il Bio Presto e l’omino in ammollo e mi trovo ora ad aver passato i 40 anni. Bei tempi quelli in cui il marketing era solo capace di farti credere che un detersivo “A” fosse migliore del detersivo “B”, solo perché andava in Tv e costava il doppio, facendo pagare poi a te consumatore i costi per tutta quella pubblicità. Mi vengono in mente centinaia di slogan, tutti fondati su affermazioni di dubbia veridicità, ma tutti talmente incisivi da essere ricordati ancora oggi, dopo quarant’anni! Negli anni che stiamo vivendo il marketing e la pubblicità si sono evoluti notevolmente: capacissimi strateghi sono stati talmente bravi a fiutare quello che il pubblico dei consumatori desiderava o temeva, da creargli addirittura un partito politico cucito addosso, ad uso e consumo – per l’appunto - di un grande uomo di marketing. E non importa che un giorno si dica bianco ed il giorno dopo lo si neghi, sostenendo che tutto è sempre stato nero, basta essere molto convinti ed assertivi quando si nega l’evidenza e ripeterlo fino alla nausea. Il consumatore-elettore ci crederà. Almeno fino a quando non si accorgerà che il detersivo che doveva lavare più bianco del bianco, non solo gli lascia il bucato grigio ma addirittura pieno di buchi. Il consumatore (o l’elettore, nel caso) non si sveglierà dal suo torpore, dall’incantesimo definito sospensione della credulità, fin quando non si renderà conto che nel suo portafogli c’è un buco enorme e che quello che c’era dentro è finito nelle tasche dei persuasori. Chissà se questo risveglio avverrà mai e se si potrà porre rimedio o sarà troppo tardi. Si è sempre portati a pensare che nessuno può fregarci. Si è portati naturalmente a fidarsi del proprio metro di giudizio e, piuttosto che ammettere le proprie colpe, si preferisce negare l’evidenza. Del resto noi italiani siamo noti in tutto il mondo per la nostra – presunta – furbizia. E’ stata colpa della crisi economica, mica mia? Sono loro, i nemici-avversari politici-dipendenti che travisano e manipolano la realtà: è colpa loro se – pur governando/gestendo noi in maniera assoluta – voi state male/l’azienda è al fallimento! Non è colpa del nostro detersivo se non lava più bianco del bianco e se al massimo fa fare strap alle vostre lenzuola, è colpa degli oppositori, dello sporco, della congiura delle fibre che si auto sabotano provocando strap e crack economico-finanziari. Etc, etc. Questo fenomeno si chiama “dissonanza cognitiva” e se vi va, approfondite pure. Ne parlava anche un mio professore di politica economica ma siccome lo detesto e siccome la sua opera era semplicemente riferita (leggasi: copiata) ad altro autore americano, allora evito di fargli pubblicità. Del resto c’è Wikipedia che è il refugium peccatorum di noi ignorantoni di ritorno (o di sola andata?). E onore e merito alla potenza del marketing, la vera magia, il vero voodoo dei nostri tempi. 15 Capitolo 3.1 Gli anni della Formazione dell’anti-mannnagger. Giusto perché detesto quelli che si autocelebrano, vi pubblico un breve stralcio dal mio curriculum vitae… Insomma uno stralcio, un distillato di vitae… Ma giuro, quasi analcolico. All’asilo ero quello che potremmo definire un brillante artista, vista la quantità e la qualità delle mie produzioni. Ero spesso invitato dalla mia maestra ad andare nell’ufficio della direttrice, ma non per ricevere ramanzine come tutti gli altri bambini vivaci che si rispettavano, ma per mettere su delle esposizioni monografiche delle mie opere e riceverne i complimenti. Passavo le giornate facendo disegni coi pennarelli su grandi fogli di carta – amavo molto rappresentare incidenti a catena, con cataste e cataste di auto distrutte, incendi, rapine con ladri mascherati ed il sacco col dollaro sulle spalle, inseguiti da aerei caccia a reazione ed elicotteri tutto nella stessa scena. E poi facevo anche piccole sculture in plastilina o in Das, una specie di creta sintetica, oppure ardite costruzioni con i mattoncini (ma non erano i Lego, che quelli costavano troppo…)etc. La creatività era il terreno dove eccellevo e la fantasia non mi mancava di certo. Anche perché avevo 5 anni! Alle elementari ero un bimbo timidissimo che mostrava però una spiccata superiorità in tutte le materie. Ero brillante nelle composizioni in italiano. Ero capace di inventare di sana pianta delle cronache della domenica (forma di tortura in uso nella scuola degli anni ’70, dove si richiedeva all’alunno di enumerare le mirabolanti avventure della propria domenica) da far impallidire quelle di Fabio Briatore! In realtà, la cosa più emozionante delle mie domeniche, poteva essere lo svenimento di una qualche fedele in Chiesa ( la mia famiglia era religiosissima e guai a perdersi una messa la domenica o tutte le feste comandate! ) durante la celebrazione del mezzogiorno un po’ troppo affollata o il richiamo del burbero parroco alla pecorella smarrita di turno, rea magari di essere arrivata con dieci minuti di ritardo. Non avevamo l’auto: con quattro figli ed un unico stipendio, i miei non potevano certo farci uscire più di una volta l’anno, anche perché se prendevamo i mezzi pubblici, il ritorno a casa diventava una vera e propria odissea. La sera c’era solo la Tv e con soli due canali, ma la nostra Tv, rigorosamente a valvoloni ed in bianco e nero, era rotta e funzionava solo il primo canale. Ricordo un’infanzia grigia, fatta dei documentari di Folco Quilici, delle Tribune Politiche, dove nessuno si sognava di insultarsi e di ripetere allo sfinimento “io l’ho ascoltata, adesso mi faccia parlare!”, dei “Programmi dell’accesso”, dei pupazzi animati, della tivù dei ragazzi rigorosamente solo alle 17. Nel 1979 finalmente mio padre poté comprarci il primo Tv a colori, ed almeno il mio mondo diventò un po’ più vario e colorato. Il massimo dell’evento sociale delle mie domeniche, due o tre volte durante l’anno, era dato dalle noiosissime riunioni di famiglia, giù dai nonni paterni. Non amavo granché quella numerosissima famiglia: un nonno fascista mai pentito, burbero e scostante la cui frase più affettuosa che ricordo era “ma ti sì magnat’ a lengua?”, giusto per non far notare la mia timidezza ed una pletora di zii, zie e cugini caciaroni con i quali non mi sentivo di condividere alcun tipo di affetto familiare. Di mia nonna poi, ricordo solo il fatto che era molto bassa e la circostanza che, per il Parkinson, faceva tintinnare a lungo le tazzine sul vassoio quando serviva il caffè. 16 Per il resto, che avrei avuto da raccontare senza la mia fantasia? Del ragù che ogni domenica preparava la mia mamma? O se avevo mangiato pollo al forno piuttosto che carne ai ferri? L’ostinazione della mia maestra verso questa forma di composizione aveva un che di sado-classista. Anche se per il resto, era proprio una gran brava donna ed una perfetta insegnante. Anche in campo matematico me la cavavo brillantemente: sapevo risolvere in brevissimo tempo i complicati problemi aritmetici riuscendo, di volta in volta, a salvare la vita di un contadino che doveva sapere quanti viaggi occorrevano per portare il suo raccolto sin nella dispensa, calcolando quanto avrebbe ricavato dalla vendita del peso netto della frutta e spesso e volentieri, aiutando anche l’idraulico Mario a capire che se il rubinetto della Sig.ra Rossi perdeva mezzo litro d’acqua all’ora, nel mentre le si riempiva la vasca da 0,7 ettolitri e le si allagava la casa, poteva chiederle un botto di soldi per la chiamata d’urgenza in sole 0,5 ore di lavoro! Insomma, ero una sorta di piccolo Archimede che oltre che fantasticare di robot e di supereroi, pensava di realizzare un giorno la macchina a moto perpetuo. A tutto ciò aggiungiamo anche il fatto che avevo sviluppato ulteriormente l’attitudine artistica: nei miei disegni si capiva che un uomo era un uomo, un albero era un albero, un cane un cane ed una casa una casa, mentre quasi tutti i miei coetanei avevano ancora le idee parecchio confuse al riguardo e le loro case avevano i tetti quadrati (avete presente quelle casette col tetto spiovente da una parte e l’angolo dritto dall’altra?) e gli alberi sembravano dei coni gelato andati a male e i cani sembravano colpiti da orribili malattie genetiche o appena passati sotto le ruote di un tir. Chiudevano il quadro e nonostante la timidezza che almeno non era così evidente negli ambienti a me più familiari, un’attitudine alla leadership, la curiosità e la propensione alla conoscenza dell’ignoto–sognavo che una volta divenuto grande, sarei partito alla volta delle Bermuda per capire cosa c’era dietro al mistero del Triangolo. Questo almeno, secondo i miei fantasiosi piani. E le mie capacità mi portavano anche una certa popolarità tra le mie compagne di classe... Ma con tutta probabilità, mi facevano solo gli occhi dolci per farsi aiutare con i compiti… Ma questa è la malizia (o il buon senso) dell’adulto che me lo fa pensare Tutti questi erano i miei punti di forza. Meno uno forse, la modestia. Quella l’avrei appresa più tardi... Purtroppo! Alle medie però, iniziarono a sentirsi i primi scricchiolii del mio ego: ricordo con orrore il primo compito di matematica dove per qualche piccola imprecisione… Non ebbi ottimo ma valido… Fu per me una tragedia! Ed ancora oggi mi domando cosa sia un valido? Che razza di voto è? Certo, dopo il primo impatto mi ripresi e ripresi ad essere brillante, ma peggio di tutto scoprii che… Non ero più popolare! Iniziavo a capire, tristemente, che le ragazzine non amavano granché i piccoli nerd ma preferivano piuttosto i calciatori in erba. Ed io, da buon mancino con le idee parecchio confuse, non sapevo neanche calciare una palla! Diventai il ragazzo invisibile con una delle medie più alte della scuola. Alla fine del triennio mi licenziai con OTTIMO e ne gioii parecchio. Anche perché non sapevo ancora quanto la parola licenziato avrebbe assunto connotati disastrosi negli anni a venire. In prima liceo scientifico, l’impatto con un nuovo ambiente, fu duro. Dopo la leadership ed il carisma, ebbero decisamente un tragico tracollo anche i miei voti in alcune materie. Mi trovai a dovermi confrontare con dei competitor molto più agguerriti - che tradotto, vuol dire alcuni compagni davvero bastardi da non credere. La matematica per me iniziò a diventare un’opinione, ed i voti, dei numeri relativi. Il latino… Bè, ero diventato mio malgrado ed a distanza di anni fatico ancora a capirne il motivo, uno dei più odiati dall’anziana proffa di latino e storia, una coetanea di Giulio Cesare che aveva il cuore tenero come un marmo del colonnato del Pantheon. Il suo hobby preferito era urlare il mio cognome come il sergente cattivo di Full Metal Jacket. Non appena notava che mi ero un attimo distratto, mi richiamava urlando, col risultato di farmi saltare dalla sedia e facendomi andare il cuore a mille, nel mentre alcuni dei simpatici compagni 17 sogghignavano senza neanche tanto pudore. Fu una tortura psicologica ma la cosa mi rafforzò: grazie a lei capii che il duro lavoro non pagava. Contava solo la furbizia, visto che molti miei compagni, studiando meno della metà di quello che facevo io, con l’astuzia riuscivano ad andare ben oltre la sufficienza. Nelle altre materie, dove più e dove meno, per fortuna me la cavavo. In prima poi, ebbi un grande professore di lettere che mi stimava molto ed ammirava il mio modo di scrivere. Fu lui a credere in me ed a spingere per la mia promozione con i colleghi che meno mi vedevano di buon occhio. Alla fine dei 5 anni, riuscii sempre a raggiungere almeno la sufficienza in tutte le materie e a non essere mai rimandato a fine anno. Certo, dovevo sgobbare e sudare ben più delle fantomatiche sette camicie. In quegli anni nel sistema scolastico non c’erano ancora i debiti, almeno per gli studenti. I genitori invece, purtroppo, già conoscevano bene l’argomento. Se non si era promossi a giugno in una o due materie, toccava sostenere un esame di riparazione a settembre, col risultato di rovinarsi le vacanze. Con tre o più materie insufficienti, si era bocciati. Il mio liceo sorgeva nel cuore di un quartiere molto borghese di Napoli anche se non proprio “vip” come quello di Posillipo o la zona di Chiaia. Il mio liceo non era un vero e proprio edificio scolastico ma piuttosto una serie di plessi disastrati, distanti anche qualche minuto di cammino tra di loro e ricavati in vari appartamenti privati, presi in fitto dallo Stato. Fino alle medie, mi ero trovato a competere in prevalenza con ragazzini per i quali l’Italiano era una lingua straniera. Alcuni avevano ripetuto gli anni parecchie volte e si trovavano in terza media già quasi maggiorenni, dopo 11 anni di scuola dell’obbligo! La loro unica aspirazione era di ottenere la licenza finale per poi poter finalmente entrare nel mondo del lavoro operaio. Al liceo – scientifico - invece, ero gomito a gomito con dei veri e propri sciacalli della rampante borghesia napoletana degli anni ‘80. Figli di professionisti, aspiranti a replicare e migliorare la fortuna dei propri genitori. Dei semi geni (anche se a onore del vero, qualche anello mancante dell’evoluzione era pur presente nella mia numerosa classe) vestiti con capi firmati da capo a piedi e che avevano iniziato a viaggiare per il mondo già in fasce, mentre io dell’estero, avevo visto solo e di striscio, lo Stato del Vaticano! Facevano lezioni private di tutto ed avevano rispetto solo dei soldi e di chi ne possedeva tanti. Fatta eccezione ovviamente, per quei pochi con i quali - per fortuna - feci amicizia e che mi salvarono l’adolescenza dalla crisi più totale. Erano gli anni degli odiosi paninari, tanto per capirci. Io tifavo per i dark invece, quelli che ascoltavano la musica elettronica dei Cure e dei Depeche Mode, anche se sulla mia felpa nera c’era l’effige di Snoopy, icona molto poco dardeggiante ed il mio capello riccio assomigliava più a quello funghettato del giovane Michael Jackson che al taglio punk di un ribelle. Tra alti e bassi, tra soddisfazioni e delusioni, anche il liceo finì e così venne il tempo delle grandi scelte: iscriversi all’università e la scelta della facoltà. Volevo fare tante cose, tante altre mi piacevano. L’anno scolastico 1988-89fu quello della maturità: era appena caduto il muro di Berlino, c’erano stati gli scontri di piazza Tienanmen e si parlava concretamente di Europa finalmente Unita. Si iniziava a sentir parlare anche di globalizzazione e di libera circolazione di merci e professioni. I prof. ci dicevano che il mercato del lavoro non sarebbe più stato quello di una volta. In sostanza, era come annunciare che non ci sarebbero più state le mezze stagioni. Credo che anzi, le mezze stagioni siano scomparse proprio in quegli anni, insieme col lavoro privo di aggettivi (per questo rimando ad una citazione del grande Massimo Troisi, il quale sosteneva che a Napoli il lavoro già di per sé si definisce come ‘a fatica’ e poi è sempre accompagnato da un aggettivo: a nero, a cottimo, part-time, a tempo determinato, etc., ma di lavoro-lavoro non ce n’è mai stata 18 traccia). Nel nuovo mondo così come ci era rappresentato dai nostri insegnanti, ci saremmo trovati a competere con Inglesi, Francesi, Spagnoli, Olandesi, Greci, etc. e quindi ci dovevamo dare da fare. Il posto fisso non ci sarebbe più stato, ma il mercato del lavoro flessibile ci avrebbe dato un’infinità di potenzialità in più. I call-center? I contratti a progetto? Cioè, quelli dove si progetta prima il momento in cui si verrà messi per strada? Durante quegli anni del liceo (anche se allo scientifico la parte artistica si riduceva allo studio della relativa storia)avevo riscoperto la passione per il disegno, ma al contempo conosciuto anche quella per l’informatica. Iniziai ad apprendere il primitivo linguaggio Basic ed a fare rudimentali programmi e videogame con il Commodore 64, sino via via a simulare forme di intelligenza artificiale per riprodurre dei giochini come la battaglia navale o il Monopoly. Sì, detto così sembra chissà cosa, ma in realtà erano giochini banali. Con i miei compagni di studio poi, avevamo inconsapevolmente scoperto la multimedialità prima che se ne parlasse ufficialmente! Grazie ad un estroso prof di filosofia, potevamo svolgere i nostri elaborati in modo molto innovativo, organizzando delle presentazioni con animazioni multimediali, seppure elaborate col mio rudimentale C=64. Mettevamo insieme le animazioni, con un testo scritto ed una base audio e…Et voilà la multimedialità! Con esibizione globale nella sala proiezioni della scuola, un sottoscala con qualche sedia, nel quale i nostri interventi erano spesso interrotti dal rumore degli sciacquoni sovrastanti, dotato di Tv antidiluviana e di un videoregistratore appartenuto a Fred Flinstone. Mi occupavo della programmazione in Basic e della grafica, gli altri del fare le ricerche. Cercavamo di stupire con effetti speciali e colori ultravivaci come recitava il famosissimo spot della Tv a colori. Ma non era né scienza né fantascienza la nostra, solo semplice passione di adolescenti, oggi molto più comune che in passato. La quantità biblica di compiti che i nostri professori ci assegnavano, ci spinse a comprendere l’importanza del team work elemento chiave per l’organizzazione di un’impresa di successo. Il mio amico Fausto, bravissimo in matematica e fisica, si occupava in prevalenza della soluzione dei relativi problemi; io ed Antonio – l’altro inseparabile amico –ci occupavamo di storia e filosofia, scrivendo degli schemini che sintetizzavano gli argomenti. Per il resto delle materie si procedeva con una struttura adhocratica (questo termine che deriva dalla locuzione ad-hoc l’avrei appreso ovviamente, molto più tardi, all’università) cioè elaborata di volta in volta a seconda degli impegni. Tanto che spesso e volentieri, si aggregava a noi anche un altro inseparabile amico, Aldo. A fine giornata, mettevamo insieme i vari pezzi del puzzle ed avevamo fatto tutti i compiti che altrimenti, avrebbero richiesto il triplo del lavoro. Per le versioni di latino, non esistendo ancora Internet e Yahoo Answers, una telefonata alle nostre compagne di classe era provvidenziale. Eravamo diventati, riducendo notevolmente gli sforzi, una macchina da 7-8 quando prima faticavamo ad arrivare alla sufficienza (onore al merito, Fausto lo era comunque, ma siccome è sempre stato un grande amico, ci prestava una paio dei suoi punti per alzarci la media ) Avessimo avuto un garage, saremmo potuti diventare gli Steve Jobs od i Bill Gates de noantri. Ma io almeno, il garage non l’avevo. Tornando al filo conduttore di questo scritto, da soli ed in maniera molto intuitiva, eravamo riusciti a comprendere che un team affiatato e organizzato con criteri di flessibilità ed intelligenza operativa, portava a risultati di gran lunga superiori alla mera sommatoria degli sforzi individuali. Una lezione di vita che, spesso, le grandi imprese ed i relativi imprenditori del nostro paese, ancora stentano a comprendere. Come materie di studio mi piacevano anche la storia economica oltre che il disegno tecnico ed il design industriale. Insomma troppe passioni, troppe idee e per giunta confuse! Ed allora per scegliere la strada della 19 propria vita, si ascoltavano i consigli dei nostri maestri, coloro che per esperienza, avrebbero dovuto instradarci nel mondo del lavoro. Il prof di filosofia – che era il personaggio più carismatico - mi sconsigliò la facoltà di architettura perché, a suo dire, fabbricava disoccupati o al più disegnatori di arredi nei mobilifici. Disegnatore di arredi… La cosa al tempo suonava quasi disdicevole, ma ora che è definita col nome di “interior designer” diventata una professione tanto figa e trendy! Il prof non ci vide lungo. Storia e lettere anche no, perché ugualmente fabbricavano disoccupati. Il burbero ma in fondo simpatico prof di mate dal canto suo, mi sconsigliò sinceramente ingegneria e matematica perché: -Sì Francè, nei tuoi compiti ci sta una ‘parvenza di matematica’ ma sinceramente… Nun è cosa pe’ ttè!… Ed in effetti la matematica astratta non era proprio il mio forte e questo quindi mi fece anche dissuadere dall’idea di fare ingegneria o informatica. Medicina poi, era una facoltà affascinante, ma avevo già un fratello che ci si era iscritto e leggere quei suoi libri enormi e conditi da immagini raccapriccianti, mi dava la nausea. Non avevo poi la capacità (o la voglia) di memorizzare le enormi quantità di dati come richiesto per quelle discipline, quindi la scartai. E allora che fare? La classica scelta di chi non sa che pesci pigliare: Economia e commercio, ma con una valida motivazione (anzi due): - era all’epoca la facoltà che apriva mille porte nel mondo del lavoro - era decisamente e notoriamente popolata da fighette! La qual cosa non mi dispiaceva affatto. Anche se poi avrei scoperto che il tipo di ragazza che ci si iscriveva, era da tenere a debita distanza. Brrr… Veri e propri registratori di cassa in gonnella. Infine, come detto, dallo studio della storia – materia da me portata in sede di maturità – avevo capito che l’economia era la chiave per capire il mondo e non avevo ancora del tutto abbandonato la passione per lo scoprire come funzionavano le “cose”. 20 Capitolo 3.2 Università e laurea. Dopo un po’ di incertezza e vari giri fatti tra le varie facoltà col mio grande amico di sempre, Fausto, decisi di iscrivermi ad Economia e Commercio. Scelsi l’indirizzo “Gestionale”, praticamente quello degli aspiranti mànnaggger. Matricola: 52528. Il primo impatto col mondo universitario fu estremamente deludente. Al primo anno di lezioni, la Facoltà era ancora disastrata. La sede principale era collocata in un antico quanto bellissimo palazzo affacciato sul lungomare, già casino di pesca dei Borboni. Ma le lezioni, per esigenze di spazio, si tenevano prevalentemente in tre cinema cittadini. Erano lezioni affollatissime, buie, che mi costarono le residue diottrie ancora rimaste. Successivamente la facoltà si trasferì nella nuova sede, quella che sembrava progettata dall’architetto di Goldrake e colorata dall’autore dell’Ape Maia: non c’era più quel bel panorama visibile dalle finestre ma in cambio era molto più funzionale e comoda. Avevo capito ben presto di aver sbagliato totalmente strada, ma non ebbi la forza di modificare il corso di quegli eventi che credevo preordinati. Mio padre che aveva dovuto interrompere gli studi al diploma per esigenze familiari, faceva grosse pressioni affinché io mi laureassi. E non volevo (o non potevo?) deluderlo. Le materie del mio corso di studi mi piacevano, più o meno, per un 50%. Per il restante 50, le trovavo noiose. Alcune poi – come Ragioneria o Matematica Finanziaria – le trovavo addirittura aberranti. Ma peggio di tutto, era la disorganizzazione della facoltà a farmi sentire davvero un pesce fuor d’acqua: corsi che pur appartenendo allo stesso anno e semestre, erano programmati alla stessa ora e nello stesso giorno, per cui risultava impossibile frequentarli entrambi e la frequenza era magari obbligatoria per sostenere l’esame. Prenotazioni degli esami che si perdevano, calendari degli appelli cambiati all’ultimo minuto ed in alcuni casi anche date d’esame anticipate, sessioni con centinaia di studenti, con bocciature seriali fatte per sfoltire il numero delle matricole, docenti ed assistenti che ti interrogavano mentre parlavano al cellulare con chissà chi… E la lista sarebbe stata davvero lunga. C’era poi un feroce clientelismo che aleggiava sfacciatamente ad ogni sessione di esame. Erano pochi i docenti che non facessero smaccate preferenze per i soliti noti e non erano infrequenti esternazioni fatte a voce alta come “Mi saluti caramente suo padre!”. Frasi che spiegavano chiaramente perché il tizio il giorno prima ti aveva fatto quella domanda così stupida sul programma d’esame, ed il giorno dopo lo superava con lode. Il caso più sfacciato era poi quello di una ragazza che si faceva accompagnare ad ogni sessione d’esame, dal proprio padre. Era – si diceva – un imprenditore, amico dei potenti della facoltà e sempre secondo indiscrezioni, coinvolto nella costruzione della nuova sede. La scenetta si ripeteva ogni volta uguale a se stessa: la ragazza veniva chiamata ma prima di muoversi il padre la precedeva ai banchi dei docenti, li salutava bisbigliando loro un paio di paroline all’orecchio e poi andava via andandosi a sedere agli ultimi posti dell’aula, in modo da poter sorvegliare l’exploit della propria pargoletta. Seguiva un immancabile 30e lode. La ragazza non saltò mai una sessione né un trenta e lode, 21 laureandosi per prima nel mio corso ed avendo subito offerto un incarico come ricercatrice. Quella sfacciata dimostrazione di “potere” e corruzione era un modo per sentirsi ancora più potenti e dire a noi altri comuni mortali, come dal classico motto del Marchese del Grillo: io sò io, e voi nun siete un cazzo! Ovviamente se gli incapaci-raccomandati dovevano andare sempre bene, bisognava mettere il bastone tra le ruote a tutti gli altri per non alterare troppo le medie dei rendimenti globali degli studenti. Anche i più bravi quindi, faticavano davvero a tenere una media alta ed al contempo, non andare fuori corso. Ed io non ero proprio uno di loro anche se, risultavo nella media sia per rendimento che per lunghezza dei tempi di studio. All’inizio vivevo gli esami come una forma di tortura. Ogni volta mi sembrava di salire sul patibolo e non rendevo per quello che studiavo. Ma poi pian piano iniziai a capire il meccanismo, reimparando la lezione appresa già al liceo: non era tanto lo sforzo che faceva la differenza, quanto la furbizia. Così imparai che seguendo certi corsi potevo sostenere l’esame col docente e non con i suoi assistenti che invece erano quelli preposti allo sterminio, fingendomi magari particolarmente interessato a materie che in realtà non mi interessavano per nulla. In questo modo, mi ripresi un pochino sia dal punto di vista del rendimento che della motivazione. Racconto un aneddoto giusto per comprendere qual era la situazione. Esame di analisi contabile e budgetting. Il corso di studi era tenuto dall’Emerito Prof. Sprunzo, noto commercialista napoletano che poteva dedicare al massimo 20 minuti del suo preziosissimo tempo alla didattica per le prime due o tre lezioni, dopodiché si eclissava totalmente e privava gli studenti della sua illustrissima presenza. Insegnare all’università voleva dire da una parte, potersi fregiare del titolo di “Prof.” sulla porta del proprio studio e poter trasferire ciò sul peso delle proprie parcelle, ma dall’altro farlo seriamente avrebbe significato fare tanti affari in meno. Ma il Prof. Sprunzo, pur essendo un miliardario impegnatissimo, non disdegnava di percepire lo stipendio statale. Per il resto, la didattica era affidata alla Professoressa Piacioni, docente associata, quarantenne, bionda ossigenata, con la voce di Sandra Milo e che vestiva sempre come la tenutaria di una casa di appuntamenti molto elegante: tailleur grigio o blu che lasciava intravedere il decolté e minigonna inguinale. Ciò per dissimulare il fatto che la docenza non era ‘arte sua’ e per non dissimulare invece che la natura l’aveva dotata di un gran bel paio di gambe e di un fisico invidiabile. Le sue lezioni le teneva seduta sulla cattedra e facendo accavallamenti da brivido, in puro stile “Basic Instinct”. Era una donna ancora piacente nonostante non fosse più giovanissima e la cosa ci distraeva dalla comprensione dei vari indici e strumenti di analisi del budget, quali ROS, ROE, ROI, etc. ma aiutava a mantenere alto il tasso di partecipazione, soprattutto maschile, alle sue lezioni. Accanto a lei, sedevano poi due ricercatori: il Dr. Squalo ed il Dr. Tiboccio, odiosi personaggi che ci guardavano in cagnesco come due segugi idrofobi. Fare l’esame con questi due tristi figuri significava bocciatura matematica o, al più, per i più preparati, un glorioso 19-20. La logica era che i titolari di cattedra facessero gli esami solo ai raccomandati e come premio per gli assidui frequentatori dei corsi. Per gli altri, per tenere bassa la media dei voti – un parametro di misurazione della validità di un corso che, francamente, stento ancora a capire – il destino era di finire in pasto al Dr. Squalo ed al collega Tiboccio, per uscire magari, al terzo tentativo, con voti miserrimi. Alle sessioni d’esame si assisteva, come ormai di consuetudine, a degli spettacoli indecorosi: il Prof. titolare faceva al massimo 10 esami in una seduta. Dalla sua bocca uscivano toni concilianti, domande davvero facili e voti altissimi. 22 La Prof. Piacioni invece era un pochino più severa anche se comunque molto dolce e materna. Molto più dei suoi colleghi tirapiedi. Faceva domande più serie e metteva voti più misurati, ma non cercava a tutti i costi di mettere in difficoltà anche lo studente più preparato. Lei si occupava prevalentemente di esaminare chi aveva seguito assiduamente il corso come forma di “premio fedeltà”, e magari era andato nel suo dipartimento negli orari di ricevimento, dimostrando di aver studiato con assiduità. Io ed il mio compagno di studi, più che la materia in sé, studiammo una tecnica di sopravvivenza a quel sistema. Non avevamo avuto il tempo per seguire tutto il corso (gli altri esami e gli altri corsi impallavano comunque!). Aspettammo l’ultimo mese di lezioni e ci facemmo notare sempre ai primi banchi. Andavamo poi, a fine lezione da lei in dipartimento e le facevamo le domande anche più cretine, ma giusto per dimostrarle il nostro interesse. Il giorno dell’esame, poco prima dell’inizio della seduta, un assistente del professore faceva l’appello degli iscritti alla sessione e si faceva consegnare i libretti. Erano ancora quei bei libretti blu, a soffietto… Tutti uguali. Io mi ero studiato la cosa un paio di sessioni prima della mia ed avevo notato quella circostanza. Una volta consegnato il tuo libretto, veniva distribuito con non si sa (ma ormai era ben noto il meccanismo ;) ) quale criterio noncasuale tra docente titolare, Piacioni e Squaletti associati e ciò già segnava la sorte che ti sarebbe toccata. Noi che avevamo seguito il corso, ci eravamo prenotati in una lista a parte che, in linea teorica, avrebbe significato il diritto di sostenere l’esame con una persona che non ti avrebbe bocciato a prescindere. Per evitare il brivido di non sapere in quali mani sarebbe finito il mio libretto quindi, lo contrassegnai sul bordo con una striscia di nastro adesivo verde brillante, in modo da simulare una riparazione e da poterlo rendere ben visibile anche a distanza. Venne il giorno dell’esame: l’assistente fece l’appello e ritirò i libretti uno ad uno. Arrivò poi la Prof. Piacioni e in base ad una lista che aveva, divise i libretti in mucchi: il mio fu messo nel gruppo di quelli affidati al titolare di cattedra… Sembrava quasi fatta. Rimase nelle sue mani fino a che, esaminati si e no 5 studenti, il professore si alzò, annunciò ai suoi collaboratori che sarebbe andato via e lasciò il mucchietto di libretti residui – tra cui il mio – al duo Squalo & Tiboccio. Il cuore mi balzò in gola: era imminente una bocciatura o il rischio di dover rifiutare un voto bassissimo, cosa che non mi potevo più permettere. So già qual è la vostra obiezione: uno studente preparato supera brillantemente un esame anche col docente più severo. No, miei cari: questo avviene in un mondo ideale. Nel mondo reale della mia facoltà, bocciare uno studente preparatissimo o farlo rendere malissimo nonostante la preparazione era quanto di più facile. Gli assistenti – la vera razza dannata della docenza – sgomitavano ed ambivano al titolo del più crudele bocciatore per mettersi in luce col titolare di cattedra. La tecnica era semplice: domanda posta male, incomprensibile ed ambigua, in modo che, qualunque fosse la tua risposta, si poteva obiettare che la si intendeva in altro modo. Seguiva un segno meno su un foglio di carta per metterti in difficoltà. Sguardo fisso nel vuoto ed inespressivo ma tendente alla smorfia di disgusto (la tecnica molto in voga tra i politici di oggi quando parla un avversario). Mai un cenno di assenso o dissenso di modo che il candidato non potesse avere un feed-back e correggersi in tempo dopo aver detto una castroneria, o al contrario, facendolo convincere di sbagliare tutto nel mentre stava dando la risposta corretta. Disattenzione, chiacchiera col collega fingendo di ascoltare od anche conversazioni al cellulare durante l’esame. Si era portati così d’istinto, a fermarsi durante la risposta, nell’attesa di riavere 23 l’attenzione. Al che, seguiva un classico “ma lei si interrompe sempre… Si vede che non è preparato, torni un’altra volta”. Quella volta però ero stufo di ricevere questo trattamento. Una volta visto il mio libretto che stava per finire nelle mani del Dr. Squalo, corsi vero la cattedra e mi rivolsi alla Prof. Piacioni. Le dissi “Professoressa, io ho seguito il corso, lei mi conosce bene, penso di aver diritto a fare l’esame con lei”. Rischiai grosso. Lei si sarebbe potuta innervosire… Ma forse la mia faccia spaventata la intenerì, forse si sentì in colpa o forse la mia audacia le fece simpatia. Fatto sta che mi chiese dove fosse il mio libretto ed io le indicai lo Squalo. Mi sorrise, si alzò ed andò verso il suo tirapiedi e cercò il mio libretto. Lui glielo passò con un ghigno malefico ed esclamando ad alta voce “Qui si fanno delle preferenze! UAH UAH!” e dando di gomito al suo vicino Tiboccio che annuì con la vitalità di uno zombie dopo i bagordi della festa di Halloween… Superai l’esame con un voto dignitoso, 26 e capii che era finito il tempo di fare la pecora. Rialzai la media sia per i voti che per il numero di esami sostenuti ed in un disperato rush finale, riuscii a togliermi di torno pesi da 90 come Statistica e Diritto Tributario, insieme a qualche complementare. Sostenuti 24 esami, mi restava ormai da sostenerne solo l’ultimo, la bestia nera di tutti gli studenti: diritto commerciale… In quella, lo Stato Italiano si ricordò di me ed essendo ancora vigente la naja obbligatoria, ad una settimana dalla scadenza ultima oltre la quale scattava il congedo automatico per una sorta di decorrenza dei termini, venni convocato dal Distretto Militare che doveva comunicarmi la destinazione ove avrei svolto il servizio civile che avevo scelto in sostituzione. La prassi voleva che, per chi era iscritto all’Università ed era alle soglie della laurea, si concedeva un avvicinamento alla propria sede universitaria in modo da permettere la conclusione degli studi. La legge prevedeva un massimo di 100 km. A me ne toccarono circa 500! Venni spedito a Certaldo, ridente paesino toscano che, una volta dati i natali al Boccaccio, si era seduto a sonnecchiare sulla sua collina ed aveva smesso di essere significativo. Mio padre per qualche tempo quasi non mi parlò più perché temeva che con quella pausa forzata, io non riuscissi poi più a laurearmi e giusto per non farmi sentire in colpa ancora di più rispetto a quanto non mi ci sentissi già io. Partii a fine giugno del 1997, era già estate e faceva molto caldo. Avevo preso quest’evento molto male, come se fosse stata una punizione divina per chissà quale colpa commessa, ero molto depresso. Non ero mai stato molto portato per i servizi sociali, ma la mia scelta mi avrebbe portato quasi senz’altro a dovermi occupare o di anziani disagiati o di handicappati, del resto erano le due cose che in quel Comune venivano assegnate a quelli del servizio civile. Una volta presentatomi al referente – un odioso vice segretario comunale che mi accolse con un’insulsa barzelletta razzista sui napoletani - e vedendo gli studi che facevo, venni assegnato ai loro uffici dei servizi sociali, ma non come prestatore d’opera piuttosto come segretario della responsabile di quei servizi ed in realtà, come jolly per coprire di volta in volta il personale che mancava. Ero alloggiato in un appartamento dedicato ai soli obiettori di coscienza, così come ancora si chiamavano quelli che avevano deciso di poter essere più utili alla patria servendola come dei pacifici volontari piuttosto che come degli indolenti soldatini di piombo. L’alloggio era grande: un appartamento con due entrate, un grande salone e 4 camere da letto ma con un bagno davvero esiguo. Era stato un tempo una sede dell’Asl, tanto che al suo interno c’era ancora una pesante porta di piombo che separava la sala raggi X dal resto. Quell’alloggio però era perlopiù vuoto. Eccettuata la prima settimana di servizio, pian piano rimanemmo solo in tre a viverci e successivamente, congedati i colleghi più anziani di lì a poco, ci restai da solo, anche 24 perché la maggior parte dei ragazzi era originaria di quel paese o del circondario. Dopo un inziale mese di noia e solitudine più assoluta, riuscii pian piano ad entrare in sintonia con i Toscani e con la loro buffa parlata che invece di primo acchito avevo odiato da morire. Strinsi amicizia con dei colleghi del posto e scoprii che sotto quel carattere un po’ burbero, si nascondeva invece una sincera e schietta simpatia. Trovai la mia permanenza lì molto più divertente ed interessante di quanto avessi pensato ed alla fine, fu una bellissima esperienza, che mi aveva introdotto al mondo del lavoro. Ero tanto bravo che mi sentivo spesso ripetere la classica frase che viene rivolta all’emigrante che sgobba: non sembri napoletano. Ripartii per casa quando l’esperienza fu finita, con lo stesso magone della partenza, ma stavolta era perché non volevo più tornare indietro. Avevo assaggiato l’indipendenza, l’ebrezza del vivere da solo e dell’autogestione, ero diventato un uomo e male mi avrebbe fatto il sentire di nuovo il peso dell’essere un “figlio di famiglia”, un inetto e senza un domani che non si era ancora laureato. Il destino beffardo poi mi riaccolse al mio congedo, con una di quelle mazzate che non dimentichi più nella vita. L’ebrezza della libertà dagli impegni para-militari finì ben presto. Seppi dai miei fratelli – ricordo bene, era il 1° maggio 1998 -che mio padre era andato fare un’ecografia al fegato perché da tempo sentiva un dolore molto insistente e fastidioso. Il radiologo che conosceva mio fratello evitò di dirgli la verità ma era per lui evidente che a mio padre restavano pochi mesi di vita, forse 6 o anche meno. Lo comunicò quindi a mio fratello in segreto ed insieme decisero che era inutile dargli quel “carico”, per cui gli nascosero la verità sulla sua terribile sorte. Per me si era aperto un baratro nel terreno ed ero stato precipitato dritto dritto nell’inferno, tra le fiamme più alte. Convivevo ancora con i miei genitori, dovevo fingere normalità per non far preoccupare mio padre e nel frattempo dovevo iniziare la corsa contro il tempo per superare quel maledetto esame, cercando di dare quell’ultima soddisfazione a mio padre. Studiare in quelle condizioni, credetemi, fu a dir poco un’esperienza atroce. I medici gli avevano dato solo 6 mesi di vita ed io non sapevo quante volte avrei potuto ripetere quell’esame (la media per gli studenti della facoltà, era di 6 volte per ottenere la promozione). Alla fine (e non so da dove) tirai fuori la forza, superai l’esame, a luglio (nel corso dei mesi avevo comunque continuato a studiare) e chiesi in extremis di poter sviluppare una tesi che mi impegnasse per il minimo tempo possibile. Riuscii ad iscrivermi alla sessione di laurea di ottobre ed in quella, mi laureai. Ebbi la soddisfazione almeno di poterlo avere mio padre , ancora lucido, tra il pubblico. Ero riuscito dunque a laurearmi come mio sognava anche se con ritardo (avevo ormai a 28 anni). Per fortuna mio padre, che pure visse ancora un anno a dispetto delle previsioni, non ha potuto vedere che forse, proprio a causa di quella laurea da lui tanto sospirata, avrei iniziato un infinito calvario per trovare lavoro. La laurea, quel momento che avevo tanto a lungo atteso come il riscatto per le sofferenze e le angherie subite, acquisì invece un sapore amaro e del tutto privo di gioia. Mi sentii terribilmente solo. 25 Capitolo 3.3 L’importanza di essere laureati: primi approcci con gli annunci di lavoro. Una laurea in economia mi è servita a poco dal punto di vista lavorativo e della carriera, visto che oggi pare che il possederne una, sia diventato più una zavorra che un’opportunità. Pensate che tra i tanti annunci di lavoro in cui mi sono imbattuto, ne ricordo uno in particolare. Cercavano candidati per una posizione di front-office per una banca. Dopo aver sciorinato la solita serie di qualità da supereroe per il candidato ideale, in coda ed in neretto campeggiava il seguente monito: ASTENERSI LAUREATI!. Proprio così. Come un tempo si usava chiudere gli annunci con ASTENERSI PERDITEMPO. Con un semplice sillogismo potremmo facilmente dedurre che il laureato di oggi è equiparabile al perditempo di una volta. La laurea, chimera, sogno, pezzo di carta, zavorra, perdita di tempo, così come volete intenderla, non mi ha spalancato le porte del mondo del lavoro, come dicevo prima, ma almeno mi ha aiutato a capire come funzionano le cose del mondo. Perché non dimentichiamolo: non sono le forze di attrazione gravitazionale degli altri pianeti e del sole che fanno girare la terra, ma le leggi della domanda e dell’offerta. Il Dio denaro ci tiene in equilibrio sul suo indice… Ed è un indice di borsa. 26 Capitolo 4 Le teorie di organizzazione aziendale. Oltre al Marketing, quella dell’ Organizzazione aziendale fu una delle discipline che studiai con maggiore interesse durante il corso di studi universitari. Il libro di testo sul quale studiavamo era opera di Henry Mintzberg (La progettazione dell'organizzazione aziendale – Il Mulino, 1996) uno studioso canadese che, nella sua carriera professionale, si è occupato prevalentemente dell’organizzazione delle imprese. Il pregio degli autori di lingua anglosassone al contrario dei nostri, è la chiarezza e la semplicità del linguaggio. I nostri docenti – almeno nella mia facoltà questa era la prassi -diventano spesso anche autori di manuali il cui studio risulta obbligatorio ai fini del superamento dell’esame. Il motivo che li spinge a scrivere spesso non è il desiderio di fornire un proprio contributo alla scienza e alla conoscenza della materia insegnata, quanto i proventi delle vendite. L’acquisto dei loro testi è obbligatorio ai fini del superamento dell’esame infatti e le vendite vanno a rimpinguare stipendi non proprio esaltanti, almeno per quelli che non praticano anche la libera professione. Tuttavia opere così prodotte, non sempre risultano utili ai fini della comprensione della materia trattata. Anzi, molto spesso l’effetto è quello di complicare concetti altrimenti molto facili da comprendere. Le loro opere spesso risultano ampollose e pesanti. Un po’ è la nostra lingua ad essere più complessa e bizantina rispetto a quella Inglese ma, dall’altra parte, temo che il motivo principale sia proprio la voglia di impressionare e confondere il lettore con parole ricercate e frasi complesse. Sembra quasi che più che mirare ad insegnare e chiarire un concetto, si punti ad ottenere una forma la cui complessità serva a dissimulare la mancanza di contenuti ed innovazione. Riformulo il concetto per dare un esempio concreto di quel modo di scrivere: I nostri docenti sono di sovente adusi ed avvezzi all’elucubrazione ed al discettamento formale della propria disciplina ai discenti mediante l’utilizzo di un eloquio forbito ancorché desueto, di una semantica ricercata nonché poco edibile, pur risultando gustosa ai più fini palati, ma del tutto indigesta agli stomaci plebei dei non iniziati… Ecco come un autore italiano direbbe di sé che parla difficile per sembrare più intelligente di quello che in realtà è. Gli autori anglosassoni invece si fanno poche seghe mentali. Innanzitutto scrivono se e solo se, hanno un contributo da dare alla materia. Il loro stile è semplice e lineare, senza fronzoli. Si avvalgono di metafore ed immagini persino banali, ma che li aiutano a rappresentare in modo molto semplice e chiaro concetti che altrimenti risulterebbero complessi ed ostici. Ancora ricordo per esempio, i gustosi esempi del manuale di Economia Politica, tutti a base di salamini e cioccolata! L’opera di Mintzberg si articolava quindi intorno ad una case-history ovvero la storia di una certa Signora Raku. La Signora Raku era inizialmente una tranquilla casalinga con la passione per la ceramica. Le sue creazioni erano degli splendidi vasi fatti e dipinti interamente a mano e senza l’aiuto di nessuno, per il solo gusto di coltivare un hobby. La notizia della sua bravura però, inizia a diffondersi velocemente col passaparola di amici e conoscenti, tanto che inizia a ricevere ordinazioni dietro pagamento, sempre più numerose da 27 parte di vari committenti a lei sconosciuti. Le ordinazioni crescono al punto che la povera Raku non ce la fa più da sola a fronteggiare la domanda dei suoi vasi e sente l’esigenza di prendere con se qualcuno che l’aiuti. La Signora Raku però è anche una persona precisa e non le va tanto che qualcuno interferisca nel suo lavoro, rischiando che la qualità delle sue opere, possa risultare diversa da quella cui ha abituato la crescente clientela. E così, inizialmente, lascia alla sua assistente solo i compiti più banali e che non richiedevano grosse competenze. Tuttavia, la domanda cresce sempre più e lei si deve dedicare prevalentemente alle attività organizzative e di vendita piuttosto che a quelle meramente produttive. Sente quindi l’esigenza di prendere altro personale e di istruirlo metodicamente, dividendo i compiti in modo preciso, per il raggiungimento di un risultato che mantenga una qualità alta e costante, sotto la sua ultima supervisione. La parabola crescente della sua attività, la spinge sempre più lontana dall’attività manuale e sempre più verso quella manageriale e finanziaria. Alla fine, la piccola attività artigianale di Raku diventerà una vera e propria azienda multinazionale il cui nome sarà Ceramico. L’autore ci porta con questa semplice storiella, per mano lungo il percorso di evoluzione produttiva dell’attività della Sig.ra Raku che – come detto -da attività individuale ed artigianale, si trasforma gradualmente in una vera e propria catena di montaggio di articoli da regalo in ceramica e poi anche diversificata con altri derivati, come diversi manufatti ceramici fatti in serie per l’edilizia. Ogni passaggio evolutivo viene presentato con tutte le relative difficoltà ed implicazioni del caso, tanto da farci comprendere concretamente le difficoltà di volta in volta incontrate e superate grazie a degli step evolutivi della sua organizzazione d’impresa. Ci viene illustrata, con questa metafora, la parabola delle organizzazioni aziendali. Dai primi esempi di organizzazione, più semplici e spontanei, e cioè le organizzazioni di tipo burocratico o gerarchie di tipo militare, in cui ogni dipendente ha un proprio capo diretto col quale e solo col quale, può comunicare e dal quale riceve gli ordini, fino a quelle più moderne e complesse. Nei primi tipi, ovviamente i subordinati non possono apportare modifiche alla propria attività che è regolamentata da stretti ed inderogabili regolamenti standardizzati che servono per mantenere degli standard di qualità costanti (così come i vasi di ceramica artigianali della Signora Raku). Man mano che le dimensioni aziendali crescono, le cose si complicano ed aumentano le necessità di relazioni ed interazioni interne: si inseriscono i primi sistemi di informazione e di reporting manageriale, mediante i quali l’azienda comunica al suo interno e che permettono al management di conoscere istante per istante, quello che accade nell’azienda. La struttura più complessa diventa poi funzionale: non ci sono più strutture verticistiche assolute e separate, ma la struttura si allarga con delle funzioni che servono diversi livelli della stessa struttura. Si ha un’ottimizzazione dei tempi di produzione, delle procedure al fine di ottenere l’efficienza, ovvero il raggiungimento degli obiettivi con la minimizzazione delle risorse impiegate. Si passa quindi dalla sequenzialità piramidale delle comunicazioni (con conseguente lentezza) alla forma a rete (oggi molto attuale), dove gli scambi sono ramificati e complessi e le interazioni avvengono in tempo reale e potenzialmente in ogni ordine e livello della struttura organizzativa dall’alto verso il basso, in direzione opposta od anche lateralmente. Se dovessi proseguire io la storia della signora Raku, direi che alla fine della parabola, percorsi tutti i livelli evolutivi, sarebbe tornata quasi al punto di partenza. Una volta diventata una megamanager avvezza ormai più alle trattative d’affari che a coltivare il suo amore per le attività manuali, la Raku avrebbe scoperto di aver perso di vista il piacere del contatto materiale con la ceramica, che era poi ciò che la rendeva davvero felice e quindi sarebbe rinato in lei il desiderio di tornare alle origini. Sarebbe passata quindi nuovamente dalla produzione in serie, a quella di oggetti unici e di elevatissimo valore, ottenuti plasmandola materia di volta in volta a seconda delle richieste del 28 mercato. A tal fine, avrebbe dovuto mettere su una struttura snella e ad-hoc, cioè dove i compiti vengono distribuiti in base ai progetti di volta in volta elaborati in funzione delle commesse. Da qui deriva appunto il termine ad-hocrazia utilizzato dagli studiosi dell’organizzazione aziendale. Organizzazione che è poi molto più simile alla bottega di Leonardo, che alle catene di montaggio come le conosciamo noi. Nel frattempo, abbiamo assistito anche al passaggio tra due diversi modelli di produzione: siamo passati dal concetto push a quello pull. Nel primo, il più antico, il produttore faceva quello che sapeva fare e lo immetteva sul mercato attendendo la risposta dei consumatori. La Ford creò il modello T ed Henry Ford amava ripetere che Ogni cliente può ottenere un'auto colorata di qualunque colore desideri, purché sia nero… Insomma, l’azienda offriva quel che sapeva fare e toccava al mercato di adattarsi. Oggi le cose non funzionano più così: la fortissima concorrenza tra diversi produttori, tutti più o meno sullo stesso livello qualitativo a parità di segmento, impone che sia il mercato a dettare legge. I produttori sono costretti a leggere ed interpretare i desideri e le tendenze del mercato ed elaborano prodotti in funzione di questi bisogni. Questo tipo di produzione è definito pull perché – si dice – è tirato dal mercato. Questa in estrema sintesi è la teoria. Adesso, se vi va, mi accompagnerete nel ripercorrere la realtà con la quale mi sono scontrato. 29 Capitolo 5 La prima esperienza lavorativa: l’agenzia di nonpubblicità. C’eravamo lasciati parlando delle esperienze formative, ma non ho raccontato ancora proprio tutto-tutto… Negli ultimi tempi trascorsi all’università, perso tra formule di matematica attuariale, budgetting, partita doppia e ameni principi di diritto, avevo capito che seppure apprezzassi la conoscenza dei meccanismi principali che regolano la nostra vita sociale ed economica, avevo provato però un senso di costrizione: ero imbrigliato in un mondo che non mi piaceva del tutto, che trovavo asettico, privo di passione e di fantasia, di creatività. Studiando marketing invece, ero entrato in contatto con menti più brillanti, meno convenzionali e più creative e finalmente avevo ritrovato un po’ di quelle mie radici e potevo sentirmi più libero da quel senso di frustrazione vissuto fino ad allora. Realizzai che, di tutto ciò che avevo sino ad allora studiato, mi interessava soprattutto il mondo che ruotava intorno alla commercializzazione e quindi alla pubblicità di un prodotto. Avevo sempre avuto interesse per tutto ciò ma non ne ero stato, fino ad allora, ancora consapevole. Tale consapevolezza l’acquisii grazie a dei concorsi indetti – attraverso la mia facoltà - da una nota multinazionale leader nella vendita del tabacco e proprietaria dei più grandi marchi alimentari (quasi nessuno sa che la maionese e le sigarette più vendute al mondo, sono prodotte dalla stessa multinazionale!). La multinazionale che, per convenienza, chiameremo Fuma & Spalma, richiedeva, da parte degli studenti il rilancio di un prodotto in difficoltà, con la creazione di una vera e propria strategia a 360° che comprendesse quindi, anche la comunicazione. Ci furono varie edizioni del concorso, una prevedeva il rilancio di una birra americana, un’altra di un formaggio da spalmare ed infine un’edizione su una miscela di caffè, peraltro imbevibile. Era quella la parte del processo produttivo che più mi piaceva: la creazione della strategia di comunicazione e vendita del prodotto. Nel frattempo Carlo, il marito di mia sorella Paola, da sempre appassionato di fumetti, aveva partecipato ad una conferenza di fumettari napoletani ed era così venuto a conoscenza dell’apertura di una scuola di fumetto ed illustrazione nella nostra città. Tra i docenti, c’erano delle vere e proprie celebrities, autori degli albi più in voga in quei tempi, come Dylan Dog e Martyn Mistere. Conoscendo la mia passione per il disegno (grazie al mio primo PC, avevo ricominciato a disegnare utilizzando i primi programmi di grafica) ma soprattutto rendendosi conto della mia frustrazione, mi consigliò di andare a curiosare in quella scuola e nel caso, iscrivermi ad un loro corso anche per divagare un po’ dai soliti giri, università-libri-esami, esami-libri-università. Inizialmente un po’ titubante, mi lasciai convincere e ci andai. Presi una appuntamento telefonico per l’indomani per un breve colloquio. Arrivai alla scuola accompagnato dal diluvio universale e cercai dimostrare un po’ quelli che erano i miei lavori che ovviamente, dato il diluvio, arrivarono totalmente inzuppati d’acqua. Lì conobbi delle persone simpatiche e di mente aperta che, sentendo della mia passione per il disegno e la pubblicità e nonostante non si capisse molto da quegli acquerelli che un tempo erano disegni usciti dalla stampante del mio pc, mi consigliarono un corso di illustrazione. Ripresi la matita in mano e mi sentii finalmente come l’Ulisse che, ritornato ad Itaca, poteva 30 sfogare la sua rabbia covata per decenni, infilzando uno ad uno, quei parassiti dei Proci che avevano bivaccato per anni a sue spese, in casa sua, contendendosi la sua donna. Gli altri ragazzi che già frequentavano la scuola, mi lasciarono a bocca aperta. C’erano dei veri e propri talenti ed una semplice matita nelle loro mani, dava rapidamente vita a dei veri capolavori. Pian piano, dopo i primi iniziali disastri, riuscivo anche io ad imitare i loro lavori e quelle che mi erano sembrate inizialmente delle magie, diventarono via via tecniche alla mia portata. Alla fine, per tutto c’è una tecnica. Tutto ciò avvenne mentre studiavo per gli ultimi esami. Da quando avevo iniziato a frequentare quella scuola (ci restai per quasi tre anni, dopo i quali riuscii a raggiugere un discreto livello come illustratore pubblicitario tanto da crearmi un book dove avevo raccolto le mie campagne virtuali) lo studio divenne meno pesante e più intenso. Studiavo molto meno, ma molto meglio. Una volta laureato, il mio desiderio fu quello di lavorare in un’agenzia pubblicitaria, anche se non sapevo come e da dove iniziare. Il mio errore forse, fu quello di cercare lavoro come copywriter quando invece ero ormai più preparato come art director ed avendo una formazione universitaria prevalentemente di marketing. Tre cose che mandavano in tilt i selezionatori di risorse umane. L’obiezione più frequente che mi si rivolgeva era: sei laureato in economia? Allora lavora in banca! Che ci fai in un’agenzia pubblicitaria? Oppure disegni così bene, perché vuoi fare il copy? A queste domande, evidentemente e purtroppo, non seppi mai dare una risposta convincente. Da dove dovevo cominciare per trovare un lavoro nel campo che più mi piaceva? Presi le pagine gialle e da lì cercai i primi indirizzi nella mia città, sottoscrissi il primo abbonamento Internet (perché nel 1998 internet girava ancora sui modem a 56K teorici e soprattutto si dovevano sottoscrivere abbonamenti oltre a pagare il traffico telefonico!) e cercai di tirare fuori quanti più indirizzi potevo dai primi motori di ricerca settoriali. Scrissi il mio primo Curriculum Vitae nel quale non potevo vantare grandi esperienze se non quelle formative e lo feci accompagnare da una quantomeno originale lettera di presentazione che faceva più o meno così: Sono un creativo in erba, pieno di idee stupefacenti. So di non avere grandi esperienze, ma non per questo mi do per spacciato. Il mio sogno non andrà in fumo. Poi c’era la mia firma, un logo che rappresentava una lampadina (le idee) la cui metà superiore era una bomba con la miccia accesa (l’esplosività delle idee). Le reazioni furono varie: in prevalenza venni ignorato, qualcuno mi rispose con i format standard del tipo la ringraziamo blàblà… la terremo presente …bla bla bla… ma tre o quattro agenzie mi risposero dandomi prova di aver letto davvero la mia lettera e facendomi anche i complimenti per l’originalità del mio CV, scusandosi con la formula dato il momento di crisi (tanto per cambiare!) non possiamo chiamarti neanche per un colloquio. Ti terremo senz’altro presente in futuro. Questo era il classico messaggio di commiato. Dopo qualche settimana però, mi arrivò anche una telefonata: veniva da un’agenzia napoletana alla quale avevo persino dimenticato di aver scritto. Mi fissarono un appuntamento per un colloquio. Tra l’altro, la loro sede era a soli 10 minuti a piedi da casa mia. La comodità e l’opportunità fuse insieme. Andai a cercare notizie su di loro e trovai sulle pagine gialle prima un’omonima agenzia di pompe funebri e poi, in piccolo, il loro riquadro pubblicitario. Si fregiavano del titolo di Group e questo mi indusse erroneamente a pensare che fosse una realtà grande e seria anche se, una volta trovato il sito internet, notai subito che faceva davvero schifo. Il giorno dell’appuntamento mi presentai in abiti eleganti (giacca) ma informali (senza cravatta) come si addice ad un ambiente creativo. Mi aprì la porta una ventenne sui trampoli, sorella del titolare e mi si presentò come segretaria. 31 Erano i tempi delle scarpe con la superzeppa in stile “mostro di Frankestein”, le sue poi avevano un che di inquietante, visto che la suola partiva già da 10cm di altezza prima del tacco, tanto da raggiungere l’altezza di un primo gradino di una scala. La ragazza mi accolse cordialmente invitandomi ad accomodarmi accanto ad una grande scrivania di vetro poggiata su dei cavalletti azzurri. In quel momento, aprì la porta che dava su questo saloncino-ingresso un’altra giovane donna alquanto corpulenta che mi si presentò con l’altisonante titolo di Service Manager, neanche lavorasse per davvero in una grande azienda milanese (come già detto, i milanesi che contano usano autodefinirsi con termini anglosassoni, probabilmente per non sentire la frustrazione di essere anche loro degli italiani). Il titolare, così lo definì lei, sarebbe arrivato di lì a poco. Nel frattempo mi intrattenne raccontandomi delle risate che gli avevo provocato col mio bizzarro curriculum e del fatto che, sicuramente, denotavo una personalità molto creativa e sopra le righe. Un rumore di chiavi nella toppa preannunciò che la porta di ingresso si sarebbe spalancata alle mie spalle. Mi si presentò un uomo giovanissimo (mio coetaneo): era alto, un po’ in carne anche lui e con i capelli a fungo come li portavo io a 14 anni ma di colore corvino. Il colloquio fu molto cordiale, alla fine mi sparò la sua offerta: potevo fare uno stage da loro, per la mirabolante cifra di 400mila lire al mese (meno degli attuali 200 euro, un rimborso spese) che ovviamente erano solo un simbolico inizio per permettermi di fare esperienza e di conoscerci reciprocamente e di lì iniziare una collaborazione duratura. Tutto ciò però, previa prova di ammissione: avrei dovuto sottoporgli entro una settimana, l’idea per un calendario che facesse da gadget e pubblicità istituzionale per l’agenzia, da regalare a clienti e potenziali contatti per le festività natalizie. Me ne andai contento per la sfida e ridacchiando tra me e me sul fatto che sarei stato anche io autore di un calendario come quelli che vedevo sempre su riviste come Max e simili che avevo iniziato a leggere per conoscere le ultime tendenze nel mondo della comunicazione e del trend, insieme con quelle settoriali. Il logo dell’agenzia era – grande fantasia! –una mela verde, ovviamente copiata dal logo della Apple. La mia idea fu quella di rappresentare l’attività dell’agenzia: l’idea che pian piano si veste di concetti e poi viene confezionata e presentata al cliente. E prendendo spunto dal concetto di mela, partii dal torsolo – l’idea – che pian piano si ricostruisce con la polpa – la strategia di marketing e l’elaborazione della pianificazione – fino alla presentazione finale al cliente – la buccia. Il progetto, suddiviso in quattro immagini, ovviamente – visto che le mele sono delle modelle facili da reperire ed a costi praticamente nulli – piacque tantissimo al titolare e fu subito messo in opera. Mi chiamarono a lavorare prima dello scadere della settimana. Avevo un solo collega, M.: il titolare e la sua compagna – l’assistente dal titolo pomposo– lo chiamavano affettuosamente Lello Arena ed in effetti per la capigliatura, la barba e la simpatia, davvero gli assomigliava come un gemello omozigote. Nonostante avesse provato a fare il collega serio e severo, dopo pochissimo dovette gettare la maschera. Diventammo presto amici e due veri creativi affiatati come se ci fossimo conosciuti da anni. Nel frattempo cercavo di colmare le mie lacune ed imparare da lui i trucchi anche nella impostazione della grafica e nell’utilizzo dei relativi programmi e soprattutto a familiarizzare con l’ostico – per me – mondo dei Mac. Il titolare, più che verso le mie capacità creative, si mostrò subito molto più interessato alle mie conoscenze nel campo del marketing. In sostanza, mi aveva preso proprio per quello: iniziai quindi a dare lezioni di marketing e 32 management a lui ed alla sua compagna, praticamente a costo zero (per dirla tutta, lui aveva come studi alle spalle, il liceo artistico, lei quello linguistico anche se non masticava le lingue straniere! Entrambi, brillantemente diplomati con 36! Insomma, mi avevano preso per farsi un corso universitario quasi a costo zero). Famose erano le sue uscite: quando nella discussione delle strategie parlavo di prodotto che farà da TRAINO al resto della gamma lui annuiva ripetendo Sì, sono convinto anche io che farà da TRAINER ed io ripetevo TRAINO e lui (ri)ripeteva ostinato: Sì, TRAINER!!! Ben presto mi si presentò un nutrito campionario dei più improbabili clienti che un’agenzia pubblicitaria potesse immaginare. Per citarne solo alcuni, c’era il gentleman driver: un pilota di off-shore che desiderava che noi gli coordinassimo campagna pubblicitaria, sito internet e raccolta sponsor (fu il mio primissimo lavoro come copy) quasi a costo zero. Poi ci fu l’imprenditore ortofrutticolo che si presentò in Jaguar e con fidanzata originaria dell’Est europeo al seguito (non saprei identificare bene la provenienza) che aveva la metà dei suoi anni, ¼ del suo peso e qualche milione di volte la sua avvenenza, malgrado l’abbondante abuso di vestiti e stivali gattopardatissimi. Nonostante l’ostentazione di ricchezza e potere in stile gangsta-rapper americano, anche costui cercava di risparmiare persino i centesimi (ed allora erano ancora centesimi di lira!) dicendosi tra l’altro, molto scettico circa l’utilità di una campagna pubblicitaria. Fu la volta poi dell’imprenditore dell’azienda conserviera che ci commissionò le etichette per la sua linea di sottoli, tra i quali v’erano i famigerati friarielli napoletani. In questo caso mi occupai soprattutto delle illustrazioni delle etichette e ricordo in particolar modo quelle dei carciofi che, secondo il suo volere, dovettero assumere uno strano colorito bluastro davvero poco invitante. In quel caso applicai quella che in marketing si definisce la regola del attacca o’ciuccio arò vò o’ padrone! (lega l’asino dove desidera il suo proprietario N.d.R.). Quello che più stimavo però, era un noto imprenditore del settore della torrefazione, proprietario di un marchio di caffè abbastanza noto a livello locale e che nonostante fosse nientemeno che lo zio del titolare, non si fidava ad affidarci seriamente la sua immagine. Noi sognavamo di poter realizzare le nostre tanto ambite campagne di manifesti 6x3, ma lui poi le affidava alla concorrenza, lasciandoci solo briciole e frustrazione, più qualche confezione di caffè in omaggio a Natale. In sostanza imparai a comprendere che nel Sud Italia in generale ed in Campania in particolare, la figura dell’ imprenditore era ben lontana da quanto avevo studiato all’università e più simile a quella di un signorotto feudale che cerca di trarre quanto più sangue dalla rapa della propria azienda, finché non sarà secca al punto tale da poter inscenare un fallimento pilotato (con tutte le conseguenze del caso verso i creditori) e ricominciare da capo con un altro prestanome. La pubblicità era considerata come un costo, un lusso, talvolta necessario, ma da tagliare e ridurre quanto più possibile. La differenza tra un’agenzia pubblicitaria e una stamperia tipografica era poi una cosa ignota ai più. Lungi da loro l’idea che fare pubblicità potesse essere un investimento, l’unico capace di farli uscire dalla mediocrità e sussistenza nella quale si trovavano. Ma finché c’erano denari per comprare la villa ed il macchinone, vestiti firmati per sé, la moglie ed i figli e potersi permettere vacanze in famiglia oltre a qualche alberghetto di semi-lusso dove portarci le amanti… a chi importava del resto? La crescita dell’azienda non era una finalità ma una necessaria conseguenza al desiderio di avere più denari da spendere per sé. Almeno questo è quanto ho verificato nella mia esperienza. Immagino e spero che ci siano anche realtà differenti. Se ne conoscete qualcuna, fortunati voi. Tra un lavoretto ed un altro, tra una pianificazione marketing, l’etichetta di un friariello o un carciofo blu puffo, l’animazione ed il copy per un sito internet, la stampa ed il taglio di una 33 tonnellata di partecipazioni di matrimonio e biglietti da visita ed in mezzo a tanta frustrazione, elaborai anche quella che era la mission principale del mio lavoro in quell’agenzia: determinare una strategia di crescita aziendale per far decollare l’agenzia dal livello locale micro-micro-micro ad uno di respiro regionale se non nazionale. In effetti la concorrenza locale non era granché e soprattutto le dimensioni delle aziendine presenti erano davvero risibili. Perlopiù si trovavano tipografi che facevano grafica, smanettoni che improvvisavano siti internet, fotografi di matrimoni che azzardavano improbabili spot. Ma un’agenzia che curasse tutto dalla pianificazione marketing alla realizzazione finale di una campagna stampa o di affissione, non c’era. Il problema principale però era la mancanza di una clientela di livello e la difficoltà di raggiungere quella – poca – esistente, con i nostri risicati mezzi. La mia idea fu quella di riuscire a colpire l’attenzione di qualche agenzia pubblicitaria di grande livello nazionale e spingerli ad interessarsi a noi per entrare a far parte della loro orbita. In effetti per una grande agenzia l’idea poteva essere interessante: non avrebbero avuto i costi fissi di una loro sede in loco ed in più si potevano generare le interazioni e le sinergie che solo un network può dare. Inoltre eravamo tutti giovanissimi, motivati e – almeno io e Lello Arena – capaci dal punto di vista creativo mentre al boss andava riconosciuta una invidiabile e innegabile abilità di venditore e PR, a dispetto della sua rozzezza ed ignoranza (forse questo ci ricorda qualche altro personaggio italiano di grande successo?) L’idea venne elaborata ed approvata nonostante qualche resistenza – Ma o’ padrone song’ semp’io! - ci tenne a precisare il boss che però aggiunse anche: - tu ovviamente, quando avremo successo, sei il mio direttore marketing ed un giorno verrai al lavoro in BMW anziché in Fiat Uno! Sic! (…ma anche sigh!) Selezionammo un pool di agenzie che potevano fare al caso nostro e mandammo in giro una sorta di video curriculum di tutti noi con tanto di presentazione multimediale e amenità varie. Sviluppammo un sito internet divertentissimo, con una melina animata che faceva da guida e con persino un test che simulava una serie di domande per stabilire – alla fine – che l’autore aveva bisogno di rivolgersi comunque a noi Il bersaglio fu colpito e bene. Un paio di agenzie di quelle medio-grandi (almeno a livello nazionale) ci contattò e sembravano davvero intenzionate ad approfondire il discorso, ma nel frattempo il boss c’aveva ripensato. Il problema era che lui non aveva le carte in regola per portare a termine per davvero questo discorso (non so che noie contabili avesse, noi dipendenti eravamo a nero, insomma, era un’agenzia che non c’era nei fatti) e non poteva ammetterlo. Aveva voluto bluffare per vedere quanto valessimo sul mercato e non si aspettava davvero una risposta. Ora che ce l’aveva, era in difficoltà. Iniziai a capire quanto poco serio fosse quell’uomo e iniziò il disincanto. Nel frattempo invece, iniziò anche il mobbing da parte sua, anche se in quel momento non sapevo ancora cosa fosse il mobbing. Mi affidò via via mansioni sempre più deprimenti se non umilianti, passò dal tono amichevole-fraterno a quello padronale, mi sospese i pagamenti (già miseri) e dopo tre mesi che non venivo pagato, la misura fu colma e decisi di andarmene. Dopo anni ho trovato il suo nome in una rosa di eletti di una nota associazione di imprenditori. Il boss si era dedicato alla politica attiva ed aveva scommesso sulla parte che da quegli anni in poi sarebbe emersa. Era riuscito in qualche modo a sanare le sue condizioni economiche e fiscali e ad ottenere dei finanziamenti europei, accordandosi infine con una delle agenzie che io avevo contattato per una partnership. Con i fondi europei – pensate! – pare che avesse comprato casa e mobili e infine messo su una nuova agenzia che funzionava sempre con lo stesso sistema: prendere giovani capaci ed inesperti dal punto di vista lavorativo, spremerli come limoni finché era possibile, buttarli fuori col mobbing. Quest’uomo continua – per quel che ne so – a vivere tranquillo nel suo squallore 34 umano/imprenditoriale ed ad operare indisturbato. Il suo nome compare ancora qualche volta sui quotidiani come creativo e manager emergente, ma io come insegna la dottrina Zen, aspetto il giorno in cui vedrò la sua salma professionale scivolare lungo il fiume e magari, potrò leggerne il nome in cronaca giudiziaria. 35 Capitolo 5.1 La lezione che ne ho tratto. L’organizzazione aziendale è una disciplina importante per lo sviluppo di un’azienda sana e dinamica. La struttura adhocratica di quest’agenzia e gli obiettivi che abbiamo quasi raggiunto (l’avremmo fatto in condizioni normali) lo dimostrano. Ma in un ambiente privo dei minimi requisiti di legalità e rispetto delle Risorse Umane, non c’è sviluppo possibile. Nel sud Italia e temo, un po’ in tutto il paese, vige ancora l’antica legge del taglia, abbatti, sfrutta e cambia territorio in uso tra le prime popolazioni nomadi, piuttosto che la successiva cura del territorio dei coltivatori/allevatori stanziali. Figurarsi quanto poco sia familiare il concetto capitalistico della catena del valore: Denaro – Merce (Servizio) – Denaro, ovvero, del denaro che, circolando, provoca la generazione di altro denaro ed arricchisce non un singolo sfruttatore, ma l’intera collettività. I nostri imprenditori vivono prevalentemente dei sussidi statali o dei fondi europei e non cercano di creare sviluppo sul territorio ma li utilizzano spesso per scopi personali, abbandonando poi l’impresa al suo destino. Ora che l’opportunità è ridurre i costi delle Risorse Umane delocalizzando, trasferiscono anche le poche produzioni residue nei paesi dell’ex blocco sovietico o negli altri paesi emergenti. Stanno fuggendo tutti lì, lasciandoci solo terra bruciata ed arida, alberi abbattuti, bestiame decimato ed il ricordo di un paese che è stato una grande potenza industriale ed economica. 36 Capitolo 6 Tentata fuga di… Cervello. Anche il mio collega ed amico Lello Arena decise con me di lasciare l’Agenzia di Nonpubblicità partenopea per tentare la strada da free-lance. Collaborai con lui per qualche piccolo lavoretto, giusto per raggranellare qualche spicciolo. Nel frattempo avevo imparato ad usare programmi come Photoshop e Flash – un programma per creare animazioni web - in maniera molto più che discreta. Al punto che io e Lello Arena, riuscivamo persino a ricreare dei veri e propri cartoni animati e questo ci permise per un po’ di sbarcare il lunario. Nel frattempo, il mio sogno era sempre quello di trovare lavoro in una vera agenzia di pubblicità e dove trovarne una se non a Milano? Le nostre strade quindi si divisero. Ricominciai l’invio dei CV a pioggia ma, ancora una volta, con risultati non molto soddisfacenti. Un giorno però, mi arrivò la risposta di un’agenzia medio-piccola come dimensioni, ma con una storia e con dei clienti che il mostro di fame napoletano, mio ex donatore di lavoro – come direbbe la Porcaro - si sarebbe solo potuto sognare! Era una vera e propria boutique della pubblicità, con prestigiosa sede in un loft sui Navigli. Avevo avuto già modo di ammirarla e di sognarla leggendone su di un numero speciale di una rivista settoriale (articolo che ingenuamente avevo creduto essere spontaneo e che invece, a detta del suo stesso committente, era in realtà concordato e profumatamente pagato dall’agenzia stessa). Il copy era uno dei più bravi della storia della pubblicità italiana, l’art e cofondatore, uno di quelli che più ammiravo e di cui avevo avidamente letto tutti i libri. La lettera di presentazione stavolta era meno bizzarra ma non meno incisiva e faceva più o meno: Quando si invia un curriculum ad un’agenzia, ci si domanda sempre se l’effetto che farà, sarà quello di un albero che cade in una foresta. Se la foresta è deserta, se non c’è nessuno lì che ne raccolga e ne comprenda il suono, l’albero sarà forse caduto invano, senza fare alcun rumore. Mi auguro che lì, in quella foresta dove io lo mando ora, ci sia qualcuno pronto ad ascoltarne ed apprezzare il suono. E PP il copy mi rispose: Ciao F., io e LM (il suo socio ed autore dei libri che avevo letto) abbiamo letto ed apprezzato molto la tua bella lettera di presentazione. Ci terrei a conoscerti. Quando sei di passaggio a Milano chiamami che fissiamo un appuntamento. Firmato: PP Quando ricevetti quest’email quasi non credevo ai miei occhi. La stampai e la rilessi e controllai che quel nome, quella firma, corrispondessero a chi credevo io e… Sì, era proprio dall’agenzia dei miei sogni che mi si invitava a sostenere un colloquio! Nel frattempo – confesso, grazie ad un’amicizia comune quanto alla fine, ininfluente – ottenni di essere ricevuto dal direttore creativo di un’altra grande agenzia, stavolta davvero troppo grande per la mia esperienza. Dopo non poche discussioni con mia madre che non era d’accordo, preparai i bagagli e partii alla volta di Milano con l’Eurostar, tirandomi dietro un Samsonite presa in prestito da mia sorella, uno di quei trolley di una volta, pesante a vuoto già una ventina di chili e che essendo stretto e lungo, si ribaltava ad ogni piccola asperità del terreno. Una scomodità più unica che rara che mi costò quasi 37 una distorsione ad una caviglia. A Milano mi accolsero il mio “amicissimo” F. e la sua di allora moglie. Abusai della loro ospitalità per tutto il tempo necessario a fare quei due colloqui ed aspettare qualche risposta. Ricordo, furono poco più che due settimane, era ottobre e non smise mai un giorno di piovere. Arrivò finalmente il giorno del primo colloquio, quello nell’agenzia-loft. Non riuscivo a credere a quello che vedevo quando, dopo aver avuto il lasciapassare da un portinaio in livrea, attraversai dei solai trasparenti, sospesi su travi di acciaio rinforzate da tiranti. Suonai alla porta e dopo una breve attesa venni ricevuto dal copy e socio dell’agenzia PP, che mi accolse cordialmente e mi fece accomodare ad un tavolo di cristallo rettangolare e ferro battuto, lungo come immaginavo fosse quello di Re Artù (anche se sapevo benissimo che lui e Lancillotto sedevano ad una tavola rotonda, non potevo non pensare che quel luogo si ispirasse a Camelot) contornato da sedie ognuna diversa dall’altra e, immagino, ognuna un pezzo da collezione a sé, sempre con un certo stile gotico e la prevalenza del materiale ferroso. La segretaria mi chiese se desiderassi qualcosa da bere, ed io visto che avevo la lingua felpata come un buon Fantozzi, le chiesi dell’acqua. Tornò con un vassoio di ferro brunito con una bottiglia di minerale e dei bicchieri enormi, anch’essi dello stesso materiale. Sì, erano proprio ispirati al Graal, l’impressione era sempre più forte. PP sorrise sotto quell’aria un po’ burbera dovuta all’età ed all’esperienza ma tutto sommato bonaria: vedi – mi disse – abbiamo usato per te anche il servizio buono – e lanciò un’occhiatina un po’ velenosa alla povera ragazza che forse non aveva capito che non ero un cliente e che quindi sarebbe bastato prendere i bicchieri ed il vassoio di volgare plastica. Dopo i soliti convenevoli da colloquio di lavoro – meno formale nell’apparenza, visto ciò che impone l’ambiente creativo ma non meno serio e severo di quello svolto presso una qualunque altra azienda – ebbi modo di mostrargli i miei lavori. Ribadì ancora che la lettera che gli avevo scritto l’aveva colpito molto favorevolmente, al punto che anche il suo socio si era incuriosito, ma che da quei primi lavori abbozzati su un book fatto, peraltro, non con l’aiuto di una scuola di pubblicità da loro riconosciuta ma da una fantomatica scuola di fumetto ed illustrazione di una città per loro (non lo disse, ma si capiva che quello era il senso) del terzo mondo, non poteva sbilanciarsi più di tanto. Prese atto però che da ogni mio poro sprizzavo amore e passione per quella professione e che quelli erano ingredienti fondamentali per riuscire in quel mestiere. Mi indicò la strada da seguire, rammaricandosi del fatto che essendo loro piccoli e con organico sovrabbondante, non potevano offrirmi al momento, neanche uno stage. Restiamo in contatto però mi disse e mi congedò con una pacca sulla spalla. Uscii ripercorrendo il percorso di cristallo e come Cenerantolo, il cugino asmatico della più famosa Cenerentola, dimenticai anziché la scarpetta, il mio ombrello e fortuna che in quel momento, gli elementi mi concessero una tregua. Scoprii che mentre a Napoli i venditori ambulanti di ombrelli spuntano come funghi alla prima pioggia e ti offrono riparo a prezzo modico, a Milano devi sborsare un bel po’ di quattrini per averne uno, dopo aver penato in giro per trovarlo. Venne dopo poco anche il giorno del secondo colloquio. Avevo contattato al telefono il direttore creativo della grande agenzia che era amico dell’amico del mio solito cognato appassionato di fumetti e che mi aveva concesso il grande onore di un’udienza. Fu di quella finta cordialità che trasuda viscidume da tutti i pori, ma allora non avevo ancora i mezzi per percepirne appieno l’artificiosità e la scambiai per un sentimento schietto di reale simpatia. Il tipo mi chiese il favore, anziché incontrarmi in agenzia, di raggiungerlo presso la sua – favolosa – abitazione, situata in un attico di una diversa zona, ma non meno prestigiosa, di Milano rispetto a quella del primo colloquio. Raggiunsi l’indirizzo con un certo anticipo ed ebbi modo di cercare di rilassarmi un pochino percorrendo il lungo stradone, poi affrontai il solito portinaio in livrea e l’ascensore che mi condusse sull’attico. 38 Il DC aveva avuto l’ernia del disco e si era appena operato. Era quindi convalescente e molto dolorante, sicché era molto poco propenso all’empatia ed alla simpatia. Venni accolto in casa da – penso – una domestica e mi fecero accomodare sulla terrazza dello splendido attico. Lui arrivò poco dopo zoppicante e con al seguito un cane di piccola taglia, scusandosi per il suo stato, si accomodò su una poltroncina tra grandi cuscini colorati. La cagnetta, non appena mi vide, corse verso di me e mi saltò in braccio, facendomi feste che un cane serio non dovrebbe mai rivolgere ad un estraneo e che io ricambiai con delle carezze sulla testolina. La cosa non servì a sciogliere il ghiaccio anzi, perché il padrone se ne risentì neanche fosse stata sua moglie ad accogliermi in vestaglia e lingerie ed a baciarmi sulla bocca in sua presenza. La richiamò dicendole stupida, non vedi che io sono qui?. Il colloquio ebbe inizio. Mi rivolse le domande di prassi: percorso di studi, provenienza, esperienze lavorative. Appena sentì: Napoli, 30 anni, laurea in Economia, saltò quasi sulla sedia nonostante ci si fosse seduto a stento tra varie smorfie di dolore: Ma tu sei laureato in Economia, hai l’età che hai (praticamente il piede nella fossa), hai poche esperienze e solo a Napoli che, non ti offendere, è una bella città ma in quanto a pubblicità… che c’è lì? Solo roba provinciale e francamente e… E non ti offendere (di nuovo?) quel provincialismo trasuda tutto dai tuoi lavori… Perché… Perché vuoi fare il creativo? Ed il copy poi? Tentai di dare una risposta a quelle obiezioni per quel che potevo, ma lui non si poteva dar pace per quelle mie ambizioni: Il copy poi… ironia della sorte, devo darti atto, come copy, sei la miglior matita 2 che mi si presenta da anni, a dispetto di tutti quelli che mi si sono presentati come art negli ultimi tempi… ma con i tuoi studi, scusa eh? Ma perché non mi fai l’account? 3 O mi vendi spazi pubblicitari. Per quello a Milano, sì che si trova lavoro… Ma per un copy che deve iniziare da zero, alla tua età… ( aridaglie!!!)… In quel momento pronunciai delle parole che – ripensate adesso – mi fanno molto ridere e mi sembrano quasi un’autocondanna a vita: Non sarò mai un venditore, non è nella mia natura. Ognuno ha delle inclinazioni e la mia ultima, è la capacità di vendere. Non fui furbo a contraddirlo, ora me ne rendo conto, ma ero ancora troppo ingenuo ed ancora credevo che il desiderio fosse la migliore strada per raggiungere un obiettivo. La cosa lo irritò fortemente. Mi condusse alzandosi con svariate smorfie di dolore, nel suo studio. Lì, accese il suo Mac e mi mostrò dei siti di pubblicità americani. Si voltò meccanicamente verso di me indicandomi lo schermo e mi disse: Se vuoi fare questo lavoro, provaci, ma sappi che se non sei mai vissuto all’estero ed intendo per degli anni, se non hai respirato l’aria di capitali della cultura come Londra, New York, Parigi, non potrai mai essere un vero creativo. Sì, magari puoi trovare qualche lavoretto di bassa manovalanza in qualche piccola agenzia qui, ne trovi quante ne vuoi, ma ti sfrutteranno per qualche annetto e ti ritroverai un giorno ad essere ormai fuori mercato e disoccupato. Insomma, mi scrisse una bella sentenza di condanna. Me ne andai con quella smorfia di dolore che si ha solo dopo che il dentista ti ha estirpato un dente del giudizio e successivamente la sua segretaria ti ha trapanato il portafogli ed il tutto senza 2 “Buona matita” significa nel gergo, uno che si destreggia bene nel disegno. In pubblicità la creatività viene suddivisa tra due figure: l’art director, che si occupa della parte grafica-visuale del lavoro ed il copy, che invece prevalentemente si occupa della parte concettuale ed esclusivamente del testo. In genere un copy non sa neanche tenere una matita in mano e la cosa non gli è neanche richiesta, vista la rigida divisione dei compiti, o almeno questa è la regola, poi si sa, i grandi sono proprio quelli che le regole le conoscono, le padroneggiano e spesso, non le rispettano. 3 L’Account invece si occupa del rapporto tra agenzia e cliente ed è una figura più manageriale che creativa. Gli account sono stimati dai creativi come i becchini lo sono dai medici 39 anestesia né ricevuta fiscale. Quegli ultimi tre anni erano stati terribili per me: la malattia di mio padre, la corsa per fare l’ultimo, difficile esame e cercare di laurearmi quando lui era ancora vivo, la sua morte, la depressione di mia madre, l’esperienza di lavoro con quel losco figuro dell’agenzia. Sentivo che tutta quella tristezza riaffiorava prepotente e mi sopraffaceva, stringendomi la gola e opprimendomi il petto come il cemento di una casa crollata. E il clima e la pioggia non aiutavano di certo, né tantomeno le telefonate che, ogni sera, facevo a casa a mia madre che, tra l’altro, aveva sempre osteggiato la mia idea di lavorare a Milano. Girellai ancora qualche giorno per la città, cercando di raccogliere un po’ le idee ed attirandomi l’odio della moglie del mio povero buon amico che ancora mi ospitava. Ma quei giorni, seppur tristi, furono anche molto utili per la mia maturazione. Innanzitutto ebbi modo di conoscere la vera capitale italiana: Milano. Milano mi apparve allora, come una strana città, pur venendo io da Napoli, città che definirla stranissima è poca cosa. Me l’aspettavo innanzitutto più grande, più tentacolare ed invece, persino io che avevo il senso dell’orientamento di un ubriaco bendato, riuscivo a girarci senza perdermi come neanche riuscivo nella mia città. A Milano si fa il contrario di quel che recita Sting in “An Englishman in New York”: a gentleman who walks but never runs. Lì invece non si cammina, si corre. E se tu non corri ma cammini è perché o sei un disadattato o un turista. Col mio passo lento ed il naso costantemente per aria, venivo fermato continuamente da venditori extracomunitari o da persone che chiedevano l’elemosina, mentre gli indigeni col loro passo da maratoneti, riuscivano a schivarne la maggior parte. Ma camminare lentamente e bighellonare a Milano, ti permette anche di vedere cose che gli altri ignorano. Ѐ un piacere per pochi fortunati o per fortunati disperati come ero io in quel momento. Sono stato una mattina ad ascoltare a bocca aperta, una guida tedesca che illustrava l’interno del Duomo. Non chiedetemi come, ma ad un certo punto, pur non capendo una parola di tedesco, ho avuto la sensazione di comprendere tutto quello che il cicerone raccontava ai turisti. Lungo il tragitto verso il Ricordi Megastore che si trovava nella galleria e nel quale passavo lunghe ore a scroccare un po’ di buona musica, facevo sempre bizzarri incontri. Una mattina mi capitò di fare la cavia per un assaggio di snack al cioccolato fondente con le nocciole. La signora che cercava dei tester fu sorpresa che finalmente qualcuno si fermasse, io invece rimasi sorpreso da quella deliziosa mangiata di dolciumi a scrocco. E mi regalarono persino un portachiavi. Il pomeriggio poi, in quei giorni c’era la presentazione del nuovo disco di Madonna, quello con ambientazione country il cui singolo era girato in una trashissima limousine guidata da Ali-G, un rapper di origini Indo-Inglesi (al secolo Sacha Baron Cohen) La presentazione consisteva in due meravigliose e sensuali ballerine di lap dance che si esibivano in una vetrina del Ricordi-Megastore, attirando frotte di uomini di tutte le età, che rimanevano incantati a guardarle come dei bambini davanti ad un negozio di trenini elettrici. Ed ovviamente, io non ero da meno . A Milano quindi non riuscii a concludere granché. A parte poi, l’aver visto questi spettacoli ameni, aver studiato la razza milanesis velocipides in tutte le sue sfumature, aver visto Marco Maccarini, ai tempi noto Veejay di MTV, correre lungo il Corso Vittorio Emanuele, vestito con una vera camicia di forza, inseguito da torme di ragazzini. E un’altra volta ho partecipato come comparsa-pubblico ad una sparatoria in una fiction di genere tragicopoliziesco (penso però che non sia mai stata trasmessa) con Romina Mondello che vestiva i panni di una poliziotta moribonda. 40 C’era tanto di regista romanaccio– un clichè - che dava i ciack e poi diceva ‘Bòna la prima’ (penso riferendosi più alla Mondello, verso la quale non nascondeva il suo interesse, piuttosto che alla scena appena girata) e che sfotteva l’attore protagonista nella scena in cui lei era stata sparata ed era sanguinante e distesa in terra ed il suo collega le doveva praticare un massaggio cardiaco, col risultato di sembrare più un maniaco palpeggiatore che un soccorritore. Insomma, Milano mi sembrò un grande luna-park a cielo aperto, popolato da gente un po’ schizzata, delle più diverse tipologie ma tutte interessanti ed a modo loro divertenti, dove le signore snob di Via Montenapoleone giudicavano le borse griffate di Louis Vuitton come ‘volgavi’ e le fotomodelle dall’aspetto tanto da sogno sulle copertine delle riviste, apparivano incredibilmente magre e malaticce se viste da vicino, all’ingresso dei casting e dove un ragazzo africano che ti aveva fermato in strada per chiederti dei soldi in cambio di un libro, vedendo la tua faccia spaesata e chiedendoti della tua storia, era capace – lui sfuggito alla fame del suo paese - di darti una pacca sulla spalla, cercando di consolarti e augurarti di trovare presto anche tu un lavoro. Un posto dove era difficile annoiarsi, anche perché nessuno – tranne me – aveva il tempo per farlo. Decisi, non avendo più avuto nessun altro appuntamento per dei colloqui, di aver più che abusato dell’ospitalità del mio buon amico e che la mia esperienza come aspirante pubblicitario milanese poteva dirsi conclusa. Tra il bicchiere mezzo pieno del primo colloquio e quello sfondato del secondo, la depressione che mi affliggeva in quel momento, mi fece propendere per la seconda ipotesi. Tornato a casa mi arresi alle pressioni dei tanti che mi dicevano che dovevo cercare un lavoro consono col mio percorso di studi e quindi iniziai a cercare altrove. Ripartii con la solita spedizione di curricula a pioggia… Chili e chili di lettere e di mail inviati verso chiunque avesse un Srl o Spa accanto all’intestazione. 41 Capitolo 6.1 La lezione che ne ho tratto. In pubblicità come negli altri tipi di azienda, in Italia, vige una rigida divisione dei compiti. Come ho spiegato precedentemente, i due ruoli di Art Director e Copywriter sono rigidamente distinti e solo raramente si può assistere ad un’inversione dei ruoli. Qualche volta soltanto lo si fa per migliorare l’affiatamento nella coppia creativa, per migliorare l’empatia e la collaborazione o come sfida perché chi non è estremamente specializzato, talvolta, può portare idee che escono fuori dai soliti binari. E la creatività è o dovrebbe essere appunto, scovare e percorrere sentieri mai battuti prima anziché, come ormai si fa troppo spesso, sbattere il prodotto come contorno ad un’allusione sessuale o al corpo di una bellissima modella/attrice. Nella realtà dei fatti italiana quindi, il processo creativo risulta essere molto standardizzato e codificato e, di conseguenza, molto poco creativo in senso stretto. La mia figura professionale, risultando fuori dagli schemi (non avevo studiato a Milano né almeno a Roma, non avevo un attestato di creatività rilasciato da una scuola di pubblicità riconosciuta ed anzi, avevo alle spalle studi economici, considerati dai più, l’antitesi della creatività; avevo un’età che per gli standard risultava troppo elevata; provenivo da una zona ritenuta provinciale; non vantavo studi o esperienze all’estero) non poteva neanche essere presa in considerazione né analizzata meglio o ancora, messa alla prova sul campo. Magari questi signori avranno avuto ragione, magari sarei stato un fallimento. Ma non hanno avuto il tempo neanche di pensarci: io non ero il candidato ideale, almeno valutandomi secondo un errore statistico standard…quindi, perché perdere tempo? Tuttavia, anche Einstein – si dice - fu bocciato una volta in fisica. Kant scrisse la sua Critica della ragion pura quando era ormai cinquantenne. Con questo non voglio dire che io sia Einstein o Kant (!) ma che, nel sistema di valutazione italiano, non c’è la capacità di comprendere se chi si trova di fronte ad un valutatore sia, a dispetto dei numeri, un possibile Einstein. Ed è anche per questo – sottolineo anche – che molti veri cervelli fuggono all’estero, dove queste capacità di comprendere i veri talenti, esistono e sono incentivate. Anche per questa ragione, il mondo dell’impresa italiano naviga e talvolta affoga, nella trista certezza della propria mediocrità standardizzata. 42 Capitolo 7 La software house pirata. Tornato a Napoli, passarono ancora altri mesi neri, di vuoto assoluto, di silenzio alle mie richieste per un colloquio di lavoro. Finì anche l’anno 2000, quello del millenium bug e ci avviammo verso il 2001, l’anno delle Torri Gemelle. Verso gennaio finalmente ricevetti una risposta: la posizione richiesta era presso una piccola software-house, sub-sub appaltatrice di una grande banca. Cercavano dei candidati per delle posizioni marketing e di consulenza alle procedure informatiche. Da ragazzino come detto, ero appassionato di computer ed avevo imparato a programmare in linguaggio Basic. Questo mi fece superare il primo colloquio e poi anche un secondo: mi dissero che forse potevo interessargli per una posizione nel marketing presso un’altra azienda loro consociata che aveva sede a Roma e per la quale si erano incaricati di svolgere le selezioni. Iniziarono settimane e mesi di telefonate, di colloqui, di rinvii. Poi un giorno, finalmente, il capo delle risorse umane mi volle rivedere: mi disse che gli ero sembrato una persona valida, adatta alle loro esigenze e che avevano sì disponibile una posizione a me congeniale, nel marketing, ma nel mentre si aspettava l’ok da Roma, potevo nel frattempo iniziare a collaborare con un’altra loro consociata, sub-sub-sub appaltatrice della banca, che aveva bisogno di figure a cavallo tra l’economista ed il programmatore. Insomma ci voleva uno che, anche se non era il Bill-Gates partenopeo, capisse qualcosa di programmazione e supervisionasse la trasformazione delle formule di matematica finanziaria in algoritmi. Accettai e firmai un contrattino per uno stage che sarebbe durato tre mesi, sempre in attesa che poi la consociata di Roma mi chiamasse. Era il periodo del passaggio verso l’euro e all’epoca, c’era molto lavoro da svolgere per il processo detto di eurizzazione che consisteva nel trasformare ogni riga di programma che avesse un richiamo alla Lira nell’equivalente formula: 1 Euro = 1936,27 Lire. In più c’era la questione dei centesimi che non erano presenti per i valori in Lire: ogni ‘campo’ numerico, cioè ogni valore in Lire, doveva essere trasformato nel formato xxx,00. Ho scritto talmente tante volte quella cifra che, penso, devo essere l’unico italiano (insieme con Romano Prodi) a ricordarne l’esatta equivalenza. L’ufficio era nei locali una volta appartenuti alla sezione informatica della banca. L’azienda appaltatrice, nostra signora datrice di lavoro, era situata ai piani alti; noi subsbuappaltatori, al piano interrato. Considerando la Banca una nave da crociera, noi stavamo sotto la sala macchine. Iniziai, ironia della sorte e dopo un anno di nera disoccupazione, proprio il primo di agosto mentre tutti gli altri andavano al mare. Faceva caldissimo e alla fermata dell’autobus di mattino presto c’ero solo io e qualche sparuta colf o badante dell’est. 43 I colleghi dell’appaltatrice ci guardavano senza vederci, neanche fossimo degli scarafaggi. Il mio team era composto da giovanissimi e la mia diretta responsabile era una strana ragazzotta, sulla trentina, con i capelli ricci e le ascelle non depilate e cespugliose in perfetto stile anni ’70. Notai la cosa con disappunto perché era estate e lei portava solo lunghi abiti fiorati con le spalle scoperte e le spalline a giromanica… Non riuscivo a guardarla! Gli altri due colleghi erano i due classici veri e propri nerd ma anche due ragazzi molto gentili e disponibili, niente affatto ostili nei miei confronti, anche se ero la matricola del gruppo. La mia boss, che aveva il simpatico difetto di pronuncia che a Napoli si definisce ‘zeppola’, ovvevo la evve al posto della evve, come avrebbe detto Totò, mi assegnava i miei compitini quotidiani e mi spiegava un po’ come funzionava il lavoro. Le mie competenze erano in realtà perlopiù superflue ed il mio lavoro, paragonabile a quello di un operaio in una catena di montaggio, solo che al posto di martellare, stringere bulloni ed avvitare, consisteva nello scrivere e controllare lunghe stringhe di testo e numeri elaborati da altri. Mentre il mio team era composto da persone simpatiche ed il mio supervisore, un uomo a metà tra il programmatore ed il contadino (produceva dell’ottimo vino bianco nelle sue vigne) cercava di mettermi a mio agio col nuovo lavoro, quelli ai piani alti erano davvero insopportabili. A metà agosto il mio team andò in ferie ed io, con sommo dispiacere, venni mandato lì dove c’erano i dirigenti, e mi dovetti sistemare accanto alla scrivania del mio diretto capo, il produttore di vino. Un giorno irruppe il capo dei capi, infuriato da avere la bava alla bocca ed indicando me – neanche fossi stato invisibile – con la faccia minacciosa che ha la scimmia cattiva che vive nell’armadio di Chris Griffin, urlando al mio superiore che nessuno l’aveva avvisato della presenza di estranei nei suoi uffici. Il capo-contadino che era uno flemmatico, scrollò le spalle e gli disse che era tutto regolare e che lui avrebbe dovuto saperlo. La scimmia cattiva se ne andò senza neanche badare al fatto che io, magari, potevo sentirmi un po’ a disagio e che avessi provato ad interloquire con lui per presentarmi. Il capo liquidò il mio spavento con un tranquillizzante “Nun ce fa caso, chillo è tutto str..z!”. Passò il mese di agosto tutto sommato serenamente ed io iniziavo a capire un po’ più quello che facevo ogni giorno. Iniziai pure ad imparare un altro linguaggio di programmazione (il Cobol) e fra un lavoretto ed un altro, nei momenti di pausa, cercavo di testare le procedure che nel frattempo stavo apprendendo. Era divertente quando vedevi che quella serie di numeri e parole magiche, si trasformava in qualcosa che avesse un senso e funzionava davvero! Ma finito agosto, il mese di settembre, a parte le temperature ancora alte, era iniziato con più di una doccia fredda. Nella mia vita privata: la ragazza che avevo conosciuto per caso quell’estate partecipando ad una mailing list di amici viaggiatori e con la quale avevo passato molto tempo a scambiare mail prima e poi lunghe telefonate, si era dimostrata una volta conosciuta dal vivo… essere una tipa alquanto stranina. Pur avendo preso lei (diciamo) l’iniziativa - aveva trovato il mio numero di cellulare nel mio sitocurriculum, dove c’erano mie foto e tutti i dati personali e mi aveva chiamato una sera– finita l’estate sembrò aver cambiato idea al punto da dimostrarsi addirittura infastidita dal mio interessamento nei suoi confronti. Non c’è altra scuola se non la vita che ti insegni a comprendere il complicatissimo linguaggio di una donna. Lingua che, solo apparentemente, è fatta delle stesse 44 parole di quelle che compongono quella di un uomo, ma con sfumature tutte da percepire (noi uomini siamo ancora dei Tv a valvole in bianco e nero, le donne invece sono dei Tv ad altissima risoluzione ed in 3D, giusto per esemplificare ). E quella volta lì, ebbi una bella lezione che poi mi è servita in futuro. Insomma, in quei giorni avevamo appena litigato e lei non voleva più saperne di me. Ci rimasi parecchio male, anche perché ancora non ero esperto in relazioni virtuali e nelle personalità borderline che abbondantemente popolano il web (nonostante l’aspetto fosse in questo caso, molto più che gradevole!). Allo stesso tempo, la banca aveva deciso di operare dei tagli sui lavori esterni ed a sua volta l’azienda che ne aveva l’appalto, aveva deciso di tagliare i suoi sub-fornitori: la mia aziendina. Noi eravamo l’ultima ruota del carro e fummo estromessi. Io ero l’ultima ruota dell’ultima ruota del carro ed il mio contrattino non venne più rinnovato. Il lavoro nel marketing con l’azienda collegata di Roma poi, si era nel frattempo perso nel nulla, anche perché a quanto pareva, c’era stata una rottura tra i responsabili risorse umane delle due società e quello col quale avevo sostenuto il colloquio inizialmente, si era trasferito altrove. Ricordo benissimo quell’11 settembre. La collega dall’ascella boscosa ricevette una telefonata dal marito. Visto che eravamo tutti insieme nello stesso stanzone, ascoltammo anche noi la conversazione: - Ma che stai dicendo? Hanno spavato a Bush? Hanno attaccato la Casa Bianca? I tevvovisti avabi? Un aeveo sulle tovvi? Migliaia di movti? GC, uno dei due colleghi, sentendo di quelle notizie apocalittiche, collegò subito e di straforo il suo modem a 56k al doppino del telefono - cosa che peraltro pur essendo tassativamente vietata, faceva comunque ogni giorno dopo pranzo - e cercò notizie più precise nel web. Da un sito di news che allora andava per la maggiore, apprese dell’attentato, degli aerei contro le torri gemelle, degli incendi, della gente disperata che si lanciava dalle finestre, degli altri attentati, ma anche che non avevano spavato al presidente con, lo devo ammettere, un po’ di rammarico da parte nostra... Tornando a casa, sentivo le persone che commentavano le notizie per strada. Nell’autobus due anziani signori si raccontavano del crollo delle torri. Pensai: le solite esagerazioni del passa-parola! Ad una macchina scoppia un pneumatico per esempio, va a sbattere contro un paletto e per il passaparola la storia diventa che c’è stata un’esplosione, una sparatoria e decine di morti. Ed invece no, quella volta le voci di strada avevano ragione: tornando a casa trovai mia madre davanti alla tivù e vidi il filmato che andava in loop, degli aerei che si schiantavano e delle torri che crollavano come dei castelli di carte. Una vera tragedia. Ma nel mio cuore ce n’era pure un’altra: nel mentre si leggevano le concitate notizie, ci arrivò la telefonata del nostro capo: l’indomani si doveva abbandonare l’ufficio, andare nella sede centrale per avere nuove destinazioni, il team era sciolto. 45 Io ero in scadenza di contratto e non avevo alcunché verso cui essere destinato. Capii che anche quel lavoro era naufragato nel nulla. Mi tennero sul filo ancora fino a dicembre, dicendomi che c’era un’altra missione per me, nel Veneto. Accettai un trasferimento nonostante la distanza, mi fecero preparare la valigia dicendomi che la cosa era imminente. Passò una settimana, due, tre, quattro, sempre col bagaglio pronto ed il cuore a pezzettini. Ogni settimana mi dicevano che la partenza era sicura per quella successiva. La quinta settimana chiamai il responsabile del personale e gli dissi che avevo capito l’antifona. Disfeci la valigia. Dovevo, come sempre, ripartire da zero e dall’invio di quegli ormai odiati CV. 46 Capitolo 7.1 La lezione che ne ho tratto. Cosa possiamo dedurre da quest’episodio? Una grande azienda delle dimensioni di una banca, affida delle lavorazioni che sono prevalentemente una tantum in appalto. L’azienda che ne prende l’appalto a sua volta, non potendo gestire l’enorme mole di lavoro, lo affida ad una serie di sub-sub appaltatrici. La catena di comunicazioni diventa un Himalaya di incomprensioni! Il supercapo che mi fece la sparata e mi trattò in modo tutt’altro che umano, era indispettito dal fatto che nessuno lo avesse avvisato. In realtà lo era stato ma per la mole di comunicazioni che ogni giorno riceveva e doveva gestire, non se ne era neanche accorto. Sui suoi metodi poco urbani sorvoliamo, non è questo il punto. Un altro punto nodale da analizzare in questo caso è la risposta italiana alla domanda di flessibilità. Propria di altri Paesi avanzati, la flessibilità per noi, si è tradotta solo nella precarizzazione del lavoro, con annessa riduzione della qualità e della produttività. Si scaricano gli imprevisti tipici di una produzione sugli anelli più deboli della catena che sono stati prima esternalizzati, in modo che l’azienda principale non ne abbia alcun influsso negativo quando occorreranno dei tagli. Molto spesso le banche sono dei pachidermi occupazionali dove buona parte delle risorse umane, sono assunte, diciamo, con criteri poco trasparenti. Fatte le dovute eccezioni, ovviamente. Ecco che quindi diventa difficile eliminare la parte di inefficienza presente al proprio interno e si preferisce delegare altrove il problema. Si esternalizzano quelle produzioni più soggette alla stagionalità e le si affidano ad imprese che si basano proprio sulla precarietà, in modo che non ci siano problemi di alcuna sorta con sindacati e quant’altro. Laddove non c’è alcun diritto, si può agire come meglio si crede. La piccola Cina che è dentro il nostro paese, è più vicina – come recita l’antico adagio – di quanto si crede. 47 Capitolo 8 La ri-masterizzazione. Se Parigi avesse lu mere, sarebbe una piccola Beri. (Proverbio pugliese) Quando sei disoccupato (e mi viene in mente la canzone di Masini disperato, praticamente uguale), gli altri gli occupati, si sentono un po’ tutti dei maestri che, a loro modo, cercano di insegnarti come fare per trovare un lavoro. Tutti, partendo da tua madre, fratelli e sorelle, cognati, cugini, amici e conoscenti ed affini sino ad arrivare al garagista, si sentono in grado ed in dovere di farti delle ramanzine e di darti dei consigli assumendo peraltro uno sguardo ed un tono di malcelato e saccente rimprovero. Se sei disoccupato è certamente colpa tua (questo soprattutto prima che la crisi mondiale si palesasse e che questo status di paria sociale diventasse tanto diffuso) Qualcosa in te non va. Ma tu non provi a cercare… E perché tu non compri i giornali… Ci stanno tante offerte di lavoro… Il problema è che ti sei laureato tardi… Il problema è che il tuo voto di laurea non è eccellente… Il problema è che ti aspetti di trovare un lavoro sotto casa… Ma che ti aspetti di fare? Forse tu pretendi troppo!… Etc. etc. La più frequente di tutte però era: Tu non trovi lavoro perché quella in economia e commercio è una laurea che sì, ti apre le porte a tutte le opportunità, ma proprio perché è così generica che alla fine te le chiude. Se non sei specializzato…. Devi avere un Master in qualcosa, ecco cosa devi fare! Facile a dirsi: per un master buono servivano soldi e tanti. Convertendo i costi di allora in euro, più o meno servivano dai 10mila in su. E se accanto al titolo del master, c’era il nome di una prestigiosa facoltà, si parlava di cifre doppie o triple. Altrimenti…rischiavi solo la fregatura. Ero disperato, non sapevo dove sbattere la testa. Il calendario scorreva inesorabile ed io diventavo sempre più vecchio, con poche esperienze e con un voto di laurea non esaltante. A gennaio del 2002 decisi che non ne potevo più di quell’attesa inutile. Nessuno rispondeva neanche più per dirmi che non poteva momentaneamente avvalersi della mia collaborazione. Nessuno mi teneva più presente. Ero iscritto a tutti i principali motori di ricerca lavorativa su internet e mi arrivavano offerte soltanto per lavori manuali e/o con specializzazioni assurde: operaio specializzato in saldature di componenti metallici punzonati con la tecnica della saldatura Samurai; operatori PLC-Comma 2, seconda traversa venendo da sinistra; Analisti Programmatori in SAP-SWAP-R27-C31 con comprovata esperienza presso l’MIT, la NASA o l’accademia di programmazione drammatica di Torvaianica e simili; oppure richiedevano lauree in ingegneria paragnostica con specializzazioni pluriennali conseguite almeno presso tre diverse organizzazioni governative segrete. Quelle che adoravo di più erano quelle offerte dove – pur conoscendo il mio sesso e dimostrando tutta l’ intelligenza del motore di ricerca - mi proponevano una candidatura come Segretaria… Non 48 che volessi fare lo snob, ma penso che il denaro che avrei speso per le cerette sarebbe stato di gran lunga superiore a quello ricevuto come stipendio. E se poi il capo m’avesse chiesto di fermarmi per uno…straordinario? No, certamente non faceva per me. Se poi gli annunci erano attinenti al mio percorso di studi e più o meno mi piacevano per le mansioni ed il settore, richiedevano che il candidato avesse già almeno 5 anni di lavoro qualificato alle spalle ed in posizione analoga! E chi me la faceva fare quell’esperienza se nessuno scommetteva su di me? Tra le tante, mi arrivò anche l’offerta per un master: proveniva da un ignoto centro studi pugliese che sbandierava presunti traguardi formativi raggiunti e si fregiava della collaborazione di banche ed aziende di medio livello che avrebbero garantito uno stage in azienda. Il costo era abbordabile, a patto di investire i miei pochi risparmi. Ma ormai, non avevo altre chance. Sembrava l’occasione buona per ottenere l’ennesimo pezzo di carta unito con l’esperienza lavorativa che altrimenti sembrava che nessuno volesse farmi fare. Se consideriamo poi che il titolo del master comprendeva sia il Management bancario (e tutti mi dicevano continuamente che dovevo lavorare in banca) che la comunicazione finanziaria e la parola comunicazione mi suonava tanto bene, pensai, forse questa è la volta buona per dare una svolta alla mia vita. Inviai un curriculum e pochi giorni dopo, mentre ero appena uscito dal supermercato ed ero carico di buste della spesa, mi arrivò una telefonata: Dottor P.? Salve, questo è il Centro Studi, lei è stato selezionato per il Master ed ha vinto una borsa di studio. E’ contento? La signorina al telefono spiegò come-cosa-dove-quando ed io non riuscivo a credere che, finalmente, qualcuno mi avesse selezionato per qualcosa e non solo, mi avesse elargito addirittura una borsa di studio! Beata ingenuità! Quelle parole vennero dette a tutti i candidati che erano niente più, niente meno, che tutti quei boccaloni che, come me, avevano fatto domanda. La borsa di studio era ovviamente lo specchietto per le allodole. Alla fine avremmo pagato per lavorare gratis! Ma questo non potevamo ancora saperlo. Il master si articolava in una parte d’aula della durata di un mese, con alloggio presso un villaggio turistico sito in provincia di Bari, sul mare, ed una parte di stage in azienda della durata di 5 mesi, da stabilire poi, secondo le proprie capacità e le richieste delle aziende partner. Le aziende partner erano due: una banca pugliese ed un’agenzia di comunicazione finanziaria di Milano. La prima offriva svariati posti, la seconda solo due! Mi preparai per la partenza, feci la solita valigia che ormai tenevo sempre a portata di mano, anche se ora mi ero procurato un trolley molto più comodo e pratico rispetto al primo. Arrivai dopo non so quante ore di viaggio e svariati treni e rischiando anche di morire, visto che quel gran cornuto di un capostazione di una stazione di scalo intermedio, diede l’ordine di partire all’Eurostar mentre stavo ancora salendo e le porte mi incastrarono per metà dentro, ma per la restante metà ancora fuori. Fortuna che almeno avevo tutti e due i piedi sullo scalino e che due passeggeri, due angeli custodi senza ali né piume, mi tirarono dentro a viva forza! Dopo queste peripezie ed un viaggio lungo e scomodo (l’Eurostar in teoria era considerato un treno da clientela vip ma su quello, modello anteguerra, c’era addirittura un clandestino senza fissa dimora e dall’odore impossibile, che chiedeva l’elemosina e gironzolava in maniera sospetta accanto al portabagagli!)arrivai finalmente nella piccola stazioncina del paesino sul mare della provincia di Bari. Quelli dell’albergo ovviamente, nonostante la mia telefonata del giorno prima, avevano sfacciatamente dimenticato di venirmi a prendere alla stazione. Dopo un’ora di attesa li richiamai dal telefono a gettoni della stazione, dove attendevo in compagnia del vento che soffiava gelido (era l’inizio di febbraio) e di un altro clochard che vagava in tondo e parlava da solo inseguendo il volo dei piccioni, anch’esso circolare. 49 I piccioni e quell’atmosfera surreale tipica della desolazione di un paesino di vacanze in pieno inverno, mi fecero sentire come il protagonista di un film di John Woo. Dopo un’altra mezz’ora di attesa, comparve un monovolume Mercedes verde, un po’ malconcio e con le insegne del villaggio turistico. Era guidato da un tipo che, per stile di guida, doveva essere un lontano parente di Jarno Trulli, il noto pilota pugliese di Formula Uno… O forse di Villeneuve padre, buonanima! Scivolando e sballottando da un lato all’altro dell’ampio sedile, durante il tragitto non potei non notare che il tachimetro non scese mai sotto i 170 km/h ed il tutto in strade poco più che urbane. Arrivammo finalmente al residence sul mare e venni scaricato insieme al bagaglio con i capelli ormai alla Don King, striature bianche comprese! Feci il check-in nella hall dell’albergo che era contiguo al residence (e lì il primo inganno, perché l’albergo era un 4 Stelle mentre il Residence… svariate stalle!) e mi condussero verso il bungalow dove – scoprii - ero ospitato al pianterreno insieme ad altri tre ragazzi ed una colonia di blatte molto ben nutrite che, probabilmente, erano lì per seguire un altro master di non so quale tipo. Al piano di sopra invece, ci sarebbero state le donne, ben 6 ragazze tutte insieme nella stessa casa! Non immaginate il casino! Al corso eravamo iscritti in più di 30, ma noi fuorisede eravamo in 10 per bungalow. Per la maggior parte ragazzi pugliesi ma di altre provincie rispetto a Bari; 5 campani di cui 2 napoletani (io e la sosia di Mascia del GF, all’epoca molto popolare) ed un romano de’ Roma, un pugile dilettante nonché neodottore in economia, il più amato dalle donne del corso, nonostante la sua bassa statura ed il suo accento davvero teribbbile. Dal punto di vista sociale quel corso fu uno spasso: praticamente vivemmo un’esperienza simile alle prime edizioni de ‘Il Grande Fratello’ ma senza un copione scritto ed un tono più da aspiranti bancari che da professionisti di Cinecittà. Avremmo potuto chiamarlo ‘Il Grande Sportello’ e farci i soldi con un format originale da vendere! Nacquero in quelle settimane anche infinite e complicatissime storie sentimentali tra i vari partecipanti del corso, ognuno dei quali si era lasciato a casa un’altra storia, quella diciamo ufficiale. Come si direbbe dalle mie parti, ci stavano più corna lì intorno che dentro a na sporta e maruzze (una cesta di lumache N.d.S) Tralascio di narrare anche delle mie vicende sentimentali durante quei mesi, perché questo è un para-trattato autobiografico di semi-organizzazione aziendale e non una riedizione in chiave economica (nel senso, del poco valore) de I dolori del giovane Werther… Il buongiorno si vide dal mattino: il primo giorno di scuola, eravamo tutti seduti nell’aula conferenze del residence quando il brusìo venne interrotto dall’ingresso di alcune persone. Prese il microfono il Dr. Sòla (così ribattezzammo l’organizzatore) che schiarendosi la voce, sentenziò: Salve a tutti, benvenuti… Bla bla bla... Siete qui per formarvi, ma noi non vi garantiamo di certo il lavoro. Quello ve lo dovrete guadagnare voi, se e quando. Del resto, se lo avessimo fatto, questo corso sarebbe costato parecchie volte di più. Brusìo in aula… Volarono parole grosse ed epiteti che avevano desinenze perlopiù in –onzo..… e in –erda. Finito l’intervento di Sòla, prese la parola l’Eminentissimo et Reverendissimo Super megadirettore Generale della banca partner che esordì con un: Moooooooòguagliò!!!! – era praticamente un Cassano, anziano ed in giacca e cravatta – Voi mòsit’ tutt’ ciucc’ (Asini N.d.S.) ma noi qua vi insegnèm com si lavor in bènc… Ma non è più quello che voi speràt… Una volt, il lavòr in bènc era un bel lavòr… Si guadagnav un sacc di sold… L’uscieeeeere quando andèv in pensiò, aveva una buonuscit che si comprava due cas’, figur’tlu’ direttor? Ma mò la musec’ è cambièt, lu’ direttore a stento si permette l’affitt’ de la ches’… L’uscièrnun ce stà più… Mò ci sit’ voi… Che fate lusteig e sit tutt’ ciùcc! – per ribadire il concetto. 50 Ed in quell’attimo mi comparve la visione del mitico Albanese nella persona di Frengo, noto commentatore sportivo foggiano che con la croce sulle spalle, passava lentamente da una parte all’altra dell’aula dicendomi con un sorriso canzonatorio: ‘Frensis, ti hanno incaprettato? Ti hanno fatto male-male?’ e poi se ne andava ridacchiando con la testa che ciondolava. In estrema sintesi: raccontandoci in uno stretto dialetto barese che ho riprodotto in maniera maccheronica (ma il Moooò e il sittuttciucc erano proprio quelli!) la sua verità e cioè che il lavoro in banca non era più quello ambito di una volta, il megadirettore ci aveva tolto anche l’ultima speranza. Se prima avevamo dei sospetti, dopo quella presentazione prendemmo atto che quel corso era una presa per i fondelli: imparammo ben poco, non fummo ascoltati per quelle che erano le nostre ambizioni (io volevo lo stage nell’agenzia di comunicazione, ma per motivi che ora tralascio, vennero preferite altre due candidate) e ci ritrovammo alla fine senza alcun vantaggio rispetto alla partenza. Fu anche però una piacevole presa per i fornelli, visto che l’alloggio era garantito per il primo mese, ma non il vitto. Il residence aveva un tristorante (la versione più triste di un ristorante) con una convenzione particolare per gli studenti: caffè a 2,50 euro e digiuno completo a 25. Optammo quindi per le cucine dei bungalow e i più coraggiosi come me, si improvvisarono cuochi, scarrafoni a parte. Ovviamente essendo ragazzi perlopiù alla prima esperienza fuori casa (io almeno, avevo fatto un anno di servizio civile ed ero il nonno del gruppo per età ed esperienza) trasformammo presto quella che sarebbe dovuta essere un’occasione di studio e di crescita professionale, in una sorta di happening all’insegna del sex, love and rock-roll (le drugs non c’erano ma l’alcol scorreva copioso) ma anche in gustoso consesso eno-gastronomico. Le ragazze del piano di sopra adottarono noi quattro ragazzi e iniziarono a coccolarci preparandoci cenette luculliane ogni sera. Le meno dotate dal punto di vista culinario, si facevano perdonare portandosi da casa, al ritorno dal weekend, i manicaretti preparati dalle mamme. Bè, i più fortunati ebbero anche di più in fatto di attenzioni, ma non ero tra quelli e mi dovetti accontentare di lasagne e altre pietanze regionali. Il corso che era partito in modo quasi tragico, finì sempre più in burla (oramai nell’ultima decina di lezioni, ogni giorno c’era un relatore diverso e sempre più deprimente ed insulso e quindi la nostra attenzione scemò totalmente), la mia destinazione fu presso la filiale della banca situata in un’amena ma tranquilla cittadina situata alle porte di Bari. Sapevo che in Puglia ci sono dei paesini col nome tanto strano quanto simile: Bitonto, Bitritto, Bitetto e Binetto, ma fino ad allora non avevo mai neanche lontanamente immaginato di poterci finire per lavoro. Quando il Dott. Sòla mi comunicò la destinazione, mi cadde la solita tegola in testa: ero destinato ad andare proprio in quella zona! Ci fu una pausa tra il corso teorico e lo stage che serviva – in quel periodo cadeva la pausa pasquale – per permetterci di trovare un alloggio. Provai prima a cercarlo da solo, ma a distanza era quasi impossibile. Alla fine, risentendomi con i compagni del corso con i quali avevo condiviso per un mese il bungalow, decisi che era meglio prendere un alloggio insieme a loro e trovammo un appartamento nel centro di Bari nei pressi della zona universitaria. Bari è una città che non ha saputo incantarmi minimamente. La zona antica è gradevole, ristrutturata com’è da poco. Ma ha un che di artificiale. Il lungomare poi, è un po’ triste e anonimo. I baresi li ho trovati – almeno quelli con cui ho avuto contatti, mi auguro di essere stato un po’ sfortunato – molto arroganti e presi di sé, poco inclini a concederti l’ amicizia e molto prevenuti verso i napoletani, molto più dei Toscani. Nel paesino di provincia invece, c’era gente molto più semplice e più alla mano. Parlavano un 51 dialetto davvero incomprensibile, una sorta di codice fiscale, ma erano più aperti ed estroversi. I clienti vip della banca mi apprezzarono subito e furono amichevoli al punto che ricevetti pure offerte di alloggio quasi gratuito, ma purtroppo avevo già dovuto pagare in anticipo per la casa di Bari. In banca c’erano il direttore, due signore molto gentili e due colleghi maschi. Mi accolsero con grande cordialità e il direttore si affezionò presto a me. Era una persona davvero gentile, un vero e proprio galantuomo, molto più del suo superiore che aveva tenuto la prima ora di lezione in aula. Le giornate passavano claustrofobiche al chiuso di quella piccola filiale. La noia la faceva da padrona. Le mattinate iniziavano con una lunga fila di pensionati vocianti e dal dialetto incomprensibile che mi insultavano (senza che però, me ne rendessi conto più di tanto vista l’osticità della loro parlata) perché mi vedevano lì, in giacca e cravatta, in piedi dietro le casse, senza fare un beneamato nulla, non sapendo che non solo non ero pagato per stare lì, ma che mi era pure proibito di fare alcunché. Occupavo il mio tempo scrivendo lettere di recupero crediti per conto del Direttore o contando le banconote che riempivano i sacchi di denaro da far ritirare dai corrieri. Non ho mai visto tanto denaro come in quel periodo! Per fortuna però, oltre ai tanti contadini e commercianti, ogni mattina ricevevo anche la gradita visita della giocattolaia. Era una assidua cliente, figlia venticinquenne di imprenditori del giocattolo che avevano un ingrosso ed una rivendita al dettaglio nel paesino e che veniva a depositare gli assegni incassati e controllare il tasso di cambio del dollaro canadese. La nonna era stata una migrante e percepiva come tanti lì in paese, una pensione in quella valuta. Qualche volta entrava simulando una improbabile rapina armata di tagliacarte (ci dimostrò così che era possibile passare attraverso il metal detector armati)) e scambiando una chiacchiera e una battuta con me, mi portava almeno un raggio di sole in giornate altrimenti grigissime. Purtroppo per me però, era superfidanzatissima, in procinto di sposarsi e quindi… ci si doveva fermare ai reciproci grandi sorrisi. Il direttore della filiale come detto, mi apprezzava al punto che un giorno, verso la fine dello stage, mi chiese: cosa posso fare per farti assumere qui in banca? Mi piacerebbe che tu venissi a lavorare da noi! Apprezzai molto quell’attestato di stima, anche se fu del tutto ininfluente sulle politiche della banca. Figuriamoci, se non lo sapeva lui come fare ad aiutarmi… Purtroppo non poté davvero fare nulla. Iniziai lo stage molto motivato, nonostante gli oscuri presagi del corso, impegnandomi e cercando di apprendere il più possibile Ma ben presto, dai nostri inviati nell’ufficio del personale (gli altri stagisti), iniziò a circolare la notizia che la banca stava facendo delle selezioni per delle assunzioni e che addirittura avrebbe aperto una filiale a Napoli, ma non aveva nessuna intenzione di assorbire noi stagisti, anzi. C’erano già dei candidati esterni di sicura prossima assunzione. In sostanza lo statuto della banca proibiva che all’interno di essa lavorassero i figli dei dipendenti. Ed allora le due banche principali della regione, che cosa avevano escogitato? Ciascuna delle due faceva assumere all’altra i figli dei rispettivi dipendenti. Pratico, pulito, senza rischi. Così fecero. Molto probabilmente gli stage avevano una doppia valenza: sicuramente attiravano fondi europei e statali per la formazione e poi, cosa non da poco, noi costituivamo una manodopera qualificata che non solo era a costo zero, ma addirittura pagante, il che aiutava notevolmente a ridurre i costi del personale ed a migliorare l’immagine esterna della banca. Trenta candidati dell’edizione del master cui ho partecipato io, più di trenta in quella precedente, totale, più di 60 ragazzi formati ma una sola candidata assunta. Casualmente, suo padre era anche un imprenditore nonché socio della banca rivale-alleata, rispetto alla nostra. 52 Quando si dice i casi della vita. Gli altri assunti invece, erano figli dei dipendenti/dirigenti dell’altra banca, cui, immagino, corrispondessero altrettanti figli dei dipendenti/dirigenti della nostra, assunti dall’altra banca. Finito lo stage, me ne tornai a casa a Napoli. Avevo fatto un’esperienza lavorativa a mie spese in tutti i sensi, ma ancora non avevo concluso nulla di concreto. Si ripartiva, per l’ennesima volta, da zero. Le mie tragedie lavorative per una strana e curiosa coincidenza del destino, sono poi spesso coincise anche con altro tipo di tragedie personali. In quei mesi di stage era iniziata e finita anche una storia d’amore che avevo erroneamente ritenuto davvero importante. Ed il fatto che dopo tutto, non solo non ero diventato il manager di una banca, ma neanche un semplice assunto come forse si sperava, probabilmente ne aveva significato il vero motivo per la sua fine. La dolce ragazza dal cuore di pietra e travestita da candida colomba, mi liquidò sentenziando che lei non voleva stare con un uomo senza un futuro. La ringrazio ancora per quelle pessime parole, perché in quel momento mi si strappò in mille pezzi, la mia camicia di Hulk. Finirono in terra in cocci, gli occhiali dell’eterno Clark Kent e finalmente capii che era ora di dare una svolta alla mia vita. Dissi basta! Basta fare sempre e soltanto il Fantozzi, qui è ora di diventare verdi e cacciare i muscoli come un bravo, incazzatissimo Hulk!!! La cosa non fu così immediata però. Passò del tempo prima che mi potessi riprendere da quell’1-2 da knock-out, ma poi iniziò da quel momento, un altro capitolo della mia vita. Ed un altro capitolo di questo libro seguirà a breve. 53 Capitolo 9 Meglio un malanno vicino che un promotore finanziario per cugino! I più di questi laureati a Harvard non valgono un cazzo. Serve gente povera, furba e affamata. Senza sentimenti. Una volta vinci e una volta perdi; ma continui a combattere. E se vuoi un amico, prenditi un cane. (Gordon Gekko) Chi è più giovane forse, non ricorderà cos’era il “gioco dell’oca”. In sintesi era un antico gioco da tavolo in cui due concorrenti dovevano far percorrere a due segnalini (due ochette, da cui il nome del gioco) un tragitto a spirale composto da caselle disegnate su di una tabellone di cartoncino. Passando di casella in casella e percorrendole a seconda del punteggio ottenuto col lancio di un dado, dalla casella partenza si arrivava sino a quella di arrivo. Alcune caselle avevano dei bonus, altre delle penalità. La peggiore e la più temuta era “Ritorna alla partenza e salta un turno”. Quando ti capitava quella, il tuo destino era segnato: avevi quasi sicuramente perso. Quella casella mi è capitato di attraversarla numerose volte nella vita. Tornato dal master, era l’estate del 2002, ripartivo quindi per l’ennesima volta dalla “partenza”. Lasciato dalla ragazza dopo un’estenuante tira e molla protrattosi fino a novembre, con un Master senza sbocchi e un’età ormai poco appetibile per gli head-hunter, cioè i cacciatori di risorse umane (che definiti così, rende bene l’idea di che razza di alieni malvagi e disumani siano) ero davvero sull’orlo del tracollo psicologico. Non sapevo più dove sbattere la testa! Iniziai per un po’ a collaborare con il mio nuovo cognato – la mia sorella maggiore di recente divorziata, aveva trovato un nuovo compagno - un agente di commercio di successo che si offrì di darmi una mano per ripartire. Partecipai con lui ad un paio di fiere nelle quali esponevano le sue aziende (settori dell’oggettistica e del gadget) e mi diede i primi rudimenti di quell’arte che per me era allora del tutto aliena, e cioè quella della vendita. Ricorderete, appena due anni prima, avevo risposto al direttore creativo della nota agenzia milanese che “Io non sarò mai un venditore”… ed invece è proprio vero, mai dire mai! Quell’esperienza però si concluse prestissimo: non avevo per niente il senso dell’orientamento, sia in auto che nelle trattative commerciali e quando dovevo andare da un potenziale cliente in un’altra provincia, per me era uno stress disumano. I navigatori GPS erano già stati inventati ma a quei tempi era una tecnologia ancora costosissima, certo non alla portata del mio portafogli. Avevo poi un’auto poco propensa ai lunghi spostamenti, una Fiat Uno di terza mano che ad ogni frenata, mi regalava brividi ed emozioni di cui volevo possibilmente fare a meno. E poi ero davvero poco convincente come venditore e riuscivo a concludere ben poco. Restava poi da dire che non mi ero ancora rassegnato al fatto di gettare nel bidone dell’immondizia, quel foglio formato A3 di pessima stampa che rispondeva al nome di “Certificato di Laurea” e sognavo ancora, in chissà quale modo, di trovare un impiego che potessi ritenere degno di esso. Per l’ennesima volta rielaborai il mio curriculum, stampai tonnellate di fogli e di lettere di 54 accompagnamento al cui solo pensiero, mi viene la nausea, e rifeci l’ennesima spedizione a pioggia a tutte le banche i cui indirizzi avevo trovato sulle pagine gialle online. Andai anche in qualche agenzia interinale e sostenni un paio di colloqui, tanto quelle non li negavano a nessuno, almeno in quegli anni. Mi arrivarono le solite 3 o 4 risposte su 100, ovviamente di gentile diniego. Una in particolare, aveva un tono molto seccato, mi diceva che non dovevo più permettermi di inviare CV di mia iniziativa perché il loro istituto assumeva solo previo concorso pubblico di cui avrei letto sulla Gazzetta Ufficiale. Mi rispose persino la BEI (Banca Europea di Investimento), cui in un disperato e folle tentativo, avevo spedito il curriculum… Cortese lettera di risposta scritta in Francese e proveniente da Bruxelless, anche se io il CV l’avevo mandato nella sede romana ed in Italiano. L’unica a darmi una chance, fu una grande banca-assicurazione che cercava promotori finanziari. Quella del promotore finanziario era una strada che, come per quella del venditore, avevo giurato e spergiurato di non voler percorrere mai. In sostanza, per chi non lo sapesse, il PF è un consulente, un libero professionista che lavorando su mandato di una banca, consiglia ai propri clienti – almeno in linea teorica – il migliore assett finanziario tarato sugli interessi e sui bisogno degli stessi. Il PF non percepisce quasi mai uno stipendio, ma come un agente di commercio, vive delle provvigioni (in sostanza una percentuale) ottenute sui nuovi investimenti effettuati dai suoi clienti più una (risibile) percentuale sull’ammontare dei capitali da lui gestiti. In linea teorica è una professione del tutto rispettabile, con una certa dignità ed un certo fascino se svolta con professionalità. Negli anni ’80 e ’90 era anche una professione molto ambita e che garantiva un tenore di vita altissimo, tanto che molti funzionari di banca, si licenziavano dal proprio posto fisso per diventare dei PF. La realtà negli anni 2000 invece, soprattutto per chi intraprendeva quella strada senza avere alle spalle un portafoglio clienti già preconfezionato (famiglia ricca, amici influenti, etc) era totalmente diversa. Studiai davvero tantissimo per superare gli esami di abilitazione alla professione. C’erano praticamente condensati, i programmi di 8-9 materie d’esame che avevo studiato ad Economia, più qualche altra che non era nel mio piano di studi, il tutto concentrato in una prova scritta ed orale. Io allora avevo un po’ perso l’allenamento allo studio, erano passati ormai degli anni dall’ultimo esame sostenuto e non ero più abituato a quei ritmi ed a quel tipo di stress. La selezione era severissima: molti candidati che facevano gli esami con me erano al loro quinto, sesto tentativo. Ma vuoi perché lo studio mi aveva aiutato a non pensare ed a buttare giù i rospi sentimentali e lavorativi, vuoi perché… Insomma, com’è che si dice, mi aiutò la fortuna del principiante, senza trascurare il fatto che la paura appartiene solo a chi ha qualcosa da perdere ed io non avevo più nulla da temere in quel senso, fatto sta che passai gli esami al primo tentativo, nonostante la trascurabile circostanza che dei 700 candidati iscritti alla prima prova - i test scritti - ricevemmo poi l’abilitazione soltanto in 42 alla seconda, finale prova orale! Dopo quell’exploit uno si aspetta il red carpet, bottiglie di champagne stappate, flash e stuoli di donne acclamanti, nonché una carriera fulgida e piena di soddisfazioni che si apprestava a spalancarsi. Ti aspetti un Gordon Gekko che, scortato dalla giovane Deryl Hannah, ti prospetta un mondo crudele ma dorato tra le torri di Wall Street. Ma la realtà fu un’altra. Ci fu solo un particolare che mi fece per un momento sperare che le cose, per quella volta, potevano andare diversamente. A presenziare gli esami finali, nel pubblico, c’era anche una coppia: un uomo sulla cinquantina, toscano e la sua giovane assistente, una donna avvenente che serviva col suo sorriso e la sua 55 presenza, ad attirare l’attenzione, molto labile, di chi superava quello scoglio. I due mi fermarono e mi si presentarono come due cacciatori di teste di una nota bancaassicurazione, rivale rispetto a quella con la quale mi ero preparato e per la quale mi apprestavo a firmare un contratto. Giusto perché nella vita non si sa mai ed anche perché insistettero tantissimo dicendo che avevano assistito al mio esame e li avevo colpiti particolarmente, mi fermai ad ascoltarli. Mi dissero che ero una persona molto brillante, uno che sapeva superare le situazioni di stress con un aplomb davvero invidiabile e che loro mi volevano a tutti i costi nella loro struttura, sicché mi invitarono a sostenere un colloquio. Non ero di certo abituato ad essere adulato e corteggiato da un’azienda e pur essendo cosciente del fatto che molte delle loro moine erano pura scena, li lasciai fare e gli diedi i miei recapiti. Da allora iniziò nei miei confronti una sorta di corteggiamento come solo uno stalker hollywoodiano potrebbe sostenere nei confronti di una superdiva. Mi sentii per un po’ anche io un “superdivo” e accettai di andare ad un colloquio, seppure col fermo proposito di rifiutare la loro offerta. Era fine luglio, mi apprestavo a partire per le vacanze con destinazione Barcellona e Costa Blanca, faceva caldissimo ed avevo poca voglia di impegnarmi. Ero già ormai mentalmente legato all’altra banca anche se avevano temporeggiato con la firma del contratto e la cosa non mi piaceva tanto. Andai al colloquio quindi, raggiunsi l’indirizzo che mi avevano fornito. Era la SIM (Società di Intermediazione Mobiliare NdS.) di un’altra banca-assicurazione che si trovava nei pressi del lungomare. Tutto sudato visto che erano le 15 di un giorno di fine luglio, mi fermai un attimo sotto all’imponente portone del signorile palazzo per cercare di riprendere un po’ il fiato, anche se a quell’ora non spirava un alito di vento e provai a ridarmi un certo contegno. Nonostante fossi deciso a rifiutare le eventuali offerte, era pur sempre un colloquio di lavoro. In quella uscì il portinaio che mi chiese in stretto napoletano: “Che r’è dottò, non vi sentite bene?” Lo rassicurai che avevo solo caldo e gli chiesi come fare per raggiungere l’ufficio della banca. Salii sino al terzo piano in un ascensore di quelli a vista, ricavato in un momento successivo alla costruzione dell’antico palazzo, nell’ampia tromba delle scale. Ad accogliermi alla porta, venne l’assistente del cacciatore toscano. Mi fecero accomodare nella sala dove il responsabile di area aveva il suo grande ufficio. Venni accolto da una piacevole sensazione di frescura: ogni grande stanza, aveva il suo condizionatore che funzionava a pieno regime. Il cacciatore di teste mi presentò al suo collega, che era il capo di quell’ufficio e iniziò il colloquio. Mi offrirono poco di più in termini economici ma qualcosa di diverso rispetto ai concorrenti con cui già stavo per firmare, considerando la cosa in prospettiva. Sarei stato, anziché uno dei tanti in una grande struttura consolidata, uno dei pochi componenti scelti in un team di PF d’élite di una struttura totalmente nuova, seppure con alle spalle un’assicurazione storica che faceva da specchietto per una potenziale clientela e che si era trasformata da poco anche in una banca. Avrei avuto pochi colleghi (solo 4 o 5) dei quali io sarei stato l’unico neofita, e tutti giovani ma affermati PF con portafogli (nominali) davvero incredibili! (un collega vantava un portafoglio clienti di 40 milioni di euro, anche se poi riuscì a tirarne dentro si e no 3 o 4). Ci aggiunsero poi una postazione di lavoro tutta per me (dall’altra parte non avrei avuto nulla) con telefono, pc ed internet e la possibilità di ricevere i miei clienti in un grande salone per le riunioni. L’atmosfera sembrava poi simpatica e meno ingessata dell’altra, accettai firmando come un incosciente, un contratto di cui non capivo ancora bene i termini. Mi offrirono un “fisso mensile” per un periodo di tempo di 2 anni, periodo ed importo che si riducevano a seconda del raggiungimento o meno di un obiettivo che in quel momento, non sapevo valutare: quattrocentomila euro. Quel fisso era però in realtà un anticipo provigionale: tradotto in termini concreti, la banca mi 56 concedeva un tot al mese in cambio del raggiungimento di un obiettivo. Mancandolo, non solo non avrei più percepito quel benefit in futuro, ma sarei risultato debitore di quanto anticipato. Un vero contratto capestro, anche se non lo sapevo in quel momento. L’impatto inziale fu qualcosa di terribile. Il capo ufficio che era un dipendente della banca e non un libero professionista come tutti gli altri, mi fece una brevissima formazione dicendomi: si fa così e così, si telefona così e così, prendi il telefono, chiama, fissa un appuntamento con chi vuoi tu e poi vediamo! Nel frattempo mi diede dei manuali da studiare, uno col regolamento aziendale ed uno con tutte le schede finanziarie dei prodotti. Ma la cosa più tragica fu imparare a telefonare dei perfetti sconosciuti per chiedere loro un appuntamento. Ricordo con sgomento quei momenti: per ogni dieci telefonate che facevo, con relativi e più o meno espliciti “vaffa”, dovevo prendermi una mezz’ora di pausa per ricaricarmi le energie. Le risposte erano ovviamente, quasi tutte negative ma pian piano imparai un po’ a dominare la conversazione e a non balbettare più frasi incomprensibili. Il mio metodo per trovare dei numeri di telefono era infallibile: al tempo ero coadiuvato da uno strumento che ora, per motivi di privacy, non esiste più. Un noto sito internet, dato un indirizzo ed un numero civico, ti dava tutto l’elenco degli abbonati corrispondenti. In questo modo potevo telefonare alle persone di quel quartiere dove risiedeva la banca e che si presumevano – visti i costi delle abitazioni - “benestanti” (nella zona nei pressi degli alberghi del lungomare, case ed affitti hanno prezzi vertiginosi) e li invitavo all’inaugurazione dei nostri uffici. Fu un’inaugurazione che feci durare quasi un anno, ma più o meno, il metodo funzionava, qualche appuntamento riuscii ad ottenerlo. Il problema grosso era che in quei mesi, parliamo del 2003, erano scoppiati come bombe a grappolo, una serie di scandali finanziari che avevano ridotto molti risparmiatori, non diciamo in mutande ma quasi. Si susseguirono la crisi dei bond Argentini, lo scandalo Cirio seguito a breve da quello Parmalat. Il Paese era ormai già in recessione, anche se non se ne parlava granché volentieri nei telegiornali, ed i rendimenti di borsa erano perlopiù altalenanti con tendenza al negativo. C’era quindi un forte scetticismo nei confronti della mia ‘specie’ e, detto proprio in modo chiaro, non si batteva un chiodo! Anche i miei colleghi si trovarono in difficoltà quando si trattò di far trasferire gli impegni dei propri clienti dalle precedenti società d’intermediazione verso la nostra e quando ci riuscivano, i clienti sottoscrivevano soltanto i prodotti meno redditizi per banca e PF. Io però ispiravo una certa fiducia nelle persone, con la mia faccia da bravo ragazzo. Qualcuno quindi venne a trovarmi in ufficio e poi mi invitò a fargli visita nella propria abitazione. Ma la maggior parte delle persone mi usava, questo è proprio il termine giusto, per farsi fare una consulenza finanziaria gratuita e per verificare quanto consigliato dalla propria banca o dal proprio PF della concorrenza. Ma al momento di concludere e passare poi alla mia gestione, se ne uscivano col classico “ci devo pensare” oppure “appena posso”, etc. Era una situazione davvero frustrante. Pur essendo discretamente bravo nel mio lavoro, anche perché nel frattempo avevo partecipato a degli interessanti corsi di formazione tenutisi a Milano, i risultati non venivano. Conoscevo i prodotti alla perfezione e davo anche consigli ai miei colleghi che, se da una parte erano dei grandi venditori, come consulenti non erano proprio il massimo. In realtà, il loro grande insegnamento fu proprio questo: per com’è strutturata la realtà italiana della professione, non conta tanto la capacità nel consigliare l’investimento, quanto – per sopravvivere – la capacità di vendere e fregare il cliente facendo, per quanto possibile, ricadere le colpe della propria mala gestione, su circostanze esterne o sulla banca. Ma c’era anche A., un collega davvero capace ed onesto che mi insegnò il valore del rispetto del 57 cliente. Il suo successo – era uno che non aveva mai raggiunto risultati strepitosi, ma aveva un portafogli di tutto rispetto ed un contratto blindato che gli garantiva un reddito più che dignitoso – l’aveva costruito su questo principio ed i suoi clienti, seppur non guadagnassero grosse cifre, erano però sicuri dei suoi consigli e del fatto che lui faceva di tutto per tutelarli anche a discapito di quanto invece gli imponeva la banca. Di suo invece, come filosofia ed approccio al cliente, la banca mandante cercava di espropriare il PF dei propri clienti, vincolandoli a sé con sistemi di disincentivo al disinvestimentoe costringendo poi i PF a vendere, per sbarcare il lunario, i prodotti finanziari più costosi ed inaffidabili. Anche quest’esperienza mi è stata molto utile per capire come i principi della buona organizzazione aziendale, siano disattesi totalmente in Italia. Quella delle SIM (le società di intermediazione mobiliare, in genere banche o banche-assicurazioni) è soprattutto una organizzazione gerarchica-piramidale. Esiste una direzione commerciale nazionale cui sono sottoposti area manager divisi per competenze territoriali e macroregionali cui sono sottoposti, a loro volta, degli area manager regionali, tutti presi con contratto a tempo determinato e pagati sui risultati. Da essi dipendono manager di livello via via decrescente (Group, Team, etc) sino al semplice PF. In quella banca vigeva invece la confusione più totale! Vi era al vertice, subito sotto l’Amministratore Delegato, un Direttore Commerciale a contratto cui seguivano nella piramide, tre manager macroregionali. Il mio, quello del colloquio, che era denominato come “Responsabile Commerciale Area Centro Sud” (lo chiamerò col terribile acronimo di RCACS d’ora in poi, così impara! ) era un dipendente a tempo indeterminato della banca cui però era sottoposto un Area Manager che invece, essendo a contratto, si sentiva indipendente dal suo superiore e sottoposto solo alle direttive del Direttore Commerciale e si dichiarava apertamente fedele solo al suo mandato. Per questo motivo i conflitti anche aspri tra i due, erano quotidiani. A questo si aggiungeva il fatto che io ero stato reclutato dal RCACS e non dall’AM e quindi ero alle dipendenze dirette del primo e la cosa, una sorta di parallelismo interno alla struttura che di fatto mi rendeva più autonomo dei colleghi, faceva imbufalire l’AM anche perché – in caso di mio exploit professionale – lui non c’avrebbe guadagnato neanche un centesimo. Perché caratteristica principale della struttura piramidale è che ogni manager percepisce un fee (ecco la milanesite che ritorna!) cioè una percentuale su quanto prodotto dai suoi sottoposti. Questo mi causò un leggero mobbing o perculamento continuato da parte dell’AM che non perdeva occasione per lanciarmi una frecciatina in qualunque frangente, come una volta che ebbi l’ardire di indossare scarpe nere e cintura di cuoio e non sapevo che il bon-ton invece lo vieta tassativamente. Quando l’RCACS si decise finalmente ad inserirmi nella piramide dell’AM, il mobbing d’incanto cessò, al punto che l’AM, in maniera per me del tutto inattesa, prese addirittura a trattarmi da vecchio amicone! (non potrò mai dimenticare gli insegnamenti sull’utilizzo smodato di una sana ipocrisia ricevuti dai miei colleghi, mi saranno per sempre di un’utilità infinita). Dopo un po’ però imparai a conoscerlo meglio ed a capire che non era poi così male come poteva sembrare a pelle. L’unica era di non mettersi mai sulla sua strada, questa era una condizione necessaria e sufficiente per averlo sempre al tuo fianco come un vero amico. Se gli ostacolavi la strada però, dovevi essere pronto ad affrontare qualunque circostanza, perché lui era un tipo davvero combattivo, che passava il tempo più che a lavorare, nello studiare cause da proporre contro questo o contro quello, preparandosi già per tempo, all’inevitabile contenzioso che gli avrebbe fatto la banca per il mancato raggiungimento dei suoi obiettivi (diciamo che in quella sede, gli obiettivi erano qualcosa di davvero relativo). Da questa frizione con l’RCACS e da altre circostanze, nacque una lunga guerra interna che durò 58 circa un anno ed una lotta di potere davvero estenuante per me che invece avrei voluto un ambiente più tranquillo per fare il mio lavoro. L’ AM non voleva cedere a certe pressioni da parte del RCACS. Le pressioni consistevano in sostanza - su direttiva del direttore commerciale – in uno scavalcamento delle competenze dell’AM, affinché i suoi PF facessero sottoscrivere ai propri clienti prodotti più rischiosi e quindi più redditizi per la banca. Per una sorta di dispetto, la direzione commerciale su consiglio del RCACS, creò la figura del “Divisional Manager” e venne chiamato ad aggiungersi all’allegra brigata, un altro supervisore, un figuro davvero triste. Il nostro era un esercito – come diceva sempre il mio amico A. – fatto solo da generali e dove non c’erano soldati da mandare in battaglia, quelli che poi, avrebbero dovuto portare la vera ricchezza all’interno della banca. Un Divisional Manager per definizione, stona parecchio in un’azienda organizzata secondo il modello funzionale e non secondo quello divisionale. Senza tirarla troppo per le lunghe e senza andare troppo in complicati tecnicismi, la struttura detta divisionale è propria piuttosto di un’azienda diversificata, che agisce su mercati ed in settori distinti e distanti tra di loro ed è organizzata con delle divisioni interne che hanno autonomia decisionale. La banca invece aveva una struttura basata sulla classica piramide che andava dal Faraone, il Direttore Commerciale, sin giù agli schiavi, i PF. Nel mentre accadeva tutto ciò e si creavano risse e baruffe in quello sparuto gruppo di uomini che avrebbe dovuto essere – almeno nominalmente – composto da dei professionisti, io continuavo la mia ricerca telefonica di clienti per riuscire a raggiungere quel benedetto budget (nel frattempo la banca mi aveva tagliato i viveri ma i costi per la professione erano altissimi, visto che mi dovevo pagare praticamente tutto, più le annuali tasse di iscrizione all’albo, il commercialista e i contributi INPS che ammontavano a più di 2.400 euro l’anno!). In uno dei soliti pomeriggi di telefonate in cerca di clienti, mi rispose un uomo anziano. Anziché mandarmi a quel paese in modo più o meno garbato come la maggior parte delle persone che contattavo, mi disse che era interessatissimo a conoscere me e la mia azienda e che si trovava proprio in procinto di dover fare un consistente investimento e che quindi, cercava nuove opportunità rispetto alle sue solite conoscenze. Mi invitò al volo a casa sua per un colloquio. Avvisai il mio capo e noncurante del fatto che poteva trattarsi di uno scherzo o di un serial killer (ma che al massimo, avrebbe solo messo fine alle mie pene professionali una volta e per sempre!) andai a casa sua. Abitava a poche decine di metri dal mio ufficio, in un lussuosissimo appartamento all’ultimo piano di un edificio che affacciava sul mare. L’interno del suo appartamento, a dispetto del lusso esterno e della cubatura (un ingresso enorme che dava su un salone ancora più grande) sembrava fermo nel tempo. Una moquette malconcia in terra dall’improbabile colore verde muffa, pareti ricoperte da quello che sembrava un rivestimento plastico marrone, in uso negli anni ’60 o ’70, un arredamento che non era né di pregio né d’epoca ma solo vecchio e malridotto, con un’illuminazione più cimiteriale che abitativa. Alla luce fioca della sua scrivania, mi accolse – come avevo intuito dalla voce - un anziano signore che mi si presentò come un docente universitario a riposo, già primario di non so quale nosocomio con non so quante specializzazioni. Mi fece letteralmente il terzo grado, chiedendomi persino che lavoro svolgessero i miei avi. Poi chiamò la moglie ed il figlio, prossimo notaio (almeno a suo dire) che si fecero ripetere tutto da capo. Dopo una mezz’ora di chiacchierata (leggasi: interrogatorio) e dopo avermi chiesto di esibirgli l’attestato di iscrizione all’albo e richiesto per la volta successiva il certificato di laurea, licenziata moglie e figlio, si sbottonò e mi raccontò la sua storia finanziaria e dei suoi ingenti capitali personali. 59 In sostanza quest’uomo che non accendeva la luce finché non era buio pesto, non offriva mai un caffè (e sono stato a casa sua svariate volte in seguito) e soprattutto, non aveva mai cambiato l’arredamento né riverniciato le pareti in cinquant’anni, possedeva solo di liquidità– esclusi quindi terreni ed immobili - qualcosa come 8 milioni di euro, la metà dei quali sul conto della zucca e l’altra metà in una polizza assicurativa che gli rendeva poco e nulla e che era in scadenza! Dapprima pensai che mi stesse prendendo in giro, ma quando mi mostrò la documentazione, mi sentii mancare. Poteva essere la svolta! Il mio capo drizzò le orecchie quando sentì il mio racconto e si diede da fare affinché riuscissi a tirare dentro la nostra barca, quella grossa balena che avrebbe potuto salvare non solo le mie sorti, ma addirittura quelle dell’intera filiale. La sua richiesta era chiara: una polizza assicurativa con un rendimento garantito annuo del 3,5%, perché quella che aveva già gli rendeva il 3. Non entro in particolari tecnici, non vi tedio con la lungaggine della trattativa che durò mesi. Non vi dico quante volte andai a casa sua, cercando di fargli credere che il nostro prodotto fosse il migliore. In quel momento poi ebbi la prova tangibile di quanto fosse assurda un’organizzazione piramidale nell’anno 2003! C’erano le mail, i telefonini che facevano le prime videochiamate, ma per avere un’informazione dalla direzione o ottenere un prodotto tagliato su misura per un cliente eccezionale, mi dovevo scontrare ancora con le gerarchie, le gelosie e le competenze a compartimenti stagni di dipendenti stipendiati, la cui vita era scandita dal timbrare di un cartellino e a cui poco interessavano le sorti della mia carriera che, invece, si basava solo su risultati concreti. Ricordo una volta uno dei dirigenti dell’ufficio che gestiva le polizze oltre un certo importo, che rispose piccato perché gli avevo sollecitato direttamente una risposta che non arrivava mai, rivolgendomi direttamente a lui e senza ripercorrere per l’ennesima volta tutta la scala gerarchica della banca. Anziché rispondermi e magari fare il suo dovere, scrisse al mio capo che mi girò la mail in copia “Chi è questo qui che si permette di scrivermi direttamente?” gli disse. E lui gli rispose “quello che sta cercando di portare 8 milioni nella banca ma che sembrano non interessarvi!”. Un’assurdità. E poi i vertici si domandavano perché la loro SIM era sempre agli ultimi posti nelle classifiche di raccolta. Il fatto più eclatante fu poi che, grazie all’attenta analisi del mio contratto da parte dell’AM, scoprii di essere stato truffato dalla mia stessa banca. Non solo il problema degli anticipi e quindi di quella forma di indebitamento, ma anche che nel mio contratto, si faceva esplicita (quanto a prima vista invisibile ed incomprensibile) esclusione delle polizze assicurative ai fini del raggiungimento del budget e quindi del premio di raccolta che mi spettava. Seppure avessi portato gli 8 milioni nella banca, non ci avrei guadagnato che poche centinaia di euro, mentre per i prodotti finanziari, il premio per la raccolta che era dell’1%, mi avrebbe fatto guadagnare 80.000 euro! E la responsabilità di gestire una somma così ingente, credetemi, ti toglie il sonno e la salute! Ed io che avevo perso ore e diottrie in quella casa buia, cercando di convincere il professore, poi sua moglie, poi suo figlio, poi tutti e tre insieme e quasi c’ero riuscito e che sognavo quella cifra che per me era davvero un sogno, e di comprarmici magari una macchinetta un po’ più vistosa rispetto alla mia Fiat Uno, con cui sentirmi finalmente ripagato di tutte le lacrime ed il sudore versati in quegli anni e poter fare finalmente il gesto padano del dito medio a chi mi aveva deluso e spezzato il cuore!Quando realizzai che genere di “pacco” mi avevano tirato,mi sentii sprofondare il mondo sotto i piedi e mi arresi. Decisi che quella professione davvero non faceva per me: mi ero fatto gabbare nel peggiore dei modi; avevo firmato un contratto senza comprendere quello che c’era scritto, mi ero speso anima 60 e corpo per far pubblicità ad un’azienda che aveva cercato di fregare me ed i clienti. La fenice era di nuovo ridotta in cenere. 61 Capitolo 10 La mia banca è differente. L’arrivo del Divisional Mànnaggger aveva segnato la fine di un’epoca per il mio team. Prima del suo arrivo, nonostante i continui litigi tra capi e colleghi, ad ora di pranzo si trovava sempre la pace come in una grande famiglia. Certe volte, mentre ero lì al telefono cercando di convincere qualcuno a farmi andare a proporgli i nostri prodotti, sentivo provenire dalle altre stanze dei rumori inquietanti: urla, fragore di oggetti scagliati contro le pareti, porte sbattute e dopo poco invece, risate, abbracci e riappacificazioni rumorose celebrate dall’arrivo dei caffè dal bar. A pranzo poi ci si ritrovava tutti in sala riunioni e si trascorreva un’oretta insieme: io mangiavo le mie mele od il panino con il prosciutto di tacchino (ero single ed in periodo salutista, cercavo di tenermi in linea); l’AM si faceva consegnare la sua solita bella pizza, profumata ed appetitosa; P.l’uomo da 40 milioni di euro e la sua fida collega, si preparavano mega panini o mega insalatone giganti annaffiate da bottiglioni di Coca Cola; A. invece, un panino che sua moglie gli aveva preparato da casa od anche nulla. Quella era anche l’occasione di un confronto: tra uno scherzo e l’altro, una battuta ed un commento serio, si parlava della situazione economica e finanziaria e ci si aggiornava sui prodotti della banca. L’arrivo del Divisional segnò la fine di tutto questo. Era un uomo molto all’antica, sui sessant’anni portati tutto sommato bene, fisico asciutto e longilineo ma dall’antipatia e la superbia davvero incredibili. Il suo primo atto da lider màximo fu quello di vietarci i pranzi in ufficio. Nonostante l’ufficio fosse molto grande, non c’era una stanza esclusiva per lui e la cosa mise soprattutto inquietudine nell’AM. Iniziò a capire che c’era qualcuno di troppo e siccome l’RCACS non aveva mai nascosto la sua antipatia nei suoi confronti, la situazione cominciò a farsi pesante per lui. Il DM si appropriò della sala riunioni e girò l’enorme tavolo (lungo almeno 3 metri per 1,5) utilizzandolo come una scrivania, questo a dimostrazione della sua megalomania. Iniziò il terrore: riunioni su riunioni, convocazioni di noi PF per paternali infinite, urla come prima ma non seguite da riappacificazioni. Si comprese ben presto che tirava un’aria irrespirabile. Chiese conto ad ognuno dei risultati (non) ottenuti e minacciò per la revoca dei mandati per giusta causa. Si capì chiaramente che l’AM sarebbe stato la prima vittima da sacrificare visto che, per il suo fare un po’ strafottente e indolente, si era inviso la direzione. Con lui seguirono a ruota il collega dei 40 milioni di portafoglio dichiarati al momento del contratto ma dei quali la banca non vide neanche il 10% (pur percependo da contratto, la discreta sommetta di 10mila euro al mese per due anni!) e la sua fida scudiera, una collega che lo seguiva come un cagnolino e con la quale condivideva un credo religioso un po’ particolare che pare, li aiutasse molto negli affari. Io per il DM ero solo una pulce, gli davo fastidio solo in quanto “creatura” dell’AM e visto che voleva cancellare lui e la sua rete, mi chiese pressantemente di presentargli le dimissioni con un’insistenza che mi fece venire l’esaurimento nervoso. Per una circostanza che aveva ben poco di casuale poi, mi arrivò una bella raccomandata dalla 62 direzione – in quel periodo ne fioccarono parecchie ed ognuna segnava una testa che stava per cadere - che mi chiedeva conto degli anticipi provigionali ricevuti e dove mi si diceva di doverli restituire immediatamente, in un’unica soluzione, visto il mancato raggiungimento del mio target. A parte la truffa iniziale ad opera del RCACS, vista la mancanza di chiarezza sulla natura degli anticipi, la loro richiesta non aveva nessun fondamento. Non erano trascorsi i 2 anni previsti da contratto e mi erano stati addebitati come disinvestimenti, dei trasferimenti di portafogli da clienti che stavano già disinvestendo (quando un promotore cambia azienda, lascia il proprio portafogli, cioè i propri clienti con relativi investimenti, alla Sim mandante, ma spesso i clienti, dopo poco, disinvestono e lo seguono nella nuova Sim. Per un PF un disinvestimento è una grande iattura, perché gli crea un malus sugli obiettivi da raggiungere. E questa era una cosa che io non potevo sapere ma la direzione sì e probabilmente, la cosa era stata fatta ad arte e con malizia). Grazie all’intercessione dell’AM invece – che pure stava andando via in quei giorni – visto che il DM cercava un assistente e che io ero il più esperto ed il meno invischiato in quella catena di odi e rancori, ottenni il condono del mio debito e di essere preso come suo collaboratore. Il DM era uno di quei manager all’antica, abituati ad avere costantemente qualcuno che svolgesse, per conto suo, tutto il lavoro operativo. Non era un uomo tecnologico. Il pc sapeva a stento accenderlo, non sapeva neanche usare Word se non con estremi sforzi e le email preferiva farsele leggere e stampare per poi dettare una risposta o abbozzarne una a matita da far poi digitare a qualcun altro. Io ero quindi la sua nemesi ed il suo complemento: sapendo usare benissimo il pc, conoscendo i prodotti, essendo conosciuto e gradito dalla banca, ero perfetto per quel ruolo di assistente. Su insistenze sue e del RCACS, fui costretto a presentare le dimissioni da PF. Buttavo così a mare tutti i soldi ed il tempo spesi per diventarlo. Iniziò in quel momento, la mia “carriera” di assistente del Divisional Manager, ovvero un tutto-fare le cui mansioni andavano da quelle di centralinista-receptionist, che si occupava di facchinaggio e portierato, al segretariato del capo, sino alle più nobili di formatore di risorse umane e consulente direzionale. Un giorno, trascorsi ormai molti mesi dall’inizio della mia nuova veste, mi sono trovato persino con l’ingrato compito di dover fare dei colloqui di lavoro a quattro aspiranti promotori finanziari ed il tutto senza il minimo preavviso da parte del mio capo e ovviamente, nessuna preparazione a riguardo, se non la mia esperienza diretta in qualità di intervistato. Ci pensate? Io dall’altra parte della barricata che facevo delle domande– idiote come tutte quelle fatte durante i colloqui di lavoro – e che potevo finalmente concludere con un bel “le faremo sapere”. Non vi nascondo due circostanze: la prima era che nel mentre facevo le domande cercando di ricordare le tante ricevute in precedenza, mi scappava da ridere; la seconda è che a tutti e quattro i candidati, cercai in tutti i modi di far capire di dover desistere da quelle insane ambizioni perché avrebbero solo avuto da rimetterci entrando in quella gabbia di matti. Comunque, siccome la storia è ciclica, anche da questo nuovo lavoro ricevetti un’altra serie di belle fregature che si palesarono ben presto e partendo dalla mia retribuzione. Avevo chiesto come corrispettivo per il mio lavoro, una cifra ben precisa su consiglio dell’AM ed il DM si era dichiarato d’accordo. Anche perché la banca gli avrebbe rimborsato quel corrispettivo sotto forma di rimborso spese per l’ufficio. Era un bel modo per eludere la normativa sul lavoro, visto che con questo escamotage, io non risultavo quale dipendente della banca, pur svolgendone le mansioni e non potevo accampare nessun diritto in caso di un eventuale contenzioso. Questo lo dico per aprire gli occhi a chi dovesse pensare ancora che le imprese del nord Italia agiscono sempre e comunque in modo trasparente ed ossequioso delle regole, mentre quelle del 63 sud sono composte solo da briganti e da pirati! L’Italia purtroppo, sotto questo punto di vista è più unita di quanto non si pensi. Al momento della firma del contratto – con la formula a progetto per tre mesi, progetto peraltro inventato dal sottoscritto di sana pianta! – notai subito che la cifra che avevo richiesto, da netta era diventata lorda ed in più, c’era una inspiegabile decurtazione di 50 euro! Roba da morti di fame! Il DM si finse sorpreso e mi diede il numero della sua commercialista per poterla chiamare e chiederle chiarimenti. Lei in tutta franchezza mi disse: senta, non è un errore, il suo datore di lavoro mi ha chiesto espressamente di limarle quei 50 euro perché altrimenti non rientrava nel contributo che gli passa la sua banca. Che vuole fare? Rifiutare per 50 euro? Ovviamente, pur essendo io quello senza soldi visto che il grande donatore di lavoro era un milionario con tanto di villa con campi da tennis e piscina, dovetti fare –come si dice- il signore, rinunciando ai 50 euro. Non avevo altra scelta. Ero sempre nello stesso ufficio di quando ero un PF, ma ora lo vivevo in modo molto diverso. Non ero più un libero professionista senza un euro ma un semi-schiavo con un minimo di retribuzione ed ancora tante speranze, seppure inchiodato alla scrivania posta all’ingressino- una sorta di reception - ed ai rigidi orari d’ufficio. Quando ogni mattina mi ritrovavo in quell’ufficio, sentivo un forte senso di scoramento e di nausea. Mi sentivo con le spalle al muro: quell’uomo emanava viscidume da tutti i pori, sapevo che non potevo fidarmi di lui e che dovevo aspettarmi di tutto, ma non avevo altra scelta. La mia speranza però era di sfruttare l’occasione per dimostrare professionalità e bravura e farmi notare con i dirigenti della banca in funzione di un’assunzione diretta. Speravo e mi fu promesso, che un giorno sarei passato dal ruolo di co.co.pro. (collaboratore a progetto) a quello di dipendente effettivo, con tanto di stipendio (vero e non simbolico!), tredicesima, contributi e ferie pagate! Un piccolo sogno borghese. Presto divenni un perno indispensabile nella struttura: se c’era uno che sapeva far andare un riottoso fax, carezzare una antidiluviana fotocopiatrice per convincerla a fare altre 100 copie senza stancarsi, dialogare con la teleassistenza per rimettere in sesto pc pieni di virus, risolvere mille problemi ai colleghi che non si prendevano mai neanche la briga di leggersi le circolari e poi combinavano una caterva di guai per ogni contratto sottoscritto, se c’era uno che sapeva spiegare ai colleghi nuovi venuti in poche parole, cosa era giusto e cosa no, quali fondi erano i migliori per il cliente ed i più convenienti per lui, se c’era uno che riusciva ad ascoltare tutti senza mai dare segni di cedimento, se c’era uno che riusciva a trasformare i numeri disastrosi in risultati relativamente ottimistici e delle scialbe riunioni in presentazioni multimediali senza sbadiglio grazie alle mie slide in Power Point, quello ero io. Ma le mie mansioni non finivano certo qui: la moglie del capo per esempio. No, non pensate a male, malpensanti!!!! ;) Avete presente la versione femminile del noto gorilla, testimonial di un famoso bitter? Bè, lei! E non vi dico quando indossava la pelliccia di vero gorilla sintetico… Un vero spettacolo! Per lei io ero una sorta di maggiordomo e mi chiedeva le cose più improbabili. Per esempio, una volta le dovetti cercare dei fornitori di antifurti per la sua casa, o riparatori di lavabiancheria, e non si contavano le volte che aveva il pc suo o delle figlie pieno di virus ed a me toccava bonificarlo, etc. Per il marito – il DM- invece, mi occupavo oltre che delle mansioni ordinarie per il mio ruolo, anche di dipanare le difficili querelle che, immancabilmente, iniziava con le compagnie telefoniche, data la cattiva abitudine di sottoscrivere contratti senza sapere che i servizi accessori in promozione, prima o poi si pagavano. Sorvolerei poi sul fatto che la splendida coppia aveva due figlie, non del tutto male come persone – stranamente erano persino simpatiche nonostante i due esemplari che le avevano generate - non 64 fosse che erano delle ventenni semi-inette e che sempre al sottoscritto, toccava risolvere molti dei loro problemi quotidiani: una volta la scelta del master, l’altra la scrittura di una tesina o il curriculum, insomma… Dovevo fare il balio anche per loro. Una volta mi capitò persino di dover rintracciare il loro bagaglio smarrito in un aeroporto di non ricordo quale località turistica, il giorno prima che iniziassero le mie ferie! Nel frattempo il pater familias, aveva completato la sostituzione dei miei vecchi colleghi con altri – se vogliamo - persino più scalcagnati e indolenti e simulò per qualche tempo efficienza e competenza con i suoi mandanti, grazie alla presentazione di report che mi faceva taroccare per far diventare positivi anche i risultati più deprimenti. Solo il mio amico A. era riuscito a sopravvivergli: grazie alla sua flemma, ad un contratto blindato costruito a tavolino dalla sapienza del vecchio AM e soprattutto al fatto che non s’era fatto infinocchiare dalla banca ed aveva fatto sottoscrivere ai suoi clienti solo strumenti finanziari di un certo livello qualitativo, era sopravvissuto alle epurazioni di massa. E grazie a lui almeno, qualche chiacchierata decente ed un po’ di compagnia in ufficio, riuscivo ad averla. Il boss in tutto riuscì a reclutare una quindicina di persone, delle quali, poche erano realmente valide. In più, reclutò sua moglie, suo cognato ed una pletora di controfigure atte a confondere le acque e gettare un po’ di fumo negli occhi della direzione. A Napoli si definirebbe una tale accozzaglia di persone come l’esercito di Franceschiello – da Francesco II di Borbone – che, secondo la tradizione popolare, era solito ordinare ai suoi marinari di fare ammuina (confusione) per confondere il nemico e far credere di essere più numerosi di quanto in realtà si era realmente. Compresi ben presto che il suo ruolo in concreto consisteva esclusivamente nel conoscere persone insoddisfatte del proprio mandato in una SIM concorrente, cercando di attirarle nella nostra struttura che, peraltro, cercava di reclutare uomini ma pagando il meno possibile. Cosa che attirava ovviamente solo i più disperati ed i meno professionali, quei volti noti che le altre Sim non avrebbero preso neanche dietro pagamento, più avvezzi al piantar grane e fare cause di lavoro contro le società mandanti che ad andare a caccia di clienti e di investimenti. Per un po’ le cose sembrarono anche andare bene: spesso e volentieri veniva il direttore commerciale da Milano con la sua assistente ed in quei frangenti, dovevo prestare la mia opera anche per loro. Iniziarono quindi a conoscermi ed apprezzarmi ed io non nascosi il mio desiderio di essere, un giorno, trasferito finalmente lì, nella sede centrale di Milano. In quel periodo per una fortunata quanto imponderabile circostanza della mia vita – una delle poche – conobbi anche colei che sarebbe diventata la mia compagna di vita, Valeria. Le cose mi sembravano andare finalmente per il verso giusto, come meritato premio per tanta fatica e le tante vicissitudini passate. Lo stipendio era basso ma almeno era qualcosa, considerato il fatto che ero ancora un bamboccione (così come amabilmente, il Ministro Padoa Schioppa definì coloro che per forza di cose, erano costretti a vivere ancora con i genitori anche oltre l’impensabile età di 30 anni) e non avevo grosse spese. Potevo quindi finalmente permettermi un’auto “quasi” nuova e un po’ più potente e figa di quella vecchia e gloriosa Fiat Uno che avevo e, perché no, concedermi anche una vacanza con la mia lei. Poco dopo però, ai primi step di verifica dei risultati raggiunti, il bluff del DM cominciò ad essere chiaro e la direzione iniziò a tagliargli i viveri ed a far saltare le prime controfigure reclutate. Persone che dopo un anno di mandato, avevano ancora un vergognoso “0” al proprio attivo nella raccolta, mentre avevano comunque intascato dalla banca anticipi per 20-30 mila euro, grazie all’aver millantato portafogli milionari in sede di reclutamento e con il beneplacito dell’odiato reclutatore. Io che non ero stato proprio il più brillante dei PF per esempio e fui costretto alle dimissioni, potevo almeno vantare di non aver lasciato un simile disastro dietro le mie spalle. Mi domandavo con quale faccia, quei tizi avessero continuato ad incassare i propri anticipi… 65 Dato il disastro che si annunciava imminente, la Direzione ovviamente, decise di porre un freno alle spese folli di quell’ufficio (parliamo di 70.000 euro al semestre solo di costi vivi per la sede) la prima cosa ad essere tagliata, indovinate, fu proprio il contributo per l’assistente e cioè lo stipendio del sottoscritto. Scaduto anche il secondo contratto trimestrale a progetto, il DM decise di prender tempo e mi fece lavorare per un po’ a nero con una netta riduzione dello stipendio. Ovviamente nel frattempo cercavo anche altri lavori, ma non riuscii a trovare niente che non fosse peggio di quello che avevo già. In questo periodo ho fatto dei memorabili colloqui di cui magari, vi parlerò in seguito. Un giorno il capo ufficio, l’RCACS, che nel frattempo aveva preso ad odiare la sua stessa creatura – quel DM che aveva reclutato per fare dispetto all’odiato AM di allora e che presto si era rivelato come una scomoda presenza ed una sua pessima figura nei confronti della direzione della banca mi chiamò in disparte durante la pausa pranzo e mi invitò a prendere un caffè con lui. Al bar mi disse che il direttore commerciale aveva bisogno di un altro assistente e mi chiese se ero disposto a trasferirmi a Milano in cambio di un contratto a tempo indeterminato. Non potete immaginare la mia gioia! Il mio disegno finalmente si era realizzato e la strategia che avevo costruito con fatica sembrava finalmente essere andata a buon fine! Ero riuscito a dimostrare quanto valevo al punto di ricevere una richiesta diretta dall’uomo più potente della banca dopo l’Amministratore Delegato ed il Direttore Generale! E’ un po’ come quando quella bella ragazza dal fisico strepitoso e dagli occhi di ghiaccio che credete non sappia neanche della vostra esistenza, si avvicina a voi, vi sorride e vi chiede di uscire. Più o meno era questa la sensazione che provavo! Come se un lungo corteggiamento fosse finalmente arrivato al dunque ed ora dovevo solo coglierne i frutti. Ed i sacrifici ed il fiele ingerito accanto a quel pessimo uomo qual era il DM, sarebbero stati ripagati. Il RCACS mi disse che la settimana successiva sarebbero venuti Direttore Commerciale ed assistente e mi avrebbero sottoposto ad un colloquio: - stai tranquillo, è praticamente certo che ti vogliono. Mi hanno chiesto unicamente di te. Ed infatti così andò: il DirCom e la sua assistente in visita a Napoli, mi chiamarono ad un certo punto nella sala riunioni mi fecero un paio di domande e mi dissero di cosa avevano bisogno: - Allora, te la senti? Ci serve una persona di cui fidarci e su cui contare quando dobbiamo stare fuori e tu sembri proprio quello giusto. - Certo che sì! - Va bene, allora appena possibile, ti facciamo volare nella sede di Torino per un colloquio col Direttore del Personale, ma non ti preoccupare, è solo una formalità. Questa cosa al DM non andò giù. Non era importante per lui il fatto che il mio stipendio si fosse dimezzato a parità di ore di lavoro, lo considerò come un affronto. Ed iniziò il mobbing nei miei confronti. Intanto i colleghi iniziarono a gufarmi: eh, adesso beato te che te ne vai a Milano! I più gentili mi dissero che me lo meritavo, perché in quell’ufficio ero soltanto sprecato. Ma anche i commenti positivi, mi diedero parecchio su i nervi. E come se non bastasse, neanche se io avessi ricoperto il ruolo di assistente del General Manager della BCE, al fax ed alla mail del mio capo, iniziarono ad arrivare una pletora di curricula di candidati disparati e più disperati di me, alcuni dei quali dai toni anche esilaranti, che miravano al mio prestigiosissimo posto che di lì a poco, probabilmente, si sarebbe liberato. In quei giorni di metà estate, la faccia del DM era tornata quella odiosa degli inizi, senza più quella finta parvenza di sorrisi che mi rivolgeva. Per immaginarvelo, dovete pensare al Sig. Burns, il capo di Homer Simpson, proprietario della centrale nucleare. 66 Ed un giorno mise in tavola le sue carte: - Tu non hai capito su chi dovevi scommettere! Dovevi stare dalla parte mia, non della banca, attento a non bruciarti! Lo ringraziai per l’incoraggiamento, gli ricordai che lui aveva sempre saputo delle mie ambizioni e che il mio non era un tradimento ma una scelta obbligata, perché avere un contratto a tempo indeterminato da una Spa era ben altra cosa rispetto al nero ed alle sue promesse basate sul nulla. E poi magari, avere un suo uomo a contatto della direzione, era una circostanza che poteva andare anche a suo vantaggio. In quegli anni ne avevo già viste di tutti i colori ed avevo capito che il mobbing non è considerato come qualcosa di disdicevole in Italia, ma come un normale ed ordinario strumento di esercizio del potere e delle prerogative di un mànnaggger degno di questa definizione. Arrivò il giorno del colloquio e – come annunciato – presi il volo per Torino, almeno quello, a spese della banca. All’aeroporto di Torino per evitare di perdermi e di far tardi al colloquio, presi un taxi che mi costò la bellezza di 30 euro per un tragitto di circa un quarto d’ora, sino al centro. E poi dicono dei napoletani… Arrivai in centro nella prestigiosa ed antica sede dell’assicurazione-banca, con un po’ di anticipo. Ne approfittai per riprendere fiato e consumare un tonificante caffè al bar. Entrai nell’antica sede risorgimentale e mi presentai alla reception: avvisarono il Direttore del Personale (badate bene, non delle Risorse Umane, ma con la denominazione di inizio ‘900! E questo fu il primo triste indizio… Quella banca non considerava i suoi lavoratori come delle risorse, ma come dei dipendenti), tale Enricomaria Pierugo Mazzantiviendalmare (a parte la parodia fantozziana, il suo nome non era molto dissimile), torinese doc dal fisico di un grissino mal cotto, rispose che dovevo accomodarmi nel suo ufficio al piano di sopra dove mi avrebbe presto raggiunto. Mi fecero entrare in una grande stanza dove, al centro, c’era una sorta di scrivania quadrata, con i bordi spioventi e più sporgenti rispetto al piano del tavolo e mi indicarono la sedia dove sedermi. Davo le spalle alla porta, quindi lui mi piombò alle spalle d’improvviso, dopo avermi fatto fare una quarto d’ora di anticamera. Si presentò, mi fece riaccomodare, visto che io mi ero alzato per dargli la mano e mi allungò dei fogli dicendomi di scrivere il mio CV lì, al momento. Gli feci notare che oltre che averglielo già mandato – come indicato dal DirCom – a mezzo mail, ne avevo comunque delle copie nella mia 24 ore. Lui insistette col suo accento nasale torinese: - sa, non dica nulla ma è nostra abitudine che restino degli scritti dei nostri colloqui. Se per cortesia me lo riempie di nuovo… Ma va bene se lo fa a memoria… Non lo ricopi semplicemente! Dovetti ricordarmi tutto quello che c’era scritto sul mio CV: date, periodi, mansioni, aziende. In più penso, volesse farmi capire che avrebbe giudicato anche la mia grafia, così come in uso negli Stati Uniti (le solite nozioni apprese durante i corsi di formazione intensivi del cavolo!). A questa circostanza va aggiunta poi la posizione scomoda che dovevo assumere: per scrivere dovevo appoggiarmi al piano del tavolo che distava non poco dal bordo della scrivania, ma non c’era lo spazio per le gambe e dovevo incurvare la schiena. Lui poi prese delle carte a caso e si mise alle mie spalle fingendosi interessato ad altro ed invece stava lì come un gufo ad osservarmi. Enricomaria – che la maledizione di Montezuma possa averlo consumato e portato via e che i vari crolli di borsa possano però prima averlo ridotto in miseria! – mise in scena tutti i trucchi più sgamati per mettermi in difficoltà, ed alla faccia del colloquio informale! Capii che le cose si mettevano in modo strano ed inatteso e cercai di difendermi e vendere cara la pelle. Cercai il più possibile di ostentare tranquillità e sicurezza al punto che lui si innervosì e 67 sbottò, fuori da ogni contesto, un messaggio in stile mafioso, in barba al suo accento e da quell’aplomb torinese di vecchia memoria, che al contrario del famoso proverbio risultava falso ma affatto cortese: –il DirCom non si doveva permettere di scavalcarlo! Lui decideva chi assumere e chi non in quella banca. La mia sicurezza non era confortata da alcun fondamento, visto che la decisione, in quella sede, l’avrebbe presa lui e soltanto lui! Aggiunse infine: lei è iper qualificato, quindi si aspetta che noi le paghiamo, giustamente, anche un bello stipendio. Ma sa, con quello che pagheremmo per avere lei, ci paghiamo 4 stagisti, capisce? Ed infatti l’uso ed abuso degli stagisti si era presto notato in quella banca disgraziata. Se al mio ingresso da promotore finanziario, potevamo contare sulla consulenza telefonica di dipendenti esperti e competenti, dopo un anno circa, il servizio venne affidato al call-center interno e da lì in poi, iniziò il delirio. Ogni volta che interloquivi con persone diverse, avevi risposte diverse, sempre parziali. Quando diventai assistente del manager, sconsigliai vivamente i colleghi di fidarsi di quanto detto dal call center. E del resto era comprensibile quella loro impreparazione: se vieni chiamato per un lavoro che sai in partenza, durerà solo pochi mesi, sei inesperto e la tua conoscenza deve essere desunta da poche dispense e da una settimana, dieci giorni al massimo di corso intensivo, se non sei affatto motivato e dai delle informazioni errate o parziali, la cosa è normale. Da quel colloquio mi aspettavo di poter avere una qualche sorpresa ma non mi sarei mai aspettato un’ accoglienza tanto ostile, vista l’importanza del mio sponsor. Pensai soltanto ad uno sfogo di un frustrato al quale si nega l’esercizio del suo piccolo e meschino potere, ma in realtà ero all’oscuro delle sue vere motivazioni perché non conoscevo delle circostanze importanti. In quel periodo di cambiamento, la banca aveva ottenuto risultati davvero pessimi. Dagli azionisti di maggioranza in giù, passando per l’Amministratore Delegato, si era deciso di cambiare i vertici operativi dell’azienda: saltò quindi prima la testa del Direttore Generale ed il DirCom l’avrebbe seguito a ruota, anche se, quando mi fece il colloquio, non ne era ancora consapevole. Ecco che quindi il primo segnale da inviargli era quello di bocciare un suo sicuro candidato. Tornai a casa un po’ disorientato: avevo capito che le cose non erano andate come speravo, ma non capivo ancora il come ed il perché. Era fine luglio quindi presto arrivarono le vacanze e le passai ad attendere una telefonata che non mi arrivò mai. A settembre aspettavo ancora una risposta ma ormai il silenzio era un chiaro segnale. Decisi che anziché attendere ancora, era meglio andare a prendersi la propria sentenza di morte direttamente alla fonte. Scrissi un’email all’assistente del DirCom anche se mi era stato tassativamente vietato e le chiesi almeno spiegazioni di quel cambio di rotta, ormai evidente. Lei mi telefonò immediatamente sul numero privato e mi chiese di poter parlare in modo riservato. Ero da solo in quel momento, quindi continuò: mi hanno detto che il colloquio non è andato bene… Non so francamente di più. Però mi spiace davvero che nessuno si sia degnato di dirtelo almeno! Le dissi – Immaginavo che avrebbero detto questo ma ti posso garantire, di colloqui di lavoro ne ho fatti un bel po’ ed almeno in questo sono esperto: il colloquio non è andato male per un mio demerito, perché per come mi avevate presentato dovevo solo prendere a schiaffi il Sig. Enricomaria per non farlo andare più che bene, visto il fatto che mi conoscevate benissimo e sapevate già come lavoro sul campo!… Invece – ed è una mia opinione e tu sei libera di non crederci – secondo me Enricomaria mi ha sabotato, ha fatto davvero di tutto per mettermi in crisi e quando ha visto che non ci riusciva si è incazzato e mi ha detto questo e quest’altro…Gli riferii del suo sfogo e degli stratagemmi puerili usati per mettermi in difficoltà. Ci fu un attimo di silenzio imbarazzato da parte sua. Se non fosse stata d’accordo con quanto dicevo avrebbe potuto rispondermi: capisco il tuo disappunto, ma le cose non sono andate come dici… 68 Ed invece lei disse, con tono di chi si aspettava il peggio e ne ha conferma:- Ah, l’avevo immaginato! E’ come temevo! Se hai avuto questa sensazione sono sicura che non te lo sei inventato… Sono davvero dispiaciuta…Adesso lo riferirò al DirCom… Deve sapere come vanno le cose qui… La ringraziai perché in quel contesto si era dimostrata l’unica persona gentile ed umana e ci salutammo. Di lì a poco il DirCom seppe davvero come andavano le cose, penso mediante la classica raccomandata che aveva il sapore della testa di cavallo mozzata in uso tra i padrini, ed anche lui venne defenestrato, mentre la sua collaboratrice, pensò bene – subito dopo il nostro colloquio – di cambiare lavoro e di farsi assumere dalla concorrenza. I rapporti col Divisional ormai erano logori. Mi aveva ridotto lo stipendio al lumicino per cui io gli avevo chiesto il part-time, nel frattempo iniziò a formare in parallelo un giovane sessantenne, agente assicurativo in pensione – una persona le cui motivazioni ancora mi sfuggono, visto che un tempo era stato il dirigente ed il proprietario di un suo grande ufficio assicurativo e doveva aver messo parecchio fieno da parte nel suo fienile. Chi glielo faceva fare di rubarmi il lavoro ed in cambio di nulla, sostituendomi a costo zero? Perché se c’era una cosa su cui potevo mettere la mano sul fuoco era proprio che il mio capo non avrebbe più cacciato un centesimo di tasca sua. Avendo compreso che il rapporto era ormai finito, richiesi aiuto al mio cognato agente di commercio che mi fece ricominciare, anche se stavolta delle aziende disponibili, c’era rimasta solo una delle meno redditizie a non essere coperta da altri colleghi. Negli ultimi mesi di part-time quindi, avevo ricominciato il lavoro come venditore, stavolta però con più mezzi ed esperienza, riuscendo un po’ meglio e con meno fatica a portare qualche ordine a casa. Tra una cosa e l’altra, trascorse un altro anno. Quasi alla metà di ottobre del 2007 il capo mi disse che di lì a poco si sarebbe dimesso dalla banca e che avrei dovuto lasciare l’ufficio il lunedì successivo, il 15 del mese e mi liquidò col mezzo stipendio che – secondo lui – mi spettava, 5 euro compresi, senza un centesimo di più né uno di meno, senza nessun ringraziamento per il mio lavoro in quegli anni. Era ancora una volta fine anno e stavo ancora una volta ripercorrendo il gioco dell’oca dalla partenza, ricominciando la strada che tutt’ora sto percorrendo. 69 Capitolo 11 Io, mànnaggger per un giorno! La fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo. (proverbio popolare) Gli ultimi giorni prima delle vacanze estive, prima della fine del mio rapporto con la bancaassicurazione, ricevetti una inattesa telefonata. Era di una cacciatrice di teste di una non meglio identificata società bancaria che cercava un manager per una sua filiale in apertura a Napoli. Ai primi colloqui capita spesso che certe selezioni vengano fatte telefonicamente e senza specificare granché dell’azienda che cerca risorse, quindi mi limitai a rispondere alle sue domande senza peraltro sperare troppo in quel colloquio peraltro inatteso. Non ricordavo proprio di aver spedito quel CV, ma ormai ne avevo mandati talmente tanti in giro per il mondo che era impossibile tenerne traccia. Dopo qualche giorno, la tale head-hunter mi richiamò e stavolta mi diede molti più particolari. La società che cercava risorse era una banca straniera, specializzata nei mutui sub-prime, una tipologia di mutuo che, confesso, fino ad allora non avevo mai sentito nominare, seppure avessi lavorato per quattro anni in una società che aveva anche mutui tra i suoi prodotti. Nel mentre la selezionatrice mi parlava, digitai sul Google il nome della banca e la parola “subprime” e cercai di capire di cosa si trattasse anche perché, se volevo diventare davvero uno dei loro manager, dovevo sapere di cosa stessimo parlando. La signora misteriosa fu entusiasta delle mie risposte e mi disse di aspettarmi un’altra telefonata. Cosa che si verificò realmente: dopo un’altra settimana, venni richiamato dalla signora che ormai mi si presentava col suo nome di battesimo e qualifica e che mi spiegò mansioni, inquadramento e retribuzione. Avevano proprio bisogno di un manager ed io gli sembravo davvero quello che faceva al caso loro. Mi offrivano un bello stipendio, il ruolo di tutto rispetto e non solo. Memore della lezione del contratto bidone, gli chiesi se quello stipendio non fosse in realtà una forma di “anticipo” e se la struttura la dovevo reclutare da solo con le mie forze o se mi era dato qualche ausilio dalla banca. Era l’offerta del Bengodi invece: stipendio (1.600 euro netti per iniziare), corsi di formazione, ufficio, struttura già selezionata e reclutata dalla banca, pronta ad eseguire i miei ordini. Mi dovevo solo limitare a svolgere il lavoro di tutti i mànnaggger che si rispettino: far lavorare gli altri più che potevano e vantarmi e godere del mio potere mànnagggeriale. Troppo bello per essere vero ma sembrava tutto maledettamente vero! Come mai si erano tanto attaccati a me? Forse perché per un ruolo da manager, 1.600 euro erano considerati pochi e quindi la posizione era poco ambita… Mentre per me non lo erano… Era questa la risposta che mi ero dato per pensare positivo. Ovviamente non si assume nessuno tantomeno per un ruolo così delicato, al telefono e quindi arrivò il giorno in cui fissarono un appuntamento per definire in concreto la loro offerta e conoscermi di persona. Quel giorno la Signora X mi chiamò e mi comunicò orario e ubicazione dei loro uffici di Roma. Venga col treno Dottore – mi disse – e le rimborseremo anche il costo dei biglietti. Anzi, corra a 70 prenotare l’Eurostar per Roma di domattina. Mezz’ora dopo appena, mi richiamò: Dottore… Ehm… Sono imbarazzatissima… Ha già fatto i biglietti? Io che sotto sotto mi aspettavo un po’ la fregatura, non mi ero affrettato e non ero corso alla biglietteria. La fortuna di essere scaramantici. Bè, ci scusi… E’ un fatto gravissimo averle dato per certo dell’appuntamento e richiamarla così… Ma sono successe cose che ora non posso dirle. La terrò senz’altro informata perché comunque abbiamo intenzione di incontrarla. Passò l’estate e la telefonata non arrivò mai più. In autunno era scoppiata la bolla dei sub-prime. Che peccato, avrei potuto essere il mànnaggger di una società fallita ancor prima di nascere e mi sono perso quest’esperienza… Mannagggia…ment! 71 Capitolo 12 La motivazione delle risorse umane. Il termine risorse umane è, a mio avviso, intriso di ipocrisia. Qualche azienda non si dà neanche la noia di essere ipocrita e parla di personale e di capo del personale (vedasi capitolo 8). Tuttavia, le imprese che reputano di essere moderne ed orientate al mercato, definiscono “risorsa” la propria forza lavoro. Terminologia a parte, se c’è una cosa che il vero mànnaggger ignora, è come si motivano i lavoratori. Perché sì, cavolo, il lavoratore della sua azienda potrà anche essere uno schiavo malpagato…ma dico anche ad una bestia da soma si da uno zuccherino, una carota quando compie il suo gravoso lavoro! Non si dice ad un mulo (dopo che ha trasportato un carico pesantissimo fino alla cima di una vetta) la prossima volta mettici più attenzione! No! Se la bestia non ha scalciato e non si è fermata a metà salita, le si da un po’ di zucchero, una carota o una bietola anche se magari, nello sforzo, ha fatto cadere qualcosa lungo il tragitto. Alla risorsa umana, no. Niente “zuccherino”. Anche se la risorsa ha sacrificato la pausa del weekend per smaltire del lavoro arretrato, non merita nemmeno un grazie per la buona volontà, l’impegno, per il tempo sacrificato alla propria vita. Anzi, alla risorsa si fa notare l’unico, perdonabilissimo - e magari senza conseguenze - errore che avrà eventualmente commesso. Ma del resto, perché far sentire un proprio schiavo come avente diritto al riconoscimento della dignità di essere umano? Che senso ha? Soprattutto se poi magari, lo schiavo pur essendo tale per nascita e per venture della vita, ha magari dieci volte più sale in zucca del suo schiavista? Ecco un'altra regola da tenere a mente il giorno che diventerete dei mànnaggger: umilia il prossimo tuo come se fosse il bambino che ti picchiava alle elementari ed ora tu sei grande e grosso e lui è rimasto col fisico di allora. Le proprie frustrazioni vanno scaricate sugli anelli più deboli della catena. La vera forza di un lavoratore non è la flessibilità intesa in senso produttivo (o almeno, non solo quella) ma la capacità di farsi scivolare addosso l’altrui pochezza e non sentirsi, per questo, sminuiti. Del resto se uno è diventato mànnaggger , noi sottoposti dobbiamo fargli credere che sia speciale, altrimenti poi lui va in crisi e rischiamo di perdere quel po’ di utile che da lui o lei, possiamo trarre. Nel mondo del lavoro vige il più aspro machiavellismo: il fine giustifica i mezzi. Ed i mezzi, soprattutto quelli economici, purtroppo, ce li può assicurare soltanto il mànnaggger di turno. Ricordo per esempio una terribile (ma per fortuna brevissima) esperienza di lavoro in un centro di assistenza fiscale molto popolare nella zona dove abitavo. Era il regno di una matrona ormai sessantenne che aveva iniziato giovanissima da zero e si era costruita, nel corso degli anni, un vero e proprio impero della contabilità. La signora gestiva la contabilità di decine di aziende ed assisteva un numero incredibile di cittadini obbligati alla denuncia dei redditi. Ci andai perché spinto (ok…obbligato!) da una delle mie due sorelle che aveva sentito dire che la Signora cercava laureati in economia, anche senza esperienza. La Signora era un tipo particolare: aveva la voce di Tina Pica, i capelli di nonna Belarda (lunghi, 72 bianchi ed incolti), un carattere più che vulcanico. Era capace di comandare a bacchetta decine di collaboratori tutti insieme e di terrorizzare tutti, anche quelli più anziani per età e da più tempo invischiati nella sua ragnatela. Non potrò mai dimenticare le sue quotidiane urla e invettive contro il malcapitato di turno. Quando mi presentai al colloquio, lei non volle manco guardare il mio curriculum. “Che me n’aggia fa e chesto curriculùm? Je ti guardo in faccia, si mi piaci allora vai buono. Si sai fà o lavoro tuoio, vai bbuono,…sinnò, te ne può pure gghì. Ah ah ah, m’ha portato u curriculùm!!! Però tu tieni na faccia che mi piace, sei sorridente! Bravo, si nu bravo guaglione si vede, sei sveglio… Ta voglio da io n’opportunità” 4. E così la signora mi offrì 500 euro al mese per un part-time di quattro ore al giorno (in nero) e mi diede appuntamento al primo di settembre. Il primo dunque mi presentai lì e le ricordai di quello che mi aveva detto. Cascò un attimo dalle nuvole e poi si ricordò di me. Ah, tu si chillu bello guaglione!!! Ah ahah! Sì, sei sorridente… Allò, miettete accanto a chesta e impara… 5 “Chesta” fu dunque la formazione che ricevetti. La collega alla quale mi dovevo affiancare era davvero una bravissima e dolcissima ragazza che cercò di farmi sentire meno spaesato di quanto non fossi… ma aveva davvero un bel pancione ed era all’ultimo giorno di lavoro prima della maternità e quindi, il giorno dopo, non ci sarebbe più stata. Il giorno successivo quindi, mi sentii davvero fuori luogo. L’impressione che ne ebbi fu davvero tragica ma mi servivano dei soldi e l’offerta di un part-time mi avrebbe consentito di non abbandonare l’altro lavoro di rappresentante che avevo appena cominciato. Dissi a me stesso: cerca di resistere. L’esperienza durò, come già detto, giusto un mese: il tempo di farmi venire un esaurimento nervoso e passare le ultime dieci notti tra gli incubi più terribili. La presenza della Signora era asfissiante, le sue tecniche (de)motivazionali degne della Gestapo. Era capace di darti un compito il minuto prima e chiederti, l’esatto minuto successivo, cosa stavi facendo e perché “perdevi tempo” (in realtà stavi solo eseguendo i suoi ordini). Capii subito che mi aveva preso per due motivi: ero un tappabuchi che avrebbe dovuto coprire le mancanze di altri soggetti che si impegnavano poco ma che non potevano essere cacciati per ovvie ragioni. Inoltre, servivo da “spauracchio” per gli altri colleghi: la mia presenza fisica doveva far sentire loro che c’era sempre pronto un rimpiazzo, qualora avessero provato ad alzare la testa. I “protetti” ovvero gli intoccabili che noi schiavetti dovevamo coprire, erano nell’ordine: 1) Il figlio minore della Signora: uno stupido maleducato venticinquenne che non riusciva a dare gli ultimi esami ad economia nonostante la madre chiamasse quotidianamente i suoi professori per farglieli superare. 2) La fidanzata del figlio della Signora: una ragazza dell’Est Europa che – a giudicare dalla differente avvenenza ed altezza tra i due – non era animata proprio da amore sincero ma doveva aver pensato bene di sistemarsi con un figlio di mammà italiano, che di certo le avrebbe consentito una vita migliore rispetto a quella di tante sue coetanee provenienti dall’Est europeo 3) Il figlio di un noto commercialista, un ragazzo con gli occhietti vispi e pungenti che sapeva il fatto suo e riusciva a far fare al prossimo quel po’ che gli veniva richiesto 4 “Che me ne devo fare di questo curriculum? Io ti guardo in faccia, se mi piaci allora va bene. Se sai fare il tuo lavoro, bene…sennò, te ne puoi pure andare. Ah, ah ah, m’ha portato il curriculum! Però tu hai una faccia che mi piace, sei sorridente!Bravo, se un bravo ragazzo si vede, sei sveglio…Te la voglio dar e io un’opportunità.” (N.d.T.) 5 Ah, tu sei quel bel ragazzo. Sì, sei sorridente. Allora, mettiti accanto a “questa” e impara… (N.d.T.) 73 Al di là del front office, ovvero dei tre o quattro ragazzi che si occupavano delle pratiche dei tanti pensionati che si recavano lì per consulenze varie, c’era l’ufficio contabilità. Lì l’atmosfera era praticamente irrespirabile. Le impiegate più anziane, assunte con la qualifica di bidelle (il centro figurava ufficialmente come una scuola che teneva dei finti corsi di abilitazione professionale) erano ormai tanto inacidite dalla vita che facevano, da sputare veleno contro chiunque avesse osato anche rivolgere loro il saluto. Mintzberg definisce una simile organizzazione come un “cesto di granchi, dove ognuno sferra colpi e fendenti all’altro e cerca di arrampicarsi sulla carcassa del proprio compagno di sventura per tentare di fuggire”. Quando la Signora mi presentò a tali impiegate, ricevetti dei grugniti di saluto e poi, non appena fu uscita dalla stanza, finsero di ignorarmi. Un paio di volte la Signora mi usò come messaggero per comunicare con loro e sempre, fingevano di ignorarmi. L’ennesima volta che non ricevetti risposta, alzai la voce e dissi che erano delle gran maleducate, che io non volevo niente da loro ma che mi limitavo a riferire gli ordini della capa. Da quel momento in poi smisero di ignorarmi ed almeno finsero una parvenza di cortesia nei miei riguardi. Ma forse la colpa non era neanche tutta loro, era quell’ambiente che ti metteva su quest’ansia, questo senso di smarrimento, come se da un tuo eventuale errore o da un momento di pausa nel lavoro, ti sarebbe potuto derivare una pena corporale dolorosa e severissima, com’era al tempo della schiavitù. Passavano i giorni e la Signora mi affidava sempre mansioni diverse e mai finalizzate ad un reale inserimento nella struttura. Un giorno dovevo togliere la parte perforata dalle fatture che erano ammonticchiate in buste di plastica ed ordinarle per data, il giorno seguente costringeva la contabile ad insegnarmi la registrazione delle stesse, il giorno successivo ancora, mi metteva in archivio ed ero costretto a tirare giù scatoloni polverosi di documenti per rimetterli in ordine alfabetico. Un’altra volta ancora, mi affiancò ad un ragazzo con una malattia congenita molto grave ed allo stato terminale, che respirava a stento e che aveva dovuto assumere per forza come categoria protetta. Quel povero ragazzo fu forse una delle persone più gentili incontrate lì dentro ma imparare qualcosa da lui, con quel filo di voce incomprensibile… fu un’esperienza che non auguro a nessuno. Ad ogni modo, il giorno successivo ero di nuovo a sistemare la polvere dell’archivio in ordine alfabetico. Insomma, era chiaro che ero di troppo. Allo scadere del trentesimo giorno, quando ormai da una settimana sentivo la Signora lamentarsi del fatto che non lavoravamo quanto dovevamo e lei non ci avrebbe pagati, ci fu la goccia che fece traboccare il vaso: il figlio coglione, quello più piccolo (c’era anche un figlio più grande, che si dava arie da grande imprenditore ma che in realtà era capace solo di spendere i soldi di sua madre) mi apostrofò per l’ennesima volta con un “Chesto” 6. Costui parlava di me con sua madre, criticando la mia presenza – mi riteneva inutile – senza curarsi del fatto che io ero lì presente e che avevo dieci anni più di lui, una laurea ed un master più di lui, parecchio sale in zucca più di lui... ma una madre milionaria in meno, rispetto a lui. Mi salì il sangue agli occhi e cominciai a scalciare e sbuffare come un toro. Mi rivolsi a sua madre, la Signora, e le dissi a muso duro: io ho capito che qua dentro sono di troppo, ho capito che lei non ha alcuna intenzione di prendermi sul serio e che mi sta facendo fare le cose più umili per farmi andare via ma almeno usate un po’ di rispetto, almeno insegni a suo figlio ad essere più educato con le persone. Se mi vuole chiamare “chesto” abbia almeno la furbizia di non farlo in mia presenza! Io HO UN NOME!!! – urlai – e sono una persona e pretendo di essere trattato con rispetto. Non mi vuole pagare? Bene, me ne vado…ma alla mia dignità non ci rinuncio. 6 “Questo qui” (N.d.T.) 74 I colleghi presenti ammutolirono e mi guardarono con invidia: chissà quante volte avranno sognato di urlare contro quella megera ed il suo degno figlio. La Signora a sua volta mi guardò con gli occhi sgranati e l’aria perplessa. Come spesso capita, molti prendono la mia bonarietà ed il mio spirito collaborativo per coglionaggine e non capiscono che invece quando la misura mi è colma, divento una vera furia. La Signora mi invitò a calmarmi e mi disse che sì, non aveva trovato una collocazione per me in quel momento. Si scusò per il figlio, mi disse che lui era stato maleducato, ma che forse io ero un po’ esaurito, ma mi giustificò dicendo chelì dentro i ritmi erano davvero frenetici e facevano saltare i nervi a tutti. Insomma, di comune accordo ci salutammo e me ne andai con la promessa da parte sua, di richiamarmi non appena ci fosse stata un’opportunità per me. Scappai via a gambe levate! Un anno e mezzo dopo, ricevetti una telefonata da parte sua: voleva utilizzarmi per una sostituzione di una sua dipendente in maternità e forse si aspettava che io sarei corso saltando di gioia. La mia più grande soddisfazione fu di declinare cortesemente l’invito, lasciandola, ancora una volta, sorpresa. 75 Capitolo 13 Direttori commerciali e Agenti di Commercio: i satrapi, gli occhi e le orecchie del re. Cito da Wikipedia: “I satrapi, generalmente scelti tra i nobili o tra gli appartenenti alla famiglia reale, avevano il compito di amministrare la giustizia, di riscuotere i tributi e di reclutare le truppe per l'esercito del "Gran Re". Il loro operato era controllato annualmente da funzionari reali itineranti, chiamati "gli occhi" e "le orecchie" del Gran Re. Forniti di estesi poteri amministrativi, militari e giudiziari all'interno della propria provincia, di fatto i satrapi erano veri e propri principi vassalli”. Nella Persia di Ciro il Grande, l’Impero era così esteso che le informazioni e gli ordini non potevano arrivare dalla capitale alla periferia (e viceversa) in tempi accettabili. La lungimiranza dell’imperatore portò a capire, secondo la regola del divide et impera, che bisognava frazionare quell’enorme territorio in macroregioni definite “satrapie”, da affidare ad uomini di fiducia. L’azione del Satrapo, il governatore della provincia, era poi coadiuvata da quella di altri uomini che viaggiavano per l’impero in lungo ed in largo e raccoglievano e diffondevano umori ed informazioni: quegli uomini fidati erano detti “gli occhi e le orecchie del re”. Essi avrebbero raccolto informazioni e notizie da elaborare e riferire al re il quale, grazie al loro operato, avrebbe potuto quindi evitare estenuanti quanto pericolosi viaggi in lungo ed in largo per il suo impero. In un’azienda, le cose funzionano allo stesso modo. In un mercato nazionale come il nostro, che di certo non è esteso come quello statunitense o quello cinese, c’è comunque una forte eterogeneità tra diverse zone. Per spiegare questo concetto, i responsabili commerciali sono soliti dire che l’Italia è stretta e lunga. In sostanza percorrendola dal Nord al Sud, si ha la netta sensazione di visitare paesi diversi seppure uniti sotto la stessa bandiera. Non ci può essere quindi un’unica politica commerciale per zone appartenenti ad aree geografiche diverse. Figuriamoci poi se una singola persona, che si trova fisicamente e culturalmente molto distante dalle estreme periferie del suo regno, può possedere da sola le conoscenze adeguata a determinare una strategia efficace senza prima aver studiato attentamente ogni singola area del territorio e del mercato di riferimento. Per ovviare a questo problema, le aziende si affidano ad uomini esperti in campo commerciale, affinché controllino aree ben definite del territorio in modo da ottenere una conoscenza analitica di ogni singolo segmento territoriale. L’insieme di questi uomini è definito Rete Vendita. Questa oltre ad essere il braccio operativo del Responsabile Commerciale, lo strumento che permette di trasformare i prodotti od i servizi delle aziende in ricchezza, può essere paragonata agli “occhi e le orecchie” del re persiano. Riassumendo la metafora dunque, potremmo dire che il nostro Imperatore corrisponde alla proprietà dell’azienda; il Satrapo è l’equivalente del direttore commerciale che, sapendo avvalersi di “occhi ed orecchie” sul territorio (la propria rete vendita), può potenzialmente raggiungere una perfetta conoscenza del territorio e del mercato in cui opera. Una conoscenza che per essere raggiunta altrimenti, richiederebbe costosissime ricerche di mercato, ovviamente alla portata solo 76 delle imprese più grandi. Non sempre poi le aziende specializzate in ricerche di mercato, raggiungono risultati rispondenti alla realtà perché, come la statistica ci insegna, interpretare certi dati e renderli universali partendo da un piccolo campione, è sempre un’impresa dagli esiti non scontati. Non tutte le aziende e non tutti di responsabili commerciali purtroppo, comprendono appieno l’importanza e la potenzialità di questo strumento di analisi domestico e praticamente a costo zero: l’agente di zona. Questi, dovendo occuparsi della vendita nel suo territorio ben circoscritto, ne acquisisce una conoscenza diretta e dettagliata ad un livello difficilmente raggiungibile da altri soggetti “esterni”. Capita così – e questo l’ho scoperto vivendo queste esperienze sulla mia pelle da quando faccio l’agente di commercio – che l’azienda non solo non ascolti quello che i suoi “satrapi” ed i suoi “sensori” sul territorio gli dicano ma che agisca all’esatto opposto. Vi parlerò quindi di alcuni casi concreti. 77 Capitolo 13.1 Il Signor T e le nonne. Grazie alla mia (certo, non lunghissima) esperienza come agente di commercio, ho avuto un’ulteriore conferma del fatto che quanto scritto nei manuali di management ed organizzazione aziendale viene totalmente o quasi completamente, disatteso. Le faticose materie di studio dei miei giorni da universitario, nella realtà italiana, vengono considerate alla stregua di passatempi per oziosi studiosi dediti all’autoerotismo intellettuale. Le imprese agiscono in maniera più istintiva che ragionata. Rispondono in maniera prevalente più alle intuizioni personali ed ai capricci della proprietà e del management che alle regole ben precise dettate dalle logiche di mercato. I princìpi che lo regolano non sono solo il frutto di un mero passatempo, ma sono mutuati dall’esperienza e dagli studi compiuti nei decenni a livello planetario, dai più grandi economisti ed esperti di management. Se qualcuno, per esempio, si è dato la briga di studiare e di spiegarci perché la produzione di un bene o di un servizio mediante il modello “push” è ormai superata dal più dinamico modello “pull” 7 in un mercato caotico e dinamico come quello attuale… un motivo ci dovrà pur essere! Allora mi domando, perché costoro ignorano tutto ciò? E se lo fanno, è per scelta motivata, ignoranza o presunzione? La risposta la lascio al lettore e per aiutarvi a maturarla, vi propongo un esempio concreto di un’azienda che chiameremo “K”. La K ha sede in una località del ricco Nord Est che potremmo definire “ridente”, non fosse per il rigido clima che la caratterizza, compensato però dal consumo su vasta scala di bevande alcoliche. Una zona d’Italia dove c’è ancora talmente tanto benessere, che la pulizia delle strade è affidata anche ad uomini che girano armati di grandi aspirapolvere che portano in spalla e dove c’è un tale ordine e rispetto delle regole che un banale ingorgo stradale causato da un altrettanto banale incidente, è un evento tanto inconsueto dal meritare la prima pagina del quotidiano locale. Per me che vivo quotidianamente nel caos anarchico di una città bella quanto indomita e problematica come Napoli, girare per quei luoghi è come vivere in una favola di Andersen od in una di quelle sfere con la neve sintetica che si vendono nei negozi di souvenir. L’azienda K produce articoli di complemento per il regalo. È a conduzione familiare ma la direzione commerciale è affidata ad un uomo estraneo alla famiglia, il Signor T. Il Signor T è un simpatico uomo d’affari quasi d’altri tempi, anche se non supera la cinquantina. Dopo un’esperienza come venditore, ha maturato la convinzione che la sua conoscenza del settore in cui opera è unica in Italia ed è altrettanto convinto di avere un fiuto infallibile per la scelta delle linee di prodotto. Per un po’ la fortuna ha assistito il nostro Mr. T e tutta l’azienda K, perché una delle loro linee è davvero molto bella e di gran qualità ed è ottenuta con un metodo di produzione di cui loro sono ancora i leader, seppure ora sia stato imitato sempre con maggiore successo da alcuni competitor diretti. Se da una parte ciò ha significato un evidente vantaggio competitivo nei confronti dell’agguerrita concorrenza, dall’altro i costi di produzione più alti comportano prezzi di vendita al pubblico più 7 Il principio del push è “io so fare questo lo faccio…poi vedo se il mercato me lo compra” mentre nel “pull” si analizzano le richieste del mercato e vi si adatta la propria offerta. (N.d.S.) 78 elevati della media. Questo ha causato e causa tutt’ora, delle oggettive difficoltà di vendita soprattutto in un periodo di crisi economica come l’attuale e nei mercati meno sviluppati dal punto di vista culturale. La K poi si è scelta una nicchia di mercato molto ben definita e ci si rintana sempre più, tagliando via quei prodotti che non vi rientrano direttamente. La concorrenza invece sta operando in tutt’altra direzione. Visto che quel segmento di mercato risente molto della disaffezione del pubblico verso un certo tipo di comunicazione, le imprese concorrenti hanno allargato la gamma dei propri prodotti verso il più vasto settore degli articoli da regalo. Per il resto, le linee dei prodotti scelti dal Mr. T, si rifanno totalmente al suo gusto personale, sviluppatosi in maniera molto marcata negli anni ’70 ed ’80. La filosofia manageriale del Sig. T, come accennavo prima, è incentrata sul principio che la produzione deve essere focalizzata su di un solo core business molto ristretto (quindi non è diversificata) e che non bisogna rincorrere le tendenze attuali ed estreme del mercato perché quando queste saranno passate – e prima o poi tutto passa – si resterebbe spiazzati. Da un lato ciò è condivisibile, almeno in parte. È altrettanto vero però, che per essere realmente competitivi, bisogna diversificare i rischi e quindi le produzioni e bisogna anticipare e fiutare le tendenze di mercato, capendo quale sarà la direzione da prendere per il futuro prima che il futuro si concretizzi. Se è vero che puntare sul cavallo che ha appena vinto la corsa non è sempre una strategia vincente, non è altrettanto vero che la strategia migliore sia invece quella di puntare solo sui brocchi che arrivano sempre per ultimi. Un altro errore spesso ripetuto dal Sig. T, è quello di riproporre personaggi ormai persi nel tempo: i brocchi di cui sopra. Ecco perché quando penso al Sig. T, mi viene in mente il titolo di un film con Richard Gere: “Il Dr. T e le donne”, il cui protagonista era un uomo che aveva il potere di leggere nella mente delle donne. Il nostro Dr. T. invece, sembra più in sintonia con i gusti delle nonne. Faccio qualche esempio concreto dei suoi errori strategici. La tendenza sempre più prevalente nel settore degli articoli da regalo o gadget indirizzati ad una fascia di consumatori con un’età che potremmo definire scolare, è di preferire i prodotti che riprendono dei personaggi, siano essi protagonisti di fiction, di cartoni animati, di serial per ragazzi. Per citare qualche esempio, hanno avuto grandi successi i merchandising di Hanna Montana, High School Musical, etc. Ma anche personaggi dei fumetti o dei cartoni anche d’antan come Micky Mouse, Minnie, Winnie The Pooh, Betty Boop, etc. Ora, se Betty Boop è stata creata all’epoca dei bisnonni degli acquirenti medi dei prodotti della K, in questi anni è stata rilanciata come un personaggio totalmente nuovo dalle principali aziende che si occupano di articoli da regalo e gadget. Invece un fenomeno come Hello Kitty – non credo che vi debba spiegare chi è – seppure sia nata ormai varie decadi fa, ha un successo che sembra non tramontare mai. Altrettanto non si può dire invece dei personaggi degli anni ’70 ed ’80 passati nel tritacarne della memoria collettiva e che la K si ostina a riproporre, senza che ciò sia accompagnato da alcuno sforzo di marketing. Soggetti molto belli ad onore del vero, ma apprezzabili solo da persone con almeno 35-40 anni di età e con un livello culturale medio-alto. Personaggi negletti, finiti ormai nel dimenticatoio perché appartenuti al vissuto di chi quei prodotti non compra più e perché non sono stati più rilanciati dalle tivù commerciali e pay tv che sono poi quelle che creano realmente le nuove tendenze. Più di mille ricerche di mercato, vale la sintetica espressività dei miei conterranei e la lapidaria capacità di giudizio di alcuni miei clienti sui prodotti od articoli che sono andato a proporre per conto della K. Esperienze che sono state per me uno strumento molto utile per capire la reale capacità di penetrazione di ciò che andavo loro a proporre. Cito alcuni dei commenti più “incisivi” che mi sono stati rivolti. 79 Dopo il lancio di un paio di linee nuove, che lo erano per davvero solo negli anni ’70, mi presento da alcuni dei miei clienti con il mio catalogo, armato di buone intenzioni e di speranza. Volevo valutare dal vivo le loro reazioni e capire se finalmente, si poteva dare una svolta nelle vendite sempre molto fiacche. Il primo cliente, il Sig. Pinco, titolare di un negozio di una zona periferica di Napoli, alla visione del terzo personaggio tirato fuori dall’oblio degli anni ’70 ed ’80 esclama senza pudore: Uanema ra miseria!!! Hanna scavat’ stì muorte?!” [Alla faccia, hanno riesumato tutti questi cadaveri? NdS] Sentenza schietta e brutale che ha anticipato in maniera quasi costante, il giudizio di tutti gli altri clienti ascoltati in seguito. I personaggi erano carini, i prodotti erano belli ma sarebbero stati riconosciuti e ricordati con affetto solo da chi fosse stato almeno quarantenne. I ragazzini ed anche solo gli under 35 invece, i veri potenziali clienti, non li avrebbero capiti e quindi apprezzati. Altra peculiarità della azienda K è sempre stata quella di essere molto radicata nel suo territorio. Il suo disegnatore di punta è conosciuto talmente nella sua città di origine (quanto negletto altrove) che il comune gli ha dedicato una permanente al Museo di Arte Moderna. Tutto ciò è poi peggiorato dalla circostanza che il Sig. T non ha mai nascosto che il colore politico del suo cuore, non è né rosso né nero, ma di un bel verde brillante come la Padania di cui si sente fiero esponente. Per questo motivo, tra i complementi venduti, esiste anche una linea ispirata alle squadre di calcio, ma tutte e tre quelle scelte, sono rigorosamente le tre grandi del nord Italia. Ora dico, è vero che il tuo cuore è verde, ma il tuo portafogli? Perché ti vuoi privare del mercato non proprio esiguo dei tifosi delle squadre del sud? Ne bastano due, Roma e Napoli per avere una platea potenziale di almeno un altro paio di milioni di clienti… Senza parlare poi delle grandi squadre siciliane. Ed invece no! Ad ogni richiesta di noi agenti del sud, seguiva una risposta che, tecnicamente parlando, poteva essere riassunta con un “va a ciapà i ratt”. Un altro cliente a tal proposito, mi fornì un’altra pittoresca quanto incisiva giustificazione per il rifiuto di acquistare tali prodotti. Mi disse: sì, qui figurati se non ci sono anche tifosi juventini, milanisti ed interisti, ma non posso rischiare di comprare questi, mi capisci? In quella entrò il garzone del bar che ci consegnava i caffè appena ordinati. Il titolare del negozio allora gli chiese: - Rafè, accà ce stà o’ rappresentante, me vuless accattà stì gadgèt’ rò’ Milàn, tu che pienz’? [Raffaele, qui c’è l’agente, vorrei comprargli questi gadget del Milan, cosa ne pensi?] - E c’aggia penzà? – rispose deciso Raffaele – che t’appicc’ a tè, a isse e pure o’ negozio! [Cosa ne dovrei pensare? Che in tal caso potrei solo dare fuoco a voi ed a tutta la merce] Scoppiammo tutti e tre a ridere fragorosamente ed io gli dissi – ti capisco ed hai pure ragione! Ancora un altro aneddoto: negozio di un certo livello in un quartiere della media borghesia cittadina. Acquirenti con disponibilità superiore alla media e titolare del negozio con un discreto livello culturale. Presento alla titolare, tra le altre cose, un nuovo gadget che ha la forma di una bottiglia di champagne e che, una volta aperto, riproduce il suono di un tappo di champagne che salta ed il rumore del liquido versato nel bicchiere. Commento della cliente: ma cos’è lo sciacquone del WC?... E ancora una volta, risata corale e pagina del catalogo girata su altro. Contro simili disarmanti obiezioni, come puoi replicare? Come fai ad essere obiettivo e non ridere di gusto insieme col tuo cliente? Semplicemente non puoi. Purtroppo il Sig. T, uomo del profondo nord, quello meno aperto allo scambio ed al confronto, col 80 cuore padano e la presunzione di conoscere il mondo dall’alto delle sue valli ed altrettanto convinto che al di sotto della linea gotica alligni solo istintiva barbarie annegata nel latte di bufala, penserà sempre che il suo modo di vedere il mondo sarà quello giusto ed insindacabile. L’apoteosi di questa filosofia di vita/aziendale, l’abbiamo raggiunta lo scorso anno, alla consueta riunione annuale della rete vendita. Là dove la direzione commerciale e la proprietà ci presentavano come di consueto, le nuove armi da usare nella nostra quotidiana battaglia, abbiamo avuto una vera e propria sorpresa. Alla cena di presentazione, prima del giorno previsto per la riunione, notammo la presenza di una coppia di strani personaggi. Lui era corpulento quanto trasandato cinquantenne, con abbondanti ed incolti capelli grigi, più simile ad un clochard che ad un artista. Lei era la sua nemesi, almeno fisicamente: una donna gracile e minuta, magra come un chiodo, vestita con un improbabile tailleur scozzese ma dalla fattura dozzinale, con i capelli a spazzola e degli antidiluviani occhiali da vista, tondi e con le lenti molto piccole e spesse. Lui si sedette ad un tavolino del bar accanto a noi agenti che intanto si chiacchierava del più e del meno mentre lei si teneva alle sue spalle, un po’ in disparte. Ad un certo punto, il nostro presunto clochard, tirò fuori da una borsa un blocco di fogli ed iniziò a schizzare delle vignette. La mia ipotesi che fosse qualcuno in cerca di una mancia in cambio di quelle orribili vignette venne presto smentita. Il duo (ig)noto ai più col nome di Snack&Sgniola, era in realtà formato da due umoristi, marito e moglie e rappresentavano secondo le pie speranze del Sig. T, l’arma totale che ci avrebbe dovuto consentire di sconfiggere la concorrenza. Concorrenza poi che non era rappresentata da una ACME o da una SPECTRE qualunque, ma nientemeno che da quell’agenda che, in quanto a popolarità, è sempre stata seconda solo rispetto alla Bibbia. L’agenda che da decenni trova posto in tutti gli zainetti di tutti gli studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado! Mentre dei due non avevo mai sentito parlare in vita mia. Snack&Sgniola – scoprii poi chiedendo ai colleghi loro corregionali – erano due disegnatori satirici conosciuti in un ambito territoriale molto ristretto e famosi penso, negli anni in cui nascevo. Fermo agli anni ’70 era infatti rimasto quel loro tipo di umorismo, molto banale e superficiale, sul limite tra la pesante battuta da avanspettacolo in stile Bagaglino e la barzelletta semi-piccante raccontata dai compagni più smaliziati delle elementari. Allo squallore delle battute – per il 90% con allusioni sessuali neanche tanto velate – si affiancavano dei disegni con un tratto che davvero, ricordava quello di un bambino dell’età di, al massimo, 10 anni. Io ed il mio capo area, quando capimmo che loro due erano la misteriosa arma-totale di cui tanto il Sig. T ci aveva parlato, ci guardammo indecisi se farci prendere dall’incredulità o dallo sbigottimento! Inutile dirvi che nel mentre alcuni colleghi loro corregionali si sbellicavano dalle risate, forse più per piaggeria che per reale apprezzamento, noi altri ci guardavamo davvero basiti. Inutile anche aggiungere qual è stato il risultato ottenuto dai prodotti ad opera della triste coppia qui in Campania: un fallimento totale quanto prevedibilissimo ed immagino che la maggior parte dei colleghi non abbia potuto fare di meglio. A questo punto viene spontaneo chiedersi che cos’è che non va nell’azienda K? La K abbiamo detto, può vantare giustamente delle produzioni bellissime e livelli qualitativi di riferimento per il mercato, ma dimostra di ignorare totalmente le peculiarità di una gran parte del mercato geograficamente, anagraficamente e culturalmente lontana dal proprio vissuto personale. La K giustifica gli scarsi risultati ottenuti sin qui, nella mia ragione con l’inefficienza della rete vendita al punto che, proprio mentre sto scrivendo, pare abbia deciso di non avvalersi ulteriormente della nostra collaborazione. 81 I risultati concreti di quest’anno nella mia area parlano chiaro: un notevole incremento dei punti vendita nelle catene della grande distribuzione libraria, un crollo verticale dei p.v. appartenenti a privati, per intenderci, la piccola cartolibreria a conduzione familiare. L’insuccesso clamoroso di alcune linee che restano ferme su tutti gli scaffali; il successo sempre e solo della solita linea ma che da sola, non giustifica più gli sforzi compiuti; il livello medio-basso di vendita per la restante parte dei prodotti. Perché cambiare rete vendita quando in sostanza il fatturato di quest’anno nella mia area è incrementato rispetto allo scorso anno, nonostante l’aggravarsi della crisi? Se ammettere i propri errori non è da tutti, di certo non è una dote che appartiene alla specie dei direttori commerciali. Più facile invece è scaricare il tutto sul proprio agente di zona. Cambiarlo non costa nulla e al massimo… Peggio di così… Perché allora, il crollo nei punti vendita medio-piccoli e perché invece l’incremento che si è manifestato (con mio sommo sforzo) nelle grandi catene viene disprezzato? Qui da noi la crisi ha avuto un’onda molto più lunga di quella nazionale ed è iniziata molto prima che nel resto del paese. Questa circostanza ha comportato un crollo verticale nelle vendite degli articoli che non appartengono ai soliti marchi che vengono sostenuti da grandi sforzi di marketing e comunicazione. Il piccolo commerciante che in questi anni si è visto crescere in maniera esponenziale i costi fissi come affitti, energia, carburanti e spese varie e che per di più trova sempre maggiori difficoltà a reperire denaro dalle banche, se non ha già chiuso, si trova con l’acqua alla gola e non può assolutamente permettersi di sperimentare articoli sconosciuti e comprare altro che non sia a vendita garantita. I piccolissimi imprenditori non possono più permettersi il rischio di impresa proprio perché è a rischio la loro sopravvivenza. I prodotti della K invece, anche qui in Campania, hanno ancora un discreto successo se esposti sugli scaffali delle grandi catene librarie e questo proprio perché ormai, il loro pubblico di riferimento, più maturo, acculturato e con maggiori disponibilità economiche, si rivolge quasi esclusivamente verso quel tipo di venditore. Tuttavia la K ed il Sig. T, non avendo grandi margini di guadagno su tale tipo di vendita – le catene librarie godono di maggiori sconti e della possibilità di rendere i prodotti invenduti - ritengono inutile tutti gli sforzi compiuti per posizionare il nostro prodotto in quelle. Una idiosincrasia insanabile che erediterà il prossimo sfortunato agente. Ma a comportarsi in maniera quantomeno discutibile non è solo l’azienda K, anzi! Chi più chi meno, agiscono tutte prescindendo dal mercato e gli esempi da portare sarebbero tantissimi. L’azienda O ad esempio, che sbaglia col pricing (cioè la determinazione dei prezzi di vendita) creandosi da sola una concorrenza interna, visto che ha la pretesa di agire sia sul mercato dell’ingrosso che quello del dettaglio, senza considerare i margini che dovrebbero comunque consentire a noi agenti di vendere ai dettaglianti se non con un vantaggio rispetto ai prezzi praticati dai grossisti, ma quantomeno con gli stessi prezzi. Così mi capita costantemente il cliente che mi chiede a quanto gli venderei il prodotto P, che lui utilizza in maniera massiva, e di sentirmi ridere dietro in maniera sfacciata quando sente che il prezzo che lui ha ottenuto sul mercato risulta molto più basso di quello che gli potrei praticare io, agente diretto. Altri casi poi li ho appresi collaborando col mio cognato-agente che mi ha introdotto su questa cattiva strada del venditore… Le sue aziende sono anch’esse foriere (e talvolta anche fioriere ) di esempi gustosissimi. Minimi d’ordine sparati a livelli insostenibili in periodi di crisi nera, con poi in subordine, l’obiettivo di allargare la propria quota di mercato; aziende dalla lunga e sana storia, divise e quindi minate, 82 per dissapori interni nella gestione familiare; produttori di articoli di qualità ma possessori di un marchio quasi sconosciuto che però pretendono di opporsi ai colossi del settore contrapponendo delle politiche di marketing ridicole… Insomma, la casistica è talmente vasta, che forse richiederebbe (o richiederà, chissà…) un libro a parte! Ovviamente quando i risultati prefissati ad inizio anno dalle aziende, non vengono raggiunti – e non vengono raggiunti quasi mai – la colpa è da scaricare sulla forza vendita che non si è impegnata abbastanza, come se poi, interesse principale della forza vendita, non fosse proprio il vendere quanto più possibile, visto che la propria retribuzione è proprio parametrata a quella vendite. Chi glielo dice ora al Sig. T che lui va più d’accordo con le nonne che con le giovani donne? 83 Capitolo 14 Di che morte dobbiamo morire? Venditori non si nasce, venditori si può diventare. La mia esperienza lo dimostra. Dei bravi manager si può imparare ad esserlo, dei pessimi mànnaggger lo si diventa se la propria presunzione è superiore alla voglia di migliorarsi, se si è privi di quel grano di umiltà che è necessario per imparare. Questa è la lezione più grande mai appresa a scuola e nella vita e me l’ha data il mio professore di matematica del liceo. Lui ci diceva che più di ogni altro sforzo fatto per apprendere, più dell’esercizio, più della predisposizione alla materia, contava l’umiltà. Se non si disponeva di quel briciolo di umiltà, non si sarebbe mai stati capaci di imparare alcunché in nessun settore della propria vita. Un timido può tranquillamente diventare una faccia di bronzo, se la sua volontà è forte e se si è disposti a percorrere una strada dura e difficoltosa, con un grandissimo lavoro su sé stessi, mettendosi alla prova e dandosi piccoli obiettivi da raggiungere, un passo alla volta. Guardandosi indietro si ha poi un senso di vertigine, vedendo tutto il percorso compiuto e quanto si è saliti in alto, più delle forze che si credeva di avere. Ma poi il senso di potenza per aver sconfitto i propri limiti è talmente grande che la vertigine si trasforma presto in ebrezza. La timidezza, come ogni nostro difetto caratteriale, può diventare anche un’opportunità: chi nasce timido come me, non perderà mai del tutto quella sua peculiarità ma, se si impara a conviverci, la debolezza si può trasformare in un’arma irresistibile. I venditori aggressivi sono ormai vissuti con fastidio dalla maggior parte dei clienti. Adesso serve qualcuno che sappia ascoltare le istanze del cliente, qualcuno di cui ci si possa fidare ed il timido – credetemi – ispira fiducia e consenso. Ovviamente, se poi dietro quell’aspetto di superfice, riuscite a dimostrare la grinta e la sicurezza, l’effetto sorpresa che ne risulta, può essere davvero l’elemento che vi consentirà di avere la vostra rivalsa. Così il manager che non sa ascoltare i suoi collaboratori, la propria forza vendita, i propri clienti, è destinato al sicuro fallimento. Può avere il prodotto migliore, può avere risorse infinite, può affidarsi ai migliori esperti, ma se ignora questa semplice lezione, è destinato quantomeno a distruggere la propria azienda. E questo discorso è valido anche per il nostro Paese. Per anni ci siamo crogiolati dei successi ottenuti dalla generazione passata. Il boom economico ci ha proiettati nel top dei paesi più sviluppati del mondo, ma a questo non è seguito un lavoro per mantenere tali risultati. La presunzione ci ha accecati, abbiamo perso il senso della misura. Ci siamo scelti una classe dirigente corrotta e clientelare che è risultata essere lo specchio della grettezza e della presunzione che ormai ci stava divorando. La famiglia, che da una parte era ricchezza e forza, si è trasformata in cosca, il Rinascimento è tornato ad essere buio Medio Evo. Occorre da parte nostra, un grande sforzo per dissaldare questi meccanismi perversi che spingono il nostro paese nel baratro. Dobbiamo eliminare quei difetti che ci sono peculiari e trasformarli in opportunità. La nostra guasconeria e la nostra originalità devono smettere di essere devastante presunzione, arroganza, individualismo e spregio delle regole, ma devono essere canalizzate nell’inventiva, nella 84 creazione di nuove strade ed opportunità per la nostra società. C’è ancora un piccolo barlume di speranza, ma occorre che i vari “mànnaggger” pubblici e privati, vengano scoperti e dichiarati per quello che sono ed estromessi dai propri potentati. Occorre uno scatto d’orgoglio affinché il merito riprenda il sopravvento sulla forza d’appartenenza e sulla casta. Non so se il cammino della mia vita si fermerà su questo binario o se prima o poi mi si parerà davanti un altro scambio e se io avrò la voglia, l’opportunità o la forza di cambiare un’altra volta direzione. La meta è ancora lontana e forse la strada sin ora intrapresa, è quella sbagliata. Quello che ho imparato in questi anni però è che davvero non ci si può permettere di fermarsi, di attendere che qualcosa cambi senza metterci in condizione di farlo cambiare. Il momento che stiamo vivendo non ispira certo l’ottimismo, ma è proprio nei momenti peggiori che uno tira fuori una forza inattesa. Come chiudere questo non libro? Steve Jobs, citando il motto di una rivista a lui cara negli anni della sua adolescenza, rivolgeva ai giovani l’invito ad essere “pazzi ed affamati”. Questa non è “the land of opportunities”, la terra delle opportunità come gli Stati Uniti d’America e gli auspici di Jobs qui non basterebbero. Io aggiungerei anche che bisogna avere gli occhi e le orecchie aperti, che non si deve mai smettere di voler imparare e mai perdere quell’umiltà e quell’intelligenza che ci fanno apprendere lezioni anche e soprattutto dalle persone che meno stimiamo e che riteniamo peggiori di quanto ci consideriamo noi. Che il Mannaggiament sia lontano voi! ;) 85
Scarica